IL “BIG KILLER” INTELLIGENTE
Uno studio italiano aggiunge un nuovo tassello all’indagine scientifica sulla capacità del tumore al polmone di eludere l’immunoterapia


Uno studio italiano aggiunge un nuovo tassello all’indagine scientifica sulla capacità del tumore al polmone di eludere l’immunoterapia

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
www.fnob.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
Giornale dei Biologi
Il Giornale dei Biologi
PRIMO PIANO
A tre anni dall’arrivo del Covid di Rino Dazzo
INTERVISTE
Tumore al polmone. Studio sulla mancata risposta all’immunoterapia di Elisabetta Gramolini
Glioblastoma, estratti naturali alleati insieme alle terapie tradizionali di Chiara Di Martino

Fiorella Belpoggi. I cinquant’anni di ricerca della scienziata del Ramazzini di Anna Lavinia
14 Attività delle cellule registrate dalle proteine auto-assemblanti di Sara Bovio
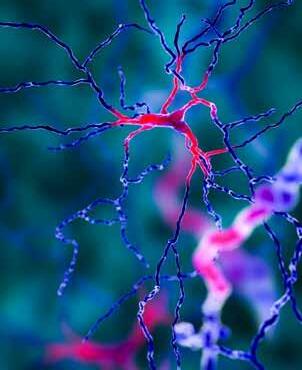
Alimentazione e cancro. Prima, durante e dopo chemio e radio-terapia di Andrea Del Buono e Armando D’Orta
Inclinazione allo sport? Una questione di pancia di Ester Trevisan
Bere acqua migliora la salute? di Domenico Esposito
Cervello e memoria motoria nel sonno di Domenico Esposito
NGF, la molecola di Levi Montalcini per l’alzheimer di Domenico Esposito
Sociale: scacciano la noia, ma bloccano nuove passioni di Domenico Esposito
L’atlante cellulare dell’endometriosi di Michelangelo Ottaviano
Caffeina per capelli Biancamaria Mancini
Cosmeceutici naturali e tecnologie antiage Carla Cimmino
L’arte farmaceutica nel Rinascimento nei secoli XV e XVI Barbara Ciardullo
Frutta e pesticidi di Gianpaolo
Co2: sale ancora il termometro di Gianpaolo Palazzo
Healthy city guide di Giovanni Misasi
Il trattato di Montreal e il buco dell’ozono di Michelangelo Ottaviano
INNOVAZIONE
I raggi X per le malattie neurodegenerative di Pasquale Santilio
Viaggio verso il centro della Terra di Pasquale Santilio
Mini-reattori per energia sulla Luna di Pasquale Santilio
Materia prime critiche da batterie al litio di Pasquale Santilio
Via Appia, la regina viarum candidata all’Unesco di

SPORT
Un 2022 da “dieci”. Il meglio dell’Italia nello sport di Antonino Palumbo
Da Masinga ad Adop. Quante “favole” alla scala del calcio di Antonino Palumbo
Atletica, nuoto, sci… Le ambizioni azzurre di Antonino Palumbo

I 40 anni di Pozzovivo “valgo il world tour” di Antonino Palumbo
Concorsi pubblici per Biologi
SCIENZE
Che cos’è l’altruismo e in quale specie possiamo trovarlo? di Jolanda Serena Pisano
Fisica e neuroscienze per la predizione di deficit neurologici dovuti a ictus di Cinzia Boschiero
Una rilettura ecologica del XX secolo (Parte I) di Antonella Pannocchia
Microbioma e sindrome dell’ovaio policistico di Giuseppe Palma
La massiccia circolazione del virus in Cina apre le porte all’insorgenza di nuove varianti
In Italia c’è un calo delle infezioni, ma è necessario proteggere i fragili con le vaccinazioni
di Rino Dazzo
Il pericolo (ri)arriva dalla Cina. Tre anni dopo la comparsa sulla scena del Covid-19, adesso sono le nuove varianti a creare preoccupazione, favorite dalla vertiginosa impennata dei casi nel gigante asiatico determinata dalla fine delle limitazioni. La strategia Covid zero del governo di Pechino si è rivelata un boomerang. Le continue serrate, i lockdown di intere città e regioni hanno messo in ginocchio l’economia, ma non hanno impedito al virus di ripresentarsi. E ora, con l’abbandono di gran parte delle misure di contenimento, la Cina è tornata a essere centro e vettore dell’epidemia, anche perché i vaccini sviluppati nei suoi laboratori non si sono rivelati efficaci come quelli utilizzati in Occidente. Quale impatto può avere la recrudescenza del virus sull’Italia e sugli altri paesi? Quanto ne sappiamo sulle nuove varianti? Dobbiamo realmente preoccuparci della loro diffusione?
I loro nomi in effetti, scelti da un docente di Biologia all’Università canadese di Guelph in Ontario, il professor Ryan Gregory, ricordano mostri della tradizione e fanno un certo effetto: Gryphon, Kraken, Orthrus, ma anche Cerberus e Centaurus. In realtà sono tutte sottovarianti di Omicron, tutte caratterizza-
te dalla capacità di allargarsi in modo molto rapido ma – a quanto sembra – non più pericolose delle precedenti. La prima a fare la sua comparsa è stata Gryphon, che l’OMS indica come sottovariante XBB, di cui Kraken (inquadrata come XBB.1.5) rappresenta un sottolignaggio. Poi è stata la volta di un’ulteriore sottovariante, Orthrus. Negli Stati Uniti Kraken nel corso del mese di gennaio ha assunto posizione dominante tra i contagi, nel Regno Unito invece sta impazzando Orthrus. I sintomi più ricorrenti? Rinorrea, mal di testa, affaticamento, starnuti, mal di gola, in alcuni casi febbre.
In Italia per il momento le nuove varianti sono state registrate in un numero limitato di casi, anzi per tutto il mese la curva dei contagi è andata progressivamente a diminuire. Tra il 12 e il 19 gennaio i contagi su scala nazionale sono diminuiti del 38,2%, con un tasso di positività sceso dall’11 al 7,6%. Ma non è il caso di sentirsi al riparo da rischi. L’intensificarsi degli spostamenti, a cominciare da quelli legati al Capodanno cinese, potrebbe determinare a breve un aumento significativo di casi. Tra i primi a sottolinearlo c’è il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortope -
dico Galeazzi di Milano: «Tra quindici giorni mi aspetto una fiammata di infezioni dalle nuove varianti».
Che vanno tenute d’occhio, senza però la necessità di allarmismi: «Siamo in una fase di transizione da un momento pandemico a un momento endemico, con un virus che sta trovando in alcune nazioni nuove occasioni di diffusione, e questo ovviamente non va bene perché il virus più si replica più può trovare delle variazioni sul tema. Il virus – spiega Pregliasco – non è intelligente, non riesce a replicarsi in modo sistematico, commette tanti errori ma a volte questi errori si rivelano più efficaci dello standard. Inoltre, le persone hanno ormai ottenuto una protezione ibrida tramite guarigioni e vaccinazioni, quindi, è più difficile per il virus diffondersi, portando a un susseguirsi molto veloce di varianti. Queste varianti sono immunoevasive, schivano la protezione ibrida di cui si parlava e sono costrette a diventare meno patogene in modo da

poter essere più contagiose. Più sono banali i casi, più c’è trasmissibilità».
Lucida anche la fotografia della situazione da parte di Matteo Bassetti, direttore della SOC Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova: «I cinesi sono passati da fare una cosa precisa a non fare più nulla, prima era tutto obbligatorio, oggi è tutto facoltativo e i risultati sono evidenti. Rispetto a quanto comunicato ufficialmente si parla di dieci volte i numeri in più, si parla di circa un milione di morti. Il pericolo varianti? È ovunque, più il virus circola più è in grado di mutare e questa variante (Kraken, ndr) non ci deve fare paura, è più contagiosa ma è anche una variante che con la copertura vaccinale è arginata. Il problema è che i fragili non sono vaccinati, il problema non sono le varianti ma sono i fragili over 75 che non hanno ricevuto ancora la dose di richiamo, la battaglia è parzialmente vinta ma la guerra la vinciamo solo se ci vacciniamo».

La ricerca è stata condotta dal gruppo guidato da Marcello Maugeri-Saccà, oncologo medico e ricercatore dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) di Roma
Una casistica ampia, una collaborazione fra un istituto italiano di primaria eccellenza ed un centro oltreoceano hanno portato ai risultati di uno studio per comprendere i meccanismi alla base della mancata reazione alle cure immunoterapiche nel caso del tumore al polmone. Il lavoro, pubblicato sull’Annals of Oncology, la rivista ufficiale dell’European Society for Medical Oncology (ESMO), è stato condotto dal gruppo guidato da Marcello Maugeri-Saccà, oncologo medico e ricercatore dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) di Roma, in collaborazione con i ricercatori del Dana-Farber Cancer Institute-Harvard Medical School di Boston e del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste.
Il tumore del polmone viene considerato il “big killer” tra le neoplasie. Ad esso nel 2021, solo in Italia, sono da imputare 34mila morti di cui circa il 60% riguarda i forti fumatori. Le vittime sono ancora tante nonostante gli enormi passi in avanti effettuati negli ultimi anni. Tra questi, vi è l’immunoterapia con anticorpi monoclonali, diventata una risorsa fondamentale del trattamento terapeutico, indicata per larga parte dei pazienti con questa diagnosi.
Molti pazienti però non rispondono a questa terapia e sperimentano un fallimento precoce delle cure. Capire i meccanismi alla base di questa resistenza farmacologica è fondamentale per migliorare ulteriormente la qualità di vita e la sopravvivenza dei nostri pazienti.
Focus centrale della ricerca quindi è stato analizzare le caratteristiche genomiche dei tumori del polmone, in questo caso gli adenocarcinomi. Circa il 20% di tali neoplasie possiede una mutazione del gene KEAP1, già da anni oggetto di ricerca del gruppo dell’Istituto romano e legato ad una minore efficacia dei trattamenti immunoterapici. In particolare gli autori hanno osservato che, correlando due parametri che ci dicono quanto è presente tale mutazione nelle cellule tumorali, è possibile identificare l’efficacia del trattamento.
«Siamo partiti proprio da un’attenta analisi dei dati genomici, frutto dell’applicazione nella pratica clinica della next-generation-sequencing (NGS) su tessuto neoplastico – spiega Marcello Maugeri-Saccà – che ci permette di conoscere nel dettaglio non solo la presenza o meno di una mutazione nel tumore, ma anche quanto è presente. Focalizzandoci su KEAP1, con questo studio dimostriamo che i pazienti con mutazioni cosiddette clonali (cioè presenti
in tutte le cellule neoplastiche) di KEAP1 hanno uno scarso beneficio dell’immunoterapia. D’altronde, abbiamo verificato che questi tumori risultano “immunologicamente freddi”, quindi poco responsivi allo stimolo dell’immunoterapia».
Infatti, i malati con un profilo meno evidente della mutazione, sono sensibili alla terapia. Al contrario, i pazienti con elevato profilo mutazionale sono resistenti. Tali risultati sono stati verificati su una larga coorte di persone, circa 700 in totale, affette da adenocarcinoma polmonare, trattate con immunoterapia, di cui erano disponibili sia i dati clinici del trattamento sia i dati genomici della neoplasia. Questo studio conferma quindi le conoscenze a cui si era giunti in passato ma si inserisce in un panorama in continua mutazione: «recentemente – ricorda l’oncologo - sono state approvate per esempio le combinazioni a base di immunoterapia e sono arrivati i primi dati promettenti di nuovi farmaci che agiscono sul sistema immunitario bloccando altri target immunologici. Sono giunti con la pratica clinica altri inibitori di proteine mutanti che fino a pochi anni fa non potevano essere bloccati da farmaci specifici. Nel frattempo che aumenta l’armamentario terapeutico, avere a disposizione questo nuovo tipo di conoscenze ci consentirà di utilizzare al meglio le terapie standard e le nuove».
Con questo lavoro si aggiunge perciò un altro tassello. «I risultati dello studio, attraverso l’uso di parametri disponibili anche in pratica clinica grazie ad un’adeguata caratterizzazione

Gli autori hanno osservato che, correlando due parametri che ci dicono quanto è presente tale mutazione nelle cellule tumorali, è possibile identificare l’efficacia del trattamento.
Anovembre scorso, l’Agenzia italiana del farmaco ha approvato durvalumab, un immunoterapico contro il tumore al polmone a piccole cellule (SCLC o microcitoma), il meno diffuso e il più difficile da curare. Per decenni, contro questo tipo di cancro è stato possibile affidarsi solo alla chemioterapia. Ora anche in Italia le persone affette potranno avere una possibilità di trattamento in più capace di migliorare sensibilmente la sopravvivenza dato che il farmaco, abbinato alla chemioterapia, si è dimostrato utile nel triplicare la sopravvivenza. Un paziente su cinque infatti è vivo a tre anni dalla diagnosi.

genomica della neoplasia, - afferma Gennaro Ciliberto, direttore scientifico dell’Istituto Regina Elena – possono, se ulteriormente confermati, consentire in futuro di selezionare sin dalla diagnosi i pazienti che avranno beneficio dal trattamento immunoterapico. Fondamentale per la realizzazione di tale lavoro è stata la collaborazione internazionale tra l’Istituto e altri due prestigiosi centri, all’avanguardia nella cura e ricerca contro il cancro».

Antonella Arcella (Neuromed) si è concentrata sull’isoginkgetina, bioflavonoide naturale isolato dalle foglie di Ginkgo biloba, per coadiuvare la lotta al tumore cerebrale maligno più frequente
Il glioblastoma multiforme è il tumore cerebrale maligno più frequente (il 12-15% di tutte le neoplasie intracraniche e il 6075% dei tumori gliali), è caratterizzato da una proliferazione cellulare aggressiva e una rapida invasione del normale tessuto cerebrale, con un’incidenza, in Italia, di 8 casi ogni 100.000 abitanti all’anno, con un picco tra i 45 e i 75 anni e una prevalenza nei maschi. Nonostante gli approcci terapeutici aggressivi consistenti nella resezione chirurgica (quando si sviluppa in aree accessibili) seguita da radio-chemioterapia con temozolomide, in molti casi non si riesce a contrastare la crescita e l’invasività del tumore, che recidiva dopo un intervallo di tempo che varia da paziente a paziente.
Nella lotta a questa patologia, le sostanze naturali potrebbero rappresentare un nuovo strumento terapeutico in concomitanza con la temozolomide. È il frutto dello studio pubblicato dal Laboratorio di Neuropatologia Molecolare dell’Unità di Neuropatologia dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli. In particolare, Antonella Arcella, che di questo laboratorio è la responsabile, si è concentrata negli ultimi 6-7 anni su una serie di sostanze naturali. Nell’ultimo studio, pubblicato su Molecules, sotto la lente di ingrandimento è finita l’isoginkgetina, un bioflavonoide
naturale isolato dalle foglie di Ginkgo biloba, che sembra avere molte proprietà curative, dalle attività antinfiammatorie a quelle antiossidanti, fino a possibili proprietà antitumorali.
Dottoressa Arcella, qual è la sua storia in questo campo?
Mi occupo di neoplasie cerebrali da 20 anni, dal punto di vista clinico effettuo la caratterizzazione molecolare: la nuova classificazione dei tumori cerebrali propende per una diagnosi integrata tra l’istologia del tumore e la caratterizzazione molecolare. Quanto alla mia attività di ricerca, svolta sempre nel polo di Ricerca Neuromed, disponiamo di un sistema di studio in vitro: abbiamo messo in coltura cellule di glioblastoma umano a partire dalla biopsia dei nostri pazienti. Il modello in vivo, invece, ci consente di valutare, in un sistema fisiologico, lo sviluppo del tumore e la risposta a nuovi trattamenti e individuare i meccanismi alterati alla base dello sviluppo del glioblastoma: “gliomagenesi”. Da qualche anno, poi, mi sono focalizzata sulle sostanze naturali: l’isoginkgetina non è la prima, ho già studiato a lungo gli effetti benefici della lattoferrina, dell’aloe emodina.
In particolare, si occupa di glioblastoma, giusto?
Esatto. La sua peculiarità sta nel fatto che
la chirurgia non si mostra risolutiva, e si assiste spesso a una recidiva. Le possibilità di cura restano poche a causa della sua variegazione: questo termine sta a indicare che ogni paziente mostra delle mutazioni specifiche quindi la biologia del tumore risulta diversa da paziente a paziente. I pazienti presentano anche fenomeni di farmaco-resistenza: è estremamente difficile, quindi, trovare un trattamento che vada bene per tutti.
Dal punto di vista delle terapie invece?
Tra i chemioterapici in prima linea c’è la temozolomide, un farmaco alchilante. La presenza, inoltre, della barriera ematoencefalica complica l’ingresso di molecole di grandi dimensioni; quindi l’armamentario terapeutico risulta veramente limitato. I risultati ottenuti con l’isoginketina ci fanno ben pensare; potrebbe entrare a far parte di una terapia multimodale che combina gli effetti della chemioterapia e dell’estratto naturale rappresentando un percorso terapeutico più efficiente.
Come è arrivata a studiare questo bioflavonoide naturale isolato dalle foglie di Ginkgo biloba?
L’isoginkgetina è stata già studiata in altri contesti per altri tumori, ne è stata dimo-strata l’efficacia nell’inibire la crescita di linee cellulari di mieloma multiplo mo-strando un tasso elevato di morte cellulare. Noi lo abbiamo sperimentato
Antonella Arcella si occupa di neoplasie cerebrali da 20 anni; dal punto di vista clinico effettua la caratterizzazione molecolare, dal momento che la nuova classificazione dei tumori cerebrali (WHO CNS 2021) propende per una diagnosi integrata tra l’istologia del tumore e la caratterizzazione molecolare; quest’ultima ha consentito di individuare “sottonicchie” biologiche molecolarmente definite nell’ambito di neoplasie dello stesso grading. Quest’attività si accosta a quella di ricerca, sempre svolta al polo di Ricerca Neuromed.

in vitro su cellule di glioblastoma dimostrando che a basse concentrazioni riesce a bloccare la crescita di queste cellule.

Cioè?
Inibisce la crescita delle cellule tumorali fino al 50% e al contempo ne riduce la migrazione, questo è molto interessante perché potrebbe impedire alle cellule tumorali di insinuarsi in zone più profonde del cervello rendendo possibile l’eradicazione chirurgica del tumore. Abbiamo inoltre cercato di capire quali fossero i meccanismi di azione con cui l’estratto agisce ed abbiamo dimostrato che è in grado di ripristinare i meccanismi omeostatici che nella cellula normale inducono alla morte cellulare: apoptosi e autofagia.
Il passo successivo della ricerca?
Dovrebbe essere la dimostrazione dell’effetto della sostanza in un modello animale che in Italia prevede una lunga serie di passaggi burocratici autorizzativi, perciò non sarà immediato.
Questo tipo di sostanza ha un limite?
Purtroppo sì: dopo la dimostrazione scientifica dell’efficacia della sostanza in vitro e in vivo, è difficile accedere a sperimentazioni cliniche veloci, eccessivamente complesse anche per il reclutamento dei pazienti. In conclusione, l’estratto da Ginko Biloba può essere considerato un’ottima sostanza adiuvante per il trattamento del glioblastoma.
Dal benzene al glifosato, dall’aspartame al 5G, cinque decenni in laboratorio senza mai rinunciare a tre valori imprescindibili: libertà, verità e responsabilità
Fiorella Belpoggi è una biologa di fama internazionale con una lunga esperienza di ricerca su sostanze chimiche, agenti ed interferenti endocrini. Protagonisti (in)discussi dei suoi studi sono stati il glifosato, i pesticidi, gli additivi delle benzine e le radiofrequenze. Ha esaminato con attenzione l’impazzimento cellulare che il cancro provoca, strettamente collegato all’ambiente in cui viviamo, ai cibi che mangiamo e all’aria che respiriamo.
Nel libro a cura della giornalista Licia Granello, sono raccontati nel dettaglio i suoi innumerevoli studi senza censure, per la tutela della salute e della qualità della vita. Questo è da sempre l’impegno dell’Istituto Ramazzini che attraverso un rigoroso lavoro di ricerca, fin dalla sua nascita, indaga il rapporto e le connessioni tra salute e ambiente. Identifica le sostanze pericolose da un punto di vista oncologico e cerca di allontanarle, ovvero di eliminarle dal mercato, anche se il percorso però non è per niente facile.
È noto il contributo della Belpoggi nel caso dell’inquinamento delle falde acquifere della comunità di Jacksonville (USA) con l’additivo delle benzine verdi, nel 2010. Il suo expertise legato ai tumori del sangue (il ben-
zene è un potente leucemogeno) ha dimostrato la correlazione del danno ambientale con l’insorgenza delle malattie tumorali. Tuttavia, “il benzene è ancora tra noi”.
Perché questo additivo considerato tossico viene ancora utilizzato?
Pubblicazioni recenti di italiani molto autorevoli, hanno messo a punto studi epidemiologici su bambini che hanno vissuto o vivono in zone a grande traffico e su figli di persone che hanno lavorato in settori dove c’è largo uso di benzene. Questi hanno evidenziato un incremento di linfomi o di leucemia. Purtroppo il vantaggio o lo svantaggio di un determinato composto, nella nostra società, viene misurato con il PIL. Quando un composto ha una serie di vantaggi tecnologici, costa poco e dà un risultato buono, per toglierlo dal mercato bisogna trovare qualcosa di paritetico o di migliore, cosa che oggi non esiste. Se noi ragioniamo in questo modo però non avremo mai uno sviluppo sostenibile. C’è bisogno sempre di un’alleanza fra il mondo produttivo e quello scientifico ma se si prescinde da questo non si va da nessuna parte.
Sapere che c’è una “soglia di sicurezza” sui rischi di una sostanza chimica, ci protegge?
Mettiamo che venga fatto uno studio e che
io trovi che una determinata sostanza è cancerogena fino a 100 mg per chilo di peso, cosa succede? Le agenzie di controllo dicono di dividere questa dose per 100 dove sicuramente non si vedranno più questi effetti, così il livello di dose di sicurezza ammessa diventerà

1. Noi però non sappiamo se questo valore 1 sia sicuro perché non l’abbiamo mai studiato, abbiamo verificato il valore massimo prima di dividerlo. Andando a studiare, invece, dosi al di sotto del Not Observed Adverse Effect
Level, potrei trovare degli effetti, diversi dal cancro che avevo ricercato nello studio, come altre patologie degenerative differenti. Questo è accaduto e infatti lo abbiamo già dimostrato in diversi studi fatti.
Si discute sempre più spesso degli effetti nocivi delle onde del 5G. Cosa ci dice la scienza?
Parliamo di un agente che non farà neanche risentire dei suoi effetti perché siamo tutti esposti. Ma tutti questi agenti e composti messi insieme provocano un disastro per la salute: una tossicità cronica e tutte le malattie neurodegenerative che ne conseguono, compreso il cancro. Il vero problema è la potenza del livello di esposizione. Affinché ci sia un livello basso io dovrei avere tante piccole antenne di
“Pubblicazioni recenti di italiani molto autorevoli, hanno messo a punto studi epidemiologici su bambini che hanno vissuto o vivono in zone a grande traffico e su figli di persone che hanno lavorato in settori dove c’è largo uso di benzene. Questi hanno evidenziato un incremento di linfomi o di leucemia”.
Fiorella Belpoggi è nata a Bologna nel 1952 ed ha conseguito la laurea in Biologia. È direttrice scientifica dell’Istituito Ramazzini, dove si dedica alla ricerca dal 1981. È membro dell’Accademia Internazionale di Patologia Tossicologica e della New York Academy of Sciences. Collabora con l’Ente di ricerca americano National Institute of Environmental Health Sciences ed è referente della Commissione Europea su salute e ambiente. Ha ricevuto riconoscimenti internazionali e ricoperto incarichi accademici.

bassa potenza ma ciò significa un costo molto elevato per le aziende. Siamo stati invasi, pervasi e immersi in un ambiente permeato dalle onde elettromagnetiche senza che l’industria investisse un centesimo sulla sicurezza. Per l’industria chimica o farmaceutica, prima della diffusione di un nuovo prodotto, occorrono migliaia di pagine di dossier con tutti gli studi raccomandati, non si capisce perché per le tecnologie questo non è richiesto.
Conoscendo da vicino gli effetti nocivi che le sostanze continuano ad avere sulla salute e sull’ambiente, riesce ancora ad essere ottimista?
Negli ultimi anni sono un po’ scoraggiata, un tempo eravamo dei pionieri, negli anni ’80 e ’90 dicevamo le stesse cose che diciamo adesso. Certo eravamo anche poco ascoltati! Adesso, se ne parla tanto ma si fa pochissimo. Da un altro punto di vista però mi sento di avere contribuito con i nostri risultati e il nostro coraggio a dire sempre la verità.
Il pensiero ed il lavoro della scienziata evidenziano senza dubbio il progresso della scienza. Allo stesso tempo però ci esortano a non ignorare i pericoli connessi alle moderne tecnologie: nuovo non è sempre uguale a buono.

I bassi livelli di ossigeno che caratterizzano l’ambiente tumorale reprimono le difese immunitarie Lo studio apre allo sviluppo di nuove terapie efficaci anche per i grandi tumori aggressivi
Una delle principali funzioni del sistema immunitario è quella di riconoscere e rimuovere le cellule anomale presenti nel corpo, come quelle tumorali. Se ne occupano in particolare i linfociti T CD8+, soldati impegnati a lottare costantemente e senza riposo contro un nemico difficile da sconfiggere. Quando però il combattimento contro un tumore dura troppo a lungo, le cellule T diventano molto meno efficaci nello svolgere il loro compito e finiscono perfino per allearsi con il “nemico” spingendo anche le altre cellule del sistema immunitario ad abbandonare la lotta.
La scoperta è di un team di ricercatori dell’Università statunitense di Pittsburgh e dell’UPMC Hillman Cancer Center ed è stata pubblicata su Nature Immunology.
Greg Delgoffe, professore di immunologia presso la Pitt’s School of Medicine, direttore del Tumor Microenvironment Center dell’UPMC Hillman Cancer Center e autore senior dello studio, spiega: «Spesso pensiamo al nostro sistema immunitario in termini assoluti: alcuni tipi di cellule sono “buoni” e altri sono “cattivi”. La scoperta principale del
nostro lavoro è invece che il sistema immunitario è molto sensibile all’ambiente locale, tanto che quando intervengono importanti variazioni al suo interno, le cellule tipicamente ritenute antitumorali possono cambiare alleato e lavorare contro di noi». Il team ha dimostrato, infatti, che la causa principale di questo “voltafaccia” sarebbero i bassi livelli di ossigeno che caratterizzano l’ambiente tumorale e che potrebbero diventare bersaglio per nuove terapie, in modo da ricondurre le cellule T a lavorare correttamente. «Ciò che abbiamo appreso nel nostro studio – rileva Delgoffe - è che quando i linfociti T stanchi passano dalla parte dei tumori, non si limitano a diventare meno funzionali, ma modificano l’ambiente circostante per spegnere attivamente le altre cellule vicine. In altre parole, le cellule T esauste non solo non lavorano per noi, ma agiscono attivamente contro di noi».
Paolo Vignali, studente del Medical Scientist Training Program di Pitt e autore principale dello studio spiega che i risultati della ricerca aprono a nuove possibilità di cura, come lo sviluppo di trattamenti per colpire il percorso responsabile del cambiamento di
fronte o l’ingegnerizzazione di migliori linfociti T per terapie basate su cellule. «Mentre il campo dell’immunoterapia si è giustamente concentrato sulla correzione della perdita di funzioni antitumorali delle cellule T – aggiunge Vignali - i nostri dati dimostrano che dovremmo anche studiare i potenziali nuovi comportamenti acquisiti da queste cellule».
Durante le ricerche gli scienziati hanno inoltre scoperto che i tumori più aggressivi tendevano ad avere più cellule T esauste immunosoppressive, mentre i tumori che crescevano più lentamente avevano cellule T esauste semplicemente meno funzionali, ma non soppressive.
«L’osservazione che l’ambiente tumorale locale poteva determinare l’immunosoppressione delle cellule T esauste – spiega Delgoffe - è stata un indizio. Da questo abbiamo capito che se fossimo riusciti a modificare l’ambiente locale, forse la natura soppressiva di queste cellule sarebbe potuta essere invertita. E così è stato: abbiamo usato farmaci che non colpiscono specificamente le cellule T, ma piuttosto cambiano il campo di battaglia in cui combattono, colpendo la vascolarizzazione e il metabolismo del tumore. Abbiamo scoperto che riportare l’ossigeno a livelli adeguati nei tessuti malati, era sufficiente a far sì che le cellule T esauste attenuassero le loro funzioni antinfiammatorie, migliorando così la risposta del tumore a diverse terapie antitumorali
“La scoperta principale del nostro lavoro è che il sistema immunitario è molto sensibile all’ambiente locale, tanto che quando intervengono importanti variazioni al suo interno, le cellule tipicamente ritenute antitumorali possono cambiare alleato e lavorare contro di noi”.
basate sul sistema immunitario. Secondo Vignali la scoperta di poter cambiare le funzioni antinfiammatorie delle cellule T esauste è particolarmente entusiasmante. Molti studi complessi e di grandi dimensioni hanno insegnato, infatti, che la maggior parte delle caratteristiche dei linfociti T esausti sono irreversibili. Tuttavia, secondo l’autore, la battaglia tra il sistema immunitario e il cancro è un delicato gioco di equilibri. I dati dello studio dimostrano che è possibile orientare il campo di battaglia e spostare l’equilibrio a favore delle cellule immunitarie, anche nei grandi tumori aggressivi.
Il team in questo momento sta proseguendo le ricerche conducendo diversi studi clinici a Pittsburgh utilizzando farmaci capaci di agire sull’ambiente tumorale in pazienti oncologici. L’obiettivo è capire se sarà possibile invertire la natura immunosoppressiva delle cellule T esauste in questi pazienti. L’interesse è rivolto anche a sviluppare farmaci che puntino direttamente alle caratteristiche soppressive delle cellule T nei pazienti.

Oltre al cancro, le cellule T esauste compaiono anche in infezioni croniche come l’epatite e l’HIV, in malattie autoimmuni come il Lupus Eritematoso Sistemico e il diabete di tipo 1 e nell’intestino. Scoprire il ruolo di queste cellule e le loro caratteristiche soppressive in altre patologie è una delle nuove direzioni che prenderà inizio da questa ricerca.

Al MIT hanno creato proteine ingegnerizzate capaci di “memorizzare” processi cellulari che rivelano quando sono attivati determinati geni o come le cellule rispondono a un farmaco
L’osservazione e la comprensione dei diversi processi cellulari sono fondamentali per distinguere i fenomeni fisiologici da quelli legati alle malattie. Un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha dimostrato che le serie di geni e i percorsi che le cellule attivano per svolgere le loro funzioni quotidiane possono essere registrati utilizzando delle proteine ingegnerizzate. Come spiegato nello studio, pubblicato sulla rivista Nature Biotechnology, gli ingegneri hanno “convinto” le cellule a registrare la sequenza dei diversi eventi in una lunga catena di subunità proteiche che, tramite l’associazione con molecole fluorescenti, può essere visualizzata e ricostruita utilizzando il microscopio ottico. Impiegando queste proteine ingegnerizzate, gli scienziati possono registrare i passaggi che rivelano l’attivazione di determinati geni o la risposta delle cellule a un farmaco. Secondo gli autori dello studio questa tecnica potrebbe aiutare a far luce sulle fasi alla base di processi come la formazione della memoria, la risposta al trattamento farmacologico e l’espressione genica.
I ricercatori spiegano che i sistemi biologici contengono molti tipi diversi di cellule, tutte con funzioni distinte. Un modo per studiare queste funzioni è di visualizzare le proteine, l’RNA o altre molecole all’interno delle cellule, che forniscono indicazioni su ciò che le cellule stanno facendo. Tuttavia, la maggior parte dei metodi offre solo una visione di un singolo momento nel tempo o non funziona bene con popolazioni di cellule molto grandi. «I sistemi biologici sono spesso composti di un gran numero di tipi diversi di cellule. Per esempio, il cervello umano ha 86 miliardi di cellule», afferma Changyang Linghu, autore principale del lavoro. «Per comprendere questo tipo di sistemi biologici – prosegue il ricercatore - dobbiamo osservare gli eventi fisiologici nel tempo in queste grandi popolazioni di cellule».
Per raggiungere quest’obiettivo, il team di ricerca ha avuto l’idea di registrare i processi cellulari come una serie di subunità proteiche che sono continuamente aggiunte a una catena. Per creare le catene, gli ingegneri hanno utilizzato subunità proteiche ingegnerizzate, normalmente non presenti nelle cellule vi-
venti, in grado di autoassemblarsi in lunghi filamenti. Il sistema geneticamente codificato prevede che una di queste subunità è prodotta continuamente all’interno delle cellule, mentre l’altra è generata solo quando accade un evento specifico. Ciascuna subunità contiene anche un corto peptide chiamato epitopo, un tag che corrisponde a un preciso stato o funzione cellulare. Ognuno di questi tag, denominati nel caso in esame HA e V5, può legarsi a un diverso anticorpo fluorescente, rendendo più facile la loro successiva visualizzazione e la determinazione della sequenza delle subunità proteiche.
Per questo studio, i ricercatori hanno fatto sì che la produzione della subunità contenente V5 dipendesse dall’attivazione di un gene chiamato c-fos, coinvolto nella codifica di nuovi ricordi. Le subunità con tag HA costituiscono la maggior parte della catena ma ogni volta che il tag V5 compare al suo interno, significa che c-fos è stato attivato in quel momento.
«Speriamo di poter usare questo tipo di autoassemblaggio proteico per registrare l’attività di ogni singola cellula», afferma Linghu. «Non si tratta solo di ottenere un’immagine istantanea nel tempo – prosegue il ricercatore - ma di registrare anche il passato, in modo simile agli anelli degli alberi che possono memorizzare in modo permanente le informazioni nel corso della crescita del legno».
Nello studio i ricercatori hanno prima utilizzato il loro sistema per registrare l’attivazione di c-fos nei neuroni in coltura. La ricerca è poi proseguita su cellule murine vive ingegnerizzate per rivelare quando gli animali fossero stati esposti a un particolare farmaco.
Il sistema progettato è di tipo modulare, così da poter scambiare diversi tag o rilevare differenti tipi di eventi cellulari, tra cui, la divisione cellulare o l’attivazione di enzimi chiamati protein chinasi che aiutano a controllare molte vie cellulari.

Poiché la lunghezza della catena proteica è limitata dalle dimensioni della cellula, esiste un compromesso tra la quantità di tempo che può essere registrata e la risoluzione temporale, o frequenza di registrazione degli eventi. «La quantità totale di informazioni che può immagazzinare una cellula è fissa, ma in linea di principio possiamo rallentare o aumentare la velocità di crescita della catena», spiega
Impiegando queste proteine ingegnerizzate, gli scienziati possono registrare i passaggi che rivelano l’attivazione di determinati geni o la risposta delle cellule a un farmaco.

Linghu. «Se vogliamo registrare per un periodo più lungo – prosegue l’autore - possiamo rallentare la sintesi in modo che raggiunga le dimensioni della cellula entro, diciamo, due settimane. In questo modo potremmo registrare più a lungo, ma con una risoluzione temporale inferiore». Se la tecnica potesse essere estesa per funzionare su periodi più lunghi, concludono i ricercatori, potrebbe essere utilizzata anche per studiare processi come l’invecchiamento e la progressione delle malattie.
Il team sta anche lavorando per arrivare a registrare più tipi di eventi nella stessa catena, aumentando il numero di subunità diverse che possono essere incorporate.
I micronutrienti presenti nel cibo che consumiamo potrebbero migliorare la risposta ai farmaci e quindi la prognosi. La pubblicazione di Del Buono e D’Orta
Molti oncologi, alla domanda dei loro pazienti su cosa dovrebbero mangiare, non sempre hanno una risposta pronta e spesso si consiglia poco di tutto, senza entrare nello specifico: ma poco di cosa?
Taluni si preoccupano esclusivamente che non perdano peso, perché quando i tumori sono in stadio avanzato finiscono per consumare il corpo, soprattutto i muscoli. Nell’illusione che “mangiando muscoli” i pazienti possano conservarne i propri, molti ancora oggi, raccomandano di mangiare carne, o prescrivono integratori proteici, senza alcuna indicazione del rapporto EAA-aminoacidi ramificati/NEAA-non essenziali, al fine di migliorarne lo stato nutrizionale e la prognosi, rischiando comunque alla fine di peggiorare la situazione. Gli EAA non sono sintetizzabili in quantità sufficienti da parte dell’organismo, mentre i secondi lo sono a partire dagli stessi EAA, quando questi ultimi sono disponibili in sufficiente quantità nell’ambiente circostante. Una recente ricerca pubblicata su FEBS7, ha ipotizzato che alterare l’equilibrio tra EAA e NEAA possa influenzarne il destino di vita o morte delle cellule cancerose. Lo studio
del Professor Dioguardi e colleghi ha, in ultima analisi, per la prima volta offerto una nuova visione della biologia del cancro, dimostrando che la cellula tumorale si è evoluta per sopravvivere in un ambiente ricco in NEAA, ma questo potenziale punto di forza in realtà potrebbe diventare la sua principale debolezza.
Ulteriore target è inoltre modulare l’espressione delle citochine pro-infiammatorie, i fattori di crescita plasmatici, ed il PH della matrice extracellulare, per ostacolare la velocità di crescita e la metastatizzazione. D’altra parte, anche il tumore stesso può scatenare una risposta infiammatoria creando processi infiammatori e tumorali interconnessi.
Oggi, di fronte a un paziente oncologico, grazie ai grandi progressi della ricerca scientifica, il cancro si cura con sempre maggior successo e l’alimentazione ricopre il ruolo vitale e primario, anche nel caso d’insorgenza di una patologia importante come quella oncologica. Si tratta di un approccio innovativo ma, ormai consolidato, in cui la terapia “allarga i propri confini” comprendendo anche le indicazioni alimentari, la nutraceutica, genomica e metabolomica con l’obiettivo di difendere la qualità di vita del malato.
Un piano alimentare in oncologia viene elaborato dopo analisi bioimpedenziometrica, bilancio azotato, interpretazione di esami per la caratterizzazione dei processi biochimici, metabolici e infiammatori “metabolomica”. Il programma elaborato dovrà modulare l’espressione delle citochine pro-infiammatorie (“inflammaging”), modulare lo stato “catabolico” nutrizionale, scegliendo alimenti ricchi in micronutrienti che possano dialogare con il genoma.
Sempre più numerosi sono gli studi che confermano il ruolo dell’alimentazione nelle persone a cui è stato diagnosticato un cancro, e il programma varierà in funzione del protocollo chemio adottato (infusionale - orale); precisiamo inoltre che le raccomandazioni del WCRF e ACS, utili per la prevenzione, non possono essere sempre applicate a malattia conclamata, questo per il continuo adattamento delle diverse popolazioni cellulari che si selezionano nella massa neoplastica, sia per sfuggire al controllo immunologico, sia per mantenere attivi i geni per una crescita incontrollata. Da non confondere dunque la “prevenzione” dalla “malattia in atto”.
Per questo non esiste un programma standard, ma il lavoro del professionista sarà sempre la personalizzazione sul metaboloma e sulla composizione corporea. L’integrazione nutraceutica verrà disciplinata dal comportamento della malattia (stadio) e dalla valutazione dei metaboliti urinari (metaboloma), e soprattutto evitare di interferire con molecole vegetali il metabolismo dei chemioterapici e/o farmaci assunti (fast o small metabolizer) dal paziente, evitando l’interazione negativa sulla farmacocinetica e farmacodinamica, con molecole di sintesi vegetale. Prestiamo molta attenzione, dunque, alle interazioni metaboliche tra alimenti e integratori, perché esse possono bloccare l’azione di enzimi importanti per l’assorbimento e il metabolismo di alcuni farmaci, e in questo modo ridurne l’efficacia.
La sinergia della selezione degli alimenti, insieme alla loro distribuzione nel corso della giornata, influisce sul modo in cui il paziente può affrontare la malattia, contrastare gli effetti indesiderati della chemioterapia e non solo, favorire il metabolismo delle cellule sane e ostacolare la crescita delle cellule malate.

La pubblicazione completa è disponibile su questa pagina web: https://www.ddclinicfoundation.eu/l/nuova-pubblicazione-alimentazione-e-cancro-2-0/.

Oggi, di fronte a un paziente oncologico, grazie ai grandi progressi della ricerca scientifica, il cancro si cura con sempre maggior successo e l’alimentazione ricopre il ruolo vitale e primario, anche nel caso d’insorgenza di una patologia importante come quella oncologica.
Medico Chirurgo, MMG – Specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica. Perfezionato in Fisiopatologia e Allergologia Respiratoria. Esperto in Nutrigenomica e Farmacogenomica. già Professore a contratto Università Gugliemo Marconi. Master di II° liv. Oncologia Integrata. Presidente Fondazione DDClinic Research Institute. Docente 2020-2021, Corso di Perfezionamento, Università Federico II, Napoli. “La Nutrizione Ottimale: aspetti-teorico pratici”. Docenza Master di II Livello in “Medicina Integrata” A.A. 2022-2023. Università degli Studi Gugliemo Marconi Roma.


edico di Medicina Generale, Biologo Nutrizionista, Nutrizionista Oncologico, Specialista in Scienze dell’Alimentazione, Docente del corso di Perfezionamento “la Nutrizione Ottimale” presso l’Università “Federico II”, socio fondatore e vicepresidente della Fondazione Onlus “DD Clinic Research Institute”, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, si occupa di nutrizione clinica generale, nutraceutica e farmacogenomica nel malato oncologico, in ambito clinico e di ricerca. Esercita la libera professione presso la Fondazione “DD Clinic Research”.
Uno studio della Perelman School of Medicine - University of Pennsylvania spiega il ruolo del microbiota intestinale nella propensione all’esercizio fisico e gli effetti sulle prestazioni
Essere più o meno sportivi è una questione di pancia. Secondo uno studio condotto dai ricercatori della Perelman School of Medicine - University of Pennsylvania, mentre si svolge attività fisica, viene voglia di farne ancora di più perché alcuni me-taboliti prodotti da specifici batteri stimolano i nervi dell’intestino collegati al cervel-lo, attivando così l’area cerebrale della motivazione che produce dopamina.
La scoperta, resa nota grazie alla pubblicazione sulla prestigiosa rivista “Nature”, è frutto di una sperimentazione su circa 200 topi non addestrati all’esercizio fisico e che correvano volontariamente su ruote o tapis roulant.
Gli studiosi hanno osservato come alle differenze nella composizione della flora batterica intestinale corrispondevano performance differenti nella corsa.
I ricercatori hanno individuato due specie batteriche strettamente legate a presta-zioni sportive migliori, Eubacterium rectale e Coprococcus eutactus, produttrici di metaboliti noti come ammidi di acidi grassi che stimolano i recettori endocannabi-noidi CB1 sui nervi sensoriali dell’intestino collegati al cervello attraverso la colonna vertebrale. La stimolazione di questi nervi, a sua volta,
provoca un aumento dei li-velli del neurotrasmettitore dopamina in una regione del cervello chiamata striato ventrale.
I ricercatori hanno ipotizzato che un maggiore rilascio di dopamina in quest’area ce-rebrale durante l’esercizio aumenti le prestazioni, rafforzando il desiderio di spen-dere sempre più energie.
Ma quanto effettivamente il microbiota intestinale incide sull’attività sportiva? Per rispondere a questo interrogativo, l’équipe statunitense ha condotto esperimenti ri-ducendo o incrementando i microrganismi presenti nell’apparato digerente dei topi. Dai risultati è emerso che le prestazioni fisiche degli animali trattati con antibiotici ad ampio spettro, e quindi con pochi microrganismi, erano dimezzate.
A questo punto, l’indagine dei ricercatori si è concentrata sull’individuazione dei componenti del microbiota coinvolti nelle prestazioni fisiche, obiettivo che ha porta-to il team a ridurre lo spettro delle combinazioni di antibiotici somministrati. Tutti, esclusa la neomicina, producevano un effetto negativo sulla corsa.
Attraverso il sequenziamento genico mirato sui batteri, gli scienziati hanno asse-gnato un ruolo di primo piano alle famiglie Erysipelotrichaceae e Lachnospiraceae e, per
fare luce sul loro coinvolgimento nella spinta motivazionale a praticare attivi-tà sportiva, hanno analizzato l’area cerebrale dove risiedono i neuroni che espri-mono i recettori della dopamina, neurotrasmettitore che controlla il movimento e la ricompensa.
Questi batteri producono piccole molecole, note come ammidi di acidi grassi, che stimolano i recettori sui nervi nell’intestino collegati direttamente lungo la colonna vertebrale al cervello, dove influenzano la motivazione aumentando il ri-lascio del neurotrasmettitore dopamina.
Quest’ultima, a sua volta, aumenta e raf-forza la voglia di muoversi. In assenza del microbiota, invece, mancano i metaboliti, i livelli di ammino ossidasi sono elevati e la dopamina viene degradata più veloce-mente con conseguenze negative sulle prestazioni fisiche.

Questo studio avvalora ancora una volta la definizione di secondo cervello data all’intestino e dimostra quanto il benessere psicofisico sia strettamente legato alla salute intestinale.
Sempre riguardo il rapporto tra sport e microbiota intestinale, secondo uno studio pubblicato da “Oxidative Medicine and Cellular Longevity”, l’esercizio fisico eserci-terebbe un’azione tesa a modificare la produzione di acido lattico nel lume intesti-nale e ciò potrebbe alimentare alcune specie batteriche amiche dell’uomo.
Inoltre, il miglioramento del flusso sanguigno dovuto all’attività sportiva nutre di più l’intestino, aiutando così a tenere alti il tono dell’umore e la qualità del sistema ner-voso e gestire efficacemente stress, ansia e sonno che rappresentano tutti poten-ziali minacce per il microbiota.

Imedici ricordano ogni volta che ne hanno occasione l’importanza per l’organismo di una buona idratazione. Si potrebbe scrivere un libro sui benefici portati in dote alla salute generale da una corretta idratazione. Ma il nuovo studio pubblicato su “eBioMedicine” di “Lancet” si è spinto oltre. Bere sarebbe infatti il segreto non soltanto per invecchiare bene e in salute, ma anche per ridurre il rischio di morte precoce. Secondo gli autori della ricerca, gli studiosi del National Institutes of Health USA, le persone adulte che si idratano poco e male sarebbero esposte negli anni a un rischio più elevato di contrarre diverse malattie, ad esempio quelle cardiache. Una scoperta allarmante se si considera che a non rispettare la dose d’acqua raccomandata giornalmente, fissata ad almeno sei bicchieri (un litro e mezzo), sarebbero circa la metà delle persone nel mondo.
Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno utilizzato i dati sanitari raccolti nell’arco di 30 anni su 11.255 adulti, mettendo sotto la lente di ingrandimento i legami tra i vari indicatori di salute e i livelli di sodio nel sangue: questi ultimi aumentano quando l’assunzione di liquidi si riduce. A partire da questa osservazione, gli esperti hanno osservato come gli adulti con elevati livelli di sodio non solo avevano maggiori probabilità di morire più giovani, ma anche più possibilità di mostrare i segni dell’invecchiamento avanzato e di sviluppare condizioni croniche rispetto a quanti presentavano livelli di sodio nella media. Mettendo a confronto le informazioni che i partecipanti avevano condiviso durante cinque visite mediche, i ricercatori hanno stabilito il collegamento tra invecchiamento biologico e livelli di sodio mediante 15 marcatori di salute; tra questi erano inclusi colesterolo, glicemia, pressione sanguigna, indici in grado di fornire informazioni sul funzionamento del sistema cardiovascolare, metabolico, renale, respiratorio e immunitario di ogni individuo.
Questa analisi ha consentito agli scienziati di osservare come gli adulti con livelli di sodio più alti nel sangue presentassero non soltanto un incremento pari al 21% rispetto al rischio di morte prematura rispetto a coloro i quali avevano il sodio nella norma, ma anche un rischio dal 15 al 50% più elevato di presentare un’età biologica più avanzata rispetto a quella attestata dalla carta di identità. A ciò si aggiunga il fatto che gli adulti appartenenti a quest’ultima categoria corrono un rischio maggiore del 64% di incorrere
in malattie croniche quali la fibrillazione atriale, l’insufficienza cardiaca, l’ictus, le malattie delle arterie periferiche, le malattie polmonari croniche, demenza e diabete. Al contrario, coloro che potevano vantare livelli di sodio nel sangue più bassi presentavano un rischio minore di contrarre malattie croniche.

Gli adulti con livelli di sodio più alti nel sangue presentassero non soltanto un incremento pari al 21% rispetto al rischio di morte prematura rispetto a coloro i quali avevano il sodio nella norma, ma anche un rischio dal 15 al 50% più elevato di presentare un’età biologica più avanzata rispetto a quella attestata dalla carta di identità. A ciò si aggiunga il fatto che gli adulti appartenenti a quest’ultima categoria corrono un rischio maggiore del 64% di incorrere in malattie croniche quali la fibrillazione atriale, l’insufficienza cardiaca, l’ictus, le malattie delle arterie periferiche, le malattie polmonari croniche, demenza e diabete.
Natalia Dmitrieva, prima autrice dello studio, ha confermato: «I risultati suggeriscono che una corretta idratazione può rallentare l’invecchiamento e prolungare la vita senza malattie. A livello globale, questo può avere un grande impatto. La diminuzione del contenuto di acqua corporea è il fattore più comune che aumenta il sodio sierico, motivo per cui i risultati suggeriscono che rimanere ben idratati può rallentare il processo di invecchiamento e prevenire o ritardare le malattie croniche». C’è però una precisazione da fare: la ricerca non dimostra che bere più acqua ridurrà necessariamente l’invecchiamento, una tale determinazione richiederebbe infatti lo svolgimento di ulteriori studi. A ribadirlo è stato il dottor Lawrence Appel, direttore del Welch Center for Prevention, Epidemiology and Clinical Research presso la Johns Hopkins University, sottolineando come la relazione tra bere liquidi e malattie croniche legate all’età rimane ad oggi «altamente speculativa» e ribadendo come lo studio del National Institutes of Health «non dimostra che bere più acqua previene le malattie croniche». Allo stesso modo Asher Rosinger, direttore del Water, Health and Nutrition Lab del Penn State College of Health and Human Development, ha affermato che la disidratazione cronica ha più probabilità di accelerare il processo di invecchiamento di quanto una buona idratazione possa contribuire a rallentarlo. Una corretta idratazione, ha affermato, «assicura che i reni funzionino correttamente e che il corpo non sia sottoposto a un ulteriore stress fisiologico».
Le persone con livelli più elevati di sodio nel sangue hanno maggiori probabilità «di essere biologicamente più vecchie, sviluppare malattie croniche e morire in giovane età», affermano gli autori, aggiungendo che la disidratazione è uno dei maggiori fattori che aumenta tali livelli. A detta dei ricercatori, l’intervallo ottimale di sodio sierico per il minor rischio di malattie croniche e/o mortalità prematura è compreso tra 138 e 142 millimoli. Le persone con un livello di 142 o superiore, ha suggerito «trarrebbero beneficio dalla valutazione della loro assunzione di liquidi», ha concluso Dmitrieva.

Lo studio degli esperti americani: una buona idratazione è uno scudo anche contro il rischio di morte precoce di Domenico Esposito

Èdurante il sonno che la memoria motoria si consolida. Un processo che diventa possibile passando al vaglio le sperimentazioni e gli errori, e “cestinando” le azioni che il cervello ha ritenuto non buone. Anche per questo motivo il sonno è importante, perché dormendo ci si concentra sui fallimenti per portare avanti i pattern che invece sono stati di successo. Il procedimento coinvolge complesse connessioni fra diverse parti del cervello e avviene durante il sonno che dà più ristoro, ovvero nella fase non-Rem. Ad arrivare a queste conclusioni sono stati i ricercatori di un team dell’Università della California di San Francisco, che ha realizzato una ricerca i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Nature”.
Per condurre la loro analisi, gli esperti hanno esaminato da vicino animali da laboratorio che svolgevano un determinato compito per raggiungere il cibo. Passando al vaglio la loro attività cerebrale, i ricercatori hanno potuto osservare come la loro attività cerebrale coinvolga tre regioni durante il sonno non-Rem: l’ippocampo, la regione responsabile di memoria e navigazione, la corteccia motoria e la corteccia prefrontale. In un periodo di osservazione durato 13 giorni, ad emergere è stato uno schema ben definito. Anzitutto, nel processo noto come apprendimento veloce, la corteccia prefrontale si coordina con l’ippocampo, probabilmente permettendo all’animale di percepire il suo movimento rispetto allo spazio che lo circonda. A seguire interviene poi un processo definito apprendimento lento, in cui la corteccia prefrontale sembra giudicare le azioni compiute sulla base della ricompensa ottenuta da un’azione che ha portato a registrare un successo. Questa fase si esegue di pari passo con corteccia motoria e ippocampo, e conduce allo spegnimento dei segnali associati ai fallimenti e all’accensione di quelli correlati al successo.
Infine, poiché le attività elettriche delle regioni diventano sincronizzate, il ruolo dell’ippocampo si riduce e le azioni giudicate di successo vengono registrate entrando a far parte della memoria motoria. All’inizio, infatti, quando gli animali apprendevano l’azione, i segnali erano disturbati; man mano che però apprendevano le azioni che portavano al raggiungimento
del cibo con successo, i ricercatori hanno rilevato una sincronizzazione dei segnali fino a che gli animali non hanno avuto tassi di successo del 70%. Dopo quel punto, il cervello sembra ignorare gli errori e mantiene la memoria motoria. In altre parole, il cervello inizia ad aspettarsi un certo livello di errore e non aggiorna la memoria motoria. L’esempio utilizzato dagli studiosi per spiegare il meccanismo ai profani è quello di Stephen Curry, stella della pallacanestro in forza alla franchigia NBA dei Golden State Warriors, famoso per la precisione al tiro. Ebbene, quando Curry effettua un tiro libero, il suo cervello attinge alla memoria motoria. Questa si consolida nel sonno, ma non significa che agli atleti - anche ai migliori come Curry - basti dormire a lungo e bene per evitare di commettere errori. Karunesh Ganguly, professore di neurologia e membro dell’UCSF Weill Institute for Neurosciences, tra gli autori dello studio, ha spiegato: «Anche gli atleti d’élite commettono errori, e questo è ciò che rende il gioco interessante. La memoria motoria non riguarda prestazioni perfette. Si tratta di errori prevedibili e successi prevedibili. Finché gli


errori sono stabili di giorno in giorno, il cervello dice: “Blocchiamo questo ricordo”». Ciò significa riordinare tutti i tiri liberi che Curry abbia mai lanciato, eliminando il ricordo di tutte le azioni tranne quelle che hanno colpito nel segno o che il cervello ha deciso che erano abbastanza buone.
Ma cosa accade in presenza di un imprevisto? Restando nel campo del basket esso può essere rappresentato da un infortunio: l’ipotesi è allora che Curry si sia fatto male a un dito e abbia dovuto imparare a tirare a canestro in modo leggermente diverso. Lo studio offre anche in questo caso una risposta, che il professor Ganguly sintetizza in questo modo: «È possibile disimparare un compito, ma per farlo devi stressare la situazione fino al punto in cui stai commettendo errori». Quando i ricercatori hanno apportato una leggera modifica alle indicazioni impartite ai topi, questi hanno commesso più errori ed è stato osservato più rumore nell’attività cerebrale dei ratti. Il cambiamento era abbastanza piccolo da evitare che i ratti dovessero ricominciare il loro apprendimento, ma tale che fossero spinti verso il punto di rottura e costretti ad imparare il nuovo compito. Ma poiché la memoria motoria si radica come un insieme di movimenti che si susseguono nel tempo, ha detto Ganguly, cambiare la memoria motoria in un movimento complesso come il tiro libero di un pallone da basket potrebbe richiedere la modifica di un movimento utilizzato per avviare l’intera sequenza. Dunque, se Curry di solito fa rimbalzare un pallone da basket due volte prima di tirarlo, Ganguly ha detto: «Potrebbe essere meglio riprogrammare il cervello facendolo rimbalzare solo una o tre volte. In questo modo, inizieresti con una tabula rasa». Per quanto possa apparire riduttivo rispetto ad uno studio così articolato, il lavoro dei ricercatori del team dell’Università della California di San Francisco sembra confermare di fatto un vecchio adagio che i nostri nonni e i nostri genitori ci hanno tramandato, per consolarci dopo un passo falso. È il seguente: sbagliando si impara. A questo punto anche dormendo. (D. E.).
Ok del ministero della Salute ai primi test del fattore di crescita delle cellule nervose. Le prossime sfide? Comprendere come si sviluppa cervello e coscienza
tagliato dopo che nel 2017 l’Ngf era diventata la base di un collirio per curare le ulcere della cornea, anche dette dermatiti neurotrofiche.
Il primo test prevede la somministrazione della molecola per via nasale. Il secondo (di fase 1), che potrebbe essere avviato fra alcune settimane, è rivolto invece alla terapia di alcune malattie neurodegenerative della retina. Come ha sottolineato il presidente della Fondazione Ebri, ad aprirsi sono prospettive interessanti anche per gli effetti dell’Ngf su alcune cellule del sistema immunitario: «Negli ultimi dieci anni lo hanno dimostrato in modo molto preciso molte ricerche, condotte anche all’Ebri», l’Istituto europeo per le ricerche sul cervello fondato dalla stessa Rita Levi Montalcini. «Si è scoperto, per esempio, che fra le cellule bersaglio dell’Ngf vi sono quelle della microglia, che svolgono un ruolo protettivo e anti-infiammatorio», ha aggiunto Cattaneo, rimarcando come questo risultato prometta di essere importante per la terapia dell’Alzheimer poiché l’Ngf potrebbe fornire una protezione alle cellule nervose colpite dalla malattia.
Il ministero della Salute ha dato il via libera ai primi test del cosiddetto “Ngf senza dolore” - fattore di crescita delle cellule nervose (Nerve Growth Factor) scoperto dal Premio Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini l’11 giugno 1951 - modificato in maniera tale che non stimoli i nervi associati alla percezione del dolore. I test, che potrebbero scattare fra alcuni mesi, a detta del presidente della Fondazione Ebri, Antonino Cattaneo - tra i collaboratori più stretti della scienziata torinese - rappresentano una delle nuove
strade per la terapia della malattia di Alzheimer, patologia neurodegenerativa che si stima colpisca 500mila persone in Italia.
Facendo il punto sugli ultimi risultati emersi dagli studi aperti di Rita Levi Montalcini, a dieci anni dalla sua morte, Cattaneo ha espresso tutta la sua soddisfazione, dichiarando di immaginare la sua mentore sorridente nel pensare alla sua molecola diventata un farmaco. Quella che la stessa Rita Levi Montalcini aveva definito “la molecola meravigliosa” sarà infatti presto oggetto di due sperimentazioni: un nuovo traguardo
Ma quali saranno le prossime sfide da vincere per i ricercatori? L’obiettivo sarà comprendere come si sviluppa il cervello e che cosa sia la coscienza. Nel primo caso un grande aiuto potrà giungere dall’utilizzo di cervelli in miniatura coltivati in laboratorio, i cosiddetti organoidi. Per la seconda sfida si intende invece combinare tecniche come elettroencefalogramma e stimolazione magnetica transcranica, così da riuscire a rilevare i segnali caratteristici della coscienza in chi dorme, è in stato vegetativo o in coma. Esplorare la coscienza, per dirla ancora una volta le parole del collaboratore di Rita Levi Montalcini, significa del resto avventurarsi in un tipo di ricerca «che tocca la natura stessa dell’uomo e della mente». (D. E.).

Utilizzare i social media?
Rimedio da tenere in considerazione per scacciare la noia, ma a patto di conoscere le conseguenze del suo impiego: tra queste, il rischio di bloccare la creatività e la possibilità di scoprire nuove passioni, visto il tempo e le energie che richiede. A dirlo è un nuovo studio condotto dai ricercatori del Trinity College di Dublino, sotto la guida di Stephen Murphy, i cui risultati sono stati pubblicati sulle pagine della rivista specializzata “Marketing Theory”.
Sotto la lente di ingrandimento degli esperti sono finite 15 persone in Gran Bretagna e Irlanda, esaminate fra il 2020 e il 2021, dunque nel pieno della pandemia di Covid-19. Analizzando a fondo le abitudini del campione, il team di ricerca ha potuto osservare che durante i lockdown, ovvero con la sospensione delle attività lavorative e la solitudine forzata, molte persone hanno sperimentato i due livelli della noia identificata tempo addietro dal filosofo tedesco Martin Heidegger: la noia superficiale e la noia profonda. Nel primo caso, spiegano i ricercatori, si ha a che fare con il tipo di noia più comune, quello stato di irrequietezza che porta a cercare distrazioni temporanee dalla vita di ogni giorno; e in questo ambito i social network giocano un ruolo preponderante. Quando si parla di noia profonda, invece, ci si riferisce all’abbondanza di tempo ininterrotto trascorso in relativa solitudine: è in questo caso che, a detta di Heidegger, la noia potrebbe spalancare la strada a pensieri e attività più creativi.
Timothy Hill, dell’Università britannica di Bath, ha spiegato: «La noia può sembrare un concetto estremamente negativo ma, in realtà, può essere molto positivo se alle persone viene data la possibilità di pensare senza distrazioni. Il problema che abbiamo osservato è che i social media possono alleviare la noia

Uno studio del Trinity College di Dublino ha scoperto che l’utilizzo dei social è sì utile per combattere la noia superficiale, ma a lungo andare preclude delle possibilità
superficiale, ma la distrazione assorbe tempo ed energia e può impedire alle persone di progredire verso uno stato di noia profonda, nel quale potrebbero scoprire nuove passioni». Emblematico è ancora una volta il caso dei lockdown, dove milioni di persone, costrette in una situazione di chiusura e preda della noia, hanno trovato il tempo e la spinta a cimentarsi in nuove attività: dal giardinaggio alla cucina, dalla pittura al bricolage, solo per citarne alcune. Ne deriva che, per quanto terribili fossero, i lockdown hanno fornito le condizioni “ideali” per una profon -
da noia, hanno affermato gli autori dello studio, che alla fine ha spinto molti a scoprire nuove passioni. Hill, coautore dello studio, ha concluso: «Questa ricerca ci ha dato una finestra per capire come la cultura e i dispositivi sempre attivi, 24 ore su 24, sette giorni su sette che promettono un’abbondanza di informazioni e intrattenimento possano risolvere la nostra noia superficiale, ma in realtà ci impediscono di trovare cose più significative. Coloro che si impegnano in “disintossicazioni digitali” potrebbero essere sulla strada giusta». (D. E.).
Il lavoro è stato realizzato dagli studiosi del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles
Negli ultimi anni sono aumentate notevolmente le campagne di sensibilizzazione sull’endometriosi: iniziative ministeriali, associazioni e perfino influencer hanno contribuito a consapevolizzare le persone di una malattia che colpisce circa il 10% delle donne di tutto il mondo. Purtroppo, anche a causa dei pochi fondi a disposizione della ricerca, molti aspetti della malattia (come le cause) sono ancora sconosciuti per medici e scienziati.
Ciò che finora si sa con certezza è che l’endometriosi è una malattia dell’età fertile, che non si verifica prima
della comparsa delle prime mestruazioni. Essa può essere definita come un’infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico, causata dalla presenza anomala in questi organi di un tessuto simile all’endometrio (il rivestimento dell’utero). Seguendo il ciclo ormonale, il tessuto endometriale “alieno” si ispessisce, si rompe e sanguina.

Il sangue del tessuto, trovandosi in una zona altra dove non può fuoriuscire, rimane bloccato in alcuni distretti generando dolori, infiammazioni, cisti o altre forme di complicazioni, anche legate alle ovaie stesse. Per una serie di
ragioni, tra cui dei sintomi aspecifici, ci vogliono in media dai 7 agli 8 anni per diagnosticare l’endometriosi e le cause esatte, come accennato, sono tuttora sconosciute. Ad oggi non esiste infatti una cura vera e proprio, ma trattamenti finalizzati esclusivamente ad un alleviamento dei sintomi, che consistono perfino, ove necessario, in interventi chirurgici di rimozione (di cisti e aderenze, ma nei casi più gravi anche delle ovaie o dell’utero).
Un passo in avanti nella lotta alla malattia è stato però fatto dagli studiosi del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, che hanno realizzato un “atlante cellulare” dove sono stati raccolti i diversi tipi di cellule coinvolti nell’endometriosi. Questo database di informazioni costituisce una base di lavoro preziosa già nell’immediato per la comprensione della patologia. Uno dei motivi per cui le cause di questa malattia sono quasi sconosciute è infatti legato alla scarsità di dati cellulari raccolti finora. Lo studio in questione, pubblicato sulla rivista Nature Genetics, spiega come gli scienziati siano riusciti a mappare e profilare i diversi tipi di cellule coinvolte nella malattia attraverso l’analisi di più di 400mila cellule prese dal tessuto pelvico di 21 donne (tra le quali solo alcune soffrivano di endometriosi).
Il team californiano ha quindi successivamente riscontrato delle differenze molecolari tra i principali sottotipi di endometriosi, evidenziando come le cellule della malattia peritoneale (che colpisce la cavità addominale) si differenzino, per esempio, da quelle dell’endometrioma ovarico. Un contributo fondamentale per il raggiungimento di tali risultati è stato fornito dai modelli di sequenziamento di nuova generazione e da altre nuove tecnologie sviluppate nell’ambito della genomica. Questa nuova mappa genetica si prospetta come una risorsa fondamentale per la comprensione delle cause della malattia, nonché per lo sviluppo di trattamenti efficienti ed efficaci per i pazienti affetti. (M. O.).
Scarica il Giornale dei Biologi
dall’area riservata MyONB
Ogni mese riceverai crediti Ecm in autoformazione e Fad

Èiniziato il nuovo anno e un buon caffè è quanto serve per partire con energia. La pensano così anche i capelli, in quanto la caffeina risulta essere un ottimo ingrediente nei trattamenti tricologici. Numerosi studi scientifici internazionali sull’argomento suggeriscono che la caffeina, insieme ad altri estratti naturali, potrebbe essere molto utile come ingrediente nel trattamento delle principali problematiche tricologiche fra cui l’abbondante caduta e l’alopecia androgenetica (AGA), quest’ultima nota come la principale causa di diradamento sia maschile che femminile. La caffeina (nome chimico 1,3,7 – trimetilxantina), nota anche come teina, è un alcaloide vegetale presente in frutti, semi e foglie di diversi tipi di piante quali caffè, tè, guaranà e mate. La sua azione a livello del cuoio capelluto è conosciuta per migliorare l’apporto sanguigno locale e con esso il sopraggiungere di ossigeno e micronutrienti ai follicoli piliferi.

Alcuni studi, come quelli condotti dal Dr. Tobias Fischer, hanno dimostrato ulteriori proprietà della caffeina a livello tricologico, come la capacità di accelerare il ciclo di crescita dei capelli aumentandone di conseguenza la velocità di allungamento.
Nello studio in questione, un team di ricercatori ha voluto testare in vitro la reazione dei follicoli alterati: lo staff ha applicato piccole concentrazioni di caffeina sui follicoli in coltura, precedentemente estratti dal cuoio capel-
luto di uomini e donne affetti da AGA, e ne ha documentato le reazioni. La ricerca ha dimostrato che la caffeina comportava una significativa stimolazione della crescita del follicolo pilifero in vitro. Lo studio in vitro ha così documentato che la caffeina ha migliorato l’allungamento del fusto del capello, la proliferazione dei cheratinociti e ha prolungato il tempo in cui il follicolo rimane nella fase di crescita (anagen). Proprio sull’allungamento della fase dell’anagen, fondamentale per aumentare la durata dei capelli, recenti evidenze suggeriscono che l’adenosina ciclica monofosfato (cAMP) potrebbe essere coinvolta nella regolazione della proliferazione e differenziazione cellulare e quindi sull’aumento della durata della fase vitale del capello. Da tempo è noto che le xantine e quindi anche la caffeina, sono capaci di inibire la fosfodiesterasi, enzima che catalizza la conversione dell’cAMP in AMP (inattivo). L’inibizione della fosfodiesterasi da parte della caffeina comporta un accumulo intracellulare di cAMP, non per una sua aumentata produzione, ma per un prolungamento dell’emivita da inibita degradazione. Queste premesse hanno indirizzato diversi ricercatori verso l’utilizzo topico delle xantine nel defluvio androgenetico a concentrazioni variabili dallo 0,2 al 2% nel tentativo di allungare la fase anagen. I risultati di questo tipo di approccio terapeutico, controllati con il tricogramma, sono stati decisamente interessanti e pertanto, considerata anche la loro assoluta innocuità, si può concludere che le xantine, in particolare la caffeina e la teofillina, potrebbero essere utilizzate come preparati topici di routine nel trattamento precoce della calvizie
La caffeina (nome chimico 1,3,7 – trimetilxantina), nota anche come teina, è un alcaloide vegetale presente in frutti, semi e foglie di diversi tipi di piante quali caffè, tè, guaranà e mate. La sua azione a livello del cuoio capelluto è conosciuta per migliorare l’apporto sanguigno locale e con esso il sopraggiungere di ossigeno e micronutrienti ai follicoli piliferi.
comune. La caffeina inoltre, possiede un’elevata attività biologica ed è capace di penetrare nella barriera cutanea agendo in profondità, ecco perché il suo utilizzo è ottimale nel preparato ad uso topico. Studi in vitro hanno evidenziato infine, che la caffeina per via topica svolge anche un’azione protettiva contro i raggi UVR che influiscono sull’omeostasi del follicolo pilifero. In uno studio clinico, la cute del cuoio capelluto umano è stata irradiata per via transepidermica utilizzando UVA e UVB; in seguito è stato applicato lo 0,1% di caffeina (5,15 mM) per via topica per 3 giorni prima dell’esposizione ai raggi UV e per 3 giorni dopo. Gli effetti della tossicità e della vitalità sono stati misurati in compartimenti cutanei e follicoli piliferi definiti. I risultati mostrano che la caffeina ha fornito protezione contro la citotossicità e la distrofia del follicolo pilifero mediata da UVR, l’apoptosi dei cheratinociti e la modulazione negativa del fattore di crescita promotore del catagen. In conclusione questo studio in vivo di irradiazione UV del cuoio capelluto fornisce la prima prova che la radiazione UV transepidermica influisce negativamente su importanti funzioni del follicolo pilifero, suggerendo che integrare la caffeina nei trattamenti topici e cosmetici può fungere da fotoprotettore dei follicoli piliferi. Possiamo concludere che l’utilizzo della caffeina per uso topico nei trattamenti tricologici è utile per aumentare la velocità di allungamento, avere potenti proprietà antiossidanti, protegge le cellule dai raggi UV e rallenta il processo di foto-invecchiamento della pelle, oltre a sostenere la fase di ricrescita nei periodi di maggiore caduta e debolezza.
Insieme ad altri estratti naturali, potrebbe essere utile nel trattamento delle principali problematiche tricologiche
di Biancamaria Mancini- Völker JM, Koch N, Becker M, Klenk A. “Caffeine and Its Pharmacological Benefits in the Management of Androgenetic Alopecia: A Review”. Skin Pharmacol Physiol. 2020;33(3):93-109.
- T.W. Fischer et al. “Differential effects of caffeine on hair shaft elongation, matrix and outer root sheath keratinocyte proliferation, and transforming growth factor‐2/insulin‐like growth factor‐1‐mediated regulation of the hair cycle in male and female human hair follicles in vitro.” British Journal of Dermatology 171.5 (2014): 1031-1043.

- Gherardini J et al.:“UV Radiation On Scalp Skin Surface Induces Scalp Hair Follicle Damage Ex Vivo” And Is Alleviated By The Topical Treatment With Caffeine. Int J Cosmet Sci. 2019 Feb 11.


Tratto da “Cosmeceutical value of herbal extracts as natural ingredients and novel technologies in anti-aging”, di Siavash Hosseinpour Chermahini, Fadzilah Adibah Abdul Majid and Mohamad Roji Sarmidi, University Teknologi Malaysia
di Carla Cimmino
Aumenta sempre più la richiesta di prodotti naturali cosmeceutici a base di erbe, ritenendo che il loro utilizzo possa essere più sicuro e si possano ridurre gli effetti collaterali. Si va dalle lozioni per il corpo agli impacchi per il viso, dai detergenti per la pelle alle creme antietà. L’industria cosmeceutica sta subendo una rivoluzione, assecondando le preferenze dei consumatori verso i prodotti naturali, trasformando la produzione.

“I cosmetici sono prodotti disponibili in commercio che vengono utilizzati per migliorare l’aspetto della pelle” (Mary e Lupo, 2001). Le aspettative dei consumatori di cosmetici e le loro esigenze sono sofisticate e attente alle evoluzioni e alle mode, questi infatti sono continuamente alla ricerca di prodotti sicuri che siano un beneficio per la loro pelle. La pelle è l’organo più esteso del nostro organismo, la principale barriera ai dannosi radicali liberi, causati da luce ultravioletta e inquinanti ambientali. Lo stress ossidativo può danneggiare lipidi, proteine, enzimi, carboidrati e DNA nelle cellule e nei tessuti, provocando danni alla membrana, frammentazione di molecole come DNA, enzimi e proteine strutturali e persino portare alla morte cellulare indotta proprio dalla frammentazione

del DNA e dalla perossidazione lipidica (Beckmann e Ames, 1998). Queste conseguenze dello stress ossidativo costituiscono le basi molecolari nello sviluppo del cancro, delle malattie neurodegenerative, delle malattie cardiovascolari, del diabete e delle malattie autoimmuni.
Si pensa che l’uso topico di vitamine (A, B, C, E, K) e di antiossidanti nei cosmetici possa proteggere meglio e ridurre al minimo i radicali liberi, oltre a indurre stimolazione della produzione di collagene, raffinamento della cheratinizzazione o effetti antinfiammatori. Le aspettative di vivere più a lungo una vita sana e attiva hanno modificato gli atteggiamenti nei confronti della salute, della bellezza e dell’invecchiamento.
La pelle è l’organo più esteso del nostro organismo, la principale barriera ai dannosi radicali liberi, causati da luce ultravioletta e inquinanti ambientali. Lo stress ossidativo può danneggiare lipidi, proteine, enzimi, carboidrati e DNA nelle cellule e nei tessuti, provocando danni alla membrana, frammentazione di molecole come DNA, enzimi e proteine strutturali e persino portare alla morte cellulare indotta proprio dalla frammentazione del DNA e dalla perossidazione lipidica. Queste conseguenze dello stress ossidativo costituiscono le basi molecolari nello sviluppo del cancro, delle malattie neurodegenerative, delle malattie cardiovascolari, del diabete e delle malattie autoimmuni.
I cosmeceutici sono i più affermati nella maggior parte dei mercati, ricordiamo il riduttore di rughe StriVectin S-D1 (originariamente un prodotto farmaceutico per combattere le smagliature) e tanti marchi per la cura della pelle ‘’Doctor’’ o ‘’Professional’’ – come Murad1, Perricone MD Cosmeceuticals1 e DDF1. L’ articolo di maggio 2008 di Cosmetics Design cita, nella ricerca di Kline and Company, che la cura della pelle è un business globale da 5,9 miliardi di dollari e la sua crescita sta superando il mercato sia negli Stati Uniti che in Europa. I nutraceutici: cibi e bevande inclusi gli omega-3 e i probiotici (batteri vivi che offrono benefici per la salute), a lungo prevalenti in Giappone, stanno aumentando di popolarità (Malik et al., 2008).
La crescente attenzione alla cura della pelle e a prodotti antietà è dovuta anche all’introduzione di trattamenti biologici avanzati e al crescente utilizzo di nanotecnologie che promuovono la giovinezza, fattori di crescita e terapie ormonali sostitutive. L’uso della genomica sta diventando il punto cruciale tra le grandi aziende di bellezza, i prodotti antietà tra poco inizino ad affrontare l’invecchiamento ai livelli biologici più basilari. Così come anche gli strumenti diagnostici stanno diventando più sofisticati, infatti i ricercatori di personalizzano prodotti e trattamenti in base alla pelle e persino al genotipo di un individuo, tutti ciò per assecondare le aspettative dei consumatori, che iniziano a cercare trattamenti e efficaci, veloci e pratici.
Gli estratti vegetali da foglie, frutti, fiori, steli, cortecce, gemme e radici sono noti nelle applicazioni cosmetiche e farmaceutiche fin
Con la crescita dell’uso di ingredienti avanzati nella cura della pelle, c’è una tendenza che rifiuta le sostanze chimiche sintetiche nei prodotti di bellezza, e la nella costante richiesta di prodotti naturali/biologici, che spesso evitano ingredienti come parabeni e altri conservanti sintetici, ftalati (solventi spesso usati nelle fragranze), siliconi, derivati petrolchimici (come l’olio minerale), solfati (come il sodio laury/laureth sulfate) e filtri solari chimici (Goliath, 2009).
Molti prodotti cosmetici hanno rivendicato funzioni biologiche come antirughe, antietà, antiacne, depigmentazione, ecc.
Per avere un effetto reale sulla pelle, gli ingredienti biologicamente attivi devono essere assorbiti dalla pelle.
dall’antichità. Utilizzati come idratanti, sbiancanti, abbronzanti, cosmetici colorati, creme solari, antiradicali, antiossidanti, immunostimolanti, lavaggi, conservanti, addensanti ecc.
Con la crescita dell’uso di ingredienti avanzati nella cura della pelle, c’è una tendenza che rifiuta le sostanze chimiche sintetiche nei prodotti di bellezza, e la nella costante richiesta di prodotti naturali/biologici, che spesso evitano ingredienti come parabeni e altri conservanti sintetici, ftalati (solventi spesso usati nelle fragranze), siliconi, derivati petrolchimici (come l’olio minerale), solfati (come il sodio laury/laureth sulfate) e filtri solari chimici (Goliath, 2009).
Molti prodotti cosmetici hanno rivendicato funzioni biologiche come antirughe, antietà, antiacne, depigmentazione, ecc. Per avere un effetto reale sulla pelle, gli ingredienti biologicamente attivi devono essere assorbiti dalla pelle. Per questo motivo, la somministrazione topica di principi attivi ha un notevole interesse nella scienza cosmetica (Zatz, 2000; Wiechers, 2000).

La domanda dei consumatori è ritardare e prevenire i segni dell’invecchiamento cutaneo, lo strato corneo della pelle è un’ottima barriera all’applicazione esterna ed è necessario impiegare veicoli appropriati per aumentare la permeazione cutanea dei principi attivi. L’uso dei fosfolipidi per aumentare la permeazione cutanea è stato oggetto di molti studi, i fosfolipidi che vengono usati in forma solubilizzata per penetrare, mostrano l’evidente riduzione dell’irritazione cutanea, rispetto a quello dei tipici stimolatori della penetrazione (Sasaki et al., 1990; Ghosh et al., 1997).
La società di ricerca e sviluppo cosmetico è sempre alla ricerca di nuovi ingredienti vegetali innovativi per l’applicazione cosmetica. I più affermati sono gli ingredienti sintetizzati o estratti da microrganismi come batteri, lieviti o alghe, inclusi polisaccaridi, pigmenti, amminoacidi, peptidi o proteine. Solo pochi processi in vitro, basati su colture di cellule vegetali, sono già affermati nell’industria cosmetica. Esempi di tali prodotti disponibili in commercio sono Shikonine come pigmento cosmetico (Fujita e Tabata, 1986; Payne et al., 1991) (prodotto da Lithospermum erythrorhizon da Mitsui Petrochemical Industries, Giappone), Arbutin come ingrediente sbiancante (Misawa, 1994; Yokoyama e Yanaigi , 1991) (prodotto da Catharanthus
roseus da Mitsui Petrochemical Industries, Giappone) o Carthamin come pigmento cosmetico (Yamamoto et al., 2002; Haghbeen, 2006; Ekiert, 2004; Oda, 2005) (prodotto da Carthamus tinctorius da Kibun, Giappone).
Oltre alla produzione di principi attivi, la biotecnologia mostra interesse anche in altre aree di ricerca cosmetica, come l’ingegneria tissutale e gli approcci molecolari per la sicurezza dei prodotti e il claim testing (Kostarelos e Rheins, 2002).
Le sostanze chimiche pericolose comuni solitamente presenti nei cosmetici sono: bentonite, parabeni, glicole propilenico ed etilenico. Alcuni prodotti antirughe e idratanti contengono bentonite e caolino (tipi di argilla che attirano l’acqua, quindi assorbono l’acqua per gonfiarsi).
I parabeni sono gli ingredienti utilizzati invece come conservanti e il loro uso può danneggiare la pelle ma l’ ambiente, infatti molti consumatori preferiscono prodotti senza parabeni, perché tossici e possono causare reazioni allergiche ed eruzioni cutanee alla pelle sensibile.
I produttori stanno cercando di sviluppare prodotti naturali contenenti ingredienti naturali e materiali vegetali, che possono rivelarsi un’alternativa ai conservanti sintetici, essendo una fonte significativa di costituenti attivi che hanno un alto livello di attività antimicrobica. Gli ingredienti di origine vegetale sono limitati, diverse piante di interesse cosmetico non possono essere utilizzate perché:1) contengono metaboliti tossici; 2) crescono troppo lentamente e non è possibile una raccolta stagionale; 3) la concentrazione dei costituenti differisce a seconda del raccolto.
Mentre si studia per capire come fermare o invertire l’invecchiamento, alcuni ingredienti antietà hanno trasformato ciò che è possibile nella cura della pelle, i più efficaci come retinoidi, peptidi e antiossidanti sono diventati i principali combattenti dell’invecchiamento cutaneo nel settore cosmetico, non trascurando idrossiacidi, vitamine (come B, C ed E), acido ialuronico, coenzima Q10, acido alfa-lipoico e tè verde che sono i pilastri nell’industria cosmetica. Tuttavia, in questo panorama in continua evoluzione, ci sono sempre nuove aggiunte, come includono fattori di crescita, sirtuine, resveratrolo, idrochinone, argirelina e dimetilamminoetanolo (DMAE).
Quanto sia abbastanza evoluta l’arte farmaceutica durante il Rinascimento lo sappiamo da un libro stampato nel 1454 ad opera dello studioso Gutenberg, mentre nelle 1492 vengono scoperte le Americhe: secondo i critici questa ultima scoperta segna la fine del Medioevo.
Questi due avvenimenti contribuiscono alla divulgazione della disciplina farmacologica: l’opera di divulgazione è resa possibile anche perché vengono stampate le opere di Ippocrate, Galeno e Discoride e, nel frattempo, viene promossa l’importazione di materie prime abbastanza preziose da territori inesplorati. Questi avvenimenti, quindi, favoriscono nuove conoscenze e nuovi saperi. All’inizio del quindicesimo secolo la materia medica, oramai ridotta a un elenco di sostanze appartenenti ai tre regni naturali (vegetale, animale e minerale) comincia a rivolgere i suoi interessi verso studi specifici.
Verso questo nuovo indirizzo scientifico sicuramente ha dato il suo contributo l’introduzione di nuove droghe vegetali (il guanaco, la gialappa, l’ipecacuana, la ratania, eccetera) portate da paesi lontani. Intanto, alcune università, come quelle di Bologna, Pisa e Padova, promuovono la nascita di erbari e orti botanici, che mirano a sperimentare proprietà e risultati terapeutici con l’uso di erbe e piante vegetali. Nel 1553 per la prima volta all’Università di Padova viene istituita la cattedra di “Lectura simplicium”, che conferirà il Diploma di farmacista: questa nuova scienza comincia a farsi notare, attraverso la pubblicazione negli anni 1552-1578 del primo trattato medico-farmacologico, denominato il Pen T’sao di Li Shih-Chen : questo trattato comprende un catalogo di erbe medicinali, accompagnato dalla descrizione di oltre mille piante medicinali e circa diecimila formulazioni di materiale erboristici. In Italia nel 1498 viene stampato in lingua italiana a Firenze la prima raccolta ufficiale dei nomi dei farmaci coi loro caratteri essenziali e con le più comuni formule d’uso.
Questo ricettario è frutto della collaborazione tra la società dei Farmacisti e la società Medica ed è il primo esempio
All’inizio del quindicesimo secolo la materia medica, oramai ridotta a un elenco di sostanze appartenenti ai tre regni naturali si interessa a studi specifici
di lavoro interprofessionale nella storia scientifica. La seconda edizione del ricettario fiorentino è del 1550 e contiene la descrizione delle doti qualitative di un buon farmacista: quello di organizzare il lavoro, assaggiare, preparare le varie misture e droghe, ad esempio i colliri, unguenti, sciroppi, antidoti contro i veleni, ricostituenti determinati da semplici composti. I secoli XV e XVI sono considerati i secoli più importanti per l’affermazione dell’alchimia: presso le corti di Austria, Spagna e Inghilterra, infatti, si procede secondo ricette mirate alla distillazione di erbe e alla preparazione di oli; inoltre, si studiano metodologie per individuare specifici farmaci. Uno degli studiosi più seguiti è Theofrastus Von Hohenheim, che i più conoscevano come Paracelso.
Questo studioso introdusse il concetto del principio attivo: ha contestato la medicina classica di Galeno e di altri rappresentanti della scienza medica e arrivò, attraverso varie fasi esperienziali, a dire che le piante medicinali “sono impure ed il loro agire è supportato dal cosiddetto principio attivo”, ricavato da procedure diverse come: la distillazione, la concentrazione o diverse manipolazioni chimiche. Paracelso propose di dare interesse a medicamenti ottenuti con reazioni chimiche, come lo stagno usato contro i vermi parassiti, lo zolfo contro ogni tipo di febbre, l’antimonio come purgante. Per queste innovazioni ideologiche, Paracelso è definito il precursore della iatrochimica, che non è altro che la chimica medica basata sulla distillazione e analisi minerale dei minerali.

Le città italiane con i propri obiettivi ambientali, sanitari, sociali e culturali hanno una nuova sfida da vincere: la relazione con il mondo animale. L’istantanea che emerge dall’XI Rapporto nazionale “Animali in Città” di Legambiente sottolinea la necessità di visioni e strategie condivise, costruite sulla cooperazione tra tutti i protagonisti istituzionali e sociali. Partiamo dall’afflusso delle risposte. Nel 2022 hanno aderito in modo completo all’indagine 986 Amministrazioni comunali (circa il 50% rappresentato dai Comuni capoluogo) e 42 Aziende sanitarie. Quattro le macroaree per valu-
tare le prestazioni: quadro delle regole (regolamenti comunali e/o ordinanze sindacali), valido solo per i Comuni; risorse impegnate e risultati ottenuti; organizzazione delle strutture e servizi al cittadino; controlli. Seguendo tali vie, l’associazione del cigno verde ha assegnato il Premio nazionale “Animali in Città 2022” ad alcune realtà virtuose capaci di mettere in campo prestazioni e condotte destinate alla prevenzione. Si confermano tra i vincitori i Comuni di Prato, Modena e Verona: al primo, secondo e terzo miglior risultato; per i sanitari l’ATS della Montagna (Sondrio), l’AUSL Toscana Centro e l’ATS Brescia. Rispetto al 2021, entra nella terza posizione l’ATS di Brescia. Il 39,6% delle istituzioni locali ha scritto di aver fatto partire l’ufficio o un servizio opportunamente riservato al settore e l’83% delle Aziende sanitarie di avere il canile sanitario e/o l’ufficio di igiene urbana veterinaria (in tre casi pure l’ospedale veterinario). A dispetto di ciò, poco meno di uno su tre (il 30,8%) dei Comuni ha la sufficienza, mentre più di quattro su cinque (l’85,7%) nella Sa-

nità pubblica fa lo stesso. Il resto non risponde o ha risultati che sono tra insufficiente e pessimo. Salgono basandosi sul 2021, guardando i numeri, i costi dichiarati per i servizi ai cittadini e verso gli amici a quattro zampe: quasi 219 milioni di euro (nel 2019 eravamo circa a 193 milioni), pari a 73 volte la quantità di denaro riservata dall’Italia per la gestione di tutti gli animali confiscati. Osservando la spesa media pro capite, si aggira intorno a 2,9 euro/cittadino per le amministrazioni comunali (in crescita rispetto al 2021 che era di 2,4 euro) e di 0,81 euro/cittadino per le Agenzie di Tutela della Salute. I Municipi asseriscono di spendere il 61,9% del bilancio destinato al settore per gestire i canili rifugio.
«Con la modifica dell’articolo nove in Costituzione, la tutela degli animali è entrata a far parte dei principi costituzionali dello Stato: un passo importante per la difesa del loro benessere, ma anche per la salute
umana. In Italia, però, - ha spiegato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente - c’è ancora molto da fare, a partire dall’attivazione dell’anagrafe unica nazionale obbligatoria per tutte le specie animali in cui convoglieranno le informazioni delle banche dati regionali. Siamo in attesa di conoscere il testo del decreto firmato dal Ministro della salute che dovrebbe essere adottato, entro marzo 2023, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per stabilire le modalità tecniche e operative per l’implementazione del SINAC (Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia) all’interno del sistema I&R (Identificazione & Registrazione) degli animali. Si acceleri al più presto».
Se torniamo alle cifre, domina il segno negativo alla voce anagrafe canina: solo 290 Comuni (il 29,4%) conoscono quanti siano i cani iscritti presenti nel proprio territorio, pari a 1.197.226 cani, e 228 (il 23,1%) sanno le nuove iscrizioni avvenute nell’anno 2021, 89.583 cani. Oltre il 70% non ha risposto. Due anni fa in media ogni dieci cani catturati, nove hanno potuto essere restituiti ai proprietari oppure sono stati dati in adozione e/o reimmessi come liberi controllati.

La prevenzione del randagismo tramite sterilizzazione ha ancora molta strada da percorrere: meno della metà delle Aziende sanitarie, il 47,6% del campione, afferma di averlo fatto. Nel 2021 sono stati sterilizzati 4.307 cani e 19.595 gatti. Poco se, nel 2021, il numero di quelli dichiarati in entrata nei canili sanitari è di 30.595; dei gatti nei gattili sanitari di 16.259 e presenti nelle colonie feline di 338.985 (di cui quasi il 50% non sterilizzato). Esigue pure le aree dedicate agli animali d’affezione: solo il 25,76% dei Comuni ha spazi dedicati, con una media di uno ogni 9.423 residenti.
Passando ai regolamenti comunali nel 2021, il 37,4% delle città ne aveva uno per la corretta detenzione, solamente il 20,2% disciplina l’accesso nei locali pubblici e negli uffici e il 7,8% ha approvato norme per favorire con agevolazioni fiscali o sussidi le adozioni dai canili. Limitati, il 6,6% dei centri urbani, quelli che hanno una mappatura delle specie presenti per conoscere la biodiversità urbana. Poco più di uno su dieci, infine, lavora per la prevenzione costruendo sovra o sottopassi stradali per evitare incidenti con animali e approvando misure nei regolamenti edilizi.
La frutta piace a tanti, ma non esce bene dal rapporto “Stop pesticidi nel piatto”, elaborato da Legambiente in collaborazione con “Alce Nero”, perché è la categoria più colpita, con il 70,36% di residui. Le tipologie coinvolte, in ordine decrescente, sono: pere (91,67%), uva (88,37%), pesche (80,65 %).

Nei piccoli frutti (more, lamponi e bacche) la percentuale più alta d’irregolarità è al 5,97%. Bene la verdura con una maggiore presenza di campioni a norma di legge e privi di fitofarmaci (65,57%, percentuale irregolarità all’1,06%). La maglia nera va a peperoni e pomodori con, rispettiva-
mente, il 60,68% e 55,03%.
Fra gli alimenti trasformati, invece, il 57,93% è conforme; si segnalano in mezzo a quelli che presentano almeno un residuo (41,46%), i cereali integrali trasformati e il vino con la maggiore percentuale di residui regolari, nell’ordine 77,78% e 61,80%
Nel 2022 è stato registrato un aumento dei campioni con tracce di pesticidi, 44,1%. Al centro dell’indagine 4.313 esemplari di prova alimen-
Il 54,81% degli alimenti analizzati risulta a norma di legge e senza residui, mentre nel 44,19% vi sono tracce di uno o più fitofarmaci
tari, compresi i prodotti ricavati da apicoltura italiana ed estera, analizzati nel 2021. A preoccupare è il 44,1% di saggi in cui sono state riscontrate tracce di uno o più fitofarmaci, tra monoresiduo (14,3%) e multiresiduo (29,8%), benché nei limiti di legge.
Sono 90 le sostanze attive identificate: spiccano alcuni grappoli d’uva con 14, delle pere con 12, certi peperoni con 10. Dai dati Efsa sappiamo che è stata analizzata una fragola, proveniente dall’Unione europea, con 35. Tra i pesticidi più scovati troviamo, in ordine decrescente, Acetamiprid, Boscalid, Fludioxonil, Azoxystrobina, Tubeconazolo e Fluopyram. Vengono evidenziate pure tracce di Thiacloprid rinvenute in due esempi di miele, in uno di pesca e in uno di mela; di Imidacloprid in 34 “modelli” tra albicocche, arance, banane, carciofi, mandarini, peperoni, uva e pomodori. In entrambi i casi, gli aiuti chimici sono stati tolti dal mercato nel 2020. Non

manca neppure il DDT in due casi. «Il nostro Paese - ha dichiarato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente - si sta dimostrando esempio virtuoso per l’intera Europa in fatto di riduzione dell’uso dei pesticidi, grazie soprattutto alle sempre più numerose aziende che scelgono l’agricoltura biologica. A conferma di ciò basti pensare al raggiungimento della quota del 17,4% di SAU (Superficie agricola utilizzata ndr) condotta con metodo biologico. È, quindi, necessario un impegno più incisivo, considerando la richiesta dell’Unione europea di raggiungere un taglio dell’uso del 62% dei pesticidi entro il 2030. Il nuovo Governo prosegua nel solco tracciato e permetta al made in Italy sano e pulito di divenire apripista del cambiamento».
Il cotone è la seconda fibra più comune al mondo, preceduta dal poliestere, rappresentando circa il 24,2% di tutta quella prodotta nel 2020. Secondo i dati del 2019 dell’International Cotton Advisory Committee (ICAC), connesso a questa coltura c’è il commercio di fitosanitari tali da costituire circa il 4,71% di tutti quelli venduti e di circa il 10,24% nei soli insetticidi (un equivalente di 200.000 tonnellate di pesticidi ogni anno).
Ampia anche la diffusione di semi geneticamente modificati, coprendo nel 2018 il 94% di superficie dedicata alla coltivazione del Gossypium hirsutum, specie coltivata di cotone più diffusa al mondo.
Durante il 2021 sono stati analizzati 108 esemplari di miele. Nella maggior parte (67,59%) tutto filava liscio. Solo due erano irregolari per il superamento del limite. I campioni con almeno un residuo sono il 30,56% del totale, e 15 diverse tipologie di pesticidi. I più frequenti sono l’erbicida Glifosato (27,94%), N (2,4 Dimethylphenyl) Formamide (17,65%) e Amitraz (14,71%), raggiungendo, in alcuni casi, otto sostanze che contemporaneamente rispondono all’appello. L’Amitraz è un acaricida classificato «come molto tossico per l’ambiente acquatico, utilizzato principalmente per combattere uno dei maggiori problemi delle api: la Varroa destructor». Si fanno notare, inoltre, due neonicotinoidi: Thiacloprid (tolto dal mercato, poiché classificato come interferente endocrino) e Acetamiprid.
«Anche per i consumatori - sostiene Erika Marrone, Direttrice qualità, ricerca e sviluppo filiere di “Alce Nero” - è sempre più chiaro il legame esistente tra agricoltura, cibo e salute dell’Ambiente e delle Persone. L’agricoltura modella non solo il nostro paesaggio e la nostra economia, ma anche le nostre comunità ed è onnipresente nelle nostre vite. Proprio per questo ci aiuta a pensare in modo più consapevole a quanto sia cruciale la transizione a modelli produttivi alternativi; tra questi l’agricoltura biologica e le diverse forme di agro-ecologia costituiscono oggi una risposta concreta e scientifica non solo alla questione climatica, ma anche alla mitigazione dei rischi per la salute dei consumatori derivanti, soprattutto, dell’esposizione cronica alle molecole chimiche capaci di alterare tanto gli ecosistemi quanto gli equilibri del nostro organismo fin dalla vita intra-uterina».

Il deciso aumento nei consumi di petrolio e carbone, che ha fatto nuovamente rialzare la testa alle fonti fossili fino a rappresentare una quota di oltre il 77% dell’energia primaria, da meno del 75% dei primi nove mesi 2021, ha avuto come immediata conseguenza la crescita nelle emissioni di CO2. La loro stima, per l’Enea, è al +6% nei primi nove mesi dell’anno (+3% nel III trimestre) dopo il +9% registrato nel 2021, rispetto al 2020. Se in molti settori stiamo tornando ai livelli pre-pandemia, siamo in controtendenza proprio per il petrolio (+8%) e il carbone (+ 47%). C’è stata, è vero, una riduzione del 3% negli utilizzi di gas, ma pure le rinnovabili hanno registrato un calo dell’11%, legato a una riduzione dell’idroelettrico che la crescita di solare ed eolico non è riuscita a bilanciare.
L’analisi dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile sul sistema energetico italiano per il secondo e terzo trimestre del 2022, evidenzia anche un’involuzione nell’indice della transizione energetica Ispred (Indice
sicurezza prezzi decarbonizzazione) -60% nel terzo trimestre. «Il forte calo dell’indice Enea-Ispred è da collegarsi, in particolare, - spiega Francesco Gracceva, il coordinatore dell’Analisi trimestrale Enea - al peggioramento della componente decarbonizzazione, scesa al valore minimo della serie storica. In questo scenario l’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni del 55% al 2030 potrà essere raggiunto solo se nei prossimi otto anni riusciamo ad ottenere una riduzione media annua di quasi il 6%».

Puntando lo sguardo sulla sicurezza energetica, si possono notare condizioni non scontate come l’alta disponibilità d’import, la fase positiva per la raffinazione, effetto dell’inconsueta situazione di nervosismo nel mercato dei prodotti e, più di tutto, il regresso nell’adeguatezza del sistema gas. «In inverno - commenta Gracceva - richiede particolare attenzione la capacità delle infrastrutture gas di coprire la punta di domanda: infatti, nel caso di un completo azzeramento dei flussi dalla Russia (scesi sotto al 20% dell’import totale nei primi nove mesi, ma già quasi a zero a ottobre), risulterebbe molto difficile coprire consumi legati a picchi di freddo intenso che investano l’intero territorio nazionale».
Durante il semestre centrale del 2022 la guerra tra Russia e Ucraina e l’inasprimento graduale delle sanzioni da parte dei Paesi occidentali contro Putin hanno generato un’intensificazione dell’ansia sui mercati energetici. La media dei prezzi all’ingrosso per gas ed elettricità, tra gennaio e settembre, è stata pari ad un aumento
In molte città italiane, per parecchi giorni l’anno, respiriamo un’aria fuori dai limiti di legge
di circa il 300% sugli stessi mesi del 2021, oltre cinque volte le medie decennali, mentre il Brent (una tipologia di petrolio che deriva dall’unione della produzione di alcuni campi petroliferi situati nel Mare del Nord) in media annua, è stato poco al di sotto dei massimi storici. Gli aumenti del gas all’ingrosso sono stati via via inclusi nei contratti dei consumatori, con effetti considerevoli sull’economia, nonostante le misure varate dall’UE per mitigare il caro energia. L’inflazione è salita a ottobre al 10% nell’Eurozona, a quasi il 13% in Italia. La spesa per l’energia nei paesi OCSE nel 2022 è stimata come raddoppiata rispetto al 2021, fino a oltre il 17% del PIL, massimo storico, un dato nei fatti anticipatore di una recessione. Le previsioni di crescita per il 2022 e il 2023, quindi, sono state riviste al ribasso sia per l’aria euro sia per il nostro Paese.
«Rispetto al 2021 un’impresa con consumi medio-bassi - sottolinea Gracceva - ha visto aumentare i prezzi di elettricità e gas rispettivamente del 60% e del 120% nel primo semestre 2022, mentre nell’intero 2022 supereranno di ben oltre il 50% i precedenti massimi storici».

Tra gennaio e settembre 2022 i consumi sono calati nell’industria, con una discesa significativa nel III trimestre (-15%), mentre è avanzata la ripresa dei trasporti, benché a tassi più contenuti (+12% nei nove mesi, +4% nel III trimestre). La risalita delle emissioni, invece, è determinata quasi interamente dalla produzione di energia elettrica e calore, dalle raffinerie e dalle industrie energivore. «Un segnale importante è che i consumi di energia hanno iniziato a contrarsi in misura progressivamente maggiore rispet-
Il costo dei servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale, stimati per il terzo trimestre 2022, è in ulteriore salita ovunque. Viene calcolato un minimo di 3,6 c€/GJ per la zona Nord-Est fino ad un massimo di oltre 5 c€/ GJ per il Mezzogiorno. Calabria e Sicilia si sono ritrovate a fare i conti, dunque, con un costo relativo a tali servizi che viene quantificato intorno al 16% del prezzo totale, contro un valore dell’11% nella zona che comprende Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

to alla dinamica di fattori determinanti come l’andamento del PIL, produzione industriale, mobilità e clima. Un trend simile si è stato registrato in tutta Europa con un calo della domanda dello 0,7% nei primi nove mesi dell’anno. È evidente - aggiunge Gracceva - che la riduzione sia stata determinata fortemente anche dagli alti prezzi dell’energia che hanno imposto a molte imprese energivore uno stop delle attività. Tuttavia, nei prossimi mesi sarà fondamentale verificare se la contrazione possa andare oltre, come effetto delle misure di risparmio energetico».
L’Analisi trimestrale Enea include anche un approfondimento sulle materie prime critiche (Critical Raw Material, CRM), la cui accessibilità potrebbe essere un collo di bottiglia per la transizione energetica. Difatti, i dati mostrano una quasi totale dipendenza dell’UE dall’estero per terre rare, platino e litio (100%), tantalio (99%) e cobalto (86%). Difficoltà ancora più forti per l’Italia, dove le CRM hanno un’incidenza sul PIL pari al 32% e sull’export all’86%. «L’eventualità di non poter soddisfare al 2030 - conclude Gracceva - la domanda di energia eolica e per i veicoli elettrici è molto forte».
Il via al nuovo progetto dell’Associazione Scientifica
Biologi senza Frontiere per i Borghi del Benessere
 di Giovanni Misasi
di Giovanni Misasi
La mission dell’Associazione Scientifica Biologi senza Frontiere (ASBSF) è migliorare la qualità della vita, dal benessere individuale a quello collettivo, con l’obiettivo di vivere nel rispetto della natura dell’uomo e dell’ambiente, valorizzando l’esistente e stimolando le coscienze a investire per il benessere delle future generazioni. Le azioni d’intervento sono mirate alla tutela delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e alla prevenzione di patologie alimentari/nutrizionali, igienico-sanitarie, ambientali indoor e outdoor e quelle che, su più fronti, minano il benessere della salute umana.
Per migliorare la qualità della vita è necessario il riconoscimento della pluralità di valori che ca-
ratterizzano il benessere dell’uomo quali, ad esempio, vivere in un ambiente sano e salubre, implementare la giustizia sociale, tutelare l’ambiente e conservare il patrimonio storico/culturale e urbanistico.
Il progetto “Borghi del Ben Essere” si propone di restituire al tipico borgo calabrese - ormai in lenta estinzione - la sua identità, recuperandone storia, tradizioni, bellezze architettoniche e biodiversità. L’idea nasce dalla constatazione che molti borghi calabresi si stanno spopolando e questo può portare alla scomparsa di culture, colture e tradizioni, di prodotti naturali rappresentativi della nostra terra, che devono necessariamente essere tramandati, al fine di mantenere integra l’identità del luogo e della gente, in quanto ogni centro storico custodisce un patrimonio culturale, artistico ed ambientale. Già 48 sono i comuni calabresi che hanno aderito al progetto. Noi crediamo fortemente che la qualità della vita trovi la sua migliore espressione proprio nel ‘sistema’ borgo antico. Per questi 48 Borghi stiamo, infatti, strutturando una serie di interventi, studi e ricerche per raggiungere l’obiettivo di recupero dell’identità del Borgo e rintracciare il percorso ideale di benessere e miglioramento della qualità della vita al fine di realizzare un modello di “Longevity City”. Oltre a tutte le iniziative in essere, rivolte alla salute ed al benessere umano ed ambientale, ci siamo proposti anche di valorizzare e promuovere i Borghi con progetti che vanno a strutturare degli itinerari, al fine di guidare i visitatori in un percorso di benessere, a partire dalle bellezze storico/culturali fino alla gastronomia
locale e certificata, esaltando la bellezza selvaggia e incontaminata di paesaggi emozionanti, dove la natura e la biodiversità sono le vere protagoniste che fanno da sfondo agli svariati percorsi di ogni singolo borgo.

La caffeina (nome chimico L a mission dell’Associazione Scientifica Biologi senza Frontiere (ASBSF) è migliorare la qualità della vita, dal benessere individuale a quello collettivo, con l’obiettivo di vivere nel rispetto della natura dell’uomo e dell’ambiente, valorizzando l’esistente e stimolando le coscienze a investire per il benessere delle future generazioni. Le azioni d’intervento sono mirate alla tutela delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e alla prevenzione di patologie alimentari/nutrizionali, igienico-sanitarie, ambientali indoor e outdoor e quelle che, su più fronti, minano il benessere della salute umana.

Il nostro territorio custodisce una incontestabile bellezza paesaggistica e naturalistica, sapori antichi e prodotti autoctoni conosciuti in tutto il mondo; il nostro intento è aprire le porte di una nuova Calabria, dove il benessere e la qualità della vita travolgono chiunque si rechi in questi luoghi. Ecco che parte il primo progetto “Healthy City Guide”, che abbiamo presentato all’Istituto Valentini di Castrolibero il 22 novembre. Il progetto si propone di creare una figura specializzata come guida nei Borghi del Benessere/Città Sane al fine di promuovere il nostro territorio nella sua bellezza storico-culturale, artistica, ambientale ed enogastronomica. Gli obiettivi del progetto sono la conoscenza, la valorizzazione e la promozione dei Borghi del Benessere calabresi, dell’agricoltura ecosostenibile, dei prodotti tipici identitari dei borghi, della cultura e delle tradizioni, della biodiversità, della flora e fauna del territorio, dell’alimentazione corretta a km 0 e della dieta mediterranea, in una cornice di bellezza paesaggistica e naturalistica unica al mondo. Al tavolo dei relatori i biologi Giovanni Misasi, Teresa Pandolfi, Maria Grazia Felice e Amelia Bruno per illustrare il programma e i dettagli del progetto; sono intervenuti Bruna Primicerio Presidente del consiglio di Castrolibero e Antonio Palermo Sindaco di Mendicino, in rappresentanza dei due Comuni scelti per il primo itinerario.
Si ringrazia il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Gabriella Greco, la prof.ssa Patrizia Gallo e la prof.ssa Maria Josè Pucci che hanno accolto il progetto con entusiasmo per dare una rilevante opportunità agli studenti della scuola. Tante le adesioni, segno che i giovani hanno il forte desiderio di conoscere e promuovere il proprio territorio, perché saranno sempre figli di questa terra ed è loro il compito di proseguire a custodire l’identità dei propri Borghi. Il nostro intento è dare loro gli strumenti per imparare ad apprezzare con nuovi occhi la bellezza che li circonda, e un metodo per riuscire a trasmetterla. Itinerari di benessere per apprezzare, oltre la cultura, l’arte e la storia, la bellezza della tranquillità e la voce mormorata della natura maestosa e intatta in quei borghi che sbrigativamente vengono definiti aree interne o depresse e dove invece ha dimora la qualità della vita.
Intorno al 1985un gruppo di ricerca scoprì che a circa 22 km di altezza dai ghiacci dell’Antartide l’ozono si era formata un’apertura
dello strato di ozono anche al Polo Nord e in numerose altre aree del pianeta (pur di portata inferiore rispetto all’Antartide). Diversi studi e analisi individuarono la causa nei clorofluorocarburi (CFC), sostanze sviluppate a partire dagli anni ’30 del Novecento e utilizzati come refrigeranti nei frigoriferi, nei condizionatori d’aria, ma anche come gas all’interno delle bombolette spray. Le prime ricerche degli anni ’60 e ’70 su queste sostanze, avevano segnalato come un loro eccessivo accumulo nell’atmosfera potesse incidere sui livelli di ozono, ma la prospettiva di dover rinunciare ad un prodotto come i CFC non era ben vista dalle industrie. Solo attraverso le pressioni dei ricercatori e degli attivisti, alcuni paesi come Canada, Stati Uniti, Danimarca, Norvegia e Svezia approvarono le prime limitazioni e divieti sull’impiego dei CFC alla fine degli anni ’70, ma la vera grande svolta ci fu nel 1987 con il trattato, il quale regolamentava la produzione e l’utilizzo dei CFC in tutto il mondo. Già gli anni successivi all’accordo di Montreal, l’assottigliamento dello strato di ozono iniziò a ridursi in buona parte del pianeta.

Nei vivacissimi anni ’80 in una società euforica e spregiudicatamente lanciata verso il futuro, ma anche scientificamente fertile e sensibile nei confronti di alcune tematiche “nuove”, nacquero i movimenti ambientalisti e le prime vere politiche ambientaliste: è il momento in cui l’uomo sta realmente prendendo coscienza dell’impatto negativo di alcune sue attività sulla Terra.
Una delle grandi questioni dell’epoca, notificata con le prime avvisaglie già a partire dalla metà degli anni ’70, riguardava la rarefazione dello strato dell’ozo-
no, la famosa e più comune questione del “buco dell’ozono”. L’ozono è la ben nota forma allotropica dell’ossigeno, nonché il gas presente nella stratosfera che avvolge il nostro pianeta proteggendolo dai raggi ultravioletti del Sole. Più precisamente, è intorno al 1985 che un gruppo di ricerca scoprì che a circa 22 km di altezza dai ghiacci dell’Antartide l’ozono si era fortemente rarefatto, formando un’apertura (più popolarmente denominata “buco”) dal quale filtravano più facilmente le radiazioni solari dannose.
Negli anni successivi le analisi seguenti avrebbero rilevato una riduzione
Oggi, una relazione realizzata da Nazioni Unite, Unione Europea e Stati Uniti ha certificato come lo strato di ozono intorno la Terra si sta rigenerando, e tale risultato è stato raggiunto anche grazie al rispetto del trattato. Secondo questo rapporto se si continuerà a rispettare i termini dell’accordo di Montreal, entro poche decine di anni la fascia di ozono potrebbe tornare a livelli normali con importanti benefici per l’ambiente. Agli attuali ritmi di ripristino, in una ventina di anni i livelli di ozono dovrebbero tornare ai valori dei primi anni ’80 in tutto il mondo fatta eccezione per le aree polari. Il rapporto fa capire come i risultati raggiunti sono importanti e che i progressi delle nuove previsioni non devono essere ignorati. L’accordo è inoltre la dimostrazione della capacità della comunità internazionale di affrontare un problema globale: è un esempio virtuoso da seguire nello sviluppo delle politiche internazionali per la lotta alla crisi climatica.

Segui la sezione Bandi e Concorsi sul sito della FNOB
Troverai gli avvisi pubblici dedicati ai Biologi
e di Elettra- Sincrotrone Trieste: ha riguardato, in particolare, modelli murini affetti da encefalomielite autoimmune (che riproduce i meccanismi e gli effetti della sclerosi multipla) con l’obiettivo di indagare, attraverso la tomografia a contrasto di fase a raggi X (XPCT), l’evoluzione temporale del danno tissutale e dell’infiammazione in diversi organi e cercare possibili biomarker precoci della malattia.

Lo studio mostra come la tomografia a contrasto di fase a raggi X possa indagare l’origine e l’evoluzione di patologie neurodegenerative
L’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma, in collaborazione con il Dipartimento di neuroscienze dell’Università di Genova e altre istituzioni di ricerca internazionali, ha condotto una ricerca che ha dimostrato come la tomografia a contrasto di fase a raggi X è una tecnica efficace per indagare l’origine e l’evoluzione di patologie neurodegenerative come la sclerosi multipla e individuare possibili biomarker precoci.
La tecnica individuata offre una risoluzione spaziale e di contrasto molto elevata anche nei tessuti poco assorbenti, come il cervello o il midollo spinale, rivelando strutture tradizionalmente considerate “invisibili” ai raggi X: infatti, è in grado di generare immagini tridimensionali del campione analizzato, permettendo una visualizzazione dalla singola cellula all’intero organo e favorendo lo studio dell’interazione delle singole unità strutturali, tra loro e con l’ambiente circostante.
Lo studio ha coinvolto anche colleghi del Sincrotrone Soleil (Francia),
Alessia Cedola, primo ricercatore del Cnr-Nanotec e coordinatore del team che ha condotto lo studio, ha spiegato: «La sclerosi multipla è una malattia demielinizzante infiammatoria che provoca un danno progressivo alle strutture del sistema nervoso centrale. La sua eziologia è ancora incerta e le manifestazioni cliniche molto variabili: processi infiammatori che coinvolgono cellule del sistema immunitario e danni assonali e neuronali. Molti studi, nell’ultimo decennio, hanno riportato il coinvolgimento dell’asse intestino-cervello, sottolineando la possibilità che le alterazioni intestinali portino a disfunzioni cerebrali e suggerendo che una variazione della permeabilità intestinale potrebbe essere la causa di questa e altre malattie neurodegenerative: il nostro studio si è perciò concentrato non solo sul sistema nervoso centrale, ma anche sull’intestino degli animali affetti da encefalomielite autoimmune. La tecnica XPCT ha consentito di identificare e monitorare, a diversi stadi presintomatici della malattia, le alterazioni strutturali e cellulari in differenti distretti anatomici».
Il lavoro ha considerato diversi organi, quali il cervello, il midollo spinale, il nervo ottico e l’intestino, descrivendo l’evoluzione dei danni. Francesca Palermo, ricercatrice del team Cnr-Nanotec, ha dichiarato: «I nostri risultati contribuiscono a gettare luce sullo sviluppo e la progressione della malattia, suggerendo che i primi segnali patologici della malattia siano da rintracciarsi nell’intestino e non nel sistema nervoso, come fino ad ora creduto».
Il processo geodinamico, fino ad oggi solo ipotizzato, che la crosta terrestre compie verso il centro della Terra durante i movimenti di sprofondamento delle placche continentali, è stato dimostrato da un team internazionale, coordinato da Luigi Dallai dell’Università “La Sapienza” di Roma e da Sandro Conticelli dell’Università di Firenze e direttore dell’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche. Lo studio ha rintracciato la testimonianza del riciclo di rocce di origine superficiale, riportate alla luce dal magma delle eruzioni vulcaniche, dopo un percorso di milioni di anni fino alle profondità del mantello terrestre.
La ricerca, alla quale hanno collaborato ricercatori dell’Università di Ferrara, dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr, del Consiglio nazionale delle ricerche francese e del centro di ricerca Certema di Grosseto, è stata pubblicata su Nature Communications. La scoperta si basa sul ritrovamento di vene contenenti quarzo, incapsulate in frammenti di mantello terrestre portati in superficie da un magma eruttato dal vulcano spagnolo Cabezo Negro, circa 2 milioni di anni fa.
Sandro Conticelli, ordinario di Petrologia e Petrografia dell’Ateneo fiorentino e direttore del Cnr-Igag, ha spiegato: «Il quarzo è un minerale tipico della crosta continentale e fino ad ora non era mai stato ritrovato materiale proveniente dal sottostante mantello terrestre. Considerando che i carotaggi terrestri non riescono ad andare oltre 10 Km di profondità, questo ritrovamento è la prima evidenza diretta di un complesso processo geodinamico basilare nell’ambito del meccanismo della tettonica delle placche: il riciclo profondo di crosta continentale all’interno del mantello terrestre».
I ricercatori, grazie all’analisi isotopica dell’ossigeno del quarzo, sono riusciti a ricostruire il viaggio della
Documentato il processo geodinamico alla base della tettonica delle placche
crosta continentale che ha portato alla formazione di questo minerale, la cui presenza è “estranea” nel mantello terrestre. Luigi Dallai, associato di Geochimica e Vulcanologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, ha dichiarato: «In pratica, la crosta continentale è stata trascinata dalla superficie all’interno del mantello terrestre. A una profondità che stimiamo essere attorno ai 30 Km e a una temperatura di circa 1000°C, la crosta continentale subdotta subisce processi di fusione e va a formare delle vene contenenti quarzo nel mantello. Pezzi di questo mantello
sono infine strappati e trasportati nuovamente sulla superficie terrestre da magmi di origine profonda. L’intero ciclo potrebbe essersi completato in un lasso di tempo che va da 10 a 2 milioni di anni fa».
«Attraverso il processo documentato, ha concluso Conticelli, molti altri elementi chimici sono trasportati dalla superficie in profondità, così da essere arricchiti prima di essere riportati in superficie. Tra questi, il carbonio e altri elementi critici, come il litio e le terre rare, la cui reperibilità assume una rilevanza economica e tecnologica». (P. S.).


sporto a bordo di un razzo cargo e l’affidabilità dei componenti, privilegiando, ove possibile, tecnologie mature made in Italy».
Nei prossimi 15 mesi ENEA E ASI delineeranno le caratteristiche dello Space Nuclear Reactor italiano, identificheranno i possibili scenari operativi (esplorazione lunare, marziana e dello spazio profondo), le tecnologie ritenute critiche, effettueranno un’analisi costi-benefici tenendo in considerazione i differenti scenari d’interesse e definiranno una roadmap di ricerca e sviluppo per le fasi successive.
ASI guarda con interesse a questa tecnologia, che potrebbe contribuire a risolvere i problemi energetici nelle fasi sia di esplorazione di altri pianeti, che per i viaggi e le esplorazioni nello Spazio profondo. Disporre di un reattore compatto, modulare, affidabile, di piccole dimensioni e in grado di garantire la necessaria sicurezza alla vita dell’uomo in un ambiente già di per se ostile, rappresenterebbe una grande potenzialità per l’esplorazione. Inoltre, operare con dimensioni contenute consentirebbe una riduzione dei costi di produzione, dei tempi di sviluppo e un ingombro che ne consentirebbero l’utilizzo esteso senza difficoltà di trasporto, in diversi scenari.
L’obiettivo dell’accordo di collaborazione tra ENEA e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è la progettazione di un mini-reattore nucleare mady in Italy compatto, leggero, affidabile e sicuro, in grado di produrre energia per le future basi lunari e la successiva colonizzazione di Marte e dello Spazio profondo. Il progetto mira a sfruttare competenze, infrastrutture e professionalità multidisciplinari dei Centri di Ricerche ENEA di Bologna e Brasimone e di ASI. L’annuncio è stato dato in occasione della seconda Gior-
nata Nazionale dello Spazio del 16 dicembre scorso.
Mariano Tarantino, responsabile della Divisione ENEA di Sicurezza e sostenibilità del nucleare, ha sottolineato: «I principi base per la progettazione dello Space Nuclear Reactor sono la modularità, in grado di garantire un facile ampliamento della potenza disponibile e la ridondanza dei sistemi essenziali per garantire la massima sicurezza del reattore. Particolare attenzione verrà posta alla minimizzazione del peso totale del sistema per rendere possibile il tra -
Fin dagli anni ’50 sono stati studiati reattori nucleari per applicazioni spaziali, come alternativa affidabile, efficiente e compatta. Se nel secolo scorso l’utilizzo è stato limitato ad alcuni prototipi negli Stati Uniti e in Russia, a partire dal 2001 il rinnovato interesse per l’esplorazione umana della Luna e di Marte ha contribuito ad accrescere gli investimenti per la progettazione di piccoli reattori da utilizzare nelle future missioni, al fine di garantire indipendenza e piena funzionalità agli “avamposti spaziali”. A livello internazionale, vi sono già altri progetti di mini-reattori. Tra i più promettenti c’è Kilopower, sviluppato dalla NASA insieme ad alcuni centri di ricerca statunitensi e il Nevada National Security Site. (P. S.).
L’obiettivo del progetto europeo ACROBAT, a cui partecipano ENEA per l’Italia, Fraunhofer Institute for Laser Technology e l’azienda specializzata nel riciclo di batterie ACCUREC Recycling GmbH per la Germania, l’Università Cattolica di Lovanio e VITO (coordinatore) per il Belgio, è recuperare oltre il 90% delle materie critiche contenute nelle batterie litio- ferro- fosfato attraverso un processo di estrazione innovativo, a basso costo e a ridotto impatto ambientale da trasferire all’industria europea.
Le batterie litio-ferro-fosfato sono una particolare tipologia di accumulatori agli ioni di litio che sta guadagnando una quota crescente di mercato (circa il 36%) grazie a caratteristiche di elevata stabilità e sicurezza, lunga durata e costo inferiore rispetto ad altre tipologie, poiché non contengono cobalto e nichel. Vengono utilizzate, soprattutto, nei sistemi di accumulo stazionario, nelle mobilità elettrica e, ancora in fase di sperimentazione, in alcune applicazioni domestiche di elettronica di consumo, ma il loro impiego è destinato ad aumentare, perché le batterie agli ioni di litio risultano fondamentali nel processo di transizione ecologica e di decarbonizzazione dell’economia a livello globale.
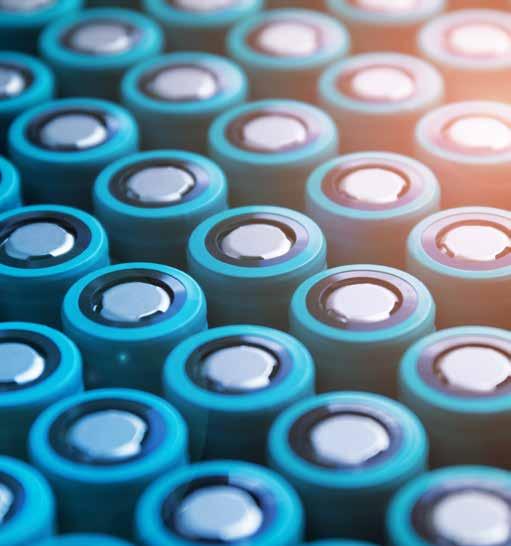
Federica Forte, ricercatrice e responsabile del progetto per ENEA, ha spiegato: «Il progetto è finalizzato a mettere a punto un nuovo processo di riciclo per estrarre dalle batterie litio, fosforo e grafite. Noi di ENEA ci occuperemo, in particolare, del processo di estrazione e di recupero dei materiali elettrolitici, come ad esempio i sali conduttori e i solventi organici. Le batterie litio-ferro-fosfato contengono materie critiche che rendono il loro riciclo un imperativo strategico; tuttavia, in Europa non è ancora una realtà industriale. Ecco, quindi, la necessità di avviare un progetto come ACROBAT, che ha come obiettivo l’unione delle competenze del mondo della ricerca e dell’industria per mettere a
Un processo di estrazione innovativo a basso costo e a ridotto impatto ambientale
punto un processo economico e sostenibile per l’estrazione, dalle batterie esauste, di materie critiche destinate a nuove produzioni».
Entro il 2030 il progetto ACROBAT punterà a raggiungere un target complessivo di recupero annuale di 5.400 tonnellate di materiale catodico (litio-ferro-fosfato), 6.200 tonnellate di grafite e 4.400 tonnellate di elettrolita. Un processo di riciclo su scala industriale permetterà di risolvere ulteriori questioni ambientali: le batterie agli ioni di litio contengono sostanze pericolose per l’ambiente, che potreb-
bero essere gestite in maniera opportuna e valorizzate durante le stesse operazioni di riciclo. La Cina, insieme all’Africa e all’America Latina, fornisce il 74% di tutte le materie prime da cui è composto un accumulatore. Inoltre, da sola la Cina produce il 66% delle batterie agli ioni di litio contro meno dell’1% della UE.
Federica Forte ha concluso: «Per l’indipendenza dell’Europa da questi approvvigionamenti, è evidente la necessità di riciclare localmente queste materie prime da prodotti a fine vita». (P. S.).
La prima strada consolare d’Italia rappresenta un capolavoro d’ingegneria civile, ma non solo. Fu anche e soprattutto un ponte tra culture, che avvicinò l’Urbe alla Grecia e al Mediterraneo

IRomani la chiamavano Regina Viarum, la regina delle strade. La più importante tra tutte le strade consolari che collegavano l’Urbe con altre città della penisola, di fatto la prima vera Autostrada del Sole che da Roma arrivava a Brundisium, l’attuale Brindisi, città di enorme importanza nell’antichità: era infatti il porto da cui avevano origine le rotte commerciali per la Grecia e per tutto l’Oriente. La Via Appia era (anzi: è) un capolavoro d’ingegneria civile, ma anche un ponte tra culture: la sua co -

struzione, dettata inizialmente da esigenze di tipo militare, velocizzò l’afflusso a Roma di elementi portanti della civiltà greca, dalla lingua al teatro, dai prodotti artigianali alla filosofia, favorendo la costruzione della civiltà classica. Ma non solo. Oltre che con la Magna Grecia e la Grecia, la Via Appia facilitò le relazioni tra Roma e l’Oriente, l’Africa e tutto il Mediterraneo. E a breve potrebbe diventare Patrimonio dell’umanità.
Lo scorso 10 gennaio è stato infatti firmato alle Terme di Diocleziano il Protocollo di intesa per la candidatura del sito “Via Appia. Regina Viarum” nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Un progetto che, sotto l’egida del Ministero della Cultura, coinvolge quattro regioni (Lazio, Campania, Basilicata e Puglia), dodici province e città metropolitane, 73 comuni, 15 parchi, la Pontificia Commissione di Arche -
ologia Sacra e 25 Università itadi Archeologia Sacra e 25 Università italiane e straniere e che prevede il restauro e la valorizzazione delle numerose evidenze archeologiche e architettoniche situate lungo il percorso della strada. L’obiettivo di fondo è coniugare la conservazione del sito con lo sviluppo sostenibile dei territori coinvolti, premessa indispensabile alla crescita sociale ed economica delle zone attraversate, alcune delle quali ai margini dei grandi circuiti turistici.

Nella presentazione della candidatura, il Sottosegretario al MiC Gianmarco Mazzi ha sottolineato: «La Via Appia è un esempio della grandezza romana, la prima via pubblica e il prototipo, anche dal punto di vista tecnico, di altre strade che hanno poi costruito i romani. Ma è anche molto di più, era un crocevia culturale, parte del sistema culturale e sociale del mondo romano: questa era forse la sua importanza principale e questo
sarà l’aspetto sul quale puntiamo. Il Ministero ha già investito 19 milioni di euro in restauri, conservazione e per la preparazione del fascicolo. Speriamo di farcela. Quando gli italiani giocano uniti, nessun risultato è impossibile». La palla adesso passa a Parigi, che dovrà valutare se la Via Appia possiede i requisiti richiesti per l’inclusione nella World Heritage List. Le sensazioni sono confortanti. La strada la cui costruzione fu iniziata dal censore Claudio Appio Cieco nel 312 a.C. e che fu completata nel 190 a.C. con l’arrivo a Brindisi rappresenta infatti il prototipo di quello che era l’efficientissimo sistema viario romano, oltre che un simbolo plurimillenario delle relazioni tra diverse culture mediterranee.
Larga 14 piedi romani (circa 4,1 metri) in modo da permettere la circolazione in entrambi i sensi di marcia, cinta da marciapiedi per il percorso pedonale, la Via Appia inizialmente collegava Roma ai Colli Albani, poi fu ampliata fino a Capua. A metà del terzo secolo fu raggiunta Maleventum, l’odierna Benevento, poi fu la volta di Taranto. Nel 190 il percorso fu completato fino a Brindisi, mentre circa 300 anni più tardi, tra il 108 e il 110 d.C., fu realizzata a tempo di record una importante diramazione, la Via Appia Traiana, una sorta di Variante di Valico ante litteram che da Maleventum raggiungeva l’Apulia e che proseguiva il suo cammino lungo la costa per raggiungere Brindisi. Il progetto di candidatura Unesco comprende tutti e 900 i chilometri del tracciato, compresi appunto quelli della diramazione traianea.
Le modalità di costruzione della Via Appia furono utilizzate per le successive strade consolari romane: tratti il più possibile rettilinei, ponti a due e tre arcate, pavimentazione fatta di basoli in pietra vulcanica poggiati su vari strati di pietrisco e terra la cui successione era accuratamente studiata per assicurare il drenaggio delle acque meteoriche. Fu lungo la Via Appia, inoltre, che apparvero per la prima volta le pietre miliari, che scandivano le distanze percorse e quelle che mancavano al raggiungimento della prossima meta. Larghi tratti della Regina Viarum si possono ammirare intatti a Roma, nel basso Lazio e in Campania. Presto l’antica autostrada che avvicinò l’Urbe al mondo potrebbe riafforare in tutto il suo splendore. ©

La Casa dei Vettii, uno dei luoghi simbolo del Parco archeologico di Pompei, ha riaperto al pubblico dopo vent’anni di chiusura. Il restauro della domus era iniziato nel 2016 sotto la direzione di Massimo Osanna e si è rivelato uno dei cantieri più complessi degli ultimi anni.

Le maggiori criticità sono state incontrate nella rimozione degli strati di cera che ricoprivano gli affreschi, i quali erano stati applicati in passato al fine di proteggere e far brillare di più i colori. Una procedura, quest’ultima, che ha danneggiato diversi dettagli dei dipinti, oscurandone alcuni particolari. Anche il Giardino del Peristilio, o Giardino colonnato, è stato oggetto di corposi interventi. Il sistema di condotte d’acque e piccole fontane che lo caratterizzavano è stato rivisto con l’inserimento di statue originali che erano custodite negli spazi espositivi e nei depositi del Parco archeologico. Tra queste è presenti la statua di Priapo, il dio dell’abbondanza. Gli spazi sono inoltre stati riempiti con piante riprodotte all’interno del vivaio del Parco, nel quale è attivo un progetto di valorizzazione dei giardini storici e delle aree verdi della città antica attraverso collaborazioni con agricoltori e produttori del territorio.
L’abitazione fu realizzata verso al fine del 1800 e apparteneva ad Aulus Vettius Conviva e ad Aulus Vettius Restitutus, presumibilmente due liberti divenuti ricchi grazie al commercio del vino. All’inaugurazione della domus erano presenti Massimo Osanna, direttore generale Musei del Mic, Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei e Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura.
«Pompei rappresenta un unicum mondiale ed è un luogo dove tocchiamo con mano il valore della nostra cultura che è certamente storico, filosofico e antropologico - afferma
Sangiuliano -. È un luogo universalmente noto che il mondo ci invidia: noi abbiamo il dovere di conservare, tutelare, preservare ma anche migliorare i servizi. Gli analisti mi dicono che nei prossimi anni i flussi turistici sono destinati a crescere perché la globalizzazione fa sì che aumentino le persone che vogliono viaggiare,
conoscere e interrogarsi e conoscere la storia dei popoli. Noi dobbiamo predisporci a tutto ciò elevando la qualità della nostra offerta e a Pompei dobbiamo migliorare l’esperienza che offriamo facendola diventare anche un valore economico autosufficiente in grado di produrre ricchezza e Pil per la nazione».
In un dialogo con Douglas Abrams, la primatologa britannica afferma che anche a seguito di distruzioni la natura ha la capacità di rigenerarsi per attenuare le vessazioni dell’uomo
Tra i resti devastanti di una pandemia, l’incombenza di una guerra mondiale e le urla sempre più strazianti di un pianeta in crisi, è ancora possibile sperare?
Jane Goodall, la più famosa primatologa, la donna dell’iconica foto in cui tende la sua mano verso un cucciolo di scimpanzé, colei che ha cambiato per sempre il mondo dell’etologia ci sta lanciando un grido d’allarme. E proprio quel primo tentativo di connessione tra uomo e animale celava una speranza vitale, la stessa di cui oggi abbiamo bisogno per sopravvivere e per affrontare l’irrefrenabile cambiamento e la conseguente perdita di biodiversità del mondo.
La leggendaria attivista in un dialogo con Douglas Abrams e con un appello urgente, chiama tutti all’azione da un capo all’altro del mondo, attraverso quei continenti che ha visitato nella sua vita “sul campo” come scienziata e come Messaggera di Pace delle Nazioni Unite. Goodall condivide quello che ha imparato nelle sue innumerevoli ricerche sulla straordinarietà della natura. Alla ricerca di un’armonia, una nuova alleanza tra gli esseri
umani e la terra, tra l’intelletto degli uomini e il loro “spirito indomito”.
Il volume è un viaggio nel suo cuore e nella sua mente sempre aperti all’altro e al futuro. Un manuale di sopravvivenza con quattro diverse ragioni per continuare a sperare.
La speranza che ripone oggi nei confronti dell’umanità è la stessa che ha portato con sé e con i suoi sogni nella foresta, quando dall’Inghilterra è partita alla volta del mondo. Chissà se allora quella giovane ragazza immaginava quanto questo pensiero ottimista le sarebbe stato d’aiuto nella vita e che sarebbe poi diventato il tema centrale dei suoi studi.
Attenzione però, la speranza è “fraintesa” non si tratta della semplice illusione passiva che qualcosa accada ma è proprio il contrario. Essere speranzosi richiede azione, costanza e tanto impegno. Ed è pure “contagiosa”, se agiamo insieme e adesso, possiamo farcela prima che sia troppo tardi. Il cambiamento climatico non è qualcosa che potrebbe colpirci in futuro, ci sta colpendo qui ed ora. Uragani e incendi devastanti, ghiacciai che si sciolgono e gravi siccità sono la realtà dei fatti. Come racconta l’autrice, negli anni spe-
di Anna Lavinia Jane Goodall, Douglas Abrams
“Il libro della speranza”
Bompiani, 2022 - 20 Euro
si a combattere per la natura, ha assistito alle peggiori devastazioni dell’uomo sull’ambiente. Nonostante ciò, ne è certa: anche se qualcosa è completamente distrutta o se abbiamo totalmente devastato un posto, col tempo e qualche aiuto, la natura tornerà. Nel mosaico della vita c’è infatti un’interconnessione imprescindibile tra le specie. Ricordiamocelo, noi dipendiamo in tutto e per tutto dalla natura. E, se preserviamo la biodiversità sulla Terra e qualunque vita su di essa, proteggiamo e salvaguardiamo noi stessi.
È davvero complicato riuscire a definire cosa sia la speranza, se un modo di vivere, un’emozione o una caratteristica personale dell’individuo. Quest’attesa fiduciosa non deve essere appannaggio dei soli giovani, è una parola che deve inevitabilmente raggiungere chi è al potere insieme ad un’altra, la saggezza. Quella che serve a chiedersi «che effetto avrà la decisione che prendo oggi sulle generazioni future? E sul benessere del pianeta? Quanto ci costerà questo essere poco saggi per riparare i nostri errori?». Intanto confidiamo in un’unica certezza: la speranza non è mai stata così necessaria.
Cristina Caboni
“La via del miele”
Garzanti, 2022 - 18,60 euro
«Ho dimenticato le mie radici. Ma il miele mi ha riportato a casa». Alice alleva api sui tetti di Parigi. Loro da sempre le indicano la strada ma adesso sono scomparse o meglio sono in fuga. La scrittrice e apicultrice sarda torna a parlarci attraverso questi insetti straordinari che ci insegnano a vivere e a difendere il mondo. (A. L.)
Virginia Feito
“Mrs March”
HarperCollins, 2022 - 19 euro

Mrs March è la fiera moglie di uno scrittore di successo, fino a quando non scopre che la protagonista del suo ultimo romanzo, una meschina prostituta, è proprio lei. Un viaggio psicologico nella salute mentale di una donna che sperimenta la follia in tutte le sue sfaccettature. Già destinato a diventare un film con Elizabeth Moss. (A. L.)
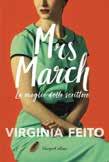
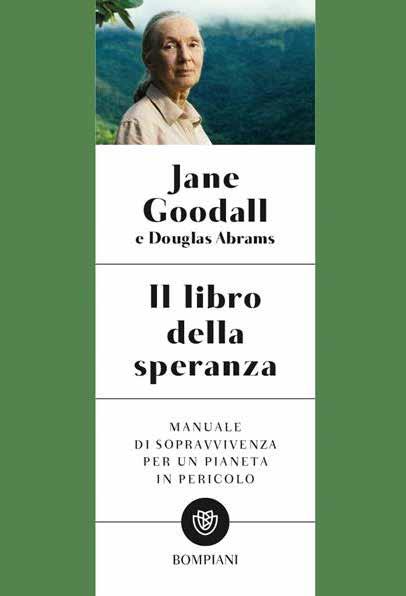
Danilo Concas
“Viaggio all’origine della vita”

Tab edizioni, 2022 - 32 euro
Da dove provengono gli esseri viventi che abitano la terra? Le piante, i funghi, i batteri e gli animali come hanno fatto a comparire sul nostro pianeta? Le ricerche e le competenze dell’autore unite alla passione per la chimica fisica e l’astrobiologia rispondono ad alcune delle domande più difficili e misteriose dell’Universo. (A. L.)
La Top ten degli atleti azzurri vincenti in diverse discipline in un anno da incorniciare

Piscine e velodromi, cilindri e clavette, schiacciate e canestri. Il 2022 è stato un anno di grandi eventi sportivi, ma anche di forti emozioni e storici traguardi firmati dagli atleti italiani. È stata dura, ma abbiamo scelto dieci nomi - anzi, in un caso, una coppia - per celebrare lo scorso anno: gran parte di questi sono noti e celebrati, almeno uno è insolito. Ne mancano altri, dalla scherma al tennis, dal rugby alla vela, ma confidiamo possano confermarsi quest’anno ed entrare nella nostra Top 10 alla prossima occasione.
Pecco Bagnaia
Era dal 2009 che un pilota italiano non vinceva la massima categoria del Motomondiale. E sembrava che il digiuno fosse destinato a continuare, visti i 91 punti di distacco accumulati dal campione in carica Fabio Quartararo. Francesco Bagnaia, per tutti Pecco, è riuscito però a trovare il feeling ideale con la sua Ducati e a inscenare una magnifica rimonta che lo ha portato a salire sul gradino più alto della classifica della MotoGp, grazie a 7 successi e 10 podi totali.
Constantini / Mosaner
Non solo curiosità e simpatia per una disciplina singolare. Nel 2022 il curling ci ha regalato molto di più, grazie a due atleti che hanno portato l’Italia dove mai era stata capace di arrivare. Ai Giochi olimpici invernali di Pechino, Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto la medaglia d’oro nel doppio misto, vincendo tutti gli incontri del torneo e mettendosi alle spalle anche nazionali dalla tradizione più florida.
Filippo Ganna
È italiano l’uomo più veloce su una bicicletta. Della storia. Filippo Ganna si è preparato per l’intera stagione preparando la grande impresa raggiunta l’8 ottobre 2022. Nel velodromo di Grenchen, in Svizzera, il ciclista italiano ha stabilito sia record dell’ora con 56,792 km percorsi, superando il primato di Daniel Bigham, sia la “miglior prestazione umana sull’ora”, detenuta dal 1996 da Chris Boardman e così chiamato perché stabilita utilizzando una bicicletta speciale.

Ferdinando De Giorgi
Alias Fefè, il ct azzurro ha riportato la Nazionale maschile di volley sul tetto del mondo, a 24 anni dall’ultimo successo della Generazione di fenomeni del quale fece parte, vin-
cendo un Europeo e tre Mondiali consecutivi. Arrivato sulla panchina azzurra nel giugno 2021, Fefè De Giorgi è stato capace di portare un gruppo giovanissimo al titolo continentale nel giro di tre mesi. Poi, nel 2022, il trionfo iridato alla Spodek arena di Katowice, 3-1 ai padroni di casa della Polonia.
Mattia Martinelli
Il suo esemplare gesto è del 2021, ma il giovane calciatore Mattia Martinelli è stato premiato con il riconoscimento WeFairPlay lo scorso novembre e, perciò, ci piace scegliere lui come icona del mondo del calcio per il 2022. Cosa ha fatto di speciale? Durante una partita della sua squadra, l’Eracle Como, l’arbitro ha negato una rete alla compagine avversaria, non accorgendosi che il pallone aveva superato la linea di porta. Se n’è avveduto invece Mattia, che ha segnalato il gol fra lo stupore di tutti e i mugugni di diversi compagni di squadra.
Sofia Goggia
Oltre a conquistare per la terza volta la Coppa del mondo di discesa libera, la campionessa di sci Sofia Goggia ha firmato nel 2022 due imprese impensabili per chiunque. Ai Giochi invernali di Pechino, si è presa l’argento a 23 giorni da una lesione parziale del legamento crociato operato anni prima. A dicembre, ha vinto una prova di Coppa del Mondo a St. Moritz il giorno dopo essersi fratturata la mano sinistra ed essersi sottoposta a operazione chirurgica.
Sofia Raffaeli
Ha appena compiuto 19 anni, ma è già la ginnasta italiana individualista più vincente di sempre. Sofia Raffaeli, marchigiana di Chiaravalle, è stata protagonista di un 2022 da sogno nel quale ha inanellato primati, diventando la prima azzurra a vincere un oro individuale agli Europei, ai Mondiali, nell’all around
iridato e nel concorso generale in Coppa del Mondo. Dopo aver brillato agli Europei, Sofia ha concluso i Mondiali di Sofia (Bulgaria) con sei medaglie: oro al cerchio, palla, nastro; bronzo alle clavette; oro nell’all-around e nella classifica Team Ranking.

Sergio Scariolo
Sangue siciliano, origini bresciane, Sergio Scariolo è uno dei tecnici italiani più vincenti della pallacanestro. Nel 2022 ha prima riportato Bologna in Eurolega e vinto l’Eurocup, seconda manifestazione continentale, sulla panchina della Virus. Poi, a settembre, ha conquistato il quarto titolo europeo alla guida della Nazionale spagnola, sconfiggendo la Francia nella finale di Berlino.
La Nazionale italiana di nuoto è ormai diventata un’autentica corazzata e i vari Acerenza, Miressi, Panziera, Pilato e Quadarella sono nomi ricorrenti sui podi delle grandi manifestazioni. Per quanto potenzialmente banale, però, scegliamo come icona della disciplina Gregorio Paltrinieri. Un campione che fa scalpore quando scende giù dal podio, come negli 800 stile libero ai Campionati del mondo di Budapest. Da lì in avanti, però, il suo 2022 è stato trionfale: fra vasca e acque libere sono arrivati due ori, un bronzo e un argento ai Mondiali, tre ori e un argento agli Europei di Roma.
Yeman Crippa
Anche l’atletica ha regalato gioie agli sportivi italiani, dal titolo iridato di Massimo Stano nella 35 km di marcia negli Usa agli ori europei di Marcell Jacobs nei 100 metri e Gianmarco Tamberi nell’alto. In Baviera, però, un’altra bella pagina è stata scritta da Yeman Crippa, re d’Europa nei 10.000 metri piani: per lui il primo sigillo internazionale in carriera, si spera di una lunga serie.
La FNOB rinnova la convenzione per fornire ai biologi un software di gestione della contabilità
Leggi l’intesa su www.fnob.it

Gioie e dispiaceri in uno degli stadi più importanti al mondo. Le rare sconfitte inaspettate delle “giganti” Inter e Milan con le “piccole” del campionato
La chiamano “La Scala del Calcio”.
È il teatro milanese del pallone e fra gli stadi più affascinanti del mondo. Anche per questo, lasciare la propria firma – in senso metaforico – sul prato dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano, ha sempre avuto un gusto speciale, che tu sia una big o una “cenerentola”. Certo, se sei un carneade alla ribalta o una squadra neopromossa e batti l’Inter o il Milan ti consegni con merito alla storia, scrivendo una pagina di carriera che neppure i nipoti si stancheranno mai di ascoltare. Le ultime favole sono quelle di Michel Ndary Adopo e Tommaso Baldanzi. Adopo, 22enne franco-ivoriano del Torino, promosso in prima squadra dopo una stagione e mezza in Serie C con la Viterbese, ha eliminato il Milan dalla Coppa Italia con un gol ai supplementari. Il 19enne Baldanzi ha invece firmato la rete con la quale il sorprendente Empoli ha battuto di misura la corazzata dell’Inter, a soli due minuti dal suo ingresso in campo.
E prima? Ce ne sono di capitoli, eccome. Il primo, uno dei più “romantici”, è il 2-1 della Cavese sul Milan del 7 novembre 1982. Per entrambe era la prima volta in Serie B: i campani neopromossi, il Diavolo retrocesso per il coinvolgimento nell’inchiesta sul calcioscommesse.
Davanti a 5mila tifosi metelliani, la Cavese ribaltò la rete di Jordan con quelle di Tivelli e Di Michele. “La Cavese sembrava il Real Madrid” commentò Gianni Vasino, inviato di “90° Minuto”. Gol da annali del calcio è quello con
cui Faustino Asprilla regalò al Parma l’1-0 sul Milan il 21 marzo 1993, interrompendo una serie-record di 58 partite senza sconfitte da parte dei rossoneri.
Quattro le partite memorabili (o da dimenticare, dipende dai punti di vista) nel primo decennio del Terzo Millennio. Il 23 dicembre 2000 il Perugia di Serse Cosmi si confezionò un regalo di Natale anticipato, battendo per 2-1 a San Siro il Milan di Maldini, Gattuso e Leonardo, allenato da Zaccheroni. Milan avanti con Shevchenko, poi il sorpasso firmato da Saudati e Vryzas. Il 22 settembre 2004, sulla panchina del Milan c’era Carlo Ancelotti, in campo anche Kakà e Seedorf. Il gol al Messina, però, lo segnò Pancaro prima del ribaltone di Giampà e Zampagna, già “giustizieri” della Roma pochi giorni prima.
Da Cosmi a un’autentica icona del calcio italiano, Mazzone: nella sfida fra “Carletti” del 30 gennaio successivo, fu il Bologna a imporsi per 1-0 sul Milan, grazie a una rete dell’ex rossonero Locatelli su assist di tacco di Zagorakis, che poi evitò il pari con un salvataggio sulla linea di porta. Ancora Bologna tre anni e mezzo dopo, il 30 gennaio 2008: 2-1 al Diavolo firmato da Di Vaio e Valiani, che vanificò il momentaneo pari di Ambrosini.
Per nulla banali anche gli incroci fra Benevento e Milan, nella stagione 2017-2018: se all’andata i campani hanno trovato il pari nel recupero con una rete del portiere Brignoli, al ritorno sono stati addirittura capaci di espu-
gnare il “Meazza”, ottenendo la prima storica vittoria esterna in Serie A, siglata da Pietro Iemmello. Sul 2-1 dello Spezia, 7 gennaio 2022, ha pesato invece un grave errore arbitrale, oltre alla bravura dei match-winner Agudelo e Gyasi e alla determinazione dei liguri.
Qualche soddisfazione ai... rivali, oltre che ai propri tifosi, l’ha data anche l’Inter. Per i supporter del Bari, San Siro è stato “dolce” in quattro occasioni, a cavallo fra Secondo e Terzo Millennio. Il 16 ottobre 1994 i pugliesi sconfissero i nerazzurri per 2-1: il primo gol fu Guerrero, che poi centrò un palo, il secondo di Tovalieri, festeggiato con il “trenino”. Un’esultanza che sarebbe poi diventata iconica. Il 18 gennaio ‘98 fu Phil Masinga a “gelare” l’Inter di Simoni e Ronaldo. Il Bari avrebbe poi vinto al ritorno, in casa, e nuovamente a Milano il 1° novembre dello stesso anno, con gol di Zambrotta e doppietta di Masinga.
Tornata a vincere fra il 2006 e il 2010, sia in Italia sia in Europa, l’Inter ha attraversato un periodo di sensibili alti e bassi negli anni successivi al decantato (e spesso “consolatorio”) Triplete, ovvero la conquista di scudetto, coppa nazionale e Coppa dei Campioni nella stessa primavera. La stagione 2011/2012 è stata emblematica. Dopo aver festeggiato all’andata un inatteso 3-1, il Novara di Mondonico ha concesso il bis nel match di ritorno il 12 feb-
braio dell’anno olimpico, espugnando lo stadio Giuseppe Meazza grazie a un tiro mancino del “profeta in patria” Caracciolo, cresciuto proprio nel quartiere San Siro. Difficile risolvere i problemi di quell’Inter, anche per un grande tecnico come Claudio Ranieri. E così, cinque giorni dopo, tenuto a galla da un super Gillet fra i pali, anche il Bologna ha approfittato della crisi nerazzurra: 3-0, doppietta di Di Vaio e rete di Acquafresca. I felsinei, del resto, hanno un ottimo feeling con San Siro: in tempi più recenti, il 5 luglio 2020, protagonisti dell’ultima “favola” rossoblù contro l’Inter sono stati due Musa, il giovane Juwara e Barrow, bravi a ribaltare la rete di Lukaku.

Fra l’autunno del 2014 e quello del 2016 anche il Cagliari ha fatto per due volte il “colpo” a San Siro. Nel primo caso, un 4-1 firmato da Sau e dalla tripletta di Ekdal, tutto nel primo tempo. In panchina, Zdenek Zeman. L’esito finale della stagione è stato però molto meno lieto. È riuscito a salvarsi, invece, il Cagliari di Massimo Rastelli che ha sbancato per 2-1 San Siro grazie a Melchiorri e a un’autorete di Handanovic, sei anni e mezzo fa.
Tutta speciale, infine, la storia di Federico Dimarco che il 15 settembre 2018, in prestito dall’Inter, ha firmato l’1-0 del Parma contro i nerazzurri con una perla balistica. Ora è un punto fermo della Beneamata. (A. P.)


Dopo un 2022 da incorniciare, le speranze dello sport italiano saranno chiamate presto alla riconferma, con atleti di altissimo livello
Èvero, non ci saranno i Mondiali di calcio, né le Olimpiadi estive. Ma l’assenza di questi due grandi eventi non sminuisce un calendario 2023 impreziosito da manifestazioni di rilievo, dall’atletica al nuoto, dai motori agli sport invernali.
I Mondiali di sci, ad esempio, dal 6 al 19 febbraio, con l’Italia a nutrire grandi speranze fra le donne. Le rivali si chiamano soprattutto Shiffrin, Vlhova, Gut ma le azzurre Sofia Goggia, Marta Bassino, Federica Brignone (tra le migliori in discesa libera, gigante e Super G) ed Elena Curtoni inseguono medaglie pesanti. Per la Goggia, c’è il
tabù dell’oro che ai Mondiali non ha mai vinto. Fra gli uomini, cercano imprese da podio Sala e Vinatzer in slalom, Casse e Paris in discesa libera.
Marzo è tempo di motori e gli appassionati italiani sperano sia un mese “rosso”. Per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, al via il 5 marzo nel Mondiale di Formula 1. Ma anche per la Ducati, che lo scorso anno ha vinto il titolo iridato con Pecco Bagnaia in Moto Gp: in Portogallo il 26 marzo il primo “via!”. Aprile è il mese del basket, con la Virtus Bologna a inseguire i playoff di Eurolega, ma anche delle grandi classiche ciclistiche del Nord (il 9, la Parigi-Roubaix), mentre dal 6 al
28 maggio torna il Giro d’Italia, con big del calibro di Remco Evenepoel, Geraint Thomas, Primoz Roglic e il nostro Filippo Ganna che, fra l’altro, quest’anno va a caccia anche di ori agli Europei (8-12 febbraio) e ai Mondiali (3-13 agosto).
E il calcio? Il campionato di Serie A finisce il 4 giugno, anche se non è improbabile che lo scudetto venga assegnato prima. Il 10, invece, la finale di Champions League. Di italiani ce ne saranno nella Final Four di Nations League, con gli azzurri di Mancini a contendere il trofeo a Olanda, Spagna e Croazia. La rincorsa al “pass” per gli Europei, invece, ripartirà in autunno. Appuntamento Mondiale invece per la Nazionale femminile che il 24 luglio debutta con la Svezia in Nuova Zelanda.
Fra le discipline che hanno inorgoglito gli sportivi italiani, negli ultimi lustri, c’è il nuoto che dal 14 al 30 luglio celebra i Mondiali rinviati nel 2021. Attesi protagonisti sono il recordman mondiale dei 100m dorso Thomas Ceccon, il re delle lunghe distanze Gregorio Paltrinieri e l’uragano Benedetta Pilato, oro nei 100m agli Europei di Budapest. Dal 19 al 27 agosto la capitale ungherese ospita invece i Mondiali di atletica: per l’Italia i grossi calibri sono sempre loro, Marcell Jacobs nei 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto, campioni olimpici in carica ma frenati da problemi fisici nell’ultima rassegna iridata.
Fra agosto e settembre ci sono i Mondiali di basket con l’Italia che corteggia la star italo-americana Paolo Banchero, prima scelta assoluta del Draft Nba 2022, per poter fare il salto di qualità. Dalla retina dei canestri alla rete di pallavolo: sia l’Italvolley maschile, sia quella femminile vogliono confermarsi campioni d’Europa, dopo i successi di due anni fa. I ragazzi di Fefè De Giorgi sono anche detentori del titolo mondiale. A settembre si assegna anche la Coppa Davis di tennis e arriva a Roma la Ryder Cup, la più prestigiosa competizione internazionale di golf. (A. P.)
La stagione World Tour dei ciclisti professionisti è già partita, con il successo assoluto di Jay Vine al Santos Tour Down Under, la vittoria nel prologo di Alberto Bettiol e le belle prove degli altri tricolori Antonio Tiberi, Alessandro Covi e Giovanni Aleotti. Fra i corridori italiani ce n’è però uno che ancora non pedala, almeno in gara, quando avrebbe tutte le carte (e il recente palmares) in regola per farlo. Malgrado l’ennesima Top 10 al Giro d’Italia e altri risultati di prestigio ai massimi livelli, il 40enne lucano Domenico Pozzovivo è ancora senza squadra. Si allena da solo, con buone sensazioni, ma è stato “mollato” per ragioni di budget anche dalla Intermarché-Wanty-Gobert, il team con cui aveva firmato per la stagione 2022 nel giorno di San Valentino.

Data significativa, questa, visto l’amore che Pozzovivo nutre per il suo lavoro, malgrado una serie di incidenti (anche gravi) che hanno minato a più riprese il suo percorso professionale. Un amore che, sommato alla professionalità e a uno stile di vita esemplare, hanno reso questo atleta decisamente performante anche all’approssimarsi degli Anta. Il Dottore, così com’è chiamato nell’ambiente, è stato nel 2022 il miglior italiano alla Freccia Vallone, è giunto ottavo al Giro d’Italia malgrado i 5 minuti persi nella tappa del Mortirolo per guai meccanici, nono al Giro di Svizzera, quinto nella Coppa Agostoni, terzo al Giro dell’Emilia dietro Mas e Pogacar.
«Qualche risultato, insomma l’ho ottenuto. E di certo non mi aspettavo di vivere un inverno simile a quello dello scorso anno. Perché ho dimostrato di avere un livello adeguato al World Tour e di poter competere nei grandi giri, puntando a un certo numero di piazzamenti importanti e facendo da riferimento per i giovani», ha spiegato Pozzovivo.
Sembrava scontato che il 40enne di Montalbano Jonico (Matera) rinnovasse con l’Intermarché, considerato che nel ranking interno alla squadra è stato il sesto corridore per punti apportati.
Ma niente. «L’Intermarché – ha rivelato Domenico - ha elaborato un’offerta molto vicina al minimo, consci loro stessi che non era una proposta accettabile. Lo scorso anno puntare su di me era una scommessa, anche se io sapevo quanto potevo dare. Oggi do garanzie. Ma la questione dipende meramente dai bilanci delle squadre». La conferma è arrivata, alla stampa di settore, dal team manager Aike Visbeek: «Adesso il nostro budget è esaurito, indipendentemente da quanto questo sia doloroso per Domenico Pozzovivo. Tutti si chiedono perché non abbia ancora un contratto, ma per noi c’è una spiegazione molto logica: non abbiamo più soldi».
Ma se è vero che «realisticamente non ci sono porte destinate ad aprirsi», per usare le parole del Dottore, è altrettanto certo che lui continua ad allenarsi. Perché le motivazioni per andare avanti sono alimentate dalle buone risposte che il fisico gli ha dato dopo aver smaltito l’ultimo capitombolo, quello al Giro di Lombardia. Da buon lucano, testardo e ostinato, Domenico vuole crederci ancora: «Sono aperto a qualsiasi opportunità che possa essere congrua e giusta per quello che posso dare sulla strada. La mia stella polare sarebbe sempre il Giro d’Italia – il suo pensiero, netto - e so di avere le potenzialità per far comodo a più di qualche squadra». (A. P.)
Scadenza, 2 febbraio 2023
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per il Dipartimento di scienze della vita. Gazzetta Ufficiale n. 3 del 1301-2023.
la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica. Gazzetta Ufficiale n. 2 del 10-01-2023.
UNIVERSITÀ DI MILANO
Scadenza, 13 febbraio 2023
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI BIOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARI DI ROMA
Scadenza, 2 febbraio 2023
“LINK CAMPUS UNIVERSITY” – ROMA
Scadenza, 8 febbraio 2023
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica. Gazzetta Ufficiale n. 6 del 24-01-2023.
UNIVERSITÀ DI ROMA “TOR VERGATA”
Scadenza, 9 febbraio 2022
Procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Dipartimento di biologia. Gazzetta Ufficiale n. 2 del 10-01-2023.
Scadenza, 9 febbraio 2022
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia, per il Dipartimento di biologia cellulare, computazionale e integrata. Gazzetta Ufficiale n. 2 del 10-01-2023.
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO “S. GIOVANNI- ADDOLORATA” DI ROMA
Scadenza, 9 febbraio 2023
Procedura di stabilizzazione del personale precario dell’area della dirigenza per
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per il Dipartimento di bioscienze. Gazzetta Ufficiale n. 3 del 1301-2023.
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI MILANO
Scadenza, 16 febbraio 2023
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinicalaboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, a tempo indeterminato, per la S.C. Medicina di laboratorio. Gazzetta Ufficiale n. 4 del 17-01-2023.
UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Scadenza, 23 febbraio 2023
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale. Gazzetta Ufficiale n.6 del 24-01-2023.
UNIVERSITÀ DEL MOLISE – CAMPOBASSO
Scadenza, 23 febbraio 2023
Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, per il Dipartimento di bioscienze e territorio. Gazzetta Ufficiale n. 6 del 24-01-2023.
È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica “RISCHI NATURALI E ANTROPICI E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE” da usufruirsi presso l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari (IBPM) del CNR di Roma, nell’ambito del progetto “Programma di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” finanziato dal MiTE - Ministero della Transizione Ecologica (Bando MiTE DD n. 117 del 15/04/2021). Per informazioni, www. cnr.it, sezione “concorsi”.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI SCIENZE DELL’ATMOSFERA E DEL CLIMA DI ROMA
Scadenza, 2 febbraio 2023
Selection by qualifications and interview pursuant to article 8 of the “Regulations concerning the recruitment of personnel with fixed-term employment contracts”, for the recruitment, pursuant to article 83 of the National Collective Labour Agreement for the 2016-2018 “Education and Research” sector, signed on 19 April 2018, of nr. 1 staff member with a professional profile of Researcher III level, for project activities PNRR CN00000033 “National Biodiversity Future CenterNBFC”, at the Institute of Atmospheric Sciences and Climate (CNR-ISAC) - office headquarters Roma. Per informazioni, www.cnr.it, sezione “concorsi”.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO PER LO STUDIO DEGLI IMPATTI ANTROPICI E SOSTENIBILITÀ IN AMBIENTE MARINO DI GENOVA
Scadenza, 9 febbraio 2023
È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica “RISORSE NATURALI ED ECOSISTEMI” da usufruirsi presso l’Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino – Sede Secondaria di Genova (GE) del CNR, nell’ambito del Progetto di Ricerca autofinanziato DTA. AD002.564 “Fisheries management and ecology - Ecology of fishes and other aquatic organisms in relation to their sustainable exploitation”. Tematica: “Biologia, ecologia, riproduzione e allevamento del cavalluccio marino (Hippocampus guttulatus)”. Per informazioni, www.cnr.it, sezione “concorsi”.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO PER LO STUDIO DEGLI IMPATTI ANTROPICI E SOSTENIBILITÀ IN AMBIENTE MARINO DI CAPO GRANITOLA (TRAPANI)
Scadenza, 13 febbraio 2023
È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di n.1 borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica “Rischi naturali e impatti antropici e tecnologie per l’ambiente” da usufruirsi presso l’Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino – Sede di Capo Granitola del CNR, nell’ambito del Progetto di Ricerca “GRANSEA - Valutazione degli impatti delle attività antropiche offshore su specie marine a supporto di un approccio ecosostenibile”. Tematica: “Studio dell’impatto antropico delle energie rinnovabili offshore sulle specie di mammiferi marini, con particolare riferimento agli effetti dell’energia acustica immessa in mare”. Per informazioni, www.cnr.it, sezione “concorsi”.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE DI PAVIA
Scadenza, 13 febbraio 2023
È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica “Medicina e Biologia” da usufruirsi presso l’Istituto di Genetica Molecolare Luigi Luca Cavalli-Sforza del CNR di Pavia, nell’ambito del seguente Progetto DSB.AD006.311 AIRC IG 2020 ID24448 GAE P0000424 “DNA polymerase lambda and genetic instability exploring novel molecular mechanisms in alternative telomeres lengthening”. Per informazioni, www.cnr.it, sezione “concorsi”.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE MARINE DI MAZARA DEL VALLO (TRAPANI)
Scadenza, 16 febbraio 2023
È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica “Scienze Ambientali – Biologiche – Naturali, Economia Ambientale” da usufruirsi presso l’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del CNR di Mazara del Vallo, nell’ambito del progetto DTA.AD002.546 “Gestione sostenibile delle risorse marine e crescita blu”: Tematica: “Valutazione del capitale naturale e dei servizi ecosistemici in ambiente marino”. Per informazioni, www. cnr.it, sezione “concorsi”.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE DI PAVIA
Scadenza, 16 febbraio 2023
È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica “Medicina e Biologia” da usufruirsi presso l’Istituto di Genetica Molecolare Luigi Luca Cavalli-Sforza del CNR di Pavia, nell’ambito del Progetto: DSB.AD006.295
“Ruolo del metabolismo dell’RNA nella neurodegenerazione”. Per informazioni, www.cnr.it, sezione “concorsi”.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO PER LA SINTESI ORGANICA E LA FOTOREATTIVITÀ DI BOLOGNA
Scadenza, 20 febbraio 2023
Selection by qualifications and interview pursuant to article 8 of the “Regulations concerning the recruitment of personnel with fixed-term employment contracts”, for the recruitment, pursuant to article 83 of the National Collective Labour Agreement for the 2016-2018 “Education and Research” sector, signed on 19 April 2018, of a staff member with a professional profile of Researcher III level, at the Institute for Organic Synthesis and Photoreactivity ISOF CNR- office headquarters Bologna For the topic SPOKE 1 : Materials for sustainability and ecological transition of the ECOSYSTEM FOR SUSTAINABLE TRANSITION IN EMILIA-ROMAGNA project. Per informazioni, www.cnr.it, sezione “concorsi”.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO PER L’ENDOCRINOLOGIA E L’ONCOLOGIA “GAETANO SALVATORE” DI NAPOLI
Scadenza, 23 febbraio 2023
Selection by qualifications and interview, pursuant to article 8 of the “Regulations concerning the recruitment of personnel with fixed-term employment contracts”, for the recruitment and article 83 of the National Collective Labour Agreement for “Education and Research” sector of the year 2016-2018, signed on 19 April 2018, of three staff member with a professional profile of Researcher III level, at the second site of Institute Endocrinology and Experimenal Oncology “G.Salvatore” (SS)- located at Via P.Castellino 111, in the context of the project “SEE LIFE - StrEngthEning the ItaLIan InFrastructure of Euro-bioimaging”, ESFRI area “Health and Food”, marked with the identification code “IR0000023 - CUP B53C22001810006. Per informazioni, www.cnr.it, sezione “concorsi”.
Perché i comportamenti di aiuto sono diffusi in natura e le ragioni per le quali potrebbe esistere un altruismo “disinteressato”, che può apportare apparenti svantaggi evolutivi al donatore
di Jolanda Serena Pisano*Centinaia di articoli scientifici hanno indagato i comportamenti altruistici, ovvero quelli che portano benefici ad altri individui. Tuttavia, la definizione di questo concetto è ancora poco chiara, con usi diversi in base agli autori1; ciò influisce anche sui criteri per definire una specie come altruista2.
Generalmente, le specie sociali vivono in gruppi in cui la cooperazione è frequente. Ne sono esempi i lupi e alcune specie di primati, pesci, gamberi e insetti eusociali. In queste specie, i comportamenti sociali sono adattativi: migliorano le probabilità dei suoi membri di riprodursi3,4. Ma se comportamenti di aiuto reciproci o mutualistici hanno esiti positivi per entrambe le parti in causa, e quindi sono sempre vantaggiosi, meno chiaro è il significato evolutivo dei comportamenti che causano uno svantaggio al soggetto che porta benefici a un altro individuo, soprattutto quando la perdita riguarda la fitness, il successo riproduttivo del donatore. È il paradosso dell’altruismo: gli individui più altruisti verrebbero sfruttati da quelli più egoisti, per cui dovrebbero scomparire, invece questo non si verifica. Tuttavia, diversi modelli hanno spiegato perché i comportamenti di aiuto sono diffusi in natura e perché potrebbe esistere un altruismo “disinteressato”, che può apportare apparenti svantaggi evolutivi al donatore2,4.
Ogni individuo può interagire socialmente con altri in diversi modi. In base alle ricompense che ognuna delle due parti ottiene, si parla di mutualismo o cooperazione (entrambi traggono vantaggi), reciprocità (quando una delle due parti riceve un vantaggio ritardato nel tempo), egoismo (quando uno dei due trae un beneficio a discapito dell’al-
* Comunicatrice della scienza, medical writer e scientific copywriter, collaboratrice di BioPills: il vostro portale scientifico.
tro), dispetto (quando nessuno dei due riceve vantaggi) e altruismo4.
Secondo la definizione più limitante, si parla di altruismo quando l’individuo attua un comportamento che apporta benefici a un altro essere vivente senza ricevere nulla in cambio, inclusa la gratificazione che può derivare dalla generosità1. In questo caso, non esisterebbero specie capaci di altruismo, dal momento che sembra che agli atti altruistici consegua praticamente sempre almeno un beneficio: le emozioni prosociali (il senso di benessere che deriva dall’essere generosi)2,5. Per questo, la maggior parte degli scienziati prende in considerazione definizioni più ampie di altruismo2, anche se secondo altri autori si tratterebbe invece di cooperazione6.
Comportamento prosociale e comportamento altruistico sono, in genere, definiti come atti positivi nei confronti di altri individui, spesso con il risultato di promozione del benessere di questi ultimi1. Le diverse definizioni di questi termini differiscono principalmente in base a 2 criteri: il tipo di individui coinvolti nello scambio e la presenza di reciprocità1,2
Alcuni autori ritengono che i comportamenti prosociali possano essere attuati nei confronti di un solo individuo, mentre secondo altre definizioni possono essere diretti nei confronti di più individui, anche interi gruppi1. Ad esempio, il citello di Belding (Spermophilus beldingi) è un roditore nordamericano che produce un fischio d’allarme quando vede avvicinarsi un predatore: questo lo espone maggiormente alla predazione, ma consente a tutto il gruppo sociale di mettersi al riparo4.
Discussioni più complesse emergono in merito a quali specie possono attuare altruismo. Alcuni autori ritengono che solo gli esseri umani possano essere altruisti, a causa delle loro capacità cognitive ed emozionali, ma la maggior parte della comunità scientifica ritiene che anche altre specie siano capaci di altruismo. In effetti, la complessità cognitiva
e la velocità di apprendimento sembrano caratteristiche non necessarie per l’emergere di comportamenti altruistici. Inoltre, non è ancora chiaro quanto gli atti altruistici si basino su caratteri derivanti dall’evoluzione e quanto da flessibilità decisionale7.
Anche il tema della consanguineità tra le parti di un atto altruistico è dibattuto: alcuni ritengono che gli unici beneficiari di altruismo possano essere solo familiari, altri che possano essere solo membri dello stesso gruppo sociale, altri ancora che, potenzialmente, possano includere tutti gli individui della stessa specie1,6. Il vampiro vero di Azara (Desmodus rotundus), tipico esempio di altruismo, vive in colonie di centinaia di individui. Ogni notte, alcune femmine vanno a procacciarsi del sangue, loro fonte alimentare. Un singolo individuo può raccogliere una grande quantità di sangue, al punto che può cederne una parte a un altro animale. Spesso lo condivide con i familiari, ma può darne anche ad altri individui estranei, che tenderanno a ricambiare il favore a distanza di tempo2,4,8
Altri autori estendono il fenomeno a individui di altre specie. Ad esempio, in alcuni casi i segnali di allarme prodotti a causa dell’avvicinamento di un predatore vengono recepiti anche da specie diverse da quella dell’individuo che comunica. Di fatto, chi emette il segnale si espone maggiormente a predazione con vantaggio sia del proprio gruppo sociale sia degli individui di altre specie1,4.

Esiste altruismo se ci sono benefici sul lungo termine?
Un comportamento che porta un beneficio a un altro individuo può far sì che, sul breve o sul lungo termine, il donatore riceva un beneficio in cambio. In caso di ritorno sul breve termine, non si parla mai di altruismo, bensì di mutualismo o cooperazione2,4,6. La cattura di una preda da parte di una leonessa è una forma di mutualismo perché si avvantaggia del pasto insieme alle compagne con cui lo condividerà. Invece, il dibattito ferve sulla possibilità di parlare di altruismo laddove l’individuo che ha attuato il comportamento di aiuto riceve un beneficio sul lungo termine. È il caso degli atti prosociali che vedono la restituzione di un favore: alcuni autori li annoverano tra gli atti altruistici, sotto la dicitura “altruismo reciproco”, mentre altri parlano soltanto di reciprocità. Ad esempio, in molti primati, gli individui appartenenti a un gruppo sociale dedicano gran parte del proprio tempo alla reciproca pulizia del pelo, il grooming. Gli etologi hanno osservato che in alcune specie, come nei babbuini (Papio cynocephalus), le coppie si alternano di frequente in questa attività4
Più spesso, gli etologi considerano propriamente altruistici gli atti prosociali reciproci che prevedono sacrifici più significativi, anche se sul lungo termine possono comportare vantaggi. Nelle specie con strategia riproduttiva K, gli individui che si accoppiano hanno una prole poco numerosa a cui dedicano molte cure. Questo comportamento parentale richiede grandi investimenti in termini di energia, tempo e difesa, che possono tradursi nella morte del genitore. Tuttavia, gli individui che lo attuano ne traggono un beneficio: la sopravvivenza della prole comporta un aumento della fitness, sebbene indiretto 2 .
Un meccanismo simile si ha nelle specie in cui alcuni individui giovani aiutano i genitori a crescere i fratelli più piccoli, come lo sciacallo dorato (Canis aureus)2, alcune ghiandaie del genere Aphelocoma, la cannaiola delle Seychelles (Bebrornis sechellensis) e il martin pescatore dalla cresta
(Megaceryle lugubris)4. Gli aiutanti al nido rinunciano (almeno sul breve periodo) a crearsi una propria famiglia, ma migliorano la sopravvivenza dei fratelli, che condividono con loro il 50% del DNA: in questo modo, aumentano comunque la propria fitness, anche se in misura minore che crescendo figli propri. In alcuni casi, aumentano anche le probabilità che i genitori sopravvivano, alimentando ulteriormente il proprio vantaggio indiretto perché incrementano la possibilità di nascita di nuovi fratelli. Alcune tra queste specie, tuttavia, vedono anche un aumento diretto nella fitness dei “babysitter”, perché questi possono ereditare il nido dei genitori. Molti autori definiscono l’aiuto al nido come una forma di altruismo facoltativo, poiché questi individui possono scegliere se aiutare i genitori o involarsi altrove. Ad esempio, la cannaiola delle Seychelles (Bebrornis sechellensis) diviene aiutante al nido soltanto laddove può incrementare la fitness dei genitori e ha scarse possibilità di riprodursi in autonomia2,4.
Caso particolare quello delle aiutanti al nido tra gli insetti eusociali, in cui vi sono poche femmine (spesso una sola per colonia) capaci di riprodursi e le altre, dette operaie, le aiutano a crescere le figlie. Negli imenotteri, i maschi sono aploidi: tutte le femmine che deriveranno da uno stesso padre avranno un identico corredo di geni paterni. Questo fa sì che le sorelle condividano circa il 75% degli alleli: di conseguenza, le operaie ricavano un beneficio indiretto di fitness molto più alto degli aiutanti al nido di altri gruppi di animali 4,7 .
L’altruismo nella specie umana
Se si considera la specie umana, le definizioni di altruismo si complicano. Un ulteriore fattore discriminante risulta essere l’intenzionalità. Secondo la visione intenzionalista, un comportamento è altruista quando chi lo attua intende apportare un vantaggio all’altro senza “secondi fini”, quindi privo del desiderio di ricevere premi in cambio o di evitare punizioni. In questa definizione, si ha un comportamento prosociale anche quando l’esito dell’azione risulta non essere benefico per il destinatario; ne sono un esempio i “genitori elicottero”, ovvero quei genitori che supportano i figli anche quando questi non ne hanno reale necessità. La presenza eccessiva finisce per minare l’autostima e la capacità di autogestione della prole. Nella visione consequenzialista, invece, l’altruismo è indipendente dalle motivazioni e consiste in comportamenti che portano uno svantaggio a chi lo attua e un vantaggio a un altro soggetto. In questa definizione, è possibile compiere atti altruistici involontari1. Un altro elemento di dubbio è il tipo di beneficio da considerare. Se in ambito evolutivo il vantaggio considerato è prevalentemente la fitness, negli esseri umani gli studiosi possono considerare anche altri aspetti, come i benefici economici (denaro, alimenti, tempo) e il benessere psicologico. Un aspetto significativo anche perché sono più difficili da valutare in studi scientifici1. Infine, alcuni sociologi e psicologi definiscono i comportamenti prosociali sulla base del contesto sociale: l’atto è considerato altruistico quando risponde a una norma sociale, una prescrizione non scritta a cui occorre attenersi per essere inclusi all’interno del gruppo sociale. Secondo questa visione, un comportamento è prosociale quando viene ritenuto tale dal gruppo, quindi non deve necessariamente apportare benefici agli altri. Tuttavia, in generale i comportamenti che le comunità ritengono altruistici in genere riflettono la necessità di apportare dei benefici alla comunità1. In effetti, nelle società umane è diffusa la punizione altruistica, la tendenza a detestare e penalizzare i disonesti, meccanismo che pare alimentare la cooperazione e l’altruismo6.
Ma allora esiste l’altruismo?
Secondo i modelli evolutivi, un gene altruistico non può

sopravvivere, perché sarebbe soverchiato dai geni egoistici2. Se un individuo riduce il proprio successo riproduttivo a favore di quello di un altro individuo, si parla di rompicapo darwiniano4. Alcuni modelli hanno tentato di spiegare questo fenomeno individuando i vantaggi evolutivi che starebbero dietro i comportamenti altruistici: meccanismi che “ripagano” l’altruista del suo atto.
Secondo il modello della selezione di gruppo (o group selection), l’altruismo sopravvive perché la selezione naturale opera a livello dei gruppi e non degli individui: i singoli altruisti sarebbero soverchiati dagli individui egoisti, ma i gruppi con più altruisti sopravviverebbero con più probabilità rispetto ai gruppi con più egoisti, perché la maggiore collaborazione li avvantaggerebbe evolutivamente2
In alcuni casi, l’altruismo può essere spiegato grazie ai legami di sangue. Secondo il modello della kin selection o selezione di parentela, gli atti altruistici sono rivolti nei confronti di parenti, e quindi risultano evolutivamente vantaggiosi perché promuovono la fitness in modo indiretto4. Questo modello spiega perché in molte specie animali gli individui si sacrificano molto più spesso per i propri parenti che per altri individui2,4. Un esempio è quello del citello di Belding: sono soprattutto le femmine a emettere il fischio di allarme, e lo fanno più spesso quando sono in prossimità di individui imparentati più o meno strettamente con loro4.
Un altro modello che spiega evolutivamente questi comportamenti di “sacrificio” è quello dell’altruismo reciproco, secondo il quale un individuo otterrà un beneficio sul lungo termine perché rivolge i comportamenti altruistici a individui che coopereranno2. Ad esempio, i delfini tursiopi (Tursiops truncatus)5, i corvi comuni (Corvus corax)8 e alcuni primati (come il tamarino edipo, Sanguinus oedipus) di fronte alla possibilità di scegliere se compiere atti egoistici o altruistici preferiscono i secondi, e spesso vengono ricambiati dai compagni6.
Tuttavia, tutti questi modelli, anche considerati contemporaneamente, non spiegano del tutto il fenomeno. Ad esempio, non riescono a spiegare evolutivamente alcuni fenomeni, come le cure alloparentali che alcuni individui possono rivolgere ad altre specie e atti altruistici senza ritorni. Nel babbuino verde (Papio anubis), i maschi adulti aiutano i compagni in difficoltà anche se non hanno ricambiato favori passati o se è improbabile che ne ricambieranno in futuro2.
Secondo il modello ASP (Altruism Selfishness Plasticity), il problema è posto nel modo errato. Infatti, le altre ipotesi si fondano sull’idea che l’altruismo sia una caratteristica che si tramanda geneticamente, in contrapposizione al “gene egoista”. Ma se, invece, entrambi i fenotipi fossero portati da uno stesso allele che può esprimersi in modo plastico rispetto alle condizioni ambientali? Il modello ASP, che sostiene questa ipotesi, trova riscontro in molte osservazioni. Ad esempio, negli imenotteri sociali la regina è “egoista” e le operaie sono “altruiste”, ma le differenze tra i ruoli dipendono esclusiva-
mente dal nutrimento che ricevono entro i primi 3 giorni di vita. In altre specie, le sanzioni sociali spingono gli individui ad agire altruisticamente in situazioni in cui altrimenti sarebbero egoisti. D’altronde, in molte specie uno stesso individuo può comportarsi altruisticamente oppure no in base alle circostanze, ad esempio rifiutando l’aiuto a un individuo che non ha ricambiato un favore precedente2. Lo si osserva nel vampiro vero di Azara: se gli individui che ricevono un pasto da un compagno si rifiutano di restituire il favore, non riceveranno più cibo nei momenti di difficoltà. In effetti, gli individui meno generosi vivono in media la metà degli altri2,4,8. Anche i gruccioni frontebianca (Merops bullockoide) e i suricati, da altruisti, in seguito a cambiamenti sociali possono divenire egoisti2
Verso definizioni più accurate
Le definizioni sono fondamentali, perché consentono di descrivere correttamente i fenomeni e di costruire la conoscenza, studio dopo studio. Laddove, invece, gli autori utilizzano lo stesso termine per fenomeni differenti e viceversa, si crea confusione, limitando la possibilità di avanzamenti nella ricerca. Perdipiù, in ambito psicologico e sociologico solo 1 articolo su 4 riporta la definizione di questi termini.
Secondo la metanalisi di Pfattheicher, Nielsen e Thielmann del 2022, è auspicabile uniformare le definizioni di comportamento prosociale e altruistico facendo riferimento a quelle già esistenti. Inoltre, sarebbe sempre buona norma specificare cosa si intende con questi termini per non rischiare fraintendimenti e utilizzarle di conseguenza, considerando tutti gli aspetti menzionati nella definizione e solo i comportamenti che rientrano in quelle casistiche1
1. Pfattheicher S, Nielsen YA, Thielmann I. Prosocial behavior and altruism: A review of concepts and definitions. Current opinion in psychology. 2022 Apr 1;44:124-9.
2. https://ethology.eu/do-animals-show-altruism/
3. https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/how-does-social-behavior-evolve-13260245/
4. Alcock J., 2017. Etologia, un approccio evolutivo. Zanichelli editore, terza edizione italiana. Copyright 2007, pp. 467-509. ISBN: 978-88-08-06799-9.
5. Lalot, M., Delfour, F., Mercera, B. et al. Prosociality and reciprocity in bottlenose dolphins (Tursiops truncatus). Animal Cognition. 2021 24: 1075–1086.
6. Gadagkar R. Cooperation. Encyclopedia of Ecology (Second Edition), Elsevier. 2019 3 281-284.
7. Reznikova Z. Altruistic Behavior and Cognitive Specialization in Animal Communities. In: Seel N.M. (eds) Encyclopedia of the Sciences of Learning, pp. 205-207. 2012.
8. https://www.apa.org/monitor/dec06/altruism
La teoria della criticità cerebrale per spiegare le relazioni fra alterazioni cerebrali e funzione nei pazienti neurologici
di Cinzia BoschieroÈstato di recente pubblicato uno studio intitolato “Recovery of neural dynamics criticality in personalized whole brain models of stroke” su «Nature Communications» che approfondisce il tema della predizione dei deficit neurologici nell’ictus attraverso modelli biofisici computerizzati dell’attività del cervello. I risultati dello studio sono dovuti ad una collaborazione internazionale tra team di fisici, neurologi e psicologi italiani ed esteri. Gli autori Rodrigo Rocha, Loren Kocillari, Samir Suweis, Michele De Grazia, Michel Thiebaut De Schotten, Marco Zorzi e Maurizio Corbetta, propongono una teoria della criticità cerebrale per spiegare le relazioni fra alterazioni cerebrali e funzione nei pazienti neurologici.
I ricercatori sottolineano “Mostriamo che i modelli dinamici del cervello intero personalizzati in bilico sulla criticità tracciano le dinamiche neurali, l’alterazione post-ictus e il comportamento a livello di singoli partecipanti”. La ricerca interdisciplinare nelle neuroscienze, ispirata dalla fisica statistica, ha suggerito che la dinamica neurale del cervello sano rimane vicino a uno stato critico, cioè in prossimità di una transizione di fase critica tra ordine e disordine, o tra attività oscillatoria asincrona o sincrona. Gli studiosi inoltre ipotizzano che i cambiamenti di criticità con il recupero dipendano da specifici meccanismi di plasticità o rimodellamento funzionale come mostrato in precedenti studi fMRI.
Ci sono diversi aspetti delle indagini approfondite in questo studio. In primo luogo, hanno utilizzato un modello stocastico del cervello intero per simulare la dinamica neurale su larga scala, utilizzando come input la connettività strutturale misurata direttamente di un paziente con ictus o un controllo sano. Va sottolineato che non hanno adattato le dinamiche risultanti alla connettività funzionale misurata empirica. La connettività strutturale è stata misurata in due punti temporali: tre mesi dopo l’ictus (t1) e un anno dopo l’ictus (t2) o
tre mesi di distanza nei controlli sani ed è stata utilizzata per costruire modelli personalizzati di tutto il cervello.
Le lesioni producono certamente deviazioni dalla normale connettività strutturale, ma queste alterazioni strutturali non corrispondono necessariamente ad un’alterazione di criticità. La dinamica critica risulta dalla combinazione di una topologia, determinata dalla connettività strutturale, e di un dato valore di eccitabilità. Il metodo utilizzato in questo studio consente di misurare gli scostamenti dalle criticità a livello di gruppo o nei singoli partecipanti, nonché il recupero delle criticità nel tempo. Il team di ricerca ha applicato una innovativa strategia del modello di calcolo ad una coorte unica di pazienti con ictus studiati in modo prospettico e longitudinale alla Washington University di St. Louis. Questa coorte è stata studiata con un’ampia batteria di test neurocomportamentali e risonanza magnetica strutturale-funzionale a due settimane, tre mesi e dodici mesi dopo l’ictus.
Questa coorte è rappresentativa della popolazione colpita da ictus sia in termini di deficit comportamentali, del loro recupero, sia della localizzazione del carico lesionale. In lavori precedenti, erano state caratterizzate le anomalie della connettività comportamentale, strutturale e funzionale in questa coorte e la loro relazione con il deterioramento comportamentale e il recupero. Nella terminologia di rete, gli ictus provocano un’acuta diminuzione della modularità che si normalizza nel tempo. Occorre sottolineare che i meccanismi fondamentali alla base delle dinamiche dell’attività cerebrale sono ancora in gran parte sconosciuti. La loro conoscenza potrebbe aiutare a comprendere la risposta del cervello a condizioni patologiche, come le lesioni cerebrali (ictus). Nonostante gli sforzi della comunità scientifica, si hanno pure troppo pochi dati inerenti i meccanismi alla base del recupero funzionale e comportamentale dei pazienti colpiti da ictus. Gli studiosi sono partiti dal fatto che
in fisica è noto da tempo che certi sistemi si trovano tra l’ordine e il caos in uno stato così detto “critico”.
In un materiale ferromagnetico, per esempio, i dipoli magnetici si allineano con i loro vicini per formare piccoli campi magnetici locali. La disposizione casuale delle loro direzioni impedisce la formazione di campi più grandi, spiegano all’Università di Padova, partner della ricerca. Quando però il materiale viene raffreddato alla temperatura critica, i campi si allineano in domini di dimensioni sempre più grandi. Una volta raffreddato fino a raggiungere una temperatura “critica”, i dipoli si allineano in tutto il materiale formando un campo unico. Le criticità come la transizione di fase ferromagnetica hanno caratteristiche distintive. Pertanto, le criticità sono state usate per descrivere molti fenomeni, dai ferromagneti ai terremoti o alla frequenza cardiaca umana ed è stato mostrato che anche il cervello potrebbe operare in prossimità di un punto critico, in cui tutti o buona parte dei neuroni hanno un comportamento collettivo e coordinato, che fornirebbe al sistema delle funzionalità ottimali, legate per esempio all’efficienza nella trasmissione delle informazioni, o alla velocità di risposta a stimoli esterni.
Se la criticità è effettivamente una proprietà fondamentale dei cervelli sani, allora le disfunzioni neurologiche alterano questa configurazione dinamica ottimale. Alcuni studi hanno riportato un’alterazione della criticità durante le crisi epilettiche, il sonno a onde lente, l’anestesia e la malattia di Alzheimer. Tuttavia, un test cruciale di questa ipotesi sarebbe quella di mostrare che alterazioni locali dell’architettura strutturale e funzionale del cervello causano anche una perdita di “criticità’” del sistema. Inoltre, se le alterazioni miglioreranno nel tempo, per esempio per una attività di fisioterapia, allora dovremmo osservare parallelamente il recupero del -

la criticità. Un’altra previsione è che se la criticità è essenziale per il comportamento, allora la sua alterazione dopo una lesione focale deve essere correlata alla disfunzione comportamentale e al recupero della funzione. Infine, i cambiamenti nella criticità dovrebbero anche essere correlati ai meccanismi di plasticità che sono alla base del recupero.
L’obiettivo del presente lavoro è stato quindi proprio quello di affrontare queste importanti domande attraverso un approccio interdisciplinare che combina neuroimmagini, neuroscienze computazionali, fisica statistica e metodi di scienza dei dati. In questa ricerca hanno usato in pratica l’ictus come modello patologico prototipo della lesione cerebrale focale umana e modelli computazionali dell’intero cervello per stimare la dinamica neurale, le alterazioni correlate nella criticità e nel comportamento e i meccanismi neurali sottostanti. Gli studiosi hanno mostrato che le lesioni da ictus generano uno stato subcritico caratterizzato da livelli ridotti di attività neurale, entropia e connettività funzionale, che si ripristina nel tempo parallelamente al comportamento.
Il miglioramento della criticità è associato a specifici rimodellamenti delle connessioni di materia bianca. Per simulare l’attività neurale a livello dell’intero cervello individuale il team di ricerca ha utilizzato il modello di plasticità omeostatica recentemente sviluppato. I dati sulla connettività strutturale erano disponibili per 79 pazienti, acquisiti tre mesi (t1) e un anno (t2) dopo l’esordio dell’ictus. Lo stesso studio include i dati di 28 controlli sani, acquisiti due volte a tre mesi di distanza. La differenza nell’intervallo di tempo tra ictus e controlli è che l’imaging di diffusione nei pazienti è stato ottenuto solo a tre e dodici mesi poiché il segnale di diffusione è altamente variabile all’inizio della lesione.
Sia a livello di singoli partecipanti che a livello di gruppo, i modelli di pazienti con ictus nella ricerca svolta mostrano una significativa perdita della dinamica critica a tre mesi che guariscono in media a un anno.
Ciò è coerente con la prima ipotesi che la criticità sia una proprietà della normale architettura strutturale del cervello. Successivamente, gli studiosi hanno esaminato le basi anatomiche delle modifiche della criticità cerebrale. Il recupero della criticità da tre a dodici mesi deve riflettere un cambiamento nella connettività strutturale sottostante. Pertanto, il team di ricerca ha appli -
cato le misure della teoria dei grafi per quantificare la topologia delle corrispondenti reti cerebrali strutturali e le alterazioni associate dopo il recupero dell’ictus. Hanno scelto il grado medio come misura della connettività di rete complessiva (densità), la modularità e l’efficienza globale come misure rispettivamente del grado di segregazione e integrazione della rete.
Inoltre, per quantificare il disturbo di connettività, hanno definito l’entropia della matrice di connettività omeostatica (HSC) in modo analogo all’entropia di connettività funzionale. Il team sottolinea:” Abbiamo ulteriormente caratterizzato l’organizzazione della rete cerebrale in termini di modularità (un indice di segregazione di rete) ed efficienza globale (un indice di integrazione di rete). Il modello riflette una configurazione di rete equilibrata che supporta la segregazione funzionale tra regioni cerebrali specializzate distinte consentendo l’integrazione funzionale. Tuttavia, l’ictus interrompe questo equilibrio. In sintesi, queste analisi indicano un rimodellamento delle connessioni della materia bianca da tre a dodici mesi dopo l’ictus che corrispondono a cambiamenti nell’organizzazione della rete.
Nelle informazioni supplementari forniamo ulteriori prove per questo rimodellamento”. I ricercatori hanno indagato quali connessioni fossero più fortemente legate all’alterazione e al recupero della criticità. A tal fine, hanno utilizzato un approccio di apprendimento automatico multivariato, basato su una regressione di Ridge convalidata in modo incrociato, per mettere in relazione le variabili di attività neurale del modello con la matrice di connettività strutturale. Questo approccio ha consentito loro di identificare i bordi e le sottoreti nell’intero cervello più fortemente correlati alla variabile di interesse. In primo luogo hanno pertanto indagato la relazione tra connettività strutturale e criticità, sia nei partecipanti sani che nei pazienti con ictus.
Una loro successiva analisi ha considerato la topologia di rete che coinvolge diverse reti funzionali e, nello specifico, hanno analizzato il collegamento medio tra coppie di reti funzionali. Infine, per verificare se i bordi predittivi di criticità facevano parte della normale architettura funzionale o riflettevano connessioni casuali, il team ha correlato il numero di bordi predittivi per ciascun nodo (ROI) con la forza del nodo corrispondente nella connettività funzionale media dei controlli sani.
L’elevata correlazione osservata in entrambi i punti temporali (ρ = 0,98 per i bordi positivi/negativi rispetto alla connettività funzionale del nodo) indica che i bordi predittivi non sono casuali, ma coerenti con la normale variabilità dell’architettura funzionale del cervello. I modelli del cervello intero di controlli sani hanno mostrato modelli stabili di attività neurale, sia nei punti temporali che negli individui. È importante comprendere le dina -
miche del modello nei partecipanti sani prima di considerare i cambiamenti nell’ictus. Gli studiosi evidenziano che hanno trovato una debole relazione tra dimensione della lesione e perdita di criticità. Non hanno studiato l’effetto della dimensione della lesione sulla disfunzione comportamentale, un argomento che intendono indagare ed approfonire in un lavoro futuro. Tuttavia, non si aspettavano un’influenza significativa della dimensione della lesione sui deficit comportamentali e sulle anomalie della connettività funzionale/strutturale post-ictus sulla base della letteratura.
I dati provengono da un ampio studio prospettico sull’ictus longitudinale descritto in precedenti pubblicazioni e il campione clinico include il set di dati di 132 pazienti con ictus (età media 54, deviazione standard 11, range 19-83; 71 maschi; 68 lesioni del lato sinistro) allo stadio subacuto (due settimane dopo l’ictus). La batteria neuropsicologica includeva 44 punteggi comportamentali in cinque domini comportamentali: linguaggio, memoria, motori, attenzione e funzione visiva. Questi domini sono stati scelti per rappresentare un’ampia gamma dei deficit più comunemente identificati nelle persone dopo un ictus. I dati per replicare tutte le figure e le tabelle sono forniti come dati di origine nello studio e sono anche depositati in Github (https://github.com/ CorbettaLab/Rodrigo2022NatComm) e Zenodo123 (https://doi.org/10.5281/zenodo. 6459955). Le singole matrici di connettività strutturale per controlli e pazienti sono state depositate nei repository Github e Zenodo. Il codice personalizzato per la modellazione della criticità è disponibile gratuitamente su https://github. com/CorbettaLab/Rodrigo2022NatComm e https:// doi.org/10.5281/zenodo.6459955. Il prof. Rodrigo Rocha (Dipartimento di Fisica dell’Università Federale di Santa Catarina, Florianópolis, Brasile) dice:” Abbiamo esaminato come le lesioni cerebrali modifichino la criticità utilizzando un nuovo approccio personalizzato di modellizzazione dell’intero cervello.
La teoria modellizza le dinamiche cerebrali individuali, cioè di un singolo paziente, sulla base di reti di connettività anatomica del cervello reali. Abbiamo studiato longitudinalmente una coorte di partecipanti sani e colpiti da ictus misurando sia la loro connettività anatomica che l’attività funzionale del cervello (attraverso la risonanza magnetica funzionale, nota come fMRI).
Per questi individui, infine, avevamo anche a disposizioni i risultati di test comportamentali. Abbiamo trovato,” sottolinea il prof. Rocha,” che i pazienti colpiti da ictus presentano, a distanza da tre mesi dall’ictus, livelli ridotti di attività neurale, della sua variabilità, e della forza delle connessioni funzionali. Tutti questi fattori contribuiscono a una perdita complessiva di criticità che però migliora nel tempo con il recupero del paziente.
Dimostriamo inoltre che i cambiamenti nella criticità predicono il grado di recupero comportamentale e dipendono in modo rilevante da specifiche connessioni della sostanza bianca. In sintesi, il nostro lavoro descrive un importante progresso nella comprensione dell’alterazione delle dinamiche cerebrali e delle relazioni cervello-comportamento nei pazienti neurologici”. Questi risultati dimostrano che modelli dinamici al computer sull’intero cervello possono essere utilizzati per tracciare e prevedere il recupero dell’ictus a livello di singolo paziente. Gli studiosi della ricerca pubblicata su Nature Communications hanno pertanto aperto a riflessioni molto importanti innquesto ambito. “Questo apre la possibilità di utilizzare questi metodo per misurare l’effetto di terapie quali la riabilitazione o la stimolazione non-invasiva”, spiega il prof. Maurizio Corbetta, Direttore del Padova Neuroscience Center (PNC) dell’Università di Padova e della Clinica Neurologica Azienda Ospedale Università Padova, e ricercatore del Venetian Institute of Molecular Medicine (VIMM). Questa ricerca è stata finanziata dal Research, Innovation and Dissemination Center per Neuromathematics (FAPESP) and the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), Brasil; European Research Council (ERC) H2020 (grant# 818521); Italian Ministry of Health (Grant# RF-2013-02359306); M.C. by the Italian Ministry of Research Departments of Excellence (20172022), CARIPARO foundation (Grant #55403), Italian Ministry of Health (Grant# RF-2018-12366899; RF2019-12369300), H2020-SC5-2019-2 (Grant # 869505); H2020-SC5-2019-2 (Grant # 869505). Altri recenti studi evidenziano che quasi due terzi dei pazienti con ictus ischemico acuto hanno almeno un fattore di rischio maggiore non diagnosticato, secondo una questa nuova ricerca. I più comuni sono la dislipidemia, l’ipertensione e la fibrillazione atriale. Questi risultati evidenziano la necessità di una maggiore consapevolezza da parte dei medici su come questa popolazione di pazienti possa avere fattori di rischio di ictus non riconosciuti.
I risultati sono stati presentati al Congresso dell’Accademia Europea di Neurologia (EAN) 2022. Ictus è un termine latino che significa “colpo” (in inglese stroke). Insorge, infatti, in maniera improvvisa: una persona in pieno benessere può accusare sintomi tipici che possono essere transitori, restare costanti o peggiorare nelle ore successive. In Italia l’ictus è la seconda causa di morte, dopo le malattie ischemiche del cuore, è responsabile del 9-10% di tutti i decessi e rappresenta la prima causa di invalidità. Ogni anno si registrano nel nostro Paese circa 90.000 ricoveri dovuti all’ictus cerebrale, di cui il 20% sono recidive. Il 20-30% delle persone colpite da ictus cerebrale muore entro un mese dall’evento e il 40-50% entro il primo anno. Solo il 25% dei pazienti sopravvissuti ad un ictus guarisce
completamente, il 75% sopravvive con una qualche forma di disabilità, e di questi la metà è portatore di un deficit così grave da perdere l’autosufficienza, stando ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità (rif. https://www.salute. gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?area=Malattie_cardiovascolari&id=28&lingua=italiano). L’ictus è più frequente dopo i 55 anni, la sua prevalenza raddoppia successivamente ad ogni decade; il 75% degli ictus si verifica nelle persone con più di 65 anni. La prevalenza di ictus nelle persone di età 65-84 anni è del 6,5% (negli uomini 7,4%, nelle donne 5,9%). La definizione di ictus comprende: ictus ischemico - si verifica quando un’arteria che irrora l’encefalo viene ostruita dalla formazione di una placca aterosclerotica e/o da un coagulo di sangue che si forma sopra la placca stessa (ictus trombotico) oppure da un coagulo di sangue che proviene dal cuore o da un altro distretto vascolare (ictus trombo-embolico); circa l’80% di tutti gli ictus è ischemico; ictus emorragico - si verifica quando un’arteria situata nell’encefalo si rompe, provocando così un’emorragia intracerebrale non traumatica (questa forma rappresenta il 15-20% di tutti gli ictus) oppure nello spazio sub-aracnoideo (l’aracnoide è una membrana protettiva del cervello; questa forma rappresenta circa il 3%-5% di tutti gli ictus); l’ipertensione è quasi sempre la causa di questa forma gravissima di ictus. Bisogna inoltre ricordare l’attacco ischemico transitorio o TIA (Transient Ischemic Attack), che si differenzia dall’ictus ischemico per la minore durata dei sintomi (inferiore alle 24 ore, anche se nella maggior parte dei casi il TIA dura pochi minuti, dai 5 ai 30 minuti). Si stima che circa un terzo delle persone che presenta un TIA, in futuro andrà incontro ad un ictus vero e proprio. In Italia il numero dei ricoveri per TIA attualmente supera i 30.000 l’anno. Presso l’ICS Maugeri di Milano un team multidisciplinare coordinato dal prof. Eugenio Parati sta realizzando altri progetti di analisi e supporto soprattutto utili alla riabilitazione post-ictus sulla base di analisi di dati correlati anche con questo studio.
• Hesse, J. & Gross, T. Self-organized criticality as a fundamental property of neural systems. Front. Syst. Neurosci. 8, 166 (2014).
• Linkenkaer-Hansen, K., Nikulin, V. V., Palva, J. M. & Ilmoniemi, R. J. Long-range temporal correlations and scaling behavior in human brain oscillations. J. Neurosci. 21, 1370 (2001).
• Haldeman, C. & Beggs, J. Critical branching captures activity in living neural networks and maximizes the number of metastable states. Phys. Rev. Lett. 94, 058101 (2005).
• Jiang, L. et al. Impaired functional criticality of human brain during Alzheimer’s disease progression. Sci. Rep. 8, 1324 (2018).
• Siegel, J. S. et al. Disruptions of network connectivity predict impairment in multiple behavioral domains after stroke. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 113, E4367–E4376 (2016).
Una disciplina sia scientifica, che si occupa dei rapporti degli esseri viventi fra loro e col mondo circostante, sia economica, poiché studia gli scambi di materia ed energia che stanno alla base della vita di Antonella Pannocchia
Ci proponiamo in questo articolo di effettuare una rilettura o lettura “ecologica” del XX secolo. L’ecologia è una disciplina scientifica, che si occupa dei rapporti degli esseri viventi fra loro e col mondo circostante; ed è pertanto una disciplina “economica” , in quanto studia gli scambi di materia ed energia, quelli che stanno alla base della vita, proprio come l’economia studia gli scambi di flussi di denaro fra gli esseri umani.
La vita “funziona” secondo questi scambi che si sono andati lentamente evolvendo nel corso di alcune migliaia di milioni di anni, accelerando nel corso degli ultimi 500 milioni di anni, con lenti mutamenti nella distribuzione planetaria delle acque e dei continenti, nella composizione chimica dell’atmosfera, nelle forme di vita vegetale e animale. Gli stessi nostri progenitori “umani”, quattro o tre o due milioni di anni fa, non differivano, come posizione “ecologica”, dagli altri animali terrestri.
La vera grande svolta nella storia “ecologica” del pianeta si è avuta circa diecimila anni fa quando alcune comunità umane si sono trasformate da raccoglitori di cibo vegetale (frutti, foglie, radici) e cacciatori di animali da cui trarre alimenti per la propria sussistenza, in coltivatori e allevatori, capaci di seminare e coltivare piante commestibili e di allevare animali da cui trarre cibo e pelli, nutrimento. Tale rivoluzione avvenuta nel Neolitico ha determinato la nascita della “proprietà”, per cui il terreno da coltivare, i raccolti ed il bestiame sono di “qualcuno”.
Tramite la detenzione o meno dei generi d cui sopra si è formata a una prima stratificazione in “classi”: quella di chi possedeva terreni e animal e quella di chi per acquistare il cibo, doveva vendere il proprio lavoro; in queste nuove società nasce la classe degli inventori-imprenditori, che comprende chi capisce che si possono staccare le pietre dalle montagne per fare case più solide, che alcune pietre, scaldate, si trasformano in oggetti metallici duri adatti per scavare meglio o per uccidere meglio prede o concorrenti. L’applicazione di queste attività “tecniche” comporta le prime modifiche all’ambiente
naturale circostante: la natura viene impoverita nelle sue risorse di suolo e di pietre e i suoi elementi (aria, acque, suolo) vengono contaminati con le scorie delle attività di trasformazione, anche se all’inizio ancora rudimentali.
Nello stesso tempo si forma la classe dei mercanti, coloro che ricercavano presso altri popoli e territori i beni materiali, mancanti nel loro paese, in cambio di altri beni materiali (sale o metalli in cambio di pelli o schiavi). Nel caso di territori riluttanti o esosi nel vendere i propri prodotti o beni, questi devono essere sottomessi; da questa necessità nascono l’imperialismo e le relative guerre. I re, i signori, i proprietari vogliono possedere e consumare beni sempre più numerosi, raffinati e speciali, al minore costo possibile il che accelera ulteriormente l’utilizzo di prodotti agricoli, di allevamenti animali, di cave e miniere di pietre e metalli e accelera di conseguenza i fenomeni di alterazione delle acque e del suolo e di inquinamento dell’aria.(1)
Nelle prime migliaia di anni dopo la rivoluzione del Neolitico le contaminazioni e i danni “ecologici” - dirette e inevitabili conseguenze dei fenomeni descritti sono rimasti relativamente limitati nello spazio, a causa della bassa densità della popolazione, anche se molti popoli ne hanno riconosciuto presto i segni. Si possono infatti citare la perdita di fertilità dei suoli dovuta all’eccessivo sfruttamento agricolo, la contaminazione delle acque, testimoniata da innumerevoli leggi emanate presso tutte le società umane; la distruzione dei boschi in seguito alle attività minerarie, con conseguente erosione e alluvioni, eccetera. Dalla lontana alba del Neolitico, lo sfruttamento e la trasformazione della natura da parte degli esseri umani e’ andato via via aumentando in conseguenza dell’aumento della popolazione terrestre e della crescente aspirazione degli uomini al possesso di crescenti quantità di merci. Le pressioni dell’uomo sulle varie aree del pianeta variano: nell’occidente europeo lo sfruttamento delle risorse naturali si fa più rapido e intenso a partire dal XVII secolo come risultato delle grandi invenzioni tecnico-scientifiche, del sorgere di una nuova classe di mercanti e imprenditori e di nuovi rapporti produttivi
nei quali l’uso delle risorse della natura non dipende più dal proprietario dei suoli o dall’inventore, ma viene mediato da chi possiede il denaro, per acquistare macchine, invenzioni e lavoro per produrre più merci e guadagnare più denaro.

Una storia “ecologica” del XX secolo ha il suo prologo nelle invenzioni del secolo precedente relative al perfezionamento nell’uso del carbone e dei minerali per produrre acciaio, nelle prime fabbriche chimiche di concimi per l’agricoltura, nelle stesse prime pratiche di riutilizzo dei rottami (di ferro, per esempio) o dei sottoprodotti e scorie dell’industria chimica per ricavarne nuove merci, anticipando quello che oggi si chiama riciclo, trattamento dei rifiuti, eccetera. Queste invenzioni, e le molte altre che caratterizzano la storia della tecnica del XX secolo, sono solo parzialmente motivate dal bisogno di liberare gli esseri umani dalla povertà e dalla fatica mentre l’aumento del denaro in circolazione; delle merci, dei patrimoni acquisiscono una importanza altrettanto rilevante.
Dal punto di vista della “storia ecologica” il XX secolo , è stato un secolo lungo, cominciato nei primi anni dell’Ottocento e durato circa duecento anni. Il cammino dei paesi (essenzialmente europei) nel XIX secolo si è svolto all’insegna di due grandi materie: il carbone e l’acciaio.
• Il carbone come fonte di energia e di materie prime industriali;
• l’acciaio come materiale da costruzione.
Carbone e acciaio hanno “liberato” l’umanità dalle precedenti fonti di energia e materiali, sostanzialmente dal fabbiso-
gno di legno usato come materiale da costruzione e come fonte di energia per la trasformazione del minerale di ferro in ferro, e hanno aperto le porte all’avvento di tre grandi protagonisti:
• le macchine, con cui è stato possibile aumentare la produzione di tessuti e alimenti per unità di capitale investito;
• l’elettricità, nuova fonte di energia ricavabile con macchine azionate dal moto delle acque o dal vapore generato in macchine termiche;
• la luce, ottenuta con l’illuminazione a gas, diffusa nella seconda metà del XIX secolo e poi con le lampade elettriche.
Se è vero che il carbone e l’acciaio hanno contributo a diminuire lo sfruttamento delle foreste, con una diminuzione dei relativi effetti negativi(2); si deve d’altro canto considerare che il carbone e l’acciaio hanno un significativo impatto sull’ambiente naturale sia dal punto di vista dello sfruttamento delle risorse minerarie che nelle fasi di trasformazione e utilizzazione. Le escavazioni minerarie er raggiungere i giacimenti di carbone e di minerali di ferro comportarono scavi sempre più profondi, la generazione di grandi quantità di scorie minerarie, imposero condizioni di lavoro minerario faticoso e insalubre.(3)
Inoltre quando il carbone era bruciato o quando carbone e minerale di ferro, insieme, venivano trattati negli altiforni, si producevano grandi masse di fumi e polveri che si rivelarono ben presto cancerogeni e tossici per le popolazioni che vivevano nelle vicinanze delle manifatture. La svolta del carbone e dell’acciaio ha comportato altre conseguenze: i giacimenti delle riserve di carbone e di minerali distribuiti in maniera ineguale nei vari paesi hanno determinato numerose guerre per la conquista dei giacimenti mentre i prodotti delle manifatture, con produzione di maggiori quantità di merci, comportano l’ampliamento dei mercati, da conquistare con le guerre coloniali, anche per accaparrarsi le numerose materie prime di quei territori.
Il carbone e l’acciaio garantirono l’avvio della meccanizzazione e della società delle macchine: le macchine erano in grado di produrre più merci a basso prezzo da offrire non solo alle classi agiate, ma anche alla nuova piccola borghesia industriale. Migliori condizioni di vita, i progressi nella medicina e una maggiore disponibilità di alimenti comportarono un rapido aumento della popolazione nei paesi industriali ed avviarono la grande reazione a catena che sta alla base del-
la economia moderna: maggiore domanda di beni materiali, maggiore produzione agricola e industriale, maggiore richiesta di macchine, maggiore richiesta di capitali, maggiori profitti. L’aumento della popolazione - 900 milioni nel 1800, 1650 nel 1900, fino ad arrivare a 6 milioni nel 2000 – ha provocato una crescente pressione sull’agricoltura, e sulle città, avviate a diventare grandi agglomerati urbani.
Nello stesso tempo gli spazi dei paesi europei cominciano a dimostrarsi stretti per gli abitanti , molti dei quali cercarono migliori condizioni di vita con l’emigrazione versi “le Americhe”, sia quella del Nord sia quella del Sud. Gli immigrati europei nel Nord America,furono indotti a cercare altri spazi, campi coltivabili, allevamenti e foreste da tagliare, verso le pianure dell’Ovest con la conseguenza della distruzione degli animali allo stato brado e dei nativi, che cercavano di difendere le loro terre, i loro pascoli e il loro modo di vivere: una economia molto povera ma molto in equilibrio con la disponibilità di risorse naturali.
La richiesta di alimenti diventava il fattore determinante dello sfruttamento delle terre, in Europa e in America. Le vecchie pratiche agricole, che consigliavano la rotazione delle colture, si rivelarono ben presto inadeguate davanti alla crescente richiesta di prodotti agricoli e zootecnici. Nella metà del XIX secolo i chimici, (4) studiarono il meccanismo della nutrizione vegetale e avanzarono le prime proposte per aumentare non solo la produzione assoluta di alimenti, ma soprattutto le rese per ettaro, la produttività, e quelle per addetto, parametro che garantisce al proprietario dei suoli un maggiore profitto per il suo capitale
Le guerre merceologiche: zolfo, nitrati
Il fattore limitante della produttività agricola è rappresentato dal contenuto di sostanze nutritive nel suolo, soprattutto dei sali di azoto, potassio, fosforo, elementi che in parte sono restituiti al suolo sotto forma di escrementi animali o umani. Tale apporto, con l’aumento di domanda dei raccolti, divenne troppo scarso e dovette ed essere integrato con l’aggiunta di concimi “artificiali” che potevano essere ricavati da giacimenti minerari quali i grandi giacimenti di nitrato sodico e di guano nell’altopiano cileno e dai giacimenti di fosfati abbondanti nell’Africa settentrionale e nella stessa America. Addirittura nel trattamento di minerali ferrosi fosforati, il fosforo, indesiderabile nella ghisa, poteva essere catturato dai rivestimenti alcalini dei forni inventati da Henry Bessemer (1813-1898) e le scorie potevano diventare concimi fosfatici (5 - 6). La crescente richiesta di concimi accelerò la crescita dell’industria chimica con immediate rilevanti conseguenze ecologiche. I minerali fosfatici e le scorie contengono del fosfato di calcio in forma non solubile nel terreno e quindi inadatta per essere assorbita dalle piante; già intorno al 1840 ci si rese conto che la soluzione andava cercata nel trattamento dei minerali fosfatici con acido solforico, una materia già prodotta industrialmente e utilizzata per la produzione del carbonato di sodio (7).
È proprio con l’industria della “soda”, richiesta per il lavaggio dei tessuti e per lo sbiancamento della carta, fino ad allora prodotta dalle ceneri delle piante, che comincia la storia dell’inquinamento come la conosciamo oggi.
Proprio nei primi anni del XIX secolo il medico francese Nicolas Leblanc (1742-1806) aveva inventato un processo per ottenere il carbonato di sodio trattando il sale (marino o di miniera) con acido solforico. Si formava acido cloridrico, un gas corrosivo, e solfato di sodio, che veniva poi trattato con carbonato di calcio e carbone e trasformato nella merce voluta, la soda, appunto, e in solfuro di calcio, un sottoprodotto fangoso, inquinante che liberava nell’aria il puzzolente idrogeno solforato.
Acido cloridrico e idrogeno solforato danneggiavano la salute di chi abitava vicino alle fabbriche e ne distruggevano le colture agricole, per cui nacque il primo movimento di contestazione. Dopo lunghi dibattiti politici furono creati i primi uffici per la lotta all’inquinamento (l’Alkali Inspectorate in Inghilterra) e furono emanate (siamo ormai nella metà dell’Ottocento), le leggi che costrinsero le fabbriche chimiche a recuperare l’acido cloridrico ( si scoprì così che l’acido cloridrico poteva essere trasformato a sua volta in merce vendibile: il cloro), e a trattare il solfuro di calcio per recuperare lo zolfo e l’acido solforico. Oltre che essenziale per l’industria della soda l’acido solforico era, come si detto, richiesto in crescenti quantità per la produzione di concimi. La materia prima per la produzione dell’acido solforico è stata per tutto il XIX secolo lo zolfo ricavato dalle miniere siciliane. Quasi un monopolio nelle mani di una classe di proprietari terrieri, improvvisatisi industriali, che cercavano di speculare sulla domanda di zolfo sfruttando la manodopera che lavorava in condizioni disumane, usando tecnologie arretrate. Gli ossidi dello zolfo che si liberavano nell’aria erano devastanti per l’agricoltura e per la salute umana. Furono così introdotte innovazioni tecniche per aumentare le rese di zolfo e la diminuzione dei costi di produzione. Interessante esempio di come la convenienza economica possa determinare la ricerca di soluzioni meno inquinanti a condizione di profitto. Lo sfruttamento dei giacimenti di zolfo siciliano ed il loro progressivo esaurimento, spinse gli acquirenti a cercare materie alternative che furono rappresentate dalla utilizzazione delle piriti spagnole, nella metà dell’Ottocento, e dalla scoperta, alla fine del XIX secolo, dei grandi giacimenti sotterranei di zolfo nel sottosuolo degli stati del Texas e della Louisiana, nel Nord America (8).
Abbastanza parallela alla storia dello zolfo è la storia dei nitrati. Necessari sia come concimi che come ingredienti per la fabbricazione della polvere da sparo, furono richiestissimi in epoca di guerre coloniali. L’unica fonte di nitrati era rappresentata dai giacimenti esistenti sull’altopiano cileno, al confine fra Cile e Bolivia. Una certa esportazione di nitrati era già cominciata nella prima metà del XIX secolo, ma la coperta del loro possibile impiego come nutrienti vegetali, provocò un brusco aumento della richiesta e dell’estrazione di nitrati dal
Cile che a sua volta determinò una serie di incidenti politici e militari fra Cile e Bolivia, culminati nella guerra del salnitro del 1880. La richiesta di nitrato sodico cileno fu accelerata anche dalle scoperte della nascitura industria chimica.
L’acido nitrico - ottenuto per trattamento del nitrato cileno con acido solforico - diventò reagente necessario per la sintesi dei coloranti e, soprattutto, dei due nuovi potenti esplosivi, nitroglicerina [(inventata dall’italiano Ascanio Sobrero (18121888 e stabilizzata con la scoperta della dinamite da parte di Alfred Nobel (1833-1896)] e nitrocellulosa. Le esportazioni cilene subirono alterne vicende e il prezzo aumentò con l’aumentare della richiesta dall’estero, anche perché il governo cileno aveva posto una pesante imposta sull’esportazione del prezioso materiale, un procedimento sia di protezione de monopolio nazionale, sia di guadagno, simile alle imposte applicate dai paesi esportatori sul petrolio, nella seconda metà del XX secolo.
Era quindi naturale che gli industriali, europei e americani, cercassero di rendersi indipendenti da una fonte di nitrati ormai sempre più indispensabile ma troppo costosa. (9)
Aspetti ambientali dei progressi della siderurgia
Il miglioramento del livello di vita e la diffusione di denaro, sia come profitto degli imprenditori che come salario del proletariato, innescarono la spirale che comportava una maggiore produzione di macchine e di tessuti. La razionalizzazione dell’industria tessile così come la fabbricazione di rotaie ferroviarie, cannoni, navi e treni, dipendeva in misura sempre più crescente dall’acciaio.
I progressi nella produzione dell’acciaio furono resi possibili dalla scoperta che i minerali di ferro potevano essere trattati utilizzando non il solo carbone fossile, ma anche un suo derivato: il coke, ottenuto scaldando ad alta temperatura il carbone. Durante la “distillazione secca” del carbone si libera una massa di sostanze volatili che ben presto si rivelarono tossiche e cancerogene, ma nello stesso tempo utili come fonti di materie prime per l’industria chimica dei coloranti e degli esplosivi.
Le zone siderurgiche europee (come la Ruhr) o americane (la Pennsylvania) diventarono i territori sporchi e fumosi in cui l’industria siderurgica crebbe e prosperò. Gli altiforni in cui il minerale di ferro veniva trattato con coke non fornivano solo ferro e acciaio, ma un prodotto intermedio, la ghisa, che doveva essere trasformata in acciaio per trattamento con aria a caldo: il già ricordato processo Bessemer ebbe un ruolo fondamentale in siderurgia, ma ben presto un crescente numero di macchinari andarono fuori uso e furono abbandonati rendendo disponibili grandi quantità di rottami di ferro. Furono così messi a punto i primi processi di “riciclo” dei rottami nei forni Martin-Siemens, fino ai più recenti forni elettrici con i quali oggi viene ottenuta dai rottami circa la metà dell’acciaio prodotto nel mondo. Altro esempio di utilizzazione di scorie e scarti.
La crescente popolazione mondiale ed il crescente numero di esseri umani che potevano chiedere migliori condizioni di vita fecero aumentare la richiesta della prima fondamentale merce, gli alimenti, che potevano essere forniti soltanto dall’agricoltura e dalla zootecnia. L’aumento delle rese agricole, grazie al crescente impiego di concimi, mostrò ben presto di provocare una diminuzione della fertilità dei suoli in una spirale che comportava più concimi, maggiori rese economiche, maggiore erosione del suolo, minore fertilità del suolo e quindi maggiori perdite ecologiche, più concimi, eccetera. Già nel corso dell’Ottocento si vide che la diffusione delle monocolture rendeva le piantagioni ecologicamente meno stabili e esposte all’attacco dei parassiti, che potevano essere combattuti con i prodotti forniti dall’industria chimica: i sali di rame e di arsenico a cui si sarebbero affiancati, nel XX secolo, i pesticidi sintetici sempre più dannosi per la vita vegetale e animale, per gli ecosistemi e per la salute umana.
La diffusione dell’organizzazione industriale della produzione e dei consumi portava alla creazione di agglomerati urbani in cui crescenti masse di popolazione si insediavano sempre più lontane dalle zone agricole: gli alimenti potevano arrivare alla città soltanto dopo essere stati sottoposti a processi di trattamento, di conservazione, di inscatolamento che comportavano un peggioramento della qualità nutritiva e consentivano frodi e falsificazioni, ma assicuravano lauti guadagni e distribuzione e consumo capillari. Alcuni governi decisero di emanare leggi per la difesa della salute e per il controllo chimico e microbiologico degli alimenti. In Francia la direzione del primo ufficio per la difesa dell’igiene degli alimenti fu affidata niente meno che al grande chimico Louis Pasteur. (10)
Le voci della protesta
Le conseguenze ecologiche negative della nascente società industriale - le premesse per gli eventi del XX secolo - misero in moto alcuni movimenti di idee che avrebbero avuto importanti conseguenze.
Si è già accennato alle prime leggi contro l’inquinamento atmosferico dovuto all’acido cloridrico, agli scarti del solfuro di calcio, agli ossidi di zolfo. Nello stesso tempo la diffusione di una cultura scientifica spinse un numero crescente di studiosi a interrogarsi sui rapporti fra esseri umani, e loro attività merceologiche, e l’ ambiente circostante.
L’inglese Charles Darwin (1809-1882) mosso dalla sua curiosità di naturalista intraprese il suo lungo viaggio (18311836) nei mari del Pacifico sulla nave Beagle, durante il quale ebbe modo per meditare sulla posizione dell’uomo nella natura. Le osservazioni di Darwin contribuirono a stimolare nuovi modi di pensare, introducendo consapevolezza dell’ interdipendenza fra gli esseri viventi e l’ambiente circostante. Il tedesco Ernst Haeckel (1834-1919) in un celebre libro del 1866, battezzò con il termine “ecologia”, l’insieme delle rela-
zioni attraverso le quali gli esseri umani modificano la natura. Una analisi molto lucida di tali relazioni è esposta dall’americano George Marsh (1801-1882) che mise in guardia contro i pericoli di una natura che “si vendica”, quando viene violentata ripetutamente (11).
Questa nuova attenzione per la fragilità della natura indusse alcuni governi, alla fine del XIX secolo, a istituire le prime “zone protette” e i primi parchi naturali, la cui bellezza e i cui valori naturalistici dovevano essere sottratti alla speculazione umana. Non a caso proprio nei decenni trionfanti del capitalismo americano, compaiono gli scritti dell’anarchico americano Henry Thoreau (1817-1862) e il suo invito ad un atteggiamento non predatorio e rispettoso della natura (12-13).
Darwin, Haeckel, Marsh, sono contemporanei di Marx (1818-1883) ed Engels (1820-1895) che, pur centrando la loro analisi sui caratteri del capitalismo, riconobbero nel modo di operare capitalistico le vere radici non solo dello sfruttamento dell’uomo, soprattutto delle classi proletarie, ma anche della formazione di deformi città, di rottura dell’equilibrio, del “ricambio organico”, fra uomo e natura.
La guerra come fonte di distruzione della vita, ma anche della natura
Nel XIX secolo, con le guerre coloniali, motivate dalla fame delle risorse naturali ed economiche, ( dalle miniere di ferro, carbone, salnitro, alla gomma, all’indaco) il processo di sfruttamento a favore delle industrie chimiche e meccaniche in rapida crescita ed evoluzione continua. Le poche organizzazioni umanitarie (la Croce Rossa fondata nel 1864) e poche voci di pacifisti avevano potuto fare ben poco. In questo contesto un sovrano non certo pacifista e certamente reazionario, come lo zar Nicola II, chiamo’ a raccolta i regnanti mondiali in una conferenza che sarebbe stata la prima conferenza mondiale della pace che si svolse nel 1899 all’ Aja. La conferenza si concluse senza nessun impegno per evitare l’impiego di armi di distruzione di massa, e azioni che colpissero la popolazione civile con effetti sulle campagne e sulla natura, e che arrecassero inutili dolori e sofferenze ai soldati, eccetera. Eventuali decisioni furono rimandate ad una seconda sessione, tenutasi nel 1907; e ad una terza conferenza sulla pace che avrebbe dovuto tenersi nel 1914.
L’altro grande evento del XIX secolo che avrebbe avuto grandissimi effetti ecologici nel XX secolo si ebbe nella metà del 1800 quando un oscuro “colonnello” americano, Edwin Drake (1819-1880), nello scavare il sottosuolo della Louisiana per cercare dei giacimenti di sale (altra materia prima per la nascente industria chimica della soda e dei prodotti per lavare), si imbatté in un giacimento di un liquido nerastro, il petrolio, di cui si conoscevano altri giacimenti in Russia, Romania e perfino nella Valle Padana. Utilizzato su scala limitata per alcuni decenni, il petrolio attrasse l’attenzione degli scien-
ziati che scoprirono che, scaldando il petrolio ad alta temperatura, si ottenevano varie “frazioni”, gassose e liquide, ed un residuo bituminoso. Tutti i prodotti ottenuti per “distillazione frazionata” del petrolio erano combustibili, trasportabili più facilmente del carbone, e pertanto potevano sostituire il carbone come fonti di calore e di energia.
Quasi contemporaneamente alla scoperta di Drake in America, un inventore toscano, Eugenio Barsanti (1821-1864), costruì un motore che, anziché essere azionato dal vapore generato dalla combustione del carbone, poteva essere azionato dai gas che si formano quando, all’interno di un cilindro, un liquido combustibile reagisce con l’ossigeno dell’aria. Il primo carburante del nuovo “motore a scoppio” fu l’alcol etilico, ma ben presto si scoprì che le frazioni “leggere” ricavate dal petrolio funzionavano benissimo per questo motore.
A differenza delle macchine a vapore, grandi e ingombranti, condannate a trascinarsi dietro o a tenersi accanto le riserve del voluminoso carbone, i motori a combustione interna potevano essere di modeste dimensioni, e necessitavano solo di piccoli e comodi serbatoi per il combustibile liquido. Ideali per incontrare il favore della nuova borghesia che voleva liberarsi dalle carrozze a cavalli, lente e scomode per muoversi più agevolmente su maggiori distanze su veicoli leggeri, veloci e indipendenti. Veicoli che si muovevano da soli : le auto-mobili. Il motore a combustione interna si presentava come la soluzione perfetta.
L’altra grande rivoluzione tecnica, la scoperta dell’elettricità, era cominciata proprio all’inizio del secolo lungo quando il fisico comasco Alessandro Volta (1745-1827) scoprì che dal contatto fra due metalli si genera un movimento di energiaquella che si sarebbe chiamata elettricità - capace di attrarre
metalli e di mettere in movimento una ruota, di scomporre dei sali disciolti in acqua, di scaldare un filamento metallico fino all’incandescenza tanto da farne una sorgente di luce. L’elettricità , generata da dinamo azionate dal moto dell’acqua o da macchine a vapore o dalle cascate d’acqua, avrebbe potuto rimpiazzare in alcuni processi chimici e metallurgici il carbone e il petrolio, scomponendo minerali resistenti liberando nuovi metalli come l’alluminio, il prezioso metallo leggero adattabile a diverse manifatture. La diffusione delle centrali idroelettriche fu accompagnata da profondi interventi sul suolo, dallo sbarramento di valli mediante dighe, dal rimodellamento del corso dei fiumi.
La conquista della gomma L’elettricità può muoversi soltanto entro fili metallici, soprattutto di rame, che devono essere isolati; le ruote dei carri, delle biciclette e delle automobili, richiedevano un materiale elastico, la gomma, ricavata da alberi presenti soltanto nelle foreste dell’Amazzonia brasiliana e da essi ricavata per tutto il XIX secolo. Gli usi della gomma si moltiplicarono dopo la scoperta, nel 1839 da parte dell’americano Charles Goodyear (1800-1860), del processo di vulcanizzazione che rendeva la gomma molto più resistente di quella greggia; nei decenni successivi la richiesta della gomma brasiliana aumentò rapidamente.
Il governo brasiliano stabilì un monopolio sulla gomma, vietando le esportazioni dei semi di Hevea, e l’estrazione della gomma attrasse folle di uomini che, sfruttati dai proprietari terrieri e pagati a cottimo, estraevano il lattice della gomma incidendo la corteccia delle piante di Hevea senza alcuna pre-
cauzione, distruggendone un gran numero.(14).
La necessità della gomma rese necessaria una penetrazione profonda nelle foreste dell’Amazzonia alla ricerca delle piante di Hevea e che si lasciò dietro un vero e proprio disastro ecologico. Fu un emblematico esempio di super-sfruttamento delle risorse della natura con conseguente distruzione della fonte stessa della ricchezza così avidamente conquistata. Così dopo una breve parentesi di ricchezza per il Brasile, il monopolio fu infranto da nuove coltivazioni di Hevea nelle colonie inglesi, francesi e olandesi del sud-est asiatico e il Brasile si trovò nella necessità di ricostruire le foreste distrutte e razionalizzare l’estrazione della gomma. (14)
La chimica e le nuove merci
Il XX secolo è stato preparato da una serie di eventi concatenati che hanno avuto anch’essi origine nel secolo precedente. I grandi viaggi intorno al mondo avevano mostrato che la natura è ricca di beni materiali in grado di alimentare industrie e commerci e di soddisfare bisogni umani - sostanze nutritive, coloranti, fibre tessili, gomma, resine, legnami, combustibili. Le conquiste coloniali hanno fatto cadere le fonti di molte di tali materie nelle mani di un numero limitato di paesi. In questo contesto, stante lo sviluppo rapido delle conoscenze scientifiche, era naturale che i chimici fossero tentati di “copiare la natura” e di riprodurre alcune di tali merci nei loro laboratori e poi nelle industrie.
Il catrame che si forma nel processo di cokizzazione dell’industria siderurgica per molto tempo ha trovato applicazione limitata soltanto per la protezione dei pali di legno e delle traversine ferroviarie; quando i chimici capirono che dai residui della cokizzazione si potevano ottenere con opportuni frazionamenti o per sintesi:
• sostanze adatte a tingere i tessuti (nel 1856 fu prodotta dall’inglese Henry Perkin (1838-1907) la prima sostanza colorante sintetica, la malveina; nel 1859 cominciò la produzione industriale della fucsina, o rosso Magenta)
• esplosivi come il trinitrotoluolo, (più conosciuto come tritolo)
• fibre tessili artificiali
• gomma artificiale
fu chiaro che le relative industrie di produzione potevano sorgere dovunque ci fossero buoni chimici, buoni laboratori e buone università. Inghilterra, Francia, Germania, e poi gli Stati Uniti d’America, diventarono ben presto i grandi centri della nascente industria chimica.
La “materia prima” per le sintesi organiche non era soltanto rappresentata dal catrame, dai minerali o dai derivati petroliferi: anche l’elettricità acquisì un importante ruolo quando fu scoperto che i concimi azotati, fino allora ottenuti, come si è ricordato, dal salnitro e dallo zolfo, potevano essere ottenuti dal carbone e dai gas dell’aria con reazioni rese possibili dall’elettricità: la calciocianammide e l’acido nitrico (importanti come concime, ma anche per le sintesi della chi-
mica organica), ottenuti al forno elettrico potevano assicurare ai paesi industriali la liberazione dal monopolio del Cile o della Sicilia. In ciascuna delle operazioni di frazionamento e trasformazione tipiche dell’ industria chimica solo una parte della materia di partenza si trasformava in merci; il resto era costituito da fanghi, emissioni gassose, e residui inquinanti che venivano scaricati nei fiumi, nel mare, in aria. Cominciavano così i grandi fenomeni di inquinamento che si riconoscono ancora oggi nelle grandi aree industriali del mondo.
L’elettricità era destinata ad avere un ruolo importante in un processo alternativo a quello Leblanc di produzione del carbonato di sodio ma era anche destinata ad avere un ruolo fondamentale nella metallurgia quando, nel 1854, l’inventore francese Henri Saint-Claire Deville (1818-1881) scoprì che partendo da prodotti dell’ argilla, con l’elettricità si otteneva un nuovo straordinario metallo, l’alluminio. Leggero, bello, resistente e comodo. La sua produzione su larga scala, sempre per via elettrolitica e con rilevanti effetti inquinanti, divenne possibile a partire dal 1887 in seguito alle contemporanee invenzioni dell’americano Charles Hall (1863-1914) e del francese Paul-Louis-Toussaint Héroult (1863-1914).
Il XX secolo si apre quindi con molte invenzioni importantissime: l’elettricità, (generata dal moto delle acque o dalle turbine azionate dal vapore), la raffinazione del petrolio, l’automobile, l’alluminio, che hanno dato nuovo volto, successo e aggressività all’imprenditoria capitalistica che andava affermandosi. Tutti gli eventi “importanti” del XX secolo - la prima guerra mondiale (1914-1919), le guerre e rivoluzioni fasciste, la seconda guerra mondiale (1939-1945), le guerre di repressione delle ribellioni delle colonie, la lunga guerra “fredda” fra paesi capitalistici (“a libero mercato”) e paesi comunisti (“a economia pianificata”) (1945-1989), sono stati legati ad eventi “merceologici” come la conquista di materie prime o di mercati, e hanno accelerato anche gli effetti negativi sull’ambiente naturale dell’intero pianeta..
La nascita dei grandi agglomerati urbani, era accompagnata da un crescente inquinamento dell’aria e dei fiumi, dall’accumulo di cumuli di rifiuti maleodoranti che determinavano una ambiente insalubre per i lavoratori e gli abitanti dei sobborghi operai. Tale situazione, tipica dell’ età vittoriana, molto ben descritta e documentata da scrittori e sociologi soprattutto inglesi e francesi, avrebbe continuato a caratterizzare la crescita urbana per tutto il Novecento. L’attrazione esercitata sulle masse dalla speranza di un lavoro urbano metteva a disposizione delle fabbriche una grande massa di mano d’opera che poteva essere sfruttata con bassi salari e con scarse condizioni di vita. Nasce in questo quadro un movimento di “ecologia di fabbrica” per la difesa delle condizioni di vita umane nelle officine, nei campi, nelle miniere come testimoniato da alcuni autori. (15-16)
Negli ultimi decenni del XIX secolo nascono i grandi movimenti socialisti per condizioni di lavoro meno disumane (limitazione dell’orario di lavoro, limitazioni dello sfruttamento
del lavoro dei ragazzi e delle donne) e la domanda di leggi per la difesa della salute dei lavoratori stessi.
La radioattività si affaccia sul Pianeta
Alla fine del XIX secolo, nel 1896, il fisico francese Henri Becquerel (1852-1908) scoprì che un sale di uranio fosforescente emette non solo luce, ma anche una radiazione diversa; questa, come i raggi X scoperti poco prima, poteva attraversare un foglio di carta nera e impressionare una lastra fotografica. Due anni dopo, ancora a Parigi, i coniugi Pierre Curie (1859-1906) e Marie Curie (1867-1934) scoprirono che nei minerali contenenti uranio era presente un “nuovo” elemento, il polonio, così chiamato in onore del paese di origine della signora Curie, che emetteva i misteriosi “raggi Becquerel” e un altro elemento ancora, il radio, due milioni e mezzo di volte più ricco di radiazioni dell’uranio. Nel 1900 l’inglese Ernest Rutheford (1871-1937) osservò che le radiazioni emesse dall’uranio sono di due tipi diversi: i raggi alfa e i raggi beta, Rutheford, insieme a Soddy (1877-1956), interpretarono la natura della radioattività e giunsero alla conclusione che l’atomo non è la particella ultima e indivisibile della materia, ma che le trasmutazioni radioattive naturali si spiegano solo con la scissione dell’atomo e l’emissione di energia.
Becquerel e i coniugi Curie ricevettero nel 1903 il premio Nobel per la Fisica. Nello stesso anno Pierre Curie scoprì che il radio sviluppa del calore, in quantità piccola in valore assoluto, ma enorme in relazione al piccolo numero di atomi che ne erano responsabili. Questa scoperta indicò che esiste un’enorme quantità di energia all’interno della materia; ancora nel 1903 Rutheford scoprì che i raggi alfa sono costituiti da particelle di materia dotate di carica positiva. Nel 1905 Albert Einstein (1879-1955) pubblicò la sua relazione sull’effetto fotoelettrico affacciando l’idea dell’equivalenza fra la massa e l’energia, entrambi aspetti interconvertibili della stessa proprietà.
Ci sarebbero voluti altri quarant’anni di ricerche e scoperte della fisica per arrivare a capire che il nucleo dell’atomo di alcuni elementi può scomporsi in frammenti più piccoli con liberazione di energia e che l’energia liberata dalla fissione nucleare può diventare un nuovo strumento di morte o una nuova fonte di energia.
Dal 1940 l’umanità convive con la consapevolezza delle enormi potenzialità e della vastità dei possibili utilizzi di questa nuova forza che può compromettere la vita umana e quella degli organismi vegetali e animali, distruggere il cancro, provocare varie forme di tumori a seconda dell’impiego che se ne fa.
Come detto, l’industria chimica offriva nuovi strumenti per liberare i paesi industriali dal monopolio del nitro cileno, essenziale per far aumentare la fertilità dei campi, per aumentare le rese e le produzioni agricole e per l’industria degli
esplosivi.
Il XX secolo si apre con la prima invenzione di un processo per tale sintesi, basato sulla combinazione diretta dell’azoto e dell’ossigeno dell’aria a circa 3000 gradi: dopo vari anni di studi e alcuni insuccessi, il processo fu applicato per la prima volta nel 1902 su scala industriale in una fabbrica che utilizzava l’elettricità fornita dalle centrali alimentate dall’acqua delle cascate del Niagara, ma fu perfezionato dai norvegesi Kristian Birkeland (1867-1917) e Sam Eyde (1866-1940) che nel 1905 arrivarono ad un processo con alti rendimenti, anche se con alti consumi di elettricità. Il sistema era attraente dove l’elettricità costava poco, come in Norvegia, ma mostrava limiti nelle altre situazioni, tanto che sempre agli inizi del XX secolo, fu sviluppato il processo di fabbricazione di un altro concime azotato, la calciocianammide, che si forma trattando con azoto il carburo di calcio (a sua volta ottenuto in forno elettrico da calce e carbone).
La vera grande crescita dell’industria dell’azoto si ebbe però , in seguito agli studi, condotti fra il 1905 e il 1907, da Fritz Haber (1868-1934) e W. H. Nernst (1864-1941) sulle reazioni ad alta pressione fra idrogeno e azoto. Non a caso il processo fu sviluppato in Germania dove le grandi riserve di carbone assicuravano la fonte da cui ottenere idrogeno, per reazione con acqua, e azoto, per reazione con l’aria; intorno al 1910 fu costruito il primo impianto per la produzione dell’ammoniaca sintetica, dalla quale facilmente era possibile ottenere concimi azotati e l’acido nitrico indispensabile per scopi bellici. La scoperta e applicazione industriale dalla sintesi dell’ammoniaca segnavano l’inizio della crisi dell’industria cilena dei nitrati, destinata rapidamente a declinare anche per l’esaurimento ormai in atto, dei giacimenti più ricchi e sfruttabili a più basso costo e con maggiori profitti.
Quindi, facendo passare l’elettricità attraverso una soluzione di cloruro di sodio era possibile ottenere, due importanti merci chimiche, l’idrato di sodio e soprattutto il cloro, ottenendo inoltre come terzo co-prodotto dell’elettrolisi l’idrogeno, un gas leggero che si rivelò ben presto ideale per caricare i palloni aerostatici, veicoli volanti più leggeri dell’aria che avrebbero avuto un ruolo importante durante la Prima guerra mondiale (1914-1919) e nei primi passi dell’aviazione intercontinentale. Il processo elettrolitico per la produzione della soda e del cloro aveva altri sottoprodotti. Il cloro trovò ben presto anche utilizzazioni militari come “gas asfissiante” direttamente e nella forma dei suoi derivati devastanti, il fosgene e l’iprite, con collaudi immediati nella Prima guerra mondiale e in Abissinia.
Si sono già citati i grandi successi nel campo della chimica specialmente nella sintesi delle sostanze coloranti, indispensabili per la tintura delle fibre e dei tessuti di cui la popolazione mondiale in aumento determinava una crescente richiesta. Le merci sintetiche ottenute, spesso a basso prezzo, con limitata richiesta di mano d’opera e su scala industriale fecero ben presto concorrenza a quelle naturali. Nella metà del XIX secolo
le sostanze coloranti disponibili erano in numero limitato e tutte dipendenti da piante, insetti, alberi: l’indaco coltivato su larga scala in India e fonte di reddito per numerosi villaggi, il guado, la malva, la cocciniglia, lo scarlatto della robbia del Brasile, il rosso del legno Brasile, i tannini. La fabbricazione artificiale o sintetica di molte di tali materie determinò in molti paesi poveri del mondo drammatiche situazioni di crisi e creò le condizioni sociali e politiche per grandi movimenti di liberazione delle colonie. La storia di Gandhi e del movimento di liberazione dell’India dall’Inghilterra affonda le radici nella grande crisi economica provocata dalla fine delle esportazioni dell’indaco.
1. G. Nebbia, La violenza delle merci, Mestre, Ecoistituto, 1999;
2. G. Nebbia, “Premesse culturali dell’attuale crisi ecologica”, in: L’uomo e l’ambiente, una inchiesta internazionale, a cura di G. Nebbia, Milano, Tamburini, 1971, p. 25-54);
3. W. S. Jevons (1835-1882) economista inglese dell’Ottocento anticipò i pericoli nel celebre libro The Coal Question (1865; seconda edizione 1866; terza edizione London, Macmillan, 1906; traduzione italiana parziale in “Quaderni di Storia ecologica”, I (1992), n. 2, pp. 1-250);
4. Justus von Liebig ( 1803-1873) Man’s role in changing the face of the Earth, a cura di W. L. Thomas Jr., Chicago, Chicago University Press, 1956, ristampa 1971;
5. Walter Ciusa (1906-1989): I cicli produttivi e le industrie chimiche fondamentali, Bologna, UPEB, 1948, e Aspetti tecnici ed economici di alcuni cicli produttivi, Bologna, Zuffi, 1954)
6. A. Clow e N. Clow, The Chemical Revolution: A Contribution to Social Technology, London, The Batchworth Press, 1952, ristampa 1993;
7. G. Nebbia, “La rivoluzione chimica, 1750-1900”, in: Autori Vari, Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1970, vol. II, p. 527-546);
8. G. Nebbia e G. Laeng, Lo zolfo e le industrie derivate, Brescia, La Scuola editrice, 1956;
9. A. Zischka, La scienza contro i monopoli, Milano, Bompiani, 1937;
10. G. Nebbia e G. Menozzi Nebbia, “Breve storia delle frodi alimentari”, in Alimentazione e salute, a cura di S. Canepari e altri, Forlì, Monduzzi, 1986, p. 60-68;
11. G. Marsh. L’uomo e la natura, ossia la superficie terrestre modificata per opera dell’uomo, Firenze, Barbera 1872; ristampa Milano, Angeli, 1988;
12. H. Thoreau, Walden o la vita nei boschi, originale inglese del 1854;
13. varie traduzioni di P. Kropotkin (1842-1922), ispiratori di Lev Tolstoi (1828-1910) e poi di Gandhi (18691948);
14. G. Nebbia, La gomma, Brescia, La Scuola editrice, luglio-agosto 1955);
15. B. Russell, Storia delle idee del XIX secolo, edizione originale 1934, traduzione italiana, Torino, Einaudi, 1950, poi Milano, Mondadori, 1961, 1970;
16. S. Merli, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale, Firenze, La Nuova Italia, 1972).
La PCOS viene anche riclassificata come una malattia metabolica, con sintomi evidenti quali l’aumento dei trigliceridi, del colesterolo lipoproteico a bassa densità e dell’insulina
di Giuseppe PalmaLa Sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è ampiamente riconosciuta come un disturbo endocrino che colpisce quasi il 10% delle donne in età riproduttiva. La PCOS è caratterizzata da iperandrogenismo (1), disfunzione ovarica unitamente ad una sindrome metabolica. I sintomi principali sono l’irsutismo, le mestruazioni irregolari e le cisti ovariche. La PCOS viene anche riclassificata come una malattia metabolica, con sintomi evidenti quali l’aumento dei trigliceridi, del colesterolo lipoproteico a bassa den -
sità e dell’insulina (2). Dal momento che il numero di donne che soffre di PCOS aumenta e il meccanismo della PCOS non è ancora chiaro, alcuni studi suggeriscono un interrelazione con il microbiota vaginale e/o intestinale.
Poiché il microbiota è in equilibrio dinamico in donne sane, contrariamente in donne affette da PCOS la sua composizione è sbilanciata. È stato ampiamente dimostrato che la disbiosi del microbiota (3) si verifica sia in modelli animali di PCOS che in donne con PCOS.

Recenti evidenze sottolineano come il microbioma vaginale nei pazienti con PCOS sia nettamente differente da quello di donne in età pre-puberale e in post-menopausa. Ciò indica che il microbioma del tratto genitale inferiore sarebbe principalmente influenzato dall’età, dal livello degli ormoni sessuali e dalle abitudini di vita e così via (4). Tra questi fattori, le mestruazioni irregolari e livelli ormonali anormali sono riconosciuti come le due ragioni principali che portano all’alterazione del microbioma vaginale nelle donne con PCOS. Mestruazioni normali con cambiamenti regolari di estrogeni e progesterone guiderebbero i cambiamenti fisiologici delle cellule epidermiche nel tratto riproduttivo a mantenere il microambiente equilibrato (incluso un microbiota equilibrato). Al contrario, mestruazioni irregolari nelle donne con PCOS porterebbero ad una disbiosi della composizione dei microbiomi del tratto genitale inferiore. Alcuni studi hanno evidenziato come la composizione del microbioma del tratto genitale inferiore, dei microbiomi vaginali e dei microbiomi del canale cervicale di donne PCOS e donne sane presenta una significativa differenza nell’ abbondanza di taxa, con una diminuzione significativa nella composizione di Lactobacillus (Tabella 1).

D’altra parte, altri microbiomi come Gardnerella vaginalis (5), possono essere associati alla promozione dell’insulino-resistenza (9), ai disturbi ormonali
ed all’ infiammazione nelle donne con PCOS. Secondo queste evidenze, è stato ipotizzato che il microbiota potesse essere coinvolto nella patogenesi della PCOS promuovendo la resistenza all’insulina, guidando la fluttuazione degli ormoni sessuali e regolando il sistema immunitario ed altri meccanismi patologici.
Allo stesso modo sono presenti in abbondanza Chlamydia trachomatis e Prevotella, questi microbiomi sono considerati potenziali taxa patogeni nella vagina e nel canale cervicale. Il loro aumento, suggerisce una conseguente diminuzione di Lactobacillus spp., è associato ad infertilità, aborto, ricorrente fallimento dell’ impianto e altri esiti avversi della gravidanza (6).
Inoltre, alcuni studi hanno riportato che Gardnerella e Prevotella (7) sono legate alle vaginosi batteriche (BV), che diminuirebbero la probabilità dell’impianto dell’embrione e persino la crescita del feto. Queste popolazioni microbiche potrebbero essere collegate alla sintomatologia delle donne con PCOS che sono spesso affette da disturbi di infertilità, aborto e molti altri esiti riproduttivi avversi.
Diversi studi hanno evidenziato che sono presenti cambiamenti del microbiota nelle donne con PCOS rispettivamente a livello di phylum, famiglia e genere. Uno studio pilota ha riportato (8) l’abbondanza di Tenericutes phylum, mentre i ceppi ML615J-28 e
S24-7 sono diminuiti nelle donne con PCOS; inoltre è stata notata una ridotta abbondanza di Akkermensia e Ruminococcaceae, mentre è presente un aumento del livello di Bacteroides ed Escherichia/Shigella nelle donne con PCOS. È interessante notare che gli
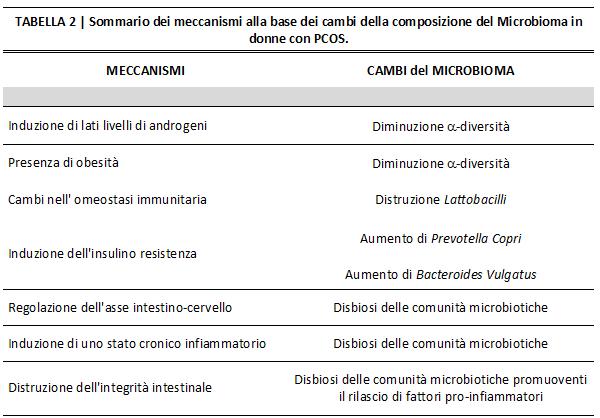
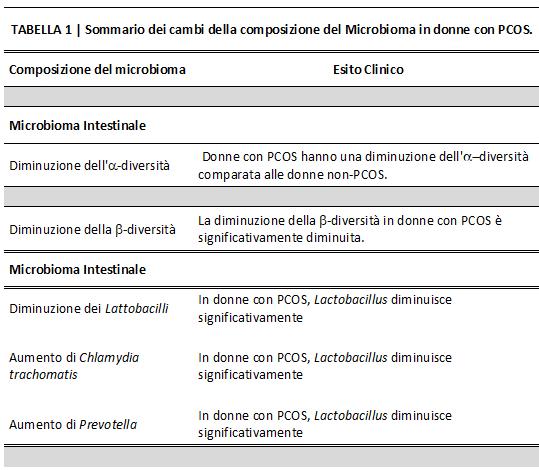
studi hanno evidenziato che il microbiota intestinale in disbiosi nelle donne con PCOS è simile a quello delle donne obese non PCOS (9), il che ha indicato una relazione poco chiara tra la composizione del microbiota nell’obesità e nella PCOS.
Le analisi genomiche a livello del phylum, riferiscono che la porzione di Actinobacteria è maggiore nelle donne con PCOS e la porzione di Bacteroidetes è più piccola nelle donne PCOS rispetto ai soggetti sani. Alcuni altri studi riportano una diversità filogenetica del phylum Bacteroidetes, che si presenta diminuito (25) in modo significativo rispetto ai controlli sani (Tabella 1). Una ricerca cinese analizzando il microbioma delle feci ha riscontrato una percentuale maggiore di Bacteroides nelle donne con PCOS. I Bacteroides, sono una specie di batterio pro-infiammatorio, ed è associato alla promozione dell’insulino-resistenza (10), dei disturbi ormonali e dell’infiammazione nelle donne con PCOS.
Detto questo, è possibile ipotizzare che il microbiota potrebbe essere coinvolto nella patogenesi della PCOS promuovendo la resistenza all’insulina, guidando la fluttuazione degli ormoni sessuali, regolando il sistema immunitario e altri meccanismi patologici.
Negli ultimi anni, l’insulino-resistenza è ampiamente riconosciuta come un disordine metabolico correlato al microbioma intestinale non solo negli animali ma anche negli uomini. È stato dimostrato che il livello sierico degli aminoacidi a catena ramificata negli individui insulino-resistenti è significativamente elevato, il che è associato al microbioma intestinale nella PCOS (11). I risultati indicano che Prevotella copri e Bacteroides vulgatus sono due specie che mediano la biosintesi dei BCAA e ne promuovono l’insulino-resistenza. Inoltre, l’insulino-resistenza potrebbe indurre iperinsulinemia e quindi guidare l’eccesso della produzione di androgeni dalle ovaie (Tabella 2). Inoltre, iperinsulinemia derivata dall’in -
sulino-resistenza potrebbe aumentare il livello di testosterone riducendo la globulina legante gli ormoni sessuali (12). Oltre ai meccanismi menzionati, vengono segnalati anche gli acidi grassi a catena corta (SCFA) nella patogenesi della PCOS tramite la promozione dell’insulino-resistenza (13). Gli SCFA (incluso acetato, propionato e butirrato) sono coinvolti in numerosi processi metabolici ed esercitano varie funzioni tra cui l’inibizione delle infiammazione la regolazione dell’equilibrio immunitario (14). Alcuni studi hanno riferito che il livello ridotto di SCFA potrebbe essere correlato allo sviluppo di insulino-resistenza (15), che svolge un ruolo importante nello sviluppo della PCOS.
Inoltre, è stato suggerito che l’acido biliare è correlato al microbioma nelle donne con PCOS; infatti il microbiota intestinale potrebbe regolare la sintesi, il metabolismo ed il riassorbimento degli acidi biliari, attraverso i recettori della vitamina D (16). Alcuni studi hanno scoperto che l’asse microbiota intestinale-acido biliare-interleuchina-22 gioca un ruolo importante nello sviluppo della PCOS (17). In breve, i livelli di acido biliare (incluso acido glicodesossicolico e acido tauroursodesossicolico) così come il livello di interleuchina-22 sono sensibilmente diminuiti nelle donne con PCOS.
Molti studi preclinici hanno evidenziato il potenziale terapeutico del trapianto di microbiota fecale contro i disturbi umani. In breve, il trapianto di microbiota fecale è effettuato tramite il trapianto di microrganismi dalle feci di donatori sani all’intestino tenue di un ricevente. Questo trattamento mira a cambiare rapidamente la composizione del microbioma intestinale del nuovo ospite e curare le malattie in modo efficace (18). Indubbiamente il trapianto di microbiota fecale potrebbe rappresentare un potenziale innovativo terapeutico con elevate opportunità per la PCOS.
1. Escobar-Morreale HF. Polycystic Ovary Syndrome: Definition, Aetiology, Diagnosis and Treatment. Nat Rev Endocrinol (2018) 14(5):270–84. doi: 10.1038/nrendo.2018.24
2. Polak K, Czyzyk A, Simoncini T, Meczekalski B. New Markers of Insulin Resistance in Polycystic Ovary Syndrome. J Endocrinol Invest (2017) 40(1):1– 8. doi: 10.1007/s40618-016-0523-8
3. Thackray VG. Sex, Microbes, and Polycystic Ovary Syndrome. Trends Endocrinol Metab (2019) 30(1):54–65. doi: 10.1016/j.tem.2018.11.001
4. Smith SA-O, Ravel J. The Vaginal Microbiota, Host Defence and Reproductive Physiology. J Physiol (2017) 15(595):451–63. doi: 10.1113/JP271694
5. Tu Y, Zheng G, Ding G, Wu Y, Xi J, Ge Y, et al. Comparative Analysis of Lower Genital Tract Microbiome Between PCOS and Healthy Women. Front Physiol (2020) 11:1108. doi: 10.3389/fphys.2020.01108
6. Al-Memar M, Bobdiwala S, Fourie H, Mannino R, Lee YS, Smith A, et al. The Association Between Vaginal Bacterial Composition and Miscarriage: A Nested Case-Control Study. BJOG (2020) 127(2):264–74. doi: 10.1111/1471-0528.15972
7.Machado A, Cerca N. Influence of Biofilm Formation by Gardnerella Vaginalis and Other Anaerobes on Bacterial Vaginosis. J Infect Dis (2015) 212(12):1856–61. doi: 10.1093/infdis/jiv338.
8.Lindheim LA-O, Bashir M, Münzker J, Trummer C, Zachhuber V, Leber B,et al. Alterations in Gut Microbiome Composition and Barrier Function AreAssociated With Reproductive and Metabolic Defects in Women WithPolycystic Ovary Syndrome (PCOS): A Pilot Study. PloS One (2017) 3(12):e0168390. doi: 10.1371/journal. pone.0168390
9.Liu R, Zhang C, Shi Y, Zhang F, Li L, Wang X, et al. Dysbiosis of Gut Microbiota Associated With Clinical Parameters in Polycystic Ovary Syndrome. Front Microbiol (2017) 28:324(8). doi: 10.3389/fmicb.2017.00324.
10.Pedersen Hk, Gudmundsdottir V, Nielsen HB, Hyotylainen T, Nielsen T, Jensen BAH, et al. Human Gut Microbes Impact Host Serum Metabolome and Insulin Sensitivity. Nature (2016) 535(7612):376–81. doi: 10.1038/nature18646
11.Qi X, Yun C, Sun L, Xia J, Wu Q, Wang Y, et al. Gut Microbiota-Bile Acid- Interleukin-22 Axis Orchestrates Polycystic Ovary Syndrome. Nat Med (2019) 25(8):1225–33. doi: 10.1038/s41591-019-0509-0.
12.Diamanti-Kandarakis E. Insulin Resistance in PCOS. Endocrine (2006) 30 (1):13–7. doi: 10.1385/ ENDO:30:1:13
13.Agus A, Planchais J, Sokol H. Gut Microbiota Regulation of Tryptophan Metabolism in Health and Disease. Cell Host Microbe (2018) 23(6):716–24. doi: 10.1016/j. chom.2018.05.003
14.Muscogiuri G, Cantone E, Cassarano S, Tuccinardi D, Barrea L, Savastano S, et al. Gut Microbiota: A New Path to Treat Obesity. Int J Obes Suppl (2019) 9 (1):10–9. doi: 10.1038/s41367-019-0011-7
15.Yang W, Yu T, Huang X, Bilotta AJ, Xu L, Lu Y, et al. Intestinal Microbiota- Derived Short-Chain Fatty Acids Regulation of Immune Cell IL-22 Production and Gut Immunity. Nat Commun (2020) 11(1):4457. doi: 10.1038/s41467-020-18262-6
16.Zhao X, Jiang Y, Xi H, Chen L, Feng X. Exploration of the Relationship Between Gut Microbiota and Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): A Review. Geburtshilfe Frauenheilkd (2020) 80(2):161–71. doi: 10.1055/ a-1081-2036
17.Song X, Sun X, Oh SF, Wu M, Zhang Y, Zheng W, et al. Microbial Bile Acid Metabolites Modulate Gut Rorg(+) Regulatory T Cell Homeostasis. Nature (2020) 577(7790):410–5. doi: 10.1038/s41586-019-1865-0
18.Green JE, Davis JA, Berk MA-O, Hair C, Loughman AA-O, Castle DA-O, et al. Efficacy and Safety of Fecal Microbiota Transplantation for the Treatment of Diseases Other Than Clostridium Difficile Infection: A Systematic Review and Meta-Analysis. Gut Microbes (2020) 12(1):1–25. doi: 10.1080/19490976.2020.1854640
Edizione mensile di AgONB (Agenzia di stampa dell’Ordine Nazionale dei Biologi)
Testata registrata al n. 52/2016 del Tribunale di Roma
Diffusione: www.fnob.it
Direttore responsabile: Claudia Tancioni
Redazione: Ufficio stampa Fnob
Progetto grafico e impaginazione: Ufficio stampa Fnob. Questo magazine digitale è scaricabile on-line dal sito internet www.fnob.it
Questo numero de “Il Giornale dei Biologi” è stato chiuso in redazione venerdì 27 gennaio 2023.
Contatti: +39 0657090205, +39 0657090225, protocollo@cert.fnob.it
Per la pubblicità, scrivere all’indirizzo protocollo@cert.fnob.it
Gli articoli e le note firmate esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.
Immagine di copertina: © Lightspring/www.shutterstock.com
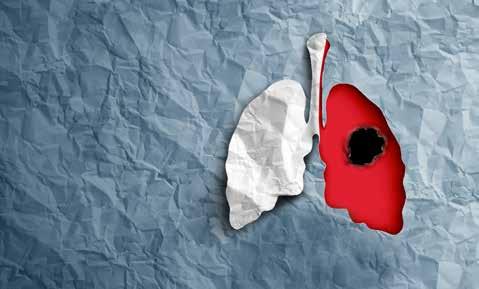
Si informano gli iscritti che gli uffici della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi forniranno informazioni telefoniche di carattere generale dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Tutte le comunicazioni dovranno pervenire tramite posta (presso Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, via Icilio 7, 00153 Roma) o all’indirizzo protocollo@cert.fnob.it, indicando nell’oggetto l’ufficio a cui la comunicazione è destinata.
È possibile recarsi presso le sedi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi previo appuntamento e soltanto qualora non sia possibile ricevere assistenza telematica. L’appuntamento va concordato con l’ufficio interessato tramite mail o telefono.
UFFICIO CONTATTO
Centralino 06 57090 200
Ufficio protocollo protocollo@cert.fnob.it
Commissario straordinario commissario.fnob@pec.it
Ufficio segreteria segreteria@fnob.it
Direzione direzione@fnob.it
*Calabria
Campania-Molise
Emilia Romagna-Marche
Lazio-Abruzzo
Lombardia
Piemonte-Liguria-Valle
D’Aosta
Puglia-Basilicata
Sardegna
Sicilia
Toscana-Umbria
Veneto-Friuli Venezia
Giulia-Trentino
Alto Adige