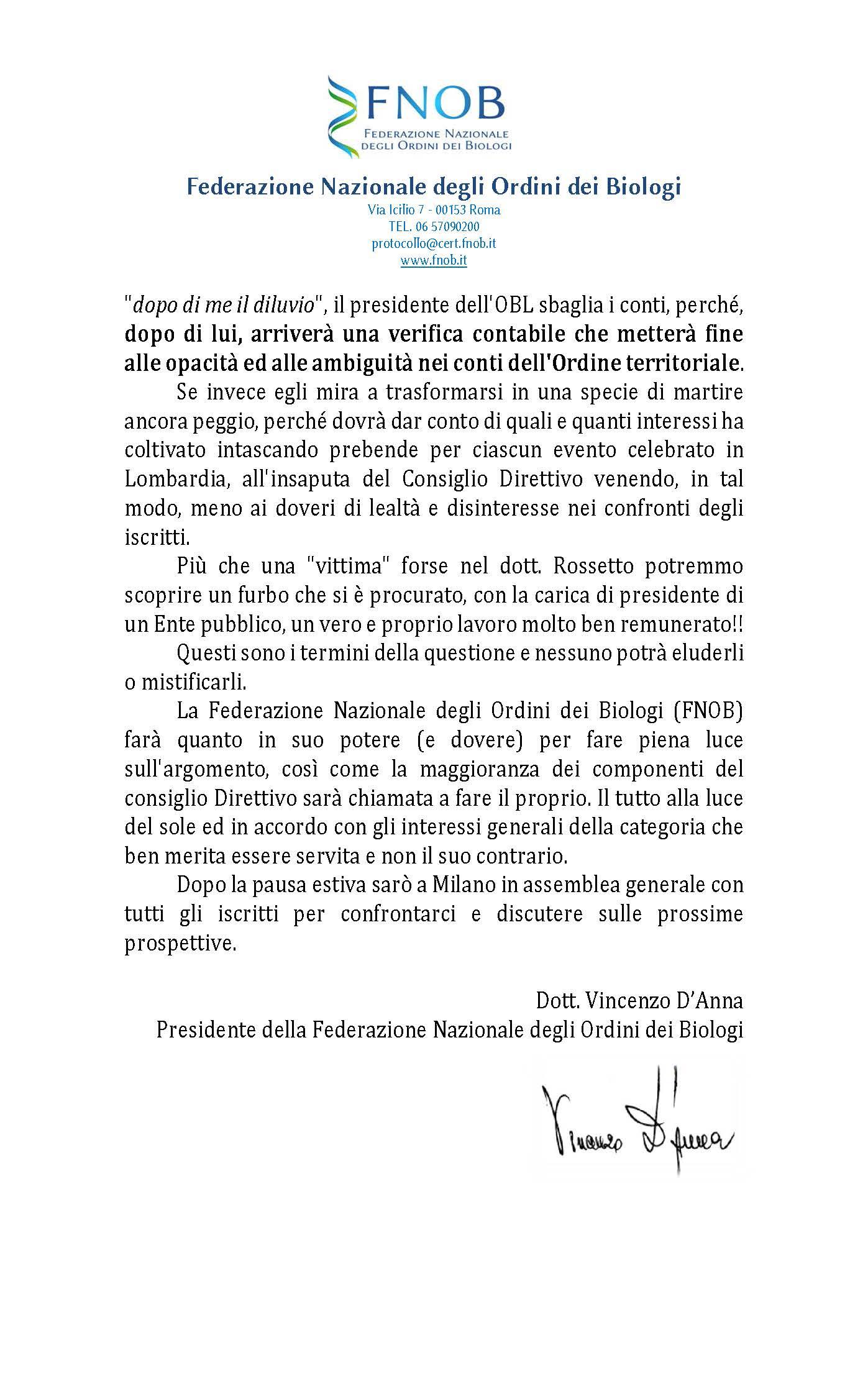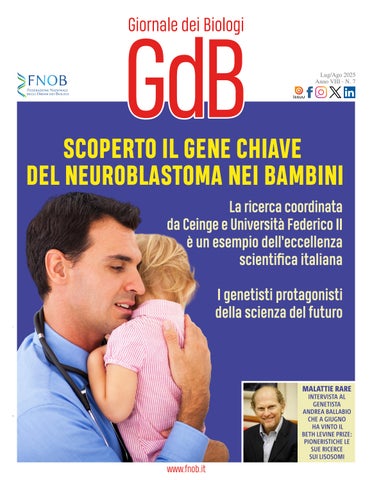DEL NEUROBLASTOMA NEI BAMBINI
La ricerca coordinata da Ceinge e Università Federico II è un esempio dell’eccellenza scientifica italiana
I genetisti protagonisti della scienza del futuro


MALATTIE RARE
INTERVISTA AL GENETISTA
ANDREA BALLABIO
CHE A GIUGNO
HA VINTO IL
BETH LEVINE PRIZE: PIONERISTICHE LE SUE RICERCE SUI LISOSOMI


Individuato il gene del più aggressivo tra i tumori dei bambini di Rino Dazzo
Neuroblastoma, sintomi e segni di Rino Dazzo
Il ruolo di genetica e medicina predittiva di Rino Dazzo
SPECIALE
Test diagnostici in farmacia: farmacisti e biologi firmano protocollo d’intesa di Matilde Andolfo
Lettera aperta ai
INTERVISTE
Lisosomi e malattie genetiche, la rivoluzionaria scoperta del gene TFEB di Ester Trevisan
Chirurgia plastica e medicina estetica: l’esperto Gianpaolo Tartaro spiega quali sono i danni da filler di Matilde Andolfo
SALUTE
Intelletto artificiale e umano si uniscono per una combinazione vincente di Gianpaolo Palazzo
Evocast, l’editor genetico evoluto in grado di inserire interi geni nelle cellule di Sara Bovio
Emoglobinopatie, in campo le ultime strategie: dalla modifica molecolare alla cura clinica di Sara Botti e Francesco D’Agostino
Cromosomi, la svolta del codice a barre di Matilde Andolfo
PMA. L’AI diventa il ‘co-pilota’ nel laboratorio per predire quali embrioni diventeranno blastocisti di Matilde Andolfo
Quando è il padre ad essere “fuori tempo”: rischi nascosti per fertilità e salute dei figli di Valerio Pisaturo
L’orologio biologico esiste anche per gli uomini: più aborti quando il partner è over 45 di Matilde Andolfo
Una nuova MRI individua le alterazioni metaboliche associate alle malattie cerebrali di Sara Bovio
Alzheimer: nasce la prima grande banca di staminali per svelarne i segreti di Carmen Paradiso
Evoluzione genetica delle metastasi: nuove scoperte e prospettive terapeutiche di Sara Bovio
Una proteina “pacificatrice”: la nuova frontiera contro le malattie autoimmuni di Carmen Paradiso
Scoperto il gene CDK12: svolta nella terapia del tumore ovarico aggressivo di Carmen Paradiso
Autismo, una banca genetica con 63 mutazioni accelera la ricerca internazionale di Carmen Paradiso
Vacanze, cosa non manca mai in valigia di Domenico Esposito
Vitiligine, perché nascondersi? di Domenico Esposito
Polidesossiribonucleotidi nelle formulazioni cosmetiche limiti e prospettive future di Carla Cimmino
AMBIENTE
L’Italia nuota e vive sull’oro blu: economia marina in forte crescita di Gianpaolo Palazzo
La minaccia silenziosa del pesce scorpione e degli altri suoi compagni di Gianpaolo Palazzo
Le specie aliene nei mari italiani, istruzioni per l’uso di Franco Andaloro
Sardegna, in barca a caccia di microplastiche: l’impatto su api e natura di Gianpaolo Palazzo
Gli orti urbani al centro delle città future di Michelangelo Ottaviano
L’efficacia dei divieti contro la plastica di Michelangelo Ottaviano
Undici ceppi batterici nativi per guarire la terra dai veleni industriali di Gianpaolo Palazzo
C’è vita tra le nuvole: come i microbi influenzano la nostra esistenza di Domenico Esposito
INNOVAZIONE
L’interazione tra campo acustico e neuroni di Pasquale Santilio
SLA, modelli avanzati per nuove terapie di Pasquale Santilio
Da Biosos nuovi prodotti in agricoltura di Pasquale Santilio
Biomirate per le missioni su Luna e Marte di Pasquale Santilio
Le immagini spettacolari del telescopio Rubin di Michelangelo Ottaviano
Scrivere la vita: il DNA umano sintetico di Michelangelo Ottaviano
Il DNA nei libri antichi: l’archeologia biomolecolare di Matthew Collins di Rino Dazzo
Un italiano a Wimbledon, Sinner sfata il tabù azzurro di Antonino Palumbo
Atletica leggera, l’Italia si conferma regina d’Europa di Antonino Palumbo
Basket, azzurre di bronzo dopo 30 anni di Antonino Palumbo
Milan rompe il digiuno azzurro al tour di Antonino Palumbo

SCIENZE
Batteri che mangiano plastica: una minaccia per i dispositivi medici? di Daniela Bencardino
Tatuaggi: tra moda e rischio di infezioni di Daniela Bencardino
Farmaci su misura grazie al DNA: la medicina personalizzata è realtà di Cristiana Berlinghieri
Paratubercolosi dei ruminanti e morbo di Crohn nell’uomo di Alessandra Mazzeo
La citologia tiroidea: strumento diagnostico e opportunità professionale di Alisia Curto Pelle
Informazioni per gli iscritti
Si informano gli iscritti che gli uffici della Federazione forniranno informazioni telefoniche di carattere generale dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Tutte le comunicazioni dovranno pervenire tramite posta (presso Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, via Icilio 7, 00153 Roma) o all’indirizzo protocollo@cert.fnob.it, indicando nell’oggetto l’ufficio a cui la comunicazione è destinata.
È possibile recarsi presso le sedi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi previo appuntamento e soltanto qualora non sia possibile ricevere assistenza telematica. L’appuntamento va concordato con l’ufficio interessato tramite mail o telefono.
UFFICIO CONTATTO
Centralino 06 57090 200
Ufficio protocollo protocollo@cert.fnob.it

Anno VIII - N. 7 Luglio/Agosto 2025
Edizione mensile di Bio’s
Testata registrata al n. 113/2021 del Tribunale di Roma
Diffusione: www.fnob.it
Direttore responsabile: Vincenzo D’Anna
Giornale dei Biologi

SCOPERTO IL GENE CHIAVE DEL NEUROBLASTOMA NEI BAMBINI
La ricerca coordinata da Ceinge e Università Federico II è un esempio dell’eccellenza scientifica italiana
I genetisti protagonisti della scienza del futuro

Questo magazine digitale è scaricabile on-line dal sito internet www.fnob.it
Questo numero del “Giornale dei Biologi” è stato chiuso in redazione il 30 luglio 2025.
Contatti: protocollo@cert.fnob.it
Gli articoli e le note firmate esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.
Immagine di copertina: @ Alexandros Michailidis/shutterstock. com

Specializzazioni Una nuova era per i Biologi
di Vincenzo D’Anna Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
“Le professioni sanitarie non mediche?
Subiscono una disparità di trattamento rispetto ai laureati in medicina per quanto concerne l’attribuzione delle borse di studio per gli specializzandi ed il numero, troppo limitato, di posti disponibili nelle scuole di specializzazione”. È questa la lamentazione - proveniente soprattutto dai più giovani iscritti all’Albo dei Biologi - che risuona, ogni anno, puntuale ed identica, come una sorta di cacofonica colonna sonora la cui eco è giunta fino ai giorni nostri. Ebbene: è arrivato finalmente il momento in cui quella lamentazione potrà cessare di fungere da “filo conduttore” tra le vecchie e le nuove generazioni. Oggi infatti è stato infranto un tabù!! La borsa per gli specializzandi “non medici” non è più un miraggio, ancorché risulti ancora troppo bassa, come valore, rispetto a quella per i laureati in medicina. Siamo tuttavia certi che in un prossimo futuro anche l’entità sarà parificata a quella dell’altra categoria degli specializzandi. Ora, pur facendo i classici scongiuri di rito, pare che a breve possa crollare anche l’al -
La borsa di studio per gli specializzandi “non medici” non è più un miraggio, ancorché risulti ancora troppo bassa come valore
tro ostacolo, ossia l’aumento del numero dei posti riservati ai “non medici” nei concorsi alle scuole di specializzazione in taluni specifici ambiti. La cosa non è di poco conto perché stavolta a proporre un meccanismo di equa compensazione non è solo la FNOB, insieme agli altri Ordini Professionali, quanto i due Ministeri competenti, ossia i Dicasteri dell’Università e della Salute. Un emendamento a firma del Ministro Anna Maria
Si apriranno nuove “possibilità” per le specializzazioni alle quali si può già accedere ed altre ancora si spalancheranno nei prossimi mesi
Bernini con l’annesso parere favorevole del ministro Orazio Schillaci è stato infatti depositato per determinare una vera e propria rivoluzione copernicana in questo particolare ambito. Si tratta di un ben congegnato, quanto semplice, meccanismo che porterà a coprire tutti i posti destinati ai laureati in medicina resi vacanti dalla man -
cata partecipazione dei medesimi alle prove per l’accesso alle scuole di specializzazione. Quelli invece non coperti per carenza di domande verranno assegnati automaticamente ai rappresentanti delle categorie sanitarie che concorrevano insieme con i medici alla copertura dei posti in quella specializzazione. Sono ormai anni che l’80 percento dei posti messi a concorso in Patologia Clinica (Biochimica Clinica), Microbiologia e Virologia, Genetica, Ematologia, Scienza dell’Alimentazione, Epidemiologia e Statistica Sanitaria vanno deserti. Si tratta di un cospicuo numero che nel 2024 ha sfiorato la soglia dei 650 posti messi a concorso! Se la tendenza dovesse confermarsi oppure, come largamente previsto, incrementarsi, nel corso del 2025 quei posti andrebbero assegnati in
grandissima parte ai Biologi classificati come idonei, ai quali si aggiungerebbero i vincitori di concorso per i posti inizialmente già previsti per gli stessi Biologi. La borsa riconosciuta ai Biologi così subentrati, resterebbe quella destinata ai laureati non medici senza alcun incremento, la qual cosa comporterà anche un risparmio di spesa per lo Stato. Ma c’è di più. All’orizzonte è prevista, con un provvedimento a parte, anche la possibilità che i Biologi possano accedere alla scuola di Anatomia Patologica ove si rilevano identiche carenze di partecipanti medici. Insomma, si apriranno nuove “possibilità” per le specializzazioni alle quali si può già accedere ed altre ancora si spalancheranno nei prossimi mesi. Non a caso un altro emendamento, che gode del parere favorevole
Per dirla tutta: ci attendono giorni in cui l’intera categoria raccoglierà i frutti tanto attesi e sperati
del MUR, aprirà le porte a nuove specializzazioni nell’area extra-sanitaria, come quella Ambientale, un campo in cui i Biologi sono ancora sottovalutati e sottostimati nei ruoli della pubblica amministrazione, come ad esempio l’accesso ad Igiene Ambientale ed alla Laboratoristica Ambientale, che finora si è svolta in modalità semiclandestina ed unicamente sul versante privato. Per dirla tutta: ci attendono giorni in cui l’intera categoria raccoglierà i frutti tanto attesi e sperati. Avremo consensi e plausi? Non credo. I Biologi, spiace a noi dirlo e agli altri sentirlo, sono dei “benaltristi”: aspettano cioè, sempre “ben altro” e spesso godono più nel rimarcare le carenze che le conquiste. Un limite che come un lascito ci portiamo dietro come una sorta di condanna.
INDIVIDUATO IL GENE DEL PIÙ AGGRESSIVO
TRA I TUMORI DEI BAMBINI
L’importante scoperta è il frutto di una ricerca coordinata da Ceinge e Federico II
Ora si può prevedere il rischio legato ai neuroblastomi e agire subito con cure mirate

ÈA essere implicato nello sviluppo del neuroblastoma, malattia che insieme ai tumori del sangue e al cervello è tra le principali cause di morte per cancro in età pediatrica, è una particolare variante genetica, indicata con la sigla rs2863002 e che si trova sul cromosoma 11. La sua presenza, come riscontrato nel corso della ricerca, è associata a un aumento del rischio di sviluppare il neuroblastoma. © aytuncucaroglu/shutterstock.com
il più aggressivo tra i tumori che colpiscono i bambini, un nemico subdolo e spietato che costituisce circa il 10% di tutti i tumori infantili e che nel 90% dei casi si riscontra nei piccoli al di sotto dei cinque anni, con diagnosi prevalentemente entro il terzo anno. Ma adesso il neuroblastoma ha un po’ meno segreti. Ed è un po’ più battibile.
Il gene che lo scatena e che è responsabile di questa forma di cancro, di cui si registrano circa 15mila casi ogni anno nel mondo, di cui 130-140 in Italia, è stato infatti scoperto grazie a una ricerca a forte impronta italiana, coordinata da Ceinge - Biotecnologie Avanzate
‘Franco Salvatore’ e dall’Università Federico II di Napoli e condotta in collaborazione con l’Irccs Gaslini di Genova e il Children’s Hospital di Philadelphia, negli Stati Uniti. I risultati dello studio, che ha analizzato più di dieci milioni di varianti genetiche relative a oltre duemila casi e quattromila controlli sani, sono stati pubblicati sulla rivista Advanced Science e segnano un importantissimo passo in avanti in direzione della medicina di precisione. Un’indagine, è bene sottolinearlo, che conferma una volta di più l’importanza del sostegno alla ricerca: è stata infatti cofinanziata dalla Fondazione Italiana per la Lotta
al Neuroblastoma, dall’associazione Open e dall’Airc (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro). Ma non solo. I risultati ottenuti valgono a dimostrare quanto la ricerca finalizzata alla comprensione dei meccanismi genetici e metabolici dei tumori possa risultare determinante in ambito di prevenzione e anche di sviluppo di terapie mirate. A essere implicato nello sviluppo del neuroblastoma, malattia che insieme ai tumori del sangue e al cervello è tra le principali cause di morte per cancro in età pediatrica, è una particolare variante genetica, indicata con la sigla rs2863002 e che si trova sul cromosoma 11. La sua presenza, come riscontrato nel corso della ricerca, è associata a un aumento del rischio di sviluppare il neuroblastoma.
In particolare, si è avuto modo di osservare come la variante rs2863002 alteri l’attività regolatrice del gene Hsd17B12, coinvolto nel metabolismo dei grassi. Come spiega Mario Capasso, genetista medico della Federico II, principal investigator del Ceinge e coordinatore della ricerca condotta tra Italia e Stati Uniti, «abbiamo analizzato milioni di dati genetici con tecniche bioinformatiche avanzate, poi siamo passati a studi epigenetici per identificare le varianti patogeniche e infine abbiamo modificato geneticamente

cellule tumorali con tecnologie di ingegneria genetica per studiarne il comportamento».
Ed è in questo modo, incrociando dati, effettuando verifiche e trovando mano a mano conferme rispetto alle ipotesi formulate, che si è compreso fino in fondo in che modo la variante agisca nel concreto. Un meccanismo illustrato da Teresa Maiorino, ricercatrice della Federico II, del Ceinge e prima autrice dello studio: «Abbiamo osservato che la variante rs2863002 aumenta l’espressione del gene Hsd17B12, che a sua volta promuove la crescita e l’invasività delle cellule tumorali. Ciò avviene attraverso un’alterazione del metabolismo lipidico».
Sono già diversi anni che i ricercatori della Federico II e del Ceinge indagano a fondo le modalità di sviluppo dei neuroblastomi, compiendo passi sempre più significativi. Tra il 2022 e il 2023, ad esempio, sono riusciti a identificare i fattori genetici che predispongono alla malattia, rendendo più veloce e tempestiva la possibilità di diagnosticare l’insorgenza del neuroblastoma. Ora hanno ricostruito passo dopo passo come il tumore si sviluppi e proliferi all’interno dei neuroblasti, cellule presenti nel sistema nervoso simpatico. Un ruolo fondamentale in questo processo è rivestito dalla variante genetica
rs2863002, che «contribuisce alla sintesi di acidi grassi a catena lunga, fondamentali per le membrane cellulari e le riserve energetiche del tumore», spiega ancora la dottoressa Maiorino. «Nei bambini con espressione elevata di questo gene, la sopravvivenza risultava significativamente più bassa».
La percentuale di sopravvivenza è influenzata in modo considerevole dalla velocità della diagnosi. Quando il neuroblastoma è diagnosticato al quarto stadio, la forma più aggressiva, solo il 35% dei bambini sopravvive una volta passati cinque anni. Più alta è invece la percentuale nei casi di neuroblastoma a prognosi più favorevole, che supera il 70%. La comprensione accurata dei meccanismi di sviluppo del tumore potrebbe rivelarsi essenziale per lo sviluppo di cure e terapie più efficaci, come sottolinea Achille Iolascon dell’Università Federico II e del Ceinge, un altro membro importante dell’equipe dei ricercatori: «Esistono già farmaci in sviluppo che colpiscono enzimi simili a Hsd17B12 e potrebbero rappresentare una nuova frontiera terapeutica per quei bambini che presentano un’attivazione di questo gene. L’obiettivo è duplice: riuscire a prevedere il rischio genetico di neuroblastoma e agire precocemente con terapie mirate».

La percentuale di sopravvivenza è influenzata in modo considerevole dalla velocità della diagnosi. Quando il neuroblastoma è diagnosticato al quarto stadio, la forma più aggressiva, solo il 35% dei bambini sopravvive una volta passati cinque anni. Più alta è invece la percentuale nei casi di neuroblastoma a prognosi più favorevole, che supera il 70%.

NEUROBLASTOMA SINTOMI E SEGNI
Trae origine dalle cellule presenti nel sistema nervoso simpatico e colpisce i più piccoli, fino ai 15 anni
Il neuroblastoma è così chiamato perché ha la sua origine dai neuroblasti, cellule presenti nel sistema nervoso simpatico, la parte del sistema nervoso che controlla alcune specifiche funzioni involontarie dell’organismo come la digestione, il battito cardiaco o la respirazione.
I neuroblasti, in particolare, sono cellule in via di sviluppo che si trovano nei nervi e sono diffuse in tutto il corpo. Per questo motivo il tumore può insorgere in sedi diverse: per lo più si riscontra nelle ghiandole surrenali o nei gangli nervosi, gruppi di cellule presenti lungo la colonna vertebrale
dall’addome alle pelvi, dal collo al torace. L’incidenza è simile tra maschi e femmine, mentre l’età media alla diagnosi è di circa 18 mesi. La quasi totalità dei neuroblastomi si riscontra nei bimbi da zero a dieci anni, anche se alcuni casi si registrano fino a 15 anni. Generalmente questo tipo di tumore non è legato a storie familiari precedenti, riscontrate appena nell’12 per cento dei casi, ed è ancora sconosciuto il ruolo dei fattori ambientali nel suo sviluppo: l’assunzione di acido folico in gravidanza da parte della madre, invece, pare avere un effetto benefico e protettivo. Sotto
il termine neuroblastoma rientrano diverse malattie originate dalle cellule embrionali del sistema nervoso. Si distinguono in particolare forme differenziate come il ganglioneuroma, tumore benigno curabile chirurgicamente, forme scarsamente differenziate come i ganglioneuroblastomi, che possono presentare aree maligne associate ad aree benigne, e forme indifferenziate come i neuroblastomi propriamente detti.
Tutti questi tumori sono identificati con la sigla TNP, che sta per tumori neuroblastici periferici. I sintomi della malattia differiscono a seconda della parte del corpo dove essa si sviluppa. In caso di localizzazione nell’addome si possono notare masse in crescita che possono provocare mancanza di appetito, senso di sazietà e dolore a livello addominale. Se il tumore si sviluppa in prossimità di specifici organi, invece, è avvertibile un senso di pressione. Molto spesso associati al neuroblastoma sono sintomi sistemici quali febbre, ipertensione, tachicardia, ecchimosi e lievi manifestazioni emorragiche. Chirurgia, laddove possibile, radioterapia e chemioterapia sono i trattamenti utilizzati nella cura della malattia, la cui prognosi è generalmente molto buona nei bimbi sotto l’anno di vita, indipendentemente dalla sua estensione.
Nel corso del primo anno di vita il neuroblastoma può regredire spontaneamente, anche se disseminato in più parti, mentre nei bambini più grandi la prognosi è meno favorevole. Il neuroblastoma è considerato dagli esperti un «insieme di tumori» dal momento che racchiude le caratteristiche genetiche di quasi tutti i tumori solidi dell’infanzia.
Il tasso di sopravvivenza si è notevolmente alzato rispetto al 25% degli anni 90 del secolo scorso: oggi si attesta intorno al 70% per i casi a prognosi più favorevole, mentre scende al 35-40% per le forme più aggressive e a prognosi sfavorevole. (R. D.).
Gli importanti progressi nella ricerca sui neuroblastomi, con l’individuazione del gene legato allo sviluppo di questo tumore molto aggressivo per i bambini, danno l’ennesima riprova della crucialità di una scienza, la genetica, che costituisce quella specifica branca della biologia preposta appunto allo studio dei geni, dell’ereditarietà e della variabilità genetica negli organismi viventi. Una branca che può offrire, nel presente e nel prossimo futuro, importanti sbocchi occupazionali.
Un genetista deve essere in grado di effettuare analisi di dati al computer attraverso l’utilizzo di software specializzati, di studiare il materiale genetico con le opportune tecnologie, di svolgere attività di ricerca scientifica volte all’individuazione di nuove cure. Ma non solo. Anche l’ideazione di nanotecnologie avanzate per nuove sperimentazioni è di pertinenza del genetista. Una figura del genere è sempre più richiesta in svariati settori, dal pubblico al privato: nel campo medico e farmacologico, ad esempio, il biologo genetista è implicato soprattutto nello studio dell’evoluzione delle malattie ereditarie, nel campo biotecnologico entra in gioco soprattutto nella scelta dei microorganismi o nella valutazione dei rischi, mentre nell’ambito di parchi ed enti pubblici è funzionale alle analisi sulla biodiversità o allo studio dei rischi genetici per specie a rischio estinzione.
Inoltre, i genetisti possono svolgere analisi genetiche di interesse commerciale su piante e animali, sui loro parassiti, fornire consulenze presso aziende biotecnologiche e biomedicali, svolgere analisi genetiche forensi, diventare curatori o tecnici presso musei o enti di ricerca specializzati in studi di tipo popolazionistico ed evolutivo. Sono solo alcune dimostrazioni delle possibilità di applicazione di un patrimonio di conoscenze e competenze davvero prezioso. Anche la

IL RUOLO DI GENETICA E MEDICINA PREDITTIVA
L’importanza della biologia, nelle sue diverse branche Per la società civile e gli sbocchi occupazionali
medicina predittiva è strettamente legata agli studi genetici. La biologia, nella fattispecie, fornisce le basi scientifiche a questo particolare approccio medico che è teso a identificare la suscettibilità di ogni individuo alle varie malattie, attraverso le conoscenze fornite dalla biologia molecolare o dalla genetica stessa.
Lo studio di DNA, RNA e proteine di un individuo, che sono oggetto delle analisi genomiche, permette di identificare varianti genetiche associate a determinate malattie, proprio come nel caso dei neuroblastomi, consentendo di approntare interven -
ti preventivi, o di ritardare e contrastare l’insorgenza delle malattie. Il biologo molecolare è al servizio della medicina predittiva, che si serve dei suoi studi e delle sue analisi per definire le migliori strategie terapeutiche e le misure di prevenzione più efficaci, compresi controlli mirati e screening ravvicinati.
Anche questo, naturalmente, è un campo che offre notevoli possibilità di sbocco e di affermazione occupazionale. La biologia, nelle sue varie branche, si conferma così una delle scienze maggiormente al servizio della società civile. (R. D.).

L’intesa firmata dal presidente FOFI Andrea Mandelli e dal presidente FNOB Vincenzo D’Anna ha l’obiettivo di assicurare il più alto livello di qualità, affidabilità e sicurezza nelle prestazioni erogate ai cittadini valorizzando le specifiche competenze professionali
TEST DIAGNOSTICI IN FARMACIA FARMACISTI E BIOLOGI
FIRMANO PROTOCOLLO D’INTESA
Èstato siglato a Roma un protocollo d’intesa che sancisce la collaborazione tra farmacisti e biologi per l’esecuzione dei test diagnostici ematico-capillari attraverso l’impiego di strumentazioni POCT (Point-of-Care-Testing). Un accordo importante quello sottoscritto tra la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB).
Il documento firmato dal presidente FOFI Andrea Mandelli e dal presidente FNOB Vincenzo D’Anna è stato consegnato al Sottosegretario di Stato Marcello Gemmato e ha l’obiettivo di assicurare il più alto livello di qualità, affidabilità e sicurezza nelle prestazioni erogate ai cittadini, valorizzando le specifiche competenze professionali, nell’ottica del rafforzamento della rete assistenziale di prossimità.
L’esecuzione dei test diagnostici POCT da parte dei farmacisti del territorio rientra tra le prestazioni previste nell’ambito della “Farmacia dei servizi”, come disciplinata dal D.lgs. 153/2009, nel rispetto degli standard e dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente Convenzione Nazionale Farmaceutica e delle Linee Guida già predisposte dalla FOFI e che sono in attesa della validazione da parte del Ministero della salute.
In virtù dell’accordo, il paziente che effettua il test ematico-capillare in farmacia riceve un attestato di esito - che non ha valore di referto - riportante i valori registrati ed elaborati dal dispositivo in uso. L’attestato di esito è sottoscritto dal farmacista che assicura il rispetto delle procedure seguite, la corretta conduzione della fase pre-analitica rispetto alle indicazioni fornite dal produttore dell’apparecchiatura con marchio CE, la scelta del test e la manutenzione della strumentazione. D’ora in poi, inoltre, su richiesta dell’assistito, le farmacie, che abbiano attivato l’apposito collegamento con un laboratorio clinico, potranno trasmettere a quest’ultimo i dati rilevati per il rilascio del referto clinico, sottoscritto dal biologo o dal medico di laboratorio.
«La firma del protocollo d’intesa segna l’avvio di una proficua collaborazione tra farmacisti e biologi, volta a garantire ai pazienti la migliore assistenza possibile. Mai come in questi anni abbiamo compreso quanto sia importante fare squadra per costruire un servizio sanitario più efficiente e vicino ai reali bisogni delle persone» - ha dichiarato il presidente FOFI, Andrea Mandelli.
La collaborazione con i biologi si inserisce in questa visione: assicurare i più elevati standard di qualità e sicurezza delle prestazioni che ogni giorno eroghiamo

In virtù dell’accordo, il paziente che effettua il test ematico-capillare in farmacia riceve un attestato di esito - che non ha valore di referto - riportante i valori registrati ed elaborati dal dispositivo in uso. L’attestato di esito è sottoscritto dal farmacista che assicura il rispetto delle procedure seguite, la corretta conduzione della fase pre-analitica rispetto alle indicazioni fornite dal produttore dell’apparecchiatura con marchio CE, la scelta del test e la manutenzione della strumentazione. D’ora in poi, inoltre, su richiesta dell’assistito, le farmacie, che abbiano attivato l’apposito collegamento con un laboratorio clinico, potranno trasmettere a quest’ultimo i dati rilevati per il rilascio del referto clinico, sottoscritto dal biologo o dal medico di laboratorio
ai cittadini, che è la priorità assoluta dei farmacisti e di tutti i professionisti del Servizio Sanitario Nazionale.
«Abbiamo salvaguardato e ribadito le diverse competenze professionali che fanno capo ai Biologi ed ai Farmacisti definendo, al tempo stesso, i loro differenti ruoli e funzioni. Il tutto in sinergia e collaborazione rafforzando, per entrambe le categorie, la professionalità che gli compete» - ha commentato Vincenzo D’Anna, presidente della FNOB. L’auspicio è che questo accordo trovi la più ampia adesione di tutti gli attori coinvolti e degli organismi di rappresentanza.
SODDISFAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE GEMMATO
«UN’INTESA CHE VALORIZZA LE PROFESSIONALITÀ E METTE AL
PRIMO
POSTO I CITTADINI»

«Plaudo all’iniziativa degli Ordini nazionali dei biologi e dei farmacisti, che hanno saputo fare sintesi nell’interesse dei cittadini, definendo in modo chiaro e sinergico le rispettive competenze sull’esecuzione dei test diagnostici in farmacia».
Queste le parole del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a commento del protocollo d’intesa consegnato dai presidenti di FNOB e FOFI, che stabilisce modalità operative di collaborazione tra farmacisti e biologi. L’obiettivo è rafforzare l’accesso alle prestazioni diagnostiche sul territorio, garantendo qualità, affidabilità e sicurezza, in una logica di sanità di prossimità realmente centrata sui bisogni del paziente.
«Il nuovo modello di sanità territoriale deve garantire ai cittadini la possibilità di accedere in modo semplice, rapido e vicino a casa ai servizi sanitari di cui hanno bisogno. L’integrazione tra professionisti permette di portare in farmacia prestazioni diagnostiche di primo livello, alleggerendo i percorsi e mantenendo in capo ai laboratori le attività ad alta complessità».
«Auspico - ha concluso Gemmato - che anche le altre organizzazioni di categoria e gli organismi di rappresentanza coinvolti, a cui il documento sarà sottoposto, condividano e sostengano questo approccio. È un passo concreto verso un’assistenza più capillare, soprattutto a beneficio delle persone più fragili e degli anziani».


LETTERA APERTA AI BIOLOGI LOMBARDI
Gentili Colleghi, la notizia diffusa incautamente e scorrettamente dal dott. Rudy Alexander Rossetto, presidente dell’Ordine dei Biologi della Lombardia, circa la sua richiesta di commissariare l’Ente da lui finora presieduto, rappresenta forse l’ultimo atto di una commedia più che di una tragedia come la si vuol far apparire.
Una commedia per la verità mal recitata da parte di un gruppo di soggetti che per mesi ha calpestato leggi e regolamenti nella gestione delle proprie funzioni, impedendo l’esercizio dei diritti alla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo che pure li richiedeva.
Questo stesso gruppo, tra l’altro, ha anche negato la visione dei conti e dei bilanci (Consuntivo e Preventivo) dei quali aveva richiesto la semplice approvazione come “atto di fede” più che come convinta e consapevole determinazione.
Dal canto suo, il presidente Rudy Alexander Rossetto ha preferito recitare la parte della vittima nel men -
tre aveva pensato bene di esercitare quella del carnefice per confondere le menti e corrompere gli spiriti. Eppure, innanzi alla manifesta e palese mancanza di una maggioranza in grado di sostenerlo, il dott. Rossetto avrebbe dovuto esercitare il dovere morale e deontologico di dimettersi lasciando così il campo ad altri invece di puntare alla distruzione di tutto invocando una fase commissariale.
Se il suo intento è quello di realizzare il famoso aforisma “dopo di me il diluvio”, il presidente dell’OBL sbaglia i conti, perché, dopo di lui, arriverà una verifica contabile che metterà fine alle opacità ed alle ambiguità nei conti dell’Ordine territoriale .
Se invece egli mira a trasformarsi in una specie di martire ancora peggio, perché dovrà dar conto di quali e quanti interessi ha coltivato intascando prebende per ciascun evento celebrato in Lombardia, all’insaputa del Consiglio Direttivo venendo, in tal modo, meno ai doveri di lealtà e disinteresse nei confronti degli iscritti. Più che una “vittima” forse nel
dott. Rossetto potremmo scoprire un furbo che si è procurato, con la carica di presidente di un Ente pubblico, un vero e proprio lavoro molto ben remunerato!!
Questi sono i termini della questione e nessuno potrà eluderli o mistificarli.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) farà quanto in suo potere (e dovere) per fare piena luce sull’argomento, così come la maggioranza dei componenti del consiglio Direttivo sarà chiamata a fare il proprio. Il tutto alla luce del sole ed in accordo con gli interessi generali della categoria che ben merita essere servita e non il suo contrario.
Dopo la pausa estiva sarò a Milano in assemblea generale con tutti gli iscritti per confrontarci e discutere sulle prossime prospettive.
Dott. Vincenzo D’Anna Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
*Alleghiamo nota ufficiale a fine GdB.*

“ LISOSOMI E MALATTIE GENETICHE LA RIVOLUZIONARIA
SCOPERTA DEL GENE TFEB
Intervista con il professore Andrea Ballabio, genetista di fama internazionale Vincitore del premio Beth Levine prize in autophagy research
di Ester Trevisan
I lisosomi sono delle strutture che sono responsabili della “pulizia” della cellula. Le sostanze che devono essere eliminate devono essere “trasportate” ai lisosomi, ed è qui che interviene il processo dell’autofagia, proprio nel trasporto delle sostanze al lisosoma. Quando questo processo di “pulizia” non funziona bene a causa, ad esempio, di mutazioni genetiche, succede che nelle cellule cominciano ad accumularsi tutte quelle sostanze che avrebbero dovuto essere eliminate e la cellula comincia a non funzionare bene.
© Achiichiii/shutterstock.com
Professor Ballabio, il Southwestern Medical Center dell’università del Texas le ha assegnato il Beth Levine prize in autophagy research. La prima reazione quando ha ricevuto la notizia?
Confesso di essere rimasto sorpreso. Ci sono al mondo moltissimi ricercatori che lavorano nel campo dell’autofagia, alcuni molto conosciuti e di grandissimo valore. Da quando questo processo biologico è stato scoperto dal ricercatore giapponese Yoshinori Ohsumi, che ha poi ottenuto il Premio Nobel nel 2016 per questa scoperta, questo campo scientifico è letteralmente esploso per l’impatto che ha avuto sia sui meccanismi cellulari che sulle malattie.
La sua scoperta del gene TFEB legata ai lisosomi ha segnato una svolta nel campo della biologia cellulare e in quello delle malattie neurodegenerative. Ci spiega in parole semplici cosa sono i lisosomi e qual è il ruolo del gene TFEB?
I lisosomi sono delle strutture che sono responsabili della “pulizia” della cellula. I lisosomi svolgono questo compito degradando e riciclando le sostanze che, una volta usate dalla cellula, devono essere eliminate. Non a caso i lisosomi sono considerati “gli spazzini cellulari”. Le sostanze che devono essere eliminate
devono essere “trasportate” ai lisosomi, ed è qui che interviene il processo dell’autofagia, proprio nel trasporto delle sostanze al lisosoma. Quando questo processo di “pulizia” non funziona bene a causa, ad esempio, di mutazioni genetiche, succede che nelle cellule cominciano ad accumularsi tutte quelle sostanze che avrebbero dovuto essere eliminate e la cellula comincia a non funzionare bene.
Alla fine questo problema porta a morte cellulare. Questo è quello che succede ad esempio in malattie genetiche rare, quali le “Malattie da accumulo lisosomiale” spesso associate a neurodegenerazione precoce, e anche in malattie comuni quali l’Alzheimer e il Parkinson che presentano neurodegenerazione in età più avanzata. La nostra scoperta in questo campo consiste nell’aver identificato un gene, chiamato TFEB, che è in grado di modulare - cioè di aumentare o diminuire-, attraverso la regolazione di tanti altri geni, la funzione dei lisosomi e dell’autofagia.
Facendo questo, TFEB è quindi in grado di ripulire le cellule da sostanze che si accumulano per difetti del lisosoma stesso. Molti gruppi di ricerca, compreso il nostro, stanno sviluppando strategie per utilizzare TFEB come strumento per curare malattie quali l’Alzheimer e il Parkinson.
Quali sono le prossime sfide che attendono la ricerca sulle malattie genetiche rare?
Per le malattie genetiche rare sono stati fatti grandi passi avanti nel campo dell’identificazione del difetto genetico e della diagnostica. Purtroppo per la terapia c’è ancora molto da fare. Si stanno seguendo due strade che in alcune malattie hanno già dato ottimi risultati: la terapia farmacologica e la terapia genica. I principali ostacoli sono l’alto numero di malattie molto diverse l’una dall’altra; la necessità di intervenire molto precocemente per evitare l’irreversibilità dei sintomi; il costo elevato delle sperimentazioni e, quindi, delle terapie. Nel nostro istituto stiamo sviluppando sistemi per superare, con strategie diverse, questi ostacoli, in modo da poter rendere disponibili le terapie a sempre più pazienti.
Una di queste strategie è quella di sviluppare terapie polivalenti con cui possono essere curate più malattie. Questa strategia sicuramente ridurrebbe di molto i tempi e i costi. Un’altra strategia per abbattere i costi è quella di ottimizzare e semplificare le procedure in modo da poterle automatizzare. La strada è ancora lunga ma sono molto ottimista.
Alla direzione del Tigem ha speso 30 anni di vita. Le manca?
Beh, non posso dire che il Tigem mi manca perché continuo a frequentarlo tutti i giorni per seguire il mio gruppo di ricerca. La ricerca è infatti la mia vera passione, mentre continuo a considerare il management come uno strumento. E poi non sono il tipo che pensa molto al passato, ancora oggi continuo a pensare alle cose che farò piuttosto che a quelle che ho già fatto...
Qual è l’eredità professionale più preziosa che le ha lasciato l’istituto Telethon di Pozzuoli? E quella umana?
Quella professionale credo sia la passione per la ricerca, quella vera, quella che ci fa fare scoperte che portano a nuove conoscenze nel campo della biologia e a volte - ma non sempre - a nuove terapie.
Quella umana credo e spero che sia la convinzione che per ottenere quello che si vuole bisogna lottare e spesso competere, ovviamente in modo leale.
Dopo la laurea in Medicina, ha trascorso un lungo periodo di tempo prima in Inghilterra e poi negli Stati Uniti, fino a tornare in Italia nel 1994 per dirigere il Tigem. La sua storia dimostra che i cervelli in fuga a volte ritornano.
A volte ritornano e a volte no. L’importante è che ci sia un flusso bidirezionale e che in Italia, oltre a italiani che ritornano, ci siano anche stranieri che vengono.
All’Università Federico II si è laureato, specializzato, e adesso sempre nello stesso ateneo insegna Genetica medica. Napoli può essere una fucina di scienziati e ricercatori?
Assolutamente si! Credo che il nostro istituto, il Tigem, ne sia una chiara dimostrazione.
Quale consiglio darebbe a un giovane studente di Biologia che vorrebbe dedicare la carriera alla ricerca?
Il mio consiglio è sicuramente di costruire delle solide basi di formazione in Italia, sia culturale sia sperimentale, per poi recarsi all’estero per un periodo non inferiore ai 3 anni.


Nato a Napoli nel 1957, Andrea Ballabio si è laureato in Medicina e chirurgia all’Università Federico II di Napoli nel 1981, dove si è anche specializzato in Pediatria nel 1985. Dopo un lungo periodo all’estero, nel 1994 è rientrato in Italia per fondare, su mandato della Fondazione Telethon, l’Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem), che ha diretto fino a marzo 2024. Attualmente Principal Investigator al Tigem, ricopre la carica di professore ordinario di Genetica medica presso il dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università Federico II di Napoli e di visiting professor presso il Baylor College of Medicine di Houston (Usa). Da sempre si occupa di studiare i meccanismi alla base delle malattie genetiche. Nel 2022 è stato nominato membro dell’Accademia dei Lincei e gli è stata conferita la Laurea Honoris Causa in Scienze Biologiche dall’Università di Camerino. Vincitore di numerosi premi, ha pubblicato oltre 400 articoli su prestigiose riviste scientifiche internazionali ed è inventore in 8 brevetti internazionali.
La scoperta consiste nell’aver identificato un gene, chiamato TFEB, che è in grado di modulare - cioè di aumentare o diminuire-, attraverso la regolazione di tanti altri geni, la funzione dei lisosomi e dell’autofagia. Facendo questo, TFEB è quindi in grado di ripulire le cellule da sostanze che si accumulano per difetti del lisosoma stesso. Molti gruppi di ricerca stanno sviluppando strategie per utilizzare TFEB come strumento per curare malattie quali l’Alzheimer e il Parkinson.


CHIRURGIA PLASTICA E MEDICINA ESTETICA
L’ESPERTO GIANPAOLO TARTARO
SPIEGA QUALI SONO I DANNI DA FILLER
Il chirurgo: «La prevenzione delle complicanze comincia prima dell’iniezione Il medico deve conoscere eventuali allergie, malattie autoimmuni, assunzione di farmaci come anticoagulanti e pregressi trattamenti estetici del paziente»
A“matissime “punturine”. Moltissime donne e moltissimi uomini, anche giovani, sembra non poterne farne almeno con il miraggio di un viso più armonico e con meno rughe. Ma, attenzione, i filler, se non eseguiti correttamente o con prodotti adeguati, possono causare danni estetici e funzionali.
Ce ne parla Gianpaolo Tartaro, direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale dell’Università della Campania e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo Facciale presso l’Università degli Studi Luigi Vanvitelli a Napoli.
Professor Tartaro, innanzitutto cosa sono i filler?
I filler - dall’inglese to fill, “riempire” - sono sostanze iniettabili di varia natura utilizzate per ottenere miglioramenti estetici aumentando il volume di alcune aree del viso o del corpo con l’obiettivo principale di esaltare l’aspetto, ripristinare i volumi perduti causati dall’invecchiamento donando un aspetto più giovane e riposato, valorizzare le salienze anatomiche, incrementare l’idratazione e l’elasticità della pelle o correggere imperfezioni o asimmetrie.
Secondo una definizione ancora diffusa sebbene antiquata, i filler sono iniettabili a livello del derma e del sottocute per il trattamento di rughe superficiali e profonde: questa definizione oggigiorno è tecnicamente inesatta, poiché i filler non sono meramente dei riempitivi.
Infatti secondo il Ministero della Salute, i prodotti attuali sono dispositivi medici invasivi di tipo chirurgico in quanto iniettati, che biostimolano i tessuti, idratandoli e stimolando la produzione di elastina e collagene quindi con caratteristiche fisico-chimiche farmacologicamente attive. Appartengono quindi alle classi di rischio più alte dei dispositivi.
Quali sono i filler più comuni?
I filler più comuni sono a base di acido ialuronico, una molecola naturalmente presente nel nostro organismo ma esistono anche altre sostanze iniettabili come collagene, idrossiapatite di calcio, o acido polilattico.
I filler permanenti sono sostanze che l’organismo non è in grado di riassorbire e che spesso considera come estranee scatenando in molti casi importanti risposte immunitarie ed infiammatorie come nel caso del silicone che rimane nel sito di iniezione per un periodo indefinito ed è stato vietato in molti Paesi, inclusa l’Italia, a causa dei potenziali rischi di gravi danni anche a distanza di tempo e spesso risolvibili solo attraverso complessi interventi di chirurgia ricostruttiva.
Prima di sottoporsi al trattamento è necessario effettuare dei test?
Non esistono test di routine, ma è fondamentale una valutazione clinica approfondita e un’anamnesi accurata del paziente. Il medico deve conoscere eventuali allergie, malattie autoimmuni, assunzione di farmaci come anticoagulanti e pregressi trattamenti estetici: la prevenzione delle complicanze comincia prima dell’iniezione. Riguardo all’esame clinico, occorre prendere in considerazione l’aspetto fisico generale, fototipo, il grado di fotoinvecchiamento, la densità e lo stato di attività delle ghiandole sebacee, il grado di lassità cutanea, la presenza di cicatrici ipertrofiche o cheloidee sulla superficie cutanea, oltre che sul viso, la presenza di infezioni nelle aree da sottoporre a trattamento con i filler ed altre dermopatie, oltre alla corretta indicazione clinica o clinico-estetica.
Sono infatti descritte come controindicazioni assolute alle procedure di iniezioni di filler le ipersensibilità specifiche accertate, il trattamento su cute lesa con problemi infettivi o infiammatori, terapie in atto con sup -
posti rallentamenti o ritardi della fase riparativa, malattie autoimmunitarie per rischio elevato di infezioni e rallentamento dei processi riparativi, la gravidanza e l’allattamento.
Inoltre è necessario informare il medico di eventuali reazioni allergiche all’anestetico locale che spesso precede la procedura iniettiva, episodi di herpes passati o contestuali, e, soprattutto, precedenti trattamenti con filler. La presenza di filler pregressi non noti è motivo sufficiente per evitare l’uso di altri filler.
Esistono test obbligatori?
Obbligatori sono due test nella regione volare dell’avambraccio, per l’utilizzo di filler a base di collagene bovino; il primo, con periodo di osservazione di non meno di 30 giorni, il secondo con periodo di osservazione di non meno di 7 giorni.
Facoltativi i test per i collageni di derivazione porcina o umana e per le altre tipologie di filler, da consigliare in pazienti con anamnesi positiva a patologie su base auto-immunitaria.
Quali sono i danni da filler e da cosa sono provocati?
I filler definiti un tempo come dermici, ad oggi sono iniettati secondo le tecniche più recenti su diversi piani del volto, interessando non più livelli meramente superficiali, ma anche un surface profondo ed osseo con effetti collaterali gravi, che includono a seconda dei casi il rischio di danni importanti come la formazione di noduli sottocutanei e granulomi, intensificazione degli episodi erpetici, ascessi sterili, infezioni batteriche da biofilm e cicatrici o complicanze disfiguranti che possono avere esiti permanenti.
I rischi aumentano se il trattamento è eseguito da personale non qualificato o in ambienti non idonei. Le complicanze vanno dalle reazioni infiammatorie come noduli, edema, granulomi fino a eventi catastrofici
come necrosi cutanea o cecità. Non è solo una questione estetica: stiamo parlando di rischio vascolare, ischemico e neurologico.
Le reazioni avverse sono riconducibili al tipo di prodotto utilizzato?
Eventi avversi e complicazioni più o meno importanti sono in relazione non solo alle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto utilizzato e alle mere modalità di infiltrazione, ma anche e soprattutto allo stato clinico del paziente.
Una pregressa infiltrazione con filler di natura non precisata è motivo sufficiente per non sottoporre il paziente a procedura, evitando così complicanze come la persistenza di un edema. Altri danni da filler sono lesioni anche importanti derivanti da
infezioni granulomatose e purulente spesso disfiguranti, provocate dalla mancata applicazione delle basilari regole di asepsi, come la mancata e adeguata disinfezione della cute prima della procedura oppure della non idoneità delle strutture, delle precarie condizioni di salute della paziente, dell’utilizzo di prodotti a base di acido ialuronico di scarsa qualità e a basso costo economico.
Ancora più frequenti sono le reazioni infiammatorie tardive, che si manifestano anche a distanza di anni dall’iniezione che dipendono dal tipo di filler utilizzato.
Come affrontare una emergenza durante o dopo una seduta di filler?
In primis è necessaria la diagnosi tempestiva. Dopo la procedura è es -

senziale l’osservazione del paziente. Nell’emergenza embolica il fattore tempo è cruciale e il medico deve saper riconoscere immediatamente i segni di una complicanza vascolare come nella necrosi cutanea o nella embolizzazione retrograda.
Dinanzi a una complicanza vascolare acuta, occlusione vascolare, ischemia o livedo reticularis, bisogna intervenire nell’arco di pochi minuti. E deve intervenire il professionista qualificato a gestire le complicanze. Secondo il protocollo descritto in letteratura (HDPHP: high dose pulsed hyaluronidase protocol) il medico deve eseguire infiltrazioni ad alte dosi, tempestive e sequenziali, di ialuronidasi, il farmaco che degrada l’acido ialuronico.
Una ischemia e successiva necrosi cutanea da filler, se non diagnosticata tempestivamente, è risolvibile solo con complessi interventi che richiedono notevole esperienza in chirurgia ricostruttiva del volto.
Cos’è la ialuronidasi e quando è necessaria?
È un enzima che dissolve l’acido ialuronico, quindi viene impiegato per correggere eccessi di volume, asimmetrie, noduli, granulomi e viene impiegato nel caso di complicanze vascolari. Alcuni scenari specifici in cui la ialuronidasi può essere necessaria includono l’eccesso di volume o le asimmetrie.
Se il filler ha creato un volume eccessivo o non uniforme, la ialuronidasi può essere utilizzata per ridurre il volume o correggere le asimmetrie, ripristinando un aspetto naturale. In alcuni casi, il filler può essere iniettato accidentalmente in un vaso sanguigno, causando ostruzione e complicanze vascolari: la ialuronidasi, somministrata tempestivamente, può aiutare a prevenire danni maggiori. In alcuni casi, la ialuronidasi può essere utilizzata per “sciogliere” un filler esistente prima di procedere con
“un nuovo trattamento estetico garantendo così risultati ottimali.
Sebbene la ialuronidasi sia uno strumento prezioso in medicina estetica per la correzione di risultati indesiderati e complicanze legate ai filler, offrendo una soluzione efficace per ripristinare l’armonia e l’aspetto naturale del viso, in letteratura sono descritte reazioni allergiche che ne definiscono la cautela nell’utilizzo.
Un’azione mirata richiede una procedura precisa in localizzazione di iniezione e quantità di prodotto, nonché l’utilizzo di procedure ecoguidate nei casi più delicati e di più difficile risoluzione, richiedendo esperienza in una procedura a volte più complessa dell’iniezione del filler stesso.
Qual è il danno peggiore che può provocare una errata “punturina”?
Il danno peggiore è l’occlusione dell’arteria retinica, che può portare a cecità irreversibile. È un evento rarissimo ma drammatico, che sottolinea l’importanza di affidarsi a chirurghi esperti con una conoscenza approfondita dell’anatomia del volto.
Ogni anno, nel mondo, si contano centinaia di casi. Questo non è un dettaglio trascurabile: è il motivo per cui l’iniezione di filler è atto medico e non cosmetico. Solo mani esperte con esperienza in chirurgia maxillo facciale e dell’orbita possono agire in maniera operativa con iniezioni retrobulbari di ialuronidasi ad alte dosi.
Quando il danno è estetico e quando è funzionale?
Un danno è estetico quando altera l’aspetto del volto, coinvolge la simmetria, il volume, l’armonia del viso mentre un danno è funzionale quando intacca la sensibilità, l’innervazione, la motilità muscolare. I danni possono essere estetici quali asimmetrie, noduli, edema o gonfiore persistente.
Sono funzionali quando provocano dolore cronico, disestesia, neurite
periferica, alterazioni della dinamica muscolare. Quando un filler compromette la mimica facciale, la respirazione nasale o la vitalità cutanea siamo dinanzi a una lesione iatrogena vera e propria. I danni funzionali possono essere transitori, ma in alcuni casi permanenti.
Nei dismorfismi post iniettivi più comuni ed evidenziati soprattutto nelle giovanissime, vi è una distorsione dell’anatomia del volto, non solo in statica ma anche in dinamica.
Esiste un’età minima per sottoporsi al trattamento?
Anche se board internazionali indicano che al di sotto dei 18 anni è possibile trattare il paziente solo con il consenso dei genitori, a differenza del Regno Unito dove esiste una legge che vieta i filler estetici sui minorenni, in Italia non c’è una legge che vieta esplicitamente questi trattamenti sebbene la medicina estetica sui minorenni sia un tema delicato, regolamentato da normative che mirano a proteggere la loro salute e il loro benessere psicologico.
È fondamentale che i trattamenti siano valutati attentamente caso per caso, considerando sia le implicazioni fisiche che quelle psicologiche. Esiste una forte raccomandazione da parte della comunità medica di non utilizzare filler sui minorenni, a meno che non vi siano ragioni psicologiche valide che giustifichino l’intervento.
Chi è lo specialista che dovrebbe eseguire le infiltrazioni di acido ialuronico, botox o biorivitalizzanti?
Sebbene tutti i medici abilitati all’esercizio della professione possano legalmente eseguire questi trattamenti, i dati disponibili in letteratura dimostrano un aumento delle complicanze legate a procedure estetiche eseguite da medici non-specialisti. Quindi il reale impatto descritto a carico di tali tecniche va in contrasto con l’opinione comune che si tratti di una banale
iniezione, una punturina di filler.
La facilità apparente dell’intervento bollato come una procedura ambulatoriale e talora la stessa economicità a discapito della qualità, rende banale un intervento spesso eseguito da medici non specializzati, senza tener conto del rischio di complicanze. La diffusione capillare e propagandistica delle metodiche di medicina estetica risulta essere esponenzialmente veicolata da politiche pubblicitarie da parte di mass media, i principali vettori per pazienti disinformati che sempre più si focalizzano sull’artificio fotografico invece che sui risultati stabili nel tempo basati sull’evidenza o sulla esperienza del chirurgo.
La raccomandazione è rivolgersi a un medico specializzato in chirurgia maxillo-facciale con competenze specifiche in chirurgia plastica del volto.
Quando un danno è definito irreversibile?
Quando nessun trattamento correttivo può ripristinare la funzione o l’aspetto preesistente. Parliamo di necrosi tissutale, cicatrici permanenti, cecità, ma anche di alterazioni psicologiche gravi nei pazienti. Tra le complicanze più gravi ed irreversibili dobbiamo ricordare la “embolia cutis medicamentosa”, la conseguenza dell’iniezione intra-arteriosa del filler che può provocare un’occlusione del vaso e necrosi dell’area irrorata da quel vaso.
La circolazione arteriosa del volto presenta numerose anastomosi e quindi l’iniezione di prodotto in un’arteria può provocare necrosi anche a distanza, come nei casi di cecità dovuti ad occlusione dell’arteria retinica quindi perdita della vista anche in caso di filler iniettato al mento o in regione mandibolare.
Quali sono le parti del viso più a rischio?
Le aree più a rischio sono quelle con fitte reti anastomotiche o vasi ad
alto flusso, come il naso, la glabella e la regione perioculare sedi di vascolarizzazione complessa quindi con collegamenti diretti con l’arteria oftalmica. In queste sedi di trattamento molto frequenti, come nel caso del rinofiller, l’iniezione richiede l’abilità di mani esperte di medici professionisti dotati di esperienza e conoscenza tecnica, consapevolezza anatomica millimetrica.
Se la procedura iniettiva più frequente è proprio la volumizzazione labiale, secondo tecniche descritte come rivoluzionarie e seducenti come le russian lips, non sorprende come uno dei siti più frequenti di necrosi massiva siano proprio le labbra, con esiti riconducibili ad alterazioni necrotiche devastanti e permanenti.
Le aree trattate con filler maggiormente soggette a complicanze vascolari sono quelle con frequenza maggiore di trattamento quindi quella labiale (22%) e nasolabiale (17%) mentre le zone maggiormente pericolose sono aree quali naso e mento, punti cardini della cosiddetta profilo plastica non chirurgica, che sono i crocevia anatomici di vascolarizzazioni di tipo terminale: una occlusio -

Gne vascolare da iniezione di filler in tali aree porterà non solo a necrosi locoregionale ma anche ad embolizzazione in distretti più lontani, quali arteria oftalmica con conseguente cecità improvvisa e definitiva.
Quali sono i consigli da dare ai pazienti che vogliono sottoporsi al trattamento?
Affidarsi sempre a un medico qualificato, verificare che il prodotto sia certificato e tracciabile, evitare trattamenti “low cost” o in centri non autorizzati. Diffidare di chi promette risultati eclatanti: la medicina estetica deve valorizzare, non trasformare. In tal senso preoccupa la giovane età
© BLACKDAY/shutterstock.com
delle pazienti che sempre più decidono di sottoporsi a trattamenti estetici, un dato che fa emergere un quadro patologico di dismorfofobia in ragazze e ragazzi che aspirano ad ideali e canoni di bellezza non realizzabili.
Il contrasto all’esercizio abusivo della professione appare ancora debole. Quali strumenti occorrono per contrastare in maniera capillare la piaga dei centri estetici abusivi?

ianpaolo Tartaro è direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale dell’Università della Campania (dal 2005) e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo Facciale presso l’Università degli Studi Luigi Vanvitelli a Napoli (dal 2006). Per accrescere la sua esperienza ed affinare la sua tecnica, ha collaborato presso numerose strutture ospedaliere Nazionali ed Estere (Svizzera e Stati Uniti), guidato da veri specialisti del settore, così da poter apprendere le tecniche più innovative e all’avanguardia che abitualmente applica nei suoi interventi chirurgici. Si tiene regolarmente aggiornato, frequentando numerosi corsi di perfezionamento di livello internazionale ed ha partecipato a numerosi congressi e meeting nazionali ed esteri in qualità di relatore. È autore di oltre 260 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali negli ambiti della chirurgia estetica, ricostruttiva, e malformativa. È membro di società scientifiche italiane ed internazionali di rilievo quali la Società Italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, l’AO Foundation (AOCMF) e la Società italiana di chirurgia maxillo-facciale per la quale ha l’incarico di revisore dei conti, di organizzare corsi e congressi e di selezionare le aziende che trattano prodotti nell’ambito della medicina estetica.
L’uso dei filler deve avvenire esclusivamente in una struttura medica autorizzata secondo le norme vigenti, da personale sanitario medico esperto ed ultra-specializzato. Serve una maggiore vigilanza da parte delle autorità sanitarie, ma anche informazione da parte dei pazienti.
È fondamentale che i pazienti siano consapevoli dei rischi e pretendano la massima trasparenza su chi esegua il trattamento. Le società scientifiche devono continuare a sensibilizzare, mentre le sanzioni contro gli abusivi devono essere più severe e applicate con rigore.
Dietro un trattamento low cost può nascondersi un abuso professionale, una sostanza non certificata o una mano non medica.
Dilagano i casi di trattamenti eseguiti in strutture come i centri estetici, luoghi privi di ogni minima regola di aspepsi e sterilità necessaria per procedure medico-chirurgiche. Il risultato? Danni, complicanze, infezioni, esiti deturpanti. (M. A.).

La ricerca evidenzia che affiancare competenze differenti produce un aumento notevole nell’individuazione delle patologie, senza sostituire il fondamentale ruolo del medico
Un orizzonte rivoluzionario si apre nella diagnostica medica, dove la sinergia tra intelligenza artificiale ed esperti umani promette un futuro di maggiore precisione e affidabilità. Non è più questione di sostituire la nostra competenza con l’algoritmo, ma di valorizzare le reciproche peculiarità, creando una complementarità inedita che si rivela un punto di forza insospettato. Un recente studio internazionale, condotto dal Max Planck institute for human development in collaborazione con Human diagnosis project (Human Dx) e l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istc), ha svelato come la “fusione” conduca a formulazioni nettamente più accurate. La ricerca, pubblicata sulla rivista “PNAS”, illumina la strada per affrontare uno dei problemi più scottanti della medicina quotidiana: la valutazione clinica. I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come ChatGPT-4, Gemini o Claude 3, offrono prospettive innovative per sostenere con efficacia l’identificazione delle patologie. Tuttavia, il loro utilizzo comporta anche rischi non trascurabili: possono, per esempio, “allucinare” generando informazioni erronee, oppure riprodurre distorsioni già presenti nel contesto medico e sociale, prendendo, talvolta, cantonate che lasciano perplessi anche gli utilizzatori più esperti. Sono state investigate le modalità ottimali di collaborazione tra specialisti e sistemi intelligenti, giungendo alla conclusione che i “team ibridi”, cioè costituiti sia da esperti umani sia da sistemi IA, superano in modo significativo la precisione delle équipe composte esclusivamente da individui o da sole macchine.
Questo elemento è particolarmente evidente per le questioni complesse e aperte, che prevedono numerose potenziali soluzioni, piuttosto che per semplici scelte binarie. «I nostri risultati - afferma Nikolas Zöller, ricercatore post-dottorato presso il Center for adaptive rationality del Max Planck institute for human development e autore principale dell’articolo - dimostrano che la cooperazione tra esperti umani e sistemi IA ha un grande potenziale per migliorare la diagnosi medica, e quindi la salute dei pazienti».
Per condurre l’indagine, sono stati sfruttati i dati messi a disposizione da Human Dx, che accostano a brevi descrizioni testuali di casi clinici (vignette) le diagnosi corrette. Utilizzandone oltre 2.100, sono state confrontate le determinazioni formulate da professionisti sanitari con quelle di cinque sistemi IA. Nell’esperimento principale, sono state simulate diverse tipologie: singoli individui, squadre di medici, di IA e miste. Complessivamente, sono state analizzate più di 40.000 risposte, ciascuna classificata e valutata attraverso gli standard medici internazionali (Snomed Ct).
L’unione di più sistemi IA ha migliorato la qualità complessiva. Mediamente, i gruppi composti da intelligenze artificiali hanno superato le prestazioni degli esperti umani nell’85% dei contesti. Tuttavia, sono stati riscontrati nume-

«Non si tratta di sostituire gli esseri umani con le macchine. Piuttosto, - chiarisce il coautore della ricerca Herzog - dovremmo considerare l’intelligenza artificiale come uno strumento complementare che dispiega appieno il suo potenziale nel processo decisionale collettivo»
rosi episodi in cui gli specialisti hanno ottenuto esiti migliori. È interessante notare che, quando l’IA commette un errore, i medici spesso giungono alla determinazione corretta. Il risultato più rilevante è che l’integrazione di entrambi i mondi produce un incremento considerevole dell’accuratezza. Pure l’aggiunta di un singolo sistema IA ai dottori, o viceversa, genera un sostanziale cambiamento favorevole.
Le conclusioni più sicure sono emerse da decisioni collettive che hanno coinvolto simultaneamente più esperti e più intelligenze artificiali. La spiegazione risiede nel fatto che entrambi incorrono in errori sistematicamente dissimili: «Non si tratta di sostituire gli esseri umani con le macchine. Piuttosto, - chiarisce il coautore Stefan Herzog, ricercatore senior presso il Max Planck institute for human development - dovremmo considerare l’intelligenza artificiale come uno strumento complementare che dispiega appieno il suo potenziale nel processo decisionale collettivo».
Ciononostante, gli autori evidenziano anche i limiti del proprio lavoro. Sono state prese in considerazione esclusivamente casistiche cliniche basate su testo, non pazienti reali in contesti effettivi. La trasferibilità diretta degli esiti alla pratica medica concreta rimane un quesito che le future osservazioni dovranno affrontare. Inoltre, ci si è concentrati unicamente sulla fase diagnostica, senza considerare le implicazioni terapeutiche. Permane, altresì, l’incertezza sull’accettazione dei sistemi di supporto basati sull’IA da parte del personale medico e dei pazienti. Ugualmente, i potenziali rischi di pregiudizi e discriminazioni, in particolare su disparità etniche, sociali o di genere, richiedono ulteriori approfondimenti.
Lo studio s’inserisce nel progetto “Hybrid human artificial collective intelligence in open-ended decision making” (Hacid), finanziato nell’ambito di Horizon Europe, che mira a promuovere lo sviluppo di futuri sistemi di supporto alle decisioni cliniche. I gruppi ibridi potrebbero dare un contributo a una equità nell’assistenza sanitaria lì dove mancano alte professionalità. «L’approccio - conclude Vito Trianni, dirigente di ricerca del Cnr-Istc e coordinatore del progetto Hacid - può essere trasferito anche ad altri ambiti professionali, come il sistema legale, la risposta alle emergenze da disastri ambientali o le politiche per il clima, ovvero ovunque siano necessarie decisioni complesse e ad alto impatto. Ad esempio, Hacid sta anche sviluppando strumenti per migliorare il processo decisionale nello sviluppo di strategie di adattamento al cambiamento climatico». (G. P.).
Il nuovo sistema consentirà una maggiore precisione nelle terapie geniche
Una svolta per una maggiore efficacia nella cura di malattie come la fibrosi cistica e l’emofilia
EVOCAST
L’EDITOR GENETICO EVOLUTO IN GRADO DI INSERIRE
INTERI GENI NELLE CELLULE

©Yurchanka Siarhei/shutterstock.com
Iricercatori del Broad Institute e della Columbia University hanno sviluppato un editor genetico rivoluzionario che consente di inserire interi geni sani in un punto preciso del DNA delle cellule riducendo notevolmente eventuali danni indesiderati al genoma. La nuova tecnica consentirà di migliorare l’efficacia delle terapie di editing genetico impiegate per trattare patologie causate da un gran numero di mutazioni a carico dello stesso gene come la fibrosi cistica e l’emofilia.
Il nuovo strumento di editing genetico, chiamato evoCAST, utilizza versioni evolute in laboratorio di enzimi chiamati trasposasi associate a CRISPR, o CAST, che spostano in modo guidato ampi tratti di DNA nei genomi batterici, ma che finora avevano mostrato un’attività minima nelle cellule dei mammiferi. Come descritto nello studio, pubblicato su Science, EvoCAST consente di tagliare il DNA in punti precisi e inserire lunghi tratti di DNA, come interi geni, in una posizione desiderata senza causare significativi danni collaterali al genoma.
Nello studio gli autori spiegano perché uno strumento come evoCAST potrebbe rendere la terapia genica più affidabile ed efficiente, in particolare per patologie come la fibrosi cistica e l’emofilia, causate da una qualsiasi delle migliaia di mutazioni diverse. «Centinaia o migliaia di mutazioni diverse nel gene CFTR possono causare la fibrosi cistica, ad esempio, quindi sarebbe necessario un numero eccessivo di farmaci di editing genetico distinti per garantire che ogni paziente possa essere trattato» - afferma Samuel Sternberg, uno degli autori principali della ricerca. «Inveceprosegue il ricercatore - uno strumento come evoCAST potrebbe consentire una singola terapia genica che inserisce un gene completo e sano nel genoma del paziente». «C’è ancora molto lavoro da fare - conclude Sternberg - ma evoCAST rappresenta una pietra miliare nello sviluppo di questi sistemi per l’inserzione permanente di un gene com-
pleto e sano, indipendentemente dal difetto genetico sottostante».
I ricercatori sostengono che i metodi utilizzati fino a oggi per le terapie geniche, come per esempio CRISPR-Cas, i virus e altri sistemi di editing, presentano degli svantaggi. Alcuni metodi sono precisi, ma consentono solo piccole correzioni. I virus, i più utilizzati nella terapia genica, possono inserire geni completi, ma lo fanno in modo casuale, attivando le risposte immunitarie. Più nel dettaglio evoCAST si basa su un sistema naturale, scoperto diversi anni fa dal laboratorio Sternberg nei batteri, che consente ai geni di “saltare” cioè spostarsi in nuove posizioni nel genoma batterico.
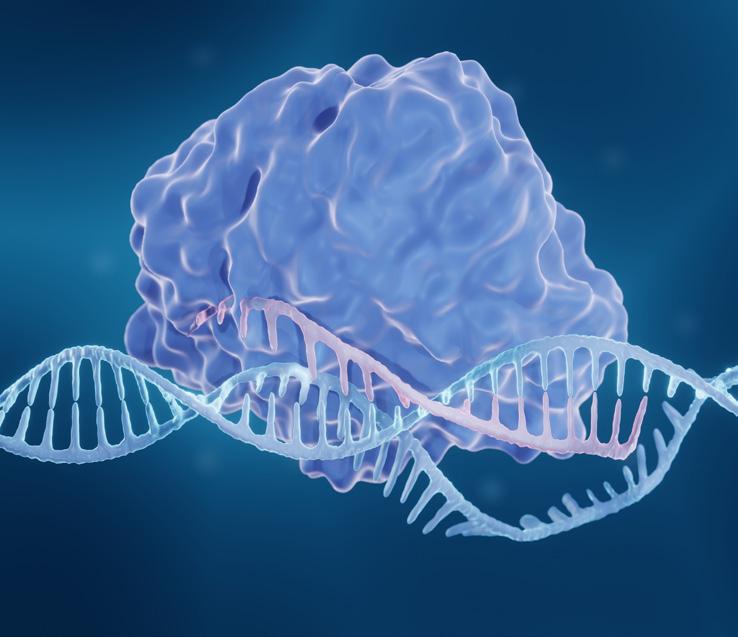
Le CAST evolute potrebbero un giorno consentire ai ricercatori di creare terapie di editing genetico che inseriscono con precisione un’intera copia di un gene sano e quindi apportano benefici a più pazienti affetti da una malattia genetica, indipendentemente dalla loro specifica mutazione patogena in quel gene
I geni “saltanti”, noti anche come trasposoni, in natura possono apportare benefici a una specie generando diversità genetica. La tecnica al centro dello studio utilizza versioni evolute in laboratorio di enzimi chiamati trasposasi associate a CRISPR, o CAST, che hanno “imparato” a utilizzare CRISPR per dirigere i salti verso punti precisi del genoma. Sulla base dei risultati dello studio, le varianti CAST evolute sono in grado
di inserire migliaia di lettere di DNA, o coppie di basi, in un sito bersaglio nel genoma delle cellule umane e sono risultate centinaia di volte più efficienti dei sistemi CAST naturali noti fino ad oggi. Le CAST evolute potrebbero un giorno consentire ai ricercatori di creare terapie di editing genetico che inseriscono con precisione un’intera copia di un gene sano e quindi apportano benefici a più pazienti affetti da una malattia genetica, indipendentemente dalla loro specifica mutazione patogena in quel gene.
Come si legge nello studio, le trasposasi batteriche associate a CRISPR (CAST) catalizzano l’integrazione del DNA guidata dall’RNA, ma sono decisamente inefficienti quando vengono impiegate nelle cellule degli organismi superiori. Utilizzando l’evoluzione artificiale continua assistita da fagi (PACE), Isaac Witte, primo autore dello studio, e colleghi hanno sviluppato una piattaforma di evoluzione continua per migliorare l’attività delle CAST ottenendo una CAST evoluta con un’efficienza aumentata di oltre 200 volte nelle cellule umane.
Questo enzima consente un’efficace integrazione genica in una varietà di siti genomici terapeuticamente rilevanti in più tipi di cellule umane, rappresentando una nuova piattaforma versatile per l’editing del genoma delle cellule dei mammiferi. Gli scienziati aggiungono che l’integrazione genica mirata e programmabile nelle cellule potrebbe consentire varie applicazioni, tra cui lo sviluppo d’immunoterapie con cellule T CAR per il trattamento del cancro e di linee cellulari transgeniche necessarie per la ricerca di base e l’ingegneria biomedica.
In questo momento, Sternberg e altri ricercatori del settore stanno affrontando una delle sfide principali legate allo sviluppo di evoCAST e di altri strumenti di editing genetico di nuova generazione: il problema della somministrazione. Si tratta di trovare metodi efficaci e sicuri per trasferire questi sistemi complessi all’interno delle cellule o dei tessuti bersaglio. (S. B.).

La terapia genica apre nuove prospettive di trattamento per l’anemia falciforme e la beta talassemia
L’Italia è tra i Paesi pionieri anche nell’applicazione clinica di CRISPR-Cas9
EMOGLOBINOPATIE IN CAMPO LE ULTIME STRATEGIE
DALLA MODIFICA MOLECOLARE
ALLA CURA CLINICA
Dopo decenni di approcci terapeutici sintomatici o palliativi, l’avvento della terapia genica ha rivoluzionato le prospettive cliniche per la cura dell’anemia falciforme (SCD) e della beta talassemia trasfusione-dipendente (TDT), due delle emoglobinopatie più diffuse a livello globale. La terapia genica apre, dunque, la strada a interventi potenzialmente risolutivi. Un passo ulteriore è stato infatti compiuto con l’introduzione dell’editing genomico, tramite CRISPR/Cas9, che consente una correzione mirata delle mutazioni patogenetiche o la modulazione di elementi regolatori nei geni dell’emoglobina intervenendo sulle cellule staminali ematopoietiche per ripristinare la sintesi di emoglobina e il fenotipo patologico.
La terapia a base di CRISPR, exagamglogene autotemcel (Casgevy®) consente la disattivazione mirata di BCL11A, repressore dell’espressione dell’emoglobina fetale (HbF), favorendo una compensazione funzionale della beta-globina difettosa. Casgevy® ha ottenuto, a febbraio del 2024, l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (da EMA e FDA) per il trattamento di pazienti (di età superiore o uguale a 12 anni) con TDT e SCD caratterizzata da crisi vaso-occlusive, per i quali è appropriato il trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSC) e non è disponibile un donatore consanguineo con antigene leucocitario umano (HLA) compatibile.
L’autorizzazione è stata concessa in base ai risultati emersi dagli studi clinici condotti anche in Italia. Questi hanno dimostrato un’efficacia della terapia su oltre il 90% dei pazienti, che viene mantenuta fino ad almeno 5 anni, ad oggi il tempo massimo di follow-up. L’Italia si
*Biologo, Specialista in Genetica, Direttore di Laboratorio di Genetica Medica di Biorep S.r.l
**Medico, Specialista in Ematologia Clinica, Oncologia, Allergologia e Igiene e Medicina Preventiva, Già Direttore del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Lodi
conferma così un’eccellenza a livello europeo per l’utilizzo clinico e l’accesso alle terapie avanzate. Il prodotto Casgevy® è stato somministrato a fine aprile-maggio 2025 in quattro pazienti affetti da anemia falciforme o da beta-talassemia: due giovani uomini affetti da SCD e due giovani donne, una affetta da SCD e l’altra da TDT trattati presso tre centri clinici di eccellenza del nostro Paese grazie anche al fondo 5% di AIFA.
Si tratta di terapie molto costose, circa due milioni di euro per ogni singolo paziente, ma con somministrazione “one-shot”, cioè una sola volta in modo definitivo e non ripetibile. Non sono stati rilevati eventi avversi gravi correlabili alla procedura di editing e la ricostituzione ematopoietica è avvenuta in tempi compatibili con le casistiche internazionali. I risultati dei trial clinici Internazionali mediante CRISP-Casp9 sono significativi: nei primi mesi successivi al trattamento, i soggetti non hanno più manifestato crisi vaso-occlusive con un tasso di assenza di eventi vaso-occlusivi superiore al 93% e indipendenza trasfusionale in oltre il 90% dei pazienti. I livelli di HbF hanno superato stabilmente il 40%, con una riduzione netta dei sintomi clinici e un miglioramento della qualità di vita.
L’editing genomico basato su CRISPR/Cas9, consentendo modificazioni sito-specifiche del DNA, minimizza il rischio di eventi genotossici a differenza della terapia genica mediata da vettori retrovirali che integrandosi casualmente nel genoma possono causare mutagenesi inserzionale e attivazione oncogena.
Restano tuttavia alcune criticità. Il condizionamento mieloablativo con busulfano è ancora necessario e può comportare effetti collaterali significativi, inclusa la tossicità gonadica. Inoltre, l’accesso alla terapia è limitato a causa dei costi elevati, produzione centralizzata e necessità di ambienti altamente specializzati. Tali ostacoli rappresentano una sfida, soprattutto nei Paesi dove queste malattie hanno la più alta incidenza. In parallelo, la ricerca si sta orientando verso soluzioni sempre più raffinate: editing in vivo, pri-
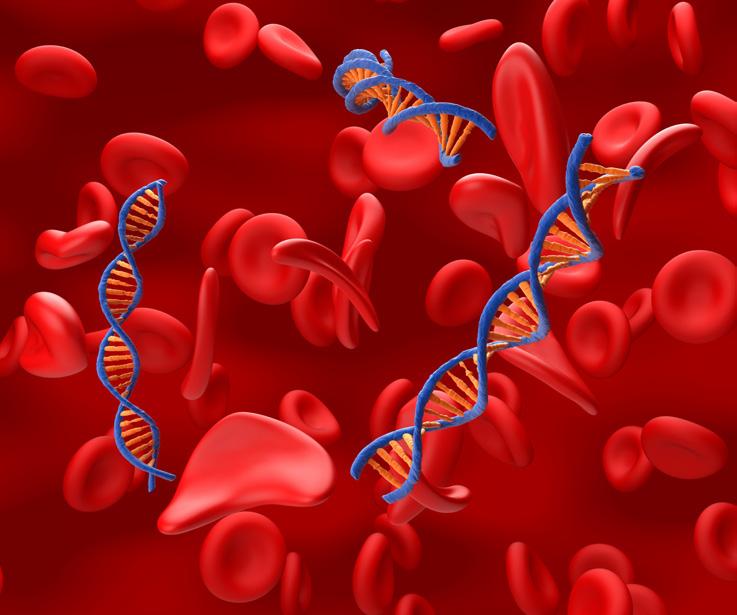
La terapia genica ha rivoluzionato le prospettive cliniche per la cura della SCD e della TDT, due delle emoglobinopatie più diffuse a livello globale. Un passo ulteriore è stato infatti compiuto con l’introduzione dell’editing genomico, tramite CRISPR/Cas9
me editing, vettori non virali e approcci mRNA-based potrebbero in futuro eliminare la necessità del trapianto cellulare ex vivo e del condizionamento mieloablativo. I risultati ottenuti con CRISPR nei pazienti trattati rappresentano una svolta concreta, trasformando patologie ereditarie gravi in condizioni potenzialmente risolvibili. L’orizzonte terapeutico, per la prima volta, si apre alla parola “cura”.
PRIMA DELL’AVVENTO DI CRISPR-CAS9
Se adesso la svolta nella cura delle emoglobinopatie è la terapia genica CRISPR-CAS9 fino a ieri le strade percorribili erano altre. I primi approcci di “gene addition” portavano al trasferimento ex-vivo di una copia funzionale del gene B-globinico - veicolata da un vettore lentivirale - in cellule staminali ematopoietiche autologhe, al fine di ripristinare una produzione efficace di emoglobina e correggere il difetto molecolare. Nel 2029 l’approvazione di betibeglogene autotemcel (Zynteglo®) con l’autorizzazione condizionata di EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) e nel 2022 di FDA (Food and Drug Administration), ha garantito l’indipendenza trasfusionale in circa l’80-90% dei pazienti nella beta talassemia trattati. Strategie analoghe per l’anemia falciforme - SCD Sickle Cell Disease (Lyfgenia®), mediante l’espressione di emoglobine anti-sickling, hanno ridotto drasticamente la frequenza degli eventi vaso-occlusivi (circa 70-80%).

CROMOSOMI , LA SVOLTA DEL CODICE A BARRE
Un nuovo studio della Sapienza apre la via a diagnosi più precise, esplorando il “buio genetico” dei centromeri
Il genoma umano non è più un mistero, almeno per un gruppo di ricercatori della Sapienza, guidati dalla biologa Simona Giunta, del dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin, che ha decifrato per la prima volta la struttura organizzata dei centromeri, regioni centrali dei cromosomi che finora erano considerate troppo complesse da analizzare.
I risultati, pubblicati sulla prestigiosa rivista Science, aprono scenari promettenti per la comprensione delle malattie genetiche e dei tumori. I centromeri giocano un ruolo cru -
ciale nella segregazione dei cromosomi durante la divisione cellulare.
Essi sono essenziali per il corretto svolgimento della mitosi e della meiosi, assicurando che ogni cellula figlia riceva il corretto numero di cromosomi. Comprenderne il meccanismo significa istituire una nuova mappa nel territorio genetico umano. Ogni cellula del nostro corpo, per dividersi correttamente, deve copiare in modo preciso il proprio DNA.
Al centro di ogni cromosoma si trova il centromero, una specie di “strozzatura” che tiene insieme le due metà simmetriche del cromoso -
ma e svolge un ruolo cruciale in questa delicata operazione.
Per decenni i centromeri, composti da lunghissime sequenze ripetitive di Dna, sono rimasti una zona d’ombra della genetica.
La squadra diretta da Simona Giunta è riuscita a scoprire che ogni centromero ha una sua “firma” specifica, come un codice a barre. Grazie a nuove tecnologie di sequenziamento e a sofisticati algoritmi, il team del Giunta Lab è riuscito a decifrare questa complessa regione che ha un pattern unico.
E non è tutto: lo stesso schema si ripete in persone diverse, suggerendo che esiste un’organizzazione coerente e conservata in tutti gli esseri umani.
Questo codice a barre può essere utilizzato per analizzare le variazioni tra individui o in presenza di patologie. I ricercatori hanno anche scoperto un elemento ricorrente in queste sequenze, battezzato “centenia”, che si trova nei centromeri e lungo i bracci dei cromosomi.
Lo studio si inserisce in un progetto più ampio, sostenuto dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro e, più recentemente, dal Consiglio Europeo della Ricerca (ERC), volto a indagare il ruolo dei centromeri nel cancro e nelle malattie genetiche.
La ricerca nel campo della genetica sta subendo un cambiamento di paradigma: non ci si concentra più solo sui geni, ma anche sulle regioni complesse e ripetitive del genomacome i centromeri - rimasti finora ai margini.
«Queste regioni stanno diventando finalmente esplorabili, con strumenti nuovi e portando nuove domande che saranno al centro della ricerca del futuro» - ha dichiarato Simona Giunta. Comprendere i centromeri rappresenta una nuova frontiera per rivelare aspetti ancora inesplorati del nostro patrimonio genetico. (M. A.).
Corso Fad
Relazioni Contaminanti Ambientali e Salute Umana

30 settembre 2025
7,5 crediti Ecm
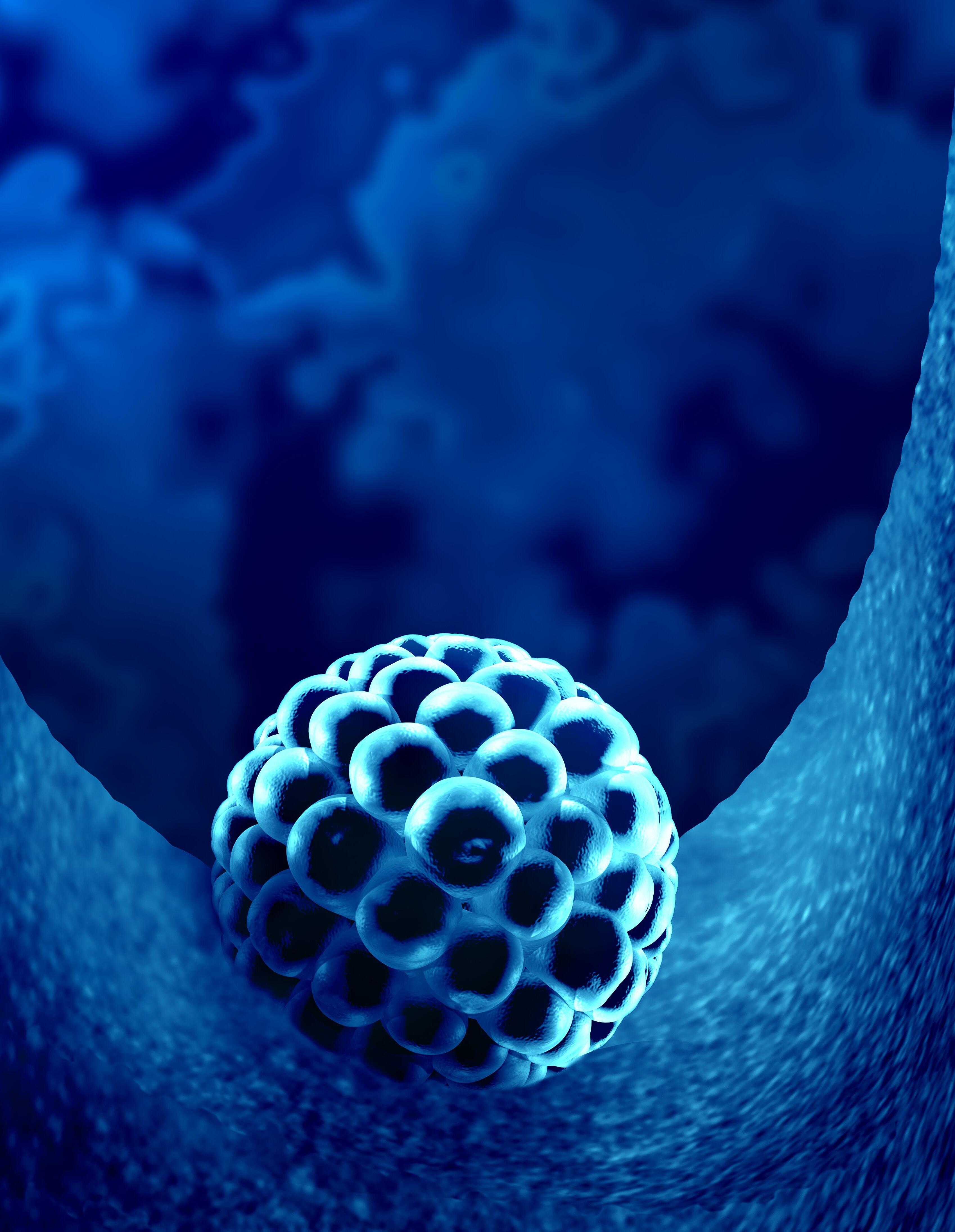
L’AI DIVENTA IL ‘CO-PILOTA’
NEL
LABORATORIO
PER PREDIRE QUALI EMBRIONI DIVENTERANNO BLASTOCISTI
Tre studi coordinati dal team di ricerca del gruppo Genera presentati al congresso Eshre di Parigi evidenziano che l’Intelligenza Artificiale aiuta a valutare la qualità di ovociti ed embrioni. Ma il ruolo dei biologi è insostituibile
Tre studi coordinati dal team di ricerca italiano del gruppo Genera presentati al 41esimo congresso della Società europea di Riproduzione umana ed embriologia (Eshre) che si è tenuto a Parigi, dimostrano come l’integrazione tra intelligenza artificiale (AI) e tecnologia time-lapse stia cambiando radicalmente le pratiche cliniche in medicina della riproduzione. E l’AI si afferma sempre più come ‘assistente’, ‘co-pilota’ dell’embriologo nel valutare la qualità degli ovociti, lo sviluppo degli embrioni e il momento ideale per la biopsia embrionale, promettendo una gestione più oggettiva, personalizzata, riproducibile ed efficiente dei trattamenti di fecondazione assistita.
Il primo studio, effettuato in collaborazione con l’Università di Pavia e grazie a un grant Eshre, ha coinvolto oltre 6.000 ovociti inseminati tramite ICSI e coltivati in incubatori time-lapse EmbryoScope, analizzando i movimenti citoplasmatici nei primi 3 giorni di sviluppo. I ricercatori hanno addestrato tre modelli AI - ROCKET, LSTM-FCN e ConvTran - utilizzando algoritmi per trasformare alcuni video in dati temporali analizzabili. I modelli hanno raggiunto un’accuratezza predittiva dello sviluppo a blastocisti, quindi della capacità dell’embrione di maturare correttamente prima del trasferimento in utero (giorno 5-7 dopo l’inseminazione), del 63% già al giorno 1 e fino al 70% al giorno 3. «I modelli sono stati sviluppati senza alcun intervento manuale, utilizzando esclusivamente dati time-lapse e senza annotazioni aggiuntive - commenta Danilo Cimadomo, Research Manager del gruppo Genera - è un passo avanti significativo verso valutazioni embrionali più precoci e oggettive. L’AI, integrando dinamiche citoplasmatiche, timing dello sviluppo e metadati dei pazienti, potrà in futuro fornire strumenti di supporto clinico sempre più personalizzati e affidabili. Il vantaggio di non essere determinate da interventi manuali degli operatori è positivo perché comporta un risparmio di tempo da investire in funzioni più cognitivamente attive e importante, e puntare a una collaborazione AI-operatori basata su osservazioni di caratteristiche differenti».
AI e qualità ovocitaria: il Magenta-score nelle donazioni Il secondo studio multicentrico, condotto in Spagna, ha valutato 1.275 ovociti di donatrici di ovociti tramite l’algoritmo Magenta-score, sviluppato da Future Fertility. Applicato in cieco prima dell’inseminazione, il sistema ha predetto con buona precisione la probabilità di sviluppo a blastocisti. Gli ovociti che hanno dato origine a blastocisti presentavano punteggi Magenta significativamente più alti rispetto a quelli che non si sono sviluppati, dimostrando l’efficacia predittiva dello strumento. Inoltre, nel 72% dei casi, il numero di blastocisti ottenute rientrava esattamente nel range previsto dall’algoritmo o era addirittura maggiore. Tra i cicli completati, il Magenta score mostrava una buona associazione anche con il tasso cumulativo di nati vivi.

«L’intelligenza artificiale e la tecnologia time-lapse possano fornire soluzioni integrate per ottimizzare la selezione ovocitaria, prevedere precocemente la competenza embrionale e standardizzare le pratiche di laboratorio, riducendo variabilità e soggettività. Dall’analisi iniziale degli ovociti fino alla biopsia preimpianto, la medicina della riproduzione entra in una nuova era, basata su dati, algoritmi e medicina personalizzata»
Tempistica della biopsia: maggiore sicurezza e standardizzazione
Il terzo studio ha affrontato una delle procedure più delicate del processo IVF: la biopsia dell’embrione per la diagnosi genetica preimpianto. Analizzando 1.943 blastocisti coltivate tra il 2013 e il 2020 e sottoposte a biopsia in diversi anni e da parte di sette operatori, i ricercatori hanno dimostrato come l’utilizzo di TLM combinata ad AI (in particolare con il sistema CHLOE di Fairtility) consenta di identificare il momento ottimale per la biopsia in modo uniforme e riproducibile. «Il momento in cui si esegue la biopsia è determinante per la qualità del risultato genetico e per la sicurezza dell’embrione - ha sottolineato Cimadomo - l’AI può aiutare a monitorare in tempo reale l’espansione e guidare l’embriologo nella scelta del momento più adeguato alla procedura».
Ma l’AI non sostituirà gli embriologi
«Questi tre studi - commenta Laura Rienzi, biologa specializzata in embriologia e direttore scientifico dei centri Genera - dimostrano come l’intelligenza artificiale e la tecnologia time-lapse possano fornire soluzioni integrate per ottimizzare la selezione ovocitaria, prevedere precocemente la competenza embrionale e standardizzare le pratiche di laboratorio, riducendo variabilità e soggettività. Dall’analisi iniziale degli ovociti fino alla biopsia preimpianto, la medicina della riproduzione entra in una nuova era, basata su dati, algoritmi e medicina personalizzata».
Anche in un recente editoriale sulla rivista RBMO (Reproductive BioMedicine Online) dal provocatorio titolo: “Abbiamo ancora bisogno degli embriologi?” la professoressa Rienzi ha evidenziato che «se da un lato gli algoritmi AI possono predire la potenzialità di impianto degli embrioni, come dimostrato da diversi studi comparativi, dall’altro l’interpretazione dei dati, la gestione dei casi complessi e l’ideazione di nuovi indicatori di performance rimangono competenze insostituibili dell’embriologo. La letteratura citata nell’editoriale suggerisce che l’AI ha una performance comparabile, ma non superiore, all’esperienza umana, soprattutto nelle attività decisionali. Anche esperienze come la vitrificazione robotizzata o l’ICSI automatizzata mostrano risultati promettenti, ma richiedono ulteriori validazioni cliniche su larga scala». (M. A.).

QUANDO È IL PADRE AD ESSERE “FUORI TEMPO” RISCHI NASCOSTI PER FERTILITÀ E SALUTE DEI FIGLI
Diversi studi dimostrano che dopo i 40 anni si osservano peggioramenti significativi nei parametri seminali
Per anni, l’attenzione della medicina riproduttiva si è concentrata quasi esclusivamente sull’età materna, considerata il principale fattore limitante della fertilità e della salute fetale. Dopo i 35 anni, ogni mese in più viene valutato, discusso, monitorato. L’età del padre, al contrario, è stata a lungo ignorata o considerata irrilevante.
Eppure, le evidenze scientifiche emerse negli ultimi anni raccontano un’altra storia: anche l’invecchiamento maschile ha un impatto concreto sulla fertilità, sugli esiti delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) e, soprattutto, sul benessere della prole.
L’aumento dell’età media dei padri al momento del concepimento è oggi un fenomeno trasversale, osservato in tutti i Paesi industrializzati. In un’epoca in cui la genitorialità è spesso posticipata, l’uomo arriva sempre più spesso alla paternità in età avanzata, inconsapevole delle implicazioni biologiche che questo può comportare. Diversi studi dimostrano che dopo i 40 anni - e in modo più marcato oltre i 50 - si osservano peggioramenti significativi nei parametri seminali, un aumento della frammentazione del DNA spermatico e un rischio più elevato di anomalie genetiche nella prole.
Per anni, l’attenzione della medicina riproduttiva si è concentrata quasi esclusivamente sull’età materna, considerata il principale fattore limitante della fertilità e della salute del futuro nascituro. Tuttavia, le evidenze scientifiche più recenti hanno dimostrato che anche l’età paterna può influenzare significativamente la probabilità di concepimento e la salute della prole.

L’invecchiamento testicolare è un processo graduale ma inesorabile. Dopo i 35 anni, si osserva un calo della concentrazione spermatica, una riduzione della motilità progressiva e una maggiore incidenza di spermatozoi con morfologia alterata. Parallelamente, aumentano i livelli di stress ossidativo e la frammentazione del DNA spermatico, entrambi marcatori noti di disfunzione riproduttiva maschile e di ridotta capacità fecondante
L’invecchiamento testicolare è un processo graduale ma inesorabile. Dopo i 35 anni, si osserva un calo della concentrazione spermatica, una riduzione della motilità progressiva e una maggiore incidenza di spermatozoi con morfologia alterata. Parallelamente, aumentano i livelli di stress ossidativo e la frammentazione del DNA spermatico, entrambi marcatori noti di disfunzione riproduttiva maschile e di ridotta capacità fecondante. L’integrità genetica del gamete maschile si riduce, mentre i sistemi di riparazione del DNA diventano progressivamente meno efficienti. Queste alterazioni non si limitano alla qualità del seme, ma si riflettono sugli esiti clinici della gravidanza. Una recente meta-analisi condotta su oltre 28 lavori relativi alle tecniche di PMA, ha evidenziato che l’età pa-
* Responsabile del Laboratorio di PMA - AOU Policlinico Umberto I, Roma e Presidente della Società Italiana di Embriologia, Riproduzione e Ricerca (SIERR)
terna avanzata è associata a una minore probabilità di gravidanza e di nati vivi, a un maggiore rischio di aborto spontaneo e a un aumento di complicanze ostetriche, anche quando si utilizzano ovociti di giovani donatrici.
Questo dato suggerisce che, sebbene gli ovociti provenienti da donne giovani siano dotati di una maggiore capacità di riparare i danni al DNA spermatico, tale meccanismo risulti spesso insufficiente a compensare le alterazioni genetiche ed epigenetiche associate all’invecchiamento maschile.
Oltre agli effetti sulla fertilità maschile e sugli esiti della gravidanza, l’età paterna avanzata può avere ripercussioni profonde e durature sulla salute dei figli. A partire dai 40 anni, aumenta in modo esponenziale la probabilità di mutazioni puntiformi de novo negli spermatozoi, dovute al numero elevato di cicli mitotici che le cellule germinali maschili subiscono nel corso della vita. Queste mutazioni, trasmesse al momento della fecondazione, sono state associate a un maggior rischio di patologie rare monogeniche, come l’acondroplasia e la sindrome di Apert, ma anche a disordini neuropsichiatrici complessi come l’autismo e la schizofrenia.
Anche l’epigenetica contribuisce a spiegare il legame tra età paterna e salute della prole. Studi recenti hanno evidenziato che l’invecchiamento maschile è associato a modificazioni nei pattern di metilazione del DNA e nell’organizzazione della cromatina spermatica, con possibili effetti sullo sviluppo embrionale precoce e sulla regolazione genica fetale. A ciò si aggiunge l’alterazione a carico di RNA non codificanti (microRNA e piRNA), che possono veicolare segnali disfunzionali all’ovocita al momento della fecondazione.
Le conseguenze cliniche di questi meccanismi sono sempre più oggetto di studio. La prole di padri anziani presenta un rischio aumentato di disordini del neurosviluppo,
disturbi cognitivi, tumori pediatrici (in particolare leucemie e tumori del sistema nervoso centrale) e, in alcuni casi, una predisposizione a malattie metaboliche e cardiovascolari in età adulta. Questi dati suggeriscono che la paternità tardiva non sia priva di conseguenze a lungo termine, e che le implicazioni vadano ben oltre la fertilità immediata.
A questa crescente mole di dati clinici si aggiungono le evidenze provenienti da studi longitudinali condotti su ampie popolazioni. Un ampio studio svedese ha mostrato che i figli di padri con più di 45 anni presentano un rischio significativamente aumentato di morte neonatale precoce, di crisi epilettiche nei primi anni di vita e di difficoltà scolastiche già nei cicli primari di istruzione.
Tali associazioni sono state osservate anche dopo aver corretto per età materna, livello socioeconomico e presenza di patologie familiari pregresse. Non meno rilevanti sono i dati emersi nel campo della salute mentale: oltre

Un ampio studio svedese ha mostrato che i figli di padri con più di 45 anni presentano un rischio significativamente aumentato di morte neonatale precoce, di crisi epilettiche nei primi anni di vita e di difficoltà scolastiche già nei cicli primari di istruzione. Alcune ipotesi suggeriscono che le mutazioni germinali, associate al danno progressivo del DNA spermatico, possano alterare i circuiti neurobiologici sin dalle prime fasi dello sviluppo embrionale
all’autismo e alla schizofrenia, l’età paterna è stata associata a un rischio incrementato di disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e disturbo bipolare. Queste condizioni, pur manifestandosi in età adulta, sembrano avere radici precoci già durante lo sviluppo fetale.
Alcune ipotesi suggeriscono che le mutazioni germinali, associate al danno progressivo del DNA spermatico, possano alterare i circuiti neurobiologici sin dalle prime fasi dello sviluppo embrionale. Dal punto di vista clinico, questi dati pongono un interrogativo etico e clinico: i futuri padri sono informati in modo adeguato sui rischi legati all’età?
In un’ottica di medicina predittiva e preventiva, considerare il fattore età anche sul versante maschile potrebbe permettere una più efficace valutazione del rischio e una gestione personalizzata della coppia infertile. Nonostante le evidenze raccolte negli ultimi anni, l’età paterna continua a essere poco considerata nei percorsi clinici e informativi legati alla procreazione.
Le linee guida delle principali società scientifiche riconoscono a fatica un “limite” oltre il quale la paternità diventa rischiosa, e i percorsi di consulenza genetica si concentrano quasi esclusivamente sul profilo materno. Questa disattenzione appare oggi ingiustificabile.
Alla luce dei dati disponibili, è auspicabile un cambiamento di paradigma che includa anche il fattore maschile nella valutazione del rischio riproduttivo. Nei centri di PMA, l’età del partner maschile dovrebbe essere oggetto di attenta considerazione, soprattutto quando si superano i 45 anni. Oltre agli aspetti strettamente clinici, il tema solleva interrogativi di natura sociale ed etica. In una società in cui la genitorialità viene sempre più posticipata, informare correttamente i futuri padri sui rischi legati all’invecchiamento riproduttivo diventa una questione di sanità pubblica.
Non si tratta di colpevolizzare, ma di responsabilizzare, di colmare un vuoto culturale e scientifico. Perché anche i padri, come le madri, hanno un tempo biologico da rispettare e ignorarlo significa trascurare una variabile determinante nella salute delle generazioni future.
Bibliografia
1. Murugesu et al., Reprod Biomed Online, 2022.
2. Kaltsas et al., Genes, 2023.
3. Sharma et al., Reproductive Biology and Endocrinology, 2015.
4. Sartorius & Nieschlag, Asian J Androl, 2010.
5. Kong et al., Nature, 2012.
6. Hultman et al., JAMA Psychiatry, 2011.
7. Reichenberg et al., Arch Gen Psychiatry, 2006.
8. Jenkins et al., PLoS Genet, 2014.
9. Yeshurun & Hannan, Front Cell Dev Biol, 2022.
L’OROLOGIO BIOLOGICO ESISTE ANCHE PER GLI UOMINI PIÙ ABORTI QUANDO
IL PARTNER È OVER 45
Lo studio presentato al congresso europeo della Medicina della riproduzione dimostra che anche se gli ovociti arrivano da una donna di 26 anni il fattore età paterna influenza negativamente gravidanze e nascite
Un tema quanto mai attuale, la procreazione medicalmente assistita. Uno studio internazionale presentato ad Eshre, il congresso europeo della società di Embriologia e Medicina della Riproduzione, pubblicato su Human Reproduction ha dimostrato che è importante anche l’età paterna. I tassi di abortività erano infatti molto più alti nelle coppie in cui il partner maschile aveva più di 45 anni, attestandosi al 23.8% rispetto al 16.3% del gruppo dei papà più giovani. Minori anche le nascite: 35.1% nel gruppo di padri più anziani rispetto al 41% dei più giovani. La ricerca prende in considerazione anche gli ovociti, “giovani”, ma se il partner maschile ha più di 45 anni si correrà un rischio maggiore di aborto con minori possibilità di nascite. Lo studio presentato a Eshre è stato condotto dal 2019 al 2023 in sei centri della fertilità in Italia e Spagna su 1712 donatrici di ovociti per cicli di fertilizzazione in vitro, con un’età media di 26.1 anni fertilizzati con spermatozoi
congelati del partner della coppia, in cui l’età media della donna era di 43.3 anni: la giovane età delle donatrici di ovociti ha consentito di studiare l’età paterna come fattore influenzante.
Lo studio ha inoltre suddiviso i partecipanti in due gruppi in base all’età del partner maschile: uno composto da 1066 uomini di età pari o inferiore a 45 anni, e l’altro da 646 uomini con più di 45 anni. Sebbene i tassi di fertilizzazione e lo sviluppo embrionale fossero simili in entrambi i gruppi, sono emerse differenze significative nei risultati clinici.
Nelle coppie con uomini over 45, il tasso di aborto spontaneo risultava sensibilmente più alto: 23,8% rispetto al 16,3% nel gruppo più giovane. Anche le percentuali di nascita sono risultate inferiori tra i padri più anziani (35,1% contro 41%). Lo studio mette in discussione le vecchie convinzioni secondo cui la qualità degli spermatozoi è meno rilevante dopo la fertilizzazione, e spinge quindi a sottolineare l’importanza di includere l’età pater-
na quando si considera un counselling per trattamenti di fertilità avendo utilizzato esclusivamente ovociti donati da donne giovani.
Secondo i ricercatori, le differenze osservate potrebbero essere attribuite a modificazioni genetiche ed epigenetiche associate all’invecchiamento maschile, come una maggiore frammentazione del DNA spermatico, un aumento delle anomalie cromosomiche e delle alterazioni nei meccanismi di metilazione del DNA. (M. A.).
ESHRE, acronimo di European Society of Human Reproduction and Embryology, è una società scientifica europea che si occupa di ricerca e pratica clinica nella riproduzione umana. Il termine “fertilità” è strettamente legato alle attività di questa società, poiché si concentra sullo studio e il trattamento dei problemi di fertilità sia maschili che femminili, oltre che sulla ricerca e sviluppo di tecniche di fecondazione assistita.

La nuova tecnologia combina la risonanza magnetica ad alta velocità con metodi di apprendimento automatico per l’elaborazione dei dati e consente una diagnosi precoce delle patologie
UNA NUOVA MRI INDIVIDUA LE ALTERAZIONI METABOLICHE ASSOCIATE ALLE MALATTIE CEREBRALI
Un team internazionale di ricercatori, guidato dall’Università dell’Illinois Urbana-Champaign, ha sviluppato una nuova tecnologia di imaging cerebrale che permette di visualizzare il metabolismo del cervello e riconoscere precocemente le alterazioni metaboliche associate alle malattie cerebrali come tumori e sclerosi multipla. Secondo gli scienziati la nuova tecnica ha il potenziale di trasformare l’imaging metabolico clinico e la capacità, a lungo ricercata in campo medico, di fornire dati in modo non invasivo e senza marcatori della funzione cerebrale e delle malattie, sia per la ricerca sia per le applicazioni cliniche.
Guidato da Zhi-Pei Liang, professore di ingegneria elettrica e informatica e membro del Beckman Institute for Advanced Science and Technology dell’Università dell’Illinois, il team internazionale ha pubblicato i risultati della ricerca sulla rivista Nature Biomedical Engineering. Nello studio i ricercatori hanno utilizzato macchine MRI cliniche con le quali hanno mappato l’attività metabolica di tutto il cervello in modo non invasivo e ad alta risoluzione. L’analisi ha rivelato differenze nell’attività metabolica e nei livelli dei neurotrasmettitori tra le regioni cerebrali, ha individuato alterazioni metaboliche nei tumori cerebrali e ha mappato e caratterizzato le lesioni della sclerosi multipla, su pazienti che hanno trascorso solo pochi minuti in uno scanner MRI.
«Comprendere il cervello, come funziona e cosa non funziona quando è danneggiato o malato è considerato uno dei compiti scientifici più entusiasmanti e impegnativi del nostro tempo - ha affermato Liang -. La risonanza magnetica ha svolto un ruolo fondamentale nello svelare i misteri del cervello negli ultimi quarant’anni. La nostra nuova tecnologia aggiunge un’altra dimensione alle capacità della risonanza magnetica per l’imaging cerebrale: la visualizzazione del metabolismo cerebrale e l’individuazione delle alterazioni metaboliche associate alle malattie cerebrali».
Rispetto alla risonanza magnetica convenzionale e a quella funzionale, la nuova tecnologia presenta diverse novità. Come spiegano gli autori, sia la tecnica MRI che quella fMRI si basano sui segnali di risonanza magnetica delle molecole d’acqua. La nuova tecnologia misura i segnali dei metaboliti cerebrali e dei neurotrasmettitori, oltre che delle molecole d’acqua, una tecnica nota come imaging spettroscopico a risonanza magnetica. «Queste immagini MRSI possono fornire nuove importanti informazioni sul funzionamento del cervello e sui processi patologici e potrebbero migliorare la sensibilità e la specificità per l’individuazione e la diagnosi delle malattie cerebrali» - ha affermato Yibo Zhao, primo autore dell’articolo. In precedenza, altri tentativi di ottenere immagini MRSI sono stati ostacolati dai lunghi tempi necessari per acquisire le immagini e dagli alti livelli di rumore che coprivano i segnali dei neurotrasmettitori. La nuova tecnica ha superato entrambe le sfide. «La

«Comprendere il cervello, come funziona e cosa non funziona quando è danneggiato o malato è considerato uno dei compiti scientifici più entusiasmanti e impegnativi del nostro tempo - ha affermato Liang -. La risonanza magnetica ha svolto un ruolo fondamentale nello svelare i misteri del cervello negli ultimi quarant’anni. La nostra nuova tecnologia aggiunge un’altra dimensione alle capacità della risonanza magnetica per l’imaging cerebrale: la visualizzazione del metabolismo cerebrale e l’individuazione delle alterazioni metaboliche associate alle malattie cerebrali»
nostra tecnologia supera diversi ostacoli tecnici di lunga data relativi all’imaging metabolico veloce ad alta risoluzione, integrando sinergicamente l’acquisizione ultraveloce dei dati con metodi di apprendimento automatico basati sulla fisica per l’elaborazione dei dati» - ha affermato Liang. Come si legge nello studio, grazie alla nuova tecnologia MRSI si ottengono mappe molecolari di alta qualità e il tempo necessario per una scansione completa del cervello si è ridotto a 12 minuti e mezzo. «I cambiamenti metabolici e fisiologici spesso si verificano prima che le anomalie strutturali e funzionali siano visibili sulle immagini MRI e fMRI convenzionali - ha dichiarato Zhao -. L’imaging metabolico, quindi, può portare a una diagnosi precoce e a un intervento tempestivo delle malattie cerebrali».
Nello studio la tecnica MRSI è stata testata su diverse popolazioni. In soggetti sani, i ricercatori hanno individuato e mappato attività metaboliche variabili in diverse regioni del cervello, indicando che tale attività non è universale. In pazienti colpiti da oligodendromioma, un tipo di tumore cerebrale, i ricercatori hanno riscontrato alterazioni metaboliche, come livelli elevati di colina e lattato, che differivano in base al diverso grado della neoplasia, anche quando i tumori apparivano identici nelle immagini cliniche della risonanza magnetica. Nei soggetti affetti da sclerosi multipla, la tecnica ha rilevato cambiamenti molecolari associati alla risposta neuro infiammatoria e una riduzione dell’attività neuronale fino a settanta giorni prima che i cambiamenti diventassero visibili sulle immagini cliniche della risonanza magnetica. I ricercatori prevedono un ampio potenziale di utilizzo clinico della loro tecnica: «Monitorando i cambiamenti metabolici nel tempo, i medici potranno valutare l’efficacia dei trattamenti per le condizioni neurologiche» - ha affermato Liang. «Le informazioni metaboliche potranno anche essere utilizzate per personalizzare i trattamenti dei singoli pazienti in base ai loro profili metabolici unici»ha concluso il ricercatore.
ALZHEIMER NASCE LA PRIMA GRANDE BANCA DI STAMINALI PER SVELARNE I SEGRETI
Una risorsa libera per la scienza globale, per comprendere i fattori genetici di rischio e sviluppare terapie personalizzate

di Carmen Paradiso
Nel mondo della ricerca scientifica, ogni passo avanti verso la comprensione dell’Alzheimer rappresenta una conquista significativa. È stata realizzata la prima grande banca di cellule staminali prelevate da persone affette da Alzheimer e da soggetti sani, un patrimonio biologico che sarà messo a disposizione della comunità scientifica globale. Il progetto, sviluppato dall’Istituto di ricerca sulla demenza del Regno Unito (UKDRI) presso l’Università di Cardiff, è stato descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Stem Cell Reports. Questa banca rappresenta una svolta non solo per la quantità e la qualità dei campioni raccolti, ma soprattutto per il principio su cui si fonda: l’accessibilità. Le cellule saranno infatti liberamente disponibili per ricercatori di tutto il mondo, con l’obiettivo di accelerare lo studio dell’Alzheimer su scala internazionale. Un nuovo paradigma collaborativo che potrebbe finalmente illuminare i tanti punti oscuri ancora presenti nella comprensione della malattia.
L’Alzheimer
è la forma più comune di demenza e colpisce circa il 10% delle persone con più di 65 anni, percentuale che sale a un terzo tra gli over 85. Si tratta di una malattia neurodegenerativa progressiva che compromette le funzioni cognitive, in particolare la memoria, il linguaggio e il ragionamento, fino a rendere il paziente completamente dipendente dagli altri.
Nonostante gli enormi sforzi scientifici compiuti negli ultimi decenni, l’eziologia dell’Alzheimer resta in larga parte sconosciuta. Una delle certezze, però, riguarda il ruolo
significativo giocato dalla genetica. Sono ormai note diverse varianti genetiche associate a un rischio maggiore di sviluppare la malattia, come ad esempio quelle a carico del gene Apoe (in particolare la variante ε4), ma il meccanismo con cui queste alterazioni influenzano l’insorgenza e la progressione della malattia è ancora oggetto di studio.
Per affrontare questa complessità, i ricercatori di Cardiff hanno realizzato una banca biologica senza precedenti, che raccoglie campioni da oltre 100 donatori, suddivisi in due gruppi principali: da un lato, persone affette da Alzheimer caratterizzate da un alto rischio genetico; dall’altro, individui sani che presentano invece un basso rischio genetico. Questa struttura comparativa permetterà di analizzare non solo la presenza delle varianti genetiche,

© Naeblys/shutterstock.com

L’Alzheimer è la forma più comune di demenza e colpisce circa il 10% delle persone con più di 65 anni, percentuale che sale a un terzo tra gli over 85. Si tratta di una malattia neurodegenerativa progressiva che compromette le funzioni cognitive, in particolare la memoria, il linguaggio e il ragionamento, fino a rendere il paziente completamente dipendente dagli altri. I ricercatori di Cardiff hanno realizzato una banca biologica senza precedenti, che raccoglie campioni da oltre 100 donatori, suddivisi in due gruppi principali: da un lato, persone affette da Alzheimer caratterizzate da un alto rischio genetico; dall’altro, individui sani che presentano invece un basso rischio genetico. Questa struttura comparativa permetterà di analizzare non solo la presenza delle varianti genetiche, ma anche il loro impatto sul funzionamento cellulare, in condizioni controllate e replicabili.
ma anche il loro impatto sul funzionamento cellulare, in condizioni controllate e replicabili.
L’innovazione di questo progetto risiede nella tecnologia delle cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC, induced pluripotent stem cells). Partendo da semplici cellule del sangue dei donatori, i ricercatori le hanno riprogrammate geneticamente in laboratorio per riportarle a uno stadio definito immaturo, in cui sono capaci di trasformarsi in qualsiasi altro tipo cellulare dell’organismo umano. In altre parole, cellule del sangue sono diventate cellule staminali pluripotenti, e queste possono poi essere guidate a differenziarsi, ad esempio, in neuroni o cellule gliali, le principali componenti del sistema nervoso. Questa tecnologia permette di ricostruire in vitro modelli cellulari altamente fedeli della malattia, simulando in laboratorio i meccanismi neurodegenerativi tipici dell’Alzheimer. Grazie alle iPSC, i ricercatori possono osservare in tempo reale come una specifica variante genetica influenzi la funzione di un neurone, come alteri le connessioni sinaptiche, o come inneschi i processi infiammatori che sembrano avere un ruolo cruciale nella malattia.
«Questa banca di cellule staminali - spiega il professor Caleb Webber, direttore del team di ricerca - è una risorsa che permetterà a molti laboratori di accedere a materiale biologico prezioso, riducendo i costi e moltiplicando le possibilità di analisi comparativa. Ma soprattutto ci permetterà di affrontare una delle sfide più grandi: capire come le differenze genetiche individuali influenzano la comparsa e la progressione dell’Alzheimer».
Per la prima volta, infatti, i ricercatori potranno studiare in modo sistematico e controllato come combinazioni diverse di varianti genetiche possano tradursi in fisiopatologie differenti. È questo il presupposto fondamentale per avvicinarsi a una medicina di precisione, che sappia offrire trattamenti costruiti sulle specificità biologiche di ogni paziente. E se da un lato la scienza di base avrà un nuovo strumento per svelare i misteri della malattia, dall’altro anche l’industria farmaceutica potrebbe trarre vantaggio da una risorsa così strutturata: le cellule della banca potranno essere utilizzate come modello per validare candidati farmaci o predire la risposta terapeutica di sottogruppi di pazienti, aprendo la strada a sperimentazioni cliniche più mirate ed efficaci.
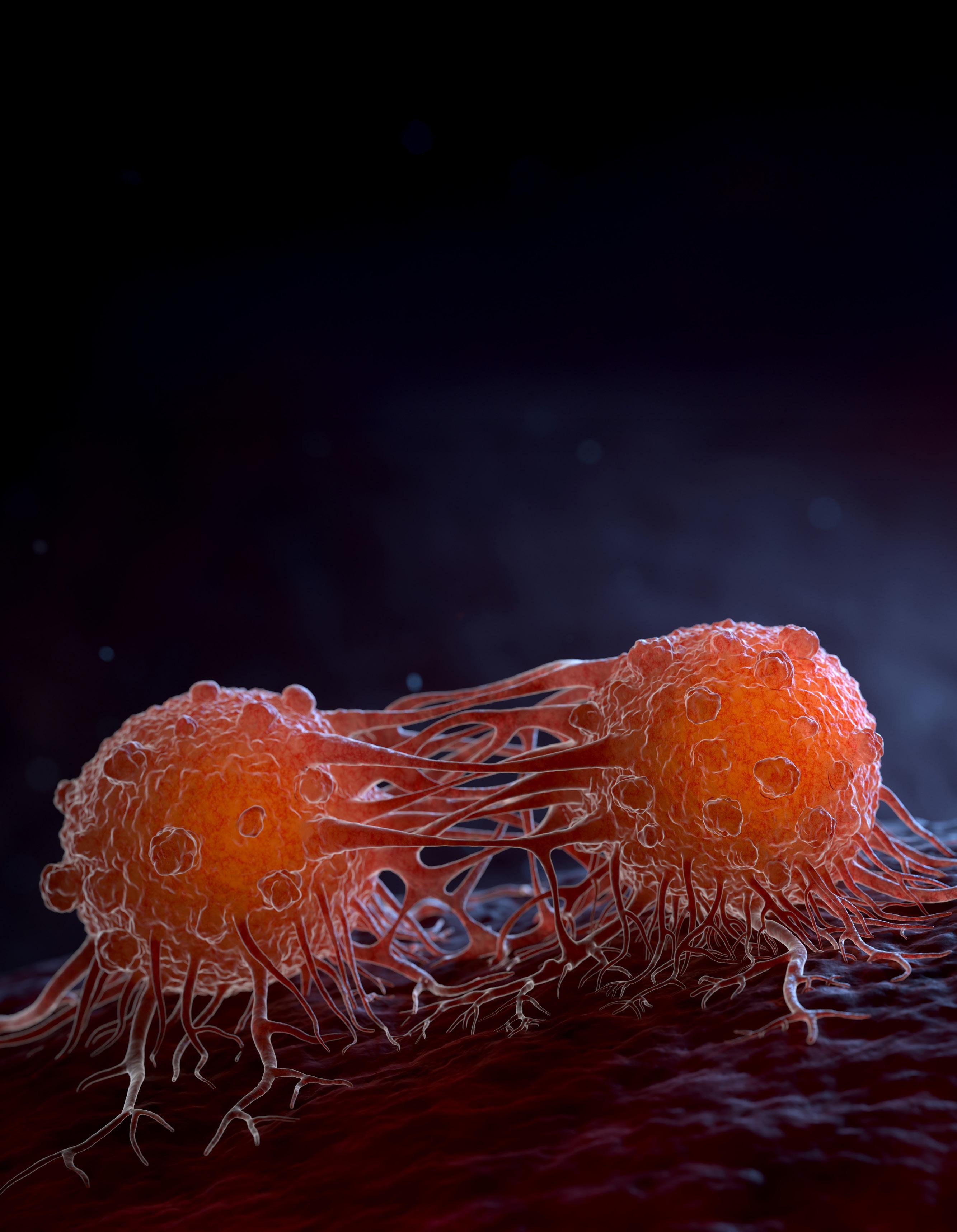
EVOLUZIONE GENETICA DELLE METASTASI NUOVE SCOPERTE E PROSPETTIVE TERAPEUTICHE
Alcuni ricercatori americani hanno scoperto che le cellule tumorali accumulano alterazioni del numero di copie geniche per resistere meglio ai trattamenti
Un nuovo studio pubblicato su Nature Genetics dai ricercatori della Weill Cornell Medicine e del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) fornisce nuove conoscenze sull’evoluzione dei tumori quando danno origine a metastasi, conoscenze che potrebbero aiutare a sviluppare strategie per migliorare l’efficacia dei trattamenti.
Secondo i dati della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, la formazione di metastasi è la causa di oltre il 90 per cento dei decessi per cancro. Le cellule metastatiche presentano una propria eterogeneità genetica, riflettendo sia l’evoluzione del tumore originario che la loro capacità di adattarsi a nuovi ambienti. Come spiegano nel dettaglio gli autori dello studio, quando il cancro si diffonde da un tumore primario a nuovi siti nel corpo, subisce cambiamenti che aumentano la sua complessità genetica. Comprendere queste differenze genomiche chiave tra tumori primari e metastatici è fondamentale per migliorare le cure cliniche.
Il team - guidato da Luc Morris, chirurgo e direttore del laboratorio di ricerca sulla genetica del cancro presso l’MSK, Xi Kathy Zhou, ricercatore presso la Weill Cornell Medicine, e Chaitanya Bandlamudi, ricercatore di genomica del cancro presso l’MSK - ha esaminato i profili genomici di oltre 3.700 pazienti affetti da 24 tipi di cancro e sottoposti a biopsia di più siti tumorali nel tempo.
Attraverso test di sequenziamento tumorale gli scienziati hanno messo a confronto i profili genetici di un tumore iniziale e di un sito metastatico dello stesso paziente. I risultati dello studio hanno mostrato che i tumori evolvono nel tempo e che le metastasi tendono ad accumulare più alterazioni del numero di copie (CNA) che mutazioni. Questo ha portato i ricercatori a chiedersi perché le CNA, ma non le mutazioni, emergano così comunemente quando i tumori metastatizzano.
Le mutazioni sono come piccoli errori nel codice genetico che possono in-
fluenzare il funzionamento di un gene, portando alla produzione di proteine anomale o all’alterazione dell’espressione genica. Le CNA, invece, si verificano quando una determinata regione del DNA, che può contenere uno o più geni, viene duplicata (aumento del numero di copie) o delezionata (perdita di copie) rispetto al numero di copie tipico nella popolazione. Queste variazioni possono essere di dimensioni variabili, da piccole duplicazioni o delezioni di singoli geni a variazioni più ampie che coinvolgono interi segmenti cromosomici.
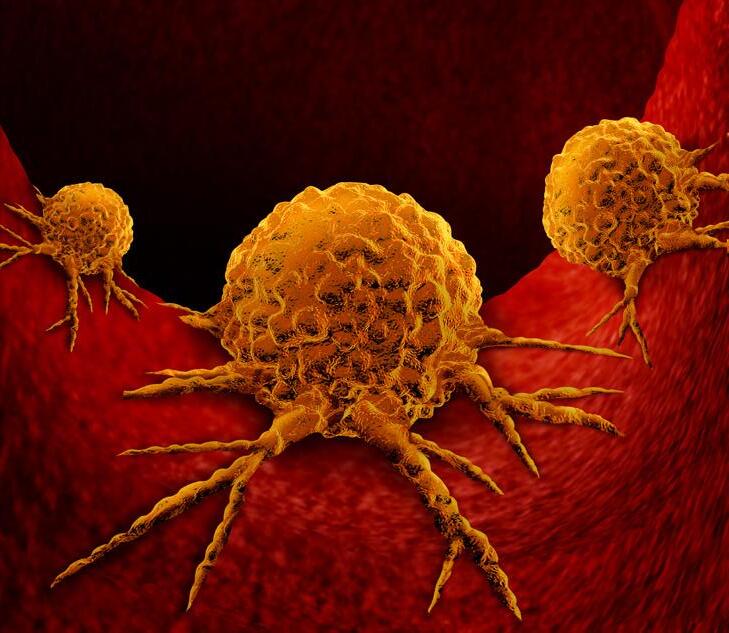
Una forma estrema di CNA - il raddoppio del genoma - si è rivelata importante durante il processo di metastasi. «Abbiamo scoperto che la duplicazione dell’intero genoma, ovvero il raddoppio dell’intero set di cromosomi in una cellula tumorale, è l’evento genetico più comune durante le metastasi, che si verifica in quasi un terzo dei pazienti» - ha dichiarato Karena Zhao, primo autore dello studio, che ha condotto la ricerca presso l’MSK. Il gruppo di scienziati americani ha quindi deciso di approfondire quali vantaggi funzionali derivassero per la cellula dal raddoppio del proprio genoma. Quando il cancro si diffonde da un tumore primario a nuovi siti nel corpo, subisce cambiamenti che aumentano la sua complessità genetica. Comprendere queste differenze genomiche chiave tra tumori primari e metastatici è fondamentale per migliorare le cure cliniche
Quando le cellule tumorali si dividono e commettono errori nella replicazione del DNA, si accumulano mutazioni. Alcune mutazioni aiutano le cellule a crescere più velocemente, mentre altre possono influenzare geni essenziali ed essere dannose per la cellula. «Il raddoppiamento del genoma consente alle cellule tumorali di fare delle scommesse, creando copie aggiuntive di geni, in modo che se una copia subisce delle mutazioni o viene cancellata, l’altra copia sopravvive intatta - ha detto Zhou -. Questo aumenta la capacità della cellula tumorale di adattarsi, sopravvivere e resistere ai trattamenti».
Inoltre, secondo i ricercatori, a differenza dei CNA, un numero maggiore di mutazioni può rendere i tumori più visibili al sistema immunitario. Questo perché le modifiche alle loro sequenze genetiche possono far sì che producano proteine anomale, che vengono quindi trattate dal sistema immunitario come una minaccia estranea. Il team ha scoperto che i CNA rendono i tumori resistenti, mentre le mutazioni li rendono più suscettibili all’immunoterapia.
«In definitiva, il nostro studio ha rilevato che durante la metastasi le cellule tumorali tendono a evolversi massimizzando i CNA, senza generare troppe mutazioni che potrebbero potenzialmente stimolare una risposta immunitaria» - ha dichiarato Bandlamudi.
Secondo gli autori dello studio l’insieme dei risultati suggerisce che nuove strategie, come le terapie che mirano a colpire l’instabilità genetica in queste cellule altamente alterate o a modificare il microambiente tumorale, potrebbero essere fondamentali per creare risposte durature nel cancro metastatico.
«Comprendere queste differenze genomiche chiave tra tumori primari e metastatici è fondamentale per migliorare le cure cliniche, poiché biomarcatori come i CNA e il carico mutazionale del tumore sono sempre più utilizzati dai medici per informare il processo decisionale, in particolare per quanto riguarda l’uso di farmaci immunoterapici» - ha concluso Morris. (S. B.).

Capace di disattivare selettivamente le cellule T autoreattive Senza indebolire il sistema immunitario. Un nuovo orizzonte terapeutico
Una nuova speranza per chi è affetto da malattie autoimmuni come il diabete di tipo 1 o la sclerosi multipla. Arriva dai laboratori di bioingegneria una scoperta che potrebbe rivoluzionare il trattamento di queste patologie: una proteina ingegnerizzata è riuscita a disinnescare in modo mirato le cellule immunitarie che, anziché proteggere l’organismo, lo aggrediscono dall’interno.
Pubblicata sulla rivista Cell, la scoperta è il frutto della collaborazione tra la Scuola di Medicina Grossman della New York University, la Zhejiang University in Cina e l’Istituto di Biofisica dell’Accademia Cinese delle Scienze. Il team internazionale, guidato da Jun Wang, Jack Wei Chen e Jizhong Lou, ha messo a punto una proteina capace di interferire con l’attività dei linfociti T autoreattivi, responsabili dell’attacco autoimmunitario, senza però compromettere l’intero sistema immunitario.
Le malattie autoimmuni rappresentano una delle sfide più complesse per la medicina moderna. In queste condizioni, il sistema immunitario, anziché riconoscere e difendere il corpo da agenti patogeni esterni, identifica come “nemiche” cellule e tessuti sani dell’organismo. Il risultato è un’infiammazione cronica e progressiva che, nel tempo, compromette il funzionamento di organi vitali. Nel diabete di tipo 1, ad esempio, le cellule T attaccano e distruggono le cellule beta del pancreas, responsabili della produzione di insulina. Nella sclerosi multipla, colpiscono la guaina mielinica che protegge i neuroni. Ad oggi, i trattamenti disponibili mirano a calmare l’aggressività del sistema immunitario nel suo complesso, spesso con effetti collaterali gravi: soppressione eccessiva delle difese, aumento del rischio di infezioni e di sviluppare tumori.
gettata nei laboratori sfrutta proprio questo meccanismo naturale, favorendo un’interazione che inibisce selettivamente i linfociti T autoreattivi, senza coinvolgere quelli impegnati nella difesa contro virus e batteri.
«Abbiamo scoperto - spiega Jun Wang -, che posizionando la nostra proteina ingegnerizzata molto vicino alle cellule T, possiamo spegnere in modo mirato quelle implicate nell’autoimmunità. È come premere un interruttore specifico, lasciando accese tutte le altre luci».
I risultati sono stati sorprendenti: gli attacchi delle cellule T si sono ridotti drasticamente. Di conseguenza, i danni ai tessuti, come il pancreas e il sistema nervoso, sono stati significativamente limitati. In particolare, è stata osservata una riduzione dei segni infiammatori e una protezione della funzionalità degli organi colpiti. Il prossimo passo sarà testare la sicurezza e l’efficacia di questa proteina in modelli più complessi e, in futuro, avviare studi clinici su pazienti umani.
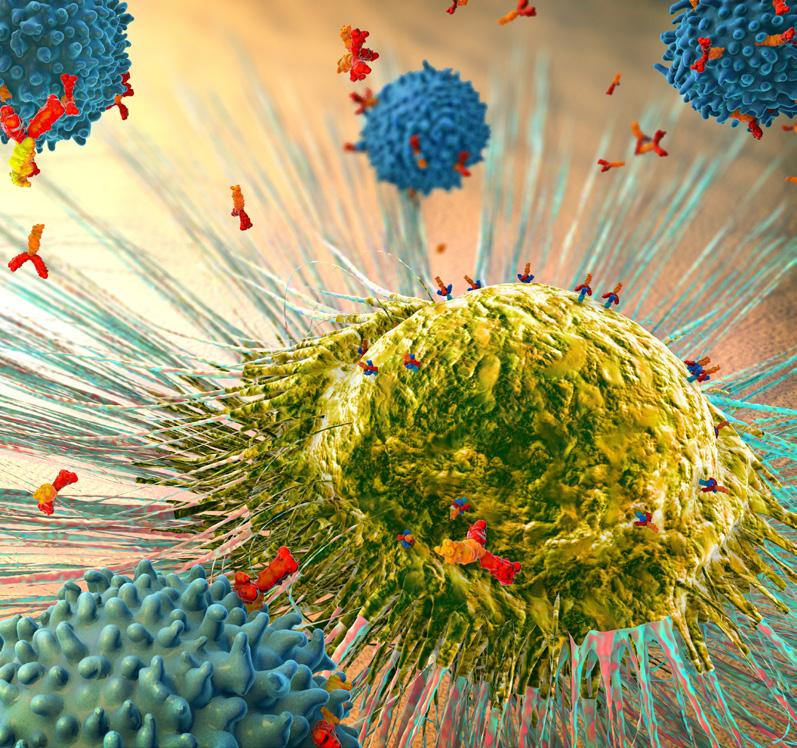
Invece di spegnere l’intero sistema immunitario, i ricercatori hanno cercato un modo per intervenire selettivamente solo sui linfociti T responsabili dell’attacco autoimmune. Per farlo, hanno ingegnerizzato una proteina capace di avvicinarsi in modo molto preciso a queste cellule e di portarle a disattivarsi
Il nuovo studio cambia completamente prospettiva. Invece di spegnere l’intero sistema immunitario, i ricercatori hanno cercato un modo per intervenire selettivamente solo sui linfociti T responsabili dell’attacco autoimmune. Per farlo, hanno ingegnerizzato una proteina capace di avvicinarsi in modo molto preciso a queste cellule e di portarle a disattivarsi. Il meccanismo sfrutta un principio già presente nel nostro organismo: le cellule immunitarie, infatti, possiedono recettori che regolano l’attivazione o l’inibizione della risposta immunitaria. La proteina pro-
Questa scoperta si inserisce nel più ampio panorama dell’immunoterapia di precisione, un settore in piena espansione che mira a intervenire in modo selettivo sui meccanismi immunitari. Se confermata, la strategia messa a punto dai ricercatori potrebbe aprire la strada a trattamenti più sicuri ed efficaci per numerose malattie autoimmuni, per le quali oggi esistono solo terapie parzialmente efficaci o fortemente immunosoppressive.
«I nostri risultati - sottolinea Wang - rivelano un intricato meccanismo che permette un approccio terapeutico mirato alle malattie autoimmuni causate dalle cellule T, per le quali mancano attualmente trattamenti immunoterapici efficaci».
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le malattie autoimmuni colpiscono oltre 50 milioni di persone nel mondo, con un impatto crescente soprattutto tra le donne e nei paesi industrializzati. La possibilità di intervenire in modo mirato sui meccanismi scatenanti, preservando il resto del sistema immunitario, rappresenta una svolta potenzialmente epocale.
Si è ancora lontani dalla cura definitiva, ma il lavoro del team internazionale di ricerca offre uno spiraglio concreto. Questa proteina creata in laboratorio potrebbe un giorno diventare un’alleata preziosa per disarmare in modo selettivo le cellule ribelli, riportando equilibrio là dove oggi domina il caos autoimmune. E con esso, una nuova qualità di vita per milioni di persone. (C. P.).
SCOPERTO IL GENE CDK12

Identificato il responsabile nella progressione del carcinoma
Apre la strada a terapie mirate, test genetici precoci e medicina di precisione
Una nuova scoperta genetica apre spiragli nella battaglia contro uno dei tumori femminili più insidiosi e letali: il carcinoma ovarico sieroso di alto grado. Un gruppo di ricercatori del Rogel Cancer Center dell’Università del Michigan ha identificato un gene, chiamato Cdk12, che svolge un ruolo chiave nell’aggressività di questa forma di cancro. La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences), ha dimostrato che la perdita di funzione di questo gene è associata a una crescita tumorale accelerata e a una riduzione significativa della sopravvivenza. Il carcinoma sieroso di alto grado (Hgsc) rappresenta circa il 70% di tutte le neoplasie ovariche e costituisce la forma più comune e aggressiva di tumore alle ovaie. Si tratta di una malattia che spesso resta silente nelle fasi iniziali, senza sintomi specifici, e viene quindi diagnosticata in stadi avanzati, quando le opzioni terapeutiche sono più limitate.
Ad oggi, la chemioterapia a base di platino rappresenta il trattamento di prima linea. Tuttavia, molte pazienti sviluppano resistenza nel tempo, rendendo inefficaci le terapie successive. «Sebbene ci siano stati progressi nella gestione del carcinoma sieroso di alto grado - ha dichiarato la professoressa Kathleen Cho, che ha coordinato lo studio con il collega Arul Chinnaiyan -, una volta che i pazienti diventano resistenti alla chemioterapia, le opzioni terapeutiche restano molto limitate e spesso empiriche». Il gene Cdk12 (Cyclin-Dependent Kinase 12) è noto per la sua funzione regolatrice nell’espressione di geni coinvolti nella risposta al danno del DNA. In condizioni normali, agisce come una sorta di guardiano del genoma, impedendo che mutazioni pericolose si accumulino nelle cellule.
Nel nuovo studio, i ricercatori hanno utilizzato modelli geneticamente modificati, in cui Cdk12 era stato inattivato. I risultati sono stati sorprendenti: l’assenza del gene ha determinato una crescita molto più rapida del tumore e una sopravvivenza inferiore. Questo ha confermato il ruolo di Cdk12 come soppressore tumorale, la cui perdita rappresenta un evento critico nella progressione della malattia. Accanto a Cdk12, lo studio ha evidenziato il ruolo di Cdk13, un gene simile e spesso coespresso, che sembra collaborare con Cdk12 nella regolazione della trascrizione genica. L’analisi combinata dei due geni suggerisce che potrebbero rappresentare bersagli terapeutici ideali per futuri farmaci mirati.
«Stiamo già testando diversi composti che colpiscono selettivamente Cdk12 e Cdk13 - ha spiegato Chinnaiyan -. L’idea è di sfruttare queste vulnerabilità genetiche per migliorare l’efficacia della chemioterapia o per sviluppare terapie alternative nei casi in cui i trattamenti standard falliscono». La possibilità di utilizzare Cdk12 come biomarcatore per identificare precocemente le pazienti

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno utilizzato modelli geneticamente modificati, in cui il gene Cdk12 era stato inattivato. I risultati sono stati sorprendenti: l’assenza del gene ha determinato una crescita molto più rapida del tumore e una sopravvivenza inferiore. Questo ha confermato il ruolo di Cdk12 come soppressore tumorale, la cui perdita rappresenta un evento critico nella progressione della malattia. Accanto a Cdk12, lo studio ha evidenziato il ruolo di Cdk13, un gene simile e spesso coespresso, che sembra collaborare con Cdk12 nella regolazione della trascrizione genica. L’analisi combinata dei due geni suggerisce che potrebbero rappresentare bersagli terapeutici ideali per futuri farmaci mirati
a rischio di sviluppare forme particolarmente aggressive apre scenari importanti anche per la medicina di precisione. Un test genetico su biopsia tumorale o su campione di sangue potrebbe permettere di personalizzare la terapia fin dall’inizio, evitando trattamenti inefficaci e ottimizzando le risorse disponibili. Inoltre, sebbene Cdk12 sia già noto per il suo coinvolgimento nel cancro alla prostata, questa è la prima volta che il suo ruolo viene messo in luce in modo così chiaro nel tumore ovarico.
La scoperta rafforza l’idea che alcuni meccanismi oncogenici siano condivisi tra diversi tipi di tumore, e che studiare tali convergenze possa ampliare l’impatto clinico delle scoperte. Come sempre accade nella ricerca oncologica, i risultati promettenti ottenuti su modelli animali dovranno essere confermati nell’uomo attraverso studi clinici controllati. Ma la direzione è chiara: la genetica sta diventando sempre più uno strumento cruciale nella comprensione del cancro e nello sviluppo di terapie innovative.
I ricercatori del Michigan sono ora al lavoro per avviare trial clinici su pazienti umani, con l’obiettivo di validare l’efficacia di farmaci diretti contro Cdk12 e Cdk13. Se i dati preliminari verranno confermati, potrà aprirsi una svolta significativa nella cura del tumore ovarico, una malattia che ogni anno colpisce decine di migliaia di donne nel mondo e che ancora oggi ha tassi di sopravvivenza molto bassi.
In un contesto dove l’urgenza di trovare cure più efficaci è tangibile, questa scoperta rappresenta un passo avanti concreto. La speranza, ora più che mai, è che la genetica possa guidare la strada verso terapie più mirate, più efficaci e, soprattutto, più giuste per ogni paziente. (C. P.).

Dall’Istituto Riken una risorsa senza precedenti Linee cellulari condivise per studiare le basi genetiche e sviluppare terapie mirate

© New Africa/shutterstock.com
Un’importante svolta nella comprensione dell’autismo arriva dal Giappone.
Dopo oltre dodici anni di lavoro, un gruppo di neuroscienziati dell’Istituto Riken ha annunciato la creazione di una banca genetica composta da 63 linee di cellule staminali embrionali, ciascuna portatrice di una diversa mutazione fortemente associata ai disturbi dello spettro autistico. I risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista Cell Genomics, aprono nuove prospettive per lo studio delle basi genetiche dell’autismo e per lo sviluppo di terapie più mirate ed efficaci.
Il progetto, coordinato da Toru Takumi, rappresenta uno dei più ambiziosi tentativi di costruire un modello sperimentale condiviso e standardizzato. A oggi, la ricerca sull’autismo ha spesso sofferto della mancanza di strumenti comuni: ogni laboratorio utilizzava tecniche e modelli propri, rendendo difficile confrontare i risultati ottenuti. Questa nuova banca genetica colma finalmente una lacuna, offrendo una piattaforma omogenea e accessibile per l’intera comunità scientifica. Le cellule staminali embrionali sono state ottenute utilizzando una combinazione di tecniche di manipolazione genetica tradizionali e CRISPR, la tecnologia di editing genetico che permette di “tagliare e incollare” il DNA con grande precisione.
Con questo approccio, i ricercatori sono riusciti a introdurre, in modo mirato, 63 mutazioni legate all’autismo, tutte derivate dallo stesso ceppo genetico. In questo modo, è stato possibile eliminare variabili sperimentali e ottenere un sistema altamente comparabile tra le diverse mutazioni. Da ciascuna linea cellulare sono state poi derivate diverse tipologie di cellule e tessuti. Questo consente di osservare non solo gli effetti genetici a livello cellulare, ma anche l’impatto sullo sviluppo cerebrale, sul comportamento e sul funzionamento dei circuiti neurali. «È un archivio vivente della complessità genetica dell’autismo - ha dichiarato Takumi -. La disponibilità pubblica di
queste linee cellulari permetterà a ricercatori di tutto il mondo di lavorare su basi comuni, accelerando enormemente la nostra capacità di comprendere i meccanismi biologici alla base dei disturbi dello spettro autistico».
Uno degli aspetti più interessanti emersi dallo studio riguarda il modo in cui le mutazioni genetiche influenzano la capacità delle cellule nervose di gestire le proteine mal ripiegate. In condizioni normali, le cellule possiedono sofisticati sistemi di controllo che riconoscono le proteine difettose e le eliminano. Tuttavia, nei modelli mutati, questo processo sembra essere compromesso: le proteine anomale si accumulano, danneggiando i neuroni e interferendo con la loro funzione.

Molte delle mutazioni presenti nella banca genetica non sono associate solo all’autismo, ma anche ad altre condizioni psichiatriche complesse, come la schizofrenia e il disturbo bipolare. Questo rafforza l’ipotesi che esistano meccanismi biologici condivisi alla base di diversi disturbi mentali e che l’approccio genetico possa rappresentare una chiave interpretativa comune
«Questa scoperta suggerisce che alcuni disturbi dello spettro autistico potrebbero essere causati da un malfunzionamento del sistema di smaltimento delle proteine difettose - spiega Takumi -. È un meccanismo già noto in alcune malattie neurodegenerative,
come l’Alzheimer o il Parkinson, ma è la prima volta che viene collegato in modo sistematico all’autismo». Questo risultato apre nuove possibilità anche sul fronte farmacologico. Se si riuscisse a ripristinare il corretto funzionamento di questi meccanismi di controllo, potrebbe essere possibile intervenire a monte, prevenendo o attenuando i danni neuronali causati dalle mutazioni genetiche. Un ulteriore elemento di interesse riguarda il fatto che molte delle mutazioni presenti nella banca genetica non sono associate solo all’autismo, ma anche ad altre condizioni psichiatriche complesse, come la schizofrenia e il disturbo bipolare. Questo rafforza l’ipotesi che esistano meccanismi biologici condivisi alla base di diversi disturbi mentali e che l’approccio genetico possa rappresentare una chiave interpretativa comune.
La banca genetica del Riken non è dunque soltanto uno strumento per studiare l’autismo, ma un vero e proprio punto di partenza per comprendere in modo più profondo la fisiopatologia del cervello e delle sue alterazioni. La sua natura aperta e condivisa riflette un modello virtuoso di scienza collaborativa, in controtendenza rispetto a logiche competitive che ancora dominano alcuni settori della ricerca biomedica. In un’epoca in cui la medicina di precisione si fa sempre più strada, risorse come questa rappresentano una base concreta per sviluppare approcci terapeutici mirati.
Comprendere quali siano gli effetti specifici di ciascuna mutazione genetica potrà infatti aiutare a identificare biomarcatori precoci, bersagli farmacologici e, auspicabilmente, cure su misura per i singoli pazienti. L’autismo, con la sua eterogeneità e complessità, richiede uno sforzo collettivo e multidisciplinare per essere compreso e affrontato. In questo senso, la banca genetica del Riken è un contributo di straordinaria importanza, che avvicina la scienza alla possibilità di fornire risposte concrete a milioni di famiglie in tutto il mondo. (C. P.).

VACANZE , COSA NON MANCA MAI IN VALIGIA
Nove italiani su dieci proprio non rinunciano ai farmaci
Sempre utili in caso di emergenza: ecco i più gettonati
Che si parta per un weekend o un periodo più lungo, che si vada al mare, in montagna, a visitare una città d’arte oppure all’avventura on the road, c’è una cosa che gli italiani non dimenticano mai di mettere in valigia: i farmaci. Soprattutto se in famiglia si annoverano persone anziane o bambini.
Un vecchio adagio che non passa mai di moda afferma che prevenire è meglio che curare. E, allora, perché non partire già attrezzati, anziché andare in giro alla ricerca di una farmacia in zone ancora ignote o maga -
ri lontane da centri abitati? Pensate: in base all’indagine effettuata da Assosalute, l’Associazione nazionale farmaci di automedicazione, con la collaborazione di Human Highway addirittura nove italiani su dieci, dunque il 90%, portano al loro seguito almeno un medicinale da banco.
A non dimenticarsi dei farmaci da viaggio sono principalmente le donne e gli over 55. Entrando nel dettaglio, il 26% delle donne preferisce abbondare inserendo in valigia - tra scarpe, vestiti e beauty case d’ordinanza - più di quattro medicinali da banco. Gli over 55, invece, riescono a ritagliare
nel proprio zainetto spazio per almeno tre farmaci di automedicazione. E, ora, capiamo quali sono i farmaci irrinunciabili, quelli senza cui proprio non ci si può mettere in viaggio. Premesso che il report sottolinea come nel trolley di ogni italiano ci siano 2,8 farmaci da banco, al primo posto in assoluto troviamo antidolorifici o antinfiammatori, utili per mal di testa, dolori muscolari e ciclo mestruale.
I dati non lasciano spazi a dubbi: quasi due su tre, per un totale del 65%, li scelgono. La percentuale schizza fino al 75% se si considerano solo le donne. Subito dopo, ecco i farmaci per i disturbi gastrointestinali. Si sa, quando si cambiano le abitudini alimentari, i rischi sono dietro l’angolo. E, infatti, il 48% degli italiani li inserisce nel proprio kit, con un vero e proprio boom nella fascia d’età compresa tra i 55 e i 64 anni. Dagli antiacidi ai lassativi, passando per antidiarroici e fermenti lattici: la scelta è ampia in base alle più svariate esigenze.
Altro incubo delle vacanze, specie per chi può permettersi di staccare la spina solo per una manciata di giorni, è la febbre. Come contrastare il verdetto impietoso del termometro o i sintomi influenzali? Per il 43% con gli antipiretici. E la percentuale aumenta fino al 50% per donne e over 55. Non è certo finita qui. Il 32% di viaggiatori non rinuncia ad antistaminici e antipruriginosi per combattere le punture degli insetti, poi disinfettanti e farmaci contro le scottature, i medicinali contro il mal di gola e quelli per la cinetosi, preziosi per chi soffre di mal d’auto o mal di mare.
Assosalute chiosa ricordando che i medicinali vanno conservati in modo adeguato, altrimenti si rischia di pregiudicarne l’efficacia. Non bisogna rimuoverli dalle confezioni originali che contengono il foglietto illustrativo, quindi occhio alle temperature. E mai esporli al sole o comunque in luoghi dove la colonnina di mercurio supera i 25°C. (D. E.).
Sono 330mila le persone che in Italia soffrono di vitiligine, eppure solo il 42% si reca dal medico per approfondire la questione. È il risultato dell’indagine condotta da Elma Research su 141 soggetti colpiti da questa patologia cronica autoimmune della pelle, che ancora oggi è sottovalutata nonostante influenzi in negativo la qualità della vita.
La recente Giornata mondiale della vitiligine, ricorrenza introdotta nel 2011, ha rappresentato l’occasione per far luce su una malattia per la quale non esiste una vera e propria cura definitiva, se non palliativi. Dall’indagine è emerso che per il 78% questa condizione, che si palesa attraverso macchie bianche sulla pelle e, talvolta, capelli bianchi o occhi più chiari, ha un impatto significativo non solo sulla salute psicologica, ma anche sulla sfera sociale, relazionale e lavorativa.
A farla da padrona è soprattutto la rassegnazione, visto che, nonostante i progressi in ambito scientifico, non sono state ancora individuate terapie in grado di debellare la vitiligine. Ed è proprio questo il motivo per cui il 42% delle persone che hanno partecipato all’indagine di Elma Research non si fa seguire da un medico. Un errore che è frutto della disinformazione e che preclude la possibilità di ricorrere a nuovi trattamenti, che invece esistono. Un dato dice tutto: il 61% degli intervistati non sa che potrebbe giovare di opzioni capaci di intervenire sulle aree interessate dal disturbo.
Le stime riferiscono che la vitiligine colpisce l’1-2% circa della popolazione mondiale, mentre i casi accertati in Italia sono circa 330.000. Si tratta, però, di numeri al ribasso, perché non tutti si rivolgono al proprio medico o a uno specialista. Un po’ per vergogna, un po’ per superficialità, c’è chi tende a nascondere le macchie comparse sulla pelle che, è bene ricordarlo, non sono contagiose e neppure pericolose per la salute.

VITILIGINE
PERCHÉ NASCONDERSI?
In base a una recente indagine in Italia sono 330mila le persone che ne soffrono, ma solo il 42% si reca dal medico
Ma che cosa scatena la perdita di pigmentazione? Sulle cause sono in corso studi, ma al momento non esistono risposte certe e ciò complica anche l’individuazione di una terapia. L’Istituto Superiore di Sanità la definisce una malattia della pelle di origine sconosciuta, probabilmente autoimmune. Ciò che si sa, invece, è che è originata dalla distruzione o dal malfunzionamento dei melanociti, ossia le cellule della pelle che producono le melanine, i pigmenti che determinano il colore naturale della pelle.
La vitiligine può presentarsi in ogni momento della vita, ma general -
mente fa il suo indesiderato esordio dopo i 20 anni d’età. Tra le prime celebrità a uscire allo scoperto va menzionato il re del pop Michael Jackson: non a caso, la Giornata mondiale della vitiligine si celebra il 25 giugno, data della scomparsa della star americana avvenuta nel 2009. E, ancora, la modella canadese di origini giamaicane Winnie Harlow e l’attrice Kasia Smutniak: le loro testimonianze sono servite ad accendere la luce su una patologia che non va più sottovaluta o nascosta, perché rischia di compromettere in maniera seria la qualità della vita. (D. E.).
POLIDESOSSIRIBONUCLEOTIDI NELLE FORMULAZIONI COSMETICHE
Rigenerazione cutanea, idratazione profonda e rilascio controllato Il futuro della cosmetica passa dai PDRN con l’ausilio dei nanoliposomi

Carla Cimmino*
L’interesse verso l’impiego dei polidesossiribonucleotidi (PDRN) in ambito cosmetico è sempre più in crescita, tutto ciò perché questi hanno abbondantemente dimostrato di favorire la rigenerazione cutanea, l’attività antinfiammatoria e l’idratazione profonda. Non mancano però di alcuni limiti significativi tra cui: instabilità intrinseca e scarsa penetrazione cutanea, che è possibile ovviare se si utilizza la strategia dell’incapsulamento in nanoliposomi, ottimizzando così la veicolazione dermica e la biodisponibilità locale di queste sostanze.
I Polidesossiribonucleotidi non sono altro che frammenti di DNA generalmente di origine ittica (es. Oncorhynchus mykiss), che hanno un peso molecolare tra 50 e 1500 kDa, la loro azione principale è quella di attivare il recettore A2A dell’adenosina, stimolare quindi la proliferazione dei fibroblasti, la sintesi di collagene ed elastina, ma anche azione di scavenger per i ROS (specie reattive dell’ossigeno), riducendo lo stress ossidativo cutaneo.
I nanoliposomi contenenti PDRN sono preparati in genere utilizzando la tecnica della doppia emulsione (W/O/W) o dell’idratazione del film lipidico, successivamente si procede alla sonificazione o estrusione per rendere le vescicole di dimensioni inferiori.
La tipica composizione di un liposoma prevede: una fase lipidica (fosfatidilcolina di soia o di origine naturale) e colesterolo che serve a dare stabilità alle membrane; una fase acquosa interna: soluzione acquosa contenente PDRN con una concentrazione che può variare (es. 0,1–1% p/v); stabilizzanti: polisorbati (Tween 80), PEG-lipidi o poliglicerolo (derivati).
* Comitato Centrale FNOB
Per garantire un’efficace penetrazione nello strato corneo le dimensioni dei nanoliposomi devono mantenersi tra i 100 e i 200 nm, i parametri per caratterizzarli molto importanti e da tenere sotto controllo sono carica superficiale ( ζ -potenziale) e l’efficienza di incapsulamento (>70%). I sistemi nanoliposomiali per un periodo di almeno 6 mesi devono garantire stabilità colloidale sufficiente, soprattutto se le condizioni ambientali sono ottimali.

L’incapsulamento dei polidesossiribonucleotidi in nanoliposomi è una strategia avanzata e tecnologicamente promettente per il settore cosmetico, la combinazione tra biocompatibilità lipidica e attività biologica dei PDRN ci introduce a formulazioni topiche con alta performance, soprattutto nei trattamenti anti-aging, lenitivi e di ripristino della barriera cutanea, si attendono però più studi clinici a lungo termine
In uno studio di Yifan He, Li Xu, Xiaojing Pei, Yinmao Dong, Xiangliang Yang, è stata utilizzata una formulazione nanoliposomiale caricata con PDRN (PDRN-NL), le cui particelle avevano dimensioni medie di 125 ± 1 nm, un indice di polidispersità (PDI) di 0,12 ± 0,02,
un potenziale zeta di -52,6 ± 0,8 mV e un’efficienza di incapsulamento dell’81,3%.
La stabilità è stata valutata con l’analizzatore di stabilità Turbiscan Lab, che ha previsto una conservazione fino a tre anni; invece, la permeabilità in vitro del PDRN-NL è stata valutata utilizzando il metodo della cella di diffusione di Franz.
Dai risultati è emersa una permeazione cutanea cumulativa di PDRNNL nell’arco di 24 ore di 1,22 volte superiore a quella del PDRN libero, con una ritenzione cutanea di PDRN-NL 1,40 volte maggiore. Invece dagli studi di rilascio in vitro è stato dimostrato che l’incapsulamento liposomiale ha migliorato la permeabilità, fornito un effetto di rilascio prolungato e una migliore stabilità del PDRN. In conclusione: le proprietà del PDRN incapsulato nei liposomi sono state migliorate, rappresentando una alternativa innovativa per l’incorporazione del PDRN nello sviluppo di prodotti per la cura della pelle.
I nanoliposomi di PDRN possono essere aggiunti in diversi cosmetici: sieri, emulsioni O/A, patch transdermici e maschere idrogel, garantire compatibilità con il pH cutaneo (5,0–6,0), zero tensioattivi aggressivi e conservanti destabilizzanti. Se si rispettano queste regole si avrà: 1) Rilascio controllato del principio attivo nei diversi strati epidermici; 2) Protezione del PDRN dalla degradazione da parte di enzimi.
L’incapsulamento dei polidesossiribonucleotidi in nanoliposomi è una strategia avanzata e tecnologicamente promettente per il settore cosmetico, la combinazione tra biocompatibilità lipidica e attività biologica dei PDRN ci introduce a formulazioni topiche con alta performance, soprattutto nei trattamenti anti-aging, lenitivi e di ripristino della barriera cutanea, si attendono però più studi clinici a lungo termine.
La Blue economy è top e a cinque vele: il 10,2% del PIL Trenta località premiate da Legambiente e Touring Club puntano su turismo dolce, sostenibilità e capitale naturale
L’ITALIA NUOTA E VIVE SULL’ORO
ECONOMIA
MARINA IN FORTE


Il mare non è solo un panorama mozzafiato, ma un vero motore economico. La sua crescente importanza è celebrata con sempre maggiore risonanza, testimoniando un valore che va ben oltre la bellezza. Parliamo di un patrimonio che, secondo i dati recenti di Legambiente, genera un fatturato annuo di 47 miliardi di euro, dà lavoro a un milione di persone, rappresentando il 10,2% del Prodotto interno lordo.
Questi numeri imponenti della Blue economy, non raccontano solo un successo monetario, ma una vera e propria rivoluzione culturale che mette al centro il Mar Mediterraneo, polo di biodiversità con oltre 17.000 specie, e i settemila chilometri costieri della Penisola.
Il segreto di questo successo è racchiuso nelle trenta località, venti marine e dieci lacustri, premiate con le “Cinque vele” nella guida “Il mare più bello 2025”, redatta in collaborazione con il Touring club italiano. Non semplici mete turistiche, ma laboratori di futuro dove si sperimenta un mix vincente fra tutela della biodiversità, turismo dolce

blu d’Italia è un capitale immenso, un’eredità preziosa che genera benessere, tuttavia per continuare a brillare, ha bisogno di essere custodito con la cura e la visione che merita, trasformando la sfida della sostenibilità nella più grande opportunità per il futuro del Paese.
e valorizzazione autentica del territorio.
A guidare la classifica delle eccellenze marine è un Sud che s’impone con forza, occupando i primi cinque posti a livello nazionale. La regina indiscussa del 2025 è Domus De Maria (SU), in provincia di Sud Sardegna, forte della neonata area marina protetta di Capo Spartivento. Un primato che va di pari passo con la dedizione verso l’Ambiente, essendo una delle nuove entrate tra i “Comuni Amici delle Tartarughe”, puntando su pulizia manuale delle spiagge, limitazioni dell’inquinamento luminoso, formazione dei gestori balneari, collaborazione con referenti scientifici per il controllo e la protezione dei nidi.
Al secondo posto si conferma la perla cilentana di Pollica (SA), seguita da Nardò (LE), un’altra nuova adesione al protocollo per la salvaguardia delle testuggini. Chiudono la cinquina d’eccellenza la sarda Baunei (NU) e la campana San Giovanni a Piro (SA). A livello regionale, la Sardegna si conferma protagonista con sei municipalità premiate, seguita da Puglia (cinque) e Cam -

pania (tre). Anche le acque dolci hanno il loro campione: il lago di Molveno, in Trentino-Alto Adige, al vertice nella classifica per il decimo anno consecutivo. Seguono quello di Monticolo ad Appiano sulla Strada del Vino (Bz) e Avigliana Grande (To).
L’attenzione alla conservazione trova la sua massima espressione nell’iniziativa “Comuni Amici delle Tartarughe”, che quest’anno vede un’adesione straordinaria: le amministrazioni che hanno firmato il protocollo sono più che triplicate, passando dalle 33 del 2024 alle attuali 103 fra cui Roma con il litorale di Ostia, Genova, La Maddalena, Tropea e Ugento. La Campania, con 25, guida questa virtuosa alleanza, seguita da Puglia (15), Calabria (13), Lazio (12), Toscana e Sardegna (10).
«La Blue economy - commenta Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente - rappresenta un pezzo di economia fondamentale per conseguire gli obiettivi climatici al 2030 e quelli del Green Deal europeo, ma è importante un approccio sempre più sostenibile, conciliando la promozione del settore marittimo, nuova occupazione, la conservazione di habitat e biodiversità e definire una governance condivisa con regole chiare. Ce lo ricorda anche la conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani a Nizza dove si è discusso di un possibile Patto europeo per gli Oceani e della qualità di mari e oceani minacciati in primis da sfruttamento, inquinamento e crisi climatica. Servono azioni internazionali e nazionali, ma anche interventi a livello territoriale».
Tuttavia, non mancano le ombre all’orizzonte. Si devono affrontare sfide epocali come la crisi climatica, la pesca intensiva che ha messo in ginocchio il settore e la pressione del turismo di massa che rischia di “soffocare” le stesse bellezze che lo alimentano. Per Legambiente, la rotta da seguire è chiara: l’Italia deve promuovere una “crescita blu” responsabile, ratificando il trattato per la tutela dell’Alto mare, sostenendo la pesca artigianale a basso impatto e incoraggiando modelli di fruizione turistica che non lascino cicatrici sul territorio.
Esempi virtuosi, fortunatamente, non mancano e tracciano la via. Dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, che gestisce
Ambiente
con rigore i flussi sui sentieri e in mare, alla fruizione controllata delle isole più fragili nell’Arcipelago Toscano; dalla piattaforma digitale “Oikos”, che permette a un numero crescente di comuni sardi di gestire le spiagge a numero chiuso, fino al network “Garda Green”, che unisce le strutture ricettive sotto un unico marchio, riconosciuto a livello internazionale.
Queste buone pratiche sono il cuore del progetto europeo “Life Sea.Net”, coordinato da Legambiente per migliorare la gestione degli ecosistemi marini attraverso un approccio condiviso. Un’urgenza, se si pensa che nella Rete Natura 2000, la quale in Italia conta 281 siti d’interesse comunitario, solo 119 possiedono oggi un piano di gestione. L’oro blu d’Italia è un capitale immenso, un’eredità preziosa che genera benessere, tuttavia per continuare a brillare, ha bisogno di essere custodito con la cura e la visione che merita, trasformando la sfida della sostenibilità nella più grande opportunità per il futuro del Paese. (G. P.).

L’attenzione alla conservazione trova la sua massima espressione nell’iniziativa “Comuni Amici delle Tartarughe”, che quest’anno vede un’adesione straordinaria: le amministrazioni che hanno firmato il protocollo sono più che triplicate, passando dalle 33 del 2024 alle attuali 103

LA MINACCIA SILENZIOSA DEL PESCE SCORPIONE E DEGLI ALTRI SUOI COMPAGNI
Cittadini e operatori del mare uniti contro gli alieni nel Mediterraneo Segnalare avvistamenti è vitale per aggiornare le mappe e supportare la ricerca scientifica
Nelle profondità blu delle nostre acque, una sorveglianza costante è più che mai necessaria. Non si tratta di un’operazione segreta, ma di un appello aperto a tutti coloro che le vivono e amano: pescatori, subacquei, semplici appassionati. L’obiettivo? Identificare e segnalare la presenza di specie aliene invasive, organismi che, a causa di fattori come il cambiamento climatico e l’ampliamento del Canale di Suez, stanno alterando l’equilibrio ecologico dei nostri ecosistemi. L’ultima indagine ha registrato ben 1.840 segnalazioni del temibile pesce scorpione (Pterois miles) aggiornate a marzo 2025: un dato che traccia una colonizzazione in piena espansione, con il Mar Jonio che si conferma epicentro di questa inusuale presenza.
Di fronte a tale emergenza ecologica crescente, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche di Ancona (Cnr-Irbim), in collaborazione con il progetto “AlienFish”, rinnovano l’invito alla cittadinanza attraverso la campagna “Attenti a quei 4!”. L’iniziativa, giunta alla sua nuova fase dopo il successo delle edizioni precedenti avviate nel 2022, si rivolge a pescatori, subacquei, diportisti e chiunque frequenti le distese azzurre, esortandoli a diventare sentinelle attive di un fronte che ci riguarda tutti. L’obiettivo è duplice: informare sui pericoli associati a queste nuove presenze e, simultaneamente, raccogliere informazioni essenziali per monitorarne la diffusione. La cooperazione dei cittadini risulta decisiva: ogni avvistamento o cattura di una delle quattro specie bersaglio, il velenoso e già citato pesce scorpione, il tossico pesce palla maculato, il pesce coniglio scuro e quello striato, può trasformarsi in un’indicazione scientifica di vitale importanza. Per contribuire, basta immortalare l’osservazione con una foto o un video e trasmetterla tramite un pratico link, o via “WhatsApp” al numero +39320 4365210. In alternativa, i Social network diventano canali di monitoraggio partecipato attraverso i gruppi Facebook “Oddfish” e “Fauna Marina Mediterranea”, con l’hashtag #Attenti4. Tutto confluisce nel portale “Ormef”, andando a formare il più esaustivo archivio sulla distribuzione delle specie alloctone. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista scientifica “Mediterranean Marine Science” proprio da Cnr-Irbim e Ispra, ha convalidato l’attendibilità dei modelli previsionali, confermando come le proiezioni climatiche indichino un incremento nel rischio d’invasione non solo per lo Jo-
nio, ma anche per le porzioni più meridionali dell’Adriatico. Manuela Falautano, ricercatrice Ispra e coordinatrice della campagna, evidenzia l’importanza del ruolo ricoperto dagli operatori del settore marittimo, il cui apporto si è dimostrato cruciale per la sorveglianza: «L’aumento delle catture e segnalazioni da parte di pescatori e subacquei, da un lato conferma l’importante ruolo da loro svolto a supporto dei ricercatori nell’attività di sorveglianza della diffusione delle specie aliene, dall’altro evidenzia la necessità di ampliare il coinvolgimento degli operatori del mare e di promuovere una chiara attività di comunicazione alla cittadinanza sulle specie potenzialmente pericolose per la salute umana, senza creare allarmismi».

L’obiettivo della campagna “Attenti a quei 4!” è duplice: informare sui pericoli associati a queste nuove presenze e, simultaneamente, raccogliere informazioni essenziali per monitorarne la diffusione. La cooperazione dei cittadini risulta decisiva
Ernesto Azzurro, ricercatore del Cnr-Irbim che ha diretto la ricerca sul pesce scorpione, ribadisce: «La maggior parte dei nuovi avvistamenti è concentrata nel Mar Ionio, una delle aree che, secondo le proiezioni climatiche, presenta il più alto rischio di aumento della vulnerabilità all’invasione da parte di questa specie tropicale, insieme alle regioni più meridionali del Mare Adriatico. I risultati dello studio offrono indicazioni significative sul continuo processo di espansione di Pterois miles, confermando l’affidabilità dei modelli e sottolineando l’urgenza di implementare strategie efficaci di monitoraggio e gestione».
Scopriamo meglio, allora questi indesiderati. Il pesce scorpione, individuato in Italia per la prima volta nel 2016, è uno degli invasori più aggressivi, conosciuto per aver colonizzato gran parte delle coste Atlantiche occidentali; le sue carni sono edibili, ma le spine sono tossiche e possono causare punture estremamente dolorose fino a 48 ore dopo il decesso dell’esemplare. Il pesce palla maculato (Lagocephalus sceleratus), segnalato nel 2013, si distingue per le macchie scure sul dorso grigio argenteo; il consumo è letale a causa di una potente neurotossina insensibile anche alla cottura, e la sua robusta dentatura può provocare morsi dolorosi. Infine, il pesce coniglio scuro (Siganus luridus) e il coniglio striato (Siganus rivulatus), avvistati rispettivamente nel 2003 e 2015, sono erbivori voraci che stanno alterando gli ambienti costieri; entrambi sono commestibili, ma esigono prudenza per le spine.
La campagna, dunque, non è solamente un’indagine, ma un gesto di responsabilità condivisa. Salvaguardare il Mediterraneo significa conoscerlo, tutelarlo e agire collettivamente, trasformando ogni cittadino in un custode consapevole della sua fragile e inestimabile magnificenza. (G. P.).

LE SPECIE ALIENE NEI MARI ITALIANI ISTRUZIONI PER L’USO
Il loro numero è in continua crescita nel Mediterraneo modificandone la biodiversità con impatti sulla salute l’economia e il benessere dell’uomo
Le specie aliene rappresentano oggi una delle più insidiose minacce alla biodiversità in quasi tutti gli ambienti del pianeta con rilevanti conseguenze sull’economia, sulla salute dei paesi interessati. Secondo la Strategia Europea per la Biodiversità già nel 2011 il 22% delle specie indigene europee erano minacciate da specie aliene.
L’importanza del fenomeno pone la lotta alle specie aliene tra gli obbiettivi primari della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD-UN 1992) che nella decima Conferenza delle Parti (Nagoya,2010) ha adottato il nuovo Piano Strategico per la Biodiversità 2011-2020 definendo i 20 “obiettivi di Aichi”, tra cui l’Obiettivo 9 sulle specie aliene: “Entro il 2020, le specie aliene invasive e le relative vie di diffusione siano identificate e classificate come prioritarie, le specie prioritarie siano controllate o eradicate e siano adottate misure per gestire le vie di diffusione e prevenirne l’introduzione e l’insediamento”.
Le raccomandazioni per contrastare l’introduzione e la diffusione di specie aliene provengono anche dalla Convenzione di Barcellona (UNEP/MAP 1978) attraverso il protocollo ASPIM (UNEP/MAP 1995) e più recentemente dalla Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (2008/56/EC) che ha indicato le specie aliene come descrittore 2 del buon stato ambientale. Tra i numerosi impegni internazionali per contrastare la diffusione delle specie aliene, vanno ricordati quelli del GIPS (Global Invasive Species Program) e di ISSG-IUCN (Invasive Species Specialist Group della World Conservation Union).
Il mare era stato, in passato, l’ambiente meno colpito dalle specie aliene ma più recentemente, la globalizzazione e l’aumento del traffico marittimo, hanno portato a una diffusione delle specie alie-
*Consiglio scientifico della Fondazione Italiana Biologi, Coordinamento Nazionale Bioeconomia ed esperto dell’Invasive Species Specialist Group dell’IUCN
ne in tutti i mari del pianeta. In mare le vie volontarie di introduzione delle specie aliene sono rappresentate dall’acquacoltura, dall’acquariologia e da altre forme di importazione come quella delle esche per la pesca. Vie di introduzione involontarie sono le acque di zavorra delle navi e le bio-incrostazioni degli scafi; anche l’importazione di animali vivi o morti e di mangimi può rappresentare una via di introduzione di parassiti e di altri patogeni alieni. Il Mediterraneo è uno dei mari del mondo più colpiti dalle invasioni biologiche sia in termini di numero di specie (Costello et al, 2010) che di velocità d’invasione (Zenetos, 2010). La presenza di specie non indigene In Mediterraneo è causata oltre che dalla loro introduzione anche dalla loro migrazione attraverso il Canale di Suez e lo Stretto di Gibilterra.
Nel 2014 la dodicesima Conferenza delle Parti della CBD (Pyeongchang, 2014) ha modificato la definizione di specie aliene ritenendo tali solo quelle introdotte dall’uomo, pertanto le specie penetrate attraverso vie naturali, come lo Stretto di Gibilterra, non possono più essere chiamate aliene, queste sono oggi indicate come specie che ampliano il loro areale di distribuzione che i ricercatori definiscono specie non native.
Le specie atlantiche hanno già in passato modificato e arricchito la biodiversità mediterranea sulla quale hanno inciso i profondi cambiamenti geomorfologici e climatici subiti dal bacino dal Cambriano ad oggi. In termini strettamente zoogeografici, le specie autoctone e le specie endemiche mediterranee, secondo Por e Dimentan (1990) dovrebbero essere cercate tra la fauna messiniana (sopravvissuta alla crisi di salinità), le altre specie sono invece pseudo-endemiche penetrate dall’Atlantico dopo l’apertura del Mediterraneo avvenuta nel Pleistocene. A causa di questa colonizzazione relativamente recente il Mediterraneo mostra una alta ricettività alle specie aliene rispetto ad ambienti altamente competitivi e non può essere considerato una regione zoogeografica autonoma Ekman (1967). Per questa ragione nel mare Mediterraneo si

Il mare era stato, in passato, l’ambiente meno colpito dalle specie aliene ma più recentemente, la globalizzazione e l’aumento del traffico marittimo, hanno portato a una diffusione delle specie aliene in tutti i mari del pianeta
preferisce utilizzare il termine specie non indigena (NIS) piuttosto che aliena.
Diversa è invece la migrazione di specie dal Mar Rosso attraverso il Canale di Suez che è realizzato dall’uomo. Nel 1902, trentatré anni dopo l’apertura del Canale, realizzato dall’architetto Ferdinand de Lesseps, è stata ritrovata ad Haifa Atherinomorus lacunosus che può essere considerata la prima specie ittica del mar Rosso in Mediterraneo. Da quel momento i ritrovamenti di specie indopacifiche in Mediterraneo orientale sono stati frequenti e Il fenomeno è stato definito da POR, nel 1978, migrazione lessepsiana. Nonostante il crescente impegno scientifico non si dispone, ancora oggi, di dati certi sul numero di NIS in Mediterraneo, ciò è dovuto sia alla difficoltà di validare molti dei ritrovamenti, sia alla divergenza di opinioni tra gli esperti. Inoltre di molte specie si dispone di un solo ritrovamento e altre sono rare. Il numero delle specie insediate, ovvero quelle che in mediterraneo hanno compiuto un intero ciclo vitale, non supera il 20% di quelle ritrovate.
Una prima revisione delle 963 specie aliene segnalate sino al 2005 in Mediterraneo (Zenetos et al. 2005) ne ha escluso 218, validandone 745, di cui 385 insediate, e ritenendone dubbie 98. Secondo Coll et al (2010), invece le NIS sono 600, ma questo numero probabilmente era sottovalutato secondo i dati di RAC/SPA e dell’Agenzia Europea per l’Ambiente che ne stimavano circa 1000.
Uno studio dell’ISPRA, incaricata dal Ministero dell’Ambiente di creare una banca dati e un atlante delle NIS mediterranee, (Andaloro F. 2004) ha

Le modifiche degli habitat da parte delle NIS possono avere gravi conseguenze sulla pesca professionale, è questo il caso delle due alghe infestanti, Caulerpa racemosa e Caulerpa Cylindracea che hanno provocato nella costa meridionale della Sicilia, seri problemi alla pesca costiera intasando le reti da posta
messo in evidenza che le specie migrate attraverso il Canale di Suez rappresentavano il 45% delle specie non indigene, il 9% era migrata attraverso Gibilterra, il 16% era stata introdotta dal traffico marittimo, l’8% attraverso l’acquacoltura e l’acquariologia e il 22 % aveva origine sconosciuta. Ma lo studio ha evidenziato soprattutto che la maggior parte delle NIS in Mediterraneo aveva affinità tropicale o subtropicale. Ciò ha portato a correlare il rapido incremento del loro ritrovamento negli ultimi 30 anni anche con il cambiamento climatico definendo un fenomeno di tropicalizzazione del Mediterraneo (Andaloro e Rinaldi 1998; Nike Bianchi, 2007).
L’Italia, con oltre 7.000 km di costa essendo al centro del mediterraneo, presenta caratteristiche idrografiche rilevanti per la diffusione di specie aliene. Una revisione recente ha identificato 165 NIS in Italia per il periodo 19452009 (Occhipinti-Ambrogi et al., 2011). Questo numero è stato aggiornato nel 2013 con l’aggiunta di 11 specie (Marchini et al., 2013). Tuttavia è inferiore ai 242 NIS riportati da Andaloro et al. (2012). Queste discrepanze possono essere attribuite ai diversi periodi considerati, ma soprattutto alle definizioni utilizzate e alle relative incertezze. È comunque evidente che il numero delle NIS trovate nei mari italiani sta aumentando anche a causa di un maggiore impegno scientifico, al citizen sciencen e alle recenti rivalutazioni dello status di
specie aliene o criptogenetiche di alcune specie aliene (Zenetos et al., 2017) e l’evoluzione degli approcci tassonomici. La cattura di specie non indigene nei mari italiani, sino a pochi anni fa, era da ritenersi occasionale sebbene fosse ricorrente, sin dal 2000, soprattutto nei mari meridionali, la cattura di specie lessepsiane come il pesce flauto (Fistularia commersoni) e il pesce coniglio (Siganus luridus) e di specie atlantiche come la ricciola fasciata (Seriola fasciata). Un caso a parte è rappresentato da tre specie introdotte dall’acquacoltura: la vongola filippina (Ruditapes philippinarum) che ha essenzialmente sostituito la vongola verace (Ruditapes decussatus) in alto Adriatico, l’ostrica giapponese (Cassostera gigas) che compete con l’ostrica comune (Ostrea edulis) e il gambero giapponese (Marsupenaeus japonicus) che oggi, in alcune aree, rappresenta una cattura comune.
La situazione è molto diversa nel bacino orientale dove la cattura di specie indopacifiche già nel 2008 rappresentava il 37% della produzione ittica (Carpentieri et al.2008). Le modifiche degli habitat da parte delle NIS possono avere gravi conseguenze sulla pesca professionale, è questo il caso delle due alghe infestanti, Caulerpa racemosa e Caulerpa Cylindracea che hanno provocato nella costa meridionale della Sicilia, seri problemi alla pesca costiera intasando le reti da posta.
La tossicità di alcune specie aliene può avere un serio impatto sulla pesca e la salute dell’uomo, come alcune alghe tossiche aliene. È questo il caso di Ostreopsis ovata e delle citate caulerpe che contengono la tossina caulerpenina. La tossicità di queste alghe aliene può portare ad una sofferenza degli organismi che se ne alimentano (Ferlline S., 2017) e può rendere non commestibili specie ittiche allevate e pescate come mitili, ostriche e ricci di mare.
Vi sono anche specie ittiche non indigene alimentarmente tossiche come i tetraodontidiformi che contegono la tetrodotossina, a questo ordine appartengono i pesci palla trovati nei mari italiani che
sono migranti atlantici (Diodon hystrix, Chilomycterus reticulatus, Sphoeroides marmoratus e Sphoeroides pachygaster), ma a preoccupare di più è pesce palla maculato indopacifico Lagocephalus sceleratus, che ha provocato numerosi decessi nel bacino di levante. È stato segnalato nei mari italiani nel 2014 ma non ha provocato vittime grazie a una prima allerta lanciata da ISPRA (Andaloro F.,2016). Un secondo early warning è stato lanciato per il pesce leone (Pterois milens) che ha spine molto velenose sebbene non letali. Piu recentemente, una NIS, il granchio blu americano (Callinectes sapidus) che era stata segnalata sin dal 1949 nella Laguna di Grado e che era pescata sporadicamente sino al 2000 si è recentemente diffusa dal Friuli alla Sicilia, acquisendo negli ultimi anni, per cause ancora oggetto di studio, la dimensione di una bio-invasione che è stata considerata una emergenza nazionale poiché la grande diffusione di questo predatore ha causato una perdita di produzione di vongole che in alcune aree dell’ Adriatico settentrionale ha raggiunto il 96% creando un enorme danno economico alle comunità locali. Attualmente per contrastare il granchio blu è stato nominato un commissario straordinario e sono stati coinvolti tutti gli istituti di ricerca dell’area.
In Tunisia e in Sicilia oltre al granchio blu americano viene catturato il granchio blu del Mar Rosso che è una specie lessepsiana che ha invaso molte aree costiere nord africane. In Tunisia il granchio blu è oggi ritenuto una risorsa che ha rappresentato nel 2021 il 25% delle esportazioni ittiche tunisine creando migliaia di posti di lavoro sia nella pesca sia nella sua trasformazione in polpa di granchio e in chitina e chitosano ricavati dalle esuvie.
L’impegno italiano contro le specie aliene marine
In Italia, nel 2002 il MASE ha affidato a ISPRA la realizzazione della banca dati, dell’atlante, della cartografia delle NIS dei mari italiani. Inoltre nell’ambito della Strategia Mediterranea per prevenire il trasferimento degli organismi ma-
rini attraverso le ballast water (UNEP/ MAP/2011) il MASE è impegnato nella realizzazione un early warning system per porti italiani selezionati attraverso una analisi del rischio e attraverso ISPRA e le ARPA regionali anche nelle attività del Descrittore 2 della Direttiva sulla Strategia Marina. Il MASAF ha invece realizzato, con l’assistenza tecnica di ISPRA, il registro delle specie esotiche in acquacoltura ai sensi del Reg. 708/2007/UE.
Considerazioni
Anche se le specie non native migrate dall’Atlantico attraverso Gibilterra non possono essere più ritenute aliene, queste modificano comunque la la biodiversità del bacino caratterizzandone una vocazione sempre più subtropicale e tropicale piuttosto che temperata.
La decisione di CBD di non ritenerle più aliene è legata al fatto che non possono essere messe in atto misure di prevenzione rispetto alla loro migrazione attraverso vie naturali così come avviene per le introduzioni da parte dell’uomo. La presenza di nuove specie non native atlantiche nel Mediterraneo occidentale e di specie indopacifiche nel bacino orientale sta amplificando la differenza della biodiversità tra le due aree rendendo il Mediterraneo centrale, un punto d’incontro tra specie non indigene indopacifiche e specie atlantiche. Il Mediterraneo centrale, ed in particolare i mari italiani, che sino al 2005 erano poco interessati dall’insediamento di specie lessepsiane hanno visto crescere rapidamente la loro presenza, soprattutto in seguito al cambiamento del transiente intermedio levantino, una corrente marina la cui modifica, legata al cambiamento climatico, ha facilitato l’arrivo di NIS dai mari orientali.
Ciò nonostante l’impatto delle specie aliene nei mari italiani, che era stato modesto sino a un decennio fa, è oggi in veloce crescita con danni sugli ecosistemi, la pesca, l’acquacoltura, il benessere delle comunità locali e la salute umana. Le risposte, come raccomandato dalle convenzioni internazionali sono quelle della prevenzione, della mitigazione e
dell’adattamento. La prevenzione prevede misure relative al trattamento delle acque di zavorra, alla autorizzazione preventiva all’introduzione di specie non indigene in acquacoltura, al contrasto alla disseminazione secondaria di NIS già presenti, la priorizzazione degli interventi verso specie pericolose e l’attuazione di un horizont scannig per prevedere l’arrivo di NIS presenti in mari vicini (specie toc-toc) nel tentativo di contrastarne l’arrivo o comunque esserne preparati a fronteggiarle. Le misure di mitigazione e adattamento prevedono il miglioramento del buon stato dei mari inquanto è provato che le NIS hanno maggiore difficolta a colonizzare ambienti sani con risorse native non depauperate, la realizzazione di sistemi di
Bibliografia
prima allerta per le specie particolarmente pericolose per l’ambiente e la salute, l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e di citizen science, l’utilizzazione commerciale delle NIS eduli promuovendone il consumo e il rilancio della pesca artigianale che è l’attività di pesca in condizione di adattarsi alle nuove specie.
Dobbiamo considerare che un mare giovane come il Mediterraneo, con ambienti degradati, molte risorse native depauperate e sottoposto al cambiamento climatico andrà incontro a continui mutamenti che potranno essere affrontati solo con una rapida capacità di risposta da parte di tutti i Paesi che vi si affacciano cosa questa che in un bacino complesso dal punto di vista geopolitico appare complesso.
1. Andaloro, F., Rinaldi, A. - 1998. Fish biodiversity change in Mediterranean sea as tropicalisation phenomenon indicator. Indicator for assessing desertification in the Mediterranean. Enne, G., D’angelo,. M. e Zanolla, C eds. Prooceding of international seminar porto torres 201-206.
2. Andaloro F. 2004 –Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene- report al MATTM pp154
3. Andaloro, F., Falautano, M., Perzia, P., Maricchiolo, C., Castriota, L., 2012. Identification and distribution of non indigenous species in the Mediterranean Sea: the Italian challenges. Aliens: The Invasive Species Bulletin, 32, 13-19.
4. Andaloro, F., Castriota, L., Falautano, M., Azzurro, E., Deidun, A. et al., 2016. Public feedback on early warning initiatives undertaken for hazardous non-indigenous species: the case of Lagocephalus sceleratus from Italian and Maltese waters. Management of Biological Invasions, 7 (4), 313-319.
5. Carpentieri, P., Lelli, S., Colloca, F., Mohanna, C., Bartolino, V., Moubayed, S. and Ardizzone, G.. 2008 JEMBA2 – Biodiversity Records Published on line.
6. Coll,M., Piroddi, C., Steenbeek, J., Cashner, K., Ben Rais Lasram, F. - 2010. The biodiversity of the Mediterranean sea: estimates, patterns, and threats. PLOSONE, 5(8): e10.1371/jornal.pone0011842.
7. Costello M.J., Coll, M., Danovaro, R., Halpin, P., Ojaveer, H. - 2010- A census of marine biodiversity Knowledge, resources and future challenges. PLOoSONE, 5(8):e12110 doi:10.1371/jiornal.pone0012110
8. Ekman, S.(1967). Zoogeography of the sea. Sidwick and Jackson limited (Eds.) New edition, London. Pp.417.
9. Felline, S., Mollo, E., Cutignano, A., Grauso, L., Andaloro, F., Castriota, L., ... & Terlizzi, A. N. T. O. N. I. O. (2017). Preliminary observations of caulerpin accumulation from the invasive Caulerpa cylindracea in native Mediterranean fish species. Aquatic Biology, 26,
10. Marchini, A., Ferrario, J., Occhipinti-Ambrogi, A., 2013. Recent additions to the alien marine biota along Italian coasts. Rapport de la Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Mer Méditerrané, 40, 887.
11. Nike bianchi C.N.,2007 Biodiversity issues for the forthcoming tropical Mediterranean sea. Hydrobiologia, 580(1): 7-21
12. Por, F. e Dimentan, C. (1985) 1990 continuity of messinian biota in the mediterranean basin. Stanley, D.J. e Wezel, F.C. (eds), Geological evolution in mediterranea basin, Springer pp.545-557.
13. Servello, G., Andaloro, F., Azzurro, E., Castriota, L., Catra, M., Chiarore, A., ... & Zenetos, A. (2019). Marine alien species in Italy: A contribution to the implementation of descriptor D2 of the marine strategy framework directive. Mediterranean Marine Science, 20(1), 1-48.
14. Zenetos, A., Çinar, M. E., Pancucci-Papadopoulou, M. A., Harmelin, J. G., Furnari, G., Andaloro, F., ... & Zibrowius, H. (2005). Annotated list of marine alien species in the Mediterranean with records of the worst invasive species. Mediterranean marine science, 6(2), 63-118.
15. Zenetos, A .2010. Trend in alien species in the Mediterranean. An answer to Gail 2009 “talking stock: inventory of alien species in Mediterranean sea”. Biological invasion,12:3379-3381
Ambiente

© Denis Belitsky/shutterstock.com

SARDEGNA IN BARCA A CACCIA
DI MICROPLASTICHE
L’IMPATTO SU API E NATURA
La biologa Colzi lancia l’allarme: «Si sa troppo poco sulle conseguenze che questi inquinanti possono avere sull’interazione tra le piante e gli insetti impollinatori»
di Domenico Esposito

Fino a poco tempo fa le microplastiche erano considerate come un problema prevalentemente marino, con bottiglie, sacchetti e reti da pesca che si frammentano fino a diventare impercettibili, minacciando pesci, uccelli e organismi acquatici. In realtà, recenti ricerche stanno dimostrando come l’inquinamento da plastica non si fermi soltanto al mare.
© Maksim Safaniuk/shutterstock.com
In barca a vela lungo le coste più incontaminate di tutta la Sardegna. No, non è un viaggio romantico. E neanche una fuga via mare per combattere la terribile calura estiva. In realtà, dietro c’è una motivazione ben più profonda: monitorare un inquinante spesso invisibile ma presente dappertutto come le microplastiche.
Il progetto si chiama BeeSafe e ha un obiettivo tanto ambizioso quanto assolutamente stringente, quello di comprendere come questi minuscoli frammenti di plastica stiano influenzando le relazioni tra piante e impollinatori. In particolare, le api, che sono fondamentali per la sopravvivenza dell’intero ecosistema terrestre. Finanziato dalla National Geographic Society, BeeSafe coinvolge ricercatori delle Università di Firenze, Siena e Cagliari. Il loro lavoro sul campo consiste nella raccolta di campioni di suolo, fiori e insetti in aree poco antropizzate, per capire quanto la contaminazione sia ormai penetrata anche in contesti che apparentemente sembrano intatti.
Fino a poco tempo fa le microplastiche erano considerate come un problema prevalentemente marino, con bottiglie, sacchetti e reti da pesca che si frammentano fino a diventare impercettibili, minacciando pesci, uccelli e organismi acquatici.
In realtà, recenti ricerche stanno dimo -
strando come l’inquinamento da plastica non si fermi soltanto al mare.
«Le microplastiche sono ovunque - ha spiegato Ilaria Colzi, biologa vegetale dell’Università di Firenze e coordinatrice del progetto -. Sebbene l’impatto di questi inquinanti sia stato ampiamente studiato negli ecosistemi acquatici, gli ambienti terrestri rimangono ancora poco esplorati. E sappiamo ancora meno circa le conseguenze che possono avere sull’interazione tra le piante e gli insetti impollinatori, un processo cruciale per la vita sulla Terra».
Tra gli impollinatori più noti e indispensabili troviamo le api selvatiche, oggi seriamente minacciate da molteplici fattori quali pesticidi, il cambiamento climatico e la perdita di habitat. Le microplastiche potrebbero essere l’ennesima voce da aggiungere a questa lunga lista di pericoli.
«Le popolazioni di api selvatiche sono in declino in molte parti del mondo - ha sottolineato David Baracchi, zoologo dell’Università di Firenze -. Le microplastiche potrebbero rappresentare un nuovo rischio per questi fragili organismi. Per valutare davvero il loro impatto, dobbiamo prima stimare il livello di esposizione reale in natura. È un passaggio fondamentale per poi condurre test di laboratorio più accurati e progettare strategie di conservazione efficaci».


L’effetto domino delle microplastiche non si ferma soltanto agli insetti. A essere in pericolo è tutta l’intera catena ecologica. Se gli impollinatori non svolgono correttamente la loro funzione, a risentirne sono anche le piante, comprese pure buona parte di quelle coltivate. «L’impollinazione è fondamentale per la riproduzione di gran parte delle piante a fiore, quindi anche per la produzione di frutta, verdura e semi - ha evidenziato Massimo Nepi, biologo dell’Università di Siena -. Qualsiasi fattore di stress che comprometta questa relazione può ridurre la biodiversità vegetale e danneggiare direttamente il rendimento agricolo»
Il monitoraggio in Sardegna, in ambienti poco alterati dalla presenza umana, offre la possibilità di studiare i livelli di fondo dell’inquinamento, ossia quelli che potrebbero riflettere una contaminazione globale e non localizzata.
Ma l’effetto domino delle microplastiche non si ferma soltanto agli insetti. A essere in pericolo è tutta l’intera catena ecologica. Se gli impollinatori non svolgono correttamente la loro funzione, a risentirne sono anche le piante, comprese pure buona parte di quelle coltivate. «L’impollinazione è fondamentale per la riproduzione di gran parte delle piante a fiore, quindi anche per la produzione di frutta, verdura e semi - ha evidenziato Massimo Nepi, biologo dell’Università di Siena -. Qualsiasi fattore di stress che comprometta questa relazione può ridurre la biodiversità vegetale e danneggiare direttamente il rendimento agricolo».
Il timore è che le microplastiche, depositandosi sui fiori o venendo ingerite accidentalmente dagli insetti, possano interferire con il comportamento degli impollinatori fino a ridurne la vitalità. Ecco spiegato perché i dati raccolti saranno cruciali al fine di valutare se questa forma di inquinamento possa essere anche un problema agricolo, oltre che ecologico.
Il progetto BeeSafe diventa, ora più che mai, non soltanto una spedizione scientifica ma anche un’iniziativa di sensibilizzazione sul tema. A bordo della barca a vela, insieme agli scienziati, viaggiano infatti anche comunicatori e documentaristi. Nel team sono coinvolti Pierluigi Cortis e Paolo Colleo (Università di Cagliari), Cristina Gonnelli, Giorgia Guardigli e Pablo Carril (Università di Firenze), Daniele Calabrese (Università di Siena), mentre Claudia Lippi dell’associazione “Lasca la Randa” cura la logistica della spedizione. La vera forza di un progetto simile consiste nell’affrontare un’emergenza spesso sottovalutata come l’inquinamento invisibile. Le microplastiche sono troppo piccole per essere notate e ciò consente loro di penetrare ovunque, anche nei luoghi più impensabili. Come, ad esempio, le bottiglie di vetro. Già, uno studio francese realizzato dagli esperti scienziati dell’Agenzia per la sicurezza alimentare ha dimostrato che nelle bevande in bottiglia di vetro è presente una quantità di microplastiche ben più elevata rispetto a quelle in bottiglia di plastica. E la causa sarebbe da ricercare nei tappi. Ciò a dimostrazione che l’inquinamento da plastica è una sfida globale da vincere a tutti i costi.

GLI ORTI URBANI AL CENTRO DELLE CITTÀ FUTURE
Uno studio europeo rivela come aiutino l’ambiente e favoriscano la salute e la coesione sociale
Nel cuore delle città, tra la pesantezza del cemento e i rumori del traffico, è necessario che una verde cellula di resistenza fiorisca palpitante, affinché sia possibile contrastare l’incedere mortifero del cambiamento climatico: e quella cellula sono gli orti urbani.
Uno studio, condotto dall’Università SWPS e dal Politecnico di Varsavia e dall’Università di Scienze della Vita di Varsavia, pubblicato sulla rivista Miscellanea Geographica, ha dimostrato come gli orti urbani non sono dei semplici appezzamenti di terra coltivata da cittadini con il
“pollice verde”, ma veri e propri presidi ecologici e sociali. Analizzando il caso di Varsavia, i ricercatori hanno individuato oltre 1.800 ettari di aree potenzialmente convertibili in orti urbani, situati entro 600 metri dalle zone abitate.
Ma il dato più sorprendente è che questi spazi, se ben gestiti, possono contribuire in modo significativo alla lotta al riscaldamento globale. Gli orti urbani assorbono CO ₂ , riducono l’inquinamento atmosferico, mitigano l’effetto “isola di calore” e migliorano la gestione delle acque piovane. Inoltre, favoriscono il compostaggio
dei rifiuti organici riducendo le emissioni di gas serra e il consumo energetico. Ma i benefici non si fermano all’ambiente: gli orti sono anche luoghi di aggregazione, educazione e benessere. Secondo le 200 interviste condotte nello studio, chi coltiva un orto urbano (prevalentemente donne anziane, famiglie della classe media, attivisti e volontari) lo fa non tanto per produrre cibo quanto per promuovere la biodiversità, l’educazione ambientale e la cooperazione tra cittadini. Ogni orto coinvolge in media 10-15 persone attive e diversi visitatori occasionali.
Gli orti diventano così spazi terapeutici dove il contatto con la natura migliora la salute mentale e rafforza il senso di comunità. In Italia, secondo i dati ISTAT e Coldiretti, gli orti urbani sono in crescita: oltre 2,1 milioni di metri quadrati coltivati, con l’Emilia-Romagna in testa a tutte le regioni. Il progetto europeo SustUrbanFoods ha dimostrato come con appena 10-20 metri quadrati si può produrre una quantità significativa di ortaggi freschi, riducendo la dipendenza dalla grande distribuzione. Tuttavia, a rallentare lo sviluppo di questi piccoli atolli di verde ci sono diversi ostacoli, come la precarietà dei terreni, l’assenza delle istituzioni e le difficoltà di coinvolgere nuovi partecipanti.
La scienza dovrà sostenere senza riserve le politiche pubbliche che promuoveranno l’inserimento degli orti nei piani urbanistici, nonché la facilitazione all’accesso ai terreni pubblici, il loro corretto utilizzo e la costituzione di una “cultura del verde” condivisa. Gli orti urbani rappresentano un tassello fondamentale per la nascita di città resilienti, che dovranno essere allevate e cresciute attivamente nel segno della sostenibilità e dell’inclusività. In un mondo in cui l’asfalto divora tutti gli spazi, ritornare consapevolmente alla terra è, forse, un sospiro di rivoluzione.
Ogni anno vengono prodotti, utilizzati e abbandonati centinaia di miliardi di sacchetti di plastica. Leggeri, economici e onnipresenti, questi oggetti di uso quotidiano finiscono troppo spesso nelle nostre acque e sulle spiagge, dove danneggiano la fauna marina, degradandosi lentamente in microplastiche dannose per l’ambiente.
Per contrastare questo fenomeno molti paesi hanno introdotto divieti o tassazioni sui sacchetti monouso: ma queste misure funzionano veramente? Ebbene, una nuova ricerca americana pubblicata sulla rivista Science, condotta da Anna Papp e Kimberly Oremus, ha analizzato oltre 45.000 interventi di pulizia costiera negli Stati Uniti tra il 2016 e il 2023. Lo studio è stato condotto analizzando la grande quantità di dati raccolta da Ocean Conservancy, un’organizzazione senza scopo di lucro che tiene traccia delle attività di pulizia da parte di migliaia di volontari. I dati facevano riferimento a raccolte rifiuti diverse tra loro, e il gruppo di ricerca non ha potuto calcolare la quantità esatta di sacchetti di plastica per ogni sito, ma è riuscito a ricostruire la loro percentuale rispetto al totale dei rifiuti raccolti e come questa è cambiata nel corso del tempo.
I risultati sono inequivocabili: nei luoghi in cui sono in vigore divieti o restrizioni, la presenza di sacchetti di plastica tra i rifiuti raccolti è diminuita fino al 47%. Lo studio ha incrociato i dati delle pulizie con 182 regolamenti locali e statali, dimostrando che le leggi più severe e durature producono effetti più visibili. In particolare, i divieti statali hanno avuto un impatto maggiore rispetto a quelli municipali, probabilmente grazie alla loro ampia applicazione e al maggiore controllo. Al contrario, nelle aree prive di restrizioni, la quantità di plastica è aumentata. Il database utilizzato, chiamato TIDES, è alimentato da migliaia di volontari tramite l’app Clean Swell. Si tratta di una delle più vaste raccolte di

L’EFFICACIA DEI DIVIETI CONTRO LA PLASTICA
I dati raccolti su 45.000 spiagge in sette anni dimostrano come gli off limits stanno dando i loro frutti
dati ambientali partecipativi al mondo, e rappresenta un esempio virtuoso di citizen science applicata alla tutela degli ecosistemi. Nonostante questi segnali incoraggianti il problema resta però enorme: secondo l’OCSE, la produzione globale di plastica potrebbe triplicare entro il 2060.
Gli esperti sottolineano infatti come i divieti locali sono di fondamentale importanza, ma comunque insignificanti rispetto alla totalità del problema. Vi è la necessità di agire alla fonte, riducendo la produzione complessiva di plastica e incentivando l’adozione di materiali alternativi,
biodegradabili o riutilizzabili. In vista dei negoziati ONU sull’inquinamento da plastica, previsti per il prossimo agosto, questo studio rappresenta una prova concreta che le politiche ambientali possono funzionare se perseguite con convinzione.
Cambiare rotta è possibile se la volontà e la cooperazione della politica, in ambito nazionale e internazionale, sono vive; come altrettanto vivo deve essere il coinvolgimento dei cittadini. Forse, se un sacchetto in meno può salvare una tartaruga, milioni di sacchetti in meno potrebbero salvare un intero ecosistema. (M. O.).

L’arricchimento del suolo con microscopici alleati promuove la crescita della flora autoctona e migliora la stabilità del terreno, lottando contro l’erosione idrica
Ambiente
Restituire vita ai suoli avvelenati, trasformando le cicatrici dell’era industriale in nuovi ecosistemi fiorenti grazie a un’alleanza inedita tra scienza e natura. La promessa è ambiziosa, ma rappresenta il cuore di una specifica attività del progetto “Return” (Multi-risk science for resilient communities under a changing climate), vasto programma nazionale di ricerca finanziato con i fondi del Pnrr per comunità più resilienti di fronte ai rischi ambientali, siano essi di origine naturale o antropica. L’iniziativa, che vede la collaborazione di ben ventisei tra università, centri di eccellenza, istituzioni e imprese private sotto il coordinamento generale del Cnr, affida all’Enea un compito di enorme importanza: sperimentare sul campo una metodologia di risanamento a basso impatto per i terreni contaminati da metalli pesanti. Il laboratorio a cielo aperto per questa attività è un luogo emblematico, l’ex sito minerario di Ingurtosu, nel sud-ovest della Sardegna, un sito che porta i segni profondi di un passato estrattivo e oggi inserita nel Parco Geominerario storico e ambientale patrocinato dall’Unesco. Qui, dove il suolo è saturo dell’eredità tossica proveniente da decenni di lavorazioni, si sta tentando di riscrivere la storia ecologico-territoriale: «Le attività legate all’estrazione mineraria - sottolinea Chiara Alisi del Laboratorio tecnologie per la salvaguardia del patrimonio architettonico e culturale - hanno causato un significativo degrado ambientale nell’area di Ingurtosu che è stata per decenni esposta a un forte inquinamento da metalli pesanti come piombo e zinco.
In questo contesto, sin dal 2011, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Cagliari, avevamo avviato degli studi sui cambiamenti della quantità dei metalli pesanti in relazione alla presenza di piante spontanee e all’attività microbica del terreno, testando anche tecniche di fitorisanamento con microrganismi, e ora stiamo recuperando l’area inquinata sostenendo la crescita
di piante di Elicriso, tipiche della zona». La strategia adottata, infatti, si allontana dalle tradizionali e invasive tecniche di bonifica per abbracciare un approccio biologico che sfrutta la sinergia tra la flora spontanea e un esercito di microscopici alleati. Il fulcro dell’intervento è la cosiddetta bioaugmentation, una pratica che consiste nell’arricchire il terreno con microrganismi selezionati per le loro peculiari capacità. In questo contesto, i ricercatori hanno isolato direttamente dagli scarti della miniera undici ceppi batterici nativi, veri e propri “superstiti” capaci non solo di tollerare concentrazioni elevate di elementi nocivi, ma, persino, d’interagire positivamente con l’ambiente circostante. Gli organismi invisibili agiscono come catalizzatori di rinascita: da un lato, producono sostanze che promuovono la crescita delle piante autoctone, aiutandole a colonizzare un substrato altrimenti inospitale; dall’altro, migliorano la qualità generale, incrementando la biodiversità microbica e contribuendo alla sua stabilizzazione fisica, contrastando così l’erosione. «I batteri - prosegue la Alisi - non possono degradare i metalli pesanti, ma possono contribuire ad immobilizzarli e favorire la rigenerazione del terreno. Le piante, infatti, stentano a crescere in un suolo contaminato. Qui entrano in gioco i batteri, che producono sostanze nutritive permettendo alle piante di attecchire. I risultati ottenuti ci incoraggiano a sviluppare un modello sostenibile e replicabile, con benefici in termini di riduzione della concentrazione e della pericolosità dei metalli, aumento della vegetazione spontanea e miglioramento della salute del suolo».
L’intervento s’inserisce in una delle otto aree tematiche, o spoke, che strutturano l’intero “Return”, quella dedicata al degrado ambientale. Il recupero di siti come Ingurtosu rappresenta una sfida cruciale per mitigare gli impatti sanitari, sociali ed economici legati alla filiera estrattiva, promuovendo, al contempo, un paradigma di circolarità e sostenibilità.

Il fulcro dell’intervento è la cosiddetta bioaugmentation, una pratica che consiste nell’arricchire il terreno con microrganismi selezionati per le loro peculiari capacità
Tuttavia, le finalità sono molto più ampie e interconnesse, puntando a una comprensione olistica dei pericoli che minacciano il nostro Pianeta. Il piano si articola, difatti, attraverso lo studio approfondito di molteplici fronti vulnerabili: dalla gestione delle risorse idriche all’instabilità dei versanti, dal monitoraggio di terremoti e vulcani alla sicurezza degli insediamenti urbani e metropolitani, fino alla resilienza delle infrastrutture critiche. Si propone di ottimizzare le metodologie di previsione, prevenzione e mitigazione, potenziando tecnologie innovative per il monitoraggio e incoraggiando un impiego più efficiente dei dati disponibili.
Un aspetto fondamentale è, inoltre, il rafforzamento del legame tra il mondo della ricerca e le applicazioni pratiche, valorizzando il trasferimento tecnologico e l’integrazione dei servizi. L’iniziativa non trascura le dimensioni sociali, economiche e culturali che determinano la capacità di una comunità di far fronte alle crisi, dedicando uno spoke specifico a questi aspetti. L’ultimo pilastro è rappresentato dalla scienza a supporto dei servizi climatici, essenziale per elaborare strategie di adattamento efficaci in un’epoca segnata da cambiamenti globali.
In questo mosaico complesso, l’esperienza sarda emerge come un simbolo potente: dimostra che l’osservazione dei meccanismi di resilienza della natura stessa possa fornire le chiavi per sanare le ferite inferte dall’uomo. Si apre, così, la strada a un futuro in cui lo sviluppo tecnologico e la tutela ambientale non sono più in antitesi, ma convergono verso un obiettivo comune di salute e prosperità per l’ecosistema e per chi lo abita. (G. P.).
LA NOSTRA ESISTENZA
Batteri, virus e organismi unicellulari viaggiano nell’atmosfera
Gli scienziati hanno scoperto che svolgono un ruolo cruciale per il clima e anche per la nostra salute

© Just dance/shutterstock.com
Ci ritroviamo spesso a osservare il cielo e in particolar modo le nuvole, magari creando storie immaginarie o rivedendo in esse delle forme a noi familiari. Talvolta le guardiamo con meraviglia, in altri casi con timore perché, se da un lato possono regalarci scenari meravigliosi come in occasione di un tramonto, dall’altro sanno essere minacciose quando è in arrivo il maltempo. Ciò che tuttavia spesso ignoriamo è che custodiscono un brulicante mondo microscopico.
Le nuvole, infatti, non sono soltanto vapori d’acqua sospesi in aria, ma delle vere e proprie isole galleggianti di vita. Al loro interno, infatti, è possibile trovare trilioni di microrganismi, tra i quali batteri, virus, funghi, alghe e altri esseri unicellulari, che viaggiano nell’atmosfera, trasportati dal vento e dalle correnti attraversando oceani e continenti. In realtà, già nel 1860 Louis Pasteur, considerato il padre della microbiologia moderna, sospettava l’esistenza di una vita invisibile nell’aria. Oggi la scienza ha dato un nome a questa realtà definendola come aerobioma, ossia l’insieme di tutti i microrganismi presenti nell’atmosfera. Ogni anno, circa un trilione di cellule batteriche e 50 milioni di tonnellate di spore fungine si sollevano dal suolo e dagli oceani per librarsi nel cielo. Le onde marine, gli incendi, le piante che rilasciano pollini o spore: tutto contribuisce a popolare questo ecosistema sospeso. Alcuni organismi non si limitano solo a essere trasportati dal vento, ma hanno sviluppato meccanismi per lanciarsi attivamente nell’aria.
Le scoperte più importanti arrivano da un osservatorio installato sulla cima del Puy de Dôme, un vulcano dormiente situato nel cuore della Francia. Da qui, un team guidato da Pierre Amato, aerobiologo dell’Università di Clermont Auvergne, ha campionato l’acqua delle nuvole, scoprendo che ogni millimetro cubo può contenere fino a 100.000 cellule. Tra queste ci sono batteri già noti, ma anche migliaia di specie nuove non classificate. I ricercatori hanno addirittura trovato segni di attività metabolica con alcune specie che riescono a nutrirsi e crescere sfruttando le sostanze organiche presenti nelle goccioline delle nuvole. È il caso dei batteri Methylobacterium, che sono capaci di metabolizzare carbonio usando la luce solare. In altre parole, ci sono batteri che letteralmente mangiano le nuvole. Questi microbi non si limitano a vivere nelle nuvole, bensì contribuiscono alla loro formazione. La pioggia si forma quando
l’acqua presente nell’atmosfera si congela e spesso ha bisogno di una particella seme attorno alla quale aggregarsi. I microrganismi, grazie alle loro pareti cellulari, sono perfetti per questo scopo. Fungine, pollini, alghe, licheni e batteri fungono da nuclei di condensazione, facilitando la nascita di cristalli di ghiaccio e quindi di pioggia o neve. Tra i più efficaci c’è il batterio Pseudomonas, che vive sulle foglie delle piante. Alcuni scienziati ipotizzano addirittura un ciclo simbiotico tra piante e batteri: i batteri favoriscono la pioggia, che fa crescere le piante, che a loro volta ospitano altri batteri. Praticamente una sorta di danza invisibile tra cielo e terra. Una delle implicazioni finita sotto le lenti degli esperti riguarda la diffusione dei geni di resistenza agli antibiotici. Amato e colleghi hanno trovato - ispezionando tra i batteri delle nuvole - fino a 29 tipi diversi di geni di resistenza. Ogni metro cubo di nuvola può contenerne fino a 10.000 e un’unica nuvola può trasportarne oltre un trilione. Questi geni provengono dalle attività umane: l’uso massiccio di antibiotici nella medicina favorisce batteri resistenti, che poi si diffondono nell’ambiente, persino nell’aria.
Dai terreni contaminati e dagli allevamenti, i batteri salgono nel cielo, viaggiano per centinaia di chilometri e tornano a terra con la pioggia, contaminando così nuovi ambienti. Studi come questi ci obbligano a rivedere la nostra idea di atmosfera, considerando le nuvole non solo fenomeni meteorologici, ma habitat dinamici che influenzano la chimica dell’aria, il ciclo dell’acqua e la salute globale. Magari non soltanto sulla Terra, dal momento che alcune ricerche suggeriscono che anche le nuvole di Venere potrebbero ospitare forme di vita microscopica, sopravvissute in quelle rare zone del pianeta dove le condizioni sono meno estreme.
D’ora in poi quando guarderemo le nuvole, lo faremo con occhi diversi. Perché scoperte di tale portata ribaltano completamente la nostra idea dell’atmosfera e capire come funziona questa sorta di rete aerea è oggi una sfida scientifica cruciale che aiuterà a prevedere il meteo con maggiore precisione e nello stesso tempo a comprendere i cicli naturali del pianeta, ma soprattutto porterà a immaginare nuove forme di prevenzione ambientale e sanitaria. In tal senso, un ruolo chiave è svolto dall’aerobiologia, la nuova scienza multidisciplinare che studia le particelle organiche, come batteri, spore fungine, piccoli insetti, granuli di polline e virus presenti nell’atmosfera. (D. E.).

I ricercatori hanno trovato segni di attività metabolica con alcune specie che riescono a nutrirsi e crescere sfruttando le sostanze organiche presenti nelle goccioline delle nuvole. È il caso dei batteri Methylobacterium, che sono capaci di metabolizzare carbonio usando la luce solare. In altre parole, ci sono batteri che letteralmente mangiano le nuvole. Questi microbi non si limitano a vivere nelle nuvole, bensì contribuiscono alla loro formazione.

L’INTERAZIONE TRA CAMPO ACUSTICO E NEURONI
Un articolo su Frontiers of Neurosystems Neuroscience descrive i risultati di alcuni esperimenti in questo ambito
Una delle sfide più affascinanti della ricerca scientifica è rivolta alla comprensione del funzionamento del cervello. La domanda, che ha stimolato lo sviluppo di tecnologie osservative, modelli e risultati scientifici in diverse discipline, ha riguardato le modalità di interconnessione di elementi considerati semplici, i neuroni, e la possibilità di realizzare un sistema complesso di acquisizione, elaborazione e decisione legata al contesto ambientale.
Sulla rivista Frontiers of Neurosystems Neuroscience è stato pubblica -
to un articolo che descrive i risultati di una serie di esperimenti mirati ad identificare il possibile ruolo del campo acustico nell’interazione delle cellule neuronali.
Gli esperimenti realizzati sono parte di un progetto nato nell’ambito del gruppo Materiali dell’iniziativa S&T Foresight del Cnr, in particolare durante un workshop dedicato al processo che collega l’informazione in un determinato contesto alla decisione e, quindi, all’azione. Un gruppo di esperti del Cnr, dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha dato vita a una serie di attività transdisciplinari mira-
te alla identificazione di elementi che potessero contribuire alla interconnessione di quegli aspetti in grado di far emergere una proprietà di insieme, ovvero la decisione come “stato del sistema”. Quindi, ci si è concentrati sul più semplice sistema complesso decisionale, quello formato da poche cellule del cervello. A tal fine, è stata disegnata e realizzata una serie di esperimenti che potesse evidenziare l’interazione tra alcune cellule attraverso l’analisi della loro motilità sulla nanoscala e misurandone simultaneamente l’energia vibrazionale attraverso un microscopio a forza atomica.
Pertanto, si tratta di unire competenze di fisica, neuroscienze e biologia focalizzandosi non più sulla interazione descritta usualmente come scambio di segnali elettrici o chimici, ma sul ruolo del campo acustico e, per la prima volta, attraverso osservazioni a scale spaziali micro e nanometriche. Sebbene un’interazione puramente chimica sia comunemente considerata l’attore principale nella comunicazione cellula-cellula, i comportamenti osservati negli esperimenti non possono essere spiegati attraverso una semplice comunicazione chimica. I risultati hanno dimostrato come un percorso complementare, ma altrettanto importante, attraverso il quale le cellule percepiscono l’ambiente circostante sia la stimolazione meccanica, che si traduce in cambiamenti nell’attività metabolica delle cellule. Questa capacità di meccano-sensorizzazione suggerisce che altri mezzi di comunicazione tra cellule possano essere rilevanti per la comunicazione cellula-cellula.
COMASAN si inquadra in una serie di ulteriori progetti che sviluppano una linea di ricerca solo apparentemente focalizzata sull’acustica, e che possano aumentare la comprensione di quei processi che portano elementi costitutivi di un sistema a realizzarne diversi stati, e studiare più in generale la dinamica degli ecosistemi complessi.
La SLA rappresenta una delle sfide più difficili per gli studiosi delle malattie neurodegenerative: le diagnosi son in crescita esponenziale per motivi ancora ignoti, e l’assenza di terapie grava sul sistema sanitario nazionale. Nel 2040, si prevede che il numero di persone diagnosticate con SLA in Europa aumenterà, con una crescita prevista del 20% rispetto al numero attuale di 28.000 casi, raggiungendo i 35.000 casi. Tale aumento è in parte dovuto alla mancanza di trattamenti efficaci che rendono la SLA una sfida crescente per la sanità pubblica.
Una ricerca svolta presso l’Istituto di genetica molecolare “Luigi Luca Cavalli-Sforza” del Cnr di Pavia ha prodotto dei risultati chiave per la definizione dei meccanismi molecolari alla base dell’accumulo di danno al DNA in cellule affette da Sclerosi laterale amiotrofica-SLA, una patologia neurodegenerativa devastante.
Lo studio, finanziato da Fondazione AriSLA, ha beneficiato del contributo di ricercatori e ricercatrici dell’Istituto di farmacologia traslazionale, dell’Istituto di biologia e patologia molecolari, della Sapienza Università di Roma e dell’Università degli studi Tor Vergata di Roma, dell’Istituto Mondino di Pavia e dell’IFOM di Milano. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Cell Death & Differentiation, rivelano che gli aggregati delle proteine FUS e TDP-43, che si accumulano nei pazienti SLA, impediscono alle cellule di segnalare e riparare il danno al DNA: questo porta a un rapido accumulo del danno, causando la perdita di funzionalità del genoma e sofferenza cellulare. Mentre, infatti, in persone sane le cellule dell’organismo riescono a riparare prontamente i molteplici danni subiti ogni giorno dal DNA in esse presente attraverso un processo di “risposta” noto come DNA Damage Response, nei pazienti affetti da SLA tale risposta cellulare non funziona in modo efficace contri-

SLA, MODELLI AVANZATI
PER NUOVE TERAPIE
Uno studio ha definito i meccanismi molecolari alla base dell’accumulo di danno al DNA in cellule affette dalla malattia
buendo alla neurodegenerazione.
Sofia Francia, ricercatrice del CnrIgm che ha coordinato lo studio, ha affermato: «Già in un precedente studio sostenuto da AriSLA avevamo dimostrato che proprio l’aggregazione delle proteine FUS e TDP-43 impedisce alle cellule di segnalare e riparare il danno al DNA. La conseguenza di questa disfunzione è che il DNA danneggiato si accumula velocemente nelle cellule, portando a perdita di funzione del genoma e ad una sofferenza della cellula stessa. Oggi, l’aver identificato gli attori maggiormente coinvolti da questo difetto ci ha per-
messo di testare a livello cellulare una terapia con un farmaco già approvato per le sue azioni antibatteriche e che recentemente ha dimostrato avere anche azioni antitumorali. I risultati ottenuti sono estremamente promettenti, in quanto rappresentano un primo passo che ci consentirà di proseguire gli studi su modelli più avanzati e, auspicabilmente, arrivare a potenziali nuove terapie».
Lo studio propone di reindirizzare una molecola già approvata per il trattamento di questa malattia, con un potenziale rapido riscontro per i pazienti. (P. S.).

DA BIOSOS NUOVI
PRODOTTI IN AGRICOLTURA
Concimi e acqua purificata dagli scarti della produzione di biogas, grazie a un innovativo processo di filtrazione
Iricercatori ENEA hanno ottenuto nuovi prodotti per l’agricoltura, come concimi, ammendanti e acqua “purificata” per uso irriguo, dallo scarto di produzione del biogas. Il risultato è stato raggiunto nell’ambito del progetto BIOSOS- BIOgas SOStenibile, coordinato dall’Università di Camerino, grazie ad un innovativo processo di filtrazione a due stadi che ha permesso di estrarre dalla frazione liquida del digestato nutrienti (azoto, fosforo e potassio) e sostanze organiche utilizzabili come fertilizzanti e ammendanti agricoli.
Inoltre, secondo i ricercatori ENEA il sistema consentirebbe di recuperare fino all’80% dell’acqua in uscita dal digestore, riutilizzabile all’interno del processo di biogasificazione, per la diluizione dei concimi o per l’irrigazione dei campi.
Gian Paolo Leone del Laboratorio Bioeconomia Circolare e responsabile per ENEA del contratto commissionato dall’Università di Camerino, ha spiegato: «Con questa innovazione offriamo il nostro contributo al raggiungimento degli obiettivi europei, in particolare della strategia Farm to Fork che prevede una riduzione
del 20% nell’utilizzo di fertilizzanti di sintesi entro il 2030; questi ultimi sono ad alta intensità energetica, contribuiscono all’esaurimento di risorse minerali come il fosforo e generano maggiori emissioni di gas serra».
Punto focale della sperimentazione ENEA è l’utilizzo di una particolare tecnologia di filtrazione che da anni è al centro delle attività di ricerca della Divisione Sistemi Agroalimentari Sostenibili. In merito, Daniele Pizzichini, ricercatore del Laboratorio ENEA Bioeconomia Circolare, ha dichiarato: «Si basa su un processo di separazione dei liquidi dove il fluido scorre parallelamente alla superficie della membrana che separa in modo efficiente l’acqua e i Sali dalle sostanze organiche concentrate. La stessa tecnologia è già utilizzata per estrarre molecole di interesse alimentare, nutraceutico e cosmetico, per recuperare proteine dai reflui lattiero-caseari (come il siero di caseificazione) e molecole antiossidanti come polifenoli e flavonoidi dalle acque di vegetazione olearie, nonché per la dissalazione di acque salmastre e marine ai fini dell’approvvigionamento idrico».
Entrando nel dettaglio, i ricercatori ENEA hanno lavorato mediante due stadi consecutivi di filtrazione presso la Hall tecnologica Processi Agro-industriali del Centro Ricerche ENEA della Casaccia. Gian Paolo Leone ha aggiunto: «Nel primo stadio di filtrazione, tratteniamo batteri potenzialmente presenti, riduciamo la torbidità legata ai solidi sospesi abbattendo così il carico inquinante per le fasi successive del trattamento. Nel secondo stadio otteniamo mediante nanofiltrazione o osmosi inversa un’acqua purificata da utilizzare per l’irrigazione delle colture e una concentrazione di macronutrienti, in particolare azoto ammoniacale, con caratteristiche diverse a seconda dello scarto organico (letame bovino o carcassa di trota iridea) ma del tutto simile ai concimi in commercio». (P. S.).
Nell’ambito del progetto BIOMIRATE, finanziato dall’ASI, un team di ricercatori ENEA, Fondazione Edmund Mach e Università Roma Tor Vergata sta lavorando a soluzioni tecnologiche avanzate per il riciclo efficiente e sostenibile delle risorse e la riduzione dell’impatto delle radiazioni cosmiche, a supporto della vita dell’uomo nelle missioni spaziali di lunga durata.
Le missioni spaziali di lunga durata, essendo al di fuori della protezione del campo magnetico terrestre, espongono l’uomo a condizioni estreme, tra cui: gravità alterata, isolamento prolungato ma anche radiazioni cosmiche e solari che possono compromettere la salute fisica e psicologica degli astronauti, nonché la funzionalità e resilienza dei sistemi biogenerativi.
Barbara Negri, Responsabile dell’Ufficio Volo Umano e Sperimentazione dell’ASI, dichiara: «Lo sviluppo di soluzioni innovative per sostenere la vita umana durante le missioni spaziali di lunga durata sulla Luna e, in prospettiva, su Marte, è un pilastro fondamentale della visione strategica dell’Agenzia Spaziale Italiana. Con il progetto BIOMIRATE (BIOrigenerativi: MItigazione del rischio da RAdiazioni mediante TEcnologie molecolari), coordinato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata in collaborazione con ENEA e la Fondazione Edmund Mach, l’ASI vuole porre le basi per la realizzazione di un modello di esplorazione spaziale sostenibile, autonoma e sicura, identificando le contromisure necessarie a proteggere gli astronauti in ambienti estremamente ostili».
L’obiettivo di BIOMIRATE è individuare strategie per la mitigazione dei rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti, al fine di garantire la sopravvivenza e la funzionalità degli organismi coinvolti nei sistemi biogenerativi, anche nelle condizioni estreme imposte dall’ambiente spaziale. Attraverso studi di genomica e trascrittomica su

BIOMIRATE PER LE MISSIONI
SU
LUNA E MARTE
Soluzioni tecnologiche avanzate a supporto della vita dell’uomo durante le esplorazioni spaziali di lunga durata
cianobatteri radioresistenti, e grazie all’impiego di tecniche di ingegneria metabolica e biologica sintetica, il progetto mira a creare un ideotipo di lattuga biofortificato, che sarà in grado di produrre antiossidanti naturali e proteine protettive del DNA, con lo scopo di ottenere varietà vegetali capaci di sopravvivere e restare produttive nello spazio e fornire un alimento funzionale per tutelare la salute degli astronauti.
L’effetto radioprotettivo e l’efficacia dell’alimentazione funzionale di questo superfood saranno valutati tramite simulazioni e sperimentalmente sulle lar-
ve della mosca soldato. Questi insetti, oltre ad essere in grado di trasformare i rifiuti organici in substrati utili per la coltivazione, rappresentano anche un promettente fonte alternativa di proteine animali.
Il loro impiego potrebbe contribuire a integrare la dieta degli astronauti, aiutando a contrastare lo stress ossidativo e apportando benefici sia dal punto di vista nutrizionale sia del benessere psicologico. Una collezione di cianobatteri radioresistenti verrà investigata per i meccanismi di riparo del DNA attraverso analisi molecolari avanzate. (P. S.).

© https://rubinobservatory.org/gallery/collections/main-gallery/n4kvj0cemd5pbdqgtjdgp2jg2t
LE IMMAGINI SPETTACOLARI DEL TELESCOPIO RUBIN
Le prime immagini dell’occhio cileno aprono una nuova era dell’astrofisica per la mappatura del cosmo
Il cielo è appena increspato e piccole nuvole battono sulla cima delle montagne. Vera C. Rubin è in piedi sulla vetta, nel cuore delle Ande cilene, a oltre 2.600 metri di altitudine, e guarda l’universo. Prendere spunto da un incipit di Calvino per iniziare un testo è sempre una buona idea; parafrasare quello di “Palomar” in un articolo in cui si parla di telescopi è un’ottima idea.
Vera C. Rubin, infatti, altri non è che una collega (forse amica chissà) del più famoso osservatore della letteratura italiana.
Tra i più avanzati telescopi mai co -
struiti, il Vera C. Rubin Observatory è il primo in assoluto per la mappatura del cielo australe.
Lo scorso 23 giugno ha rilasciato le prime immagini segnando l’inizio ufficiale della sua missione scientifica: la Legacy Survey of Space and Time (LSST), una campagna decennale che ha promesso di rivoluzionare la comprensione del cosmo.
Le immagini diffuse mostrano con una nitidezza mai vista prima la Nebulosa Trifida, la Nebulosa Laguna e l’ammasso di galassie della Vergine. In meno di dieci ore di osservazioni, il telescopio ha catturato milioni di
stelle, galassie e oltre 2.000 asteroidi, molti dei quali mai osservati prima. Il cuore tecnologico dell’osservatorio è la LSST Camera, la più grande fotocamera digitale mai costruita: 3.200 megapixel, capace di coprire un’area del cielo pari a 45 volte la Luna piena.
Ogni notte, Rubin produrrà circa 20 terabyte di dati, creando un vero e proprio “film” dell’universo in movimento. Ogni porzione del cielo sarà osservata circa 800 volte in dieci anni, permettendo di monitorare supernovae, stelle variabili, galassie in fusione e oggetti potenzialmente pericolosi per la Terra.
Inoltre, grazie alla sua capacità di osservare il cielo con continuità, potrà ricostruire l’evoluzione dinamica dell’universo, offrendo nuove risposte su fenomeni ancora misteriosi come la materia oscura e l’energia oscura. Il progetto, frutto di una collaborazione internazionale guidata da NSF e DOE, vede anche l’Italia protagonista grazie all’INAF, che partecipa all’analisi dei dati e alla formazione di giovani ricercatori. Le immagini, presentate anche in Italia durante un evento al Palazzo dei Normanni di Palermo, hanno lasciato la comunità scientifica senza fiato.
Non si tratta solo di bellezza visiva, ma di una nuova modalità di fare astronomia: non più scatti statici, ma un cielo dinamico, aggiornato in tempo reale. Rubin rappresenta un salto concettuale, un passaggio dall’astrofotografia all’astro-cinematografia. Molti astrofisici sostengono che si sta entrando in un’epoca in cui «l’universo non va più solo osservato, ma raccontato in sequenze temporali», come afferma il professor Roberto Ragazzoni.
Se così fosse, allora, non ci si sta allontanando dall’obiettivo ultimo che il signor Palomar si era prefissato ormai quarant’anni fa: descrivere il tempo, quello della sua vita, istante per istante, finché non li avrà descritti tutti. (M. O.).
Dalle strutture di ricerca del Regno Unito, un gruppo di scienziati ha deciso di affrontare una delle sfide più ambiziose della biologia moderna: scrivere da zero un cromosoma umano. È il progetto Synthetic Human Genome (SynHG), finanziato con dieci milioni di sterline dal Wellcome Trust, e che coinvolge le università di Cambridge, Oxford, Manchester e l’Imperial College di Londra.
L’obiettivo è creare entro dieci anni il primo cromosoma umano sintetico, aprendo la strada a una nuova era nella medicina, nella genetica e a nuove questioni etiche nel panorama scientifico. A differenza dell’editing genetico, che modifica porzioni esistenti di DNA, la sintesi genomica implica la costruzione ex novo di sequenze genetiche complesse, un’impresa che richiede tecnologie ancora in fase di sviluppo.
Ad oggi, il genoma sintetico più grande mai realizzato è quello del batterio Escherichia coli, con circa 4,5 milioni di coppie di basi: quello umano ne contiene oltre 3 miliardi. La montagna da scalare è a dir poco colossale, ma le potenzialità che seguirebbero una riuscita del progetto sono altrettanto straordinarie. Diversi scienziati potrebbero sviluppare terapie cellulari personalizzate, trapianti senza donatori, trattamenti anti-aging, cellule resistenti a virus e persino creare modelli di malattie genetiche per testare i farmaci in modo più preciso.
Una parte della comunità scientifica immagina un futuro in cui sarà possibile progettare cellule umane su misura, capaci di svolgere compiti specifici come combattere i tumori, rigenerare i tessuti danneggiati o la chiave per combattere le future pandemie. Tuttavia, il progetto solleva inevitabilmente anche degli interrogativi profondi: cosa accadrebbe se la capacità di “scrivere la vita” finisse nelle mani sbagliate? Proprio in vir-

SCRIVERE LA VITA
IL DNA UMANO SINTETICO
Tra rivoluzione e rischio etico un progetto di ricerca britannico vuole creare il primo cromosoma da zero
tù di queste ragioni, parallelamente al lavoro degli scienziati, è prevista un’indagine che studi le implicazioni etiche e sociali della ricerca, guidata da esperti di sociologia, filosofia e bioetica.
La comunità scientifica è divisa: c’è chi vede in SynHG una rivoluzione simile a quella del Progetto Genoma Umano del 2003, e chi teme si stia varcando una soglia pericolosa, dove la scienza rischia di trasformarsi in una sorta di “ingegneria dell’uomo” in cui, a tutti gli effetti, si giocherebbe a fare Dio. Altri ancora, invece, sostengono che abbandonare questi
progetti non ne impedirà lo sviluppo, ma ne limiterà soltanto la trasparenza. La storia ci ha insegnato che ogni grande innovazione ha portato con sé un uso che ne ha determinato la sua natura, e che il compito della società e del singolo individuo è sempre stato, e dovrà essere, quello di produrre opportunità e non rischi.
Un concetto banale, scontato da ripetere; ma lo è meno se si pensa al numero di fallimenti etici annoverati nella storia del genere umano in anni e anni di “progresso”. Scrivere la vita sarà forse possibile, ma saremo pronti a leggerne le conseguenze? (M. O.).
©Gorodenkoff/shutterstock.com

Le pagine dei testi medievali sono zeppe di dati relativi a esseri umani e animali Dal loro studio una miniera di informazioni preziose e sorprendenti sul nostro passato
IL DNA NEI LIBRI ANTICHI
Oltre che per il contenuto dei loro scritti, le pagine dei libri antichi rappresentano una miniera inesauribile di informazioni e testimonianze anche sotto un altro punto di vista: contengono infatti innumerevoli tracce di DNA. I testi medievali soprattutto, scritti a mano dai monaci amanuensi su libri costituiti da pelli di animali e toccati, smaneggiati, finanche baciati da un enorme numero di persone nel corso degli anni e dei secoli, costituiscono uno degli oggetti privilegiati d’indagine di Matthew Collins, professore dell’Università di Cambridge e dell’Università di Copenaghen, che in passato ha insegnato anche alla York University dove ha fondato BioArCh, uno speciale dipartimento che mette insieme le competenze provenienti da tre scienze diverse: biologia, archeologia e chimica. Non solo libri, in ogni caso: tra le sue ultime ricerche c’è “Dietro la maschera – Analisi archeometrica di quattro maschere mummiche romano-egizie dorate provenienti dalla Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen”.
Il professor Collins è una delle massime autorità mondiali di una specifica branca della biologia, una delle infinite possibilità di applicazione della scienza che studia la vita: l’archeologia biomolecolare. Di cosa si tratta? Dell’applicazione di tecnologie biomolecolari allo studio e alla conservazione di materiali biologici provenienti da siti, contesti e reperti archeologici, in particolare per quel che è relativo all’analisi del DNA estratto da resti umani, animali e vegetali.
Tornando ai libri, è straordinario quel che l’accademico inglese e altri ricercatori irlandesi, francesi e statunitensi hanno scoperto alcuni anni fa a proposito dei Vangeli di York, dei volumi sacri della Chiesa d’Inghilterra prodotti nel X secolo su libri e pergamene scritti su pelli di vari animali: mucche e cervi soprattutto, ma anche pecore, capre e daini. Ancora oggi gli Arcivescovi di York li usano per far giurare fedeltà alla chiesa Anglicana baciandone le pagine e contribuendo, inconsapevolmente, all’arricchimento del DNA depositato sulle stesse.
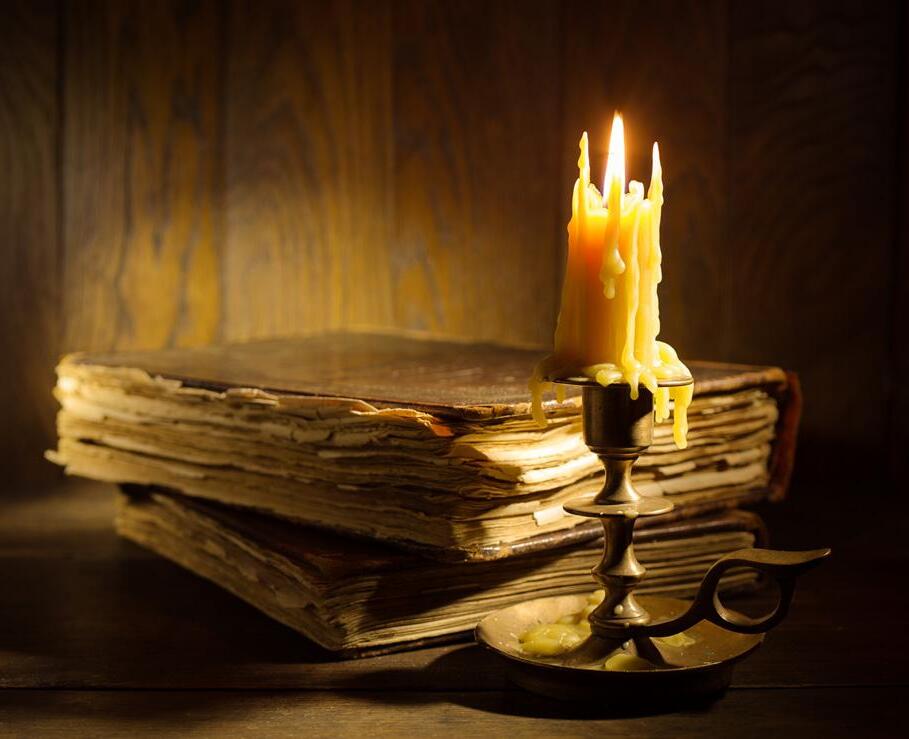
L’anno di realizzazione di ogni singolo manoscritto ha consentito di seguire e mappare l’evoluzione di batteri come lo Staffilococco aureo, che prolifera nel naso ed è coinvolto in diverse infezioni del tratto respiratorio, e del Propionibacterium, che invece è legato a eruzioni di acne
L’idea di indagare questi testi antichi - «una sorgente inimmaginabile di informazioni biologiche, una cassa piena di dati molecolari», come sottolineato da Collins in un articolo pubblicato sul giornale scientifico Royal Society - è nata curiosamente da un fallimento: la difficoltà a estrarre DNA dalle ossa di reperti animali trovati durante gli scavi di un accampamento vichingo nel nord dell’Inghilterra. Se
le minuziose analisi di questo materiale avevano consentito di estrarre un po’ di dati solo da sette ossa, lo studio dei volumi conservati nelle vicine biblioteche ha portato alla luce un’incredibile serie di informazioni. E non c’è stato neppure bisogno di organizzare lunghe e costose campagne di scavo: solo di strofinare le pagine dei testi medievali con un cancellino, una per una, catalogando con cura tutte le operazioni effettuate sulle migliaia di libri, manoscritti e pergamene oggetto di indagine. I risultati ottenuti sono stati sorprendenti. Ad esempio, il lavoro di Collins e della sua squadra di ricerca ha consentito di tracciare migrazioni umane e di mandrie di animali, di ricostruire l’evoluzione delle tecniche amanuensi, di risalire ai virus di cui soffrivano le popolazioni in uno speciale periodo storico, ma anche di esaminare le corrispondenze tra carestie, pestilenze e specifici eventi con le coeve opere letterarie. Dallo studio dei già menzionati Vangeli di York è emersa una probabile moria di cervi che deve aver afflitto le isole britanniche intorno al 1200 e che è stata risolta solo con l’importazione di un’altra specie di cervi dal continente, complice l’invasione normanna. Preziose anche le informazioni relative alle infezioni virali delle persone che maneggiavano le pagine dei testi. L’anno di realizzazione di ogni singolo manoscritto ha consentito di seguire e mappare l’evoluzione di batteri come lo Staffilococco aureo, che prolifera nel naso ed è coinvolto in diverse infezioni del tratto respiratorio, e del Propionibacterium, che invece è legato a eruzioni di acne. Lo stesso DNA degli insetti che hanno corrotto le pagine ha arricchito il livello di conoscenza su alcuni aspetti cruciali: le analisi eseguite su un libro dei Vangeli di Luca, in particolare, ha consentito di localizzarne la produzione in un monastero del Nord Europa, piuttosto che in uno dell’Europa meridionale come si riteneva erroneamente. Questo perché il DNA dei vermi che hanno danneggiato alcune pagine è riconducibile a un particolare tipo di tarlo del legno, l’Anobium punctatum, caratteristico della Gran Bretagna e della Scandinavia. Insomma, se Collins e i suoi collaboratori stanno esaminando il vasto patrimonio librario britannico, chissà quante informazioni preziose potrebbero emergere dallo studio meticoloso e dall’analisi, effettuata con le tecniche dell’archeologia biomolecolare, di tutti i libri conservati in Italia e nel resto d’Europa. La sfida è lanciata. E le informazioni emergenti da questi studi potrebbero rivelarsi cruciali. (R. D.).

Capolavoro del tennista altoatesino nel torneo più prestigioso del mondo Battuto in finale il rivale Alcaraz, che lo aveva rimontato e sconfitto 35 prima a Parigi
«Niente, e dico niente, è paragonabile alla vittoria a Wimbledon». Parole di André Agassi, leggenda del tennis. Ma sono tante le citazioni che fotografano il torneo di tennis più prestigioso del mondo o meglio le traduzioni, perché nessun italiano - fino alla sera del 13 luglio 2025 - poteva spiegare cosa significa vincerlo. Poi è arrivato Jannik Sinner, 23 anni, numero 1 del mondo, classe e garbo da vendere, a cesellare una pagina di storia nuova, in un libro senza capitoli “azzurri”.
L’italiano atipico si è preso con perfezionata classe ed elegante determinazione l’edizione numero 138 dei Championships, baciando quel trofeo solo sfiorato quattro anni fa da Matteo Berrettini, sullo stesso campo che dodici mesi prima avevano visto Jasmine Paolini fermarsi a un passo dal successo in campo femminile. L’ha fatto costringendo alla resa il grande rivale, Carlos Alcaraz, che del “Mondiale del tennis” - qual è considerato il torneo di Wimbledon - aveva vinto le ultime due edizioni e le ultime 20 partite disputate. E che 35 giorni prima aveva rimontato e battuto al quinto set il campionissimo altoatesino nella finale del Roland Garros a Parigi, dopo aver annullato tre palle break consecutive nel quarto di cinque infiniti set.
«Quando ero piccolo, Wimbledon era il sogno dei sogni, perché questo torneo sembra così lontano da dove vengo io. Adesso sto vivendo il mio sogno» le parole del simbolo gentile e potente dello sport italiano, dopo aver ricevuto l’ambita coppa dalle mani della principessa Kate Middleton.
Il cammino di Sinner è stato quasi immacolato. Con un brivido, al quarto turno contro l’imprevedibile e talentuoso Dimitrov. Complice una caduta con botta al gomito nel primo game, l’italiano era sotto di due set e 2-2 contro il bulgaro, autore di una prestazione da stropicciarsi gli occhi. Fino all’infortunio, una lesione al pettorale
destro, che ha portato Dimitrov al ritiro. Ma Jannik è tornato dirompente contro Shelton e con il sette volte re di Wimbledon, Novak Djokovic (“giustizieri” rispettivamente di Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli), entrambi spazzati via in tre set dall’altoatesino. Infine, la finale con Alcaraz. Iniziata bene o, comunque, meglio del rivale, primo a cedere il servizio. Virata verso lo spagnolo, vincitore del primo set grazie a due break di fila (64). Svoltata definitivamente da Sinner a partire dall’ultimo game del secondo set, capolavoro di tecnica e di carattere, con colpi di manuale.

«Quando ero piccolo, Wimbledon era il sogno dei sogni, perché questo torneo sembra così lontano da dove vengo io. Adesso sto vivendo il mio sogno» - le parole del campione Sinner dopo aver ricevuto l’ambita coppa dalle mani della principessa Kate Middleton
Fra le parole chiave usate per raccontare il successo di Sinner c’è “coraggio”, sottolineata da ex atleti e commentatori sportivi fra cui Adriano Panatta, «perché per vincere questi match il coraggio serve e lui ‘ha dimostrato in certe parti del match». Come la seconda di servizio a 175 km orari sul set point Alcaraz nel primo set, poi vanificata da un doppio fallo e da un clamoroso rovescio in back dello spagnolo. Come l’intero game successivo, con break immediato (e decisivo) nel
secondo set. Coraggio e classe, il mix che ha portato Sinner a cercare e trovare un ace sulla seconda palla sul 3-4, 30 pari nel terzo set.
E a forzare ancora una volta la seconda sul 4-3, 15-40 nel quarto parziale, annullando la prima di due palle break per Alcaraz, in un momento cruciale per la sua corsa al trono. Fra le altre epifanie del coraggio di Jannik, coach Simone Vagnozzi ha ricordato in un’intervista anche la risposta con il rovescio lungo linea su un break point.
Come a Parigi, sono arrivati tre match poi. Stavolta sul servizio di Sinner. Annullato il primo, a segno il secondo, grazie a un’inesorabile prima di servizio. Jannik ha allargato le braccia e il sorriso, ha abbracciato Alcaraz, esemplare nell’accettare il risultato e complimentarsi con l’amico-rivale. Si è piegato sulle ginocchia, poggiandosi alla racchetta e ha dato qualche pacca alla “sacra erba” londinese, come fosse la spalla di un vecchio amico.
Poi il cerimoniale, l’incontro con la famiglia reale inglese («Sei un’ispirazione per tutti noi», gli ha detto la principessa Kate) e infine anche il ballo con Iga Swiatek, regina del torneo femminile. Per Sinner quarto torneo Slam, ventesimo titolo Atp e un messaggio a se stesso e al mondo: anche dalle delusioni più grandi si può uscire più forti. Se poi si è già numeri 1, il risultato è un’altra meravigliosa pagina di storia.
Fognini, un addio di gran classe Italiani da applausi a Wimbledon. Non solo per il vincitore, Jannik Sinner, e per i talentuosi outsider Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego Con una splendida prestazione contro Carlo Alcaraz, bicampione uscente, si è conclusa al primo turno sul Centre Court la carriera di Fabio Fognini, ex numero 9, riferimento per l’attuale generazione di talenti italiani. Costellate di giocate sopraffine, la sfida è durata cinque set, oltre quattro ore e si è conclusa con un’ovazione. Il modo migliore per congedarsi.
© Raffaele Conti 88/shutterstock.com

ATLETICA LEGGERA L’ITALIA SI CONFERMA REGINA D’EUROPA
I successi dei big Fabbri, Battocletti e Iapichino sospingono gli azzurri verso il primo posto Applausi anche per i giovani. A settembre i Mondiali
Grandi nomi ma anche gradite sorprese: l’Italia dell’atletica leggera si è confermata regina degli Europei a squadre, andati in scena a Madrid a inizio estate. Trascinato da Leonardo Fabbri, Nadia Battocletti e Larissa Iapichino, vincitori delle rispettive prove, e con il contributo dei vari Folorunso, Biasutti, Simonelli, Pernici, Desalu, Furlani, Saraceni, Coiro e della staffetta mista 4x400m, ma anche di chi il podio l’ha solo sfiorato, il team azzurro ha rimontato e battuto la Polonia e la Germania. Segnali positivi in vista dei Campionati del Mondo in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre prossimi. Attesa protagonista degli Europei a squadre, Nadia Battocletti non si è fatta desiderare. La fuoriclasse trentina del mezzofondo, argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha confermato perché fosse la favorita nei 5000 metri, controllando le rivali per poi imprimere l’accelerazione decisiva nell’ultimo giro e mezzo. Seicento metri troppo “esagerati” per tutte le altre. Per una conferma, anche due sorprese in casa azzurra, nella seconda giornata della rassegna continentale a squadre. Senza il bronzo olimpico di Parigi Andy Diaz, è stato Simone
Biasutti a portare a casa una medaglia con la misura di 16,94, superata solo all’ultimo salto dal francese Seremes. Si è superato anche Francesco Pernici negli 800 metri, pur cedendo di un soffio nella volatona con Mohamed Attaoui.
Giù dal podio, quarte, sia Elisa Molinarolo nell’asta sia Anna Polinari nei 400 metri, con la seconda prestazione italiana all-time. Stesso risultato, con primato personale nel giro di pista, per Edoardo Scotti. Quinto posto per la primatista italiana dei 100m e argento nei 60m ai recenti Mondiali indoor, Zaynab Dosso, alla sua seconda gara verso Tokyo 2025.
La terza giornata degli Europei ha visto l’Italia volare al comando della classifica degli Europei a squadre, malgrado risultati in chiaroscuro. Ci si aspettava l’exploit del ventenne Mattia Furlani nel salto in lungo, ma i riscontri migliori sono arrivati dai meno attesi diciannovenni Matteo Sioli nel salto in alto ed Erika Saraceni nel salto triplo. Furlani ha pagato tre nulli negli ultimi tre salti, nei quali non è riuscito a tornare davanti allo svedese Montler, né tanto meno a rimontare un immenso Tentoglou, due volte campione olimpico, vincitore con la misura di 8,46 metri.
negli 800 metri ha ottenuto il massimo possibile finendo terza.
L’Italia ha portato fieno utile nella cascina della classifica generale anche con i quarti posti di Sara Fantini, campionessa d’Europa in carica, nel martello, Giada Carmassi nei 100m ostacoli, la staffetta 4x100 femminile (Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Zaynab Dosso) e Alessandro Sibilio, malgrado il momento non felicissimo, nei 400m ostacoli.
A mettere il sigillo sul successo dell’Italia sono stati due dei big più attesi, entrambi fiorentini: Leonardo Fabbri nel getto del peso e Larissa Iapichino nel salto in lungo. Fabbri ha dominato la propria gara, arrivando alla misura migliore di 21,68 all’ultimo tentativo. A stretto giro, ecco Larissa risalire dall’ottavo posto di inizio prova al gradino più alto del podio, con un balzo a sei metri e 92 centimetri. Un successo che ha reso matematico l’oro della squadra azzurra. Firma importante sul risultato nella giornata finale, è stata anche quella di Eseosa Desalu, secondo con la sua miglior prestazione stagionale nei 200m uomini.

© ErreRoberto/shutterstock.com
Assente Gianmarco Tamberi, rientrato poi senza brillare al Golden Gala, è stato Matteo Sioli a far brillare l’azzurro nel salto in alto. Avvincente il “triello” col tedesco Potye e il ceco Stefela, unico a superare 2,30 metri (e pure, poi, 2,33) mentre l’azzurro si è fermato a 2,27. Debutto clamoroso per la neoprimatista italiana junior Erica Saraceni, altra classe 2006, bronzo nel triplo grazie al suo nuovo personale e nuovo primato U20 (14,08m).
Buone notizie, dunque, per l’atletica leggera italiana in vista dell’appuntamento principe della stagione, rappresentato dai Campionati del mondo 2025 in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. In Giappone l’Italia confida di ritrovare un Mattia Furlani più in “palla” e il miglior Gianmarco Tamberi, unico oro azzurro a Budapest 2023. In Ungheria, andarono a medaglia anche Leonardo Fabbri e la staffetta 4x100m maschile, argento, e Antonella Palmisano, bronzo nella 20 km di marcia.
A mettere il sigillo sul successo dell’Italia sono stati due dei big più attesi, entrambi fiorentini: Leonardo Fabbri nel getto del peso e Larissa Iapichino nel salto in lungo. Larissa risale dall’ottavo posto di inizio prova al gradino più alto del podio, con un balzo a sei metri e 92 centimetri
Pur lontano dal suo primato nazionale, Lorenzo Simonelli è uscito comunque dalla gara dei 100 ostacoli con un bel risultato, un secondo posto immediatamente alle spalle dello svizzero Joseph. A proposito di ostacoli, Ayomide Folorunso era considerata la favorita dei 400m ma è stata superata sul rettilineo finale dalla portoghese Binta Diallo. A podio anche Elisa Coiro, che
Punto interrogativo su Marcell Jacobs, il cui rientro in Finlandia non è stato all’altezza delle aspettative, facendo modificare anche il piano di avvicinamento alla rassegna iridata. Non vanno dimenticate, naturalmente, le chance del triplista Andy Diaz, bronzo ai Giochi di Parigi 2024 e campione del mondo indoor quest’anno, stessi exploit ottenuti sui medesimi palcoscenici da Furlani. (A. P.).

BASKET, AZZURRE DI
BRONZO DOPO 30 ANNI
Zandalasini trascina le ragazze del ct Capobianco, battuta la Francia. A settembre tocca gli uomini contro la Spagna
Un bronzo dolce e un po’ amaro per le ragazze, un’edizione tutta da vivere per i ragazzi. È un’estate di ambizioni continentali per la pallacanestro azzurra, impegnata con le due Nazionali nei rispettivi Campionati europei. Solo un canestro da tre nel finale della sfida col Belgio, poi vincitore della rassegna, ha tolto l’Italbasket femminile il pass per una storica finale con la Spagna, a trent’anni dall’argento di Brno. Il 64-66 in semifinale, fissato sul tabellone malgrado la rimonta azzurra dell’ultimo quarto (parziale di 17-0 e vantaggio di due punti a 26 se-
condi dal termine), è stato l’unico neo di un’edizione - appunto - quasi perfetta per la stella Cecilia Zandalasini e le sue compagne. Nessuna esitazione nei tre match del girone B disputate a Bologna: piegata 70-61 la Serbia nel match inaugurale, poi 77-66 la Slovenia grazie a un super secondo quarto, quindi 65-61 la Lituania. Ben più tirato e incerto il quarto di finale con la Turchia, al Pireo di Atene.
Avanti in avvio, sotto all’intervallo (31-35), le azzurre sono precipitate a -9 prima di rimontare, allungare e farsi raggiungere su una palla perse a un respiro dalla fine. All’overtime 6
punti di Cubaj, canestro della vittoria di Zandalasini (76-74) e poi “tripla” sbagliata dalle turche sulla sirena. Seconda miglior difesa nei gironi, il Belgio ha a lungo imbrigliato le azzurre in semifinale: vana e illusoria la reazione nell’ultimo quarto di gara, concluso da una tripla di Verona sul ferro.
Le ragazze del ct Andrea Capobianco (premiato come miglior tecnico del torneo) sono state però bravissime a reagire e prendersi il bronzo, sconfiggendo per 69-54 la Francia. Decisivi i due parziali centrali del match, nei quali l’Italia è volata sul +8 (53-45) per poi mantenere la barra dritta fino alla fine. Su tutte Zandalasini con 20 punti, efficaci anche Verona con 11 e Cubaj con 10. Prossimo appuntamento per le azzurre, a marzo, è il torneo premondiale che qualifica al Campionato del Mondo nel settembre 2026 in Germania.
Gli Europei maschili di basket sono invece in programma fra Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia dal 27 agosto al 14 settembre prossimi, con fasi finali a Riga. E promettono spettacolo, vista la presenza di diverse stelle del campionato Nba, il più impegnativo e prestigioso del mondo. Dallo sloveno Luka Doncic al greco Giannis Antetokoumpo, dal lettone Kristaps Porzingis al tedesco Franz Wagner fino al finlandese Lauri Markkanen, ala degli Utah Jazz, e all’italiano Simone Fontecchio, fresco di passaggio dai Detroit Pistons ai Miami Heat.
Girone non semplice a Limassol per l’Italia, che debutta il 28 agosto alle 20.30 italiane con la Grecia di Antetokoumpo, per poi tornare in campo con la Georgia sabato 30 (ore 14) il 31 con la Bosnia Erzegovina domenica 31 (ore 20.30), la Spagna detentrice del titolo martedì 2 settembre (ore 20.30) e l’abbordabile Cipro giovedì 4 settembre (ore 17.15). Passano in quattro, per incrociarsi con il girone D che ospita Francia, Slovenia, Polonia, Israele, Belgio e Islanda. Ci sarà da divertirsi. E da “soffrire”, sportivamente parlando. (A. P.).
Da uno scattante scalatore a un potente velocista, da un elegante “cavaliere” della Tripla Corona (capace cioè di vincere in carriera Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a Espana) a un campione olimpico e iridato su pista. Sei anni, 113 giorni: tanti ne sono passati dal successo di Vincenzo Nibali a Val Thorens a quello di Jonathan Milan a Laval, il digiuno più lungo del ciclismo italiano al Tour.
Milan, cinque lettere che a livello internazionale sono state a lungo associate a vittorie e spettacolo, anche se in campo calcistico. Da qualche anno, però, queste lettere nello stesso ordine sono il cognome dell’astro nascente dello sprint italiano. Sbocciato su pista. Olimpionico del quartetto nel 2021, iridato dell’inseguimento individuale nel 2024 con il record del mondo, Jonathan si era saputo distinguere su strada già al Giro d’Italia 2023 e 2024, aggiudicandosi quattro tappe e due maglie ciclamino a punti. E neppure alla Grande Boucle non si è fatto attendere. O, forse, solo un po’. Nella terza tappa, a Dunkerque, Milan il successo l’ha solo sfiorato, battuto da un altro asso delle volate quale il belga Tim Merlier. Una maledizione italiana? Per fortuna no. C’è voluto qualche altro giorno d’attesa: il 12 luglio “Johnny” si è preso l’ottava tappa, davanti a Wout Van Aert e Kaden Groves, interrompendo il sortilegio. Un digiuno che suona davvero insolito e indigesto, nella corsa che ci ha visti protagonisti nell’albo d’oro con nomi del calibro di Bottecchia, Bartali, Coppi, Gimondi, Nencini e Pantani, oltre a quel Nibali che del Tour de France ha vinto la classifica generale nel 2014 e ben sei tappe, l’ultima delle quali nel luglio 2019 a Val Thorens. A quell’edizione della Grande Boucle, la 106esima, risale anche l’ultima tappa con un italiano in maglia gialla, Giulio Ciccone, l’ottava di 200 km fra Mâcon e Saint-Étienne, il 13 luglio. Prima di lui, erano stati 29 i connazionali a ri-

MILAN ROMPE IL DIGIUNO
AZZURRO AL TOUR
Il successo di “Johnny” a Laval ha posto fine a un sortilegio che durava da sei anni e 113 tappe
uscirci. Dopo, nessuno. Due anni fa l’abruzzese si è riaffacciato fra i primi tre della classifica generale, dopo il secondo posto nella frazione pirenaica Pau-Laruns, in un’edizione che l’ha visto conquistare la maglia a pois di migliore scalatore.
In quattro, oltre a Milan, hanno sfiorato il successo di tappa dopo Nibali e prima che lo stesso Milan ci riuscisse. Al Tour de France 2021 c’erano andati vicini uno splendido Mattia Cattaneo a Tignes, secondo anche se staccato di oltre 5’ da Ben O’ Conner e con il campione d’Italia Sonny Colbrelli terzo, e lo stesso Tricolore a Saint-Gaudens,
preceduto solo da un risoluto Patrick Konrad. L’anno dopo, secondo posto per Alberto Bettiol a Mende, dopo aver condotto in solitaria una 14esima tappa poi andata a Michael Matthews, in rimonta. Quindi è toccato a Ciccone, secondo nella frazione numero 5 del Tour 2023 alle spalle di Jai Hindley. Dopo Laval, Milan ha sfiorato l’immediata doppietta a Châteauroux, rimontato nei metri finali da Merlier. Ma ha consolidato la sua leadership nella classifica a punti, davanti a un Tadej Pogacar dichiaratamente ingolosito non solo daal trionfo assoluto, ma anche dalla maglia verde. (A. P.).
NON VOLEVO MORIRE MA NON SAPEVO PIÙ
COME SI FACEVA A VIVERE
Il disturbo bipolare spiegato attraverso la testimonianza di chi l’ha vissuto
di Anna Lavinia
Alessandra Arachi Lunatica
Solferino, 2025 – 16,50 euro
Il 30 marzo 1853 in una piccola cittadina olandese nasceva Vincent Van Gogh e molti anni dopo, in questo stesso giorno di primavera, le persone si sono riunite per celebrare la Giornata mondiale del disturbo bipolare. Una drammatica vita in “altalena” è quella che ha vissuto il genio dell’arte ed è quello che milioni di persone in tutto il mondo sperimentano quotidianamente.
Tra questi c’è Alessandra che in un giovedì sera di ottobre decide di porre fine alla sua vita con una sostanza inodore, incolore ed insapore, il monossido di carbonio. Fino a quando la sua macchina parcheggiata in mezzo al nulla attira l’attenzione di Stefano (in special modo quella di Pisolo, il suo cane) che la nota e la salva. «Non volevo morire, quel giorno. Ma non sapevo più come si faceva a vivere» - scrive Alessandra Arachi, giornalista, autrice e protagonista di questo drammatico episodio. In qualche modo, nonostante i presupposti sfavorevoli, riesce a sopravvivere.
Qualcuno l’ha strappata alla morte, è viva e può raccontare a tutti la sua esistenza alle prese con il disturbo bipolare. Sembra strano
ma non è l’unica cosa folle di questa cruda e struggente storia. Autostrade contromano, spese pazze e manie di persecuzione. Tutto è reale nei disturbi psichici e tutto deve essere preso seriamente. In questo senso, è particolarmente necessaria una nota di comprensione da parte di medici e familiari ma anche se la maggior parte delle volte c’è non è del tutto percepita da chi sta soffrendo.
Una spinta di coraggio e un pizzico di ironia sono i propulsori di questo racconto autobiografico che mette nero su bianco il dolore, il disagio e la vergogna di chi lo abita da dentro e di chi lo guarda da fuori: il disturbo bipolare. Non è come le altre, questa patologia ti porta «al culmine della felicità e a quello della disperazione». C’è un alternarsi di fasi depressive con calo dell’umore, insonnia, pensieri autodistruttivi e di fasi ipomaniacali caratterizzate invece da un miglioramento dello stato d’animo con tendenza euforica ed espansiva.
È come se la mente di una persona fosse “abitata” da un polo Nord e un polo Sud a momenti alterni che ad un certo punto esplodono causando situazioni complesse e complicate da

definire. Spesso inspiegabili agli occhi degli altri. Da fuori non è semplice distinguere questa condizione, anche la scienza ha provato a farlo ma non sempre ci è riuscita.
Ad esempio, la rivista Nature ha raccontato della creazione di un test ematico in vitro in grado di diagnosticare il disturbo bipolare distinguendolo dalla depressione unipolare per dare agli psichiatri l’opportunità di formulare diagnosi più corrette e in poco tempo. Anche se la cura è la vera svolta per questa condizione, la terapia non deve fermarsi ai farmaci che servono ma non bastano. Occorre un adeguato supporto psicologico e una psicoeducazione che insegni a riconoscere i sintomi e a capire quando la malattia va fermata.
Chi lotta con le difficoltà e le paure di una malattia mentale non ha un semplice “problema da risolvere” ma un muro di solitudine da abbattere. Costantemente alla ricerca di un supporto che accoglie e non giudica, che ascolta e non tace. E qui, l’autrice fa proprio questo: grida a gran voce il suo dolore e fa appello alla speranza affinché si possano liberare le persone dalla sofferenza, certo che si può fare.
Hirac Gurden
Sentire il mondo
Touring, 2025 – 24,00 euro
Il pane appena sfornato, il caffè che straborda dalla caffettiera o una goccia di benzina che tocca l’asfalto. Alcuni odori hanno la strana capacità di emozionarci e di catapultarci in un attimo in tempi lontani. La strana relazione tra l’olfatto e il nostro cervello viene indagata in questo volume che ascolta il misterioso linguaggio degli odori. (A. L.).

Kathy Willis
La natura che cura
Aboca edizioni, 2025 – 28,00 euro
Uno studio ha rivelato che i pazienti che dopo un intervento guardavano gli alberi dalla finestra della loro stanza di ospedale miglioravano tre volte più velocemente. Vedere, annusare, toccare ed ascoltare le piante ci rende sani, felici e longevi. Lo conferma la scienza e lo sperimenta l’autrice del libro con i suoi consigli. (A. L.).
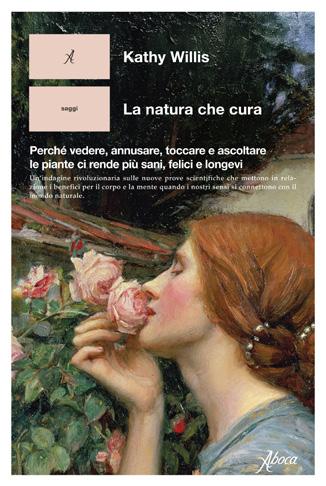
V. Gallese, S. Moriggi, P. C. Rivoltella
Oltre la tecnofobia
Raffaello Cortina Editore, 2025 - 16,00 euro
Alle nuove tecnologie e al mondo digitale è strettamente correlata la condivisione ma l’altra faccia della medaglia è già sul banco degli imputati: la soggettivazione a discapito della socialità. Tra fake news e deduzioni troppo affrettate, gli studiosi fanno i conti con le sfide del progresso e delle nuove generazioni. (A. L.).



Lunedì 4 agosto 2025 presso la suggestiva sede della Lega Navale di Sciacca verrà presentato il libro “Cibo che cura”, frutto del lavoro di tutta l’U.O.S.D. di Oncologia dell’ospedale di Sciacca, diretta dal Dr. Domenico Santangelo e soprattutto dall’annesso ambulatorio di nutrizione clinica gestito dai colleghi Matteo Pillitteri, Dario Incorvaia e Roberta Piccione, rivolto ai pazienti oncologici.
L’ambulatorio è attivo dal 13/02/2023 con oltre 900 accessi (ad oggi) e rappresenta una importante realtà nel panorama oncologico siciliano, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali (PDTA nutrizione).
I proventi derivanti dalla vendita di tale libro, acquistabile in libreria o su Amazon, saranno devoluti alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) e destinati alla creazione di una o più borse di studio per giovani biologi interessati a formarsi e operare nel campo della nutrizione clinica in oncologia, promuovendo così la crescita di nuove figure professionali competenti e qualificate in un ambito tanto delicato quanto strategico per il benessere del paziente oncologico.

BATTERI CHE MANGIANO PLASTICA: UNA MINACCIA PER I DISPOSITIVI MEDICI?
Questa capacità permette ai patogeni di sopravvivere a lungo in ambienti ospedalieri
Molti dei dispositivi medici impiantabili sono formati da plastica: cateteri e tubi endotracheali per ventilatori realizzati in cloruro di polivinile (PVC), pacemaker che contengono poliuretano (PU), impianti vascolari in politereftalato di etilene (PET) e ancora reti chirurgiche e suture di polipropilene (PP) e policaprolattone (PCL) biodegradabile. Tutti questi impianti sono esposti al rischio di contaminazione batterica e possono causare infezioni, anche gravi e difficili da trattare [1,2].
Il policaprolattone (PCL), per esempio, è un poliestere sintetico in uso fin dagli anni ‘50 e trova impiego in numerose applicazioni mediche, tra cui suture, otturazioni dentali e filler dermici stimolatori di collagene. È spesso preferito ad altri polimeri plastici per via delle sue proprietà viscoelastiche, della bassa temperatura di fusione, dell’elevata biocompatibilità e versatilità, che ne consente la miscelazione con copolimeri e la lavorazione tramite stampa 3D. Inoltre, è biodegradabile, biocompatibile e bioriassorbibile.
Poiché può essere “caricato” con farmaci terapeutici, come antimicrobici o composti che favoriscono la guarigione, viene utilizzato anche per le medicazioni delle ferite, favorendone l’uso come substrato per applicazioni di rilascio controllato di farmaci. Inoltre, viene utilizzato anche in applicazioni di ingegneria tissutale, inclusi gli
* Comunicatrice scientifica e Medical writer
scaffold ossei, evidenziando il suo ruolo sempre più rilevante negli interventi medici innovativi [3,4].
Alcuni batteri ambientali sono dotati di enzimi che gli conferiscono la capacità di degradare diversi tipi di plastica come il PET e il PCL. Questi enzimi, infatti, sono in grado di rompere polimeri naturali ma questo loro potenziale è attualmente oggetto di studio nei batteri responsabili di infezioni cliniche.
La degradazione di un impianto medico da parte di un patogeno comprometterebbe l’integrità di tali dispositivi e favorirebbe la creazione di nicchie più profonde per la colonizzazione, complicando il trattamento dell’infezione. Inoltre, i patogeni possono sfruttare la plastica come fonte di carbonio per sostenere la loro crescita, prolungando così la loro persistenza sulle superfici ospedaliere con un aumentato rischio di colonizzazione e infezione dell’ospite.
Un gruppo di ricercatori della Brunel University di Londra ha recentemente condotto un’analisi genomica sui patogeni umani per individuare potenziali omologhi di geni noti per la degradazione della plastica. Tra i risultati, è stato identificato un nuovo enzima in grado di degradare il PCL, presente in un ceppo di Pseudomonas aeruginosa isolato da una ferita.
I ricercatori hanno inoltre osservato che la presenza di PCL induce un significativo aumento nella formazione di biofilm, un importante fattore di virulenza associato al fallimento dei trattamenti di prima linea, e può contribuire a un incremento della virulenza in vivo [5].

Pap1, il gene che aiuta i patogeni a sopravvivere sulla plastica
I ricercatori hanno analizzato diverse specie patogene alla ricerca degli omologhi di 23 enzimi noti per degradare i poliesteri. Questi enzimi sono presenti nel database PAZy, una banca dati che raccoglie esclusivamente quelli attivi sulla plastica. L’analisi delle sequenze genomiche ha individuato 871 corrispondenze con questi enzimi, ma sono state selezionate solo 94 proteine, in quanto appartenenti a 15 specie patogene isolate da campioni clinici, come sangue e ferite.
Tra queste, due proteine di tipo carbossilesterasi B isolate da ceppi di Streptococcus pneumoniae da campioni nasofaringei in Thailandia, hanno mostrato un’identità superiore al 60% rispetto alla poliesterasi funzionale BsEstB. Un’altra proteina, un’idrolasi alfa/beta, isolata da una ferita infettata da Pseudomonas aeruginosa nel Regno Unito, ha mostrato una copertura dell’87% e un’identità del 61,76% con l’enzima PET5, precedentemente caratterizzato per la degradazione dei poliesteri.
La costruzione dell’albero filogenetico che include tutte le proteine identificate e gli enzimi noti per la degradazione dei poliesteri ha portato alla luce le loro strette relazioni evolutive. Questa analisi ha suggerito che il potenziale enzimatico per degradare la plastica è codificato nei genomi di una vasta gamma di patogeni clinicamente rilevanti [5,6].
Tra le proteine con un’identità di sequenza superiore al 60% è stata selezionata l’idrolasi alfa/beta, (evolutivamente correlata a molti enzimi noti per la degradazione della plastica) per poi essere espressa in un ospite di Escherichia coli e testata per la sua attività degradativa.
© Gorodenkoff/shutterstock.com
Fondamentale però è stato il reperimento dell’isolato clinico di origine, il ceppo Pseudomonas aeruginosa PAW23, che ha permesso di approfondire la caratterizzazione degli effetti della degradazione della plastica sul comportamento del patogeno. La proteina è stata denominata Pap1 (pathogen-associated polyesterase 1) e la sua somiglianza strutturale con le poliesterasi funzionali già note e i siti attivi coinvolti nella degradazione dei poliesteri, ne suggeriscono la funzionalità enzimatica [7]. Ma per valutarne l’effettiva funzionalità e capacità di degradare il PCL, il gene pap1 è stato clonato in un vettore di espressione e successivamente trasformato in un ceppo ospite di E. coli.
Poi è stato scelto un altro ceppo di E. coli come controllo e substrato modello nei test di degradazione dei poliesteri e saggi qualitativi e quantitativi per misurarne l’attività enzimatica. L’induzione dell’espressione di pap1 ha portato alla formazione di un’area di degradazione del PCL, confermando che la proteina Pap1 è effettivamente una poliesterasi funzionale. Come previsto, il controllo negativo non ha mostrato alcuna degradazione del PCL. Pap1 è classificata come una PETasi di tipo IIa, con l’eccezione di una sostituzione nel sito attivo I, dove il triptofano conservato è sostituito da una tirosina (Y172). Per valutare l’importanza di questo residuo non canonico, è stata prodotta una variante di Pap1 con la mutazione Y172W e confrontata con la versione originale in un test di degradazione del PCL. La mutazione ha ridotto l’attività degradativa, evidenziando l’importanza funzionale della tirosina in quella posizione e confermando Pap1 come enzima in grado di degradare il PCL [5,8].
I ricercatori hanno voluto dimostrare che Pap1 è fun -
zionale anche quando viene espresso eterologamente nel suo ospite E. coli, e che conserva la sua funzionalità nel suo patogeno nativo. Per lo scopo è stato utilizzato l’isolato clinico originario codificante pap1, Pseudomonas aeruginosa PA-W23, per testarne l’attività degradativa su un terreno contenente PCL.
L’area di degradazione è risultata più evidente rispetto a quella osservata in E. coli che esprimeva pap1, confermando che l’isolato clinico era in grado di degradare il PCL. Inoltre, osservate al microscopio, le particelle di PCL apparivano molto più piccole e con cavità profonde. Questo livello di degradazione dimostra come l’integrità strutturale dei dispositivi medici contenenti PCL, quali suture o impianti, possa essere seriamente compromessa dalla presenza di patogeni in grado di degradarlo. Successivamente, è stato valutato se il ceppo fosse in grado non solo di degradare, ma anche di metabolizzare il PCL.
È stato quindi condotto un saggio di crescita in terreno minimo contenente PCL come unica fonte di carbonio e utilizzando come controllo lo stesso terreno privo di carbonio. I risultati hanno confermato che Pseudomonas aeruginosa PA-W23 è in grado di utilizzare il PCL come unica fonte di carbonio. Questa capacità potrebbe permettere ai patogeni di sopravvivere a lungo all’interno dell’ospite o in ambienti ospedalieri, soprattutto in condizioni di scarsità di nutrienti.
L’introduzione di pap1 in un sito neutro del cromosoma di ceppi clinici che normalmente non degradano la plastica ha conferito loro l’attività di degradazione del PCL, confermando che l’attività di Pap1 può essere trasferita ad altri ceppi ospiti [5].
L’impatto sulla clinica
La scoperta del gene pap1 pone diverse sfide cliniche in merito alla gestione delle infezioni.
Dal punto di vista dell’ospite, la capacità di un patogeno di compromettere l’integrità strutturale di qualsiasi dispositivo medico o impianto contenente PCL potrebbe causare il fallimento dell’intervento. Dal punto di vista del patogeno, invece, la capacità di degradare la plastica potrebbe permettere al microrganismo di creare cavità all’interno dei dispositivi, sfuggendo così all’azione del sistema immunitario, dei disinfettanti o degli antibiotici.
Anche la capacità di utilizzare la plastica come fonte di carbonio è una preoccupazione importante perché potrebbe favorire la persistenza dei patogeni nell’ambiente ospedaliero. Per esempio attraverso la formazione del biofilm, la modalità di crescita che rende i batteri particolarmente resistenti ai trattamenti [5,9,10].
A quanto pare, i patogeni che codificano enzimi in grado di degradare la plastica sono meglio equipaggiati per sopravvivere sulle superfici utilizzando la plastica stessa
come fonte di crescita o degradandola per formare cavità, all’interno delle quali possono essere protetti dai tradizionali metodi di decontaminazione delle superfici [11].
La presenza di batteri degradanti la plastica nell’ambito sanitario non è inaspettata. Gli ospedali contengono grandi quantità di plastica e, nell’ambiente, l’abbondanza di geni per la degradazione della plastica è direttamente correlata alla diffusione dell’inquinamento. Questo suggerisce che l’esposizione alla plastica in ambito ospedaliero stia guidando l’adattamento e la diffusione di questi enzimi.
Il possesso di questi enzimi è un vantaggio per i patogeni e la loro selezione e diffusione sono destinate ad aumentare nel tempo. Esiste, inoltre, la minaccia rappresentata da alcune specie di batteri ambientali che possono essere considerati patogeni opportunisti e che potranno sviluppare la capacità di degradare la plastica nell’ambiente per poi sfruttarla in un contesto clinico [12].
Le infezioni urinarie a catetere o la polmonite asso -

ciata a ventilazione meccanica, sono ben note in ambito sanitario ed entrambe causate da P. aeruginosa. I pazienti affetti possono andare incontro a degenze ospedaliere prolungate, maggiore rischio di riammissione e aumentato rischio di batteriemia o mortalità. Se i batteri responsabili di queste infezioni fossero anche in grado di degradare il dispositivo stesso e di sopravvivere grazie ai prodotti di degradazione, il loro impatto in sanità acquisirebbe una grande rilevanza clinica [13].
Conclusioni
I patogeni umani e gli isolati clinici rappresentano un serbatoio di potenziali nuovi enzimi capaci di degradare la plastica, che potrebbero essere sfruttati per sviluppare soluzioni enzimatiche volte ad affrontare la crisi dei rifiuti plastici. La biodegradabilità del PCL è uno dei suoi principali vantaggi per l’uso in ambito sanitario, ma potrebbe essere anche il suo punto debole.
Nella progettazione dei dispositivi medici bisogne -

© sasirin pamai/shutterstock.com
rebbe considerare la possibilità che vengano degradati dal patogeno responsabile dell’infezione, complicando il trattamento. È possibile, ad esempio, aggiungere componenti antimicrobici ai dispositivi medici in PCL per ridurre il rischio di infezione e biodegradazione.
Alcuni studi sono già in corso, come l’uso di nanoparticelle di argento o di ossido di rame, oppure l’elettrofilatura (allungamento della struttura polimerica tramite alta tensione) del PCL con nanotubi di halloysite (argilla minerale) contenente eritromicina.
Bibliografia
1. Sastri, V.R. (2014). 1 - Introduction. In Plastics in Medical Devices, Second Edition, V.R. Sastri, ed. (Oxford: William Andrew Publishing), pp. 1–8
2. Rajendran, S., and Anand, S.C. (2020). 11 - Woven textiles for medical applications. In Woven Textiles, Second Edition, K.L. Gandhi, ed. (Woodhead Publishing), pp. 441–470
3. Koo, H.T., Oh, J., and Heo, C.Y. (2022). Cranioplasty Using Three-Dimensional-Printed Polycaprolactone Implant and Free Latissimus Dorsi Musculocutaneous Flap in a Patient with Repeated Wound Problem following Titanium Cranioplasty. Arch. Plast. Surg. 49, 740–744
4. Dwivedi, R., Kumar, S., Pandey, R., Mahajan, A., Nandana, D., Katti, D.S., and Mehrotra, D. (2020). Polycaprolactone as biomaterial for bone scaffolds: Review of literature. J. Oral Biol. Craniofac. Res. 10, 381–388
5. Howard SA, de Dios R, Maslova E, Myridakis A, Miller TH, McCarthy RR. Pseudomonas aeruginosa clinical isolates can encode plastic-degrading enzymes that allow survival on plastic and augment biofilm formation. Cell Rep. 2025 May 5:115650
6. Danso D, Schmeisser C, Chow J, Zimmermann W, Wei R, Leggewie C, Li X, Hazen T, Streit WR. New Insights into the Function and Global Distribution of Polyethylene Terephthalate (PET)-Degrading Bacteria and Enzymes in Marine and Terrestrial Metagenomes. Appl Environ Microbiol. 2018 Apr 2;84(8):e02773-17
7. Joo S, Cho IJ, Seo H, Son HF, Sagong HY, Shin TJ, Choi SY, Lee SY, Kim KJ. Structural insight into molecular mechanism of poly(ethylene terephthalate) degradation. Nat Commun. 2018 Jan 26;9(1):382
8. Howard SA, McCarthy RR. Modulating biofilm can potentiate activity of novel plastic-degrading enzymes. NPJ Biofilms Microbiomes. 2023 Oct 3;9(1):72
9. Liao, C., Huang, X., Wang, Q., Yao, D., and Lu, W. (2022). Virulence Factors of Pseudomonas Aeruginosa and Antivirulence Strategies to Combat Its Drug Resistance. Front. Cell. Infect. Microbiol. 12, 9267
10. Thi, M.T.T., Wibowo, D., and Rehm, B.H.A. (2020). Pseudomonas aeruginosa Biofilms. Int. J. Mol. Sci. 21, 8671
11. Vickery, K., Deva, A., Jacombs, A., Allan, J., Valente, P., and Gosbell, I.B. (2012). Presence of biofilm containing viable multiresistant organisms despite terminal cleaning on clinical surfaces in an intensive care unit. J. Hosp. Infect. 80, 52–55
12. Alwazzeh, M.J., Alkuwaiti, F.A., Alqasim, M., Alwarthan, S., and El-ghoneimy, Y. (2020). Infective Endocarditis Caused by Pseudomonas stutzeri: A Case Report and Literature Review. Infect. Dis. Rep. 12, 105–109
13. Judy, J., Baumer, D., and Khoo, C. (2021). Descriptive Analysis of Healthcare Resource Utilization and Costs Associated with Treatment of Urinary Tract Infections in United States Hospitals. Am. J. Infect. Control 49, S2

TATUAGGI TRA MODA E RISCHIO DI INFEZIONI
In aumento le complicanze immunologiche e infettive post trattamento
Un tempo, il tatuaggio era un segno culturale o simbolico, oggi è diventato un fenomeno molto diffuso: oltre il 40% degli adulti, in molte regioni del mondo, mostra almeno un disegno permanente sulla pelle. Anche il trucco permanente è ampiamente diffuso, come microblading, micropigmentazione, camouflage, che del tatuaggio tradizionale condivide strumenti e tecniche, ma a fini cosmetici. Si tratta sempre di deposizione di pigmenti esogeni nel derma, ma è bene considerare che dietro l’espressione estetica si nasconde una pericolosa minaccia per la salute.
Il tatuaggio, infatti, rappresenta un potenziale veicolo di complicazioni cliniche, anche gravi. Le prime segnalazioni di eventi avversi risalgono all’inizio del XIX secolo, quando venivano descritti i primi casi di infiammazione, febbre, sepsi e morte in seguito a tatuaggi. Già allora si intuiva il ruolo del tatuaggio nella trasmissione di infezioni batteriche, come la cancrena e la sifilide.
Oggi, le complicanze associate sono numerose e complesse: reazioni immunologiche, allergiche, tossiche e infettive, che si manifestano come vere e proprie patologie cliniche. La pratica del tatuaggio espone la cute al rischio microbiologico ed è un pericolo che merita attenzione e approfondimento da parte della sanità [1].
Le complicazioni e reazioni avverse correlate ai tatuaggi sono complesse e diversificate e si manifestano come veri e propri sintomi clinici. Gli effetti avversi sulla salute associati ai tatuaggi possono essere classificati in due categorie principali:
• complicazioni non infettive, come reazioni immunologiche o tossiche, incluse infiammazioni e reazioni allergiche, tumori o reazioni cancerogene;
• complicazioni infettive, che includono infezioni microbiche causate da batteri, virus, funghi e parassiti.
In genere, le persone tatuate si rivolgono al medico solo in caso di gravi complicanze. Di conseguenza, i tassi precisi di incidenza delle infezioni causate dai tatuaggi non sono disponibili. Alcuni studi hanno stimato che tra il 27% e il 68% delle persone tatuate sono state osservate conseguenze dopo il tatuaggio, anche solo un leggero sollevamento della pelle o prurito, mentre circa l’1–6% delle persone tatuate ha sviluppato infezioni microbiche [2,3].
Tipi di microrganismi e loro ricorrenza
Le infezioni legate ai tatuaggi possono essere causate da quattro categorie di microrganismi: batteri, virus, funghi e parassiti. Tra queste, le infezioni batteriche risultano le più frequenti, seguite da quelle virali e fungine. Il primo caso di infezione microbica da tatuaggio risale al 1820, ed era di origine batterica.
Da allora, le infezioni batteriche hanno continuato ad essere la maggior parte dei casi segnalati e la varietà delle
specie identificate è aumentata nel tempo: prima del 2000 si contavano solo 11 specie, oggi il numero è salito a 34. Questo incremento nella diversità delle specie potrebbe essere legato a un miglioramento delle tecniche diagnostiche, ma è utile anche per indicare un’evoluzione nel tipo di infezioni batteriche che possono insorgere in seguito a un tatuaggio. Le principali specie batteriche identificate nei casi di infezione da tatuaggio sono 4: Treponema pallidum (responsabile della sifilide), un gruppo di specie di micobatteri non tubercolari (NTM), un gruppo del complesso Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium bovis, e specie di Staphylococcus aureus.
Un tempo la malattia da sifilide veniva trasmessa principalmente attraverso la saliva dei tatuatori affetti da sifilide oppure tramite le attrezzature contaminate. Inizialmente, l’associazione tra tatuaggi e sifilide era così ampiamente riconosciuta che il tatuaggio veniva persino considerato un segno di sifilide. Con il tempo, i casi di trasmissione della sifilide associati ai tatuaggi sono diventati rari e, oggi, questi episodi sembrano appartenere solo alla storia. Solo nel 2010 è stato riportato un caso di lesioni da sifilide secondaria comparse all’interno di un tatuaggio. I micobatteri non tubercolari causano principalmente infezioni cutanee localizzate, manifestandosi come cellulite, ascessi o noduli, specialmente nel sito di inoculazione [4,5].
Le infezioni causate da Staphylococcus aureus sono principalmente infezioni piogeniche frequentemente associate a pratiche di tatuaggio con scarsa igiene. La gravità dell’infezione varia da forme minori e localizzate a forme gravi e sistemiche, includendo infezioni superficiali acute e profonde, come eritema, impetigine, follicolite, foruncolosi, cellulite e ascessi. In alcuni casi, queste infezioni possono evolvere in condizioni invasive o più gravi, come batteriemia, endocardite, fascite necrotizzante, cancrena e setticemia potenzialmente letale. Sono state riportate anche infezioni piogeniche causate da altre specie batteriche come Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus agalactiae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus lugdunensis, Enterobacter cloacae ed Enterobacter aerogenes.
La prima infezione virale associata a un tatuaggio risale al 1884, quando fu segnalato un caso di verruca volgare, riconducibile al papillomavirus umano (HPV). Da allora, sono stati documentati oltre 90 casi di infezioni virali legate a tatuaggi, che hanno coinvolto più di 300 persone in tutto il mondo. Tra i virus identificati, sono quattro quelli principali:
1. Virus dell’epatite B;
2. Virus dell’epatite C;
3. Papillomavirus umano (HPV);
4. Poxvirus (vaiolo delle scimmie, vaiolo umano e varicella.
Fino al 2000, i virus dell’epatite, soprattutto l’epatite B, erano i protagonisti. Dal 2000 in poi, invece, non è stato più segnalato alcun caso di epatite B legato ai tatuaggi ma hanno preso il sopravvento HPV e poxvirus e Herpes simplex [6]. Le infezioni fungine legate ai tatuaggi sono molto più rare rispetto a quelle batteriche o virali, ma esistono e sono in aumento. Ad oggi, sono stati identificati 14 diversi agenti patogeni fungini in 28 casi documentati di infezione da tatuaggio. Nessun fungo è risultato dominante, ma un gruppo di dermatofiti, responsabili della classica tigna (tinea corporis), ha causato circa il 60% di tutti i casi. In particolare:
1. Epidermophyton floccosum;
2. Microsporum canis;
3. Mycobacterium gypseum;
4. Trichophyton rubrum;
5. Trichophyton tonsurans.
Questi microrganismi colpiscono gli strati superficiali della pelle, provocando arrossamenti, prurito e desquamazioni [1].
Le fonti di infezioni da tatuaggio
Le infezioni che possono insorgere in seguito a un tatuaggio possono avere quattro principali fonti di origine. Il tatuatore può rappresentare un potenziale veicolo di patogeni, con il rischio di trasmettere infezioni attraverso, per esempio, la saliva. Scarsa igiene durante le pratiche di tatuaggio, incluso l’uso di acqua non sterile o di strumenti non adeguatamente sterilizzati, possono esporre la pelle a microrganismi patogeni.
Inchiostri contaminati da patogeni possono costituire una fonte diretta di infezione, così come inadeguate cure post-tatuaggio possono anch’esse portare allo sviluppo di infezioni.
Individuare la via di trasmissione dell’infezione è spesso difficile, soprattutto quando è trascorso molto tempo dal tatuaggio, ma è fondamentale per fornire il trattamento adeguato e per prevenire nuovi casi originati dalla stessa causa [7].
Dopo il 2000 si è registrata una diminuzione del ruolo dei tatuatori come fonte diretta di infezione, ma le infezioni dovute a pratiche igieniche carenti continuano a essere frequenti, indicando che, nonostante le normative e le attività di formazione, il problema dell’igiene non è stato ancora risolto del tutto. Le infezioni da inchiostro contaminato, invece, sono emerse dopo il 2000 e oggi rappresentano un rischio sanitario importante che può avvenire in due modi:
• durante la produzione industriale;
• poco prima dell’applicazione del tatuaggio.
Molti casi riportano che gli inchiostri vengono spesso diluiti prima dell’uso con acqua non sterile, come quella del rubinetto. Se l’infezione è localizzata in un’area che corrisponde a un colore specifico, con ogni probabilità è dovuta alla contaminazione dell’inchiostro di quel colore [8].
In casi rari ed estremi, possono verificarsi infezioni potenzialmente letali che solitamente si sviluppano entro una settimana dal tatuaggio e possono evolvere in infezioni acute del sangue (sepsi) che compromettono la funzionalità di più organi con esito fatale.
La comparsa dei sintomi può variare da qualche ora a pochi giorni, mesi o addirittura diversi anni dopo aver ricevuto un tatuaggio. La variabilità dell’esordio è influenzata principalmente dal tipo di microrganismo e dalla natura dell’infezione, ad esempio, sistemica o locale. Nel caso delle infezioni batteriche, i sintomi tendono a comparire subito dopo il tatuaggio, con oltre il 50% dei casi che si manifesta entro 2 settimane.

I sintomi iniziali riguardano principalmente infezioni piogeniche causate da Staphylococcus, Streptococcus e Pseudomonas spp., oltre alla maggior parte delle infezioni da micobatteri non tubercolari (NTM). Alcune altre infezioni da NTM, come quelle causate da Mycobacterium haemophilum e Mycobacterium immunogenum, impiegano spesso da 1 a 3 mesi per manifestarsi. È stato anche riportato un caso in cui l’infezione da NTM è comparsa 5 mesi dopo il tatuaggio. Al contrario, le infezioni
da Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium leprae hanno in genere periodi di incubazione molto più lunghi, spesso oltre i 6 mesi o anche diversi anni, e in casi estremi si sono manifestate dopo più di 20 anni [9].
Tatuatori professionisti e non professionisti a confronto
Le leggi e i regolamenti che disciplinano i tatuaggi, introdotti negli anni 2000, hanno previsto la registrazione dei locali, il rilascio di licenze ai tatuatori e corsi di formazione sull’igiene. Purtroppo, è molto facile reperire inchiostri, attrezzature e istruzioni online con il risultato che molte persone si tatuano a casa, in modalità fai-da-te, oppure si affidano a persone non autorizzate e senza formazione professionale.
Non si conosce con esattezza il numero o la proporzione di persone che scelgono tatuatori professionisti rispetto a quelle che si rivolgono a persone non professionali. Nel complesso, non sono state osservate differenze significative nei tipi di microrganismi che hanno causato infezioni tra i tatuaggi eseguiti da professionisti rispetto a quelli eseguiti

da non professionisti. Questi risultati suggeriscono che le infezioni possono insorgere indipendentemente dallo status professionale del tatuatore, indicando che il rischio di infezione esiste anche quando il tatuaggio viene realizzato da un professionista in uno studio ben attrezzato [10].
Conclusioni
Nonostante i progressi nelle politiche di sanità pubblica e una maggiore consapevolezza dei rischi legati ai tatuaggi, risultano in aumento sia il numero che la varietà delle infezioni microbiche. Dopo gli anni 2000, si è osservata anche una maggiore tendenza della popolazione a tatuarsi, a livello mondiale. In particolare, i casi di infezioni batteriche sono aumentati, mentre la segnalazione di infezioni virali, fungine e parassitarie si è mantenuta costante.
Anche la prevalenza delle diverse specie microbiche è cambiata, con l’emergere di infezioni da specie precedentemente non associate ai tatuaggi, come i micobatteri non tubercolari (NTM), soprattutto negli ultimi anni. Le persone con un sistema immunitario compromesso rappresentano una sfida particolare in questo contesto perché risultano più vulnerabili alle infezioni rispetto agli individui sani.
Nel complesso, sono relativamente rari i casi di infezione da tatuaggio in persone immunodepresse ma è importante sottolineare che possono avere conseguenze gravi. (D. B.).
Bibliografia
1. Kondakala S, Yoon S, Daddy-Gaoh S, Foley S, Kweon O, Kim SJ. Microbiology of tattoo-associated infections since 1820. Lancet Microbe. 2025 Apr;6(4):101005
2. van der Bent SAS. Tattoo complications: diagnosis and treatment. PhD Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, 2021
3. Liszewski, W ∙ Kream, E ∙ Helland, S ∙ et al. The demographics and rates of tattoo complications, regret, and unsafe tattooing practices: a cross-sectional study Dermatol Surg. 2015; 41:1283-1289
4. Rukstinat GJ. Tattoos: a survey, with special reference to tattoos and scars as indicators of syphilis. Arch Pathol 1941; 31: 640–55
5. Long GE, Rickman LS. Infectious complications of tattoos. Clin Infect Dis 1994; 18: 610–19
6. Cohen PR. Tattoo-Associated Viral Infections: A Review. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2021 Oct 23; 14:1529-1540
7. Wenzel SM, Rittmann I, Landthaler M, Bäumler W. Adverse reactions after tattooing: review of the literature and comparison to results of a survey. Dermatology 2013; 226: 138–47
8. Mudedla S, Avendano EE, Raman G. Non-tuberculous Mycobacterium skin infections after tattooing in healthy individuals: a systematic review of case reports. Dermatol Online J 2015; 21: 13030/ qt8mr3r4f0
9. Ghorpade A. Inoculation (tattoo) leprosy: a report of 31 cases. J Eur Acad Dermatol Venereol 2002; 16: 494–99
10. Brown KM, Perlmutter P, McDermott RJ. Youth and tattoos: what school health personnel should know. J Sch Health 2000;70: 355–60
di Cristiana Berlinghieri*

Il patrimonio genetico guida le terapie del futuro
Meno effetti collaterali, più precisione nelle cure
FARMACI SU MISURA GRAZIE AL DNA
LA MEDICINA
PERSONALIZZATA
È REALTÀ
Non tutti i farmaci funzionano allo stesso modo per tutti. Oggi, grazie alla genetica, possiamo capire perché e scegliere cure più efficaci, più sicure e davvero su misura.
Una compressa che per qualcuno è miracolosa, per un altro può essere inutile o addirittura dannosa. Succede più spesso di quanto si pensi. La ragione, spesso, è nel nostro DNA.
Ognuno di noi ha un patrimonio genetico unico, che influenza il modo in cui il corpo assorbe, trasforma ed elimina i farmaci.
Immagina di andare dal medico e ricevere una cura pensata apposta per te: il farmaco giusto, alla dose giusta, al momento giusto. Non è fantascienza, ma il futuro - anzi, il presente - della medicina. Si chiama medicina personalizzata e si basa sullo studio del nostro DNA per capire come reagiamo ai farmaci.
La medicina personalizzata, resa possibile dalla farmacogenetica e dalla farmacogenomica, apre una nuova era: quella in cui le terapie non sono più standard, ma costruite su misura per ogni paziente.
Cosa sono farmacogenetica e farmacogenomica?
Farmacogenetica e farmacogenomica sembrano parole simili, ma indicano approcci diversi:
• La farmacogenetica studia come singoli geni influenzano la risposta ai farmaci. Perché una medicina fa effetto su una persona e su un’altra no? Spesso la spiegazione è scritta nel DNA.
• La farmacogenomica, invece, analizza tutto il genoma. L’obiettivo è più ambizioso: capire le basi genetiche della risposta ai farmaci e usare queste informazioni per sviluppare nuove terapie personalizzate.
Perché il DNA fa la differenza?
Non tutti metabolizziamo i farmaci allo stesso modo. Alcuni enzimi, come quelli del gruppo citocromo P450, lavorano più o meno velocemente a seconda della nostra genetica.
Questo può cambiare radicalmente l’effetto del farmaco:
• Se l’enzima è troppo lento, il farmaco può accumularsi nel corpo e causare effetti collaterali.
• Se è troppo veloce, il farmaco viene eliminato prima di fare effetto.
Anche altre proteine, come i trasportatori cellulari, influiscono su quanto farmaco arriva davvero dove serve. In sintesi: il nostro DNA influenza efficacia e sicurezza dei trattamenti.
*Farmacologa, biologa nutrizionista

©
Quando il DNA salva la vita: esempi concreti
Ecco alcuni casi in cui conoscere il proprio profilo genetico può fare la differenza:
• HLA-B5701 e abacavir: questo allele può causare una grave reazione allergica a un farmaco per l’HIV. Oggi si fa un test genetico prima di iniziare la cura.
• HLA-B1502 e carbamazepina: comune in Asia, questo gene aumenta il rischio di una reazione cutanea pericolosa. In molti Paesi asiatici il test genetico è obbligatorio.
• Gene IRS1 e metformina: alcune varianti genetiche influenzano la risposta alla metformina, un farmaco molto usato nel diabete di tipo 2. Conoscere queste varianti può migliorare il trattamento.
Una terapia fatta su misura
I vantaggi della medicina personalizzata non si limitano ai casi più critici. Conoscere il proprio profilo genetico permette di: ricevere cure più efficaci, ridurre il rischio di effetti collaterali, evitare terapie inutili o potenzialmente dannose. In futuro, anche la prescrizione di un comune antidolorifico o di un antidepressivo potrebbe essere basata sul nostro DNA, rendendo le terapie sempre più precise.
Le sfide da superare
Nonostante i progressi, restano alcune difficoltà. In molti Paesi i test genetici non sono ancora disponibili per tutti e spesso sono costosi. Serve inoltre una formazione specifica per i medici, che devono interpretare i risultati e applicarli correttamente.
Il futuro è già iniziato
La medicina personalizzata non è più una promessa lontana. In molti ospedali e centri specializzati è già realtà. Grazie ai test genetici, sempre più pazienti possono ricevere la terapia giusta, al momento giusto, nella dose giusta. Questa rivoluzione silenziosa sta cambiando non solo il modo in cui ci curiamo, ma anche il rapporto tra medico e paziente. Non più farmaci “per tutti”, ma farmaci “per te”. E per molti, può fare tutta la differenza.
Scienze
Il corso Fad associato a questo articolo dà la possibilità agli iscritti all’albo dei biologi di acquisire 4,5 crediti Ecm Consulta l’area riservata MyBio
PARATUBERCOLOSI DEI RUMINANTI E MORBO DI CROHN NELL’UOMO
L’articolo è associato al corso Fad da 4,5 crediti Ecm disponibile nell’area riservata MyBio
di Alessandra Mazzeo*
La nuova normativa europea sulla salute animaleRegolamento (UE) 2016/429 - introduce norme complete per la gestione delle malattie animali trasmissibili, che variano dall’eradicazione obbligatoria di infezioni zoonotiche, quali la brucellosi e la tubercolosi bovina, a programmi opzionali di eradicazione che ciascuno Stato Membro o suo territorio possono attivare, come per la Paratubercolosi dei Ruminanti o Malattia di Johne (Johne’s Disease - JD), sostenuta da Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP).
La JD è un’infiammazione intestinale cronica, progressiva, che presenta un lungo periodo di incubazione, con una fase iniziale in cui non avviene escrezione del patogeno, mentre in fase clinica l’escrezione è abbondante e accompagnata dalla lunga sopravvivenza del patogeno nell’ambiente. MAP, entrato per via orale, colonizza la mucosa e la sottomucosa intestinale, proliferando all’interno dei macrofagi intestinali e causando dilatazione dei vasi linfatici, ingrossamento dei linfonodi mesenterici ed enterite granulomatosa cronica, con comparsa di diarrea, dapprima intermittente e poi cronica, che porta l’animale infetto in
*Biologa, Specialista in Microbiologia e Virologia, professore aggregato e - dopo il pensionamento - docente a contratto degli insegnamenti di Malattie Infettive e Salubrità delle Produzioni Zootecniche e di Zoonosi a Trasmissione Alimentare dei corsi di laurea del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti (DiAAA) dell’Università degli Studi del Molise
stato cachettico e all’exitus. Nei ruminanti domestici JD è diffusa in tutto il mondo, provocando notevoli perdite economiche per ridotta produzione di latte, maggiore incidenza di mastiti cliniche e di altre malattie infettive, ridotta fertilità, minore valore commerciale dei capi. Nel computo dei danni economici vanno considerati anche quelli indotti dalle limitazioni commerciali per gli animali infetti o per gli animali e prodotti derivati provenienti da territori che non godono di qualifica sanitaria, la cui movimentazione verso Stati Membri che hanno già attivato programmi opzionali di controllo è interdetta.
Per le aree interne appenniniche e montane d’Italia e della UE, che sono zone fragili, con carenza di servizi, spesso afflitte da depopolamento, dall’invecchiamento della popolazione e dal gap tecnologico, che presentano zoo-economia poco sviluppata e ove si assiste alla degradazione del suolo e alla riduzione della biodiversità, la mitigazione delle perdite economiche causate dal decremento di produttività degli animali allevati indotto da infezioni è particolarmente importante. I programmi opzionali - rientrando nel più ampio approccio One Health adottato nella UE - sarebbero particolarmente adatti ad instaurare sinergia con le policies europee del Green Deal, della Farm to Fork Strategy e della rivalutazione delle aree interne, ove avrebbero la funzione di:
• contrastare lo spopolamento, grazie al ristoro della catena di valore della produzione di latte e derivati;
• sostenere il benessere animale;
• consentire la conservazione dei pascoli e, quindi,
del suolo e della biodiversità;
• ridurre il rischio di esposizione a malattie zoonotiche per residenti e turisti attratti dal valore ecologico e ricreativo del territorio, oltre che dai prodotti alimentari tipici.
Considerando che l’avvio di tali programmi nelle regioni italiane e Province Autonome a zooeconomia particolarmente sviluppata ha dimostrato che il conseguimento della certificazione sanitaria può essere un processo lungo, la loro attivazione nelle aree interne è urgente e imperativa per la protezione dell’economia locale legata al bestiame, ai prodotti lattiero-caseari, alla protezione del patrimonio culturale e tradizionale delle aree interne, fino alla promozione dell’ambiente e della salute umana.
L’importanza di MAP e JD nel settore zootecnico, sia in termini di perdite economiche che di benessere animale, è infatti ulteriormente amplificata dal suo presunto potenziale zoonotico. Fin dal secolo scorso, infatti, MAP è sospettato di essere l’agente causale o un promotore iniziale del Morbo di Crohn nell’uomo (Crohn’s Disease - CD), malattia infiammatoria intestinale che può interessare l’ileo terminale, il cieco e il colon, o l’intero tratto gastrointestinale, provocando disbiosi e innesco della cascata infiammatoria che portano a una serie di patologie che spaziano dall’enterite granulomatosa cronica - con ispessimento delle pareti intestinali e conseguenti complicanze quali malassorbimento, anemia, osteoporosi, ostruzione intestinale, fistole, ascessi e ulcere - fino a disordini neurologici. Gli studi indicano un aumento dell’incidenza di CD negli Stati Uniti e in altre parti del mondo.
Nei soggetti affetti da CD è più alto il rischio di sviluppare cancro colo-rettale e cancro del piccolo intestino. La presenza di MAP nel latte in polvere per neonati e il suo potenziale ruolo nell’esposizione precoce sollevano importanti questioni epidemiologiche, soprattutto considerando che l’allattamento al seno sembra avere un effetto protettivo contro il Morbo di Crohn. È significativo notare che MAP è stato rilevato nel latte crudo di animali domestici in diversi Paesi ad alto reddito, dove campioni di latte pastorizzato sono risultati positivi per MAP coltivabile. Poiché la temperatura di pasteurizzazione abbatte la concentrazione iniziale di MAP di almeno 4 logaritmi, la probabilità di sopravvivenza alla pastorizzazione è funzione della carica contaminante iniziale del patogeno.
Alcuni ricercatori chiedono un’azione collettiva: le comunità mediche e di ricerca devono riconoscere MAP come un patogeno zoonotico, rendendo imperativa la sua eradicazione dal bestiame, l’obbligo per le industrie di produrre e certificare esclusivamente latte artificiale privo di MAP per l’alimentazione dei neonati, la riduzione della presenza del patogeno nella catena alimentare, lo sviluppo di vaccini e di trattamenti antibiotici per l’uomo.
Il raggiungimento dell’obiettivo di eradicazione della JD dagli allevamenti richiederà finanziamenti pubblici e il coinvolgimento attivo di politici e allevatori, con supporto di professionisti in vari ambiti - molti dei quali ricadono negli ambiti della professione del Biologo - quali:
• studi sulle interazioni tra ambiente, fauna selvatica, animali domestici e uomo;
• pratiche agricole sostenibili e sicure; sorveglianza sanitaria e gestione degli animali;
• gestione della qualità e sicurezza alimentare;
• ricerca sulle malattie zoonotiche e occupazionali;
• valutazione dei costi e dei benefici delle politiche sanitarie, agricole e alimentari adottate;
• studi sulle influenze della dieta nel CD;
• ampia diffusione delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti con supporti di comunicazione visiva e multimediale per la sensibilizzazione dei cittadini. Tutti gli esperti dovrebbero interagire in stretta collaborazione, seguendo l’approccio interdisciplinare richiesto dall’applicazione del paradigma One Health, per proteggere la salute animale e l’ambiente e affrontare il potenziale ruolo zoonotico della JD (Mazzeo et al., Enhancing Inner Area Revaluation Through Optional Control Programmes for Infectious Bovine Rhinotracheitis and Ruminant Paratuberculosis Potentially Linked to Crohn’s Disease in Humans. Int. J. Environ. Res. Public Health 2024, 21,1595. https://doi.org/10.3390/ijerph21121595).



















































Il corso Fad associato a questo articolo dà la possibilità agli iscritti all’albo dei biologi di acquisire 4,5 crediti Ecm Consulta l’area riservata MyBio
LA CITOLOGIA TIROIDEA STRUMENTO DIAGNOSTICO E OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE
L’articolo è associato al corso Fad da 4,5crediti Ecm disponibile nell’area riservata MyBio
di Alisia Curto Pelle*
La citologia tiroidea è uno degli strumenti più importanti nella diagnosi precoce delle patologie tiroidee, in particolare dei noduli sospetti e delle neoplasie. In un contesto clinico in continua evoluzione, il ruolo del Biologo assume un’importanza crescente anche nell’ambito della citopatologia. Per questo nasce il corso FAD “Citologia tiroidea: classificazione, casi clinici e percorso diagnostico-terapeutico”, pensato appositamente per i biologi che desiderano approfondire competenze teoriche e pratiche in questo settore.
Il corso è rivolto a:
• Biologi clinici, che operano in laboratori pubblici o privati;
• Biologi specializzandi, che vogliono orientarsi verso l’ambito diagnostico e anatomo-patologico;
• Professionisti sanitari che collaborano nei team multidisciplinari nella gestione delle malattie tiroidee.
Obiettivi formativi
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una solida base teorica e applicativa sulla citologia tiroidea, con particolare attenzione a:
• Il ruolo dell’agoaspirato tiroideo nella diagnosi dei noduli;
• La classificazione citologica SIAPEC-IAP (TIR 1
*Biologa Specialista in Patologia Clinica
- TIR 5);
• L’interpretazione di quadri citologici specifici;
• L’analisi di casi clinici reali per comprendere l’approccio diagnostico e terapeutico;
• Le basi del follow-up post-operatorio in relazione ai risultati istologici.
Il corso è fruibile interamente online, su piattaforma FAD. Al termine del corso, è previsto un test di valutazione finale e il rilascio dei crediti ECM per i biologi.




FORMAZIONE ECM PER I BIOLOGI
Scarica il Giornale dei Biologi
dall’area riservata MyBio
Ogni mese riceverai crediti Ecm in autoformazione e Fad