PROFESSIONI SANITARIE UNITE PER LA SALUTE DI TUTTI

Il 20 febbraio è stata celebrata la terza giornata nazionale delle personale sociosanitario
Alla cerimonia presente anche il Ministro della Salute


Il 20 febbraio è stata celebrata la terza giornata nazionale delle personale sociosanitario
Alla cerimonia presente anche il Ministro della Salute
PRIMO PIANO
I biologi alla terza giornata nazionale del personale sociosanitario
Covid, la via d’uscita sembra vicina. Ma c’è un nuovo allarme legato all’aviaria di Rino Dazzo
Farmaco per i calcoli alla colecisti diventa alleato contro il covid di Ester Trevisan
Neuroblastoma, team italiano identifica fattori genetici di predisposizione di Chiara Di Martino
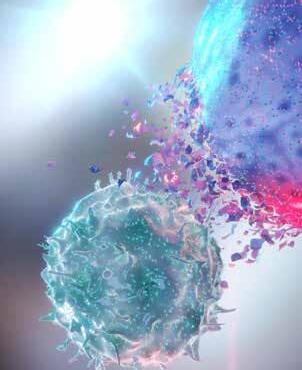
Le qualità antinfiammatorie del cibo che mangiamo ce le insegna la biologia di Ester Trevisan
16 Tumori: la correlazione tra ossisteroli e risposta immunitaria di Anna Lavinia
Studio italo-tedesco indaga un nuovo gene responsabile dell’autismo di Elisabetta Gramolini
Lo sport riduce il rischio di sviluppare demenza di Domenico Esposito
Atlanti cerebrali postnatali individuano anomalie di Domenico Esposito
Come si formano le immagini e dove vengono immagazzinate nel cervello di Elisabetta Gramolini
Caffè con latte e l’effetto antifiammatorio di Domenico Esposito
Obesità e morbo di Alzheimer: neurodegenerazione simile di Domenico Esposito

Pantenolo per capelli Biancamaria Mancini
L’Azeloyl tetrapeptide-23 contro
AMBIENTE
Bellezze da preservare di Gianpaolo Palazzo
L’energia sostenibile e la trasformazione digitale in agricoltura di Gianpaolo Palazzo
Respiriamo una cattiva aria di Gianpaolo Palazzo
Inquinamento acustico e atmosferico nelle aree urbane di Teresa Pandolfi e Giovanni Misasi
INNOVAZIONE
Sphinks, l’algoritmo che scova i tumori e indica la terapia personalizzata di Sara Bovio
Tumori, l’ecosistema alla base del loro sviluppo di Pasquale Santilio
Campi elettromagnetici per la reazioni chimiche di Pasquale Santilio

Meno inquinamento con biocarburanti per aerei di Pasquale Santilio
Batteri fertilizzanti per siccità e produzione di Pasquale Santilio
BENI CULTURALI
Capitali riunite. A Gorizio e a Nuova Gorica ha vinto la cultura di Rino Dazzo
A Verona terrazzamenti dell’età del Bronzo di Pietro Sapia
L’Italia delle nevi torna a sognare grazie al “fattore B” di Antonino Palumbo
Volley, a Conegliano un “brindisi” tira l’altro inseguendo la Champions di Antonino Palumbo
Poker di consonni su pista agli europei di Antonino Palumbo
Le regine del ciclocross di casa Holmgren di Antonino Palumbo
Il ruolo del latte materno nello sviluppo del microbiota intestinale infantile di Federica Ruin
Metodo non invasivo per indentificare una potenziale causa dell’ipertensione di Cinzia Boschiero
Una rilettura ecologica del XX secolo (Parte II) di Antonella Pannocchia
Narrare per prevenire: il caso degli infortuni sul lavoro di Eleonora Tosco et al.

*Calabria
Campania-Molise
Emilia Romagna-Marche
Lazio-Abruzzo
Lombardia
Piemonte-Liguria-Valle
D’Aosta
Puglia-Basilicata
Sardegna
Sicilia
Toscana-Umbria
Veneto-Friuli
Venezia
Giulia-Trentino
Alto Adige
Le unidici Federazioni e Consigli nazionali dei professionisti della salute celebrano insieme la rincorrenza negli spazi dell’Università Pontificia a Roma
nsieme per garantire la salute di tutti”. Questo lo slogan scelto per la terza “Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato”, celebrata il 20 febbraio 2023 a Roma, nell’aula Magna della Pontificia Università San Tommaso D’Aquino, dalle undici Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini delle Professioni sociosanitarie. Istituita il 13 novembre 2020 con la legge 155, la giornata vuole onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus. La data del 20 febbraio è stata scelta per ricordare il giorno in cui a Codogno venne scoperto il “paziente uno”.

Una ricorrenza che i rappresentati di Federazioni e Consigli hanno deciso di ricordare insieme per sottolineare l’attività quotidianamente svolta a tutela della salute dei cittadini. «Le professioni sociosanitarie – affermano i presidenti in un comunicato congiunto– sono da sempre accanto a chi soffre e ha bisogno del loro aiuto. Anche nelle fasi più dure della pandemia l’assistenza non è mai venuta meno». L’incontro è stato moderato da Arianna Ciampoli, conduttrice e presentatrice TV, mentre il discorso di apertura della cerimonia è stato tenuto da Barbara Mangiacavalli, presidente delle professioni infermieristiche, che ha spiegato come «la salute sia un diritto inviolabile di cui la persona non può essere privata». Orazio
Schillaci, ministro della salute, ha illustrato come sia necessario «prendersi cura di chi si prende cura di noi. Il mio plauso - prosegue il ministrova all’operato di tutti i professionisti sanitari, per ciò che è stato fatto nel periodo pandemico e per tutto quello che continuano a fare ogni giorno per garantire la salute di tutti, un diritto sancito dalla costituzione italiana».
In rappresentanza delle istituzioni è intervenuto il Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, che ha spiegato come l’emergenza sanitaria per gli operatori della salute si manifesti ogni giorno, perché ogni giorno ciascuno di voi combatte per salvare o migliorare la vita di qualcuno.
Monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha raccontato come la cura della persona sia la misura del grado di civiltà di una società moderna e di una democrazia matura. Senza diritto alla salute non c’è democrazia reale. Anche Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha manifestato il suo sostegno alla giornata con una lettera nella quale ha rinnovato l’impegno delle Regioni a investire nel Servizio Sanitario nazionale partendo proprio dal ruolo fondamentale del capitale umano che rappresenta un patrimonio prezioso da non disperdere. In sala erano presenti i presidenti e i consiglieri degli ordini regionali dei biologi insieme al commissario straordinario della Federazione Nazionale dei Biologi, Pasquale Piscopo, che ha dedicato «la partecipazione della Fnob alle tre donne, tre
biologhe, che tra le prime in Europa hanno isolato il virus del Covid-19, all’esordio della pandemia, nel laboratorio di Virologia dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. A Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti va ancora una volta la riconoscenza della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi». La cerimonia ha visto l’esibizione della Redshoeswomen Orchestra, che ha suonato il concerto-recital dal titolo “L’immensa bellezza”, diretto dalla maestra Dominga Damato.
In alto, gli organi direttivi dei biologi. Al centro, da sinistra, Orazio Schillaci, ministro della Salute, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, e Pasquale Piscopo, commissario della Fonb. Accanto, la sala con Arianna Ciampoli, presentatrice Tv e moderatrice della giornata.





Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità il pericolo da H5N1 va tenuto sotto controllo
Il virus può trasmettersi direttamente all’uomo, ma si è ancora in tempo per fermarlo
di Rino DazzoSe ne parla sempre meno, ormai, e per fortuna ci si ammala sempre più di rado, soprattutto in forma grave. La lunga battaglia contro il Covid - il 9 marzo 2020, tre anni fa, in Italia fu adottato il primo lockdown nazionale, seguito dopo pochi giorni da analoghe misure varate dagli altri governi europei - sembra finalmente volgere al termine. Nonostante il proliferare di nuove sottovarianti di Omicron come Kraken e Orthrus, in grado di replicarsi con rapidità ma non più pericolose delle precedenti, i numeri della pandemia non spaventano più. La partita è ancora in corso, sia chiaro: nel suo ultimo bollettino su scala mondiale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato quasi 5,3 milioni di nuovi casi dal 23 gennaio al 19 febbraio, con oltre 48mila decessi e con il fulcro dei nuovi contagi che sembra essersi concentrato nell’Europa dell’Est, in Russia e in Polonia. Ma l’emergenza in senso stretto ormai non è più tale. Anche e soprattutto in Italia, dove a dispetto di un leggero aumento dei casi riscontrati, l’occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva rimane ampiamente al di sotto dei livelli di guardia.
L’Oms ha anche aggiornato le sue raccomandazioni. Rinnovato il consiglio a utilizza-
re le mascherine «per chiunque si trovi in uno spazio affollato, chiuso o scarsamente ventilato», mentre è estesa fortemente la raccomandazione all’uso di un particolare antivirale orale, Paxlovid (nirmatrelvir-ritonavir), «anche per le donne incinte o che allattano, le quali dovrebbero consultare il proprio medico per determinare se devono assumere questo farmaco, dati i probabili benefici e la mancanza di eventi avversi segnalati». Paxlovid è un antivirale raccomandato per la prima volta nell’aprile del 2022 per pazienti Covid lievi o moderati, ad alto rischio di ricovero, mentre in sede di prevenzione è rinnovato l’invito a completare il ciclo vaccinale e ad aggiornare periodicamente la protezione con i vaccini più aggiornati.
Diversi studi attestano come le ultime sottovarianti abbiano alte capacità di sfuggire alla risposta immunitaria ottenuta con tre dosi dei vaccini a mRNA monovalenti (Pfizer o Moderna), mentre un richiamo con il vaccino bivalente (quello aggiornato contro Omicron) è in grado di ripristinare una buona protezione. In India, intanto, è stato lanciato sul mercato iNCOVACC, innovativo vaccino intranasale approvato alcuni mesi fa e prodotto dalla Bharat Biotec che funziona come un comune spray nasale, inducendo vasta risposta immunitaria
sia delle cellule T che di quelle della mucosa nasale, sede primaria di penetrazione del virus.
Insomma, la via d’uscita dalla pandemia Covid non è mai stata tanto vicina. Ma risuonano già altri campanelli d’allarme. Quello che desta maggiori preoccupazioni nella comunità scientifica è legato alla diffusione sempre più massiccia dell’influenza aviaria e dei casi, sempre più frequenti, di trasmissione della malattia a mammiferi e altri animali, uomo compreso. Nelle scorse settimane una bimba di nove anni è risultata contagiata in Ecuador, a fine febbraio una di undici anni è morta in Cambogia.
Ma cos’è l’aviaria? Si tratta di una malattia degli uccelli causata da un virus dell’influenza di tipo A, diffusa in tutto il mondo e con tassi di mortalità per i volatili che possono avvicinarsi al 100% per i ceppi ad alta patogenicità. Come H5N1, emerso per la prima volta nel 1996 e responsabile dell’epidemia in corso che, nata nel 2003 nel Sud-est asiatico, si è diffusa in tutto il Sudamerica e ha toccato anche gli Stati Uniti. H5N1 è stato riscontrato anche in orsi, volpi, visoni, lontre e persino delfini e leoni marini ed è proprio la diffusione massiva del virus influenzale in altre specie a rendere l’influenza aviaria la maggior indiziata per un’eventuale futura pandemia, da scongiurare a ogni costo.
L’aviaria è una malattia degli uccelli causata da un virus dell’influenza di tipo A, diffusa in tutto il mondo e con tassi di mortalità per i volatili che possono avvicinarsi al 100% per i ceppi ad alta patogenicità. Come H5N1, emerso per la prima volta nel 1996 e responsabile dell’epidemia in corso che, nata nel 2003 nel Sud-est asiatico, si è diffusa in tutto il Sudamerica e ha toccato anche gli Stati Uniti.

Scrive l’Istituto Superiore di Sanità: «Il rischio principale, che fa temere l’avvento di una nuova pandemia dopo le tre che si sono verificate nel corso del XX secolo (1918, 1957, 1968), è che la compresenza del virus aviario con quello dell’influenza umana, in una persona infettata da entrambi, faciliti la ricombinazione di H5N1 e lo renda capace di trasmettersi nella popolazione umana».
Secondo la virologa Ilaria Capua siamo ancora in tempo per scongiurare il peggio, ma occorre un’inversione di rotta come quella suggerita in un articolo scritto per il Corriere della Sera: «Quello che sta accadendo con influenza aviaria è il risultato di 25 anni di incapacità a gestire il problema, che affonda le radici nella necessità di allevare sempre più animali a basso costo. A livello mondiale siamo passati dall’allevare ogni anno 13,9 miliardi di polli da carne nel 2000 a 25,8 miliardi nel 2021. Si chiama raddoppio in vent’anni».
La priorità assoluta, secondo la scienziata italiana, è «investire urgentemente e massicciamente in vaccini per l’uomo e per gli animali che possano arrestare o addirittura prevenire le conseguenze di questa nuova sciagura. È una corsa contro il tempo e bisogna agire. Adesso».

Intervista a Teresa Brevini, 28 anni, milanese, dottoranda all’Università di Cambridge, che ha partecipato alla ricerca guidata dal dottor Fotios Sampazio-tis e pubblicata da Nature
Grazie al lavoro di ricerca condotto dal team del Wellcome-MRC Cambridge Stem Cell Institute dell’Università di Cambridge, si prospetta una nuova strategia tera-peutica contro la SARS-CoV-2. Nuova, ma basata su un vecchio farmaco impiegato nella cura dei calcoli alla colecisti: l’Acido ursodesossicolico. La dottoressa Teresa Brevini, giovane dottoranda dell’istituto di ricerca britannico, spiega al nostro giornale come è avvenuta la scoperta, in cosa consiste e quali sono gli scenari futuri.
Un vecchio farmaco per una nuova terapia contro il Covid. Dottoressa Brevini, ci racconta come siete arrivati a intuire che Udca, ovvero l’Acido ursodesossicolico utilizzato per il trattamento di calcoli alle colecisti e sabbia biliare, poteva essere la chiave di volta nella lotta al virus della SARS-CoV-2?
È stata una scoperta davvero fortuita. Nel laboratorio del dottor Fotios Sampazio-tis a Cambridge, nel Regno Unito, ci occupiamo di malattie dei dotti biliari e studiamo gli effetti che la bile ha sulle cellule di questi dotti. All’inizio della pandemia, abbiamo scoperto che gli acidi biliari sono in grado di modulare l’espressione del recettore virale ACE2. Quando poi abbiamo scoperto che ACE2 era il recettore di
ingresso per SARS-CoV-2, tutto ha fatto “click” e abbiamo capito che potevamo sfruttare questo meccanismo molecolare, e i farmaci che vi agiscono, per ridurre l’ingresso del virus nelle nostre cellule.
Qual è l’aspetto innovativo introdotto da questo farmaco?
L’aspetto più innovativo di questo farmaco è senza dubbio il fatto che invece di agire sul virus come la maggior parte delle terapie in uso, tra cui farmaci antivirali e anticorpi monoclonali, interviene sulle nostre cellule, riducendo l’espressione di ACE2. Agendo sull’ospite, invece che sull’agente patogeno, questa strategia ha un rischio minore di sviluppare resistenza da parte del virus e offre un importante livello di protezione nei confronti di nuove varianti che utilizzano ACE2, contro cui le nostre terapie attuali spesso dimostrano un’efficienza ridotta.
Luci e ombre del nuovo approccio terapeutico?
Dato il meccanismo di azione, questo farmaco agisce prevenendo o riducendo l’infezione da parte di SARS-CoV-2; mentre abbiamo dimostrato in modo esausti-vo questo effetto, c’è ancora molto lavoro da fare per capire se UDCA possa esse-re utilizzato una volta che
l’infezione si è sviluppata. Nonostante ciò, questo far-maco risponde a una delle più grandi esigenze del momento, ovvero offrire una terapia preventiva per il COVID-19 che sia efficace anche in quei soggetti che non possono beneficiare dai vaccini, per esempio perché hanno un sistema immunita-rio compromesso. Nei nostri studi clinici preliminari, UDCA ha già confermato di essere efficace nel prevenire lo sviluppo di una forma moderata o severa del CO-VID-19 in individui vulnerabili, tra cui coloro che hanno ricevuto un trapianto di fe-gato o pazienti con malattie croniche.
L’impiego di questa terapia potrebbe rendere superfluo il ricorso alla vacci-nazione?
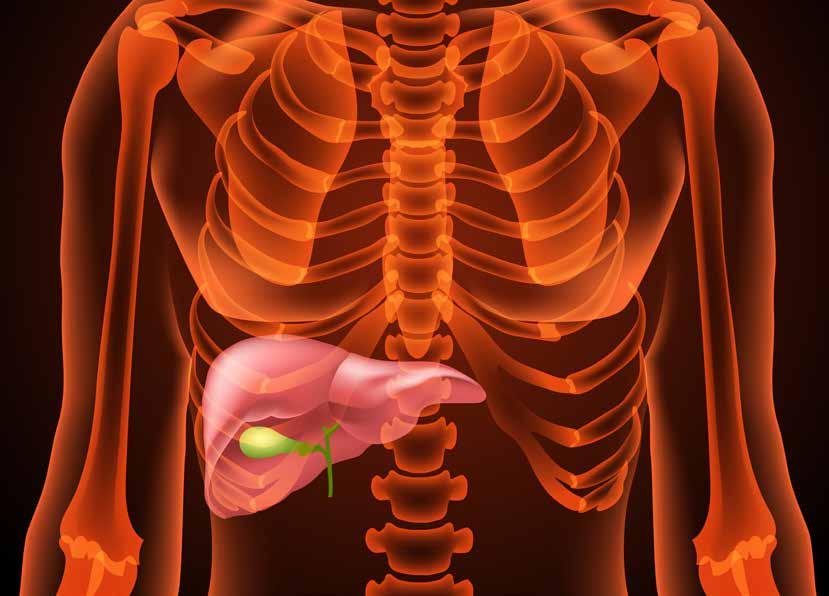
Assolutamente no, la vaccinazione contro il COVID-19 resta il mezzo più potente che abbiamo. Il vaccino agisce insegnando al nostro sistema immunitario a rico-noscere ed eliminare il virus, mentre UDCA, riducendo i livelli del recettore virale, previene l’ingresso del virus nelle nostre cellule. Le due terapie agiscono in modo sinergistico; perciò, UDCA, più che sostituire i vaccini, potrebbe rappresentare un’altra arma nel nostro arsenale per combattere il virus e potenziare l’effetto dei vaccini.
Quali sono i prossimi step?
Il prossimo step è senza dubbio testare
Teresa Brevini (laurea Triennale e Magistrale in Biotecnologie Mediche alla Statale di Milano) ha ottenuto una borsa di dottorato alla European Association for the Study of the Liver (EASL) per condurre un PhD nel laboratorio del Dr Fotios Sampaziotis all’Università di Cambridge (UK). Il suo campo di ricerca, che le è valso il prestigioso premio dalla società di ricerca applicata di Cambridge (CSAR PhD Award), si concentra sullo sviluppo di terapie sperimentali per il trattamento di malattie del fegato.

UDCA in un trial clinico. Per fare ciò, ab-biamo bisogno di tanti casi di COVID-19 e al momento, dato the la vaccinazione è stata così efficiente, stiamo discutendo come procedere. Un’opzione è testare questo farmaco in paesi in via di sviluppo, dove i vaccini non sono ancora così dif-fusi perché troppo cari o difficili da distribuire. In questo modo, potremmo riuscire a ottenere risultati più chiari e a testare immediatamente UDCA nei paesi dove c’è maggiore bisogno di terapie alternative.
Giovane, altamente qualificata, appassionata del suo lavoro, ma “in forze” in un prestigioso istituto di ricerca estero. La scienza non ha confini territoriali, ma lei si sente un po’ un cervello in fuga?
Devo dire che non mi sono mai sentita ‘in fuga’. Sono venuta in Inghilterra alla fine della mia laurea magistrale e ho trovato un ambiente perfetto nel laboratorio del dottor Sampaziotis; più che l’istituto, quello che ha fatto la differenza per me è sta-to trovare un team con cui c’è intesa, supporto e si lavora bene. Nel lungo termi-ne, però, spero di trovare delle opportunità che mi permettano di tornare in Italia e stabilire lì il mio laboratorio, non solo per sfuggire alla pioggia inglese, ma anche per portare in Italia tutto quello che ho imparato.
Il 12% dei bambini malati presenta almeno una mutazione ereditata tra le 116 patogeniche individuate in diversi geni. A raccontarlo è uno degli autori dello studio, Mario Capasso
Il neuroblastoma è il tumore pediatrico extracranico solido più comune: colpisce bambini e adolescenti fino ai 15 anni, registrando circa 15.000 casi ogni anno nel mondo, 130 in Italia. Il Neuroblastoma è un tumore maligno che ha origine dai neuroblasti, cellule presenti nel sistema nervoso simpatico ed è considerato la prima causa di morte e la terza neoplasia per frequenza dopo le leucemie e i tumori cerebrali dell’infanzia. Alcuni studi sul genoma hanno guidato la scoperta di varianti di rischio comuni, ma nessuno, finora, aveva studiato il contributo di varianti rare alla suscettibilità a questa patologia. È quello che hanno appena fatto Mario Capasso e Achille Iolascon, Principal Investigator del CEINGE e, rispettivamente, professore associato e ordinario di Genetica Medica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. In uno studio scientifico pubblicato su eBioMedicine, rivista del gruppo editoriale The Lancet, hanno condotto un sequenziamento dell’intero esoma di 664 casi di neuroblastoma e 822 controlli, utilizzando dati genetici di convalida derivanti da coorti indipendenti di pazienti per identificare i geni con varianti di rischio rare. Si tratta del bagaglio di dati tra i più ampi mai utilizzati al mondo per questa patologia.
Grazie a questo studio, si delinea una speranza in più per la diagnosi precoce e la cura di una malattia rara e allarmante. È Mario Capasso a spiegare da dove è partito il team di ricerca, e dove è arrivato.
Professore, ci racconta la genesi di questo studio?
Abbiamo iniziato circa 5-6 anni con la raccolta di un numero davvero ampio di campioni di DNA di bambini con neuroblastoma. Parallelamente, li abbiamo sottoposti a sequenziamento di nuova generazione integrato con analisi computazionali avanzate, che ci consentono di analizzare tutti i geni finora conosciuti a costi sostenibili e in tempi rapidi. Naturalmente, oltre ai dati genitici di pazienti, abbiamo raccolto anche quelli di soggetti sani. In questa fase è stato essenziale il contributo dell’esperto bioinformatico Ferdinando Bonfiglio, primo autore del lavoro, insieme a i colleghi che lavorano nella facility di Bioinformatica per Next Generation Sequencing del CEINGE.
Lo step successivo qual è stato?
Abbiamo cercato di verificare quali, tra le mutazioni rare, fossero patogeniche, quali cioè fossero responsabili del rischio di sviluppare un tumore. Detto in altre parole, volevamo individuare una presunta predisposizione ge-
netica al neuroblastoma, che si manifesta, solitamente, intorno ai 18 mesi di età e dipende da un difetto del sistema nervoso periferico. La “sede” iniziale è il surrene, e purtroppo si tratta di una patologia che ha ancora una bassa percentuale di guarigione: solo il 20-30% dei casi supera la malattia.
Cosa avete scoperto?
Lavorando su quelle mutazioni che potessero avere un risvolto clinico, la maggior parte colpiva geni coinvolti nel meccanismo di riparazione del DNA. E questa è la grande potenzialità dello studio: quelle mutazioni possono diventare bersagli terapeutici come già avviene con i geni BRCA1 e BRCA2, mutati anche nel cancro alla mammella e in quello ovarico. Nei soggetti portatori di queste mutazioni, i farmaci agiscono in modo selettivo. Si fa negli adulti, e allora ci siamo chiesti: possiamo farlo anche nei bambini?
E qual è stata la risposta?
Ci proveremo. Il prossimo obiettivo sarà provare quelle stesse terapie con studi ad hoc per i bambini. Nel frattempo, continueremo ad allargare la casistica dei campioni e valutare la funzione di queste mutazioni in linee cellulari di neuroblastoma.
I “casi” analizzati provenivano tutti dall’Italia?
Sì, e ci tengo a ringraziare l’Istituto Giannina Gaslini di Genova che dispone di una biobanca centralizzata di Dna e altro materiale biologico sul neuroblastoma. La ricerca, tra
Mario Capasso, laureato in Biotecnologie all’Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli e Dottore di ricerca in Medicina Molecolare, fin dal 2001 ha svolto ricerca in diversi istituti italiani ed esteri. Professore Associato di Genetica Medica alla Federico II, è responsabile del servizio di Bioinformatica per NGS al CEINGE. I suoi interessi di ricerca sono incentrati sulla genomica traslazionale applicata ai tumori pediatrici. Nel 2010 ha ricevuto il Guido Paolucci International Award per il miglior articolo scientifico in oncologia pediatrica.

l’altro, è stata finanziata dalla OPEN Onlus, Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma e Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Inoltre, tutti i dati genetici sono stati resi disponibili in un database online che altri studiosi potranno liberamente consultare per sviluppare nuove ricerche.
Se volesse riassumere, dati alla mano, quello che è emerso dallo studio cosa potrebbe dire?
Che il 12% dei bambini malati presentava almeno una mutazione ereditata tra le 116 patogeniche che abbiamo individuato in diversi geni. Si può ipotizzare, allora, una oncopredisposizione e, con questa capacità predittiva, potremo rispondere a nuove domande, come per esempio: si può calcolare il rischio di ammalarsi? Per arrivare a un responso, saranno necessari nuovi studi prospettici.

La prospettiva qual è?
È una prospettiva davvero interessante, perché, se la risposta a quella domanda fosse affermativa, si potranno strutturare protocolli di prevenzione e sorveglianza. I risultati ottenuti finora – e quelli che, speriamo, arriveranno – sono utili a migliorare la diagnosi rendendola sempre più precoce e certa e a migliorare la gestione clinica del paziente indirizzando il medico verso l’utilizzo di trattamenti personalizzati. Senza contare che possono aiutare anche a comprendere meglio i meccanismi molecolari alla base dello sviluppo di malattie non oncologiche.
Intervista a Monica Pagani: “Le emozioni, i pensieri e le risposte metaboliche nei diversi organi sono in funzione di ciò che abbiamo introdotto”
“Siamo ciò che mangiamo” e “mens sana in corpore sano” sono due aforismi entrati ormai di pieno diritto nel nostro linguaggio comune. Forse un po’ meno nella nostra quotidianità a tavola, considerato che circa tre milioni di italiani, pari al cinque per cento dell’intera popolazione, soffre di disturbi alimentari. Di questo e molto altro ancora abbiamo parlato con la dottoressa Monica Pagani, biologa nutrizionista, ideatrice di un metodo di ricerca in un ambito in cui la Fnob promuoverà eventi nazionali di formazione dedicati a laboratoristi, nutrizionisti, cosmetologici e nutrizionisti dello sport.
Dottoressa Pagani, perché è ancora così difficile imparare a instaurare un rapporto corretto con il cibo?
Le difficoltà di rapportarsi con il cibo sono spesso legate alle emozioni. Il cibo ingerito infatti produce reazioni a livello del sistema metabolico ormonale e per questo motivo è molto importante la scelta della molecola da introdurre all’interno del nostro organismo. Quale carburante scegliamo per il nostro motore metabolico? Le emozioni, i pensieri e le risposte metaboliche nei diversi organi sono in funzione di ciò che abbiamo introdotto. Nel “momento emozionale” la scarica ormonale adrenalinica è spinta al
massimo, è un’accelerazione metabolica a tutti gli effetti. Le emozioni arrivano all’improvviso, in una manciata di secondi. In quel preciso istante possiamo solo fare appello a tutte le nostre capacità di self-control per mantenere il nostro equilibrio psico-fisico. Il controllo delle emozioni, il mantenimento dell’equilibrio dell’esplosione delle nostre emozioni ci permetteranno di entrare in contatto con ogni singola cellula del nostro corpo e comprendere cosa significa “controllo”. Fondamentale è mantenere e modulare l’equilibrio sull’asse intestino-cervello. La nostra scelta alimentare e non solo produce nel nostro organismo una cascata di reazioni fino a livello cellulare. La connessione tra intestino e cervello è alla base del ciclo metabolico ormonale, ecco perché è importante instaurare un rapporto corretto con il cibo. Le emozioni ci portano a prendere decisioni e influiscono sul benessere, sulle attività e sulle nostre capacità di relazione. Mangiare troppo o troppo poco, abbinare male gli alimenti, scegliere l’alimento “giusto” per ognuno di noi, allenarsi troppo o in modo sbagliato possono tradursi in alterazioni delle nostre condizioni fisiche. Ricordiamoci che non tutto quello che “fa bene” fa necessariamente bene a tutti. Ognuno di noi “funziona” in modo diverso. Le risposte cellulari possono essere differenti in ognuno di noi.
Una metodica da lei utilizzata per osservare importanti informazioni sullo stato di salute prevede l’analisi di una goccia di sangue attraverso un particolare microscopio. Ci spiega i dettagli?
L’utilizzo del microscopio per lo studio e l’osservazione delle cellule ci aiuta a monitorare nel tempo i cambiamenti che avvengono all’interno del nostro organismo, osservando i globuli rossi e bianchi presenti all’interno di una goccia di sangue attraverso la tecnica della microscopia in campo oscuro. Con questa metodica è possibile osservare strutture batteriche di piccole dimensioni ben al di sotto del potere di risoluzione del microscopio ottico in campo chiaro. La microscopia in campo oscuro, che permette di analizzare un campione ematico a un ingrandimento di circa 1300 volte, rivela cambiamenti della funzionalità delle cellule sanguigne, come pure delle deposizioni di fibrina (proteiche) che possono precedere uno stato patologico. Non sostituisce il convenzionale “quadro ematologico”, ma lo completa. Si possono così trovare indicazioni su problemi intestinali, linfatici o derivanti da focolai, debolezze del sistema immunitario oppure la tendenza verso un’allergia. La microscopia in campo oscuro monitora lo stato infiammatorio che è alla base di ogni stato patologico. La forma, la dimensione, il comportamento delle cellule del sangue possono essere indicative per lo studio dinamico della biologia dell’organismo.
Uno stile di vita sano è anche una questione di feeling cinofilo, secondo lei. Cioè?
Il feeling e l’emozione che si crea e sviluppa tra noi e il nostro amico a quattro zampe sta tutta nella chimica dello sguardo. Quando i nostri cani ci guardano negli occhi, leggono il nostro umore, sentono l’odore dei nostri ormoni della gioia, della serenità, dello stress, dell’ansia, che sono prodotti dal cervello in relazione a come funziona il nostro intestino. Se mangio “bene”, assumo i macro e micronutrienti di cui ho bisogno, elimino le tossine, sono sgonfio e piatto, allora sto bene. In questo modo l’intestino comunica con il cervello per la produzione degli ormoni della serenità e del benessere e di conseguenza questa combinazione chimica e biochimica ha influenze sul nostro comportamento. Contrariamente, otterrò produzione di stress e ansia. Il nostro cane sente questi ormoni con il naso, legge il nostro umore e il nostro comportamento. Questo feeling io lo chiamo “la magia dello sguardo”. I miei cani da soccorso e salvataggio aiutano nella prevenzione di problemi comportamentali, nutrizionali e fisici.
La dottoressa Monica Pagani è Biologa Nutrizionista. Si occupa di nutrizione e nutrigeno-mica, settore specialistico della genetica, che si occupa della relazione tra il cibo e i geni. Tra i titoli conseguiti: Master in Disturbi dello Spettro Autistico; Specializzazione e Certifi-cazione in Omotossicologia, International Academy for Homotoxicology; Specializzazione in Nutrizione. Scuola in Nutrizione Clinica Lipidomica, Stress e Nutraceutica. La Nutrigene-tica. Corso di Lettura in Campo Oscuro in NanoMicroscopia. Personal Trainer e Istruttore di Fitness. Istruttore Cinofilo Nazionale.

Il rapporto con l’animale è in grado di arrecare non solo benefici emotivi, ma anche fisici come l’abbassamento della pressione sanguigna e il rallentamento del battito cardiaco.
Nutrizione, intestino, cervello e sport sono i quattro cardini fondamentali su cui, secondo lei, si fonda il benessere di una persona. Qual è il contributo apportato da ciascuno di essi e come si fondono tra di loro?
Usiamo ogni singolo alimento come fosse un tassello di un puzzle per costruire il nostro equilibrio di vita. Quello che mangiamo è in grado di infiammarci o sfiammarci. Ecco perché è così importante la scelta delle materie prime per ognuno di noi. La combinazione nutrizionale, selezionata e di qualità per una proposta ad azione anti-infiammatoria e di prevenzione, è personalizzata secondo abbinamenti selezionati. Sfruttiamo il potere di ogni singolo alimento per raggiungere il nostro equilibrio metabolico ormonale. La serotonina è un neurotrasmettitore che funziona come ormone, è prodotta dal cervello e dall’intestino al 95 per cento. Ha un’importanza fondamentale per l’intestino perché agisce sul movimento intestinale, peristalsi, sull’assorbimento, sull’attività immunitaria, sul dolore enterico oltre che avere un effetto antidepressivo, ansiolitico, rilassante e favorisce la memoria. Bassi livelli di serotonina portano a stati infiammatori, come fermentazione intestinale, stress, alti livelli di cortisolo, difficoltà digestiva. Lo sport è in grado di ridurre lo stress, l’ansia e depressione. Aiuta a regolarizzare il sonno e migliora la concentrazione sul lavoro e nello studio. Facciamo prevenzione sfruttando anche i benefici dell’attività fisica sportiva. Credo fermamente che questi quattro cardini siano alla base della prevenzione per la nostra salute e benessere, tanto che ho fondato la International Academy N.I.C.S.® Nutrizione Intestino Cervello Sport.

Il processo è determinato dal collasso dei lipidi all’interno del reticolo endoplasmatico e può essere sfruttato nella terapia del cancro e delle malattie neurodegenerative
Un nuovo studio pubblicato su Nature Chemical Biology offre nuovi dettagli sulla ferroptosi, una forma di morte cellulare che è stata scoperta nel 2012 alla Columbia University e che rappresenta una potenziale via di trattamento nei confronti di malattie anche letali come il cancro.
La ferroptosi è una forma di morte cellulare ossidativa, non apoptotica, dipendente dal ferro e strettamente legata al metabolismo e alle malattie. Nel laboratorio guidato dal dottor Stockwell, i ricercatori studiano con strumenti chimici e biologici come la ferroptosi si attiva durante i normali processi fisiologici e negli stati patologici e come può essere indotta e inibita per ottenere benefici terapeutici in vari tipi di cancro e malattie neurodegenerative.
Il nuovo lavoro, intitolato “Identification of Essential Sites of Lipid Peroxidation in Ferroptosis”, identifica per la prima volta che nella ferroptosi la morte cellulare è determinata dal collasso dei lipidi all’interno del reticolo endoplasmatico, struttura che circonda il nucleo della cellula. Quando i lipidi che compongono parzialmente il reticolo endoplasmatico si
combinano con l’ossigeno, la ricerca rileva che la membrana si stacca, determinando il collasso della cellula. Sebbene gli scienziati abbiano ipotizzato che molte parti diverse della cellula potrebbero essere fondamentali nella ferroptosi, questa ricerca evidenzia l’importanza centrale del reticolo endoplasmatico. Secondo gli autori dello studio, la scoperta potrebbe aiutare gli scienziati a progettare terapie migliori e più mirate che inducano o fermino la ferroptosi per trattare gravi malattie letali come il cancro.
La ricerca è stata condotta dai laboratori del professor Brent Stockwell e del professor Wei Min della Columbia e dal laboratorio del dottor Keith Woerpel della New York University.
«Questa ricerca rappresenta un altro importante passo avanti nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di questa tipologia di morte cellulare e ci è di aiuto per capire come possiamo sfruttare la ferroptosi per salvare vite umane», ha dichiarato Stockwell.
Stockwell ha identificato per la prima volta la ferroptosi come una forma distinta di morte cellulare nel 2012, più di un decennio dopo aver osservato alcune cellule tumorali che, trattate con una sostanza chimica specifica, mori-
vano in modo diverso dalla maggior parte delle cellule. Invece di formare vesciche, dette blebs, e poi far collassare il nucleo, queste cellule sembravano morire principalmente a causa della disgregazione degli strati lipidici.
Da quando Stockwell ha scoperto la ferroptosi, lui e molti altri ricercatori hanno continuato a studiarla. Hanno individuato che la ferroptosi può verificarsi sia in contesti sani, come modo in cui le cellule resistenti si autodistruggono una volta invecchiate, sia in situazioni patologiche, quando le cellule normali muoiono prima del dovuto. È quest’ultimo contesto che rende la ferroptosi promettente per il trattamento delle malattie: essere in grado di indurre intenzionalmente la ferroptosi potrebbe aiutare a fermare la divisione incontrollata di alcune cellule tumorali. Inoltre, capire meglio perché la ferroptosi si verifica in malattie neurologiche come la malattia di Huntington, il Parkinson, l’Alzheimer e il morbo di Lou Gehrig potrebbe aiutare gli scienziati a capire come fermare la morte cellulare per ferroptosi quando non dovrebbe verificarsi.
La ferroptosi rappresenta una potenziale via di trattamento per i tumori resistenti ai farmaci e può svolgere un ruolo nella patologia di alcune malattie degenerative.


Attraverso l’integrazione di biochimica, chimica organica sintetica, chimica computazionale, biofisica e chimica analitica, il laboratorio di
Stockwell mira a produrre potenti terapie determinando nuovi meccanismi d’azione coinvolti nella morte cellulare e in particolare nella ferroptosi. In particolare, l’identificazione delle membrane subcellulari essenziali per la ferroptosi e la sequenza della loro perossidazione guideranno le strategie di scoperta dei farmaci e i meccanismi patologici rilevanti per la ferroptosi. «In questo studio – spiega Stockwell - abbiamo impiegato l’imaging a fluorescenza e la diffusione Raman stimolata per esaminare la relazione tra struttura-attività-distribuzione dei composti che modificano la ferroptosi». «Abbiamo scoperto – prosegue l’autore - che, sebbene la perossidazione lipidica in varie membrane subcellulari possa indurre la ferroptosi, la membrana del reticolo endoplasmatico (ER) è un sito chiave della perossidazione lipidica».
«I nostri risultati – conclude Stockwell - suggeriscono un modello di progressione ordinata della perossidazione di membrana durante la ferroptosi, che si accumula inizialmente nella membrana ER e successivamente nella membrana plasmatica».
Gli autori concludono quindi che la progettazione di inibitori e induttori della ferroptosi mirati all’ER può essere utilizzata per controllare in modo ottimale la dinamica della perossidazione lipidica nelle cellule sottoposte a ferroptosi finalizzata allo sviluppo di nuove terapie.
Un innovativo studio sui linfomi dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari fa passi in avanti verso terapie sempre più personalizzate ed efficaci
Tra i vari tipi di tumore, il linfoma diffuso a grandi cellule B è il più frequente e tra i più aggressivi. Un recente studio dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari in collaborazione con l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, ha dato nuove speranze. La ricerca, pubblicata sulla rivista internazionale “Hematological Oncology” è stata condotta presso il laboratorio di diagnostica ematologica e terapia cellulare, guidato dal dottor Sabino Ciavarella, affiliato all’Unità di Ematologia.
I risultati hanno svelato una correlazione tra metabolismo del colesterolo e i macrofagi, le cellule immunitarie incaricate di ripulire l’organismo da cellule malate come quelle tumorali. Il lavoro che il team porta avanti da circa due anni è orientato a comprendere i nuovi meccanismi e i fattori biologici in grado di predire la risposta ai farmaci. Un salto di qualità è stato fatto anche grazie a complesse analisi di Big Data clinici e molecolari raccolti in database internazionali ed esplorati dai ricercatori attraverso interrogazioni bioinformatiche.
Lo studio si inserisce in un innovativo filone, sempre più rilevante negli ultimi anni nella scienza oncoematologica, volto a comprendere tutto ciò che vive intorno alla cellula tumorale: il microambiente. Un insieme di cellule non neoplastiche che risentono nel comportamento biologico dell’azione e dell’influenza delle cellule tumorali. Data la sua “vicinanza” con le cellule malate, il microambiente condiziona lo sviluppo e la progressione della malattia. «Ci si è resi conto che non è solo la cellula malata a guidare il comportamento della malattia ma tante altre componenti come macrofagi, linfociti, neutrofili, pur non essendo dannose di per sé, producono effetti che possono essere anti o pro-tumorali» aggiunge l’oncoematologo responsabile del laboratorio barese.
Nello specifico, gli studiosi si sono interrogati sul funzionamento di alcune delle cellule al suo interno come i macrofagi che si possono classificare in due modalità contrastanti. I pro-infiammatori o antitumorali e gli immunosoppressori che, al contrario, riducono la capacità del sistema immunitario favorendo indirettamente la progressione del
cancro. «Perché in due persone diverse con la medesima malattia, la stessa situazione clinica e lo stesso numero di macrofagi, la risposta alla stessa terapia può risultare differente?» si chiedono gli autori della ricerca.


Occorre spiegare che i macrofagi sono influenzati nella loro funzione da alcuni recettori nucleari denominati LXR (Liver-X-receptors). Essi «fungono da fattori di trascrizione: a stimolo recepito determinano una modifica nel DNA della cellula, modificando l’espressione di alcuni geni che andranno ad impattare sulla funzione del macrofago stesso» precisa Ciavarella. In questo caso, entra in gioco “lo stimolo” ovvero l’ossisterolo, una sostanza chimica derivata dal metabolismo del colesterolo, necessaria alla sopravvivenza delle cellule. Questa piccola molecola potrebbe avere variabili livelli di concentrazione atti ad influenzare il comportamento dei macrofagi.
Per la prima volta, infatti, l’espressione LXR è stata correlata con una funzione macrofagica pro-infiammatoria. Lo studioso spiega che «i tumori che avevano dentro più macrofagi che esprimevano maggiormente il recettore LXR erano quelli pro-infiammatori ed erano significativamente associati ad una migliore risposta ai farmaci». Sui soggetti valutati, i risultati hanno mostrato che, a parità di trattamento, le persone con una minore espressione del recettore sono quelle a più alto rischio e rispondono peggio alle cure, ma con la modulazione di questo recettore potrebbero migliorare l’andamento della malattia.
Nello stesso lavoro, è stato fatto un passo avanti anche nelle terapie, i ricercatori hanno sperimentato (in vitro) un farmaco già in cor-
Lo studio si inserisce in un innovativo filone, sempre più rilevante negli ultimi anni nella scienza oncoematologica, volto a comprendere tutto ciò che vive intorno alla cellula tumorale: il microambiente.
Kateryna Kon/shutterstock.comso di valutazione clinica sull’uomo per valutarne l’efficacia sul linfoma,
Il vero successo, ci tiene a sottolineare Ciavarella, è che in futuro attraverso un farmaco si possa modificare la funzione macrofagica, rendendola positiva contro il tumore. La terapia farmacologica diventerebbe innovativa poiché non si “combatterebbe” direttamente la cellula tumorale, ma quelle che le stanno intorno. Il lavoro compiuto assume anche una valenza prognostica. Attraverso una tecnologia denominata Nanostring è già possibile misurare l’espressione di LXR direttamente al momento della diagnosi, senza ulteriori analisi o esami invasivi per il paziente. Un innovativo studio che pone oggi, sotto diversi aspetti, un tassello importante nel progresso scientifico in oncoematologia.
©
Il laboratorio barese, in stretta collaborazione con biologi e biotecnologi del CNR Nanotech di Lecce, sta sviluppando un modello organoide di linfonodo in vitro. Un prototipo che servirà, nel nuovo studio in corso, a capire nel dettaglio i meccanismi di funzionamento del recettore ed a valutare l’efficacia dei farmaci sui macrofagi. Inoltre, la Fondazione Italiana Linfomi ha dato ai ricercatori l’accesso ad un’ampia casistica di dati, interi protocolli clinici per poter perfezionare lo studio.

Una ricerca pubblicata su Brain, a cura delle Università di Torino e Colonia, osserva le mutazioni di CAPRIN1 responsabili di una forma rara
Un’altra tessera nel mosaico di conoscenze sullo spettro autistico si aggiunge grazie a uno studio sulle mutazioni del gene CAPRIN1. I ricercatori, coordinati da Alfredo Brusco, docente del dipartimento di Scienze mediche dell’Università di Torino e della Genetica medica universitaria della Città della Salute di Torino, in collaborazione con l’Università di Colonia, hanno dimostrato il ruolo del gene nello sviluppo di una rara forma di autismo. Il lavoro, pubblicato sulla rivista “Brain”, si è basato sullo sviluppo di modelli in vitro di cellule neuronali e sulle nuove tecnologie di sequenziamento del DNA.
La ricerca ha dimostrato che perdere una delle due copie di CAPRIN1 causa un’alterazione della organizzazione, della funzione dei neuroni e della loro attività elettrica. «Abbiamo utilizzato la tecnologia CRISPR/Cas9 per modificare cellule pluripotenti umane in coltura in modo da spegnere una delle due copie del gene, mimando così la situazione dei pazienti», spiega Lisa Pavinato, dottoranda presso il dipartimento di Scienze mediche dell’ateneo.
L’importanza dello studio risiede nella definizione del ruolo biologico del gene, in quanto «codifica – continua la ricercatrice -
per l’omonima proteina CAPRIN1, la quale è stato dimostrato ha un ruolo fondamentale per il mantenimento dei network neuronali, per la plasticità sinaptica e per la formazione di memoria a lungo termine. CAPRIN1 interagisce con molte proteine che a loro volta hanno un ruolo chiave per il funzionamento neuronale; prima tra tutte la proteina FMRP (Fragile X Mental Retardation Protein), che è codificata dal gene FMR1, associato ad una delle più comuni cause genetiche di disabilità intellettiva (la Sindrome dell’X-Fragile). Il nostro studio e altri (Viegas et al., 2022 Developmental Cell), hanno dimostrato un ruolo importante di CAPRIN1 per il controllo della stabilità degli mRNA e per il controllo della traduzione proteica, con importanti risvolti su decine di proteine. E’ probabile che CAPRIN1 agisca perciò come un attore principale nel controllo e la regolazione di molte proteine coinvolte nel funzionamento neuronale, che a loro volta sono possibili candidate per essere coinvolte in disordini del neurosviluppo».
Questa ultima ricerca segue una serie di lavori pubblicati nel contesto del Progetto NeuroWES, guidato dai professori Brusco e Giovanni Battista Ferrero del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, che ha
contribuito a chiarire le basi genetiche del disturbo dello spettro autistico. L’analisi di centinaia di pazienti ha permesso di individuare un caso piemontese in cui era persa un’ampia regione di un cromosoma che comprendeva il gene CAPRIN1. Questa iniziale osservazione ha permesso di ipotizzare il ruolo di CAPRIN1 nella patogenesi dell’autismo e la successiva identificazione di 12 pazienti con una mutazione nel gene ne ha dimostrato il ruolo patogenico.
I risultati ottenuti sono tuttavia solo la punta di un iceberg. Sono infatti previste altre ricerche che possano approfondire. «Stiamo –aggiunge Pavinato - continuando a reclutare pazienti con varianti nel gene CAPRIN1, con l’obbiettivo di espandere e/o rafforzare sia le caratteristiche cliniche dei pazienti CAPRIN1 sia il ventaglio di mutazioni in essi riscontrate. A livello funzionale stiamo continuando a studiare il ruolo della proteina CAPRIN1 mediante l’utilizzo di diversi modelli cellulari, inclusi neuroni derivati da cellule staminali pluripotenti indotte. Essendo CAPRIN1 una proteina chiave per la funzionalità neuronale ed interagendo con molte altre proteine, pensiamo che i nostri studi avranno un impatto anche per la caratterizzazione di altri geni malattia».

L’identificazione di nuovi geni associati a forme di disturbo dello spettro autistico è in evoluzione, l’osservazione introduce alla strada per una corretta diagnosi: «in questo momento – continua - stiamo a poco a poco correlando diversi geni a disordini del neuro-
L’identificazione di nuovi geni associati a forme di disturbo dello spettro autistico è in evoluzione, l’osservazione introduce alla strada per una corretta diagnosi.
 © Marian Weyo/shutterstock.com
© Marian Weyo/shutterstock.com
L’ autismo è un disturbo del neurosviluppo che esordisce nei primi anni di vita e colpisce l’1% della popolazione manifestandosi con una vasta gamma di presentazioni cliniche e diversi livelli di gravità. Solo negli ultimi decenni è stata introdotta nella pratica clinica la definizione dello spettro autistico dal momento che la presentazione dei disturbi è estremamente eterogenea e correlata a numerosi sottogruppi clinici con specifiche basi biologiche. Grazie ai progressi nello studio del genoma umano, negli ultimi anni, inoltre, è stata dimostrata la base genetica di molte condizioni caratterizzate da manifestazioni che rientrano nei disturbi dello spettro autistico.
sviluppo; oggi sono circa cento, ma si stima che diverse centinaia di geni possano essere coinvolti in queste condizioni. Dietro questo tipo di lavoro ci sono anni di studi, determinati in prima fase dal reclutamento di un numero ragionevole di pazienti con mutazioni nello stesso gene e caratteristiche cliniche sovrapponibili. Ricevere una diagnosi genetica per le famiglie significa spesso ricevere finalmente una risposta, mettendo talvolta un punto ad anni di ricerche che non avevano dato i frutti sperati; ampliare perciò il pannello di geni associati a diverse condizioni è di fondamentale importanza. Penso – conclude - che al momento siamo ancora lontani dalle terapie, ma sicuramente ci si sta iniziando a muovere anche in questo senso». (E. G.)

Lo dicono i dati di una recente ricerca dell’Università della California di San Diego
di Domenico Esposito
Un recente studio, pubblicato sulla rivista “Alzheimer’s & Dementia”, ha dimostrato mediante l’utilizzo di accelerometri che livelli più elevati di attività fisica moderata-vigorosa e di camminate giornaliere sono associati ad un rischio minore di decadimento cognitivo lieve e di demenza nelle donne dai 63 anni in su. Inoltre, lo studio, condotto da un team di ricercatori dell’Università della California di San Diego, ha rilevato che le passeggiate di intensità moderata-vigorosa, ma non quelle leggere, sono associate ad un rischio inferiore di declino cognitivo. Ciò fornisce un’indicazione importante sul fatto che per prevenire o ritardare il declino cognitivo non sia importante soltanto svolgere l’attività fisica, ma anche l’intensità con cui questa viene effettuata.
L’assenza di trattamenti efficaci per la demenza fa sì che molti scienziati in giro per il mondo siano alla ricerca di strategie efficaci, molte delle quali fondate sul mantenimento di uno stile di vita sano, in grado attenuare i fattori di rischio della demenza. Già in passato alcuni studi avevano dimostrato che maggiori livelli di attività fisica e minori comportamenti sedentari potrebbero ridurre le probabilità di incorrere in questo tipo di disturbo, ma si erano basati generalmente su resoconti personali con un’accuratezza limitata. Da qui la decisione di utilizzare un accelerometro, in grado di fornire valutazioni oggettive dell’attività fisica svolta e dei comportamenti sedentari che i questionari autodichiarati non possono valutare con precisione.

Il dottor Raphael Wald, neuropsicologo del Baptist Health Marcus Neuroscience Institute, in relazione alla ricerca ha parlato di «un modo per confermare ulteriormente ciò che già sapevamo, sottolineando l’importanza di un esercizio fisico da moderato a vigoroso. Lo studio ha dimostrato anche che non esiste un vero e proprio limite ai guadagni cognitivi che si possono ottenere con l’attività fisica. Più si può fare in sicurezza, più si riduce il rischio di declino cognitivo». Più in particolare, la ricerca ha rilevato che 31 minuti aggiuntivi di attività fisica giornaliera moderata-vigorosa sono associati a una riduzione del rischio di deterioramento cognitivo lieve o demenza del 21%. Allo stesso modo, l’inclusione di 1.865 passi in più nella routine quotidiana è stata associata ad un rischio di declino cognitivo inferiore del 33%.
In attesa di essere replicata in studi successivi, la quantificazione del numero di passi giornalieri associati ad un minor rischio di declino cognitivo
potrebbe aiutare a sviluppare linee guida per la salute pubblica.
Il presente studio ha riguardato 1.277 donne con un’età media di 82 anni arruolate nella Women’s Health Initiative, uno studio a lungo termine volto a prevenire le condizioni croniche nelle donne in postmenopausa. Le partecipanti allo studio non presentavano sintomi di deterioramento cognitivo lieve o demenza all’inizio dello studio. I ricercatori hanno anche effettuato valutazioni cognitive annuali per telefono per identificare eventuali casi insorti durante lo studio. Monitorando i partecipanti per un follow-up medio di 4,2 anni, è emerso che a 267 persone è stato diagnosticato un lieve deterioramento cognitivo o una probabile demenza.
La ricerca ha rilevato che 31 minuti aggiuntivi di attività fisica giornaliera moderata-vigorosa sono associati a una riduzione del rischio di deterioramento cognitivo lieve o demenza del 21%. Allo stesso modo, l’inclusione di 1.865 passi in più nella routine quotidiana è stata associata ad un rischio di declino cognitivo inferiore del 33%. In attesa di essere replicata in studi successivi, la quantificazione del numero di passi giornalieri associati ad un minor rischio di declino cognitivo potrebbe aiutare a sviluppare linee guida per la salute pubblica.
I ricercatori hanno suddiviso i partecipanti in quattro gruppi uguali in base all’esecuzione di ogni specifico movimento fisico, tra cui l’attività fisica di intensità leggera, l’attività fisica moderata-vigorosa e il tempo trascorso seduti o sdraiati. Le partecipanti con livelli di attività fisica moderata-vigorosa più intensa presentavano un rischio di decadimento cognitivo lieve inferiore del 36% rispetto a quelle nel gruppo più basso. La differenza nel rischio di demenza non era statisticamente significativa. Tuttavia, le partecipanti al gruppo più alto di passi giornalieri (almeno 4.050 passi al giorno) presentavano un rischio di decadimento cognitivo lieve inferiore del 64% e un rischio di sintomi di demenza inferiore del 52% rispetto alle donne del quartile più basso (meno di 1.867 passi).
La demenza è un gruppo di condizioni neurologiche caratterizzate da deficit nel pensare, ricordare e ragionare. La gravità di questi deficit interferisce con la quotidianità ed è più pronunciata del declino delle funzioni cognitive osservato durante l’invecchiamento sano. D’altra parte, il decadimento cognitivo lieve è una condizione che comporta deficit nel pensiero o nella memoria che, a differenza della demenza, non sono abbastanza gravi da interferire con le attività quotidiane. Questo si configura spesso come una fase intermedia tra l’invecchiamento tipico e la demenza, ma non sempre i soggetti che ne sono affetti finiscono per sviluppare la demenza.
Il dottor Wald ha chiosato: «Ritengo che questo studio sia particolarmente utile in quanto sempre più persone si rivolgono alla tecnologia per motivarsi a mantenersi in forma. Fornisce numeri solidi a cui le persone possono aspirare per ottenere miglioramenti cognitivi».

Un nuovo studio di ricercatori americani ha dimostrato che sono in grado di monitorare i processi cellulari nel cervello nei primi due anni di vita

Lo sviluppo del cervello umano è un processo complesso e prolungato che inizia durante la terza settimana di gestazione e si estende fino all’età adulta. Durante il tardo periodo prenatale e la prima infanzia, una miriade di processi cellulari determinano la rapida crescita del cervello del neonato durante i primi due anni di vita, con conseguenti cambiamenti strutturali e riorganizzazione dei circuiti neurali. Una quantificazione precisa della crescita precoce del cervello sarebbe in grado di favorire un cambiamento radicale nella nostra comprensione dei processi che portano alla maturazione delle funzioni cognitive. Tuttavia, gli sforzi in questa direzione sono stati finora ostacolati dalla scarsità di atlanti cerebrali per la mappatura delle caratteristiche dello sviluppo cerebrale precoce. Mediante questi atlanti, i medici sono infatti in grado di osservare come si presenta lo sviluppo strutturale e funzionale del cervello, rendendo più facile individuare i sintomi di uno sviluppo anomalo, come il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, la dislessia e la paralisi cerebrale.

Basta probabilmente questa breve premessa a sottolineare l’importanza dello studio condotto da Pew-Thian Yap, professore del Dipartimento di Radiologia della University of North Carolina Health Care, negli Stati Uniti. Il docente, insieme ai colleghi del dipartimento e del Biomedical Research Imaging Center (BRIC), è riuscito nell’impresa di creare una nuova serie di atlanti cerebrali infantili in grado di registrare, mese per mese, i dettagli del cervello in fase di sviluppo da un punto di vista spazio-temporale.
Nello studio in questione, fresco di pubblicazione sulla rivista “Nature Methods”, gli scienziati hanno dato vita ad una serie di atlanti cerebrali utilizzabili nei bambini di età compresa tra le due settimane e i due anni di vita. Il professor Yap non ha nascosto la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, soprattutto immaginando gli utilizzi che i medici potranno fare in futuro della scoperta: «I nostri atlanti - ha spiegato - saranno una risorsa preziosa per gli scienziati del cervello per svelare i caratteri essenziali, tanto quelli normali quanto quelli abnormi, di quella che è probabilmente la fase più importante dello sviluppo del cervello umano».
Come detto, quando lo sviluppo non procede secondo i giusti schemi, le conseguenze dannose possono avere un impatto negativo sulla qualità
Lo studio condotto da Pew-Thian Yap, professore del Dipartimento di Radiologia della University of North Carolina Health Care, negli Stati Uniti, insieme ai colleghi del dipartimento e del Biomedical Research Imaging Center (BRIC), ha creato una nuova serie di atlanti cerebrali infantili in grado di registrare, mese per mese, i dettagli del cervello in fase di sviluppo da un punto di vista spazio-temporale.
della vita dell’individuo; esiste infatti un marcato incremento del rischio di sviluppare autismo, schizofrenia, disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Mediante l’utilizzo di atlanti nel cervello dei neonati, i ricercatori si sono invece dimostrati in grado di fotografare cambiamenti eterogenei inerenti alla struttura cerebrale. Fra gli altri fattori che gli atlanti cerebrali sono stati capaci di tenere sotto stretto controllo c’è anche quello della geometrica corticale. Una “unità di misura” spesso utilizzata è lo spessore corticale, considerato in termini di neuroanatomia lo spessore della materia grigia del cervello, ovvero lo strato più esterno del tessuto delle cellule nervose. L’atlante cerebrale infantile sviluppato dagli scienziati a stelle e strisce è stato in grado di mostrare che lo spessore corticale cresce velocemente durante il primo anno di vita e in maniera più lenta nel secondo. Ma c’è di più: gli atlanti hanno infatti rivelato che le cortecce delle regioni temporali, parietali e prefrontali del cervello sono più spesse delle cortecce visive e sensomotorie primarie. Ciò è coerente con la scoperta che le funzioni di ordine superiore del cervello infantile - come l’attenzione, la memoria di lavoro, l’inibizione e la risoluzione dei problemi - maturano più lentamente rispetto alle aree del cervello responsabili delle funzioni visive, motorie e sensoriali.

Nel complesso, l’atlante registra accuratamente l’andamento di crescita cerebrale del neonato e lo fa con ricchi dettagli anatomici. Questi strumenti sono stati infatti in grado di registrare i cambiamenti mensili nelle dimensioni, nella forma e nella geometria corticale dei cervelli in normale sviluppo, nonché il contrasto tissutale, il volume e le caratteristiche microstrutturali da due settimane a due anni di età.
Il professor Yap, a proposito della scoperta del team di ricerca, ha chiosato: «Speriamo che questi atlanti diventino un modello di coordinamento comune per facilitare la scoperta di nuove conoscenze sui processi di sviluppo alla base della cognizione e del comportamento sociale dei bambini». Quella messa a punto dagli studiosi americani è una preziosa risorsa per consentire a scienziati di tutto il mondo di studiare con una strumentazione ad elevata sensibilità lo sviluppo postnatale del cervello umano, identificando in questo modo le prime radici dei disturbi neurologici e quantificare le malformazioni legate allo sviluppo nella speranza, un giorno, di poter intervenire. (D. E.).
Parte CENIMINT, un progetto in collaborazione fra Fondazione Santa Lucia Irccs e dipartimento di psicologia della Sapienza per conoscere meglio le funzioni cerebrali
Come si formano le immagini e in quali aree vengono conservati i ricordi. In che misura cambiano i meccanismi cerebrali dall’età pediatrica a quella senile. E infine come le strategie di neuroriabilitazione sviluppano la riserva cognitiva, utile a proteggere in caso di malattia del sistema nervoso centrale. Queste alcune delle attività previste dal CENIMINT, Centro neuroimmagini multimodali integrate, un progetto nato dalla collaborazione tra la Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma, ospedale di neuroriabilitazione e istituto di ricerca in neuroscienze, e il dipartimento di Psicologia di Sapienza Università di Roma.
L’obiettivo è applicare un approccio multimodale allo studio del cervello, associando tecniche avanzate di neuroimaging non invasivo, grazie alla potente e innovativa risonanza magnetica a 3 Tesla, all’analisi del segnale neuroelettrico dell’elettroencefalogramma. Il mix di competenze, strumenti sofisticati e indagini multidisciplinari permetterà di conoscere più a fondo struttura, funzionamento e connettività cerebrale in relazione con i diversi fenomeni mentali. Un sogno che si av-
vera per molti ricercatori impegnati in diversi settori che potranno così studiare gli effetti dell’intervento psicologico e neuropsicologico, individuare le migliori pratiche di diagnosi e prevenzione delle malattie neurologiche e le opportune strategie di neuroriabilitazione.
Il progetto parte da basi solide. Anzi, solidissime, se si considera che il Santa Lucia e il dipartimento dell’ateneo romano lavorano insieme già da tre decadi. «Da sempre - commenta il professor Carlo Caltagirone, neurologo e direttore scientifico del Santa Lucia Irccs - la nostra collaborazione si fonda sulla possibilità di realizzare studi clinici e pre-clinici sulla neurobiologia del comportamento e delle funzioni cognitive.
La speranza è sempre quella di trovare delle correlazioni fra la struttura che sostiene il pensiero e il modo di agire, sia in condizione di normalità sia nella patologia. Finalmente oggi, con la risonanza ad alto campo a 3 Tesla, è possibile studiare in maniera intermodale la connettività fra le diverse aree cerebrali, a riposo e durante lo svolgimento di attività cognitive. Questo ci permette di avere informazioni più sofisticate anche perché siamo in
grado di integrarle con il segnale bioelettrico cerebrale. È possibile inoltre con la risonanza magnetica, tramite dei software che permettono di analizzare in dettaglio l’input, ricostruire che cosa l’individuo sta vedendo». Grazie alle tecniche di intelligenza artificiale e della bioinformatica è possibile infatti decodificare il segnale della risonanza, in maniera tale da riconoscere se l’individuo sta guardando una mano oppure il pavimento.
«È un dettaglio – spiega Caltagirone - così sofisticato che ci permette di sapere cosa succede nell’individuo sano e poi nel malato in caso di lesioni del sistema nervoso centrale e capire se c’è la possibilità di trovare soluzioni per la neuroriabilitazione. Nell’individuo sano ciò ci consente di avere informazioni sul funzionamento del cervello ma anche di avere competenze sulla rete di strutture che partecipano a quella determinata funzione cognitiva. Il vantaggio sta nel tipo di risonanza che offre una altissima capacità di risoluzione spaziale, cioè indica con precisione qual è l’area attivata, ma non ha una alta definizione temporale. Il segnale bioelettrico cerebrale è esattamente l’opposto: ha una altissima risoluzione temporale ma una bassa risoluzione spaziale. Metterli insieme ci permette di combinare con chiarezza i segnali e collocarli in maniera precisa. L’applicazione – prevede - potrà essere per esempio il riconoscimento dei pazienti che hanno forme pre-cliniche iniziali di compromissione cognitiva. Per loro sarà possibile anticipare le diagnosi di anni».
I laboratori del progetto saranno all’interno della Fondazione Santa Lucia Irccs. Ciò permetterà l’accesso diretto ad un contesto in cui coesistono ricerca di base e clinica tra -

“È possibile con la risonanza magnetica, tramite dei software che permettono di analizzare in dettaglio l’input, ricostruire che cosa l’individuo sta vedendo.
© DedMityay/shutterstock.comslazionale, fondando il lavoro sulle competenze sviluppate nel servizio di oltre 2mila pazienti ricoverati ogni anno e assistiti negli ambulatori.

Altra nota positiva è la formazione di una nuova generazione di neuroscienziati che coinvolgerà laureandi, dottorandi e specializzandi in attività di frontiera. «La costituzione di un centro di ricerca nel campo delle neuroimmagini - dichiara la professoressa Anna Maria Giannini, psicologa e direttrice del dipartimento - è uno dei punti essenziali del progetto pluriennale di sviluppo del dipartimento, che prevede l’acquisto di sofisticate strumentazioni scientifiche e il reclutamento di giovani ricercatori: progetto grazie al quale abbiamo recentemente ottenuto per la seconda volta consecutiva il riconoscimento come dipartimento di eccellenza».
Un po’ biologia, un po’ programmazione. La bioinformatica da quasi trenta anni vive un momento di fermento grazie al coinvolgimento in numerosissimi progetti di ricerca che richiedono lo studio e l’analisi di dati biologici attraverso sistemi di simulazione matematica. È un campo di indagine interdisciplinare perché non richiede solo l’apporto dei biologi ma anche di fisici, ingegneri, matematici e chimici. In Italia sono attivi vari corsi di laurea specifici.

lavoro di ricerca dimostra che quando un polifenolo reagisce con un amminoacido il suo effetto inibitorio sull’infiammazione nelle cellule immunitarie ne risulta potenziato. Ecco perché è facile immaginare che il cocktail di caffè e latte sia in grado di sortire un effetto benefico sull’infiammazione negli esseri umani. In particolare, gli scienziati hanno osservato che le cellule immunitarie trattate con la combinazione di polifenoli e amminoacidi risultavano due volte più efficaci nel contrastare l’infiammazione rispetto alle cellule cui erano stati aggiunti soltanto polifenoli.
Già in passato alcuni studi avevano dimostrato la capacità dei polifenoli di legarsi alle proteine nei prodotti a base di carne, latte e birra. In questo caso i ricercatori hanno deciso di concentrarsi su un’associazione in particolare, testando cioè se il legame avesse luogo anche in una bevanda al caffè con il latte. Una verifica non scontata visto che i chicchi di caffè sono ricchi di polifenoli mentre il latte è ricco di proteine. Secondo la professoressa Nissen Lund, il risultato della ricerca prova che «la reazione tra polifenoli e proteine avviene anche in alcune delle bevande al caffè con il latte che abbiamo studiato». Effettivamente, ha osservato la docente, la reazione avviene in maniera così rapida che è stato difficile evitarla in tutti gli alimenti studiati finora.
Una tazza di caffè con l’aggiunta di latte, il più classico dei cappuccini, per iniziare meglio la giornata? Un’abitudine diffusa, per molti un rito, ma quanti immaginavano che una simile azione fosse anche in grado di ottenere un effetto antinfiammatorio sull’organismo? A suggerire che il connubio dei due ingredienti possa garantire tale risultato è infatti un nuovo studio condotto dai ricercatori del Dipartimento di Scienze dell’Alimentazione, in collaborazione con i ricercatori del Dipartimento di Scienze Veterinarie e Animali dell’U-

niversità di Copenaghen, che hanno studiato come si comportano i polifenoli quando sono combinati con gli amminoacidi, i cosiddetti “mattoni” delle proteine. Il segreto dietro questa scoperta starebbe proprio nei polifenoli, antiossidanti impiegati anche dall’industria alimentare al fine di rallentare l’ossidazione e il deterioramento della qualità degli alimenti.
La professoressa Marianne Nissen Lund, del Dipartimento di scienze alimentari dell’ateneo danese, coordinatrice dello studio fresco di pubblicazione sul “Journal of Agricultural and Food Chemistry”, ha spiegato che il
Per queste ragioni non è azzardato ipotizzare che la reazione e l’effetto antinfiammatorio potenzialmente benefico si verifichino anche quando ad essere combinati sono altri alimenti costituiti da proteine e frutta o verdura. L’esperta è stata ancora più circostanziata: «Posso immaginare che qualcosa di simile accada, ad esempio, in un piatto di carne con verdure o in un frullato, se ti assicuri di aggiungere proteine come latte o yogurt». Nissen Lund è ottimista sulle prospettive di questa scoperta: «Poiché gli esseri umani non assorbono così tanti polifenoli, molti ricercatori stanno studiando come incapsularli in strutture proteiche che migliorino il loro assorbimento nel corpo». (D. E.).
Un nuovo studio condotto dagli scienziati del Montreal Neurological Institute-Hospital della McGill University ha scoperto una correlazione tra la neurodegenerazione nelle persone obese e i pazienti affetti da Alzheimer. Se già in passato alcune ricerche avevano dimostrato che l’obesità è correlata a problemi tipici del morbo, quali danni cerebrovascolari e accumulo di beta-amiloide, tuttavia finora nessuno studio aveva effettuato un confronto diretto tra i modelli di atrofia cerebrale nell’Alzheimer e nell’obesità.

Utilizzando un campione composto da oltre 1.300 individui, i ricercatori hanno messo a confronto i modelli di atrofia della materia grigia nell’obesità e nella malattia neurodegenerativa. Il raffronto ha riguardato da una parte i pazienti affetti da Alzheimer e soggetti sani, dall’altra gli obesi e i non obesi, con gli studiosi che hanno creato mappe di atrofia della materia grigia per ciascun gruppo. Gli scienziati hanno così scoperto che l’obesità e l’Alzheimer influiscono sull’assottigliamento della materia grigia corticale, un potenziale sintomo di degenerazione, in modo simile. Nei due gruppi, ad esempio, l’assottigliamento della corteccia temporo-parietale destra e della corteccia prefrontale sinistra era somigliante. Ciò suggerisce che l’obesità possa causare lo stesso tipo di neurodegenerazione riscontrata nelle persone affette dal morbo.
L’obesità è sempre più riconosciuta come una malattia multisistemica che colpisce, tra gli altri, gli apparati respiratorio, gastrointestinale e cardiovascolare. Il nuovo studio, pubblicato sul “Journal of Alzheimer’s Disease”, indica la presenza di un impatto che è anche di tipo neurologico, dimostrando che l’obesità può giocare un ruolo nello sviluppo dell’Alzheimer e di altre forme di demenza. Filip Morys, ricercatore di dottorato presso The Neuro e primo autore dello studio, ha dichiarato: «Il nostro studio rafforza la letteratura precedente che indicava l’obesità come un fattore si-
gnificativo nell’Alzheimer, dimostrando che l’assottigliamento corticale potrebbe essere uno dei potenziali meccanismi di rischio. I nostri risultati rafforzano la possibilità che la perdita negli individui in sovrappeso e obesi possa anche diminuire il successivo rischio di neurodegenerazione e demenza».
The Neuro - The Montreal Neurological Institute-Hospital - è leader mondiale per la ricerca sul cervello e l’assistenza avanzata ai pazienti. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 1934 ad opera del famoso neurochirurgo Wilder Penfield, è cresciuto fino a diventare il più grande centro clinico e di ricerca
specializzato in neuroscienze del Canada e uno dei più grandi al mondo. Nel 2016 è stato il primo istituto al mondo ad abbracciare completamente la filosofia dell’Open Science, creando il Tanenbaum Open Science Institute. La perfetta integrazione tra ricerca, assistenza ai pazienti e formazione delle migliori menti del mondo fa sì che The Neuro si trovi in una posizione unica per avere un impatto significativo sulla comprensione e sul trattamento dei disturbi del sistema nervoso. Il Montreal Neurological Institute è un istituto di ricerca e insegnamento della McGill University. (D. E.).
1. Davis MG et al.: “A novel cosmetic approach to treat thinning hair”. Br J Dermatol. 2011 Dec; 165 Suppl 3:24-30.
2. Proksch E, Nissen HP. “Dexpanthenol enhances skin barrier repair and reduces inflammation after sodium lauryl sulphate-induced irritation”. J Dermatolog Treat. 2002; 13: 173–8.
3. Stettler H et al.: “A new topical panthenol-containing emollient for maintenance treatment of childhood atopic dermatitis: results from a multicenter prospective study”. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):774-779.
4. Tanaka Y et al. “Androgenetic Alopecia Treatment in Asian Men”.2 J Clin Aesthet Dermatol. 2018 Jul;11(7):32-35.
5. Wiederholt T et al., Exp Dermatol, 18 (11) (2009) 969-967.
Il Pantenolo viene scoperto nel 1936, in modo quasi casuale nel tentativo di capire le cause della pellagra nei polli; si scoprì che la causa della malattia era la mancanza di pantenolo nella dieta. Da quel momento si iniziarono a studiare e a comprendere le grandi proprietà e i molteplici benefici del suo utilizzo anche nell’uomo. La sua mancanza generava dermatiti, arrossamenti e dermatite seborroica, così si sviluppò la prima formulazione contenente D-pantenolo da utilizzare direttamente sulla pelle. Al giorno d’oggi esistono vari preparati di D-pantenolo topico frequentemente utilizzati nel campo della dermatologia e della cura della pelle, in quanto cofattore in molte reazioni enzimatiche importanti, tanto da essere impiegato in processi e cure che arrivano alla rigenerazione cellulare cutanea. Il pantenolo, o provitamina B5, è la forma alcolica ridotta dell’acido pantotenico. Il Pantenolo è idrosolubile ed è formato da due molecole con importanti ruoli funzionali: il Coenzima A (CoA) e la proteina trasportatrice dei gruppi acile (ACP). Il CoA è un cofattore indispensabile in numerose vie metaboliche e reazioni enzimatiche tra cui il metabolismo degli acidi grassi, colesterolo, corpi chetonici. L’ACP viene utilizzata nella sintesi ex-novo degli acidi grassi. L’utilizzo topico del pantenolo riesce ad avere quindi una buona penetrazione trans-epidermica producendo effetti rigeneranti e correttivi, compreso l’aumento della proliferazione dei fibroblasti e la riepitelizzazione accelerata nella guarigione delle ferite. L’azione rigenerante del pantenolo è stata dimostrata da diversi studi effettuati sia in vitro che in vivo, dove si osserva che il pantenolo induce l’attività mitotica dei fibroblasti del derma stimolandone la prolife-
razione e favorendo la sintesi delle proteine e la divisione cellulare. Il meccanismo che si trova alla base dell’effetto proliferante stimolato dal pantenolo, è dovuto alla sua capacità di modulare l’espressione di alcuni geni coinvolti nella proliferazione dei fibroblasti, tra cui i geni che codificano per le interleuchine IL-6, IL-8, per la proteina DNA-binding protein inhibitor ID-1, per la proteina HMOX-1 (heme oxygenase 1), per la proteina HspB7 (heat shock 27kDa protein family, member 7 (cardiovascular), per il CYP1B1 (cytochrome P450 1B1) e per la proteina MARCH-II (membrane-associated ring finger (C3HC4) 2, E3 ubiquitin protein ligase).
Il pantenolo oggi è molto utilizzato anche ad uso tricologico ed è un prodotto immancabile per la nostra hair rutine, infatti la sua applicazione è capace di idratare e decongestionare il cuoio capelluto, anche in caso di forfora, desquamazione, infiammazione e

rossore. Il pantenolo agisce inoltre sui fusti capillari, in quanto capace di lubrificare e levigare le superfici ruvide dei capelli rendendoli più forti, lucidi e facili da pettinare, anche in caso di capelli fragili, trattati e assottigliati.
Il pantenolo già di per sé ricco di proprietà, riesce ad amplificare i suoi benefici se utilizzato in sinergia con alcuni estratti naturali, come dimostrato da Davis in uno studio del 2011, in cui si osserva che il pantenolo associato a caffeina e niacinamide, influenza chiaramente il diametro delle strutture capillari determinando maggiore ispessimento, elasticità, flessibilità e resistenza alla rottura dell’intera massa capillare. Il pantenolo, oltre ad essere un prodotto naturale da usare in alternativa ai rimedi farmacologici, può essere usato anche in modo complementare amplificando i benefici delle cure farmacologiche stesse, come dimostrato dal ricercatore Tanaka in un suo studio clinico da lui condotto: il pantenolo, associato alle terapie farmacologiche, velocizza e amplifica il trattamento dell’alopecia androgenetica (AGA) già dopo pochi mesi dal suo utilizzo.
Infine, sono numerosi gli studi che confermano anche le sue spiccate proprietà anti-infiammatorie. In particolare, in uno studio condotto dal ricercatore Proksch si è osservato come l’utilizzo topico di una crema contenente D-pantenolo abbia ridotto l’arrossamento cutaneo in soggetti a cui era stata precedentemente indotta irritazione mediante sodio lauril solfato. I suoi benefici, insieme alla sua sicurezza di utilizzo, si osservano anche in età pediatrica su neonati e bambini con dermatite atopica lieve.
Il Pantenolo, presente in moltissimi alimenti e oggi in moltissimi preparati ad uso topico, è una ricchezza per cute e capelli nella face, body e hair routine ed è un rimedio efficace nel trattamento delle alterazioni cutanee e nella rigenerazione e guarigione delle ferite.

L’invecchiamento cutaneo è un complesso fenomeno predeterminato geneticamente ma che può essere intensificato da molti altri fattori ovvero agenti fisici e ambientali (le radiazioni solari, l’inquinamento e il freddo), ma anche da abitudini di vita errate (diete non equilibrate, stress, fumo etc)
La glicazione è un evento fisiologico che colpisce con l’avanzare dell’età tutte le proteine dell’organismo comprese quelle dermiche, avviene con un meccanismo di tipo non enzimatico, il glucosio si lega alle proteine dermiche di sostegno, il collagene e l’elastina, provocando modifiche nella loro struttura, cui segue una complessa successione di reazioni a catena che portano alla formazione di prodotti di glicosilazione avanzata chiamati Advanced Glycation Endproducts (AGEs). Gli AGEs, formano ponti molecolari con le proteine del derma determinando una disorganizzazione del tessuto che diventa più rigido e fragile. Con l’avanzare dell’età c’è un impoverimento della popolazione di fibroblasti con una diminuzione della sintesi di collagene ed elastina. L’Ossidazione, invece è un processo generato da fattori esogeni come lo stress, i raggi UV e l’inquinamento che determinano la formazione dei Reactive Oxygen Species (ROS), specie radicaliche dell’ossigeno altamente reattive e di radicali liberi. Questi potenti agenti ossidanti reagiscono ossidando macromolecole fondamentali dell’organismo quali i lipidi, il DNA, le proteine e i coenzimi. Gli effetti generati possono essere anche di grave entità: danno delle membrane cellulari, mutazioni, formazione di prodotti tossici.

Per poter rallentare questi due processi è stato sviluppato un nuovo ingrediente partendo da Acido Azelaico e Tetrapeptide 23: il prodotto di reazione (Azeloyl Tetrapeptide 23: nome INCI) è un peptide di sintesi contenente due molecole di Alanina e due di Istidina. Le coppie aminoacidiche, ognuna contenente una molecola di Alanina e una di Istidina (ALA-HIS), si trovano rispettivamente alle due estremità (ALA-HIS- azeloylALA-HIS) dell’Acido Azelaico.
Attività antiossidante in vitro
Attraverso test in vitro su cheratinociti è stata misurata la capacità antiossidante del prodotto in esame tramite ossidazione indotta con perossidi e analisi colorimetrica, Azeloyl Tetrapeptide 23 ha dimostrato un’attività antiossidante raggiungendo il 50% di inibizione della perossidazione dopo 56 secondi e rimanendo con un’attività ele-
© Ground Picture/shutterstock.com

vata (> 60%) fino a 200 secondi. Si riduceva inoltre la capacità di formazione dei ROS nei cheratinociti. SI è visto che dopo un irraggiamento UVA di quattro minuti, l’Azeloyl Tetrapeptide 23 riduceva la formazione di ROS di oltre il 40%; dopo venti minuti senza irraggiamento UVA, l’Azeloyl Tetrapeptide 23 ha dimostrato una significativa attività antiossidante verso i processi fisiologici di ossidazione riducendo la formazione di ROS di oltre il 45%.
Attività antiglicazione
I lisati cellulari di fibroblasti umani sono stati trattati con diverse concentrazioni di Azeloyl Tetrapeptide 23 e i dati ottenuti hanno dimostrato che, dopo 72 ore di trattamento, l’Azeloyl Tetrapeptide 23 allo 0.5% diminuisce la formazione di AGEs di circa il 50%, che si mantiene anche aumentando la dose all’1%.
Attività antiaging in vivo

Il protocollo è stato effettuato su12 volontari trattati due volte al giorno per sei settimane, con applicazione sul viso di un’emulsione al 5% di Azeloyl Tetrapeptide 23 confrontata col placebo. Sono stati valutati gli effetti antiage e antirughe; elasticità, idratazione, densità e luminosità cuta-
nea e rugosità, morbidezza della pelle, tollerabilità cutanea e perioculare mediante autovalutazione.
Discussione e conclusioni
Azeloyl Tetrapeptide 23 ha dimostrato non solo di essere un innovativo agente funzionale antiaging ma anche tecnologicamente versatile e facilmente incorporabile nella maggioranza delle formulazioni cosmetiche. Durante la fase di studio sistematico è stato dimostrato l’estrema praticità d’uso di questo nuovo ingrediente, che è disponibile in soluzione acquosa limpida, stabile e facilmente dosabile, che può essere incorporato nelle formulazioni a una temperatura non troppo elevata, considerando la sua struttura proteica facilmente termolabile. Durante le prove di solubilità e compatibilità con vari ingredienti cosmetici non si sono incontrate rilevanti difficoltà. Azeloyl Tetrapeptide 23 ha dimostrato di possedere un’elevata stabilità alle variazioni di pH, rimanendo stabile in un ampio range di valori: pH 2.9-14; può essere utilizzato anche con concentrazioni molto elevate di alcol ed elettroliti. Durante la preparazione di gel ed emulsioni non si è rilevato alcun problema significativo, eccetto una leggera diminuzione della viscosità; dal punto di vista funzionale ha rivelato una significativa attività antiaging manifestando una elevata azione anti-glicazione ed antiossidante; si è rivelato un agente anti-glicazione offrendosi come substrato ‘esca’ nella reazione di ‘caramellizzazione’ delle proteine dermiche. Negli studi in vitro, Azeloyl Tetrapeptide 23 ha dimostrato la capacità di impedire la formazione di proteine glicate, in particolare del collagene, tutti gli studi sinora eseguiti indicano che è un antiaging efficace ed innovativo. A differenza degli altri tetrapeptidi, è presente nella struttura un dipeptide doppio che rende la molecola simmetrica; si distingue per il suo meccanismo d’azione: infatti è il primo tetrapeptide con elevata azione antiglicazione, mentre nel vasto scenario dei peptidi anti-invecchiamento prevale un meccanismo botox-like.
Scarica il Giornale dei Biologi
dall’area riservata MyONB
Ogni mese riceverai crediti Ecm in autoformazione e Fad

Il ripristino delle zone umide è un’opportunità per la valorizzazione del territorio italiano di Gianpaolo Palazzo

Lo slogan per la Giornata Mondiale delle Zone Umide (2 febbraio), nata ricordando la firma nel 1971 della Convenzione di Ramsar, era “It’s time for wetlands restoration” (È tempo di recuperare le zone umide). Legambiente ha presentato il report “Ecosistemi acquatici” in cui racconta dodici buone pratiche italiane e dieci proposte per tutelare e apprezzare al meglio questi forzieri di biodiversità, capaci di porre un limite alla crisi climatica e di attrarre un turismo sostenibile. Sono, difatti, i più efficienti pozzi di assorbimento per il carbonio sulla Terra; raccolgono le piogge in eccesso, schivando il rischio d’inondazioni, sempre più intense, e riducono la siccità, minimizzando la carenza d’acqua. In Italia 57 d’importanza internazionale sono riconosciute e incluse nell’elenco della Convenzione di Ramsar, distribuite in quindici Regioni, per un totale di 73.982 ettari. Inoltre, ci sono nove aree in fase d’istituzione, portando il numero totale a 66.

Tra le buone notizie c’è quella che riguarda Trento. Presso il MUSE - Museo delle Scienze, è stato realizzato un laghetto urbano di circa duemila mq, profondo 1,80 metri, che preserva più di quattromila piante di oltre ottanta specie vegetali acquatiche e palustri, alcune di esse molto rare. I visitatori possono ammirare con i loro occhi l’ambiente naturale che avevano davanti i trentini 150 anni fa lungo le golene dell’Adige. Il fiume attraversa il capoluogo di provincia e di regione creando una piccola oasi di diversità biologica cittadina. Lì è facile scoprire piante, anfibi e insetti, insieme con un laboratorio per lo studio, la protezione naturalistica e le attività educative connesse alla citizen science.
In alcuni fiumi di Emilia Romagna e Liguria, invece, sono stati rilasciati gamberi di fiume Austropotamobius pallipes, una specie autoctona che negli ultimi venti anni ha visto ridurre, secondo i dati dell’associazione dal cigno verde, circa il 74% della propria popolazione, lasciando spazio, anche a causa dell’intervento umano, a una moltitudine di altri “alieni” invasivi. Il gambero d’acqua dolce ha un ruolo fondamentale, poiché è in grado d’influenzare la densità e la distribuzione degli altri organismi, tramite il proprio comportamento onnivoro e bioturbatore, oltre ad essere un alimento importante per pesci, uccelli e mammiferi. Sono stati introdotti 1.538 esemplari di “gamberi dalle zampe bianche” nati in cattività e, dopo una serie di controlli sanitari per verificarne lo stato di salute, hanno potuto vivere in alcuni
corsi d’acqua idonei alla loro crescita. Negli stessi sono stati recuperati, in aggiunta, circa quarantamila esemplari di gambero rosso della Louisiana, nuovi e pericolosi colonizzatori.
Presso il MUSE - Museo delle Scienze, è stato realizzato un laghetto urbano di circa duemila mq, profondo 1,80 metri, che preserva più di quattromila piante di oltre ottanta specie vegetali acquatiche e palustri, alcune di esse molto rare. I visitatori possono ammirare con i loro occhi l’ambiente naturale che avevano davanti i trentini 150 anni fa lungo le golene dell’Adige. Il fiume attraversa il capoluogo di provincia e di regione creando una piccola oasi di diversità biologica cittadina. Lì è facile scoprire piante, anfibi e insetti, insieme con un laboratorio per lo studio, la protezione naturalistica e le attività educative connesse alla citizen science.
Spostandosi in Sicilia, la Stiftung Pro Artenvielfalt (Spa - Fondazione Pro Biodiversità) dopo aver acquistato nel 2014 il Pantano Cuba, grazie alle donazioni di oltre ventinovemila cittadini tedeschi, ha completato l’iter per acquisire anche il Pantano Longarini nella parte sud orientale dell’isola. Ci saranno, così, una serie di specchi d’acqua sorvegliati e circondati da terreni e pendii tra le province di Ragusa e Siracusa. Il primo passo della Fondazione è stato quello di recintare gli spazi in modo da frenare e rimuovere fenomeni di degrado. Il progetto complessivo prevede investimenti che potenzino l’intera area per rinforzare l’economia locale legata all’escursionismo naturalistico e alla produzione agricola biologica.
«Valorizzare le conoscenze scientifiche e sottolineare le problematiche gestionali delle zone umide - spiega Antonio Nicoletti, responsabile Aree Protette e Biodiversità di Legambiente - è il nostro obiettivo, raggiungibile coinvolgendo cittadini e istituzioni nella tutela di ecosistemi fragili e fondamentali per la nostra vita. La Giornata delle Zone Umide è anche l’occasione per Legambiente di rafforzare la campagna “30% di territorio protetto entro il 2030”, dato che molte aree protette da istituire sono ecosistemi fluviali o zone umide. In tal senso, i Contratti di Fiume sono un’opportunità per una maggiore integrazione tra politiche locali e sovralocali e per attrarre nuove risorse e migliorare la gestione idraulico-ambientale o socioeconomica dei territori. È quel che suggeriamo per l’Ofanto, affiancando al percorso per i due Contratti di Fiume dell’Alto e Media-Bassa Valle, una riflessione sull’istituzione del Parco nazionale del Fiume Ofanto, dalla sorgente in Campania alla Foce in Puglia».
Legambiente per le zone umide propone di: aumentarne la tutela per raggiungere il 30% di territorio nazionale protetto; rafforzare la biodiversità e le normative per garantire la gestione integrata delle risorse idriche; migliorare l’integrazione e la gestione unitaria delle aree naturali; sorvegliare il capitale del paesaggio e rafforzare i servizi ecosistemici; ridurre l’inquinamento; combattere le specie aliene; ripristinare gli habitat acquatici degradati; migliorarne la pianificazione integrata; contrastare le illegalità ambientali, reprimendo il bracconaggio e favorendo la pesca sostenibile; supportare, infine, la bioeconomia circolare.
© LucaUva, pere, ortaggi, allevamento e intelligenza artificiale sarà un quartetto con il quale misurarsi per cercare di non farsi sorprendere dai rapidi cambiamenti climatici e costruire un mondo più sostenibile. Al fianco degli agricoltori ci sarà il progetto di ricerca europeo “Symbiosyst”, finanziato dal programma europeo “Horizon” e condotto da diciotto partner, tra cui per l’Italia: Enea, Eurac Research (coordinatore), EF Solare Italia, Convert, ETA Florence Renewable Energy, Centro di Sperimentazione Laimburg e Südtiroler Bauernbund. Lo scopo, da centrare in un quadriennio, è sviluppare tecnologie innovative per aumentare la competitività dell’agrivoltaico in Europa e ridurre l’impatto sull’ambiente e il paesaggio.

Si mira a promuovere progetti “solari” personalizzati, che incoraggino iniziative e investimenti. I moduli fotovoltaici saranno studiati per adattarsi all’uso su terreni agricoli e strutture di montaggio, attivando nuove procedure operative e di gestione, a seconda delle diverse zone climatiche. Questo permetterà la progressiva crescita della ricerca scientifica, unita allo sviluppo di nuovi sistemi scalabili ed economicamente vantaggiosi. L’intelligenza artificiale verrà utilizzata
per la modellizzazione dedicata alla produzione di energia elettrica, alla crescita delle piante, alla gestione degli impianti e al supporto decisionale. Enea si dedicherà alla creazione di nuovi metodi e strumenti per progettare installazioni sostenibili che combinino produzione agricola ed energetica. Inoltre, lavorerà su architetture informative basate su GIS che integrino conoscenze multidisciplinari, coinvolgendo tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti nell’iniziativa economica, attraverso azioni di formazione per consolidare la Rete Nazionale Agrivoltaico Sostenibile.
«L’agrivoltaico sostenibile può essere considerato come una soluzione sartoriale, che risponde ad una generale visione sistemica dei vari sottosistemi coinvolti e che adatta una metodologia generale a specifici contesti territoriali, e cioè a diversi paesaggi, comunità e sistemi economici - spiega Alessandra Scognamiglio del Laboratorio Enea di Dispositivi innovativi e coordinatrice della Task force AgrivoltaicoSostenibile@ENEA».
In Alto Adige, su un meleto a guyot, il partner italiano EF Solare costruirà per i test “in campo” un impianto dimostra-
tivo al fine di sperimentare tecnologie innovative che aiutino l’irrigazione e la protezione da gelo e grandine. I dati raccolti sulla produzione agricola, di energia elettrica e sull’impatto ambientale verranno poi trasferiti dentro alcune linee guida dedicate alla costruzione di moduli fotovoltaici rispettosi della Natura. Altra fonte d’ispirazione potrà essere quanto realizzato, sempre dalla stessa azienda, a Scalea (Cs): un prototipo a inseguimento solare, infisso nel suolo senza fondazioni in cemento. L’impianto dista dal terreno circa tre metri in altezza e ha file proporzionatamente distanziate per consentire l’attività agricola e fotovoltaica, assicurando un preciso contributo di luce diretta e diffusa. Le costruzioni sono integrate con gli impianti di nebulizzazione e fertirrigazione programmabili e gestibili da remoto. Tale configurazione permette di poter coltivare quasi totalmente le aree coinvolte, assicurando la presenza coesistente e continuativa di attività agricole e gestione dell’impianto “acchiappa sole”.
«Oltre ai decisori politici, questi strumenti supporteranno anche gli enti autorizzativi e i potenziali investitori del settore. In questo contesto - sottolinea Grazia Fattoruso del Laboratorio
Gli altri partner del progetto “Symbiosyst” sono: in Belgio, Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC), KU Leuven, Lucisun, 3E e Belgisch Laboratorium Van Elektriciteitsindustrie; nei Paesi Bassi, Technische Universiteit Delft, Kubo Innovations BV e Physee Products BV; in Germania, Aleo Solar GmbH; in Spagna, Universitat Politecnica de Catalunya; nel Regno Unito, Above Surveying LTD (partner affiliato). Insieme all’Italia vogliono portare competitività nell’agrivoltaico europeo, non trascurando né l’ecologia né il territorio.
ENEA di Sviluppo applicazioni digitali, fotovoltaiche e sensoristiche e membro della Task force AgrivoltaicoSostenibile@ENEA - saranno realizzate anche le linee guida per l’integrazione nel paesaggio».

Il gruppo di esperti multidisciplinare dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile è nato con l’intento di facilitare conoscenze e buone pratiche per avviare soluzioni innovatrici. Sono stati coinvolti due dipartimenti “Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili” e “Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali”, che, sin da subito, hanno messo a disposizione laboratori, infrastrutture e professionalità pluriennali.
«I sistemi agrivoltaici sono soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e, nello stesso tempo, rendere la nostra agricoltura più innovativa, competitiva e sostenibile. Per fare questo, però - conclude Federica Colucci del Laboratorio Enea di biodiversità e servizi ecosistemici e membro della Task force AgrivoltaicoSostenibile@ENEA - c’è bisogno di promuovere la conoscenza, condividere le esperienze e dare una spinta alla formazione, anche attraverso l’organizzazione di webinar». (G. P.).

l’aria sta finendo / ed io non ci sto più». Gianna Nannini nella sua canzone del 2020 “L’aria sta finendo” sembra anticipare i risultati del rapporto di Legambiente
“Mal Aria di città. Cambio di passo cercasi”. Pubblicato nell’ambito della Clean Cities Campaign, certifica che i livelli d’inquinamento atmosferico in molti centri urbani italiani sono ancora troppo elevati e lontani dai limiti previsti per il 2030. Lo scorso anno alcuni capoluoghi di provincia sono stati bocciati, sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili (PM10, PM2.5) sia del biossido di azoto (NO2). Sono 29 le città, fra le 95 monitorate, che hanno superato gli attuali limiti normativi per gli sforamenti di PM10 (35 dì all’anno con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi/ metro cubo): le centraline di Torino (Grassi) si piazzano al primo posto con 98 giorni di violazioni, seguite da Milano (Senato) con 84, Asti (Baussano) 79, Modena (Giardini) 75, Padova (Arcella) e Venezia (Tagliamento) con 70. Tutte hanno doppiato il numero di eccedenze consentite. L’analisi delle medie annuali riguardo al PM10 non ha mostrato “scavalcamenti” rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente, tuttavia questo non è sufficiente per garantire la salute dei cittadini. Infatti, le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale

della Sanità e gli argini previsti dalla nuova Direttiva europea sulla qualità dell’aria, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2030, richiedono standard più rigorosi. Solo il 24% delle città, ovvero 23 su 95, non hanno superato la soglia di 20 µg/mc per il PM10, mentre 72 sono irrispettose verso quanto stabilito dalle norme.
A rimboccarsi le maniche per invertire la rotta negativa e ridurre le concentrazioni secondo i nuovi parametri (20 µg/mc da non superare per il PM10, 10 µg/mc per il PM2.5, 20 µg/mc per l’NO2) sono: Torino e Milano (riduzione necessaria del 43%), Cremona (42%), Andria (41%) e Alessandria (40%) per il PM10; Monza (60%), Milano, Cremona, Padova e Vicenza (57%), Bergamo, Piacenza, Alessandria e Torino (55%), Como (52%), Brescia, Asti e Mantova (50%) per il PM2.5. Milano (47%), Torino (46%), Palermo (44%), Como (43%), Catania (41%), Roma (39%), Monza, Genova, Trento e Bolzano (34%) dovranno sforzarsi pure per l’NO2.
«L’inquinamento atmosferico non è solo un problema ambientale, ma anche sanitario di grande importanza. In Europa - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - è la prima causa di morte prematura dovuta a fattori ambientali e l’Italia registra un triste primato con più di 52.000 decessi annui da PM2.5, pari a
Nel 2022, 29 città su 95 hanno superato i limiti giornalieri di PM10
1/5 di quelli rilevate in tutto il continente. È necessario agire con urgenza per salvaguardare la salute dei cittadini, introducendo politiche efficaci ed integrate che incidano sulle diverse fonti di smog, dalla mobilità al riscaldamento degli edifici, dall’industria all’agricoltura. In ambito urbano è fondamentale la promozione di azioni concrete sulla mobilità sostenibile attraverso investimenti importanti sul trasporto pubblico, il ridisegno dello spazio cittadino con pedonalizzazioni e zone 30, politiche di promozione dell’uso delle due ruote in sicurezza, la diffusione delle reti di ricarica dei mezzi elettrici, facilitando la scelta di ridurre fortemente l’uso dell’auto privata».

Tante comunità italiane sono ancora lontane dall’obiettivo previsto per il PM10, che richiede una riduzione delle concentrazioni cittadine tra il 30% e il 43% nei prossimi sette anni. Tuttavia, basandosi sulle tendenze di riduzione registrate nell’ultimo decennio, potrebbero esserne necessari diciassette in media per raggiungere l’obiettivo, spostandosi al 2040, piuttosto che farsi trovare in regola entro il 2030. Modena, Treviso e Vercelli, secondo l’associazione ambientalista, avrebbero bisogno di oltre trent’anni. La situazione è simile per l’NO2, e Catania impiegherebbe oltre quarant’anni per risanare l’aria, mantenendo le attuali tendenze di diminuzione, mentre Monza, Bolzano
e Trento ne richiederebbero più di quindici. Per combattere l’inquinamento, vengono proposti da Legambiente alcuni interventi “a misura di città”: passaggio dalle Ztl (zone a traffico limitato) alle ZEZ (Zone a zero emissioni). Guardando a Milano (con l’area B) e, soprattutto, all’ultra Low Emission Zone londinese, le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti moderano le emissioni da traffico del 30% e del 40%. Serve poi un piano di riqualificazione energetica dell’edilizia pubblica e privata, oltre alla riconversione delle abitazioni ad emissioni zero con incentivi per la sostituzione delle caldaie a gas. Si dovrebbe passare dopo al potenziamento del trasporto pubblico e rapido di massa (TRM) attraverso la quadruplicazione dell’offerta di linea e la promozione di abbonamenti integrati, copiando la Germania. La mobilità a energia elettrica condivisa (bici, auto, van e cargo bike) andrebbe ancor più sostenuta e aiutata realizzando nuovi chilometri di percorsi ciclabili. Lo spazio pubblico urbano dovrebbe essere a misura d’uomo, puntando su sicurezza stradale e limiti di velocità, come già accade a Cesena, Torino, Bologna e Milano. Occorre arrivare all’elettrico, infine, anche prima del 2035, grazie alla crescente espansione delle ZEZ, alla triplicazione dell’immatricolazione di autobus a elettricità e all’istituzione dei distretti ZED (Zero Emissions Distribution).
Come noto, il connubio uomo-ambiente è un binomio indissolubile; acqua, cibo e aria sono necessari e fondamentali per la vita, ed è dalla loro salubrità che dipende la qualità della vita in termini di salute.
Proteggere e tutelare l’ambiente vuol dire dunque, in prima istanza, proteggere e tutelare la nostra salute.
È urgente riflettere sul fatto che l’uomo ha sempre vissuto interagendo con l’ambiente, ma con il passare del tempo ne ha sfruttato le potenzialità al massimo,
al costo di distruggerlo (soprattutto dai tempi della rivoluzione industriale), senza tener conto che - compromettendo l’ecosistema di cui fa parte - avrebbe compromesso la qualità della sua stessa vita. Il crescente consumo di suolo, l’utilizzo di processi industriali inefficienti e la densità abitativa comportano squilibri naturali spesso irreversibili, e pongono a rischio la sopravvivenza del genere umano. L’aumento del degrado è visibile soprattutto nelle regioni industrializzate, dove l’impatto ambientale causato dall’antropizzazione è maggiore rispetto al passato, non solo per l’aumento della popolazione, ma anche per le maggiori fonti di inquinamento e conseguente perdita di biodiversità.
I conflitti uomo e ambiente che hanno causato danni alla salute umana ed ambientale sono ormai noti, ecco perché è necessario rivalutare la relazione uomo e natura per migliorare la salute individuale e pubblica.
Ad oggi l’inquinamento atmosferico e acu-
L’impatto della contaminazione ambientale sulla qualità di vita degli abitanti delle città
 di Teresa Pandolfi* e Giovanni Misasi**
di Teresa Pandolfi* e Giovanni Misasi**
stico rappresenta il principale rischio per la salute e la qualità della vita nelle aree urbane.
L’inquinamento atmosferico è causato principalmente dal particolato, un insieme di sostanze costituite da polveri sottili, fumo, microparticelle e sostanze liquide che rimangono sospese in atmosfera e – in presenza di particolari condizioni climatiche, come l’assenza di piogge o di venti prevalenti – determinano un duraturo peggioramento della qualità dell’aria respirata a causa di un effetto “aerosol”.
Il particolato, se di origine antropica, è il risultato dei processi di combustione termica nel settore dei trasporti, nelle attività che utilizzano sostanze chimiche volatili (quali solventi e carburanti), in impianti industriali a ciclo continuo come centrali elettriche o termovalorizzatori, nei sistemi di riscaldamento o refrigerazione in aree ad alta concentrazione antropica, come pure in agricoltura intensiva, mediante l’utilizzo di fertilizzanti azotati che causano la dispersione di ammoniaca in atmosfera.
La direttiva europea sulla qualità dell’aria (2008/CE/50) fissa per il particolato Pm10 il limite medio giornaliero di 50 µg/m3 e max 35
sforamenti in un anno, e quello medio annuale pari a 40 µg/m3. I valori soglia per il particolato ultrasottile Pm2,5 sono ancora più stringenti: infatti, le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) indicano in 10 µg/m3 il valore associato con elevati rischi per la salute umana.

Nonostante ciò, le città italiane sono malate. Secondo l’Ocse (2020), l’Italia registra valori durevolmente al di sopra dei limiti. Inoltre, nel dossier annuale di Legambiente “Mal’aria di città” (2020), si legge che il 2019 è stato un “anno nero per la qualità dell’aria”, poiché ben 26 centri urbani sono risultati non a norma in relazione al superamento dei valori limite di legge riguardanti le polveri sottili (Pm10) e l’ozono (O3), e 54 città hanno superato il numero massimo di sforamenti di legge, fissato in 35 giorni all’anno per il Pm10 e in 25 per l’ozono (O3).
Le polveri sottili presenti nell’aria hanno dimensioni microsco -
* CTS Associazione Scientifica Biologi senza Frontiere.
** Presidente Associazione Scientifica Biologi senza Frontiere.
*** Responsabile scientifico CTS Associazione Scientifica Biologi senza Frontiere.
piche, nell’ordine di diametro uguale o inferiore a 10 millesimi di millimetro e la loro pericolosità è inversamente proporzionale alla loro dimensione: tanto più piccole sono tali particelle, tanto più facilmente esse vengono inalate nel sistema respiratorio danneggiando gli alveoli polmonari e causando pertanto infiammazioni e rischi per la salute.
Le polveri sottili possono essere causate indirettamente da comportamenti predatori posti in essere dagli esseri umani, spesso responsabili di incendi boschivi o di dissesto idrogeologico nel tentativo di consumare maggiore quantità di suolo per finalità produttive.
Inoltre, alcune sostanze come l’arsenico, il cadmio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici, sono agenti cancerogeni genotossici per l’uomo e non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale queste sostanze non comportano un rischio.
Nelle aree urbane sono in crescita anche i livelli di rumore ambientale, in particolar modo quelli causati dall’aumento del traffico e dalle attività industriali. L’esposizione costante e pro-
lungata all’inquinamento acustico può incidere negativamente sulla salute e sulla qualità della vita, può portare a rischi cardiovascolari, riduzione delle prestazioni cognitive nei bambini, disturbi del sonno.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato il rumore del traffico, compreso quello aereo, stradale o ferroviario, tra le cause principali di malattie in Europa occidentale.
Il report sull’inquinamento acustico - EEA No 22/2019
“Environmental noise in Europe – 2020”- evidenzia che il rumore ambientale rimane un grave problema per la salute; guardando ai dati attuali, infatti, l’AEA stima che il rumore ambientale contribuisca a causare 48000 nuovi casi di cardiopatie ischemiche l’anno, oltre a 12000 decessi prematuri. Secondo le stime, 22 milioni di persone soffrirebbero di elevata irritabilità cronica e 6,5 milioni di gravi disturbi cronici del sonno; inoltre, il rumore degli aerei causerebbe una compromissione della capacità di lettura in 12500 bambini in età scolare.

L’inquinamento acustico rappresenta dunque, a tutti gli effetti, un indicatore relativo alla qualità della vita e al benessere psichico.
Nelle nuove linee guida dell’OMS presentate nel 2018, si definiscono i nuovi livelli di esposizione al rumore che non devono essere superati per limitare al massimo gli effetti nocivi sulla salute. Tali raccomandazioni suggeriscono che l’esposizione a lungo termine al rumore non deve superare:
• 53 dB giorno-sera-notte e 45 dB durante la notte per il traffico stradale;
• 54dB giorno-sera-notte e 44 dB durante la notte per il treno;
• 45 dB nel periodo giorno-sera-notte e 40 dB durante la notte per gli aerei;
• 45 dB giorno-sera-notte per le turbine eoliche, indicatore e limite di recente introduzione.
L’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) ha anche pubblicato un visualizzatore che presenta l’impatto combinato sulla salute dell’inquinamento atmosferico e del rumore del traffico stradale, con una risoluzione di 1 km x 1 km nelle città in cui sono disponibili i dati. L’impatto dell’inquinamento atmosferico è misurato in termini di mortalità e l’impatto dell’inquinamento acustico stradale è misurato in termini di disturbo elevato a lungo termine.
L’ambiente inquinato e lo stile di vita incidono non solo sull’aspettativa di vita, ma anche e soprattutto sulla qualità della vita, in termini di cattiva salute. Un indicatore per esprimere quantitativamente l’impatto di una malattia sulla salute è il DALY, disability-adjusted life year, adottato anche dall’OMS, - che è pari alla somma degli anni di vita persi (YLL) a causa di una morte prematura e di quelli vissuti in malattia (YLD), invece che in salute. La mortalità e la morbilità, in tal modo, sono combinati in un unico indicatore comune: un DALY è pari ad un anno di vita perso.
Per migliorare la qualità della vita è necessario rivalutare la simbiosi uomo-ambiente; nel contesto urbanistico è doveroso riconoscere e tutelare il bene comune della città, proteggendo l’ambiente nella città e nel territorio, dando priorità al bene comune per il giovamento individuale e collettivo. Puntare pertanto ad una nuova consapevolezza, a una nuova responsabilità, a una nuova cultura urbana, un nuovo modo di progettare il territorio in difesa del bene comune.
La mission della nostra associazione – ASBSF - è migliorare la qualità della vita, con l’obiettivo di vivere nel rispetto della natura, dell’uomo e dell’ambiente, tenendo conto che il concetto di qualità della vita risulta non soltanto complesso per sua natura, ma è anche andato nel tempo modificandosi parallelamente al mutare dei bisogni, dei modelli culturali e valoriali.

Come Associazione Scientifica, con il Progetto Borghi del Benessere, stiamo strutturando una serie d’interventi, studi e attività di ricerca per disegnare un percorso verso questa meta.
Il nostro Borgo è il modello di applicazione
Per migliorare la qualità della vita è necessario rivalutare la simbiosi uomo-ambiente; nel contesto urbanistico è doveroso riconoscere e tutelare il bene comune della città, proteggendo l’ambiente nella città e nel territorio, dando priorità al bene comune per il giovamento individuale e collettivo. Puntare pertanto ad una nuova consapevolezza, a una nuova responsabilità, a una nuova cultura urbana, un nuovo modo di progettare il territorio in difesa del bene comune. La mission della nostra associazione – ASBSF - è migliorare la qualità della vita, con l’obiettivo di vivere nel rispetto della natura, dell’uomo e dell’ambiente, tenendo conto che il concetto di qualità della vita risulta non soltanto complesso per sua natura, ma è anche andato nel tempo modificandosi parallelamente al mutare dei bisogni, dei modelli culturali e valoriali.
della nuova eco ed equo sostenibilità, secondo una nuova cultura fondata da una parte su un’idea di città, di spazi, mobilità e di servizi, il cui strumento di attuazione passi per il rispetto dei bisogni umani e dove le risorse, e le nostre immense potenzialità storiche e naturalistiche, siano valutate secondo un approccio multidimensionale e, dall’altra, su una visione di progetti ad alto contenuto d’innovazione. È stato pertanto predisposto in ciascun Borgo, che ha aderito alla rete dei Borghi del Benessere, un Osservatorio Socio-Ambientale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico della popolazione, al fine di effettuare iniziative volte al miglioramento della salute, oltre al rilevamento di dati utili alla ricerca scientifica. L’alterazione delle matrici ambientali, come noto, è spesso associata e correlabile all’insorgenza di patologie nell’ uomo.
Il nostro obiettivo è di guardare oltre gli indicatori esclusivamente economici del benessere come espressione della salute delle persone, il benessere è sempre più misurato dall’esistenza di un ambiente sano, dal movimento corretto, da una vita sana e consapevole. Concentrandosi su interventi urbani che migliorino lo stile di vita dei cittadini, si intende salvaguardare il bene comune degli spazi naturali, piacevoli, anche per le generazioni a venire.
Il progetto “Borghi del Benessere” è una realtà già in essere e può rappresentare la svolta per una migliore qualità della vita in un contesto sano, naturale e a misura d’uomo.
- Ispra (2020), Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”
- Legambiente (2020), Rapporto “Mal’Aria di città”.
- Ocse (2020), Rapporto “Environmental health and strengthening resilience to pandemics”
- https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise/viewer-on-combined-health-impacts
- https://www.repertoriosalute.it/nuove-linee-guida-delloms-sul-rumore/
- https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/ sheet/75/inquinamento-atmosferico-e-acustico
- https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-noise-in-europe
- https://www.eea.europa.eu/it/articles/inquinamento-acustico-un-grave-problema
- https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/158
Le chinasi alterate che generano la crescita incontrollata delle cellule e la resistenza ai trattamenti. Modello testato sul glioblastoma, è utilizzabile anche in altri tipi di cancro
Grazie all’intelligenza artificiale è stato compiuto un passo importante nella medicina di precisione. Un gruppo di ricerca internazionale, guidato da scienziati del Sylvester Comprehensive Cancer Center della University of Miami Miller School of Medicine, ha sviluppato un nuovo algoritmo di apprendimento automatico in grado di riconoscere vari tipi di tumori maligni e, per ognuno di essi, individuare le armi più efficaci per combatterlo.
L’algoritmo si chiama SPHINKS (Substrate PHosphosite-based Inference for Network of KinaseS) e combina grandi insiemi di dati provenienti da più fonti per riconoscere gli enzimi, chiamati chinasi, la cui attività alterata è stata riscontrata in diversi tipi di tumori.
Nella ricerca pubblicata su Nature Cancer, SPHINKS è stato testato per la prima volta sul glioblastoma, uno dei tumori più letali, ma l’algoritmo è ugualmente applicabile in molti tipi di tumori. I pazienti affetti da glioblastoma hanno prognosi infauste: il tasso di sopravvivenza a cinque anni è inferiore al 10%.
Sebbene si stiano sviluppando numerosi far-
maci per contribuire a migliorare questo dato, i medici avevano bisogno di trovare un modo per identificare i meccanismi molecolari che influiscono sulla malattia di ciascun paziente e personalizzare le cure.
Nello studio, SPHINKS ha identificato le chinasi (PKCδ e DNAPKcs) associate alla progressione in due sottotipi di glioblastoma. Inoltre, utilizzando organoidi tumorali cresciuti in laboratorio da campioni di pazienti, il team ha dimostrato che farmaci mirati che interferiscono con le due chinasi possono bloccare la crescita tumorale. Queste chinasi anomale sono state attivate anche in sottotipi tumorali del seno, del polmone e di altri tipi di cancro.
«Questo tipo di ricerche offre opportunità immediate di cambiare il modo in cui i pazienti affetti da glioblastoma vengono gestiti di routine nella clinica», ha dichiarato Antonio Iavarone, direttore aggiunto del Sylvester Comprehensive Cancer Center e autore senior dello studio. «SPHINKS offre agli oncologi un nuovo strumento per applicare i trattamenti corretti in sottotipi tumorali omogenei».
In un lavoro precedente, il team di Iavarone aveva presentato una nuova classificazione del glioblastoma, che coglieva i tratti chiave delle cellule tumorali e raggruppava i pazienti in base alle loro possibilità di sopravvivenza e alla vulnerabilità del loro tumore ai farmaci. Nell’ultimo studio queste classificazioni sono state confermate in modo indipendente attraverso diverse piattaforme omiche: genomica (geni), proteomica (proteine), lipidomica (molecole di grasso), acetilomica (epigenetica), metabolomica (metaboliti) e altre. Le discipline omiche utilizzano tecnologie di analisi che consentono la produzione dati in numero molto elevato e nello stesso intervallo di tempo, utili per descrivere e interpretare un determinato sistema biologico.

Ma come funziona SPHINKS? Gli autori spiegano che l’algoritmo sfrutta l’apprendimento automatico per migliorare i set di dati omici e creare un interattoma (un insieme completo delle interazioni molecolari nelle cellule) al fine di individuare le chinasi che generano una crescita cellulare incontrollata e la resistenza ai trattamenti in ciascun sottotipo di glioblastoma. Questi risultati dimostrano che i dati multi-omici possono generare nuovi algoritmi in grado di prevedere quali terapie mirate specifiche possono fornire le migliori opzioni terapeutiche in base al sottotipo di glioblastoma di ciascun paziente.

«Siamo ora in grado di raggruppare i pazienti affetti da glioblastoma in base a caratteristiche biologiche presenti contemporaneamente nelle diverse omiche», ha dichiarato il dottor Iavarone.
SPHINKS e i metodi associati offrono anche il vantaggio di poter essere facilmente inseriti e utilizzati nei vari laboratori di patologia molecolare. Anna Lasorella, professoressa di biochimica e biologia molecolare e coautore dello studio, ha dichiarato: «Importando i dati omici nel portale web che abbiamo creato e dedicato all’algoritmo, i patologi ricevono informazioni di classificazione per un ciascun tumore. Queste classificazioni possono essere immediatamente applicate alla cura del paziente».
L’altro aspetto che sottolineano gli autori è che SPHINKS è applicabile oltre che al glioblastoma, a molti tipi di cancro. L’équipe ha trovato le stesse chinasi coinvolte nel cancro del seno, del polmone e in altri tumori. I dotto-
Questo tipo di ricerche offre opportunità immediate di cambiare il modo in cui i pazienti affetti da glioblastoma vengono gestiti di routine nella clinica.
© Gorodenkoff/shutterstock.com
© Den Rise/shutterstock.com
ri Iavarone, Lasorella e colleghi ritengono che queste informazioni potrebbero addirittura contribuire a creare un nuovo tipo di sperimentazione clinica che includerebbe pazienti con lo stesso sottotipo biologico ma non necessariamente con lo stesso tipo di cancro. «Se i pazienti – ha detto Iavarone - affetti da glioblastoma, cancro al seno o al polmone presentano caratteristiche molecolari simili, potrebbero essere inclusi nello stesso studio». «Invece di fare più studi per una singola neoplasia – conclude il ricercatore - potremmo farne uno solo e potenzialmente portare più rapidamente farmaci più efficaci ai pazienti».
Lo studio, che parte dall’analisi del metabolismo cellulare è stato pubblicato sulla rivista ACS Nano

Loretta L. del Mercato, del Cnr-Nanotec, ha spiegato: «Siamo riusciti a creare un microambiente simile a quello naturale per lo sviluppo delle cellule tumorali, realizzando membrane nanofibrose contenenti sensori ottici che simulano la struttura della matrice extracellulare, la parte dei tessuti nei quali non sono presenti cellule. Queste membrane permettono di ricostruire, con un’elevata risoluzione spaziale e temporale, i flussi di protoni e le reti di scambio tra cellule all’interno di una popolazione cellulare eterogenea: le differenze tra singole cellule, infatti, influenzano fortemente il comportamento collettivo dei sistemi biologici e, di conseguenza, possono inficiare l’efficacia dei trattamenti medici».
«La scelta del modello di studio, il tumore del pancreas, è da considerarsi strategica perché questa patologia rientra tra i tumori big killer ed è particolarmente resistente ai trattamenti farmacologici», ha precisato Amalia Azzariti dell’Istituto tumori di Bari.
Ricercatori dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche di Lecce, in collaborazione con l’Instituto Biofisika (Spagna), la Fondazione Ikerbasque (Spagna), l’Istituto Italiano per la Medicina Genomica (ente strumentale della Fondazione Compagnia di san Paolo), il Politecnico di Torino, l’Università del Salento (Lecce) e l’Istituto tumori “Giovanni Paolo II” Ircss di Bari, hanno condotto una ricerca, che ha visto la realizzazione di una nuova piattaforma in grado
di ricostruire l’ecosistema alla base dello sviluppo dei tumori, partendo dall’analisi del metabolismo cellulare. Questo tipo di studi, focalizzato sulle singole cellule, trova applicazione in diversi ambiti, nelle patologie tumorali, nell’immunologia e nella neurologia, ed è importante perché individua meccanismi che non sarebbero identificabili attraverso indagini eseguite sull’intera popolazione cellulare. Tuttavia, le tecniche che attualmente vengono utilizzate per la misurazione delle caratteristiche metaboliche delle cellule sono spesso costose e invasive.
Andrea De Martino, del Politecnico di Torino, ha proseguito dichiarando: «È importante notare che in questo ecosistema le cellule tumorali e non tumorali possono scambiarsi i ruoli, in contrasto con l’idea diffusa che le tumorali operino soprattutto come donatrici di acido lattico e non come accettori, ovvero come cellule che lo accolgono. Pertanto, le strategie che puntano a limitare la crescita dei tumori riducendo la loro capacità di espellere acido lattico potrebbero rivelarsi inefficaci».
«Analizzando l’acidificazione di massa di una coltura tumorale, nota come effetto Warburg, che è un segno distintivo del cancro, abbiamo ricostruito il contributo apportato da ogni singola cellula. Si è potuto così constatare che l’acido lattico secreto dalle cellule donatrici funge sia da molecola di segnalazione nella comunicazione cellulare che da substrato per gli accettori», ha concluso Daniele De Martino dell’Istituto Biofisika/Ikerbasque.
Èuna sfida per la comunità scientifica poter controllare le reazioni chimiche, considerato il costante impegno nel rendere più efficiente la sintesi di nuove molecole che possano essere utilizzate per applicazioni in ambito farmaceutico o come plastiche o per il design di nuovi materiali. I metodi di solito utilizzati per modificare il decorso di una reazione chimica sono basati su variazioni di parametri come temperatura o pressione, oppure utilizzano catalizzatori solidi o in soluzione: questi approcci, però, agiscono su scala più ampia e, spesso non consentono di controllare parti specifiche e localizzate delle molecole coinvolte. Un team di ricerca internazionale, che comprende anche ricercatori italiani dell’Istituto per i processi chimico fisici del Cnr, aggiunge un importante tassello alla comprensione e al controllo dei processi chimici che avvengono in presenza di campi elettromagnetici.
Lo studio, pubblicato su Nature Communications, è guidato dal Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter di Amburgo (Germania): esso si colloca nell’ambito della chimica polaritonica, il settore che studia come manipolare i materiali attraverso l’uso di cavità ottiche, cioè spazi confinati in cui le molecole interagiscono fortemente con la luce.
Enrico Ronca, ricercatore del Cnr-Ipcf che ha cofirmato lo studio, ha spiegato: «Le reazioni chimiche sono direttamente correlate alle vibrazioni degli atomi coinvolti, ma è molto difficile controllare selettivamente questi movimenti. Se questo fosse possibile, però, sarebbe sufficiente riuscire a fornire solo una piccola quantità di energia ad alcuni atomi al momento giusto, proprio come un giocatore di biliardo vuole spingere solo una pallina sul tavolo, per far sì che la reazione avvenga. Il nostro studio ha rivelato che le condizioni all’interno della cavità ottica influenzano l’energia di vibrazione degli
atomi attorno a specifici legami della molecola, modificandone quindi la reattività chimica. Al di fuori della cavità, quell’energia viene solitamente depositata su un singolo legame durante la reazione, che alla fine si può rompere: questa differenza è un passaggio chiave per spiegare perché le reazioni sono rallentate all’interno della cavità. Il nostro lavoro teorico migliora la comprensione dei meccanismi microscopici coinvolti in questo processo, in particolare per il caso specifico di una reazione inibita dal campo elettromagnetico, che abbiamo studiato con la tecnica della
Quantum-Electrodynamical Density-Functional Theory».
Christian Schafer della Chalmers University of Technology, ha aggiunto: «Abbiamo scoperto che la cavità apre un nuovo percorso di reazione, quindi è meno probabile che l’energia venga incanalata su un singolo legame. Questo è il processo chiave che inibisce la reazione chimica, perché diminuisce la probabilità di rompere un legame specifico». Nonostante la necessità di un’ulteriore validazione sperimentale, è stato sottolineato il ruolo fondamentale dello studio. (P. S.).

calcolato gli indici di emissione per tipo di carburante, che esprimono la concentrazione di inquinante presente nei gas di scarico dell’aereo in funzione della quantità di combustibile bruciato. Le due miscele a base di biocarburanti hanno fatto registrare per tutte le prove una riduzione media del 20% e fino al 40% per medi regimi di potenza motore, delle emissioni di black carbon, ossia il carbonio elementare; allo stesso tempo, abbiamo rilevato l’aumento fino al 30% del biossido di azoto e della quantità di particelle totali emesse, in particolare delle nanoparticelle».

Enea ha sperimentato miscele di biocombustibile e cherosene ottenendo una riduzione delle emissioni inquinanti
Èstato sperimentato, per la prima volta nel nostro Paese, l’uso di miscele di biocombustibile e cherosene su un jet militare, ottenendo una riduzione fino al 40% delle emissioni di inquinanti complessive. A calcolare questo taglio è stato uno studio condotto da ricercatori Enea, in collaborazione con l’Aeronautica Militare, nell’ambito dell’accordo di cooperazione in materia di utilizzo di biocombustibili nel settore dell’aviazione, che coinvolge anche Cnr e Ministero dell’Ambiente e della Sicu-
rezza Energetica. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista internazionale Toxics. I test sono stati condotti su due diverse miscele contenenti il 13% e il 17% di biocombustibile nel corso di diverse prove motore con velivolo a terra, presso la Divisione Aerea di Sperimentazione e Spaziale dell’aeroporto militare di Pratica di Mare, vicino Roma.
Antonella Malaguti, ricercatrice Enea del Laboratorio di Inquinamento Atmosferico presso il Centro Ricerche di Bologna, ha spiegato «Grazie al nostro laboratorio mobile abbiamo
Il ricercatore Maurizio Gualtieri, in servizio all’Enea al momento della ricerca e ora presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha sottolineato: «Novità assoluta per questa tipologia di ricerca, è stata la valutazione delle potenziali risposte biologiche del polmone umano ai prodotti di combustione, mediante l’esposizione diretta di un modello in vitro di cellule bronchiali alle emissioni sia dei combustibili fossili sia delle due miscele a base di biocarburante. Questo test, associato al calcolo della dose di esposizione a livello polmonare, apre scenari rilevanti per la determinazione del potenziale rischio per l’uomo. Inoltre, la campagna di test ha evidenziato una maggiore deposizione di particelle fini e ultrafini (cioè con diametro inferiore a 100 nanometri), sia nel sistema cellulare che a livello polmonare, anche se tale incremento non deve ascriversi in maniera prioritaria alla componente bio delle miscele di carburante».
I risultati biologici hanno evidenziato un aumento della risposta antiossidante delle cellule, quantificata attraverso l’espressione del gene HO-1 (le emissioni con carburante tradizionale ha effetti lievemente maggiori rispetto ai nuovi biocarburanti). Analizzando la risposta delle cellule a distanza di un’ora dalla fine dell’esposizione, l’attivazione della risposta antiossidante è incrementata notevolmente. (P. S.).
Enea, l’Università degli Studi di Cagliari, CRS4 e Mutah University (Giordania), hanno collaborato al progetto denominato Ortumannu finalizzato a sostituire i fertilizzanti chimici con microrganismi e batteri in grado di favorire la crescita delle piante anche nei periodi di stress idrico, migliorando le funzioni del suolo e la produzione agricola. Grazie all’utilizzo integrato di risorse naturali, biotecnologie e strumenti di caratterizzazione, monitoraggio e modellazione all’avanguardia, si punta a contrastare l’impoverimento dei suoli e a promuovere una produzione agricola di alta qualità, riducendo l’utilizzo di fertilizzanti, pesticidi e acqua.
Nell’ambito del progetto, il team di ricercatori dell’enea è stato impegnato nella caratterizzazione microbiologica del suolo presso una stazione agronomica della regione di Al-Ghweir in Giordania, contraddistinta da suoli improduttive scarsità di risorse naturali e acqua. In seguito, utilizzando il sequenziamento del gene 16S rDNA, il team ha isolato e identificato dal suolo 40 ceppi di batteri che sono stati testati per la capacità di promuovere la crescita delle piante, fissare l’azoto, mobilizzare il fosforo, solubilizzare il potassio e produrre siderofori, cioè sostanze organiche in grado di influenzare l’accrescimento delle piante.
I ceppi con le migliori caratteristiche sono stati selezionati per creare la formula microbica più efficace da applicare in un campo sperimentale della Mutah University coltivato a sorgo, una specie vegetale della famiglia delle graminacee, che cresce tutto l’anno. Viene considerato il quinto cereale per importanza di coltivazione nell’economia agricola del mondo, già coltivato già dai tempi antichi proprio per la sua resistenza anche in terreni con poca acqua o in caso di siccità.
Rispetto all’uso di fertilizzanti chimici come, ad esempio, il fosfato biammonico (DAP), la sperimentazione in campo ha dimostrato l’efficacia
Il progetto Ortumannu mira a sostituire i fertilizzanti chimici con microrganismi e batteri
della formula microbica nel sostenere la crescita durante la fase di produzione di fusti secondari del sorgo (accestimento). Inoltre, è stato anche rilevato che in condizioni di stress idrico le piante inoculate con il biofertilizzante sono sopravvissute in buone condizioni fisiologiche, a differenza delle piante che sono state concimate con fertilizzante chimico.

Chiara Alisi, ricercatrice Enea del Laboratorio di Osservazioni e misure per l’ambiente e il clima e referente del progetto per l’Agenzia, ha dichiarato: «Ad oggi abbiamo dimo -
strato che la fertilizzazione con una formula microbica sito-specifica, naturale ed endemica può sostituire quella chimica e andare a migliorare le pratiche agricole spesso basate sull’uso intensivo di fertilizzanti e sullo sfruttamento eccessivo delle risorse idriche, causando l’impoverimento dei suoli. Per questo motivo auspichiamo un impatto positivo sulle comunità locali che abbiamo già coinvolto nella ricerca, ma ci impegneremo anche per un rapido processo di trasferimento dei risultati al settore agroindustriale». (P. S.).
Il muro di filo spinato e le barriere invalicabili sono un lontano (e triste) ricordo Le due città, italiana e slovena, si preparano insieme al grande appuntamento del 2025

Dalle divisioni del passato alla condivisione di una straordinaria esperienza futura, il titolo di Capitale europea della cultura per il 2025. Gorizia e Nova Gorica la vivranno come se fossero una cosa sola, come se fossero ancora unite. Le due anime, italiana e slovena, di una sola città che nel corso dei secoli è stata crocevia di culture, luogo di passaggio e di fusione, ma anche di incontro e di scambio. Dove la Storia ha separato, ci penserà la Cultura a riunire e ad accomunare valori, tradizioni ed esperienze. Con una data simbolo per la cerimonia inaugurale: l’8 febbraio 2025. Scelta non a caso, come sottolineato dal mini-
stro della Cultura italiano Gennaro Sangiuliano e dalla sua omologa slovena, Asta Vrecko: «L’8 febbraio è la Giornata della cultura che si celebra da tempo in Slovenia, legata allo scrittore France Prešeren. Ma coincide anche con la nascita di uno dei nostri più grandi poeti, Giuseppe Ungaretti, che conobbe questo territorio durante la prima guerra mondiale come soldato e che qui scrisse alcuni dei suoi indimenticabili versi».
La candidatura di Nova Gorica, «Go! 2025», è stata premiata dalle istituzioni europee e avrà in Gorizia un partner imprescindibile. La prima volta di una città slovena Capitale della cultura e – di fatto – la quinta per una città

italiana dopo Firenze (1986), Bologna (2000), Genova (2004) e Matera (2019). Così ancora il ministro Sangiuliano: «L’Italia è e deve essere orgogliosa per questo riconoscimento che fa finalmente emergere le vicende di un territorio, quello del Goriziano, attraverso il quale è passata la storia d’Europa e in cui un drammatico confine ha profondamente segnato le comunità che lo abitano. Ma i cittadini di Nova Gorica in Slovenia, e di Gorizia in Italia, hanno saputo superare rancori e divisioni e hanno deciso di ricostruire insieme il loro futuro, diventando un modello e un simbolo per l’Europa e ottenendo così il giusto riconoscimento di questo loro straordinario cammino».
Gorizia e Nova Gorica, del resto, sono state una sola città fino al termine della Seconda Guerra Mondiale. Fu il confine imposto dal Trattato di Parigi del 1947 a tagliarla letteralmente in due: il centro storico rimase italiano, la stazione Transalpina e i quartieri della periferia orientale passarono alla Jugoslavia. Con un muro dalla base in calcestruzzo larga 50 centimetri e sormontato da una ringhiera di circa un metro e mezzo che avrebbe tristemente anticipato quello di Berlino e che avrebbe diviso non solo la parte occidentale e quella orientale della cittadina, ma anche affetti, amicizie e persino parenti. Solo dopo quattro anni, durante
i quali fece costruire a velocità impressionante strade, edifici e interi quartieri in modo da rendere Nova Gorica una vera e propria città contraltare di Gorizia, Tito concesse ai residenti di salutare i propri cari oltre confine in quella che è ricordata come la «domenica delle scope»: il 13 agosto 1951. Il recinto di filo spinato che tagliava in due piazza della Transalpina rimase chiuso, fu invece aperto il valico della Casa Rossa dove migliaia di persone si ammassarono per poter finalmente riabbracciare amici e conoscenti, ma anche per fare acquisti in Italia, depositare o prelevare denaro, persino concedersi l’ascolto di una messa. Erano altri tempi, anche se sono passati soltanto 72 anni, e lo dimostra il fatto che la sera fecero tutti ritorno nelle proprie case.

Gorizia e Nova Gorica tornarono a essere due blocchi rigidamente separati fino al 1962, quando la stipula degli Accordi di Udine garantì le prime, parziali aperture territoriali. Nel 1964 ci fu persino un’elementare forma d’integrazione amministrativa che ha preceduto di undici anni i trattati di Osimo del 1975, che stabilirono l’inizio ufficiale di una collaborazione tra Italia e Jugoslavia. Il resto è storia recente. Nel 1998, dopo che la Slovenia si era resa indipendente dalla federazione di Belgrado, fu firmato un protocollo di collaborazione tra le due amministrazioni comunali a cui ha aderito un anno dopo quella di Sempeter-Vortojba, in italiano San Pietro Vertoiba, comune scissosi nel frattempo da quello di Nova Gorica. Dal 2002 le tre giunte lavorano in sinergia, con la creazione di un Ufficio Transfrontaliero preposto alla cooperazione e alla semplificazione linguistica e legislativa.
Dal 2004, con l’ingresso della Slovenia nell’area Schengen, la cortina di ferro che tagliava in due piazza della Transalpina è stata definitivamente rimossa e il valico della Casa Rossa è stato aperto una volta per tutte. Solo nel 2020 il confine e le barriere sono state ripristinate per un breve periodo, durante i momenti più bui della pandemia Covid. Ma il futuro è fatto di connessioni sempre più strette. Il titolo di Capitale europea della cultura è anche e soprattutto occasione per nuovi progetti di integrazione, tra cui la pista ciclabile transfrontaliera. Ciò che prima era tenuto separato con la forza delle barriere e dei muri, adesso è destinato a viaggiare insieme, nel segno della cultura.

Nel corso dell’ultima campagna di scavi archeologici condotta dall’Università Statale di Milano nel sito preistorico della Colombare di Negrar di Valpolicella, a Verona, sono state ritrovate tracce di una casa datata attorno al IV millennio a. C. e di strutture terrazzate risalenti all’età del bronzo.
La scoperta racconta nuove informazioni sul sito e sui suoi abitanti, che si vanno ad aggiungere a quelle raccolte nel 2021, quando i ricercatori appurarono la presenza di pollini di vite negli strati archeologici di età neolitica, confermando che le pratiche di coltivazione di questa pianta risalissero già a 6300 anni fa.

Le ricerche, guidate da Umberto Tecchiati, docente di Preistoria e di Ecologia preistorica del dipartimento di Beni culturali e ambientali dell’Università degli Studi di Milano, sono state concentrate nella stessa area che fu oggetto di indagini nel 2019 e nel 2021, dove fu trovata una trincea databile tra il Neolitico e l’inizio dell’età del Rame. La ripresa dei lavori di scavo è prevista per l’estate e l’obiettivo dei ricercatori sarà quello di mettere in luce la casa del Neolitico tardo e di ampliare le indagini delle zone terrazzate. Intanto, negli spazi del laboratorio del dipartimento di Beni culturali e ambientali, un’equipe di studenti e di specializzandi continuerà ad analizzare e studiare i reperti trovati, mentre i resti faunistici e i campioni di terreno saranno affidati a professionisti che svolgeranno più approfondite analisi strumentali in specifici laboratori.
La campagna realizzata sul sito archeologico veronese si caratterizza proprio come una ricerca multidisciplinare. Il team dell’Università Statale è affiancato sul campo da Cristiano Putzolu, docente
di archeologia digitale presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Il progetto di ricerca è infatti finalizzato alla valorizzazione e condivisione pubblica dei risultati. La direzione è affidanta congiuntamente anche a Paola Salzani, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. Allo scavo hanno partecipato circa venti esperti tra studenti e studentesse dei corsi di laurea in Scienze dei Beni culturali e in Archeologia, e specializzande della Scuola di specializzazione in Beni archeologici dell’Università Statale.
Titoli iridati per Brignone in combinata e Bassino in super G in Francia. Nel biathlon, oro per Comola, Wierer, Auchentaller e Vittozzi nella staffetta femminile ai Mondiali in Germania

L’Italia del Circo Bianco è tornata a graffiare. Con le sue leonesse, in primis: da Brignone e Bassino nello sci alpino alle magnifiche quattro staffettiste azzurre del biathlon, ovvero Comola, Wierer, Auchentaller e Vittozzi. Aspettando l’epilogo dei mondiali di sci nordico, il 2023 è iniziato con il brillio di ori, argenti e bronzi nelle rassegne iridate ospitate rispettivamente da Courchevel/Méribel (Francia) e Oberhof (Germania).

Il primo raggio di sole azzurro ha illuminato l’alba del Mondiale, nella gara di combinata femminile. E pensare che, dopo aver dominato il Super G, Federica Brignone ha tagliato il traguardo dello slalom con la sensazione che potesse mancare qualcosina per l’oro. «Ci ho provato» ha urlato alle telecamere, ripensando a quell’errore all’altezza del secondo intermedia. E la campionessa uscente Mikaela Shiffrin
l’avrebbe sorpassata, non
fosse per l’uscita a due sole porte dal traguardo, dopo una rimonta continua sin dal primo intermedio. Per Federica, un ritorno sul podio iridato a 12 anni dall’argento in gigante a Garmisch. «Erano tre edizioni ai Mondiali che non ero al 100 per cento o fisicamente o mentalmente, questa volta mi sono ricaricata per dare il massimo» ha commentato Federica. Ottava nel Super G vinto da un’altra azzurra, Marta Bassino, Brignone ha “rischiato” di concedere un clamoroso bis, piazzandosi seconda nel gigante vinto per soli 12 centesimi dalla regina Mikaela Shiffrin.
Se la valdostana ha raggiunto Isolde Kostner e Deborah Compagnoni in testa alla classifica delle plurimedagliate azzurre ai Mondiali, Marta Bassino ha regalato un oro all’Italia nel Super G femminile a 26 anni dall’analoga impresa della Kostner. Partita piano, la 26enne cuneese è stata autrice di un finale sontuoso, che le ha permesso di battere di 11 centesimi la Shiffrin e di 33 l’austriaca Cornelia Huetter e la norvegese Kajsa Vi -
cfhoff Lie. «L’oro in parallelo di due anni fa era stato bello - ha detto Bassino, che prima di Méribel non aveva mai vinto in Super Gma stavolta è qualcosa di più, di forte. Sono veramente contenta di me stessa e allo stesso tempo meravigliata di avere fatto la gara così bene».
Smaltite poi le delusioni della Goggia e dei velocisti, l’Italia ha chiuso il Mondiale con il bel terzo posto di Alex Vinatzer nello slalom vinto da Henrik Kristoffersen davanti al greco AJ Ginnis. Una medaglia, la quarta, che ha proiettato gli azzurri al quarto posto del medagliere ex-aequo con gli Stati Uniti che però hanno vinto un argento in più. «Sono riuscito a mettere insieme due manche, è stato un inverno difficile» ha commentato Vinatzer, ripensando alle numerose uscite anticipate: «Avevo buone sensazioni, in partenza ho detto al mio skiman: ci vediamo all’arrivo».
Dalle grande festa alla corte di Francia alle nevi di Oberhof, Germania, dove l’Italia ha conquistato uno straordinario oro nella staffetta femminile ai Mondiali di biathlon. Prova straordinaria, quella delle azzurre, impressionanti a poligono, con due soli errori su 40 tentativi, contro i 6 delle tedesche padrone di casa e i 12 delle svedesi. Dalla calmissima Samuela Comola all’implacabile Lisa Vittozzi, che ha riscattato l’agrodolce bronzo nell’Individuale femminile, nella quale un errore all’ultimo di 20 tiri l’aveva privata di una possibile medaglia d’oro e di un sicuro argento. E poi “sua maestà” Dorothea Wierer, che nelle prove di squadra dà sempre il meglio di sé, e la giovane Hannah Auchentaller, esemplare nella gestione

delle emozioni nei due poligoni. Era dal 1995 che sul gradino più alto della staffetta femminile non saliva una fra Norvegia, Germania e Russia, mentre l’Italia prima d’ora aveva conquistato al massimo il bronzo, nel 2013 e nel 2015. «È stata una vittoria bellissima, straordinaria. Siamo felicissime perché è stato bellissimo» il commento di Lisa Vittozzi, che nell’ultima tornata al poligono ha messo una pressione decisiva alla tedesca Denise Herrmann: «Sapevo di essere in buone condizioni con il tiro in piedi, quindi, ho voluto forzare il più possibile per mettere Herrmann sotto pressione e alla fine è andata alla grande» le parole della biathleta bellunese.
I sentori che potesse arrivare un grande risultato nella prova a squadre femminile c’erano tutti, dopo l’argento del quartetto formato da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel nella staffetta mista e il risultato della 15 km femminile con Vittozzi terza e Comola quarta, quest’ultima con un percorso netto al poligono. In chiusura di mondiale, l’Italia ha sfiorato il sorpasso sulla Germania nel medagliere (sarebbe stato necessario un altro argento), concludendo terza nella Single Mixed con Vittozzi e Giacomel, alle spalle di Norvegia e Austria. Gli azzurri hanno totalizzato quattro podi totali, gli stessi di Anterselva 2020 e uno meno di Östersund 2019, edizioni chiuse al terzo posto nel medagliere. Se si pensa, però, che nel penultimo Mondiale (2021) eravamo rimasti all’asciutto, quanto espresso dall’Italia del biathlon in Germania – per il presente e in prospettiva – ha un sapore ancora più dolce.

Segui la sezione Bandi e Concorsi sul sito della FNOB
Troverai gli avvisi pubblici dedicati ai Biologi
Le ragazze allenate da Daniele Santarelli continuano a vincere malgrado la mezza rivoluzione estiva: con la Coppa Italia sono 19 i trofei vinti a partire dallo scudetto 2016
Un “dna” vincente, un naming sponsor che evoca festeggiamenti, una favola quasi perfetta. Quella che in sei anni e mezzo ha portato nella bacheca della Prosecco Doc Imoco Conegliano la bellezza di 19 trofei e nel roster delle Pantere alcune fra le più forti giocatrici della pallavolo mondiale. Paola Egonu, Miriam Sylla e Monica “Moki” De Gennaro, tanto per citare tre nomi noti a chi il volley lo segue con attenzione soprattutto quando gioca la nazionale. E poi la schiacciatrice statunitense Kathryn Plummer, la centrale olandese Robin de Kruijf, la palleggiatrice e attuale capitana Joanna Wolosz, la giovane opposto Isabelle Haak, arrivata la scorsa estate al posto di Egonu e già decisiva nei momenti più importanti, migliore in campo sia nel Mondiale per club a dicembre, sia nella finale di Coppa Italia a fine gennaio.
Questione di “dna”, dicevamo. Quello che ha portato l’Imoco, in dieci anni (e poco più) a diventare una delle squadre di pallavolo più forti al mondo, tanto da trionfare anche in Champions League nel 2021 e nel Mondiale per club nel 2019 e lo scorso anno.
I successi del club veneto sono iniziati con Davide Mazzanti, passato poi alla guida della Nazionale femminili, e si sono moltiplicati negli ultimi sei anni con il suo “delfino”
Daniele Santarelli, marito di De Gennaro e autentico Re Mida del volley. Basti pensare
al suo 2022, lungo il quale si è aggiudicato la Coppa Italia, lo Scudetto, la Supercoppa e il Mondiale per Club con l’Imoco, e il titolo iridato con la Serbia, per poi accettare l’incarico di ct della nazionale femminile della Turchia.
I trionfi di Conegliano sono proseguiti a dispetto della mezza rivoluzione estiva. Che, va detto, se ha visto salutare l’Imoco campionesse come Paola Egonu, Miriam Sylla e Raphaela Folie (oltre alle varie Caravello, Courtney, Frosini, Vuchkova, Omoruyi e Giulia Gennari), ha comunque ridisegnato la squadra con ragazze di assoluto valore. Come Isabelle Haak, 23 enne svedese di Lund, che aveva fatto piangere Conegliano nella finale di Champions League dello scorso anno a Lubiana, in maglia VakifBank. “Bella” aveva fatto sognare i suoi nuovi tifosi sin dalla prima intervista, dicendo di avere la sensazione “che le mie caratteristiche si adattino bene al loro sistema! A Conegliano piace il gioco veloce e io adoro i palloni veloci. Inoltre vengono proposte molte combinazioni diverse, cosa che mi piace molto”. A dicembre, nella finale del Mondiale per club, Haak si è elevata sopra l’altissimo livello tecnico delle duellanti –tra le altre Egonu, Gabi e Gunes da un lato, Wolosz, Robinson e De Gennaro dall’altro – mettendo a referto 34 punti e prendendosi il titolo di Mvp – Most valuable player, ovvero la migliore in campo. Poi si è ripe -
tuta nella finale di Coppa Italia, vinta per 3-0 sulla Vero Volley Milano: per Bella, 23 punti (su 75 della squadra) con percentuale del 54 per cento in attacco.


Altro volto nuovo, ma non del tutto, è Kelsey Robinson Cook, 30enne schiacciatrice statunitense, che nel 2016 siglò il punto decisivo per le Pantere nella finale-scudetto. Sposata in Toscana con il collega Brian Cook, reduce da un quinquennio girovago fra Turchia, Cina e Giappone, “Kesh” è tornata a Conegliano mettendo a segno punti pesanti nei momenti più caldi delle partite. Italianissime sono invece le centrali Marina Lubian e Federica Squarcini, entrambe classe 2000, l’una piemontese l’altra toscana, che oltre ad avere colpi importanti stanno mettendo in mostra anche una certa maturità nelle fasi decisive. Di maturità ed esperienza ne ha da vendere Alessia Gennari, campionessa d’Europa con l’Italia, pure lei arrivata la scorsa estate, al pari di Alexa Lea Grey, Roberta Carraro e Ylenia Pericati.
Aspettando Sarah Fahr, tornata finalmente a dominare sotto rete dopo due infortuni consecutivi al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, le certezze di Coneglia -
no nella prima parte di stagione sono state Moki De Gennaro, atleta dalle rare doti difensive, il “martello” Kathryn Plummer, la centrale Robin de Kruijff e a dirigere l’orchestra Joanna Wolosz, palleggiatrice dalle mille soluzioni, capace di rendere felici tutte le “cannoniere” dell’Imoco. A mettere assieme certezze e novità, appunto, c’è Santarelli: “Nonostante un bel cambiamento sapevo che il nuovo gruppo avrebbe potuto darmi soddisfazioni e così è stato”, ha dichiarato in una recente intervista. Per molti, Daniele è il miglior allenatore del mondo, anche se a lui piace distribuire i meriti, come fanno i grandi condottieri: “Sono convinto che una vittoria non sia mai merito di un solo componente, ma il frutto del lavoro di un grande gruppo in cui ogni componente porta il suo mattone”.
Con la forza del progetto e dei risultati, con tre trofei già in bacheca, Conegliano ora si concentra sulla corsa allo scudetto (sarebbe il sesto in sette anni) e sul sogno Champions League. Dalla Pool A, le ragazze di Santarelli sono emerse con 6 successi in altrettante partite. Torneranno in campo a marzo, per i quarti di finale. (A. P.)
francese Benjamin Thomas, compagno di squadra di Consonni alla Cofidis: 162 punti a 146. Gara velocissima: i primi 100 giri sono stati percorsi alla media di 54,479 km/h.

L’ultima medaglia di Simone è arrivata nell’Americana maschile, in coppia con Michele Scartezzini. Prova straordinaria, quella dei due azzurri, privati solo all’ultima volata dell’oro da una fortissima Germania, a conclusione di una gara corsa a quasi 58 km orari di media.
Jonathan Milan ha invece fatto il bis di ori nell’inseguimento individuale: il 22enne friulano ha battuto l’ex primatista dell’ora, l’inglese Dan Bigham, chiudendo il 4’03”774. Bronzo al tedesco Tobias Buck-Gramcko. Per Milan si è trattato del terzo oro europeo, il secondo nella prova individuale dopo quello del 2021.
Il ciclista bergamasco ha conquistato due medaglie d’oro e due d’argento Italia “regina” nell’inseguimento a squadre e individuale. Due podi per le donne
Tre medaglie d’oro, tre d’argento e una di bronzo. Un bilancio lusinghiero per l’Italia del ciclismo ai Campionati europei su pista di Grenchen (Svizzera). La copertina azzurra se l’è presa Simone Consonni, 28enne bergamasco di Brembate Sopra, portacolori del team francese Cofidis. Dopo l’oro nella corsa a punti, Consonni ha trionfato con la squadra azzurra dell’inseguimento e ha conquistato l’argento nell’Omnium e nell’Americana.
Reduce dal successo su strada in una tappa del Saudi Tour, l’olimpionico ha inaugurato la rassegna continentale elvetica vincendo la corsa a punti a quota 54,
+3 rispetto allo spagnolo Torres e +6 sul francese Grondin, quest’ultimo arrivato all’ultimo sprint a pari punti con Consonni. C’è la firma dell’atleta lombardo anche sulla medaglia d’oro dell’Italia nell’inseguimento a squadre, visto che Consonni ha dato il suo contributo per portare in finale il quartetto. A completare l’opera ci hanno pensato Francesco Lamon, Manlio Moro, Jonathan Milan e “sua maestà” Filippo Ganna, che si sono messi alle spalle la Gran Bretagna, confermando l’Italia al top dopo il trionfo olimpico. Consonni è andato forte anche nell’Omnium, specialità olimpica, combattendo su ogni sprint e guadagnando anche un giro di pista, prima di cedere al
Due invece le medaglie in campo femminile. L’Italia, campionessa del mondo in carica, non ce l’ha fatta a ripetersi nell’Inseguimento a squadre, perdendo contro la Gran Bretagna ma conquistando un argento importante. Martina Alzini, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini hanno concluso la finale col tempo di 4’16”018, alle spalle della Gran Bretagna (4’13”890) e davanti alla Germania. Bronzo agrodolce, infine, nell’Americana femminile per Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini, dietro la solita Gran Bretagna (Archibald e Barker) e Francia (Berteau e Copponi). Puntavano a qualcosa in più e dopo i primi quattro sprint erano a “braccetto” con le britanniche. Poi qualche errore ha condizionato l’esito finale della gara. Ma brave comunque.
L’Italia ha concluso gli Europei al quarto posto nel medagliere, dietro Germania, Gran Bretagna e Paesi Bassi. Marco Villa, commissario tecnico della Nazionale di ciclismo su pista, ha parlato di un bilancio positivo: «Abbiamo dimostrato di essere una delle nazionali europee più forti – ha commentato Villa dopo Grenchen - e ci tenevano a dimostrarlo. E dato bei segnali in vista di Parigi 2024: abbiamo un anno e mezzo per essere ancora più competitivi». (A. P.)
Il loro obiettivo, sul volo per l’Europa, era già ben chiaro: regalare al Canada la prima medaglia a un Mondiale di ciclocross. Sono riuscite a fare ancora meglio, vincendone due, le più prestigiose. Nella stessa gara. C’è altro? Si: Isabella e Ava Holmgren, oro e argento fra le Juniores in quel di Hoogerheide (Paesi Bassi), sono sorelle gemelle. Nate il 22 maggio 2005 e cresciute a “pane” - si fa per dire – e bicicletta.
Erano partite piano, entrambe. Poi la lenta rimonta. La prima a tagliare il traguardo è stata Isabella, detta Bella. Ha abbracciato i genitori, poi ha visto sbucare Ava, seconda dietro di lei e davanti alla francese Célia Gery, che ha battuto allo sprint l’italiana Federica Venturelli. Si sono abbracciate, con parole d’amore. «Quanto ho tagliato il traguardo ero emozionatissima, non riuscivo a crederci. Poi ho visto arrivare mia sorella seconda, un momento meraviglioso», ha detto Isabella dopo la gara. E ava, di rimando: «Puntavo a ottenere la prima medaglia del Canada, ma è andata ancora meglio: ha vinto mia sorella e siamo andate entrambe sul podio».
Le diciassettenni canadesi erano le favorite della gara Junior femminile. Ava era reduce dal titolo panamericano di categoria (con Isabella terza) e dai successi nel Campionato nazionale Elite e nella gara Junior di Coppa del Mondo di Besançon, a una settimana dai Mondiali. Isabella si era imposta nel Campionato nazionale Junior e vinto a Capodanno fra le pari età al GP Sven Nys, prova dell’X2O Trofee, prima di inanellare tre podi consecutivi in Coppa del Mondo.
Nella prova iridata del 2022, le sorelle Holmgren avevano chiuso settima (Ava) e ottava (Isabella) a Fayetteville, staccate fra loro di 17 secondi. Stavolta è stata Isabella la più veloce. A giocare per lei sono state anche le condizioni del percorso, particolarmente fangoso. E del resto la neocampionessa del mondo ha ammesso di preferire le gare in Europa «perché è davvero raro disputare una gara all’asciutto».

Le due ruote sono sempre state una passione di famiglia, a casa Holmgren. Isabella e Ava sono figlie di Rob e Lisa, ex atleti, e sorelle di Gunnar, primo di cinque figli e già campione nazionale canadese di cross country: completano la famiglia Torunn e Max, pure loro più grandi delle gemelle. Gunnar, che fino a 14 anni ha praticato pattinaggio con buoni risultati, ha raccontato che suo padre è stato il suo allenatore e la madre la sua consigliera. Probabile sia così per le gemelle, anche se nel loro caso sono tre le figure di riferimento, Gunnar compreso.
Intanto, in gara, Isabella e Ava sono, sì, sorelle ma fino a un certo punto.
Gioco di squadra? Ni. Capita, naturalmente, di lavorare per un intento comune. Ma prima o poi, nel pieno della battaglia, si diventa avversarie. «Prima di correre, stabiliamo sempre un certo numero di giri in cui corriamo l’una contro l’altra, anche perché è escluso che una di noi due alzi il piede per far vincere l’altra. Non decidiamo in anticipo chi sarà la punta: è la gara a stabilire chi vince», ha spiegato Isabella. Intanto, in una disciplina che in campo femminile parla soprattutto olandese –o in alternativa fiammingo o francese –le gemelle Holmgren hanno scritto una bella pagina di storia. Che proveranno a ripetere. (A. P.)
Un volume ripercorre le telecronache del giornalista friulano, principe dei narratori dello sport negli anni Ottanta e Novanta, quando il pallone era meno gonfiato
di Anna Lavinia Giuseppe Malaspina, Antonino PalumboUrbone Publishing, 2023 – 16 euro
Era il 17 luglio 1994 e la voce inconfondibile che risuonava nel silenzio delle case degli italiani era quella di Bruno Pizzul che manteneva il suo garbo e la sua compostezza durante l’indimenticabile e a dir poco maledetta, finale dei mondiali statunitensi. Si potrebbe riportare alla mente una storica vittoria della Juventus all’ultimo minuto contro il Paris Saint-Germain o la sconfitta pungente del Real Madrid contro il Torino, ma qualsiasi sia la fede calcistica o la generazione di appartenenza, se c’è un gol nelle orecchie di tutti risuonerà la sua infallibile voce.
E se, invece, c’è qualcuno che non era lì ad ascoltarlo in quegli anni, questo libro può diventare motivo di scoperta di chi ha visto giocare dal vivo Diego Armando Maradona e la Nazionale di Enzo Bearzot. Un saggio semiserio dove si gioca a calcio attraverso la “grammatica” di Bruno Pizzul, si esplora e racconta la forza comunicativa di avverbi, sostantivi e soprattutto interiezioni del popolare telecronista.
Quella dei giornalisti Malaspina e Palumbo, sembra una vera e propria trasvolata sui
campi, dalle partite del Bel Paese alle dispute internazionali. Con empatia, abilità lessicale ed una grande capacità di accordare improvvisazione e preparazione, Pizzul ha marchiato a fuoco quattro decenni di telecronaca del calcio. La sua voce è quella dei sogni che si sono realizzati per alcune squadre come il Milan che tra gli anni ‘80 e ’90 ha dominato il calcio o degli incubi di altre squadre che, invece, hanno subito pesanti sconfitte in Serie A. Tra le sue tante frasi iconiche, ce ne sono certe che aprono istantaneamente a momenti storici del calcio. Espressioni coniate in completa improvvisazione hanno creato uno stile particolare di commento e non solo, alcuni di questi termini sono diventati “cult” di uso comune.
Con Juventus – Barcellona, partita che ha originato l’epifania dell’assoluto calcistico Ed è gol, il linguaggio guida (neanche a dirlo) gli undici capitoli dedicati alle sue indimenticabili telecronache. Dalla finale della Coppa dei campioni tra Liverpool e Roma del maggio 1984 all’infernale partita dei mondiali tra Corea del Sud ed Italia del giugno 2002. Arrivando alle ultime pagine del volume si può
“Ed è gol. Viaggio nelle telecronache di Bruno Pizzul”
inoltre gustare un’inedita intervista alla voce narrante di pagine indimenticabili del calcio italiano. Parole sempre ben misurate e accuratamente scelte. Con poche e semplici frasi ha dato vita a perle dialettiche in grado di coinvolgere le persone in ascolto, trasmettendo loro sia l’emozione del calciatore sia del pubblico presente allo stadio.
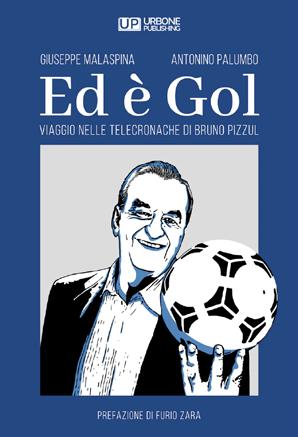
Con lui, l’Italia ha corso dietro ad un pallone comodamente dal divano di casa, ha gioito ed esultato per incredibili gol o mirabolanti parate ma ha anche pianto con dignità e classe. Una voce “di famiglia” per gli italiani, e non importava se al 90’ minuto eri sul carro dei vincitori o dei vinti, lui era lì ad accompagnarti con il suo fair play e la sua imparzialità universalmente riconosciuta. In due parole: passione e competenza al servizio del telespettatore, come d’altronde fa questo libro per il lettore.
Il prezioso lavoro dei due autori restituisce un’icona, un riferimento per il giornalismo sportivo, non solo calcistico. Insomma, per dirla con le loro parole, “la straordinarietà dello sport si nutre anche delle parole che adopera chi tenta di raccontarlo”.
Dan Saladino
“Mangiare fino all’estinzione”
Einaudi, 2023 – 23 euro
Ci sono cibi che rischiano di sparire per sempre insieme alla biodiversità. Il giornalista inglese ne traccia una grande lista rossa ed attraverso il globo va alla ricerca di formaggi, birre e conserve rarissime. La loro precaria esistenza rivela del resto il bisogno di salvaguardia del nostro pianeta, prima che sia troppo tardi. (A. L.)
Guido Barbujani
“Come eravamo. Storie dalla grande storia dell’uomo”

Laterza, 2022 – 20 euro
“Finalmente possiamo vederli, i nostri antenati.” Grazie alla lettura del DNA ed allo scrupoloso lavoro di genetisti, paleontologi ed archeologi, oggi possiamo sapere come eravamo e conoscere come era la vita quotidiana milioni di anni fa. Guardando i loro occhi e i loro volti, possiamo capire meglio quanto in realtà siamo vicini. (A. L.)
“Autismo e alimentazione”

Ipertesto.org, 2022
Il volume, scritto a quattro mani, offre spunti di riflessione sull’autismo dal punto di vista psicologico e nutrizionale. Strategie, metodi di intervento e strumenti per orientare professionisti nell’approccio della psicopatologia ed esperti di nutrizione nella gestione corretta dell’alimentazione in questo particolare contesto. (A. L.)

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO – GENOVA
Scadenza, 2 marzo 2023
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato. Gazzetta Ufficiale n. 8 del 31-01-2023.
“ALMA MATER STUDIORUM”
Scadenza, 7 marzo 2023
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali. Gazzetta Ufficiale n. 8 del 31-01-2023.
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA
Scadenza, 12 marzo 2023
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore medico o biologo o chimico di struttura complessa, disciplina di patologia clinica, per il P.O. di Patti. Gazzetta Ufficiale n. 11 del 10-02-2023.
Scadenza, 16 marzo 2023
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/E1Biochimica generale, per il Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale. Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14-02-2023.
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA DI MILANO
Scadenza, 23 marzo 2023
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico o biologo direttore di struttura complessa, varie discipline, area della medicina diagnostica e dei servizi, per la S. C. Microbiologia clinica. Gazzetta Ufficiale n. 14 del 21-02-2023.
Scadenza, 24 marzo 2023
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali. Gazzetta Ufficiale n.13 del 17-02-2023.
Scadenza, 2 marzo 2023
A public selection based on qualifications and an interview is announced pursuant to article 8 of the “Regulations concerning the hiring of personnel with a fixed-term employment contract” for the recruitment, with a fixed-term employment contract pursuant to article 83 of the CCNL (National Collective Bargaining Agreement) of the “Education and Research” Sector 2016-2018, signed on 19 April 2018, of a staff member with a professional profile of Researcher - Level III, initial salary range, at the Institute for the BioEconomy (IBE-CNR) for carrying out scientific-technological research activities within the project: CN_00000022 - National Research Centre for Agricultural Technologies (Agritech) (Project Code CUP B83C22002840001) (D.D. MUR n.
1032/2022) in the framework of the Call for proposals “Proposte di intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di ‘campioni nazionali’ di ricerca e sviluppo su alcune key enabling technologies”. Per informazioni, www.cnr.it, sezione “concorsi”.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI PORTICI Scadenza, 2 marzo 2023
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato” per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore - III livello, fascia stipendiale iniziale, presso l’Istituto di Bioscienze e BioRisorse – sede di Portici (NA) per lo svolgimento di attività di ricerca scientifico nell’ambito del progetto citato nelle premesse. Durata: 12 mesi, prorogabile fino alla fine del progetto. Per informazioni, www.cnr.it, sezione “concorsi”.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI PALERMO
Scadenza, 2 marzo 2023
A public selection based on qualifications and an interview is announced pursuant to article 8 of the “Regulations concerning the hiring of personnel with a fixed-term employment contract” for the recruitment, with a fixed-term employment contract pursuant to article 83 of the CCNL (National Collective Bargaining
Agreement) of the “Education and Research” Sector 2016-2018, signed on 19 April 2018, of a staff member with a professional profile of Researcher III level, initial salary range, at the Institute of Bioscienze e BioRisorse office headquarters Palermo for carrying out scientific-technological research activities within the project PNRR MUR – M4C2 – Investiment 1.4 - Notice “National centers” - D.D. n. 3138 del 16 dicember 2021 amended by DD n.3175 del 18 december 2021 – CN00000022 “National Research Centre for Agricultural Technologies”- notification of the Directorial Decree di granting funding n.1032 del 17.06.2022CUP B83C22002840001. Per informazioni, www.cnr.it, sezione “concorsi”.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI BIOMEMBRANE, BIOENERGETICA E BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI DI BARI
Scadenza, 2 marzo 2023
A public selection based on qualifications and an interview is announced pursuant to article 8 of the “Regulations concerning the hiring of personnel with a fixed-term employment contract” for the recruitment, with a fixed-term employment contract pursuant to article 83 of the CCNL (National Collective Bargaining Agreement) of the “Education and Research” Sector 2016-2018, signed on 19 April 2018, of a staff member with a professional profile of Researcher - III level, initial salary range, at the Istituto di Biomembrane, Bioenergetica e Biotecnologie Molecolari (IBIOM) for carrying out scientific-technological research activities within the project mentioned in the introduction. Per informazioni, www.cnr.it, sezione “concorsi”.
A public selection based on qualifications and an interview is announced pursuant to article 8 of the “Regulations concerning the hiring of personnel with a fixed-term employment contract” for the recruitment, with a fixed-term employment contract pursuant to article 83
of the CCNL (National Collective Bargaining Agreement) of the “Education and Research” Sector 2016-2018, signed on 19 April 2018, of a staff member with a professional profile of Researcher - Level III, initial salary range, at the Institute of Biosciences and BioResources- headquarters of Bari to perform scientifictechnological research activities within the project PNRR MUR – M4C2 – Investiment 1.4 – Notice “National centers” - D.D. n. 3138 del 16 dicember 2021 amended by DD n.3175 del 18 december 2021 –CN00000022 “National Research Centre for Agricultural Technologies”- notification of the Directorial Decree di granting funding n.1032 del 17.06.2022- CUP B83C22002840001. Per informazioni, www.cnr.it, sezione “concorsi”.
E BIOIMMAGINI DI NAPOLI
Scadenza, 2 marzo 2023
A public selection based on qualifications and an interview is announced pursuant to article 8 of the “Regulations concerning the hiring of personnel with a fixed-term employment contract” for the recruitment, with a fixed- term employment contract pursuant to article 83 of the CCNL (National Collective Bargaining Agreement) of the “Education and Research” Sector 2016-2018, signed on 19 April 2018, of a staff member with a professional profile of Technologist - Level III, initial salary range, at the Institute of Biostructures and Bioimaging (CNR-IBB) - office headquarters Napoli for carrying out scientifictechnological research activities within the project mentioned in the introduction. Per informazioni, www.cnr. it, sezione “concorsi”.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO DI NAPOLI
Scadenza, 6 marzo 2023
A public selection based on qualifications and an interview is announced pursuant to article 8 of the “Regulations concerning the hiring of personnel with
a fixed-term employment contract” for the recruitment, with a fixed-term employment contract pursuant to article 83 of the CCNL (National Collective Bargaining Agreement) of the “Education and Research” Sector 2016-2018, signed on 19 April 2018, of a staff member with a professional profile of Researcher - Level III, initial salary range, at the Institute for the Animal Production System in the Mediterranean Environment – office headquarters Portici (NA), Italy ,for carrying out scientific-technological research activities within the project mentioned in the introduction. Per informazioni, www.cnr. it, sezione “concorsi”.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE DI SESTO FIORENTINO (FIRENZE)
Scadenza, 13 marzo 2023
A public selection based on qualifications and an interview is announced pursuant to article 8 of the “Regulations concerning the hiring of personnel with a fixed-term employment contract” for the recruitment, with a fixed-term employment contract pursuant to article 83 of the CCNL (National Collective Bargaining Agreement) of the “Education and Research” Sector 2016-2018, signed on 19 April 2018, of a staff member with a professional profile of Researcher- Level III, initial salary range, at the CNR-Institute for Sustainable Plant Protection (IPSP) for carrying out scientific-technological research activities within the project: CN_00000022 - National Research Centre for Agricultural Technologies (AGRITECH) –CUP B83C22002840001 (D.D. MUR n. 1032/2022) - in the framework of the Call for proposals “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies” - Centri Nazionali (DD 3138/2021) funded by Reforms and Investments Under the Recovery and Resilience Plan NextGenerationEU, Mission 4 - “Education and Research” Component 2 Investimento 1.4. Per informazioni, www.cnr.it, sezione “concorsi”.
L’allattamento al seno è un fattore cruciale nel determinare l’acquisizione da parte del neonato di una flora batterica health-promoting, che assicura la salute dell’individuo non solo nel breve periodo ma anche a lungo termine di Federica Ruin*
Il latte è un fluido biologico estremamente complesso e altamente variabile prodotto e secreto dalla ghiandola mammaria, evolutosi nel corso dei millenni per assumere la composizione più adatta per nutrire il neonato e proteggerlo dalle malattie mentre il suo sistema immunitario matura1.
Pertanto, l’allattamento è riconosciuto essere il metodo migliore e ineguagliabile per alimentare i neonati, grazie ai benefici per la salute a breve e lungo termine che determina sia per la madre sia per il bambino2. Proprio per questo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’allattamento al seno in maniera esclusiva fino al sesto mese di vita, mantenendo poi il latte materno come scelta prioritaria per l’alimentazione fino ai due anni di vita2.
Componenti bioattivi del latte materno
I numerosi benefici per la salute associati all’allattamento derivano dall’azione combinata dei componenti nutrizionali e bioattivi presenti nel latte materno e l’entità della maggior parte degli effetti biologici accertati è stata correlata direttamente alla durata dell’allattamento al seno2.
Il latte prodotto da ogni madre ha una composizione unica e caratteristica, che si modifica significativamente in risposta a molti fattori per soddisfare le esigenze specifiche del neonato1.
Oltre a essere ricco in proteine, lipidi e carboidrati – fonti nutrizionali imprescindibili per la crescita del bambino-, il latte materno contiene infatti miriadi di composti bioattivi. Elementi che, influenzando processi biologici, hanno un impatto significativo sulla funzionalità dell’organismo e sullo stato di salute. I componenti bioattivi del latte materno provengono da una varietà di fonti: alcuni sono prodotti e secreti dall’epitelio mammario, altri sono rilasciati dalle cellule presenti nel latte mater-
* Studentessa di Biologia della Salute all’Università di Bologna e collaboratrice di BioPills: il vostro portale scientifico.
no, altri ancora sono presenti nel siero materno e vengono trasportati attraverso l’epitelio mammario3.
Tra i componenti bioattivi principali, si annoverano numerosi fattori di crescita, tra cui il fattore di crescita epidermico (EGF), fattori di crescita neuronali (BDNF e GDNF), e il fattore di crescita vascolare endoteliale (VEGF)3. Il latte materno è una fonte importante anche di ormoni che regolano il metabolismo energetico, il peso corporeo e l’appetito, come le adipochine, la leptina e la grelina3.
Oltre ai fattori di crescita e ai fattori metabolici, il latte materno è ricco di fattori immunologici che proteggono il neonato da infezioni e infiammazione. Il latte materno rappresenta infatti l’unica fonte di anticorpi per le prime 4 settimane di vita del neonato e fornisce in particolare sIgA che agiscono localmente come prima linea di difesa immunitaria antigene-specifica4. Il latte materno contiene inoltre una varietà di cellule convolte nell’immunità innata e adattiva, come macrofagi, cellule T, linfociti, e fornisce al neonato citochine coinvolte nella modulazione dell’infiammazione, dell’emopoiesi e della risposta immunitaria, come TGF-beta, IL-10, IL-1RA, TNFR I e II 3,4. Importante è anche la presenza nel latte materno di proteine con attività antimicrobica e antinfiammatoria, come la lattoferrina, la lattoaderina e il lisozima4
Il latte materno fornisce quindi al neonato una serie di componenti che garantiscono una protezione immunologica diretta dopo la nascita e contribuiscono a modulare la risposta immunitaria.
In aggiunta a questi elementi, il latte materno è ricco di componenti prebiotiche e probiotiche fondamentali per garantire il corretto sviluppo del microbiota intestinale infantile, che è un componente fondamentale nel determinare il benessere a breve e lungo termine dell’individuo. Negli ultimi anni numerosi studi hanno infatti evidenziato differenze significative nella composizione del microbiota intestinale tra neonati allattati al seno e neonati alimentati con latte artificiale, che si riflettono in una diversa incidenza di numerose patologie acute e croniche.
Dopo lattosio e lipidi, il terzo componente solido più abbondante nel latte umano è rappresentato dagli oligosaccaridi, presenti a una concentrazione di 20-23 g/L nel colostro e 12-14 g/L nel latte maturo5. Gli oligosaccaridi del latte umano (HMOs) sono un gruppo di zuccheri complessi caratterizzati da un’importante diversità strutturale, la cui sintesi endogena è strettamente correlata al background genetico materno6
L’importanza di questa famiglia di carboidrati per il neonato è legata alla loro azione prebiotica. Gli HMOs sono ingredienti resistenti all’acidità gastrica, all’idrolisi da parte degli enzimi dell’ospite e all’assorbimento gastrointestinale, ma vengono fermentati selettivamente nel tratto distale dell’intestino da specifici gruppi di batteri del microbiota intestinale5,6.
Gli HMOs hanno quindi un ruolo fondamentale nel modellare la composizione del microbiota intestinale infantile, aumentando l’abbondanza dei cosiddetti “batteri buoni”. Gli oligosaccaridi del latte materno sono infatti tra i principali fattori bifidogenici presenti nella dieta del neonato e sono quindi direttamente responsabili della dominanza dei bifidobatteri nel microbiota intestinale di neonati allattati al seno5
La fermentazione degli HMOs da parte da alcune specie di Bifidobacterium ha conseguenze benefiche per l’ecosistema intestinale anche grazie alla produzione di acidi grassi a corta catena. Mentre l’acido acetico riduce il pH dell’intestino, esplicando un’azione batteriostatica che inibisce la crescita di potenziali batteri patogeni, il butirrato sostiene la replicazione e la funzionalità dei colonociti rappresentando la principale fonte energetica per queste cellule5. Inoltre, questa famiglia di oligosaccaridi esercita un diretto effetto antimicrobico, giocando un
ruolo importante nella prevenzione di infezioni gastrointestinali e respiratorie nel neonato. Gli HMOs, simulando la struttura del glicocalice, agiscono da recettori solubili in grado di catturare i patogeni prevenendone la penetrazione nelle mucose; inoltre sembra che questi oligosaccaridi abbiano anche la capacità di modificare il profilo dei glicani espressi sulla superficie cellulare5. Dal momento che differenze nel genoma materno sono responsabili di differenze nel profilo degli HMOs nel latte, i neonati di madri diverse potranno essere protetti in maniera più o meno efficace da particolari infezioni in base agli specifici oligosaccaridi assunti con l’allattamento.
Infine, gli HMOs possono influenzare l’immunità innata e adattiva del neonato. Ad esempio, agendo a livello dell’epitelio intestinale, promuovono l’espressione delle proteine delle giunzioni serrate, diminuendo in questo modo la permeabilità intestinale e potenziando l’effetto barriera6.

Il microbiota del latte materno
Fino a pochi anni fa il latte materno era ritenuto un fluido sterile e la presenza di batteri, rilevata mediante tecniche coltura-dipendenti, era attribuita a fenomeni di contaminazione. Oggi si sa che il latte materno ha un proprio microbiota caratteristico, costituito da diverse centinaia di specie e generi batterici alla concentrazione approssimativa di 1000 CFUs/mL7. Il recente sviluppo di tecniche coltura-indipendenti ha permesso di espandere la nostra conoscenza riguardo alla composizione e alla diversità del microbiota del latte materno. In particolare, le specie batteriche più frequentemente identificate in questo fluido appartengono ai generi Streptococcus e Staphylococcus; si ritrovano inoltre batteri appartenenti ai generi Bifidobacterium, Lactobacillus, Propionibacteria, Enterococcus e membri della famiglia delle Enterobacterales7.
L’origine di questa popolazione batterica non è ancora nota con certezza: due sono le ipotesi maggiormente accreditate, non necessariamente mutuamente esclusive.
L’ipotesi tradizionale ritiene che la presenza di batteri nel latte materno sia il risultato di una contaminazione da parte di microrganismi provenienti dalla pelle della madre o dalla cavità orale del neonato che si realizza durante la suzione. A sostegno di questa ipotesi vi è il fatto che filotipi batterici caratteristici del microbiota cutaneo, appartenenti in particolare ai generi Staphylococcus e Corynebacterium, si ritrovano anche nel latte materno8. Inoltre, mediante la fotografia a infrarossi, è stato registrato un certo grado di flusso retrogrado di latte materno che dalla bocca del neonato refluisce nei dotti lattiferi
durante la suzione9. Tuttavia, questa ipotesi non è sufficiente a spiegare la diversità del microbiota del latte materno e non giustifica la presenza in questo fluido di specie anaerobiche associate all’ambiente intestinale. È stato quindi ipotizzato che batteri presenti nell’intestino materno possano raggiungere la ghiandola mammaria attraverso un percorso endogeno entero-mammario10. Anche se l’esatto meccanismo fisiologico di questa traslocazione non è ancora stato completamente chiarito, alcuni lavori hanno dimostrato la capacità delle cellule dendritiche di attraversare l’epitelio intestinale e legare batteri non patogeni presenti nel lume dell’intestino, trasportandoli alla ghiandola mammaria attraverso il sistema linfatico e circolatorio8.
La presenza di una popolazione batterica nel latte materno permette ai neonati allattati al seno di assumere fino a 800 000 batteri al giorno7. Questo rende il latte materno la seconda fonte di microrganismi per il neonato dopo il canale vaginale. L’ipotesi di un trasferimento verticale di microrganismi dalla madre al neonato è stata confermata da molti studi, che hanno dimostrato la condivisione di specifici ceppi di Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus, e Staphylococcus tra il latte materno e le feci dei neonati7. Durante il primo mese di vita, i neonati allattati al seno condividono il 28% dei batteri delle loro feci con il microbiota del latte materno e questa percentuale aumenta con la quantità di latte materno assunto giornalmente in maniera dose-dipendente7
Il microbiota del latte materno è quindi responsabile della colonizzazione microbica del tratto intestinale dei neonati e ha pertanto un ruolo chiave nell’influenzare lo sviluppo e la salute del neonato sia a breve che a lungo termine. La comunità microbica del latte materno ha un ruolo importante nel ridurre e prevenire l’incidenza e la gravità delle infezioni batteriche attraverso diversi meccanismi, come l’esclusione competitiva esercitata dai batteri commensali, la produzione di composti antimicrobici, la promozione della funzione barriera a livello intestinale realizzata incrementando la produzione di mucina e riducendo la permeabilità intestinale7,9. Inoltre, il microbiota del latte materno potrebbe essere coinvolto nella maturazione del sistema immunitario del neonato, dal momento che alcuni ceppi batterici si sono dimostrati in grado di modulare sia la risposta innata sia quella acquisita in vitro e in modelli animali7,9
intestinale infantile
La colonizzazione microbica del tratto intestinale del neonato è un processo dinamico e non casuale che coincide con l’assemblaggio de novo di una complessa comunità microbica. Fino a poco tempo fa si riteneva che questo processo di colonizzazione avesse inizio solo al momento del parto. Ma un numero crescente di evidenze scientifiche sembra ora contraddire questo dogma, dimostrando la presenza di batteri nella placenta, nel cordone ombelicale e nel fluido amniotico11.
L’allattamento al seno contribuisce in maniera importante
allo sviluppo del microbiota intestinale infantile sia direttamente, mediante il trasferimento di microrganismi commensali e potenziali probiotici, sia indirettamente, fornendo agenti antimicrobici e substrati prebiotici fermentabili da specifici gruppi batterici. Studi condotti confrontando il microbiota intestinale tra neonati allattati al seno e neonati alimentati con latte artificiale, hanno dimostrato come nel primo gruppo il microbiota presenti una minore diversità filogenetica12. Questo risultato è direttamente correlabile all’assunzione di latte materno, che fornisce substrati selettivamente fermentabili solo da alcune specie batteriche. Viene a determinarsi, così, la dominanza del genere Bifidobacterium, che rappresenta tra il 50% e il 90% della popolazione batterica rilevata nelle feci dei neonati allattati al seno6. Il microbiota infantile di neonati alimentati con latti formulati presenta invece una maggiore complessità e una maggiore abbondanza di Streptococcaceae, Staphylococcaceae, Clostridiaceae, Enterococcaceae, Bacteroides, Lachnospiraceae e Veillonella11,12. Inoltre, sembra che nei neonati alimentati con formulazioni di latte artificiale il microbiota diverga più precocemente verso il profilo del microbiota adulto11.
I benefici dell’allattamento al seno
L’allattamento al seno fornisce dunque componenti nutrizionali e bioattivi fondamentali per garantire la salute del neonato, promuovendo la maturazione del sistema immunitario e la colonizzazione microbica dell’intestino nelle prime settimane di vita. Oggi la comunità scientifica individua nel microbiota intestinale di neonati sani nati a termine, partoriti con parto vaginale ed esclusivamente allattati al seno lo standard di riferimento per lo sviluppo di un microbiota infantile promotore della salute del neonato a breve e lungo termine13 Benefici per la salute a breve termine
Numerosi studi hanno dimostrato come l’assunzione di latte materno riduca il rischio di morte e malattia nei primi anni di vita, diminuendo l’incidenza della sindrome della morte improvvisa del lattante e conferendo protezione al neonato da un’ampia gamma di patologie tra cui infezioni gastrointestinali, infezioni respiratorie, diarrea ed enterite necrotizzante2,8.
Recentemente, ad esempio, è stato scoperto che alcuni oligosaccaridi del latte materno presentano proprietà antimicrobiche e antiadesive nei confronti dello Streptococcus di gruppo B che è la principale causa di infezione delle membrane fetali, infezione che può portare a sepsi neonatale, parto pretermine o morte fetale8. Inoltre, saggi in vitro hanno dimostrato come gli HMOs siano in grado di ridurre notevolmente la colonizzazione dell’epitelio intestinale da parte di Campylobacter jejuni, di ceppi di Escherichia coli enteropatogeni e di Listeria monocytogenes6. L’attività antiadesiva di questa famiglia di carboidrati si esplica anche nei confronti di numerosi virus responsabili di infezioni potenzialmente molto gravi nei neonati, quali Rotavirus, virus respiratori e Norovirus6
La prevalenza del genere Bifidobacterium nel microbiota intestinale dei neonati allattati al seno ha un ruolo attivo impre-
scindibile nella promozione della salute del neonato, al punto che una ridotta abbondanza di questi microrganismi nel tratto intestinale è stata associata a diversi disordini metabolici e immunitari13. Questo gruppo batterico è infatti in grado di aderire agli enterociti prevenendo da un lato la distruzione della barriera epiteliale intestinale e il passaggio in circolo di tossine batteriche letali, dall’altro la colonizzazione del tratto intestinale da parte di patogeni. Questo avviene attraverso la competizione per i nutrienti e la secrezione di piccoli peptidi con attività batteriostatica o battericida su altri ceppi microbici, le batteriocine13.
I bifidobatteri hanno un ruolo importante anche nella maturazione del sistema immunitario e alti livelli di questo gruppo batterico nel microbiota sono stati associati anche a una migliore risposta immunitaria alla vaccinazione13 Benefici per la salute a lungo termine
I componenti nutrizionali e bioattivi forniti dal latte materno hanno benefici anche per la salute a lungo termine. Studi di coorte hanno infatti dimostrato come una prolungata esposizione al latte materno sia associata a una riduzione significativa del rischio di sviluppare malattie croniche come le allergie, l’asma, il diabete, l’obesità, la sindrome dell’intestino irritabile, il morbo di Crohn2,8 Inoltre, l’assunzione del latte materno sembrerebbe correlata a un miglioramento dello sviluppo cognitivo nei bambini8.
Un numero crescente di evidenze dimostra come i primi 1000 giorni di vita di un neonato rappresentino una finestra critica di opportunità per il benessere futuro dell’individuo: in questo periodo la formazione e la composizione del microbiota intestinale hanno un ruolo chiave nel guidare lo sviluppo immunologico e l’instaurarsi di una condizione fisiologica di omeostasi13. Il ruolo del microbiota intestinale infantile nella salute a lungo termine sembra essere correlato alla massiva stimolazione antigenica determinata dalla colonizzazione microbica primaria del tratto intestinale 11. Questo processo è necessario per la corretta maturazione del sistema immunitario, dell’epitelio intestinale e del metabolismo associato, oltre che degli organi distali11.
Conclusioni e prospettive future
Nonostante l’allattamento al seno sia la scelta raccomandata per l’alimentazione del neonato nei primi mesi di vita, molti sono i determinanti che possono influenzare il ricorso al latte artificiale. Esistono però differenze importanti nella composizione e nella quantità dei componenti nutrizionali e bioattivi tra i latti formulati e il latte materno, differenze che si ripercuotono sullo sviluppo del microbiota intestinale infantile e sulla salute del neonato a breve e lungo termine8.
L’obiettivo della ricerca in questo campo è quindi quello di inserire all’interno delle formulazioni di latte artificiale quei componenti del latte materno che giocano un ruolo chiave nella crescita e nel benessere del bambino e che risultano assenti nel latte vaccino.
Lo sviluppo di additivi alimentari prebiotici ottenuti per sintesi artificiale e funzionalmente simili agli HMOs è stato uno dei primi passi avanti in questa direzione, con l’ap-
provazione di 7 oligosaccaridi per uso alimentare8. Questi composti si sono dimostrati in grado di mimare l’attività prebiotica degli HMOs e influenzare positivamente la composizione della flora intestinale dei neonati alimentati con latte artificiale addizionato di prebiotici, avvicinandola a quella di neonati allattati al seno5
Il latte artificiale risulta inoltre privo della popolazione batterica caratteristica del latte materno. L’addizione di batteri probiotici - eventualmente isolati dal latte materno stesso - alle formulazioni di latte artificiale promuoverebbe quindi la colonizzazione microbica dell’intestino di neonati non allattati al seno, ma è necessario effettuare ricerche approfondite per assicurare la sicurezza e l’efficacia delle formulazioni di latte artificiale addizionate con probiotici, oltre alla capacità dei ceppi probiotici di sopravvivere al transito nel tratto gastrointestinale e di esercitare effetti benefici8
1. Andreas NJ, Kampmann B, Mehring Le-Doare K. Human breast milk: A review on its composition and bioactivity. Early Human Development. 2015;91(11):629-635. doi:10.1016/j.earlhumdev.2015.08.013
2. Mosca F, Giannì ML. Human milk: composition and health benefits. Pediatr Med Chir. 2017;39(2). doi:10.4081/pmc.2017.155
3. Ballard O, Morrow AL. Human Milk Composition. Pediatric Clinics of North America. 2013;60(1):49-74. doi:10.1016/j.pcl.2012.10.002
4. Thai JD, Gregory KE. Bioactive Factors in Human Breast Milk Attenuate Intestinal Inflammation during Early Life. Nutrients. 2020;12(2):581. doi:10.3390/ nu12020581
5. Wiciski M, Sawicka E, Gbalski J, Kubiak K, Malinowski B. Human Milk Oligosaccharides: Health Benefits, Potential Applications in Infant Formulas, and Pharmacology. Nutrients. 2020;12(1):266. doi:10.3390/nu12010266
6. Zhang S, Li T, Xie J, et al. Gold standard for nutrition: a review of human milk oligosaccharide and its effects on infant gut microbiota. Microb Cell Fact. 2021;20(1):108. doi:10.1186/s12934-021-01599-y
7. Le Doare K, Holder B, Bassett A, Pannaraj PS. Mother’s Milk: A Purposeful Contribution to the Development of the Infant Microbiota and Immunity. Front Immunol. 2018;9:361. doi:10.3389/fimmu.2018.00361
8. Lyons KE, Ryan CA, Dempsey EM, Ross RP, Stanton C. Breast Milk, a Source of Beneficial Microbes and Associated Benefits for Infant Health. Nutrients. 2020;12(4):1039. doi:10.3390/nu12041039
9. Fernández L, Langa S, Martín V, et al. The human milk microbiota: Origin and potential roles in health and disease. Pharmacological Research. 2013;69(1):110. doi:10.1016/j.phrs.2012.09.001
10. Rodríguez JM. The Origin of Human Milk Bacteria: Is There a Bacterial Entero-Mammary Pathway during Late Pregnancy and Lactation?1234. Adv Nutr. 2014;5(6):779-784. doi:10.3945/an.114.007229
11. Milani C, Duranti S, Bottacini F, et al. The First Microbial Colonizers of the Human Gut: Composition, Activities, and Health Implications of the Infant Gut Microbiota. Microbiol Mol Biol Rev. 2017;81(4):e00036-17. doi:10.1128/ MMBR.00036-17
12. Ma J, Li Z, Zhang W, et al. Comparison of gut microbiota in exclusively breast-fed and formula-fed babies: a study of 91 term infants. Sci Rep. 2020;10(1):15792. doi:10.1038/s41598-020-72635-x
13. Saturio S, Nogacka AM, Alvarado-Jasso GM, et al. Role of Bifidobacteria on Infant Health. Microorganisms. 2021;9(12):2415. doi:10.3390/microorganisms9122415
Il reagente a base di fluoro rileva se l’ormone aldosterone viene prodotto in modo anomalo, il che è un possibile segno di un adenoma surrenale, un tumore che può causare ipertensione e può essere rimosso chirurgicamente di Cinzia Boschiero
Si ritiene che circa il 10-15% dei casi di ipertensione, o ipertensione, sia causato da un’eccessiva produzione dell’ormone aldosterone, che influisce sull’equilibrio idrico-salino del corpo. E’ stato di recente pubblicato uno studio sul Journal of Nuclear Medicine in cui i ricercatori hanno sviluppato un metodo non invasivo per identificare una potenziale causa di ipertensione con una drastica riduzione dell’esposizione alle radiazioni.
Il reagente a base di fluoro rileva se l’ormone aldosterone viene prodotto in modo anomalo, il che è un possibile segno di un adenoma surrenale, un tumore che può causare ipertensione e può essere rimosso chirurgicamente. È molto rilevante il fatto che si sia sviluppato un nuovo reagente per individuare un adenoma surrenale che causa l’ipertensione, visto che l’ipertensione è uno dei principali fattori di rischio delle malattie cardiovascolari e che le malattie ischemiche del cuore sono la prima causa di morte al mondo secondo il Global burden of Disease Study 2010 e, secondo i dati forniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è all’origine di oltre 9 milioni di decessi l’anno.
L’obiettivo di questo studio era di preparare e valutare un analogo del fluoro-18 di NP-59 per fungere da agente di imaging PET per l’imaging funzionale delle ghiandole surrenali basato sull’uso del colesterolo. I precedenti tentativi di preparare un simile analogo di NP-59 si sono rivelati sfuggenti. La valutazione preclinica e clinica potrebbe essere effettuata una volta stabilito il nuovo analogo del fluoro della produzione di NP-59. L’imaging dell’utilizzo del colesterolo è possibile con l’agente di scintiscanning/SPECT iodio-131, NP-59. Questo agente ha fornito una misura non invasiva della funzione surrenale e della sintesi di steroidi. Tuttavia, gli isotopi di iodio hanno provocato scarsa risoluzione, problemi di produzione e dosimetria di radiazioni elevate per i pazienti che ne hanno limitato l’uso e l’impatto clinico. Un analogo
del fluoro-18 affronterebbe queste carenze pur mantenendo la capacità di visualizzare l’utilizzo del colesterolo. Grazie a questo studio il recente sviluppo di un nuovo reagente per la fluorurazione insieme ad un percorso migliorato verso il precursore NP-59 ha consentito la preparazione di un analogo del fluoro di NP-59, FNP-59. Nello studio viene descritta la radiochimica per il 18F-FNP-59 radiomarcato con fluoro-18, e sono stati condotti studi di dosimetria delle radiazioni di roditori e imaging in vivo nei conigli della Nuova Zelanda. Dopo studi di tossicità in vivo, è stata ottenuta l’approvazione IND e sono state acquisite le prime immagini umane con dosimetria utilizzando l’agente.
Come risultato, grazie a studi sulla tossicità in vivo, la ricerca ha dimostrato che l’FNP-59 è sicuro per l’uso e la dose previsti. Inoltre, i ricercatori con approfondimenti di biodistribuzione con 18F-FNP-59 hanno dimostrato un profilo farmacocinetico simile a NP-59, ma con una ridotta esposizione alle radiazioni. Le immagini animali in vivo hanno dimostrato l’assorbimento previsto nei tessuti che utilizzano il colesterolo: cistifellea, fegato e ghiandole surrenali. Innanzitutto nelle immagini umane non si sono verificati eventi avversi e i ricercatori hanno dimostrato l’accumulo nei tessuti bersaglio (fegato e ghiandole surrenali).
La manipolazione dell’assorbimento è stata dimostrata anche con i pazienti che hanno ricevuto la cosintropina, con conseguente miglioramento dell’assorbimento. In conclusione, 18F-FNP-59 ha fornito immagini a risoluzione più elevata, con una dose di radiazioni inferiore ai soggetti. Ha il potenziale per fornire un test non invasivo per i pazienti con malattie corticosurrenali. Bisogna ricordare che il colesterolo è essenziale in numerosi processi biologici e i cambiamenti nel traffico di colesterolo sono una caratteristica importante di molte malattie come la sindrome di Cushing, l’aldosteronismo primario, l’iperandrogenismo, il carcinoma adrenocorticale e, soprattutto,
in base al numero di pazienti colpiti, l’aterosclerosi. Data l’importanza del colesterolo, gli sforzi per immaginare la sua distribuzione e in particolare il suo coinvolgimento nelle ghiandole surrenali erano un’area di interesse e già negli anni ‘70 gli analoghi del colesterolo marcati con iodio-131 furono sviluppati come agenti di scintigrafia, a cominciare dal 19-iodocolesterolo. Si scoprì quindi che una modifica dello scaffold steroideo tramite un riarrangiamento termico dava NP-59, un tracciante notevolmente migliorato con surrene superiore uptake. NP-59 è stato successivamente sviluppato per l’uso nella diagnosi dell’aldosteronismo primario e di altre malattie correlate della corteccia surrenale legate all’aumento dell’utilizzo del colesterolo. Tuttavia, sottolineano i ricercatori di questo studio, NP-59 non ha mai visto un’ampia adozione come agente diagnostico a causa dei limiti dello iodio-131 tra cui sintesi difficile; requisito di un protocollo di imaging multiday che consenta la clearance del tessuto di fondo; accumulo di iodio 131 libero nella tiroide; scarsa qualità dell’immagine a causa del fotone ad alta energia emesso da 131I, e di conseguenza scarsa dosimetria della radiazione escludendo il suo uso di screening di routine. Dati i limiti di NP-59, sono stati fatti molti sforzi nella ricerca a livello mondiale per immaginare la causa dell’aldosteronismo primario che non si basano sull’accumulo di colesterolo.
Agenti di imaging a base del precursore (colesterolo) dell’aldosterone (o di altri ormoni steroidei corticali) sono in grado di rappresentare la loro produzione mediante il loro assorbimento, in modo simile all’FDG come surrogato della glicolisi. Ciò consente di utilizzare l’imaging del colesterolo per l’aldosteronismo primario; così come, per l’eccessiva produzione di cortisolo e altre patologie che dipendono dal colesterolo. Negli anni che seguirono l’introduzione di NP-59 e il suo studio come agente di imaging per il comportamento come colesterolo marcato, furono intrapresi numerosi sforzi per migliorare la molecola utilizzando vari radionuclidi e modifiche strutturali. I progressi nella chimica del fluoro e nella radiochimica del fluoro-18 ora rendono possibile e dimostrata la marcatura radioattiva di un analogo del colesterolo fluorurato (FNP-59). Ciò fornirà immagini a risoluzione più elevata con una dose radioattiva inferiore al soggetto e potenzialmente offrirà un’alternativa non invasiva all’AVS come sottolineano i ricercatori di questo studio. In questa ricerca tutto il lavoro sugli animali è stato svolto sotto l’approvazione della IACUC presso l’Università del Michigan. Tutti gli studi sull’uomo sono stati eseguiti nell’ambito di un FDA IND, registrato su clinicaltrials.gov (NCT04532489 e NCT04546126) e l’approvazione locale dell’IRB dell’Università del Michigan con il consenso informato scritto ottenuto. La generazione di un analogo fluorurato di NP-59 è stata tentata per più di 40 anni, spiegano i ricercatori: ”Il nostro laboratorio ha sviluppato numerosi progressi nelle tecniche di radiochimica che hanno consentito lo sviluppo di FNP-59.27,28 Prima della sintesi della versione radioattiva, uno standard di riferimento doveva essere prodotto con fluoruro non radioattivo. Questo standard di riferimento consen -

tirebbe il controllo di qualità per confermare la preparazione di FNP-59 radioattivo (18F-FNP-59) e per eseguire studi di tossicità per la valutazione e l’approvazione IND dell’agente per lo studio sull’uomo.
La preparazione dello standard di riferimento per FNP-59 è stata ottenuta e pubblicata dal nostro gruppo”. Una volta preparato lo standard non radioattivo FNP-59, il team di ricerca ha rivolto la sua attenzione al 18F-FNP-59. Sono stati in grado di ottenere la sintesi utilizzando le tecniche chimiche di radiofluorurazione sperimentate presso la loro sede di ricerca negli ultimi cinque anni. “Partendo dal colesterolo”, dicono i ricercatori di questo studio,”questa sintesi richiede meno passaggi ed utilizza tecniche chimiche più sicure rispetto alla sintesi di NP-59. In particolare, la radiosintesi utilizza solo solventi di classe 3 (Linea guida di armonizzazione ICH per i solventi residui basata sulla tossicità dei solventi) ed è condotta secondo le attuali buone pratiche di fabbricazione, con la dose risultante formulata ad un’attività specifica superiore a NP-59”. Le procedure di sintesi dettagliate, inclusi i dati QC/HPLC per l’agente e i precursori intermedi, sono fornite nella sezione supplementare della ricerca o possono essere ottenute su richiesta contattando gli autori. uno studio di tossicità acuta a dose singola per FNP-59 è stato condotto presso la struttura in vivo dello stato del Michigan. In questo studio, a ratti Sprague Dawley maschi e femmine (n=20, 10M/10F) sono stati somministrati 416 µ g/kg di FNP-59 per via endovenosa, 1.000 volte la dose equivalente umana prevista nella formulazione da utilizzare per studi di imaging PET. Nello studio sono stati registrati i pesi corporei; il sangue è stato raccolto a intervalli per la chimica clinica e l’emocromo completo; le osservazioni cliniche sono state registrate quotidianamente e il consumo di cibo è stato monitorato. Per l’imaging in vivo è stato condotto uno studio pilota con conigli neozelandesi. I conigli (n=2) sono stati anestetizzati con isoflurano e sono stati dosati tramite somministrazione endovenosa di 18F-FNP-59 (2,26 0,09 mCi). L’imaging dei conigli con PET (Concorde MicroPET) si è verificato a 2 e 3 ore. L’imaging in vivo è stato effettuato nei conigli della Nuova Zelanda.
Questo modello animale ha dimostrato l’assorbimento di 18F-FNP-59 nei tessuti previsti (ghiandole surrenali e fegato). In particolare, l’assorbimento è stato visto anche nella cistifellea, che è stato previsto e non visto nei ratti data la loro assenza anatomica di una cistifellea. Negli esseri umani coinvolti nello studio non ci sono stati eventi avversi gravi, l’assorbimento negli organi bersaglio osservati e la dose di radiazione calcolata era quasi due ordini di grandezza inferiore alla dose di radiazione storica 131I-NP-59. Ancora più importante, l’assorbimento è stato osservato nelle ghiandole surrenali, tramite imaging funzionale di assorbimento del colesterolo. Sebbene
l’assorbimento di 18F-FNP-59 nelle ghiandole surrenali umane sia stato inferiore a quello osservato nei roditori, i dati di questa ricerca suggeriscono che ci può essere abbastanza attività per consentire l’imaging in momenti successivi rispetto alle 6 ore dimostrate. Uno dei vantaggi degli scanner PET/CT total-body in arrivo on-line è che offrono una maggiore sensibilità in quanto vengono osservate più disintegrazioni rispetto alle apparecchiature standard.40,41
Tuttavia, questi vantaggi non sono ancora stati dimostrati, un obiettivo futuro a cui il team di ricerca sta ancora lavorando. I ricercatori hanno sviluppato e dimostrato la sintesi di 18F-FNP-59 partendo dal colesterolo. I prodotti finali e intermedi sono stati confermati tramite analisi NMR e spettrometria di massa. La purezza del precursore e dello standard di riferimento (> 90%) sono state ulteriormente confermate tramite HPLC in fase inversa utilizzando il rilevamento UV a 212 nm; dati dettagliati per la sintesi e la caratterizzazione sono presenti nei dati supplementari per standard, precursori e intermedi. La radiosintesi utilizza solo solventi di classe 3 ed è condotta secondo le attuali Buone Pratiche di Fabbricazione, con la dose risultante formulata ad una specifica attività più elevata di quelle raggiunte per NP-59.31,32. Questo lavoro dimostra la fattibilità iniziale di 18F-FNP-59 al traffico del colesterolo di immagine e specificamente all’assorbimento in tessuto surrenale corticale umano. Gli studi futuri esploreranno se 18F-FNP-59 può servire come metodo non invasivo alla causa laterale di rappresentazione contro bilaterale di aldosteronismo primario. L’aldosteronismo primario, noto anche come sindrome di Conn, è una patologia del sistema endocrino caratterizzata dalla secrezione eccessiva dell’ormone aldosterone da parte delle ghiandole surrenali. La produzione eccessiva dell’ormone comporta la ritenzione di sodio e la perdita di potassio dall’organismo, con conseguente innalzamento della pressione sanguigna (ipertensione) Le implicazioni per la cura dei pazienti sono rilevanti in quanto con lo sviluppo di FNP-59 il team di ricerca spiega che si potrà esplorare se questo agente può identificare la causa dell’aldosteronismo primario (adenoma contro l’iperplasia bilaterale), potenzialmente limitando la necessità di campionamento della vena surrenale prima della terapia definitiva. Passi avanti enormi sono dunque stati fatti sinora nella medicina nucleare che è la branca della medicina che si occupa di diagnosticare e trattare le patologie più diverse utilizzando le radiazioni. L’aggettivo “nucleare” deriva proprio dal fatto che queste radiazioni vengono emesse dai nuclei di alcuni atomi. Lo studio è rilevante anche in quanto in Italia, ad esempio, il quadro della pressione arteriosa e dell’ipertensione è descritto dai dati raccolti dal Porgetto Cuore (Cnesps-Iss) nell’ambito di due indagini dell’Osservatorio epidemiologico cardio -
vascolare/Health Examination Survey (Oec/Hes).
Secondo l’Oec/Hes, attualmente, nel nostro Paese, il 56% degli uomini e il 43% delle donne di età 35-79 anni sono ipertesi. I valori medi della pressione arteriosa sono più elevati negli uomini rispetto alle donne e sono più elevati al Nord e al Sud rispetto al Centro. Anche per quanto riguarda il trattamento antipertensivo il quadro appare migliore per le donne, sia nel complesso sia per area geografica. Nonostante i progressi nella diagnosi e la disponibilità di farmaci efficaci e, metà delle persone ipertese non sa di esserlo e molti pur essendo a conoscenza della loro condizione non si curano adeguatamente. Negli ultimi trent’anni il numero di persone affette da ipertensione nel mondo è raddoppiato, passando da 650 milioni a 1,2 miliardi. L’incremento si è registrato prevalentemente nei Paesi a basso e medio reddito. È il risultato di una delle più ampie indagini sull’andamento globale dell’ipertensione che ha coinvolto 100 milioni di persone nell’arco di tre decenni in 184 Paesi. La ricerca realizzata dalla Non-Communicable Disease Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) e pubblicato su Lancet ha analizzato i dati di 1.200 studi rappresentativi della popolazione, consegnando la fotografia dell’attuale situazione che gli stessi autori descrivono come paradossale: negli ultimi anni sono stati ottenuti numerosi progressi nella diagnosi e nella terapia dell’ipertensione, attualmente sono ampiamente disponibili farmaci a basso costo dall’efficacia comprovata e le strategie preventive sono arcinote.
Eppure circa la metà delle persone che soffre di pressione alta ignora di avere questo problema di salute dalle conseguenze per nulla trascurabili (la pressione alta è un fattore di rischio riconosciuto per ictus, infarto, malattie renali). E c’è un’ampia casistica di persone che pur avendo ricevuto una diagnosi non segue alcuna terapia. Si tratta del 53 per cento delle donne e del 62 per cento degli uomini. Gli autori dello studio hanno dimostrato un percorso conciso migliorato per sintetizzare lo standard di riferimento FNP-59 e il precursore Radiolabeling. È stato sviluppato un processo conforme alle GMP per la produzione di 18F-FNP-59 utilizzando solo solventi di classe 3 in conformità con i principi della radiochimica verde.33,34 Inoltre, sono stati condotti calcoli dosimetrici di radiazione e studi di dosaggio di singola tossicità acuta che hanno dimostrato che l’agente era sicuro e appropriato per il deposito di una nuova applicazione sperimentale di farmaco (IND) alla FDA. La valutazione preliminare ha dimostrato che 18F-FNP-59 si è comportato in modo quasi identico ai dati storici 131I-NP-59, con un profilo di sicurezza notevolmente migliorato dato i due ordini di riduzione della dose radioattiva agli organi bersaglio, e che il target richiesto per i rapporti di fondo può essere raggiunto entro i limiti fisici di emivita del fluoro-18.
- Counsell RE, Ranade VV, Blair RJ, Beierwaltes WH, Weinhold PA. Tumor localizing agents. IX. Radioiodinated cholesterol. Steroids 1970; 16(3): 317-28.
- Sarkar SD, Beierwaltes H, Ice RD, et al. A new and superior adrenal scanning agent, NP-59. J Nucl Med 1975;
- Chen YC, Wei CK, Chen PF, Tzeng JE, Chuang TL, Wang Y-F. Seeking the invisible: I-131 NP-59 SPECT/CT for primary hyperaldosteronism. Kidney international 2009;
- Chen Y-C, Chiu J-S, Wang Y-F. NP-59 SPECT/CT Imaging in Stage 1 Hypertensive and Atypical Primary Aldosteronism: A 5-Year Retrospective Analysis of Clinicolaboratory and Imaging Features. The Scientific World Journal 2013;
- Chen Y-C, Su Y-C, Wei C-K, et al. Diagnostic value of I-131 NP-59 SPECT/CT scintigraphy in patients with subclinical or atypical features of primary aldosteronism. Journal of biomedicine & biotechnology 2011;
- Kazerooni EA, Sisson JC, Shapiro B, et al. Diagnostic accuracy and pitfalls of [iodine-131]6-beta-iodomethyl-19-norcholesterol (NP-59) imaging. J Nucl Med 1990;
- Papierska L, wikła J, Rabijewski M, Glinicki P, Otto M, Kasperlik-Załuska A. Adrenal (131)I-6-iodomethylnorcholesterol scintigraphy in choosing the side for adrenalectomy in bilateral adrenal tumors with subclinical hypercortisolemia. Abdominal Imaging 2015;
- White ML, Gauger PG, Doherty GM, et al. The role of radiologic studies in the evaluation and management of primary hyperaldosteronism. Surgery 2008;
- Wong KK, Komissarova M, Avram AM, Fig LM, Gross MD. Adrenal cortical imaging with I-131 NP-59 SPECT-CT. Clin Nucl Med 2010;
- Schwartz CC, Berman M, Vlahcevic ZR, Halloran LG, Gregory DH, Swell L. Multicompartmental analysis of cholesterol metabolism in man. Characterization of the hepatic bile acid and biliary cholesterol precursor sites. J Clin Invest 1978; -Bravo E, Botham KM, Mindham MA, Mayes PA, Marinelli T, Cantafora A. Evaluation in vivo of the differential uptake and processing of high-density lipoprotein unesterified cholesterol and cholesteryl ester in the rat. Biochim Biophys Acta 1994;
- Vandenberghe S, Moskal P, Karp JS. State of the art in total body PET. EJNMMI Phys 2020; 7(1): 35.
- Badawi RD, Shi H, Hu P, et al. First Human Imaging Studies with the EXPLORER Total-Body PET Scanner. J Nucl Med 2019; 60(3): 299-303.
- Gross MD, Grekin RJ, Brown LE, Marsh DD, Beierwaltes WH. The relationship of adrenal iodocholesterol uptake to adrenal zona glomerulosa function. J Clin Endocrinol Metab 1981; 52(4): 612-5.
- Lu CC, Yen RF, Peng KY, et al. NP-59 Adrenal Scintigraphy as an Imaging Biomarker to Predict KCNJ5 Mutation in Primary Aldosteronism Patients. Front Endocrinol (Lausanne) 2021; 12: 644927
-Schwartz CC, Berman M, Vlahcevic ZR, Swell L. Multicompartmental analysis of cholesterol metabolism in man. Quantitative kinetic evaluation of precursor sources and turnover of high density lipoprotein cholesterol esters. J Clin Invest 1982;
- Schwartz CC, Vlahcevic ZR, Berman M, Meadows JG, Nisman RM, Swell L. Central role of high density lipoprotein in plasma free cholesterol metabolism. J Clin Invest 1982; 70(1): 105-16.
Una disciplina sia scientifica, che si occupa dei rapporti degli esseri viventi fra loro e col mondo circostante, sia economica, poiché studia gli scambi di materia ed energia che stanno alla base della vita
di Antonella Pannocchia
Aspetti “ecologici” deli anni XX e XXX del Novecento
Il grande massacro della Prima guerra mondiale (19141918) era stato possibile anche grazie alla drammatica “efficienza” dell’industria chimica: nuove armi, nuovi esplosivi, nuovi strumenti come l’automobile e l’aeroplano, consentirono distruzioni di beni materiali, di vite umane e di ricchezze naturali su una scala senza precedenti e uguagliata soltanto da quanto sarebbe avvenuto poco dopo nella Seconda guerra mondiale (1939-1945).
Le popolazioni che uscivano dalla guerra furono travolte da un’ondata di consumismo; la produzione industriale in serie dell’automobile, l’introduzione in commercio di benzine sempre più potenti, grazie anche all’invenzione del piombo tetraetile, sostanza pericolosa da fabbricare e destinata ad aggravare l’inquinamento atmosferico urbano fino al punto che ne dovette essere vietato l’uso, contribuirono alla frenesia dei consumi, che peraltro ebbe breve durata.
Alla fine degli anni Venti tutti i paesi europei e americani furono investiti dalla “Grande crisi” che fu finanziaria, ma fu anche crisi di materie prime; distruzione di eccesso di produzione e nello stesso tempo ondate di povertà.
Lo sfruttamento eccessivo delle una volta fertili pianure americane aveva lasciato dietro di sé terre erose dalle piogge e dal vento; l’abbandono delle terre portò a migrazioni bibliche di popolazioni fino a quando Franklin Delano Roosevelt (18821945), presidente degli Stati Uniti dal 1933 al 1945, non lancio’ il New Deal, la nuova grande politica di superamento della crisi attraverso opere di difesa del suolo, di rimboschimento, ripresa della produzione, anche utilizzando centrali elettriche e industrie chimiche e minerarie nazionalizzate. La politica del New Deal incoraggiò l’utilizzazione delle eccedenze agricole e dei sottoprodotti agricoli e forestali per ricavarne merci alternative a quelle di importazione. Si può ricordare a questo proposito la produzione di alcol etilico carburante da rifiuti e scarti di legno e di raccolti agricoli. Fu lanciata una campagna di riciclo dei materiali e metalli, furono incoraggiate nelle piantagioni degli Stati del Sud le coltivazioni di piante della gomma alternative
all’Hevea o di piante adatte a fornire fibre tessili. Addirittura fu coniata la parola “chemiurgia” per indicare la scienza e la tecnica di utilizzazione dei prodotti agricoli per ricavarne materie prime e merci industriali. Furono incentivati studi sull’utilizzazione dell’energia solare (1).
In Europa la Grande crisi - che aveva colpito per prima la Germania - offrì il terreno fertile per l’affermazione dei fascismi, soprattutto quello italiano e quello tedesco, con le loro politiche autarchiche per far fronte a problemi di scarsità di materie prime e in preparazione di una nuova guerra. Il nazismo, spietato nella sua follia militare, aveva però ereditato dalla cultura romantica tedesca una attenzione per la “terra” e per il ruralismo (2-3).
Anche in questo caso ebbero un ruolo centrale le tecniche di utilizzazione del carbone, abbondante in Germania, per produrre merci fino allora derivate dal petrolio, tecniche di riutilizzo delle scorie e dei rottami, eccetera. Alcune delle proposte dell’autarchia soprattutto fascista erano palesemente anti-ecologiche ma la bonifica delle zone umide rese abitabili e coltivabili aree fino ad allora sotto-utilizzate e malsane (4)
Una storia ecologica a parte, ancora tutta da scrivere, anche nelle sue contraddizioni, ha avuto l’Unione Sovietica che, nata con la rivoluzione bolscevica del 1917, era un gigantesco paese, con alcune zone urbanizzate e industrializzate e grandissimi spazi praticamente disabitati, ricca di foreste, acque, minerali, terreni preziosi per l’agricoltura, vaste terre ecologicamente incontaminate, e con grandissimi problemi di popolazioni sbandate, di operai e contadini disoccupati, di città nel caos, di territori minacciati dalle forze bianche antisovietiche e dai loro alleati occidentali.
Nei primi mesi di esistenza dello stato bolscevico, mentre era in corso la guerra civile, i dirigenti sovietici, e fra questi lo stesso Lenin, avevano compreso che certe zone naturali preziose dovevano essere preservate; già nel 1918 furono creati i primi uffici naturalistici e furono creati i primi parchi nazionali, fra
cui quello del delta del Volga.
Nello stesso tempo la domanda di rapida industrializzazione imponeva un intenso programma di opere pubbliche, fra cui la costruzione di dighe per la produzione di energia idroelettrica e la regolazione del corso dei fiumi per ricavarne acqua per l’irrigazione. Le grandi opere pubbliche, l’agricoltura intensiva e le prime imprese manifatturiere non potevano badare alle conseguenze ecologiche anche se l’Unione Sovietica disponeva di un gruppo di biologi, geologi e naturalisti, fra cui spiccava Vladimir Vernadskij (1863-1945), lo studioso a cui si devono i concetti fondamentali di biosfera e di geochimica.
A parte il costo umano, il bilancio delle opere realizzate nell’Unione Sovietica nel periodo staliniano, e nel periodo successivo vede molti errori, effetti negativi delle opere pubbliche e di irrigazione, inquinamenti ambientali dovuti alle industrie. Al fianco di scienziati come i biologi Vernadskij e Giorgy Gause (1910-1986) avrebbero ottenuto ascolto anche pessimi pseudo-studiosi come Lysenko (1898-1976) al quale vanno attribuiti molti effetti negativi dell’agricoltura e dell’ecologia sovietica (56).
La politica economica sovietica era basata su processi di pianificazione che avevano l’obiettivo di indicare, al governo centrale, quante e quali merci produrre, anche al fine di ridurre gli sprechi e di utilizzare al meglio le risorse interne del paese assediato e isolato. Per rispondere alla domanda di pianificazione fu creato l’ufficio centrale del piano, Gosplan, che affrontò lo studio dell’economia sulla base dei bisogni di beni materiali dell’economia del paese e della sua popolazione (7-8). Su ispirazione del pensiero marxista furono costruite le prime tavole
intersettoriali dell’economia, alla cui redazione collaborò il giovane Wassily Leontief (1906-1999) che, emigrato poi negli Stati Uniti, applicò il principio, nel periodo roosveltiano, all’economia americana ed ottenne il premio Nobel per l’Economia. Sempre ai fini della razionalizzazione e della diminuzione degli sprechi furono sviluppati standard di qualità e le norme di standardizzazione e unificazione delle merci.
L’età dell’oro della Biologia (19251940)
Al fianco dei primi segni dei guasti ecologici dovuti all’industrializzazione, c’è stato un importante movimento scientifico e culturale che il biologo Franco Scudo ha chiamato l”età dell’oro dell’ecologia” (9).

In molti paesi molti studiosi si sono interrogati sulle possibili relazioni fra disponibilità di risorse, in particolare di cibo e di spazio, e velocità con cui aumentano le popolazioni animali, e implicitamente anche la popolazione umana. Uno studioso americano di scienze attuariali, Alfred Lotka (1880-1949), propose delle equazioni matematiche in grado di mostrare come una popolazione animale aumenta o diminuisce a seconda della disponibilità di spazio e di alimenti; anzi elaborò delle equazioni che mostravano come differenti popolazioni si comportano quando si nutrono di un comune cibo disponibile in quantità limitata - come sono limitate le risorse sul pianeta Terra - secondo rapporti di concorrenza, come una popolazione si nutre degli individui di un’altra popolazione (rapporti fra prede e predatori), come due popolazioni convivono con forme di parassitismo, eccetera (10).
Questi lavori di carattere biologico gettavano le basi per una maggiore consapevolezza dei “limiti” della Terra e per lo studio dei rapporti fra popolazioni umane e disponibilità di risorse naturali, che sarebbe stato sviluppato negli anni Sessanta e Settanta.
La seconda Guerra Mondiale
Sebbene non sia ancora scritta una storia ecologica della Seconda guerra mondiale, segnaliamo che l’aspetto più noto è rappresentato dalla costruzione e dall’uso della bomba atomica: Dal 16 luglio 1945, data dell’esplosione della prima bomba atomica ad Alamagordo nel New Mexico, il mondo non sarebbe mai più stato uguale. Negli stermini dei “successi” tecnico-scientifici di tale guerra, affonda le radici la storia ecologica della seconda metà del Novecento.
Gli anni Cinquanta del XX secolo furono caratterizzati
dalla ricostruzione dopo i danni della guerra, da una voglia di consumi e di merci, da un eccezionale sviluppo industriale ed economico che poteva avvalersi dei progressi tecnici realizzati per approntare gli strumenti della morte. La guerra fredda, l’aspro confronto politico e militare fra Stati Uniti e Unione Sovietica, ha innescato un grande sforzo di produzione di macchinari, merci, manufatti, armi.
I due imperi potevano contare su un gruppo di paesi satelliti, su un Terzo Mondo in condizioni coloniali da cui trarre (apparentemente) senza fine materie prime, fonti energetiche, minerali, prodotti agricoli e forestali. La guerra di Corea aveva segnato la comparsa di una nuova potenza militare e industriale, la Cina, afflitta da uno stato di grande povertà e arretratezza e da conflitti ideologici con l’altro grande paese comunista, l’Unione Sovietica. Su tutta l’umanità incombeva la minaccia di una guerra nucleare, resa palpabile e “visibile” dal “successo” delle esplosioni sperimentali di bombe nucleari sempre più potenti: circa mille bombe furono fatte esplodere nell’atmosfera da Stati Uniti, Unione Sovietica, Inghilterra, Francia, dal 1946 ai primi anni Sessanta.
La ricaduta al suolo, su tutto il pianeta, dei frammenti radioattivi delle esplosioni nucleari, ha per la prima volta fatto comprendere due aspetti squisitamente ecologici:
1. la modificazione chimica e fisica dell’aria e degli oceani non conosce confini e coinvolge tutto il pianeta;
2. la contaminazione di aria, acqua e suolo con i prodotti di fissione, che emettono radioattività per secoli, compromette la salute e la base naturale vitale di intere future generazioni.
La grande paura della contaminazione radioattiva planetaria si può considerare il motore della prima contestazione ecologica che portò ,con l’avvento dell’amministrazione Kennedy al governo negli Stati Uniti, al trattato del 1963 che almeno ha vietato l’esplosione delle bombe nucleari nell’atmosfera (anche se la Francia ha continuato tali esperimenti fino al 1974)(11 - 12).
Nonostante la grande paura degli anni Cinquanta, per tutti gli anni Sessanta e successivi è continuata la corsa alla fabbricazione di bombe sempre più potenti e ci sono state altre mille esplosioni nucleari nel sottosuolo. A dire la verità la contestazione delle armi nucleari non è stata molto attiva in Italia negli anni Sessanta; la stessa installazione nel 1960 in Puglia di missili americani con testata nucleari, è passata quasi inosservata così come in generale ha avuto poco peso la contestazione della presenza di armi nucleari in Italia (13 - 14).
Anche l’Italia prende coscienza
I primi movimenti di contestazione ecologica in Italia hanno piuttosto riguardato i guasti dell’urbanizzazione e quelli dell’inquinamento delle acque. Il miracolo economico degli anni Cinquanta aveva portato una forte immigrazione dal Sud al Nord d’Italia, una crescente richiesta di abitazioni, la nascita di quartieri satellite congestionati e spesso abusivi; nello stesso tempo c’è stato un assalto speculativo ai centri storici, con stra-
volgimento dei valori culturali e urbanistici. Questo aspetto ha dato vita, nel 1955, alla prima associazione ambientalista, Italia Nostra, con finalità essenzialmente di difesa dei valori storici e culturali; solo successivamente l’attenzione si sarebbe estesa anche ad altri problemi ambientali, come l’inquinamento dell’aria dovuto al traffico e alle industrie.
Esistevano, naturalmente delle associazioni per la difesa della natura, ma la loro visibilità sarebbe aumentata soltanto alla fine degli anni Sessanta (15 - 16).
Non a caso la prima contestazione universitaria negli anni Sessanta è partita dalla “domanda di urbanistica”, come occasione per contrastare la speculazione urbana, resa possibile dal controllo di fatto della pubblica amministrazione, nazionale e locale. Le fonti per proposte di urbanistica alternativa esistevano: nella breve stagione del movimento di Comunità, Adriano Olivetti (1901-1960) aveva fatto tradurre e pubblicare i libri sull’urbanistica organica di Lewis Mumford (1895-1990) (la traduzione di Città nella storia, apparso nel 1961, è del 1963) e di Patrick Geddes (1854-1932) (la traduzione di Città in evoluzione, apparso nel 1915, è del 1970); la traduzione di Megalopoli di Jean Gottman è del 1970. Inoltre dalla metà degli anni Cinquanta Antonio Cederna (1920-1996) stava pubblicando su “il Mondo” e poi sul “Corriere della Sera”, una serie di articoli di denuncia del degrado urbano, che avrebbero alimentato la campagna di informazione e la mobilitazione organizzata da Italia Nostra negli anni Sessanta.
Uno dei vistosi aspetti del degrado urbano era rappresentato dall’inquinamento atmosferico; le fotografie dei monumenti all’aperto corrosi dai gas acidi emanati dai camini delle industrie e del riscaldamento domestico, e dai tubi di scappamento delle automobili, fecero il giro del mondo e spinsero alla richiesta, anche in Italia, della prima legge contro l’inquinamento atmosferico, emanata nel 1966; una legge blanda, che toccava soltanto alcuni aspetti delle fonti di inquinamento, ma che offriva una base di conoscenza e delle norme per qualche azione di difesa della salute dei cittadini. Quasi contemporaneamente, negli anni Sessanta, veniva sollevato il problema dell’acqua e dell’inquinamento dei fiumi e dei laghi.
La Fast, la Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche creata da Luigi Morandi a Milano come “Casa della cultura scientifica”, cominciò a dedicare una serie di indagini sui consumi idrici, sullo spreco di acqua, e sull’inquinamento. Non era, un “movimento” di protesta, ma l’iniziativa fornì le informazioni per quella che sarebbe stata una pagina importante della contestazione (17-18).
Fu così possibile rendere noto che l’inquinamento delle acque, la presenza in superficie di schiume persistenti, erano il risultato dell’uso dei fiumi e dei laghi come ricettacoli di tutti i rifiuti urbani, industriali e agricoli, e della produzione di merci inquinanti, come la prima generazione di detersivi sintetici. A mano a mano che venivano perfezionate ed estese le analisi chimiche sulla composizione delle acque, veniva riconosciuta la presenza di residui di detersivi, metalli tossici,
pesticidi, concimi azotati e fosfatici. La serie di iniziative sulle acque della Fast ebbe un ruolo importante per l’avvio di un lungo dibattito parlamentare che portò, nel 1976, all’approvazione della prima legge contro l’inquinamento delle acque, la cosiddetta “legge Merli”, dal nome del deputato, democristiano, che si era fatto promotore dell’iniziativa, e che fu punito, con la mancata rielezione, per il disturbo arrecato alle industrie (19).
La nascita della contestazione
La nascita della vera e propria contestazione ecologica si può far risalire alla seconda metà degli anni Sessanta e agli Stati Uniti. L’opinione pubblica, già sollecitata dalle contestazioni contro la guerra del Vietnam, contro le compromissioni fra università e industria, dalle battaglie per i diritti civili e per i diritti dei neri, era preparata ad ascoltare anche altre voci di protesta.
I giornali e le case editrici erano preparate a dare spazio ad articoli, libri e pubblicazioni sui grandi temi “ecologici” come l’ “esplosione” della popolazione mondiale; i pericoli dell’inquinamento dovuto ai pesticidi, soprattutto ai pesticidi clorurati; la congestione del traffico automobilistico e urbano; la contaminazione radioattiva dovuta alle esplosioni delle bombe atomiche del sistema nucleare-militare e alle centrali del nascente potere nucleare-commerciale; gli incidenti e gli inquinamenti industriali; le delusioni dell’“economia”, incapace di descrivere, col suo unico indicatore, il Prodotto interno lordo, i danni delle attività produttive ed economiche alla salute e alla natura.
Questi temi, talvolta con qualche anno di ritardo, arrivarono in Italia: ne parlarono i giornali, si cominciò a discuterne nelle università e nelle associazioni ( ma non nel governo e nei partiti). Un ruolo fondamentale ebbe il libro di una biologa americana, Rachel Carson (1907-1964), Primavera silenziosa (20).
Il libro, come è ben noto, spiegava che se si fosse continuato, in agricoltura, ad usare pesticidi clorurati persistenti, non degradabili, capaci di disperdersi nel suolo, nelle acque sotterranee, e nel mare, queste sostanze tossiche sarebbero state assorbite dall’erba, dagli animali, sarebbero finiti nel cibo, nel latte alimentare e anche in quello materno, e un giorno, con la morte degli uccelli, la primavera sarebbe stata, appunto, “silenziosa”. La lettura e discussione di questo libro, in Italia nella seconda metà degli anni Sessanta, portò alle prime forme di protesta contro l’uso dei pesticidi in agricoltura.
Come gli elementi radioattivi, anche i pesticidi persistenti per la loro natura chimica si disperdevano, attraverso i fiumi e gli oceani, in tutto il pianeta e avrebbero fatto sentire i propri effetti anche sulle generazioni future. Del resto pochi anni prima (intorno al 1966) l’economista americano Kenneth Boulding (1910-1993) aveva scritto che il nostro pianeta va considerato come una navicella spaziale, “Spaceship Earth”. I suoi abitanti solo dal suo interno possono trarre aria, e acqua, e alimenti, e beni materiali, e solo nel suo interno possono immettere le scorie, i gas, i liquidi, i rifiuti della loro vita: le risorse di questa nave spaziale, unica casa che abbiamo nello spazio, sono grandi, ma non illimitate, così come è limitata la sua capacità ricettiva
per i rifiuti. Immagini suggestive che ben presto furono lette e discusse anche in Italia, negli stessi anni Sessanta.
Inoltre ricevevano nuovo stimolo gli studi sul futuro, sollecitati ora da nuove preoccupazioni come quelle per il degrado urbano e per quello della natura. Alcune indagini sui possibili futuri furono condotte negli Stati Uniti già negli anni Sessanta: un movimento sui “futuri possibili”, o “futuribili” era nato, sempre negli anni Sessanta, in Francia per iniziativa di Bertrand De Jouvenel (1903-1987), scrittore, politologo ed economista critico (21).
Nelle sue opere numerose pagine sulla inattendibilità del Pil come indicatore del benessere individuale e sociale ed ambientale. Il biologo americano Paul Ehrlich scrisse una serie di libri che furono letti e divulgati anche in Italia da vari scrittori, fra cui Alfredo Todisco, un giornalista del “Corriere della Sera”. Negli anni Sessanta cominciarono a ricevere attenzione anche in Italia i movimenti internazionali di liberazione che stavano sorgendo, pur pieni di contraddizioni, nel “Terzo Mondo”.
La decolonizzazione aveva portato al passaggio dal dominio da parte degli stati coloniali europei ad una nuova colonizzazione da parte delle multinazionali dell’energia, dei minerali, del legno, dei prodotti agricoli. La protesta rivendicava il diritto sia all’indipendenza politica, sia anche a frenare la predazione e l’arroganza delle multinazionali occidentali. Il paesi del Terzo Mondo, divenuti membri delle Nazioni Unite, si organizzarono come gruppo di paesi “non allineati”, o “gruppo dei 77”, e cominciarono a far sentire la loro voce nelle assemblee e nelle conferenze in cui si parlava di commercio e di sviluppo rivendicando anche il diritto all’uso delle risorse naturali locali da parte delle popolazioni locali. La ribellione dell’Iran contro lo Scià e le multinazionali del petrolio, quella della Libia, la ribellione del Cile di Allende contro le multinazionali del rame, contenevano in parte - ma furono poco percepite come tali in Italia - la consapevolezza che le risorse naturali di interesse economico sono limitate, e devono essere usate nell’interesse e a vantaggio delle popolazioni che le possiedono. Una pagina interessante del dibattito “ecologico” degli anni Sessanta riguarda la crescente attenzione per i problemi della popolazione e delle risorse da parte delle chiese cristiane, anche se con diversa angolazione da parte dei cattolici e dei protestanti per quanto riguarda il controllo della natalità. Indicazioni sulla violenza associata allo sfruttamento delle risorse naturali e all’esplosione dei consumi merceologici nei paesi del “primo mondo” capitalistico, si trovano nei documenti del Concilio Vaticano II e in alcune encicliche, come Pacem in terris del 1963 di Giovanni XXIII, Populorum Progressio di Paolo VI del 1967, nella costituzione pastorale (uno dei documenti finali del concilio) Gaudium et spes del 1965. Il contenuto “ecologico”, che pure era presente, di tali documenti è passato quasi inosservato in Italia, con l’eccezione del dibattito sul controllo della popolazione, associato alla preparazione e alla pubblicazione dell’enciclica Humanae vitae di Paolo VI, del 1968, ap-
parsa nel pieno del dibattito sui nuovi diritti al divorzio e all’aborto. Così come ben poca attenzione in Italia è stata rivolta alle pubblicazioni e al dibattito esistente nel mondo protestante sugli stessi temi. Kenneth Boulding, uno dei più ascoltati, anche perché di professione rispettato economista, critici alla società dei consumi e impegnato nel movimento ambientalista e pacifista, era quacchero.
La vera esplosione dell’ecologia si ebbe a partire dall’inizio del 1970. Il 1970 era stato dichiarato anno europeo della conservazione della natura, ma di questo non si era accorto quasi nessuno. L’effetto esplosivo si ebbe con l’arrivo in Italia del movimento sorto negli Stati Uniti e che sarebbe culminato con la proclamazione delle “giornata della Terra”, l’Earth Day, fissata per il 22 aprile 1970. L’iniziativa era organizzata da moltissime associazioni, gruppi di studenti, campus universitari, con un grande rilievo nei mezzi di comunicazione e un forte effetto, anche emotivo, sull’opinione pubblica americana. Furono pubblicati, in centinaia di migliaia di copie, le raccolte degli articoli sulla popolazione, sull’inquinamento, contro l’economia capitalistica, in difesa della natura, che fino allora erano passati quasi inosservati.
L’aspetto interessante è che il movimento “esplose” letteralmente dalla base, come continuazione ideale dei movimenti degli studenti del 1968. Non a caso partì dalla California dove era anche più forte la contestazione della guerra del Vietnam, della “chimica”, del petrolio, dell’automobile, dei pesticidi, delle armi nucleari.
Seguendo lo stesso cammino, anche in Italia la stampa e i grandi mezzi di comunicazione cominciarono a guardare i fiumi e a scoprire le schiume che li soffocavano, a guardare l’aria e a constatare quanto poco fosse trasparente e respirabile e a raccontare questi fatti ai loro lettori e ascoltatori. Il 22 aprile 1970 la Fast di Milano organizzò una conferenza sul tema: “L’uomo e l’ambiente”. Dall’estero arrivavano sempre più frequenti segnali di disastri ecologici: dalla perdita del petrolio nel mare, dall’esplosione delle piattaforme petrolifere come quella al largo di Santa Barbara in California, dalla scoperta che nel Vietnam erano state usati diserbanti contaminati da una sostanza chiamata “diossina”, che avrebbe avuto ben altra risonanza pochi anni dopo, con l’incidente di Seveso del 1976.
Le industrie chimiche nel golfo di Minamata in Giappone, con i loro scarichi di mercurio avevano avvelenato decine di pescatori; c’erano simili industrie anche in Italia?
Le centrali nucleari, tanto sicure ed efficienti, subivano un incidente dopo l’altro, con perdita di radioattività nell’ambiente; ma anche in Italia c’erano quattro centrali nucleari: quale grado di affidabilità avevano?

Il potere economico e politico italiano, furono presi di sorpresa.
Un intelligente e attento uomo politico come Fanfani, allora presidente del Senato, fu probabilmente il primo a compren-
dere la forza esplosiva della nuova contestazione e costituì, alla fine del 1970, una commissione speciale di senatori e studiosi, per rendersi conto dei problemi che l’“ecologia” portava in sé. Tanto più che si stava rapidamente avvicinando un evento a cui nessuno fino allora aveva badato: le Nazioni Unite avevano indetto, per il maggio 1972, una conferenza internazionale a Stoccolma sul tema “L’ambiente umano” alla quale erano invitati i governi perché raccontassero quello che stavano facendo e che intendevano fare per l’ambiente.
Nei due anni che vanno dall’aprile 1970 al maggio 1972 apparvero e furono tradotti anche in Italia gli scritti di Ehrlich, già ricordato, che attribuiva all’esplosione della popolazione mondiale la vera causa prima del degrado ambientale, e dell’altro biologo americano Barry Commoner (1917-2012), che piuttosto attribuiva le colpe di tale degrado alla tecnologia capitalistica. In questa atmosfera cominciarono a circolare le bozze di una ricerca commissionata dal Club di Roma ad alcuni studiosi del Massachusetts Institute of Technology degli Stati Uniti.
Il Club di Roma era un gruppo di alcune decine di dirigenti, imprenditori, uomini politici internazionali che avevano deciso di condurre uno studio sul futuro, sulle sfide dell’umanità. La domanda posta agli studiosi era, più o meno: se veramente siamo di fronte ad un aumento della popolazione sempre più rapido, ad una crescente domanda di minerali, cibo, acqua, fonti di energia, se veramente sta aumentando l’inquinamento del pianeta, che cosa si può fare per fermare questa tendenza?
Il risultato dello studio, che apparve sotto forma di libretto nella primavera del 1972, col titolo Limits to growth, malamente tradotto in italiano come I limiti dello sviluppo, anziché
come I limiti alla crescita, (22-23) era più o meno il seguente: “se” la popolazione mondiale continuasse a crescere al ritmo di quegli anni Settanta, la crescente richiesta di alimenti impoverirebbe la fertilità dei suoli, la crescente produzione di merci farebbe crescere l’inquinamento dell’ambiente, l’impoverimento delle riserve di risorse naturali (acqua, foreste, minerali, fonti di energia) provocherebbe conflitti per la loro conquista; malattie, epidemie, fame, conflitti non solo frenerebbero la crescita della popolazione, ma ne provocherebbero una traumatica diminuzione. Il libro concludeva che, per evitare catastrofi, epidemie, guerre, sarebbe stato necessario rallentare, porre dei limiti, “fermare” la crescita della popolazione, dell’estrazione di materiali e risorse dalla natura, della produzione agricola e industriale. La “crescita” - growth, appunto - che non ha niente a che vedere con lo sviluppo - fu indicata come la fonte dei guai presenti e futuri del pianeta, il “male” da mettere in discussione e sottoporre a “limiti”, da frenare. Il libro suscitò dibattiti senza fine.
La vivace primavera dell’ecologia si sarebbe dissolta nell’autunno del 1973; nel Cile il colpo di stato che rimosse Allende nel settembre, riaprì le porte del paese alle multinazionali americane del rame; l’aumento del prezzo del petrolio da parte dei paesi esportatori nell’ottobre dello stesso anno: sembravano i segni di quelle turbolenze che erano “previste” nel libro sui “limiti alla crescita”. Il 1974 e gli anni successivi furono investiti da una crisi economica che rivelava il ruolo critico, nell’economia, della scarsità delle materie prime, fra cui i metalli strategici e il petrolio, il fatto che “le merci e le materie contano”, come andava scrivendo l’economista Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994), e che sono scarse in assoluto (21). Ma la necessità

di uscire dalla crisi economica contribuì all’accantonamento del dibattito sui limiti alla crescita.
Come molti ricorderanno, nell’ottobre 1973 i paesi petroliferi, riuniti in un cartello denominato OPEC (organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) decisero di sospendere per alcuni giorni l’esportazione del petrolio e di aumentare il prezzo di questa indispensabile materia prima da tre a dodici dollari al barile, cioè, in moneta del tempo, da 10 a 40 mila lire (1973) alla tonnellata. Si disse allora, e si fa credere ancora adesso, che tale aumento fu la “vendetta” degli sceicchi contro l’Occidente che aveva fornito armi e sostegno a Israele nella sua risposta-lampo all’attacco egiziano in realtà la crisi petrolifera, e la crisi delle materie prime che seguì, avevano delle radici molto più profonde e complicate.
Intorno al petrolio, divenuto, negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, materia indispensabile per qualsiasi società industriale, era da tempo in corso una guerra sia sotterranea che palese.
Lo si era visto già nel 1953 con la rivolta di Mossadeq in Persia contro lo Scià, con la chiusura del Canale di Suez nel 1956 e la sua nazionalizzazione da parte dell’Egitto. Erano tutti segni che i paesi del Sud del mondo (allora chiamati “Terzo Mondo”), detentori di materie prime indispensabili per i paesi industriali - petrolio, ferro, cromo, prodotti agricoli e forestali, eccetera - erano stanchi di farsi sfruttare.
Anche dopo la fine della dominazione coloniale, i paesi industriali continuavano a dominare, attraverso le compagnie multinazionali, la corruzione, la guerriglia, i governi dei paesi emergenti, assicurandosi dei prezzi bassi per le materie prime. I paesi industriali riuscivano così ad acquistare materie prime a basso prezzo, le trasformavano in manufatti e vendevano questi manufatti ad alto prezzo trattenendo al proprio interno il “valore aggiunto” col lavoro e le tecniche di trasformazione.
Nel 1960 i paesi petroliferi avevano creato l’OPEC e nel 1964 si era tenuta la prima conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, UNCTAD, secondo l’acronimo inglese. Ma i due imperi del Nord del mondo erano troppo forti per preoccuparsi, e non si preoccuparono neanche quando, nel 1970, il colonnello Gheddafi, appena salito al potere in Libia, aveva nazionalizzato i campi petroliferi e aveva aumentato il prezzo del petrolio greggio da due a tre dollari al barile.
Quasi contemporaneamente in Cile il socialista Salvador Allende veniva eletto presidente al posto del democristiano Frei. Già Frei aveva proceduto ad una “cilenizzazione” delle miniere di rame, sfruttate da decenni dalle multinazionali americane, riconoscendo però alle compagnie straniere un indennizzo per gli investimenti che esse avevano fino allora fatto. Allende fece un passo avanti: attuò una completa “nazionalizzazione” delle stesse miniere stabilendo che le multinazionali del rame avevano già guadagnato abbastanza con lo sfruttamento di una preziosa e scarsa risorsa cilena e che si dovevano considerare largamente indennizzate.
Gli eventi dei primi anni Settanta destarono una grande
ondata di speranza in tutti i paesi sottosviluppati, questa stessa speranza di cambiamento nell’uso, nello sfruttamento, dei beni del pianeta era contenuta anche nell’ondata di contestazione ecologica che stava percorrendo, a partire dal 1965, tutti i paesi industriali:
La scienza ecologica insegnava che il pianeta ha dimensioni limitate, che limitate ed esauribili sono le riserve di petrolio, di minerali, di acqua, di foreste, che le risorse naturali del pianeta devono essere gestite come beni collettivi e nell’interesse di tutti i popoli, non solo delle potenze industriali.

Del resto i segni dell’esaurimento delle risorse naturali erano davanti agli occhi di tutti; nei paesi industriali scarseggiava l’acqua, contaminata dagli agenti inquinanti; con i suoi smodati consumi di petrolio gli Stati Uniti erano passati da paesi esportatori di petrolio a paese importatore di questa materia prima; i giacimenti di rame più ricchi, nel Cile o nel Canada, si stavano esaurendo e occorreva ormai estrarre rame da minerali sempre più poveri e costosi. L’estate del 1973 fu segnata da molti eventi contradditori:
1. nel Cile si stavano susseguendo scioperi e manifestazioni contro il programma di austerità proposto da Allende e la crisi esplose il 14 settembre 1973 con il colpo di stato che abbatté il governo socialista e portò al governo i militari, guidati da Pinochet che riaprì le porte del Cile alle multinazionali americani sopratutto del rame;
2. Se il mercato del rame era turbolento, altrettanto lo era quello del petrolio: dopo il primo aumento del prezzo, praticato da Gheddafi nel 1970, per tutto il 1971 e 1972 vi erano stati incontri, spesso tempestosi, tra i paesi esportatori e le compagnie petrolifere: i primi chiedevano aumenti delle royalties pagate dai concessionari ai paesi in cui operavano; le seconde cercavano di limitare i danni arrecati dalla nuova unità e forza del cartello dei paesi esportatori. Nel corso del 1973 un altro piccolo aumento del prezzo del petrolio si era avuto dopo gli incontri di Ginevra in giugno e di Vienna in settembre; la riunione successiva dell’OPEC era stata fissata per il giorno 8
ottobre. Il colpo di stato del settembre nel Cile mostrò ai paesi del Sud del mondo che con le buone sarebbe stato difficile proteggere i propri interessi. Il mondo capitalistico occidentale ascoltava soltanto la voce dei soldi e i prezzi delle materie prime potevano essere aumentati soltanto con azioni concordate fra paesi produttori.
3. Il 6 ottobre, giorno del Yom Kippur, scoppiava la guerra in Israele e la riunione dell’OPEC dell’8 ottobre a Vienna si svolse in un clima di grande tensione. Nelle settimane successive i paesi arabi membri dell’OPEC decisero di sospendere per alcuni giorni le esportazioni e tutti si trovarono d’accordo nell’aumentare di due volte e mezzo il prezzo del greggio.
Rileggendo le pagine dei giornali dell’ottobre 1973 si prova sbalordimento per la miopia dei governanti; in Italia in particolare era in vigore un “piano energetico” che prevedeva una espansione dei consumi delle fonti di energia, la costruzione di decine di centrali nucleari, un crescente ricorso al petrolio, al punto che l’ENEL, che era diventato proprietario delle miniere di carbone del Sulcis, aveva deciso nel 1971 di chiuderle definitivamente.
Il Parlamento italiano condusse nel novembre del 1973 una indagine conoscitiva sul problema dell’energia: mentre il petrolio scarseggiava e aumentava di prezzo, il governo non modificava i suoi piani a medio termine, limitandosi a provvedimenti occasionali come la limitazione della circolazione degli autoveicoli la domenica. Le strade con i cittadini a cavallo o in bicicletta o sui pattini a rotelle sembravano scherzose feste più che segni di un vero cambiamento nella politica energetica, l’avvio di una lotta allo spreco e all’inquinamento.
Nell’aprile del 1974 le Nazioni Unite, nell’ambito dell’assemblea generale, organizzarono una sessione speciale sulle materie prime; apparve così che dalla crisi si poteva uscire soltanto con l’adozione di un “nuovo ordine economico internazionale” che assicurasse un adeguato sviluppo ai paesi del Sud del mondo, un interscambio di tecnologie e di esperienze, una politica delle materie prime che tenesse conto dei problemi di scarsità e rallentasse il degrado ambientale.
Le buone intenzioni restarono al livello di parole e i paesi dell’OPEC risposero con una serie di aumenti del prezzo del petrolio (fino a 40 dollari al barile alla fine degli anni Settanta), dei minerali, dei prodotti agricoli di li a breve fu chiaro che la crisi continuava. Dopo la crisi petrolifera, il Consiglio Nazionale delle Ricerche investì molto denaro in un “progetto energetico finalizzato” che non sortì grandi risultati. I pannelli solari, che si moltiplicarono come scalda-acqua sui tetti di scuole e abitazioni, sovvenzionati da pubblico denaro, restarono in pochi anni, quando il prezzo del petrolio ritornò a valori “normali”, inutilizzati, ad arrugginire all’aria.
Si inizio’ a parlare di “sviluppo “sostenibile”. Secondo la definizione originale del 1976, per essere sostenibile uno sviluppo
o una società devono essere capaci di assicurare alle generazioni future una adeguata disponibilità di risorse materiali, il che è possibile soltanto con un contenimento dello sfruttamento della natura. Durante gli anni 1970-1980, tra le riflessioni e studi ambientalisti più influenti di autori italiani furono [1] un libro di Enzo Tiezzi sulla necessità di riconciliare sviluppo umano e processi naturali su scala planetaria;[14] un libro di Aldo Sacchetti sulle sfide ecologiche poste dallo sviluppo industriale;[15] il lavoro dello storico Alberto Caracciolo che promosse la disciplina della storia ambientale [16] un libro di Vezio De Lucia di esame critico delle vicende urbanistiche italiane [un libro di Dario Paccino che criticò il carattere sostanzialmente conservatore dell’ondata ambientalista e indicò la necessità di un ambientalismo critico e di classe;[18] la denuncia dei danni ambientali di Antonio Cederna;[8] il lavoro di Giovanni Ciccotti, Marcello Cini, Michelangelo de Maria e Giovanni Jona‐Lasinio che mise in discussione la neutralità politica della scienza e aprì una vasta discussione;[19] la riflessione di Laura Conti su ecologia e società; un libro di Valerio Giacomini e Valerio Romani sulle aree protette che divenne un importante punto di riferimento per i promotori e gestori di parchi naturali provenienti dai partiti di sinistra;[21] l’opera del magistrato Gianfranco Amendola sulla divulgazione del diritto ambientale.[20-22]
Alcune opere divulgative ottennero grande successo: tra di esse una Guida alla natura d’Italia costituì la prima introduzione di alta divulgazione agli ambienti naturali italiani, ebbe un enorme successo di pubblico con sei edizioni fino al 1984 e fu seguita da dieci guide regionali, altrettanto popolari. L’opera diede un notevole contributo all’educazione degli italiani all’ambiente, allo sviluppo del turismo naturalistico e alla battaglia per i parchi.[1] Si moltiplicarono le riviste di interesse ambientale. Nel 1970 La Federazione Pro Natura diede vita al bollettino mensile Natura e società, diretto da Dario Paccino: per diversi anni la rivista svolse un importante ruolo di animazione e di stimolo, con una forte connotazione politica. Nel 1971 iniziarono le pubblicazioni della rivista Ecologia diretta da Virginio Bettini: nel 1980 divenne il mensile a larga tiratura “La Nuova Ecologia”, dal 1996 rivista ufficiale di Legambiente,[1] con dichiarati obiettivi di mobilitazione sociale sulle problematiche ambientali. L’antica rivista di divulgazione scientifica Sapere, dal 1974 sotto una nuova direzione editoriale, accentuò lo studio di aspetti sociali e politici dei problemi ambientali: pubblicò numerose inchieste su casi di inquinamento e un supplemento intitolato “Ambiente e potere. Negli anni 1970 si fece strada l’educazione ambientale nelle scuole. Si diffusero iniziative soprattutto nella scuola dell’obbligo, promosse dagli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo.[7] Tra le campagne di sensibilizzazione pubblica di grande rilievo furono quelle di Legambiente: la Goletta Verde e il “Treno Verde”: questo, organizzato dal 1988 per misurare l’inquinamento nelle città italiane, rappresentò la più grande campagna svolta fino ad allora in Italia per l’informazione scientifica e sensibilizzazione sulla qualità
dell’aria nelle città, sulla mobilità e sui danni provocati dal rumore [1].
1. G. Nebbia, “La chemiurgia”, “Casabella”, XLI (1977), n. 426, pp. 14-15);
2. W. Bramwell, Ecologia e società nella Germania nazista;
3. W. Darré e il partito dei verdi di Hitler, edizione originale 1985, traduzione italiana: Gardolo di Trento, Reverdito, 1988;
4. A. D’Onofrio, Ruralismo e storia nel terzo reich, Napoli, Liguori editore, 1997;
5. J.Herf, Il modernismo reazionario. Tecnologia, cultura e politica nella Germania di Weimar e del Terzo Reich, edizione originale 1984, traduzione italiana, Bologna, Il Mulino, 1988);.
6. D. R. Weiner, Models of nature. Ecology, conservation and cultural revolution in Soviet Russia, Bloomington, Indiana University Press, 1988;
7. J. K. Gerner e L. Lundgren, Planhushallning Och Miljoproblem: Sovjetisk Debatt Om Natur Och Samhalle 19601976, Stockholm, LiberFèorlag, 1978, e M. I. Goldman, The spoils of progress. Environmental pollution in the Soviet Union, Cambridge (Ma), MIT Press, 1972);
8. N. Spulber , La strategia sovietica per lo sviluppo economico, 1924-1930, edizione originale 1940, traduzione italiana: Torino, Einaudi, 1964;
9. F. Scudo, “The ‘Golden Age’ of theoretical ecology, A conceptual appraisal”, “Revue européenne des sciences sociales”, XXII (1984), pp. 11-64);
10. A. Lotka : Elements of mathematical biology, edizione originale 1924, ristampa New York, Dover 1956;
11. U. D’Ancona, La lotta per l’esistenza, Torino, Einaudi, 1942;
12. S. E. Kingsland, Modeling nature. Episodes in the history of population ecology, Chicago, Chicago University Press, 1985;
13. L. S. Wittner, Rebels against war. The american peace movement, 1933-1983, Philadelphia, Temple University Press, 1984;
14. L. S. Wittner , One world or none. A history of the world nuclear disarmament movement through 1953, Stanford, Stanford University Press, 1993;
15. P. Nash, The other missiles of October. Eisenhower, Kennedy and the Jupiters, 1957-1963, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1997;
16. L. Nuti, “Dall’operazione ‘Deep rock’ all’operazione ‘Pot Pie’: una storia documentata dei missili SM 78 Jupiter in Italia”, “Storia delle relazioni internazionali”, XII (1996/97), n.1, pp. 96-139, e n. 2, pp. 106-149);
17. M. De Giuseppe, “Gli italiani e la questione atomica negli anni Cinquanta”, “Ricerche di storia politica”, III (2000), n. 1, pp. 29-52;
18. G. Nebbia, “Breve storia della contestazione ecologica”, “Quaderni di Storia ecologica”, I (1994), n. 4, pp. 19-70;
19. G. Nebbia, “La ‘primavera’ dell’ecologia italiana”, “Giano”, XI (1999), n. 32, pp. 125-143);
20. R. Carson. Primavera silenziosa. Feltrinelli 1962;
21. B. De Jouvenel. Arcadie. Essais sur le mieux-vivre. Paris, Futurible, SEDEIS.1968;
22. D.M: Meadows, I limiti della crescita. LuCe Edizioni.
23. N. Georgescu-Roegen, Energia e miti economici, Torino, Bollati Boringhieri, 1998.
Importanti e diversi fattori che possono concorrere a provocare un infortunio. Quando il racconto è un efficace strumento per il trasferimento delle indicazioni per la prevenzione di Eleonora Tosco*,
Èda tempo che il mondo della salute pubblica guarda con interesse agli elementi della narrazione e all’utilizzo delle storie per comunicare in modo più efficace i temi della malattia, della promozione della salute e della prevenzione.
In ambito clinico, è riconosciuto da anni il valore della medicina narrativa (Charon, 2006) come metodo integrativo e complementare alle informazioni medico-scientifiche, capace di favorire la relazione medico-paziente, di migliorare la gestione delle patologie e integrare i diversi punti di vista di tutti i soggetti coinvolti nei processi di cura.
Anche nel campo della salute pubblica, in particolare nei programmi e progetti di prevenzione, l’utilizzo della narrazione inizia a muovere i primi passi come valido strumento per il trasferimento delle conoscenze, per una comunicazione efficace e attenta ai bisogni conoscitivi del destinatario e per il miglioramento dell’attività professionale degli operatori della salute.
Tra le diverse caratteristiche che rendono la narrazione una strategia efficace per comunicare nell’ambito della prevenzione, le seguenti sono quelle maggiormente rilevanti: La Conoscenza e
La narrazione, avendo il potere di “dare forma al disordine delle esperienze” (Eco, 1994), è da sempre lo strumento principale della costruzione e della trasmissione del sapere e permette di rendere comprensibile, comunicabile e ricordabile il vissuto.
Il dispositivo narrativo, infatti, risulta particolarmente efficace per chiarire e facilitare la comprensione di eventi, esperienze, situazioni umane, mettendo a fuoco informazio-
* DoRS - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute, ASL TO3 - Regione Piemonte
** SC a DU Servizio di Epidemiologia, ASL TO3 - Regione Piemonte
ni in cui giocano un ruolo centrale le persone, le loro storie, gli aspetti etici e i valori di cui sono portatori, le loro intenzioni, motivazioni e scelte. Attraverso la narrazione, il soggetto delinea coordinate interpretative e prefigurative di eventi, azioni, situazioni costruendo su queste basi forme di conoscenza che lo possono orientare nel suo agire futuro.
La Costruzione di modelli di comportamento
La letteratura (Miller-Day, 2013) ha evidenziato che la narrazione è in grado di accrescere nei soggetti il senso di autoefficacia rispetto alla risoluzione di situazioni complesse. Le storie, infatti, dimostrano come i personaggi agiscono in relazione agli eventi e quali strategie di comportamento mettono in atto per far fronte a problemi e situazioni complesse. Le storie possono essere un esempio di “ciò che non andava fatto” e di “cosa si sarebbe dovuto fare” in termini di risoluzione di problemi.
Il Coinvolgimento
Per coinvolgimento, nel processo di lettura di una storia, si intende un insieme di attenzione, immaginazione e emozioni (Frank, 2015). Oltre che dal punto di vista cognitivo, infatti, le storie hanno il potere di toccare il lettore dal punto di vista emotivo, in modo più o meno intenso. La storia, a differenza di uno scritto formale e puramente informativo, permette di scoprire o riscoprire vissuti, saperi, visioni del mondo che ognuno porta con sé, facilita l’immedesimazione e l’empatia e stimola la fantasia e l’immaginazione, che sono riconosciuti come forti motori di cambiamento.
L’
La struttura narrativa permette al lettore di identificarsi con la storia e con i personaggi. Il senso di empatia e identificazione che suscitano le storie, gioca un ruolo fondamentale nei processi di comunicazione, permette di interiorizzare e avere un ricordo durevole delle informazioni ricevute, di rielaborare il proprio vissuto e di guidare i comportamenti futuri.
Le quattro caratteristiche della narrazione sopra analizzate rendono evidenti le potenzialità dell’utilizzo di questo
approccio per comunicare in modo più chiaro, accessibile e efficace la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A queste caratteristiche si aggiungono gli elementi costitutivi di una storia (ambientazione, personaggi, sequenza delle azioni, “morale della favola”) che consentono di arricchire di informazioni importanti le tradizionali inchieste infortuni, rendendole un potente strumento per il trasferimento delle indicazioni per la prevenzione.
Il presente articolo nasce dall’esperienza del progetto “Dall’inchiesta alla storia: costruzione di un repertorio di storie di infortunio sul lavoro” (Fubini, 2016), in cui un gruppo di operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) ha sperimentato, dopo esser stato adeguatamente formato, la riscrittura delle inchieste infortuni utilizzando gli elementi della narrazione. Trattandosi di infortuni oggetto di inchiesta, le storie riguardano eventi molto gravi o mortali. Gli operatori dei Servizi di prevenzione coinvolti hanno trasformato le loro inchieste infortunio in storie, consentendo di dare vita ad un sito che raccoglie a tutt’oggi 91 storie (Storie d’Infortunio (dors.it). Questo lavoro, reso pubblico dal Centro di Documentazione Regionale per la Promozione della salute – DoRS (www.dors.it), può essere utilizzato allo scopo di condividere le indicazioni per la prevenzione in un contesto lavorativo intrinseco, ma anche
a scopo di formazione e informazione.
L’obiettivo dell’articolo è descrivere come un’inchiesta di infortunio sul lavoro possa diventare una storia, attraverso l’analisi degli elementi tipici della narrazione applicati alle dinamiche infortunistiche e discutendone le ricadute sull’efficacia comunicativa nel diffondere il tema della sicurezza sul lavoro orientando le scelte e gli interventi di prevenzione. Utilizzando gli elementi chiave e le caratteristiche di base di un testo narrativo, con riferimento ai modelli teorici del semiologo Greimas, è stato analizzato il passaggio dalla stesura dell’inchiesta infortunio, risultato di un processo lungo e articolato di ricostruzione dei fatti, alla scrittura della storia di infortunio.
L’analisi
Il riferimento teorico individuato per l’analisi delle storie di infortunio è il lavoro del semiologo lituano Algirdas Julien Greimas (Greimas, 1983). Il titolo, le dimensioni di spazio e tempo, i personaggi (secondo il modello attanziale), il punto di vista, la struttura del racconto (seguendo lo schema narrativo canonico), e la morale della favola sono gli elementi della narrazione presi in analisi in questo articolo. Che cos’è una storia?
Una storia può essere definita come “una rappresentazione di eventi e personaggi connessi tra loro, con una
struttura identificabile e delimitata nello spazio e nel tempo” (Kreuter, 2007).
I fatti narrati possono essere veri, di cui l’autore del racconto è stato protagonista o testimone diretto, o immaginari ma verosimili, in cui l’autore dà libero sfogo alla sua fantasia.
Nel caso delle storie di infortunio si fa sempre riferimento ad accadimenti realmente avvenuti in uno spazio e in un tempo definito e con una sequenza strutturata di azioni.
Il titolo
Il titolo è un elemento essenziale di qualsiasi racconto. E’ infatti l’elemento che cattura fin da subito l’attenzione, contiene delle promesse e stimola la curiosità. Il titolo può indicare un luogo, se è significativo per lo svolgimento della storia o di alcune delle sue parti più salienti, oppure richiamare un evento cruciale del racconto, o ancora contenere il nome di un personaggio il cui ruolo è centrale per lo svolgimento dei fatti che si leggeranno.
Nel caso delle storie di infortunio il titolo può riferirsi in modo diretto all’evento (es. esplosione al Molino Cordero di Fossano, cinque lavoratori perdono la vita), oppure al nome del protagonista dell’infortunio (es. Io sono Cheng) o ancora utilizzando metafore o riferimenti letterari-cinematografici alla dinamica dell’infortunio (es. Le verità nascoste).
Le categorie di spazio e tempo
Il luogo e il tempo (stagione, ora, temperatura) sono componenti fondamentali in ogni storia: insieme costituiscono quella che viene definita l’ambientazione. Spesso è proprio un determinato luogo o un momento preciso a condizionare l’evolversi e l’esito di una vicenda.
Nel caso delle storie di infortunio è evidente come la stagione e la temperatura (freddo, caldo) possano essere determinanti per lo svolgersi dei fatti, specialmente per le attività svolte all’aperto. Così come l’orario della giornata in cui è avvenuto l’infortunio: possono entrare in gioco ad esempio la stanchezza e la distrazione dopo molte ore di lavoro.
I personaggi
Senza personaggi non esisterebbero le storie. Normalmente in ogni storia ci sono uno o più personaggi principali e altri secondari.
Nelle storie di infortunio le tre principali categorie di personaggi sono rappresentate dall’infortunato (o infortunati), dal collega (o colleghi) e dal datore (o datori) di lavoro. Nell’analisi qui proposta per la descrizione dei personaggi della storia di infortunio si è utilizzato il modello dei ruoli narrativi (modello attanziale) proposto da Greimas così strutturato:
• Il destinante: chi dà l’incarico per svolgere una determinata azione. Nelle storie di infortunio può essere rappresentato dall’impresa, dal capocantiere, dal responsabile di un appalto, ecc..
• Il soggetto: colui che deve eseguire l’azione. Nelle storie di infortunio si tratta del lavoratore infortunato.
• L’oggetto: l’azione. Nelle storie di infortunio è il lavoro, l’attività, la mansione da svolgere
• L’opponente: la persona o la cosa che impedisce che l’azione venga svolta facilmente. Nelle storie di infortunio, si può rintracciare l’opponente ad esempio in un macchinario difettoso, nelle procedure di sicurezza non a norma
• L’aiutante: la persona o l’oggetto che facilitano il compimento dell’azione. Nelle storie di infortunio si tratta quasi sempre di uno o più colleghi dell’infortunato.
Il punto di vista
In qualsiasi tipo di narrazione, il punto di vista, ovvero l’angolazione dalla quale si vede il susseguirsi degli eventi, è di grande importanza per conferire un determinato senso agli avvenimenti.
Nell’inchiesta e poi nelle storie di infortunio, il narratore è esterno. Narrando solitamente in terza persona, egli si colloca su un piano superiore rispetto al momento in cui avvengono le vicende narrate e, conoscendone l’epilogo, è in grado di muoversi nel tempo anticipando o posticipando i fatti. Il narratore della storia di infortunio è l’operatore dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro (SPreSAL). Se vi è la presenza di testimonianze, si aggiungono al narratore esterno i cosiddetti narratori interni che arricchiscono la ricostruzione dell’evento con il loro punto di vista e il loro vissuto emotivo. Il narratore interno può essere il protagonista della vicenda o un testimone al momento dell’infortunio (nelle storie di infortunio spesso si tratta di un collega di lavoro).
Lo schema narrativo canonico
La semiotica di Greimas struttura l’andamento di un racconto in quattro fasi che costituiscono il cosiddetto schema narrativo canonico, un modello a quattro “tappe” che può essere utilizzato per l’analisi di qualsiasi formazione testuale, dalla favola per bambini al discorso politico. In questo caso si applicherà alle storie di infortunio. Le fasi del modello sono le seguenti:
• Manipolazione: consiste in ciò che si deve fare. Prima che si acquisisca la competenza accumulando esperienza e superando prove e ostacoli, deve esserci un obiettivo del racconto, una posta in gioco, deve esserci un contratto tra chi chiede che una determinata azione sia svolta (destinante) e chi quell’azione la metterà in atto (destinatario).
• Nelle storie di infortunio la manipolazione consiste nell’incarico lavorativo che l’azienda dà ai suoi dipendenti.
• Competenza: rappresenta che cosa si è in grado di fare. Chi è destinato a compiere la performanza deve conquistare i mezzi concettuali e materiali necessari: accumulare sapere, dimostrare il proprio valore.
• Nelle storie di infortunio la competenza è rappresentata dalle capacità (pratiche, intellettuali) del lavoratore per
svolgere un determinato compito e dalle possibilità (strumentali, oggettive, fisiche, psicologiche) per svolgerlo al meglio.
• Performanza: rappresenta l’azione svolta, cosa si è fatto. Per avere un racconto non basta una serie di fatti ordinati, occorre qualcosa che deve essere compiuto, una missione da realizzare.
• La performanza nelle storie di infortunio è rappresentata dall’insieme di azioni che hanno portato all’infortunio.
• Sanzione: è costituita dall’esito della storia. Il racconto si conclude non necessariamente quando l’azione è compiuta, ma quando essa viene riconosciuta da parte di chi ha dato inizio all’azione, da chi, cioè, ha stipulato il contratto.
• Nel caso delle storie di infortunio il ciclo narrativo si conclude sempre con una sanzione negativa (infortunio), in quanto il destinatario, per ragioni diverse, non riesce a portare a termine il compito che gli è stato affidato al momento della manipolazione.
La Morale della favola
Ogni storia ha un finale che rappresenta le conseguenze derivanti dalle azioni messe in atto nello svolgersi degli eventi e che può costituire un insegnamento per il futuro: è la cosiddetta morale della favola (Che cosa si impara da questa storia? Che cosa ci insegnano i protagonisti?).
Mentre le storie tradizionali possono essere caratterizzate da un lieto fine, nelle storie di infortunio il finale coincide sempre con l’infortunio, spesso mortale. La morale della favola di queste storie è da rintracciare quindi nelle cosiddette “Indicazioni per la prevenzione” ovvero una serie di raccomandazioni ricavate dall’analisi dell’infortunio che possono essere condivise tra gli operatori della prevenzione come strumento di apprendimento e trasferite nella pratica in modo che si evitino in futuro eventi analoghi.
Il presente articolo illustra come le dinamiche infortunistiche possano prestarsi a essere raccontate secondo le categorie tipiche della narrazione (il tempo e lo spazio, la situazione lavorativa e emotiva dei soggetti coinvolti, le testimonianze che offrono punti di vista alternativi, la morale della favola), e dell’organizzazione testuale, risultandone arricchite di elementi importanti per la comunicazione della prevenzione e l’apprendimento di comportamenti sicuri.
L’inchiesta infortunio che diventa storia assume caratteristiche importanti anche sotto il profilo della comunicazione: i contenuti diventano più chiari, accessibili e coinvolgenti. L’aggiunta delle testimonianze poi, arricchisce il racconto di umanità, favorendo l’empatia e l’immedesimazione, emozioni che possono incidere fortemente e guidare le scelte comportamentali.
A differenza delle tradizionali inchieste, le storie di infortunio, attraverso gli elementi della narrazione e in modo particolare con l’aggiunta delle indicazioni per la prevenzione, possono diventare, inoltre, un efficace strumento di appren-
dimento e di condivisione da utilizzare in contesti formativi.
L’utilizzo di tecniche della narrazione per descrivere gli eventi infortunistici sul lavoro è una strategia di comunicazione efficace in termini di arricchimento, accessibilità e comprensione dei contenuti nonché di trasferibilità degli stessi nella pratica degli operatori della prevenzione.
Conclusioni
Un approccio alla sicurezza nei luoghi di lavoro che non si limiti a fornire solo dati e statistiche ma che invece, riconoscendo la complessità delle dinamiche infortunistiche, tenga conto del vissuto e della voce dei soggetti coinvolti, arricchisce di senso e di umanità gli eventi, favorisce lo scambio di esperienze tra gli operatori della sicurezza, costituisce una modalità di apprendimento dall’esperienza innovativa e coinvolgente e consente di portare in modo più efficace l’attenzione su un tema così cruciale come quello degli infortuni sul lavoro, anche al di fuori del settore specifico degli operatori della prevenzione. La storia diventa strumento di maggiore valorizzazione del lavoro degli operatori della sicurezza, veicolo di scambio di esperienze e saperi e fonte documentale preziosa in grado di orientare scelte e interventi futuri in ambito preventivo.
• Barthes R., Duisit L., (1975) An Introduction to the Structural Analysis of Narrative, New Literary History 6 (2), On Narrative and Narratives, 237-272
• Bruner J., (1991) The Narrative Construction of Reality, Critical Enquire, 18 (1), 1-21. doi: 10.1086/448619
• Charon R., (2006) Narrative Medicine Honoring the stories of illness: Oxford University Press.
• Eco U., (1994) Six Walks in the Fictional Woods: Harvard University Press.
• Frank L.B., (2015) Telling stories, saving lives: creating narrative health messages, Health Communication, 154-163. doi: 10.1080/10410236.2014.974126
• Fubini L. et al., (2016) La narrazione degli infortuni sul lavoro come base per il miglioramento delle attività preventive, La medicina del lavoro, 107 (3), 178-185
• Greimas A.J, (1983) Structural Semantics: An Attempt at Method Hardcover: University of Nebraska Press
• Kreuter M. et al., Narrative communication in cancer prevention and control: a framework to guide research and application, Annals of behavioural medicine, 33 (3), 221-235. doi: 10.1080/08836610701357922
• Miller-Day M., (2013) Narrative Means to Preventative Ends: A Narrative Engagement Framework for Designing Prevention Interventions, Health Communication; 28 (7) 657-670. doi: 10.1080/10410236.2012.762861
• Polvani S., (2016) Cura alle stelle. Manuale di salute narrativa: Maria Margherita Bulgarini
• VanDeCarr P., (2015) Storytelling and social change, Retrieved from Working narratives website: http://workingnarratives.org/project/story-guide/
• Ventres W., Gross P., (2016) Getting Started: A Call for Storytelling in Family Medicine Education, Family Medicine, 48 (9), 682-687

La FNOB rinnova la convenzione per fornire ai biologi un software di gestione della contabilità
Leggi l’intesa su www.fnob.it

Edizione mensile di AgONB (Agenzia di stampa dell’Ordine Nazionale dei Biologi)

Testata registrata al n. 52/2016 del Tribunale di Roma
Diffusione: www.fnob.it
Direttore responsabile: Claudia Tancioni
Redazione: Ufficio stampa Fnob
Progetto grafico e impaginazione: Ufficio stampa Fnob. Questo magazine digitale è scaricabile on-line dal sito internet www.fnob.it
Questo numero del “Giornale dei Biologi” è stato chiuso in redazione venerdì 24 febbraio 2023.
Contatti: +39 0657090205, +39 0657090225, protocollo@cert.fnob.it
Per la pubblicità, scrivere all’indirizzo protocollo@cert.fnob.it
Gli articoli e le note firmate esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.
Immagine di copertina: © Andrey_Popov/www.shutterstock.com
Si informano gli iscritti che gli uffici della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi forniranno informazioni telefoniche di carattere generale dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Tutte le comunicazioni dovranno pervenire tramite posta (presso Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, via Icilio 7, 00153 Roma) o all’indirizzo protocollo@cert.fnob.it, indicando nell’oggetto l’ufficio a cui la comunicazione è destinata.
È possibile recarsi presso le sedi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi previo appuntamento e soltanto qualora non sia possibile ricevere assistenza telematica. L’appuntamento va concordato con l’ufficio interessato tramite mail o telefono.
UFFICIO CONTATTO
Centralino 06 57090 200
Ufficio protocollo protocollo@cert.fnob.it
Commissario straordinario commissario.fnob@pec.it
Ufficio segreteria segreteria@fnob.it
Direzione direzione@fnob.it
Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
www.fnob.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
Giornale dei Biologi
Il Giornale dei Biologi