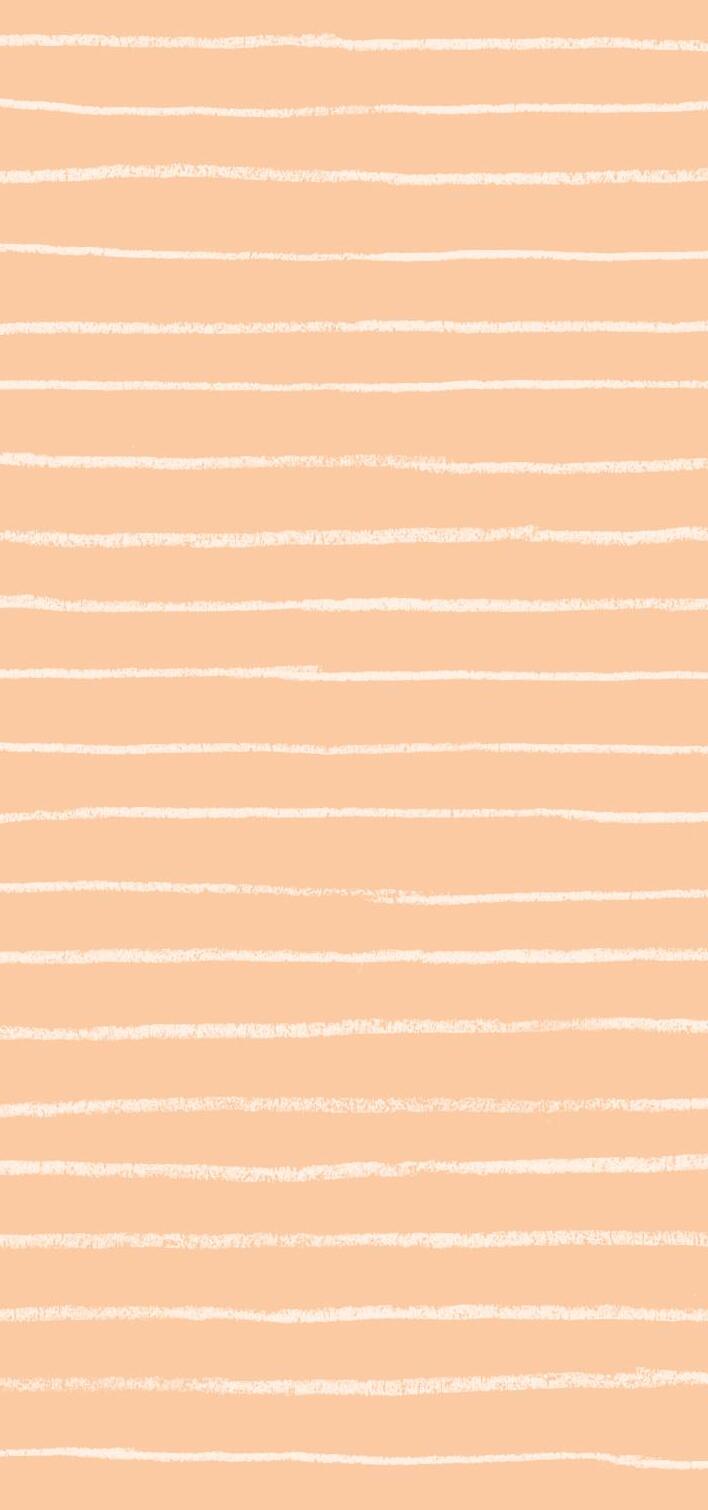I Quaderni della Ricerca
SISTER
Contrastare il bullismo femminile con la sorellanza
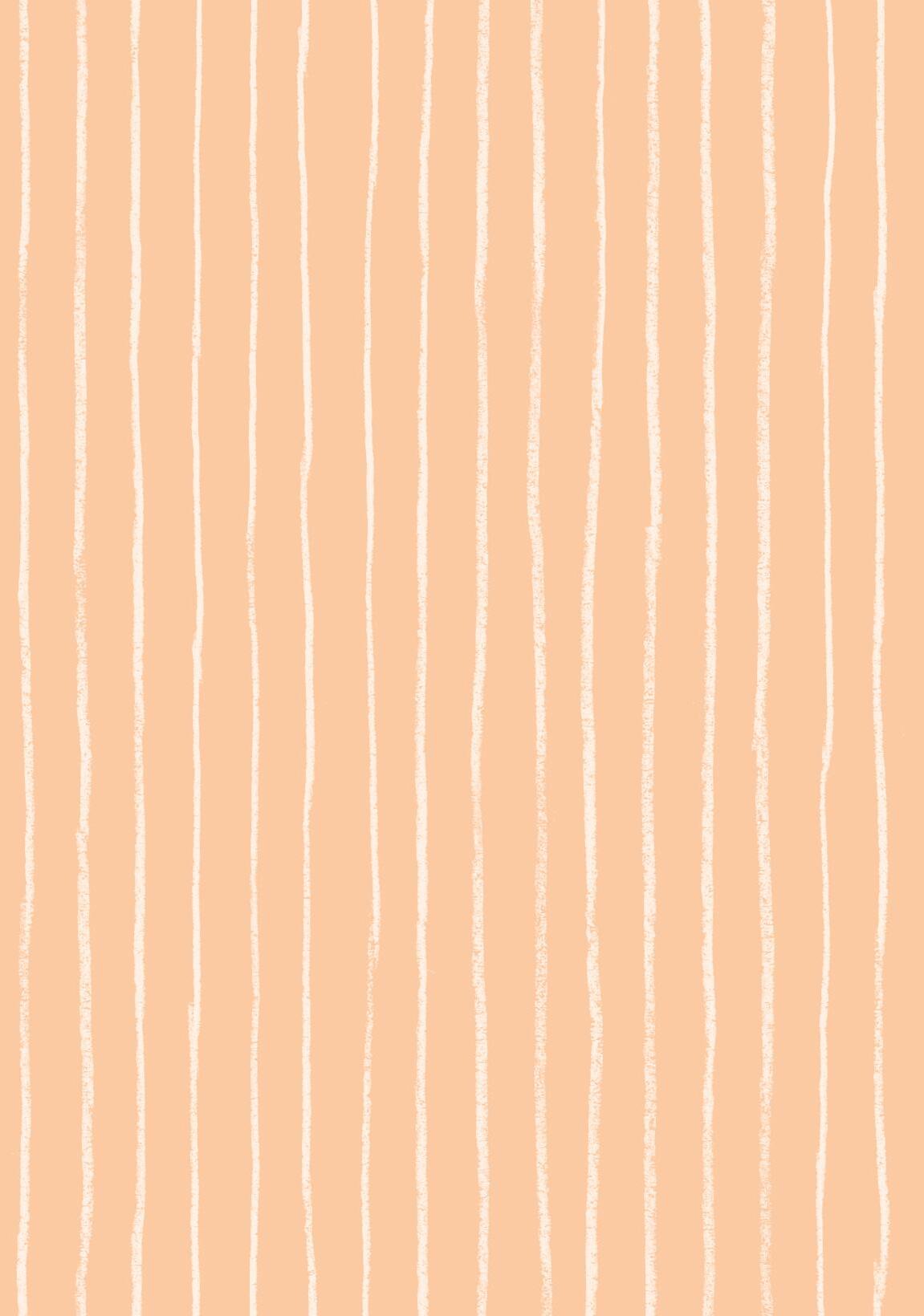
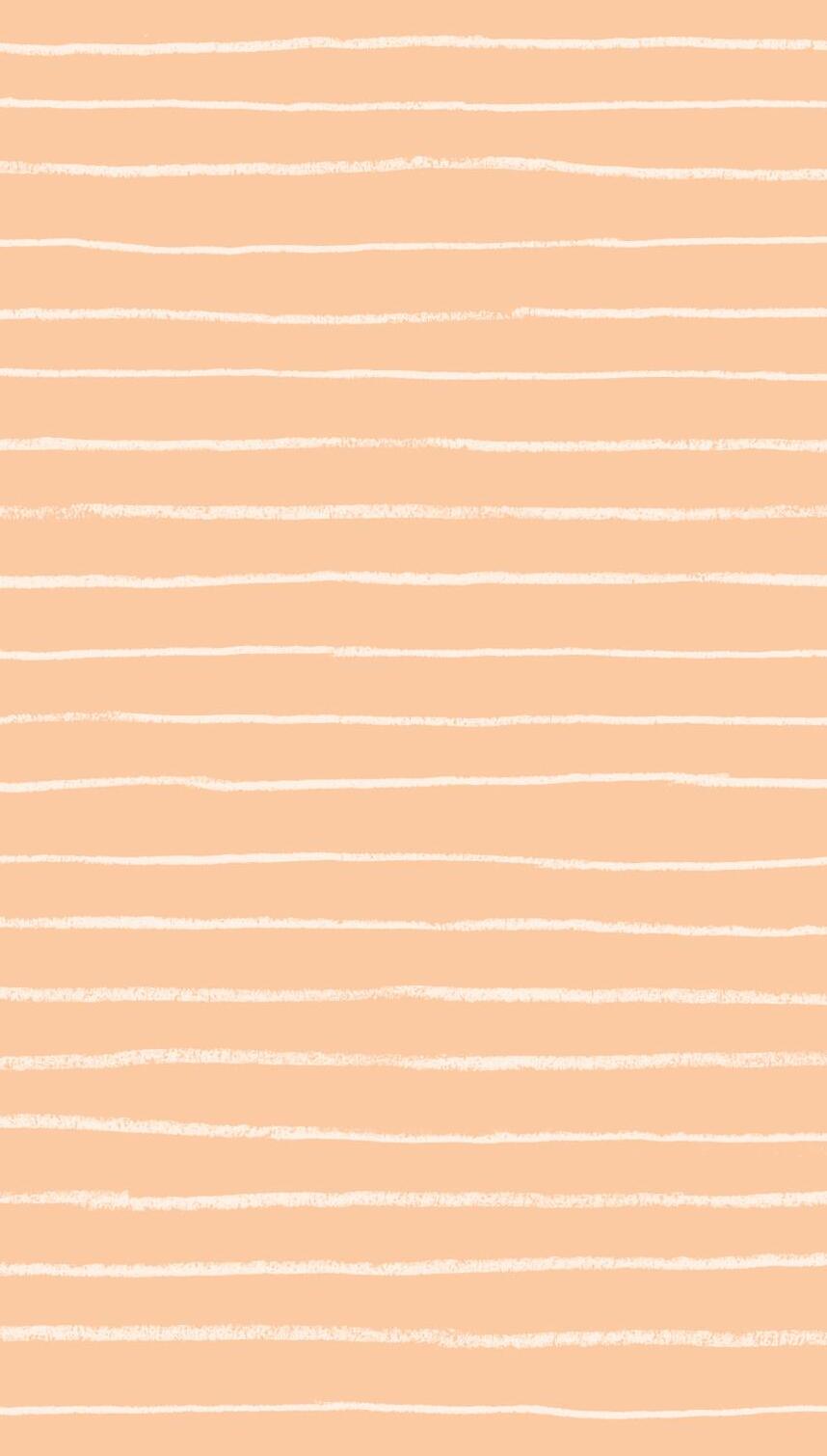
Antonia De Vita, Francesco Vittori
I Quaderni della Ricerca 89
SISTER
Contrastare il bullismo femminile con la sorellanza
Antonia De Vita, Francesco Vittori
© Loescher Editore - 2025
Sede operativa Via Vittorio Amedeo II, 18 - 10121 Torino www.loescher.it
Diritti riservati
I diritti di pubblicazione, riproduzione, comunicazione, distribuzione, trascrizione, traduzione, noleggio, prestito, esecuzione, elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale e di adattamento totale o parziale su supporti di qualsiasi tipo e con qualsiasi mezzo (comprese le copie digitali e fotostatiche), sono riservati per tutti i paesi. L’acquisto della presente copia dell’opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce.
Fotocopie e permessi di riproduzione
Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E. del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E.
Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico, commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l’editore potrà concedere a pagamento l’autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume. Le richieste vanno inoltrate a Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (CLEARedi) Corso di Porta Romana, n. 108 - 20122 Milano e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale. La loro fotocopia per i soli esemplari esistenti nelle biblioteche è consentita, anche oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all’opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell’editore, una successiva edizione, né le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. Nei contratti di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei e archivi, la facoltà di cui all’art. 71 - ter legge diritto d’autore. Per permessi di riproduzione diversi dalle fotocopie rivolgersi a diritti@loescher.it Licenze per riassunto, citazione e riproduzione parziale a uso didattico con mezzi digitali La citazione, la riproduzione e il riassunto, se fatti con mezzi digitali, sono consentiti (art. 70 bis legge sul diritto d’autore), limitatamente a brani o parti di opera, a) esclusivamente per finalità illustrative a uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. (La finalità illustrativa si consegue con esempi, chiarimenti, commenti, spiegazioni, domande, nel corso di una lezione); b) sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le parti di opere sono utilizzate;
c) a condizione che, per i materiali educativi, non siano disponibili sul mercato licenze volontarie che autorizzano tali usi.
Loescher offre al mercato due tipi di licenze di durata limitata all’anno scolastico in cui le licenze sono concesse: A) licenze gratuite per la riproduzione, citazione o riassunto di una parte di opera non superiore al 5%. Non è consentito superare tale limite del 5% attraverso una pluralità di licenze gratuite, B) licenze a pagamento per la riproduzione, citazione, riassunto parziale ma superiore al 5% e comunque inferiore al 40% dell’opera.
Per usufruire di tali licenze occorre seguire le istruzioni su www.loescher.it/licenzeeducative L’autorizzazione è strettamente riservata all’istituto educativo licenziatario e non è trasferibile in alcun modo e a qualsiasi titolo.
Ristampe 6 5 4 3 2 1 N 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026
ISBN 9788820139070
In alcune immagini di questo volume potrebbero essere visibili i nomi di prodotti commerciali e dei relativi marchi delle case produttrici. La presenza di tali illustrazioni risponde a un’esigenza didattica e non è, in nessun caso, da interpretarsi come una scelta di merito della Casa editrice né, tantomeno, come un invito al consumo di determinati prodotti. I marchi registrati in copertina sono segni distintivi registrati, anche quando non sono seguiti dal simbolo ® Nonostante la passione e la competenza delle persone coinvolte nella realizzazione di quest’opera, è possibile che in essa siano riscontrabili errori o imprecisioni. Ce ne scusiamo fin d’ora con i lettori e ringraziamo coloro che, contribuendo al miglioramento dell’opera stessa, vorranno segnalarceli all’indirizzo clienti@loescher.it
Loescher Editore Divisione di Zanichelli editore S.p.A. opera con Sistema Qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001. Per i riferimenti consultare www.loescher.it
Il contenuto di questo libro non è stato approvato dalle Nazioni Unite e quindi potrebbe non riflettere la posizione ufficiale di questa organizzazione.
Diritto di TDM
L’estrazione di dati da questa opera o da parti di essa e le attività connesse non sono consentite, salvi i casi di utilizzazioni libere ammessi dalla legge. L’editore può concedere una licenza. La richiesta va indirizzata a tdm@loescher.it
Coordinamento editoriale: Alessandra Nesti
Realizzazione editoriale e tecnica: PhP - Grosseto
Impaginazione: Silvia Filoni
Copertina: Visualgrafika – Torino
Progetto grafico interni: Fregi e Majuscole – Torino
Progetto grafico copertina: Leftloft – Milano/New York
Stampa: Gravinese Industrie Grafiche S.r.l., via Lombardore
Introduzione. Con le comunità scolastiche per contrastare il bullismo femminile
azioni di contrasto dal basso con approccio Student’s Voice
1. Il bullismo in adolescenza: corpi ribelli in un campo di battaglia
1 .1 . Essere adolescenti oggi: fragilità e narcisismo nella transizione identitaria
1 . 2 . L’adolescenza nelle correnti affettive: tra sperimentazione e giudizio
Sperimentare o giudicare?
1 . 3 . I grandi cambiamenti della pubertà
I social media tra le/gli adolescenti
1 .4 . Considerazioni conclusive
Sonia Bertoglio, Francesco Vittori
3.2.2. Livello classe
3.3.1. Una politica integrata antibullismo a scuola
3.3.2. Come si può costruire una “politica” scolastica
3 .4 . Interventi a livello di gruppo-classe in Fonzi e Menesini
3.4.1. L’approccio curricolare
3.4.2. L’intervento sul problema delle prepotenze nella scuola media nell’approccio curricolare
3.4.3. Risultati del primo anno
3.4.4. Secondo anno di esperienza
3 . 5 . L’educazione tra pari e i modelli di supporto tra coetanei in Menesini
3.5.1. “L’operatore amico”
3.5.2. La ricerca nella provincia di Lucca
4. Co-progettare azioni di contrasto con le comunità scolastiche: la sperimentazione SISTER
di Antonia De Vita, Francesco Vittori, Sonia Bertoglio 4 .1 . Le dimensioni innovative
4 . 2 . Le azioni di ricerca-formazione svolte nel contesto scolastico nel progetto SISTER
4.2.1. Laboratorio “16 Attitudini”
4.2.2. Teatro dell’Oppresso
4.2.3. Valutazione con studenti e insegnanti delle attività di ricerca-formazione
4 . 3 . I workshop di co-progettazione con le studenti e le insegnanti . . .
4 .4 . Riflessioni conclusive
4 . 5 . Alcuni consigli per le comunità scolastiche
Bibliografia
Prefazione
di Federico Batini, Università degli Studi di Perugia
Questo libro, SISTER. Contrastare il bullismo femminile con la sorellanza, è il risultato di un lungo percorso di ricerca e sperimentazione educativa che ha coinvolto, per oltre sette anni, scuole, studenti, insegnanti e ricercatrici/ricercatori in un impegno condiviso, per affrontare una delle forme più invisibili e trascurate di prevaricazione tra pari: il bullismo femminile. Lontano da semplificazioni stereotipate o da letture genericamente psicologizzanti del fenomeno, il volume assume una prospettiva di genere e intersezionale per interpretare la violenza tra ragazze come forma specifica di aggressività relazionale, inscritta nella costruzione identitaria adolescenziale e nella grammatica simbolica del femminile.
Il volume affonda le proprie ragioni nella convinzione che siano le comunità scolastiche – nella loro quotidianità educativa – a detenere il potenziale trasformativo necessario per innescare un cambiamento. La ricerca educativa è chiamata a facilitarlo “sporcandosi le mani”, ovvero instaurando un fecondo dialogo con le pratiche e gli accadimenti concreti di queste comunità, per rispondere ai bisogni di tutte le soggettività specifiche che le costituiscono.
Il progetto SISTER nasce con l’intento di rendere visibile l’invisibile, restituendo voce e ruolo attivo alle vere esperte del bullismo femminile: le studenti. L’opzione metodologico-valoriale è forte: inserirsi nel quadro della versione più radicale dell’approccio Student’s Voice: trasformare le studenti in ricercatrici1. Come mettono in luce i diversi modelli di ricerca in ottica Student’s Voice2 , infatti, non si tratta semplicemente di ascoltare le posizioni di
1. Si veda F. Batini, M. Evangelista, Da studenti a ricercatori. Percorso completo di didattica della ricerca, Giunti, Firenze 2017; F. Batini, G. Benvenuto, Le parole “disperse”. La voce degli studenti drop-out e la ricerca etnografica in pedagogia, in P. Sposetti, G. Szpunar (a cura di), Narrazione e educazione, 6 (pp. 67-78), Edizioni Nuova Cultura, Roma 2016.
2. V. Grion, F. Dettori, Student Voice: nuove traiettorie della ricerca educativa, in M. Tomarchio, S. Ulivieri (a cura di), Pedagogia militante. Diritti, culture, territorio (pp. 851-859), ETS, Pisa 2015.
ragazzi e ragazze, ma piuttosto di coinvolgerli in ciò che li riguarda, fino a svilupparne capacità di co-leadership di ricerca3, attitudini ad affrontare le situazioni da indagare come co-ricercatori o ricercatori4, di autorizzarli a trovare risposte e agire, e non meramente a rispondere a un programma definito dagli adulti5.
Il posizionamento e la consapevolezza metodologica delle ricercatrici e dei ricercatori si fecondano qui reciprocamente, e costituiscono condizioni necessarie alla credibilità dell’azione. Quando l’azione di ricerca si sostanzia nella partecipazione, le pratiche di ascolto e coinvolgimento sono sì strumenti operativi metodologicamente sorvegliati, ma costituiscono anche, allo stesso tempo, la definizione dei confini di un’attenzione, confini che debbono sempre essere rimarcati per starvi dentro. Sembra facile, non lo è per gli adulti in generale, e in particolare per la ricerca.
La ricerca, e gli stessi dispositivi con cui viene organizzata, confrontata, valutata, è spesso sbilanciata sui risultati, sugli output, mentre in azioni di ricerca partecipativa e trasformativa la preoccupazione principale sta nella qualità e nel funzionamento dei processi, nella reale assunzione dei ruoli che si propone di facilitare, nella difficilissima cessione del “potere” di controllo. Quasi un ossimoro, una ricerca in cui le ricercatrici e i ricercatori di professione perdono il controllo per cederlo alle/agli studenti.
In questo progetto, attraverso i racconti delle studenti, le pratiche di ricerca partecipata e l’attivazione di processi di co-progettazione educativa, è stato possibile costruire un modello di intervento centrato sul protagonismo giovanile, sulla sorellanza come dispositivo relazionale generativo, e su un’idea di scuola come spazio politico e affettivo in grado di leggere e trasformare le disuguaglianze.
A sostenere e attraversare l’intero volume è l’idea che il bullismo femminile, nella sua natura relazionale, ambigua, intima e spesso invisibile, non possa essere affrontato con strumenti tradizionali, ma richieda uno sguardo nuovo, capace di accogliere la complessità delle soggettività coinvolte, delle appartenenze multiple e delle relazioni di potere che si intrecciano nei contesti scolastici.
3. D. Mitra, Increasing Student Voice and Moving Toward Youth Leadership, in «The Prevention Researcher», 13(1), pp. 7-10, 2006.
4. M. Fielding, Students as radical agents of change, in «Journal of Educational Change», 2(3), pp. 123-141, 2001, https://doi.org/10.1023/A:1017949213447; M. Fielding, Transformative approaches to student voice: theoretical underpinnings, recalcitrant realities, in «British Educational Research Journal», 30(2), pp. 295–311, 2004, https://doi.org/10.1080/0141192042000195236
5. F. Batini, V. Grion, E. Rubat du Mérac, Ascoltare gli studenti per formare gli insegnanti?, in «Annali online della Didattica e della Formazione Docente», 15(25), supp., pp. 40-54, 2023, https:// doi.org/10.15160/2038-1034/2629.
SISTER è dunque più di un progetto, e questo, che avete tra le mani, è più di un libro: è un appello alla trasformazione delle pratiche educative, alla restituzione di un ruolo fondamentale a coloro per i quali i sistemi educativi e di istruzione sono costruiti, alla costruzione di alleanze tra pari e tra generazioni, alla valorizzazione delle differenze come risorsa per immaginare e abitare una scuola più giusta, equa e capace di cura.
Il volume fornisce anche indicazioni concrete per affrontare e prevenire questo fenomeno, emerse da un lungo lavoro con le studenti, che noi adulti dovremmo essere capaci di prendere sul serio e di non pre-comprendere.
Speriamo che questo lavoro apra altri itinerari di ricerca e trasformazione educativa in cui, finalmente, restituiamo a tutte le studenti e gli studenti ciò che, di fatto, è loro.
Introduzione . Con le comunità scolastiche per contrastare il bullismo femminile
di Antonia De Vita, Francesco Vittori
Per iniziare: una dedica
Questo volume è dedicato alle e agli insegnanti che quotidianamente si trovano a fronteggiare episodi di bullismo, e che desiderano attrezzarsi nella propria comunità scolastica per prevenire e gestire i comportamenti aggressivi delle ragazze e dei ragazzi.
Nasce da un percorso di sette anni di ricerca sul campo in cui, per gradi, abbiamo cominciato a studiare il fenomeno del bullismo femminile, a partire da alcune scuole di Verona e coinvolgendo le studenti maggiorenni, fino ad arrivare alla raccolta dati in diverse città-campione del nostro Paese.
Questa ricerca ci ha permesso di incontrare ragazze che vivono molto spesso situazioni difficili di bullismo in solitudine, eppure capaci di parlarne con la precisione e la competenza di vere esperte, e che sono cresciute assieme a noi in questi anni di progetti e ricerca comune. Assieme a loro, abbiamo incontrato insegnanti appassionate e dedite alle loro studenti e al loro benessere. Le ringraziamo per aver fatto comunità di ricerca assieme a noi.
SISTER. Contrastare il bullismo femminile con la sorellanza vorrebbe essere uno strumento teorico-pratico capace di ispirare le comunità scolastiche ad attivare le risorse interne alla propria scuola, e in particolare a dare voce e protagonismo alle vere esperte del bullismo femminile: le studenti.
SISTER. Contrastare il bullismo femminile con la sorellanza è un titolo che riassume ciò che ci sta a cuore sostenere e promuovere. Infatti, le azioni efficaci di contrasto al bullismo possono nascere coinvolgendo, nella ricerca delle risposte e delle soluzioni adottabili nel contesto scolastico, le studenti: le vere specialiste del fenomeno. L’altra idea riguarda la relazione di “sorellanza”, che rappresenta una configurazione relazionale significativa per cambiare di segno all’aggressività e alla distruttività tra ragazze. Essere sorelle è una rappresentazione della solidarietà e della complicità femminile che nella tradizione femminile e femminista non azzera una certa opacità caratterizzante le relazioni femminili, ma ne mette in luce la positività e gli aspetti generativi.
Per arrivare a fondo di queste proposte abbiamo adottato una prospettiva di genere, nei confronti del bullismo, che ci sembra fondamentale per aprire nuovi significati, articolando il testo in quattro distinti capitoli.
Nel primo capitolo ci soffermiamo sulla transizione identitaria in adolescenza per le ragazze e i ragazzi, per approfondire le specificità del bullismo femminile che è qualitativamente differente da quello maschile. Insistiamo in particolare sulla ribellione dei corpi in adolescenza, nell’arena delle differenze che si urtano.
Nel secondo capitolo discutiamo i dati quantitativi disponibili sul bullismo in Italia, approfondendo quelli raccolti nella ricerca nazionale “Il bullismo a scuola. Un’indagine intersezionale mixed-method”, che ha coinvolto sei Università (Verona, Milano-Bicocca, Genova, Perugia, Enna-Kore, Foggia) e città di piccola e media dimensione, del Nord, Centro e sud dell’Italia e che è stata coordinata da Antonia De Vita (Università di Verona) e da Giuseppe Burgio (Università Enna “Kore”). Si discutono anche le principali iniziative di contrasto adottate da parte delle istituzioni.
Nel terzo capitolo riassumiamo i modelli pionieristici di contrasto al bullismo. Dopo aver tracciato una breve panoramica dei modelli ecologici di tipo sistemico, in particolare gli approcci proposti da Dan Olweus e da Sonia Sharp e Peter Smith, descriviamo il modello curricolare proposto da Ersilia Menesini. Si giunge poi, nel quarto e ultimo capitolo, alla presentazione del progetto sperimentale “Co-progettare azioni di contrasto al bullismo con le comunità scolastiche”, che rappresenta la terza fase della ricerca nazionale “Il bullismo femminile a scuola”. Questa terza e ultima fase di ricerca è stata avviata soltanto dall’Università degli Studi di Verona, utilizzando un approccio di tipo partecipativo e di ricerca-formazione. Essa aveva come finalità l’elaborazione di un modello educativo di contrasto al bullismo femminile co-progettato con le studenti e gli/le insegnanti coinvolti nella fase uno e due della ricerca. Il progetto sperimentale ha infatti esplorato i margini di intervento tra pari, per agire nelle situazioni e nel contesto in cui il bullismo femminile si manifesta, con azioni di contrasto che partano dal basso, dalle coetanee6. Questa sperimentazione, di cui parleremo diffusamente nel cap. 4, cerca di mettere in risalto l’importanza delle voci degli/delle studenti, riconoscendo loro l’importanza in quanto attori e attrici presenti nelle scene di prevaricazione, aggressione ed emarginazione. La metodologia adottata ha seguito l’approccio cosiddetto Student’s Voice, il quale riconosce un ruolo attivo e partecipativo nell’apprendimento e nel benessere nei contesti educatici, ovvero studenti capaci e co-partecipi nelle decisioni che li riguardano.
6. Ivi, p. 72.
Prospettive di genere per leggere il bullismo7
Leggere il bullismo attraverso una prospettiva di genere è un’esigenza maturata attraverso il riconoscimento delle potenzialità e dei limiti della letteratura che interpreta i fenomeni, e tra questi il bullismo maschile e femminile, come universali e dunque neutro-maschili. Il pensiero femminile e femminista ha articolato negli ultimi quarant’anni un discorso scientifico che arricchisce la lettura della realtà nella sua complessità, facendo luce sui soggetti sessuati e parziali8, su una prospettiva legata alla differenza sessuale e alla riflessione di genere come imprescindibile prospettiva ermeneutica nonché sui saperi situati e incarnati in soggetti e contesti specifici9, giungendo all’interessante prospettiva intersezionale, che permette di parlare di diversità alla luce del fatto che ogni persona è portatrice contemporaneamente di più diversità10.
Le motivazioni, i bisogni simbolici, i processi di individuazione e i comportamenti di ragazze e ragazzi sono differenti alla radice, ed è quindi importante aprire sia il bullismo femminile sia quello maschile a chiavi di lettura autonome. Anche la relazione tra bullismo femminile-maschile e omofobia, nella doppia versione gayfobia o lesbofobia, può emergere solo da una lettura sessuata nutrita dalla riflessione di genere11. È importante sottolineare gli elementi che accomunano il bullismo femminile con quello maschile, per giungere poi a definirne gli aspetti di irriducibilità, che tuttavia non andranno visti come irrigidimento stereotipico ed essenzialistico nei due generi.
Oltre alla prospettiva di genere è importante considerare anche la pro-
7. Le idee di questo paragrafo sono una ripresa di A. De Vita, Bullismo femminile a scuola e omofobia in una prospettiva intersezionale, pubblicato in F. Batini, I.D.M. Scierri (a cura di), In/sicurezza fra i banchi. Bullismo, omofobia e discriminazioni a scuola: dati, riflessioni, percorsi a partire da una ricerca nelle scuole secondarie umbre (pp. 151-170), Franco Angeli, Milano 2021.
8. Aa. Vv., Diotima. Il pensiero della differenza sessuale, La Tartaruga, Milano 1987.
9. D. Haraway, Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and The Privilege of Partial Perspective, in «Feminist Studies», 14(3), pp. 193-229, 1988.
10. N. Yuval-Davis, Belonging and the Politics of Belonging, in «Patterns of Prejudice», 40(3), pp. 196213, 2006; S. Marchetti, Intersezionalità, in C. Botti (a cura di), Etiche della diversità culturale (pp. 133-148), Le Lettere, Firenze 2013.
11. G. Burgio, Adolescenza e violenza. Il bullismo omofobico come forma-zione alla maschilità, Mimesis, Roma 2012; G. Burgio, La femminilità corretta. I copioni di genere nel bullismo femminile, in G. Burgio (a cura di), Il bullismo femminile. Genere, dinamiche relazionali, rappresentazioni (pp. 32-54), Franco Angeli, Milano 2018; F. Batini, Identità sessuale: un’assenza ingiustificata. Ricerca, strumenti e informazioni per la prevenzione del bullismo omofobico a scuola, I Quaderni della Ricerca #08, Loescher Editore, Torino 2014; F. Batini, Il corpo assente Conseguenze di un silenzio e piste di lavoro, in «Annali online della Didattica e della Formazione Docente», 12(20), pp. 43-55, 2020, http://dx.doi.org/10.15160/2038-1034/12264; A. De Vita, Il lato oscuro delle relazioni tra donne, in G. Burgio (a cura di), Il bullismo femminile. Genere, dinamiche relazionali, rappresentazioni (pp. 88103), Franco Angeli, Milano 2018.
spettiva intersezionale, per presentare una lettura che sappia intrecciare l’appartenenza delle persone a più categorie sociali interagenti tra loro sia a livello soggettivo sia livello di gruppi e istituzioni. È utile imparare a leggere, come propongono le pensatrici intersezionali, gli «incroci»12 oppure le «intersezioni fra assi di potere»13 creati dall’intreccio delle categorie che sono più significative a seconda del contesto: genere, cultura, religione, classe. Questi incroci sono molto presenti nella scuola italiana da decenni, e in particolar modo in alcune scuole, che presentano una popolazione studentesca particolarmente eterogenea.
Prima di entrare nel merito delle principali differenze tra bullismo femminile e maschile, e di soffermarci sulla loro morfologia, risulta fruttuoso e opportuno riattraversare rapidamente il territorio che questi due fenomeni hanno in comune, a partire da quanto emerge dalla letteratura internazionale.
In maniera concorde, le studiose e gli studiosi individuano come elemento comune al bullismo tra ragazze e tra ragazzi la descrizione del fenomeno: Sharp e Smith14 parlano di un tipo di azione che mira deliberatamente a fare del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi e persino anni, ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c’è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare l’altro/l’altra. Il pioniere degli studi sul bullismo Olweus15 lo descrive come una violenza fisica, verbale o psicologica ripetuta, che si protrae nel tempo, con uno squilibrio tra vittima e carnefice. Specifico del bullismo è l’abuso tra pari16 fondato sul binomio dominio-sottomissione, che nasconde essenzialmente un bisogno fondamentale di riconoscimento da parte di chi bullizza. Possiamo infatti leggere nelle azioni del/della bullo/a una dichiarazione gridata di valore, un “io valgo” che trova solo nella prepotenza e nella violenza un modo per dirsi. Il bullismo si configura quindi come una particolare forma di aggressività in cui la/il bulla/o manifesta consapevolezza e intenzionalità nei suoi comportamenti, cosa che manca del tutto a chi presenta un disturbo speci-
12. K. Crenshaw, Demarginalising the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine. Feminist Theory, and Anti-racist Politics, in H. Lutz, M.H. Vivar, L. Supik (eds.), Framing Intersectionality: Debates on A Multifaceted Concept in Gender Studies (pp. 25-42), Routledge, London 2011.
13. Yuval-Davis, Belonging and the Politics of Belonging cit.
14. S. Sharp, P.K. Smith, Tackling bullying in your school. A practical handbook for teachers, trad. it. di F. Pedrotti, Erickson, Trento 1995.
15. D. Olweus, Bullying at school: what we know and what we can do, trad. it. di M. Dema, Giunti, Firenze 1996.
16. Sharp, Smith, Tackling bullying in your school. A practical handbook for teachers cit.
fico di tipo patologico. Costituisce inoltre un fenomeno sociale per le sue tre accezioni: è un’attività che si dispiega in un teatro sociale e in un contesto pubblico; è spesso compiuta in gruppo; nasce dalle relazioni sociali al cui interno si dispiega e ha a che fare con la definizione da parte di ragazze e ragazzi della «propria collocazione nella società». La ricerca del proprio posto nel contesto sociale è infatti un compito di sviluppo fondamentale in adolescenza; nella rete relazionale si cercano gli strumenti concettuali e pratici per definire la propria posizione sociale e per negoziare la propria reputazione17.
Il bullismo, femminile e maschile, trova nel contesto scolastico il suo principale palcoscenico, essendo la scuola un luogo centrale della produzione di relazioni. Essa viene intesa dalle/dagli adolescenti come un teatro di socialità, e il bullismo, con le sue dinamiche, è capace di creare gerarchie di prestigio, successo, popolarità all’interno del gruppo.
Tra le caratteristiche cha accomunano il bullismo femminile e quello maschile troviamo il fatto che entrambi attaccano «le diversità percepite»: le persone che hanno delle disabilità, le minoranze culturali, chi viene percepito come omo-bisessuale, chi pratica un’altra religione. Tuttavia, le diversità percepite si possono ampliare moltissimo attraverso svariate micro-diversità che vengono definite in relazione a un canone di “bellezza” e di “adeguatezza” oltre che all’aderenza alle norme di genere stabilite dalla bulla o dal bullo. Una diversità percepita e bersagliata può essere ad esempio vestire fuori moda o troppo alla moda, avere l’acne in viso o viceversa una pelle bellissima, non amare il calcio quando i compagni lo adorano o preferire la lettura tra persone che la detestano.
Due bullismi differenti
Dopo aver attraversato, seppur velocemente, gli elementi che il bullismo femminile ha in comune con quello maschile, possiamo ora concentrarci sugli aspetti che li rendono irriducibili l’uno all’altro. In una prospettiva di genere è importante individuare alcune caratteristiche specifiche ai due bullismi, alla luce delle dinamiche di costruzione della femminilità da un lato18 e della mascolinità19 dall’altro.
17. N. Emler, S. Reicher, Adolescenti e devianza. La gestione collettiva della reputazione, trad. it. di A. Palmonari, il Mulino, Bologna 2000.
18. Burgio, La femminilità corretta. I copioni di genere nel bullismo femminile cit.; De Vita, Il lato oscuro delle relazioni tra donne cit.
19. Burgio, Adolescenza e violenza. Il bullismo omofobico come forma-zione alla maschilità cit.
Nel comprendere e interpretare il bullismo femminile può essere molto utile tenere presente come nella storia delle donne si è andata definendo, e ancora oggi si definisce, l’identità femminile, tra costruzione sociale e autodeterminazione delle donne20. Avendo presente questo contesto, è più eloquente e significativo quanto la letteratura ci dice sul bullismo femminile inteso come violenza indiretta e psicologica, difficile da percepire e da vedere poiché fondata su dinamiche “subdole”, sotterranee, su gesti di violenza e di aggressività che si sviluppano tra le pieghe delle relazioni femminili. Un tipo di aggressività che tende a fare dell’esclusione, dell’isolamento di una in relazione a un gruppo di pari e/o della maldicenza e della denigrazione di altre ragazze, i suoi tratti peculiari.
La specializzazione femminile nell’aggressione relazionale21 trova una sua ragion d’essere alla luce del fatto che storicamente le donne sono state escluse dalla dimensione pubblica e sociale per essere confinate nel privato e nella cura delle relazioni. Il territorio delle donne è quello dei rapporti, che sono dunque una “specializzazione femminile”, usati per esercitare sia la cura sia il potere e il controllo.
Grazie al grande lavoro della critica femminile e femminista degli ultimi cinquant’anni, è emerso quanto la cultura patriarcale abbia addestrato le bambine e le donne ad aderire al ruolo di soggetti deboli, a mostrarsi dolci, passive, accudenti, lasciando ben poco spazio all’espressione creativa degli aspetti aggressivi e delle pulsioni violente. Per le donne è stato più difficile esercitare altre parti, di segno opposto – l’altro lato del femminile, il lato oscuro.
La teorica e femminista americana Adrienne Rich nel 1979 intitolò uno dei suoi libri dedicato alla scrittura femminile On Lies, Secrets, and Silence22 (trad. it. Segreti silenzi e bugie. Il mondo comune delle donne). Questo titolo nomina alcuni aspetti tipici di una grammatica e di un lessico femminile, che rievoca quanto studiato sul bullismo femminile inteso come relazioni aggressive tra simili: relazioni che possono rivelarsi di grande complicità e alleanza oppure diventare violente e distruttive. Il testo affronta il tema delle donne che tra molti sforzi giungono alla scrittura intesa come capacità di nominarsi, di trovare una voce nello spazio pubblico in un contesto sociale che
20. A. Cavarero, F. Restaino, Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche, Bruno Mondadori, Milano 2002; M.M. Rivera Garretas, Nominare il mondo al femminile, trad. it. di E. Scaramuzza, Editori Riuniti, Roma 1988.
21. L. Occhini, Bullismo a scuola: conoscere il fenomeno per prepararsi ad intervenire, in «Educational reflective practices», 1, pp. 210-223, 2014.
22. A. Rich, Segreti silenzi e bugie. Il mondo comune delle donne, trad. it. di R. Mazzoni, La Tartaruga, Milano 1982.
rende loro la vita molto ardua. Nella difficoltà del loro procedere, le donne apprendono svariate strategie di sopravvivenza, oltre che una grammatica del “mondo comune femminile”, che presenta un lato luminoso e creativo e uno denso di ombre e di disfacimento.
La violenza indiretta e relazionale ha a che fare con questa grammatica, e con la non iscrizione nell’ordine simbolico del discorso di un negativo che possa dirsi anche al femminile senza essere demonizzato. Nella maggior parte delle ricerche emerge che i ragazzi sono più aggressivi delle ragazze, ma da studi recenti, focalizzati sulle differenze qualitative delle aggressioni, si è scoperto che le ragazze imparano metodi diversi per la risoluzione dei conflitti 23 .
Nel mondo comune delle donne troviamo la solidarietà e la sorellanza, la competizione e la distruttività. Il bullismo femminile mette allo scoperto il difficile itinerario che le ragazze devono percorrere per individuarsi come donne, nel continuum materno, nella tensione che comporta attraversare «la parte oscura delle relazioni femminili»24. La parziale invisibilità del bullismo femminile, così come dell’omosessualità femminile, ha proprio a che fare con gli spazi della relazione come spazi privilegiati (dalle donne) o obbligatori (per le donne). Sappiamo infatti che, pur prevedendo un pubblico, i gesti di bullismo vengono compiuti dalle ragazze nei luoghi più intimi o nascosti come i bagni, gli spogliatoi, i corridoi, oltre che nelle chat e sui cellulari. A questa invisibilità, ci dicono i dati ISTAT del 2019, corrisponde tuttavia una percentuale di vittimizzazione25 più alta per le ragazze (9,9%) rispetto ai ragazzi (8,5%). Questi dati confermano che per comprendere e studiare il bullismo femminile è necessario adoperare chiavi di lettura e strumenti che sappiano entrare nelle specificità delle relazioni tra ragazze e in particolare del loro lato oscuro26.
Margaret Atwood, nel suo romanzo Occhio di gatto27, racconta, tra le altre cose, del bullismo che la protagonista subisce dalla sua migliore amica. La dinamica ambivalente amica/nemica la ritroviamo di frequente nei casi di bullismo femminile, ed è una dinamica definita come “subdola” e “più cattiva” di quella tra ragazzi. Nel progetto abbiamo scommesso sulla possibilità che il lato oscuro del bullismo femminile possa essere contrastato dal suo lato lu-
23. K. Björkqvist, Sex differences in physical, verbal, and indirect aggression: A review of recent research, in «Journal of Research», 30(3-4), pp. 177-188, 1994.
24. De Vita, Il lato oscuro delle relazioni tra donne cit.
25. Per vittimizzazione si intende l’essere vittima, e il complesso delle conseguenze di natura fisica, psicologica, sociale ed economica che ne derivano.
26. De Vita, Il lato oscuro delle relazioni tra donne cit.
27. M. Atwood, Occhio di gatto, trad. it. di M. Papi, Mondadori, Milano 1990.
minoso: relazioni di sorellanza che rappresentino un fattore di protezione per le ragazze più giovani, vittime di bullismo nello stesso contesto scolastico.
Co-progettare azioni di contrasto dal basso con approccio
Student’s Voice
Nella realtà scolastica la/il ragazza/o vive la sua quotidianità, fa esperienze importanti di socializzazione, sperimenta diversi modi di interazione, apprende le regole dello stare insieme, accresce le abilità cognitive, emotive e relazionali. Ogni bambina/o, ragazza/o deve sentirsi sicuro e accolto a scuola; la scuola dovrebbe garantire un ambiente sicuro, dare sostegno emotivo e favorire esperienze di socializzazione in un ambiente dove le differenze convivono28. La scuola non è solo il luogo della socialità delle/dei ragazze/i, «ma è anche il luogo centrale di produzione di tale socialità»29; la scuola è intesa dalle/dagli adolescenti come “teatro” di socialità dove il bullismo, con le sue dinamiche crea una gerarchia di prestigio, successo, popolarità all’interno del gruppo30 e la scuola diviene in primis un luogo in cui si manifestano episodi di condotte aggressive31.
La scuola non è solo il luogo dove si socializza, ma è il luogo centrale di questa socialità, dove ragazzi e ragazze hanno la possibilità di relazionarsi con i coetanei, e dove le relazioni che si instaurano rappresentano, probabilmente, per la maggior parte dei/delle ragazzi/e, il più importante ambito di socializzazione, nel quale emergono dinamiche di bullismo, ancora oggi di difficile individuazione32 .
Per meglio comprendere il bullismo femminile e definire la dimensione quantitativa e qualitativa del bullismo femminile era necessario, come detto sopra, utilizzare uno sguardo di genere e intersezionale33, e anche poter ascoltare le voci delle persone direttamente interessate: le studenti. Per questa ragione ci è sembrato importante adottare un approccio Student’s Voice34 .
28. F. Batini, Bullismo: un quadro d’insieme, in Batini, Scierri (a cura di), In/sicurezza tra i banchi cit., pp. 11-55.
29. G. Burgio, (a cura di), Comprendere il bullismo femminile. Genere, dinamiche relazionali, rappresentazioni, Franco Angeli, Milano 2018, p. 35.
30. A. De Vita, Il bullismo femminile: alcuni pattern emergenti, in S. Polenghi, F. Cereda, P. Zini (a cura di), in «Atti del Convegno Nazionale Siped», La responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali (pp. 549-556), Pensa Multimedia, Lecce 2021.
31. Olweus, Bullying at school: what we know and what we can do cit.
32. Ivi.
33. De Vita, Burgio, Prospettive di genere nella vittimizzazione tra ragazze. La prima ricerca nazionale mixed method sul bullismo femminile in adolescenza cit.
34. V. Grion, A. Cook-Sather (a cura di), Student Voice. Prospettive internazionali e pratiche emergenti
Nei primi anni Novanta del Novecento, a partire dal lavoro di Jonathan Kozol35 il quale, nell’introduzione di Savage Inequalities, affermava che «la voce dei bambini […] è stata esclusa dall’intero dibattito sull’educazione e sulle riforme», alcuni ricercatori, educatori e critici, in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito, hanno messo in evidenza l’assenza della prospettiva dei ragazzi e delle ragazze nei discorsi che li riguardano e la necessità di prestare più attenzione alle loro esperienze, coinvolgendoli con un ruolo attivo, come consulenti esperti nelle ricerche educative, valorizzando le loro conoscenze e i loro interessi36.
Anche se ancora poco conosciuto in Italia, da circa vent’anni a livello internazionale si è diffuso un movimento pedagogico definito Student’s Voice. La sua prima comparsa si deve al lavoro di alcuni ricercatori, soprattutto in ambito anglofono, in particolare a due ricercatrici inglesi, Jean Rudduck 37 e Julia Flutter 38, le quali, attraverso une serie di ricerche, hanno rilevato quanto possa essere importante l’ascolto delle voci degli/delle studenti per migliorare le pratiche d’insegnamento e di apprendimento. Infatti, se si dà agli/alle studenti la possibilità di esprimere ciò che pensano della scuola e si favorisce lo sviluppo di un loro maggior senso di responsabilità come membri di una comunità d’apprendimento, si può arrivare a una nuova concezione del ruolo di ragazze e ragazzi: invece di vederli come dipendenti e incapaci, sono da valorizzare, ascoltare e rispettare39. La scelta di utilizzare l’approccio Student’s Voice è stata dettata dal riconoscimento dell’importanza delle voci degli/delle studenti nei processi educativi, come co-partecipanti di una comunità di apprendimento.
Adottare una prospettiva di genere e intersezionale che permetta di rendere visibile il bullismo femminile, coinvolgendo le ragazze in qualità di “esperte di bullismo femminile” non solo in quanto protagoniste e spettatrici, ma anche come co-ricercatrici, ci è sembrata la cosa più coerente e interessante da fare per incentivare azioni di prevenzione e contrasto peer-to-peer. in Italia, Guerini, Milano 2013; Grion, Dettori, Student Voice: nuove traiettorie nella ricerca educativa cit.
35. J. Kozol, Savage Inequalities: Children in America’s Schools, Broadway Paperbacks, New York 1991, p. 5.
36. Grion, Cook-Sather (a cura di), Student Voice. Prospettive internazionali e pratiche emergenti in Italia cit.
37. J. Rudduck, J. Flutter, How to improve your school, Bloomsbury Publishing, London 2004.
38. J. Flutter, Alla ricerca delle voci degli studenti: il viaggio di una ricercatrice, in V. Grion, A. CookSather (a cura di), Student Voice. Prospettive internazionali e pratiche emergenti in Italia, Guerini, Milano 2013, pp. 100-118.
39. Ivi.
QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 21, L.D.A.). ESCLUSO DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO.
SISTER
Contrastare il bullismo femminile con la sorellanza
La preoccupazione per il fenomeno del bullismo in adolescenza è diventata dilagante, sia nei contesti scolastici sia nel discorso pubblico. Un fenomeno antico di cui ora, tuttavia, abbiamo più consapevolezza e senso di responsabilità. Con il desiderio di accompagnare le comunità scolastiche – in particolare insegnanti, dirigenti e famiglie – nella difficile sfida di fronteggiare l’aggressività e la violenza tra ragazze, SISTER si sofferma sui modelli messi a punto nel tempo per prevenire e contrastare questi fenomeni, coinvolgendo le adolescenti e scommettendo sulla forza delle relazioni femminili che si esprime nella sorellanza. Il volume prende avvio dalla transizione identitaria propria dell’adolescenza, affrontando le specificità del bullismo femminile, qualitativamente differente da quello maschile, per passare ad analizzare i dati sul bullismo in Italia, anche attingendo ai risultati della ricerca nazionale “Il bullismo a scuola. Un’indagine intersezionale mixed-method” realizzata nelle città di Foggia, Arezzo, Perugia, Verona, Milano, Genova e Palermo. Il cuore del volume si concentra sui risultati della sperimentazione SISTER, un percorso di ricerca-formazione partecipata che ha coinvolto le studenti e le/gli insegnanti di due scuole secondarie di secondo grado a Verona nel biennio 2022-2023. Dalla narrazione dell’esperienza di percorsi di autoconsapevolezza emotiva e affettiva (16 Attitudini) e di rinforzo della capacità di agire e non solo di guardare (Teatro dell’Oppresso), emerge come a rendere efficaci le azioni di contrasto al bullismo sia proprio il coinvolgimento significativo delle vere “esperte” del bullismo femminile stesso: le ragazze. Perché oltre il bullismo femminile c’è la sorellanza.
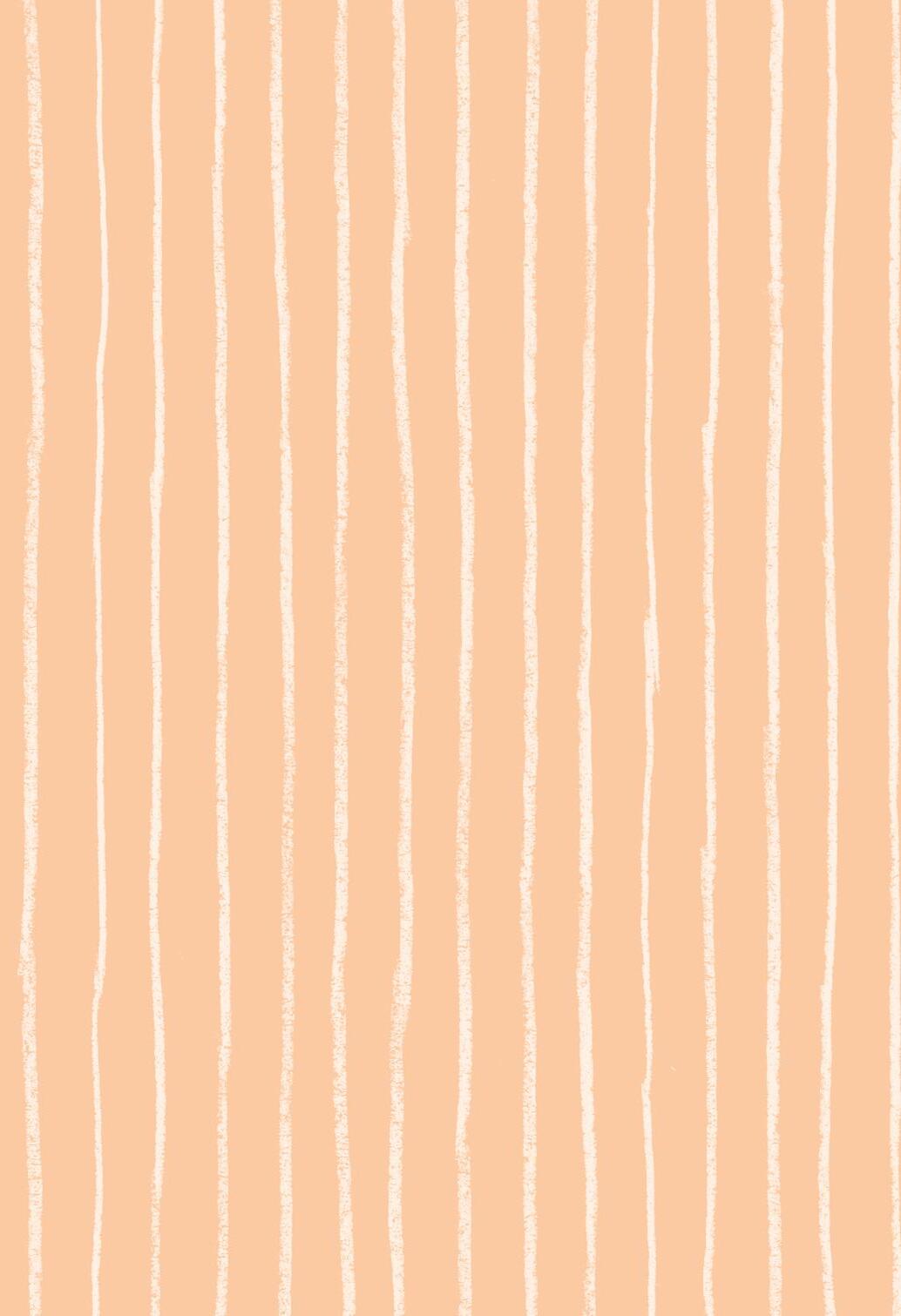
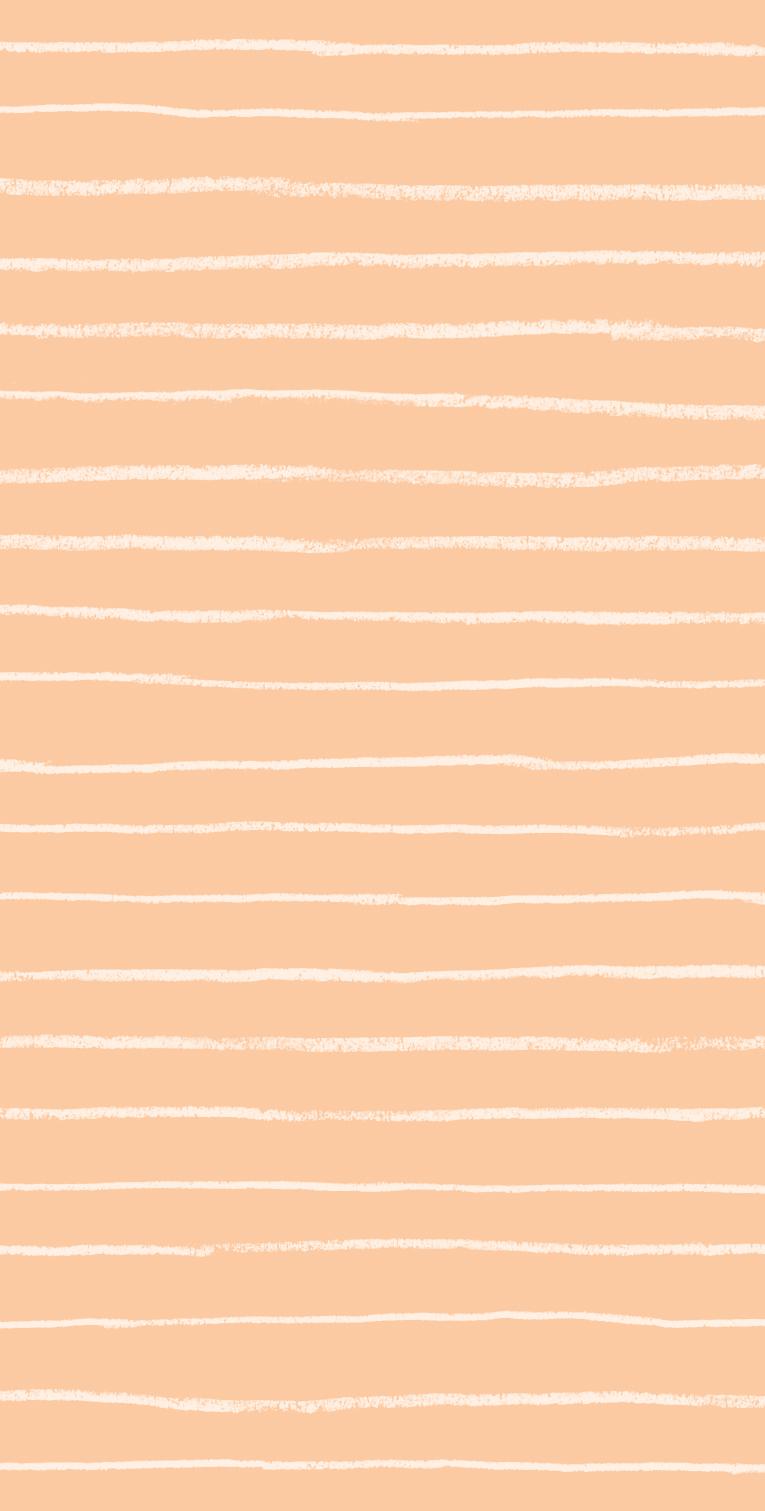
Antonia De Vita è Professora Associata di Pedagogia generale e sociale all’Università di Verona. Si occupa di educazione di genere, transizione ecosociale e processi di formazione e capacitazione in una prospettiva di pedagogia critica. Ha codiretto la ricerca nazionale sul bullismo femminile. Tra le sue ultime pubblicazioni: Ecopedagogia femminista. Prospettive di genere nella transizione ecosociale, FrancoAngeli 2024.
Francesco Vittori è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona in Pedagogia generale e sociale. Il suo lavoro di ricerca attraversa e intreccia la pedagogia critica e sociale, gli studi di genere e intersezionali, la formazione alla cittadinanza ecologica, le pratiche di consumo-produzione sostenibili, l’agroecologia come paradigma trasformativo e la digital education. Tra le sue ultime pubblicazioni: Agroecopedagogia. Prospettive educative e formative nei movimenti per la terra, Franco Angeli 2025.
€ 9,10