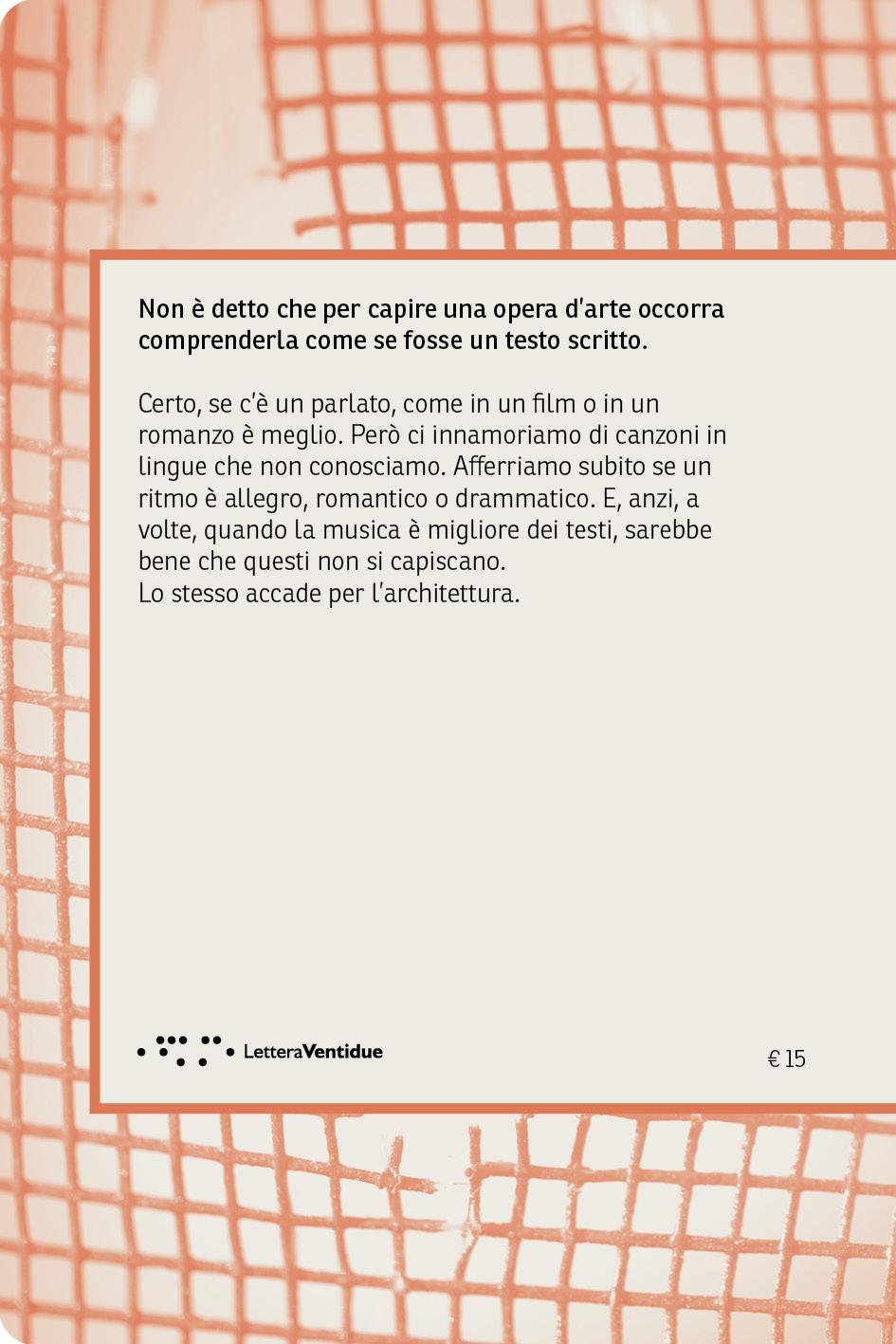Linguaggio
Non è detto che per capire una opera d’arte occorra comprenderla come se fosse un testo scritto. Certo, se c’è un parlato, come in un film o in un romanzo, è meglio. Però ci innamoriamo di canzoni in lingue che non conosciamo. Afferriamo subito se un ritmo è allegro, romantico o drammatico. E, anzi, a volte, quando la musica è migliore dei testi, sarebbe bene che questi non si capiscano. Amiamo la Callas anche se non la seguiamo parola per parola e la preferiamo ad altre interpreti tecnicamente più brave che scandivano meglio le frasi ma cantavano senza la sua espressività. Ugualmente, senza ricorrere alle parole, comprendiamo intuitivamente come funzionano gli utensili comuni. Capiamo subito che una sedia è una sedia e che un vaso del bagno è un vaso del bagno. E difatti li distinguiamo subito in caso di bisogno. Questo non accade con gli oggetti troppo disegnati. A volte, per esempio, facciamo fatica a capire come si accenda un elettrodomestico o si attivi la doccia, ma si tratta di eccezioni che derivano da un eccesso di astrazione di chi li ha progettati. Il pulsante non si vede, per esempio, perché l’oggetto deve avere una forma perfettamente geometrica, non disturbata da alcuna escrescenza.
Analisi funzionale
Se passiamo ora all’architettura, ci comportiamo bene o male come davanti a una sedia. Cerchiamo innanzitutto di capire come funziona l’edificio e se risponde a requisiti.
L’analisi funzionale è, infatti, una attività che facciamo spontaneamente e in via del tutto preliminare. Come lo si può utilizzare? Come risponde alle richieste che gli sono state fatte? Come è illuminato? Che esposizione ha? È flessibile? Quanta manutenzione richiede? Ci accorgiamo però che queste domande apparentemente semplici, in realtà sono insidiose. Prendiamo una piramide. Certamente risponde a uno scopo. Uno scopo, però, superato e, diciamolo pure, sbagliato: nessuno di noi oggi crederebbe seriamente che la piramide possa garantirci l’immortalità. Inoltre, se volessimo giudicare la piramide dal punto di vista delle risorse impegnate, la dovremmo considerare una follia. Così come dovremmo considerare negativamente la gran parte degli edifici realizzati prima del Movimento Moderno e, in particolare, del funzionalismo. La storia ce ne mostra numerosi, anche straordinariamente belli, che non rispondono affatto a criteri di funzionalità pratica, almeno nel senso che noi oggi attribuiamo alla parola. Valgano per tutte le opere di Antoni Gaudì.
Il cestino di Le Corbusier
Di buon funzionamento, se guardiamo l’architettura occidentale nel suo sviluppo storico, in un modo o nell’altro se ne parla almeno dai tempi di Marco Vitruvio Pollione (80-15 a.C.). Un personaggio importante, forse il più famoso teorico dell’architettura di tutti i tempi. Autore del trattato De architectura, che è stato il fondamento dell’architettura occidentale almeno fino alla fine del XIX secolo.
Vitruvio non usa la parola funzione. Parla di firmitas e utilitas. E aggiunge una terza qualità: la venustas. Oltre che solido e utile, l’edificio deve essere bello. E, in effetti, se osserviamo gli edifici romani di una certa importanza ci accorgiamo che firmitas, utilitas e venustas non sono esattamente la rispondenza alle funzioni che noi oggi cerchiamo negli edifici. Dentro il Pantheon, per esempio piove, e la sua utilitas è più da intendere in senso simbolico che performativo. Potremmo dire: il Pantheon svolge benissimo la sua funzione di essere il Pantheon che è anche quella di comunicarci un senso di solidità e, soprattutto, di bellezza. Insomma: una architettura è una architettura perché dietro c’è una idea estetica a tutto tondo che mette insieme più fattori. Non bastano da sole la solidità, l’utilità o la bellezza.
Su questo argomento anche Le Corbusier, 1900 anni dopo, era d’accordo. Per lui parlare di semplice funzione non aveva senso. E a chi non gli dava ragione mostrava il cestino delle cartacce fatto di fili di ferro che aveva sotto il tavolo. Se preso a calci, il cestino si deformava e diventava brutto, tuttavia, volendo, poteva continuare a svolgere la propria funzione di cestino ed ospitare lo stesso numero di cartacce di prima. Ma, aggiungeva, chi l’avrebbe mai voluto un cestino del genere? Segno che noi per riconoscere dignità di oggetto a un oggetto, andiamo oltre il semplice funzionamento. Cerchiamo una forma che bene rappresenti la funzione svolta. Insomma, qualcosa di molto vicino alla triade vitruviana in cui alla fimitas e alla utilitas aggiungiamo la venustas. Si può muovere una obiezione: chi l’ha detto che il nostro cestino debba avere una perfetta forma troncoconica o cilindrica come immaginiamo avesse il cestino di le Corbusier? Ipotizziamo che a deformarlo non sia un calcio dello svizzero francese ma sia chiamata Zaha Hadid. Probabilmente ne uscirebbe un cestino molto più interessante di quello amato dal purista Le Corbusier. E nessuno si sognerebbe di negare a tale oggetto la dignità di cestino. Solo per dire che, quando la venustas entra in gioco, le cose diventano complesse. A partire dal fatto che il cestino non potrebbe sembrarci (forse non a tutti, ma sicuramente ad alcuni) un cestino. Potrebbe per esempio essere interpretato come una scultura che noi adoperiamo anche per buttare le cartacce. E in effetti c’è un gustoso aneddoto secondo il quale lo scultore Claes Oldemburg − che lo ricordiamo
ha collaborato con Frank O. Gehry per la realizzazione del Chiat Day Building a Los Angeles, il cui ingresso ha forma di un gigantesco binocolo − affermava che la differenza tra una grande scultura e una architettura risiede nel fatto che solo all’interno di quest’ultima si trovano i servizi igienici. Nel caso del cestino della Hadid, in cui mancano i servizi igienici, diventa molto difficile capire se si tratti di un oggetto funzionale o di una scultura.
Duck e decorated shed
In che modo un edificio ci comunica che è adibito a un certo scopo? Una risposta ancora insuperata ce l’ha data Robert Venturi. Possiamo capire la sua funzione o perché ci sono delle scritte o dei segnali che me lo dicono o perché ha una forma tale da raccontarci subito cosa ospita. Cosa vuol dire: avere una forma tale da raccontarci cosa ospita? Prendiamo, dice Venturi, un chiosco che vende carne di anatra e che è fatto a forma di anatra. Se noi lo guardiamo, capiamo subito la sua funzione.
Chiamiamo la prima modalità decorated shed, e la seconda modalità duck.
Il decorated shed potrà essere un qualsiasi edificio generico, cioè senza alcuna particolare caratteristica formale, purché arricchito con alcuni elementi (scritte, simboli) che fanno capire la funzione svolta. Se un edificio è sormontato da una croce e c’è scritto chiesa, non avremo dubbi sulla sua destinazione, qualsiasi sia la forma dell’edificio. Oppure, più prosaicamente, pensate a quando siete all’aeroporto e cercate il bagno: sapete come individuare la porta giusta non perché sia diversa dalle altre ma grazie alla grafica stilizzata di una figura maschile o femminile, simbolo che universalmente vuol dire bagno per gli uomini o per le donne.
Denotare e connotare
Dicevamo che gli anni sessanta sono stati ossessionati dal problema del rapporto tra l’universo degli oggetti artificiali che produciamo, quindi anche l’architettura, e il linguaggio. Tra i personaggi che hanno scritto a proposito vi è il semiologo Umberto Eco che dal 1966 al 1969 insegna alla facoltà di architettura di Firenze e nel 1968 pubblica il libro La struttura assente nel quale, oltre a porsi il problema di una struttura semiologica unificata, pone quello più prosaico del modo in cui usiamo e interpretiamo il mondo degli oggetti che ci circonda e, in particolare, l’architettura.
Un buon oggetto − sostiene Eco − per essere tale denota chiaramente la propria funzione. Chiunque capisce immediatamente che una sedia è una sedia, una maniglia una maniglia e una tazza una tazza. E questo vincolo di comprensione delimita il limite della mia possibile creatività. Non posso, per esempio, pensare a una uscita di emergenza che non sia facilmente individuabile o a una casa di cui non si capisca il funzionamento.
Nello stesso tempo, ogni oggetto connota valori diversi. Un trono, per esempio, è una sedia ma non si riduce a svolgere una semplice funzione di sedia. Anzi
dalla sua intransigenza, dal suo carattere brusco e dal suo originale modo di insegnare.
Il 3 giugno dello stesso anno gli muore la madre.
Il fallimento della sua vocazione di insegnante e la depressione provocata dalla perdita della madre preoccupano la sorella di Wittgenstein, Margaret Stonborough, che in quel periodo aveva dato incarico a Paul Engelmann, discepolo di Adolf Loos, di costruirle una casa. Margaret decide così di coinvolgere il fratello nell’impresa edilizia, sfruttandone l’inclinazione per l’architettura.
Le modifiche che Wittgenstein apporta al progetto di Engelmann sono minime. L’impianto volumetrico rimane inalterato, se escludiamo il piccolo corpo aggiunto dell’ingresso e la zona retrostante; i prospetti sono modificati solo per ritocchi alle dimensioni delle finestre e alle loro posizioni reciproche; la divisione degli ambienti interni non è alterata, a meno di limitati spostamenti dei tramezzi.
Eppure Wittgenstein dedica alla casa energie immense e enorme attenzione.«Ludwig – ricorda la sorella Hermine – disegnò ogni finestra, ogni porta, ogni chiusura, ogni radiatore con esattezza, come se fossero strumenti di precisione, e nelle più nobili proporzioni, e poi riuscì a far accettare con la sua inflessibile energia che le cose fossero eseguite con uguale esattezza… Anche al particolare più invisibile fu dedicata la stessa attenzione che alle cose fondamentali, perché tutto era importante, tranne tempo e denaro».
Wijdenveld attribuisce l’attenzione esasperata di
Wittgenstein alle più minute questioni di dettaglio al gusto classico del filosofo: «la casa – sostiene- deve essere associata con le tendenze classiciste che ricorrono nella storia dell’architettura. Comune a queste è la morigeratezza nell’articolazione e l’ornamento, guidata da una regola assoluta della bellezza, in cui è di fondamentale importanza il sistema delle proporzioni». La tesi appare poco convincente: innanzitutto perché nell’opera di Wittgenstein non si riscontra l’applicazione di alcun sistema proporzionale preciso. Le proporzioni che hanno voluto trovare gli esegeti hanno approssimazioni del 5 e più per cento; sono quindi troppo imprecise per essere state fatte proprie da un eterno insoddisfatto che non esitò, a costruzione quasi ultimata, a demolire il solaio del soggiorno per una difformità di pochi centimetri. La tesi non convince inoltre perché Wittgenstein impiegò non poche delle sue energie per spezzare simmetrie (per es. eliminando una delle due nicchie della stanza della libreria), infrangere allineamenti (per es. ponendo fuori asse la bucatura della porta d’ingresso rispetto alle finestre sovrastanti), differenziare e disarticolare le parti (p. es. ideando finestre diverse per ogni facciata).
Per lui, inoltre, ogni concezione classica è troppo intrisa di valori connotativi, di riferimenti metafisici. Da qui, l’avversione del filosofo verso lo spazio tradizionale, carico di valori tattili, espressivi, simbolici e la predilezione per uno spazio neutro, trasparente, cioè tale da non interferire con i singoli oggetti che lo strutturano e con le persone che lo abitano «il mio ideale è una certa
della disciplina ma nello stesso tempo privare questo riferimento della propria temporalità? Da qui la scelta di realizzare edifici che si rifanno genericamente a forme del passato e quindi privi decorazioni e di richiami a precisi momenti storici. Quasi come fantasmi, impongono la loro presenza. Una presenza che però è, nonostante le intenzioni, carica di connotazioni. Anche il maggiordomo di Grassi, come quello di Wittgenstein, non riesce a rendersi trasparente.
E però è questa incondizionata apertura alla storia e chiusura a tutte le chiacchiere di una estetica sociologica di accatto che negli anni sessanta esercita un notevole fascino. Nasce il progetto dell’autonomia. Progetto che in un modo o nell’altro è fatto proprio da numerosi architetti che credono che il compito di un edificio sia essere solo sé stesso, qualunque cosa possa ciò significare (e, difatti, per ognuno significa qualcosa di diverso). Un atteggiamento che produce numerose opere significative. Alcune, come nel caso di Aldo Rossi si rifanno alla tradizione italiana, attingendo a piene mani al vocabolario formale semplificato che proviene dalla metafisica. Altre lavorano sulla sintassi del linguaggio, depurandolo dalla dimensione semiologica, cioè dai significati, per farlo diventare puro gioco combinatorio, come nel caso di Peter Eisenman.
Tre sono i motivi che, a mio avviso, determinano il fascino dell’autonomia. In primo luogo, il carattere severo e rigoroso che si contrappone ai pasticci formali di progettisti che troppe volte, nel nome della creatività, pensano di potersi vendere come artisti impegnati.
In secondo luogo, l’esaltazione del mestiere e della sua tradizione. Un buon architetto sa che le mode corrono più veloci dei problemi da risolvere e che la costruzione si deve confrontare con questi ultimi e non con le prime.
In terzo luogo, la sensazione di un avvicinarsi all’essenza dell’architettura. Dalla tradizione storica infatti sono riprese le forme depurate da ciò che viene giudicato inessenziale ed estemporaneo, per arrivare a ciò che si crede essere la pura soluzione del problema.
Ma è effettivamente la soluzione del problema? O si tratta semplicemente della pretesa di scoprire un’essenza che non esiste? Tanto più che l’architettura autonoma, più la si vuole rendere asciutta, severa, essenziale, più, come abbiamo visto, si carica di valori connotativi e ci sfugge.
Ma, forse, il fascino risiede proprio nel suo essere vaga e inafferrabile. Così sebbene abbia raggiunto il suo apice negli anni settanta e ottanta e sia stata messa da parte nel successivo periodo decostruttivista, l’idea dell’autonomia è tornata in tempi più recenti.
Penso per esempio al lavoro teorico di Pier Vittorio Aureli e alla proposta di un’architettura assoluta. Mentre recentemente è stata promossa da Valerio Olgiati e Markus Breitschmid con il nome di Architettura nonreferenziale (cfr. il libro del 2019).
Quest’ultima non ha velleità di raccontare e/o rappresentare il mondo a lei esterno, evita le forme appariscenti dello star-system per concentrarsi su ciò che la caratterizza da sempre, cioè lo spazio. Sembrerebbe