ODiSSEA Omero
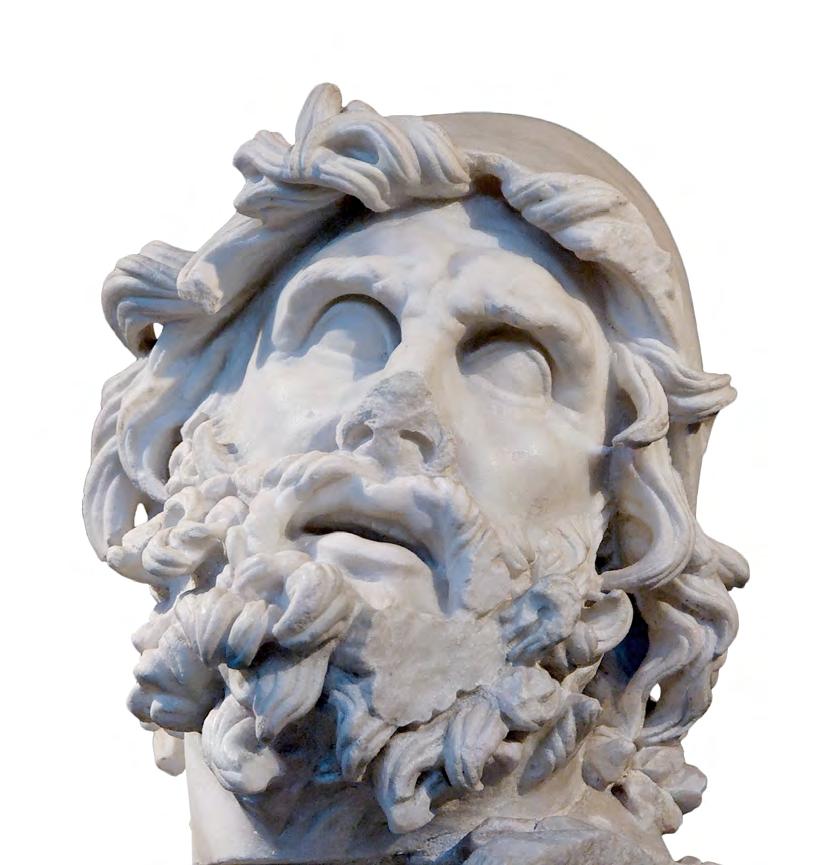
e
Questo libro appartiene a ____________________________________
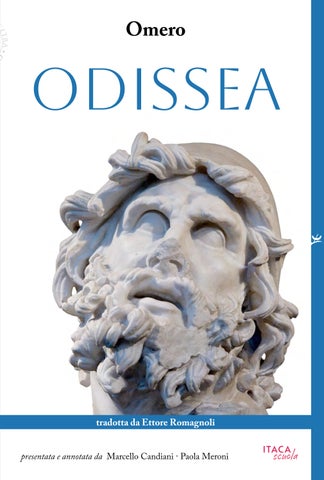
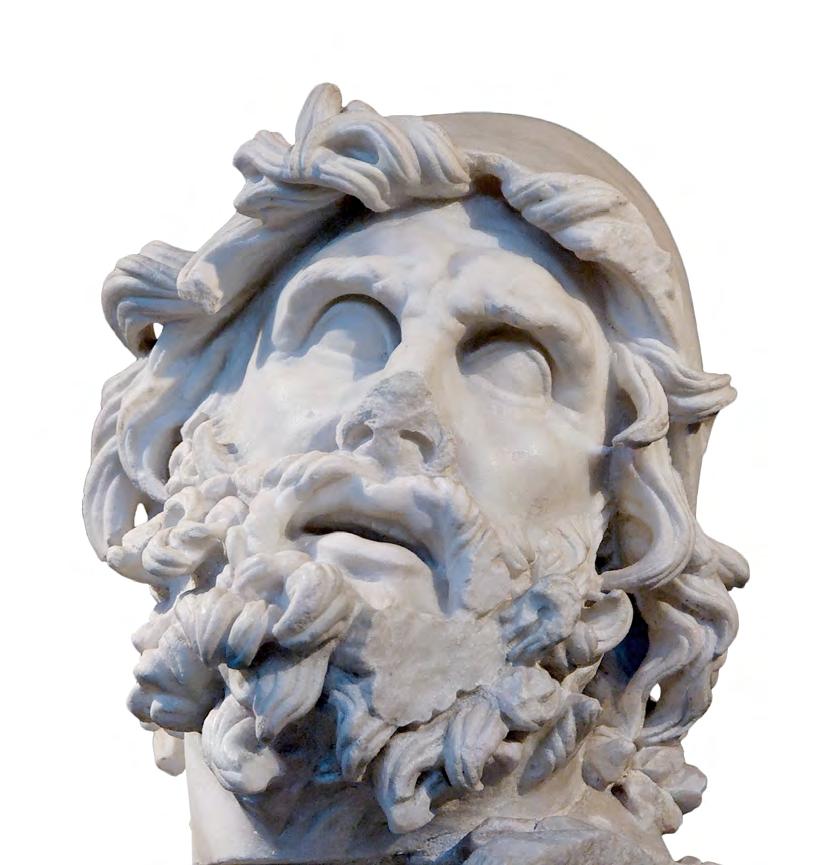
e
Questo libro appartiene a ____________________________________
tradotta da Ettore Romagnoli
presentata e annotata da Marcello Candiani Paola Meroni
Pubblicare è dare alla luce.
Desideriamo mettere in luce parole che accompagnino le persone nella vita.
Questa è la responsabilità che abbiamo come editori. Libri compagni di viaggio.
Nella collana La Cetra Omero
Iliade tradotta da Vincenzo Monti a cura di Raffaela Paggi, Francesco Francia, Daniele Ferrari
Omero
Odissea www.itacaedizioni.it/odissea
Prima edizione: maggio 2010
Sesta ristampa: maggio 2025
© 2010 Itaca srl, Castel Bolognese Tutti i diritti riservati
ISBN 978-88-526-0222-1
Progetto grafico: Andrea Cimatti
Cura editoriale: Cristina Zoli
Stampato in Italia da Modulgrafica Forlivese, Forlì (FC)
Col nostro lavoro cerchiamo di rispettare l’ambiente in tutte le fasi di realizzazione, dalla produzione alla distribuzione. Utilizziamo inchiostri vegetali senza componenti derivati dal petrolio e stampiamo esclusivamente in Italia con fornitori di fiducia, riducendo così le distanze di trasporto.
In copertina
Testa di Ulisse, dal gruppo scultoreo dell’accecamento di Polifemo Marmo, II secolo a.C.
Sperlonga, Museo Archeologico Nazionale
Seguici su www.itacalibri.it www.itacaedizioni.it www.itacascuola.it Itacalibri Itacalibri
Presso la tavola di Alcinoo, sontuosamente imbandita, sedevano i principi dell’isola dei Feaci, i primi, i più importanti, i più ricchi signori che potessero ambire alla compagnia del sovrano. Alcuni servi recavano enormi spiedi su cui la carne aveva appena finito di arrostire; canestri di frutta di ogni tipo e stagione ingombravano la mensa. Dietro ai primi servitori, altri portavano vino pregiato e lo versavano a ciascuno in ampi calici. I commensali si erano riuniti per accogliere Ulisse, ospite misterioso che non si era ancora presentato, e per udire la sua storia. Ma l’ospitalità è un rito singolare, ha un proprio spazio e propri tempi. L’ospite è sacro. La fretta è bandita.
Per incantare i propri invitati, il re Alcinoo mandò a chiamare un aedo, Demodoco. Dopo pochi attimi questi varcò la soglia del palazzo regale con passo lento e incerto. Le pareti della sala irradiavano la loro luce dorata in ogni direzione, ma il vecchio aedo non poté avvedersene, poiché cieco. È questa la triste condizione cui molto spesso gli aedi, i cantori delle gesta eroiche, dovettero soggiacere: gli dèi donarono loro al tempo stesso un bene e un male, privandoli della vista per spalancare loro l’occhio della mente, così da poter cantare sotto ispirazione divina eventi cui tuttavia essi non presero parte direttamente.
Demodoco venne fatto accomodare tra i commensali e poté unirsi al banchetto. Un servitore sollevò il braccio del vecchio per insegnargli il gesto che egli avrebbe dovuto in seguito ripetere da solo, quando avesse desiderato staccare la cetra dal muro e intraprendere il proprio canto. Quest’ultimo non si lasciò pregare molto: si alzò da tavola, impugnò la cetra e iniziò a cantare.
Che significato aveva tale canto presso gli uomini greci? Si trattava di semplice intrattenimento? No. In un’epoca in cui non esistevano libri e non vi era ancora la lettura, la poesia epica, tramandata oralmente, aveva un valore anzitutto formativo. In essa erano depositati valori e saperi da trasmettere e insegnare. Essa era al tempo stesso libro sacro, storia nazionale, manuale didattico. Il banchetto in onore di un ospite, i festeggiamenti per una vittoria sportiva, se abbracciati dal suono della cetra, con la quale sempre l’aedo accompagnava la propria voce, diventavano in un attimo l’occasione per la trasmissione di un sapere tradizionale, un momento educativo.
Demodoco intraprese il canto della guerra di Troia. Esistevano certamente diversi cicli epici, ma, per tutti gli uomini, la parola “epica” significava e significa
tuttora anzitutto Iliade. Quest’opera racconta un mondo intero e non già l’avventura di un singolo personaggio. L’ira di Apollo insegna il timore per gli dèi, i capricci di Era la loro imprevedibilità; il valore di Achille addita a tutti quello del guerriero, il suo destino allude all’inesorabilità del Fato; fiumi, mari, venti, monti, suggeriscono all’uomo greco una presenza divina e l’Iliade ce li mostra personificati; Enea combatte sul corpo di un amico morto, mostrando il valore irriducibile dell’uomo; Ettore incarna il sacrificio eroico per la patria, dietro cui si cela l’amore più vero e responsabile per la donna; la realizzazione dello scudo di Achille da parte di Efesto è un manuale di istruzioni per tutti i fabbri, le scene in esso raffigurate insegnano l’alternarsi delle stagioni e delle coltivazioni; in ogni periodo della splendente civiltà greca, ripensa all’Iliade l’uomo che deve celebrare un sacrificio, partecipare a una competizione atletica, impugnare un’arma, pescare in un fiume o arare un campo. Tanto vasto era dunque il compito affidato dalla società greca alla poesia epica, e di conseguenza tanto fondamentale era il ruolo degli aedi, incaricati della sua diffusione. Questi viaggiavano per tutta la Grecia e, ovunque fosse loro richiesto, recitavano a memoria singoli episodi, modellando la voce al suono delle corde musicali, scegliendo i versi più opportuni, più legati alla circostanza in cui di volta in volta si trovavano. L’Iliade era dunque conosciuta in tale modo, come somma di episodi, i quali andavano a formare un universo completo ancor più che la storia di un personaggio. Terminato il proprio compito, Demodoco posò la cetra e tornò a sedersi tra i commensali. Si alzò allora Ulisse e raccontò ai Feaci il proprio viaggio, durante il quale molte disavventure lo avevano sempre più allontanato dalla patria che egli aveva cercato di raggiungere con tutte le proprie forze. La sua narrazione non durò che due o tre ore, durante le quali, tuttavia, avvenne un passaggio epocale. Non fu un’esplosione tonante, ma piuttosto un mutamento discreto. Eppure al termine del suo racconto certamente qualcuno degli invitati se ne avvide: la cetra era rimasta appesa al muro. Per tutto quel tempo le parole dell’eroe avevano risuonato nell’aurea sala senza che alcuno strumento le sostenesse. La parola divenne musica e, nel contempo, crebbe di significato.
L’alternarsi di Demodoco e Ulisse, narrato nel libro VIII dell’Odissea, è un simbolo che sintetizza efficacemente quale novità introdusse quest’opera. Pur rimanendo, per molti aspetti, simile all’Iliade, conservandone anzitutto il ruolo di opera depositaria di un immenso patrimonio culturale, l’Odissea celebra il passaggio alla narrazione, al racconto.
Quando si pensa a Demodoco oppure allo stesso Omero come cantori che si esibivano a corte, non bisogna pensare, infatti, che l’Odissea sia nata come un’opera improvvisata o come un accostamento di miti e di storie avventurose già esistenti. Il poeta dell’Odissea è molto più accorto di quanto possiamo immaginare; lo dimostra la struttura stessa dell’opera, di per sé già dichiarata nel proemio. Nei primi versi, infatti, Omero, chiedendo l’ispirazione alla Musa, dichiara che il protagonista dell’opera è un uomo, Ulisse (dal cui nome greco, Odisseo, deriva appunto il nome Odissea), costretto a vagare per dieci anni dopo aver riportato la
vittoria combattendo con l’esercito acheo nella guerra di Troia. Partito di là con molti compagni, approderà in patria da solo, perché anche gli ultimi di essi troveranno la morte a causa della propria stoltezza, per aver divorato i buoi sacri al Sole, trasgredendo così un comando divino. La trama, per come appare nel proemio, è dunque lineare: l’Odissea vuole essere la storia di un uomo, in particolare del suo ritorno da Troia (con tutti gli ostacoli che questo comporta) e del suo rientro a casa, dove da anni lo aspettano la moglie Penelope e il figlio Telemaco.
Tuttavia il modo in cui vengono presentati questi avvenimenti non è altrettanto lineare: l’ascoltatore (o il lettore) dell’Odissea non segue le avventure del protagonista in ordine cronologico, da quando salpa da Troia fino al completo reinserimento nella vita familiare a Itaca; il narratore, raccontando la storia, gioca con gli eventi, anticipandone alcuni nella narrazione, posticipandone altri. Quando il poeta attacca il proemio, solo quaranta giorni separano Ulisse da Itaca, eppure, leggendo l’opera, sapremmo ricostruire non solo gli avvenimenti di quel periodo, ma anche quelli dei dieci anni precedenti.
La novità dell’Odissea rispetto all’Iliade è proprio questa: il narratore è in grado di gestire la storia con un sapiente intreccio. L’Odissea non è solo il risultato di una serie di miti o racconti giustapposti, ma vuole essere un’opera unitaria. Questo è dovuto alla ormai maturata consapevolezza del mestiere di cantore epico, ma anche all’oggetto della narrazione: la storia, cioè, di un uomo, nel cui vissuto presente si intrecciano i ricordi e i racconti di un passato più o meno recente.
Omero cede più volte il ruolo di narratore ad altri personaggi: innanzitutto a Ulisse, quando egli alla corte dei Feaci racconta del proprio viaggio fino al momento presente; a Demodoco, quando egli canta della caduta di Troia; oppure ancora a Ulisse, quando, approdato a Itaca, pur di non farsi riconoscere, inventa storie false, ma verosimili, sulle proprie origini cretesi. Tanto il vissuto del personaggio Ulisse è vario, tanto il narratore – di volta in volta diverso – è costretto a esplorare differenti modalità narrative, facendosi così quasi precursore di diversi generi letterari: quando Ulisse racconta del proprio ritorno alla corte dei Feaci, il suo non è solo un racconto di avventure; egli intreccia il filone dei racconti fantastici (Circe, Polifemo, Lotofagi…) e della geografia di luoghi meravigliosi con quello storico del ritorno da una guerra realmente accaduta. Non solo: se i primi libri dell’opera in cui Telemaco si muove alla ricerca del padre assomigliano più a un moderno “romanzo della crescita” che a un’opera epica, gli ultimi anticipano quello che oggi chiameremmo il genere poliziesco: Ulisse, infatti, una volta giunto a Itaca, con estrema prudenza decide di non svelare la propria identità a chi già lo conosceva, se non dopo aver indagato la fedeltà di ciascuno. Il libro V invece dedica una parte consistente dei propri versi alla costruzione della zattera con cui Ulisse arriva all’isola dei Feaci e raccoglie in questo modo tutto il sapere tecnico dell’epoca riguardo all’arte del navigare, costituendo un piccolo esempio di letteratura didascalica, compito cui la poesia omerica mai rinuncia del tutto. Se quindi la grande novità dell’Odissea, che la rende un’opera più matura rispetto all’Iliade, è la sapiente narrazione, resta comunque il patrimonio di un
sapere comune, dal quale Omero attinge instancabilmente. Tutta la cultura greca antica viene compresa nella vita di un uomo, Ulisse. L’Odissea, che ancor oggi ci accingiamo a leggere con vivo interesse, è portatrice di questo sapere.
Alcuni studiosi moderni ritengono che dietro la figura del cantore Demodoco possa celarsi in realtà Omero: l’aedo dei Feaci era infatti cieco, ma gli dèi avevano voluto compensare questa mancanza fisica con una capacità eccezionale, quella di saper cantare in maniera mirabile le gesta epiche degli eroi greci. Così anche Omero, sul quale si mescolano notizie storiche e leggende, era probabilmente un cantore, cieco, che girava nelle corti antiche e si esibiva nel canto, accompagnato dalla propria cetra. Il poeta visse probabilmente tra il IX e l’VIII secolo prima di Cristo; sebbene molte città antiche ne vantassero i natali, la sua esistenza deve essere collocata ad ogni modo in una città dell’Asia Minore, a quei tempi fiorente colonia greca (forse Chio o Smirne).
Omero si esibiva oralmente, recitando a memoria alcuni versi, a seconda delle richieste e delle preferenze del proprio uditorio. Solo alcuni secoli dopo (forse nel V a.C.) venne messa per iscritto l’Odissea, in una redazione non molto distante da quella che leggiamo noi oggi.
Omero, così come Demodoco nel corso dell’Odissea, era un cantore di professione: non solo aveva una specifica competenza tecnica che gli permetteva di accompagnare il canto della propria voce col suono di uno strumento, ma aveva la chiara consapevolezza del fatto che la propria esibizione non fosse uno sfogo improvvisato, ma il più alto fenomeno artistico allora conosciuto. La più importante manifestazione a livello artistico e sociale era costituita infatti dal canto epico, che radunava attorno a sé i personaggi nobili delle corti in occasioni rinomate, come feste o banchetti.
Omero non inventava il contenuto del proprio canto, ma lo derivava da tutto quel patrimonio di sapere e di miti che nei secoli precedenti si era formato nella coscienza dell’uomo greco; l’originalità del suo canto, perciò, non sta – come noi ci aspetteremmo – nella novità dei contenuti, che erano per lo più noti; la grandezza di Omero sta invece nell’aver saputo custodire la memoria di un passato storico, di un sapere religioso, di una cultura che ha reso grande e rende tuttora interessante per noi l’uomo greco.
La traduzione
L’Odissea è stata scritta in greco antico in versi chiamati esametri. L’esametro era il verso col quale venivano scritte le composizioni più solenni, perché era particolarmente lungo e conferiva alla poesia un ritmo lento e regolare. Era perciò il verso
più adatto per la narrazione di gesta epiche, tanto che anche i Romani, diversi secoli dopo Omero, continuarono a farne uso per le celebrazioni più solenni. Il ritmo del singolo verso era basato su un certo numero di sillabe (mai meno di 13 e mai più di 18) e sulla costante presenza di una pausa al suo interno.
Ettore Romagnoli (Roma, 1871-1938), cimentandosi nella traduzione dell’opera, cercò di restituire alla versione italiana quella musicalità e quel ritmo che erano propri dell’originaria poesia greca. Docente di lingua e di letteratura greca all’università di Catania e poi in altri prestigiosi atenei italiani, volle conservare anche nella versione italiana dell’opera le caratteristiche formali dell’esametro greco. Nella sua traduzione viene infatti mantenuto costante il numero di sillabe e si ricrea la presenza di una pausa all’interno del verso italiano. La poesia di Romagnoli propone una sintassi semplice, ma un lessico elevato, in un modo che risulta molto fedele all’originale greco, e allo stesso tempo ben accessibile ai lettori italiani.
Questo testo nasce in continuità con una precedente iniziativa editoriale, l’Iliade (Omero, Iliade, traduzione di Vincenzo Monti, a cura di R. Paggi, F. Francia, D. Ferrari, Itaca, Castel Bolognese 2004), e da questa ha pertanto ereditato l’idea di garantire l’integralità della trama, suddividendo i ventiquattro libri dell’opera in ulteriori paragrafi, molti dei quali sono stati riportati in versi, alcuni riassunti in prosa. Sempre dal già citato volume è stato sostanzialmente mutuato un apparato didattico che facilita la lettura del testo senza mai sostituirsi a esso in modo invasivo, suggerendo invece l’immedesimazione del lettore nei personaggi e negli avvenimenti.
Le introduzioni
I ventiquattro libri in cui tradizionalmente è divisa l’opera sono stati raggruppati in quattro sezioni narrative, a ciascuna delle quali è stata premessa un’introduzione. L’introduzione intende presentare brevemente la trama dei libri contenuti nella sezione, mettendo in evidenza i nuclei tematici prevalenti.
Le note
Il testo è stato dotato di un apparato di note a piè di pagina cui sono affidati differenti compiti, sebbene tutti sostanzialmente miranti alla fruibilità e godibilità del testo.
Vi sono anzitutto note che forniscono la costruzione in prosa del testo poetico nei punti di maggior difficoltà, chiarendo i costrutti sintattici presenti. Questo genere di note non è preponderante, in quanto si è supposta nel lettore la precedente acquisizione di una discreta familiarità con la lingua poetica e con la sua particolare costruzione. Il testo di Romagnoli, del resto, presenta minori difficoltà
rispetto a quello dell’Iliade del Monti, sul quale peraltro numerose generazioni di studenti si sono formate, e fornisce così la possibilità di affidarlo senza problemi alla lettura individuale.
A sostegno di queste note ve ne sono altre di carattere lessicale, essenziali per guidare la comprensione del testo. Più semplici nella sua struttura sintattica, i versi di Romagnoli non rinunciano a un lessico ampio ed elevato, il quale talvolta necessita di essere parafrasato per poter diventare accessibile al giovane lettore. Queste note, pertanto, forniscono la spiegazione di lessemi o locuzioni attraverso sinonimi, perifrasi e, ove possibile, etimologie. Nella compilazione di questo genere di note, in particolare, è stata nostra cura mostrare i rapporti esistenti tra certe parole desuete e altri vocaboli di uso tutt’oggi comune, suggerendo la ricostruzione del significato delle prime a partire da quello dei secondi.
Alcune note evidenziano la presenza nel testo di figure retoriche o di particolari costruzioni linguistiche, la ricorrenza delle quali è stata segnalata tramite la sottolineatura in nota del loro nome (________), cui si accompagna una loro spiegazione.
La quarta tipologia di note è quella che ha ricevuto maggior spazio, ovvero quella concernente le note di approfondimento. Gli approfondimenti vanno nella direzione di una ricostruzione del contesto storico, geografico, sociale e culturale della Grecia antica, madre di Omero e culla della società e del pensiero occidentale, oppure in quella di una conoscenza dettagliata della mitologia. Tali note sono state segnalate con un simbolo apposito che le introduce ().
Le carte storico-geografiche
Il primo strumento didattico riportato in appendice è costituito da alcune carte storico-geografiche, indispensabili per favorire il processo d’immedesimazione durante la lettura e per assecondare ogni incipiente curiosità storica. Tra esse figurano: le ricostruzioni geografiche della Grecia antica e dell’Asia minore e della Magna Grecia, con particolare attenzione all’individuazione delle principali città e regioni in cui il territorio era suddiviso; la ricostruzione del mondo conosciuto secondo la tradizione greca; la carta del viaggio di Ulisse attraverso il Mediterraneo; la mappa dell’isola di Itaca.
Le cronologie
Per favorire la comprensione del testo e la sua ripresa, abbiamo voluto ricostruire la cronologia dello svolgersi dell’azione narrata nel libro giorno dopo giorno e la cronologia del ritorno di Ulisse da Troia, secondo quanto l’eroe stesso riferisce nel suo racconto ai Feaci.
L’indice dei nomi e dei luoghi
Infine, a completamento delle note, è stato creato in appendice un indice dei nomi e dei luoghi citati che si incontrano nel corso della lettura. Tali nomi sono brevemente spiegati in nota nel punto del libro in cui ricorrono per la prima volta,
ma sono stati poi ripresi e approfonditi ulteriormente tramite questo strumento di facile consultazione, utile soprattutto nel prosieguo della lettura, quando personaggi e luoghi già incontrati potrebbero non essere più immediatamente noti alla memoria del lettore.
In concomitanza con l’uscita del presente volume è stata aggiornata la guida per l’insegnante che si accompagna all’Iliade. Essa, nuovamente concepita come strumento unitario per entrambi i testi, attraverso alcune pagine critiche sul poema e sul mondo omerico fornisce le ragioni della valenza culturale e formativa di Iliade e Odissea e offre suggerimenti e percorsi didattici per ciascuno dei due testi.
L’Odissea è il racconto di Ulisse, eppure il suo protagonista tarda a entrare in scena. I primi quattro libri, infatti, sono dedicati al figlio dell’eroe, Telemaco, e per questo sono noti con il nome di Telemachia. In essi si assiste alla crescita di Telemaco, il quale inizia ad assumersi grosse responsabilità, a prendere decisioni, ad affrontare lunghi viaggi. L’improvviso mutamento del ragazzo è spettacolo agli occhi di tutti, che, lieti o contrariati che siano, ne osservano la risolutezza e l’ardire.
La biologia ci insegna con facilità che dai nostri genitori, o più genericamente dai nostri avi, noi tutti ereditiamo i tratti somatici, i quali vengono ricomposti in noi in modo unico e singolare. Vi è però un altro caso che oltrepassa le leggi della genetica, ed è piuttosto legato alla quotidiana convivenza. Crescendo accanto ai nostri genitori, o, ancor più, solamente nascendo da essi, infatti, assumiamo anche tratti del loro temperamento e della loro personalità che comunichiamo attraverso particolari minimi, discretissimi, ma assai espressivi, quali il modo di sorridere, di alzare la voce, o semplicemente di guardare. Telemaco stesso non si sottrae a questa legge. Viaggiando per la Grecia, egli vive un’avventura entusiasmante e personalissima, nella quale tuttavia reca con sé anche l’ombra del padre, che egli ricorda in ogni suo passo: se ne accorge Nestore sentendolo parlare; a Menelao, addirittura, basta osservare solamente il modo in cui il giovane reclina il capo. Ogni mossa del giovane gli è propria, gli appartiene, ma al tempo stesso parla del padre. In questo modo Omero dà voce a Ulisse sin dai primi versi dell’Odissea, pur nascondendolo abilmente ai nostri occhi.
Vi è poi un secondo aspetto per il quale la presenza di Ulisse pervade l’intera opera sin dalle sue prime mosse, ed esso è, paradossalmente, la sua assenza. L’eroe manca da Itaca da molti anni e, seppur disperati e disillusi, tutti quanti ne lamentano l’assenza: Penelope resiste alle lusinghe dei pretendenti in attesa del marito; Telemaco piange la mancanza del padre e, esortato da Minerva, corre a domandarne notizia; Menelao rimpiange l’amico disperso prima ancora di riconoscerne il figlio; gli dèi stessi in cielo si preoccupano della sorte di Ulisse. Il ricordo insistito della sua assenza, vero motore di questa prima sezione, alimenta così l’attesa della sua comparsa, per la quale Omero attende con pazienza e notevole abilità narrativa il libro V.
Libro i – Riunitisi a concilio, gli dèi decidono che è giunto il momento in cui Ulisse possa tornare a casa dopo un errare lungo quasi dieci anni. Minerva in particolare intercede per l’eroe, del quale solo Poseidone, dio del mare, non
vorrebbe vedere la salvezza. Ermete, dunque, messaggero degli dèi, andrà sull’isola di Ogigia, dove ingiungerà a Calipso la ripartenza di Ulisse. Minerva, nel frattempo, si reca a Itaca. Qui trova il giovane Telemaco, il quale, rassegnato alla scomparsa del padre, non ha né la forza né la volontà necessarie per scacciare i Proci, giovani pretendenti alla mano della madre, Penelope, i quali gozzovigliano e banchettano con le ricchezze di Ulisse. La dea, assunte le sembianze di un principe straniero, sprona il ragazzo e gli consiglia di compiere un viaggio in cerca di notizie del padre. Infonde poi coraggio nell’animo di Telemaco, tanto che questi inizia a rispondere colpo su colpo ai Proci, meditando la loro rovina.
Libro ii – Deciso a seguire i consigli di Minerva, il mattino seguente Telemaco convoca l’assemblea degli Itacesi e lì denuncia pubblicamente i soprusi dei pretendenti, annunciando la propria intenzione di compiere un viaggio. I Proci tentano di giustificare il loro atteggiamento, accusando piuttosto Penelope di essere ambigua e ingannevole. Tuttavia Giove mostra chiaramente il proprio volere, inviando un prodigio favorevole a Telemaco.
Terminata l’assemblea, il giovane si ritira a palazzo, dove chiede alla serva Euriclea di preparargli le provviste per poter partire in quella stessa notte, raccomandando inoltre alla vecchia nutrice di non rivelare alcunché alla madre Penelope, la quale ha già molte pene in cuore. Quando tutto è pronto, Telemaco salpa da Itaca alla volta di Pilo.
Libro iii – Telemaco sbarca a Pilo e sulla spiaggia incontra il vecchio Nestore, signore dell’isola, intento a celebrare un sacrificio al dio Poseidone. Accolto dall’anziano sovrano, Telemaco si presenta e chiede informazioni sul padre a Nestore, il quale ha combattuto a Troia con Ulisse ed è famoso per la sua saggezza. Nestore, tuttavia, non può essere molto utile al ragazzo: l’ultima volta che ha visto Ulisse, infatti, è stata alla partenza da Troia, ma i due eroi hanno viaggiato su navi differenti, partendo in momenti diversi e seguendo ciascuno rotte proprie. La delusione di Telemaco è subito abbracciata da Minerva, la quale sta accompagnando il giovane, avendo assunto l’aspetto di Mentore, vecchio amico del padre: in quest’occasione, infatti, la dea rivela la propria presenza trasformandosi in un’aquila.
Il giorno successivo, dopo aver compiuto nuovi sacrifici agli dèi, Nestore fornisce a Telemaco dei cavalli per raggiungere Sparta. Il giovane figlio di Ulisse parte, accompagnato da Pisistrato, suo coetaneo e figlio di Nestore.
Libro iV – Giunti a Sparta, i due giovani si recano al palazzo di Menelao, dal cui splendore rimangono abbagliati. Qui sono accolti dal sovrano e da Elena, sua consorte. Telemaco non si è ancora presentato e già Menelao, raccontando la propria storia, ha modo di lodare suo padre Ulisse. Le lacrime del ragazzo tradiscono la sua identità e lo costringono a presentarsi. Alla richiesta di informazioni
di Telemaco, Menelao risponde raccontando un altro episodio del proprio ritorno da Troia. Durante la sua permanenza in Egitto, infatti, l’eroe greco aveva costretto il dio marino Proteo a rivelargli il suo destino e quello di alcuni altri eroi greci, tra cui Ulisse, il quale da anni si trova sull’isola di Ogigia, trattenuto dalla ninfa Calipso. In questo modo Telemaco scopre che il padre, seppur disperso, vive ancora.
Intanto a Itaca i Proci vengono a conoscenza del viaggio di Telemaco. Colpiti e spaventati dalla determinazione del giovane, iniziano a temere per la propria sorte e gli preparano un agguato al suo ritorno. Un araldo, Medonte, informa la madre Penelope delle intenzioni dei Proci, causandole così nuove preoccupazioni. La donna è però rassicurata da Minerva, che le appare in sogno avendo assunto le sembianze di Iftime, sua sorella.
Proemio
Narrami l’uomo d’ingegno molteplice, o Musa, che tanto errò, poi che distrusse la rocca di Troia divina, vide molte città, di molti uomini l’indole1 seppe, e assai patì pel mare, cercando com’egli e i compagni
5 salva potesser la vita serbare,2 e tornare alla patria.
Ma non però i compagni salvò, per quanto bramoso, anzi perirono essi per loro propria nequizia,3 folli! Vorarono i bovi del Sol ch’alto valica;4 e il Nume contese ad essi il dì del ritorno. O Dea, figlia di Giove, 10 donde che sia movendo,5 tu narra anche a me questi eventi.
Già tutti quelli che aveano sfuggita la sorte funesta,6 erano in patria, lontani dal pelago7 ormai, dalla guerra.
Lui sol,8 che rivedere bramava la patria e la sposa, Calipso9 trattenea nei fulgidi spechi,10 la Diva,
1 indole: “carattere”.
2 serbare: “conservare”, “tenere”. Ancora oggi in ogni automobile è presente il serbatoio, dove è contenuto il carburante.
3 nequizia: “stoltezza”, “scelleratezza”, “empietà”.
4 ch’alto valica: “che attraversa il cielo”.
5 donde che sia movendo: “incominciando (movendo) da dove preferisci”.
6 Si fa qui riferimento ai guerrieri tornati in patria dopo la guerra di Ilio.
7 pelago: “mare”. Si provi a riflettere sul suo significato partendo da un’altra parola italiana piuttosto nota: arcipelago. L’arcipelago infatti indica un raggruppamento di isole, ma deve il proprio nome al mar Mediterraneo, considerato dai greci “mare principale” (traduzione letterale di arcipelago). Essendo questo mare ricco di importanti isole, in seguito ogni raggruppamento di isole ha assunto il nome di arcipelago.
8 Lui sol: il pronome si riferisce a Ulisse ed è complemento oggetto di trattenea; il soggetto è Calipso
9 Calipso era una ninfa, figlia di Atlante, e abitava l’isola di Ogigia. Qui Ulisse naufragò al termine delle sue avventure; la ninfa, tuttavia, essendosene innamorata, lo trattenne per sette anni, e mai lo avrebbe lasciato partire, se non fosse giunto un ordine divino.
10 spechi: “grotte”. Ancora oggi a Subiaco, in provincia di Roma, esiste il Sacro Speco, cioè la grotta in cui per un periodo della sua vita si ritirò a vivere da eremita san Benedetto.
15 la veneranda Ninfa, perché lo bramava suo sposo.11
Ma quando poi, col volger degli anni, fu giunto anche il tempo ch’egli dovea, per decreto dei Numi, tornare alla terra d’Itaca,12 neppur qui, neppur fra gli amici, i travagli giunse a sfuggire. Pietà sentivan di lui tutti i Numi,
20 tranne Posidone; questi serbava immutabile sdegno contro il divino Ulisse, pria ch’egli giungesse alla patria. Ma degli Etiopi questi gito13 era alle terre lontane –sono le genti estreme del mondo, in due zone divise, gli uni ove il sol s’immerge nel pelago, gli altri ove sorge14 –
25 dove di agnelli e di tori gli offrivano sacre ecatombi.
Quivi, assistendo al convito, godevasi; e stavano gli altri
Dei nella reggia accolti di Giove, signore d’Olimpo. Or, così prese a dire degli uomini il padre e dei Numi, poi che gli risovvenne del nobile Egisto, cui morte
30 inflitto aveva Oreste, figliuol d’Agamènnone illustre. Dunque, pensando a quello, fra i Numi così prese a dire: «Ahimè, come i mortali dàn sempre la colpa ai Celesti!
Dicono che da noi provengono i mali; ma invece essi, coi loro peccati, li attirano, in onta al destino».15
[35-43] Per argomentare con più efficacia le proprie parole, Giove decide di narrare per filo e per segno il mito di Oreste, cui precedentemente aveva solo accennato. In assenza di Agamennone, Egisto era divenuto l’amante di Clitemnestra, moglie dell’Atride. Non appena Agamennone fu di ritorno dalla guerra d’Ilio, Egisto lo uccise a tradimento, macchiandosi così di un orribile delitto, nonostante Ermete, ai latini noto come Mercurio, lo avesse avvertito
11 Suo sposo è predicativo dell’oggetto, si riferisce a lo (Ulisse).
12 Itaca è la patria di Ulisse, l’isola su cui è nato e di cui è signore.
13 gito: “andato”.
14 La geografia degli antichi Greci aveva un sapore mitico, specialmente quando si provava a indicare il confine del mondo conosciuto. Gli Etiopi sono una popolazione beata che vive all’estremo oriente, dove il sole sorge ogni mattina. Sono considerati amici e ospiti degli dèi, poiché vivono in una splendente luce solare. L’altro polo geografico è l’estremo occidente, il confine con il mondo reale, confine segnato dal fiume Oceano, in cui il sole si rituffa alla sera: qui vivono i Cimmeri, una popolazione misteriosa. Perennemente privata della luce del sole, la terra dei Cimmeri ospita anche il regno dei morti. Tra questi due popoli dalle caratteristiche estremizzate (uno amatissimo dagli dèi, l’altro completamente ignorato) vivono tutti gli uomini comuni.
15 in onta al destino: “ in aggiunta a quanti ne erano loro destinati”, “contravvenendo al loro destino”.
di non commettere l’empia azione. Su di lui, tuttavia, si abbatté la vendetta di Oreste, figlio di Agamennone, il quale non risparmiò la madre stessa.
E a lui così rispose la Diva dagli occhi azzurrini:16
45 «O padre nostro Cronìde, supremo fra tutti i Celesti, ben meritata fu la pena a cui quegli17 soggiacque: muoia così, chiunque si macchia di simili colpe. Ma mi si spezza il cuore, pensando al saggissimo Ulisse, misero, che dagli amici lontano, si strugge di doglia,18
50 in mezzo al mare, in un’isola, ov’è l’umbilico del ponto.19 Fitta è quell’isola d’alberi; e quivi una Diva soggiorna nella sua casa: la figlia d’Atlante, nemico dei Numi, che tutti sa del mare gli abissi, che regge i pilastri alti, che l’un dall’altro dividono il cielo e la terra.20
55 La figlia sua trattiene quel gramo21 che sempre si lagna, e di molcirlo22 tenta con molli, con blande parole, se mai d’Itaca farlo potesse oblioso.23 Ma Ulisse vorrebbe anche il sol fumo vedere che sbalza dai tetti della sua terra, e morire. Ma questo, o Signore d’Olimpo, 60 punto24 il cuor tuo non commuove. Nell’ampie di Troia pianure, presso le navi argive, non t’erano forse d’Ulisse grate le sacre offerte? Con lui perché tanto ti crucci?»25
16 la Diva dagli occhi azzurrini. Con questa espressione e con altre simili, sempre relative al colore chiaro degli occhi, Omero fa riferimento a Minerva.
17 Quegli si riferisce a Egisto.
18 doglia: “dolore”. Anche oggi a una donna che sta partorendo vengono le doglie, ovvero i dolori che precedono immediatamente e annunciano il parto.
19 umbilico del ponto. Ponto significa “mare”. L’Ellesponto, di cui probabilmente si è già letto o sentito parlare, appunto significa “mare della Grecia”. Umbilico (cioè “ombelico”) del ponto è una metafora che serve a indicare il centro del mare, ovvero il punto più lontano da ogni costa, quello più sperduto.
20 Atlante era un Titano il quale si era alleato con Crono, padre di Giove, per tentare la rivolta contro gli dèi dell’Olimpo. Fallito l’attacco, Atlante venne catturato e punito: fu costretto così a reggere sulle proprie spalle la volta del cielo.
21 gramo: “infelice”.
22 molcirlo: “renderlo docile”, “affabularlo”, “incantarlo”. La ninfa che incanta con la sua bellezza vuole distogliere l’attenzione dell’eroe da ciò che egli realmente desidera.
23 se mai d’Itaca farlo potesse oblioso: “se mai potesse fargli dimenticare Itaca”.
24 punto: “per nulla”.
25 ti crucci: “ti arrabbi”.
E a lei rispose il figlio di Crono che i nugoli aduna:26 «Quale parola, o figlia, t’uscì dalla chiostra dei denti?27
65 Come dimenticarmi potrò mai d’Ulisse divino, che tutti quanti avanza per senno i mortali, ed offerte fe’28 più che ogni altro agli Dei sempiterni, signori del cielo?
Ma il Dio che cinge la terra, Posidone, eterno corruccio serba nel cuor, pel Ciclope, che Ulisse fe’ privo dell’occhio, 70 per Polifemo divino, che tutti vinceva i Ciclopi di gagliardia.29 La vita gli diede la Ninfa Toòsa, figlia di Forcide,30 re del mare che mai non si miete.31 Non gli dà morte; ma lungi vagare lo fa dalla patria. Ora, su via, tutti quanti siam qui, provvediamo che Ulisse
75 possa tornare alla patria. Deporre Posidone l’ira dovrà: ché non potrà, contrastando al volere di tutti, venire a lotta, ei solo, con tutti i Beati del cielo».
[78-94] Minerva risponde al padre esponendo il suo progetto: si mandi Mercurio ad intimare a Calipso la partenza dell’eroe Ulisse; nel frattempo ella si recherà a Itaca per suggerire a Telemaco, figlio di Ulisse, come muoversi in attesa del padre.
26 Il figlio di Crono, Giove, è detto adunatore di nugoli, cioè “radunatore di nuvole”, in quanto ha tra i suoi poteri caratteristici quello di comandare le tempeste.
27 Quale parola, o figlia, t’uscì dalla chiostra dei denti? Chiostra significa “recinto”. Il verso può essere così parafrasato: “Che cosa hai mai detto?” L’intera frase costituisce un’espressione formulare, con la quale si vuole indicare che il personaggio che la pronuncia è preso da grande stupore. Omero costruisce alcune frasi formulari che possano adattarsi a diversi punti della storia e le riutilizza. È una sorta di linguaggio in codice che si crea per una duplice comodità: chi recita ha a disposizione un repertorio di frasi adatte a certe situazioni che può con gran facilità tenere a mente; chi ascolta riconosce nella narrazione alcune espressioni che gli sono familiari e sa quale sentimento l’autore vuole suscitare.
28 Fe’ è spesso usato al posto di “fece”.
29 Di gagliardia è un complemento di limitazione. Il Ciclope, cioè Polifemo, come ci informa Omero, superava tutti i suoi compagni nella forza fisica. La storia di Polifemo verrà raccontata in seguito, nel libro IX.
30 Forcide era una divinità marina, padre di Toòsa, una ninfa che unendosi a Posidone generò Polifemo e tanti altri Ciclopi, uomini giganteschi con un solo occhio in mezzo alla fronte.
31 mare che mai non si miete. Le civiltà antiche hanno certamente conosciuto il mare e le sue risorse, ma erano popoli sostanzialmente dediti ad agricoltura e allevamento. Il grano e il bestiame erano l’unità di misura della ricchezza. Pertanto quando si dice che il mare non si miete si vuole indicare che esso non è capace di produrre frutto, cioè non si può coltivare.
Minerva a Itaca
[95-104] La dea indossa i calzari e impugna il proprio bastone. Assunte le sembianze di Mente, signore dei Tafi,32 scende dall’Olimpo alla volta di Itaca.
105 E trovò33 dunque i Proci34 magnifici. Stavano appunto lì, dinanzi alla porta, godendosi al giuoco dei dadi,35 seduti sopra pelli di bovi che avevano uccisi.
E banditori36 ad essi d’attorno; e gli svelti valletti, quelli mescevano il vino con l’acqua negli ampi cratèri,
110 questi tergean con le spugne dai mille forami37 le mense, e le ponean loro innanzi: tagliavano scalchi38 le carni. Assai prima d’ogni altro, Telemaco simile ai Numi, la vide; ché39 sedeva, col cuore in angoscia, fra i Proci, l’immagine del padre con l’occhio dell’alma fissando,40
115 se mai giungesse, e i Proci sperdesse lontan dalla casa, sì che, lucrando41 onore, tornasse signor dei suoi tetti.
Pensava a ciò, seduto fra i Proci; ed Atena gli apparve; ond’ei42 sùbito all’atrio si spinse; ché in cuor gli pesava
32 I Tafi sono una popolazione di mercanti e predoni che prende il nome da Tafo, la loro isola di provenienza, posta sul mar Ionio nei pressi dell’Acarnania, nella parte occidentale della Grecia, appena a nord del Peloponneso.
33 Il soggetto è Minerva.
34 Proci sembrerebbe il nome di una popolazione, tanto è vero che risulta scritto con l’iniziale maiuscola. Eppure, se andiamo a controllare sull’originale testo greco, il termine che corrisponde è mnesterai, cioè “pretendenti”. Si tratta di un nome comune, dunque, non di un nome proprio. In latino per indicare i pretendenti esiste il termine procus e pertanto si è utilizzato questo. I Proci, infatti, altro non erano che i signori di Itaca e di altre isole attorno a essa, i quali, approfittando dall’assenza di Ulisse e della giovinezza di Telemaco, si erano stabiliti in Itaca a palazzo nella speranza che Penelope, moglie di Ulisse, ne scegliesse uno come suo sposo, concedendogli così la sovranità sull’isola tutta.
35 godendosi al giuoco dei dadi: “divertendosi giocando a dadi”.
36 I banditori sono gli “araldi”, cioè quei servi incaricati di recare dei messaggi. Qui tuttavia svolgono delle mansioni da semplici servi.
37 forami: “fori”, “buchi”. I servitori utilizzano dunque spugne porose.
38 Scalco è un’altra parola per indicare un servitore. Ancora oggi sopravvive la parola “maniscalco”.
39 Ché è spesso utilizzato per “poiché”; introduce cioè una subordinata causale.
40 l’immagine del padre con l’occhio dell’alma fissando: vale a dire che Telemaco ha il cuore in attesa, sempre teso alla ricerca del padre.
41 lucrando: “guadagnando”, “riacquistando”.
42 Onde è una congiunzione che ha solitamente significato consecutivo (“dunque”, “allora”, “cosicché”) o finale (“affinché”).
sopra la soglia lasciare un ospite a lungo. Vicino 120 le andò, per man la prese, le tolse la lancia di bronzo, e, a lei rivolto, il volo diresse di tali parole:43 «Ospite, salve! Sarai fra noi benvenuto. Or ti ciba, e dopo il pranzo dirai qual causa fra noi ti conduce».44 Dentro, com’ebbe ciò detto, l’addusse; ed Atena seguiva.
[125-156] Nel palazzo ha luogo il pranzo. L’ospite viene accolto e fatto sedere in un luogo sufficientemente appartato; una serva lava le sue mani e apparecchia la tavola, recando carni e vino in abbondanza. In breve tempo i Proci si uniscono al banchetto, gettando avidamente le mani su ogni pietanza. Dopo essersi ristorati, questi chiamano l’aedo Femio, costringendolo a cantare per il loro diletto. Telemaco allora si rivolge al misterioso ospite.
«Ospite caro, vorrai spiacerti di ciò ch’io ti dico?
A questa gente importa la cetera e il canto; e s’intende: ché, senza scotto pagare, divorano i beni d’un altro: 160 d’un uomo onde45 ora l’ossa marciscono bianche alla pioggia sopra la terra, oppure le voltola il flutto del mare: ché se tornar lo vedessero in Itaca, tutti di certo implorerebber dai Numi piuttosto sveltezza di gambe, non già46 di vesti e d’oro dovizia opulenta.47 Ma ora
43 il volo diresse di tali parole. Altra espressione formulare. Le parole volano, al pari delle frecce, perché capaci di cogliere in pieno il loro bersaglio. Quando le parole volano, dunque, significa che sono parole chiare, incisive, che colgono nel segno.
44 A ben vedere, ai nostri occhi la scena appena narrata risulta un po’ strana: uno straniero si reca a palazzo e viene subito rifocillato; solo in seguito egli si dovrà preoccupare di presentarsi. Agli occhi di un greco, tuttavia, ciò era normalissimo, anzi, dovuto. L’ospite era sempre accolto come mandato dagli dèi, e pertanto la sua identità non era certo la cosa più importante. Giove era il protettore dell’ospitalità, e chi non rispettava l’ospite commetteva un atto empio, dissacratore. L’ospitalità era così tanto importante e sacra che il vincolo di amicizia si tramandava in seguito per diverse generazioni. Questo è proprio quanto avviene anche nel libro VI dell’Iliade, quando Diomede e Glauco rifiutano di combattersi perché un vincolo di ospitalità legava i loro nonni.
45 Onde non ha qui alcun valore di congiunzione finale o consecutiva, ma è un pronome relativo e significa “di cui”.
46 non già: “invece che”.
47 Telemaco è certo della morte del padre, al punto di affermare che il suo ritorno in Itaca sarebbe piuttosto paragonabile al ritorno di un fantasma, la cui apparizione spingerebbe la gente a pregare gli dèi, non tanto per ottenere in dono ricchezze, ma gambe veloci per fuggire.
165 quegli al suo tristo destino soggiacque; né alcuna speranza più ci riscalda il cuore, se pure qualcuno ci dice ch’egli farà ritorno. Per lui non è scritto il ritorno. Ma dimmi questo adesso, rispondimi senza mentire: chi sei? Di quale gente? Qual è la tua terra e il tuo sangue?
170 Sopra quale naviglio sei giunto? Com’è che i nocchieri t’hanno condotto ad Itaca? Ed essi chi sono? Ché a piedi non crederò davvero che tu sia fra noi pervenuto. E il vero anche di questo, rispondi: ch’io voglio saperlo: se qui la prima volta giungi ora, o se tu di mio padre 175 ospite sei, ché la casa d’Ulisse più d’uno conosce, perché soleva anch’egli pel mondo vagar fra la gente».
[177-192] Minerva si presenta allora fingendosi Mente, re dei Tafi, e cattura subito la simpatia di Telemaco ricordandogli l’affetto che nutre verso suo padre, al quale lo lega inoltre un antico dovere di ospitalità.
Il ricordo di Ulisse
«Io,48 poi, son qui disceso, perché dire udii che tuo padre era tornato; ma invece la via gli precludono i Numi.
195 Ché non è morto Ulisse, sparito non è dalla terra; ma trattenuto è, vivo tuttora, nel mare infinito, sopra le balze remote d’un’isola: contro sua voglia è trattenuto lì, da genti crudeli e selvagge.
Ora un pronostico49 fare ti voglio, che i Numi del cielo 200 a me gittano in cuore, che compiersi, credo, si deve, per quanto né profeta, né sperto d’augurî50 mi sono.
Non resterà più a lungo tuo padre lontan dalla patria, né pur se stretto fosse fra ceppi di ferro. Ed il modo ben troverà di tornare: ché astuzie a dovizia possiede.51
205 Ma dimmi questo, adesso, rispondimi senza menzogna: se tu, giovin prestante qual sei, sei figliuolo d’Ulisse: ché a lui mirabilmente somigli nel volto e negli occhi.
48 Chi parla è Mente, cioè Minerva.
49 pronostico: “previsione”.
50 sperto d’augurî: “esperto di vaticini”, “di profezie”.
51 astuzie a dovizia possiede: “possiede astuzie in grande quantità”, “è capace di molte astuzie”.
Ben lo conosco: ché spesso con lui mi solevo trovare, prima che verso Troia salpasse, ove mossero quanti
210 eran più prodi Argivi, sovresse52 le concave navi; Ulisse da quel dì più non vidi, né me vide Ulisse».
E a lei queste parole rispose Telemaco scaltro: «Ospite, ed io parlerò, senza nulla detorcer dal vero.
Dice la madre mia ch’io sono figliuolo d’Ulisse:
215 io per me non lo so: che niuno conosce suo padre.
Deh! così fossi, invece, figliuolo d’un uom fortunato, quale pur sia, che toccasse vecchiezza godendo i suoi beni!
Ora del più disgraziato fra quanti son nati a morire, di lui dicono ch’io son figlio, giacché vuoi saperlo».
220 E a lui rispose Atena, la Diva ch’à glauche le ciglia:53 «No, che non t’hanno fatto discender gli Dei da una stirpe di poco nome, se tale Penèlope a luce ti diede.
Ma dimmi ancora questo, rispondimi senza menzogna: questa festa che è? Che è questa turba? Convito
225 oppur nozze? Non è modesto banchetto d’amici.
Gente arrogante mi sembra, che nella tua casa banchetta, a farti oltraggio e danno. Vedendo una tale sozzura, ogni uom che senno avesse, dovria, qui giungendo, adirarsi».
E a lei queste parole rispose Telemaco scaltro:
230 «Ospite, poi che queste domande mi volgi, e t’informi, esser dové54 questa casa da biasimo immune e opulenta, quando tuttora qui vivea tra il suo popol quell’uomo.
Altro ora vollero i Numi, che a lui macchinarono il male, sì ch’ei disparve; e di niuno si persero tanto le tracce.
52 sovresse. Si può tradurre semplicemente con “sopra”; è dunque una preposizione impropria. Osservandola con più attenzione si nota che in essa è contenuto e fuso insieme anche il pronome esse (sovra esse: “sopra di esse”), superfluo e da non parafrasare, poiché il nome è presente (le navi); tale pronome comunque concorda in genere e numero con il nome cui si riferisce. Per questa ragione si trovano anche in altri punti del testo sovressa, sovresso e sovressi, sempre traducibili con “sopra” e riferiti a nomi di diverso genere e numero.
53 glauche le ciglia Glauco è un aggettivo che spesso viene tradotto come “bianco”, ma in realtà indica più genericamente un colore chiaro, quindi anche il grigio e l’azzurrino. Tradurre i nomi dei colori greci in italiano è molto difficile, dal momento che non se ne possiedono i precisi equivalenti. Nel caso specifico, comunque, sarà bene intendere l’aggettivo con “celeste”, “azzurrino”: difficilmente, infatti, si può pensare a Minerva come alla dea dagli occhi bianchi!
54 Dové è una forma tronca per “dovette”.
235 Ché tanto non sarebbe, s’ei fosse pur morto, il mio cruccio, se fra i compagni suoi cadea, combattendo i Troiani, o fra le man degli amici, poi ch’ebbe compiuta la guerra. Tutti gli Achivi allora gli avrebbero alzata una tomba, ed alta gloria avrebbe lasciato alla moglie ed al figlio.
240 Invece, senza gloria via l’hanno rapito le Arpìe:55 niuno l’ha visto, niuno sa nulla, lamenti ed ambasce56 ei m’ha lasciato. Né solo per lui mi lamento o mi cruccio: d’altri cocenti affanni mi vollero oppresso i Celesti. Perché quanti signori governan queste isole intorno, 245 Same, Dulichio, Zacinto57 coperta di selve; e i signori tutti, ch’ànno58 in possesso le balze d’Itaca alpestre, sposa pretendono avere mia madre, e distrugger la casa. Essa le nozze odiose respinger non sa; né s’induce pure a compirle. Frattanto divoran, distruggono quelli 250 la casa mia; ché presto me pure vorranno distrutto».
[251-268] La dea risponde alla rassegnazione del giovane Telemaco auspicando il ritorno di Ulisse e ricordandogli come il padre si sarebbe comportato nella medesima situazione. Ma, da ultimo, rammenta che il ritorno dell’eroe «su le ginocchia dei Numi riposa».
«Ma intanto, io t’esorto a pensare come da casa tua tu possa cacciar quei superbi.59
55 Le Arpie erano degli spiriti maligni che impersonavano i venti tempestosi. Raffigurate come esseri dal volto e dal busto di donna, ma con ali e zampe da uccelli, secondo il mito erano solite rapire gli uomini per nasconderli in luoghi ignoti o addirittura nel regno dei morti.
56 ambasce: “pene”, “sofferenze”, “dolori”.
57 Same, Dulichio, Zacinto. Sono questi i nomi delle isole appartenenti al regno di Ulisse, da cui provengono i Proci. Same è da identificare probabilmente con la parte settentrionale dell’attuale Cefalonia, Dulichio con il resto di essa. Zacinto è l’attuale Zante.
58 Ch’ànno sta per “che hanno”; fino a qualche tempo fa la forma del verbo avere “hanno” poteva venire scritta anche così. In seguito si è preferito utilizzare esclusivamente la lettera h al posto dell’accento. Tale lettera solitamente sta a indicare un suono aspirato (si pensi alla differenza di pronuncia tra gli inglesi tree, “albero” e three, “tre”) o indurito (la differenza tra marcio e marchio). In questo caso, tuttavia, la lettera h è un semplice accorgimento grafico e non comporta nessuno dei due fenomeni sopra citati (anno e hanno si pronunciano esattamente allo stesso modo).
59 quei superbi: si fa qui riferimento ai Proci.
270 Dunque intendimi bene, fa’ tutto come ora io ti dico.
A parlamento chiama domani su l’alba gli Achei, e parla a tutti quanti, che sian testimonî i Celesti.
Ai Proci ingiungi che via si sperdano, ognuno ai suoi beni; ed a tua madre, se il cuore la induce, che scelga uno sposo,
275 che dalla casa vada lontano del prode tuo padre.
E quelli appresteranno le nozze, offriranno regali molti, quanti a una figlia diletta darebbe suo padre. Ed un consiglio a te porgerò, se ascolto vuoi darmi.
Di venti remi un legno prepara, qual sia più veloce,
280 e muovi a dimandare notizie del padre lontano, se da qualche uomo averne potessi, o ascoltare un responso60 di Giove, onde61 ai mortali la fama più ampia s’effonde. Volgiti prima a Pilo, dimandane a Nestore62 divo; di là, recati al biondo Menelao,63 sovrano di Sparta,
285 ch’ultimo ritornò fra gli Achèi loricati64 di bronzo. Se di tuo padre avrai notizia, che vive e che torna, resta, ed attendi ancora, sia pure fra i crucci, un altro anno; ma se ti dicono invece che spento è, che più non esiste, allora alla paterna tua terra diletta ritorna,
290 levagli un tumulo, rendigli estreme onoranze solenni, come ad un re si conviene. Poi scegli a tua madre uno sposo. E quando tutto ciò tu abbia provvisto e compiuto, tempo sarà che vada volgendo nel seno e nel cuore come nella tua casa provveda alla morte dei Proci, 295 sia con l’inganno, sia con atti palesi. Con ciance più trastullar non ti devi, ché a te l’età tua nol consente».65
60 responso: “messaggio”, “risposta” del dio a una domanda rivoltagli.
61 onde: “di cui”, “del quale” (pronome relativo).
62 Nestore era il più anziano e saggio fra tutti i guerrieri che presero parte alla guerra di Troia, dopo la quale fece ritorno a Pilo, la sua terra.
63 Menelao, fratello di Agamennone, riuscì a tornare in patria, a Sparta, dopo un lungo peregrinare. È perciò la persona più indicata per avere informazioni su Ulisse, poiché può infatti averne sentite nel suo lungo viaggio di ritorno, se non addirittura aver condiviso con il padre di Telemaco alcune avventure in mare.
64 loricati: “corazzati”. La lorica è la “corazza”.
65 Con ciance più trastullar non ti devi, ché a te l’età tua nol consente. “Non devi più perder tempo con sciocchezze, poiché la tua età non te lo consente”. Minerva istruisce Telemaco suggerendogli i primi passi da compiere. Non rivela al giovane figlio di Ulisse tutto quanto dovrà accadere
[297-317] Minerva esorta Telemaco a seguire i suoi consigli, richiamando alla sua memoria le gesta di Oreste, che fu capace di vendicare il padre. Ciò detto, si congeda, rifiutando l’invito del ragazzo a trattenersi ulteriormente per ristorarsi con un tiepido bagno.
Così disse; e partì la Diva dagli occhi azzurrini. Volò, ché forma assunse d’augello; e a Telemaco in seno 320 forza e fiducia ispirò, più vivo il ricordo gli rese del padre suo, che prima non fosse; e fra sé ripensando, pieno fu di stupore:66 ché intese che quello era un Nume. E subito dopo tornò quel giovin divino fra i Proci.
La madre Penelope
Stava l’insigne vate67 fra i Proci cantando; e in silenzio
325 quelli ascoltavan seduti. Cantava il ritorno che Atena Pallade inflisse agli Achivi, da Troia, funesto di lutti.68 Ed ecco, udì dall’alto la voce divina del vate d’Icario la figliuola, Penèlope piena di senno, e dalle stanze eccelse discese dell’alto palagio,
e lascia a lui il compito di agire, di dare effetto ai suoi consigli. Con le figure di Telemaco e Minerva, Omero dunque ci mostra come il dio guidi l’uomo accompagnandolo, sostenendolo, ma mai sostituendosi a lui.
66 Il dio che visita l’uomo lo rende pieno di stupore. La parola stupore deriva dal verbo latino stupeo, che significa “rimanere a bocca aperta”. Dallo stesso verbo ha origine anche la parola stupido. Rimanere a bocca aperta, infatti, può essere al tempo stesso segno di grande intelligenza e semplicità o di assoluta demenza: colui che rimane a bocca aperta come un bambino di fronte a qualcosa di grande e bello è stupito; colui che resta con la bocca aperta senza essere davanti a nulla di particolare, fermo e perso nei suoi pensieri, è stupido.
67 L’insigne vate è Femio, che i Proci avevano precedentemente chiamato perché li dilettasse con la sua arte.
68 Cantava il ritorno che Atena Pallade inflisse agli Achivi, da Troia, funesto di lutti. Ulisse non è il solo eroe greco ad aver dovuto affrontare mille peripezie durante il viaggio di ritorno dalla guerra di Troia. Anche Nestore e Menelao (come loro stessi racconteranno nei libri III e IV) dovettero fuggire da molti pericoli, affrontando l’ira di Minerva. Questi due eroi tuttavia sono giunti in patria da tempo e il loro ritorno è divenuto oggetto di molti canti degli aedi. I Greci dedicarono addirittura un genere letterario al racconto del ritorno in patria di un eroe: si tratta dei nòstoi (che in greco significa appunto “ritorni”). L’ira di Minerva può risultare strana, dal momento che durante tutta la guerra di Troia la dea aveva protetto e non certo osteggiato gli Achei. Tuttavia il poema noto come Iliou Persis (“La caduta di Ilio”) racconta l’episodio che fece infuriare la dea. Aiace Oileo, infatti, aveva osato portare via da un tempio dedicato a Minerva la sacerdotessa Cassandra, figlia di Priamo. Gli Achei, tuttavia, non vollero punire in alcun modo l’eroe greco, scatenando la furia della dea figlia di Giove.
330 sola non già, ché due seguivano ancelle i suoi passi.
E poi che quella donna divina fu giunta fra i Proci, stie’ de l’adorna sala vicino ai pilastri,69 alla soglia, schermo facendo alle guance del morbido velo;70 e le ancelle modeste accanto a lei restarono, a entrambi i suoi fianchi.
335 E lagrimando, così prese a dire al cantore divino: «Femio, tu sai molte altre lusinghe dei cuori mortali,71 d’uomini gesta e di Numi, che sogliono i vati cantare. Prendi a cantare qualcuna di queste; e costoro in silenzio t’odano, vino bevendo; ma questa canzone di lutto
340 lascia, che sempre a me nel seno profondo il mio cuore strugge, perché su me questa funebre doglia ricade, poiché d’un uomo tale m’angustia la brama e il ricordo, di cui la fama vola per l’Ellade tutta e per Argo».
E a lei queste parole Telemaco scaltro rispose:
345 «O madre mia, perché contendere72 al dolce poeta ch’egli ivi73 canti, dove la mente lo spinge? I poeti colpa non hanno: è Giove la causa di tutto, che il bene comparte e il mal, così come pur gli talenta,74 ai mortali. Biasmo75 non gli è dei Dànai cantare il funesto ritorno,
350 perché, più che ad ogni altra, largiscono gli uomini elogi alla canzone che sembri suonare più nuova a chi l’ode.76
L’anima e il cuore tuo, dunque, abbian la forza d’udire: ché non al solo Ulisse conteso fu il dì del ritorno;
69 stie’ de l’adorna sala vicino ai pilastri. Da ordinare così: stie’ (“stette”) vicino ai pilastri de l’adorna sala De l’ è una preposizione articolata in cui la preposizione e l’articolo non si sono ancora saldati.
70 schermo facendo alle guance del morbido velo. Da ordinare così: facendo del morbido velo schermo alle guance. Schermo significa “scudo”, “riparo”. Penelope aveva dunque il volto coperto da un velo.
71 lusinghe dei cuori mortali: “storie capaci di incantare il cuore degli uomini”. Quando i cuori sono incantati, gli uomini, stregati, sono costretti all’ascolto. Con ciò si vuole indicare il fascino che i racconti degli aedi esercitavano sul pubblico.
72 contendere: “impedire”.
73 Ivi è un avverbio di luogo: “qui”.
74 così come pur gli talenta: “così come vuole”.
75 Biasmo: “biasimo”, “motivo di colpa, di vergogna”.
76 Telemaco spiega come sia un giusto diritto del poeta cantare una canzone di argomento così recente, dato che riscuotono maggior successo proprio i racconti che risultano più nuovi alle orecchie degli uditori.
ma spenti fûr molti altri di quei che pugnarono a Troia.
355 Alle tue stanze, su, ritorna, e ai tuoi compiti bada, al fuso ed alla rocca,77 partisci comandi alle ancelle, che affrettino i lavori; e agli uomini lascia la cura dei canti; e pria a me, che son della casa il signore».
E nuovamente allora, Penelope, tutta stupita,
360 salì, ché penetrata del figlio l’avean le parole.78 E con le ancelle insieme venuta all’eccelse sue stanze, piangeva Ulisse, lo sposo diletto; sinché su le ciglia infuse a lei soave sopor l’occhicerula Atena.
Per la magione79 ombrosa, frattanto, con alto schiamazzo,
365 tutti chiedevano i Proci di stendersi sopra i lettucci. E a lor queste parole Telemaco scaltro rivolse: «O della madre mia pretendenti arroganti e superbi, adesso del banchetto godiamo il piacere; e ogni grido cessi: ché udire tale cantor cosa è troppo soave,
370 quale è costui, che ai Numi del cielo pari è nella voce. Domani all’alba, poi, troviamoci tutti raccolti a parlamento; ch’io voglio con franca80 parola intimarvi d’uscir da questa casa. Cercatevi altrove i banchetti, mangiate i beni vostri, reciproche mense allestite.
375 Ma se vi sembra poi che sia più piacevole e giusto senza timor di pena distruggere i beni d’un solo, rodete pure. Ma io chiamerò dell’Olimpo i Signori, se mai Giove conceda che ciò che vi spetta vi tocchi: invendicati allora dovrete qui dentro morire».
77 rocca. È l’attrezzo usato per la filatura, costituito da un’asta di legno con una testa ingrossata attorno alla quale si arrotola il filo.
78 Telemaco sta diventando uomo e questo si vede anche nella risolutezza con la quale è ora capace di prendere certe importanti decisioni. La madre pertanto si stupisce nel riconoscere che il figlio è cambiato, è cresciuto, ed è ora capace di azioni prima impensabili.
79 La magione è la “casa”. La medesima radice della parola italiana magione si è conservata nel termine francese maison, che significa appunto “casa”.
80 franca: “chiara”, “libera”, “decisa”.
380 Così parlava; e tutti si morser le labbra coi denti, meravigliati come Telemaco ardito parlasse.81
[382-421] Intervengono allora due pretendenti: Antinoo ed Eurimaco. Il primo vuole intavolare una lite con il giovane. Gli predice che non diverrà mai sovrano di Itaca, ma Telemaco gli tiene testa. Eurimaco, di seguito, più scaltro e meno irruento, inizia a indagare insistentemente circa il misterioso ospite con cui Telemaco si è trattenuto. Il figlio di Ulisse riesce a eludere i sospetti raccontando con tono deciso la storia del suo ospite, Mente di Tafo.
La notte in attesa
[422-432] Giunta la sera, Telemaco si reca nella propria stanza, accompagnato da Euriclea, colei che, comprata come serva da Laerte, padre di Ulisse, era stata la nutrice dell’eroe e in seguito di Telemaco stesso.
Questa82 recava accese le fiaccole. Più d’ogni ancella essa lo amava; lo aveva curato quand’era bambino.
435 Della sua stanza bella Telemaco l’uscio dischiuse, sede’ sovra il giaciglio, si sfilò la tunica molle, e fra le man la gittò della sedula83 vecchia. Costei la tunica piegò, la compose nelle sue pieghe, poi dal talamo uscì, traendosi dietro la porta, 440 il chiavistello tirò per la fune. E Telemaco intanto tutta la notte dormì, fra velli di pecora avvolto, nel suo pensiero i consigli volgendo che Atena gli diede.
81 meravigliati come Telemaco ardito parlasse. Ancora una volta dalle reazioni dei personaggi comprendiamo come Telemaco non sia più lo stesso, cioè non sia più un ragazzino: ormai si comporta da uomo.
82 Questa. Il pronome si riferisce a Euriclea.
83 sedula: “laboriosa”, “premurosa”.
L’assemblea degli Itacesi
Come, al mattino, Aurora comparve, ch’à dita di rose,1 ecco, il figliuolo diletto d’Ulisse balzò dal giaciglio,2 cinse la tunica, all’omero3 appese l’aguzza sua spada, sotto i nitidi piedi si strinse i sandali belli, 5 e dalla stanza uscì, che un Nume sembrava nel volto.
Ed agli araldi, voci squillanti, di subito impose di radunare a consiglio gli Achei dalle floride chiome. Quelli lanciarono il bando,4 accorser veloci gli Achivi. Or, poi che tutti furono accorsi, Telemaco mosse 10 verso la piazza, in pugno stringendo la lancia di bronzo, solo non già, ché dappresso seguianlo due cani veloci.
Tutto lo aveva Atena cosparso di grazia celeste; e l’ammiravan tutte, mentr’egli incedeva,5 le genti. Sedè sul trono del padre, gli fecero luogo i vegliardi;6
1 Come, al mattino, Aurora comparve, ch’à dita di rose. Questo verso ricorre più volte in Omero per indicare l’alba mattutina. È un’espressione formulare molto bella, costituita da una metafora nella quale i primi raggi del sole sorgente sono paragonati alle rosee dita di una mano.
2 giaciglio: “letto”, “luogo dove stendersi”.
3 L’omero è un osso del braccio, ma qui l’espressione serve a indicare la spalla.
4 Il bando è un annuncio che viene fatto pubblicamente a tutta la comunità. Il banditore era il messaggero incaricato di portare tale annuncio in tutta la città. Oggigiorno esistono ancora i bandi: generalmente si tratta di annunci di concorsi fatti dalle amministrazioni pubbliche. Vi è però una traccia di questa antica parola anche nel termine bandito, “fuorilegge”. Il bandito infatti era colui la cui condanna veniva resa nota pubblicamente, appunto con un bando, cosicché agli occhi di tutta la comunità divenisse pericoloso e ricercato.
5 incedeva. Incedere sta per “camminare”, “venire avanti”. In latino il verbo cedere significava appunto “andare”. Apparentemente questo verbo latino non esiste più in italiano, ma in realtà è alla base di tanti verbi e dei loro derivati, parole oggi molto usate. Basta infatti aggiungere delle preposizioni al verbo per ottenere: accedere (accesso), procedere (processo, processione), antecedere (antecedente), retrocedere (retrocessione), precedere (precedente, precedenza), incedere, eccedere (eccesso, eccezione), concedere (concessione), succedere (successo), intercedere (intercessione)
6 gli fecero luogo i vegliardi: “i più anziani gli fecero posto”. Nelle assemblee i vecchi sedevano in cerchio su pietre levigate. Ci informa di questo Omero stesso, nell’Iliade, quando descrive un’assemblea scolpita da Vulcano sullo scudo di Achille (Iliade, libro XVIII, vv. 671-843).
15 ed a parlar cominciò fra loro il nobile Egizio, che mille e mille cose sapea, ch’era curvo per gli anni.
[170-240] Il vecchio Egizio ha quattro figli: uno, Antifo, è partito con Ulisse e non farà più ritorno a Itaca; un altro, Eurinomo, gozzoviglia con i Proci; gli ultimi due amministrano la casa e i beni del padre. Sperando nel cuore il ritorno del figlio combattente, il vecchio domanda a Telemaco il motivo di questa assemblea:
25 «Datemi ascolto, udite ciò ch’io voglio dirvi, o Itacesi:7 mai né assemblea né consiglio finora fra noi non si tenne, da quando Ulisse, stirpe di Numi, partì su le navi. Chi ci convoca adesso? Necessità chi mai n’ebbe, sia dei giovani, sia di quanti siam d’anni già gravi?8
30 Udì novella forse di schiera che qui s’avvicini, e, come prima l’udì, vuol darcene chiara novella?
O proporrà, parlerà d’altra cosa che al popolo giovi?
Sia benedetto! Ché uomo dabbene mi sembra. Recare voglia a buon esito Giove, ciò ch’egli vagheggia9 nel cuore».
35 Disse. Ed il figlio d’Ulisse godé per l’augurio; e seduto più non restò: ché lo empieva desìo di parlare al convegno.
Stette nel mezzo; e a lui, Pisènore araldo, maestro d’accorgimenti scaltri, nel pugno poneva lo scettro.10
E prima al vecchio Egizio rivolto, Telemaco disse:
7 Chi parla è Egizio, vecchio abitante di Itaca.
8 Necessità chi mai n’ebbe, sia dei giovani, sia di quanti siam d’anni già gravi? Da ordinare così: chi mai, sia dei giovani sia di quanti siam già gravi d’anni, n’ebbe necessità? (n’ = ne, “di ciò”, “dell’assemblea”). L’aggettivo grave significa letteralmente “pesante”. Grave si può dunque dire di un masso o di un pezzo di piombo. Non a caso viene chiamata forza di gravità quella forza che attira i corpi verso il basso in virtù del loro peso. Oggi tuttavia questo aggettivo si utilizza maggiormente in senso figurato: una grave offesa è un’offesa difficile da sopportare, pesante dunque; un fatto grave è un fatto che si fatica a sostenere da soli.
9 vagheggia: “desidera”.
10 Lo scettro aveva una duplice funzione: innanzitutto era il bastone che distingueva il re da tutti gli altri uomini; inoltre, come nel nostro caso, era quell’oggetto che veniva consegnato durante l’assemblea a chi stava per prendere la parola. Nel momento in cui una persona riceveva lo scettro da un servitore era autorizzata a parlare di fronte all’assemblea. Allo stesso modo, quando il discorso era terminato, lo scettro tornava nelle mani del servitore, che lo avrebbe in seguito consegnato al successivo oratore.
40 «Lungi non è quell’uomo,11 buon vecchio, e ben presto il saprai. Io convocai l’assemblea. Gran doglia colpisce il mio cuore. Non già novella udii di schiera che qui s’avvicini, né vengo a voi, per darvene primo la certa novella. Né proporrò, parlerò d’altra cosa che al popolo giovi;
45 ma delle due sciagure piombate su me, nel mio tetto. Perduto ho il padre mio valoroso, che un giorno fra voi resse lo scettro, ed era benigno per voi come un padre. Assai maggiore è l’altra, che presto l’intera mia casa percoterà, tutte quante distrutte m’avrà le sostanze.
50 Ressa d’intorno a mia madre, che schifali, fan pretendenti,12 figli di gente che noi contiam13 fra i più grandi signori, ch’ànno ribrezzo di mettere piè nella casa del padre, d’Icario,14 che dovrebbe concedere ad essi la figlia, e la darebbe a quello che più gli tornasse gradito.
55 In casa nostra, invece, trascorron le intere giornate, ad accoppare bovi, con pecore e pingui15 capretti, e fan lauti banchetti, tracannano16 senza riguardo vino fiammante, e distruggono i beni migliori; ché un uomo non c’è, quale era Ulisse, che tenga lontano il flagello 60 da questa casa. Noi, da tanto finora non siamo; ed anche pel futuro saremo da poco ed imbelli».17
[62-79] Descrivendo le ingiustizie compiute dai Proci, Telemaco chiede che qualcuno intervenga a porre freno a tale incresciosa situazione. Il suo discorso è autorevole, ed il giovane si sforza per risultare fermo e deciso, eppure non ottiene nessuna risposta affermativa. Al termine, allora, Telemaco scioglie tutta la sua tensione piangendo a dirotto.
11 quell’uomo: Telemaco fa qui riferimento al padre Ulisse.
12 Ressa d’intorno a mia madre, che schifali, fan pretendenti. Da ordinare così: (i) pretendenti fan ressa d’intorno a mia madre, che li schifa (“li ripudia”).
13 contiam: “consideriamo”.
14 Icario è il padre di Penelope.
15 pingui: “grassi”.
16 tracannano: “mandano giù per la gola”. Parlando di canne, infatti, Omero fa riferimento alla gola.
17 Noi, da tanto finora non siamo; ed anche pel futuro saremo da poco ed imbelli: “noi ora non siamo capaci di cacciarli, e anche per il futuro saremo incapaci e deboli”.
80 Così tutto cruccioso parlò, gittò al suolo lo scettro,
E si disciolse in pianto: pervase pietà tutti i cuori.
E tutti quanti gli altri rimasero muti; né alcuno dopo parole osò contrapporre a Telemaco:18 solo
Antìnoo19 n’ebbe ardire, ma gli volse così la parola:
85 «Impetuoso Telemaco magniloquente,20 che21 oltraggi
hai contro noi scagliati! Vorresti pur biasimo apporci!22
I pretendenti Achei, verso te sono immuni da colpa.23
È di tua madre la colpa, che grande maestra è d’astuzie.
Questo è il terz’anno, né manca gran tempo, ed il quarto si compie,
90 che degli Achei pretendenti i cuori delude tua madre.
Lascia che sperino tutti, promesse a ciascuno comparte, manda messaggi, ed altre speranze vagheggia il suo cuore.
E la sua mente poi rivolse ad un nuovo tranello.
Una gran tela ordì24 nella reggia, ed a tesserla imprese,25
95 sottile e lunga lunga; poi queste parole ci disse:
“Giovani miei pretendenti, poiché spento è Ulisse divino, abbiate pazienza, per quanto bramosi di nozze, ch’io questo manto compia, né vada perduto il già fatto.
Sudario26 per Laerte dev’essere, il dì che l’eroe
100 della dogliosa morte soccomba a la sorte ferale:27 ché delle donne Achee non debba taluna incolparmi,
18 né alcuno dopo parole osò contrapporre a Telemaco. Da ordinare così: né alcuno dopo osò contrapporre parole a Telemaco. Dopo è dunque un avverbio, non una preposizione impropria.
19 Antinoo è uno dei Proci. Assieme a Eurimaco è il più ostile al giovane Telemaco.
20 magniloquente: “che parla in modo solenne”. È un aggettivo composto da un avverbio latino significante “grande” (magne) e dal participio presente del verbo latino significante “parlare” (loquens). Si potrebbe tradurre anche così: “che parla in grande”. Qui però non è utilizzato per fare un complimento, ma con tono ironico.
21 che, “quali”. È aggettivo esclamativo.
22 Vorresti pur biasimo apporci!: “vorresti pure ricoprirci di infamia!”.
23 immuni da colpa: “esenti da colpa”, cioè “senza colpa”.
24 ordì: “preparò”. L’orditura infatti è una fase preparatoria della tessitura. In essa viene preparato sul telaio l’ordito, ovvero quell’insieme di fili attraverso i quali, grazie a uno strumento chiamato navetta, verrà in seguito fatto passare il filo di trama. Dall’intreccio del filo di trama con quelli di ordito nascerà la tela.
25 a tesserla imprese: “si mise a tesserla”.
26 Il sudario era un lenzuolo con cui veniva coperta la salma del defunto.
27 ferale: “crudele”.
che senza manto giaccia chi tanti conquiderne28 seppe”.
Tanto diceva; e restò convinto il nostro animo altero.29
Ella così di giorno a tessere imprese la tela, 105 e poi di notte, a lume di fiaccola, tutto sfaceva.
Restò tre anni occulto l’inganno, e gabbati gli Achivi; 30 ma, come il quarto giunse, tornando la bella stagione, una delle sue donne31 c’informò, che tutto sapeva; e la cogliemmo mentre sfaceva la fulgida tela.
110 Così, pur contro voglia, le fu necessario compirla.
E questo i pretendenti rispondono a te, perché bene tu sappia i fatti, e teco32 li sappiano tutti gli Achivi.
Alla sua casa or tu rimanda tua madre, ed imponi che sposi uno di noi, chi suo padre le imponga, e le piaccia».
[115-129] A queste parole Antinoo fa seguire la minaccia di non abbandonare mai la reggia di Ulisse, continuando a consumarne le ricchezze assieme ai compagni.
Il presagio divino
[130-146] Telemaco si rifiuta di cacciare di casa la madre, temendo di dover pagare un compenso a suo padre Icario, e di dover poi giustamente subire la vendetta che, a causa di questo suo atto, Penelope domanderebbe agli dèi. Vendetta, del resto, è ciò che egli stesso in questo momento merita, e promette ai Proci di pregare Giove affinché presto gliela conceda. A tale dichiarazione del giovane, che tuttavia ancora non ha invocato il padre degli dèi, Giove risponde prontamente mandando un segno divino.
E Giove tonante, dall’alto, dal vertice del monte, scagliò due aquile a volo.
28 conquiderne: “conquistarne”, “acquistarne”. Non è degno della passata ricchezza di Laerte il fatto che egli ora muoia senza neppure un sudario, lui che ne avrebbe potuti acquistare molti.
29 altero: “fiero”, “superbo”.
30 Restò tre anni occulto l’inganno, e gabbati gli Achivi. Da ordinare così: (per) tre anni l’inganno restò occulto (“nascosto”) e gli Achivi (restarono) gabbati (“ingannati”). Occulto e gabbati sono due complementi predicativi del soggetto (rispettivamente di inganno e di Achivi), dipendenti dal verbo restare
31 una delle sue donne: si fa riferimento a una serva di Penelope.
32 teco: “con te”, “assieme a te”. Allo stesso modo possiamo trovare le forme meco (“con me”) e seco (“con sé”, “con loro”).
Queste calarono un po’, secondo gli spiri33 del vento, l’una vicina all’altra, librate su l’ali distese.
150 Poi, quando furono giunte sovressa la piazza sonora,34 volando a rota, qui starnazzarono35 forte le penne, tutti guardarono in viso, dagli occhi spirando rovina; e l’una all’altra con l’unghie squarciando la gola ed il collo, verso le case d’Itaca, a destra avventarono il volo.
155 Quando ebber visti gli augelli,36 sgomenti rimasero tutti, ed ondeggiavano in cuore che cosa avvenire dovesse.37
Ed Aliterse, l’eroe vegliardo, di Mastore figlio, parlò, che quanti aveva compagni d’età superava nel decifrare voli d’augelli e profetici segni.
160 Questi, con senno e prudenza parlò, pronunciò tali detti: «Porgete ascolto a quello ch’io sono per dire,38 Itacesi; e specialmente ai Proci rivolti sian questi miei detti, poiché grave sciagura su loro già rotola: Ulisse non rimarrà più a lungo lontan dai suoi cari; ma presso39
165 forse a quest’ora già si trova, già strage e sciagura per tutti quanti i Proci prepara; ed avremo il malanno anche molti altri che in Itaca abbiamo soggiorno. Or su via,
33 Gli spiri sono i “soffi” del vento. Spirare significa “soffiare”.
34 La piazza è detta sonora per via del vociare delle persone in essa radunate. Si tratta di una figura retorica chiamata metonimia, con la quale si indica un oggetto attraverso l’utilizzo di un termine che ha con il primo un rapporto logico o materiale. In questo caso, infatti, non è la piazza a essere di per sé sonora, ma è il vociare delle persone presenti che la rende tale; l’aggettivo sonora, che logicamente andrebbe riferito alle persone contenute, invece qui concorda col “contenitore” piazza.
35 starnazzarono Starnazzare significa letteralmente “agitare le ali sbattendole contro terra”; dunque significa anche “fare chiasso”. Quando si dice che le oche starnazzano, in realtà non si vuole indicare il loro verso, bensì questo sbattere di ali chiassoso.
36 augelli: “uccelli”. I Greci prima e i Romani in seguito credettero di poter leggere il futuro attraverso l’osservazione del volo e del canto degli uccelli. Non tutte le persone, però, possedevano questa capacità divinatoria: ne erano capaci solo alcuni indovini, chiamati àuguri. Ancora oggi con la parola augurio si indica il desiderio, il presentimento di un bene per il futuro. Augurio, augure e augello (da cui l’italiano uccello) derivano dalla medesima radice au-/av-
37 ondeggiavano in cuore che cosa avvenire dovesse. Con questa splendida metafora Omero mostra l’incertezza e la paura che assalgono le menti di coloro che assistono alla scena, paragonabili solamente al movimento dell’onda del mare: il cuore, raffigurato come una barca in mezzo a un mare in tempesta, viene spinto dalle onde ora di qua ora di là. Si consideri inoltre che i Greci ritenevano che il cuore fosse la sede non solo degli affetti, ma anche dell’intelligenza.
38 sono per dire: “sto per dire”. È un verbo fraseologico.
39 presso: “vicino”. Qui è utilizzato con funzione di avverbio.
sia provveduto in tempo che i Proci desistano;40 ed essi si pieghin di buon grado: sarà molto meglio per loro, 170 ch’io senza prove non faccio presagi, ma so quel che dico. Ed anche per Ulisse tornâr tutti veri i presagi,41 come io li dissi, quando gli Achivi salparon per Ilio, e seco loro,42 Ulisse l’accorto partiva. Gli dissi che, dopo molti travagli, perduti i compagni suoi tutti, 175 dopo venti anni, in patria tornato sarebbe; né alcuno più lo conoscerebbe. Ciò dissi; ed or tutto s’avvera».
Ecco e di Pòlibo il figlio, Eurìmaco, questo rispose: «O vecchio, su, da bravo, ritorna ora a casa, e il profeta fallo ai tuoi figli, perché non incappino in qualche malanno.
180 Su questo punto, io sono profeta di te più valente. Uccelli, tanti e tanti ne volano ai raggi del sole, né tutti quanti sono fatidici.43 Ulisse è ben morto, lungi di qui. Magari tu pure così fossi morto, che tanto non avresti parlato e spacciato presagi, 185 né di Telemaco avresti la furia aizzata, sperando qualche regalo, ch’ei voglia largirti, e recartelo a casa. Ora, una cosa chiara ti dico, ed avrà compimento. Se tu, che tante cose, da tanto, hai veduto, indurrai, ecciterai, coi tuoi detti, un giovane, a duro contegno,44
190 egli si troverà costretto a più acerbo partito;45 e a te, vecchio, imporremo la multa; e rodendoti il cuore, tu la dovrai pagare; né lieve sarà la tua doglia».
L’annuncio del viaggio di Telemaco
[193-205] Dopo aver brutalmente minacciato Aliterse, Eurimaco si rivolge a Telemaco, ribadendo quanto pochi istanti prima gli aveva detto Antìnoo: se non vuole continuare a vedere le proprie ricchezze consumate e divorate,
40 desistano: “cedano”, “lascino perdere”.
41 tornâr tutti veri i presagi: “si avverarono tutti i presagi”.
42 seco loro. Seco significa “con loro”; loro è pertanto semplicemente rafforzativo.
43 Fatidico significa letteralmente “che dice il fato”, cioè “che è capace di rivelare gli eventi futuri”.
44 duro contegno: “atteggiamento deciso e battagliero”.
45 più acerbo partito: “una più dura sorte”, “un peggior destino”.
torni egli a casa e rimandi Penelope da Icario, cosicché nuovamente sia data in sposa a qualcuno.
E a lui queste parole Telemaco scaltro rispose: «Eurìmaco, e voi tutti che ambite sposare mia madre, io non vi voglio pregare, non voglio più a lungo parlarvi. Questo già tutti i Numi, già tutti gli Achivi lo sanno.
210 Su, via, datemi un legno veloce,46 con venti compagni, che per andare e tornare forniscano meco la via, però che47 a Sparta io voglio recarmi, ed a Pilo sabbiosa, a dimandar di mio padre novelle, che manca da tanto, se me ne dia qualcuno degli uomini, o n’oda la Fama,48
215 che suol recare notizie degli uomini, e figlia è di Giove. E se mai sentirò che vive mio padre e che torna, pur tribolato così, potrei sopportare un altro anno; ma se invece saprò ch’è spento, non è più tra i vivi, farò ritorno al suolo nativo; ed un tumulo a lui
220 innalzerò, gran copia49 farò di funebri offerte, quante convengono; e poi darò mia madre a uno sposo».
[222-255] Telemaco ha dichiarato le sue intenzioni davanti a tutta l’assemblea degli Itacesi. Non ha dunque più bisogno di parlare. Saranno altri, Mentore e Leocrito, a continuare lo scontro litigioso, il primo difendendo le ragioni
46 Con il termine legno si sta qui indicando in realtà la “nave”. Si tratta di una metonimia, con la quale si utilizza al posto dell’oggetto di cui si vuole parlare (“nave”) il materiale di cui esso è fatto (legno).
47 però che: “poiché”.
48 La Fama è personificata e appare come un essere divino. Veniva immaginata come un mostro alato gigantesco capace di spostarsi con grande velocità, coperto di piume sotto le quali si aprivano tantissimi occhi per vedere. Per ascoltare, usava un enorme numero di orecchie e diffondeva le voci facendo risuonare infinite bocche nelle quali si agitavano altrettante lingue. È descritta molto bene da Virgilio nella sua Eneide: «Subito va la Fama per le grandi città; la Fama, fulminea fra tutti i mali. Possiede vigore di movimento, e acquista forze con l’andare; dapprima piccola e timorosa, poi si solleva nell’aria e avanza sul suolo, e cela il capo tra le nubi. La Terra madre la generò veloce di passi e d’infaticabili ali, mostro orrendo, immane. Di quante piume riveste il corpo, tanti vigili occhi ha sotto, tante lingue, e altrettante bocche risuonano e orecchi protende. Di notte vola tra il cielo e la terra nell’ombra, stridendo, e non chiude gli occhi al dolce sonno; di giorno siede spiando sul culmine di un tetto, o su alte torri, e sgomenta grandi città, tenace messaggera tanto del falso e del malvagio, quanto del vero» (Eneide, libro IV, vv. 173-188).
49 gran copia: “grande quantità”, “abbondanza”.
del giovane figlio di Ulisse, il secondo parteggiando per i Proci. L’assemblea, infine, viene sciolta.
La preghiera a Minerva
I popolani si spersero, ognuno movendo al suo tetto, e i pretendenti verso la casa d’Ulisse divino. Ma Telemaco, solo venuto alla spiaggia del mare, tuffò nei bianchi flutti le mani,50 e si volse ad Atena:
260 «Odimi, o Diva, che ieri scendesti nella mia casa, e m’ingiungesti che, ascesa la nave,51 pel cerulo52 ponto io navigassi, e notizie chiedessi del padre, che lungi è già da tanto. Ma ora mi pongono indugio53 gli Achivi, e più di tutti gli altri i Proci arroganti e maligni».
265 Queste parole diceva pregando; ed Atena gli giunse presso, che assunta aveva la voce di Mèntore,54 e il volto; e, favellando, a lui parlò queste alate parole: «Mai tu non fosti, né mai sarai stolto, Telemaco, o inetto,55 se di tuo padre in te stillato56 è il buono ardimento.
270 Deh! Che uomo era quello, per compiere imprese e discorsi! Non ti sarà dunque vano, né senza effetto il viaggio. Se poi, madre non t’è Penelope, e quei non t’è padre, non t’avverrà, credo io, di compiere ciò che disegni.57 Pochi dei figli, invero, riescono simili ai padri:
50 tuffò nei bianchi flutti le mani. Immergere le mani nell’acqua era un gesto rituale di purificazione e aveva un significato preciso. Ci si lavava le mani prima di pregare per essere puri, cioè puliti, nel momento in cui ci si accostava alla divinità. Dell’esistenza di questo rituale, comune a molte religioni antiche, abbiamo oggi una testimonianza nella purificazione che precede la preghiera musulmana.
51 Ascendere è il contrario di discendere e significa quindi “salire”. L’espressione qui significa “dopo essere salito sulla nave”.
52 cerulo: “del colore del cielo”, “azzurro”.
53 mi pongono indugio: l’espressione porre indugio significa “ostacolare”.
54 Mentore è un amico di Ulisse, del quale Minerva prende spesso le sembianze quando si mostra agli uomini nel corso dell’avventura narrata nell’Odissea.
55 Inetto deriva dal latino in-aptus e significa letteralmente “non adatto”, “incapace”. Qui è preceduto dalla congiunzione o. Si ordini così: tu, Telemaco, non fosti mai, né mai sarai, stolto o inetto
56 In latino stilla significa “goccia”. Stillato si dice di una sostanza che cade goccia dopo goccia, come se il coraggio di Ulisse si fosse travasato a poco a poco nel figlio Telemaco.
57 disegni: il verbo disegnare qui va inteso come “progettare”.
275 i più sono più tristi,58 ben pochi migliori dei padri.
Ma tu no, nel futuro non mai sarai stolto ed inetto, ché l’accortezza d’Ulisse non mai t’è fallita nel seno: e queste imprese spero che tu possa addurre a buon fine.
Più non curarti dunque di ciò che disegnano i Proci,
280 né dei progetti loro; non sono assennati né giusti, né prevedere sanno la Morte e la livida Parca59 ch’è già su loro, perché debban tutti in un giorno perire.
Né più a lungo dovrà tardare il viaggio che brami: tale paterno amico io sono per te, che una pronta 285 nave t’appresterò, che sarò nel viaggio al tuo fianco».
La preoccupazione di Euriclea
[286-342] Telemaco fa ritorno a casa, dove lo attendono i Proci. Questi tentano di accattivarsi la simpatia del giovane invitandolo a unirsi a loro nel banchetto, dimenticando l’inimicizia che li divide. Telemaco però rifiuta con fermezza. Ne segue l’ennesimo litigio, cui i Proci sommano diversi auguri e minacce di morte per il giovane. Ignorandoli, Telemaco raggiunge le cantine, dove trova Euriclea, la serva fedele, alla quale dà istruzioni per i preparativi del viaggio e a cui rivolge alcune speciali raccomandazioni.
La chiamò dunque Telemaco, e queste parole le disse: «Mamma,60 su dunque, via, ne l’anfore versami vino 345 soave, il più gustoso fra quelli che tu tieni in serbo, per amore d’Ulisse divino, di quel poveretto, se mai qui tornerà, schivando le Parche e la Morte; dodici fanne colme, e adatta su tutte un coperchio, e quindi versa in otri61 di pelle cuciti farina:
58 In latino l’aggettivo tristis non significava solamente “di cattivo umore”, come oggi, ma anche “di cattiva qualità”; qui infatti tristi è da intendersi come “peggiori”.
59 Le Parche erano le divinità che presiedevano al destino dell’uomo. Erano raffigurate come tre vecchie e scorbutiche tessitrici, vestite con scuri stracci. La prima filava il tessuto della vita, la seconda assegnava i destini a ogni individuo stabilendone anche la durata, e la terza tagliava il filo della vita al momento stabilito. Le loro decisioni erano immutabili: neppure gli dèi potevano cambiarle. Livida significa “scura”, appunto perché vestita di scuri abiti. Ancor oggi si chiama livido la macchia scura che si forma sulla pelle a seguito di un trauma.
60 Mamma: Telemaco si rivolge a Euriclea con un termine molto affettuoso, essendo stata la sua nutrice, e prima ancora quella di suo padre.
61 L’otre è l’antenato dell’odierna borraccia. Era una sacca di pelle animale dentro la quale veni-
350 venti vi sian misure di grano schiacciato alla mola,62 e nessun altro lo sappia. Prepara, e tien qui tutto pronto, ché a prenderlo io verrò, come giunto sia Vespero,63 quando alle sue stanze salga mia madre, e s’accinga a dormire. Ch’io voglio a Sparta e a Pilo sabbiosa recarmi, e notizie
355 chieder, se averle mai potessi, del padre diletto». Disse. Ed in pianto scoppiò la fida nutrice Euriclea; e, singhiozzando, a lui parlò queste alate parole: «Figlio mio caro, e come ti venne mai questo pensiero?
Dove andar vuoi, pel mondo, che è tanto grande, tu gioia
360 unica della tua casa? È morto lontano tuo padre stirpe di Numi, Ulisse, fra genti straniere. Ed i Proci come tu parta, ordiranno raggiri, sicché tu di frode debba perire, ed essi divorino tutti i tuoi beni!
No, no, rimani qui, rimani sul tuo:64 ché bisogno
365 non hai d’andare errando, cercando malanni pel mare».
A lei queste parole Telemaco scaltro rispose:
«Mamma, fa’ cuore: questo consiglio non fu senza un Nume.
Giurami invece che nulla di questo a mia madre dirai, prima che undici o dodici giorni non siano trascorsi,65
370 o ch’ella sappia ch’io son d’Itaca lungi, e s’affligga, sì che le guance belle non debba distrugger nel pianto».
vano conservati acqua o vino necessari per affrontare un viaggio. Poteva essere utilizzato anche quale contenitore per farine.
62 La mola è la grossa pietra di forma circolare che viene utilizzata nei frantoi per triturare il grano e farne farina. La si trova nei mulini (che alla mola devono il proprio nome). Una curiosità: nella nostra bocca abbiamo dei denti detti molari, che sono larghi e piatti e sono così chiamati perché servono a frantumare e triturare il cibo, esattamente la stessa azione compiuta da una mola all’interno di un mulino.
63 Vespero è il nome con cui veniva indicato il pianeta Venere, all’occhio umano simile a una semplice stella; questo astro è il primo ad apparire nel cielo poco prima del tramonto, e pertanto indica l’imminente venuta della sera.
64 rimani sul tuo: “rimani a proteggere e custodire i tuoi averi”.
65 prima che undici o dodici giorni non siano trascorsi. È piuttosto buffo immaginarsi una madre che debba aspettare undici o dodici giorni prima di accorgersi dell’assenza da casa dell’unico figlio. Qui la quantità di giorni indicata da Omero non è da intendersi in senso letterale, ma vuole indicare simbolicamente un periodo di tempo sufficientemente lungo.
[372-401] Minerva intanto si aggira per le strade di Itaca avendo assunto le sembianze del giovane Telemaco. Riesce così a radunare nel cuore della notte venti marinai, i quali preparano subito la nave per partire. La dea raggiunge poi il palazzo di Ulisse e lì, avendo assunto le sembianze di Mentore e avendo fatto calare il sonno sugli occhi dei Proci, informa Telemaco di come tutto sia disposto per la partenza. Il giovane Telemaco e la dea, allora, raggiungono i compagni sulla spiaggia.
Or, poi che scesi alla spiaggia furon essi e giunti alla nave, qui su la riva i compagni chiomati trovarono; e ad essi tali parole volse Telemaco, forza divina:
405 «Su via, compagni, andiamo, pigliam le provviste, che pronte sono già tutte ne l’atrio: mia madre né ancella veruna66 nulla ne sa: solo una di quelle n’ha udito parola».
E così detto mosse. Seguirono tutti i suoi passi, e portâr tutto sopra la nave dai solidi banchi,67
410 come ordinato aveva d’Ulisse il figliuolo diletto.
Poi su la nave salì Telemaco; e innanzi era Atena, che su la poppa sedé del legno; e Telemaco stette presso alla Dea. Le funi disciolsero allora i compagni, e, asceso anch’essi il legno, sederono presso gli scalmi.68
415 Atena Diva ad essi propizia una brezza, gagliardo un Zefiro inviò, che garrìa69 sul purpureo mare.70
Ed i compagni incitò Telemaco, e l’ordine diede di metter mano agli attrezzi. Fûr docili quelli al comando; e l’albero d’abete rizzato, nel cavo del baglio71
66 Veruna letteralmente significa “alcuna”. Preceduto da né diventa “nessuna”.
67 I banchi sono le panche dove sedevano i rematori.
68 Gli scalmi sono i sostegni lungo il bordo della nave ai quali viene appoggiato il remo.
69 garrìa: garrire significa “fischiare”. Comunemente il verbo è riferito agli uccelli, mentre qui è riferito a Zefiro, un vento, che al pari dei volatili corre sulla superficie del mare.
70 Qui il mare è purpureo, cioè, verrebbe da tradurre, “violaceo”. Tra gli aggettivi che i Greci utilizzavano per descrivere il colore del mare ve ne era uno che significava letteralmente “color del vino”. Con tale termine, tuttavia, essi intendevano semplicemente riferirsi a un tipo di colorazione scura.
71 I bagli in una nave sono le assi di legno collocate orizzontalmente che uniscono le due sponde dell’imbarcazione. Nelle antiche navi, durante la navigazione, l’albero veniva montato solo quando bisognava utilizzarlo.
420 lo conficcarono, e fermo lo tenner legato agli stragli;72 e issaron con le drizze73 robuste la candida vela. Gonfiò la vela a mezzo la brezza:74 dintorno a la chiglia75 alto strepe’,76 sotto il corso del legno, il purpureo flutto: la nave lungo il flutto correva, e compieva il viaggio.
425 Poi, delle funi i capi legati, entro il celere legno colme di vino levaron le coppe e libarono77 ai Numi, ch’àn sempiterna vita, che ignoran la morte; e su tutti alla possente figlia di Giove ch’à glauche le ciglia. Tutta la notte e all’alba così fece rotta la nave.
72 Gli stragli sono dei cavi che dovevano sostenere l’albero, una volta che questo veniva issato.
73 Le drizze sono le corde utilizzate per issare la vela.
74 Gonfiò la vela a mezzo la brezza. Da ordinare così: la brezza gonfiò la vela a mezzo (cioè “nel mezzo”).
75 La chiglia è lo scheletro della nave, la struttura principale del suo scafo.
76 alto strepe’: “mandò un forte rumore”, “fece un violento rumore”.
77 libarono Libare significa “bere”, “brindare” in onore degli dèi.
Libro III
Lo sbarco a Pilo
E il sole balzò su, lasciando la bella palude,1 verso la bronzea2 volta del cielo, per fulgere ai Numi ed ai mortali sopra la terra datrice di biade.3
E giunser quelli a Pilo,4 la salda città di Nelèo.5
5 I Pili, presso al mare, di tori negrissimi offerta faceano al Dio che scuote la terra, che azzurre ha le chiome.6
[7-11] Telemaco giunge a Pilo mentre gli abitanti della città sono intenti a sacrificare agli dèi nove tori. Giunti a riva, piegano la vela e scendono dalla nave.
Dunque, sbarcò Telemaco, e Atena i suoi passi guidava, Dea dalla glauca pupilla, che prima parlò, che gli disse: «La timidezza per te più non fa, né punto né poco:7
15 ché traversato il mare, Telemaco, hai tu, per sapere del padre tuo, qual terra lo copre,8 qual sorte l’ha colto.
1 la bella palude. Con questa espressione si fa riferimento al mare. I Greci pensavano che il sole al tramonto si immergesse nell’oceano e poi sorgesse da lì il mattino seguente.
2 La volta del cielo è detta bronzea per via del suo colore luminoso, lucente.
3 Il termine biada si riferisce oggi genericamente a numerose specie di cereali, dati in pasto agli animali. Anticamente indicava soprattutto l’avena, all’epoca molto diffusa in tutte le regioni del Mediterraneo.
4 In Grecia esistevano almeno tre città aventi per nome Pilo. La Pilo di Nestore con molta probabilità è in Messenia, ovvero nella parte sud-occidentale del Peloponneso.
5 Neleo è l’antico signore di Pilo, di cui Nestore è uno dei dodici figli. Quando Eracle conquistò la città, uccise Neleo e dieci suoi figli.
6 Il dio che scuote la terra e che azzurre ha le chiome è Posidone, dio del mare. Omero si rivolge sempre a Posidone con questi due epiteti. Il secondo è molto chiaro, perché è facile aspettarsi che il dio del mare abbia i capelli azzurri, mentre il primo è meno comprensibile, perché in genere i terremoti non sono suscitati da Posidone. Tuttavia questo epiteto risulta più chiaro se si rilegge il libro XX dell’Iliade, dove Omero racconta di un terremoto scatenato proprio da questo dio. Si pensi inoltre come ancor oggi, nelle località costiere, dopo un terremoto si aspetti sempre l’arrivo di un ancor più temuto maremoto o tsunami.
7 né punto né poco: “per nulla”.
8 qual terra lo copre: “dove è seppellito”. Per i Greci la sepoltura aveva una grande importanza, innanzitutto perché era considerata l’ultimo gesto di pietà nei confronti di una persona cara;
A Nestore, su via, t’appressa diritto: vediamo che sentimento egli abbia nascosto nel seno. E tu stesso volgi la prece9 a lui, ché t’abbia a parlar senza inganno.
20 Non ti dirà menzogna, ché troppo è fornito di senno».
A lei queste parole rispose Telemaco scaltro: «Mentore, come andrò? Come dunque lo devo pregare? Sperto io non sono punto di accorti discorsi; e vergogna è per un giovane, quando rivolge dimande al più vecchio».
25 E a lui rispose Atena, la Diva che glauche ha le ciglia: «Pur qualche idea nella mente, tu stesso, Telemaco, avrai: altre vorrà suggerirtene un Nume: che nato e cresciuto tu, ben mi credo, senza favore dei Numi non sei».
E, così detto, mosse i piedi veloci a guidarlo10
30 Pallade Atena; ed egli seguì le vestigia11 divine.
L’accogliente vecchio eroe
E giunsero così tra i Pili seduti a convegno. Nestore qui coi figli sedeva; e i compagni, le carni pel desco12 negli spiedi figgean, le ponevano al fuoco. E come gli stranieri visti ebbero, accorsero tutti,
35 volsero ad essi saluti, sedere li fecero; e primo fattosi presso Pisìstrato, figlio di Nestore, a entrambi strinse le mani, e presso la mensa, su morbide pelli seder li fece, stese sovressa la sabbia del mare, accanto al fratel suo Trasìmede, accanto a suo padre.
40 E delle viscere parte gli offerse;13 e in un calice d’oro gli mescé vino.
inoltre perché si riteneva che se una persona non fosse stata sepolta non avrebbe avuto accesso al regno dei morti.
9 prece: “preghiera”. In latino pregare si dice precare. La c si è trasformata in g, ma se si osserva il verbo italiano imprecare, contrario di pregare, si ritrova tale e quale il verbo latino originario.
10 a guidarlo: “per guidarlo”, “per mostrargli la strada”. È una subordinata finale.
11 vestigia: “orme”, “impronte”. Investigare è un verbo che deriva da questo nome e significa letteralmente “seguire le impronte, le tracce”.
12 Il desco è la tavola su cui si apparecchiano i cibi per essere mangiati. La parola può indicare anche il momento del pranzo.
13 E delle viscere parte gli offerse. Da ordinare così: e gli offerse parte delle viscere. Le viscere sono le interiora dell’animale sacrificato (milza, fegato, cuore, polmoni), considerate la parte più prelibata del banchetto.
[41-62] Trasimede offre del vino agli ospiti, partendo da Mentore, che è il più anziano. Minerva, che si cela sotto le spoglie di Mentore, si compiace di questa forma di rispetto e invoca sulla famiglia di Nestore una benedizione divina, che immediatamente lei stessa impartisce. Segue un lauto banchetto.
[63-77] Terminato il banchetto, Nestore domanda agli ospiti chi essi siano e da dove vengano, se siano vagabondi e dispersi o se viaggino con un intento particolare. Prende allora la parola Telemaco:
«Nestore, figlio di Nelèo, gran vanto di tutti gli Argivi, di dove siamo tu chiedi? Rispondere dunque io ti debbo.
80 D’Itaca giunti siamo, che sorge alle falde del Neio.14
Una ragion privata, non pubblica, esporre ti devo.
Dietro alla fama io vo di mio padre, se n’oda novelle, del paziente15 Ulisse divino, che, come si narra,16 espugnò, combattendo con te, la città dei Troiani.
85 Di tutti gli altri, quanti pugnar coi Troiani, sappiamo dove ciascuno dové soccombere al fato di lutto: a lui volle il Cronìde17 infliggere ignota la morte,18 poi che nessuno sa dire di certo dov’egli sia morto, se su la terra ei cadde, nell’aspro cimento di guerra,
90 o se piuttosto in mare, tra l’onde perì d’Anfitrìte.19
Per questo, ai tuoi ginocchi20 giungo ora; perché ti compiaccia di raccontarmi la triste sua fine, se tu l’abbia vista
14 Il Neio è un monte presente sull’isola di Itaca.
15 paziente: l’aggettivo in questo caso non significa “che sa aspettare”, ma è legato alla radice del verbo patire; si può quindi intendere “che sa sopportare molti dolori, molte fatiche”.
16 come si narra. Questo brevissimo inciso mostra come il racconto della guerra di Troia all’epoca dovesse essere universalmente noto, al punto che il poeta può sostenere con verosimiglianza che esso sia arrivato in patria precedendo addirittura il ritorno degli eroi stessi.
17 Cronìde: è un patronimico che si riferisce al figlio di Crono, cioè Giove.
18 a lui volle il Cronìde infliggere ignota la morte. La gloria e il ricordo dell’eroe erano così tanto importanti nella società greca che non è possibile immaginare una condanna peggiore di una morte anonima e ignota, sconosciuta a tutti.
19 Anfitrite è una delle Nereidi, divinità marine, e moglie di Posidone. In Omero il suo nome indica anche più genericamente il mare.
20 ai tuoi ginocchi giungo ora. Nel mondo greco chi supplica una persona le abbraccia le ginocchia.
con gli occhi tuoi, se udita parola tu n’abbia d’altrui.21
Né per riguardo o pietà molcire ti piaccia i tuoi detti, 95 ma tutto ciò che ti cadde sott’occhio raccontami chiaro, te ne scongiuro, se pure mio padre, se il nobile Ulisse mai di parole o di fatti promessa ti fece e mantenne sotto Ilio, dove tanti dolori soffriron gli Achivi. Memore adesso di ciò, favellami vere parole».22
100 E Nestore, gerenio23 guerriero, così gli rispose: «Caro, perché mi ricordi le doglie che avemmo a soffrire coi figli impetuosi d’Acaia24 sul suolo troiano, e quante volte coi legni, sovresso il ceruleo mare, errando a far bottino, dovunque guidavaci Achille, 105 e quante combattemmo di Priamo intorno alla rocca? Qui cadder poi trafitti quanti eran fra noi più valenti.
Aiace giace qui, fortissimo, qui giace Achille, Pàtroclo qui, che per senno poteva agguagliarsi ai Celesti. Qui cadde pure il figlio mio prode, che macchia non ebbe,25
110 Antiloco, veloce nel corso, e temprato alla pugna.26
21 Telemaco interroga Nestore in quanto possibile testimone oculare delle disavventure di Ulisse. La testimonianza oculare era infatti considerata la più veritiera. La testimonianza indiretta, ovvero il racconto di fatti visti da altre persone e solamente riferiti, era invece considerata meno affidabile. Tuttavia Telemaco non disprezza neppure questa seconda possibile strada per conoscere qualcosa circa la sorte del padre.
22 Memore adesso di ciò, favellami vere parole: “ricordandoti ciò che ti ho appena detto, raccontami la verità”.
23 gerenio: “vecchio”.
24 figli impetuosi d’Acaia. Con questa espressione si fa riferimento ai guerrieri Achei. L’Acaia è la regione più settentrionale del Peloponneso. I suoi figli sono gli Achei, termine con cui, ad ogni modo, Omero indica tutti i Greci.
25 In questi versi sono elencati i nomi di alcuni valorosi guerrieri morti durante la guerra di Troia. Patroclo, scudiero di Achille, chiese all’eroe di poter indossare le sue armi e si gettò nella mischia, dove trovò morte per mano di Ettore. Achille morì mentre inseguiva alcuni fuggitivi troiani presso le porte Scee: Paride, infatti, lo colpì con una freccia al tallone, il suo unico punto vulnerabile. Aiace Telamonio si uccise con le proprie mani dopo che si vide negare le armi di Achille. Morto il Pelìde, infatti, gli eroi greci iniziarono a contendersi le sue armi. Esse sarebbero spettate al migliore dei Greci, e Minerva, arbitro della scelta, le assegnò a Ulisse, provocando così l’irreparabile sdegno del possente Aiace. Antiloco venne ucciso da Memnone mentre stava correndo in aiuto del padre Nestore: la sua morte così nobile ed eroica fa sì che esso possa essere definito senza macchia, cioè “innocente, di animo nobile”.
26 veloce nel corso, e temprato alla pugna. Temprato significa “resistente”, “addestrato”. Questo verbo è utilizzato più propriamente per i metalli e indica un procedimento che serve a renderli più resistenti. Nel corso e alla pugna sono due complementi di limitazione.
E molte altre sciagure patimmo, oltre a queste. E chi mai tutte narrarle potrebbe fra quanti sono uomini al mondo? Neppur se presso a me restando cinque anni, sei anni, chiedessi quanti mali patiron gli Achivi divini:
115 ché tediato27 prima faresti ritorno alla patria».
Il racconto del ritorno da Troia
«Nove anni li stringemmo d’assedio, molteplici frodi tramando a loro danno. E infine ci arrise28 il Cronìde. Quivi nessuno ardìa gareggiar con Ulisse di senno, che di gran lunga il primo, nel tesser molteplici inganni29
120 era quell’uomo divino, tuo padre, se tu, come dici, fosti da lui generato. Ti guardo, e rispetto m’invade: ché, nel parlare, a lui davvero somigli. Nessuno s’aspetterebbe parole sì scaltre da un giovin tuo pari.
Or, sin che Ulisse ed io lì fummo, non mai nei consigli,
125 nei parlamenti mai non avemmo parere discorde;30 ma con un solo avviso nel cuore e nel saggio pensiero, favellavamo agli Argivi, per fare che il meglio seguisse.31
Or, poi che avemmo abbattuta la rocca di Priamo eccelsa, Giove decise che lutto cogliesse gli Achivi al ritorno,
130 però che tutti quanti non erano saggi né giusti.32
Molti di loro perciò soccombettero al triste destino, per la funesta furia d’Atena dai ceruli sguardi,
27 tediato: “annoiato”.
28 ci arrise: “ci fu favorevole”.
29 tesser molteplici inganni. Nel libro II dell’Odissea si è visto come Penelope per lungo tempo riuscì a ingannare i Proci grazie alla propria tela, che ella tesseva di giorno e disfaceva di notte. Probabilmente non è un caso che Omero abbia voluto che lo strumento del più famoso degli inganni fosse proprio un telaio. È infatti affascinante notare come ancora al giorno d’oggi i verbi utilizzati per descrivere un inganno o un raggiro (tramare, tessere, ordire) siano presi metaforicamente in prestito dal linguaggio tecnico della tessitura.
30 Discorde significa letteralmente “diviso nel cuore”. Ulisse e Nestore non ebbero mai pareri contrastanti, ma anzi parlarono sempre con un solo avviso nel cuore
31 per fare che il meglio seguisse: “per far sì che accadesse la cosa migliore, più conveniente”. È una subordinata finale.
32 Giove impone agli Achei un ritorno difficoltoso perché Aiace Oileo aveva commesso un sacrilegio: aveva strappato Cassandra, la figlia di Priamo, dall’altare presso il quale si era rifugiata.
che la discordia accese tra i duci figliuoli d’Atrèo.33
A parlamento quelli chiamarono tutti gli Achivi,
135 stolidamente,34 contro l’usanza, al tramonto del sole; sicché vennero gravi di vino35 i figliuoli d’Acaia. Dissero allora perché radunate avevan le schiere.
E Menelao consigliava che tutti pensasser gli Achivi ad affrettare il ritorno su l’ampia distesa del mare.
140 Ad Agamènnone invece non piacque l’avviso: le genti ei trattener voleva, di vittime sacre ecatombi offrire, per placare d’Atena il terribile sdegno. Stolto! Né pur sapeva che invano l’avrebbe tentato: ché non si storna36 d’un tratto la mente dei Numi immortali.
145 Stavano i due così scambiandosi dure parole: ed ecco, in piè balzaron gli Achivi dai belli schinieri,37 con infinito clamore: ché in due si partivan gli avvisi. Passammo quella notte tra gravi pensieri ondeggiando, ché Giove sopra noi del danno addensava il cordoglio.38
150 Surta l’aurora, alcuni spingemmo le navi nel mare, e vi ponemmo dentro le prede con l’agili donne. L’altra metà della gente rimase, colà si trattenne presso Agamènnone, figlio d’Atrèo guidatore di genti. Noi sulle navi, dunque, salimmo. E veloci, le navi
155 presero il largo; e un Dio spianò l’onde feraci dei mostri.39 Giunti a Tènedo,40 offrimmo, pregando il ritorno, ai Celesti vittime sacre. Ma Giove nemico non volle il ritorno; e suscitò fra noi di nuovo una fiera contesa.
33 i duci figliuoli d’Atrèo. Gli Atridi, i figli di Atreo, sono Agamennone e Menelao.
34 stolidamente: “stoltamente”.
35 gravi di vino: “appesantiti dal vino”, “ubriachi”.
36 storna. Stornare significa “cambiare di opinione”.
37 dai belli schinieri. È un epiteto con il quale Omero si rivolge agli Achei. Significa “dai bei gambali”. Lo schiniere è quella parte dell’armatura che protegge la gamba.
38 del danno addensava il cordoglio. Da ordinare così: addensava il cordoglio del danno. Il cordoglio è il “dolore”. Questa parola è formata da cor, “cuore” e doglio, “dolore”. Del danno è complemento di causa.
39 l’onde feraci dei mostri: “le onde selvagge del mare”. È una metonimia. I mostri, infatti, sono gli animali enormi contenuti nel mare. Al posto della parola indicante il contenitore (mare) è stata utilizzata quella indicante il contenuto (mostri).
40 Tenedo è una piccola isola del mar Egeo, non particolarmente distante da Troia. Il primo giorno del viaggio di ritorno, dunque, non era stato molto lungo.
Le curve navi ascese,41 taluni tornarono al campo, 160 seguendo Ulisse, scaltro signore, dal savio consiglio, ligi al volere, così, d’Agamennone figlio d’Atrèo. Ma io fuggii, con quanti navigli m’avevan seguito, ché ben sapevo i mali che un demone tristo42 tramava.
Fuggì pure il Tidide,43 sospinse alla fuga i compagni; 165 e Menelao chioma bionda, più tardi, con noi pure venne».
[166-178] Il viaggio di Nestore e dei suoi compagni conosce numerose prove. In particolare, giunti a Chio, i naviganti sono incerti su quale direzione prendere, e Posidone, da loro invocato, mostra chiaramente la rotta da seguire per evitare pericoli mortali.
«Ed io rivolsi a Pilo la rotta; né il vento si spense, 180 da che l’aveva il Nume sospinto a soffiare propizio.
Così, di tutto ignaro, la patria, o figliuolo, rividi; e nulla so degli altri, chi sia già perito, chi salvo».
[183-206] Da molto tempo, dunque, Nestore non vede Ulisse, e le sue informazioni circa la sorte dell’eroe itacese non possono essere molto utili. Di tanti eroi greci Nestore ha sentito raccontare il ritorno, ma non del padre di Telemaco.
I consigli di Nestore
«Dicono infatti, che i Proci, che bramano sposa tua madre, nella tua casa, contro tua voglia, ti tramano danni.
Dimmi se tu di buon grado ti pieghi, o se invece la gente, 210 se il popol tuo t’aborre,44 per qualche responso del Nume.
E chi sa che a punire la lor prepotenza non giunga
Ulisse un dì: che solo non giunga, o con tutti i compagni. Deh!, se t’amasse così la Diva dagli occhi azzurrini, come una volta pensiero si dava del nobile Ulisse,
41 Le curve navi ascese: “dopo essere saliti sulle navi”. È una subordinata temporale. Le imbarcazioni sono dette curve per via della forma del loro scafo.
42 tristo: “malvagio”.
43 Tidide è un patronimico indicante Diomede, figlio di Tideo. Diomede era uno dei più valorosi eroi greci che combatterono a Troia.
44 aborre: “odia”, “caccia”.
215 quando soffriron tanto fra il popol di Troia gli Argivi!
Ch’io mai tanto palese45 non vidi che amassero i Numi, come Pallade Atena vicina era sempre ad Ulisse. Deh!, se volesse così diligerti, averti nel cuore!
Allora alcun dei Proci dovrebbe scordarsi le nozze».
220 A lui queste parole Telemaco scaltro rispose:
«O vecchio, questo augurio non penso che possa avverarsi; troppo esso è grande. Stupore mi tiene. Se tanto sperassi, non lo vedrei compiuto, neppur se volessero i Numi».
E gli rispose così la Diva dagli occhi azzurrini:
225 «Qual detto mai, figliuolo, t’uscì dalla chiostra dei denti?
Facile a un Dio, se vuole, salvare anche un uomo lontano.
Solo la morte, che tutti fa eguali, neppure gli Dei posson tenere lungi da un uomo diletto, quel giorno che la funesta Parca lo afferra con morte dogliosa».
230 E a lei queste parole Telemaco scaltro rispose: «Mentore, non si favelli di ciò, per desìo che se n’abbia.46
Vero non è che mio padre si appresti al ritorno; ma i Numi hanno per lui decretata la morte e la livida Parca».
[234-300] A questo punto Nestore risponde a una domanda di Telemaco, il quale vuole conoscere il racconto dettagliato della morte di Agamennone, in particolare il motivo per cui il fratello Menelao non fosse presente a difenderlo da Egisto, assassino dell’Atride. Nestore soddisfa la curiosità del giovane figlio di Ulisse.
«E tu, dunque, figliuolo, non ir47 così a lungo vagando lontan dalla tua casa, lasciando i tuoi beni in balìa di tali prepotenti, ché tutto non debban mangiare, tutto spartire; e vano48 per te non riesca il viaggio.
305 Ma ti consiglio e ti esorto che vada a cercar Menelao: ch’egli da poco è tornato da terre straniere, da genti d’onde sperare il ritorno nessuno in suo cuore potrebbe,
45 Palese è un aggettivo, qui usato con funzione di avverbio. Significa “chiaramente”.
46 per desìo che se n’abbia: “nonostante io ne abbia desiderio, lo desideri”; è una subordinata concessiva.
47 ir (ire): “andare”.
48 vano: “inutile”. È complemento predicativo del soggetto.
quando la furia dei venti sospinto lo avesse in quel mare, dove neppure gli uccelli che migrano possono andare
310 solo in un anno e tornare: tanto esso è terribile e grande. Con la tua nave e i compagni, su, dunque, ora mettiti in mare. O, se per terra vuoi gire,49 son pronti i cavalli ed il cocchio, ed i figliuoli miei, che teco faranno la strada alla divina Sparta,50 dov’è Menelao chioma bionda.
315 Volgi preghiera a lui, perché senza inganno ti parli; né ti dirà menzogna: ché grande saggezza è la sua».
Così parlava; e il sole disparve, la tenebra scese.
[318-329] Minerva ringrazia Nestore per i suoi saggi consigli; quindi lo invita a terminare il banchetto sacrificale e a dedicarsi ai preparativi per la notte.
330 Ora, poi ch’ebber libato,51 bevuto quant’ebbero voglia, allora Atena e, bello, Telemaco, al pari dei Numi, brama mostrarono entrambi di fare alla nave ritorno.
Ma li trattenne con queste parole il signore gerenio: «Giove con gli altri Celesti da me tale scorno52 allontani,
335 che voi da casa mia tornare dobbiate alla nave come un mendico53 io fossi, che pure non abbia una veste, non un mantello in casa, non una coperta d’avanzo, morbida, ch’ei ci si possa coprire, o se un ospite giunga.
Molti mantelli invece son qui, molte belle coperte.
340 Davvero no, che il figlio d’Ulisse, d’un tale guerriero, non dormirà, sin ch’io vivrò, sopra un banco di nave, né, dopo me, sinché rimangano in casa i miei figli, per ospitar chiunque verrà peregrino54 al mio tetto». E gli rispose Atena, la Diva ch’à glauche le ciglia:
49 Gire è una trasformazione di ire. Significa dunque anch’esso “andare”.
50 La città di Sparta si trova nel Peloponneso meridionale. Pilo e Sparta sono dunque abbastanza vicine, e il tratto che le separa può essere percorso via mare, circumnavigando a sud il Peloponneso o, più comodamente, via terra.
51 libato Libare significa “fare sacrifici”.
52 scorno: “vergogna”.
53 mendico: “mendicante”.
54 peregrino: “pellegrino”. Qui va meglio inteso come “straniero”.
345 «Parole, o caro vecchio, tu dici opportune; e ti deve dare Telemaco ascolto: che questo è il partito migliore. E questi, dunque, adesso verrà con te per dormire, nella tua casa; ma io tornar voglio al negro naviglio, per incorare55 i compagni, per dir tutto ad essi: ché solo
350 io posso dir che sono fra loro d’età più provetto.56
Giovani tutti son gli altri: seguito Telemaco han tutti per amicizia: ed hanno l’età del figliuolo d’Ulisse.
Dunque, io vorrei passare la notte vicino alla nave, e all’alba, poi, cercare la terra dei Càuconi57 prodi, 355 dove m’è necessario riscuotere un debito antico, e non da poco. E questo fanciullo ch’è giunto al tuo tetto, mandalo tu, con tuo figlio, sul carro; ed aggioga cavalli, per lui, quelli che sono più forti, e più rapidi al corso».
Detto così, la Diva dagli occhi azzurrini scomparve,
360 che un’aquila marina sembrò. Sbigottirono58 tutti a quella vista. E il vecchio fu tutto stupore; e la mano strinse a Telemaco, e il labbro movendo a parlare, gli disse: «Caro, non credo che tu riesca un dappoco, un imbelle, se, così giovane, già ti sono compagni i Celesti: 365 ché questo è veramente dei Numi d’Olimpo;59 e non altri che la figliuola di Giove, l’insigne60 Tritògena61 Atena, ella, che sovra tutti gli Argivi pregiava tuo padre. Siimi propizia, Signora,62 concedimi fama ed onore, per me, pei figli miei, per la mia virtuosa consorte: 370 e una giovenca a te sgozzerò bianca, larga di fronte,
55 incorare: “far coraggio”.
56 sono fra loro d’età più provetto. Provetto significa “avanzato”; d’età è un complemento di limitazione. L’espressione significa quindi “sono più grande, più avanti negli anni”.
57 I Cauconi erano un popolo antichissimo, del quale Omero stesso non conservava che il ricordo. Il territorio in cui risiedettero era il Peloponneso occidentale.
58 Sbigottirono: “rimasero stupiti”.
59 ché questo è veramente dei Numi d’Olimpo. “Poiché questo è davvero (uno) degli dèi dell’Olimpo”. Dei Numi è un complemento partitivo.
60 insigne: “famosa”, “nobile”.
61 Tritogena. È un epiteto che si riferisce a Minerva. Il suo significato non è molto chiaro: potrebbe voler dire “nata tre volte”.
62 Qui Nestore cessa di rivolgersi a Telemaco e inizia la propria preghiera a Minerva.
non doma ancora al giogo dell’uomo,63 né ancora legata. Questa t’immolerò, dopo averle indorate le corna».
Tali parole disse. Né Pallade Atena fu sorda.64
[374-391] Nestore conduce allora Telemaco presso i propri palazzi; nuovamente gli offre del dolce vino e fa preparare nell’atrio un letto per il giovane.
[392-462] Al risveglio, Nestore e i suoi figli sacrificano una giovenca a Minerva, come promesso il giorno precedente. Al sacrificio segue, secondo la consuetudine, il banchetto con le carni della vittima immolata. Dopo il banchetto, i pensieri del vecchio eroe tornano al giovane ospite itacese e alle sue necessità.
«Figli, su via, per Telemaco i vaghi cavalli criniti65 qui conducete, e aggiogateli al carro, ch’ei compia il viaggio».66
465 Disse. Ubbidirono quelli, né furono sordi all’invito: rapidamente aggiogarono al cocchio i corsieri67 veloci, e pane dentro e vino la dispensiera vi pose, e companatico,68 quali manducano69 i sacri sovrani.
E Telemaco allora salì sul bellissimo cocchio, 470 e presso a lui salì Pisistrato, duce di genti, figlio di Nestore; e nelle sue mani le redini strinse. Quindi sferzò i cavalli: né furono questi incresciosi;70 ma, l’alta71 casa lasciata di Pilo, volarono al piano, e da mattina a sera, correndo, agitarono il giogo.
63 non doma ancora al giogo dell’uomo: “non ancora domata dal giogo dell’uomo”. Il giogo è uno strumento di legno che viene posto al collo dei buoi per legare a essi un carro o un aratro da trainare.
64 Né Pallade Atena fu sorda. Questa è una figura retorica chiamata litote. La litote consiste nel dare un giudizio utilizzando un termine contrario preceduto da una particella di negazione. Non fu sorda significa infatti che ascoltò.
65 I vaghi cavalli criniti sono “i bei cavalli con la criniera”, ovvero “i cavalli dalla bella criniera”. Vago significa “desiderato”, quindi “bello”.
66 ch’ei compia il viaggio: è una subordinata finale.
67 I corsieri sono i cavalli.
68 Il companatico è tutto quello che si mangia con il pane (cum, “con” + panis, “pane”). Genericamente indica il cibo.
69 manducano: “mangiano”.
70 incresciosi: “contrari”.
71 La casa di Nestore è detta alta perché si trova in cima a un terreno scosceso.
475 Il sole profondò, s’ombrarono tutte le strade. Ed essi alla città di Fere eran giunti, alla casa di Diocle,72 figliuolo d’Orsiloco, figlio d’Alfeo. Ospiti questi li accolse, trascorsero quivi la notte. Come l’Aurora apparì mattiniera ch’à dita di rose,
480 strinsero al giogo i cavalli, ascesero il cocchio leggiadro, vibrar le sferze; e lenti non furono al corso i cavalli; ma pel frugifero73 piano movevano; e quivi il viaggio compiêr:74 tanto i cavalli movevano a corso veloce.
E il sole tramontò, scese l’ombra su tutte le strade.
72 L’antica Fere è l’odierna città di Calamata, posta a metà strada tra Pilo e Sparta. La stirpe di Diocle, signore di Fere, discendeva dal fiume Alfeo. Nell’epica omerica, infatti, i fiumi sono spesso personificati. Si veda ad esempio il libro XXI dell’Iliade, in cui Achille è impegnato in una terribile lotta contro il fiume Xanto.
73 frugifero: “che porta frutti”. Il frutto che nasce nei campi è il grano.
74 compiêr: “compirono”, “portarono a compimento”.
Libro IV
L’accoglienza di Menelao
[1-63] Telemaco e Pisistrato giungono a Sparta. Menelao è intento a festeggiare il matrimonio di due suoi figli e perciò non si accorge subito della presenza dei giovani viaggiatori. Chi se ne avvede, invece, è Eteone, servo dell’eroe Atride. Il vecchio servo, tuttavia, è indeciso se accogliere i due ospiti o se rimandarli a casa e dedicarsi totalmente al banchetto nuziale; si rivolge quindi a Menelao, il quale lo rimprovera e lo invita ad accogliere prontamente gli ospiti. Telemaco e Pisistrato allora lasciano i loro cavalli alle cure dei servitori e, dopo essersi rinfrescati e ristorati, vengono introdotti nella splendente reggia di Menelao.
E poi ch’ebber sedata1 la brama del cibo e del vino,
65 queste parole di Nestore al figlio Telemaco disse,2 presso tenendogli il viso, perché non udissero gli altri:
«Figlio di Nestore, guarda, diletto dell’anima mia, come per tutta la sala sonora sfolgora il bronzo, come rifulge l’oro, l’argento, l’elettro,3 l’avorio!
70 Forse di Giove Olimpio così dovrà esser la corte. Che meraviglie, e quante! Contemplo e non fo che stupire!» Mentre così diceva, l’udì Menelao chioma bionda, e, rivolgendosi ad essi, parlò queste alate parole: «Niun4 dei mortali può con Giove contendere, o figli, 75 ché i suoi palazzi, le sue ricchezze non hanno mai fine. Quanto ai mortali, può darsi che alcuno con me di ricchezze contenda; o forse no: ché dopo i travagli e l’errore5 lungo, d’otto anni, molte con me ne recai su le navi.
1 sedata Sedare: “placare”, “calmare”, “far cessare”. Da questo verbo nasce il termine sedativo
2 queste parole di Nestore al figlio Telemaco disse. Da ordinare così: Telemaco disse queste parole al figlio di Nestore
3 L’elettro è il cosiddetto “oro bianco”, una lega di oro e argento; altre volte il termine serve a indicare l’ambra, una pietra preziosa.
4 Niun: “nessuno”. Niun e nessuno sono due diversi esiti dell’unione della negazione ne al pronome uno (ne + uno).
5 errore: “errare”, “viaggiare senza mai riuscire a raggiungere la meta”.
A Cipro errando giunsi, nel suol dei Fenici, in Egitto,
80 e nella Libia, dove cornuti già nascon gli agnelli: ché qui figlian tre volte, nel giro d’un anno, le greggi.6 Quivi a nessun dei capi di gente, a nessun dei pastori, mancava mai né carne, né cacio, né latte soave: ch’offrono sempre latte le greggi, da mungerlo in copia.
85 Or, mentre erravo per quelle contrade e adunavo7 ricchezze tante, in quel tempo un uomo m’uccise con frode il fratello alla sprovvista, tradito dalla moglie sua maledetta.8
Così non mi fa lieto regnare fra questi tesori. Dai vostri padri poi, chiunque sian essi, sapute
90 le mie sciagure avrete: ché molto io soffersi, e perdei la mia casa, opulenta9 di tante bellezze e ricchezze. Oh!, se la terza parte soltanto ne avessi, ed in vita fossero gli uomini ancora che allora trovaron la morte, lungi dal suolo argivo10 che nutre cavalli, sotto Ilio!
95 Ora, sebbene per tutti col cruccio nel cuore m’affligga, – ché cento volte e cento fra i muri di questa mia reggia ora placo piangendo le doglie del cuore; ora poi desisto, ché fastidio vien presto del gelido pianto –non tanto, e me ne duole, per tutti costoro m’affliggo,
100 quanto per uno solo, che quando a lui penso, odiosi cibo mi rende e sonno: ché niun degli Achivi sofferse quanti travagli e fatiche sofferse Ulisse.11 E la sorte serbava a lui tormenti, a me non sanabil rimpianto di lui, che sta lontano da tanto da tanto; e neppure
6 In questi due versi Omero descrive la Libia in modo iperbolico. Gli agnelli sono infatti già dotati di corna fin dalla nascita, le pecore sono capaci di figliare tre volte all’anno. Queste indicazioni sono appunto esagerate (iperboli), perché le corna spuntano nella maturità dell’animale e le pecore partoriscono una volta sola all’anno. Così facendo, però, l’autore intende sottolineare la strepitosa ricchezza e fecondità di questa terra.
7 adunavo: “radunavo”.
8 Menelao si sta riferendo alla morte del fratello Agamennone, ucciso a tradimento dalla moglie Clitemnestra e dal suo amante Egisto.
9 opulenta: “ricca”, “piena”.
10 argivo: aggettivo che si riferisce alla città di Argo, da cui proveniva Agamennone. Argo è situata nella parte nord-orientale del Peloponneso.
11 Menelao non sa di aver di fronte il figlio di Ulisse, e pertanto la lode dell’eroe itacese non è una forma di cortesia, ma nasce da una sincera ammirazione.
105 sappiam se è vivo o morto. Ma forse lo piangono morto Laerte, il vecchio padre, la saggia Penelope, e il figlio Telemaco, che nato da poco lasciò nella reggia». Disse: e in Telemaco brama suscitò di piangere il padre. Di lui parlare udendo, gli caddero lagrime al suolo,
110 e agli occhi sollevò dinanzi il purpureo manto con ambedue le mani. Si accorse di ciò Menelao; e, riflettendo, incerto rimase, se il giovin lasciasse che menzione da sé facesse del padre o se prima interrogarlo dovesse, per aver contezza12 di tutto.
[115-129] Uscita dalle sue stanze, la bella Elena si presenta e si siede al fianco del marito. La seguono Adreste, Alcippe e Filo, sue serve.
130 Nel seggio s’adagiò,13 sotto i pie’ lo sgabello tenendo, e s’informò di tutto, volgendosi quindi allo sposo: «Già, Menelao divino, sappiamo che uomini sono questi, cui14 la fortuna sospinse alla nostra dimora? M’inganno, o dico il vero? Ma il cuore mi spinge a parlare.
135 Uomo non vidi mai così somigliante ad altro uomo, né donna ad altra donna, sì ch’io nel mirare15 stupisco, come a Telemaco questi mi par che somigli, al figliuolo d’Ulisse, animo eccelso, che in Itaca il figlio lasciava, nato da poco, quando, per me, cagna senza pudore,16
140 mossero a Troia gli Achivi, cercando la guerra feroce». E Menelao chioma bionda con queste parole rispose: «Anch’io, penso così, sposa mia, come tu congetturi: ché tali e quali sono i suoi pie’, tali e quali le mani,
12 Il termine contezza indica una conoscenza dettagliata. Oggi noi utilizziamo alcune espressioni analoghe: rendere conto, resoconto.
13 Il soggetto è Elena.
14 cui: in questo caso equivale a “che”, complemento oggetto della subordinata relativa.
15 mirare: “guardare”. Da questo verbo latino derivano gli aggettivi “mirabile” e “meraviglioso”.
16 cagna senza pudore. Elena si definisce in questo modo perché è consapevole della propria responsabilità nello scoppio della guerra di Troia. Infatti la guerra è stata originata dal suo rapimento da parte del troiano Paride e dal conseguente desiderio di vendetta degli Achei.
e come volge gli occhi, e il capo, e su fino i capelli.
145 Ed ora appunto a Ulisse divin m’era corso il pensiero, e ragionavo di lui, quanto ebbe a stentare,17 a soffrire, per mia cagione; e questi piangeva con lagrime fitte, e s’era tratto agli occhi dinanzi il purpureo manto».
[149-211] Telemaco non vuole insuperbirsi e pertanto non intende rivelare la propria identità. Interviene allora Pisistrato, il quale racconta a tutti la triste storia di Telemaco e il motivo del loro viaggio. Il racconto del giovane figlio di Nestore consente a Menelao di ricordare quale affetto lo leghi a Ulisse, il quale è purtroppo disperso. Le dolci parole accorate commuovono tutti i presenti, i quali si abbandonano al pianto. In breve, tuttavia, Menelao si ricompone e invita gli ospiti a continuare il banchetto.
Il cavallo di Troia
[212-259] Durante il banchetto Elena, mossa a compassione, decide di sciogliere nelle bevande un potente farmaco capace di far dimenticare qualunque dolore. Subito dopo, la bella moglie di Menelao racconta un episodio di cui
Ulisse è stato protagonista. Mentre infatti ella si trovava a Troia, un giorno Ulisse si travestì da mendicante e riuscì a penetrare nella città del re Priamo. Elena lo riconobbe, ma l’eroe greco fu abile a non farsi tradire dalla donna, evitando opportunamente le sue domande. Compiuto il sopraluogo all’interno della città di Troia, Ulisse poté allora tornare alle navi achee; prima, però, volle trafiggere con la propria spada molti guerrieri troiani, cogliendoli di sorpresa dentro le mura della loro stessa città. Al racconto di Elena si aggancia Menelao, raccontando anch’egli un’impresa di Ulisse, quella che lo rese più famoso: l’inganno del cavallo.
260 «Ormai di molti eroi conobbi il pensiero e il consiglio, e viaggiato ho per tante e tante contrade. Ma niuno queste pupille mai non hanno veduto, che tale fosse, qual era Ulisse tenace,18 magnanimo cuore. Ohi, che impresa fu quella, quanto ebbe a soffrire quel prode, 265 nel levigato cavallo dov’erano tutti i più forti degli Achei, per recare la strage e la Parca ai Troiani! 19
17 stentare: “faticare”. L’odierna espressione a stento significa infatti “a fatica”.
18 tenace: “resistente”.
19 Nel libro II dell’Eneide è raccontata con precisione la storia del cavallo di Troia. I Greci
Là tu20 venisti allora: poiché ti spingeva a chiamarci un dèmone, bramoso di far gloriosi i Troiani.21
Venìa dietro ai tuoi passi Deìfobo22 simile a un Dio.
270 Tre giri tu facesti, palpando il convesso rifugio,23 e tutti quanti i più forti fra i Danai per nome chiamasti, contraffacendo la voce di tutte le loro consorti. Ebbene, allora io stesso, col Tidide e Ulisse divino, seduti dentro il fianco del cavallo, udimmo i tuoi gridi.
275 Noi due, balzati in piedi, di brama ardevamo, o d’uscire, o rimanendo pur dentro, rispondere tosto;24 ma Ulisse ci frenò, ci trattenne, per grande che fosse la brama.25
E tutti quanti muti rimasero i figli d’Acaia.
Anticlo solo ai tuoi richiami risponder voleva.
280 Ma Ulisse a lui la bocca schiacciò con la mano possente, senza pietà. Così salvò tutti gli Achivi; e lo tenne sin che Pallade Atena non t’ebbe condotta lontano».
[283-342] Terminato il racconto di Menelao, Telemaco si accorge di essere molto stanco e chiede di potersi riposare. Il figlio di Ulisse si congeda dal signore di Sparta e viene accompagnato da una serva in una stanza. Qui trascorre la notte.
che stavano assediando Troia, infatti, avevano simulato la partenza e si erano tutti rifugiati all’interno di questa immensa costruzione in legno a forma di cavallo. I Troiani credettero che il cavallo fosse un dono agli dèi lasciato dai Greci e lo consideravano pertanto sacro. Alcuni addirittura volevano portarlo in città. Il sacerdote Laocoonte si oppose, denunciando l’inganno, e scagliò la sua lancia contro il cavallo. I Troiani, esitanti, non credettero a Laocoonte, e tuttavia non vollero neppure introdurre in città l’enorme statua di legno. Pochi giorni dopo Laocoonte venne ucciso assieme ai suoi due figli da due serpenti marini, colto di sorpresa mentre stava sacrificando un toro. L’episodio venne interpretato dai Troiani come un monito divino, una vendetta contro chi aveva oltraggiato il cavallo. La costruzione greca venne allora trasportata all’interno di Troia, tra le cui mura gli stessi cittadini aprirono una breccia. Appena entrati in città, di notte, i guerrieri greci uscirono dal cavallo e compirono la strage.
20 tu: Menelao si riferisce alla moglie Elena, con la quale sta dialogando.
21 Là tu venisti allora: poiché ti spingeva a chiamarci un dèmone, bramoso di far gloriosi i Troiani Menelao si riferisce all’episodio in cui Elena chiama per nome ad uno ad uno i guerrieri dentro il cavallo di Troia, imitando le voci delle loro mogli. Questa mossa deve essere stata ispirata in lei da una divinità avversa ai Greci: se loro avessero risposto dal ventre del cavallo, i Troiani avrebbero capito che si trattava di un inganno.
22 Deifobo è un figlio di Priamo; divenne il maggiore dei capi troiani dopo la morte di Ettore.
23 il convesso rifugio: è il cavallo, dentro cui si erano nascosti i guerrieri achei.
24 tosto: “subito”.
25 per grande che fosse la brama: “benché fosse grande il desiderio”. È una subordinata concessiva.
La mattina successiva riceve nuova e festosa accoglienza da parte dell’Atride. Su invito di Menelao, Telemaco espone chiaramente le ragioni della sua visita, domandando all’eroe greco se egli abbia notizie del padre Ulisse. Per soddisfare la richiesta del giovane, Menelao inizia il racconto del suo viaggio di ritorno da Troia, poiché le sole informazioni che possiede a tal riguardo le ha ottenute da Pròteo, divino abitatore del mare, incontrato in Egitto.
L’inganno a Proteo
[343-422] Il racconto del signore di Sparta parte da quando egli si trovava in Egitto, da dove gli dèi non gli consentivano di ripartire, facendo infuriare le onde ogniqualvolta provasse a mettere le navi in mare. Erano trascorsi venti giorni e Menelao e i suoi compagni iniziavano a patire la fame, scarseggiando le provviste. Menelao aveva ormai capito di aver scatenato la furia di un qualche dio, ma non sapendo quale, non aveva idea di come placarne l’ira. Allora Idotea, dea marina figlia di Proteo, ebbe compassione per la sorte degli eroi greci e suggerì a Menelao un inganno per intrappolare suo padre Proteo e costringerlo a rivelare loro quale fosse il dio che avevano offeso. Il giorno successivo Menelao fece esattamente quanto Idotèa gli aveva indicato.
«Come l’Aurora spuntò mattiniera, ch’à dita di rose, lungo le dune26 mossi del mare infinito, levai 425 fervide27 preci ai Numi: con me tre compagni recavo in cui più confidavo, per compier qualsiasi impresa. Ecco, e la Diva Idotèa nei gorghi del mare profondi s’immerse; e fuor del mare portò quattro pelli di foca, tutte scoiate di fresco, tramando a suo padre un inganno.
430 Poi, nella sabbia del lido, scavati giacigli, vi stette ad aspettarci. Noi giungemmo lì presso; ed in fila ella ci pose a giacere, gittò su ciascuno una pelle. E in quell’agguato avremmo trovata la morte; ché troppo ci torturava, funesto, l’odor delle foche marine: 435 chi mai dormir potrebbe vicino ad un mostro del mare?
Ma ci salvò, trovò la Diva efficace riparo.
Ambrosia avea recata con sé, di dolcissimo aroma:28
26 Con il termine dune si fa riferimento alla spiaggia.
27 fervide: “accese”, “potenti”.
28 Ambrosia: è propriamente il cibo di cui si nutrono gli dèi, che aveva la caratteristica di essere molto profumato.
sotto le nari29 a ciascuno la stese, ed il lezzo30 disperse.
Tutto il mattino restammo così pazienti all’attesa.
440 Ed ecco, fuor dall’acqua sbucarono in frotta31 le foche, e si corcarono32 in fila, vicino ai frangenti del mare.
A mezzogiorno, il vecchio,33 dal mare emergendo, satolle34
bene trovò le foche, ne fe’ la rassegna ed il conto, e mise primi noi nel novero;35 e il cuor non gli disse
445 ch’ivi era trama d’inganno. E anch’egli si pose a giacere.
Urlando, allora noi ci lanciammo, gittammo le braccia ad avvinghiarlo: né il vecchio del mare scordò le sue frodi:36 anzi divenne prima leone di fitta criniera, poscia dragone, poscia pantera ed immane cinghiale,
450 poi mobile acqua, poi parve albero eccelso fronzuto.37 Ma noi tenacemente su lui serravamo la stretta.
E quando infine, il vecchio, maestro d’astuzie, fu stanco, si volse a me con queste parole, con queste domande: “Figlio d’Atrèo, qual Nume con te macchinò queste insidie?
455 Ché mi prendeste, contro mia voglia, all’agguato? Che brami?” Così mi disse; ed io con queste parole risposi: “Vecchio, lo sai: ché tenti sviarmi con queste domande? Sai che da lungo tempo nell’isola indugio, né via posso trovare di scampo: sicché si distrugge il mio cuore.
460 Ora tu dimmi, almeno, ché nulla è nascosto ai Celesti, quale dei Numi così m’inceppa e mi lega il cammino, e quale il mio ritorno sarà sopra il mare pescoso”».
[463-541] Pròteo spiegò a Menelao che tutti i loro mali nacquero nel momento in cui essi si scordarono di sacrificare a Giove prima di mettersi in viaggio e
29 le nari: “le narici”.
30 Lezzo (o olezzo) è il “cattivo odore”.
31 in frotta: “in gran quantità”, “in gruppo”.
32 si corcarono: “si coricarono”, “si sdraiarono”.
33 il vecchio: si fa riferimento a Proteo.
34 satolle: “sazie”, “piene”; Proteo, che ha cura delle sue foche come un pastore delle sue pecore, si preoccupa che esse siano ben nutrite.
35 novero: “conto”. Annoverare significa infatti “contare”, “elencare”.
36 le sue frodi. Idotea aveva avvertito Menelao che il padre Proteo, una volta catturato, avrebbe provato a divincolarsi assumendo mille forme differenti.
37 fronzuto: “ricco di fronde”.
diede quindi indicazioni su come fare a riparare il torto fatto al padre degli dèi. Menelao volse allora un’altra domanda al vecchio dio marino: volle conoscere il ritorno dei suoi compagni eroi. La creatura divina raccontò anzitutto la sorte di Aiace, il quale non fece ritorno vivo a casa, e quella del fratello di Menelao, Agamennone, giunto salvo ad Argo, ma qui assassinato da Egisto. Menelao si addolorò di fronte al racconto della morte del fratello e si mise a piangere. In seguito domandò a Pròteo della sorte di Ulisse:
«“Ora di questi ho saputo. Ma parlami adesso del terzo, che vive ancor, prigione fra i gorghi del mare infinito”. Così gli dissi; ed egli rispose con queste parole: 545 “D’Ulisse tu vuoi dire, che in Itaca aveva dimora: lo vidi che di pianto bagnava in un’isola il ciglio, nell’antro38 della Ninfa Calipso, che a forza lo tiene, così ch’egli non può tornare alla terra nativa, poi che non ha compagni, né legni dagli agili remi,
550 che trasportar sul dorso lo possan del mare infinito.39 Per te, poi, Menelao, nutrito di Giove,40 destino non è morire in Argo, compir qui la sorte mortale; ma te nei Campi Elisi,41 del mondo agli estremi confini, i Numi condurranno, dov’è Radamanto42 crin biondo,
555 dove senza molestia per gli uomini scorre la vita, dove non cade neve né pioggia, né fiera procella,43 anzi l’Oceano sempre di Zefiro gli aliti adduce, che veemente44 spira, che reca frescura alle genti;
38 antro: “grotta”.
39 che trasportar sul dorso lo possan del mare infinito. Da ordinare così: che lo possan trasportar sul dorso del mare infinito
40 nutrito di Giove: “discendente di Giove”, in quanto Menelao era marito di Elena, figlia di Giove e Leda.
41 I Campi Elisi non sono esattamente il corrispettivo del nostro paradiso. I Greci lo consideravano infatti un luogo ultraterreno dove venivano accolti solo pochi privilegiati. I morti comuni andavano invece tutti nell’Ade.
42 Radamanto: figlio di Giove ed Europa, è il giudice che governa i Campi Elisi. Altri giudici infernali sono Minosse ed Eaco, che governano l’Ade e ne regolano l’accesso. Caratteristica comune di questi tre uomini, infatti, è quella di aver avuto in vita la fama di essere stati estremamente giusti e onesti, tanto da meritare una volta morti il ruolo di giudici delle anime.
43 fiera procella: “feroce tempesta”.
44 Veemente è propriamente un aggettivo, qui utilizzato come avverbio che significa “con forza”, “con violenza”.
ché genero di Giove te stimano, o d’Elena sposo”.
560 Detto così, tra i flutti del mare s’immerse. Ed io mossi verso le navi, insieme con gli altri miei prodi compagni; e il cuor, mentr’io movevo, m’ondava a tumulto nel seno».
Itaca, amata terra rocciosa
[563-576] Terminato il proprio racconto, Menelao invita il giovane figlio di Ulisse a trattenersi qualche giorno a Sparta, ma il giovane rivolge fieramente il pensiero alla sua città.
«Ma ora, in casa mia, su dunque, Telemaco, resta, sino che giunga l’undecimo giorno, il duodecimo giorno. Allora avrai da me congedo e bellissimi doni:
580 tre corsieri, ed un cocchio brunito,45 ed un calice bello v’aggiungerò, sì che tu ai Numi che vivono eterni possa libare, possa di me ricordarti ogni giorno». E a lui rispose il saggio Telemaco queste parole: «Qui trattenermi più a lungo, figliuolo d’Atrèo, non ti piaccia.
585 Anche per tutto un anno restar presso te gradirei, senza che mi prendesse la voglia de’ miei genitori, né della casa; tanto m’allieta l’udir la tua voce, i tuoi racconti. Ma già per me sono in pena i compagni nella divina Pilo, e a lungo tu qui mi trattieni.
590 E i doni che vuoi farmi, sian tali ch’io possa riporli:46 ché io non condurrò cavalli ad Itaca. A Sparta li47 lascerò, perché tu li possa godere. Tu piani vasti possiedi, ove fitti germogliano il cìpero e il loto,48 ed il frumento, e la spelta49 con l’orzo fulgente in gran copia; 595 ma in Itaca, né prati, né vie per cavalli: sol capre
45 Brunito non indica semplicemente il colore scuro, ma anche la sua brillantezza.
46 ch’io possa riporli. Telemaco, sapendo che la propria isola è inadatta ai cavalli, chiede doni altrettanto preziosi, ma di diversa natura; suggerisce infatti doni che possano essere riposti in uno scrigno. Riporli: “custodirli”.
47 Il pronome li si riferisce ai cavalli di Telemaco.
48 Il cipero è una pianta aromatica proveniente dall’isola di Cipro, da cui prende il nome. Con il termine loto si fa invece allusione al trifoglio.
49 La spelta è una specie particolare di frumento a spiga molto sottile.
pasce;50 eppur m’è più cara che s’ella pascesse corsieri.
E già, niuna isola è adatta pei cocchi, né ricca di prati, quante s’adagian nel pelago; ed Itaca meno d’ogni altra».
[599-614] Menelao loda la saggezza del giovane Telemaco e promette di cambiare i doni, offrendogli un cratere dorato.
Intanto a Itaca…
615 Ed in quel tempo, i Proci, dinanzi alla casa d’Ulisse, coi giavellotti, coi dischi, giocavan sul liscio spiazzato, com’eran soliti, mostra facendo di loro arroganza.
Antinoo sedeva col divino Eurimaco: entrambi capi dei Proci, che molto di forza eccedevan sugli altri.
620 Fattosi presso ad essi, Noèmone, figlio di Fronio, queste dimande, queste parole ad Antinoo volse: «Antinoo, dunque abbiamo contezza, oppur nulla sappiamo, quando Telemaco torni da Pilo sabbiosa? È partito con la mia nave; e adesso bisogno ne avrei, per recarmi
625 ad Elide, la bella città. Qui posseggo giumente, dodici, ed hanno sotto ciascuna un muletto che poppa.51
Ora vorrei svezzarne qualcuno, e venirlo domando».52
Disse; e stupirono gli altri; ché mai non avrebber creduto ch’ito sarebbe a Pilo Telemaco. Presso al porcaro, 630 presso alle greggi, pei campi credean che sarebbe rimasto.
Ed Antinoo, figlio d’Eupito, così prese a dire: «Dimmi la verità: dov’è andato? Che giovani ha scelto per suoi compagni? Scelti fra i nobili d’Itaca, o servi e mercenari? Ché pure di questo sarebbe capace.
635 Ed anche dimmi il vero di questo, ch’io voglio saperlo: se tuo malgrado, a forza t’ha tolta la nave, o se prego te n’ha rivolto, e tu concessa gliel’hai di buon grado».
50 pasce: “nutre”. Da questo verbo deriva la parola “pascolo”.
51 L’Elide è la regione nord-occidentale del Peloponneso, affacciata alla quale vi è l’isola di Itaca. Proprio a causa dell’inadeguatezza all’allevamento del territorio itacese, molti abitanti di Itaca possedevano dei pascoli sulla vicina terraferma.
52 e venirlo domando: “e vengo a domandare di poterlo prendere”. Noemone domanda di poter andare sulla terraferma a prendere qualche suo muletto da svezzare, e quindi chiede che gli sia data una nave, dal momento che la sua è stata affidata a Telemaco.
E Noèmone, figlio di Fronio, così gli rispose:
«Io di buon grado la nave gli diedi. Che mai si può fare,
640 quando un tal uomo ti prega, percosso da tante sciagure?
Negargli quanto ei chiede, sarebbe difficile cosa.
Gli fûr compagni quelli che in Itaca dopo di noi
sono i migliori: Mentore io vidi salire sul legno, se pur non era un Nume che avesse la stessa sembianza.
645 Di ciò non stupirei, ché in Itaca ieri mattina
Mentore ho visto, e quel giorno salpare lo vidi per Pilo».
Dette queste parole, tornava alla casa paterna.
E quelli, l’uno e l’altro crucciati nell’animo altero, posero fine ai giuochi, raccolsero tutti i compagni;
650 ed Antinoo, figlio d’Eupito, così prese a dire: «Poveri noi, non è cosa da poco, che questo viaggio abbia con tanta arroganza compiuto Telemaco. E noi nol credevamo! A dispetto di tanti,53 un ragazzo è partito da sé, scelto ha la gente migliore, varata la nave.54
655 Anche per il futuro saprà contro noi capeggiarli.
Giove lo stermini, prima che giunga al vigore degli anni!
Su, presto, datemi un legno veloce con venti compagni, sì che m’apposti e gli tenda, per quando ritorna, un’insidia entro gli ormeggi d’Itaca, oppur fra gli scogli di Same, 660 ch’egli col suo malanno veleggi a cercare suo padre!»
Disse; e approvarono tutti che séguito avesse il disegno; ed in pie’ surti, alla casa d’Ulisse rivolsero i passi.
Il sogno di Penelope
[663-774] Avendo udito le intenzioni dei Proci, l’araldo Medonte corre a riferire tutta la vicenda a Penelope. La donna viene così a sapere che il figlio Telemaco è partito e se ne dispera. A questo punto Euriclea non può tacere e rivela alla padrona la propria complicità, cercando inutilmente di rassicurarla.
775 Ma su ne l’alte stanze, la saggia Penelope, intanto, digiuna stava, senza né cibo toccar, né bevanda,
53 A dispetto di tanti: “contrariamente a quanto tanti pensavano”.
54 varata la nave. Varare una nave significa toglierne gli ormeggi e metterla in mare, pronta alla partenza.
e si struggeva, se il figlio sarebbe sfuggito alla morte, o se cader dovesse per mano dei Proci arroganti. Quanti disegni volge leone atterrito, se intorno
780 di cacciatori una schiera lo stringe, gli tende l’insidia, tanti volgeva pensieri Penelope. E il sonno la colse. E con le membra disciolte, reclina55 nel sonno giaceva.
Or quivi Atena, azzurra pupilla, ebbe un altro pensiero. Foggiò56 ne l’aria, forma di donna gli diede, un fantasma
785 simile a Iftìme, la figlia d’Icario magnanimo cuore, 57 ch’era ad Eumèlo sposa, signor de la reggia di Fere. Questa mandata alle case ell’aveva d’Ulisse divino, perché sviar potesse Penelope, sempre gemente e sempre lacrimosa, dai gemiti gonfi di pianto.
790 Dal chiavistello, presso la cinghia, nel talamo entrata,58 sopra il suo capo volò, queste alate parole le disse: «Anche nel sonno hai colmo di cruccio,59 Penelope, il cuore!
Pure non vogliono i Numi, cui lene60 trascorre la vita, che tu pianga e t’affanni. È, sappilo, già di ritorno
795 il figlio tuo: che i Numi nol tengono in conto d’un empio».61
A lei rispose queste parole Penelope saggia, entro le porte dei sogni sopita in dolcissimo sonno:62
«Perché sei qui venuta, sorella? Venir pel passato tu non solevi, perché la tua casa è tanto lontana.
800 E mi conforti ch’io desista dai tanti cordogli e dagli affanni che sempre mi crucciano l’animo e il cuore. Prima perdei lo sposo mio forte, dal cuor di leone, ch’era per ogni virtù famoso fra i Danai tutti: ora il figliuolo diletto partito è sul legno ricurvo, 805 semplice ancora, inesperto d’imprese e d’accorti discorsi.
55 reclina: “sdraiata”. Questo aggettivo è qui utilizzato con funzione predicativa.
56 Foggiò. Il verbo foggiare, o forgiare, significa “formare”, “dare forma”.
57 Figlia di Icario, e dunque sorella di Penelope. Iftime era sposa di Eumelo, signore di Fere.
58 Grazie alla sua consistenza aerea, Iftime riesce a entrare da una fessura posta all’altezza del chiavistello, senza bisogno alcuno di aprire la porta. Il talamo è la stanza da letto.
59 colmo di cruccio: “pieno di dolore”.
60 lene: “mite”, “facile”.
61 i Numi nol tengono in conto d’un empio: “gli dèi non lo considerano un uomo empio”.
62 entro le porte dei sogni sopita in dolcissimo sonno. Penelope dialoga con la sorella in sogno, senza svegliarsi. Sopita infatti significa “addormentata”.
Ed io perciò di lui m’affanno anche più che d’Ulisse, e tremo tutta, e temo che qualche sciagura lo colga, o nelle terre di quelli dov’ei s’è recato, o per mare, poi che ai suoi danni vanno tramando malevoli molti, 810 che voglion la sua morte, pria ch’egli ritorni alla patria».
E le rispose il vano63 fantasma con queste parole: «Fa’ cuore, e il seno tuo soverchio timor non accolga;64 tale al suo fianco, a guidarlo, cammina un compagno che ognuno prece farebbe d’averlo vicino, tanto egli è possente:
815 Pallade Atena, la Diva che prova pietà del tuo pianto. Ella m’ha qui mandato, perché tutto ciò ti dicessi».
E le rispose con queste parole Penelope accorta: «Dunque, se un Nume tu sei, se udita d’un Nume hai la voce, su via, parlami pure d’UIisse, di quel poverino, 820 se vive ancor, se vede tuttora la luce del sole, o se defunto è già fra le tenebre cupe d’Averno».65
E le rispose il vano fantasma con queste parole: «Non ti potrò di lui rispondere tanto sicuro, se vivo egli è, se spento. Né dir vane cose mi piace».
825 Detto così, dalla toppa dell’uscio il fantasma si sperse, tra le folate del vento. Dal sonno balzò la figliuola d’Icario, e il cuore in seno le fu consolato: sì chiaro erale apparso il sogno ne l’ètere buio notturno.
E i Proci, intanto, ascesa la nave, correvano il mare, 830 modo cercando come Telemaco avesse la morte.
Un’isola rocciosa si leva tra i flutti del mare, a mezza via tra Itaca e Same, tutta aspra di scogli: Astèride.66 Non grande; ma duplici rade67 vi sono per gli ancoraggi; e qui si fermaron gli Achivi68 all’agguato.
63 vano: qui l’aggettivo è usato nel suo significato di “inconsistente”.
64 il seno tuo soverchio timor non accolga. Da ordinare così: il seno tuo non accolga soverchio timore. Soverchio significa “eccessivo”, “troppo grande”.
65 Averno è sinonimo di Ade, Oltretomba, cioè il regno dei morti.
66 Astèride. L’unica isola a metà strada tra Itaca e Same è quella oggi chiamata col nome di Dascalio, che in realtà è poco più grande di uno scoglio.
67 Una rada è un’insenatura, riparata da venti e correnti marine, e quindi luogo ideale per attraccare la nave.
68 Gli Achivi sono, in questo caso, i Proci.
Sull’isola di Ogigia il lettore incontra per la prima volta Ulisse. Sinora ne ha sentito parlare, ma adesso lo vede agire. Una sorpresa, però, lo attende, costringendolo a mettere da parte qualsiasi immagine che egli se ne sia fatto: l’eroe, in disparte sulla spiaggia, piange, volgendo gli occhi all’orizzonte che si delinea sul mare. Ben lungi dall’essere un segno di debolezza, questo suo pianto, magistrale scelta di Omero, ci presenta Ulisse per quello che è, ossia un eroe pienamente umano, molto più vicino a noi del divino Achille, figlio di una dea e prodigiosamente dotato di forza e velocità. Egli piange la propria sorte, consumato dal desiderio di poter rivedere la patria e riabbracciare i propri cari. La sua eroicità non è sovrumana, ma trae origine dalla stessa forza misteriosa per cui una madre impara a vegliare sul figlio appena nato, un padre a lavorare notte e giorno per la propria famiglia: è una determinazione resa possibile dallo scopo per cui è vissuta, sostenuta da un affetto più grande. Il pianto di Ulisse, dunque, non nasce dallo sconforto, ma parla di una nostalgia. Il ritratto dell’eroe è completato dal racconto delle sue disavventure. Conosciamo allora un uomo saggio e prudente, che ha così a cuore la possibilità del proprio ritorno da non prendere mai decisioni avventate; anche quando le circostanze stringono, egli si mostra risoluto e pronto all’azione, senza rinunciare tuttavia a valutare ogni possibile strada da percorrere. È un capo amato dai propri uomini e a loro sinceramente legato, che con dolore assiste ai cedimenti e ai tradimenti di alcuni di essi e che cerca di non perderne neppure uno, ma che è costretto ad assistere impotente al loro crudele destino, avendo ormai deciso il Fato di strapparglieli tutti. È un fervido lavoratore, abile e instancabile artigiano. È un guerriero astuto, capace di domare con la propria intelligenza esseri che lo superano grandemente in forza e statura, ma la cui barbarie e trascuratezza rendono più simili agli animali che agli uomini. È un uomo vivo, nel quale, pur essendo egli costretto a vagare e a sopportare tante difficoltà e prove, affiora sempre il desiderio di esplorare il mondo e incontrarne gli abitanti, di legarsi ad essi e riceverne l’ospitalità. Ulisse non decide di fare un viaggio per esplorare il mondo, ma conosce il mondo perché costretto a viaggiare. Nel suo lungo errare non vi è nulla di programmato, ma ogni tappa si offre all’eroe come un nuovo imprevisto. Da sempre, allora, la tradizione letteraria ha inteso ravvisare in questo viaggio la metafora della vita umana. Il viaggio di Ulisse raffigura quello di ogni uomo: è il viaggio della vita. Non è un caso dunque, che Omero decida di far raccontare all’eroe stesso il proprio vagare. Il racconto di Ulisse presso la corte dei Feaci potrebbe assomigliare a un mero espediente narrativo (Omero avrebbe cioè semplicemente
bisogno di trovare un momento in cui raccontare gli avvenimenti precedentemente vissuti dal suo protagonista), ma in realtà ha un importante ruolo all’interno della storia. Ulisse, infatti, riprende consapevolezza di chi egli sia raccontando la propria vita, riassaporandone i dolori e riscoprendo l’aiuto divino ricevuto. Fu un racconto volto a dei curiosi ascoltatori? Ulisse raccontò le proprie avventure per intrattenere gli ospiti di Alcinoo? No, lo fece per se stesso. Essendo un uomo, come tutti gli uomini, Ulisse impara dalla propria esperienza, cresce riconsiderando il proprio vissuto. In altri momenti del libro Ulisse sarà invitato a rinnovare il proprio racconto e sempre sarà chiamato a crescere nella consapevolezza di quanto gli è accaduto. Del resto ogni racconto umano, ogni opera letteraria realmente interessante, nasce come domanda sulla vita dell’uomo, sul viaggio che egli affronta quotidianamente.
Libro V – Ermete giunge sull’isola di Ogigia, in cerca della ninfa Calipso. Trovatala nella sua grotta, le impone di lasciar partire Ulisse, che la dea invece avrebbe desiderato tenere con sé come marito. L’eroe, frattanto, si trova in disparte sulla spiaggia, piangendo per la troppa nostalgia della moglie e del figlio. Qui la ninfa lo raggiunge e lo invita alla partenza. Superata un’iniziale diffidenza e subite le ultime insistenze di Calipso, Ulisse costruisce una robusta zattera e parte sul vasto mare.
Dopo diversi giorni di navigazione, giunto quasi a Itaca, il dio del mare, Poseidone, scatena una terribile tempesta che distrugge la zattera di Ulisse, mentre molteplici venti lo respingono sempre più in alto mare. Interviene allora Ino, divinità marina, a soccorso dell’eroe: gli porge un velo con cui cingersi i fianchi e lo invita a nuotare verso la vicina isola di Scheria, dove abitano i Feaci. Avvicinandosi all’isola, tuttavia, Ulisse fatica ad approdare a terra, temendo di poter essere schiantato dalle onde contro gli scogli. Solo dopo molti e faticosi tentativi, l’eroe itacese nota aprirsi nel mare la foce di un fiume, passando attraverso la quale riesce a raggiungere l’isola. Qui si distende a riposare sotto dei folti cespugli.
Libro Vi – Mentre Ulisse, stremato, riposa nel bosco, Minerva si reca nel palazzo regale dei Feaci, dove dorme Nausicaa, la figlia del re Alcinoo. Assunte le sembianze di un’amica, la sveglia e la invita a recarsi al fiume a lavare delle stoffe. Così la ragazza s’incammina e con essa vanno molte amiche ancelle.
Lavate tutte le vesti, le ragazze si ristorano e dopo pranzo iniziano a giocare a palla. A un certo punto, a causa di un tiro sbagliato, la palla si perde e le ragazze urlano dispiaciute e allarmate. Le urla riescono a svegliare Ulisse, il quale decide di presentarsi per chiedere aiuto. L’eroe itacese, sporco e ferito qual è, non può che spaventare le fanciulle, che insieme vorrebbero fuggire, tutte tranne Nausicaa, cui Minerva infonde coraggio.
Ulisse, dunque, viene ascoltato, lavato e infine condotto in città, affinché i sovrani di Scheria possano stabilire come meglio aiutarlo. La giovane ragazza, tuttavia, vergognandosi di entrare in città accanto a uno sconosciuto e temendo
le maldicenze che ne sarebbero nate, chiede a Ulisse di fermarsi una volta giunti nei pressi della città e di entrarvi da solo in un secondo momento, domandando la strada per il palazzo di Alcinoo.
Libro Vii – Ulisse entra nella città dei Feaci e, dopo aver chiesto indicazioni, trova la reggia di Alcinoo. Il palazzo del sovrano si distingue tra tutti per il suo splendore, costruito con metalli preziosissimi e ricco di alberi sui quali i frutti maturano in continuazione.
Qui Ulisse, in un primo momento nascosto agli occhi di tutti da una nube che lo avvolge, si getta supplice ai piedi della regina Arete, domandando aiuto per il proprio ritorno a casa. I sovrani di Scheria gli rivolgono solamente poche domande circa le circostanze del suo approdo all’isola, ma presto lo congedano, affinché possa andare a riposarsi.
Libro Viii – La mattina successiva i signori feaci si riuniscono in assemblea per udire la storia di Ulisse. Come ogni banchetto che si rispetti, tuttavia, il racconto dell’ospite è preceduto dal canto di un aedo, Demodoco. Quest’ultimo narra alcuni episodi legati alla guerra di Troia, il cui ricordo costringe Ulisse al pianto. Alcinoo se ne avvede e consiglia di interrompere il banchetto. Suggerisce così di intrattenersi all’aperto con delle gare atletiche. L’eroe di Itaca non vorrebbe prendervi parte, ma l’arroganza di un giovane lo spinge a gareggiare nel lancio del disco, fornendo un’impressionante dimostrazione della propria forza, che neppure gli anni di naufragio sono riusciti a fiaccare.
Ritornati nella sala del palazzo, dopo un ulteriore canto di Demodoco, Ulisse viene invitato da Alcinoo a raccontare a tutti la propria storia.
Libro iX – Inizia così il racconto di Ulisse. Una volta partito da Troia, l’eroe, navigando verso Itaca, incappa in numerosi naufragi. I primi avvengono nella terra dei Ciconi e dei Lotofagi, dove muoiono alcuni compagni dell’eroe. Da lì Ulisse giunge nella terra dei Ciclopi, esseri spaventosi e senza legge alcuna. Spinto dal desiderio di conoscere le genti del luogo, l’eroe si avventura con alcuni compagni nell’entroterra e trova la grotta di Polifemo. Attende allora il ritorno del padrone di casa per farne la conoscenza, ma l’accoglienza che il Ciclope riserva agli ospiti è ben diversa da quella che questi avrebbero potuto aspettarsi: Polifemo, infatti, afferra due uomini e li divora.
Attendendo il momento di essere mangiato, Ulisse escogita uno stratagemma per vendicarsi e fuggire. Dopo aver fatto ubriacare il terribile mostro, mentre questi dorme pesantemente conficca un palo appuntito e arroventato nel suo unico occhio, accecandolo. Polifemo, dolorante e smanioso di furore, si siede presso l’uscita della grotta, intenzionato a non concedere alcuna possibilità di fuga agli uomini. Ulisse, però, trova il modo di uscire da lì, nascondendosi sotto le pecore e i montoni che il mostro lascia andare a pascolare.
Una volta giunto alla nave, Ulisse, dopo averlo tenuto all’inizio prudente-
mente nascosto, svela il proprio nome al Ciclope, il quale maledice l’eroe e invoca vendetta presso il padre Poseidone.
Libro X – Scampati al Ciclope, Ulisse e i compagni giungono all’isola di Eolo, dio dei venti. Questi li accoglie, li ristora e dona loro un otre nel quale racchiude tutti i venti impetuosi, cosicché i marinai possano affrontare senza problemi la navigazione. Quando sono quasi giunti a Itaca, tuttavia, i compagni di Ulisse aprono l’otre per folle curiosità e vengono rispediti dai venti presso l’isola di Eolo. Il dio questa volta li caccia in malo modo.
Passando per la pericolosissima terra dei Lestrigoni, naufragano in seguito sull’isola Eea. Un manipolo di uomini esplora l’isola e giunge alla casa della maga Circe, la quale ammalia gli inaspettati visitatori e li trasforma in porci. Ulisse parte allora per liberare i compagni e, grazie all’aiuto di Ermete, vanifica l’incantesimo della donna. Sconfitta, Circe impara a rispettare e servire i propri ospiti, che soggiornano presso la sua casa per un anno intero, quasi dimenticandosi la patria fino ad allora tanto desiderata.
Quando decidono di rimettersi in viaggio, Ulisse e i compagni si congedano da Circe, la quale, tuttavia, suggerisce all’eroe di scendere nell’Ade e consultare l’indovino Tiresia, che potrà rivelargli la via da seguire per ritornare a Itaca.
Libro Xi – Giunti nell’Ade, gli uomini, seguendo le indicazioni di Circe, preparano degli animali da sacrificare, cosicché il sangue delle bestie consenta alle ombre dei morti di poter parlare. Qui Ulisse consulta Tiresia, il quale profetizza l’arrivo dei viaggiatori all’isola del Sole, da dove, a patto di non commettere alcuna empietà, potranno poi raggiungere comodamente Itaca. Ulisse s’imbatte poi in altre anime: la madre Anticlea, che l’eroe non sapeva essere morta, Achille, Agamennone e Aiace, suoi amici ed eroici combattenti a Troia. Incontra molte altre ombre di uomini e di esseri prodigiosi, ma presto riparte, non volendo trattenersi a lungo nel regno dei morti.
Libro Xii – Ulisse, dunque, si rimette in mare e qui incappa in due pericoli mortali: le Sirene, delle quali vuole ascoltare il canto senza tuttavia venir da loro stregato, e Scilla e Cariddi, due mostri marini che divorano gran parte dei suoi uomini.
Con i pochi uomini rimasti, l’eroe giunge all’isola del Sole, dove proibisce a tutti di mangiare i buoi del dio che pascolavano su quella terra. Tuttavia un vento impetuoso agita il mare e impedisce ai marinai di rimettersi in viaggio. Essendo ormai tutti stremati per la fame, Euriloco, compagno di Ulisse, spinge alcuni uomini a cibarsi dei buoi, trasgredendo quello che sembrava essere solo un crudele ordine del loro comandante. Il dio Sole, irato, tende ai marinai una trappola: non appena questi si sono rimessi in mare, manda una tempesta terribile dalla quale si salva solo Ulisse, che approda a Ogigia, isola di Calipso.
Con quest’ultima tappa termina il racconto di Ulisse ai Feaci.
Il volo di Ermete
[1-42] Al sorgere dell’aurora gli dèi si radunano nuovamente a concilio. Per prima prende la parola Minerva e racconta brevemente le sventure di Ulisse per impietosire Giove: così il dio darà il proprio consenso a un ritorno favorevole per l’eroe. Ulisse infatti si trova sull’isola di Ogigia, prigioniero della ninfa Calipso, senza una nave e dei compagni che possano accompagnarlo a casa. Inoltre Minerva riferisce a Giove la propria preoccupazione per Telemaco, del quale i Proci tramano la morte. Giove non si lascia pregare e non solo concede a Minerva di vegliare su Telemaco perché torni a Itaca sano e salvo, ma dà anche ordine a Ermete di recarsi sull’isola di Ogigia perché provveda al ritorno di Ulisse1.
Disse così: né tardò l’Argicida che l’anime guida;2 subito sotto le piante si strinse i leggiadri calzari 45 d’oro, immortali, che via lo rapivan su l’umido gorgo,3 via per l’intermine4 terra insieme coi soffi del vento; anche la verga prese, onde5 gli occhi degli uomini sfiora, questi se vuoi sopirli, se dormono quelli, a destarli;6 quella stringendo in pugno, volava il gagliardo Argicida.
1 Il nuovo concilio degli dèi altro non è che una ripetizione di quello già svoltosi precedentemente, narrato nel libro I. Dobbiamo quindi ricercare la necessità di tale concilio solamente nell’esigenza del poeta di ricollegare alle decisioni dell’assemblea degli dèi il viaggio di Mercurio che viene qui narrato. Infatti la lunga sezione dedicata ai viaggi di Telemaco ha ormai allontanato dalla memoria di chi ascolta il poeta l’ordine di Giove dato al messaggero degli dèi, che qui viene pertanto ribadito.
2 l’Argicida che l’anime guida: è un epiteto di Ermete, il dio che guida i viandanti nei loro viaggi e accompagna le anime dei defunti nell’aldilà. Argicida significa “uccisore di Argo”: il termine fa riferimento all’impresa con la quale il dio liberò Io, amante di Zeus, dal terribile guardiano cui la gelosa Era l’aveva affidata, Argo, mostro dai cento occhi, cinquanta dei quali a turno erano sempre aperti e vigili.
3 I calzari di Mercurio sono così leggeri da poterlo far correre sulla superficie del mare (l’umido gorgo).
4 intermine: “senza termine”, “sterminata”.
5 Onde di solito è usato come avverbio, “da dove”; qui ha valore relativo: “con la quale”.
6 La verga, cioè il “bastone”, è un elemento costante del dio e serve a svegliare gli uomini oppure ad addormentarli. Nel corso della spedizione non verrà utilizzata.
50 Su la Pièride7 giunto, piombò giù dall’etra8 nel ponto, sopra le creste dei flutti lanciandosi, pari al gabbiano che dietro i pesci per gli orridi gorghi del mare infiniti s’avventa, e immerge ne la salsedine l’ali sue folte: simile a quello, correva sui vortici innumeri Ermete.
55 Ma quando all’isola giunto fu poi, che remota sorgeva,9 dal violaceo ponto balzò, mosse verso la costa, sin che pervenne alla grande spelonca,10 dimora alla Ninfa ricciola bella. Ed appunto quivi era,11 allorché giunse Ermete.
La grotta di Calipso
Sul focolare un gran fuoco brillava, e per l’isola tutta
60 si diffondeva l’odore del cedro che ardeva, e del dolce larice;12 e dentro la Diva, cantando con voce soave, scorrea tutto il telaio con l’aurea spola, e tesseva. Una foresta folta cresceva d’intorno allo speco, tutta in rigoglio: il pioppo, l’ontano, il fragrante cipresso; 65 quivi facevano il nido gli uccelli dall’ala veloce, gufi, e sparvieri, e cornacchie ciarliere13 che vivon sul mare. Ed una vite domestica intorno alla cava spelonca, tutta di grappoli colma, girava la pompa dei tralci. Quattro fontane in fila volgevan chiare acque, sgorganti
7 La Pieride è una regione montuosa che si trova a nord del monte Olimpo, la sede degli dèi. In questo caso è verosimile il passaggio attraverso questa regione: Ermes, allontanandosi dal monte su cui si era appena tenuto il concilio divino, parte per raggiungere Ulisse e inizialmente si muove verso nord. In realtà accade che la Pieride venga spesso menzionata nell’epica greca ogniqualvolta un dio si muova, sebbene egli non debba necessariamente passare nelle vicinanze dell’Olimpo, ma solo per indicare che chi compie il viaggio è un personaggio di origine divina.
8 dall’etra: “dall’aria”, “dal cielo”.
9 Remota è complemento predicativo del soggetto isola. Ogigia è sempre presentata come un’isola misteriosa la cui caratteristica principale è l’estrema lontananza dal mondo greco, tanto che non è stato possibile a noi moderni identificarla con certezza. L’idea di un luogo remoto e sconosciuto è contenuta anche nel nome di Calipso, che significa propriamente “nascondere”: la dea infatti nasconde l’eroe in un’isola per lo più sconosciuta.
10 spelonca (o speco): “grotta”.
11 Il soggetto è Calipso.
12 Il cedro e il larice sono alberi d’alto fusto, la cui resina, bruciando, produce un inebriante profumo.
13 ciarliere: letteralmente “chiacchierone”. Le cornacchie sono così definite in quanto gracchiano di continuo.
70 l’una vicina all’altra, poi volte per quattro cammini.14
E molli prati d’intorno fiorian petrosello e viole. Anche un Celeste, che quivi giungesse, dovrebbe a tal vista meravigliato ristare, dovrebbe gioir nel suo cuore.15
E qui stette e ammirò l’Argicida, che l’anime guida.
75 Poi, dopo ch’ebbe a sua posta mirate le tante bellezze, entro la grotta capace16 diritto si mise; né tarda a riconoscerlo fu la celeste regina Calipso: poi che non sono ignoti gli Dei sempiterni uno all’altro, neppur quando l’un d’essi dimora in contrade lontane.
80 Ma non rinvenne17 dentro lo speco il magnanimo Ulisse, che, come sempre soleva, giaceva sovressa la spiaggia, pianto versando, gemendo, di crucci rodendosi il cuore.
L’incontro tra Calipso ed Ermete
[83-109] Calipso accoglie Ermete e gli domanda il motivo della sua venuta. Il dio non è giunto a Ogigia di sua spontanea volontà, ma per obbedienza ai comandi di Giove, secondo i quali è destino che Ulisse possa tornare in patria. Piena di sdegno, la Ninfa reagisce così alle parole di Ermete:
110 «Tristi voi Numi siete, siete invidi18, come niun altri.
[…]
E così, Numi, ora invidia m’avete, che ho meco un mortale. Io lo salvai, che soletto qui giunse, inforcando una trave, poi che la rapida nave, lanciando la folgore ardente, Giove fenduta gli aveva19 per mezzo al purpureo ponto.
125 Io lo nutrivo, io l’amavo, io fatta gli avevo promessa
14 Le acque delle quattro fontane nascevano in un unico punto, ma poi si dividevano in quattro direzioni differenti (quattro cammini).
15 La vegetazione dell’isola di Ogigia è particolarmente abbondante: ci sono ontani, pioppi, cipressi, una vite dai tralci rigogliosi (la pompa dei tralci), oltre a petrosello (“prezzemolo”) e viole; inoltre l’isola è piena di animali: uccelli, gufi, sparvieri e cornacchie. Attraverso questa ricchezza di particolari Omero vuole descrivere un luogo idilliaco, che non può essere altro che divino, in contrasto con l’estrema solitudine e condizione di abbandono in cui si trova Ulisse.
16 Capace non significa “abile” in questo caso, ma “spaziosa”, “ampia”. La capacità di un contenitore è infatti la sua “ampiezza”, cioè la quantità di liquido che può essere contenuta.
17 rinvenne: “trovò”.
18 invidi: “invidiosi”.
19 fenduta gli aveva. Da ordinare così: gli aveva fenduta, cioè “squarciata”.
che sarà fatto immortale, che immune sarà da vecchiezza. Ma se possibil non è che un altro dei Numi contrasti la volontà de l’egioco20 Giove, né vana la renda, vada pur via, se quegli comanda, se quegli lo spinge,
130 sovra lo sterile mare; ma io rimandarlo non posso, poi che non ho navigli forniti di remi, o nocchieri che trasportare lo possan su l’ampia distesa del mare. Ben lo potrò di consigli giovare, dicendogli il modo ch’ei senza danno possa tornare alla patria sua terra».
135 E le rispose così l’Argicida che l’anime guida: «Dunque licenzialo,21 ed abbi rispetto al volere di Giove, che non si debba poi corrucciare, e colpirti il suo sdegno».22
Dette queste parole, partì l’Argicida gagliardo.
E la divina Ninfa, poiché del figliuolo di Crono
140 udito ebbe il comando, si volse a cercare l’eroe.
E lo trovò che sedeva sovressa la spiaggia; né gli occhi erano asciutti mai di pianto, e struggea la sua vita23 desiderando il ritorno; ché cara non gli era la Ninfa. […]
Ulisse è diffidente
Standogli presso, così gli parlò la divina Signora: «O sciagurato, non starmi qui a piangere, a struggerti il cuore
150 ch’io di buon grado,24 infine, ti lascio tornare alla patria.
Taglia, su via, grossi tronchi, compagina25 a colpi di scure una gran zattera, e sopra conficcaci coste ben alte,26
20 Giove è spesso definito egioco. Significa letteralmente “fornito dell’egida”. L’egida era uno scudo che Giove utilizzava non in combattimento, ma che agitava per suscitare una tempesta. Una leggenda tarda vuole che tale scudo sia stato costruito da Efesto (Vulcano) con la pelle della capra Amaltea, che aveva accudito in segreto Giove, quando questi non era che un piccolo neonato.
21 licenzialo. Il verbo licenziare non significa solamente “allontanare una persona dal lavoro”, ma anche “lasciar libero di andare”, “congedare”.
22 il suo sdegno è soggetto di “(debba) colpirti”.
23 struggea la sua vita: “consumava la sua vita nel rimpianto”.
24 di buon grado: “volentieri”.
25 compagina. Il verbo compaginare vuol dire “costruire unendo le singole parti”.
26 Le coste sono le sponde che venivano conficcate in verticale; quanto più sono alte, tanto più riparano dalla forza delle onde.
sì che ti possa portare sovresso il ceruleo mare. Dentro ti ci porrò pane, acqua e purpureo vino,
155 quanto ti basti a nutrirti, che tu non patisca la fame; e poi ti coprirò di vesti; ed un prospero soffio dietro ti spirerò, sì che tu torni illeso a la patria, se ciò vogliono i Numi che reggono il cielo profondo, che sono più possenti di me nel volere e nel fare».
160 Disse. Ed un gelo corse le vene27 ad Ulisse divino.
Schiuse a rispondere il labbro, parlò queste alate parole:
«Altro tu mediti, o Dea, non già ch’io ritorni, se imponi che l’infinito mare io sopra una zattera varchi, l’orrido immane gorgo, che sino28 le navi perfette
165 prore veloci arresta, se pur soffia prospera brezza: contro tua voglia mai non sarà ch’io la zattera ascenda, se tu rifiuti, o Dea, di prestarmi un gran giuramento che contro me qualche nuovo malanno non mediti in cuore».
Disse così. La celeste regina Calipso sorrise,
170 l’accarezzò con la mano, le labbra dischiuse, gli disse:
«Tu sei davvero furbo, scaltrezza davver non ti manca!
Che razza di promessa m’hai chiesto ch’io debba prestare!
M’odano dunque la Terra, la volta suprema del Cielo, m’oda l’acqua di Stige precipite29 – è questo il più grande,
175 il più tremendo giuro pei Numi beati – che io niuna novella sciagura non macchino in cuore a tuo danno. Medito quello, a quello per te penserò, che qualora io mi trovassi in tal caso, pensare dovrei per me stessa.30
Perché quello ch’è giusto so ben riconoscere; e in seno
180 mi batte un cuor che sente pietà, non un cuore di ferro!»
Quando ebbe detto così, la diva regina a guidarlo mosse veloce; ed Ulisse movea de la Ninfa su l’orme.
27 Si noti l’uso transitivo del verbo corse, che qui equivale a “percorse”. Il gelo che percorre le vene di Ulisse è un brivido, dovuto non solo alla paura della traversata, ma anche al timore che Calipso voglia in qualche modo ingannarlo.
28 sino: “persino”, “addirittura”.
29 Stige precipite: “il rapido Stige”. Lo Stige è uno dei fiumi che si trovano nell’Inferno.
30 Medito quello, a quello per te penserò, che qualora io mi trovassi in tal caso, pensare dovrei per me stessa: “io penso e ti consiglio quello che consiglierei a me stessa se mi trovassi in una circostanza simile alla tua”.
L’uomo e la Diva così pervennero al concavo speco. Ed egli dunque allora salì sopra il trono onde Ermete
185 erasi alzato, e la Ninfa gli pose dinanzi ogni cibo, e da mangiare e da bere, di quelli cui ciba il mortale. Essa di fronte ad Ulisse divino sedeva; e le ancelle presso di lei collocarono nettare e ambrosia; e le mani su le vivande imbandite distesero l’uomo e la Diva.
Una proposta allettante
190 Or, poi che furono sazi di cibi e bevande, Calipso, diva Regina, prima parlò, disse queste parole: «Figlio divin di Laerte, dal senno molteplice, Ulisse, dunque davvero tu vuoi tornare alla casa diletta, alla tua patria terra? Sta bene, ricevi l’addio.
195 Ma se però tu potessi veder quanti e quali travagli prima di giungere al suolo natale a te serba il Destino, qui rimarresti con me, diverresti immortale, e tua casa questa caverna sarebbe, per quanto vedere tu brami la sposa tua, che sempre la cerchi di notte e di giorno.
200 Ch’io mi lusingo31 non esser da meno di lei, né di viso né di persona: possibil non è che una donna mortale con le immortali Dee rivaleggi di forme e d’aspetto».32 E l’accortissimo Ulisse rispose con tali parole: «Dea veneranda, adirarti così contro me non ti piaccia.
205 So bene anch’io tutto quello che dici, di quanto la cede di fronte a te, di statura, di forme, Penelope scaltra:33 ch’ella è mortale, ed immune tu sei da vecchiezza e da morte. Ma, pure essendo così, notte e giorno io desidero e bramo
31 mi lusingo: “mi vanto”.
32 Con questo discorso Calipso vuole convincere Ulisse a rimanere ad Ogigia; gli argomenti della persuasione sono diversi: non solo gli annuncia un ritorno pieno di dolori e fatiche, ma gli ricorda anche la promessa di renderlo immortale che in precedenza gli aveva rivolto. Infine ribadisce che la bellezza di una dea, quale lei è, non potrà mai competere con quella di una donna mortale come Penelope.
33 So bene anch’io tutto quello che dici, di quanto la cede di fronte a te, di statura, di forme, Penelope scaltra. Da ordinare così: so bene anch’io tutto quello che dici, di quanto Penelope scaltra la cede (“sia inferiore”) di fronte a te, di statura, di forme (“di aspetto”). Di statura e di forme sono complementi di limitazione; la statura era una parte essenziale della bellezza greca.
tornare alla mia casa, vedere quel dì ch’io ritorni.
210 Ché se qualcun degli Dei mi colpisce sugli ebbri marosi,34 saldo il mio petto sarà, poi che l’anima è avvezza ai cordogli. Molto ho patito già: tra le zuffe e tra i vortici, molto ho sopportato già: venga pure il novello travaglio».
Disse. Ed il sole s’immerse nel mare, e la tenebra scese.
[…]
Come l’Aurora apparì mattiniera, ch’à dita di rose, subito Ulisse divino si cinse la clamide e il manto.35
E grazioso un peplo, che come l’argento fulgeva,
220 cinse la Ninfa; e a l’anche d’attorno si cinse una zona36 bella, a fiorami d’oro; e d’un velo coperse le chiome; quindi al ritorno d’Ulisse, magnanimo cuore, provvide. Prima una scure di bronzo, manevole,37 grande, a due tagli con il bel manico infisso di solido ulivo, gli diede;
225 quindi gli porse un’ascia di filo sottile;38 e l’addusse verso l’estremo confine dell’isola, ove alberi grandi, pioppi ed ontani, crescevano: al cielo giungeva l’abete; aridi tutti, ben secchi, da correre lievi a fior d’acqua.39
Or, poi che gli ebbe mostrato la selva degli alberi grandi, 230 alla sua grotta tornò la divina regina Calipso.
Egli a tagliare i tronchi si mise, e fu l’opera breve.
Ne abbatté venti fra tutti, poi li digrossò con la scure,
34 I marosi, cioè le onde del mare, sono qui definiti ebbri, ovvero “ubriachi”. Quando il mare è agitato, infatti, il suo ondeggiare tortuoso può far pensare al modo di camminare incerto di una persona ubriaca. È però possibile intendere l’aggettivo in un altro modo: nella versione originale greca infatti si trova una parola che significa letteralmente “color del vino”. Questo epiteto riferito al mare indica genericamente una colorazione scura. È tuttavia suggestiva la traduzione ebbri, perché richiama il movimento ondulatorio delle acque.
35 la clamide e il manto: la clamide era una sorta di tunica che copriva quasi interamente il corpo (dal collo fino al ginocchio); per manto si intende il mantello.
36 zona: “cintura”.
37 manevole: “maneggevole”, “facile da adoperare”.
38 ascia di filo sottile: “ascia dalla lama sottile”. La scure che precedentemente era stata data a Ulisse doveva servire per abbattere gli alberi e ridurli in pezzi; l’ascia invece, essendo dotata di una lama sottile, serviva per rifinire il lavoro, cioè per raddrizzare e ridurre alla giusta misura le travi di legno.
39 correre lievi a fior d’acqua: “galleggiare”.
poi li squadrò con cura, stendendovi sopra lo spago. Portò Calipso intanto, divina signora, i trivelli.40
235 E Ulisse tutti i travi forò, li connesse l’un l’altro, poi li saldò con incastri, con fitte compagi41 di chiodi. Come vediam calafati maestri42 dell’arte la chiglia arrotondar d’una nave da carico grande, in tal modo s’affaccendava Ulisse d’attorno alla zattera grande.
240 I madieri piantò, li congiunse di fitti ginocchi, poi con imboni grandi compie’ tutto attorno il fasciame;43 conficcò l’albero in mezzo, su l’albero stese l’antenna,44 poi costruì, per poterla guidare su i flutti, il timone, poi con fascine di giunchi via via l’assiepò tutto in giro,
245 che la schermisser45 dai vortici; e molta zavorra46 vi mise. Ecco, e gli porse la tela Calipso, la diva regina, per costruire le vele, che furono anch’esse compiute, e v’adattò le mantiglie, con l’orza e la poggia e la scotta.47 E sovra curri48 infine la spinse nel mare divino.
[250-269] Per quattro lunghi giorni Ulisse si dedica alla costruzione della zattera; compiuto il lavoro, Calipso provvede così come aveva promesso a fornire a Ulisse acqua, vino e provviste abbondanti, che bastino per tutta la traversata
40 I trivelli sono attrezzi che hanno una funzione paragonabile a quella dei nostri trapani: consentono di forare le superfici.
41 Il temine compage (o compagine) significa “concatenatura”, “unione”.
42 calafati maestri: “carpentieri navali”. Più propriamente si dice calafato l’operaio specializzato che costruisce e rende stabile e impenetrabile all’acqua la chiglia di una nave.
43 I madieri piantò … il fasciame. La narrazione della costruzione della zattera diventa in questi versi sempre più tecnica, per mostrare l’abilità di Ulisse, che opera come un vero e proprio costruttore esperto. I madieri sono i pali che vengono inseriti perpendicolarmente alla chiglia, perché poi vadano a formare l’ossatura delle fiancate. I ginocchi congiungono trasversalmente questi pali, ai quali vengono inchiodati per rendere solida la struttura della barca. Gli imboni sono invece grosse tavole che vengono sovrapposte ai ginocchi per formare il parapetto (fasciame).
44 L’antenna è quel palo perpendicolare all’albero che serve per sorreggere la vela.
45 Schermire significa letteralmente “fare schermo”, cioè “riparare”.
46 La zavorra è il materiale pesante caricato sulle navi per renderle stabili.
47 v’adattò le mantiglie, con l’orza e la poggia e la scotta. L’intervento finale per la costruzione della zattera è compiuto da Calipso, che posiziona e sistema le diverse corde che legano la vela all’albero e all’antenna. Le mantiglie, l’orza, la poggia e la scotta non sono altro che i nomi tecnici delle diverse corde che sostengono la vela.
48 I curri sono quei rulli che vengono posti sotto una barca e che permettono di spingerla più facilmente verso il mare dopo che la si è costruita.
fino a Itaca. Suscita poi un vento favorevole, che permette a Ulisse di navigare in assoluta tranquillità per ben diciassette giorni. Il diciottesimo cominciano a intravedersi i monti dell’isola di Itaca, simili a un cumulo di nubi.
[270-284] Nel frattempo Posidone, tornando verso l’Olimpo dopo un viaggio in Etiopia, si accorge che Ulisse è riuscito a evadere dall’isola di Ogigia. Per lui questo fatto è insopportabile: non può permettere che l’eroe, colpevole di aver accecato suo figlio Polifemo, torni incolume in patria. Per vendicarsi, perciò, il dio del mare raduna tutti i venti e suscita una terribile tempesta sulle acque.
285 Vennero meno ad Ulisse allor le ginocchia ed il cuore,49 e nel suo cruccio, così favellava al magnanimo spirto:50
«Misero, misero me! Quale dunque sarà la mia fine?
Temo che quanto la Diva predetto m’avea, tutto avvenga, quando mi disse che prima di giungere al suolo nativo
290 tanti dovrei soffrire travagli: ecco, tutto s’avvera!
Quanti mai nugoli Giove raduna a recingere il cielo!
Come sconvolge i marosi! Da tutte le parti de l’etra come le raffiche incalzano! È certa l’orribile morte!
Tre, quattro volte beati quei Danai che a pro’ degli Atridi,51
295 sotto le mura d’Ilio pugnando, trovaron la morte!
Deh!, fossi io pure caduto, deh!, colto m’avesse il destino quella giornata che tante zagaglie52 di bronzo i Troiani contro di me saettavano, intorno al morente Pelide!
Dato sepolcro m’avrebber gli Achei, la mia fama esaltata.
300 Ora il destino mi vuole rapito da ignobile53 morte».
Mentre diceva così, con terribile cozzo un gran flutto su lui piombò dall’alto, mulinò54 la zattera in giro.
49 È molto bella l’immagine per cui a Ulisse vengono meno il cuore e le ginocchia, cioè è provato dalla fatica fisica e nel cuore, perché si rende conto che lo aspetta un momento particolarmente difficile.
50 così favellava al magnanimo spirto: “così parlava a se stesso”.
51 a pro’ degli Atridi: “a vantaggio”, “a favore degli Atridi”.
52 zagaglie: “lance”.
53 Ignobile significa letteralmente “non conosciuta”, “sconosciuta”.
54 mulinò: “girò su se stessa”, “rotolò”.
E da la zattera ei fu sbalzato lontano; il timone via gli sfuggì da le mani: di venti un miscuglio, battendo
305 con terribile raffica l’albero a mezzo, lo franse, via per il mare disperse lontano la vela e l’antenna. Ben lungo tempo Ulisse sott’acqua rimase; e la testa risollevar non potea di sotto la furia dei gorghi, tanto era grave la veste che a lui die’ la diva Calipso.
310 Risommò55 pure, alla fine, sputò la salsuggine amara, che da la bocca e le nari sgorgava con fitto gorgoglio, né si scordò della zatta, per quanto stremato di forze: dietro, fra l’urto dei flutti, le corse, le man su vi strinse, ci si distese nel mezzo, schivando il destino di morte.
315 Per le correnti qua e là lo portavano i grandi marosi. Come la Bora d’Autunno mulina le foglie dei cardi su la pianura, che l’una con l’altra s’addensano in mucchi, così qua e là pei flutti rapivan la zattera i venti. Ora la56 dava Noto a Borea che via la portasse,
320 Euro a Zefiro poi la cedeva, ludibrio a inseguirla.57
Il velo di Ino
Ecco, e lo vide la figlia di Cadmo dai piedi sottili,58 Ino la bianca,59 che prima vivea fra le genti mortali, ora tra i gorghi del mare partecipa onori divini.60 Essa ebbe dunque pietà d’Ulisse, dei suoi patimenti;
325 e si sedé su la zattera, e tali parole gli volse:
55 Risommò: “riuscì a riportarsi in superficie, a galla”.
56 Il pronome la si riferisce alla zattera.
57 ludibrio a inseguirla: “divertendosi a inseguirla”.
58 dai piedi sottili: questo epiteto indica che Ino è agile e leggera nei movimenti.
59 Ino è la dea incaricata di portar soccorso ai naviganti in pericolo. Come anche altre divinità marine, è detta la bianca, colore che ricorda la schiuma del mare. Il mito racconta che Ino fu la seconda moglie di Atamante, dall’unione con il quale nacquero i figli Learco e Melicerte. Dopo la morte della sorella Semele, madre di Dioniso, Ino persuase Atamante ad allevare il piccolo dio, nato dall’unione della sorella di Ino con Zeus. Era, per vendicarsi del tradimento, fece impazzire Ino, la quale uccise Melicerte gettandolo in una pentola d’acqua bollente, e suo marito Atamante, che uccise Learco con uno spiedo, scambiandolo nel delirio per un cervo. Ino, una volta che fu rinsavita, si gettò in mare con il cadavere di Melicerte e i due vennero trasformati in divinità marine.
60 partecipa onori divini: “è onorata assieme agli dèi”.
«O sventurato, perché Nettuno che scuote la terra tanto è crucciato con te, ti manda sì gravi malanni?
Ma non vedrà la tua morte, per quanto egli n’abbia gran voglia. Senno, mi par, non ti manca. Fa’ dunque così: le tue vesti
330 spoglia; la zattera ai venti, che via la trascinino, lascia; stendi a nuotare le braccia, per giungere al suol dei Feaci. Vuole il destino che qui tu trovi l’approdo e lo scampo. Prendi, ed avvolgiti il petto con questo mio velo immortale, e non temere che doglia t’angusti, né morte ti colga.
335 Ma quando sentirai la terra sottesse le palme,61 scioglilo, scaglialo allora lontano nel mare vinoso, molto lontan da la terra, altrove volgendo lo sguardo». Queste parole gli disse la Diva, ed il velo gli porse; poi per il mar traballante di flutti di nuovo s’immerse,
340 sì che una fòlaga62 parve; sparì dentro un vortice negro. E pensier varî Ulisse tenace fra sé rivolgeva, e nel suo cruccio così favellava al magnanimo cuore: «Misero me! Che qualcuno dei Numi mi tessa una frode nuova, che questo consiglio mi dà ch’io la zattera lasci?
345 No, non lo posso seguire, ché troppo lontana questi occhi vedon la terra, ov’ei63 disse che stato sarebbe il mio scampo. No, farò invece così, che mi sembra il partito migliore: sin che le travi insieme rimangono strette in compage, io dove son rimarrò, pazïente di questo travaglio.
350 Ove poi qualche maroso per mezzo la zattera spezzi, allora nuoterò, ché partito migliore non resta».
[352-374] Nonostante la sua diffidenza, Ulisse capisce presto di non avere alternative, poiché una potente onda lo catapulta fuori dalla zattera. L’unica possibilità per salvarsi è quindi seguire i consigli di Ino. Anche Atena si dà da fare per placare tutti i venti, ad eccezione di Borea, che avrebbe trasportato Ulisse nella direzione dell’isola dei Feaci.
61 le palme: “il palmo delle mani”.
62 La folaga è un uccello marino, famoso per la velocità con cui si getta sui pesci per mangiarli.
63 ei: si riferisce a Ino.
Come raggiungere l’isola?
375 Ora due notti e due giorni vagò tra le masse dei flutti, e ben sovente64 innanzi si vide l’estrema rovina. Ma quando Aurora dai riccioli belli recò la terza alba, ecco d’un tratto cessò la bora, e tornò la bonaccia senza più alito. E Ulisse, dall’alto d’un grande maroso,
380 vide, aguzzando le ciglia, ormai già vicina la terra.
Come gioiscono i figli vedendo risorgere il padre che patimenti crudeli soffriva, giacendo nel morbo, con struggimento lungo, premendolo un demone infesto, e poi dal male i Numi lo affrancano,65 e gaudio è vederlo:
385 così gradita apparve la terra ed il bosco ad Ulisse. Ed il desio di calcare coi piedi la terra affrettava le braccia al nuoto; ma quando poi giunse a portata di voce,66 anche il frastuono gli giunse del mare sovressi gli scogli. Rumoreggiavano i flutti con alto rimbombo alla terra,
390 con orrido ruggito, di schiuma coprivano tutto: poi che non v’erano porti che navi accogliessero o rade, ma sopra l’onde sporgenti scogliere, ma sassi e dirupi. Cuore e ginocchia ad Ulisse mancaron, com’egli ciò vide, e favellò così, nel suo cruccio, al magnanimo cuore:
395 «Ahi!, poi che Giove mi diede che contro ogni speme vedessi la terra, e a nuoto questa voragine immane ho varcata, porta non vedo alcuna, che m’apra un’uscita dal mare.
A me dinanzi acuti dirupi si levano, e intorno mugge dei flutti lo strepito, e liscia s’allunga la ripa, 400 ed è profondo il mare; e modo non v’è che su i piedi possa poggiarmi alla fine, sfuggire alla morte. Se pure, mentre io m’affanno all’approdo, non giunga e m’afferri [un gran flutto, che contro un orrido scoglio mi lanci, e il mio sforzo deluda.
64 sovente: “spesso”.
65 lo affrancano: “lo rendono franco”, cioè “libero”.
66 Giunse a portata di voce è un’espressione utilizzata per indicare una distanza. Significa: “giunse tanto vicino da poter sentire o da poter essere udito”. In questo caso Ulisse si è avvicinato così tanto alla riva da poter udire il fragore provocato dalle onde che si abbattono violentemente sugli scogli.
Ché, se proseguo a nuotare lunghessa la costa, se a caso
405 spiagge declivi nell’onde rinvenga o tranquilli rifugi, temo che ancora una volta m’afferri, e lontano mi sbalzi qualche procella, ad empire di gemiti il mare pescoso, o che su me, dagli anfratti del mar, qualche demone avventi uno degli orridi mostri cui nutre la diva Anfitrite:
410 poi che so bene quale odio Posidone grande mi porta».67 Or, mentre questi pensieri volgeva ne l’alma e nel cuore, ecco un immane flutto lo sbattè su gli aspri frangenti. Qui si sarebbe squarciata la pelle, spezzate qui l’ossa, se non l’avesse ispirato la Diva occhicerula Atena.
415 Ei si lanciò con entrambe le mani, s’avvinse allo scoglio, quivi si tenne gemendo, sin che fu passato il gran flutto. Così potè schivarlo; ma poi, nel reflusso, di nuovo sopra gli fu,68 lo sbatté, lo scagliò lontano nel mare.
Come allorché si strappa un polpo dal suo nascondiglio,
420 che nei tentacoli molte pietruzze rimangono infitte: così sopra le rocce restarono brani sdruciti69 delle gagliarde sue mani; e un alto maroso il coperse.70
Finalmente l’approdo
Quivi, pur contro il destino, già spento era il misero Ulisse, se non gli avesse infuso prontezza la Diva occhiazzurra.
425 Via dal maroso emerso, che ruggìa correndo alla riva, egli nuotò costeggiando, guardando alla terra, se in caso spiagge declivi nell’onde vedesse o rifugi securi. E quando poi d’un fiume dal rapido corso alla foce giunse nuotando, ove il luogo gli parve più acconcio all’approdo, 430 scevro71 di vortici, e intorno sorgevan ripari dal vento, visto lo sbocco del fiume, tal prece nel cuore gli volse:
67 Emerge in questo ragionamento di Ulisse l’estrema difficoltà della situazione in cui si trova: qualunque ipotesi si affacci alla sua mente è ricca di pericoli.
68 Il soggetto di sopra gli fu è il gran flutto
69 brani sdruciti: “brandelli strappati”.
70 un alto maroso il coperse: “un’alta ondata lo ricoprì”.
71 scevro: “privo”.
«Odimi, o Sire, comunque ti chiami!72 Con molte preghiere io mi rivolgo a te. Di Posidone fuggo gli oltraggi, fuggo dal mare. Rispetto pure essi i Celesti immortali
435 portano all’uom, quale ei sia, che giunga errabondo, come io giungo ora a te, dopo tanti travagli, e ai tuoi piedi mi prostro.
Abbi pietà, signore, di me: che a te supplice giungo».
Disse: ed il Nume il suo gorgo frenò, la corrente rattenne subito, innanzi gli fece bonaccia, ed in fretta lo trasse
440 presso le foci del fiume: ed egli piombò sui ginocchi, sopra le valide palme, tanto era dal mare fiaccato. Tutto era gonfio il suo corpo: giù giù da la bocca e le nari, l’acqua sgorgava a gran fiotti; e senza favella né fiato, senza più moto giaceva, prostrato da immane stanchezza.
445 Poscia, quando ebbe il fiato ripreso, e lo spirito in cuore fu ritornato, la benda disciolse da sé de la Diva, e la gittò nei gorghi, che al mare correvan, del fiume.
Per la corrente di nuovo la trasse un gran vortice; ed Ino subito l’ebbe ripresa. E Ulisse, scampato dal fiume,
450 entro un giuncheto73 piegò le ginocchia, baciò le feraci zolle, e, crucciato, rivolse tai detti al magnanimo cuore: «Ahimè, che mai farò? Quale orribile sorte m’attende?
Se su la riva del fiume la notte vegliando io trascorro, certo la brina maligna, insieme, e la fradicia guazza74
455 abbatteranno il mio spirito oppresso dal grave travaglio, che sul mattino, dal fiume si leva una gelida brezza.
Ove poi l’argine io salga, se dentro l’ombrosa boscaglia voglio assopirmi, fra i densi cespugli, se pur mi risparmia, freddo e stanchezza, e il sonno soave su me sopraggiunge, 460 temo ch’io debba finire ludibrio alle fiere voraci».75 Poi, riflettendo, questo gli parve il partito migliore.76
72 Ulisse si sta rivolgendo alla divinità del fiume, da cui si credeva che dipendesse l’ingrossarsi o l’abbassarsi del corso d’acqua.
73 giuncheto: luogo dove crescono molti giunchi, piante che di solito vivono vicino a corsi d’acqua.
74 guazza: “rugiada”.
75 temo ch’io debba finire ludibrio alle fiere voraci: “temo di finire straziato dalle bestie”. Voraci significa “divoratrici”.
76 Le riflessioni e l’indecisione di Ulisse non finiscono con l’approdo sulla terra ferma: l’eroe è
S’incamminò verso il bosco, che sopra un’altura sorgeva presso alla ripa; e trovò riparo entro un doppio cespuglio che da confuse radici crescea, d’oleastro e d’ulivo.
465 Quivi né l’umida furia soffiava dei rapidi venti, né vi potevano battere i raggi del sole fulgente, né penetrarvi la pioggia traverso potea: così fitti l’uno con l’altro intrecciati crescevano. Ulisse al riparo quivi si mise, e le mani die’ subito attorno, e s’estrusse77
470 comodo un letto; ché c’erano foglie cadute a gran mucchi, quante due uomini o tre riparare potrebber dal gelo ne la stagione d’inverno, per quanto essa rigida fosse. Molto fu lieto Ulisse divino, quando egli le vide: si rannicchiò lì nel mezzo, si ricoprì tutto di foglie.
475 Come chi senza vicini soggiorna all’estremo d’un campo, suole celare sotto la cenere negra uno stizzo,78 per conservare il seme del fuoco, né altrove cercarlo. Così nascosto Ulisse restò tra le foglie; ed Atena su la pupilla sopore gli effuse, che, attorno a le ciglia
480 steso un velame, tregua ponesse all’immane stanchezza.
ancora incerto se dormire sulla riva del fiume, dove la gelida brina sul far del mattino lo avrebbe colpito, oppure se risalire il fiume e fermarsi nel bosco, dove si annida il pericolo delle bestie feroci.
77 s’estrusse: “si preparò”.
78 stizzo: “tizzo” (o “tizzone”), cioè un pezzo di legno o di carbone ardente.
Libro VI
Minerva escogita un piano
[1-16] Ulisse, ormai stremato dalla stanchezza, è approdato a Scheria, l’isola in cui abita il popolo dei Feaci, e si abbandona al sonno, al riparo dei fitti cespugli del bosco. Nello stesso momento Minerva giunge direttamente alla reggia del re Alcinoo, anticipando così l’arrivo di Ulisse, e lì vede dormire una ragazza la cui bellezza è pari a quella delle dee.
Era Nausica,1 la figlia d’Alcinoo magnanimo cuore; e presso lei due serventi, soffuse di grazia, ai due lati stavan dell’uscio; e tuttora chiuse eran le fulgide imposte.
20 Ma come un soffio di vento2 la Diva balzò sul giaciglio della fanciulla, sul capo le stette,3 le prese a parlare, pari in sembianze alla figlia del prode nocchiere Dinanto,4 ch’era fanciulla a lei pari negli anni, e diletta al suo cuore. Simile a questa in sembianze, la Diva occhicerula disse:
25 «Dunque, così negligente,5 Nausica, tua madre t’ha fatta?
Stanno buttate lì senza cura le belle tue vesti, e son vicine le nozze per te, quando tu belle vesti devi indossare, e a quelli donarne che a te fanno scorta:6 poi che da queste larghezze7 si forma la fama onorata
30 presso le genti, e il padre s’allegra e la nobile madre.
1 Per ragioni metriche, tale nome ricorre talvolta in questa forma, talaltra con la vocale finale ripetuta (Nausicaa).
2 come un soffio di vento. Il paragone tra la dea e il vento è dovuto non solo alla leggerezza, ma anche alla rapidità: quest’ultima era infatti una caratteristica quasi esclusivamente divina.
3 sul capo le stette: era un’antica credenza che i sogni non venissero in mente a chi dormiva, ma fossero una figura esterna che fisicamente si posava sulla testa del dormiente.
4 alla figlia del prode nocchiere Dinanto. Non si sa con esattezza chi sia questa amica di Nausica, la quale, peraltro, in seguito non la accompagnerà al fiume, come viene qui detto.
5 negligente: “trascurata”.
6 a quelli donarne che a te fanno scorta: fare scorta vuol dire “accompagnare”. Ci si riferisce all’usanza secondo la quale la sposa donava delle belle vesti a coloro che l’avrebbero accompagnata alla casa dello sposo durante il corteo nuziale.
7 larghezze: “gesti di generosità”.
Dunque rechiamoci, appena sarà sorta l’alba, a lavare.
Io ti sarò nel lavoro compagna, ché tu lo fornisca8 prima che possa: che a lungo fanciulla tu già non rimani.
Quanti più prodi vanta l’accolta9 di tutti i Feaci, 35 dove tu pure sei nota, già sposa ti cercano a gara.
Presto, via, prega tuo padre, che prima che sorga l’Aurora faccia attaccare ad un carro due muli che portin le vesti, portin le cinte, i mantelli, le variopinte coperte.
E meglio anche è per te che vada così, non a piedi,
40 ché molto son distanti da questa città le fontane».
[41-84] Minerva si allontana e vola di nuovo verso l’Olimpo. Al sorgere dell’aurora Nausica si desta dal sonno e subito si muove alla ricerca del padre, così come Minerva le aveva suggerito in sogno. Dal momento che è molto timida, ha vergogna di affrontare l’argomento delle nozze con lui, perciò si limita a chiedergli che venga preparato un carro perché lei possa andare al fiume con le ancelle a lavare i panni. Non appena Alcinoo accorda il suo permesso, le ragazze si dirigono al fiume con un carro carico di vesti, di vivande, di vino e di un prezioso olio per ungere i propri corpi dopo il bagno.
Le ragazze al fiume
85 Or, quando all’acque del fiume bellissime furono giunte, dove fontane perenni correvano, e molta bell’acqua fuor dalla terra sgorgava, da terger qualunque lordura, quivi di sotto al carro le ancelle disciolser le mule, e le mandarono lungo le rive ed i gorghi del fiume,
90 ch’ivi pascessero l’erba più dolce del miele. Dal carro scesero poi, nell’acqua cerulea gittaron le vesti, e dentro i botri,10 di forza, coi piè le pigiavano a gara. Poscia, quand’ebbero bene lavate, purgate le vesti, tutte le stesero in fila sovressa la spiaggia del mare,
95 dove più l’acque, battendo la spiaggia, sciacquavan la ghiaia. Poscia, lavatesi, e tutte cosperse di lucido ulivo,
8 fornisca: “provveda”, “porti a compimento”.
9 l’accolta: “l’assemblea”.
10 i botri: propriamente sono dei bacini in cui l’acqua ristagna.
preser l’asciolvere,11 presso le ripide rive del fiume, mentre asciugavano i panni, distesi alla spera del sole.12 Dopo che furono paghe di cibo le ancelle e Nausica,
100 tutte, gittate via le bende,13 giocarono a palla: e la battuta dava Nausica dal candido braccio.
Come la Diva che gode lanciare saette, sui monti corre, sovresso il Tegèto, sovresso il sublime Erimanto, lieta, seguendo l’orme di verri o di rapidi cervi,
105 e le figliuole di Giove che godon dei campi, le Ninfe, strette le esultano attorno, delizia del cuor di Latona, ma sovra tutte Artemide estolle14 la fronte e le guance, belle son tutte, ma quella fra tutte di subito scerni,15 tale fra tutte le ancelle brillava la vergine pura.16
110 Ma quando poi Nausica di già s’apprestava al ritorno, già ripiegate aveva le vesti, aggiogate le mule, altro rivolse in mente la diva occhicerula Atena,17 perché, ridesto, Ulisse vedesse la vergine bella, che la città dei Feaci potesse indicargli. La palla
115 verso un’ancella, dunque, gittò la regina; ma il colpo fu mal diretto: e la palla piombò giù nei vortici fondi.
11 L’asciolvere è la colazione. Era stata preparata e caricata sul carro dalla regina Arete, moglie di Alcinoo.
12 distesi alla spera del sole: “distesi ai raggi del sole”. Spera equivale a “sfera”.
13 gittate via le bende: le bende sono i veli che tipicamente coprivano la testa e scendevano sulle spalle delle ancelle. Vengono tolte al momento di giocare per permettere alle ragazze dei movimenti più agili.
14 estolle: “solleva”. L’espressione significa che Artemide supera nettamente nell’altezza le altre Ninfe; poiché l’altezza era considerata sinonimo di bellezza, le superava decisamente anche in questo.
15 scerni: “discerni”, “individui”.
16 La complessa similitudine vuole paragonare la bellezza di Artemide, dea della caccia (la Diva che gode lanciare saette), che sempre si distingue tra le Ninfe pur belle che la circondano, a quella di Nausica, splendida fra tutte le ancelle. Il Taigeto (o Tegeto) è un monte della Laconia; invece l’Erimanto è una montagna del Peloponneso. La loro fama era legata all’abbondante selvaggina che li popolava: infatti sull’Erimanto visse il famoso cinghiale cacciato da Ercole in una delle sue fatiche. Non stupisce perciò trovar qui menzionati i verri, cioè i “cinghiali”. Latona è la madre di Artemide.
17 altro rivolse in mente la diva occhicerula Atena. Da ordinare così: la diva occhicerulea Atena le rivolse in mente altro
Esse un altissimo grido levarono; e Ulisse fu desto. E si sedette; e in mente gli errarono questi pensieri: «Povero me! Di che gente sarò capitato al paese?
120 Forse feroci selvaggi saranno, nemici del giusto, od ospitali, e avranno l’ossequio18 dei Numi nel cuore?
Giunto all’orecchio m’è di femmine un grido. Fanciulle sembrano: son di certo vicino ad un luogo abitato. Via, converrà ch’io stesso mi muova, per esserne certo».
125 Disse. Ed emerse Ulisse divino di sotto ai cespugli; e da la fitta macchia divelto con mano gagliarda tutto fronzuto un virgulto,19 ai fianchi lo cinse: indi mosse, pari a leone sui monti nutrito, che forte e sicuro contro la pioggia e il vento si lancia, e son gli occhi una bragia,20
130 e si precipita sopra le pecore, sopra i giovenchi, sopra i selvaggi cervi; e infine lo spinge la fame a insidiar le greggi fin dentro le case sbarrate; similemente Ulisse, fra tante leggiadre fanciulle si presentò, così brutto com’era; ma farlo era d’uopo.21
135 Orrido apparve ad esse, bruttato così di salmastro;22 e sbigottite23 si sperser chi qua chi là per la spiaggia. Sola rimase la figlia d’Alcinoo, ché Atena le membra le preservò dal terrore, coraggio nell’alma le infuse. Ferma gli stette dinanzi. E Ulisse ondeggiava fra due:24
140 se della vaga fanciulla stringesse i ginocchi, e pregasse, o se pregasse così da lontano, con dolci parole, che la città gl’indicasse dov’era, che vesti gli desse. Questo, a pensarci, dunque, gli parve il partito migliore: che la pregasse così da lungi, con dolci parole,
145 ché non dovesse adirarsi, sentendosi stretta ai ginocchi.
18 ossequio: “rispetto”.
19 da la fitta macchia divelto con mano gagliarda tutto fronzuto un virgulto. Da ordinare così: divelto (“strappato”) con mano gagliarda un virgulto tutto fronzuto (“un ramoscello frondoso”) da la fitta macchia.
20 bragia: “brace”. L’espressione indica che gli occhi ardono, brillano.
21 era d’uopo: “era necessario”.
22 bruttato così di salmastro: “reso brutto dalla salsedine”.
23 sbigottite: “spaventate”.
24 ondeggiava fra due: “era indeciso tra due alternative”.
E le rivolse queste parole soavi ed accorte:
«Io ti scongiuro, o signora. Sei forse una Diva? O una donna?
Ché se una Diva tu sei, di quelle che in cielo han dimora, io t’affiguro25 alla figlia di Giove, ad Artemide casta:
150 nella statura, nei tratti sei quella, ed in ogni tua forma.
Ma se una donna tu sei di quelle che vivono in terra, deh!, fortunati tre volte tuo padre e la nobil tua madre, deh!, fortunati i fratelli tre volte: ché troppo i lor cuori di contentezza per te dovran tuttodì giubilare,
155 quando essi veggono un tale germoglio spiccarsi alla danza.26
Ma più beato fra tutti, beato nel cuore, quell’uomo che, prevalendo coi doni, ti possa condurre al suo tetto!27
Ché creatura mortale né uomo né donna a te pari mai non vider questi occhi. Ti guardo, e m’invade timore.
160 Vidi a te simile, in Delo, vicino all’altare d’Apollo, un ramoscello di palma28 che nuovo sorgea dal terreno; ed anche allor, mirando, stupore percosse il mio cuore, ché mai tale vermena29 sbocciata non era dal suolo, come anche adesso, o donna, stupisco, t’ammiro, e non oso
165 stringer le tue ginocchia. Terribile doglia m’opprime. Ieri scampai, dopo venti giornate, dagli ebbri marosi; mi trascinarono, tutto quel tempo, dall’isola Ogigia flutti d’irose procelle.30 Qui un demone adesso mi spinge, perché nuove sciagure sopporti anche qui: ché non credo
170 siano finite, ma molte tuttor me ne serbano i Numi. Abbi pietà, Signora, di me. Dopo tanti travagli tu sei la prima che incontro, nessuno ho pur visto degli altri abitatori di questa città, di questa contrada.
25 t’affiguro: “ti paragono”, “ti riconosco simile”.
26 spiccarsi alla danza: “cimentarsi nella danza”. La danza era considerata l’attività che meglio permetteva alla bellezza femminile di svelarsi.
27 Condurre al suo tetto vuol dire “sposare”. Durante il corteo nuziale, infatti, era usanza che la sposa abbandonasse la propria casa per dirigersi a quella dello sposo.
28 Vidi a te simile, in Delo, vicino all’altare d’Apollo, un ramoscello di palma: Ulisse riferisce di aver visto a Delo, probabilmente mentre ritornava da Troia, una palma. Questo albero non era comune in Grecia e in generale nel Mediterraneo; Ulisse paragona perciò la straordinaria preziosità della palma alla non comune bellezza di Nausica.
29 vermena: “germoglio”.
30 flutti d’irose procelle è soggetto di mi trascinarono
Mostrami, via, la città, dammi un cencio, ch’io possa coprirmi,
175 se, qui venendo, un panno recavi da involger le vesti.
E ti concedan gli Dei tutto ciò che vagheggia il tuo cuore, sposo ti diano e casa, ti diano la dolce concordia.
Ché non c’è cosa al mondo migliore, più degna di questa: quando lo sposo e la sposa governan la casa d’accordo,
180 con un volere medesimo; assai se ne crucciano i tristi, ma se ne allegrano i buoni, ma essi n’acquistano fama».
Nausica si prende cura del naufrago
E gli rispose così Nausica dal candido braccio: «O straniero, davvero né tristo tu sembri né stolto; ma la felicità partisce fra gli uomini Giove
185 sire d’Olimpo, a chi più gli piace; ora al buono, ora al tristo.
A te diede cordogli, cordogli tu devi patire.
Ma or che in questa terra, che in questa città sei pur giunto, a te non mancheranno né vesti, né nulla di quanto porger conviene ad un misero, oppresso dai mali, che prega.
190 Ti mostrerò la città, saprai quale nome han le genti.
Di questo suolo, di questa città son signori i Feaci; e la figliuola io sono d’Alcinoo magnanimo cuore, che dei gagliardi animosi Feaci le sorti governa».
Disse; e la voce levò per chiamare le ancelle vezzose:31
195 «State un po’ ferme! Così fuggite alla vista d’un uomo?
Immaginate forse ch’ei nutra sinistri pensieri?
Non c’è, né sarà mai32 nel mondo quel tristo mortale che della gente feacia pervenga alla terra, e minacci l’impeto ostile: ché troppo siam cari ai Beati Celesti, 200 ed abitiamo lontani da tutto, ai confini del mondo, tra l’estuare33 infinito dei flutti; e nessuno ci cerca.
Ma questo misero è giunto qui naufrago errante; e dobbiamo prenderne cura adesso; perché forestieri e mendichi
31 vezzose: “graziose”, “belle”.
32 né sarà mai: “né esisterà mai”.
33 Estuare significa “ribollire”. Per strano che possa sembrare, il termine estuario (indicante una tipologia di foce di un fiume) deriva proprio da qui: l’acqua del fiume, gettandosi continuamente nel mare, si agita e pare ribollire.
tutti li manda Giove, ché poi si contentan di poco.34
205 Presto, fanciulle, dunque, recategli cibo e bevande, fategli un bagno sul greto del fiume,35 al riparo dei venti».
Disse: e ristettero quelle, chiamandosi l’una con l’altra.
E su la riva, al riparo del vento, condussero Ulisse, come diceva la figlia d’Alcinoo magnanimo cuore.
[210-219] Come è stato ordinato loro da Nausica, le ancelle conducono Ulisse al fiume e gli donano una tunica e un mantello perché possa poi vestirsi.
Ulisse è condotto in città
220 Lavava intanto Ulisse divino nel fiume il salmastro36 che gl’incrostava tutte le valide spalle ed il dorso, e dai capelli asterse le gromme37 del sale marino. Poi, quando tutto fu lavato, fu d’olio cosperso, si ricoprì con le vesti che date Nausica gli aveva;
225 e la divina Atena, la figlia di Giove, lo rese più maestoso d’aspetto, più alto; e dal capo gli fece piovere a boccoli, e simili al fior del giacinto,38 le chiome. Come in argento l’oro agemina artefice sperto, cui svelarono Atena, la diva Palladia, ed Efesto,
230 tutti i segreti dell’arte,39 sì ch’egli belle opere compie,
34 I motivi per cui Nausica accetta di prendersi cura del naufrago sono due: innanzitutto perché, come gli stranieri, così anche tutti i mendicanti sono un dono di Giove, perciò meritano la medesima accoglienza che di solito si riserva agli ospiti; inoltre perché basta poco per soddisfare le loro richieste.
35 greto del fiume: “letto del fiume”.
36 Lavava intanto Ulisse divino nel fiume il salmastro. Da ordinare così: intanto Ulisse divino lavava il salmastro (“la salsedine”) nel fiume.
37 asterse le gromme: “ripulì le incrostazioni”.
38 simili al fior del giacinto. La somiglianza tra i boccoli di Ulisse e i fiori del giacinto può essere spiegata in due sensi: non solo i fiori sono fitti e presentano dei petali spesso arricciati (cosa che richiamerebbe i boccoli di Ulisse), ma sono anche scuri. Il paragone si può riferire quindi sia all’aspetto, sia al colore della chioma dell’eroe.
39 Come … dell’arte. Da ordinare così: come artefice sperto (“un esperto artigiano”), cui Atena, la diva Palladia ed Efesto svelarono tutti i segreti dell’arte, agemina (“incastona”) oro in argento. Palladia è un nome associato ad Atena, che equivale a Pallade. La similitudine perciò paragona l’opera perfetta di un artigiano esperto a quella di Atena che infonde bellezza a Ulisse. Vengono chiamati per questo in causa i due dèi a cui competono i lavori manuali: Atena è propriamente la dea delle arti ed Efesto il dio del fuoco.
così la Diva infuse bellezza sugli omeri e il capo d’Ulisse. Egli in disparte sedè su la spiaggia del mare, tutto di grazia e bellezza fulgente. E Nausica mirava; e questi detti infine rivolse a le ancelle ricciute:
235 «Datemi retta a quello che dico,40 fanciulle mie belle: non senza volontà dei Numi signori d’Olimpo giunto è quest’uom tra i Feaci, compagni diletti dei Numi: ché poco fa sembrava meschino, dappoco; e somiglia ora ai Celesti, ch’àn sede nei sommi fastigi del cielo.41
240 Deh!, se la sorte a me serbasse pur simile sposo! Deh!, se volesse qui rimanere, ed avervi dimora!
Ma dunque, via, fanciulle, porgetegli cibo e bevande».
Così diceva. E quelle non furono sorde né pigre.42
Posero accanto a Ulisse divino vivande, bevande;
245 e mangiò quivi Ulisse, progenie di Superi,43 e bevve avidamente, ché privo da tanto era stato di cibo. Provvide intanto ad altro Nausica dal candido braccio.
Tutte piegò le vesti, le pose sul lucido carro, poscia aggiogò le mule dai zoccoli solidi, ascese,
250 e la parola ad Ulisse rivolta, così gli diceva: «Ospite, levati44 adesso, moviamo; ch’io possa guidarti alla città, del padre mio savio alla casa; qui, credo, potrai conoscer quanti primeggian su tutti i Feaci.
Ma fa’ così, ché mi sembra che tu non sia privo di senno.
255 Sin che ci troveremo fra prati, fra campi e poderi, seguimi pure a passi veloci, vicino alle ancelle, dietro i muletti e il carro, ché io sarò guida al cammino.
Fermati poi, come in vista sarà la città. La vedrai tutta di torri cinta:45 due porti vi s’aprono ai lati,
40 Il pronome personale mi è ridondante, superfluo: “date retta a quello che dico”.
41 nei sommi fastigi del cielo: “nella parte più alta del cielo”.
42 non furono sorde né pigre. Si tratta di una litote, una figura retorica che consiste nel negare l’opposto di quel che si vuole affermare: l’espressione serve a sottolineare il fatto che le ancelle ascoltarono attentamente.
43 progenie di Superi: “stirpe divina”. Le divinità venivano chiamate anche Superi, in quanto dimorano in alto.
44 levati: “alzati”. Ancora oggi per indicare l’azione di portare qualcosa in alto diciamo sollevare (letteralmente “levare in alto”, “alzare”).
45 Cinta è complemento predicativo dell’oggetto riferito al pronome la (la città).
260 ed una breve striscia di terra fra loro; in due file qui sono, tutte in secco, le navi, e il suo stallo ha ciascuna. Ed una piazza s’allarga dintorno al bellissimo tempio di Posidone:46 ed è lastricata con blocchi di pietra, grossi, qui tratti da lungi.47 Gli arnesi dei negri navigli
265 quivi apparecchiano, gomene e vele, qui aguzzano remi: ché né di frecce né d’archi si danno pensiero i Feaci, bensì d’antenne, di remi per navi, di legni veloci, su cui traversan lieti le candide spume del mare.48
Temo di questi l’amara censura,49 che dietro le spalle
270 non mi funesti qualcuno, ché il popolo è assai maldicente; e che talun, più maligno, non debba, incontrandomi, dire: “Quello straniero alto e bello che segue Nausica, o chi sia, dove l’avrà pescato? Vuol farne di certo un marito!
Certo, è qualcuno arrivato da lungi, per mare. E Nausica
275 subito se l’è pigliato, ché qui non ce n’era abbastanza.
O che sia sceso dal cielo, commosso alle tante preghiere, qualche Celeste che intenda tenerla per sempre sua sposa?
Meglio, se, gironzolando, trovare ha potuto un marito d’un’altra parte; ché quelli di qui li disprezza; per quanto
280 ce n’è di molti e bravi, tra questi Feaci, a volerla!”
Questo direbbero, e scorno50 sarebbe per me: ché pure io mi sdegnerei con un’altra che simil condotta tenesse, che contro volontà dei suoi, vivi il padre e la madre, prima d’andare a nozze, con uomini insiem si mostrasse.
285 Ospite, e ascolta in fretta ciò ch’io ti dirò, perché possa subito aver da mio padre la scorta del dolce ritorno.
Lungo il sentiero vedrai bellissimo un bosco di pioppi sacro ad Atena: un prato lo cinge, vi sgorga una fonte.
46 Non bisogna dimenticare che i Feaci si ritenevano discendenti di Posidone: la loro abilità nella navigazione era senz’altro un dono del dio del mare, che in cambio esigeva non solo sacrifici, ma anche un’assoluta fedeltà.
47 qui tratti da lungi: “portati qui da lontano”.
48 I Feaci sono totalmente digiuni di lotte e guerre, per questo si dice che non fanno uso di frecce e di archi; sono però esperti navigatori: le loro navi risultano veloci come il pensiero, ben solide e sicure.
49 l’amara censura: “la maldicenza”.
50 scorno: “vergogna”.
Quivi è un podere, un fiorente verzier51 di mio padre, lontano
290 dalla città, quanto giunge la voce d’un uomo che gridi. Fermati, e aspetta qui per un pezzo, sin ch’io non sia giunta alla città, sinché siam tornate a casa del babbo. Quando potrai supporre che abbiamo raggiunta la casa, nella città dei Feaci tu pure entra allora; e dimanda
295 la casa di mio padre, d’Alcinoo magnanimo cuore. Facile cosa è distinguerla: un bimbo che ancor non parlasse ti ci potrebbe guidare, perché non son già costruite come quella d’Alcinoo, le case degli altri Feaci. Poi, quando accolto t’avrà la corte dell’alto palagio,
300 entra diritto nella gran sala, ché lì troverai al focolare seduta mia madre, e la fiamma l’irraggia;52 lane purpuree fila, poggiata ad un’alta colonna, ch’è uno stupore vederla; le seggono a tergo53 le ancelle. Quivi, d’Alcinoo il trono, vicino al suo trono, vedrai,
305 dove mio padre siede, che liba, che sembra un Iddio. Ma non badare a lui; tu prostrati e abbraccia i ginocchi di mia madre, se il giorno pur brami veder del ritorno, ed allegrartene presto, sebben la tua terra è lontana».
[309-324] Subito Nausica, le ancelle e Ulisse si mettono in marcia verso la reggia, così come era stato deciso. Giunto in un bosco sacro a Minerva, Ulisse le rivolge una preghiera perché lo renda gradito ai Feaci e in grado di suscitare la loro pietà. La dea ascolta la preghiera dell’eroe.
51 verzier: “giardino”.
52 la fiamma l’irraggia. Fiamma è soggetto; il complemento oggetto è il pronome l’ (la), riferito alla madre. La frase significa dunque: “la fiamma la illumina”.
53 a tergo: “alle spalle”.
Libro VII
Ulisse arriva in città
[1-13] Nausicaa giunge a casa precedendo Ulisse. Le vanno incontro i fratelli e la serva Eurimedusa, aiutandola a raccogliere dal carro le vesti lavate al fiume.
E verso la città Ulisse divino anch’ei mosse; 15 e provvedendo al suo bene, fittissima nebbia d’attorno gli avvolse Atena, perché nessun degli alteri Feaci, se l’incontrasse, dovesse schernirlo,1 indagare chi fosse. Ma quando era all’amena2 città già vicino, dinanzi qui gli si fece Atena, la Diva dagli occhi azzurrini, 20 simile a giovinetta fanciulla, e reggeva una brocca. Gli si fermò dinanzi; e Ulisse divino le chiese: «Figlia, sapresti indicarmi la casa dov’è del sovrano, d’Alcìnoo, che regge le genti di questa contrada?
Ch’io sono giunto qui, tapino3 straniero, da lungi,
25 da terra assai remota; perciò nessun uomo di quanti hanno dimora in questa lontana contrada io conosco». E gli rispose Atena, la Diva dagli occhi azzurrini: «Ospite padre, ti posso mostrare la casa che dici, che dell’onesto mio padre vicino alla casa si leva.
30 Su, vieni dunque, senza far motto,4 e t’insegno la strada: e non guardare alcuno, non volger parola ad alcuno, perché la gente di qui mal soffre le genti straniere, né di buon grado accoglie, né ama chi giunge di fuori.
Ch’essi affidati alle navi veloci traversan l’abisso
40 ampio del mare: così vuole il Nume che scuote la terra; e le lor navi come ali son celeri, come il pensiero».
1 schernirlo: “offenderlo”.
2 amena: “incantevole”.
3 tapino: “misero”.
4 far motto: “parlare”.
Pallade Atena, com’ebbe ciò detto, si mosse a guidarlo rapidamente; e Ulisse le peste5 seguia della Diva. Né alcuno lo scoprì dei Feaci maestri di navi,
45 mentre movea traverso la loro città, poi che Atena nol consentia, la Diva possente ricciuta, che attorno, per il suo bene, a lui stringeva una nuvola densa. Stupito Ulisse intanto la rada6 ammirava e le navi agili, e degli eroi le piazze, e le mura massicce,
50 eccelse, d’alti pali munite, stupende a vederle. Ma quando poi furon giunti del Sire alla fulgida casa, prese a parlare Atena, la Diva dagli occhi azzurrini: «Ospite padre, è questa la casa che tu mi chiedevi ch’io t’indicassi. Quivi entro, seduti a godere il banchetto, 55 i re tu troverai nutriti da Giove. Tu entra, né alcun timore il cuore ti stringa: ché in ogni vicenda meglio, per quanto giunga da lungi, si trova un uom franco».
[58-77] Prima di congedarsi da Ulisse, Minerva dà all’eroe delle ultime istruzioni: gli descrive la coppia regale che avrebbe trovato all’interno del palazzo, il re Alcinoo e la regina Arete, suggerendogli di fare tutto il possibile per entrare nelle grazie di quest’ultima.
La reggia dorata
E, così detto, partì la Diva dagli occhi azzurrini, su l’infecondo mare, lasciando l’amabile Scheria, 80 e giunse a Maratona,7 ne l’ampie contrade d’Atene, e d’Eretteo8 s’addentrò nella casa. Ed Ulisse moveva verso la casa d’Alcinoo famosa. Ma, pria di varcare la bronzea soglia, stette: ché il cuore gli andava estuando.9
5 le peste: “i passi”. Ulisse si lascia condurre dalla persona incontrata seguendone i passi.
6 rada: “golfo”, “porto”.
7 Maratona è una pianura dell’Attica, poco distante da Atene, passata alla storia per la celebre vittoria che gli Ateniesi, capitanati da Milziade, riportarono sui Persiani di re Dario nel V secolo a.C. In quell’occasione Filippide, un messaggero greco, venne incaricato di portare la notizia della vittoria ad Atene. Egli percorse allora di corsa i 42 km che separavano Maratona da Atene. Per ricordare questa impresa venne istituita all’interno dei giochi olimpici una corsa della medesima lunghezza chiamata maratona, tuttora esistente.
8 Eretteo era un eroe ateniese a cui era dedicato un tempio.
9 estuando: “ribollendo”.
Ché s’effondeva come di sole e di luna un bagliore
85 giù della bella casa d’Alcinoo da l’alto fastigio: ché dalla soglia al fondo correan due pareti di bronzo, d’ambe le parti, e un fregio sovra esse di smalto azzurrino.
Due porte d’oro dentro chiudevan la solida casa, e stipiti d’argento calcavan la soglia di bronzo;
90 ed era l’architrave d’argento, l’anello era d’oro. E dai due lati v’eran due cani, uno d’oro, un d’argento, che avea costrutti Efesto, con quanta perizia10 ei possiede, per custodire la casa d’Alcinoo magnanimo cuore: ed immortali sono, ché mai non li coglie vecchiezza.11
95 E troni eran poggiati di qua di là, tutto d’intorno alle pareti, via via, dalla soglia al recesso;12 e tappeti sottili, opre di femmine industri su v’eran gittati. Sedere sopra questi soleano i signori Feaci a bere ed a mangiare; ché avevano grande abbondanza.
100 E sopra saldi plinti,13 fanciulli foggiati nell’oro stavano, e nelle mani reggevano fiaccole ardenti, a rischiarar, la notte, le genti sedute a convivio. V’erano dentro la casa cinquanta fantesche14 al lavoro. Fra le due mole queste tritavano il biondo frumento:
105 quelle tessevano tele, sui fusi avvolgevano lana;15 l’agili mani foglie sembravan di tremuli pioppi:16 olio stillava giù dai pettini sopra il tessuto.
Quanto i Feaci sono più sperti degli uomini tutti nel governare le navi veloci sul pelago, tanto
110 valgon le donne al telaio: ché dono fu insigne d’Atena
10 perizia: “abilità pratica”.
11 Questi due cani erano degli autentici robot: costruiti da Efesto con dei metalli preziosi, erano vivi e sorvegliavano la casa di Alcinoo.
12 dalla soglia al recesso: “dal luogo che più è a contatto con l’esterno (la soglia) a quello più appartato, più nascosto (il recesso)”. L’espressione indica quindi che ogni locale del palazzo era arredato con sfarzo.
13 plinti: “piedistalli”.
14 fantesche: “serve”.
15 Queste… quelle… sono forme correlate.
16 L’immagine qui utilizzata è molto bella: le agili mani delle lavoratrici si muovono rapidamente e incessantemente, simili al tremolio continuo delle foglie di pioppo al vento.
esperte essere in opre bellissime, e aver dritto senno.17
E un gran giardino è presso le porte dell’ampio cortile, di quattro iugeri;18 e tutto d’intorno vi corre un recinto; e quivi alberi grandi verdeggiano, sempre in rigoglio:
115 e peri, e melograni, e meli dai floridi frutti, e fichi tutti dolci, e ulivi gremiti19 di bacche.
Mai da questi alberi il frutto non cade né viene a mancare, d’inverno né d’estate, ché sempre vi dura; e perenne
Zefiro spira, e alcuni fa nascere, ed altri matura.
120 Sopra la pera invecchia la pera, il pomo sul pomo, e ogni altro frutto: sul grappolo il grappolo, il fico sul fico.
Ed una vigna è qui piantata, coi grappoli fitti, onde una parte, già spiccati, appassiscono al sole, sovra uno spiazzo aprico;20 più lungi ne fanno vendemmia;
125 altri li stanno pigiando; più oltre racimoli verdi gittano appena il fiore, mentre altri divengono neri.
E ben disposte aiuole vicino all’estremo filare crescono, e danno perenne fulgore di fior d’ogni specie.
E sgorgan due fontane, che l’una per tutto il giardino
130 spandesi, e l’altra corre traverso il cortile alla soglia sino all’eccelsa casa. Da questa acqua attinge la gente. Questi ad Alcinoo doni stupendi concessero i Numi.
Ulisse chiede aiuto
Quivi fermatosi, Ulisse tenace divino ammirava.
E poi che d’ammirare tutta ebbe saziata la brama, 135 rapidamente varcò la soglia ed entrò nella casa.
Ed i signori trovò dei Feaci che guidan le genti, mentre libavano al Nume che scorge da lungi, Argicida:
17 ché dono fu insigne d’Atena esperte essere in opre bellissime, e aver dritto senno. Da ordinare così: ché essere esperte in opre bellissime e aver senno dritto fu dono insigne d’Atena Dritto significa “giusto”.
18 Lo iugero era un’unità di misura agraria. Corrispondeva alla quantità di terreno che una coppia di buoi (detta iugum in latino) arava in una giornata, ovvero un rettangolo di terra di circa 2.500 m2
19 gremiti: “pieni”, “ricolmi”.
20 Aprico significa letteralmente “aperto”, quindi “esposto al sole”, in quanto non racchiuso tra montagne.
l’ultima coppa a questo libavano, prima del sonno.21
S’avviò dunque Ulisse divino traverso la stanza, 140 cinto di molta nebbia che Atena infondevagli intorno, perché giunger non visto potesse ad Arete e al sovrano.
Dunque Ulisse abbracciò così le ginocchia d’Arete; ed ecco, a lui d’attorno si sciolse la nebbia divina.
Ammutolirono tutti, vedendo che un uomo era entrato; 145 guardarono, stupirono; e Ulisse levò tale prece: «Arete, o figlia tu di Ressènore pari ai Celesti,22 giungo al tuo sposo, alle tue ginocchia ed a questo convito dopo travagli molti. Concedano i Numi a voi tutti vita felice, e che possa ciascuno trasmettere ai figli
150 gli aviti23 beni e tutti gli onori dal popolo avuti.
Ora una scorta a me date che presto io ritorni alla patria, ché da gran tempo, errando lontano dai cari, io patisco».
Così detto, sedé nella cenere, accanto alla fiamma del focolare; e tutti rimasero senza parola.
[155-184] Tutti i Feaci restano ammutoliti e immobili di fronte a tale scena, non sapendo che fare. Interviene allora un vecchio principe, Echeno, suggerendo al re Alcinoo di accogliere l’ospite in modo adeguato, senza lasciare che resti ancora a lungo sdraiato a terra in preghiera. Obbedendo al saggio consiglio, Alcinoo fa lavare e accomodare il misterioso ospite. Ma, perché Ulisse possa riposarsi, il sovrano dei Feaci rimanda al giorno successivo ogni cerimonia di accoglienza pubblica.
185 «Principi, condottieri dei Feaci, or datemi ascolto, ch’io vi dirò quanto il cuore nel seno m’ispira ch’io dica.
Dopo il banchetto, a casa ritorni ciascuno a dormire.
Domani all’alba, tutti chiamati i signori più annosi,24 onore in casa nostra si faccia a quest’ospite, e ai Numi
21 Il Nume argicida è Mercurio. A lui i Feaci libavano prima di dormire, in quanto tra i compiti di questa divinità vi era anche quello di dispensare il sonno.
22 Arete era figlia di Ressenore, a sua volta fratello di Alcinoo. I due fratelli sovrani erano discendenti di Posidone. Dopo che Apollo uccise Ressenore, la figlia Arete andò in sposa allo zio Alcinoo, al quale partorì Nausicaa.
23 aviti: “ereditati dagli avi, dagli antenati”.
24 annosi: “carichi di anni”, quindi “anziani”, “vecchi”.
190 bei sacrifici offriamo. E quindi si pensi alla scorta, perché, senza travaglio né cruccio, quest’ospite nostro possa, da noi condotto, tornare alla terra materna, ed allegrarsi presto, per quanto di qui sia lontana; né male alcuno ei debba frattanto soffrir, né cordoglio25
195 prima ch’alla sua patria sia giunto. Qui poscia patire dovrà quello che a lui la Sorte e le Parche crudeli hanno filato il giorno che a luce lo diede sua madre. Se poi qualcuno fosse dei Numi discesi dal cielo, altro disegno allora rivolgono in mente i Celesti.
200 Però che sino ad ora solevano i Numi apparirci palesemente, quando le insigni ecatombe offrivamo, e a mensa dove noi sedevamo, sedevano anch’essi. E pur se viandante che vada soletto l’incontra, non si nascondon, poi che siam noi ad essi vicini,
205 come i Ciclopi, come le fiere tribù dei Giganti».26
E gli rispose così l’accorto pensiero d’Ulisse: «Altro pensiero, Alcinoo, tu devi formare. Io non sono simile punto ai Numi, del cielo immortali Signori, né di statura, né d’aspetto; ma pari ai mortali;
210 a quelli dei mortali che voi conosciate più oppressi dalle sciagure; a quelli, per ciò ch’io patii, sono pari.
E molte ancora più sciagure potrei raccontarvi, se vi narrassi ciò ch’io patii per volere dei Numi.
Ma or, per quanto cruccio mi stringa, lasciate ch’io ceni;
215 ché non esiste nulla del ventre più rabido:27 è un cane, che di necessità fa sì che di lui ti ricordi, anche se molto afflitto sei tu, se dolore t’affanna, come ora avviene a me, ché il dolore m’affligge ed il ventre
25 cordoglio: “dolore (doglio) nel cuore (cor)”.
26 Ulisse è apparso all’improvviso per il dileguarsi della nebbia di cui lo aveva circondato Minerva: questo giustifica la supposizione di Alcinoo, benché gli sembri strano che un dio si mostri ai Feaci sotto l’aspetto di un uomo, in quanto sono soliti mostrarsi loro palesemente, non solo nei banchetti e sacrifici solenni, ma anche negli incontri occasionali e fortuiti. Se così fosse, gli dèi devono avere cambiato opinione, mutato modo di agire (altro disegno allora rivolgono in mente i Celesti). I Feaci, infatti, sono un popolo di stirpe divina, come quello dei Ciclopi e dei Giganti.
27 rabido: “rabbioso”.
mi sprona senza tregua ch’io mangi, ch’io beva; e di tutto
220 ciò ch’io soffersi mi fa dimentico e vuol ch’io m’impinzi.
E voi, come l’aurora nel ciel brillerà, procurate che io, misero me, possa infine tornare alla patria, dopo sì lunghi travagli. Quando abbia veduti i miei beni, i servi miei, l’eccelsa mia casa, oh, ben venga la morte!»
225 Così diceva. E tutti gli diedero lode. E partito preser28 di dargli scorta: ché bene egli aveva parlato.
E poi ch’ebber libato, bevuto quanto ebbero brama, i convitati a dormire tornarono ognuno alla casa.
Il racconto è solo accennato…
Dentro alla sala invece rimase Ulisse divino, 230 e Alcinoo pari ai Numi rimase ivi pure, ed Arete. Or dopo che i famigli29 le mense sgombrâr dagli arnesi, volse il discorso Arete dal candido braccio ad Ulisse, però ch’essa le vesti conobbe, e la tunica, e il manto bello, che avea con le ancelle di casa ella stessa intessuto.30
235 E a lui dunque si volse col volo di queste parole: «Questa domanda io prima rivolger ti voglio, straniero: Chi sei? Di quali genti? Chi mai ti donò quella veste?
Non dici tu che sei qui naufrago giunto per mare?»
E le rispose così l’accorto pensiero d’Ulisse:
240 «Regina, è dura cosa, se tutto narrare io ti debbo, perché troppe sventure m’inflissero i Numi d’Olimpo. Pur quello ti dirò che tu mi domandi e che brami. Sorge un’isola, Ogigia, nei gorghi remoti del mare. Quivi la figlia d’Atlante, Calipso dai riccioli belli, 245 abita, Diva possente, maestra d’inganni; né proprio nessuno a lei s’accosta, né Nume, né uomo mortale. Ma io, misero me, fui spinto da un demone a lei: solo, poiché la veloce mia nave col folgore31 ardente
28 partito preser di…: “presero la decisione di…”.
29 i famigli: “i servitori”.
30 Arete riconosce indosso a Ulisse i vestiti che ella stessa aveva cucito e che aveva affidato alla figlia Nausicaa da lavare al fiume.
31 folgore: “fulmine”.
ebbe spezzato Giove in mezzo al purpureo ponto.
250 Qui gli altri miei compagni trovarono tutti la morte. Io della nave alla chiglia mi strinsi con ambe le braccia, e fui per nove dì trascinato. Nel decimo, a notte, gli Dei nell’isola Ogigia mi spinsero, dove Calipso abita, Diva possente dai riccioli belli. M’accolse
255 ella con tutto il cuore, mi die’ da nutrirmi, e promise ch’ella m’avrebbe reso immune da morte e vecchiaia.
Ma non pote’ giammai convincermi il cuore nel seno.
Quivi sette anni rimasi continui,32 di pianto bagnando sempre le vesti ambrosie33 che date m’aveva Calipso.
260 Ma quando giunse poi, volgendosi i dì, l’anno ottavo, allora m’esortò, conforto mi die’ ch’io partissi, ché lo voleva Giove, se pur non mutò la sua mente.34
Sopra una zattera stretta da molte ritorte35 mi pose, pane mi die’, vino pretto, mi cinse di vesti divine,
265 e un’aura dietro me spedì favorevole e mite.
Per dieci giorni e sette così navigai sopra l’onde. Al diciottesimo apparvero i monti velati d’ombria36 di questa vostra terra; e il cuore mi rise di gioia. Misero me! Ché dovevo trovarmi fra molti travagli
270 che inflisse a me Posidone, il Nume che scuote la terra, che mi sbarrò la via con l’urto di venti contrarî, e suscitò marosi terribili;37 e flutti su flutti
non consentivano a me di restar su la zattera. In lagni alti io rompevo.38 Infine la39 franse un gran cozzo di venti:
275 e allora io fendei questa voragine a nuoto. Alla fine
32 sette anni … continui: “sette anni senza interruzione, di fila”.
33 ambrosie. L’ambrosia è il cibo che solo gli dèi conoscono. L’aggettivo indica dunque qualcosa che è propriamente divino, immortale.
34 Ulisse fa due supposizioni per spiegare come Calipso si sia decisa a lasciarlo andare. Egli non sa del messaggio recato da Mercurio, perché la dea non gli ha detto nulla di ciò. Perciò egli ipotizza che dietro la partenza concessagli vi sia o il volere di Giove o un improvviso cambio di opinione della dea stessa, che mai l’aveva lasciato partire prima di allora.
35 ritorte: “corde”.
36 ombria: “nebbia”, “foschia”.
37 marosi terribili: “terribili ondate”.
38 In lagni alti io rompevo: “mi lamentavo grandemente”.
39 Il pronome la si riferisce alla zattera.
i venti e le correnti mi spinsero all’isola vostra, dove m’avrebbe un grande maroso spezzato alla terra, sbattendomi alle immani scogliere e all’inospite costa;40 ma io, trattomi indietro, di nuovo nuotai, sin ch’io giunsi
280 al fiume, ove mi parve che fosse migliore l’approdo, privo di scogli, e alture sorgevano a schermo dei venti. Qui caddi e presi fiato; e scese la notte divina. Fattomi quindi lungi dal fiume caduto dal cielo,41 dentro un macchione a dormire mi posi; e un gran mucchio di foglie
285 mi feci attorno; e un Dio m’infuse infinito sopore.42 Qui, nel fogliame dormii, per quanto crucciato nel cuore, tutta la notte, e l’alba, e mezzo del giorno seguente. Quando calava il sole, dal sonno soave fui sgombro; e di tua figlia vidi le ancelle, che sopra la spiaggia
290 giocavano; e tra loro tua figlia sembrava una Dea.
Io la pregai; né essa fallì di saggezza ai dettami:43 anzi più assai ne mostrò che tu non credessi trovarne in così tenera età: ché poco è dei giovani il senno. Essa mi diede pane, mi diede purpureo vino,
295 lavar mi fe’ nell’acqua del fiume, mi die’ queste vesti». E gli rispose Alcinoo, gli volse così la parola: «Ospite, in una cosa non ha dimostrato gran senno la figlia mia: che te condotto non ha con le ancelle, alla mia casa, quando tu prima l’avevi pregata».
300 E gli rispose così l’accorto pensiero d’Ulisse: «Eroe, non biasimare di ciò l’incolpevole figlia. Essa m’aveva detto che io con le ancelle seguissi; ma io non volli, avendo riguardo di te, paventando44 che a quella vista tu non dovessi salire in furore:
40 Dove m’avrebbe un grande maroso spezzato alla terra, sbattendomi alle immani scogliere e all’inospite costa: “dove una grossa ondata mi avrebbe schiantato a terra, fracassandomi contro i grandi scogli e la riva rocciosa”.
41 Fattomi quindi lungi: “allontanatomi”. Il fiume è detto caduto dal cielo perché l’acqua che lo alimenta è appunto quella piovana.
42 sopore: “sonno”. Si pensi all’aggettivo soporifero, “che fa addormentare”.
43 né essa fallì di saggezza ai dettami: “ed essa non dimenticò quanto suggerisce, quanto detta (i dettami) la saggezza”. Nel racconto di Ulisse, Nausicaa si comporta saggiamente, come la buona educazione ricevuta le ha suggerito di fare.
44 paventando: “temendo”.
305 ché tutti quanti noi mortali collerici siamo».
E gli rispose Alcinoo, gli volse così la parola: «Ospite, no, che un cuore siffatto io non chiudo nel seno, ch’io stoltamente m’adiri: val meglio attenersi a giustizia. Deh!, se mai Giove padre volesse, ed Atena ed Apollo,
310 che, tale essendo qual sei, pensando tu pur come io penso, sposa tu avessi mia figlia, mio genero fossi chiamato, e qui restassi! A te la casa ed i beni darei, se volentieri restassi: ché contro tua voglia tenerti niuno vorrà dei Feaci: deh!, Giove già mai non lo voglia!
315 Sappi che per domani farò che s’appresti il viaggio.
Allora tu potrai giacere sopito nel sonno; e noi sospingeremo la nave sul mare in bonaccia,45 sin che tu giunga alla terra materna, o dovunque tu brami, anche se andar tu volessi lontano più assai de l’Eubea,
320 la terra più remota, raccontano i nostri nocchieri.46
Essi la videro quando condussero là Radamanto biondo, che Tizio voleva vedere, il figliuolo di Gea.47
Essi vi andarono, senza fatica facendo il viaggio, e nel medesimo giorno percorser la via del ritorno.
325 Ma lo potrai vedere da te, come sappian le navi nostre e i nocchieri nostri sconvolgere i flutti coi remi».
[327-345] L’eroe itacese prega Giove perché possa rendere eterna la fama di Alcinoo e affinché egli stesso possa ritornare in patria. Con questa speranza in cuore, Ulisse viene accompagnato nel portico, dove gli è già stato preparato un letto. Anche il re e la regina si ritirano nelle loro stanze.
45 Il mare si dice in bonaccia quando è calmo, quando cioè non soffia alcun vento che possa agitarlo.
46 Il nocchiere è colui che guida la nave.
47 Tizio era un gigante il quale, per aver recato offesa a Latona, madre di Apollo e Diana, fu ucciso da questi due e relegato nell’Ade. Abitò nell’Eubea, e proprio lì venne in seguito venerato come eroe. In Eubea, pertanto, venne condotto dai Feaci l’eroe Radamanto, desideroso di fare visita a Tizio.
Libro VIII
Demodoco, l’aedo dei Feaci
L’assemblea nella piazza
Come l’Aurora apparì mattiniera, ch’à dita di rose, ecco balzò dal letto la forza d’Alcinoo divina,1 ecco balzò dal letto Ulisse eversore di rocche.2 E andâr, movendo prima la forza d’Alcinoo divina, 5 presso le navi, dove s’apria dei Feaci la piazza.3
E giunti qui, sederon sovressi i lucenti sedili, l’un presso all’altro: e per la città mosse Pallade Atena che le sembianze assunte avea dell’araldo del sire, per provvedere al ritorno d’Ulisse magnanimo. E presso 10 fattasi a questo e a quello, così gli volgea la parola: «Presto, su via, signori Feaci che il popol guidate, movete all’assemblea, che l’ospite udire possiate ch’è testé4 giunto alla casa d’Alcinoo mente divina, dopo un errare lungo pel mare, che sembra un iddio!»
15 Così dicendo, eccitò la voglia d’ognuno e lo zelo,5 sì che la piazza ed i seggi s’empierono rapidamente di genti convocate. E molti stupiano, mirando il figlio di Laerte dal senno divino: ché Atena profuso aveagli grazia celeste su gli omeri e il capo, 20 e poi reso l’aveva più alto e più saldo a vedere, ché riuscire accetto6 potesse a tutti i Feaci,
1 la forza d’Alcinoo divina: “il forte e divino Alcinoo”. È comune in Omero l’uso del sostantivo astratto al posto dell’aggettivo corrispondente.
2 eversore di rocche: “distruttore di città fortificate”. Si allude evidentemente alla parte fondamentale che Ulisse ebbe nella distruzione di Troia.
3 La piazza è il centro della vita civile, il luogo dove si svolgono le assemblee e dove si amministra la giustizia. Nell’isola dei Feaci, popolo di navigatori e mercanti, la piazza si trovava in prossimità del porto.
4 testé: “adesso”, “proprio ora”.
5 zelo: “desiderio intenso”, “una volontà fortissima”. In questo caso il desiderio di tutti è quello di partecipare all’assemblea.
6 riuscire accetto: “risultare gradito”.
e venerando e possente, che compiere i molti potesse cimenti, onde i Feaci saggiaron le forze d’Ulisse.7
Or quando poi s’accolsero, e furono insieme adunati,
25 prese a parlare Alcinoo tra loro, così prese a dire: «Datemi ascolto, signori Feaci che il popol guidate, ch’io voglio dire quello che il cuore nel seno mi detta. Questo straniero non so chi sia, che qui naufrago giunse, non so se da le genti di levante, oppur di ponente,8
30 a noi chiede una scorta che lui riconduca alla patria.
Or noi, come altra volta facemmo, apprestiamo la scorta; poiché niuno altra volta fu mai, che, ospitato in mia casa, dovesse quivi a lungo restar, sospirando il ritorno.
Su via, spingiamo dunque nel mare divino un naviglio
35 che mai solcate l’onde non abbia, e scegliamo cinquanta e due nocchieri, quelli dei nostri che abbiamo migliori. E tutti, poi che abbiate legati i remi agli scalmi, scendete a terra e, senza frapporre indugio, movete alla mia reggia, e qui pranzate: ché tutti io convito.9
40 Ai marinai impartisco quest’ordine. E voi che reggete lo scettro alla mia casa fulgente, o signori, venite, ché festeggiar lo straniero vogliamo sotto il mio tetto.
Né si rifiuti alcuno. Demòdoco quindi si chiami, il divino cantore: ché a lui più che a ogni altro i Celesti
45 diêr che molcire i cuori potesse, ov’ei brama, col canto».10
Demodoco il cantore
[46-59] Ormeggiate le proprie navi, i signori Feaci si dirigono tutti alla reggia di Alcinoo. Il sovrano ha fatto preparare un banchetto con dodici capretti,
7 che compiere i molti potesse cimenti, onde i Feaci saggiaron le forze d’Ulisse: “affinché potesse compiere le molte prove con le quali i Feaci avrebbero misurato la forza di Ulisse”. Le prove di cui si parla sono le gare atletiche che Ulisse dovrà sostenere a breve per dimostrare ai Feaci il proprio valore.
8 Levante e ponente indicano rispettivamente l’est e l’ovest, ovvero la direzione verso la quale si vede il sole sorgere (levarsi da terra) e quella verso la quale lo si vede tramontare (porsi a terra). È proprio questa la differenza racchiusa nel modo di chiamare le due parti della regione Liguria: riviera di Ponente e riviera di Levante.
9 convito: “invito”.
10 i Celesti diêr che molcire i cuori potesse, ov’ei brama, col canto: “gli dèi gli concessero che potesse allietare i cuori con il canto ogni volta che lo desiderasse”.
otto maiali e due buoi. Nel frattempo si è provveduto a inviare un messaggero, Pontonoo, affinché rechi a palazzo l’aedo Demodoco.
60 E giunse anche l’araldo,11 guidando il diletto cantore, cui12 predilesse la Musa, donandogli un bene ed un male: privo lo fe’ degli occhi, ma il canto soave gli diede. Di ferree borchie adorno un trono gli offrì Pontonòo, in mezzo ai convitati, poggiandolo a un alto pilastro;
65 quivi poscia appiccò, sul suo capo, la cétera arguta, a un chiodo, e gli mostrò come tender dovesse la mano per dispiccarla;13 e presso gli pose un canestro ed un desco bello e una coppa di vino, da ber finché voglia ne avesse. Su le vivande allestite gittarono tutti le mani;
70 e poi ch’ebber placata la fame e la sete, la Musa spinse il cantor che le gesta degli eroi dicesse in un canto la cui fama salire dovesse di lì fino al cielo: la lite che s’accese fra Ulisse ed Achille Pelide, ch’ebber contesa un giorno, nell’agape sacra ai Celesti,
75 con minacciose parole.14 Fu lieto Agamènnone allora, che quel contrasto sorgesse fra i primi guerrier degli Argivi, ché Febo Apollo fausto15 predetto gli aveva tal segno nella santissima Pito, quand’ei la marmorea soglia16 varcò per consultarlo; ché allor, per volere di Giove, 80 per i Troiani e pei Danai volgea degli affanni il principio. Queste il cantore illustre vicende cantava. Ed Ulisse l’ampio purpureo mantello con ambe le valide mani
11 L’araldo cui si fa riferimento è Pontonoo, che è stato incaricato di recare a palazzo l’aedo Demodoco.
12 cui: pronome relativo con funzione di complemento oggetto (“che”).
13 per dispiccarla: “per staccarla”.
14 La lite di cui si parla non è raccontata nell’Iliade, poema che racconta gli eventi decisivi della guerra di Troia. Pare tuttavia che fosse un argomento piuttosto noto all’epoca, raccontato in un’opera mai giuntaci, la Kypria. Sembra che Ulisse e Achille durante un sacro banchetto (agape) discussero animatamente sul modo di conquistare Troia: il primo sosteneva che si dovesse ricorrere all’astuzia, il secondo alla forza. Questa lite era stata predetta ad Agamennone come segno premonitore della vittoria su Troia: ecco dunque spiegata la ragione della gioia che prova Agamennone nell’assistere alla lite tra i due suoi più valorosi guerrieri.
15 Fausto è un aggettivo che indica qualcosa di estremamente positivo.
16 La marmorea soglia è la soglia del tempio di Delfi, anticamente chiamata Pito, dove il dio Apollo pronunciava i suoi vaticini per bocca di una sacerdotessa chiamata Pizia.
si trasse sopra il capo, nascose il suo nobile volto, ché lo pungea vergogna di piangere innanzi ai Feaci.
85 E quante volte il poeta divino cessava il suo canto, tante tergeva17 le lagrime, il manto scostava dal viso, e, tolto in mano il nappo capace,18 libava ai Celesti: quando ricominciava, poiché lo incitavano al canto i principi Feaci, che molto godeano al suo verso, 90 di nuovo Ulisse il volto celava nel manto e piangeva. E a tutti quanti allora sarebbe sfuggito il suo pianto; Alcinoo solamente, che presso gli stava seduto, lo guardò, se n’accorse, l’udì che piangeva accorato, ed ai Feaci il volo rivolse di queste parole:
95 «Datemi ascolto, signori Feaci che il popol guidate: sazî siam tutti oramai di cibo, ciascuno a sua brama, e della lira, che vibra compagna alla florida mensa. Usciamo adesso, e prova facciamo di tutte le gare, perché l’ospite possa, tornato alla terra materna,
100 dire agli amici quanto più validi siam d’ogni gente nell’arte della lotta, nei pugni, nel salto, nel corso».
[102-128] I Feaci escono dal palazzo per recarsi allo stadio. I giochi si aprono con le gare di velocità, che vedono come vincitore uno dei figli di Alcinoo. Un altro dei figli del re, Laodamante, nota che Ulisse non prende parte alle gare e assieme a un compagno, Eurialo, vorrebbe invitarlo. Ben presto, però, il prepotente Eurialo inizia a provocare lo straniero.
Or, poi che tutti quanti si fur sazïati di gare,
130 Laodamante, figliuolo d’Alcinoo, così prese a dire: «Amici, interroghiamo, su via, lo straniero, se sperto fosse di qualche gara. Meschino ei non è nell’aspetto: saldi i suoi femori sono, le gambe ed entrambe le braccia, massiccio il collo, e grande la forza; neppure gli manca
17 tergeva: “asciugava”, “puliva”. Questa forma verbale deriva dal latino tergere, “pulire”, il quale non è del tutto scomparso dalla lingua italiana, ma si può ritrovare in alcune parole: detersivo, detergente, tergicristallo.
18 e, tolto in mano il nappo capace: “e sollevata (tolto) in mano l’ampia coppa”.
135 la gioventù; soltanto prostrato19 è dai molti malanni: ché non esiste, io dico, malanno peggiore del mare, per abbattere un uomo, per quanto esser possa gagliardo».
E gli rispose allora Eurialo con queste parole: «Laodamante, opportune son queste parole che dici:
140 il tuo pensiero esponi tu stesso e rivolgi l’invito».
E poi che il prode figlio d’Alcinoo ebbe udito, si mosse in mezzo all’adunanza, si fermò, si volse ad Ulisse: «Ospite padre, anche tu, su via, prendi parte alle gare, se esperto sei di gare: ché tal sembreresti a vederti:
145 ché non si dà per un uomo, sin ch’ei vive, gloria più grande di quella che le mani si acquistano e i validi piedi.20
Tenta la prova, su via, bandisci21 gli affanni dal cuore, poiché non è lontano per te del ritorno il momento; anzi, la nave è di già nel mare, e son pronti i nocchieri».
150 E gli rispose così l’accorto pensiero d’Ulisse: «Laodamante, perché questo invito che il cuore mi sferza?22
Alle sciagure ho rivolta la mente ben più che alle gare: ché tanti affanni e tanti travagli ho dovuto patire. Ed ora, del ritorno bramoso, nel vostro convegno
155 seggo, e rivolgo al re la prece, ed al popolo tutto».
Eurialo queste allora gli volse rissose parole: «Ospite, assimigliarti non posso ad un uom che maestro sia ne le gare che spesso si sogliono indir23 fra le genti: anzi, ad un uomo che sopra navile dal fitto remeggio
160 giri pel mondo, a capo di gente che va mercatando,24 e che del carico solo sollecito25 sia, delle merci e dei rapaci guadagni. L’aspetto non hai d’un atleta».
Lo guardò bieco Ulisse, rispose con queste parole:
19 prostrato: “affaticato”.
20 Per i Greci i giochi atletici avevano grande importanza ed erano il fondamento delle grandi celebrazioni nazionali, le gare pitiche, le nemee, le istmiche e le olimpiche (queste ultime note ai più come Olimpiadi), in cui si alternavano le cerimonie religiose con le competizioni sportive. I vincitori di queste gare ricevevano grandi onori e venivano celebrati da famosi poeti.
21 bandisci: “allontana”.
22 sferza: “colpisce”, “ferisce”.
23 indir: “organizzare”, “decretare”.
24 mercatando: “mercanteggiando”, “commerciando”.
25 sollecito: “preoccupato”, “attento”.
«Ospite, e tu non bene mi parli, e somigli un protervo.26
165 Non danno i Numi a tutti del pari gli amabili doni, e bell’aspetto, e senno profondo e faconda parola.27
Esservi un uomo può, che sia ben meschino d’aspetto, ma di bellezza un Nume ghirlandi i suoi detti;28 e gli sguardi volge su lui chi l’ode gioendo. Con franca modestia
170 dolce favella un altro, brillando fra il popolo; e quando giunge in una città, l’onorano al pari d’un Nume.
Bello d’aspetto è un terzo, somiglia ai Celesti d’Olimpo, ma di nessuna grazia s’abbellano a lui le parole, come sei tu, che insigne sei tanto d’aspetto, né meglio
175 neppure un Dio potrebbe plasmarti; e di mente sei stolto, e provocato m’hai nel cuore lo sdegno, parlando senza riguardo. No, non sono inesperto di gare, come tu dici; ed anzi mi credo ch’io fossi tra i primi, quando la gioventù vigor m’infondeva nel braccio.
180 Ma ora sono oppresso dai mali e dai crucci: ché troppo ebbi a soffrire, tra guerre di genti e tra l’urto dei flutti.
E pure, anche così, fra tanti dolori, alle gare vo’ cimentarmi: ché tu coi detti mordaci m’aizzi».29
Disse. Ed involto com’era nel manto, lanciandosi, un disco
185 prese, massiccio, più grande, pesante più molto di quelli onde soleano fra loro contendere in gara i Feaci.30
E, roteatolo, via lo lanciò dalla mano gagliarda.
Alto la pietra rombò, chinarono a terra la testa gl’incliti navigatori Feaci, maestri di remi, 190 a quella furia; e la pietra, scagliata a gran forza dal pugno, oltre volò le gittate di tutti.31 Ed Atena il segnale
26 somigli un protervo: “sembri un arrogante”.
27 I grandi doni che gli dèi possono elargire agli uomini secondo la mentalità greca erano la bellezza (bell’aspetto), l’intelligenza (senno profondo) e l’eloquenza, l’abilità nel parlare (faconda parola). Eurialo ha il primo dono, ma è privo degli altri due, che sono ben più importanti.
28 ma di bellezza un Nume ghirlandi i suoi detti. L’eloquenza è concepita in modo molto poetico come la benevolenza di un dio che corona (ghirlandare) di bellezza le parole dell’uomo.
29 ché tu coi detti mordaci m’aizzi: “poiché tu mi provochi con le tue parole insolenti”.
30 Solitamente i Feaci gareggiavano con dischi di metallo, il cui peso poteva variare da 1,5 a 5,7 kg. Il disco scagliato da Ulisse è invece di pietra e il suo peso si aggira intorno ai 7 kg.
31 La gittata è la distanza percorsa in volo da un corpo che viene lanciato. Ad esempio, la gittata di un’arma da fuoco è la distanza che il proiettile può percorrere in aria prima di cadere a terra.
pose,32 che aveva assunta sembianza d’un uomo e che disse: «Ospite, un cieco anch’egli potrebbe distinguere il segno, così palpando: perché non è già confuso con gli altri, 195 anzi, più avanti molto. Compiaciti pur della gara, ché superarti o agguagliarti nessuno potrà dei Feaci».
Disse così. Molto lieto fu Ulisse divino tenace, e s’allegrò che un amico benigno trovò nel consesso; e più leggero in cuore si volse a parlare ai Feaci:
200 «Giovani, or sino a questo giungete; ed un altro di poi ne scaglierò pari al primo, mi spero, e forse anche più lungi. E qualunque altra gara la brama vi spinga a cercare, si tenti, via, la prova, giacché l’ira mia suscitaste: al pugilato, alla lotta, al corso, ché io non rifiuto,
205 quando Laodamante s’escluda, verun dei Feaci.
Ospite quegli m’è: chi mai misurar si vorrebbe con chi l’ospita e l’ama? È un uomo dappoco, uno stolto, quei che, trovandosi in terra d’estranëi, provoca a gare chi l’ospita: distrugge da sé qual sia vogliasi33 bene.
210 Ma niun rifiuto,34 niuno disprezzo degli altri Feaci: a faccia a faccia voglio vederli e tentarne le forze, ché delle gare, quante ce n’è, non son punto inesperto.
Un arco levigato so ben maneggiare, e per primo saprei colpire un uomo, lanciando una freccia, nel fitto
215 delle nemiche turbe, se pur molti e molti compagni stessero presso lui, scagliassero dardi ai nemici. Il solo Filottete di me più valeva,35 nei giorni quando gli Achivi a Troia tentaron la prova dell’arco.
Ma di gran lunga il migliore mi credo fra quanti mortali
220 vivono adesso e pane manducano sopra la terra. Certo che non vorrei gareggiar con gli eroi d’una volta, né con Eurìto, re d’Ecalìa,36 né con Ercole: quelli
32 Ieri, come oggi, la misurazione di un lancio era effettuata da un giudice che poneva un segnale dove era caduto il disco.
33 qual sia vogliasi: “qualsiasi”, “qualsivoglia”.
34 niun rifiuto: “io non rifiuto nessuno”.
35 Filottete era il capo dei Tessali della Magnesia che navigarono verso Troia. Famoso arciere, possedeva l’arco e le frecce di Ercole, con le quali colpiva infallibilmente il bersaglio.
36 Eurito era il re dell’Ecalia, città della Messenia o della Tessaglia, ed era molto abile nell’uso
ardìan perfino i Numi sfidare nell’arte dell’arco.
Per quanto Eurìto grande ben presto morì; né colpirlo
225 poté fra le sue mura vecchiaia, ma Febo lo uccise, irato che al cimento lo avea provocato dell’arco.
Il giavellotto posso lanciare come altri una freccia.
Solo nel corso temo che possa qualcun dei Feaci vincermi, poi che troppi patii miserandi37 travagli, 230 tra i flutti errando a lungo, né sopra le navi temprarmi38 sempre potevo, e fiaccate perciò mi si son le ginocchia».
Le scuse di Alcinoo e le danze
[232-451] Ulisse è risentito, ma interviene il sovrano Alcinoo a placare gli animi. Egli invita tutti ad assistere a una splendida danza di giovani ragazzi e ragazze. Per riconciliarsi con l’ospite, Eurialo offre in dono a Ulisse una preziosa spada e questi accetta di buon grado.
L’addio di Nausicaa
Ed ecco allor Nausica, spirante celeste bellezza,39 presso alla porta dinanzi gli stie’, nella solida sala.
E stupefece, com’ebbe su Ulisse gittato lo sguardo,
455 e si rivolse a lui col volo di queste parole: «Ospite, salve! E di me, quando in patria sia giunto, ricordo serba: compenso mi devi d’averti salvato, io la prima».
E le rispose così l’accorto pensiero d’Ulisse: «O tu, figlia d’Alcinoo magnanimo cuore, Nausicaa, 460 così lo sposo d’Era che tuona dal cielo profondo faccia che a casa io giunga, che il dì del ritorno io pur vegga!
Allora, anche colà, sì come ad un Nume, ogni giorno ti volgerò preghiere: ché tu m’hai salvato, fanciulla».
dell’arco. Egli aveva promesso in sposa la figlia Iole a chi lo avesse vinto nella prova dell’arco, ma, superato da Ercole, non mantenne la promessa. Ercole distrusse allora la sua città ed Eurito fu costretto a rifugiarsi in Eubea, dove lo uccise Apollo, il dio arciere, con cui questi aveva osato cimentarsi.
37 miserandi: “da commiserare”, “che fanno piangere”.
38 temprarmi: “allenarmi”.
39 spirante celeste bellezza: “che emanava una bellezza celeste”, “bella come una dea”.
[464-479] Nuovamente Ulisse viene invitato a banchetto presso il re e ancora una volta giunge Demodoco a dilettare i presenti. Anche per il vecchio cantore è stato preparato un pezzo di carne arrostita, poiché è giusto che egli sia rispettato per la maestria che dimostra nella sua nobile arte.
480 E poi che fu sedata la brama del cibo e del vino, Ulisse, il sire tutto scaltrezza, a Demòdoco disse: «Te più che ogni altro onoro, Demòdoco: o sia che la Musa figlia di Giove t’abbia nel canto addestrato, od Apollo. Mirabilmente tu sai cantar degli Achei le sciagure, 485 quanto operaron, quanto patiron, soffrirono in guerra, come se stato fossi presente, o se alcuno di loro lo avesse a te narrato. Cambia ora argomento e il cavallo narra, l’ordigno di legno ch’Epèo con Atena costrusse, e nella rocca Ulisse divino con frode l’addusse,
490 d’uomini avendolo empiuto, che Troia poi misero a sacco.40
Se tutto questo saprai per ordine a me tu narrare, subito andrò dicendo fra tutte le genti del mondo che a te concesse il Nume41 la grazia divina del canto». Disse. E il poeta svolse, movendo dal Nume, il suo canto.
495 Dal punto incominciò che sopra le navi gli Argivi ascesi e date al fuoco le tende, si misero in mare. E Ulisse, in Troia già, nascosto al cavallo nel grembo, era coi suoi compagni, già stretti i Troiani a consesso, che aveano entro la reggia condotta essi stessi la fiera.42
500 Qui stava. E intorno ad essa, fra varie sentenze i Troiani eran perplessi: e tre43 parean prevalere su l’altre. O di spaccar con la furia del bronzo quel concavo legno,
40 La storia del cavallo di Troia è già stata raccontata nel libro IV, durante l’incontro tra Telemaco e Menelao.
41 Apollo è il dio che concede agli aedi il dono del canto e la capacità di conoscere tutti gli eventi mitologici successi, pur senza aver potuto prendere parte al loro svolgimento.
42 Con il termine fiera (letteralmente “bestia”) ci si riferisce al cavallo di legno.
43 tre: tre (sentenze), cioè “tre pareri”.
o di scagliarlo giù per le rupi dal sommo dell’arce,44 oppure, insigne pregio, lasciarlo in omaggio ai Celesti.45
505 E sovra gli altri dovea prevalere quest’ultimo avviso, ch’era per essi fatale soccombere46 quando la rocca avesse accolto il grande cavallo di legno, ove tutti eran gli Argivi più forti, forieri47 di morte ai Troiani. E cantò poscia come gli Achei, dal cavallo balzati,
510 lasciato il cavo agguato,48 la rocca mettevano a sacco.
Cantò come chi qua chi là saccheggiarono Troia, e come Ulisse, insieme col pari agli dèi Menelao, simile a Marte, piombò di Deìfobo sopra la casa;49 narrò come la guerra più dura egli quivi sostenne,
515 e la vittoria a lui consentì la magnanima Atena.
Così dunque cantava l’insigne poeta. Ed Ulisse struggeasi; e il pianto giù dal ciglio bagnava le guance. Come una donna piange protesa sovresso lo sposo, che per la sua città, pei suoi cittadini è caduto, 520 per tener lungi il giorno fatal dalla rocca e dai figli: essa, che cader morto lo vide e dar gli ultimi guizzi, amaramente piange, protesa sul corpo; e i nemici di dietro, con le lance, le battono gli omeri e il collo, e via schiava l’adducon, ché soffra fatiche e dolori;
525 e a lei pel più doglioso tormento s’emacian50 le guance; così bagnava Ulisse di misero pianto le ciglia.
44 arce: “rocca”, “cittadella”.
45 Di fronte all’apparire del cavallo, misteriosa e gigantesca costruzione in legno, i Troiani si radunano in assemblea per decidere che cosa farne. Tra le tante possibili soluzioni, solo tre raccolgono maggior consenso: le prime due comportano in diverso modo la distruzione del cavallo, la terza prevede che esso sia lasciato intatto, accolto entro le mura della città e considerato come un dono da offrire agli dèi.
46 ch’era per essi fatale soccombere: “poiché era per essi destino morire”.
47 forieri: “portatori”.
48 agguato: qui significa “nascondiglio”.
49 Menelao piombò sulla casa di Deifobo per riprendersi Elena, in quanto la donna era andata in sposa a questo giovane fratello di Ettore e Paride, dopo la morte in guerra di quest’ultimo.
50 s’emacian: il verbo emaciare significa “deperirsi”, “smagrirsi”. Le guance emaciate sono dunque scavate, smagrite, a causa della sofferenza.
Niuno degli altri però s’accorse che Ulisse piangeva. Alcinoo solamente, che presso gli stava seduto, lo guardò, se n’accorse, l’udì che piangeva accorato, 530 ed ai Feaci, maestri di remi, così favellava: «Datemi ascolto, signori Feaci che il popol guidate.
Metta Demòdoco ormai da parte la cetera arguta, ch’ei non riesce a tutti gradito con questo suo canto. Da quando stiamo qui cenando, e il cantor s’è levato,
535 l’ospite mai non ha desistito dal pianto accorato.51
A lui di certo grave cordoglio s’addensa nel cuore.
Taccia Demòdoco, dunque, ché tutti vogliamo esser lieti, l’ospite e noi che ospizio gli diamo, ché questo è pel meglio.
Ché noi per reverenza52 di lui tutto abbiamo apprestato,
540 la scorta e i cari doni che a lui con affetto porgiamo.
Un peregrino, un ospite, al par d’un fratello è diletto all’uom che in seno accolga barlume, anche poco, di senno.53
Ma non volermi anche tu54 celare con scaltri artifizi quanto io chieder ti voglio. Per te meglio val favellare.
545 Dimmi il tuo nome, come solevano in patria chiamarti la madre, il padre, i tuoi cittadini, le genti vicine: ché non c’è uomo al mondo, sia nobile, sia della plebe, che senza nome affatto rimanga, una volta ch’ei nacque, ma, quanti nascono, a tutti lo pongono i lor genitori.
550 Dimmi la patria tua, la città, la tribù: ché le navi possano a quella meta rivolger la mente, e condurti. Però che timonieri non hanno le navi feacie, non han timone, come le navi degli altri: esse stesse, le navi, dei nocchieri comprendon la mente e il volere;
555 di tutte quante le genti conoscono i fertili campi e le città; traversan, di nebbia e caligine avvolte, velocemente, la vasta voragin del mare; e timore non c’è che possan danno patire, che vadan perdute.55
51 mai non ha desistito dal pianto accorato: “non ha mai cessato di piangere addolorato”.
52 reverenza: “rispetto”.
53 Un peregrino … di senno. Da ordinare così: all’uom che accolga in seno barlume di senno, anche poco, un peregrino, un ospite, è diletto al par d’un fratello.
54 Alcinoo si rivolge ora direttamente a Ulisse.
55 Però che timonieri non hanno … che vadan perdute. Le navi dei Feaci si muovono da sole per il
Salvo che questo udii narrar da mio padre Nausìto.
560 Disse che il Dio Posìdone un dì si sarebbe adirato contro di noi, che in salvo guidiamo per mare le genti. E disse che una volta, tornando, una nave feacia franta sarebbe stata fra i gorghi nebbiosi del mare ed un gran monte avrebbe la nostra città circondata.
565 Così diceva il vecchio Nausìto. Se quanto egli disse compiersi debba, o incompiuto restare, è volere del Nume.56
Ma questo dimmi or tu, rispondimi senza menzogna.
Come ti sei trovato pel mare errabondo? A che terra sei pervenuto, a quali uomini, a quali città ben costrutte,
570 e quali eran crudeli, selvaggi, nemici a giustizia, quali ospitali, invece, di mente devota ai Celesti?
E perché piangi, dimmi, perché ti lamenti accorato quando il destin degli Argivi tu ascolti, dei Danai, d’Ilio?
L’hanno voluto i Numi, filarono i Numi tal sorte, 575 perché soggetto avesse di canti la gente ventura.57
Qualche tuo valoroso parente t’è morto pugnando a Troia? Oppure un suocero, un genero? Questi i più cari sono fra tutti, dopo la stirpe congiunta di sangue. Oppure qualche tuo compagno hai perduto, che grazie
580 avea presso te grandi? Da meno non è d’un fratello l’uomo ch’è a te d’affetto legato, e che senno possiede».
mare, senza bisogno che alcuno imponga loro una rotta o si affanni ai remi. Con un’immagine azzardata si può dire che queste navi avessero al tempo stesso il navigatore satellitare e il pilota automatico!
56 Alcinoo racconta a Ulisse la profezia che suo padre Nausito ricevette: una nave feacia si sarebbe schiantata sugli scogli e l’isola di Scheria sarebbe stata schiacciata da una montagna per via dell’ira di Posidone. Ciò non si è ancora avverato, ma è questione di pochi giorni: sarà proprio il viaggio con cui i Feaci scorteranno Ulisse a Itaca la causa della collera del dio del mare, irato contro Ulisse per la morte del figlio Polifemo e quindi contro chiunque gli rechi aiuto.
57 ventura: “futura”, “prossima” (letteralmente “che verrà”).
Ulisse si presenta ai Feaci
[1-11] Quando Alcinoo propone di interrompere il canto di Demodoco, per dare così a Ulisse l’occasione di presentarsi, l’eroe vorrebbe opporsi: nulla è infatti più dolce che ascoltare un cantore, riuniti a banchetto, quando regna la pace. Ma in seguito così prosegue Ulisse nel suo discorso:
«Ma la tua brama t’ha indotto che tu dei miei lutti dogliosi mi dimandassi, per farmi più ancor sospirare e lagnare. Quale per primo, quale per ultimo debbo narrarti?
15 Tanti e poi tanti me n’hanno mandati i Signori del Cielo!
Per prima cosa il mio nome vo’1 dirvi, che voi lo sappiate, ed io possa così, sfuggito il mio giorno fatale, ospite vostro restare, sebbene lontano è il mio tetto.2
Son di Laerte il figlio, famoso fra gli uomini tutti
20 per la scaltrezza, Ulisse: giungeva mia fama a le stelle. Itaca è mia dimora, visibil da lungi, ché il monte Nèrito, tremulo tutto di selve, nel mezzo si leva. Molte altre isole attorno le son, l’una all’altra vicina: Same, Dulichio, e, tutta coperta di selve, Zacinto.
25 Queste, distanti da lei, son volte a Oriente; a Ponente Itaca ultima sorge. La spiaggia è poco alta sul mare, aspra di sassi, ma pure nutrice di prodi. E ti dico che della propria casa non v’è cosa al mondo più dolce.
Sì che voleva Calipso, la Diva, con sé trattenermi; 30 similemente Circe, l’eèa frodolenta,3 voleva
1 vo’: “voglio”. La parola ha subito un troncamento, cioè la caduta della sillaba finale.
2 Io possa così, sfuggito il mio giorno fatale, ospite vostro restare, sebbene lontano è il mio tetto: Ulisse vuole dire che se mai riuscirà a tornare in patria, tuttavia rimarrà legato da vincoli di ospitalità ai Feaci e potrà essere di nuovo per loro un ospite, anche se questo è improbabile, dal momento che Itaca e Scheria – così, almeno, crede Ulisse – sono molto distanti.
3 L’eèa frodolenta è apposizione di Circe, una maga che abitava l’isola di Eea. È definita frodolenta, cioè “ingannatrice”, perché imbrogliava gli uomini con un incantesimo e poi li trasformava in maiali. La sua storia verrà raccontata nel libro X
nel suo palagio tenermi, bramando ch’io fossi suo sposo.
Ma non poterono mai convincere questo mio cuore: ché niuna cosa v’è della patria e dei figli più cara, per quanto ricca sia la casa ove passi la vita, 35 quando in estranea terra, lontano tu sii dai tuoi figli.4
Ora però ti debbo narrare le molte sciagure onde5 m’afflisse Giove quand’io ritornavo da Troia».
[38-80] Inizia qui il racconto dei viaggi di Ulisse: il vento spinge la flotta verso nord, precisamente a Ismaro nella terra dei Ciconi, dove Ulisse espugna e depreda la città. Ma i suoi compagni non si accontentano del bottino e si rifiutano di riprendere il viaggio se non dopo aver bevuto abbondante vino ed essersi cibati a sazietà. Così fanno in tempo ad arrivare altri Ciconi che per avere una rivincita sfidano in una durissima battaglia gli Achei, riuscendo a sopraffarli poiché erano di gran lunga più numerosi. In questo modo Ulisse perde sei compagni per ognuna delle dodici navi. I superstiti, affranti, riprendono la navigazione, ma li sorprende un’improvvisa tempesta che li svia verso luoghi sconosciuti.
[81-103] Al decimo giorno di navigazione, la flotta approda alla terra dei Lotofagi, un popolo che si ciba del fiore del loto. Ulisse manda tre compagni a ispezionare la zona e a conoscere la popolazione che la abita: i Lotofagi sono così ospitali che subito donano il fiore agli stranieri appena giunti. Il loto è molto dolce, ma altrettanto pericoloso, poiché spinge chi lo mangia a non smettere mai e a non darsi più pensiero per il ritorno, pur di continuare a poter gustare di quella bontà. Ulisse è così costretto ad andare a riprendere i compagni, dimentichi della propria missione, e a riportarli a forza sulle navi per riprendere la navigazione.
4 In questo punto si capisce meglio il motivo per cui Ulisse abbia rifiutato il dono dell’immortalità che Calipso gli aveva offerto: certo si trattava di un premio allettante, ma che non aveva niente a che vedere con lo struggente desiderio di Ulisse di tornare in patria e rivedere i propri cari. Questo sentimento, infatti, era più forte di tutti i doni che Ulisse avrebbe potuto desiderare.
5 onde: “con le quali”.
«Quivi più innanzi spingemmo col cruccio nel cuore le navi;
105 e dei Ciclopi alla terra6 giungemmo, arroganti e malvagi, che per campare a quello s’affidan che mandano i Numi, chè con le proprie mani non arano o piantano seme, ché senza seme, tutto, senza opra d’aratro lì cresce: l’orzo, il frumento cresce, le viti che i grappoli pingui
110 recan dell’uva, e Giove le nutre con l’onda piovana. Essi non hanno assemblee di popolo, o giudici o leggi, ma degli eccelsi monti dimoran sui vertici sommi, entro capaci spechi, dov’ha ciascun d’essi l’impero della sua moglie, dei figli; né l’uno dell’altro si cura.7
115 Quivi dinanzi a un porto un’isola bassa si stende, né troppo presso, né troppo lontana dal suol dei Ciclopi, tutta coperta di selve. Qui crescono a torme8 infinite capre selvagge: ché mai non vien passo d’uomo a scacciarle, né cacciatore v’approda, di quelli che stentan la vita9
120 per le foreste, seguendo le fiere sui greppi montani, 10 né le possiede pastore, né gente che scalzi le zolle; ma non solcata mai dall’aratro, non mai seminata, d’uomini è vuota; e solo nutrìca le capre belanti. Poi che non hanno i Ciclopi battelli dai fianchi di minio,11
6 La terra dei Ciclopi non è di facile identificazione. Tuttavia, già le prime testimonianze degli storici greci (che vissero più di trecento anni dopo Omero) ipotizzavano che i Ciclopi avessero abitato la Sicilia, sebbene la cosa non risulti molto plausibile, dato che più facilmente la Sicilia viene riconosciuta dietro una tappa successiva del viaggio di Ulisse, quella dell’isola di Trinacria.
7 In questi versi Ulisse descrive l’organizzazione sociale dei Ciclopi, mettendo in evidenza come sia arretrata e come loro siano dei selvaggi: non solo non hanno leggi, giudici o assemblee di popolo, ma ognuno vive isolato in caverne. Ogni Ciclope comanda nella propria casa e non si cura degli altri, cioè non esiste un’organizzazione in città o villaggi. Non esiste neppure alcuna forma di agricoltura (vv. 107-110; vv. 122-123), né di navigazione e commercio (vv. 125-128): i Ciclopi, infatti, si cibano principalmente delle carni degli animali che pascolano selvaggiamente sull’isola (vv. 117-121).
8 torme: “schiere”.
9 stentan la vita: “sopportano una vita disagiata”.
10 greppi montani: “fianchi scoscesi della montagna”.
11 battelli dai fianchi di minio: le pareti delle navi erano dipinte di rosso da entrambi i lati della prua con minio. Il minio era una sostanza ricavata da un minerale con la quale si otteneva una tempera rossa. La miniatura medievale è così chiamata in quanto era un’illustrazione di un manoscritto che, almeno inizialmente, veniva realizzata appunto con questo colore.
125 navicellai non hanno, che sappiano navi costrurre salde di costa, su cui, movendo agli estremi paesi, ad ogni lor bisogno provvedan, com’è pure usanza delle altre genti, che l’una si reca dall’altra per mare. Abili artefici, grato potrebbero farne il soggiorno;
130 prati vi sono, presso del mare spumoso alla spiaggia, morbidi, irrigui:12 la vite potrebbe fiorirvi in rigoglio; facile arare la terra sarebbe; potrebber le biade mietere ad ogni stagione, ché opimo13 v’è sotto il terriccio.
V’è ben sicuro un porto, né d’uopo di gómena è quivi,
135 né con macigni fissare le navi, né a poppa legarle: basta soltanto lì dentro sospingerle, e attendere il giorno che di salpare i nocchieri decidano, e soffino i venti.
Proprio nel fondo al porto, sottessa una cava spelonca, limpida scorre una fonte, d’intorno vi crescono i pioppi.
140 Verso quel porto movemmo, ché un Dio ci guidò nel cammino, entro la buia notte, che pure un barlume non v’era, ma fonda14 nebbia oscura stringeva d’attorno le navi, né si vedeva la luna, del cielo fra i nuvoli ascosa. Quindi nessuno di noi quell’isola vide, nessuno
145 gli alti marosi che rotolavano verso la spiaggia, prima che contro la spiaggia cozzasser le rapide navi. Ammainammo tutte le vele allor su la nave e discendemmo anche noi sul lido, nei pressi del mare; quivi, dormendo, attendemmo che in cielo sorgesse l’Aurora.
150 Quando l’Aurora apparì mattiniera ch’à dita di rose, pieni di meraviglia movemmo per l’isola in giro».
Nella grotta di Polifemo
[152-214] Quando tutti si sono ristorati, Ulisse espone ai compagni il proprio piano: spinto da un forte desiderio di conoscere, si propone di andare a
12 I prati sono detti morbidi a causa dell’erba che vi cresce rigogliosa e folta; sono definiti anche irrigui, cioè “ricchi d’acqua”.
13 Opimo: “grasso”. Essendo il terreno grasso, cioè ricco di sostanze nutritive, è anche fertile. Quest’ultima è una considerazione di Ulisse: sebbene i Ciclopi non pratichino l’agricoltura, tuttavia la loro terra sarebbe adatta alla coltivazione, in quanto la vite e i cereali crescerebbero abbondanti e senza sforzi.
14 Fonda: “profonda”.
indagare insieme agli uomini della sua nave chi sia la popolazione che abita l’isola di fronte, mentre gli altri sarebbero rimasti a custodire le restanti navi. Una volta approdati nella terra da esplorare, Ulisse sceglie solo alcuni dei compagni perché lo seguano e decide di portare con sé un otre di vino particolarmente pregiato e potente, tanto che per berlo bisognava scioglierne una misura in venti misure d’acqua (non in una o due, come era abitudine): Ulisse infatti presagisce che avrebbe avuto a che fare con qualche mostruoso gigante. Giungono così in un’enorme grotta e, stupiti, osservano ogni cosa, attendendo il misterioso padrone di casa.
«In breve d’ora all’antro giungemmo; ma lui non trovammo, 215 ch’egli guidando stava le greggi pel pascolo pingue. Dentro lo speco noi guardavamo, stupiti, ogni cosa.
Ché sotto i caci i graticci piegavan;15 d’agnelli e capretti rigurgitavan le stalle: distinti eran gli uni dagli altri, a parte i grandi, a parte i mezzani, i lattonzoli16 a parte.
220 E riboccavano tutti di siero di latte i bei vasi e le scodelle e le secchie dov’egli mungeva le greggi.
La prima cosa che qui mi chiesero i cari compagni fu di pigliare un po’ dei caci, ed uscire dallo speco cacciare in fretta capretti ed agnelli dai chiusi17
225 alla veloce nave, di spingerci a fuga pei flutti.
Ma io prestare orecchio non volli, che molto era meglio: ch’io lo volevo vedere, riceverne doni ospitali; ma non dovea riuscire gradito ai compagni l’aspetto.
Quivi accendemmo il fuoco, ardemmo agli dèi le primizie,
230 poscia gustammo noi stessi del cacio. E, seduti, attendemmo ch’egli18 tornasse dal pascolo. E giunse, portando un gran mucchio d’aride legna, che lume facesse durante il suo pasto.
Lo scaricò nello speco, levando un alto rimbombo, sì che noi, sbigottiti, fuggimmo nel fondo dell’antro.
235 Quello le pingui greggi, ch’ei munger soleva, nell’ampio speco sospinse tutte; ma fuori lasciò dalla soglia i maschi, arieti e capri, rinchiusi nell’alto recinto.
15 sotto i caci i graticci piegavan: “i graticci si piegavano sotto il peso dei formaggi (caci)”.
16 i lattonzoli: “i cuccioli”; vengono chiamati così perché si nutrono di latte.
17 dai chiusi: “dalle stalle”.
18 Il pronome egli si riferisce al Ciclope, Polifemo, il mostro immane che abita la caverna.
Poscia, un macigno grande, gigante, levò, come porta della caverna lo pose: neppure lo avrebbero smosso
240 ventidue carri, saldi, con quattro ruote,19 dal suolo, tanto era immane la rupe piantata a la bocca dell’antro.
Postosi quindi a sedere, con garbo e con ordine munse pecore e capre, e pose d’ognuna alle mamme i lattonzi:20 fatta cagliare poi metà di quel candido latte,
245 lo collocò, rappreso così, nei corbelli21 di giunco: l’altra metà la pose nei vasi e nei secchi, per berlo, attingerlo di lì, la cena a sua posta innaffiarne.22
Poscia, quand’ebbe in fretta sbrigate le proprie faccende, allora accese il fuoco, ci scorse al chiarore, e ci chiese:
250 “O forestieri, chi siete? Di dove moveste a solcare l’umide vie? Navigate per qualche negozio?23 O piuttosto alla ventura, sì come sul mar vanno errando i pirati, che risican la vita, recando travagli ai foresti?”
Disse così. Noi sentimmo spezzarcisi il cuore nel petto, 255 per il terror della voce profonda, e dell’orrido aspetto.
Ma, tuttavia, parole trovai per rispondergli, e dissi: “Noi siamo Achei: da Troia, sbattuti da mille procelle, sopra l’immenso abisso moviamo del pelago; e mentre desideriamo alla patria tornare, per altri sentieri, 260 per altre strade erriamo: ché Giove ci nega il ritorno.
Siamo guerrieri del figlio d’Atrèo, d’Agamennone sire, onde24 l’immensa gloria levata s’è fino a le stelle:
19 ventidue carri, saldi, con quattro ruote: i carri con quattro ruote, particolarmente stabili, erano utilizzati per il trasporto di materiale pesante, a differenza di quelli a due ruote, più agili, che servivano per gli spostamenti in guerra.
20 pose d’ognuna alle mamme i lattonzi. Da ordinare così: pose i lattonzi alle mamme (“mammelle”) d’ognuna.
21 corbelli: “recipienti rotondi”.
22 la cena a sua posta innaffiarne. Da ordinare così: innaffiarne la cena a sua posta. A sua posta vuol dire “a suo piacimento”; oggi nel linguaggio comune si è conservato l’avverbio apposta, letteralmente a posta, cioè “di proposito”. Per accompagnare i propri pasti, il Ciclope non beveva acqua o vino, ma latte. Il verbo innaffiare rende bene l’idea di un consumo smodato ed esagerato.
23 Negozio di per sé non indica un esercizio commerciale, ma etimologicamente significa “affare”, nel senso generico di “qualche cosa da fare”; infatti è letteralmente il contrario della parola ozio, essendo formato dalla negazione ne- e dalla parola ozio.
24 onde: “del quale”.
tale una eccelsa città espugnò, tante genti distrusse. E siamo stati qui gittati dal mare; e, prostrati
265 supplici ai tuoi ginocchi, preghiamo che un dono ospitale tu voglia offrirci, o quale presente convenga a foresti.25
Abbi rispetto ai Numi, Signore, ché supplici siamo: e forestieri ed oranti li vendica Giove ospitale, Giove, che a fianco loro viaggia, che sacri li rende”.
270 Dissi. Ma l’altro, cuore spietato, così mi rispose: “Tu sei balordo, oppure tu vieni da molto lontano, ospite mio, che mi dici ch’io tema o mi guardi dai Numi. Non se ne curano mica di Giove l’egioco, i Ciclopi, né dei beati celesti, ché siamo più forti di loro.
275 Né vi risparmierei per timore dell’ira di Giove, né te, né i tuoi compagni, se il cuor mi dicesse il contrario.
Ma, dimmi un po’, dov’è giunta la bella tua nave all’approdo? Qui presso, od all’estremo del lido? Vorrei pur saperlo”. Disse così per sapere. Ma io, che non sono uno sciocco,26
280 bene l’intesi; e, mentendo, risposi il contrario del vero: “M’ha sfracellata la nave Posidone, il dio dei tremuoti: presso una punta, all’orlo del vostro paese la spinse, contro gli scogli la scaraventò, ché la furia del mare la sospingeva; io con questi sfuggir potei l’orrida morte”.
285 Dissi così. Quello, cuore spietato, neppure rispose; ma saltò su, le mani gittò sui compagni; e d’un colpo presine due, li sbattè, come cuccioli, contro la terra, ed il cervello si sparse per terra, umettò27 tutto il suolo; quindi, tagliatili a pezzi, la cena imbandiva; e mangiava
290 come leone che vive sui monti; né nulla lasciava: né i muscoli, né l’ossa, né i visceri, né le midolla. Noi tendevamo piangendo le mani al Signor dei Celesti, né sapevamo che fare, vedendo quell’orrido scempio.
25 o quale presente convenga a foresti: “o quale dono si addica a degli stranieri” (foresti sta per “forestieri”).
26 Ulisse capisce che il Ciclope non è affidabile, dal momento che rifiuta il rituale dell’ospitalità e non accetta di obbedire agli dèi, poiché i Ciclopi si considerano più forti di loro. Perciò, con la sua abituale ed estrema prudenza, comincia a diffidare di lui ed elude la domanda, non dicendo dove siano le loro navi, così come poco prima non ha detto il suo nome.
27 umettò: “inumidì”.
Ed il Ciclope, quand’ebbe rempiuta l’immane ventraia,28
295 pascendo carne umana, bevendoci su puro latte, dentro lo speco a dormire si mise, disteso fra il gregge. Questo partito29 allora m’arrise al magnanimo cuore: farmigli presso, stringendo nel pugno l’immane mia spada, e, ricercatolo al tasto, nel punto piantargliela dove
300 nel diaframma sta il fegato.30 E un altro pensiero mi tenne: ch’ivi saremmo anche noi periti di misera fine, ché dall’eccelso ingresso rimuover l’immane macigno noi non avremmo potuto, che posto egli aveva a sbarrarlo. Onde, così, fra i lamenti, l’Aurora divina attendemmo.
305 Come l’Aurora apparì mattiniera, ch’à dita di rose, accese il fuoco, i greggi bellissimi munse il Ciclope, tutti per ordine, e appese al sen d’ogni madre i lattonzi.
Poscia, quand’ebbe in fretta sbrigate coteste faccende, presi ad un colpo due dei compagni, ne fece il suo pasto;
310 e dopo il pasto, cacciò fuor dall’antro le pecore pingui, agevolmente levando l’immane macigno; e di nuovo poi ve lo pose, come mettesse il coperchio a un turcasso;31 e su pel monte spinse, con sufoli32 lunghi, le greggi».
«Io, nella grotta rimasto, fra me macchinavo in che modo
315 trarre vendetta, se Atena volesse pur darmene gloria.
Pensa e ripensa, questo mi parve il partito migliore. Presso alle stalle un tronco d’ulivo steso era, ancor verde, come reciso il Ciclope l’aveva per farne un randello, quando rasciutto33 fosse. Ci parve, allorché lo scorgemmo,
320 l’albero d’una nave cui venti sospingono remi,34
28 rempiuta l’immane ventraia: “riempito il ventre gigantesco”.
29 partito: “decisione”.
30 nel punto piantargliela dove nel diaframma sta il fegato. Il diaframma indica qui genericamente l’addome; il fegato è un organo vitale: Ulisse è infatti preso da un forte impeto di vendetta e vorrebbe uccidere il Ciclope, dal momento che ha appena divorato due suoi compagni.
31 turcasso: “faretra”, cioè il contenitore in cui si tengono le frecce.
32 sufoli (o zufoli): “fischi”.
33 rasciutto: “asciugato per bene”, “seccato”.
34 cui venti sospingono remi: venti è attributo di remi; cui è utilizzato in questo caso come complemento oggetto di sospingono. Si intenda allora così: “che venti remi spingono”.
d’una tartana35 grande, che solca gli abissi del mare: tale la sua lunghezza, tale era, a veder, la grossezza. Io ne tagliai per tre braccia, lo diedi ai compagni a raschiare. Essi lo resero liscio, puntuto io ne resi un dei capi;
325 quindi lo presi, indurire lo feci alla vampa del fuoco, e lo riposi poi, nascondendolo sotto lo strame36 ch’era per tutto l’antro cosparso con grande abbondanza; e dissi poi che a sorte tirassero gli altri compagni, chi dar meco di piglio dovesse a quel tronco, e nell’occhio,
330 quando giacesse immerso nel sonno, ficcarlo al Ciclope. Scelse la sorte quelli che scelti io medesimo avrei: erano quattro, ed io quinto m’accinsi con loro all’impresa. Giunse la sera, e il Ciclope tornò, pascolando le greggi. Subito dentro lo speco sospinse le pecore pingui,
335 tutte, ché non ne lasciò nessuna di fuori all’aperto, o qualche sua ragione n’avesse, o che un Dio lo guidasse.37
Quindi, posto l’immane macigno alla bocca dell’antro, sedè, pecore munse per ordine, e capre belanti, una per una; e alle mamme d’ognuna poneva il lattonzo.
340 Poscia, quand’ebbe in fretta sbrigate coteste faccende, presi ad un colpo due dei compagni, ne fece il suo pasto. Presso al Ciclope allora mi feci; e, porgendo una coppa d’ellera,38 grande, piena di vino purpureo, gli dissi: “Piglia, Ciclope, bevi del vino, giacché sei pasciuto
345 di carne umana; e ve’39 che liquore chiudeva nei fianchi la nostra nave. Ed io l’avrei pur libato a tua gloria, se pietoso tu rimandato m’avessi a la patria. No, tu sei troppo feroce. Chi altri, dei tanti mortali, qui vorrà più venire, se tanto feroce ti mostri?”
350 Dissi così. Quello prese, trincò, ci pigliò tanto gusto
35 tartana: “nave da carico”.
36 strame: strato di erbe secche e paglia che costituiva il “pavimento” della caverna.
37 La sera precedente, Polifemo aveva lasciato fuori dalla grotta i maschi del gregge, invece ora li fa entrare tutti quanti. Ulisse non sa spiegarsi la ragione di questo comportamento (se il Ciclope avesse qualche motivo oppure se fosse guidato da un dio). Il fatto è che Ulisse e i compagni dovranno la loro salvezza proprio a questi montoni e caproni.
38 ellera: “edera”.
39 ve’: “vedi”, “guarda”.
a tracannare la dolce bevanda, e ne chiese dell’altra:
“Non ti dispiaccia di darmene ancora. E poi dimmi il tuo nome, subito qui, ché un regalo poi t’offro, da farti contento.
Anche ai Ciclopi, s’intende, la fertile terra produce
355 vino, e la pioggia di Giove lo cresce nei grappoli pingui; sì, ma codesto è un vero ruscello di nettare e ambrosia!”
Disse. Ed un’altra volta quel vino di fiamma gli offersi. Tre volte io glie ne porsi, tre volte ne bevve lo stolto.
Ora, quand’ebbe il vino sviata la mente al Ciclope,
360 io me gli volsi40 allora, con queste melliflue parole: “Tu mi dimandi il mio nome, Ciclope; ne io vo’ tacerlo.
Però tu devi darmi quel dono ospitale promesso. Nessuno è il nome mio.41 Nessuno mia madre mi chiama, Nessuno il padre mio. Nessuno i compagni miei tutti”.
365 Dissi così. Quello, cuore spietato, così mi rispose “Nessuno, ultimo te mangerò fra tutti i compagni, prima tutti quegli altri: sarà questo il dono ospitale”.
Disse, si buttò giù supino, sdraiato per terra, con la gran testa rovescia, ché il sonno l’aveva pigliato
370 con la sua forza che tutto soggioga. E sgorgavano pezzi di carne umana e vino dal gozzo; e russava briaco.
Sotto la cenere allora cacciai, fondo fondo quel tronco, che divenisse rovente. Poi feci coraggio ai compagni, ché per timore qualcuno di lor non m’avesse a mancare,
375 e quando, infine, il trave d’ulivo, sebben fosse verde, stava per prendere fuoco, ché era già tutto rovente, io dalla bracia42 lo tolsi, mi feci vicino al Ciclope,43 coi miei compagni attorno; e un Dio forza grande c’infuse. Quelli, afferrato il tronco d’ulivo aguzzato alla punta, 380 lo conficcaron nell’occhio: su l’altro capo io premevo, lo roteavo. Come sul trave, in cantiere, a forarlo un tien fisso il trapano, e gli altri di sotto, le cinghie
40 io me gli volsi: “io rivolsi me stesso a lui”, “mi rivolsi a lui”.
41 Avendo capito che non avrebbe mai potuto competere con la forza fisica del Ciclope, Ulisse intuisce che per sopraffare il crudele Polifemo deve ricorrere all’astuzia.
42 bracia: “brace”.
43 Il nome stesso Ciclope significa letteralmente “dall’occhio rotondo”, ma già ai tempi di Omero aveva assunto il valore di “dall’unico occhio”.
tirano dalle due bande, e il trapano corre pur sempre, così, ficcato il trave nell’occhio al Ciclope, a mulino
385 lo giravamo; e il sangue scorrea per il palo infocato. Il sopracciglio ed il ciglio rimasero arsi nel vampo, la pupilla bruciò, sfrigolaron le radiche44 al fuoco.
Come allorquando un fabbro nell’acqua gelida immerge una bipenne o una scure, per darle la tempera,45 e quella
390 manda stridore grande, ché il ferro così si fa saldo, così l’occhio strideva dintorno a quel palo. Ed un urlo alto ei levò, tremendo: lo speco fu tutto un rimbombo. Noi, sbigottiti, schizzammo lontano. Dall’occhio la trave egli si estrasse, tutta di sangue inzuppata, e lontano
395 via la scagliò da sé, brancolando;46 e con grida selvagge gli altri Ciclopi chiamò, che aveano lì attorno dimora, entro caverne, sopra le cime ventose dei monti.
Corsero, chi di qua, chi di là, tutti, udendo quegli urli; e, stando attorno all’antro, gli chieser qual fosse il suo male:
400 “Che gran malanno mai t’occorre, che a mezza la notte tu c’interrompi il sonno, gridando così, Polifemo?
Forse qualche uomo ti ruba, per quanto t’opponga, le greggi? Forse qualcuno t’uccide per frode, t’uccide per forza?”
E rispondeva dall’antro così Polifemo gagliardo:
405 “Per frode e non per forza, Nessuno, o compagni, m’uccide!”
E gli risposero quelli così, con veloci parole: “E dunque, se nessuno ti fa violenza, codesto malanno vien da Giove: nessuno potrebbe schivarlo;47 e tu scongiura dunque Posidone, il dio che t’è padre”.
410 Detto così se n’andarono; e il cuor mi rideva nel petto, che con la fine astuzia del nome io l’avevo ingannato».
44 le radiche: “le radici (dell’occhio)”.
45 tempera: “tempra”. La tempratura è quel procedimento utilizzato per rendere più saldi e resistenti i metalli.
46 brancolando: “andando a tentoni”; il Ciclope era ormai accecato.
47 Ha qui successo l’inganno escogitato da Ulisse: gli altri Ciclopi non capiscono che Nessuno è il nome proprio dell’artefice del male, ma interpretano la frase di Polifemo (“Nessuno mi uccide!”) come “Nessuna persona mi uccide!”. Perciò immaginano che il male che colpisce il Ciclope sia la follia e lo abbandonano al suo destino, poiché le malattie mentali sono mandate da Giove.
La fuga dall’antro
«Ed il Ciclope, levando lamenti nel fiero tormento, via, brancolando, levò dall’ingresso l’immane macigno, e si sedè traverso la porta, protese le mani, 415 se ne ghermisse qualcuno che uscire tentasse fra il gregge: tanto, nel suo cervello, credeva ch’io semplice48 fossi. Io riflettevo, frattanto, qual fosse il migliore partito, come potrei qualche mezzo trovar di sfuggire la morte, io, con i miei compagni; né frode lasciavo o tranello
420 ch’io non rimuginassi, ché grande era il rischio, e vicino. Pensa e ripensa, questo mi parve il partito migliore. Nel gregge eran montoni di vello fittissimo, grossi, belli, coi negri manti che aveano riflessi viola.49 Io, tre per tre, senza far rumore, li avvinsi a più doppi,
425 coi vimini,50 ove51 il tristo Ciclope soleva dormire: quello di mezzo, un uomo portava sospeso al suo ventre; gli altri due, da riparo servian da una parte e dall’altra. Ogni tre pecore, dunque, portavano un uomo. Ed io, poi c’era un ariete, il capo miglior della greggia: io mi posi
430 sotto il suo ventre, al dorso gli cinsi le braccia, e rimasi pendulo;52 ed ambe attorte53 le mani al fittissimo vello, lì mi tenevo saldo, con cuor paziente, alla prova. Attendevamo dunque, fra questi travagli, l’Aurora. Come l’Aurora apparì mattiniera, ch’à dita di rose,
435 tutti si spinsero al pascolo i maschi del gregge. Non munte,54 lunghi levavan belati le femmine intorno ai presepi,55 gonfie com’eran le mamme di latte. Ed il loro signore, pur fra gli spasimi orribili, andava palpando sul dorso
48 L’aggettivo semplice è qui usato nell’accezione negativa di “sprovveduto”, “sciocco”.
49 riflessi viola: in questo caso l’aggettivo viola indica genericamente un colore scuro.
50 li avvinsi a più doppi, coi vimini: “li legai (avvinsi) con più giri (più doppi) di rami di salici (vimini)”.
51 ove: “su cui”.
52 pendulo: “sospeso”, “penzolante”.
53 attorte: “attorcigliate”.
54 Non munte: essendo stato accecato, il Ciclope non aveva potuto compiere il proprio dovere mattutino.
55 presepi: “stalle”, “recinti”.
tutti al passaggio i montoni, via via; né s’accorse, lo sciocco,
440 ch’erano i miei compagni legati alle pance villose. Ultimo venne di tutta la gregge l’ariete, ché impaccio gli era il suo vello: ch’io v’ero appeso, con palpito grande.56
E Polifemo possente, così, palpandolo, disse: “Pigro montone, com’è che ti lanci per ultimo fuori
445 della caverna? Sinora tu indietro restar non solevi, anzi tu primo, primo di tutti, il fior molle de l’erba a pascolare, a gran salti, correvi, tu primo giungevi alle correnti dei fiumi, tu a vespero primo bramavi fare alle stalle ritorno; ed ora sei l’ultimo. Piangi tu forse
450 l’occhio del tuo signore?57 Ridotto m’ha cieco un infame, coi suoi compagni tristi, che il senno mi tolse col vino: Nessuno. Ah!, ma di certo l’aspetta una fine funesta. Deh!, se il mio sentimento tu avessi e potessi parlare, dirmi ove s’è nascosto quell’uomo, a sfuggir la mia furia!
455 Gli vorrei dare un tal picchio, che il suo cervello per l’antro schizzasse a terra qua e là. Che gran sollievo sarebbe dei mali che Nessuno mi diede, quest’uomo da nulla!”
Disse, e lasciò passare l’ariete all’aperto. Ed appena fummo lontani un tratto così dal recinto e dall’antro,
460 prima mi distaccai dall’ariete e sciolsi i compagni; poscia le pingui greggi dalle agili gambe spingemmo velocemente, con molti rigiri, e giungemmo alla nave.
Ben s’allegrarono, quando ci videro, i cari compagni, che dalla morte eravamo scampati; e piangevan gli estinti.
465 Ma non permisi – e un cenno bastò della testa – che sfogo dessero al pianto; e ordinai che presto le greggi lanose sopra la nave gittassero e presto pigliassero il largo. Essi la nave subito ascesero e, in fila seduti, sopra i banchi, col tonfo dei remi battevano il mare».
56 con palpito grande. Ulisse è preso da un forte batticuore. Lo agitano timore e speranza assieme: un attimo ancora e per lui può compiersi la fuga progettata o la terribile fine.
57 Si osservi di quale grande ironia è capace Omero. Polifemo si rivolge al montone come a un amico, credendo che egli stia piangendo la sventura del padrone, e si rammarica del fatto che l’animale, non potendo parlare, non gli possa indicare dove si trovi l’uomo che l’ha ferito. E proprio mentre il Ciclope si rivolge con tali parole al montone, l’animale è strumento tanto involontario quanto decisivo della fuga di Ulisse.
La maledizione di Polifemo
470 «Ma quando fui lontano quanto giunge il grido d’un uomo, queste parole allora d’oltraggio rivolsi al Ciclope: “Quelli che tu, prepotente Ciclope, nel fondo dell’antro hai divorato, non eran compagni di qualche codardo. Doveano i tuoi misfatti caderti alla fine sul capo,58
475 che non avevi riguardo, ribaldo,59 a sbranare in tua casa gli ospiti; e Giove e gli Dei tutti quanti perciò t’han punito”. Dissi così. Tanto più s’accese il furor del Ciclope; e d’un gran monte divelse, su noi scaraventò la cresta.60 Essa piombò dinanzi la prora alla cerula nave,
480 e traballò, ribollì tutto il mare al piombar della rupe; ed il riflusso spinse di nuovo la nave alla terra, un cavallone del mare la fece approdare alla spiaggia.
Ma io, stringendo un lungo spunzone61 con ambe le mani, la spinsi ancora al largo. E l’ordine diedi ai compagni,
485 senza parlare, a cenni, che forza facesser coi remi, per isfuggire al pericolo; e curvi li vidi vogare.
Ma quando eravam lungi due volte lo spazio di prima, io mi rivolsi al Ciclope di nuovo. D’intorno i compagni mi tratteneano, chi qua, chi là, con soavi preghiere:
490 “O sciagurato, perché di nuovo eccitar quel selvaggio?
Quel suo macigno or ora scagliando, ha respinta la nave novellamente al lido, sicché ci credemmo perduti:
s’egli di nuovo ti sente che gridi, o soltanto che parli, scaglia di nuovo su noi qualche aspro macigno, e fracassa 495 le nostre teste e la nave, ché sai dove arriva col tiro!”
Disser: non fecer però convinto l’ardito mio cuore.
Ma nuovamente – tant’ira m’ardeva nel cuore – gridai:
“Se ti dovesse qualcuno degli uomini chieder, Ciclope, conto dell’occhio, com’è che cieco sei sì sconciamente,
58 Doveano i tuoi misfatti caderti alla fine sul capo: “alla fine hai dovuto pagare per le tue colpe”.
59 Ribaldo è apposizione al soggetto, cioè al Ciclope, e significa “scellerato”, “violento”.
60 e d’un gran monte divelse, su noi scaraventò la cresta. Da ordinare così: e divelse la cresta di un gran monte, su noi (la) scaraventò.
61 Lo spunzone era un bastone con la punta ferrata che veniva utilizzato per allontanare la barca dalla riva.
500 digli che Ulisse te l’ha cavato, il figliuol di Laerte, quegli che Troia espugnò, che in Itaca vive ed impera”. Dissi; e gemendo rispose con queste parole il Ciclope: “Misero me, che allora si compie un antico responso! C’era una volta un uomo fra noi, ch’era grande, era saggio,
505 Tèlemo, figlio d’Eurìmi, nell’arte profetica sommo, che tra i Ciclopi invecchiò dicendo le sorti. E costui m’aveva tutto ciò predetto che un giorno avverrebbe: ch’io per mano d’Ulisse privato sarei della vista. Io m’aspettavo sempre, però, di vedermi arrivare 510 qualche gran pezzo d’uomo membruto, aitante, forzuto!
Adesso, invece, un uomo da nulla, slombato,62 piccino, cavato m’ha quest’occhio, che pria m’ha fiaccato col vino.
Ma vieni adesso qui: vo’ doni ospitali offerirti, e da mio padre impetrare che a te dia felice ritorno: 515 ch’io del Signore del mare son figlio,63 e mio padre si dice. Egli, se vuole, potrà ridarmi la vista: niun altri né dei mortali terrestri potrà, né dei Numi del cielo”.
Così mi disse; ed io con queste parole risposi: “Deh!, l’anima così potessi strapparti e la vita,
520 e nella casa dell’Orco64 spedirti, com’io sono certo che risanarti quell’occhio neppure tuo padre saprebbe!”
Io così dissi. E quello, levate su al cielo le palme, queste parole di prece rivolse al Signore del mare: “Dio che la terra stringi, Posidone cerulo crine,65
525 odi, se son davvero tuo figlio, se tu sei mio padre: fa’ che l’espugnatore di Troia più a casa non torni; e s’egli è pur destino che vegga gli amici, che giunga alla sua casa bella, al suol della patria, vi giunga tardi, miseramente, su nave straniera; né vivo
530 più gli rimanga un compagno; né in casa trovi altro che doglie!”»
62 Slombato letteralmente significa “senza lombi”, cioè “senza fianchi”, quindi “sfiancato”, “smidollato”.
63 Polifemo è figlio di Posidone.
64 nella casa dell’Orco: “nel regno dei morti”.
65 cerulo crine: “dai capelli azzurri”.
[531-560] Il Ciclope non frena la sua ira e scaglia un altro macigno che per poco non colpisce l’imbarcazione di Ulisse. Tuttavia i marinai riescono a raggiungere l’isola sulla quale sostano in lacrime gli altri compagni, da due giorni in attesa del ritorno degli amici. Lì vengono compiuti sacrifici in onore di Giove, perché continui a proteggerli. Ma Ulisse nel suo racconto ai Feaci già anticipa che il suo desiderio non sarà esaudito: il dio aveva già stabilito la rovina di tutte le navi e di tutti i compagni. Il giorno seguente salpano nuovamente, lieti di essere sopravvissuti, ma crucciati per i compagni appena scomparsi.
Libro X Eolo e Circe
L’otre dei venti
[1-16] Lasciati i Ciclopi, Ulisse approda con la propria flotta in un’isola che pare fiabesca: è una terra vagante, che si muove continuamente nel mare. Regna sull’isola Eolo, il signore dei venti, che vive in una reggia con i dodici figli, sei maschi e sei femmine sposati fra di loro. Eolo ospita Ulisse per un mese, chiedendogli notizie sulla guerra di Troia e sul ritorno degli eroi.
«E quando poi gli chiesi congedo, che andar mi lasciasse, non vi s’oppose in nulla, ma cura si die’ del viaggio. Tolse le cuoia a un bue di nove anni; e, foggiatene un otre1, 20 quivi rinchiuse e legò le furie dei venti mugghianti; perché Giove l’aveva nomato2 custode dei venti, per eccitarli, per farli posare, com’egli volesse. E li legò nel curvo naviglio, con una cordella lucida, argentea, ché spiro, pur menomo,3 fuor non ne uscisse.
25 Quindi, per me lasciò spirare di Zefiro un soffio che sospingesse la nave con noi; né doveva il disegno compiersi: noi, con la nostra follia, lo facemmo fallire. Dunque, per nove dì, navigammo di notte e di giorno; nel decimo era già comparsa la terra natale, 30 e vedevamo i pastori, già prossimi, accendere i fuochi. Quivi un soave sonno m’invase, ché tanto ero stanco,4 poi che al timone sempre seduto ero stato, né ad altri mai l’affidai dei compagni, per giunger più presto alla patria. E cominciarono l’uno con l’altro i compagni a cianciare, 35 a dir ch’oro ed argento recavo nell’otre, e donato
1 L’otre è una borsa in pelle (cuoia, da cui “cuoio”), dove si potevano riporre cibi o bevande da trasportare durante un viaggio.
2 Nomato è una forma sincopata (in cui, cioè, sono cadute delle lettere) per “nominato”.
3 menomo: “minimo”.
4 Il sonno prende Ulisse solamente alla fine del viaggio, quando, alla vista di Itaca, ha cominciato a rilassarsi, sentendosi ormai al sicuro.
l’aveva Eolo a me, d’Ippòta il munifico figlio.
E si guardavano, e tali discorsi uno all’altro faceva: “Oh vedi quest’Ulisse, com’è caro a tutti e onorato, qualunque sia città, qualunque paese ove giunga!
40 Quante ricchezze porta con sé, dal bottino di Troia!
E invece noi, che abbiamo compiuto lo stesso viaggio, ce ne dobbiamo a casa tornar con un pugno di mosche.
E adesso Eolo, poi, per dargli una prova d’affetto, questa razza di regalo gli ha fatto! Su, svelti, vediamo
45 che cosa c’è, quant’argento, quant’oro contiene quell’otre”.5 Questo dicevano; e infine prevalse il malvagio consiglio.
Sciolsero l’otre; e tutti d’un tratto scoppiarono i venti; e la repente procella, ghermita la nave, nel mare li trascinò, piangenti, lontan dalla patria».
[50-79] L’improvvisa tempesta risospinge le navi sull’isola di Eolo e Ulisse si presenta nuovamente alla reggia come suo supplice, implorando il signore dei venti perché lo aiuti. Quest’ultimo reagisce con sdegno: non è giusto che si prenda ancora a cuore il ritorno di Ulisse, poiché egli è evidentemente in odio agli dèi se è stato di nuovo spinto sull’isola. Eolo perciò scaccia in malo modo gli stranieri, che sono costretti a riprendere la navigazione senza più il favore dei venti.
[80-134] Ulisse salpa dall’isola Eolia e giunge dopo sei giorni di navigazione nella terra dei Lestrigoni, creature gigantesche, violente e inospitali. La loro isola ha delle caratteristiche eccezionali: lì la notte è di durata brevissima, mentre il giorno si estende per diverse ore. Ulisse manda due uomini accompagnati da un araldo a esplorare i dintorni e a cercare notizie sulla popolazione di quei luoghi: costoro incontrano una fanciulla gigante che li indirizza verso la reggia, dimora dei propri genitori. Suo padre Antifate, anziché accogliere gli ospiti, improvvisamente ne afferra uno e lo divora; spaventati, gli altri due si danno alla fuga e riescono in breve a raggiungere le navi. Ma Antifate leva un grido di guerra e chiama numerosi altri Lestrigoni, i quali cominciano
5 I compagni di Ulisse non potevano sollevare l’otre, poiché era legato da una corda al corpo della nave; se avessero potuto farlo, avrebbero sicuramente dedotto dalla leggerezza del peso che esso non conteneva metalli preziosi!
ad afferrare dei massi dal peso disumano e a scagliarli con violenza contro le imbarcazioni di Ulisse e dei suoi. L’unica nave che riesce a superare l’attacco è quella di Ulisse; le altre vengono affondate con il loro equipaggio.
L’approdo all’isola di Circe
135 «Ecco, ed all’isola Eèa giungemmo, ove Circe abitava, Circe dai riccioli belli, la Diva possente canora, ch’era sorella d’Eèta, signore di mente feroce.6
Erano entrambi nati dal Sole che illumina il mondo: fu madre loro Perse, fu Oceano padre di Perse.
140 Qui, su la spiaggia del mare spingemmo in silenzio la nave, dentro un sicuro porto: ché un Dio sopraggiunse a guidarci; qui, dalla nave usciti, due giorni giacemmo e due notti, ché ci rodeva il cuore stanchezza commista a cordoglio».
La caccia al cervo
«Quando la terza giornata, però, l’alba ricciola schiuse,
145 io, la zagaglia7 presa con me, preso il ferro affilato, velocemente mossi dal legno, a scoprire d’intorno se mai tracce vedessi di campi, se udissi una voce.
E sopra un’alta asceso vedetta di rupi,8 ivi stetti; ed ampie strade scorsi di là, vidi un fumo levarsi
150 su dalla casa di Circe, tra dense boscaglie e tra selve. Subito ch’ebbi visto quel fumo con quelle faville, prima l’idea mi venne d’andare, di chieder novelle; ma, ripensandoci poi, mi parve che meglio sarebbe ch’io prima andassi al legno veloce, e a la riva del mare,
6 Eeta è il fratello di Circe; è il crudele re della Colchide, una regione barbara che si trovava sulle sponde del mar Nero. È noto il suo comportamento spietato nei confronti di Giasone: quest’ultimo aveva ricevuto l’incarico di portare a compimento una difficile missione, quella di recuperare il Vello d’oro, cioè la preziosa pelle dorata di un montone, che era in possesso di Eeta. Il re della Colchide però non voleva privarsene, allora decretò che Giasone avrebbe potuto impadronirsene solo se avesse compiuto con successo delle imprese impossibili: aggiogare due tori spiranti fuoco e dai piedi di bronzo, per arare con essi un campo in cui Eeta stesso aveva seminato denti di drago; infine uccidere i guerrieri nati da quella semina prodigiosa. Solo con l’aiuto della maga Medea, figlia del re della Colchide, Giasone supererà le prove.
7 zagaglia: “lancia”.
8 sopra un’alta asceso vedetta di rupi. Da ordinare così: asceso sopra un’alta vedetta di rupi, ovvero “salito su un’alta rupe per vedere”.
155 cibassi i miei compagni, mandassi a cercare notizie.
Or, quando giunto ero già vicino alla rapida nave, solo coi tristi pensieri, di me compassione ebbe un Nume, che su la stessa mia strada sospinse un cornigero9 cervo, grande, che al fiume scendeva, dai paschi silvestri, per bere,
160 come l’aveva sospinto la furia cocente del Sole.
Proprio mentre egli usciva, nel mezzo del dorso, alla spina io lo colpii: lo passò la zagaglia di bronzo fuor fuori.
Giù nella polvere cadde mugghiando, volò via lo spirto: puntai sul corpo il piede, fuor trassi la picca di bronzo10
165 dalla ferita, e a terra depostala, qui la lasciai».
[166-201] Ulisse con grande sforzo trasporta l’immane cervo ai compagni e li esorta a cibarsene, perché non si lascino vincere dalla fame e dallo scoraggiamento. Il mattino seguente Ulisse raccoglie i suoi uomini e ammette con rammarico di essersi perso: non sa più da che parte sia Itaca. È quindi necessario chiedere aiuto a qualcuno degli abitanti dell’isola. I compagni, all’udire queste parole, si riempiono di sconforto, ripensando alla triste fine degli amici divorati dal Ciclope e da Antifate, re dei Lestrigoni, ma Ulisse li rimprovera, perché non serve proprio a niente lamentarsi e darsi al pianto; serve piuttosto reagire.
L’incantesimo di Circe
«Quivi in due schiere tutti divisi i miei prodi compagni, pari di numero, e un capo preposi a ciascuna. Dell’una tenni il comando io stesso, dell’altra fu Eurìloco duce.
205 Quindi agitammo le sorti11 nel cavo d’un elmo di bronzo; e balzò fuori la sorte d’Euriloco, cuore gagliardo.
Egli si mosse; e insieme con lui ventidue dei compagni.
Essi piangevano; e noi sul lido lasciarono in pianto.
Entro una valle, il palagio trovarono bello di Circe,
9 cornigero: “che porta le corna”, quindi “che ha le corna”.
10 La picca di bronzo è la lancia con cui Ulisse aveva conficcato il cervo.
11 agitammo le sorti: le sorti erano piccole pietre sulle quali veniva posto un segno, che corrispondeva a una persona precisa. Le pietre erano poi messe in un elmo e agitate. La prima che fuoriusciva avrebbe indicato il prescelto per la missione. Da qui derivano i modi di dire in italiano estrarre a sorte o tirare a sorte, per indicare che qualcosa viene scelto mediante un sorteggio, un evento tanto casuale e imprevedibile quanto la fuoriuscita di una determinata pietruzza dall’elmo.
210 tutto di lucidi marmi, nel mezzo a un’aprica pianura. Tutto d’intorno, lupi movevano e alpestri leoni, ch’essa tenea domati, perché li molceva coi filtri; né s’avventarono punto sugli uomini; e invece, levati sui pie’, le lunghe code festosi agitavano tutti.
215 Come al padrone che torna da mensa costumano12 i cani scodinzolare, ché sempre con sé porta qualche leccume,13 così lupi ed unghiuti leoni d’intorno ai compagni scodinzolavano; e quelli temevan, veggendo le fiere. Stettero innanzi alla soglia di Circe dal fulgido crine.
220 E udîr la voce bella di Circe che dentro cantava, ed una tela grande tesseva, immortale, siccome l’opere son delle Dive, son fini eleganti fulgenti. Primo a parlare prese Polìte signore di genti, ch’era fra tutti i compagni l’esimio, il più caro al mio cuore:
225 “Compagni miei, lì dentro c’è una che tesse una tela, e dolcemente canta, che tutta n’echeggia la casa, non so se donna o diva: su, diamole presto una voce”.
Disse così: tutti quanti levaron le voci a chiamare. Subito Circe aperse le fulgide porte, uscì fuori,
230 e l’invitò. Tutti quanti le tennero incauti dietro;14 solo Eurìloco fuori restò, che temea qualche inganno. Circe, condottili dentro, su seggi e su troni li assise, cacio per essi intrise con miele dorato e farina, con vin di fiamma; e filtri maligni mescè ne l’intriso, 235 ché della terra nativa ricordo nei cuor non restasse. Or, poi che Circe ebbe offerto, quegli altri ingoiato l’intriso, li colpì con una verga, li rinchiuse dentro il porcile; e già di porci avevano setole, muso, grugnito, tutto l’aspetto: soltanto la mente era quella di prima.
240 Furon così rinchiusi, che urlavan, piangevano; e Circe ghiande per cibo ad essi gittò, corniole, lecciole,15
12 costumano: il verbo costumare significa “è costume”, “è uso”, “è abitudine”.
13 leccume: “leccornia”, “cibo squisito”.
14 Tutti quanti le tennero incauti dietro: “tutti quanti le andarono dietro incautamente, imprudentemente”.
15 Corniole e lecciole sono rispettivamente le bacche di due alberi, il corniolo e il leccio. Assieme alle ghiande, sono cibi di cui i maiali sono tipicamente ghiotti.
tutte vivande dei porci, che sempre le grufano16 a terra. Solo alla rapida nave Euriloco fece ritorno.
E la notizia recò, dei compagni la sorte e l’obbrobrio; 245 né, perché si sforzasse,17 gli uscian le parole di bocca, tanto era grande il cordoglio che il cuor gli feriva: eran gli occhi gonfi di pianto; né altro sapea che levare lamenti. Ma, come noi, stupefatti, l’incalzavam di domande, pure, alla fine, ci disse la sorte degli altri compagni».
[250-258] Euriloco riferisce brevemente che cosa è successo nella casa di Circe: sentendola cantare, i compagni furono attirati dalla dolcezza della voce, perciò la chiamarono ed ella non esitò a farli entrare. Solamente lui, Euriloco, che temeva un inganno, restò fuori: vide sparire tutti gli altri e attese invano il loro ritorno.
I consigli di Ermete
«Disse. Io la spada mia grande di bronzo, dai chiovi d’argento,18
260 presi, e le frecce, e l’arco, me li gittai su le spalle, e gli ordinai di guidarmi per quella medesima via.
Egli però mi strinse con ambe le mani i ginocchi, e, lagrimando, queste mi volse veloci parole:
“Contro mia voglia lì non condurmi! Qui lasciami, Ulisse!
265 Ché neppur tu, lo so bene, potrai ritornare, né alcuno ricondurrai dei compagni. No, presto fuggiamo con questi: forse potremo ancora schivar l’ora nostra fatale”.
Così disse. Ma io con queste parole risposi: “Se tu lo brami, dunque, Euriloco, resta sul lido,
270 presso la nave nera,19 che c’è da mangiare e da bere.
Io però devo andare. Dovere è per me, che mi spinge”.
Detto così, mi staccai dalla nave, dal lido del mare.
16 Grufare (o grufolare) si dice dei maiali quando si muovono con il muso a terra alla ricerca di cibo.
17 perché si sforzasse: “benché si sforzasse”, è una subordinata concessiva.
18 dai chiovi d’argento: chiovi sta per “chiodi”; l’espressione significa che l’impugnatura della spada era decorata con chiodi d’argento.
19 La nave è detta nera perché generalmente le imbarcazioni erano ricoperte di pece, quindi di colore scuro.
Ma, quando presso ero giunto, movendo pei sacri burroni,20 alla magione grande di Circe maestra di filtri,
275 mentre vi stavo entrando, si fece a me contro il signore dell’aurea verga, Ermète, che simile in tutto pareva a giovinetto che imbruna la guancia,21 negli anni più cari.
Egli mi prese per mano, volgendomi queste parole: “Misero, e dove vai, solo solo, per queste colline,
280 che non conosci il paese? Son lì, nella casa di Circe, i tuoi compagni, chiusi nel fondo di saldi porcili; son diventati ciacchi.22 Tu qui vieni forse a salvarli? Non tornerai neppur tu, resterai, te lo dico, con gli altri.
Io dai malanni, però, ti voglio sottrarre, e salvarti.
285 Entra pur nella casa di Circe; ma prima quest’erba prendi, che l’ora fatale terrà dal tuo capo lontana.
E tutti quanti ascolta di Circe i disegni ferali.23
Essa ti preparerà, mescendovi un filtro, un intriso; ma senza effetto sarà l’incanto, ché a sperderlo vale
290 l’erba ch’ora io ti darò, salutifera. Ora odi anche il resto.
Come toccato Circe t’avrà con la lunga sua verga, subito tu dal fianco snudata l’aguzza tua spada, scagliati sopra di lei, sì come volessi sgozzarla”. […]
300 Quando ebbe detto così, un’erba mi die’ l’Argicida, che la divelse dal suolo, mi disse qual n’era il potere.
Negra essa avea la radice, sembravano latte i suoi fiori:24 moli la chiamano i Numi; né facile cosa è sbarbarla per i mortali; ma tutto concesso è ai signori del cielo.25
305 Quindi, per mezzo a le selve dell’isola, Ermète a l’Olimpo fece ritorno; ed io mi volsi alla casa di Circe; e m’ondeggiava in vario tumulto, appressandomi, il cuore».
20 I burroni sono detti sacri poiché fanno parte dei domini di Circe, che è una dea.
21 che imbruna la guancia: “a cui inizia a crescere la barba”.
22 ciacchi: “maiali”.
23 i disegni ferali: “i progetti rovinosi, pericolosi”.
24 sembravano latte i suoi fiori: per il loro intenso colore bianco, i fiori ricordano il latte.
25 Viene messo in evidenza con questa espressione il fatto che l’erba moli appartiene esclusivamente al mondo divino, dal momento che solo gli dèi sono in grado di sradicarla (sbarbarla).
Ulisse affronta Circe
«Della ricciuta Dea ristetti alla soglia. E qui, fermo, un grido alto levai. Udì la mia voce la Diva, 310 subito fuori uscì, le lucide porte dischiuse, e mi chiamò: col cruccio nel cuor, tenni dietro ai suoi passi. Essa in un trono mi fece sedere, dai chiovi d’argento, istoriato,26 ricco; né ai piedi mancò lo sgabello.
Quindi in un vaso d’oro mi pose un intriso, da berlo;
315 e, macchinando il mio male, l’aveva d’un farmaco infuso.
Or, poi che l’ebbi bevuto, ma nulla era stato l’incanto,27 su me battè la verga, volgendomi queste parole:
“Va’ nel porcile, sdraiati adesso con gli altri compagni”.
Disse. Ma io, sguainata dal fianco l’aguzza mia spada, 320 sopra di lei m’avventai, sì come volessi sgozzarla.
Essa, con un grande urlo, s’abbassò, mi strinse i ginocchi,28 e, singhiozzando, queste parole veloci mi disse: “Chi sei tu mai? Di dove? I tuoi genitori chi sono?
La tua città? Stupore mi prende, che tu quell’intriso
325 hai tracannato, e schivato l’incanto. Nessun dei mortali che trangugiato l’avesse poté mai sottrarsi a quel filtro.
Certo lo scaltro Ulisse devi essere tu. Tante volte me lo predisse già l’Argicida dall’aurea verga, che, ritornando da Troia, su negro veloce naviglio,
330 qui tu saresti approdato. Ma via, la tua spada riponi”».
[331-363] Poiché Circe ha scoperto l’identità e il valore dell’ospite, depone il suo atteggiamento di ostilità e fa preparare dalle ancelle una splendida accoglienza per Ulisse. Queste non solo predispongono cuscini sui sedili, preparano cibi e bevande, ma riscaldano l’acqua per offrire all’eroe un bagno tiepido.
26 istoriato: “con delle figure intagliate”.
27 ma nulla era stato l’incanto: l’effetto dell’incantesimo non si fa sentire su Ulisse, diversamente da quanto era accaduto con i compagni; ciò avviene grazie all’influsso benefico dell’erba moli.
28 mi strinse i ginocchi: con questa postura si vuole identificare un atteggiamento di supplica; Circe ora è impaurita, non è più fiduciosa come prima nelle proprie arti magiche.
La liberazione dei compagni
«E di mangiare Circe mi disse; né voglia io ne avevo.
365 Ma stavo lì, con le idee volte altrove, a funesti presagi. Circe, poi che mi vide seduto così, che le mani non accostavo al cibo, ma tutto ero immerso in cordoglio, mi si fe’ presso, e queste parole veloci mi disse: “Perché stai dunque, Ulisse, così, che somigli ad un muto,
370 senza bevanda né cibo toccare, rodendoti il cuore?
Forse qualche altra mia frode paventi?29 Non devi temere quando ti ho già prestato il giuramento dei Numi!”
Questo mi disse; ed io risposi con queste parole: “Circe, qual uomo dunque, che privo non sia di ragione,
375 potrebbe avere cuore di cibo gustare o bevanda, prima d’aver veduti disciolti i suoi cari compagni?
Se tu brami davvero ch’io mangi, ch’io beva, disciogli, liberi fa’ ch’io possa vedere i compagni diletti”.
Dissi. E subito Circe traverso le camere mosse,
380 con la sua verga in pugno, aprì del porcile le porte, e fuor li trasse: porci sembravan che avesser nove anni.30
Essi dinanzi alla Diva ristettero; e quella fra loro mosse; ed uno per uno con un altro farmaco li unse.
Caddero tosto dai corpi le setole ch’eran cresciute
385 per le virtù del filtro maligno di prima; e d’un tratto d’uomo ripreser sembianza, più giovani ancora di come erano prima, molto più belli a vedere, e più grandi. E mi conobbero; ed uno per uno mi strinser la mano, e fra le lagrime, grida levaron di gioia; e la casa
390 alto echeggiava tutta. La Diva, a pietà mossa anch’ella, fattasi a me vicina, mi volse così la parola: “O di Laerte figlio divino, scaltrissimo Ulisse, ora alla rapida nave ritorna e alla spiaggia del mare. Prima di tutto, in secco traete la nave alla spiaggia,
29 paventi: “temi”.
30 che avesser nove anni: un maiale dell’età di nove anni è particolarmente vecchio. Con quest’affermazione Ulisse vuole dire che, anche se i compagni erano stati trasformati da poco tempo, sembrava che fossero maiali da sempre, dal momento che non era possibile notare nessuna differenza tra loro e dei veri porci.
395 e nelle grotte ponete gli attrezzi ed il carico tutto; poscia ritorna qui coi tuoi prediletti compagni”. Disse. E convinto rimase da quelle parole il mio cuore; e mi rivolsi alla nave mia ratta,31 e alla riva del mare.
Quivi i diletti compagni trovai su la rapida nave,
400 che con miseri lagni versavano lagrime amare.
Come d’intorno alle vacche, se tornano in mandra32 a la stalla, poi che satolle33 d’erba si furon pei campi, i giovenchi tutti saltellano attorno, né posson tenerli i recinti, ch’essi con fitti muggiti si lanciano incontro alle madri,
405 similemente, come comparvi ai loro occhi, i compagni verso di me, lagrimando, si volsero, e parve a ciascuno come se fossero in patria tornati di già, nelle mura stesse d’Itaca alpestre, dov’erano nati e cresciuti.
E, tra le lagrime, queste dicevano alate parole:
410 “Pel tuo ritorno, Ulisse divino, così ci allegriamo, come se ad Itaca giunti già fossimo, al suolo natale.
Su via, narraci come son morti gli altri compagni”.
Dissero; ed io con queste parole soavi risposi:
“Per prima cosa, la nave tiriamo sul lido all’asciutto, 415 e nelle grotte poniamo gli attrezzi ed il carico tutto.
E tutti quanti poi sbrigatevi insieme a seguirmi, ché nella sacra dimora di Circe vediate i compagni starsene a lauta mensa: ché cibo non manca o bevanda”».
Il timore di Euriloco
«Dissi così: né indugio frapposero quelli a obbedirmi.
420 Solo Eurìloco, tutti tenea indietro i compagni, e si volgeva ad essi, con queste veloci parole: “Poveri noi, dove andiamo?34 V’è presa la voglia dei guai, che nella casa di Circe volete cacciarvi? Ma quella ci muterà quanti siamo in lupi, in maiali, in leoni
31 ratta: “veloce”, “rapida”.
32 in mandra: “in mandria”, cioè “in gruppo”.
33 satolle: “piene”, “sazie”.
34 Euriloco è pieno di paura perché memore dei fatti accaduti poco prima, quando aveva atteso invano il ritorno dei compagni, trasformati in porci da Circe.
425 per poi tenerci a forza lì attorno, a far guardia alla casa. Come il Ciclope, quando ci chiuse nell’antro i compagni, ch’entro vi s’eran cacciati con questo imprudente d’Ulisse, e per la sua follia lasciaron la vita anche quelli”. Questi i suoi detti. E allora mi corse alla mente il pensiero
430 di sguainare dal fianco robusto l’aguzza mia spada, e di sbalzargli a terra, d’un colpo, la testa dal busto, sebben prossimo ei m’era parente.35 Ma gli altri compagni, chi di qua, chi di là, mi trattenner con dolci parole: “Divino Ulisse, questo, se tu non t’opponi, si lasci 435 qui, che rimanga presso la nave, che guardi la nave: noi ti seguiamo tutti di Circe alla sacra dimora”.
Dissero; e giù dalla nave discesi, lasciarono il mare; né già rimase Euriloco a guardia del concavo legno, ma ci seguì, ché troppo temè la mia fiera minaccia”.
Le istruzioni di Circe per la partenza
[440-457] Circe si prende cura anche dei compagni di Ulisse, offrendo loro la possibilità di lavarsi e vestirsi di tuniche nuove. Grande è la commozione di tutti i compagni, che non possono credere di essersi ritrovati insieme a Ulisse. La maga li esorta a rimanere per tutto il tempo che ritengono necessario, finché ritorni in loro il desiderio e soprattutto la forza di riprendere la navigazione.
«E qui, giorno per giorno restammo lo spazio d’un anno, a satollarci di carne, che tanta ce n’era, e di vino.
460 Ma quando un anno fu trascorso, stagione a stagione, furon compiuti i mesi, compiute le lunghe giornate, così, trattomi a parte, mi dissero i cari compagni:
“Diletto Ulisse, è tempo che d’Itaca tu ti ricordi, se pur vuole il destino che salvo tu rieda,36 che giunga
35 La reazione di Ulisse sembrerebbe esagerata e fuori luogo, tanto più che lui stesso ammette che Euriloco è suo parente. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che Ulisse è un guerriero, perciò abituato a reazioni violente; inoltre sono anni che è lontano da casa, dalla moglie e dal figlio: ora che vede la patria sempre più vicina, non può accettare che alle difficoltà esterne si aggiungano anche quelle dovute al timore dei propri compagni. La paura di Euriloco è vista perciò come un impedimento che rischia di allontanare ulteriormente nel tempo il ritorno dell’eroe.
36 rieda: “ritorni”.
465 alla diletta terra tua patria, e all’eccelsa tua casa”.
Dissero; e fu convinto da quelle parole il mio cuore.
Tutto quel giorno, dunque, sinché tramontato fu il sole, sedemmo a mensa, carni cibammo, trincammo vin dolce.
[…]
Quando s’immerse il sole nel mare, e la tenebra giunse, strinsi alla Dea le ginocchia, volgendole questa preghiera: “Circe, mantieni oramai la promessa che tu mi facesti di rimandarmi a casa, ché fiero desio me ne punge
475 ed i compagni miei; ché appena lontana tu sei, tutti mi vengono attorno piangendo, e mi spezzano il cuore”.
Dissi. E rispose queste parole la diva signora: “O di Laerte figlio divino, scaltrissimo Ulisse, non rimarrete, no, contro voglia fra queste mie mura;
480 ma devi prima un altro viaggio compire, e d’Averno e di Persèfone senza pietà visitare le case,37 per dimandare all’alma del cieco Tiresia38 un responso, all’indovino di Tebe, che sempre ha lo spirito pronto, ché gli concesse Persefone, a lui sol fra tutti i defunti,
485 tale saggezza serbare, ché l’altre son ombre errabonde”.39
Questo mi disse; io sentii spezzarmisi il cuore nel petto.
E mi scioglievo in pianto, gittato sul letto, né il cuore più mi bastava ch’io vivessi, vedessi la luce. Ma quando poi di pianto, di stare bocconi fui sazio,
490 io le risposi allora, le volsi così la parola:
37 Case d’Averno e di Persefone. Averno è propriamente il regno dei morti, anche se con questa espressione si indica anche Plutone (o Ade), il re dei morti; Persefone (o Proserpina) è la figlia di Cerere, dea delle messi. Persefone, secondo il mito, venne rapita da Plutone, che la rese sua sposa e così la portò con sé nel regno dei morti. Si dice che ella trascorresse col marito nell’Ade sei mesi all’anno (quelli autunnali e invernali) e i restanti sei (primavera ed estate) sulla Terra con la madre.
38 Tiresia è un indovino tebano, già cieco durante la vita terrena. Il motivo della sua cecità è spiegato da diversi miti: il più famoso narra che egli osò contemplare Minerva mentre questa usciva da un lago in cui era andata a lavarsi. Per questo suo atto di estrema impudenza, gli venne tolta la vista; tuttavia in cambio gli fu data la capacità di prevedere il futuro e quindi il dono di dare responsi veritieri.
39 ché l’altre son ombre errabonde: il riferimento è alle altre anime del regno dei morti, definite “errabonde”, cioè ombre senza coscienza, a differenza di Tiresia che ancora dopo la morte conserva la propria capacità di pensiero e di preveggenza; per questo gli sarà possibile illustrare a Ulisse che cosa lo aspetterà.
“Circe, e chi mai potrà guidarmi per questo viaggio? Sopra cerulea nave nessuno all’Averno mai giunse!”
Questo le dissi: così mi rispose la diva signora: “O di Laerte figlio divino, scaltrissimo Ulisse, 495 darti non devi pensiero di alcuno che guidi la nave: l’albero innalza, tendi sovr’esso le candide vele, siediti poscia; e quella volerà col soffio di Bora. Ma quando poi nel mezzo d’Oceano sarà la tua nave, quivi è la bassa spiaggia, qui son di Persefone i boschi,
500 negri pioppi giganti, piangenti sterili salici.40 Qui sui profondi gorghi d’Oceano ferma la nave, e tu stesso sprofonda nell’umida casa d’Averno. Nell’Acheronte qui Piriflegetonte si versa, Cocito qui, ch’è ramo divelto dall’acque di Stige:41
505 sotto una rupe insieme s’incontrano i fiumi mugghianti. A questa rupe appressati, Ulisse, e fa’ ciò ch’io ti dico.
Scava una fossa che un braccio42 misuri per lungo e per largo, e spargi a terra qui libagioni per tutti i defunti, una di latte e di miele, un’altra di vino soave,
510 ed una terza d’acqua; cospargivi bianca farina. Supplica quindi le fatue parvenze43 dei morti, e prometti che, ritornato in patria, tu ad essi una intatta giovenca immolerai, la più bella, di doni colmando la pira.44 Ed a Tiresia, a parte, prometti che un pecoro nero
515 immolerai, per lui solo, di tutta la gregge il più bello. Poi, quando avrai le preci rivolte alle genti dei morti, immola qui due pecore negre, una femmina e un maschio,
40 negri pioppi giganti, piangenti sterili salici: se per noi è il cipresso l’albero tradizionalmente associato ai cimiteri, tra i Greci la stessa funzione era attribuita ai pioppi e ai salici piangenti, qui definiti sterili, cioè “infruttuosi”, perché perdono i frutti prima della loro completa maturazione.
41 Nell’Acheronte qui Piriflegetonte si versa, Cocito qui, ch’è ramo divelto dall’acque di Stige: Acheronte, Piriflegetonte, Cocito e Stige sono i quattro fiumi che tradizionalmente attraversano l’inferno. I loro nomi sono parlanti e significano rispettivamente “Fiume degli affanni”, “Fiume infuocato”, “Fiume dei lamenti” e “Fiume della tristezza”.
42 Il braccio è un’antica unità di misura, che doveva essere compresa tra i 60 e i 75 centimetri.
43 le fatue parvenze: “le ombre evanescenti, che svaniscono”.
44 La pira è la catasta di legna sulla quale venivano bruciati i corpi dei morti o su cui si immolavano animali.
che con la fronte sian rivolti all’Èrebo.45 Indietro tu torna allora, di nuovo rivolgiti al fiume corrente.
520 E molte anime qui venire vedrai di defunti. Volgiti allora ai compagni, dà l’ordine ad essi che, prese le vittime giacenti, sgozzate dal lucido bronzo, l’ardano, dopo scoiate, e invochino i Numi d’Averno, Ade possente, e Persefone ignara di teneri sensi.46
525 Sfodera poi dal fianco gagliardo l’aguzza tua spada, piantati lì, non lasciare le fatue parvenze dei morti avvicinarsi al sangue, se prima Tiresia non parli. Inclito47 Ulisse, e infine verrà l’indovino di Tebe, che ti dirà la strada che batter dovrai, le distanze,
530 ed il ritorno, quale sarà per il mare pescoso”.
Circe parlava ancora, che sorse l’Aurora divina.
Essa di vesti mi cinse, d’un manto e una tunica bella, ed essa stessa indossò, la Diva, un gran manto d’argento, fine, tutto elegante, ai fianchi si strinse una zona
535 bella, tessuta d’oro, la fronte recinse di bende.
Ed io mossi per tutte le stanze a spronare i compagni, presso a ciascuno d’essi sostando, con dolci parole: “Più non dormite, adesso, lasciate il soave sopore.
Andiamo via, ché Circe la diva mi diede congedo”.
540 Questo io dicevo; e i cuor prodi godevano a queste parole. Ma senza lutto neppure di lì ricondussi i compagni.
C’era tra questi un Elpènore, ed era il più giovin di tutti, né molto prode alla guerra, né molto svegliato di mente. Questo, aggravato di vino, bramoso di fresco, era andato
545 sopra l’altana48 a dormire, lontano da tutti. Ed udendo muoversi gli altri compagni, le voci, il tumulto, riscosso tutto d’un tratto, scordò da qual parte scendea l’alta scala: mosse dal lato opposto, piombò giù dal tetto, ed il collo gli si troncò dalle vertebre, e scese lo spirito all’Ade».
45 L’Erebo è la parte più profonda dell’Averno, nella quale venivano punite le colpe più gravi.
46 ignara di teneri sensi: “senza pietà”, “che non risparmia nessuno”.
47 Inclito: “nobile”, “illustre”.
48 L’altana è una sorta di terrazzo.
[550-563] Ulisse riferisce ai compagni la necessità di andare nell’Ade a interrogare Tiresia, così come gli ha ordinato Circe. Quelli ancora una volta sono presi dallo sconforto e tra le lacrime si dirigono alla spiaggia, rassegnati alla partenza verso un luogo così ostile e pauroso.
Il regno spaventoso
[1-50] Ulisse e i suoi compagni si imbarcano e vengono spinti dal vento oltre i confini del fiume Oceano. Giungono dunque al paese dei Cimmeri, che vivono sempre all’ombra, giacché mai il sole brilla sulla loro terra. Sceso a riva, Ulisse segue minuziosamente le indicazioni di Circe: scavata una fossa, vi sparge dentro latte, miele, acqua e farina e subito offre sacrifici. Molte ombre di morti allora si avvicinano alla fossa, desiderose di bere sangue e poter dunque nutrirsi e parlare all’eroe. Ulisse, però, allontana con la spada chiunque provi ad avvicinarsi.
L’ombra di Elpenore
«Prima l’anima giunse d’Elpènore,1 il nostro compagno che seppellito ancora non era sottessa la terra, ma nella casa di Circe lasciato avevamo il suo corpo non seppellito, non pianto, perché ci premeva altra cura.
55 Piansi, vedendolo qui, pietà ne sentii nel mio cuore e a lui così mi volsi, dicendogli alate parole:
“Come sei giunto, Elpènore, in questa caligine2 fosca? Prima tu a piedi sei giunto, che io sopra il negro naviglio”.
Così gli dissi; ed egli, piangendo, così mi rispose:
60 “Ulisse, o di Laerte divino scaltrissimo figlio, tristo un demone m’ha rovinato, e la forza del vino.3
Addormentato m’ero in casa di Circe e sul punto di venir via, scordai da qual parte scendeva la scala: mossi dal lato opposto, piombai giù dal tetto; ed il collo
65 mi si stroncò nelle vertebre, e scese lo spirito all’Ade.
1 Si tratta del compagno di Ulisse caduto dal terrazzo di Circe, di cui l’eroe non conosce ancora la sorte. Dal momento che il cadavere di Elpenore non ha ancora ricevuto sepoltura, la sua anima si trova fuori dall’Ade: potrà esservi accolto solo quando il suo corpo giacerà sottoterra.
2 caligine: “nebbia”, “foschia”.
3 tristo un demone m’ha rovinato, e la forza del vino: “un dio ostile e l’ubriachezza mi hanno rovinato”.
Ora, per i tuoi cari, che sono lontani, io ti prego, per la tua sposa, pel padre che t’ha nutricato piccino, e per Telemaco, solo lasciato da te nella reggia, giacché so che, partendo di qui, dalle case d’Averno, 70 dirigerai di nuovo la prora per l’isola eea.4
Quivi ti prego che tu di me ti ricordi, o signore, sì che, partendo, senza sepolcro non m’abbia a lasciare, senza compianto: per me non ti segua lo sdegno dei Numi. Bensì con l’armi, quante n’ho indosso, mi brucia sul rogo
75 e un tumulo m’innalza sul lido spumoso del mare, ché giunga anche ai venturi notizia di questo infelice. Questo per me devi compiere. E il remo sul tumulo infiggi, ond’io fra i miei compagni remigar solevo da vivo”.5
Così mi disse; ed io con queste parole risposi:
80 «Tutto per te, sventurato, farò, compierò quanto chiedi».
Così noi due stavamo, con queste dogliose parole, io da una parte, distesa tenendo sul sangue la spada,6 e del compagno l’ombra, con molte parole, dall’altra».
«E della madre mia defunta qui l’anima apparve, 85 d’Antìclëa, la figlia d’Autòlico cuore gagliardo,7 che lasciai viva quando per Ilio la sacra salpai. E lagrime versai, vedendola, e in cuore m’afflissi; ma non permisi, per quanto gran cruccio mi fosse, che al sangue s’avvicinasse, prima d’aver consultato Tiresia. 90 Ed ecco, l’alma giunse del vate8 di Tebe, Tiresia, con l’aureo scettro in pugno, che me riconobbe, e mi disse: “O di Laerte figlio divino, scaltrissimo Ulisse, or come mai, sventurato, lasciata la luce del sole,
4 l’isola eea: è l’isola della maga Circe.
5 Secondo la sua richiesta, la tomba di Elpenore dovrà essere adornata con il remo che egli aveva usato in vita, affinché ciò possa simboleggiare e ricordare a tutti quale titolo di gloria egli abbia potuto vantare in vita, quello cioè di essere stato un abile marinaio.
6 Ulisse tiene la spada distesa sul sangue per impedire che le anime dei morti vi si avvicinino per bere.
7 Anticlea è la madre di Ulisse, figlia di Autolico, a sua volta figlio del dio Mercurio.
8 vate: “indovino”.
giunto sei qui, per vedere la trista contrada dei morti?
95 Scostati, via, dalla fossa, tien lungi l’aguzza tua spada, ch’io beva il sangue, e poi ti volga veridici detti”.
Così disse. Io, scostata la spada dai chiovi d’argento, nella guaina di nuovo la spinsi. E il veridico vate, bevuto il negro sangue, così mosse il labbro a parlare:
100 “Celebre Ulisse, il ritorno più dolce del miele tu cerchi. Ma te lo renderà difficile un Dio: ché oblïoso
l’Enosigèo non credo,9 che accolse rancore nell’alma contro di te, furente, perché gli accecasti suo figlio. Eppure, anche così tornerete, sebben fra le ambasce,10
105 se le tue brame e le brame frenare saprai dei compagni, allor che primamente dal mare color di viola all’isola Trinacria11 coi solidi legni tu approdi.
Qui troverete bovi che pascono, e pecore grasse, greggi del Sole, che tutto dall’alto contempla, e tutto ode.
110 Se tu le lasci illese, se pensi soltanto al ritorno, sia pur fra mille crucci, tornare potrete alla patria.
Ma se le offendi, invece, predico rovina al tuo legno, ai tuoi compagni. E se pur tu giunga a salvarti, ben tardi, tutti perduti i tuoi compagni, su nave straniera,
115 doglioso tornerai, troverai nella casa il malanno: uomini troverai che protervi12 ti vorano i beni, che la tua sposa per sé vagheggiano, e le offrono doni.
Ma tu farai, tornando, giustizia di lor tracotanza.
E quando avrai purgata così la tua casa dai Proci,
120 o con l’inganno, o a viso aperto, col bronzo affilato, allora dà di piglio a un agile remo, e viaggia, sinché tu giunga a genti che il pelago mai non han visto,
9 oblïoso l’Enosigèo non credo: “non credo che Posidone (l’Enosigèo) sia dimentico, abbia dimenticato”. Ulisse viene a conoscere, grazie a Tiresia, quanto ancora non sa della maledizione del Ciclope, accolta dal padre di questi, il dio del mare. Sarà infatti Posidone il più acceso oppositore del ritorno di Ulisse in patria, cercando di impedirglielo in tutti i modi.
10 ambasce: “pericoli, difficoltà”.
11 Trinacria: è l’isola di Sicilia, che ancora oggi viene chiamata in questo modo. Il termine deriva dal greco e significa “tre promontori”: si tratta dei promontori del Pachino, del Peloro e del Lilibeo, che sorgono ai tre vertici dell’isola, che ha appunto forma triangolare.
12 protervi: “arroganti”, “insolenti”.
né cibo mangian mai commisto con grani di sale, che navi mai vedute non hanno dai fianchi robusti,
125 né maneggevoli remi, che sono come ali ai navigli.13 E questo segno ti do, ben chiaro, che tu non lo scordi. Quando, imbattendosi in te un altro, che pure viaggi, un ventilabro14 ti dica che rechi su l’omero saldo, allora in terra tu conficca il tuo solido remo,
130 ed a Nettuno immola sceltissime vittime: un toro, un ariete e un verro, petulco15 signore di scrofe. Alla tua patria quindi ritorna; ed ai Numi immortali ch’ànno nell’ampio Olimpo dimora, offri sacre ecatombi, a tutti quanti, per ordine. E infine dal mare una morte
135 placida a te verrà, che soavemente t’uccida, fiaccato già da mite vecchiezza. E felici dattorno popoli a te saranno. Vero è tutto ciò ch’io ti dico”. Così mi disse. Ed io risposi con queste parole: “Tiresia, i Numi stessi tramaron così questi eventi.
140 Ma dimmi questo, adesso, rispondimi senza menzogna: io della madre mia già spenta qui l’anima veggo, ed essa presso al sangue sta senza parola, e sul figlio non leva pur lo sguardo, a lui non rivolge parola; dimmi, signore, come potrà riconoscer suo figlio”.
145 Così dissi; ed ei pronto rispose con queste parole: “Una risposta ti posso dar subito; e tu nella mente figgila. Della gente defunta chiunque tu lasci giungere a bere il sangue, può dirti veraci parole: a chi tu lo contenda, dovrà senza motto ritrarsi”».16
13 Tutte le caratteristiche attribuite a questo popolo presso cui dovrà arrivare Ulisse ci indicano chiaramente che deve trattarsi di un popolazione a cui non è affatto noto il mare. La profezia di Tiresia va oltre il contenuto del libro dell’Odissea, il quale si fermerà al ristabilimento del giusto ordine sull’isola di Itaca. Si è pensato allora che l’ultima parte della vita di Ulisse potesse essere narrata in un’altra opera, chiamata Telegonia, di cui ci informa qualche autore antico, ma che a noi non è mai giunta. La Telegonia avrebbe così concluso il ciclo troiano incominciato con Iliade e Odissea
14 Il ventilabro era una larga pala che i contadini utilizzavano per fare aria sul grano e separarlo in questo modo dalla pula.
15 petulco: “aggressivo”.
16 Rispondendo a una domanda di Ulisse, Tiresia ci spiega per quale motivo i morti desiderino tanto bere il sangue degli animali sacrificati: essi infatti, una volta giunti nell’Ade, perdono la
La madre defunta
150 «Ora, poi ch’ebbe così pronunciati i fatidici detti, tornò l’alma del prence17 Tiresia alla casa d’Averno, ed io fermo colà rimasi, finché sopraggiunse mia madre, e il negro sangue fumante bevette; ed allora mi riconobbe; e, piangendo, mi volse l’alata parola:
155 “Come sei giunto, o figlio, tra questa caligine buia, vivo tuttora? È ben arduo pei vivi veder questi luoghi, ché per lo mezzo vi sono gran fiumi ed immani18 canali: l’Ocèano, innanzi tutto, che facil non è traversarlo, chi debba muovere a piedi, chi solido legno non abbia.
160 Forse da Troia qui dopo lunghi giorni d’errore, con la tua nave, coi tuoi compagni sei giunto? Toccata Itaca ancor non hai, non hai visto la casa e la sposa?”
Così mi disse; ed io risposi con queste parole: “Necessità, madre mia, m’addusse alle case d’Averno,
165 ch’io consultar dovevo Tiresia, il profeta di Tebe; ché giunto ancor non sono vicino all’Acaia, né piede sulla mia terra ho messo; ma vado soffrendo ed errando da che prima seguii d’Agamennone sangue divino verso Ilio, di cavalli nutrice, a pugnar coi Troiani.
170 Ma dimmi adesso ciò, rispondimi senza menzogna: quale di morte doglioso destino t’ha dunque fiaccata?
Un lungo morbo, forse? O Artemide vaga di strali19 te con le miti saette percosse, e ti diede la morte?
E di mio padre dimmi, del figlio che in casa ho lasciato, 175 se ancora il mio potere ad essi rimane, o se altri l’occupa già, per certezza ch’io più ritornare non debba. E dimmi della sposa contesa, che pensa e disegna: se presso il figlio rimane, di tutto fedele custode,
memoria della vita vissuta, e possono riacquistarla per pochi attimi solo nutrendosi del sangue dei sacrifici.
17 Prence significa letteralmente “principe”. Qui però è utilizzato nel suo significato più generico di “nobile”.
18 Immane significa letteralmente “non misurabile”, e quindi “enorme”. È il sinonimo perfetto di immenso, il quale ha il medesimo significato letterale.
19 vaga di strali: “che ama le frecce”, “che ama scagliare frecce”.
o se l’ha già sposata chi più fra gli Achivi primeggia”.20
180 Così dissi. E a me pronta rispose la nobile madre: “Certo, rimane certo la sposa, con cuore tenace, nella tua casa; e vede distruggersi l’un dopo l’altro le notti e i giorni, in pena; né mai si rasciuga il suo pianto. Il tuo potere no, nessuno lo usurpa; ma in pace
185 vigila sui tuoi beni Telemaco, e parte alle mense pubbliche prende, come s’addice ad un re, ché ciascuno lo invita. Ma tuo padre la vita nei campi trascorre, e mai nella città non scende, né letto possiede, né manti, né coperte, né vaghi tappeti. L’inverno,
190 vicino al focolare, tra i servi riman dentro casa, sopra la cenere, e dorme coperto di misere vesti; quando l’estate poi sopra giunge, ed il florido autunno, qua e là sopra le balze, fra i tralci di qualche vigneto, si sdraia lungo in terra, su letti di foglie cadute;
195 e qui crucciato giace, gran doglia nutrendo nel cuore, te desiando; e su lui s’aggrava21 la triste vecchiaia. E sono morta anch’io così, la mia sorte ho compiuta. Né dentro casa la Diva che scaglia diritte le frecce22 m’ha con le miti saette percossa, e rapita dai vivi,
200 né pure sopra a me piombato è veruno dei morbi che via rapiscon l’alme dai corpi con tabe23 odïosa; bensì la brama di te, l’affanno per te, l’accorato amor di te, la mia vita distrussero, o nobile Ulisse”. Così parlava. E allora mi corse alla mente la brama
205 di stringere al mio cuore la madre defunta. Tre volte io mi lanciai, come dentro spingevami il cuore all’abbraccio,
20 Ulisse interroga la madre su tre argomenti (la sua morte, il padre, la moglie) e per tutti e tre i casi offre due possibili risposte tra cui scegliere. La madre risponde nell’ordine inverso e per quanto riguarda la sua morte, ultimo argomento trattato, non può convalidare nessuna delle ipotesi del figlio, ma ne dichiara la ragione, da lui non supposta. Invertendo l’ordine delle risposte e rompendo lo schema della scelta tra due possibilità già date, Omero riesce a focalizzare tutta l’attenzione di chi ascolta sul punto più drammatico dell’intero dialogo, la morte di Anticlea.
21 s’aggrava: “pesa”.
22 La Diva che scaglia diritte le frecce è Artemide, la quale è spesso citata come dispensatrice di morte. Ad Artemide e alle sue frecce venivano in particolare attribuite le morti improvvise che avvenivano tra le mura domestiche, cioè le morti per infarto.
23 tabe: “ferita”.
e tre dalle mie mani svolò, come un’ombra od un sogno.
Tanto più acuta allora doglianza m’intesi nel cuore; e a lei parlai, mi volsi col volo di queste parole:
210 “Madre mia, ché non resti, quand’io pur ti voglio abbracciare, sicché, pur nell’Averno, gittandoti al collo le braccia, l’amara gioia entrambi godere possiamo del pianto?
Oppure a me la bella Persefone un’ombra ha mandata, perché più ancora io debba lagnarmi, distruggermi il cuore?”24
215 Io così dissi; e così rispose la nobile madre: “Ahimè, figliuolo mio, sventurato più d’ogni mortale, te non inganna la bella Persefone figlia di Giove.
Ma questa è dei mortali, se scendon sotterra, la sorte.
Ché nervi più non hanno che reggano l’ossa e le carni;
220 ma queste e quelli strugge la furia del fuoco possente rutilo,25 appena l’alma lasciato ha lo scheletro bianco; e via l’alma svolazza per l’etere,26 simile a sogno.
Ma su, presto, alla luce di nuovo la brama rivolgi, e apprendi ciò, ché tutto ridirlo tu possa alla sposa”».
[225-326] Dopo che Anticlea è partita, molte altre donne si affollano intorno alla fossa, anch’esse desiderose di bere il sangue e di rivivere per un attimo. Ulisse consente che esse ordinatamente possano fare ciò e apprende da ciascuna il nome e qualche particolare della loro vita.
[327-382] Terminata la rassegna delle eroine, Ulisse desidererebbe andare a letto a riposarsi. Tuttavia prima Arete e poi Alcinoo lo pregano di continuare il suo racconto, chiedendogli, in particolare, se abbia incontrato nell’Ade qualche vecchio compagno delle guerra di Troia. Ulisse dunque soddisfa la curiosità della coppia regale.
24 Non riuscendo ad abbracciare la madre, Ulisse suppone che Persefone, dea signora dell’Ade, gli abbia mandato un fantasma per ingannarlo. In realtà egli non può abbracciarla perché, una volta morta, essa ha perduto ogni consistenza fisica.
25 rutilo: “rosso”.
26 l’etere: “l’aria”.
Agamennone
«Dunque, dopo che l’alme di tante eroine disperse ebbe chi qua chi là Persefone, Dea veneranda,
385 l’anima si mostrò d’Agamennone figlio d’Atrèo, tutta crucciosa; e intorno l’altre anime gli erano strette che nella casa d’Egisto trovarono il fato di morte. Subito mi conobbe, poi ch’ebbe bevuto del sangue: acutamente gemé, versando gran copia di pianto,
390 e stese a me le braccia, bramoso di stringermi al cuore; ma poi non era in lui la forza, non era il vigore che nelle membra sue pieghevoli27 un giorno era stato.
E colmo di pietà fu il mio cuore, vedendolo; e piansi, e mi rivolsi a lui col volo di queste parole:
395 “Sire di genti, Agamennone, illustre figliuolo d’Atrèo, quale t’ha mai prostrato destino di sorte funesta?
Sopra le navi forse t’uccise il Signore del mare, di furïosi venti levando un’immane procella, oppur sopra la terra t’uccisero genti nemiche,
400 mentre giovenchi rapivi, fiorenti di pecore greggi?
O per la tua città, per le donne tue combattevi?”
Così gli dissi; ed egli con queste parole rispose: “O di Laerte figlio divino, scaltrissimo Ulisse, non già sopra le navi m’uccise il Signore del mare,
405 di furïosi venti levando un’immane procella; bensì m’apparecchiò la sorte fatale, e m’uccise Egisto; e insiem con lui la mia moglie dannata. In sua casa a mensa ei m’invitò, mi sgozzò, come un bue su la greppia.28
Finii così di morte miserrima; e gli altri compagni, 410 tutti accoppati senza pietà, come porci selvaggi entro la casa d’un uomo di molto potere opulento,29 per epule,30 per nozze, per qualche solenne convito. Di molti uomini tu sei stato presente alla morte,
27 pieghevoli: “agili”.
28 come un bue su la greppia: “come si uccide un bue sulla mangiatoia, mentre sta mangiando”, cioè cogliendolo di sorpresa.
29 opulento: “ricco”.
30 epule: “banchetti”.
uomo contro uomo azzuffati, oppur nel furor della pugna;
415 ma gran pietà commosso t’avrebbe, se lì visto avessi come d’intorno ai crateri, d’intorno alle tavole colme, noi giacevamo, e il suolo tutto era un gorgoglio di sangue. E di Cassandra31 udii, della figlia di Priamo, il grido, ch’era uno strazio: vicino a me la sgozzò Clitemnestra, 420 la frodolenta; ed io percotea con le braccia la terra, morendo, con la spada confitta nel corpo. E la cagna s’allontanò; né, mentre scendevo alle case dell’Ade, degnò tender la mano, per chiudermi gli occhi e le labbra. Opera alcuna di donna non c’è così atroce e selvaggia
425 come il misfatto turpe che quella pensò: d’apprestare la morte al suo compagno legittimo. Ed io m’aspettavo che festa i figli miei m’avrebbero fatto, e i famigli come tornassi. Ma quella, maestra d’ogni arte funesta, sopra di sé, sopra quante saranno le donne future,
430 profuse vituperio,32 se pur bene adoperi alcuna”.
Così diceva. Ed io risposi con queste parole: “Ah! di quant’odio Giove che volge su tutto lo sguardo, con le muliebri frodi33 percosse la stirpe d’Atreo sin da principio! Fu Elena a molti cagione di morte;
435 a te, mentre lungi eri, tramò Clitemnestra l’inganno”. Così dicevo; ed egli con queste parole rispose: “Perciò troppo benigno non sii neppur tu con tua moglie, né confidarle tutto, qualunque discorso tu sappia; bensì dille una cosa, ma lasciane un’altra nascosta.
440 Sebbene, Ulisse, tu non avrai da tua moglie la morte.
Troppo ella è saggia, e troppo nutrita di buoni pensieri, d’Icario la figliuola, Penelope piena di senno”».
[443-463] Agamennone domanda con ansia a Ulisse notizie del figlio Oreste, ma l’eroe non è in grado di rispondere, perché da troppo tempo vaga per il mare e di nessuno ha udito notizia. I due guerrieri allora si separano.
31 Cassandra era una bellissima figlia di Priamo. Andò schiava ad Agamennone dopo la caduta di Troia e fu uccisa nel massacro generale da Clitemnestra, gelosa della sua bellezza.
32 profuse vituperio: “sparse vergogna”.
33 muliebri frodi: “inganni delle donne”. Muliebre è un aggettivo significante “femminile”, “donnesco”.
«L’alma mi ravvisò dell’Eàcide34 piede veloce;
465 e a me, piangendo, il volo diresse di queste parole: “O di Laerte figlio divino, scaltrissimo Ulisse, misero te, quale impresa più audace potevi tentare? Come sei sceso all’Averno dove hanno dimora i defunti privi di mente, vane parvenze di tristi mortali?”
470 Così mi disse; ed io con queste parole risposi:
“Achille, o di Peleo figliuolo, o il maggior tra gli Achivi, venni per consultare Tiresia, se a volte un consiglio mi desse, ond’io potessi tornarmene in Itaca alpestre; ché ancor presso all’Acaia non sono arrivato, né giunto
475 alla mia terra, ma sempre mi trovo fra i triboli.35 O Achille, niuno fra noi di te più felice, né in vita, né in morte. Perché quando eri vivo, qual Nume ti abbiamo onorato, quanti eravamo Argivi. Defunto, pur qui tra i defunti sei grande. E dunque, Achille, se morto pur sei, non crucciarti”.
480 Così dissi. Egli a me rispose con queste parole:
“Non mi volere, Ulisse divino, lodare la morte: vorrei, sopra la terra vivendo, esser servo d’un altro, d’un uom privo di beni, che anch’egli stentasse la vita, piuttosto che regnare su tutta la turba dei morti.
485 Ma dimmi una parola, su via, del mio figlio gagliardo, se tuttavia si lancia per primo dove arde la pugna, o se caduto è già. Di Peleo senza macchia, se sai, parlami, se dei forti Mirmidoni regge le schiere, o se l’onor sovrano gli negano in Ellade e in Ftia,
490 perché già la vecchiaia le mani ed i piedi gli fiacca. Deh!, se potessi alla luce del sole volargli in soccorso, tal nelle forze, quale per l’ampie contrade di Troia il fiore dei guerrieri prostravo,36 in aiuto agli Argivi! Se tale, anche un istante, tornassi alla casa paterna,
34 Eacide. Questo patronimico indica Achille, non riferendosi tuttavia al padre (Peleo), bensì al nonno paterno (Eaco).
35 fra i triboli: “in grande difficoltà”.
36 prostravo: il verbo prostrare significa letteralmente “stendere a terra”, “gettare al suolo”; ha infatti la stessa radice del sostantivo “strada”.
495 render saprei funesta la furia e le invitte mie mani a quei che gli fan forza, che privo lo voglion d’onori”».
[497-530] Questa volta Ulisse è in grado di rispondere alle domande dell’amico, poiché ha combattuto a Troia a fianco di Neottolemo, il figlio di Achille.
Riferisce allora all’eroe le grandi imprese del figlio, riempiendo di orgoglio l’animo del Pelide.
Aiace
«L’altre anime, via via giungendo, dei morti guerrieri, stavano piene di doglie, narrando ciascuna sue pene.
L’alma però d’Aiace figliuol di Telàmone, stava sola in disparte, tutta crucciata con me per la gara
535 ch’ebbi con lui, che vinsi vicino alle navi ricurve.
Premio eran l’armi d’Achille: deposte la madre divina le avea: Pallade Atena fu giudice, e seco i Troiani. Deh!, non avessi mai conseguita quella vittoria!
Ché, per sua causa, la terra nel grembo nascose un tant’uomo:37
540 Aiace, che d’aspetto, che d’opere egregie eccelleva sui Danai tutti, dopo l’egregio figliuol di Peleo.
E a lui mi volsi allora, con queste parole soavi: “O di Telamone figlio, Aiace, neppure dopo morto scordar ti vuoi del cruccio contro me per l’armi dannate
545 onde,38 voler dei Numi, gran doglie patiron gli Argivi, tale una loro torre crollava con te! Di tua morte non meno che d’Achille figliuol di Peleo ci crucciammo quanti eravamo Achivi, dal fondo del cuor; né cagione altra vi fu; ma Giove la schiera dei Danai guerrieri
550 ferocemente odiava: perciò decretò la tua morte. Ora t’appressa qui, porgi ascolto, signore, ai miei detti, odi le mie parole, pon freno alla furia, allo sdegno”. Dissi così, ma nessuna risposta mi diede; ed insieme con l’altre anime mosse, per l’Erebo, asilo dei morti».39
37 la terra nel grembo nascose un tant’uomo: “la terra nascose nel suo grembo un uomo così valoroso”, “un uomo così valoroso fu sepolto”.
38 onde: “a causa delle quali”.
39 asilo dei morti: quest’espressione indica semplicemente il luogo in cui risiedevano i morti.
Le pene dell’Inferno
555 «Quivi, benché adirato, risposta m’avrebbe pur data, gli avrei parlato ancora; ma il cuore nel fondo del seno veder desiderava pur l’anima d’altri defunti.
E qui Minosse40 scorsi, di Giove il chiarissimo figlio, che con lo scettro d’oro partiva giustizia fra i morti, 560 seduto; a quel signore d’intorno chiedeano i giudizi l’anime, quale in pie’, quale seduta, nel regno d’Averno.
E scorsi dopo lui, figura gigante, Orïone,41 che delle fiere gli spettri cacciava pel prato asfodelo, quelle che uccise un giorno avea pei monti deserti, 565 ed una clava di bronzo vibrava, che mai non si frange.
E Tizio42 vidi, il figlio di Gea, famosissima Diva, che sulla terra giaceva, che ben nove plettri43 occupava, e gli rodevano due vulturi44 il fegato, un quinci, uno quindi,45 scavandogli entro l’epa;46 né a schermo ei tendeva le mani, 570 perché Latona offese, la sposa di Giove, che l’ampie terre di Panopèo traversava, alla volta di Pito.47
E poi Tàntalo48 vidi, che spasimi orrendi soffriva, entro un padule49 immerso, che il mento giungeva a lambirgli.
40 Minosse era figlio di Giove ed Europa. Regnò su Creta e, dopo la sua morte, divenne uno dei giudici infernali. Stando davanti all’ingresso del regno dei morti, egli decideva la sorte di ciascun’anima defunta.
41 Orione era un fortissimo cacciatore che abitava la regione della Beozia. Era così bello che fece innamorare di sé la dea Aurora, ed era tanto abile nella caccia da suscitare la gelosia della più abile delle cacciatrici, la dea Artemide, che lo uccise. Dopo la sua morte fu trasformato in una costellazione.
42 Tizio era un gigante di enorme dimensione, il quale fu ucciso da Apollo e Artemide per aver offeso Latona, loro madre.
43 Il plettro è un’antica unità di misura indicante circa 30 m. Sdraiato per terra, dunque, il gigante Tizio copriva più di 250 m di terreno.
44 vulturi: “avvoltoi”.
45 un quinci, uno quindi: “uno da una parte, uno dall’altra”.
46 L’epa è il ventre, più precisamente il fegato.
47 Panopeo è un’antica città della Focide, regione della Grecia centrale, appena sopra il Peloponneso. Pito è l’antico nome di Delfi, città del celebre oracolo.
48 Tantalo era re della Lidia, amatissimo dagli dèi, i quali spesso si recavano a cena da lui. Un giorno egli volle mettere alla prova i suoi ospiti e, per provare se essi fossero davvero onniscienti, fece cucinare le carni del proprio figlio Pelope. A causa di questo delitto fu condannato a patire eternamente la fame e la sete.
49 padule: “palude”.
Languiva egli di sete, né un sorso poteva gustarne,
575 ché, quante volte il vecchio, per ansia di ber, si chinava, tante, assorbita, l’acqua spariva, e d’intorno ai suoi piedi negra la terra appariva, ché un Dio la rendeva risecca.
Ed alberi fronzuti gran copia di penduli50 pomi gli profondevano attorno, granati, dolcissimi fichi, 580 pere soavi, mele, con verde fiorita d’ulive.
Ma quante volte il vecchio tendeva le mani a ghermirli, tante lanciava il vento le rame51 alle nuvole ombrose.
E poi Sìsifo52 vidi, che spasimi orrendi pativa, che con entrambe le mani spingeva un immane macigno.
585 Esso, facendo forza con ambe le mani ed i piedi, su su, fino alla vetta, spingeva il macigno; ma quando già superava la cima, lo cacciava indietro una forza.
Di nuovo al piano così rotolava l’orrendo macigno.
Ed ei di nuovo in su lo spingeva, e puntava; e il sudore
590 scorrea pei membri; e via gli balzava dal capo la polve.
E scorsi dopo lui la possa d’Ercole53 invitto, l’ombra, perché l’eroe fra i Numi che vivono eterni
50 penduli: “penzolanti”.
51 le rame: “i rami”.
52 Sisifo era figlio di Eolo e fondatore della città di Corinto. Era un uomo molto astuto e malvagio, il quale riuscì a ingannare persino Giove. Una volta morto, allora, venne condannato per l’eternità a un lavoro lungo, faticoso e inutile, dato che continuamente richiedeva di essere iniziato daccapo: egli doveva infatti spingere con tutte le sue forze un enorme masso in cima a una montagna; una volta arrivato, tuttavia, il masso rotolava giù per l’altro versante del monte, e così Sisifo doveva riprendere dal principio il proprio lavoro.
53 la possa d’Ercole: “il forte Ercole”. Ercole nacque da Giove e Alcmena. Giunone, gelosa di Alcmena, riuscì con un’astuzia a condannare Ercole ad essere servo di Euristeo, che lo espose a gravi e inutili pericoli, ordinandogli le famose dodici fatiche. Queste furono: 1) uccidere il leone di Nemea, la cui pelle non poteva essere scalfita da alcuna arma; 2) uccidere l’Idra di Lerna, mostro dalle teste di serpente che si moltiplicavano ogniqualvolta fossero state mozzate; 3) catturare il cinghiale di Erimanto; 4) catturare la velocissima cerva di Cerinea; 5) disperdere gli uccelli del lago Stinfalo, carnivori e dotati di becco e zampe di bronzo; 6) ripulire in un giorno le stalle del re Augia, i cui animali crescevano a dismisura e della cui pulizia il re non si era mai curato; 7) catturare il toro di Creta; 8) catturare le cavalle di Diomede, divoratrici di carne umana; 9) impossessarsi della cintura di Ippolita, che era regina delle Amazzoni, gigantesche donne combattenti; 10) rubare i buoi di Gerione, gigante a tre teste; 11) rubare i pomi d’oro del giardino delle Esperidi, luogo difeso dal drago Ladone; 12) portare a Micene, vivo, Cerbero, il cane a tre teste che faceva guardia al regno degli Inferi.
gode i convivi,54 ed Ebe dal piede leggiadro55 è sua sposa.
E intorno era un clangore56 di spiriti, come d’augelli, 595 sbigottiti, chi qua, chi là; pari a livida notte, ei, stretto l’arco ignudo, sul nervo dell’arco una freccia, terribilmente guatava, come uomo già pronto a ferire.
A lui d’intorno al petto reggeva un gran balteo57 la spada, orrido, tutto d’oro, di storie mirabili impresso: 600 orsi, cinghiali feroci, leoni dagli occhi di fiamma, con zuffe, con battaglie, con morti di genti e stermini.
L’uom che con l’arte sua costruire quel balteo sapesse, altra opra a quella pari comporre mai più non potrebbe.
Mi riconobbe, appena gli caddi sott’occhio, l’eroe, 605 e, singhiozzando, il volo mi volse di queste parole: “O di Laerte figlio divino, scaltrissimo Ulisse, forse anche tu, sventurato, soffristi un malvagio destino, simile a quello ch’io trascinai sotto i raggi del sole?
Io del Cronìde Giove fui figlio: ma pure un travaglio 610 interminabile m’ebbi, ché a un uomo di molto più tristo di me dovei servire,58 che gravi fatiche m’impose.
Ed una volta, anche qui mi mandò, per prendere il cane59 ché non pensava ch’io superar potessi la prova.
E tuttavia io lo presi, potei fuor d’Averno condurlo, 615 ché mi fûr guida Ermete e Atena dagli occhi azzurrini”».
«Ed io fermo colà rimasi, attendendo se alcuno venisse degli eroi vissuti nei tempi remoti.
E avrei veduto allora qui, certo, gli eroi che bramavo; ma mille turbe e mille si accolsero prima di morti, 620 con infinito clamore. E bianco terror m’invase
54 gode i convivi: “partecipa ai banchetti”.
55 Ebe era la dea della giovinezza e dispensiera degli dèi.
56 clangore: “rumore”, “frastuono”.
57 balteo: “tracolla”.
58 Ercole fa riferimento a Euristeo.
59 Il riferimento è all’ultima fatica di Ercole, quella di Cerbero.
che della Gòrgone60 a me la testa, dell’orrido mostro fuor dalle case d’Averno mandasse Persèfone bella.
Onde, alla nave presto tornato, ai compagni ordinai che sovra il ponte anch’essi salisser, tagliasser le funi, 625 senza indugiare. V’entraron quelli, sederono ai remi.
E via l’onda recò dell’Oceano sui rivi la nave: prima la spinsero i remi; poi giunse la prospera brezza».
60 La Gorgone è la Medusa, la cui testa ricoperta di serpi aveva il potere di pietrificare chiunque la guardasse. Anche dopo la morte di Medusa, la sua testa conservò il proprio mortale potere.
Le Sirene, Scilla e Cariddi, i buoi del Sole
Circe istruisce Ulisse sul viaggio
[1-35] Non appena giungono sull’isola di Eea, Ulisse e i suoi compagni seppelliscono il corpo di Elpenore, come promesso all’anima dello stesso, innalzando un tumulo presso la spiaggia ed ergendovi sopra un remo. Informata del ritorno degli uomini, Circe corre loro incontro e li saluta calorosamente, offrendo un lauto banchetto. Al termine di esso, la maga prende la parola per informare i naviganti dei pericoli a loro prossimi.
«Circe divina, allora, così la parola mi volse:
“Tutte trascorse già son queste vicende:1 ora ascolta ciò ch’io ti dico; e un Dio farà che tu ben le ricordi.
Alle Sirene2 presso tu giungere devi anzitutto,
40 che tutti quanti gli uomini incantan che giungono ad esse.
Chi s’avvicina a loro, mal cauto, ed ascolta la voce delle Sirene, quello non mai la sua sposa ed i figli più lo vedranno tornare, diletto mai più non ne avranno;
ma le Sirene incanto gli fanno con limpide voci, 45 sedute sopra un prato. D’intorno c’è d’ossa un gran mucchio, d’uomini putrescenti, di scheletri e pelli aggrinzite.
Oltre tu passa; e fa rammollir della cera soave, e dei compagni riempi le orecchie, che alcuno non oda. Udirle puoi tu solo, se brami; ma prima i compagni
50 nella veloce nave ti avvincano3 i piedi e le mani, dritto, con funi, a ridosso ti leghin dell’albero, stretto,
1 Tutte trascorse già son queste vicende. Circe fa riferimento al viaggio nell’Ade da cui Ulisse è appena tornato e che egli le ha raccontato durante il pasto.
2 Secondo il mito, le Sirene erano in origine delle splendide ninfe, compagne della dea Proserpina. Quando Plutone rapì Proserpina per farne sua sposa nell’Ade, Cerere, madre di quest’ultima, adirata con loro che non furono capaci di difendere la figlia, le mutò in mostri marini, dal corpo di pesce e il volto di fanciulla.
3 avvincano: “leghino”. In latino “legare” si dice vincīre. In italiano questo verbo non esiste più, ma se ne conserva traccia in alcune parole: un vincolo è qualcosa che bisogna rispettare, che lega, obbliga (ob-liga, “lega”); un romanzo avvincente ti lega a sé, tenendoti sveglio notti intere a leggerlo.
sì che delle Sirene godere tu possa la voce.
Ma se tu preghi i compagni, se d’esser disciolto comandi, legare tanto più ti devon con doppie ritorte.
55 Or, quando poi saranno passati più innanzi i compagni, tu troverai due strade; né voglio descriverti adesso punto per punto, quale tu devi seguire. Tu stesso devi pensarci, Ulisse: d’entrambe però ti fo cenno. Rupi da questa parte, sul mare precipiti; ed alto
60 romba contro esse il flutto d’Anfitrite4 ciglio d’azzurro:
Scogli Cozzanti chiamare le sogliono i Numi beati. Né creature alate frequentano mai queste plaghe,5 né le fugaci palombe6 che recano a Giove l’ambrosia.
Pure, qualcuna sempre la liscia scogliera n’inghiotte;
65 e un’altra ne invia Giove, ché il numero sempre sia pieno.
Mai nave d’uomini alcuna fu salva, che quivi giungesse; anzi le travi dei legni, confuse degli uomini ai corpi, alti marosi trascinan, e d’orrido fuoco procelle.
Sola poté superarle la nave che giunse d’Eèta,7
70 Argo, famosa a tutti, che vinse del pelago i flutti.
E si sarebbe anche questa spezzata all’immane scogliera, senza la guida d’Era, cui molto era caro Giasone.
Due rupi indi ci sono, che il cielo infinito una attinge col vertice aspro, e tutta la cinge una nuvola azzurra,
75 che non si dissipa mai; né mai su quel culmine eccelso, sia pure estate, autunno pur sia, fulge l’aria serena.
Né vi potrebbe un uomo salire, né scendere mai, neppur se venti mani, se pur venti piedi egli avesse: poiché liscia è la pietra così come fosse raschiata.
80 Nel mezzo della rupe vaneggia una fosca spelonca,
4 Il flutto d’Anfitrite è un’espressione utilizzata per indicare il mare. Nel mito Anfitrite era la sposa di Posidone.
5 plaghe: “rocce”.
6 palombe: “colombe”.
7 la nave che giunse d’Eèta. È la nave chiamata Argo, quella con cui gli Argonauti, guidati da Giasone, partirono da Jolco, in Grecia, verso la Colchide, dove regnava Eeta, per impadronirsi del vello (cioè il manto lanoso) del montone d’oro. Compiuta l’impresa grazie all’aiuto di Medea, gli Argonauti fuggirono per mare. Nel viaggio di ritorno la nave Argo si trovò a passare presso gli Scogli Cozzanti, ma grazie all’aiuto di Giunone ne uscì incolume.
che s’inabissa nel buio, nell’Erebo. A questa da presso spinger dovete, Ulisse divino, la rapida nave.
Né se giù dalla nave lanciasse un arciere valente frecce dall’arco, potrebbe raggiungere il concavo speco.
85 Abita quivi Scilla,8 che terribilmente schiamazza.
È la sua voce come di cane spoppato di fresco; ma più terribil mostro di questo non c’è; né veruno s’allegrerebbe a incontrarlo, neppure se fosse un Iddio.
Dodici piedi ha questa, ma niuno le serve al cammino;
90 ed ha sei colli, lunghi, lunghissimi, e termina ognuno con una testa orrenda: son quivi tre file di denti, fitti, addensati, molteplici, pieni di livida morte.
Sta rimpiattata sempre nel mezzo del concavo speco, e solamente sporge la testa dal baratro orrendo.
95 Quivi alla pesca sta, spiando allo scoglio d’intorno cani di mare,9 o delfini, o quale altro mostro più grande possa ghermir, che a mille nutrisce Anfitrite sonora.
Né si potranno mai dar vanto i nocchieri che illesi siano sfuggiti ad essa; perché ciascheduno dei capi
100 stende e ghermisce un uomo dal grembo alle cerule navi. Ulisse, e l’altra rupe vedrai, ch’è di molto più bassa; l’una vicina all’altra, ché distano un tiro di freccia. Un caprifico10 grande vi sorge, un rigoglio di fronde; e sotto a questo, inghiotte del mar l’onde negre Cariddi.11
105 Tre volte al giorno fuori le gitta, tre poi le ringoia terribilmente. E fa’ di non esservi, quando l’inghiotte: ché non varrebbe a salvarti neppure il signore dell’onde; ma, più che puoi vicino movendo alla rupe di Scilla, spingi velocemente la nave, ché molto val meglio
8 Circe doveva conoscere molto bene Scilla, dato che, secondo il mito, lei stessa l’aveva tramutata in mostro. Scilla, un tempo giovane e bellissima ragazza, era stata trasformata in terribile mostro dalla maga di Eea, la quale era gelosa dell’amore che Glauco provava per la fanciulla. Scilla abitava un promontorio che si è soliti localizzare lungo lo stretto che separa Reggio Calabria da Messina; questo mostro abitava nella parte calabra.
9 cani di mare: “foche”.
10 caprifico: “fico selvatico”.
11 Secondo il mito, Cariddi era una donna, la quale venne tramutata in mostro da Giove per aver rubato i buoi di Ercole. Cariddi viveva in un promontorio opposto a quello di Scilla, in territorio siculo.
110 piangere sei compagni, che perderli tutti ad un colpo”.
Questo mi disse; ed io, doglioso, così le risposi: “Or via, su dunque, o Diva, tu questo ora dimmi sicuro, se pur dato mi fosse sfuggir la funesta Cariddi, potrei Scilla affrontare, quand’ella mi strugga i compagni?”
115 Io così dissi. Così rispose la Diva signora: “Dunque, vagheggi ancora fatiche ed imprese guerresche?
Povero te! Non sai che cedere ai Numi bisogna?
Scilla non è malanno mortale, è prodigio immortale, uno spavento, un orrore selvaggio, con cui non si lotta:
120 contro di lei non c’è riparo, bisogna fuggire.
Ché se tu l’arma impugni, se indugi vicino alla rupe, una seconda volta pavento12 che, fuori sbucando, con altrettanti capi t’afferri altrettanti compagni.
No no, spingete in fretta la nave, e invocate Crataia
125 che die’ la vita a Scilla, flagello a le misere genti: essa farà che desista, né ancora una volta t’assalti.
L’isola poi toccherai Trinacrïa, dove del Sole sono allevate le molte giovenche e le floride greggi: sette mandre di vacche, di pecore belle altrettante,
130 ch’ànno cinquanta capi ciascuna; né furon figliate, né mai verranno a morte. Due Dive ne sono custodi: Lampétia, e Faetùsa, due ninfe dai riccioli belli, cui generava al Sole sublime la diva Neera.
Poi che le diede a luce, che l’inclita madre le crebbe,
135 ne l’isola remota Trinacria fissò la lor sede, che custodisser le greggi del padre e le belle giovenche.
Ora, se illese tu le lasci, e ti preme il ritorno, pur dopo molte sciagure, farete ritorno alla patria; ma se tu poi le molesti, l’estrema rovina predico
140 alla tua nave, ai compagni. Tu poi, se pur fuggi la morte, tornerai tardi, a fatica, avrai tutti persi i compagni”».13
12 pavento: “temo”.
13 Circe rinnova la profezia che Tiresia fece a Ulisse nell’Oltretomba, raccontata nel libro precedente.
Le Sirene
[142-164] Circe ha appena smesso di parlare quando spunta l’aurora, e Ulisse, desideroso di rivedere quanto prima la sua casa, fa subito mettere in mare la nave. La maga manda una brezza leggera che possa spingere l’imbarcazione sull’acqua. Ulisse istruisce i compagni circa il pericolo delle Sirene e dà loro le istruzioni necessarie per oltrepassarlo illesi, quelle stesse indicazioni che Circe gli aveva fornito.
165 «Tutto ai compagni così spiegai, dissi punto per punto; e intanto il ben costrutto naviglio era all’isola giunto delle Sirene in brev’ora, ché il vento spirava propizio. Ma, giunti qui, la brezza cessò, fu bonaccia sul mare, senza più soffio di vento, sopir fece un demone i flutti.
170 Sursero i miei compagni, le vele calarono allora, ed al naviglio in fondo le posero; e ai remi seduti, coi levigati abeti14 facevano bianchi i marosi.15
Con l’affilata spada di bronzo un gran disco di cera allora io sminuzzai, la plasmai con la mano gagliarda.
175 Calda la cera tosto divenne, pel grande mio sforzo, e per i raggi del sire figliuol d’Iperione,16 del Sole: e ad uno ad uno, ai miei compagni le orecchie rempiei.
Essi le mani allora mi strinsero insieme ed i piedi; poscia, con funi, a ridosso mi strinser dell’albero; ed essi,
180 seduti ai banchi, il mare spumoso battevan coi remi.
Ma quando poi, vogando di lena, giungemmo vicino quanto è d’un uomo il grido, le Sirene videro il legno che s’accostava; e la voce canora spiegarono al canto: “Vieni qui dunque, Ulisse famoso, fulgor degli Achivi.
185 Ferma la nave, ché udire tu possa la nostra canzone, poi che nessuno passò qui oltre col cerulo legno, pria che dal nostro labbro udisse il mellifluo17 canto; lieto chi l’ode, e ricco di molta scïenza poi parte,
14 coi levigati abeti: “coi remi”. Questi venivano infatti costruiti con un particolare tipo di legno molto resinoso, quello d’abete, e quindi poco permeabile all’acqua.
15 facevano bianchi i marosi. Le onde del mare (i marosi) diventano bianche per via della spuma che si forma a causa del continuo battere dei remi sull’acqua.
16 Iperione era un titano, figlio di Urano e Gea, padre del Sole, della Luna e dell’Aurora.
17 mellifluo: “dolce come il miele”.
poi che sappiamo tutto, sappiam ciò che Achivi e Troiani
190 fecer nell’ampia Troia, pel sommo volere dei Numi: tutto che avvien su la terra di popoli altrice18 sappiamo”. Questo, levando la voce soave, dicevano; e il cuore mi si struggeva di brama, coi cigli imponevo ai compagni che mi sciogliesser dai lacci; ma quelli sforzavano i remi.
195 Anzi, saltarono su Perimède ed Eurìloco, e tanto più con legami doppi m’avvinsero all’albero stretto.
Solo quando oltre già passati eravamo, e la voce delle Sirene più non si udiva, né il canto, la cera ond’io rempiute avevo ad essi le orecchie, i compagni
200 via si tolsero, e me disciolsero pur dai legami».
Scilla e Cariddi
[201-221] Superata l’isola delle Sirene, la nave di Ulisse giunge in prossimità dei due temibilissimi promontori che prendono il nome dai mostri che lì hanno dimora: Scilla e Cariddi. I compagni non sono informati del pericolo, e Ulisse giudica opportuno tenerli all’oscuro di tutto. Ciò nonostante, un’improvvisa vampata di fumo spaventa i marinai, tanto che Ulisse deve tranquillizzarli, ricordando loro i pericoli già trascorsi e superati con successo.
«Tanto io diceva; e i miei consigli seguirono quelli.
Ma non parlai di Scilla, dell’inevitabil flagello, ché per timore i compagni cader non lasciassero i remi,
225 per rannicchiarsi nel fondo del legno.19 Ed allora, il consiglio scordai, troppo increscioso,20 di Circe, che imposto m’aveva ch’io non prendessi l’armi; bensì l’armi belle mi cinsi, strinsi nel pugno due lunghe zagaglie,21 e mi posi sul ponte, a prora; ché di qui m’aspettavo che pria dalle rupi
230 Scilla apparisse, che scempio dovevami far dei compagni.
Ma non potei vederla, ma invano stancai le pupille
18 altrice: “nutrice”, “che nutre”. Dalla stessa radice si forma pure il termine “alimenti”.
19 Circe aveva detto a Ulisse che sei dei suoi compagni sarebbero stati divorati da Scilla e che questo era inevitabile, il minore dei mali che potessero accadere. Se Ulisse, però, avesse comunicato ciò ai compagni, giunti nei pressi del mostro, nessuno avrebbe più remato, e tutti avrebbero preferito nascondersi per non essere catturati.
20 increscioso: “rischioso”.
21 La zagaglia è una lancia corta.
nella nebbiosa rupe figgendo per tutto lo sguardo. Navigavamo dunque così quello stretto, gemendo, ché da una parte era Scilla, dall’altra la diva Cariddi
235 con gran frastuono l’acque salmastre del mare inghiottiva. Quando vomìale,22 come caldaia sovresso un gran fuoco, tutta con gran turbinio gorgogliava; e su alta la schiuma sino all’eccelsa vetta d’entrambe le rupi scagliava; ma quando l’acque poi salmastre di nuovo inghiottiva,
240 tutta al di dentro appariva sconvolta, e la roccia d’intorno levava orrendo mugghio, la terra appariva nel fondo bruna di sabbia. Terrore sbiancò tutti in viso i compagni. Noi guardavamo Cariddi, temendo l’estrema rovina, quando, d’un tratto, Scilla dal concavo legno mi tolse
245 sei dei compagni, quelli che aveano più forza e più cuore; i lor piedi e le mani già in alto vidi io: ché per l’aria li sollevava il mostro. Levaron la voce a chiamarmi: ché mi chiamarono a nome, sgomenti,23 per l’ultima volta. Come allorché da una rupe, con una lunghissima canna,
250 il pescatore l’esca prepara pei pesci minuti, e getta in mare il corno d’un bove selvatico,24 e quando uno n’ha preso, fuori dal mare lo gitta, che guizza, così per l’erta rupe su tratti, guizzavano quelli. E li vorò sulla bocca dell’antro, che alzavano grida,
255 che a me, nella iattura25 mortale, tendevan le mani. Questo, fra quanti travagli patii, ricercando le strade del mare, fu lo scempio più orrendo che vider questi occhi».
«Ora, sfuggito che avemmo lo scoglio di Scilla, e Cariddi, ecco ben presto giungemmo all’isola sacra del Sole.
260 Erano quivi belle giovenche dall’ampia cervice,26
22 vomìale: “le vomitava”.
23 sgomenti: “spaventati”.
24 il corno d’un bove selvatico: la lenza era ricoperta nell’ultima sua parte da un piccolo rivestimento di corno, perché i pesci, abboccando, non recidessero il filo cui era attaccato l’amo.
25 iattura: “sventura”.
26 cervice: “collo”.
e molte pingui27 greggi del Sole che in cielo trascorre. Ecco, ed ancora nel mare, sin dentro la cerula nave, delle giovenche pascenti nei campi mi giunse il muggito, ed il belar delle pecore; e allor mi tornarono a mente
265 dell’indovino di Tebe, del cieco Tiresia, i responsi, e della maga Circe, che tanto m’avevano ingiunto ch’io l’isola schivassi del Sole che allegra i mortali. Ed ai compagni allora, col cruccio nel cuore, parlai: “Datemi retta, compagni, sebbene già tanto soffrite,
270 ch’io di Tiresia vi dica, del cieco indovino, i responsi, e della maga eea, di Circe, che tanto m’ingiunse ch’io l’isola schivassi del Sole che allegra i mortali. Dunque, oltre l’isola, via, spingete la cerula nave”. Dissi. Ma quelli in petto sentirono frangersi il cuore;
275 ed Euriloco queste parole astïose mi volse:
“Sei pur crudele, Ulisse! Perché tu sei tanto gagliardo, che non ti stanchi mai, che sei tutto impastato di ferro, neppure ai tuoi compagni, spossati, che cadon dal sonno, tu non permetti che a terra, nell’isola scendano, dove
280 lauta potremmo imbandire la mensa; e c’ingiungi che, ancora stanchi, voghiamo così, per la notte che scende veloce, lungi dall’isola, fra la caligine fosca del mare; e nella notte i venti si levano a strugger le navi, impetuosi. E chi sfuggirebbe alla fine funesta,
285 se sovra noi, d’un tratto, giungesse una furia di venti, di Noto, ovvero l’aspra di Zefiro furia, che pure contro il voler dei Numi possenti distrugga le navi?
No, si rispetti adesso la notte e la tenebra, a terra la mensa si prepari vicino alla rapida nave;
290 dimani, all’alba prima, di nuovo saremo sul mare”. Questo Euriloco disse; approvarono gli altri compagni. E ben conobbi allora che un demone il danno tramava; e, volto ad essi, queste parole veloci a lor dissi: “Tutti mi fate forza, Euriloco, ed io son solo;
295 ma tutti quanti adesso prestatemi un gran giuramento:
27 pingui: “grasse”.
che, se mai qualche mandra di vacche troviamo, o una greggia grande di pecore, niuno sia tanto malvagio né empio che né vacca né pecora uccida. Ma state contenti solo a quel cibo che a me die’ Circe, la Diva immortale”.
300 Dissi. E così come io volli giurarono subito quelli».
[301-323] Scesi a terra, i marinai preparano un ricco banchetto, risparmiando buoi e pecore, secondo quanto giurato a Ulisse. Si fermano poi sulla spiaggia a dormire e il sonno ritempra le loro membra. Una triste sorpresa, però, attende Ulisse al risveglio: Noto, vento impetuoso, si è alzato sul mare, rendendo impossibile la ripartenza della barca. Per un mese intero continuerà a soffiare, costringendo i naviganti a una lunga sosta sull’isola Trinacria.
«Ora, sinché durò vivanda e purpureo vino, 325 per il timor della vita, nessuno toccò le giovenche; e quando poi dal legno consunte28 fûr tutte le dapi,29 necessità li spinse che andassero attorno, cacciando pesci, od uccelli, o qual preda cadesse lor sotto le mani.
Ora, nell’isola un dì m’addentrai, ché volevo una prece
330 volgere ai Numi, se alcuno m’addita la via del ritorno. E, come giunto fui lontano dai cari compagni, in una parte al riparo dei venti, deterse le mani, pregai tutti i Celesti, quanti hanno dimora in Olimpo. Quelli soave sonno profusero a me su le ciglia;
335 ed un consiglio intanto Euriloco diede ai compagni: “Datemi retta, per quanto prostrati dai mali, o compagni.
Certo, odïosa per l’uomo tapino è ogni specie di morte; ma la più misera fine, di certo, è morire di fame.
Dunque, su via, le giovenche del Sole pigliam, le più grasse
340 ed immoliamole ai Numi che hanno dimora in Olimpo.
Ché se in Itaca poi torneremo, alla terra natale, subito allora al Sole, che il cielo traversa, un gran tempio innalzeremo, e in esso porrem tante statue belle.
Ché se, sdegnato poi per le vacche dai corni superbi,
28 consunte: “consumate”.
29 Il termine dapi indica le “provviste”, che Ulisse e i compagni avevano sulla propria nave (il legno).
345 voglia vederci morti, né alcuno dei Numi contrasti, meglio ingozzare l’acqua, morire, una volta, alla fine, che striminzire più a lungo, restando in quest’isola grama”. Queste parole disse Euriloco; e niuno si oppose. Onde, afferrate le belle giovenche del Sol, le più grasse,
350 di lì presso – perché non lungi a le cerule navi pascean, lucide belle, le vacche dall’ampia cervice –postele in gruppo, volte preghiere ai beati Celesti, tenere foglie alla vetta reciser di quercia fronzuta, poiché bianco orzo non era nei fianchi dell’agile nave.
355 Quando ebber poi pregato, sgozzate, scoiate le vacche, scarnificaron le cosce, le avvolsero d’adipe30 a doppio, sopra vi posero brani di carne che sangue gemeva. Né per libar su le offerte che ardevano c’era vin pretto; ma le spruzzarono d’acqua, l’entragne31 arrostirono tutte.
360 E poi ch’ebber bruciate le cosce, pasciute32 l’entragne, il resto, fatto a pezzi, confissero dentro gli spiedi. Dalle mie ciglia in quel punto partiva il soave sopore, onde a la nave feci ritorno e a la spiaggia del mare.
Ma, quando giunto ero già vicino alla rapida nave,
365 ecco, m’avvolse tutto d’omento33 bruciato un profumo: onde mi volsi, con alto lamento, ai Signori del cielo:
“Giove padre, e voi tutti, Celesti ch’eterni vivete, per la sventura mia m’immergeste nel sonno funesto, ed i compagni intanto commiser l’orrendo misfatto!”
370 Nunzia34 frattanto giungeva Lampètia dal peplo elegante velocemente al Sole, che uccise avevam le giovenche.
E corrucciato il Sole così favellava ai Celesti: “Giove padre, e voi tutti, Celesti ch’eterni vivete, punite ora i compagni d’Ulisse figliuol di Laerte,
375 empï, che posero a morte le vacche onde avevo io diletto quando io mi dipartivo dalla terra agli astri del cielo,
30 d’adipe: “di grasso”. Con esso venivano avvolte le carni destinate alla cottura.
31 l’entragne: “le interiora”. Venivano abbrustolite e servite agli ospiti più importanti prima del pranzo vero e proprio.
32 pasciute: “mangiate”.
33 omento: “grasso”.
34 Nunzia: “messaggera”, “annunciatrice”. È un complemento predicativo del soggetto.
e quando poi dal cielo scendevo di nuovo alla terra. Ma se un castigo non hanno che agguagli35 lo scempio commesso, io mi sprofondo nell’Ade, la luce comparto36 ai defunti”.
380 E gli rispose Giove che i nuvoli accumula, e disse: “Sole, comparti pure la luce ai Signori d’Olimpo, ed alle genti mortali, sovressa la terra feconda: ch’io con la folgore ardente ben presto la rapida nave colpirò, sminuzzerò in mezzo al purpureo ponto”.
385 Queste cose io le udii da Calipso, la Diva ricciuta che le sapeva, mi disse, dal duce di spiriti Ermète.37 Dunque, come io raggiunsi la nave e le rive del mare, a tutti, uno per uno, rivolsi rampogne; ma vano era cercar rimedi: ché morte eran già le giovenche.
390 Ed i Celesti ad essi mostrarono presto prodigi: serpean le pelli,38 le carni muggivano, crude o già cotte, sopra gli spiedi, lagni s’udivano, come di bovi. E si cibarono per altri sei giorni i diletti compagni con le giovenche pingui del Sole, che avevan predate.
395 Quando il Cronide, infine, fe’ sorgere il settimo giorno, ecco, ed il vento infine cessò di soffiar la procella. Subito noi la nave salimmo, sul mar la spingemmo, l’albero alzammo, sovr’esso spiegammo la candida vela».
Il terribile naufragio
«Ma quando lungi eravam dall’isola già, né pareva
400 terra veruna allo sguardo, null’altro che il cielo ed il mare, ecco, il figliuolo di Crono sospese una nuvola azzurra sopra la nave; e di sotto il pelago oscuro divenne. Né lungo tempo corse la nave, ché subito giunse Zefiro furïoso, con l’urlo d’un turbine immane,
35 agguagli: “uguagli”.
36 comparto: “porto”, “diffondo”.
37 Questa precisazione che Ulisse fa interrompendo il suo racconto è di estremo realismo: egli infatti poteva aver saputo dai compagni le parole pronunciate da Euriloco sulla spiaggia, ma come poteva conoscere i dialoghi avvenuti sull’Olimpo tra Giove e Apollo? Per prevenire allora le obiezioni dell’uditorio, l’eroe porta questa giustificazione: Calipso gli ha riferito quanto è accaduto in cielo, a sua volta informata da Mercurio (Ermete).
38 serpean: “si muovevano strisciando”, simili a serpenti.
405 e la procella del vento dell’albero entrambi gli stragli spezzò: l’albero cadde, gli attrezzi qua e là sparpagliati furono in fondo alla nave. E l’albero, a poppa piombando sovra la testa il pilota colpì: scricchiolarono l’ossa tutte a quel colpo del cranio; ed ei, quasi un tuffo facesse,
410 giù da coperta piombò, che restò senza spirito il corpo. Giove in quella tonò, percosse col fulmine il legno; e questo mulinò, colpito dal folgore, e tutto si riempì di solfo: piombarono in mare i compagni, e, trascinati dai gorghi, giravano attorno alla nave, 415 come cornacchie; e un Dio negò che tornassero a bordo. Io per la nave qua e là correvo, sin quando un maroso via dalla chiglia le coste39 divelse; e la chiglia spogliata travolse un flutto; e abbatté sovr’essa l’albero, e a questo era la gomena attorta, tagliata dal cuoio d’un bove.
420 Con questa entrambi avvinsi, la chiglia con l’albero, sopra mi vi sedetti; e via mi rapirono i venti funesti.
Quivi Zefiro allora cessò di spirar la procella; ma sopraggiunse Noto veloce a recarmi travaglio, sì ch’io dovessi ancora passare dinanzi a Cariddi.
425 Fui trascinato per tutta la notte; ed al sorger del sole giunsi di nuovo alla rupe di Scilla e all’orrenda Cariddi. Essa inghiottiva allora i flutti salmastri del mare. Io con un lancio in alto raggiunsi il gran caprifico.
Qui, come un pipistrello, ghermito restai; né sui piedi
430 dato mi fu sicuro poggiarmi, né ascender più alto: ché lontan le radici avevo di molto, e troppo alti erano i rami lunghi massicci che ombravan Cariddi. Tenacemente così mi tenevo avvinghiato, aspettando che riversasse Cariddi la chiglia con l’albero. E infine
435 giunsero a me. Nell’ora che il giudice lascia la piazza, dove ha deciso sui piati di molti, e alla cena s’avvia,40 ecco, due travi alfine dal gorgo sbucar di Cariddi. Subito allora allargai piedi e mani per sopra cadervi,
39 Le coste sono le assi laterali della chiglia della nave.
40 Ulisse attende attaccato alla roccia fino a sera, cioè l’ora in cui il giudice lascia la piazza, dopo aver deciso delle contese (piati) di molti.
e su le grandi travi con alto rimbombo piombai.
440 Poi, seduto che fui, distesi le palme al remeggio; né dei Celesti e degli uomini il padre permise che Scilla mi distinguesse: se no, non potevo sfuggire alla morte. Qui nove giorni errai. La decima notte, i Celesti me nell’isola Ogigia spinsero, dove Calipso
445 abita, Diva possente canora dai riccioli belli, che mi dilesse e curò. Ma che cosa ti vado io narrando?
L’avete udito già narrare da me nella reggia, tu con la saggia tua sposa; né tedio maggiore io conosco che di ripetere punto per punto le cose già dette».41
41 Ulisse ha già raccontato ai Feaci la sua permanenza presso Calipso nel libro VII
Durante il viaggio per il mare Mediterraneo, Ulisse ha più volte dato prova del proprio valore. Spesso il lettore l’ha visto in azione, avendo dovuto l’eroe far fronte a mille pericoli, spinto dal desiderio di sopravvivere e ritornare a Itaca. Ma la possibilità di azione che in seguito si offre a Ulisse, una volta tornato in patria, è assai differente: dovendo costruire un piano per vendicarsi, egli diventa l’attore primo, l’elemento motore dello svolgersi dei fatti. Perseguitato per lunghi anni, diviene il persecutore dei Proci. A essi spetteranno sorprese e imprevisti, ma per Ulisse (e per il lettore, che vive la storia accanto all’eroe) ogni passo è fermo, calcolato, conosciuto. Tutto avviene secondo il suo disegno, ogni cosa va secondo i suoi piani: impartisce ordini e questi vengono eseguiti alla lettera, prevede con successo le mosse degli avversari, mette in conto anche di dover essere picchiato, ma dopo tutto anche questo serve allo scopo finale.
Divenuto comandante di un piccolo esercito composto dal figlio e due pastori, Ulisse deve prima sincerarsi della loro assoluta fedeltà. In questa sezione assistiamo allora a una serrata indagine che il protagonista conduce tra la propria gente e i propri cari. Lo strumento che egli adopera per tale compito è la menzogna, il racconto verosimile. L’eroe si costruisce, infatti, molte maschere, assume prudentemente diverse identità, e così facendo riesce a portare a galla, a stanare i reali e differenti sentimenti che animano Telemaco, Eumeo, Melanzio, Filezio, Euriclea, Melanto, suoi parenti o servitori, capendo così su quali soltanto egli possa fare cieco affidamento.
Ulisse assume la veste di abile e infallibile stratega, e proprio in questo momento scopre che il suo ritorno in patria è stato voluto e seguito in ogni suo passo da uno stratega infinitamente più abile di lui: la dea Atena. La figlia di Giove, che ha guidato in patria l’eroe con discrezione, senza mai rivelarglisi, da questo punto della storia appare a Ulisse in diverse occasioni e lo istruisce e accompagna nella propria opera vendicativa.
Libro Xiii – Il giorno successivo al racconto, Ulisse si congeda dai Feaci, i quali lo riaccompagnano a Itaca su una loro nave. Il dio Poseidone, irato per l’aiuto offerto all’eroe itacese, durante il viaggio di ritorno a Scheria pietrifica la nave dei Feaci, ricordando al re Alcinoo un’antica profezia.
Giunto a Itaca, Ulisse stenta a riconoscerla e vi riesce solo dopo aver interrogato un giovane pastore. Questi altri non è che Minerva, la quale si rivela all’eroe e gli mostra dove nascondere le ricchezze offertegli da Alcinoo. Assieme a Ulisse, poi, la dea studia un piano per vendicarsi dei Proci: Ulisse dovrà muta-
re aspetto e recarsi alla capanna del porcaro Eumeo, attendendo lì il ritorno di Telemaco.
Libro XiV – Giunto alla capanna di Eumeo, Ulisse viene accolto dal vecchio porcaro, il quale, pur non essendo particolarmente benestante, non esita a condividere le proprie sostanze con l’ospite straniero. Ulisse non si rivela al vecchio amico, ma si finge cittadino cretese. In tal maniera può indagare l’animo di Eumeo, che scopre essere rimasto in tutti questi anni fedelissimo al padrone, del ritorno del quale, tuttavia, ormai dispera.
Libro XV – Recatasi a Sparta, intanto, Minerva sollecita il ritorno di Telemaco. Il giovane si congeda da Menelao e la sua ripartenza è salutata con il volo profetico di alcune oche selvatiche. Giunto presso la propria nave, a Pilo, Telemaco salpa immediatamente per Itaca.
A Itaca intanto Eumeo continua a intrattenere Ulisse, servendolo come ospite gradito e raccontandogli con maggiori dettagli la propria storia e la sorte toccata alla casa di Ulisse in assenza dell’eroe.
Finalmente la nave di Telemaco giunge in patria, fermandosi tuttavia in un porto secondario ed evitando così l’insidia dei Proci.
Libro XVi – Telemaco giunge alla capanna di Eumeo e qui incontra il mendico cretese, dietro cui si cela il padre Ulisse. Il giovane ordina al porcaro di recarsi a palazzo e avvisare la madre Penelope del suo ritorno.
Approfittando dell’assenza di Eumeo, Minerva favorisce il riconoscimento di Ulisse da parte del figlio, che avviene non senza dubbi e timore di nuovi inganni. Finalmente insieme, padre e figlio architettano un piano per vendicarsi dei Proci e delle loro insolenze.
A palazzo, intanto, i pretendenti scoprono di essere stati raggirati da Telemaco, che è ormai giunto a Itaca sfuggendo alla loro trappola. Eumeo arriva da Penelope, la quale tuttavia è già stata informata del ritorno del figlio. Il porcaro fa dunque ritorno alla capanna.
Libro XVii – Il giorno seguente Telemaco torna a palazzo, tra lo stupore dei Proci e la gioia della madre Penelope. Più tardi muovono per raggiungerlo anche Ulisse ed Eumeo. Lungo il tragitto i due incontrano il pastore Melanzio, il quale, geloso del favore che gode presso i pretendenti, insulta Ulisse, in cui vede solo un fastidioso mendicante.
Giunto a palazzo, per via del proprio ingannevole travestimento, Ulisse non viene accolto da nessuno; solo il vecchio cane Argo lo riconosce e lo saluta festosamente, prima di acquattarsi e morire, finalmente in pace. I Proci riservano invece un pessimo trattamento al misterioso ospite, coprendolo d’insulti e percosse, spettacolo cui Telemaco assiste sopportando in silenzio. Penelope vorrebbe conoscere l’ospite per riservargli migliore accoglienza, ma il colloquio tra i due viene rimandato a dopo cena.
Libro XViii – Di nuovo Ulisse deve sopportare maltrattamenti e insulti: prima è costretto a lottare per il divertimento dei Proci contro un altro mendicante, Iro, il quale viene sonoramente battuto e punito per la propria arroganza; in seguito viene preso di mira dai pretendenti, che lo scherniscono e lo bersagliano, tirandogli addosso il cibo. Ancora una volta Ulisse sopporta con pazienza.
Libro XiX – Approfittando della confusione, Telemaco suggerisce di togliere dai muri le armi, affinché i Proci non si azzuffino tra di loro nel colmo della loro ebbrezza: in realtà, privarli di ogni possibile arma fa precisamente parte del piano di Ulisse e Telemaco.
Nel frattempo Ulisse è convocato da Penelope. La donna vuole interrogare l’uomo per avere notizie del marito, ma usa con lo straniero molta prudenza, sospettando ormai di tutti: negli anni passati, infatti, molti ciarlatani si sono presentati a lei, vantando false informazioni su Ulisse. Ulisse convince Penelope della propria sincerità e viene pertanto da lei ben accolto. Una serva, Euriclea, è incaricata di lavare lo straniero. Notando una cicatrice sulla gamba dell’uomo, l’anziana donna riconosce l’eroe, ma Ulisse prontamente la trattiene dal rivelarlo alla padrona.
Durante la notte, Penelope riceve in sogno il suggerimento di indire una gara con l’arco, promettendosi come sposa per il vincitore.
Libro XX – Trascorsa una notte agitata, nella quale sia pregusta la strage sia teme possibili imprevisti, nel corso della mattinata seguente Ulisse incontra Filezio, un altro pastore e fedele amico. I Proci intanto si apprestano ad affrontare una giornata come tante, riunendosi per l’ennesimo banchetto.
Libro XIII
Ulisse si congeda da Alcinoo
[1-15] Il lungo racconto che Ulisse ha svolto dei suoi viaggi e delle sue avventure ha colpito particolarmente i Feaci, che hanno ascoltato tutto quanto in silenzio, come presi da un incanto. Interviene alla fine il re Alcinoo, promettendo a Ulisse doni preziosi e un ritorno sicuro, dal momento che ha già sofferto troppo.
Così diceva Alcinoo, né spiacquero agli altri i suoi detti; e, per dormire, così, tornarono ognuno alla casa. Poi, come Aurora apparì mattiniera, che dita ha di rose, mossero verso la nave, portando i magnifici bronzi.1
20 E qui, sul legno ascesa la forza d’Alcinoo divina, li collocò sotto i banchi, perché non recassero impaccio a niuno dei nocchieri, quando essi sedessero ai remi. Mossero gli altri alla casa del sire, e apprestaron le mense; ed un giovenco immolò per essi al figliuolo di Crono
25 che addensa i negri nembi, la forza d’Alcinoo divina. Bruciate poi le cosce, divisero il lauto banchetto, tutti gioiosi. E cantò fra loro Demodoco, il vate caro ai Celesti, e segno d’amore alle genti.2 Ma Ulisse al sole sfolgorante volgeva sovente lo sguardo,
30 e n’affrettava il tramonto:3 ché troppo bramava il ritorno.
Come la cena brama bifolco che per la maggese spinge da mane a sera l’aratro ed i fulvidi bovi – 4
1 I magnifici bronzi sono i doni promessi da Alcinoo; si tratta più precisamente di tripodi (pregiati sostegni a tre piedi per vasi, sotto i quali spesso ardeva il fuoco per scaldare l’acqua contenuta nel recipiente) e lebeti, cioè preziosi vasi.
2 segno d’amore alle genti: “amato da tutte le genti”.
3 Non sappiamo quale sia l’argomento del canto di Demodoco, poiché Omero stesso non ritiene importante comunicarcelo: quello che interessa qui è soltanto il desiderio struggente di Ulisse di poter tornare in patria. Affrettare il tramonto significa, infatti, che Ulisse non vede l’ora che giunga la sera, quando è prevista la sua partenza dall’isola.
4 Come la cena … fulvidi bovi. Da ordinare così: come bifolco (“contadino”), che spinge l’aratro
grande piacere il sole gli fa che s’immerge, ed al pasto s’affretta, e, mentre muove, gli mancano sotto i ginocchi –,5
35 così giunse ad Ulisse gradito il tramonto del sole.
Ed ai Feaci, amici dei remi, parlò senza indugio; e specialmente ad Alcinoo si volse con queste parole: «Ottimo sire, Alcinoo, preclaro6 fra tutte le genti, libate or, congedatemi incolume, e siate felici,
40 perché quanto il mio cuore bramava, già tutto è disposto, la scorta, e i cari doni. Deh!, facciano i Numi del cielo ch’io profittare ne possa! Trovare io, deh!, possa al ritorno immacolata la sposa, trovar possa illesi gli amici.
E voi che qui restate rendete felici le spose
45 vostre legittime e i figli. E possano i Numi accordarvi ogni delizia, e lungi dal popol tenere ogni danno».
Così diceva; e tutti plaudirono, e chieser congedo per lo straniero che aveva così nobilmente parlato.
[49-62] Come Ulisse ha chiesto, viene libato del vino a Giove e il servitore Pontonoo lo distribuisce a tutti i presenti, perché possano partecipare alla preghiera. Ulisse infine si congeda dalla regina Arete e la saluta caramente, con l’augurio che possa essere felice fino alla vecchiaia e godere sempre dei figli e del marito.
E, così detto, Ulisse divino varcò quella soglia; ed un araldo con lui spediva Alcinoo possente, 65 che lo guidasse alla riva del mare e a la rapida nave.
Arete poi mandò, che seco movesser, tre ancelle. Recava una di queste la tunica e un nitido manto; aveva dato il saldo ben chiuso forziere ad un’altra; ed una terza pane recava e purpurëo vino.
70 Giunti che furono al lido del mare e a la rapida nave, i navichieri tutto deposer nei concavi fianchi;
ed i fulvidi bovi da mane (“mattina”) a sera per la maggese (“campo”), brama la cena. I buoi sono detti fulvidi, cioè “fulvi”, “dal pelo rossiccio”.
5 gli mancano sotto i ginocchi: “si sente venire meno”, “sente le gambe cedere”.
6 preclaro: “famosissimo”.
poi per Ulisse una coltre7 deposero e un panno di lino a poppa, sovra i banchi del concavo legno, ché quivi tranquillamente dormisse. La nave egli ascese, e in silenzio
75 si coricò. Sedevano quelli, ciascuno al suo remo, in fila: indi, dal sasso forato8 la gomena sciolta, reclini, con le pale dei remi sconvolsero l’onde. E mite sonno scese sovresse le palpebre a Ulisse, dolcissimo, profondo, che sonno pareva di morte.
80 E come quattro maschi puledri trascorrono9 il piano, che della sferza ai colpi si mossero tutti ad un punto, ed a gran balzi dal suolo si spiccano, e compion la via, così si sollevava la poppa del legno; e di dietro rigorgogliava il flutto purpureo del mare sonoro.
85 Sicuramente la nave correa senza indugio; né aggiunta10 l’avrebbe uno sparviero, ch’è pur degli uccelli il più ratto:11 con tale impeto i gorghi fendeva del pelago il legno,12 l’uomo recando che senno nutria pari a quello dei Numi, che avea sino a quel punto sofferto per tanti travagli,
90 sperimentando le guerre degli uomini e i flutti del mare; ed or d’ogni suo cruccio giaceva oblioso e tranquillo.
Finalmente a Itaca
Quando nel cielo surse bianchissimo l’astro che annuncia la luce,13 appena brilla, d’Aurora che presto si leva, giunse all’isola allora la nave dal corso veloce.
95 C’è nell’isola d’Itaca un porto che al veglio del mare Fòrcino14 è sacro. All’ingresso si sporgono due promontori
7 coltre: “coperta”.
8 sasso forato: si fa riferimento a un pilastro di pietra che aveva un buco attraverso il quale si faceva passare la fune (gomena) che teneva la nave ormeggiata nel porto.
9 Trascorrono è qui utilizzato come sinonimo di “percorrono”.
10 aggiunta: “raggiunta”.
11 ratto: “veloce”.
12 con tale impeto i gorghi fendeva del pelago il legno. Da ordinare così: il legno fendeva i gorghi del pelago con tale impeto.
13 L’astro che annuncia la luce è il pianeta Venere, all’occhio umano simile a una stella, che per ultimo scompare nel momento in cui la notte cede il posto al giorno.
14 Forcino (o Forco) è un vecchio (veglio) dio del mare, padre di tutti i mostri marini. A lui si deve la costruzione del porto di Itaca.
scoscesi, che dal porto strapiomban sul pelago, e fuori tengono gli alti marosi gonfiati dal soffio dei venti impetuosi. Ivi dentro le navi dai solidi fianchi
100 pur senza gomena stanno, quand’hanno gettato l’ormeggio. Leva un ulivo, al fondo del porto, le foglie; e accanto ad esso un antro gradevole scuro ed azzurro come l’aria: vi stanno le Ninfe che Nàiadi15 han nome. Quivi crateri sono, con anfore grosse di pietra;
105 quivi le pecchie fanno lor bugni,16 e preparano il miele; quivi telai di pietra grandissimi, dove le Ninfe tessono manti azzurri purpurei,17 stupore a vederli. Acque perennemente vi scorrono. E s’apron due porte, questa rivolta a Bora,18 per dove è l’accesso ai mortali,
110 è più divina quella che a Noto si volge;19 né quivi possono gli uomini entrare, ché quivi è l’accesso dei Numi. Quivi i Feaci, del luogo già sperti,20 approdarono; e il legno sopra la terra balzò, sino al mezzo di quanto era lungo, impetuoso: tal forza di mani incombeva sui remi.
115 E fuor dal ben commesso21 navile balzati alla spiaggia, prima di tutto, Ulisse levaron dal concavo legno, lui con le sue coperte fulgenti, col drappo di lino, e lo deposero sopra la sabbia, che ancora dormiva; e le ricchezze presso gli poser, che i prenci Feaci
120 date, mercé d’Atena, gli avevan quand’egli partiva;22
15 Le Ninfe Naiadi sono delle divinità benefiche dei boschi e dei fiumi, che nutrono le piante e le greggi.
16 Le pecchie fanno lor bugni: “le api costruiscono i propri alveari”.
17 manti azzurri purpurei. L’espressione sembrerebbe contraddittoria: i manti hanno colore azzurro oppure violaceo? L’incoerenza può essere spiegata se si pensa al probabile uso di tessere stoffe del colore del mare, cioè di quella tinta indefinita tra l’azzurro e il “porpora”, così come ritenevano i Greci.
18 rivolta a Bora: Bora (o Borea) è il vento che proviene da nord; quindi l’espressione significa “rivolta a nord”.
19 a Noto si volge: “è rivolta a sud”, essendo Noto il vento del sud.
20 sperti: “esperti”, “conoscitori”.
21 ben commesso: “ben costruito”.
22 che i prenci Feaci date, mercé d’Atena, gli avevan quand’egli partiva. Da ordinare così: che i prenci (“principi”) Feaci gli avevan date, mercé d’Atena, quand’egli partiva. L’espressione mercé d’Atena significa “grazie ad Atena”, “per opera di Atena”. La parola mercé è la forma tronca di mercede, cioè “ricompensa”.
e presso il piè dell’ulivo le posero tutte in un mucchio, fuor della via battuta:23 ché a caso, qualcuno, passando pria del risveglio d’Ulisse, non dovesse farne man bassa. E poi presero anch’essi la via del ritorno.
[125-157] L’arrivo di Ulisse a Itaca suscita la potente ira di Nettuno, il quale si lamenta con Giove per il fatto che l’eroe non solo sia riuscito a raggiungere la patria, ma sia anche pieno dei ricchi doni che i Feaci gli hanno dato: non avrebbe ottenuto pari ricchezze neanche se fosse tornato direttamente da Troia con tutto il bottino! Nettuno comprende che Giove aveva già promesso a Ulisse l’approdo in patria, e allora rivolge la propria ira contro i Feaci, che sembrano avergli mancato di rispetto. In risposta, il re degli dèi lo rassicura: potrà vendicarsi con loro come meglio crede.
E come l’ebbe udito, il Nume che scuote la terra subito mosse alla Scheria, dove hanno dimora i Feaci.
160 Quivi attese. E la nave già presso alla spiaggia giungeva, rapida i flutti solcando. Ma l’Enosigèo24 le fu sopra, e in pietra la mutò, fe’ ch’essa mettesse radici,25 con la man prona26 al fondo gravandola. E quindi scomparve.
E gl’incliti nocchieri Feaci, maestri di remi, 165 parlaron l’uno all’altro, volgendosi alate parole; ed a tal vista così diceva ciascuno al vicino: «Ahimè!, chi mai la nave, mentre essa giungeva a la spiaggia, ha radicata nel mare? Già tutta visibile ella era!» Così diceano; e niuno sapeva com’era avvenuto.
170 E allora ad essi Alcinoo si volse con queste parole:
23 La via battuta è la strada solitamente percorsa (battuta) dai piedi di tutti. L’espressione fuor della via battuta vuole quindi indicare un luogo appartato, lontano dagli sguardi dei più.
24 Enosigeo è un epiteto di Nettuno, che significa “scuotitore della terra”. Egli era infatti anche il dio dei terremoti.
25 mettesse radici: “fosse immobilizzata”. La nave viene perciò pietrificata da Nettuno poco lontano dalla riva dell’isola e i marinai rimangono uccisi; il sasso a forma di nave servirà come monito ai Feaci, ricordando loro per il futuro il rispetto e il timore dovuti al dio. Gli antichi identificavano la nave feacia in un enorme scoglio che ancora oggi si erge nel mare appena fuori dal porto di Corfù; già alla fine dell’VIII secolo a.C. si pensava quindi che Scheria coincidesse con l’isola di Corfù.
26 con la man prona: “con il palmo della mano aperto e rivolto verso il basso”.
«Miseri noi, che adesso si avvera un antico presagio del padre mio: che il Dio del mar si sarebbe sdegnato perché tutti avanziamo, se alcuno scortiamo per mare.27
E dir solea che un giorno tra i ceruli gorghi del ponto
175 un legno dei Feaci bellissimo avrebbe spezzato, e ricoperta avrebbe la nostra città d’un gran monte.
Così diceva il veglio, come ora s’è tutto avverato. Ora, su via, tutti quanti facciamo come io vi consiglio: scorta a nessun dei mortali non s’offra, che capiti a caso
180 nella città dei Feaci; poi, dodici tori trascelti, s’offrano al Dio del mare, se, mosso a pietà, più non cerchi sopra la nostra città gravare l’altissimo monte».
Disse così; temerono quelli, e condussero i tori.
Così dunque al signore Posidone alzarono preci,
185 stando all’altare intorno, del popol feacio i signori, guida alle genti.
E Ulisse divino dal sonno si scosse, che nella terra materna dormiva. Né questa conobbe, ché n’era lungi da tanto, e intorno recinto di nebbia
Pallade Atena,28 la diva figliuola di Giove,
190 sì che invisibile fosse, che tutto essa dirgli potesse, perché né la sua sposa, né i suoi cittadini e gli amici lo conoscesser, pria ch’egli traesse vendetta dei Proci. Perciò tutte le cose mostrarono aspetto diverso agli occhi dell’eroe: le lunghe strade, le rade
195 schiuse all’approdo, le rupi precipiti, gli alberi folti. Balzò sui piedi, gli occhi rivolse alla terra paterna, ed un lamento quindi levò, si batté sopra le cosce ambe le palme prone. Così lamentandosi, disse: «Misero me, di che genti son giunto ancora alla terra?
200 Nomadi violenti saranno, ed ignari di leggi, o senso hanno ospitale, mente hanno devota ai Celesti?
27 perché tutti avanziamo: “perché siamo superiori a tutti”.
28 e intorno recinto di nebbia Pallade Atena: “Pallade Atena (l’aveva) recinto di nebbia”, cioè “l’aveva avvolto”, “circondato”. Recinto è qui utilizzato come verbo, non come sostantivo.
Dove mai porterò tutte queste ricchezze? Ed io stesso dove mi volgerò? Tra i Feaci le avessi lasciate, ché poi giunto a qualche altro dei prenci potenti sarei, 205 che ospizio e scorta dato m’avrebbe, sì ch’io ritornassi. Ora non so dove io le collochi, e qui non le voglio lasciar, ché divenire non debbano preda degli altri. Povero me! Non tutti forniti di senno, né giusti eran dunque i signori che reggon le genti feacie!
210 Essi in un’altra terra mi fecero addurre; promessa fecer che in Itaca avrei sbarcato, e fu vana promessa. Giove li possa punire, che i supplici cura, che guarda gli uomini tutti dal cielo, che assegna castigo a chi pecca. Ma via, le mie ricchezze vo’ adesso contare, e vedere
215 se me ne avessero tolte, fuggendo sul concavo legno».29
Disse; ed il novero fece dei tripodi tutti e i lebeti; e quindi l’oro, e quindi le fulgide vesti tessute. Né gli mancava nulla. E allor, sospirando la patria, egli si trascinò su la spiaggia del mare sonante,
220 versando amaro pianto. E Atena gli venne dappresso, che avea d’un giovinetto di greggi custode parvenza, tenero tenero, quali dei principi sono i figliuoli; ed un mantello aveva sugli omeri, duplice e ricco, e sotto i morbidi piedi calzari, e zagaglie nel pugno.
225 E Ulisse s’allegrò, vedendola,30 e incontro le mosse, e a lei rivolse il volo di queste veloci parole: «O caro, poi che in questa contrada te primo io ritrovo, salute a te. Né idea ti colga di offesa recarmi, anzi salvezza a questi miei beni procaccia, e a me stesso.
230 Come un Iddio t’invoco, ti stringo, piegando i ginocchi; e tu la verità di questo rispondi, ch’io sappia: che terra è questa? Che gente? Quali uomini quivi han dimora?
29 Ulisse è sicuro di non essere giunto a Itaca, altrimenti certamente l’avrebbe riconosciuta. Il mancato riconoscimento può essere spiegato con il fatto che Ulisse è rimasto lontano vent’anni dalla patria e con la nebbia di cui Minerva l’ha avvolto, che rende inconsueto l’aspetto dell’isola. Si convince perciò che i Feaci, approfittando del suo pesante sonno, lo abbiano ingannato e trasportato in un luogo sconosciuto e forse anche inospitale.
30 Ulisse si rallegra nel vedere Minerva non perché l’abbia riconosciuta, ma perché quel giovinetto sembra essere affidabile: a lui potrà dunque chiedere in quale terra sia mai giunto.
Una delle isole è questa che sorgon dal mare, o una spiaggia che si protende tra i flutti del mar dalla fertile terra?»
235 E gli rispose così la Diva dagli occhi azzurrini: «Stolido sembri, oppure sei giunto da lungi, straniero, se tu di questa terra notizie mi chiedi: ché oscuro punto31 il suo nome non è, bensì lo conoscono molti quanti abitan le terre rivolte all’aurora ed al sole,
240 e quanti, a tergo, quelle rivolte all’ombroso occidente.32
Aspra ella è ben di sassi, non tale da corrervi carri: misera troppo no, ma neppure troppo ampia si stende. Biade vi crescono, quante difficile è dirtelo, e vino; piogge la rendono sempre feconda, e copiosa rugiada.
245 Buona nutrice è di capre, nutrice di bovi; e una selva vi cresce d’ogni pianta, con fonti che corron perenni. Ospite, sino a Troia conoscono d’Itaca il nome, ch’è dalla terra achea, raccontano, tanto lontana».
La falsa storia del soldato cretese
Così disse. Ed Ulisse tenace divino fu lieto,
250 che giunto era alla patria, così come detto gli aveva Pàllade Atena, figlia di Giove che l’egida regge.
E a lei dunque si volse, col volo di queste parole, né disse il vero, ché un motto già già formato33 trattenne, sempre volgendo in mente prudenti assennati pensieri:
255 «D’Itaca udii parlare nell’ampie contrade di Troia, da lungi, sopra il mare. Ed ecco ch’io stesso vi giungo, con queste mie ricchezze. Lasciatene ai figli altrettante, erro fuggiasco, ché Orsiloco piede veloce, figliuolo d’Idomenèo,34 trafissi, che in Creta dall’ampie contrade
31 punto: “per niente”.
32 le terre rivolte all’aurora ed al sole … quelle rivolte all’ombroso occidente: l’espressione indica le terre rivolte a oriente e a occidente. Se per noi il punto cardinale di riferimento per l’orientamento è il nord, per i Greci era l’est; perciò l’ovest si trovava alle spalle (a tergo) per chi guardava il sole sorgere. L’occidente è detto ombroso perché il buio della notte segue immediatamente il tramonto del sole.
33 Il motto già già formato è l’espressione di gioia che subito si era formata in lui, ma che l’astuto eroe prudentemente trattiene.
34 Orsiloco piede veloce, figliuolo d’Idomenèo: Idomeneo, allora noto a tutti, era davvero il re di Creta; Orsiloco, invece, è un personaggio inventato dalla fantasia di Ulisse.
260 tutti quegli uomini industri35 vincea nella gara del corso, perché privo mandarmi di tutta la preda di Troia ei mi voleva,36 per cui sofferti ebbi tanti travagli, volgendomi tra zuffe di genti e furore di flutti: tutto perché piaciuto non m’era servire a suo padre,
265 sotto le mura di Troia; ma io comandavo altre genti.37 Dunque, mentre egli tornava dai campi, gli tesi un agguato con un compagno, e lo uccisi con una zagaglia38 di bronzo.
Notte oscurissima il cielo copriva; né alcuno ci vide di quelle genti: occulto rimasi, quando io l’ebbi ucciso.
270 E poscia, come l’ebbi trafitto col bronzo affilato, subito i passi a una nave diressi, e agli esperti Fenici volsi preghiera, e ad essi lasciai quanta preda bastasse, che m’accogliesser fuggiasco nel legno, e recassero a Pilo, o in Elide divina, dove hanno dominio gli Epéi.39
275 Però di qui lontani li tenne la forza del vento, contro ogni loro voglia, ché far non mi vollero inganno. Di lì, poi, dopo lungo vagar, qui giungemmo di notte.
In fretta quivi al porto spingemmo coi remi la nave, né alcun pensò, per quanto ne avessero brama, alla cena;
280 anzi, sbarcati lì, ci ponemmo a sedere digiuni. Quivi discese su me stanchissimo un sonno soave. Ed essi, i beni miei levati dal concavo legno, li poser presso me, dove io sopra il lido giacevo; e quindi, asceso il legno, salpâr verso Sidone bella,40
285 ed io rimasi qui, col cuore ferito dal cruccio».
35 industri: “attivi”, “energici”.
36 privo mandarmi di tutta la preda di Troia ei mi voleva. Da ordinare così: ei voleva mandarmi privo di tutta la preda (“bottino”) di Troia
37 Nel racconto inventato da Ulisse Orsiloco si sarebbe risentito con lui, soldato cretese, il quale durante la guerra di Troia avrebbe preferito guidare un proprio gruppo di uomini piuttosto che combattere nell’esercito guidato dal re Idomeneo. Per questo motivo non avrebbe voluto concedere a Ulisse il bottino conquistato a Troia.
38 zagaglia: “lancia”.
39 L’Elide è una regione del Peloponneso anticamente abitata dal popolo degli Epei. La città di Pilo, sulla quale regnava Nestore, confinava con l’Elide.
40 Sidone, situata lungo le coste orientali del mar Mediterraneo, era una delle città fenicie più importanti.
Ulisse riconosce Itaca
Così disse; e, ridendo, la Diva dagli occhi azzurrini, a carezzarlo stese la mano. E sembianza di donna aveva, grande, bella, maestra d’ogni arte gentile; e a lui parlando, il volo rivolse di queste parole:
290 «Fine davvero, scaltrito41 sarebbe chi te superasse nelle malizie, ché tutte le sai, fosse pure un Celeste. Raggiratore dai mille trovati,42 mai sazio di frodi, neppur qui, nella terra paterna, ristai43 dagl’inganni, dai menzogneri discorsi, che cari ti son da la culla!
295 Ma via, più non si parli di questo; ed entrambi cerchiamo qualche astuzia, ché tu sei fra tutti i mortali il più scaltro, di mente e di parola, ed io fra i Celesti d’Olimpo son per saggezza e finezza famosa. Né tu conoscesti Pallade Atena, la figlia di Giove, che, sempre vicina,
300 in tutti i tuoi travagli t’assisto e ti sono custode. E modo anche trovai che caro ai Feaci tu fossi. Ed ora sono qui per tessere teco un consiglio, e per nascondere i beni che t’hanno donato i Feaci per mio volere e mio consiglio, allorché tu partisti.
305 E tutti quanti i travagli ti dico che devi soffrire nella tua casa, com’è destino. E tu devi patirli; ed a nessuno ti devi svelare, né uomo, né donna, ché dopo lungo errare sei giunto; ma startene muto, patire i gravi crucci, le ingiurie patir delle genti».
310 E le rispose così l’accorto pensiero d’Ulisse: «Difficil cosa è, Diva, per l’uomo mortal che t’incontra, te ravvisar, per accorto ch’ei sia, ché tu assumi ogni aspetto. Ma questo io bene so: che dapprima tu m’eri benigna, finché sotto le mura di Troia pugnaron gli Achivi,
315 ma poi che la città di Priamo avemmo distrutta, poi che le navi ascendemmo e un Nume disperse gli Achivi, io non ti vidi, o figlia di Giove, mai più, né m’accorsi
41 Fine: “intelligente”; scaltrito: “scaltro”, “furbo”.
42 Raggiratore dai mille trovati: “ingannatore dalle infinite trovate”, “dalle infinite risorse”.
43 ristai: “resti lontano”, “ti astieni”.
che sulla nave mia salissi a schermire il mio danno;44 ma sempre, entro il mio seno sentendo squarciarmisi il cuore, 320 errai, sin che i Celesti me libero fêr dai malanni: e fu quando tu prima fra il popol dei ricchi Feaci ed alla loro città mi guidasti, facendomi cuore. Ed or pel padre tuo ti supplico, ch’io non mi credo d’essere giunto all’isola d’Itaca, e invece m’aggiro
325 sopra qualche altra terra, e penso che tu per dileggio mi dica queste cose, per trarre in inganno il mio cuore: dimmi se veramente son giunto alla terra materna».
[328-350] Minerva è colpita dalla prudenza e dal senno di Ulisse e se ne compiace. Per rispondere alla provocazione dell’eroe, dice che negli ultimi anni non è accorsa in suo aiuto non solo perché sapeva che prima o poi sarebbe approdato a Itaca, ma anche per non contrastare il disegno di Posidone, che era pieno di rancore verso Ulisse per l’accecamento del Ciclope. Infine la dea mostra a Ulisse i luoghi di Itaca, perché egli si convinca di essere davvero giunto in patria.
Disse la Diva, e disperse la nebbia; e visibile tutta fu la contrada. E Ulisse fu colmo di gioia, ché vide la terra patria; e baciò le zolle datrici di spelta;45 e questa prece volse, levando le mani, alle Ninfe:
355 «Naiadi Ninfe, di Giove figliuole, mai più non credevo ch’io pur v’avrei vedute! Gradite per ora la prece; poi doni v’offrirò, sì come una volta li offrivo, se la figliuola di Giove, datrice di prede,46 consente benigna a me ch’io viva, che rida fortuna a mio figlio».
I consigli di Minerva
[360-394] Minerva consiglia a Ulisse come sia meglio agire per potersi vendicare dei Proci e per riappropriarsi del proprio potere sull’isola: innanzitutto è necessario nascondere in una grotta le ricchezze donate dai Feaci, perché nessuno possa rubarle. Così Ulisse le trasporta tutte al sicuro, e Atena sbarra
44 schermire: “fare da schermo”, “proteggere”.
45 spelta: “frumento”.
46 datrice di prede: questo epiteto si riferisce a Minerva, dea spesso affiancata alla guerra.
l’ingresso con un masso enorme. Poi – continua Minerva – è necessario escogitare insieme un piano:
395 «Ora io farò che niuno degli uomini più ti ravvisi.47 Ti renderò grinzosa48 la pelle su l’agili membra, farò le chiome bionde sparir dal tuo capo, di cenci ti coprirò, che faccian ribrezzo a chiunque ti vegga; gli occhi ti offuscherò, che adesso rifulgono belli,
400 sì che vituperoso49 tu sembri ai Proci arroganti, ed alla sposa e al figlio, che in casa, partendo, hai lasciati. E tu, per prima cosa, ti devi recar dal porcaro50 che custodisce i tuoi porci, che te predilige sincero, ch’ama tuo figlio, ed ama Penelope piena di senno.
405 Lo troverai che guarda le scrofe che stanno pascendo presso alla rocca del Corvo, sovressa la fonte Aretusa: cibano ghiande, quante ne bramano, e bevono l’acqua torbida, onde si nutre il florido armento dei porci.51
Qui sosta, e presso a lui rimani, e dimandagli tutto,
410 sin ch’io non giunga a Sparta, città delle femmine belle, per richiamare, o Ulisse, Telemaco, il figlio tuo caro, che quelle belle contrade cercò, cercò Menelao, per chiedere notizia di te, se tu ancora vivessi».
E le rispose così l’accorto pensiero d’Ulisse:
415 «Detto perché non gliel’hai, tu che pure di tutto hai contezza?
Forse perché travagli patir debba anch’egli, ed errare sopra lo sterile mare, mentre altri gli vorano i beni?»
E gli rispose così la Diva dagli occhi azzurrini: «Troppa cura di lui non deve affannare il tuo cuore:
420 io stessa l’ho inviato, perché buona fama acquistasse
47 ti ravvisi: “ti riconosca”.
48 grinzosa: “rugosa”.
49 vituperoso: “che merita vituperio”, cioè “biasimo”, “disapprovazione”.
50 Il porcaro è Eumeo, un fedele servitore di Ulisse, che viveva in una capanna e continuava ad allevare porci, così come faceva quando Ulisse lasciò Itaca per combattere nella guerra di Troia. Ora però a malincuore è costretto a servire i Proci, che si sono impossessati della reggia dell’eroe.
51 il florido armento dei porci. Armento è un termine indicante la mandria di animali; florido significa “ricco”, “numeroso”.
andando lì; né cruccio veruno lo turba,52 e tranquillo sta nella casa d’Atreo,53 soggiorna fra beni e dovizie. Vero è che in una nave gli tendono i Proci un agguato, che lo vorrebbero morto pria ch’egli sia giunto alla patria;
425 ma non sarà, credo io: dovrà pria la terra coprire talun di quei superbi che tutti ti vorano i beni». Mentre così diceva, la Dea lo sfiorò d’una verga. Di grinze tutte quante coperse le floride membra, gli fe’ sparir dal capo le chiome sue bionde; e su tutta
430 la sua persona stese la pelle d’un vecchio cadente, foschi54 gli rese gli occhi, che prima fulgevano belli. Ed una tunica indosso gli pose, ed un misero manto, roba stracciata, lorda, di sudicio fumo annerita, ed una logora pelle su quelli, di rapido cervo.
435 Poscia un bastone in mano gli diede, e una rozza bisaccia,55 tutta a brandelli; e al collo pendea da una logora cinghia. Presi così gli accordi, si mosser divisi; e la Dea a Lacedèmone56 andò, per cercare il figliuolo d’Ulisse.
52 né cruccio veruno lo turba: “e non lo turba alcuna preoccupazione”.
53 nella casa d’Atreo, cioè nella casa di Menelao, di cui Atreo era il padre.
54 foschi: “spenti”, “inespressivi”.
55 La bisaccia era una grossa sacca che si portava a tracolla (pendea da una logora cinghia) ed era un tipico contrassegno dei mendicanti o, comunque, di gente povera.
56 Lacedemone è un altro nome di Sparta.
Libro XIV
Eumeo, il devoto servitore
L’arrivo alla capanna
Dunque, dal porto Ulisse s’avviò per l’aspro sentiero, sopra selvose piagge,1 traverso ad alture, ove Atena detto gli avea che fosse la casa del fido porcaro che provvedeva il cibo per tutta la gente d’Ulisse.
5 E lo trovò seduto dinanzi alla casa, ove eccelso era costrutto un recinto spazioso, elegante, isolato, in uno spiazzo aperto da tutte le bande.2 Il porcaro stesso l’aveva costrutto, quando era partito il signore, ché la regina né il vecchio Laerte non v’ebbero parte.
10 L’avea con grandi pietre costrutto, e recinto di pruni. E tanti pali aveva confitti via via tutto intorno, molti, fitti, tagliati nel duro dell’ilice negra.3 Dentro il recinto aveva costrutte ben dodici stalle, l’una vicina all’altra, da starci a giacere le scrofe.
15 Erano chiuse in ciascuna cinquanta scrofe feconde, sdraiate a terra;4 i maschi giacevano fuor nella corte, molti di meno, giacché provvedevano a farli scemare5 i seminumi Proci,6 ché ad essi doveva il porcaro sempre il migliore via via spedire dei ciacchi7 più grassi:
20 così di maschi in tutto ce n’era trecentosessanta. Stavano quattro mastini lì presso, e sembravano fiere, sempre alla guardia: il fido porcaro li aveva cresciuti. Eumeo stava or tagliando la florida pelle d’un bove,
1 piagge: “terreni in pendenza”.
2 da tutte le bande: “da tutti i lati”.
3 nel duro dell’ilice negra: “nella parte più dura (cioè più interna) del leccio (ilice)”.
4 Le scrofe sono quindi seicento.
5 scemare: “diminuire”.
6 i seminumi Proci: l’epiteto seminumi era tradizionalmente utilizzato per i re e per i principi. Essendo i Proci i signori delle isole attorno a Itaca, l’epiteto si addice anche a loro.
7 ciacchi: “maiali”.
e ne foggiava ai suoi piedi calzari. Erano iti i garzoni,
25 tre dietro i porci, chi qua, chi là, per il pascolo, al prato; il quarto, Eumeo l’aveva mandato in città, che recasse ai prepotenti Proci, che a ciò l’astringevano,8 un ciacco, per immolarlo ai Numi, per farne satolle9 di carne.
Immantinente10 i cani latratori videro Ulisse,
30 e con grandi urli addosso gli corsero; e subito Ulisse prudentemente sedè, lasciò andar dalle mani il bastone. Pure, qui, presso alle stesse sue stalle, ne andava malconcio,11 se non correva a cacciarli con rapidi passi il porcaro, che lasciò andare il suo cuoio, si precipitò su la porta,
35 e con grandi urli, con una gragnuola di pietre,12 i mastini sperse, chi qua, chi là. Poi, volto al Signore, gli disse: «Povero vecchio, per poco non t’hanno sbranato i mastini, all’improvviso! E avuto davvero ne avrei gran rimorso: e già cordogli e pene mi danno abbastanza i Celesti,
40 che me ne sto qui doglioso, piangendo il mio re semidio, ed allevare i porci mi tocca, ingrassarli per gli altri, che me li mangino; e quello fors’anche patisce la fame, ramingo13 se ne va fra genti e città forestiere, se pure è vivo ancora, se vede la luce del sole!
45 Seguimi, adesso, entriamo nella mia capanna, buon vecchio, sì che ti possa anche tu saziare di cibo e di vino, e poi mi dica donde sei giunto, e che pene hai sofferto».
Nella capanna, dicendo così, lo condusse il porcaro. Sopra la terra ammucchiò gran copia di frasche, 50 vi stese la pelle d’un villoso caprone selvatico, folta, grande, che bene potesse sdraiarsi, e lo fece sedere. De l’accoglienza Ulisse fu lieto, e tai detti gli volse: «Ospite, Giove e tutti ti diano gli altri Celesti
8 l’astringevano: “lo costringevano”.
9 per farne satolle: “per farne scorpacciate”.
10 Immantinente: “subito”.
11 ne andava malconcio: “gli sarebbe andata male”.
12 gragnuola: “grandine”. L’espressione significa che le pietre lanciate da Eumeo cadevano sui cani fitte come la grandine.
13 ramingo: “vagabondo”.
ciò che tu brami: ché fatta m’hai sì cordiale accoglienza!»
55 E di rimando, Eumeo porcaro, così tu dicevi: «Ospite, anche se un uomo di te più meschino giungesse, io non saprei fargli sgarbo: ché gli ospiti, i poveri, tutti li manda Giove. Certo, dovrai contentarti. Ben poco è ciò ch’io posso darti, che questa è la sorte dei servi:
60 trepidar sempre, quando comandano i nuovi padroni. Poi che ai Celesti piacque frodar del ritorno14 il mio sire, che mi voleva bene davvero, che dato m’avrebbe certo podere, casa, corredo, e una sposa di garbo, come il signor liberale suol dare al suo servo, che molto
65 sudi al lavoro, e un Dio gli arrida al lavoro ch’ei compie, come sorride a questo ch’io compio. Oh!, se fosse invecchiato qui, tali doni avrebbe largito a me pure, il mio sire.
Invece è morto! Così fosse d’Elena morta la razza, da cima a fondo, che fece procombere15 tanti guerrieri!
70 Ché Ulisse anch’egli andò, per l’onor d’Agamennone, ad Ilio, alla città dei veloci puledri, a pugnar coi Troiani».
Detto così, con la cinghia si strinse la tunica ai fianchi,16 e si diresse a le stalle, dov’erano chiuse le mandre dei porcellini; e due di lì fuor ne trasse, li uccise,
75 li rosolò, li squartò, i quarti17 infilò negli spiedi; e quando furon cotti, presentò la carne ad Ulisse, calda, infilata agli spiedi, cosparsa di bianca farina.
[78-108] Eumeo invita Ulisse a cibarsi della carne dei porcellini e si giustifica perché non può offrire all’ospite quella più pregiata dei maiali adulti: questa infatti è destinata ai Proci, che senza pudore la pretendono ogni giorno. Il porcaro parla con grande rassegnazione all’ospite di questa situazione, poiché sa bene di non poter far nulla per cambiarla.
14 frodar del ritorno: “privare del ritorno con l’inganno” (frode).
15 procombere: “soccombere”, “morire”. Eumeo maledice Elena e la sua stirpe, poiché fu causa della guerra di Troia e quindi anche del mancato ritorno di Ulisse in patria.
16 Per essere più libero nei movimenti.
17 i quarti: l’espressione non ha alcun valore matematico; intende piuttosto indicare le parti in cui l’animale viene diviso o, meglio, squartato (s-quartato), cioè “diviso in quarti”.
La fedeltà al padrone disperso
Così parlava. E Ulisse cibava le carni, beveva
110 avidamente, muto, pensando al malanno dei Proci. Quando ebbe poi mangiato, placata la brama del cibo, Eumeo colmò di vino la coppa dov’egli beveva, e gliela porse colma. Godendo nell’anima, Ulisse la ricevè, gli parlò con queste veloci parole:
115 «Caro, e chi dunque è mai quest’uomo sì ricco e possente, come tu dici, che t’ha comperato per servo?18 Tu dici ch’egli la morte incontrò per l’onor d’Agamennone. Oh!, dimmi, dimmi com’era, se a caso ne avessi uno simil veduto.
Sùbito te lo direi: per Giove lo giuro, pei Numi
120 quanti han dimora in cielo. Ché molto pel mondo ho vagato».
E dei porcari il capo rispose con queste parole: «Niuno che giunga errabondo convincer saprebbe, buon vecchio, né la sua sposa, né il figlio, l’arrivo annunciando d’Ulisse;19 ché della buona accoglienza profittano tutti; ma poi
125 spaccian menzogne a vuoto, non dicono nulla di vero. Qualsiasi peregrino che al popolo d’Itaca giunga, va dalla nostra regina, si mette a spacciare fandonie.
Quella feste gli fa, lo carezza, e dimanda, e dimanda; e tra i singhiozzi giù le cadono lagrime fitte,
130 come s’addice a una sposa, se lungi le muore lo sposo. Buon vecchio, ed anche tu sapresti, se alcuno ti desse tunica, o veste o manto, ben presto inventar qualche ciancia. Ma cani intanto e uccelli veloci saranno in procinto già di sbranar dall’ossa la pelle d’Ulisse ch’è spento,
135 o l’hanno i pesci già divorato nel pelago; e l’ossa giacciono sopra la spiaggia, sepolte in un mucchio di sabbia. Questa la fine sua sarà stata. E in gran lutto ha gittato tutti gli amici, e me per primo, ché un altro signore più non lo trovo, dovunque mi volga, più buono d’Ulisse,
18 Ulisse con questa domanda vuole mettere alla prova Eumeo, per vedere se i suoi sentimenti nei confronti del padrone sono autentici.
19 Niuno che giunga … d’Ulisse. Da ordinare così: niuno che giunga errabondo annunciando l’arrivo d’Ulisse saprebbe convincer né la sua sposa, né il figlio.
140 neppur se ritornare potessi a mio padre, a mia madre, alla mia casa, dove son nato e cresciuto fanciullo; neppur di loro tanto mi dolgo, sebbene pur bramo di rivederli, di fare ritorno alla patria mia terra, ma mi distrugge il dolore d’Ulisse lontano. O buon vecchio,
145 sebbene ei non sia qui, mi perito pur di nomarlo:20 tanto ei m’amava, tanto di me si dava pensiero; e non padrone:21 fratello, sebbene sia lungi, lo invoco».
E gli rispose Ulisse tenace divino tai detti: «O mio caro, giacché non fai che negare, ed affermi
150 ch’egli non tornerà, giacché tanto incredulo sei, io non ti voglio annunziare soltanto, ma voglio giurarti che Ulisse tornerà; né prima dimando il compenso,22 ma solamente quando egli sarà tornato alla patria; prima, sebbene il bisogno mi prema, non voglio accettarlo.
155 Ché m’è come la porta d’Averno odioso quell’uomo che, da miseria astretto, s’induce a spacciare menzogne. Sappiano Giove, ch’è primo fra i Numi, e la mensa ospitale, e il focolare, dov’io son giunto, del nobile Ulisse, che tutto quanto sarà compiuto come ora t’annunzio:
160 dentro quest’anno stesso vedrete qui giungere Ulisse».
E rispondevi, Eumeo porcaro, con queste parole: «Non io dovrò pagarti, buon vecchio, codesto compenso, né tornerà più mai Ulisse alla patria. Ma bevi pure tranquillo, e ad altro volgiamo la mente; e tal doglia
165 non richiamarmi al pensiero, ché il cuore mi duole nel petto, quando qualcuno fa menzione del caro signore.
Il giuramento lasciamolo stare. Ed Ulisse ritorni come n’ho brama io, Penelope, il vecchio Laerte ed il figliuolo divino d’Ulisse, Telemaco. Intanto
170 per questo m’affliggo io: per Telemaco ho cruccio perenne,
20 mi perito pur di nomarlo: “ho tuttavia soggezione a nominarlo”. Il rispetto e la devozione di Eumeo per il padrone sono così grandi che ha perfino timore a pronunciare il suo nome.
21 Padrone, come anche il successivo fratello, sono complementi predicativi dell’oggetto del verbo invoco.
22 Il compenso era la ricompensa prevista quando si avverava una predizione, un giuramento.
ch’era cresciuto, mercé dei Superi, come un virgulto, ed io simile al padre speravo che crescer dovesse, tale apparir fra le genti, di forme e d’aspetto ammirando; ed ora, invece, quale non so dei mortali o dei Numi
175 gli abbia sconvolta la mente, ché nuove a cercare del padre è andato a Pilo santa. Ma intanto i magnifici Proci tesa un’insidia gli hanno per quando ritorna, ché spento vogliono lungi d’Itaca il germe d’Arcisio divino.23 Ma pure lui, dobbiamo lasciarlo al suo fato, o sia preso,
180 o sfugga, e sopra lui protenda la mano il Cronide».
La falsa storia del mendicante
[181-355] Come prevede il rituale dell’ospitalità, Eumeo, dopo aver rifocillato abbondantemente il proprio ospite, gli chiede di presentarsi, ma il prudente Ulisse inventa una storia falsa. Dice di essere figlio di una schiava e di un ricco cretese, di essere sempre stato un ottimo guerriero, tanto da esser stato scelto per combattere nella guerra di Troia al fianco di Idomeneo, il re di Creta. Racconta che, tornato a casa dalla lunga guerra, decise di ripartire subito per l’Egitto con alcuni suoi compagni. Questi però, anziché esplorare il territorio, così come egli aveva loro ordinato, lo saccheggiarono e per questo vennero poi uccisi dagli abitanti; egli, tuttavia, riuscì a salvarsi presentandosi disarmato e come supplice al cospetto del re. Rimase lì otto anni, accumulando tesori, finché giunse un uomo fenicio che gli promise di portarlo via con sé nella sua ricca casa; ma questo si rivelò essere un inganno: egli in realtà voleva solo appropriarsi dei suoi tesori e poi venderlo ai pirati. Ma Giove, pur di salvare lo straniero, suscitò una terribile tempesta che rovesciò la nave fenicia. Le onde spinsero l’uomo nella terra dei Tesproti. Qui venne accolto benignamente dal re e – continua il mendicante – sentì parlare di Ulisse, che in quel momento era a consultare l’oracolo di Dodona, per scoprire se per lui fosse previsto il ritorno a Itaca oppure no. Poco dopo il re gli concedette di tornare a casa su una nave, ma le persone dell’equipaggio lo aggredirono, ed egli si salvò con l’aiuto degli dèi gettandosi in mare a nuoto. Così il mendicante dice di essere giunto fino alla capanna di Eumeo.
23 germe d’Arcisio divino: Arcisio è il bisnonno di Telemaco, essendo padre di Laerte; è detto divino perché è figlio di Giove. Germe (letteralmente “germoglio”) significa qui “discendenza”.
Eumeo è incredulo
E a lui, porcaro Eumeo, rispondevi con queste parole: «O sventurato straniero, m’hai l’anima proprio commossa, tutte le tue sofferenze narrandomi e tutti gli errori.
Ma farmi non saprai convinto che il vero tu dici,
360 quando tu parli d’Ulisse. Perché senza scopo un tuo pari deve spacciare menzogne? Ben so ciò che credere io devo quanto al ritorno d’Ulisse, che odiarono tutti i Celesti, perché quando tesseva la guerra nol vollero morto fra le troiane schiere, sepolto da mano d’amici.
365 Tutti gli Achivi allora gli avrebbero alzata una tomba, ed alta gloria avrebbe per sé, per suo figlio raccolta.
Invece senza onore via l’hanno rapito le Arpie. Ed io vivo in disparte, dei porci a custodia; né mai vado in città, se non quando, se capita a caso un messaggio,
370 qui mi manda a cercare Penelope piena di senno.
Tutti mi vengono allora d’intorno, e mi volgon dimande, quei che si crucciano il cuore pel re che da tanto è lontano, e quei che ne son lieti,24 che a ufo25 ne mangiano i beni.
Ma io non voglio più dimandare né chieder notizie,
375 dal dì che un uomo giunse d’Etolia a narrarmi fandonie: che, avendo ucciso un uomo, vagato per tanti paesi, giunse alla mia capanna, dove io con amore l’accolsi.
A Creta, ei mi narrò, veduto l’aveano, che presso Idomeneo riparava le navi malconce dal mare; 380 ed in estate, disse, tornato sarebbe o in autunno, coi suoi compagni forti, recando gran copia di beni.26
Misero vecchio, ma tu, perché t’ha qui un demone addotto, non compiacermi con false parole, non farmi lusinga;27
24 quei che si crucciano … e quei che ne son lieti: sono due espressioni correlate, che indicano rispettivamente i servi fedeli e gli amici di Ulisse (quei che si crucciano) e i Proci (quei che ne son lieti).
25 a ufo: “a sbafo”, “a spese degli altri”.
26 Non si sa con esattezza chi sia quest’uomo bugiardo giunto dall’Etolia (una regione della Grecia centrale) che annunciava come imminente il ritorno di Ulisse. Tuttavia è chiaro il senso della battuta di Eumeo, che ormai non si illude più quando sente uno sconosciuto predire l’arrivo del padrone.
27 Non farmi lusinga: “non cercare di allettarmi, di conquistarmi”.
che io non già per questo t’avrò né riguardo né amore, 385 ma per pietà di te, per rispetto di Giove ospitale».
E a lui così rispose l’accorto pensiero d’Ulisse: «Davvero, un cuore alberghi nel seno che troppo diffida,28 quando neppur giurando potuto ho far sì che mi creda.
E allora, dunque, adesso stringiam questo patto; e ad entrambi
390 sian testimoni i Numi del Cielo, signori d’Olimpo. Se un giorno il signor tuo vedrai ritornare alla patria, mettimi indosso, ch’io mi vesta, una tunica o un manto, e mandami a Dulichio,29 dov’io sempre agogno tornare. Se poi non giunge, come t’ho detto, il tuo sire, ai famigli
395 ordine imparti che giù mi scaglin da un erto macigno,30 perché qualche altro pitocco si astenga dal tesser menzogne».
[397-451] È l’ora di cena: tornano i compagni di Eumeo con i maiali e li chiudono nelle stalle per farli dormire. Eumeo decide di immolare un porcello per l’ospite straniero: la bestia viene uccisa, sgozzata e fatta a pezzi. Solo dopo aver pregato gli dèi che concedano il ritorno di Ulisse, la carne viene cotta sul fuoco e mangiata.
E sopraggiunse la notte deserta di luna, e pioveva senza posa, e spirava la furia di Zefiro, sempre d’acqua foriero.31 Ed Ulisse parlò, per provare il porcaro, 455 se si togliesse il gabbano32 per darglielo, oppure esortasse altri a far questo, perché di lui si prendea tanta cura: «Eumeo, tu, adesso, e gli altri compagni prestatemi orecchio: io voglio fare un voto,33 narrarvi una storia, ché il vino mi sprona a ciò, capitoso,34 che suole istigare il più savio
28 un cuore alberghi nel seno che troppo diffida. Da ordinare così: alberghi (“ospiti”) nel seno (“nel petto”) un cuore che troppo diffida.
29 Dulichio è un’isola non lontana da Itaca, probabilmente da identificarsi con la parte meridionale dell’attuale Cefalonia, alla quale lo straniero vuole approdare. Già i marinai della nave che in passato l’aggredirono gli avevano promesso che l’avrebbero condotto là.
30 da un erto macigno: “da una ripida rupe”.
31 foriero: “portatore”.
32 gabbano: “mantello”.
33 fare un voto: non tanto “fare una promessa”, ma “esprimere un desiderio”.
34 capitoso: “che dà alla testa” (al capo).
460 al canto, alle soavi risate, alla danza, e lo spinge a dir tali parole che meglio sarebbe tacere. Or che alle ciarle ho dato principio, non voglio troncarle. Deh! Se giovane io fossi, se fossi tuttora gagliardo come quel dì che sotto le mura di Troia un agguato
465 tendemmo ed eseguimmo! Ulisse ed il re Menelao erano guida, ed io, che seco mi vollero, terzo. E quando alla città giungemmo e all’eccelse sue mura, quivi dintorno alla rocca, qua e là per i fitti cespugli, tra la palude e le canne, stavam rannicchiati nell’armi.
470 E sopraggiunse, calata la bora, una notte di gelo triste: cadea la neve dal cielo, più dura che brina, gelida, e sovra gli scudi stendeva una crosta di ghiaccio. Gli altri compagni miei tutti avevano tuniche e manti e, con gli scudi coperte le spalle, dormivan tranquilli;
475 solo io fra tutti avevo lasciato nel campo il mantello, stolto, perché non pensavo che vincermi il gelo dovesse, e con lo scudo venni soltanto, e la bella cintura.
Ma quando al terzo fu la notte,35 e cadevano gli astri, Ulisse, ch’era a me vicino, col gomito urtai,
480 e gli parlai così, né quegli fu tardo ad udirmi:
“O di Laerte figlio, divino scaltrissimo Ulisse, tra poco io non sarò fra i vivi, ché il freddo mi abbatte, perché meco non ho mantello, ché un demone triste m’indusse a prender solo la tunica; ed or non c’è scampo”.
485 E allora Ulisse questo disegno formò nella mente, unico quale egli era nel dare consigli e alla pugna; e, con un fil di voce, mi volse così la parola: “Sta’ zitto ora, perché non t’oda verun degli Achivi”. Quindi la testa poggiò sul gomito, e prese a parlare:
490 “Datemi ascolto, amici, ché apparso m’è un sogno divino. Troppo ci siamo spinti lontan dalla nave. Qualcuno vada, e all’Atride Agamennone prence di popoli dica s’egli potesse qui più gente mandar dalle navi”.
Disse. E tosto s’alzò Toante d’Andrèmone figlio,
35 quando al terzo fu la notte: “quando ormai erano trascorsi i due terzi della notte”. L’espressione indica cioè le ore che precedono l’alba, quelle in cui il freddo si fa più pungente.
495 velocemente, e lungi gittato il purpureo manto, verso la nave affrettò la corsa; e nel manto36 di quello beatamente dormii, finché non apparve l’Aurora.
Deh, se giovine ancora fossi io, tal vigore, deh!, avessi!»
Eumeo porcaro, e a lui rispondesti con queste parole:
500 «Vecchio, il racconto che tu m’hai fatto, non merita biasmo, né solo un motto hai detto che impronto,37 che inutile fosse. Così per questa volta tu avrai da coprirti;38 e null’altro ti mancherà di quanto conviene apprestare a un tapino.
Però dimani all’alba dovrai rivestire i tuoi cenci,
505 ché non abbiamo qui né mantelli né tuniche tante da ricambiarli: ciascuno possiede la veste che indossa.
Ma quando giunga poi d’Ulisse il diletto figliuolo, egli dar ti potrà le vesti, la tunica, il manto, ed inviarti dove ti dice la brama del cuore».
510 Detto così, si levò, gli allestì vicino alla fiamma un letto, e lo coprì con pelli di pecore e capre.
E quando Ulisse fu sdraiato, un mantello pesante grande gli gittò sopra, che pronto tenea di ricambio, e l’indossava quando più crudo infierisse l’inverno.
[515-525] Ulisse e gli altri garzoni si mettono a dormire nella capanna, mentre Eumeo si incammina verso la stalla per riposare accanto ai suoi porci. Ulisse si addormenta ripensando alla fedeltà del porcaro, che dopo vent’anni di assenza del padrone non ha smesso di prendersi cura dei suoi beni.
36 Di solito i mantelli non avevano maniche, perciò erano spesso utilizzati come coperte. Erano comunemente di lana e di colore scuro (purpureo).
37 impronto: “inopportuno”, “inadatto”.
38 Eumeo capisce subito l’intento con cui lo straniero ha voluto raccontare l’episodio del mantello: non desiderava altro che procurarsene uno per quella notte.
Libro XV
Il ritorno di Telemaco
Il ritorno è deciso
Pallade Atena, frattanto,1 di Sparta a le belle contrade s’era recata, ché il vago2 figliuol del magnanimo Ulisse memore far del ritorno voleva, incitarlo a partire. E Telemaco e il figlio di Nestore fulgido 3 insieme
5 di Menelao glorïoso nell’atrio dormenti rinvenne. Anzi, di Nestore il figlio vinto era dal morbido sonno; ma non giaceva nel sonno Telemaco: in cuore gli stava fitto il pensiero del padre, che desto lo aveva tenuto tutta la notte. Atena vicina gli stette, e gli disse:
10 «Bene non fai, che tu erri, Telemaco, lungi alla patria, ed i tuoi beni tu lasci ad uomini tanto arroganti nella tua casa. Bada che tutti non debbano i beni tuoi divorare, spartirli, che vano per te non riesca questo viaggio».
[14-26] Minerva sprona Telemaco affinché solleciti Menelao a farlo ripartire. A casa, infatti, la madre Penelope è rimasta sola, ed è giunto il momento che il figlio ritorni per verificare se ella sia rimasta fedele a Ulisse, assente da tanti anni.
«Un’altra cosa ancora ti dico, e tu fanne tesoro.
I più valenti dei Proci ti stanno tendendo un’insidia nello stretto di mare fra Itaca e Same rocciosa, 30 per trucidarti, prima che tu sia tornato alla patria.4
Ma non potranno, credo io; dovrà pria la terra coprire
1 La narrazione del viaggio di Telemaco è stata sospesa alla fine del libro IV: il tempo dell’azione del giovane figlio di Ulisse è stato bloccato per poter narrare le vicende del padre. Adesso Omero riprende il racconto di Telemaco dal punto esatto in cui lo aveva abbandonato.
2 vago: “bello”.
3 il figlio di Nestore fulgido: è Pisistrato, che ha accompagnato Telemaco nel suo viaggio a Sparta.
4 Viene qui fatto riferimento all’imboscata che i Proci stanno preparando a Telemaco, il cui progetto è narrato al termine del libro IV
molti di questi Proci che vorano a te le sostanze.
Dunque, lontano tieni dall’isole il rapido legno, naviga solo di notte, ché a tergo una prospera brezza
35 uno ti manderà dei Numi, che veglia a salvarti.
Ma come prima ad un lembo tu d’Itaca giunto sarai, alla città rimanda la nave con tutti i compagni, e tu recati, prima di tutto, al fedele porcaro,5 che custodisce le greggi dei porci, e che t’ama di cuore.
40 Quivi trascorri la notte; poi fa’ che il porcaro s’affretti alla città, per recare la nuova6 a Penelope scaltra, che tu sei sano e salvo, che sei ritornato da Pilo».
Detto così, la Diva partì per le cime d’Olimpo; ed ei, dal dolce sonno riscosse di Nestore il figlio,
45 scotendolo col piede; poi queste parole gli disse: «Figlio di Nestore, su, Pisistrato, destati, al carro guida ed aggioga i cavalli, per metterci tosto in cammino».
E Pisistrato, figlio di Nestore, questo rispose: «Possibile non è, per quanto la brama c’incalzi,
50 spingere un cocchio tra il buio notturno. Sarà presto l’alba.
Stiamo, sinché Menelao, l’insigne figliuolo d’Atreo, giunga, e i doni ospitali ci rechi, e li ponga sul cocchio, e, favellando parole soavi, il congedo ci dia.
Chi l’ospitalità riceve, per tutta la vita
55 l’uomo ricorda che a lui l’offerse con cuore amoroso».
[56-156] Appena spunta l’alba, Telemaco si reca dal sovrano Menelao e gli comunica il suo desiderio di rimettersi in viaggio. Menelao accoglie la richiesta del giovane ospite e fa preparare un lauto banchetto per congedarsi degnamente dal figlio di Ulisse. Durante il pranzo il re di Sparta dona a Telemaco un cratere d’argento; la moglie Elena non è da meno, e offre in dono all’ospite uno splendido peplo. Pisistrato raccoglie tutti i doni e li ripone in una cesta appositamente sistemata sul carro. Al termine del banchetto avvengono gli
5 Il fedele porcaro è Eumeo, il guardiano degli animali della famiglia di Ulisse.
6 la nuova: “la notizia”. Si pensi ad esempio al possibile doppio significato del termine inglese new
ultimi saluti: Menelao in particolare chiede che gli venga salutato caramente il saggio Nestore, padre di Pisistrato e suo compagno durante la guerra di Troia. Telemaco a sua volta saluta il re di Sparta, senza nascondergli che egli ormai ha smesso di sperare nel ritorno di suo padre.
Detto ebbe appena, e a destra, nell’etere, un’aquila apparve,7 che fra gli artigli un’oca stringeva d’immane grossezza, via dalla corte8 ghermita; seguivan con alti clamori
160 uomini e donne. E quella, poiché giunse ad essi vicina, a destra si lanciò, dinanzi ai corsieri.9 A tal vista, lieti fûr quelli, il cuore brillò nel petto a ciascuno; e Pisistrato, il figlio di Nestore, prese a parlare: «Spiegaci, Menelao, divino pastore di genti,
165 se per te manda oppure per noi tal miracolo il Nume». Disse; e la mente allora raccolse a pensar Menelao, per dare ad essi, dopo pensato, un’acconcia10 risposta. Elena bella però lo prevenne con queste parole: «Datemi ascolto, ed io l’evento dirò che i Celesti
170 gittano in cuore a me, come io credo che compiersi debba. Come quest’aquila, giunta dal monte ov’ha il nido e la stirpe, quest’oca entro la casa nutrita ghermì, parimenti, dopo i travagli, e il lungo vagare sul pelago, Ulisse in patria tornerà, vendetta farà. Forse è giunto
175 mentre favello, e già pianta seme di danno pei Proci».
E le rispose queste parole Telemaco scaltro: «Deh!, così voglia d’Era lo sposo, il tonante Cronide!
A te come ad un Nume allor leverei la preghiera!».
Disse: e la sferza vibrò su la groppa ai cavalli veloci.
7 Vedere un’aquila apparire da destra era segno di buon augurio, ragion per cui tutti subito se ne rallegrano. Un dio ha dunque mandato una profezia favorevole, ma il segnale divino ha ancora bisogno di essere interpretato: chi riguarda anzitutto? Telemaco? Menelao? E cosa viene augurato? Pisistrato allora si rivolge a Menelao, affinché possa chiarire la volontà del nume.
8 corte: “cortile”.
9 I corsieri sono i cavalli utilizzati per spingere il carro, i cavalli da viaggio, da corsa.
10 acconcia: “ben fatta”, “ben pensata”, “adeguata”.
Alla volta di Itaca
180 Traverso alla città, verso i campi, si spinsero quelli, e da mattina a sera scuoterono il giogo a galoppo. Il sole tramontò, s’ombravano tutte le strade, quando giunsero a Fere,11 di Diocle innanzi alla casa, figlio d’Orsiloco, a cui fu padre l’Alfeo.12 Qui la notte 185 trascorsero; ed a loro die’ Diocle doni ospitali. Come l’Aurora apparì mattiniera, ch’à dita di rose, stretti i corsieri al giogo, balzaron sul cocchio dipinto, fuor dalla porta li spinser, dal portico tutto sonoro;13 quindi le sferze sui dorsi vibrarono; e corsero quelli.
190 Subito quindi alla rocca pervennero eccelsa di Pilo; e Telemaco allora si volse di Nestore al figlio: «Figlio di Nestore, puoi promettermi quello ch’io chiedo, e mantenerlo? Noi rende ospiti già da gran tempo l’amor che i nostri padri stringeva. Siam pari negli anni; 195 questo viaggio stringe più ancora la nostra concordia. Non mi condurre lontano dal mare, ma lasciami, o caro, nel porto qui, ché tuo padre, per darmi ancor prove d’affetto, mi tratterrebbe ancora. Ma d’uopo è14 che invece io m’affretti».
[199-213] Pisistrato vuole aiutare l’amico, ma teme che il padre Nestore possa giudicare inopportuna una così rapida ripartenza, e che possa pertanto venire di persona a cercare l’ospite Telemaco e ricondurlo in città a riposarsi. Consiglia allora all’amico di non perdere tempo, ma di mettere in mare la nave prima che egli sia giunto presso il padre.
Ed esortando i compagni, così Telemaco disse:
215 «Apparecchiate, compagni, gli attrezzi del nero naviglio, ed ascendiamo noi stessi la nave, per metterci in via».
Disse; ascoltarono quelli, né furono tardi a obbedire.
E ne la nave subito ascesi, sedettero ai banchi.
Questo faceva. Ed alzava preghiere Telemaco, e offriva
11 Anche nel viaggio di andata Telemaco e Pisistrato avevano sostato a Fere, presso Diocle.
12 L’Alfeo è il fiume più importante del Peloponneso.
13 sonoro: “rumoroso”; il portico risuonava delle voci e dei rumori della gente lì radunata.
14 d’uopo è: “è necessario”.
220 un sacrificio ad Atena, vicino alla poppa. Ed un uomo giunse a lui presso, straniero, che d’Argo giungeva fuggiasco, che aveva ucciso un uomo.15
[222-253] L’uomo che si avvicina è Teoclimeno, indovino, nipote a sua volta di un altro indovino, Melampo. La sua famiglia era caduta in disgrazia a Pilo, e per questo motivo egli cercava di fuggire.
Il nome era Tëoclimèno. Ristette vicino all’eroe
255 che presso al negro suo naviglio libava e pregava, ed a parlare prese con queste veloci parole: «Caro, che in questa terra sacrifichi ai Numi, ti prego pei sacrifici, pel demone, al quale tu li offri, ed insieme per il tuo capo stesso, pei tuoi compagni, tu dimmi
260 la verità ch’io ti chiedo, non farmi segreto di nulla.
Chi sei? Di dove giungi? Qual è la tua patria e i parenti?»16
A lui queste parole rispose Telemaco scaltro: «Senza verun inganno risponderti voglio, straniero.
D’Itaca è la mia stirpe; Ulisse è mio padre, se dire
265 non debbo fu:17 ché ora trovò lagrimevole fine.
Perciò, raccolti questi compagni, sul negro naviglio mossi a cercar notizie del padre che manca da tanto».
Tëoclimeno, mente divina, così gli rispose:
«Anch’io son dalla patria lontano, ché un uomo vi uccisi
270 della mia stirpe; e molti gli restano amici e parenti in Argo, di cavalli nutrice, ed è grande lor possa.18
Per ischivare dunque la truce vendetta e la morte, fuggo, ch’è omai destino per me gir19 fra gli uomini errando.
Or nella nave, poiché fuggiasco io t’imploro, m’accogli,
15 Chi commetteva un omicidio, volontariamente o involontariamente, doveva pagare una forte somma di denaro ai parenti dell’ucciso, oppure lasciare la patria e non farvi mai più ritorno.
16 Teoclimeno non rivolge queste domande a Telemaco per curiosità o come forma di cortesia, ma lo fa per interesse vitale: egli infatti sta cercando un luogo sicuro dove evitare la vendetta dei parenti dell’ucciso, e deve pertanto sapere se la nave di Telemaco farà vela verso un luogo a lui ostile o disposto ad accoglierlo.
17 Telemaco corregge il tempo verbale della sua affermazione, preso dal sospetto che il padre possa essere ormai defunto.
18 possa: “potenza”, “forza”.
19 gir: “andare”.
275 ché non m’uccidano: mossi già sono, io mi credo, a inseguirmi».
E a lui queste parole rispose Telemaco scaltro: «Davvero a mal tuo grado20 scacciar non ti vo’ dalla nave.
Seguimi: larghi qui ti saremo di quello che abbiamo».
Disse; e la lancia di bronzo che l’altro porgevagli, prese,
280 e la poggiò sovressa la tolda21 del curvo naviglio.
Quindi egli stesso ascese la nave del mar viatrice, ed alla poppa quivi si pose a sedere; e a sé presso Tëoclimeno; e i compagni disciolser da poppa le funi.
Poi di por mano agli attrezzi Telemaco impose ai compagni, 285 senza più indugio, né quelli fûr tardi a seguire il comando: alto d’abete il tronco levâr, nell’incasso rotondo lo conficcarono, poi lo legaron con gomene ai bordi, issarono con guigge di cuoio le candide vele.
Ed una prospera brezza spirò l’occhicerula Atena,
290 gagliardamente spirando traverso l’aria, ché presto correr potesse la nave sui vortici salsi22 del mare.
Il Sole tramontò, s’ombrarono tutte le strade; e verso Fea la nave, sospinta dal soffio di Giove, e lungo l’Elide, ove hanno potere gli Epèi, fece vela.
295 Vêr l’isole rocciose23 di qui poi diresse la rotta, modo cercando come schivasse l’insidia di morte.24
Ulisse e Eumeo
Nella capanna, Ulisse, frattanto,25 e l’onesto porcaro cenarono; e con essi cenarono gli altri pastori. E poi che fu placata la brama di cibo e di vino,
20 a mal tuo grado: “contro la tua volontà”.
21 La tolda è il ponte della nave; il tronco (v. 286) ne è l’albero, mentre le guigge (v. 288) sono delle strisce di cuoio particolarmente resistenti, usate per legare le vele all’albero.
22 salsi: “salati”.
23 Le isole rocciose verso cui la nave di Telemaco fa rotta sono Itaca e Cefalonia.
24 L’insidia mortale a cui si fa riferimento è la trappola preparata dai Proci per il giovane figlio di Ulisse.
25 Nuovamente il “regista” Omero sposta la sua telecamera e torna a inquadrare Ulisse, che aveva lasciato al termine del libro precedente. Vi è però un salto cronologico, seppur breve. Avevamo lasciato Ulisse mentre si stava coricando per la notte; lo ritroviamo ora pronto per la cena: sono dunque trascorse la notte intera e la giornata successiva.
300 prese a parlare Ulisse, per mettere a prova il porcaro, se veramente lo amasse, se qui lo invitasse a restare entro la stalla, o se la città lo esortasse a cercare: «Odimi, – disse – Eumeo, voi datemi ascolto, o compagni: alla città dimani desidero all’alba recarmi,
305 per mendicare, e gravezza non dare né a te, né agli amici. Or tu dammi un consiglio, dammi anche un compagno sicuro, che mi conduca quivi; poi, giunto ch’io sia, da me stesso attorno andrò cercando chi m’offra un tozzo, un bicchiere, come vuol la mia sorte. Poi, giunto alla casa d’Ulisse,
310 recar vorrei le mie notizie a Penelope scaltra, e mescolarmi coi Proci superbi, tentare se il vitto essi volessero darmi, ch’àn tante e poi tante sostanze, ed io potrei fra loro prestare qualsiasi servigio.
Dir te lo voglio, e dammi tu ascolto, ed intendimi bene:
315 mercé del Nume Ermete,26 che guida gli spiriti all’Ade, che grazia spande e fama su l’opre degli uomini tutti, niuno con me gareggiare saprebbe nel render servigi, fendere l’aride legne, disporle a catasta sul fuoco, fare le parti, arrostire le carni, mescere il vino:
320 tutto ciò per cui serve la gente da meno ai signori».27
E tu, porcaro Eumeo, crucciato così rispondevi: «Oh!, poveretti noi, come mai t’è venuto pel capo questo pensiero? Davvero tu vuoi trovar qui la tua morte. Davvero tu ti vuoi cacciar nella turba dei Proci,
325 la cui superbia, la cui tracotanza pervengono al cielo? No, davvero, che a te non somigliano i loro valletti! Giovani sono, vestiti di manti e di tuniche belle, nitidi sempre, e molli le chiome ed i volti vezzosi hanno i valletti loro. Le tavole ben levigate
330 sono ricolme sempre di pane, di carne, di vino. Via, resta qui: la tua presenza a nessuno dà peso, non a me, né a veruno di quanti compagni son meco.
26 mercé del Nume Ermete: “con il favore di Mercurio”. Il dio era anche il protettore delle attività più umili, quali quelle che elenca Ulisse: spaccare la legna, arrostire le carni, versare il vino.
27 tutto ciò per cui serve la gente da meno ai signori: “tutti lavori per i quali i poveri si rivelano utili ai ricchi”.
Quando sarà poi giunto d’Ulisse il figliuolo diletto, egli ti donerà mantello tunica e veste, 335 e ti farà condurre dove tu desideri e brami».
E Ulisse, eroe tenace divino, così gli rispose: «Al padre Giove, Eumeo, deh!, caro così tu divenga, come a me sei, ché fine ponesti alla misera doglia dell’errar mio,28 ché male peggiore non v’ha pei mortali.
340 Ma pel dannato ventre patiscono crucci crudeli gli uomini, quando li opprime la pena, il cordoglio e l’esilio.
Ora, se qui mi trattieni, se vuoi ch’io Telemaco attenda, dimmi, su via, della madre d’Ulisse divino e del padre, ch’era, quando egli partì, sul limite già di vecchiaia, 345 se sono ancora in vita, se vedono i raggi del Sole, o se son morti già, se son nelle case d’Averno».
Ed il capoccia porcaro rispose con queste parole:
«O stranïero, il vero vo’ dirti, non dirti menzogna. Vive Laerte ancora, ma implora dì e notte il Cronide, 350 che gli tolga la vita, lo faccia morir nel suo letto: tanto dolore l’opprime del caro suo figlio lontano, e della morta sposa fedel,29 che, morendo in gran doglia, l’abbandonò, più grave gli rese la mora degli anni.30
Essa morì per la pena del caro figliuolo perduto, 355 di miserevole morte, quale mai non debba colpire chi come amico qui dimora, ed ha tratto d’amico.31
Dunque, sin ch’ella era in vita, sebbene mai sempre cruciata, erami grato a lei rivolger parole e dimande, ch’ella m’aveva nutrito insieme con Ctìmene bella,32
28 Ulisse pronuncia queste parole con estrema commozione e verità: il suo errare è finito. Eumeo non può capire a che cosa realmente si stia riferendo il suo ospite, ma le parole di quest’ultimo non lo sorprendono: l’uomo che ha di fronte, egli crede, è pur sempre un mendicante che ha vagato a lungo.
29 La morta sposa fedel è Anticlea, madre di Ulisse e moglie di Laerte; l’eroe è già informato della sua morte, avendola incontrata nell’Ade (libro XI).
30 la mora degli anni: “il peso degli anni”. Letteralmente significherebbe “l’indugio degli anni”, cioè il loro non voler trascorrere. Gli anni trascorsi senza il figlio sono stati per Anticlea lunghi e dolorosi, e l’hanno lentamente trascinata alla morte.
31 ha tratto d’amico: “si comporta come un amico”, “agisce da amico”.
32 Ctimene è la sorella minore di Ulisse.
360 la sua più tenera figlia, la prode fanciulla elegante. Con quella io crebbi, e quasi del pari ci amava. Ma quando di giovinezza entrambi giungemmo agli amabili giorni, a Same ella andò sposa, ché n’ebbero innumeri doni; a me la mia regina die’ tunica veste e mantello,
365 ch’io mi coprissi bene, calzari mi die’ con le guigge, e in questo campo mi fe’ soggiornare; e m’amava di cuore. Nulla di tutto ciò mi resta. Ma i Numi anche adesso fanno che prosperi e cresca qualunque lavoro ch’io faccia.33 Cibo e bevanda io per me ne traggo, e per gli ospiti degni.
370 E di Penelope mai non odo la voce soave, né so che cosa faccia, ché un grave malanno è piombato di tracotante gente sovressa la casa; ed i servi bramano invece udire, parlar con la loro signora, bramano il pane, il vino, ricevere qualche regalo
375 che i servi allegra, quando portar se lo possono ai campi».
[376-491] Ulisse conosce bene Eumeo, ma continua a recitare la parte del forestiero. Gli domanda allora di raccontargli con maggiori dettagli la sua storia. Il guardiano dei porci non si fa pregare. Figlio di un ricco signore, Eumeo nacque sull’isola Siria. La sua levatrice era una donna fenicia, originaria di Sidone. Un giorno giunsero sull’isola dei mercanti fenici, i quali conobbero la donna e le offrirono di rapirla per riportarla in patria. La donna, invaghitasi di uno dei mercanti, non solo accettò l’offerta, ma volle in qualche modo contraccambiare il favore che avrebbe ricevuto: decise allora di rapire il piccolo Eumeo, cosicché i mercanti, giunti a Sidone, potessero chiedere al padre un ricco riscatto. Tuttavia la nave non giunse mai in patria: la dea Artemide la fece naufragare, e i flutti del mare risparmiarono solo il piccolo. Eumeo venne spinto dalle onde verso Itaca, dove fu trovato e venduto come schiavo. Malgrado ciò il suo nuovo padrone, Laerte, seppe vedere in lui un figlio prima ancora che un servo.
33 Eumeo ha visto morire la padrona Anticlea, vede Laerte sofferente, la casa e la sposa di Ulisse insidiate, ma può provare ugualmente pace. Gli dèi infatti non l’hanno abbandonato, e di ciò è segno sicuro il fatto che nulla gli manchi. L’abbondanza di cibo, la buona produzione dei campi e del bestiame erano salutati dai Greci come segno certissimo del favore degli dèi, come conferma benevola di una vita giusta, di un agire adeguato.
L’arrivo di Telemaco
Di Telemaco intanto i compagni sciolser le vele, abbassarono l’albero,34 ch’erano al lido, e, scesi dalla nave sovressa la spiaggia del mare, apparecchiarono il pasto, mescerono il fulgido vino.
495 E poi ch’ebber placata la brama del cibo e del vino, queste parole ad essi rivolse Telemaco scaltro: «Voi verso la città spingete ora il negro naviglio; io verso la campagna mi reco a vedere i pastori. Visti i poderi, in città tornerò verso sera; e dimani
500 mattina vi darò compenso del vostro viaggio: di carni un buon banchetto, di vini soavi al palato».
Tëoclimeno, stirpe divina, così gli rispose: «Ove andrò io, figlio mio? Dovrò forse bussare alla casa di alcun di quelli ch’ànno potere in Itaca alpestre?35
505 Oppur direttamente cercar la tua reggia e tua madre?». E gli rispose queste parole Telemaco scaltro:
«In altri tempi, bene io ti direi di venire in mia casa, ché non avresti penuria36 di doni ospitali; ma ora peggio per te sarebbe, quando io non ci sono, e mia madre
510 non ti vedrebbe neppure, ché mai non si mostra fra i Proci; ma nelle stanze più alte vive ella, ed intesse una tela.
Ma un altro io ti dirò, da cui ti potresti recare: Eurimaco, il figliuolo brillante di Polibo accorto, ch’ora la gente d’Itaca ammira al pari d’un Nume.
515 Questi è il miglior di gran lunga fra i giovani tutti che sposa chiedon mia madre, e bramano avere lo scettro d’Ulisse.
Così potesse Giove Cronide che regna nell’etra37 pria delle nozze a loro foggiare l’estrema rovina!». Mentre così diceva, volò dalla destra un uccello, 520 uno sparviere, l’araldo38 veloce d’Apollo; e con l’unghie
34 Precedentemente è stato descritto il montaggio dell’albero, ora si accenna al suo smontaggio. Le navi greche, infatti, erano dotate di un albero estraibile, affinché i naviganti potessero valutare di volta in volta se navigare a vela o a remo.
35 alpestre: “montuosa”.
36 penuria: “mancanza”, “scarsezza”.
37 etra: “cielo”.
38 araldo: “messaggero”. Lo sparviero è araldo del dio, poiché ne reca il messaggio. Sarà poi
spennava una colomba ghermita; e lasciava le penne cadere al suolo, fra la nave e Telemaco. E allora Tëoclimeno via lo trasse, lontan dai compagni, forte gli strinse la mano, parlò, disse queste parole:
525 «Non senza un Dio, lo sparviere, Telemaco, è giunto da destra, ch’io con questi occhi ho veduto ch’egli era sparviere augurale. Stirpe veruna non c’è fra il popolo d’Itaca alpestre più della vostra regale: voi sempre sarete i più forti».
E a lui rispose queste parole Telemaco scaltro:
530 «Oh!, se potesser davvero, straniero, avverarsi i tuoi detti! L’affetto mio tu allora potresti provare, e i miei doni: tanti, che chi t’incontrasse dovrebbe chiamarti beato!»
Tali parole quindi rivolse al suo fido Pirèo: «Figlio di Clito, Pireo, che solito sei d’ascoltarmi
535 più dei compagni tutti che a Pilo son meco seguiti,39 dunque nella tua casa quest’ospite adesso conduci. Sin ch’io non giunga, onore tu fagli, tu abbine cura».
E gli rispose Pireo, di lancia gagliardo campione: «Fin che ti piace qui rimani, Telemaco; ed io 540 ospiterò quest’uomo, che nulla mancare gli debba».
Detto così, salì su la nave, fe’ cenno ai compagni che vi salissero anch’essi, sciogliesser le gomene. E quelli senza indugiar vi salirono, ai banchi sederono, ai remi.
I bei calzari allora Telemaco ai piedi si strinse,
545 e la gagliarda lancia, dal cuspide40 aguzzo di bronzo, via dalla tolda prese. E gli altri, le gomene sciolte,41 alla città, sul mare movendo, diressero il corso, come ordinato aveva Telemaco figlio d’Ulisse.
E questi, a piè movendo veloce, pervenne a la stalla
550 dove a migliaia42 i porci contava, e tra loro viveva onesto, e pien d’affetto pei proprî signori, il porcaro. compito dell’indovino tradurre tale messaggio agli uomini.
39 a Pilo son meco seguiti: “sono giunti con me a Pilo”, “mi hanno seguito a Pilo”.
40 cuspide: “punta”.
41 le gomene sciolte: “dopo aver sciolto, slegato le corde”.
42 La cifra non va interpretata in senso letterale: del resto il conto esatto era già stato fatto nel libro precedente. Omero vuol dire che i capi di bestiame di Eumeo sono moltissimi, più di quanti se ne possano immaginare, e pertanto prova a farlo capire tramite un’azzardata esagerazione.
Libro XVI
Telemaco riconosce il padre
Telemaco giunge alla capanna
Nella capanna Ulisse frattanto e l’onesto porcaro apparecchiaron l’asciolvere, e accesero il fuoco all’aurora, ed i custodi spedirono a pascer le mandre dei porci. Ed ecco i latratori mastini agitaron le code,
5 senza abbaiar: ché giungeva Telemaco. Ulisse ben vide scodinzolare i cani. E giunse un rumore di passi. E subito ad Eumeo rivolse veloci parole: «Eumeo, qualche compagno qui giunge di certo, o qualche altro che tu conosci bene, perché non abbaiano i cani,
10 bensì scuoton la coda; e sento un rumore di passi».1 Compiuta la parola non ebbe, che il figlio suo caro stette dinanzi alla porta. Balzò stupefatto il porcaro, e dalle mani gli caddero i vasi coi quali mesceva lo scintillante vino; incontro si fece al signore,
15 il capo gli baciò, entrambe le fulgide luci2, e l’una e l’altra mano, rigando di lagrime il viso. Come un tenero padre che accoglie amoroso un figliuolo che dopo il decimo anno da terra lontana ritorna, l’unico, l’ultimo nato, per cui tante doglie sofferse, 20 così stringeva il fido porcaro Telemaco allora fra le sue braccia, ché lo vedeva scampato da morte. E lo copria, singhiozzando, di baci, e così gli diceva: «Sei pur tornato, luce mia dolce, Telemaco! Quando per Pilo tu partisti, pensai di mai più rivederti!
25 Entra, su dunque, figliuolo mio caro, ché in cuore io m’allegri nel rivederti qui, giunto appena da terra lontana,
1 Ulisse sente un rumore di passi, ma è certo che si tratti di una persona amica: ha inteso ciò osservando i cani, i quali hanno iniziato a scodinzolare senza abbaiare, comportamento che suggerisce la visita di una persona conosciuta. Due semplici indizi, debitamente osservati, suggeriscono dunque a Ulisse come comportarsi.
2 fulgide luci: “brillanti occhi”.
ché tu non usi spesso venir tra i pastori pei campi, anzi vivi in città, che sembra al cuor tuo non ispiaccia3 sempre veder la turba, per quanto odïosa, dei Proci».
[30-88] Prima ancora di entrare nella capanna, Telemaco domanda a Eumeo come si sia comportata la madre Penelope in sua assenza, se sia rimasta fedele al marito disperso o se abbia accettato le lusinghe dei Proci. Rassicurato dal porcaro circa l’integrità della madre, il giovane varca la soglia dell’umile casa di Eumeo. Ulisse si alza per cedergli il posto, ma Eumeo lo blocca e provvede a procurare un altro seggio. Telemaco nota allora lo sconosciuto ospite e durante il pranzo chiede a Eumeo di presentarglielo. Questi racconta la storia del mercante cretese rapito dai Tesproti, la storia dietro cui Ulisse si nasconde, e affida l’ospite alle cure del giovane padrone. Telemaco è rammaricato di non poter ospitare lo straniero presso la propria casa, e descrive a Ulisse la situazione a palazzo e le insolenze dei Proci.
E a lui così rispose Ulisse tenace divino:
90 «O caro, se non è conteso che anch’io qui favelli,4 deh!, quanto cruccio, udendo le vostre parole, m’accora!
Quali misfatti, a quello che dite, commettono i Proci nella tua casa, facendo sopruso ad un giovin tuo pari!
Dimmi se tu di buon grado ti sei rassegnato, o se forse
95 t’odiano i cittadini per qualche presagio celeste, o se dei tuoi fratelli ti lagni, nei quali è pur forza fidar nella battaglia, se pure è tra voi gran contesa.5
Deh! se al pari di te fossi giovane, e questo mio cuore avessi, e il figlio fossi d’Ulisse, o il medesimo Ulisse, 100 vorrei farmi tagliare la testa da qualche nemico, se non sapessi a tutti tramare l’estrema rovina.
Ché se col numero poi dovesser me solo prostrare,6 preferirei trafitto procombere7 sotto il mio tetto, morto giacere, prima d’assistere a tanta vergogna».
3 ispiaccia: “dispiaccia”.
4 se non è conteso che anch’io qui favelli: “se non mi è proibito parlare”.
5 o se dei tuoi fratelli … gran contesa. Da ordinare così: o se ti lagni dei tuoi fratelli, nei quali è pur forza (“è necessario”) fidar nella battaglia, pure se tra voi è gran contesa.
6 Prostrare è qui sinonimo di “uccidere”.
7 procombere: “soccombere”.
[105-150] Telemaco non si è rassegnato a soccombere alla volontà dei Proci, ma nuovamente espone all’ospite la situazione difficile e delicata in cui si trova. Rassicurato l’ospite, impartisce ordini a Eumeo. Questi dovrà andare a palazzo e avvisare Penelope, lei soltanto, del ritorno del figlio: neppure Laerte, come invece vorrebbe Eumeo, dovrà saperlo. Terminato il proprio compito, Eumeo dovrà tornare di corsa alla capanna.
Disse ad Eumeo così. Prese questi i calzari, ai suoi piedi li strinse, alla città volse il passo. Né agli occhi d’Atena sfuggì, quando lasciò la capanna, il fedele porcaro.
Venne ivi presso la Dea. Sembrava all’aspetto una donna
155 alta, slanciata, bella, maestra d’egregi8 lavori.
Dinanzi alla capanna ristette, visibile a Ulisse.
Ma non la vide però Telemaco, pur non s’accorse: ché manifesti a tutti non sogliono i Numi apparire. Ma ben la vide Ulisse, la videro i cani; e, sgomenti, 160 senza abbaiar, mugolando, si sparser qua là per la stalla.
Essa fe’ cenno con gli occhi. Ulisse divino comprese, e uscì fuor da la stalla, lunghesso il gran muro di cinta, le stette innanzi. E queste parole a lui volse la Diva:
«O di Laerte figlio divino, scaltrissimo Ulisse, 165 parla a tuo figlio, oramai, non volergli più nulla tacere.
Ed alla vostra città bellissima andate, e tramate ai tracotanti9 Proci l’estrema rovina. Ed io stessa sarò da voi non lungi,10 ché brama ho pure io di pugnare».
Detto così, la Dea lo toccò con un’aurea verga.
170 Poscia un mantello bene lavato e una tunica bella su lui gittò, le membra gli rese più giovani e forti: bruna tornò la pelle, le grinze sparîr dalle guance, la barba attorno al mento divenne cerulea bruna.11
S’allontanò, ciò fatto, la Diva; ed Ulisse di nuovo
8 egregi: “splendidi”, “illustri”. Questo aggettivo deriva dal nome gregge, e indica originariamente l’animale scelto tra tutti quelli del gregge, il migliore. Egregio letteralmente significa “preso dal gregge”, “scelto”, “individuato come migliore”.
9 tracotanti: “superbi”, “insolenti”.
10 Ed io stessa sarò da voi non lungi: “ed io vi sarò vicino”. È una litote.
11 cerulea bruna: “nera con riflessi tanto lucenti da sembrare azzurrini”.
175 entrò nella capanna. Stupore percosse suo figlio, che un Nume lo credé, volse altrove, sgomento,12 lo sguardo; e a lui parlò, si volse col volo di queste parole: «Ben altro, ospite, or sei da quello che or ora sembravi.
Altre son le tue vesti, ben altro è il color di tua pelle:
180 un Nume sei tu certo, di quelli che imperano13 in cielo. Siici propizio, che a te possiamo offerir sacrifizi grati, con aurei doni di pregio. Rispondimi, oh Nume!».
E a lui così rispose Ulisse tenace divino: «No, che non sono un Dio. Perché m’assomigli ai Celesti?
185 Il padre tuo sono io, pel quale tu, molto gemendo, molti dolori soffri, patisci dei Proci i soprusi!».
E, così detto, baciò suo figlio; e stillò per le guance giù sino a terra il pianto, ché a lungo l’aveva frenato.
Ma Telemaco, ancora non certo che fosse suo padre,
190 a lui risposta diede con queste veloci parole:
«No, che mio padre Ulisse non sei. Qualche demone sei, che mi lusinga,14 perché si accrescano ancor le mie pene.
Ché nessun uomo mortale può compiere tale prodigio solo col suo valore, qualora non giunga un Celeste,
195 che facilmente, se vuole, può renderlo giovine o vecchio; ché vecchio eri testé,15 coperto di miseri cenci, ed or somigli ai Numi signori del cielo infinito».
E a lui rispose Ulisse l’accorto con queste parole:
«Non devi oltre misura, Telemaco, far meraviglia,
200 se vedi qui tuo padre, non devi più a lungo stupire.
No, nessun altro Ulisse qui mai giungerà: sono io quello, che, dopo avere a lungo sofferto ed errato pel mondo, giungo alla patria; e venti anni, da quando partii, son trascorsi. Opera è stata questa d’Atena, la diva guerriera,
205 che facilmente, quale desidera, tale mi rende: simile ad un pitocco talvolta, talvolta ad un uomo
12 sgomento: “spaventato”.
13 imperano: “comandano”, “regnano”.
14 mi lusinga: “mi illude”, “mi inganna”. Oltre a considerare lo spavento e il timore di trovarsi di fronte a un qualche prodigio certamente divino, si deve anche notare che Telemaco non può avere un ricordo della fisionomia del padre, che ha visto partire quand’era ancora in fasce.
15 testé: “poco fa”.
giovane, tutto coperto di panni bellissimi; ai Numi ch’ànno nell’ampio cielo dimora, è ben facile cosa rendere a loro posta16 magnifico un uomo o deforme».
210 Detto così, cadeva seduto. E Telemaco allora, stretto il buon padre al cuore, proruppe in lamenti, in singulti,17 ché il cuore all’uno e all’altro pervase la gioia del pianto.
Piangeano acutamente, più fitto di queruli18 augelli, aquile od avoltoi rapaci, privati dei figli
215 dai cacciatori, prima che l’ale impennassero al volo:19 così misero pianto versavano entrambi dal ciglio.
[217-231] Dopo aver dato sfogo alle lacrime troppo a lungo trattenute, Telemaco desidera sapere in che modo il padre sia giunto a Itaca. Ulisse racconta allora dei Feaci che lo hanno condotto in patria, ma subito taglia corto e volge il suo pensiero ai Proci, a come vendicarsi dei loro misfatti e riprendere possesso della propria casa.
«Su via, parlami dunque, dei Proci fa’ novero,20 ch’io possa vedere quanti sono essi, e chi sono; ed allora io, riflettendo, vedrò, ché mal non mi serve il mio senno,
235 se basteremo noi due da soli a contender con essi, senza soccorso, oppure cercare dovremo compagni». E gli rispose con queste parole Telemaco scaltro: «O padre, udito ho sempre cantare le lodi tue grandi, ch’eri guerriero valente di mano e scaltrito di senno.21
240 Ma temerario troppo parlasti, sì ch’io ne stupisco. Come potrebber due soli combatter con molti gagliardi?
16 a loro posta: “a loro piacere”.
17 singulti: “singhiozzi”.
18 queruli: “lamentosi”.
19 prima che l’ale impennassero al volo. Il verbo impennare significa letteralmente “ricoprire di penne”, “mettere le penne”: infatti contiene il sostantivo penna. Si dice che un uccello impenna le ali quando ha sviluppato su di esse delle penne sufficientemente robuste da farlo volare. Ecco dunque spiegato il motivo per il quale oggi si può dire che una motocicletta o un cavallo impennano: certamente non perché si ricoprano di piume, ma perché, alzando la loro parte anteriore, sembrano disporsi al volo.
20 dei Proci fa’ novero: “fammi il conto, l’elenco dei Proci”, “dimmi il loro numero”.
21 Di mano e di senno sono due complementi di limitazione.
Dieci o due volte dieci soltanto non sono i nemici, anzi, molti di più: potrai farne subito il conto. Cinquanta e due son giunti da Dulico giovani eletti,
245 e sei famigli sono venuti con loro. Da Samo venti garzoni e quattro son giunti ad Itaca. Venti figli d’Achei di Zacinto son qui presenti. E la stessa Itaca dodici, quanti si credon migliori, ne schiera. È seco loro Medonte, l’araldo, il cantore divino,
250 son due famigli con essi, esperti a scalcare22 le carni. Se questa gente23 intrusa dovremo affrontare da soli, temo che amara e funesta ti possa saper la vendetta dell’arroganza loro.24 Su, cerca, se tu, meditando, trovi qualcuno che voglia con animo schietto aiutarci».
255 E a lui così rispose Ulisse tenace divino: «Dunque, ti parlerò; tu intendilo e tienilo a mente, e pensa se bastare ci possono Atena con Giove, o se alcun altro debbo cercare per nostra difesa».
E gli rispose queste parole Telemaco scaltro:
260 «Buoni son questi due difensori che m’hai nominati; usi a sedere in alto, sui nuvoli eccelsi, ed impero hanno su tutti gli altri Celesti e su tutti i mortali».
E gli rispose Ulisse tenace divino, gli disse: «Bene, non li vedrai restar lungo tempo lontani
265 dalla feroce mischia, nel giorno che sotto il mio tetto verrà fra i Proci e noi decisa la furia di Marte.25
Or, non appena sorga l’Aurora, tu torna alla reggia, e qui mettiti in mezzo fra i Proci arroganti e superbi. Anche io poi ci verrò, più tardi, guidato da Eumeo,
22 scalcare: “staccare dall’osso”.
23 Da Dulico (o Dulichio) provengono 52 Proci e 6 servi (famigli), 24 da Samo, 20 da Zacinto e 12 da Itaca, cui vanno sommati 2 servi, l’araldo (Medonte) e il cantore (Femio). I Proci sono in tutti 108, cui vanno aggiunte altre 10 persone: Ulisse e Telemaco devono dunque fronteggiare 118 persone.
24 temo che amara e funesta ti possa saper la vendetta dell’arroganza loro: “temo che il tentativo di vendicarti della loro arroganza ti possa costare caro, addirittura ucciderti”. Saper qui significa letteralmente “aver sapore”. La frase andrebbe così parafrasata: “temo che la vendetta della loro arroganza possa aver per te un sapore amaro e funesto”.
25 nel giorno che sotto il mio tetto verrà fra i Proci e noi decisa la furia di Marte: “nel giorno in cui nella mia casa verrà decisa la battaglia tra noi e i Proci”.
270 e le sembianze avrò d’un vecchio cencioso e pitocco; e se nella mia casa coprirmi oseranno d’oltraggi, le sofferenze mie patisca in silenzio il tuo cuore, anche se per un piede dovessero fuor dalla porta mettermi, e fare di me bersaglio. Tu guarda, e sopporta.
275 Consigliali però che desistan da tali stoltezze, blande26 parole ad essi rivolgi; né ascolto daranno.
E giunto allor sarà per essi il momento fatale.
E un’altra cosa ancora ti dico, e tu tienila a mente.
Quando m’ispiri Atena, la dea dall’accorto consiglio,
280 ti farò cenno così col capo. Tu intendimi allora, e quante in quella stanza sono armi da guerra raduna, e poi recale su, fino all’ultima, e ponile ai canti27 dell’armeria. Se poi volessero i Proci sapere e interrogarti, rispondi con queste melliflue parole:
285 “L’ho tratte giù28 dal fumo, perché più non sembrano quelle che Ulisse un giorno qui lasciava partendo per Troia, ma brutte sono, ovunque le giunse la vampa del fuoco.29
E poi, questo più grave pensiero ispirato m’ha un Nume: che voi, presi dal vino, possiate venire a contesa
290 e l’un l’altro ferire, possiate macchiare di strage festa e convivio, ché il ferro da solo trascina la gente”.30
E lascia per noi due solamente due lance e due spade, e due scudi di pelle, che stiano a portata di mano, quando ci serviranno per muovere contro ai nemici.
295 E Giove ad essi e Atena sapranno sconvolger la mente.
E un’altra cosa ancora vo’ dirti, e tu tienila a mente.
Se tu davvero sei mio figlio, se sei del mio sangue, nessuno deve ancora sapere il ritorno d’Ulisse. Neppur Laerte deve saperlo, neppure il porcaro,
300 né dei famigli alcuno, neppure Penelope: soli
26 blande: “giuste”, “sagge”, equilibrate”.
27 I canti sono gli “angoli”, i luoghi più nascosti della stanza.
28 L’ho tratte giù: “le ho tolte, allontanate”.
29 ma brutte sono, ovunque le giunse la vampa del fuoco. Le armi sono diventate brutte, annerendosi in tutte le parti in cui sono state raggiunte dal fumo.
30 ché il ferro da solo trascina la gente: “poiché la sola vista delle armi spinge la gente a combattere”.
la mente delle ancelle dobbiamo tu ed io scandagliare;31 ed i famigli anch’essi tentare dobbiamo, e cercare quale di loro ci onori, col cuore disposto al rispetto, quale di noi non si cura, ma te, che sei giovane, spregia».32
[305-318] Telemaco si dice pronto a lottare assieme al padre, ma confessa di non comprendere l’utilità di quanto proposto da Ulisse: perché perdere tanto tempo a esaminare la fedeltà di tutti i servi e di tutte le ancelle, lasciando così ai Proci ancora molto tempo per dissipare i beni della famiglia?
E ad Itaca frattanto giungeva la solida nave
320 che conduceva da Pilo Telemaco e tutti i compagni.
Ora, poi che fûr giunti nel mezzo del porto profondo, quelli sospinsero il negro naviglio alla spiaggia; ed i servi volonterosi via ne levaron gli attrezzi, e alla casa portarono del figlio di Ulisse i bellissimi doni;
325 ed alla casa poi d’Ulisse mandarono un messo, che la novella fausta33 recasse a Penelope scaltra ch’era nei campi Telemaco, e aveva ordinato che il legno per la città proseguisse, perché l’animosa regina strugger non si dovesse, temendo, in continuo pianto.
330 Or s’incontrarono a un punto l’araldo e l’onesto porcaro, ch’ambi dovean recare lo stesso messaggio a la donna. E com’essi del re divino fûr giunti alla casa, alto parlò l’araldo fra tutti i famigli, e le disse: «Il tuo figliuolo è già, regina, tornato da Pilo».
335 Presso a Penelope invece si fece l’onesto porcaro, e tutto le narrò, come aveva Telemaco imposto; e poi che l’ambasciata compié tutta in ordine, mosse via dalla sala, via dalla corte, e tornò fra i suoi porci. Tristi, turbati i Proci rimasero. Uscîr della sala,
31 scandagliare: “indagare”, “sondare”. Oggi il verbo indica in particolare l’operazione con la quale si esaminano i fondali marini.
32 spregia: “disprezza”.
33 Fausto (o fasto) è un aggettivo indicante una connotazione genericamente positiva, significa cioè “buono”. Il suo contrario è nefasto
340 mossero fuor dalla corte, di là dal gran muro, all’aperto, quivi, a seder, della reggia si posero innanzi alla porta.
E primo allora il figlio di Polibo, Eurimaco, disse: «Amici miei, con questo viaggio, davvero un’impresa oltremisura grande compiuta ha Telemaco. E noi
345 nol credevamo! Su via, s’appresti la nave più snella, e rematori esperti vi salgan, che ai nostri compagni possano dare al più presto l’avviso che tornino a casa».34
Compiuta non avea la parola, che Anfinomo, gli occhi volgendo al mare, vide la nave arrivare nel porto, 350 e ammainar le vele, e stendersi ai remi le palme.35
Ed ai compagni disse così, dolcemente ridendo: «D’ambascerie non c’è bisogno: vedeteli giunti.
O tutto ha detto ad essi qualcun dei Celesti, o la nave hanno veduta essi stessi, ma coglier non l’hanno potuta».
355 Disse. Ed alzatisi tutti, si spinsero al lido del mare. Subito gli altri la nave sospinsero al lido; ed i servi volonterosi via ne levarono tutti gli attrezzi.
E poi tutti a convegno si strinsero, e niuno fra loro lasciâr, giovine o vecchio, seder, che dei loro non fosse.
360 E Antinöo, figliuolo d’Eupito, così prese a dire:
«Ahimè!, come han salvato costui dal periglio i Celesti!
Su per le balze ventose, le intere giornate, vedette stavano a turno perpetuo;36 né in terra al tramonto del sole discendevamo, a passare la notte, ma sempre sul mare
365 attendevam, bordeggiando37 sovra agile nave, l’aurora, pronti all’insidia, per coglier Telemaco, e dargli la morte.
E invece lui, frattanto, un demone a casa condusse.
Ora, su via, qui adesso pensiamo qual morte funesta infliggergli possiamo, sì ch’ei non ci sfugga, ch’io penso
370 che mai compiuto il nostro disegno sarà sin ch’ei viva, ché molto è nel consiglio sagace Telemaco e scaltro,
34 I Proci vogliono richiamare i loro compagni inutilmente appostati su una nave per sorprendere Telemaco, ormai giunto in città.
35 stendersi ai remi le palme. Quest’espressione indica l’azione di remare, in quanto le palme sono le mani che vengono portate (stese) sui remi.
36 perpetuo: “continuo”, “senza interruzioni o soste”.
37 bordeggiando: “navigando presso la costa”, per sorvegliarla.
né tutte quante le genti s’adoprano in nostro favore. Dunque, spicciatevi, su, prima ch’egli raduni gli Achivi a parlamento, ché nulla, penso io, lascerà ch’ei non tenti;38
375 anzi, li aizzerà, dirà, surto in mezzo a parlare, che noi funerea morte gli ordimmo, e fallimmo la mira.
Né quelli, udendo ciò, loderanno le nostre misfatte, e temo che alcun danno non abbiano a farci, a scacciarci via dalle nostre terre, raminghi per terre straniere.
380 Or preveniamolo. E mentre lontano è nei campi, o s’avvia vêr39 la città, s’uccida. Pigliamoci allora i suoi beni, le sue sostanze, e fra noi dividiamole; e diamo la casa alla regina e a chi la sposa, ché n’abbia possesso. Se poi queste parole vi spiacciono, e invece bramate
385 ch’ei viver debba, e tutta goder la sostanza paterna, non si rimanga più qui tutti raccolti, a mangiargli i beni suoi, per quanto gustosi, ma ognuno, recando doni da casa sua, richieda le nozze, e la donna scelga chi più le piaccia, chi vuole che scelga il Destino».
[390-448] Un dubbio allora assale Anfinomo, il più saggio dei Proci. Il misfatto che essi stanno tramando è terribile e sacrilego, e sarebbe opportuno sacrificare a un dio per conoscerne la volontà: con l’assenso divino, infatti, egli stesso sarebbe pronto a commettere il delitto, ma senza il favore celeste ne avrebbe molto timore. La paura di Anfinomo è condivisa da diversi compagni, ma i capi dei Proci non vi danno seriamente credito. I pretendenti giungono allora a palazzo e qui incontrano Penelope, la quale, informata della tentata insidia al figlio, sfida gli impostori chiedendo loro conto delle azioni che stavano per commettere. Eurimaco, però, assicura la donna di desiderare per suo figlio ogni bene e di essere pronto a farsene il difensore qualora questi dovesse venir attaccato da qualcuno. Dice ciò per rassicurare la madre di Telemaco, ma per farlo deve mentire: nel suo cuore, infatti, continua ad architettare la morte del giovane.
38 ché nulla, penso io, lascerà ch’ei non tenti: “poiché, credo, egli non lascerà nulla di intentato”, cioè “proverà in tutti i modi”.
39 vêr: “verso”.
L’ultima notte nella capanna
Su l’imbrunire, intanto, giungeva l’onesto porcaro
450 presso ad Ulisse ed al figlio. Sgozzato un porcello d’un anno, stavano questi allestendo la cena. Ed Atena, d’un tratto fattasi presso a loro, di nuovo il figliuol di Laerte con la sua verga toccò, di nuovo lo rese vecchiardo, e lo coprì di cenci, perché non dovesse il porcaro,
455 vedendolo così, riconoscerlo, e senza sapersi più contenere, tutto narrasse a Penelope scaltra. Primo Telemaco a lui con queste parole si volse: «Eccoti, Eumeo! Che cosa si dice in città? Son tornati i valorosi Proci, di già, dall’agguato a me teso?
460 O sono ancora lì, m’aspettan che a casa io ritorni?» Eumeo fedele, e tu rispondevi con queste parole: «A cuore non mi stava sapere né chieder di questo, andando alla città, ma il cuor mi diceva ch’io presto facessi l’ambasciata, che subito poi ritornassi.
465 Ed incontrai, mandato dai tuoi compagni, un messaggio:40 questi a tua madre, prima di me, recò la novella. Un’altra cosa io so, ché l’ho con questi occhi veduta.
Già fuor della città camminavo, al ritorno, ove sorge d’Ermete il colle,41 quando io vidi un veloce naviglio
470 entrar nel nostro porto. Molti uomini v’erano dentro, ed era pieno colmo di scudi, di lance a due punte.
Di certo non lo so, ma penso che fossero quelli». Disse così. Sorrise Telemaco, forza divina, gli occhi volgendo al padre; sfuggì quel sorriso al porcaro.
475 Or poi che tutto fu compiuto, e imbandita la mensa, qui banchettarono, e niuno restò con la brama del cibo. E quindi, e fame e sete placate, rivolser la mente anche a dormire; e il sonno su loro profuse i suoi doni.
40 messaggio: “messaggero”.
41 Il colle sacro a Ermete (Mercurio) era il monte Neio, sull’isola di Itaca.
Libro XVII Argo, il cane fedele
L’atteso ritorno di Telemaco
[1-27] Telemaco lascia la capanna di Eumeo, dopo aver dato istruzioni al porcaro perché conduca il mendicante in città, in modo che possa elemosinare qualcosa da mangiare.
Ed ecco, appena fu pervenuto alla comoda casa, quivi depose la lancia, poggiandola a un’alta colonna,
30 ed egli stesso entrò, varcando la soglia di pietra. Assai prima d’ogni altro lo scorse la fida Euriclea, mentre stendeva pelli di pecora sotto i bei troni; e, lagrimando, incontro diritta gli corse; ed intorno si radunavano l’altre fantesche1 d’Ulisse tenace,
35 e a lui, con liete grida, baciavano gli omeri e il capo. Dalle sue stanze frattanto veniva Penelope scaltra, pari ad Artemide, pari all’aurea beltà d’Afrodite; e al collo del figliuolo gittò, lagrimando, le braccia, e lo baciò sul capo, su entrambe le fulgide luci,
40 e gli parlò, fra i singulti, con queste veloci parole: «Sei qui, luce mia dolce, Telemaco! Io già mi credevo di non vederti mai più, dal dì che salpasti per Pilo, contro mia voglia, in segreto, cercando notizie del padre! Or via, narrami dunque che cosa hai potuto sapere».
45 E a lei queste parole rispose Telemaco scaltro: «Non provocarmi al pianto, non far, cara madre, che in seno mi tremi il cuor, sebbene sfuggita ho la morte improvvisa.
Lavati adesso, le membra tue cingi di candide vesti, e a tutti i Numi fa promessa di scelte ecatombi,
50 se Giove mai farà che si possa compir la vendetta.
Ora alla piazza io vado, ché voglio chiamar lo straniero
1 fantesche: “servitrici”, “ancelle”.
che è di già venuto con me, mentre io qui ritornavo.2
Io l’ho mandato innanzi con gli altri fedeli compagni, ed a Pireo lo affidai, perché lo guidasse al suo tetto, 55 ne avesse cura, onore gli rendesse, sin ch’io non giungessi». Disse così. Senz’ali restò la parola a sua madre;3 tacque ella, si mondò, si coprì di candide vesti, e scelte ai Numi tutti promise offerire ecatombi, se Giove omai volesse compiuta la loro vendetta.
60 Frattanto traversava la casa Telemaco e usciva, stretta la lancia in pugno; seguiano due cani veloci. Ed una grazia su lui profuse indicibile Atena, sì che, mentr’egli passava, miravan le genti stupite. E tutti a lui d’attorno si strinsero i Proci superbi, 65 con parolette dolci, ma in cuore volgendo tristizie.4
[66-164] Come preannunciato, l’indovino Teoclimeno giunge alla reggia accompagnato da Pireo. Dopo il banchetto di accoglienza, Penelope chiede di nuovo al figlio notizie del marito Ulisse, se mai tornerà a Itaca. Telemaco questa volta risponde alla domanda della madre, ripercorrendo le tappe del proprio viaggio a Pilo e a Sparta e riferendo quanto gli era stato detto da Menelao: Ulisse era prigioniero della ninfa Calipso. A questo punto Teoclimeno interviene nella discussione e corregge Telemaco: Ulisse si trova già sull’isola di Itaca.
Ulisse è insultato
[165-198] Mentre i Proci si accingono a un lauto banchetto, Eumeo e Ulisse si incamminano verso la città, così come Telemaco aveva ordinato loro.
I due5 mossero; e a guardia restarono i cani e i pastori
2 Telemaco si riferisce all’indovino Teoclimeno.
3 Senz’ali restò la parola a sua madre: “sua madre non pronunciò parole”, “restò muta”. Le parole alate sono quelle che raggiungono il bersaglio; viceversa, quelle senz’ali sono quelle che nemmeno vengono indirizzate, cioè pronunciate. Penelope rimane senza parole perché non comprende l’atteggiamento del figlio, che anziché farle un dettagliato resoconto del viaggio, subito si allontana inspiegabilmente dalla reggia.
4 L’atteggiamento dei Proci è cioè carico di ipocrisia: fingono di essere lieti del rientro di Telemaco, ma in realtà avevano a lungo sperato nel suo mancato ritorno. Volgendo tristizie significa “meditando propositi malvagi”.
5 Ulisse ed Eumeo.
200 della capanna. Ed Eumeo condusse in tal guisa6 il signore alla città: d’aspetto cencioso e pitocco e vecchiardo, puntellato al bastone, coperto di miseri stracci. Quando ebbero così percorsa la strada rocciosa, già presso alla città, pervennero a un limpido fonte,
205 cinto di muri, dove solevano attinger le genti. Polittore, Itaco e Nerito7 un giorno l’avevano estrutto;8 e d’ogni parte un bosco di pioppi nutriti dall’acqua cresceva attorno attorno. Sgorgava la gelida polla9 alto,10 su da una roccia; sorgeva su quella un alloro
210 sacro alle Ninfe, e chiunque passasse, ivi offria sacrifizio. Qui s’incontrò con essi Melanzio, figliuolo di Dolio, che conduceva capre, trascelte dal meglio dei branchi, per banchettarne i Proci;11 moveano con lui due pastori.
Appena li ebbe visti, cominciò a coprirli d’ingiurie
215 vituperose, sconce, che accesero il cuore d’Ulisse. «Ora davvero sì, che un briccone accompagna un briccone! Com’è vero ch’un dio li fa, e poi li accompagna! Dove conduci questo lezzone, dannato porcaro, questo pitocco schifoso, flagello di tavole?12 A quanti
220 stipiti s’appoggerà, sdruscerà13 le sue spalle, chiedendo in dono non lebeti né spade, ma tozzi di pane! Se tu lo dessi a me per fare la guardia al podere, essere mozzo di stalla, portare la foglia ai capretti, forse, succiando siero, potrebbe rifarsi le polpe.14
6 in tal guisa: “in tal modo”. Spesso si può trovare la locuzione avverbiale a guisa di per dire “simile a”.
7 Polittore, Itaco e Nerito sono probabilmente tre antichi signori dell’isola oppure i capostipiti. Itaco e Nerito sono eroi eponimi, cioè che hanno dato il proprio nome a qualcosa: il primo all’isola, il secondo al monte più alto di questa.
8 estrutto: “costruito”.
9 polla: “sorgente”, “zampillo”.
10 Alto non ha qui valore di aggettivo, ma di avverbio: “in alto”.
11 Melanzio è un arrogante pastore, amico dei Proci, che procura loro le capre perché possano banchettare (per banchettarne i Proci).
12 lezzone: “uomo sudicio”. Il lezzo è un odore particolarmente fastidioso. Flagello di tavole significa “rovina per le tavole”, perché l’accattone è affamato e chiede continuamente da mangiare.
13 sdruscerà: “consumerà”.
14 succiando siero, potrebbe rifarsi le polpe: “bevendo siero, potrebbe ingrassare”. Il siero è ciò
225 Ma poi che apprese il tristo mestiere,15 badare al lavoro ei non vorrà: vorrà tra il popolo gir pitoccando, e, questuando16 qua e là, nutricare l’ingordo suo ventre. Ora una cosa vi dico, che certo vedrete compiuta: qualora egli alla casa d’Ulisse vicino si accosti,
230 molti sgabelli vedrete volar dalle mani dei Proci, che gli faranno a pezzi la testa, le costole a pezzi». Detto così, l’arrogante, passando, colpì con un calcio sopra la coscia Ulisse, ma punto né poco lo scosse, ch’egli restò piantato dov’era. E rimase fra due: 235 se col bastone dovesse colpirlo e levargli la vita, oppur di peso alzarlo e battergli a terra la testa. Ma si contenne però, pose freno al suo cuore. E il porcaro, vedendo, si crucciò, le mani levò, fece un voto:
«O della fonte Ninfe, di Giove figliuole, se Ulisse
240 d’agnelli e di capretti le cosce vi offrì su gli altari, di pingue adipe avvolte, compietemi il voto ch’io faccio: possa, deh!, possa Ulisse tornare, lo guidi un Celeste; ei sperderebbe, sì, le grandi arie che adesso ti dai, svillaneggiando tutti, a zonzo vagando ogni giorno
245 per la città, mentre il gregge distruggono i tristi pastori!»
E gli rispose così Melanzio guardiano di capre: «Poveri noi, questo cane maestro di guai, come parla!
Un giorno o l’altro voglio cacciarlo in un legno, e portarlo d’Itaca lungi, dove fruttarmi un bel gruzzolo possa!
250 Così volesse Apollo colpire Telemaco, oppure fare che alcun dei Proci lo debba accoppare oggi stesso, come da un pezzo sfumò la speranza che Ulisse ritorni!»
E, così detto, i due lasciò che movevano adagio, ed egli, di buon passo rivolto alla casa d’Ulisse, 255 presto vi giunse, v’entrò, si mise fra i Proci a sedere, che resta del latte dopo che è stato fatto il formaggio. Di solito viene utilizzato come bevanda per i maiali, ma Melanzio insinua che per il mendicante sarebbe un cibo così gradito da farlo ingrassare.
15 Il tristo mestiere è quello del mendicante. È un mestiere tristo perché, secondo Melanzio, chi vi si dedica lo fa solo per mancanza di voglia di mettersi al lavoro.
16 questuando: “mendicando”, “accattando”.
a Eurimaco di fronte, che gli era su tutti benigno.
I servi della mensa gli diêr la sua parte di carne, e la massaia attenta gli pose vicino del pane.
Argo, il cane fedele
S’erano intanto appressati Ulisse e il fedele porcaro;
260 ma si fermaron, ché ad essi giungeva a l’orecchio lo squillo d’una sonora lira, ché Femio prendeva a cantare.17
E Ulisse allora prese per mano il porcaro e gli disse: «Eumeo, di certo è questa la fulgida casa d’Ulisse: la riconosco bene, che pur fra molte altre è distinta.
265 L’un edificio è legato con l’altro, di mura e di merli tutta la corte è munita,18 la chiude una solida porta a due battenti: certo niun uomo potrebbe sforzarla.
E intendo pur che dentro molti uomini sono a banchetto, che pingue fumo intorno d’arrosto19 s’effonde, e la lira
270 garrisce, che compagna crearono i Numi al banchetto».
Tu allora, Eumeo, fedele porcaro, così rispondevi:
«Bene hai veduto. E già pur nel resto non manchi di senno.
Ma su, pensiamo come si sbriga ora questa faccenda: se meglio è che tu prima di me nella fulgida reggia
275 entri e ti mesca20 tra i Proci, mentre io me ne resto qui fuori, oppur tu resta, ed io, se meglio ti sembra, entro primo. Non indugiare, però, che alcuno di fuor non ti scorga, e con randelli e con sassi non debba colpirti. Sta’ in guardia». E Ulisse a lui rispose, l’eroe pertinace21 divino:
280 «Lo so, ci penserò: tu parli a chi bene t’intende.
17 Femio è l’aedo della reggia di Ulisse, così come Demodoco lo era di quella di Alcinoo sull’isola dei Feaci. Il canto dell’aedo fa fermare Ulisse e gli permette di riconoscere con sicurezza la propria dimora.
18 munita: “difesa”.
19 pingue fumo intorno d’arrosto: non è il fumo ad essere pingue (“grasso”), ma l’arrosto. Si tratta di una figura retorica che si chiama sinestesia, che consiste nell’attribuire a una parola una caratteristica che si percepisce con un senso diverso da quello col quale siamo soliti percepire quella cosa. Vale a dire che noi innanzitutto vediamo il fumo utilizzando un senso (la vista), ma gli associamo un aspetto ad esso collegato, il sapore dell’arrosto, che però logicamente dovremmo cogliere con un altro senso, il gusto.
20 mesca: “mescoli”.
21 pertinace: “resistente”, “tenace”.
Va’ pure innanzi tu, ché io qui di fuori t’attendo. Ché, quanto a busse o colpi di sasso, novizio non sono, ma tollerante è il mio cuore, da quanti malanni ho sofferto, in guerra, e sopra il mare; mi tocchi per giunta anche questo, 285 perché modo non c’è che il ventre affamato si taccia, il maledetto ventre, che agli uomini fa tanto male, per cui si attrezzan pure le solide navi sul mare inseminato, 22 che recano tanti malanni a le genti». Stavano dunque così tra lor questi due ragionando;
290 e un can levò, che quivi giaceva, la testa e le orecchie. Ed Argo esso era, il cane d’Ulisse. Allevato ei l’aveva, senza goderne,23 ché prima dovè partire per Ilio.
I Proci per l’innanzi soleano menarlo alla caccia:24 i caprioli e i cervi cacciava, e le capre selvagge;
295 messo or da banda,25 e privo del signore, ch’era lontano, giacea sopra un gran mucchio di fimo26 di muli e di bovi ch’era ammassato all’uscio dinanzi; ed i servi d’Ulisse qui lo27 prendean, per dare l’ingrasso ai suoi vasti poderi.
Il cane Argo qui dunque giacea, tutto pieno di zecche.
300 E appena, ecco, s’accorse d’Ulisse che gli era vicino, scosse la coda, entrambe lasciò ricadere le orecchie; ma poi la forza non ebbe di farsi dappresso al padrone. E questi, le pupille distolse, una lagrima terse, senza ch’Eumeo lo vedesse, ché seppe nascondersi; e chiese:
305 «Eumeo, gran meraviglia che giaccia nel fimo un tal cane! Bello d’aspetto è certo. Però questo dir non saprei, s’egli, oltre a questa bellezza, veloce anche fosse nel corso,
22 perché modo non c’è … sul mare inseminato: “perché non c’è modo di mettere a tacere la maledetta fame, che fa soffrire tanto gli uomini e per la quale si compiono anche lunghe traversate sul mare”. Ulisse non è spaventato dalla possibilità di essere colpito o aggredito all’interno della reggia, perché è abituato a sopportare di tutto, come ogni altro mendicante è disposto a qualunque cosa (perfino ad affrontare pericolosi viaggi) pur di procurarsi del cibo.
23 senza goderne: “senza poterne usufruire (per la caccia)”.
24 I Proci per l’innanzi soleano menarlo alla caccia: “i Proci nel primo periodo (per l’innanzi) erano soliti portarlo (menarlo) a cacciare”.
25 messo or da banda: “messo ora da parte”.
26 fimo: “letame”.
27 Il pronome (lo) si riferisce al fimo
oppur se come i cani da mensa28 egli fosse, che solo per la bellezza loro li allevano i loro padroni».
310 Tu allora, Eumeo, fedele porcaro, così rispondevi: «Purtroppo, il cane è questo d’un uomo che morto è lontano. Deh!, se tale egli fosse tuttora di forme e di forze quale qui lo lasciò, partendo per Troia, il signore, ben, la sua forza e il vigore vedendo, stupir tu dovresti.
315 Ché niuna fiera a lui sfuggire potea negli anfratti29 della profonda selva, quand’ei la scovasse, ché troppo era sagace dell’orme.30 Ma ora l’opprime sciagura. Il suo padrone è morto lontano; e le ancelle incresciose31 cura non n’hanno più, ché i servi, se i loro signori
320 più non li vegliano, compier non vogliono il loro dovere, perché Giove, che tutto contempla dal cielo, ad un uomo, se cade in servitù, metà del suo pregio gli toglie».32
Dette queste parole, entrò nella fulgida casa, e difilato andò verso l’atrio, alla volta dei Proci.
325 Ed Argo fu ghermito dal fato di livida morte, poscia ch’egli ebbe, dopo venti anni, rivisto il signore.33
Ulisse resiste alle provocazioni
[327-442] Entrato nella reggia, Ulisse comincia a elemosinare dai Proci qualcosa da mangiare, così da metterli alla prova e scoprire chi di loro sia malvagio e chi invece sia più pietoso. Tutti offrono con generosità del cibo, fino a riempire la bisaccia del mendicante, ad eccezione di Antinoo, che, preso da un forte odio, con decisione si rifiuta. Il mendicante allora racconta la propria storia, sintetizzando quel che poco prima aveva detto a Eumeo: era di ricca famiglia, ma Giove lo condusse in Egitto dove i compagni lo rovinarono; come mendicante fu trasportato a Cipro e poi nell’isola di Itaca.
28 I cani da mensa sono quelli di lusso, solitamente tenuti come ornamento per la casa perché non servono per cacciare né per fare da guardia.
29 anfratti: “nascondigli”.
30 sagace dell’orme: “intelligente nel riconoscere le orme”.
31 incresciose: “avverse”, “traditrici”.
32 perché Giove, che tutto contempla dal cielo, ad un uomo, se cade in servitù, metà del suo pregio gli toglie. Omero intende dire che un uomo divenuto schiavo e costretto a lavorare per gli altri rende la metà di quanto farebbe se lavorasse liberamente e per sé.
33 Il cane Argo, che per anni aveva sopportato tante ingiustizie e sofferenze, si abbandona placidamente alla morte, in pace per aver finalmente rivisto il padrone.
E Antinoo gli parlò, gli rispose con queste parole: «Qual Dio ci manda questo malanno, a guastare le feste?
445 Fermati in mezzo costì,34 lontan dalla tavola mia, ché tu presto approdare non debba a una Cipro, a un Egitto di molto amaro!35 Tu sei sfacciato e protervo, accattone!
Ad uno a uno, a tutti ti accosti: da tutti ricevi a piene mani, ché niuna pietà, niun riguardo li frena
450 dal farsi belli coi beni degli altri, ché n’hanno di molti».
E ritraendosi, Ulisse, l’accorto pensiero, gli disse: «Ahimè! l’animo, dunque, tu pari all’aspetto non hai! Di casa tua non daresti neppure un granello di sale, se d’altri ora alla mensa tu siedi, ed il cuor non ti basta
455 di darmi un po’ di cibo: ché tu n’hai dinanzi gran copia». Così disse. Ed il cuore d’Antinoo più arse di furia; e bieco36 lo guardò, parlò, disse queste parole: «Uscir da questa sala, dovrà, dico io, riuscirti poco gradito, dacché tu osi anche dire insolenze!»37
460 Così disse, afferrò, scagliò lo sgabello, e lo colse al sommo della schiena, su l’omero destro. Ma Ulisse stette come una rupe;38 né il colpo d’Antinoo lo fece pur vacillare; e, muto, volgeva feroci pensieri.
Crollò la testa, tornò su la soglia, la colma bisaccia
465 depose a terra, e ai Proci con queste parole si volse: «Datemi ascolto, o voi che ambite l’eccelsa regina: ch’io dico ciò che il cuore mi va suggerendo nel seno. Cruccio non è, non è rammarico alcuno nel cuore, per chicchessia, se resta colpito mentr’egli difende
470 le sue sostanze, i suoi giovenchi, le pecore bianche. Antinoo invece m’ha colpito pel ventre dannato,
34 costì: è un avverbio di luogo. Significa “lì dove sei”.
35 a una Cipro, a un Egitto di molto amaro. Antinoo si fa beffe del racconto del mendicante, ripetendo in una minaccia i luoghi lì nominati.
36 bieco: “biecamente”, “con lo sguardo carico di odio”. L’aggettivo ha qui valore predicativo, avverbiale.
37 dacché tu osi anche dire insolenze: “poiché hai il coraggio di dire parole sfacciate”. In-solenza significa letteralmente “una cosa che non si è soliti fare o dire”, cioè che non si addice alla situazione, che quindi risulta esagerata, sfacciata.
38 stette come una rupe: “rimase immobile come una montagna”.
pel maledetto ventre che tanto travaglia le genti.
Ma se ci sono Dei, se ci son pei tapini l’Erinni,39 dovrà, prima ch’ei sposi, piombare su Antinoo la morte».
475 E gli rispose così Antinoo, figlio d’Eupito: «Siediti, e mangia in silenzio, straniero, oppur vattene altrove, che non ti debbano i Proci, se tu così parli, scacciare, presoti per un pie’, per un braccio, e cavarti la pelle». Disse. Però fieramente rimasero gli altri sdegnati;
480 e gli parlò così talun di quei giovani altieri: «Bello, Antinoo, non fu colpire un tapino errabondo. Povero te, se fosse qualcuno dei Numi del cielo!
Ché spesso i Numi stessi, d’erranti stranieri in sembianza, percorron le città, tutte quante assumendo le forme, 485 per esplorare le genti, chi sia prepotente, chi giusto».
Così diceano i Proci. Ma quegli dei loro discorsi non si curava punto. Telemaco il cruccio a quel colpo crescer sentì. Ma stilla40 dal ciglio però non gli cadde; solo crollò, volgendo sinistri pensieri, la testa.41
[490-603] Penelope, profondamente addolorata per l’accoglienza che Antinoo ha riservato allo straniero, manda Eumeo a chiamarlo per interrogarlo se mai abbia visto Ulisse nei suoi numerosi viaggi. Il mendicante, dimostrando grande prudenza, preferisce aspettare il tramonto per recarsi nelle stanze di Penelope: al buio correrà di meno il rischio di essere visto dai temibili Proci. Nel frattempo Eumeo si congeda da Telemaco e ritorna alla sua capanna.
39 Le Erinni sono le divinità della vendetta.
40 stilla: “goccia”; in questo caso “lacrima”.
41 crollò … la testa: è il medesimo gesto che poco prima (v. 464) aveva compiuto Ulisse, rassegnandosi (temporaneamente) a non reagire di fronte alla prepotenza e alla violenza di Antinoo. Qui Telemaco ha la stessa reazione del padre: anche a lui crolla la testa perché è profondamente addolorato nel vedere Ulisse preso di mira dai Proci senza poter farsi valere. Telemaco è quindi sempre più simile al padre, non solo fisicamente, ma anche nel modo di fare.
Libro XVIII
La lotta con Iro
Due mendicanti a palazzo
E sopraggiunse un pitocco che andava per Itaca in giro, limosinando,1 famoso per rabida furia vorace di rimpinzare la pancia2 di cibi e bevande. Né forza, né possedeva coraggio, ma grande era e grosso a vederlo.
5 E si chiamava Arnèo: tal nome gli pose la madre quand’egli nacque, ma Iro solevano i Proci chiamarlo, ch’egli a portare ambasciate trottava ove tu gli dicessi.3
Dunque, appena fu giunto, scacciar volle Ulisse di casa, e l’affrontò con parole rissose: «Via, sgombera, o vecchio,
10 quella è la porta! Se no, per un pie’ ti ghermisco, ed io stesso ti ci trascino. Non vedi? M’ammiccano tutti con gli occhi, m’incitan ch’io ti trascini. Però mi vergogno di farlo. Sfratta, se tu non vuoi leticare,4 venire alle mani». E bieco lo guardò Ulisse, e così gli rispose:
15 «O galantuomo,5 niun male ti faccio o ti dico, né invidia, se chicchessia ti regala, ti porto, e se tu molto buschi.6
C’è posto in questa casa per me e per te, né tu devi invidiar l’altrui bene. Mi sembri anche tu mendicante, come sono io, vagabondo: provvedano i Numi ad entrambi.
20 Non provocarmi alla zuffa, ché, in ira salito, non debba, pur così vecchio, di sangue le labbra cospargerti e il petto.
1 limosinando: “chiedendo l’elemosina”.
2 famoso per rabida furia vorace di rimpinzare la pancia: “famoso per la rabbiosa ingordigia (la rabida furia vorace) con cui si rimpinzava la pancia”.
3 Per il nome Iro viene qui suggerita una scherzosa derivazione da Iride, la messaggera degli dèi: Iro sarebbe il corrispondente maschile di Iride. Come la dea era incaricata di recare messaggi, così anche Arneo eseguiva scrupolosamente questo compito, tanto da meritare tale soprannome. Anche Arneo è un nome parlante e ben si addice a un mendicante, perché significa “colui che ottiene”, “colui che acquisisce”.
4 leticare: “litigare”.
5 galantuomo: il tono della battuta di Ulisse è ironico.
6 buschi: “ricevi”.
Certo! E domani sarei più tranquillo, ché tu per un pezzo non metteresti più piede, credo io, nella casa d’Ulisse».
Iro accattone, montato su tutte le furie, rispose:
25 «Poveri noi, che mulino di chiacchiere è questo affamato!
Pare una sguattera vecchia! Ma penso di fargli un servizio, ambe le guance scotendogli, tutti schizzandogli i denti dalle mascelle, come d’un porco che strugge le biade.7
Ora succingiti,8 e tutti ci osservino, mentre lottiamo:
30 come vuoi tu con un uomo più giovin di te misurarti?»
Dinanzi all’alta porta, sovressa la lucida soglia, così fra i due quest’aspra contesa d’ingiurie avvampava.
E se n’accorse Antinoo, sovrano mercè dei Celesti,9 e tali detti volse, ridendo di gusto, ai compagni:
35 «Amici miei, tal bazza10 non mai ci toccò prima d’ora.
Qual mai dolce sollazzo quest’oggi ci mandano i Numi!
Il forestiero con Iro, venuti fra loro a contesa, stanno per azzuffarsi. Su dunque, aizziamoli, svelti!»
Disse così. Tutti quanti s’alzarono in piedi ridendo,
40 e s’aggrupparono in giro dintorno ai cenciosi pitocchi.
E così disse allora Antinoo, figlio d’Eupito: «Datemi retta, compagni magnanimi, a quello ch’io dico: qui sopra il fuoco ci sono codeste pancette di capra d’adipe e sangue rempiute; poniamole sopra la mensa, 45 e chi dei due più mostri vigore e consegua il trionfo, si faccia pure avanti, ne pigli finché gliene basti, e stia sempre a banchetto fra noi, d’ora innanzi; e permesso non abbia altro pitocco che dentro si cacci a piatire». 11
7 come d’un porco che strugge le biade. Iro schernisce Ulisse dicendo che gli avrebbe reso un ottimo servizio qualora gli avesse fatto schizzar fuori dalla bocca tutti i denti a suon di pugni. Per farsi meglio intendere utilizza un’immagine all’epoca nota a tutti: un’antica legge, infatti, consentiva ai proprietari terrieri di strappare i denti ai porci quando li avessero sorpresi a divorare i propri raccolti.
8 succingiti: il verbo succingere indica l’azione di arrotolare le vesti ai fianchi per avere le gambe libere ed essere quindi più pronto nei movimenti della lotta.
9 sovrano mercè dei Celesti: “sovrano per grazia degli dèi”.
10 La bazza è propriamente la carta fortunata che in alcuni giochi si prende all’avversario; più in generale indica un colpo di fortuna. Si può quindi intendere così: “un tale colpo di fortuna non ci capitò mai prima d’ora”.
11 piatire: “chiedere con grande insistenza”.
La lotta con Iro
Queste parole Antinoo diceva, e assentivano tutti.
50 E l’accortissimo Ulisse, con subdola mente12 rispose: «Buoni signori, che un vecchio fiaccato dai guai si misuri con uno assai più fresco, possibil non è. Ma la fame mi ci costringe, la trista, per farmi accoppare di busse.13 Ma tutti voi, su dunque, prestatemi giuro solenne
55 che, per soccorrere Iro, nessuno la mano gagliarda malvagiamente su me leverà per mettermi a terra». Così diceva; e tutti giurarono come chiedeva. E poi ch’ebber formato, prestato quel giuro solenne, sorse fra loro, divino rampollo, Telemaco, e disse:
60 «Se il cuore, ospite, a te, pur basta, e lo spirito prode, contro quest’uomo, niun altro tu devi temer degli Achivi: ché se qualcun ti battesse, l’avrebbe da fare con molti.14
E Antinoo con me lo promette, ed Eurimaco, entrambi sovrani, entrambi saggi: la casa che t’ospita è mia».
65 Disse così. Tutti quanti approvarono; e subito Ulisse come una fascia ai fianchi d’intorno i suoi stracci si cinse,15 e le sue cosce gagliarde si videro e grosse, e le polpe larghe, ed i fianchi e le braccia massicce, ché Atena, venuta presso al pastore di genti, le membra gli aveva ingrossate.
70 Tutti le gran meraviglie facevano i Proci a tal vista.
E l’un guardando l’altro, diceva ciascuno al vicino: «Iro a momenti è spacciato! S’è andato a cercare il malanno! Vedi che reni, che lombi16 non ha sfoderato quel vecchio!». Tanto dicevano. E ad Iro veniva già meno il coraggio.
12 con subdola mente: “in modo ingannevole”. Ulisse finge di essere un povero mendicante spossato da una vita faticosa e di stenti, pertanto dice che non è possibile che lui si confronti con Iro, più giovane e quindi più forte.
13 busse: “botte”. Ulisse in questo dialogo con i Proci si finge molto debole per riuscire a strappar loro la promessa di non aiutare Iro nella lotta.
14 se qualcun ti battesse, l’avrebbe da fare con molti: “se qualcuno ti colpisse, dovrebbe vedersela con molti”.
15 come una fascia ai fianchi d’intorno i suoi stracci si cinse. Da ordinare così: si cinse intorno ai fianchi i suoi stracci come una fascia.
16 Che reni, che lombi è una figura retorica chiamata endiadi: si utilizzano due parole per indicare una sola cosa. In questo caso si indicano i fianchi di Ulisse.
75 Ma tuttavia lo fasciarono17 i servi, lo spinsero a forza, pien di paura; e le polpe tremavan per tutte le membra. Ma lo copriva Antinoo d’ingiurie, così gli diceva: «Mai non ci fossi, bove poltrone,18 venuto fra i piedi, se devi stare a tremare, se tanta paura ti mette
80 un uomo vecchio, oppresso dai guai che gli piombano addosso! Ma ti prometto, e quanto prometto sarà mantenuto, che se costui risulta più forte di te, se ti vince, in fondo ad un battello ti gitto, e ti mando per mare sino al tiranno Echèto, flagello del genere umano,19
85 che ti reciderà col ferro le orecchie ed il naso». Disse; e tanto più quello tremava per ogni suo membro.
Lo trascinarono in mezzo; e in guardia si misero entrambi. Ulisse allora, mente sagace, ondeggiava fra due:
90 se gli vibrasse un tal colpo da farlo piombare giù morto, o se, con meno furia, soltanto da stenderlo al suolo. E riflettendo, questo gli parve pel meglio: vibrarlo con meno furia, che al colpo non riconoscessero Ulisse. Dunque si misero in guardia, ed Iro colpì su la spalla
95 diritta,20 e Ulisse sotto l’orecchio, sul collo, e gli franse l’ossa: la bocca fu subito nera, fu piena di sangue; e giù con un gran mugghio piombò nella polvere, i denti fuori schizzò, scalciando coi piedi la terra; ed i Proci, alte levando le mani, crepavan dal ridere. Ulisse
100 lo trascinò per un piede traverso il vestibolo, giunse fuori dell’uscio, nel portico; e qui, presso il muro di cinta lo collocò, lo poggiò, tra le mani gli pose un bastone, e la parola gli volse, dicendogli alate parole: «Resta per ora qui seduto, ed i cani ed i porci
17 lo fasciarono: i servi compiono la stessa azione di arrotolare le vesti intorno ai fianchi di Iro che poco prima aveva fatto anche Ulisse.
18 bove poltrone: è un insulto e si traduce letteralmente con l’espressione “bue fannullone”. Il verbo poltrire, da cui deriva l’aggettivo poltrone, indica lo stare seduti a terra senza fare nulla per un lungo periodo di tempo.
19 Echeto probabilmente è un personaggio immaginario delle leggende popolari, famoso per le proprie crudeltà. Si racconta che la sua violenza non si arrestava neanche nei confronti della figlia, che venne da lui accecata. Con questa esagerata minaccia Antinoo vuole solo spronare Iro alla vittoria.
20 la spalla diritta: “la spalla destra”.
105 scaccia, e non fare il padrone degli ospiti e dei poverelli, tristo che sei: se no ti potrà capitare di peggio». Disse; e d’intorno al collo gli cinse l’immonda bisaccia tutta rattoppi e sbrendoli,21 appesa a una cinghia di cuoio. Poscia se ne tornò nella sala e si assise. Ed i Proci,
110 come lo videro, a ridere, a dirgli parole di lode:22 «Ospite, possa Giove concederti e gli altri Celesti tutto ciò che tu brami, che grato riesce al tuo cuore:23 che ci hai levato d’attorno quest’otre sfondato24, che il tozzo25 iva cercando per Itaca! E presto vogliamo spedirlo 115 per mare a Echeto re, flagello del genere umano». Tanto dicevano. E Ulisse fu lieto di questo saluto.
[117-156] Anfinomo, il più onesto dei Proci, si complimenta con Ulisse per la forza che ha dimostrato e gli augura che gli dèi gli concedano tutto quel che desidera. Il mendicante a sua volta augura ad Anfinomo, uomo di buon cuore, di poter presto tornare alla sua terra, prima che Ulisse torni a far strage dei Proci.
Penelope si mostra ai Proci
E Atena allor, ch’à glauche le ciglia, a Penelope in mente, alla figliuola scaltrissima d’Icario, infuse l’idea di presentarsi ai Proci, perché di più ardore avvampasse
160 l’alma dei giovani, ed essa più stima riscoter dovesse e dallo sposo e dal figlio, di quanta già prima ne aveva. Senza sapere perché, sorrise ella dunque, e sì disse: «Come non mai prima d’ora, Eurinome,26 il cuore m’ispira ch’io mi presenti ai Proci, per quanto li aborra;27 e a mio figlio
165 una parola vo’ dire che forse sarà per suo bene:
21 sbrendoli: “brandelli”.
22 Manca qui il verbo che regge gli infiniti. Si intende: (“cominciarono”) a ridere, a dirgli parole di lode
23 che grato riesce al tuo cuore: “che risulta gradito al tuo cuore”.
24 quest’otre sfondato: l’espressione si riferisce evidentemente a Iro, qui paragonato a un otre senza fondo per la sua insaziabilità. Ancora oggi è rimasto il modo di dire “pozzo senza fondo” per indicare una persona ingorda.
25 tozzo: “pezzo di pane”.
26 Eurinome è la fidata serva dispensiera a cui Penelope si rivolge.
27 aborra: il verbo aborrire significa “avere in odio”.
che troppo insieme ai Proci non resti, ché son quei superbi pieni di belle parole, ma tramano dietro l’insidia».
[168-185] La serva Eurinome approva il desiderio di Penelope, ma consiglia alla regina di curare il proprio aspetto detergendo il viso e spalmandovi un prezioso unguento, così da mostrarsi ai Proci in tutta la sua bellezza. Di fronte al secco rifiuto di Penelope, interviene Atena.
Altro allor volse in mente la diva occhicerula Atena:
sopra la figlia d’Icario effuse tranquillo sopore, l’addormentò reclina, sovresso il gran seggio, le membra abbandonate al riposo. Frattanto la Dea fra le Dee
190 doni le diede immortali, perché l’ammirassero i Proci. Prima sul viso bello cosparse l’unguento d’ambrosia onde pur essa la Dea di Citera dal serto vezzoso s’asperge,28 quando va fra l’amabile stuol de le Grazie. Quindi più alta la rese, più florida molto a vederla,
195 candida più la rese d’avorio pur ora fenduto.29
Quand’ebbe ciò compiuto, partì la divina signora, e dalle stanze le ancelle giungean dalle candide braccia, parlando ad alta voce, sicché, dal sopore riscossa, ella si stropicciò con le mani le palpebre e disse:
200 «Oh poveretta me, che morbido sonno m’ha presa! Oh, m’inviasse una morte sì amabile, Artemide pura,30 subito adesso, che più non debba distruggere in pianto questa mia misera vita per brama del caro mio sposo d’ogni virtù dotato, del primo in valor fra gli Achivi».
205 Poich’ebbe detto così, dalle fulgide stanze discese,
28 onde pur essa la Dea di Citera dal serto vezzoso s’asperge: “con il quale (onde) anche la dea di Citera dalla bella corona (dal serto vezzoso) si unge”. Si tratta di Venere, dea della bellezza, che si credeva fosse nata dalla spuma del mare presso l’isola di Citera.
29 candida più la rese d’avorio pur ora fenduto. Da ordinare così: la rese più candida dell’avorio pur ora fenduto. Minerva rende la pelle di Penelope luminosa e chiara, così come l’avorio quando è appena tagliato (fenduto); l’avorio, infatti, con l’uso e con il passare del tempo tende a ingiallire. Minerva dona a Penelope più bellezza e più fascino di quanto già non possegga, anche perché la donna sta per rivedere il marito dopo vent’anni. Quando infatti scenderà le scale, non si mostrerà solo ai Proci, ma, a sua insaputa, anche a Ulisse.
30 Una delle prerogative di Artemide era quella di donare alle donne una dolce morte con i suoi dardi: chi ne veniva colpito si addormentava per sempre senza provare dolore. Per questo motivo Penelope associa il proprio sonno alla morte.
sola non già, ma i suoi passi seguivano entrambe le ancelle. Or, come appena fra i Proci fu giunta la donna divina, alta, presso un dei pilastri, che il tetto reggevano, stette, chiusa nel morbido velo le gote; e le ancelle vezzose31
210 stavano entrambe ai suoi lati. Mancar le ginocchia a tal vista, tutti s’intesero i giovani, e i cuori molciti d’amore.32 […]
Ella a Telemaco, al figlio diletto, volgea la parola: “Più non t’assistono cuore né senno, Telemaco. Quando
215 eri tuttora fanciullo, vedevi assai meglio il tuo bene. Ora che fatto sei grande, che tocchi l’età più fiorente, e chicchessia ti guardasse, vedendoti come sei bello. come sei grande e gagliardo, direbbe felice tuo padre, or non hai più criterio, più salda la mente non hai:
220 poi che seguì tal fatto: che tu nella casa paterna hai tollerato che un ospite fosse così malmenato”.
E le rispose con tali parole Telemaco saggio:
“Non ti saprei biasimare, che tanto, o mia madre, t’adiri.
L’animo mio vede tutto, dal male sa scernere33 il bene,
225 ch’io più non son fanciullo; ma dato non m’è ch’io m’attenga sempre a giustizia,34 ché questi malvagi mi son sempre addosso, sempre di qua e di là m’incalzan, né c’è chi mi aiuti. Ben altra fine s’ebbe la zuffa fra l’ospite ed Iro che non voleano i Proci: la forza di quello prevalse.
230 Deh!, se mai Giove padre, se Atena volesse ed Apollo che nelle nostre case dovessero i Proci abbattuti le membra rilasciare così, dondolare la testa, uno dentro le stanze, quell’altro dinanzi alla porta, come quell’Iro adesso battuto sta lì nella corte,35
235 col capo tentennante, che un uomo ubbriaco ti sembra, né si può reggere più diritto sui pie’, né partire
31 vezzose: “dolci”, “premurose”.
32 Mancar le ginocchia a tal vista, tutti s’intesero i giovani, e i cuori molciti d’amore: “tutti i giovani alla vista di Penelope si sentirono mancare le ginocchia ed ebbero i cuori presi dall’amore”.
33 scernere: “distinguere”.
34 ma dato non m’è ch’io m’attenga sempre a giustizia: “ma non è possibile che io agisca sempre secondo giustizia”.
35 nella corte: “nel cortile”.
per rifugiarsi a casa, ché più non lo reggon le gambe”. Queste parole fra loro scambiavano il figlio e la madre; ed a Penelope Eurimaco volse così la parola:
240 «D’Icario figlia, regina, Penelope scaltra ed accorta, se ti vedessero tutti gli Argivi con tutti gli Achei, assai più pretendenti la vostra magione36 vedrebbe da mane a sera, a mensa, ché superi tutte le donne tu, per aspetto e bellezza, per savia37 finezza di mente».
245 E a lui queste parole rispose Penelope scaltra: «Tutte le doti mie distrussero, Eurimaco, i Numi, le forme, la bellezza, quel dì che verso Ilio gli Argivi sciolser le vele, e con loro partiva anche Ulisse mio sposo».
[249-266] Penelope rammenta il momento della partenza di Ulisse e le precise parole con cui si salutarono vent’anni prima; lo sposo, non sapendo se mai sarebbe tornato, aveva ordinato alla moglie di prendere un nuovo marito quando Telemaco fosse diventato un giovane.
«Presto verrà la notte che nozze aborrite m’appresti, misera me, poi che Giove mi volle privar d’ogni bene. Ma quanto grave cruccio su l’anima e il cuore mi pesa!
270 Questo non era l’uso degl’innamorati d’un tempo, quando una nobile donna figliuola d’un uomo opulento38 desideravano sposa, cercandone a gara il possesso; bensì portavano essi giovenchi, con pecore pingui, da banchettare i parenti, presenti offerivan di pregio,
275 non divoravano, senza pagar, le sostanze degli altri!»
Così diceva, e Ulisse divino tenace fu lieto ch’ella carpisse39 ai Proci regali, ed i cuor lusingasse con parolette melate, ben altro volgendo nel cuore. E a lei così rispose Antinoo, figlio d’Eupito:
280 «D’Icario figlia, saggia Penelope, i doni tu accetta di chicchessia degli Achivi, che voglia portarteli in casa,
36 la vostra magione: “la vostra casa”.
37 savia: “saggia”.
38 opulento: “ricco”.
39 carpisse: “estorcesse”, “prendesse”.
poi che non è cosa bella respingere doni. Ma noi non torneremo alle nostre faccende, né altrove, se prima tu non eleggi uno sposo fra noi, chi ti sembri il migliore».
[285-298] I pretendenti fanno a gara nell’offrire a Penelope doni preziosi, che le ancelle trasportano nella camera della regina.
Ulisse è preso di mira
[299-340] Quando scende la sera, Melanto, una delle ancelle, investe Ulisse con dei pungenti insulti e lo ammonisce a non vantarsi eccessivamente solo perché ha battuto Iro: egli resta comunque un povero mendicante. La reazione di Ulisse è spietata: minaccia Melanto di morte per le dure parole che gli ha rivolto. Le altre ancelle, spaventate, se la danno a gambe, mentre i Proci riprendono a farsi beffe dello straniero.
Primo il figliuol di Polibo, Eurimaco, queste parole disse, fra l’alte risa dei Proci, a dileggio d’Ulisse:40 «Datemi ascolto, voi, pretendenti dell’inclita donna: io voglio dire una cosa che l’animo dentro mi detta.
345 Non è qui giunto senza volere di Numi quell’uomo: questo baglior di faci s’effonde, se pur non m’inganno, dalla sua fronte, ché in testa non gli è più rimasto un capello!»41 Disse così; poi volse tai detti ad Ulisse guerriero: «O forestiere, vorresti, se io ti prendessi e ti dessi
350 quanto salario ti basti, servire lontano pei campi, fare fascine di pruni, piantare grandi alberi? Il cibo somministrare lì ti farei tutti i giorni, le vesti io ti darei da coprirti, le scarpe da mettere ai piedi. Ma l’arte del briccone tu hai solo appresa, e il lavoro
355 poco ti piacerà: vorrai mendicar fra la gente, e pittimare, sinché rimpinzi l’ingordo tuo ventre».42
E di rimando, Ulisse rispose con queste parole:
40 a dileggio d’Ulisse: “per deridere Ulisse”.
41 Eurimaco sembra voler frenare la violenza dei Proci, asserendo che lo straniero è mandato dagli dèi; ma poi bruscamente si fa beffe dell’idea di una presenza divina, dicendo che la luce (baglior di faci) che sembra irradiarsi da Ulisse in realtà proviene dalla sua testa calva.
42 pittimare, sinché rimpinzi l’ingordo tuo ventre: “infastidire (pittimare) finché non riempi (rimpinzi) il tuo ventre ingordo”.
«Se fosse gara fra noi, chi più a lungo resista al travaglio, di primavera, quando, Eurimaco, i giorni son lunghi, 360 a falciar l’erba, e in pugno m’avessi una falce ricurva, ed una simile tu,43 provando chi fa più lavoro, sino al tramonto digiuni restando, e ci fosse tanta erba, o se ci fossero buoi da spingere, quelli più forti, grandi, lucenti di pelo, ben d’erba pasciuti, di possa 365 simili,44 simili d’anni, che grande la forza ne fosse, e quattro iugeri,45 e sotto l’aratro s’aprisser le zolle, tu mi potresti vedere se dritto so schiudere il solco.
Che se la guerra oggi stesso piacesse eccitare al Cronide, d’onde che fosse, e uno scudo m’avessi con due giavellotti 370 ed un elmetto di bronzo calcato d’intorno alle tempie, tu ne le prime file combattere allor mi vedresti, né, rampognando il mio ventre,46 staresti a colpirmi d’ingiurie; adesso, invece, cuore scortese che sei, tu m’ingiurî, e ti figuri d’essere un forte campione, un grand’uomo,
375 perché tu sei fra questi dappoco, e non già fra valenti.
Ma se, tornando, Ulisse giungesse alla terra natale, ti sembrerebbe angusta,47 per quanto sian larghi i battenti, la porta, quando tu la infilassi, per dartela a gambe!»
Disse, e di cruccio più fiero s’accese ad Eurimaco il petto;
380 e bieco lo guardò, alate parole rispose: «Presto vo’ darti il malanno,48 pitocco cialtrone, che cianci con tanta tracotanza dinanzi a tanti uomini, senza punto sgomento nell’animo. O il vino t’ha dato alla testa, oppure indole è tua di sperdere chiacchiere al vento».
385 Come ebbe detto, diede di piglio a un panchetto; ma Ulisse, chino, d’Anfinomo presso si strinse ai ginocchi, schivando l’ira d’Eurimaco; e questi colpì la man dritta al coppiere.
Diede un rimbombo, al suolo cadendo, la brocca; e il fanciullo
43 ed una simile tu (sottinteso: “ne avessi in pugno”).
44 di possa simili: “simili nella forza”.
45 e quattro iugeri: “e (se il campo fosse di) quattro iugeri”.
46 rampognando il mio ventre: “rimproverando il mio ventre”, cioè “rinfacciandomi il bisogno di cibo”.
47 angusta: “stretta”.
48 vo’ darti il malanno: “voglio punirti”.
sopra il piantito49 piombò, con un gemito lungo. Ed i Proci
390 alto levaron frastuono che l’ombra varcò de le sale.
E favellavan così, l’uno all’altro rivolto al vicino: «Deh!, fosse andato altrove, a rompersi il collo, lontano di qui, questo foresto che provoca tanto subbuglio.
Ora per un pitocco ci stiamo azzuffando! E finito
395 è della mensa il piacere, perdendoci in queste miserie!»
E questo disse allora Telemaco, stirpe divina: «Bravi signori, vi gira la testa, né i cibi ed il vino più vi riesce a nascondere,50 e un demone certo v’incita; bene pasciuti siete, tornate a casa a dormire,
400 se pur n’avete voglia, ché io non discaccio nessuno».
Disse così. Tutti quelli si morser le labbra coi denti, stupefacendosi come Telemaco ardito parlasse.
E la parola prese Anfinomo e disse: «Compagni, niuno tra voi s’adiri per queste sue giuste parole,
405 né rimbeccar lo voglia con dure parole a contrasto.
Non maltrattate più degli ospiti alcun, dei famigli che nella casa vivon d’Ulisse divino! Su via, vada il coppiere in giro, nei calici il vino dispensi, sì che si libi, e torni ciascuno al suo tetto al riposo;
410 e lo straniero qui, sotto il tetto si lasci d’Ulisse, che n’abbia cura Telemaco: è lui della casa il padrone».
[412-418] I pretendenti rimangono persuasi dalle parole di Anfinomo e, dopo aver compiuto un sacrificio agli dèi, vanno a dormire ciascuno nella propria casa.
49 piantito: “pavimento”.
50 né i cibi ed il vino più vi riesce a nascondere: “non riuscite più a nascondere che vi siete ingozzati di troppo cibo e troppo vino”.
Libro XIX
Il trasporto delle armi
Ma nella sala Ulisse divino, tenace, restava,1 e con Atena andava tramando la morte dei Proci; e prima queste alate parole a Telemaco volse: «L’armi da guerra tutte, Telemaco, adesso bisogna
5 riporre altrove; e se t’interroga alcuno dei Proci, se vuol sapere, di’ queste blande parole a quetarlo: “L’ho tratte giù dal fumo, perché più non sembrano quelle che Ulisse un giorno qui lasciava, partendo per Troia, ma brutte sono, ovunque le giunse2 la vampa del fuoco.
10 E poi, questo più grave pensiero m’ispira un Celeste: che voi, presi dal vino, possiate venire a contesa, e l’un l’altro ferirvi, macchiare il banchetto e le nozze col sangue vostro; il ferro da solo trascina la gente”».3 Così disse. E, obbedendo Telemaco al padre diletto,
15 dalle sue stanze chiamò Euriclea, la nutrice, e le disse: «Dentro le stanze, o mamma,4 trattienimi un po’ le fantesche,5 ché radunar nella sala voglio io le belle armi del padre, che giaccion per la casa neglette,6 ed il fumo le oscura, da che partì mio padre, mentre ero tuttora bambino.
20 Porre le voglio dove non giunga l’afflato7 del fuoco». E gli rispose così la fida nutrice Euriclea: «Oh!, se davvero un giorno prendessi il partito, figliuolo, di custodire i tuoi beni, di darti pensier della casa!
1 I Proci si sono allontanati per andare a riposare e Ulisse resta solo nella stanza con il figlio Telemaco.
2 giunse: “raggiunse”.
3 il ferro da solo trascina la gente: “la sola vista delle armi spinge la gente alla rissa”.
4 mamma. Telemaco si rivolge in modo molto affettuoso e confidenziale a Euriclea, la quale lo ha allevato come una seconda madre.
5 fantesche: “serve”.
6 neglette: “trascurate”, “abbandonate”.
7 afflato: propriamente “soffio”. Qui indica la vampa del fuoco.
Ma chi ti seguirà recando la luce? Le ancelle,
25 che lo potevano fare, non vuoi che abbandonin le stanze!”
Queste parole a lei rispose Telemaco scaltro: “Mi seguirà lo straniero, perché non voglio io che poltrisca niuno che mangi il mio pane, per quanto da lungi sia giunto».
Così dunque parlò; né l’altra soggiunse parola,
30 e tutte quante le porte serrò delle comode stanze. All’opera allor pronti, Ulisse ed il fulgido figlio gli elmetti trasportaron, le aguzze zagaglie, gli scudi ombelicati di borchie.8 Reggendo una fiaccola d’oro, Pallade Atena effondeva d’intorno bellissima luce.
35 E volse allora al padre Telemaco queste parole:
«O padre mio, che grande miracolo scorgon questi occhi?
Vedi che le pareti, le travi di pin della stanza, i bei tramezzi, e l’alte colonne che reggono il tetto, brillano al guardo come se qui scintillasse un gran fuoco?
40 Certo è qui alcuno dei Numi che reggono il cielo infinito».
E gli rispose così l’accorto pensiero d’Ulisse: «Taci, ed i tuoi pensieri raffrena; né più dimandare.
Tale il costume è appunto dei Numi che reggon l’Olimpo.9
Recati adesso a dormire tu dunque, mentre io qui rimango:
45 mettere voglio ancora a prova le ancelle e tua madre, che m’interrogherà, la misera, punto per punto».
Così disse; e traverso la sala, al chiaror delle faci,10 mosse Telemaco, entrò, per dormir nella stanza, ove sempre solea giacere, quando su lui discendeva il sopore.
50 Quivi dunque, attendendo l’Aurora divina, si giacque.
Entro la sala invece Ulisse divino rimase, che con Atena andava tramando la morte dei Proci.
8 ombelicati di borchie. Gli scudi avevano al centro uno o più dischi di bronzo, o borchie, che somigliavano a degli ombelichi.
9 Tale il costume è appunto dei Numi che reggon l’Olimpo: “questa è appunto l’abitudine degli dèi”, cioè quella di assistere gli uomini senza tuttavia mostrarsi.
10 faci: “torce”, “fiaccole”.
[53-95] Nella sala Ulisse rimane dunque solo. Appare allora Penelope, decisa a incontrare lo straniero per interrogarlo circa il marito scomparso. La accompagnano le serve, le quali, appena entrate, iniziano a riordinare la mensa abbandonata dagli arroganti pretendenti. Una di queste, Melanto, serva impertinente, si rivolge a Ulisse con parole sprezzanti, cercando di allontanarlo dalla sala, ma viene duramente richiamata da Penelope. La donna, infine, si rivolge allo straniero:
E poi queste parole rivolse alla fida massaia:11 «Uno sgabello porta, con pelli da stendervi sopra, Eurinome, sicché lo straniero vi segga e mi parli e ciò ch’io dico ascolti, ché volgergli debbo dimande».
100 Disse così. L’attenta massaia portò lo sgabello subito, a terra lo pose, distese sovra esso le pelli. Quivi a sedere Ulisse tenace divino si pose.
E cominciò per prima Penelope scaltra a parlare: «Questo ti chiedo prima, straniero: chi sei? La tua gente
105 qual è? Dov’è la tua città? Dove sono i parenti?».
E a lei così rispose l’accorto pensiero d’Ulisse: «Niun dei mortali, o divina, sovressa l’illimite12 terra biasimo apporti potrebbe,13 ché al cielo perviene tua fama, come d’un qualche re senza macchia, che tema i Celesti,
110 che sovra molte genti magnanime tenda lo scettro e la giustizia onori. La terra feconda gli cresce orzo e frumento, gravati son gli alberi tutti di pomi, figliano senza mai sosta le greggi, offre il pelago i pesci: tanto il suo buon governo gli frutta; e la gente è felice.
115 Perciò sotto il tuo tetto rivolgimi ogni altra dimanda; ma non mi chiedere, no, la mia stirpe, la terra materna, se tanto più non vuoi gravare il cuor mio di cordoglio, pure al ricordo, ché molto sono io sventurato, e sconviene starsene in casa d’altri levando lamenti e piatendo.14
11 massaia: ci si riferisce a Eurinome; il soggetto della frase è Penelope.
12 illimite: letteralmente “senza limite”, in quanto formato da in (negazione) e limite.
13 biasimo apporti potrebbe: “potrebbe rimproverarti”.
14 piatendo: “piangendo”, “lamentandosi”.
120 Nulla di peggio v’è che un pianto perenne; ed io temo che delle ancelle alcuna si crucci, o tu stessa non dica che in lagrime io mi struggo perché sono pieno di vino».
[123-201] Ulisse prova dunque a evitare le domande di Penelope adducendo come scusa il gran dolore che il ricordo gli provocherebbe. Ma Penelope non abbandona le proprie intenzioni: narra allora all’ospite la propria tristissima storia, la scomparsa del marito, le insidie dei Proci e i suoi disperati tentativi di rimandare le nozze, mostrandosi disposta a raccontare tutto quanto per filo e per segno, nonostante il ricordo di ciò debba sicuramente procurarle infinito dolore. A questo punto Ulisse non può essere da meno, non può a sua volta sottrarsi al doloroso racconto, e inventa una storia per continuare a nascondere la sua vera identità. Si presenta come Etone, un cretese, figlio di Deucalione, e afferma di aver incontrato Ulisse sulla propria isola quando questi vi fece sosta per dodici giorni, durante il viaggio verso Troia.
Così molte menzogne parlava in sembianza di vero; e udiva quella, e pianto versava, e bagnava le guance. Come su l’alte cime dei monti si fonde15 la neve,
205 dove da Zefiro fu cospersa,16 quando Euro la scioglie,17 e, mentre si dissolve, si gonfiano i letti dei fiumi, così le guance belle struggevano lagrime e pianto.
Piangeva ella il suo sposo, che l’era dinanzi. Ed Ulisse pietà della sua donna sentìa, di sue lunghe querele,18
210 ma gli occhi al par di corno restavano, al pari di ferro, nelle palpebre immoti,19 ché ad arte frenava il suo pianto.
Poi che si fu sazïata la donna di gemiti e pianti, di nuovo a lui rivolta, parlò queste alate parole: «Ora davvero porre ti debbo alla prova, straniero,
215 se veramente colà, sì come tu dici, ad Ulisse offristi ed ai suoi prodi compagni la casa ospitale.
Dimmi che specie mai di vesti ei cingeva alle membra,
15 si fonde: “si scioglie”.
16 cospersa: “sparsa”; per i Greci, Zefiro era un vento freddo che, soffiando da nord-ovest, portava freddo e neve.
17 Euro invece era un vento caldo proveniente da sud-est, che scioglieva ghiacci e nevi.
18 querele: “lamenti”.
19 Gli occhi di Ulisse restano immobili, duri come le corna di un animale o come il ferro: egli non vuole che il pianto lo tradisca, rivelando così a Penelope la sua vera identità.
e quale era di lui l’aspetto e dei prodi compagni».
E le rispose così l’accorto pensiero d’Ulisse:
220 «Donna, difficile cosa parlare d’un uomo lontano, da tanto e tanto tempo, ché già son trascorsi venti anni, dal giorno ch’ei lasciò la mia patria, la casa ospitale.
Pur tuttavia ti dirò com’egli m’appare alla mente. Aveva Ulisse, sangue divino, un mantello a due doppi20
225 di porpora, villoso:21 stringealo una fibula d’oro con una gemina staffa.22 Immagini ornavano il dorso: coi piedi un can premeva, stringeva fra i denti un cerbiatto varïopinto, che tutto guizzava, stupore a vederli, ch’erano d’oro; e quello mordeva, strozzava il cerbiatto,
230 e questo, pur tentando fuggire, guizzava coi piedi. Ed una tunica vidi, che tutte cingeagli le membra, fulgida, fine come la buccia d’un arido pomo, così morbida; e come la luce del sole fulgeva, sì che a mirarlo stupite restavano femmine molte.
235 E un’altra cosa ancora ti dico, e tu figgila in mente: non so se tali vesti Ulisse le prese di casa, o se qualcun degli amici, degli ospiti alcuno, mentr’egli era per mar, gliele diede, ché amico era Ulisse di molti, ché tra gli Achivi ben pochi potevano stargli alla pari.
240 Ed una spada allora gli diedi di bronzo, e una bella tunica doppia, che ai pie’ gli scendeva, di porpora; e seco a fargli scorta mossi fin presso alla rapida nave. Ed un araldo poco di lui più provetto negli anni, seguialo; ed anche questo ti dico qual era d’aspetto:
245 curvo di spalle, nero di pelle, di chiome ricciute; era il suo nome Euribàte; e lui più che gli altri compagni molto pregiava Ulisse, ché aveva concordi pensieri». Così disse. E la brama di pianto nel cuore alla donna crebbe ancor più, ché i segni conobbe descritti da Ulisse.
20 un mantello a due doppi: un mantello così grande che ci si poteva avvolgere dentro due volte.
21 villoso: “con molto pelo”, quindi adatto a scaldare.
22 stringealo una fibula d’oro con una gemina staffa. Il mantello di Ulisse era tenuto stretto da una spilla (fibula) dorata, la quale aveva un doppio (gemina) aggancio (staffa).
250 E poi che fu sfogata la brama del flebile23 pianto, schiuse a rispondere allora le labbra, così prese a dire: «Se pïetosa cura, nel cuor poco fa mi destavi, ospite, or sotto il mio tetto sarai venerato ed amato, però ch’io stessa diedi le vesti che dici ad Ulisse.
255 ben ripiegate, come le tolsi di stanza; e una fibbia per ornamento v’aggiunsi. Ahimè, che vederlo di nuovo più non potrò, che al suo tetto ritorni, alla terra paterna, ché con sinistro augurio Ulisse salpò su le navi verso Ilio maledetta, che pur non vorrei nominare!»
260 E a lei così rispose l’accorto pensiero d’Ulisse: «O veneranda consorte d’Ulisse, figliuol di Laerte, il tuo bel viso più non sciupare, non struggerti il cuore per singhiozzare il tuo sposo. Rampogna non già te ne faccio: ogni altra donna ch’abbia perduto il legittimo sposo
265 che a lei s’unì d’amore, che n’ebbe figliuoli, lo piange, anche se Ulisse non sia, cui24 dicono pari ai Celesti. Ma tuttavia desisti dal pianto25 ed ascolta i miei detti: ch’io voglio dirti, senza mentire né asconderti nulla, ciò che narrare udii poco fa del ritorno d’Ulisse, 270 poco lontano di qui, fra le tesprote genti felici:26 che Ulisse vive, e porta con sé molti e rari cimelî,27 che asilo fra le genti riceve; ma i cari compagni perse e la rapida nave, nel mare purpureo, salpando dall’isola Trinacria, per l’ira del Sole e di Giove, 275 ché aveano i suoi compagni sgozzati i giovenchi del Sole. Quelli morirono tutti tra il fiero ondeggiare del ponto; su la carena28 Ulisse gittato fu invece dai flutti al suolo dei Feaci, che sono parenti dei Numi,
23 flebile: “appena percettibile”, “debole”. Quello di Penelope era dunque un pianto pieno di dolore e rassegnazione.
24 cui: “che” (pronome relativo con funzione di complemento oggetto).
25 desisti dal pianto: “smetti di piangere”.
26 I Tesproti abitavano le coste dell’Epiro, a poca distanza dall’isola dei Feaci. Pur mentendo, Ulisse cerca di rimanere quanto più possibile vicino al reale svolgimento dei fatti.
27 cimelî: “oggetti preziosi”.
28 La carena è la “chiglia” della nave, aggrappandosi ai resti della quale Ulisse poté giungere a Scheria, isola dei Feaci, trascinato dalle onde marine.
che di gran cuore onore gli fecero come a un Celeste, 280 gli offriron molti doni, e incolume in patria essi stessi voleano accompagnarlo. E qui già sarebbe da un pezzo Ulisse, ma però gli parve migliore partito per molte terre andare vagando, e ammassare ricchezze: tanto nel lucro Ulisse più scaltro è degli uomini tutti, 285 né dei mortali alcuno contendere seco potrebbe. Questo mi raccontò Fidone, dei Tesproti sire».
[287-348] Ulisse, non ancora riconosciuto dalla moglie, le assicura che il marito sarebbe tornato a casa in meno di un anno, ma Penelope presente invece che non lo rivedrà più, e crede quindi che lo straniero si stia illudendo. La donna comanda alle serve di lavare e vestire Etone (questo è il nome che aveva assunto Ulisse), poiché vede in lui un amico di Ulisse e poiché occorre sempre mostrarsi cortesi e ospitali con tutti. Ulisse però, con molta umiltà, non vuole che alcuna ancella gli lavi i piedi, a meno che questa non sia vecchia e abbia molto sofferto: egli infatti vuole farsi servire solo da chi gli è sinceramente compagno nella sventura. Penelope approva la saggezza dell’ospite e lo affida alle cure della vecchia Euriclea.
«Ospite caro, fra quanti stranieri mi giunser da lungi
350 alla mia casa, nessuno fu mai più assennato, più caro: tanto assennato e giusto mi par tutto quello che dici.
C’è nella casa una vecchia di sano giudizio, ed accorta, che crebbe ed allevò quel misero:29 ché tra le braccia subito l’ebbe, dacché30 la madre lo diede alla luce.
355 Essa ti laverà, per quanto sia debole, i piedi. Dunque, Euriclea fedele, tu alzati subito, e lava l’ospite: esso ha l’età del tuo signore: ché Ulisse simili a questo avrà piedi e mani pur egli: ché presto, se la sciagura li opprime, divengono vecchi i mortali».
La cicatrice
[360-374] Ricordando le sciagure del caro padrone disperso, la vecchia serva, Euriclea, si accinge a lavare i piedi dello sciagurato ospite cretese.
29 quel misero: Penelope si riferisce a Ulisse.
30 dacché: “da quando”.
375 «Dunque, io ti laverò, per amor di Penelope, e insieme per amor tuo, ché il cuore mi sento balzare nel seno per le sciagure tue. Tu, poi, ciò ch’io dico comprendi. Molti giunsero qui fra noi sventurati stranieri, ma niuno, ti dirò, vidi mai tanto simile a Ulisse,
380 quanto di forme tu gli somigli, di voce, di piedi». E le rispose Ulisse, l’eroe dall’accorto pensiero: «Vecchia, dicon così tutti quelli che ci hanno veduti Ulisse e me: che siamo l’immagine l’uno dell’altro, come tu stessa adesso, che ben m’osservi, mi dici».
385 Così disse. Portò la vecchia una conca lucente, dove soleva i piedi lavare; e molta acqua v’infuse, gelida, ed altra calda ne aggiunse. Ed Ulisse, frattanto, lungi dal focolare sede’, verso l’ombra si volse, ché subito teme’ che quella vedere potesse
390 la cicatrice,31 e tutto venisse scoperto. La vecchia, fattasi presso, a lavare si diede il signore. E conobbe subito la ferita che un verro32 una volta gl’inferse col bianco dente, quando movea con Autòlico33 e i figli verso il Parnaso.34
[394-465] Omero racconta la storia della ferita di Ulisse. Quando l’eroe nacque, venne a trovarlo il nonno Autolico, il quale gli pose il nome di Ulisse e gli promise ricchi doni, che egli sarebbe dovuto andare a prendere una volta che fosse cresciuto. Divenuto ragazzo, Ulisse andò dunque a trovare Autolico e lì rimase alcuni giorni. Un giorno, partecipando a una battuta di caccia con il nonno e con i suoi figli, il giovane Ulisse si imbatté in un grosso cinghiale, sul quale ebbe la meglio, senza tuttavia poter evitare che l’animale lo mordesse vicino al ginocchio, procurandogli una ferita di cui Ulisse avrebbe conservato per sempre la cicatrice.
31 Ulisse ha sulla gamba una cicatrice che lo caratterizza e che la vecchia Euriclea ben conosce.
32 verro: “cinghiale”.
33 Autolico, figlio di Mercurio, fu padre di Anticlea, madre di Ulisse, e quindi nonno di quest’ultimo.
34 Il Parnaso è un monte della Grecia, a nord del Peloponneso, dove risiedeva il nonno di Ulisse e dove, secondo la tradizione, avevano casa le nove Muse. Esse erano le dee ispiratrici delle arti: Calliope era la musa della poesia epica, Clio della storia, Erato della poesia amorosa, Euterpe della poesia lirica, Melpomene della tragedia, Polimnia del mimo, Talia della commedia, Tersicore della danza e Urania dell’astronomia.
Dunque la vecchia, prone tendendo le mani a lavarlo, al tocco la ferita conobbe. Cader lasciò il piede,35 e nella conca la gamba piombò; diede il rame un rimbombo, si reclinò da una banda,36 al suol cadde l’acqua rovescia.
470 Gioia ed ambascia insieme le strinsero l’animo: gli occhi le si gonfiaron di pianto, la voce rimase strozzata. E carezzando il mento d’Ulisse, così gli diceva: «Dunque, sei proprio Ulisse! Né io, figlio mio, riconobbi il mio signore, avanti che il pie’ non gli avessi palpato!»
475 E, così detto, verso Penelope gli occhi rivolse, ché dello sposo dirle volea, ch’era qui, nella stanza. Ma quella né badarle potè, né pur volger lo sguardo: tanto il pensiero Atena le aveva offuscato. Ed Ulisse subito la ghermì con la destra, la strinse alla gola,
480 e con la manca37 a sé presso traendola, questo le disse: «Perché dunque, nutrice, mi vuoi rovinare? Tu stessa m’hai sul tuo seno cresciuto! Adesso, trascorsi venti anni, dopo tanti travagli, son giunto alla terra materna, e poi che conosciuto m’hai tu, che svelato m’ha un Nume,
485 taci, che nessun altro lo venga a saper nella casa. Perché questo io ti dico che certo avverrà. Se tu parli, e a me conceda un Dio ch’io stermini i Proci superbi, non ti risparmierò, sebbene tu sii mia nutrice, allor che ucciderò tutte quante le ancelle di casa».
490 E gli rispose queste parole la scaltra Euriclea: «Qual detto, figlio mio, t’uscì dalla chiostra dei denti? Tu sai qual forza ho in seno, ch’è salda, che mai non si flette!
Come la dura pietra resister saprò, come il ferro.
E un’altra cosa ancora ti dico, e tu figgila in mente.
495 Se col tuo braccio un Dio fiaccherà l’arroganza dei Proci, allora io ti dirò tutte quante le ancelle di casa, quelle che oltraggio ti recano, e quelle che son senza colpa».
35 Cader lasciò il piede. Per poterlo lavare con cura, Euriclea teneva il piede di Ulisse sollevato. La prima reazione che ebbe in seguito alla sorprendente scoperta fu quella di lasciar cadere il piede dell’ospite nel catino (conca).
36 si reclinò da una banda: “si piegò su un lato”.
37 La manca è la mano sinistra.
E a lei così rispose l’accorto pensiero d’Ulisse: «Nutrice, e perché mai tu dici così? Non lo devi. 500 Bene osservare io stesso saprò, riconoscerle io stesso. Ma più non dir parole, rimetti la cosa ai Celesti». Così disse; e la vecchia si mosse traverso la stanza, a prendere acqua ancora, ché s’era versata38 la prima. E quando l’ebbe poi lavato, spalmato con l’olio, 505 Ulisse accanto al fuoco di nuovo portò lo sgabello, per riscaldarsi, e sotto i cenci coprì la ferita.
Il sogno di Penelope e la prova delle scuri
[507-551] Penelope trattiene ancora qualche istante il proprio ospite, poiché vuole raccontargli un sogno fatto pochi giorni prima. Nel sogno la moglie di Ulisse si trova a guardare le venti oche che beccano il mangime nel cortile di casa. A un certo punto dal cielo scende un’aquila che uccide tutte le oche. Penelope e le ancelle piangono gli animali scomparsi, ma l’aquila scende nuovamente, e, avvicinandosi a lei, le profetizza il ritorno di Ulisse e la strage dei Proci, spiegandole che lei, l’aquila, simboleggia l’eroe itacese e che le oche simboleggiano gli arroganti pretendenti. Penelope chiede all’ospite di interpretare tale sogno, sebbene nel sogno stesso l’aquila le abbia voluto fornire una spiegazione.
E le rispose così l’accorto pensiero d’Ulisse:
«In nessun modo, o donna, possibil non è di tal sogno volgere altrove il senso, se Ulisse medesimo ha detto 555 com’ei lo compierà.39 Sui Proci sovrasta la morte, su tutti, e niun potrà sfuggire il ferale40 destino».
E gli rispose la scaltra Penelope queste parole: «Sono difficili a intendere i sogni, son privi di senso, ospite; e ciò che v’appare non tutto si compie ai mortali.
560 Infatti, sono due le porte dei labili41 sogni:
38 versata: “rovesciata”, “versata a terra”.
39 se Ulisse medesimo ha detto com’ei lo compierà. Ulisse, sotto forma di aquila, ha appena parlato alla moglie nel sogno, profetizzandole la strage dei Proci: non è dunque possibile, afferma l’eroe, interpretare il sogno in alcun altro modo.
40 ferale: “terribile”, “mortale”.
41 labili: “deboli”; nello specifico, i sogni sono deboli in quanto svaniscono subito, sono evanescenti.
sono di corno le imposte nell’una, nell’altra d’avorio; e i sogni che traverso ci giungon le lastre d’avorio, sono ingannevoli, e i detti che recan non giungono al fine; ma quelli che traversan la porta di lucido corno, 565 all’uomo che li scorge prenunzian veridici eventi.
Ma che di qui sia giunto non spero il terribile sogno: bello sarebbe troppo per me, pel diletto mio figlio!
E un’altra cosa ancora ti dico, e tu figgila in mente: troppo odïosa per me quell’alba sarà che mi spinga
570 lungi dal tetto d’Ulisse. Perciò vo’ proporre una gara: le scuri ch’egli in casa soleva una volta disporre come puntelli di nave42 in fila; son dodici in tutto, e tutte traversarle da lungi solea con un dardo.43 Questo cimento44 ai Proci vo’ adesso proporre, e qual d’essi
575 più facilmente di tutti riesca a tendere l’arco, e con la freccia saprà traversare le dodici scuri, quello potrei seguire, lasciando il legittimo tetto del mio consorte, bello qual è, d’ogni bene ricolmo, di cui sempre dovrò ricordarmi, persino nei sogni».
580 E le rispose così l’accorto pensiero d’Ulisse: «O vereconda sposa d’Ulisse figliuol di Laerte, più a lungo in casa tua differir45 non ti piaccia la gara, ché prima tu vedrai qui giungere Ulisse sagace, prima che questi provando le mani su l’arco lucente, 585 tendan la corda, e avventin la freccia traverso le scuri».
[586-602] Nonostante la sua compagnia le risulti molto gradita, Penelope congeda l’ospite e lo manda a dormire, recandosi a sua volta nella propria stanza. Una volta sola, la donna libera il pianto a lungo trattenuto, commiserando la triste sorte del marito e la propria. Giunge allora Minerva a infonderle sulle ciglia un dolce sonno.
42 come puntelli di nave. Penelope ricorda il modo in cui il marito disponeva le scuri, ovvero alla maniera in cui si sistemano i puntelli che reggono i fianchi di una nave in costruzione.
43 Le scuri, piantate a terra dalla parte del manico, avevano nella parte superiore un’apertura ad anello. Ulisse era capace di far passare una freccia attraverso gli anelli di dodici di esse, disposte in fila a una certa distanza l’una dall’altra.
44 cimento: “prova”, “impresa”.
45 differir: “rinviare”, “rimandare”.
L’ultimo banchetto
La notte insonne
[1-13] Stesa una pelle di bue a terra, Ulisse si prepara a passare la notte nell’atrio del palazzo. Tuttavia è ben difficile per l’eroe riuscire a prendere sonno, poiché sono troppi i pensieri che lo assalgono: le fatiche patite, la pena della moglie, la vendetta da compiere.
Ma in seno il suo cuore latrava come una cagna che accorre dei teneri cuccioli a schermo1
15 contro ad un uomo ignoto, che latra ed è pronta alla lotta.
In seno il cuor così gli latrava per quelle sozzure; e il petto ei2 si batteva, così gli volgeva rampogna: «Tollera, cuore mio! Patisti un tormento più cane3 quel dì che Polifemo, l’orribile mostro, sbranava
20 i miei compagni prodi. Tu allor tollerasti, ed infine dall’antro ove pensavi morire ti trasse il mio senno».4 Così disse a rampogna del cuor che gli ondava nel seno.
E obbediente in tutto gli fu, pazïente il suo cuore, senza dar crollo. Pure egli s’andava qua là voltolando.5
25 Come talvolta un uomo sovresso un gran fuoco che arde va voltolando un ventricolo pieno di sangue e di grasso di qua di là, perché si possa più presto arrostire, Ulisse parimenti qua e là si girava, pensando come gittar le mani potesse sui Proci sfrontati,
30 ch’erano molti, ed ei solo. E Atena, discesa dal cielo,
1 a schermo: “a difesa”.
2 ei. Il pronome soggetto si riferisce a Ulisse.
3 Patisti un tormento più cane: “soffristi un tormento peggiore”. Si pensi anche all’espressione freddo cane per indicare un freddo insopportabile.
4 dall’antro ove pensavi morire ti trasse il mio senno. Ulisse sta parlando al proprio cuore spaventato: “la mia intelligenza ti fece uscire (ti trasse) dalla grotta (antro) dove pensavi di dover morire”.
5 voltolando: “girandosi”. Ulisse si rivoltava continuamente nelle coperte; dal sonno inquieto traspare la sua agitazione.
presso gli giunse, e aveva sembianza di donna mortale.
E stando a lui sul capo parlò queste ratte6 parole: «Perché stai così desto, tapino fra tutti i mortali? Pur la tua casa è questa, pur qui la tua sposa soggiorna,
35 e un figlio quale ognuno vorrebbe che fosse suo figlio!»
E le rispose così l’accorto pensiero d’Ulisse: «O diva, tutto quello che dici risponde a giustizia. Ma questo punto andava nel seno volgendo il mio cuore: come potrò sui Proci sfrontati gittare le mani,
40 ch’io sono solo, ed essi qui dentro son sempre una frotta. E un altro punto ancora più grave mi preme la mente: se mercé tua, mercé di Giove, ad ucciderli io valgo, dove potrò fuggire? Vorrei che tu ciò mi dicessi».
E gli rispose Atena, la Diva da gli occhi azzurrini:
45 «In un compagno di me più gramo7 altri avrebbe pur fede, che pur mortale fosse, che quello ch’io so non sapesse. Stolto! Ch’io sono Dea, ché a difenderti sempre provvedo in tutti i tuoi travagli. Questo ora ben chiaro ti dico: pur se cinquanta schiere ci avessero chiusi nel mezzo
50 di guerrïeri mortali bramosi di abbatterti in zuffa, tu prenderesti ad essi le pecore pingui e i giovenchi.8
Dunque abbandonati al sonno, ché troppo molesto è vegliare tutta la notte insonne, né a lungo più devi patire». Così disse. Ed a lui sopore versò su le ciglia,
55 ed essa ritornò, la Dea, fra le Dive d’Olimpo. Quando il sonno che scioglie le membra e le pene del cuore ebbe ghermito l’eroe, si destò la sollecita sposa, e su molli coltri levata a sedere, piangeva. E quando il cuore suo fu poi sazïato di pianto,
60 prima ad Artemide volse la donna divina una prece: «Figlia di Giove, Artemide, Dea veneranda, oh!, se infine scagliandomi una freccia nel seno tu pur m’uccidessi
6 ratte: “rapide”.
7 più gramo: “più debole”.
8 tu prenderesti ad essi le pecore pingui e i giovenchi. Minerva spiega a Ulisse che, grazie al suo aiuto, avrebbe potuto anche combattere contro cinquanta schiere di guerrieri e risultarne vincitore, potendo dunque rubare loro il bestiame come bottino di guerra.
subito adesso, oppure, ghermitami qualche procella, mi trasportasse via9 pei tramiti10 oscuri dell’Ade, 65 o mi gittasse alle foci d’Oceano11 che lungi fluisce, come le figlie ghermì di Pandaro un dì la procella!»12
[67-121] Ulisse si sveglia e chiede a Giove di mostrargli il suo favore attraverso qualche segno. Il dio non tarda a mandare all’eroe un duplice presagio. Dapprima un tuono esplode nel cielo, che pure non contiene alcuna nuvola; in seguito una delle serve che lavorano alla macina del palazzo prega Giove affinché i Proci vengano allontanati in quel giorno stesso. Nella mente di Ulisse allora inizia ad abitare la certezza che avrebbe punito con successo gli empi pretendenti.
[122-159] Il giorno in cui si sarebbe compiuta la strage dei Proci inizia come una normale altra giornata. Telemaco si alza e si informa presso Euriclea riguardo allo straniero. La vecchia serva, animata da una nuova contentezza, dirige i lavori domestici delle altre serve: chi accende il fuoco, chi spazza, chi lava il pavimento, chi sistema i tappeti, chi mette in ordine le mense e le stoviglie, chi va alla fontana a procurare l’acqua.
160 I servi degli Achei frattanto giungevano. E allora presero a fender legna con abili colpi; e le donne tornaron dalla fonte. Dopo essi giungeva il porcaro,
9 ghermitami qualche procella, mi trasportasse via: “qualche turbine mi rapisse, dopo avermi afferrato (ghermitami)”.
10 tramiti: “sentieri”.
11 alle foci d’Oceano. I Greci ritenevano che il mondo intero fosse circondato completamente da un unico grande fiume, il fiume Oceano. Le sue foci si trovavano fuori dal mondo conosciuto, e lì sorgeva l’Ade, il regno delle anime defunte.
12 come le figlie ghermì di Pandaro un dì la procella. Secondo il mito, Pandaro rubò dal tempio di Giove a Creta un cane d’oro, e per questo il dio lo punì. Tuttavia non fu l’uomo a subire alcun male, bensì le tre figlie: Filomena fu indotta con l’inganno a uccidere erroneamente il figlio e venne in seguito tramutata in usignolo; Merope e Cleotera vennero invece rapite da una tempesta, dietro la quale si celavano le Arpie.
seco tre porci recando, fra tutti i più pingui13 e pasciuti,14 e li lasciò che a loro agio pascessero via pei cortili.
165 Ed ei queste parole cortesi rivolse ad Ulisse: «O forestiere, gli Achei15 t’han dunque maggiore riguardo, o ti maltrattano, come solevano innanzi, anche adesso?»
E gli rispose Ulisse sagace con queste parole: «Eumeo, deh!, se16 i Celesti punire volesser gli oltraggi
170 che, macchinando imprese nefande, mi scagliano questi, in casa d’altri, senza pur briciolo aver di pudore».
Queste parole i due scambiavano l’uno con l’altro. E giunse presso ad essi Melanzio, pastore di capre, che conduceva le capre più belle di tutta la gregge,
175 per banchettarne i Proci. Veniano con lui due pastori. Dunque costui le bestie legò sotto il portico; e a Ulisse queste parole poi rivolse, per mordergli il cuore:
«In questa casa vuoi rimanere anche adesso, straniero, a fastidir la gente? Perché non infili la porta?17
180 Ma già, secondo me, liberarci di te non potremo senza un assaggio di botte, ché tu senza punto18 riguardo vai pitoccando.19 Anche altrove ci sono banchetti d’Achivi».
Così disse; ed Ulisse nessuna risposta gli diede, ma senza motto il capo crollò,20 meditando il suo danno.
185 E dopo loro giunse per terzo Filezio il capoccia,21 ai Proci pingui capre recando e una sterile manza. Le avevan qui recate nocchieri, che sopra le barche trasportano anche genti, ché chiedono ad esse il passaggio.22
13 pingui: “grassi”.
14 pasciuti: “nutriti”.
15 gli Achei: “i Proci”.
16 La congiunzione se serve a introdurre una frase che esprime un desiderio, un augurio, che tuttavia si teme possa non realizzarsi con facilità. Si può tradurre con: “magari…”.
17 Perché non infili la porta? “Perché non te ne vai?”.
18 punto: “alcuno”.
19 pitoccando: “mendicando”.
20 senza motto il capo crollò: “abbassò la testa senza parlare (senza motto)”.
21 Il termine capoccia indica che Filezio è un capomandriano, ai cui ordini sottostanno diversi altri pastori.
22 L’isola di Itaca era rocciosa e priva di grandi prati. Le mandrie venivano allora trasportate via nave sul continente, ove potessero pascolare.
Dunque costui le bestie legò sotto il portico, presso 190 si fece a Eumeo porcaro, gli volse così la parola: «Chi è, porcaro, questo straniero da poco qui giunto, dentro la casa nostra? Qual è la sua gente, lo sai?
Qual è la sua famiglia? Qual è la sua terra natale?
D’aspetto, poverino, somiglia davvero a un sovrano, 195 ma di sciagure i Numi opprimono chi vaga ramingo,23 quando essi hanno tramato, sia pur contro un re, la rovina».
Disse. E, venutogli presso, gli fe’ con la mano un saluto; e a lui parlando, queste veloci parole rivolse: «Ospite padre, salute! T’arrida nei giorni venturi
200 fortuna, poi che adesso t’opprimono molte sciagure. Giove padre, nessuno tra i Numi è di te più funesto! Degli uomini pietà non senti, ch’ài pur generati, quando nei mali avvolti li vedi, nei crucci funesti.
Come t’ho visto, sudore m’è corso pel corpo, e di pianto
205 mi si son colmi24 gli occhi, pensando ad Ulisse, che anch’egli, mi credo, andrà ramingo pel mondo con simili cenci, se pure ancora è in vita, se vede la luce del sole.
Se poi morto è di già, se sceso è alla casa d’Averno, ahimè!, misero Ulisse, signor senza taccia,25 che in questo
210 popol di Cefallenî,26 quando ero ancor bimbo, mi pose custode ai bovi, ch’ora non hanno più numero, e a niuno può maggior messe di bovi fiorir dalle larghe cervici. Ma forestieri audaci m’impongon che ad essi li serbi, per divorarli; e punto non curano il figlio ch’è in casa,
215 né la vendetta dei Numi paventano: tanta è la brama di divorare i beni del re che lontano si trova.
Ed il mio cuore a me nell’animo volge e rivolge tali pensieri. Male sarìa, mentre il figlio ancor vive, ch’io me ne andassi insieme coi bovi tra genti straniere,
220 presso ad un’altra tribù. Ma peggio è che qui rimanendo
23 ramingo: “solitario”.
24 colmi: “colmati”.
25 signor senza taccia: “signore di cui nessuno può parlar male”.
26 popol di Cefallenî: l’espressione è generica e intende indicare tutti i possedimenti di Ulisse: Itaca, Dulichio, Zante, Samo (detta anche Cefallenia) e un tratto del continente di fronte alle isole.
a custodire i buoi d’altra gente mi debba crucciare.
E già sarei da un pezzo fuggito, da un altro sovrano già mi sarei recato, ché reggere qui più non posso, ma sempre a quel meschino rivolta ho la mente, che un giorno
225 donde27 non so, pur torni, per fare sterminio dei Proci».
E gli rispose Ulisse lo scaltro con queste parole: «O mandrïano, giacché né malvagio né stolto mi sembri, e bene intendo anche io che senno t’ispira la mente, voglio una cosa dirti, con giuro solenne affermarla:
230 sappiano Giove, ch’è primo fra i Numi, e la mensa ospitale,28 che Ulisse giungerà mentre ancor qui sarai. Di sicuro potrai con gli occhi tuoi vederlo, se pur tu n’hai brama, che i Proci ammazzerà, che adoprano qui da padroni».
235 E il mandriano dei bovi con queste parole rispose: «Deh, stranïero, le tue parole compiesse il Cronide! Bene vedresti allora qual sia la mia forza, il mio braccio!»
E allora anch’egli Eumeo rivolse la prece ai Celesti tutti, che il saggio Ulisse tornare potesse alla reggia.
L’ultimo banchetto dei Proci
[240-275] Un terribile presagio giunge agli occhi dei Proci: un’aquila appare nel cielo e afferra una colomba. Incuranti di questo segno divino, i Proci si preparano al banchetto: stendono i propri mantelli sui sedili, uccidono gli animali e ne arrostiscono le carni. Tra i commensali appare Ulisse, ancora sotto le mentite spoglie dell’ospite straniero, e Telemaco chiede che egli possa prender parte alla mensa al pari degli altri, ricordando ai Proci che loro stessi non sono che ospiti, e non padroni di casa. Il tono imperioso di Telemaco fa innervosire i pretendenti alla mano della madre.
E l’ecatombe sacra dei Numi29 annunciaron gli araldi per la città; si adunaron gli Achei dalle floride chiome sotto l’ombroso bosco di Apollo che lungi saetta.
27 donde (o d’onde): “da dove”.
28 sappiano Giove, … e la mensa ospitale: “sappiano Giove e gli ospiti radunati a mensa (i Proci)”.
29 l’ecatombe sacra dei Numi: si tratta del sacrificio solenne che viene celebrato in occasione delle feste. Ricorre in quel giorno la festa di Apollo.
Quando ebber cotte poi, dagli spiedi sfilate le polpe,30
280 divisero le parti, sederono a lauto banchetto.
Ed i famigli a Ulisse dinanzi ponevan la parte simile a quella dei Proci, ché aveva così comandato Telemaco, figliuolo diletto d’Ulisse divino.
Ma non permise Atena che i Proci ponessero freno
285 alle crucciose scede;31 volea ch’ira sempre più tetra tutto invadesse il cuore d’Ulisse figliuol di Laerte.
V’era fra i Proci un uomo maestro d’ogni tristizia,32 che nome avea Ctesippo: in Same sorgea la sua casa. Pieno di presunzione costui per le grandi ricchezze,
290 desiderava la sposa d’Ulisse, da tanto lontano.
Dunque, prese costui fra i Proci arroganti a parlare: «Porgete ascolto a quello ch’io dico, magnanimi Proci. L’ospite avuta ha già, come pur conveniva, una parte pari alla nostra, ché bello davvero non è, non è giusto
295 che quando un ospite giunge, Telemaco debba mancargli.
Ma bramo adesso offrirgli anche io qualche dono ospitale,33 ch’egli a sua volta lo doni a chi l’accudisce nel bagno, o a quale altro gli piaccia dei servi d’Ulisse divino». Così disse. Ed un piede di bove pigliò da un canestro,34
300 e lo scagliò con mano sicura. Ma Ulisse, chinando agilemente la testa, pervenne a schivarlo. E nel cuore amaramente sorrise. Percossa ne fu la parete.
Ed a Ctesippo questa rampogna Telemaco volse: «Meglio per te che così sia finita la cosa, Ctesippo.
305 Fallito hai lo straniero, che seppe schivare il tuo colpo.
Se no, certo trafitto t’avrei con l’acuta mia lancia, e tuo padre t’avrebbe dovuto apprestare la fossa invece che le nozze. Pertanto, nessuno in mia casa commetta villania, ché tutto ora vedo e comprendo
310 il buono ed il cattivo. Sinora troppo ero fanciullo.
30 le polpe: “le carni”.
31 alle crucciose scede: “ai terribili insulti”.
32 maestro d’ogni tristizia: “malvagio”.
33 Il tono di Ctesippo è ironico, sarcastico. Si vedrà tra poco di quale dono egli stia parlando.
34 canestro: “cesto”. Non a caso i giocatori di pallacanestro oggi sono detti anche cestisti
Vedere e sopportare m’è forza la vostra arroganza, che mi sgozzate le greggi, che il vino ed il pan divorate, ché per un solo è cosa difficile a molti por freno. Ma non oprate più da nemici, non fate più danni.
315 Ché se bramate oramai ch’io muoia trafitto dal bronzo, anche io questo vorrei, perché molto meglio sarebbe morir, che tuttodì assistere a queste sozzure».
[318-343] I Proci sono colpiti dall’autorevolezza con cui parla e agisce Telemaco: egli è realmente cresciuto ed è pronto a divenire il padrone di casa. Si alza allora Agelao, uno dei pretendenti, e invita i compagni a non utilizzare più maniere tanto brutali, né con Telemaco, né con l’ospite, né con alcuno dei servi del palazzo. Con parole misurate e cortesi, poi, suggerisce a Telemaco di spronare la madre Penelope a nuove nozze, giacché è chiaro ormai che Ulisse non sarebbe tornato a casa. Telemaco dichiara davanti a tutti i Proci che egli non si opporrà certamente a un nuovo matrimonio, ma solo a condizione che la richiesta provenga dalla madre stessa: egli non la obbligherà in alcun modo.
Così disse Telemaco. E Pallade Atena fra i Proci
345 inestinguibil riso destò, ne sconvolse le menti. Si dirompevano già per le risa via via le mascelle, le carni ancora intrise di sangue ingollavano,35 e gli occhi gonfi di lagrime aveano, ché in cor presentivano il lutto.36
E a lor così parlò Teoclimeno37 mente divina:
350 «O sciagurati, che male vi coglie? Di tenebre avvolti i vostri capi sono, le facce, giù, sino ai ginocchi, ardono i vostri lagni,38 di pianto le guance son molli, son le pareti infuse di sangue ed i vaghi tramezzi,39 pieno di spettri40 è l’atrio, di spettri la corte ribocca,
355 verso la tenebra erranti, nel regno dell’Erebo: il sole
35 ingollavano: “ingoiavano”.
36 Gli occhi dei Proci si riempiono di lacrime per il troppo ridere, ma, commenta Omero, tali lacrime non sono che il presagio funesto di quanto sta per accadere a loro.
37 Teoclimeno è l’indovino che Telemaco aveva imbarcato a Pilo.
38 ardono i vostri lagni: “i vostri lamenti risuonano fortemente”.
39 i vaghi tramezzi: “i bei travicelli”. Sono le travi del soffitto.
40 spettri. Teoclimeno preannuncia la morte dei Proci e dice quindi di poter vedere le loro anime (spettri) aggirarsi nel palazzo in cerca della via per l’Ade.
s’è dileguato, in cielo diffusa è caligine tetra». Così disse. Ma tutti proruppero in risa gioconde.
Ed il figliuolo di Polibo, Eurimaco, prese a parlare: «È pazzo il forestiere testé giunto qui chi sa d’onde.
360 Accompagnatelo presto, ragazzi, via, fuori dall’uscio, che se ne vada in piazza, giacché qui gli par che sia notte!»
E gli rispose così Teoclimeno, mente divina: «Eurimaco, io non ti prego che guida tu debba offerirmi, perché posseggo gli occhi, le orecchie ed entrambi i miei piedi,
365 e nella mente ho un cervello ben saldo, per nulla sconnesso. Mi basteranno a uscire dall’uscio, ch’io scorgo un malanno che sopra voi s’avanza, né alcun sfuggirlo e scampare potrà dei Proci, che per la casa d’Ulisse divino fate agli ospiti oltraggio, compiete ogni azione ribalda».41
370 Così dicendo, uscì dalla solida casa d’Ulisse, ed a Pireo42 si recò, che liete accoglienze gli fece.
E l’uno all’altro ammiccando, di scherni coprivano i Proci per provocare a sdegno Telemaco gli ospiti suoi; e gli diceva taluno di quegli arroganti signori:
375 «Niuno avrà ospiti grami, Telemaco, al pari dei tuoi. Un vagabondo è questo, che va pitoccando alla strada, che pane e vino va cercando, che nulla sa fare, voglia di lavorare non ha, vano peso alla terra;43 quell’altro or ora uscito, s’è messo a parlar da profeta.
380 Dovresti darmi retta, ché certo sarebbe assai meglio. Fra i banchi d’una nave questi ospiti gitta, e in Sicilia mandiamoli: potrai ritrarne discreto guadagno».44
Così diceano i Proci. Né l’altro curava i lor detti, bensì, muto, lo sguardo volgeva a suo padre, e attendeva
385 l’istante ch’ei sui Proci sfrontati avventasse le mani.
41 compiete ogni azione ribalda: “commettete qualsiasi tipo di azione malvagia”.
42 Pireo è l’amico di Telemaco presso cui il vecchio indovino aveva già trovato ospitalità non appena giunto a Itaca.
43 vano peso alla terra. L’odiato ospite viene schernito dai Proci, che lo apostrofano come un “inutile peso che grava sul terreno”, paragonandolo quasi a un inutile e pesante sacco poggiato al suolo.
44 potrai ritrarne discreto guadagno. I Proci suggeriscono a Telemaco di imbarcare i propri ospiti miserevoli (grami) e di venderli come schiavi.
Ora, di fronte alla sala, seduta sul fulgido trono, d’Icario la figliuola, Penelope mente assennata, udiva ciò che quelli dicevano dentro la stanza. A banchettare quelli seguiano, ridendo in gran festa, 390 in gran copia, ché bestie ne aveano sgozzate di molte.
Ma nessun altro banchetto men pro’ dovea fare45 di quello che s’apprestavano a offrire la Diva ed il valido Ulisse ai Proci, che per primi tessêr quella trama d’infamia.
45 men pro’ dovea fare: “doveva giovare di meno”, “doveva essere meno favorevole”.
La strage dei Proci non avviene sotto l’ala di una furia cieca e vendicatrice, ma è studiata, preparata. In essa due uomini che hanno servito i pretendenti, il cantore Femio e l’araldo Medonte, addirittura ottengono il perdono e vengono risparmiati. Non è un atto impulsivo, ma un momento del progressivo ristabilimento di un ordine. Ulisse vuole restaurare, infatti, l’ordine che la presenza a palazzo dei Proci ha totalmente sovvertito. L’eroe, in fin dei conti, chiede che dalle tante ingiustizie patite durante il proprio viaggio possa nascere finalmente un orizzonte di giustizia e felicità per sé e per la propria famiglia.
La pace conclusiva che Ulisse ottiene a Itaca, tuttavia, non è dovuta al semplice ristabilimento di un ordine passato, degli antichi rapporti sociali e affettivi. L’ordine che Ulisse riporta è più grande di quello passato, è quasi ereditato dal suo lungo vagare ed è frutto della sua tanto sofferta assenza da casa. L’eroe, infatti, torna più saggio e più scaltro di prima. Suo figlio Telemaco è cresciuto ed è divenuto saggio e coraggioso. La moglie Penelope gli si è mostrata fedele, e su di lei adesso il marito potrà fare affidamento per sempre, sorte che al contrario –secondo quanto ci dice Omero sin dall’inizio dell’Odissea – non era toccata agli altri eroi che avevano combattuto a Troia, primo fra tutti Agamennone, tradito e ucciso dalla consorte. I servi e le ancelle infedeli sono stati puniti, mentre quelli realmente preoccupati della sorte del padrone hanno ricevuto il premio del suo affetto. Il padre Laerte, dopo aver sofferto in solitudine la mancanza del figlio da casa, seppellendo la moglie e disinteressandosi della sorte della nuora e del nipote, contempla con orgoglio la nobiltà d’animo della propria discendenza e ritrova la forza e la baldanza per combattere a fianco dei più giovani.
Libro XXi – La mattina seguente Penelope raggiunge i Proci e propone di tirare con il famoso arco del marito. Questi, pieni di superbia, non si fanno indietro e accettano di buon grado. Per primo si cimenta con l’arco Telemaco, e starebbe già per riuscire a scagliare la freccia a bersaglio, ma un cenno segreto del padre lo fa desistere dall’impresa. Seguono allora i tentativi di alcuni Proci, i quali tuttavia non riescono neppure a flettere l’arco. Tra gli insulti di tutti, il mendicante si offre di tentare la prova e la porta a compimento con successo. Penelope viene intanto fatta allontanare dalla sala, poiché la strage sta per avere inizio.
Libro XXii – Mentre Telemaco, infatti, corre a prendere delle armi per sé e per il padre, Ulisse si rivela agli arroganti pretendenti e li tempesta di frecce, sebbene questi siano in numero grandemente superiore. L’infedele Melanzio riesce una
prima volta a procurare delle armi ai Proci, ma al secondo tentativo viene catturato da Eumeo e Filezio.
La strage dei Proci continua senza soste, anche perché Minerva stessa è scesa a combattere a fianco di Ulisse. Uccisi tutti i pretendenti, Ulisse si volge alla punizione delle ancelle che si sono dimostrate infedeli.
Libro XXiii – Dopo che Ulisse ha giustiziato le serve, la vecchia Euriclea corre a chiamare Penelope e la informa dell’avvenuta strage e della presenza del marito a palazzo. Penelope si dimostra guardinga e sospettosa, e per l’ennesima volta vuole mettere alla prova lo straniero. Constatato che l’uomo effettivamente conosce anche i segreti noti solo a lei e al marito, Penelope accoglie con commozione il ritrovato Ulisse e vi trascorre insieme tutta la notte, raccontandogli il dolore degli anni appena trascorsi e godendo finalmente della sua compagnia.
Libro XXiV – Abbandonata la vita, le ombre dei pretendenti giungono nell’Ade e qui, in un dialogo con Agamennone, riconoscono la propria colpa e le proprie nefandezze.
A Itaca, intanto, Ulisse decide di trasferire prudentemente tutta la famiglia in campagna, temendo la vendetta dei parenti degli uccisi. Giunto quindi al podere di Laerte, si fa riconoscere dal padre, che da tempo ormai aveva smesso di sperare nel suo ritorno.
In quella stessa giornata Ulisse e la sua famiglia vengono raggiunti dai parenti dei Proci, infuriati per la strage dei figli, e contro di essi sono costretti a iniziare un’altra battaglia, che Minerva, tuttavia, interrompe in breve tempo, desiderando garantire all’eroe la pace, dopo avergli procurato il giusto ritorno.
Libro XXI
Penelope indice la gara
Pallade Atena intanto, la Diva ch’à glauche le ciglia, mise a Penelope in cuore, d’Icario alla scaltra figliuola, che proponesse ai Proci la prova dell’arco e dell’asce, perché la gara fosse che desse principio alla strage 5 entro la casa d’Ulisse. Salì per l’eccelsa scalea alle sue stanze, strinse la valida man sulla chiave bella, arcuata, di bronzo, con l’elsa1 di lucido avorio. Poscia, entro un’ultima stanza remota passò con le ancelle, dove i tesori tutti giacevan riposti d’Ulisse, 10 l’oro ed il bronzo e i molti lavori foggiati nel ferro. Ed era quivi l’arco ricurvo, era qui la faretra dei dardi, e molte v’eran saette foriere di lagni: doni che a Sparta, un dì che Ulisse con lui vi convenne, gli offrì l’ospite Ifito,2 figliuolo d’Eurito divino.
[15-41] Ulisse e Ifito erano andati a Sparta per ragioni differenti: il primo era stato mandato come ambasciatore per esigere un risarcimento a seguito di un duro saccheggio subito; Ifito invece era alla ricerca di cavalle, poiché le sue erano tutte morte. Durante l’incontro fortuito Ulisse ottenne l’arco, che non portò a Troia per combattere, ma lasciò a casa, in ricordo dell’amico Ifito, morto poco dopo l’incontro a Sparta.
Or, come dunque la donna divina fu al talamo giunta, e superò la soglia di quercia che il fabbro dal legno piallata un giorno aveva, tirandola a filo di squadra, 45 e avea sopra le imposte costrutte e la lucida porta,
1 l’elsa: “l’impugnatura”.
2 doni che a Sparta, un dì che Ulisse con lui vi convenne, gli offrì l’ospite Ifito. Da ordinare così: doni che gli offrì l’ospite Ifito a Sparta, un dì che Ulisse con lui vi convenne. Ifito è figlio di Eurito, un famosissimo arciere. Quando Ulisse e Ifito, per diversi motivi, si trovarono ospiti del re Orsiloco, ebbero l’occasione di scambiarsi dei doni: Ulisse ricevette il prezioso arco, prima appartenuto al padre di Ifito, e diede a sua volta in cambio una spada e una lancia.
rapidamente qui da l’anello sfilò la coreggia,3 spinse nel foro la chiave, respinse indietro i paletti, premendo avanti;4 e quelli mandarono un mugghio di toro che sovra il prato pasca. Tal mugghio suonò dai paletti
50 respinti dalla chiave, dischiuso fu subito l’uscio.
E sopra l’alto palco5 la donna balzò. Quivi l’arche stavano, e dentro quelle riposte le vesti fragranti. Quindi l’arco staccò, levata sui pie’, dal piolo, con la vagina lucente6 che tutto fasciavalo attorno;
55 e poi, balzata giù, posatolo sulle ginocchia, dalla vagina l’arco traendo, in gran pianto proruppe.7 Quando fu sazia poi del gemito lungo del pianto, mosse di lì, s’avviò per la sala, fra i Proci superbi, l’arco reggendo in mano dai capi ricurvi, e il turcasso8
60 ov’eran chiuse molte saette foriere9 di pianto; e seco lei le ancelle recavano un cesto, ove ferro era di molto e bronzo, già premi ai certami10 d’Ulisse. Dunque, come la donna divina fu giunta fra i Proci, stie’ della salda sala vicino alle imposte, diritta, 65 teso dinanzi alle gote tenendo il suo fulgido velo. E la parola ai Proci rivolse, così prese a dire:
«Datemi ascolto, o Proci superbi, che in questa mia casa soliti siete adunarvi per bere e mangiar tutto il giorno, poiché da lungo tempo Ulisse mio sposo è lontano, 70 né sapevate altra meta trovare dei vostri discorsi,
3 La coreggia è una cinghia di cuoio utilizzata per chiudere la porta.
4 La porta aveva doppi battenti; per aprirla era necessario sciogliere il nodo della corda (facendo così scorrere il chiavistello interno) e poi inserire la chiave; girando la chiave si sarebbero sollevati i paletti che fissavano la porta al terreno.
5 L’alto palco è un’impalcatura costruita in legno sulla quale venivano appoggiate le casse (le arche) che contenevano vesti e oggetti di valore perché non si impregnassero dell’umidità del suolo. Le vesti vengono definite fragranti perché molto spesso le casse contenevano anche dei profumi che servivano ad allontanare il pericolo dei tarli.
6 L’arco era dunque protetto da una custodia splendida (la vagina lucente) ed era appeso al muro ad un chiodo (piolo).
7 L’arco richiama fortemente alla mente di Penelope la figura del marito; il pianto è dovuto quindi al ricordo struggente di Ulisse.
8 turcasso: “faretra”.
9 foriere: “portatrici”.
10 certami: “battaglie”.
che di volermi sposare, di rendermi vostra consorte. Presto, su via, pretendenti, sentite che gara io propongo. Io vi consegno questo grande arco d’Ulisse divino; e chi più facilmente fra voi saprà stenderne il nervo, 75 e con la freccia saprà traversare dodici scuri, io quello seguirò, lascerò questa casa ove sposa, ove fui madre, bella, ricolma d’ogni dovizia,11 tale che pur nei sogni dovrò sempre averne il ricordo».
Così disse. E ad Eumeo die’ l’ordine, al fido porcaro, 80 che consegnasse l’arco ai Proci e le lucide scuri. Eumeo lo ricevé piangendo, e lo porse; e il bovaro12 piangea dall’altro lato, poiché vide l’arco del sire.
E a lor si volse Antinoo, parlò per coprirli d’ingiurie: «Sciocchi, villani, che non vedete dall’oggi al dimani,
85 povera gente, perché versar tante lagrime, e il cuore turbare alla regina, che l’animo ha già tanto afflitto per altra cura, perché perduto ha il diletto consorte?
Statevene a mangiare lì zitti; e se pianger volete, uscite a pianger fuori dell’uscio, e lasciate qui l’arco,
90 onde13 sarà dei Proci la gara incruenta: ch’io penso che tendere quest’arco non sia troppo agevole impresa, perché fra tutti questi non c’è verun uomo che valga quanto valeva Ulisse, ché io con questi occhi l’ho visto, e ben me lo rammento, sebbene ero ancora fanciullo».
95 Così disse, ma il cuore nel sen gli nutria la speranza ch’ei tenderebbe il nervo, che l’asce fuor fuor passerebbe; e invece egli doveva gustarne per primo le frecce,14 lanciate dalle mani d’Ulisse, ch’egli ora offendeva, standogli in casa, e inoltre spingeva alle ingiurie i compagni.
11 dovizia: “ricchezza”.
12 Il bovaro è Filezio, servitore fedele di Ulisse. Anche Eumeo e Filezio piangono perché l’arco risveglia in loro il ricordo del padrone.
13 onde: “col quale”.
14 Antinoo infatti sarà il primo tra i pretendenti ad essere colpito dalle frecce di Ulisse nell’imminente strage.
100 E a lui così parlò Telemaco mente divina: «Ahimè, davvero Giove Cronide m’ha reso demente! La madre mia diletta mi dice, sebbene assennata, ch’ella con altri andrà, che abbandonerà questa casa, e intanto io me la rido, mi balocco15 al par d’uno stolto.
105 Ora, Proci, su via, poiché tale premio è proposto –tale una donna quale per tutta la terra d’Acaia né in Pilo sacra c’è l’eguale, né in Argo o in Micene, e voi ben lo sapete: ché devo lodare mia madre? –ora fine ai pretesti si ponga, ed a tendere l’arco
110 non indugiate più: si tenti la prova, e si vegga. Anzi, io medesimo voglio tentare la gara dell’arco. E se lo tenderò, se saprò traversare le scuri, via non andrà da questa mia casa la nobile madre per seguire altri, me lasciando qui solo e doglioso,
115 mentre già posso in gara contender con l’armi del padre». Disse. E, balzato in piedi, dagli omeri il rosso mantello depose giù, sfilò dal collo l’acuta sua spada, l’asce dispose quindi. Scavò per tutte una fossa grande traverso la sala, tracciandola a filo di squadra,
120 e v’assodò la terra d’attorno. E stupirono tutti con che garbo le pose, né mai visto aveva quel gioco. Poscia alla soglia andò, vi stette, fe’ prova dell’arco.
S’adoperò tre volte per fletterlo come avea brama: tre volte si fiaccò, sebbene tuttora sperasse
125 tendere il nervo, e spinger la freccia fuor fuori dall’asce.
E ben la quarta volta curvato lo avrebbe di forza, ma la sua voglia Ulisse frenò con un cenno del capo.16
E allora disse ai Proci Telemaco mente divina:
15 mi balocco: “mi diverto”.
16 Telemaco, simile al padre nella prestanza fisica, al quarto tentativo sarebbe riuscito a tendere la corda dell’arco, ma il suo sforzo viene interrotto dallo stesso Ulisse. Se Telemaco avesse portato a termine la prova, il padre non avrebbe potuto mostrare la sua bravura, né tanto meno umiliare i Proci per la loro incapacità. Il cenno del capo che tipicamente facevano gli antichi Greci per negare qualcosa consisteva in un’alzata di sopracciglia. L’usanza è rimasta fino al giorno d’oggi in Grecia.
«Ahimè tristo! O sarò mai sempre un imbelle,17 un dappoco,
130 o troppo giovane sono tuttora, ed ho fiacche le mani. Orsù, via, dunque, voi che me superate di forza, date di piglio all’arco, ché compier si possa la gara».
Così disse. E lontano da sé l’arco a terra depose, poggiandolo ai battenti ben solidi, ben levigati:
135 il dardo acuto quindi chinò vicino a l’anello,18 e nuovamente sede’ sul trono dond’era pria surto.19
E allora Antinoo, figlio d’Eupito, così prese a dire: «Su, dalla destra, compagni, da dove a libar si comincia, l’un dopo l’altro sorgete,20 tentate la prova dell’arco».
140 Così diceva Antinoo; né a quelli dispiacque l’invito.
E si levò per primo Leiòde, figliuolo d’Enòpo, di sacrifici maestro,21 che in fondo sedeva alla mensa presso al cratere bello mai sempre. A lui solo odiose erano l’empietà, nemico dei Proci tutti era.
145 Dunque primo egli così prese l’arco e l’aguzza saetta: mosse alla soglia, stette, tentò di flettere l’arco, né lo pote’ curvare, pria furono stanche le mani morbide, non temprate dall’uso. E così disse ai Proci: «Amici, io non lo posso curvare. Tenti altri la prova,
150 che già quest’arco privi molti altri farà dei migliori dell’alma e della vita,22 perché meglio vale morire
17 sarò mai sempre un imbelle: “sarò sempre un debole”. Mai sempre significa semplicemente “sempre”.
18 Telemaco appoggia l’arco verticalmente ai battenti della porta e incastra la freccia nell’apposito anello che congiunge i due bracci dell’arco.
19 dond’era pria surto: “dal quale si era alzato prima”.
20 Antinoo suggerisce che i pretendenti si alzino per tentare la prova da destra, seguendo il medesimo ordine nel quale il coppiere serve loro il vino a tavola, perché procedere da destra era considerato segno di buon augurio. Inoltre questa successione rispecchiava un ordine crescente di valore: infatti i primi a gareggiare sarebbero stati i Proci meno importanti, mentre l’ultimo sarebbe stato Antinoo, il più autorevole tra di loro.
21 Leiode era propriamente un aruspice, cioè un indovino che basava le proprie previsioni sull’osservazione delle interiora degli animali; aveva poi il compito di soprintendere ai sacrifici, facendo bruciare le parti della vittima destinate agli dèi.
22 quest’arco privi molti altri farà dei migliori dell’alma e della vita. Da ordinare così: quest’arco farà privi dell’alma (“anima”) e della vita molti altri dei migliori
che restar vivi, quando fallito ci fosse lo scopo per cui giorno per giorno noi qui ci aduniamo in attesa. Tuttora alcuno in cuore la speme alimenta e la brama
155 di sposa aver la moglie d’Ulisse, Penelope scaltra, ma quando avrà veduto, tentata la prova dell’arco, qualcuna altra dovrà cercar delle Achive eleganti, per propria moglie, e offrirle presenti di nozze; e la donna sarà di chi più doni le porga, e chi scelga il destino».
160 E gli rispose così, coprendolo Antinoo d’ingiurie: «Quale parola, Leiode, ti uscì dalla chiostra dei denti? Dura parola, e grave, che udendola m’empie di sdegno, se veramente quest’arco dovrà render privi i migliori dell’alma e della vita, perché tu non vali a curvarlo.
165 Ma gli è che la tua madre saputo non t’ha generare tale campion che sappia scagliare saette dagli archi.
Ma facilmente sapranno curvarlo i magnanimi Proci».
Così disse, e chiamò Melanzio pastore di capre: «Ora del fuoco accendi, Melanzio, su via, nella stanza,
170 ed un gran seggio accanto vi poni, e sopra esso dei velli; e porta un grosso disco di grasso, ché in casa ne trovi, perché, scaldato ed unto di grasso quest’arco, possiamo fare la prova e curvarlo, condurre a buon fine il cimento».23
Così disse. Ed accese Melanzio l’indomito fuoco,
175 ed un gran seggio accanto vi pose, e sovr’esso le pelli.
Poscia di grasso portò, ché in casa ve n’era, un gran disco.
E, riscaldato l’arco, tentaron di tenderlo i Proci.
Invano: troppo indietro restavano ad essi le forze.
Solo indugiâr24 la prova Antinoo ed Eurimaco bello, 180 ch’erano i capi dei Proci, per nascita molto più insigni.
[181-237] Nel frattempo Eumeo e Filezio escono dalla sala e Ulisse li segue: vuole cogliere l’occasione per rivelarsi a loro in segreto. Quando Ulisse mostra loro la cicatrice della ferita infertagli dal cinghiale, i due sono presi da forte commozione. Ma non è questo il tempo di piangere: Ulisse ordina a Eumeo
23 il cimento: “la prova”.
24 indugiâr: “indugiarono”; qui in maniera insolita è costruito transitivamente e significa “rimandarono”.
di far sbarrare la sala della prova dell’arco dalle ancelle e di riferire loro che restino alla larga, anche se dovessero sentire forti rumori; Filezio nel frattempo avrebbe chiuso le porte dell’atrio, cosicché la stanza sarebbe rimasta totalmente isolata. Ulisse rientra quindi nella sala.
Avea dato di piglio frattanto Eurimaco all’arco, e lo scaldava alla vampa del fuoco qua e là. Ma neppure
240 così gli venne fatto di tenderlo, e il solido cuore forte piangeva; e tutto crucciato, così prese a dire: «Ahi!, quale ambascia25 per me, per tutti i compagni m’invade! E non mi lagno già per le nozze, se ben me ne affliggo:26 molte altre donne achive pur vivono in Itaca alpestre
245 cinta dal mare, ed altre per l’altre città, ma mi lagno perché tanto da meno noi siamo in vigore d’Ulisse pari ai Celesti, né siamo capaci di tender quest’arco, e biasmo tal ne avremo, che i posteri ancor lo sapranno». E gli rispose così Antinoo figlio d’Eupito:
250 «No, non andrà così, Eurimaco, intendilo bene.
Oggi pel Dio dell’arco nel popolo è festa solenne: chi mai di tender l’arco curar si vorrebbe? Smettete, state tranquilli. Le scuri direi di lasciarle qui tutte dove ora sono; ché niuno vorrà, se non erro, introdursi
255 entro la casa d’Ulisse figliuol di Laerte, e rubarle».27
[256-265] La proposta di Antinoo di rimandare la gara è accolta con entusiasmo anche dagli altri Proci; ha quindi inizio un banchetto in onore di Apollo.
Ulisse si propone come concorrente
Ora, poi ch’ebber libato, bevuto ciascuno a sua posta, così lo scaltro Ulisse parlò, meditando l’inganno: «Datemi ascolto, voi che ambite l’illustre regina. Prima ad Eurimaco volgo la prece e ad Antinoo divino,
25 ambascia: “angoscia”.
26 Se ben me ne affliggo è una subordinata concessiva. Se e ben non sono ancora saldati, a differenza di quanto avviene nella più nota congiunzione sebbene.
27 L’intento di Antinoo non è certo quello di festeggiare il dio Apollo; egli con questo pretesto vuole semplicemente guadagnare tempo e spera che intanto la gara venga dimenticata.
270 perché questo consiglio che diedero è certo opportuno. Ora si lasci l’arco, si volga la mente ai Celesti; domani all’alba, il Nume darà la vittoria a chi brama. Ma l’arco levigato date ora a me, ch’io tra voi delle mie mani provi la forza, se ancora il vigore
275 mi resta, quale un giorno l’avevo nelle agili membra, oppur se l’han distrutto l’inerzia28 e l’errare mio lungo». Così diceva Ulisse. Ma grande fu l’ira di tutti, per il timor che l’arco lucente egli a tender valesse.
[279-302] Antinoo risponde alla presuntuosa richiesta del mendicante in modo aggressivo, rimproverandolo per la sua arroganza e ipotizzando che il vino gli abbia dato alla testa: un accattone non può certo partecipare a una gara tra nobili! Fortunatamente interviene Penelope in favore di Ulisse.
E a lui queste parole Penelope scaltra rispose:
«Antinoo, bello non è, non è giusto coprire d’oltraggi
305 chi giunge ospite qui di Telemaco. Pensi tu forse che se questo straniero potesse il grande arco d’Ulisse tendere mai, se a tanto valergli potesse la forza, alla sua casa potrebbe condurmi, ed avermi sua sposa?
Niuno fra voi non voglia crucciare per questo il suo cuore».
310 Ed il figliuolo di Polibo, Eurimaco, questo rispose: «O Penelope, o figlia d’Icario, che tanto sei scaltra, no, non pensiam, non ci sembra che questi via possa condurti, bensì la mala voce temiamo d’uomini e donne, che non ci lanci qualche plebeo questi motti d’oltraggio:
315 “Uomini assai da poco d’un prode vagheggian29 la sposa, che poi non sono stati capaci di tendere un arco, e invece uno qui giunto per caso, un pitocco straniero, subito lo flette’, scagliò il dardo traverso alle scuri”. Così diranno; e questo per noi sarà biasimo grande».
320 E gli rispose queste parole Penelope scaltra: «Possibil non è già tra il popolo aver buona fama, quando si oltraggia, quando si vorano, Eurimaco, i beni
28 inerzia: “inattività”.
29 vagheggian: “desiderano”.
d’un valoroso eroe. Questa altra vergogna temete?30
Questo straniero è grande, di valide membra robusto, 325 buona è sua stirpe, dice, figliuolo è di nobile padre. Dategli dunque l’arco lucente, e si tenti la prova».
[327-364] Telemaco approva la decisione della madre di far partecipare il mendicante alla gara: se riuscirà a tendere l’arco, gli verranno date delle vesti con cui coprirsi e delle armi. Penelope sale nelle sue stanze, come il figlio le ha espressamente ordinato, in modo che gli uomini possano rimanere indisturbati. Tornato nella sala dell’arco, il giovane esorta Eumeo a porre l’arco nelle mani di Ulisse, suscitando lo sdegno dei Proci.
La vittoria del mendicante
365 Così disse;31 e ai suoi detti levarono risa gioconde i Proci tutti quanti diêr bando allo sdegno feroce32 contro Telemaco; e il fido porcaro traverso la sala portò l’arco, ristie’,33 lo porse ad Ulisse divino. Poi, la nutrice Euriclea chiamata, così le parlava:
370 «Telemaco ti dà quest’ordine, saggia Euriclea: che della sala tu le solide porte ora chiuda, ed anche se tumulti, se urli degli uomini udissi dentro il recinto nostro rinchiusi, non esca dall’uscio, bensì badi alle tue faccende e rimanga in silenzio».
375 Così diceva Eumeo, né quella rispose parola; e della sala bene costrutta le imposte rinchiuse. Poi dalla casa, senza far motto, uscì fuori Filezio, e fermò l’uscio a chiave dell’aula dal saldo recinto.
E di papiro una fune da nave nel portico v’era.
380 L’uscio ei vi34 strinse, poi di nuovo tornò nella sala,
30 La risposta di Eurimaco a Penelope è perfettamente logica: il motivo per cui i Proci temono lo straniero non è tanto che sposi la regina, quanto la cattiva fama che loro stessi acquisterebbero se il mendicante riuscisse nella prova in cui tutti loro hanno fallito. Penelope dunque ribatte che i Proci non devono temere niente da questo punto di vista: già possiedono una cattiva fama, dal momento che da tempo divorano (vorano) i beni di un altro uomo. È lecito dunque dare l’arco al mendicante.
31 Telemaco ha appena esortato il porcaro a dare l’arco al mendicante.
32 diêr bando allo sdegno feroce: “misero da parte il feroce sdegno”.
33 ristie’: “si fermò”.
34 Il pronome vi si riferisce alla fune. È un complemento di mezzo.
e sovra lo sgabello, dond’erasi or ora levato, sede’, guardando Ulisse. Già questi iva l’arco provando, guardandolo per tutto, qua e là volgendol, se a caso, mentre egli era lontano, corroso l’avessero i tarli.
385 E nel vederlo, così dicea questi e quegli al vicino: «Intenditore d’archi perito35 deve esser costui. Davvero, o ch’egli n’ha lasciato uno simile a casa, oppur se lo vorrà costrurre; qua e là per le mani lo va girando, questo pitocco maestro di guai».
390 E soggiungeva un altro di quei tracotanti signori: «Così della Fortuna potesse raccogliere i doni, com’egli ora potrà riuscire a tender quest’arco!»36
Così diceano i Proci. Ma Ulisse frattanto, lo scaltro, poi ch’ebbe punto a punto scrutato, provato il grande arco,
395 come allorquando un uomo di cetera esperto o di canto agevolmente tende sul bischero nuovo37 una corda, così l’arco suo grande Ulisse piegò senza sforzo. Poi, con la destra prese la corda, ne fece la prova; e quella un suono acuto mandò, che una rondine parve.
400 Grave l’ambascia fu dei Proci, sbiancarono in viso tutti; e Giove mandò con lo scoppio d’un tuono il presagio.
Ma lieto il cuore fu d’Ulisse tenace divino, che a lui tale presagio mandasse il figliuolo di Crono. E prese un dardo acuto che fuor del turcasso giaceva
405 sopra la mensa – dentro rinchiusi ancora erano gli altri –onde38 gli Achivi presto doveano saggiare la punta. Col cubito39 alto, quindi, tirando la corda e la cocca,40 dallo sgabello dove sedeva scagliò la saetta
35 perito: “esperto”.
36 Così della Fortuna potesse raccogliere i doni, com’egli ora potrà riuscire a tender quest’arco! L’augurio qui pronunciato è fortemente malevolo e può essere tradotto così: “Oh se il mendicante avesse lo stesso (cioè così scarso) successo nella vita di quello che avrà con l’arco!”.
37 Il bischero è quel perno che serve a tirare o ad allentare le corde degli strumenti musicali; qui si riferisce alla cetra (cetera).
38 onde: “del quale”. Si riferisce alla parola dardo.
39 cubito: “gomito”.
40 La cocca è la parte posteriore della freccia, precisamente quella in cui è praticata una tacca per fissare la freccia stessa alla corda. Si dice propriamente scoccare una freccia per indicarne l’allontanamento dalla cocca dell’arco.
dritto mirando; e niuna fallì de le scuri: sfiorando
410 l’impugnatura a sommo, uscì via dall’ultimo foro il grave bronzeo dardo. E Ulisse a Telemaco disse: «Vergogna non ti fa, Telemaco, questo straniero ospite tuo: fallita la mira non ho, né stentato troppo, per tendere l’arco. Le forze mi valgono ancora.
415 Quello non sono che i Proci maltrattano e copron d’ingiurie. Ora il momento è giunto, finché dura il dì, d’ammannire41 il pranzo ai Proci; e poi potranno pigliarsi altri svaghi col canto e con la cetra, che sono ornamento alla mensa». Disse, e fe’ cenno con gli occhi. Di subito cinse la spada
420 Telemaco, figliuolo diletto d’Ulisse divino, gittò sul giavellotto la mano, e vicino a suo padre stette vicino al seggio, fulgente nel lucido bronzo.
41 ammannire: “preparare”.
Ulisse si svela ai Proci
Ecco, ed Ulisse l’accorto dai cenci le membra disciolse, e sopra l’alta soglia1 con l’arco balzò, col turcasso pieno di frecce. E le frecce veloci dinanzi ai suoi piedi sparse sul suolo; ed ai Proci si volse con tali parole:
5 «Questo cimento da folli fu pure condotto alla fine. Or vo’ tentare un altro bersaglio, cui niuno finora volse la mira, se Apollo mi dà la vittoria e l’imbrocco».2 Disse; e un’amara saetta vibrò contro Antinoo. Stava questi levando allora un calice duplice d’ansa,3
10 d’oro, leggiadro, e con ambe le man’ l’appressava alle labbra, per tracannarne il vino, né in cuor gli passava la morte. Creder chi mai potrebbe che in mezzo a un convito, fra tanti uomini, un uomo solo, per quanto gagliardo egli fosse, così la negra Parca recasse, il malanno e la morte?
15 Ma la saetta d’Ulisse lo colse per mezzo alla gola, forò da parte a parte la cuspide il morbido collo.4
Piegò su l’un dei fianchi rovescio il ferito, la coppa giù dalle mani gli cadde, sprizzò dalle nari un gran fiotto di negro sangue; e in furia coi piedi springando, respinse
20 lungi da sé la mensa:5 i cibi si sparsero al suolo, furono il pane e la carne lordati di sangue. Ed i Proci
1 L’alta soglia è l’alto gradino che si trovava all’ingresso della sala dove erano riuniti i Proci. Ulisse vi sale per poter essere visto da tutti e per impedire ogni possibile tentativo di fuga dalla porta alle sue spalle.
2 l’imbrocco: “la capacità di colpire nel segno”.
3 calice duplice d’ansa: “calice a due manici”. Antinoo sta levando il calice per bere, così come Ulisse aveva proposto poco prima (fine del libro XXI); l’azione che esprime il totale benessere del pretendente è in netto contrasto col destino che improvvisamente lo coglie.
4 forò da parte a parte la cuspide il morbido collo. La cuspide (la “punta”) è soggetto di forò; la frase è da ordinare così: la cuspide forò da parte a parte il morbido collo
5 e in furia coi piedi springando, respinse lungi da sé la mensa. Colto dalla freccia alla gola, Antinoo cade, e nel cadere agonizzante prende a calci (springare) la tavola (mensa), che pertanto si rovescia.
alto levarono un grido, vedendo il compagno riverso, e su balzâr dai seggi, correndo qua e là per la stanza, gli occhi ansiosi d’intorno volgendo alle salde pareti.
25 Ma scudo ivi non era da prender, né solida lancia.
E con irose parole, d’ingiurie coprirono Ulisse: «Pel tuo malanno, straniero, colpito hai quest’uomo. Di gare non ne farai più altre: di certo farai mala fine. Quest’uomo hai posto a morte che era il migliore
30 dei figli d’Itaca: adesso dovranno sfamarsi di te gli avvoltoi».
E biecamente Ulisse guardandoli, questo rispose: «Cani, non lo pensavate che dalla città dei Troiani sarei tornato un giorno, che a sacco tutta la casa mi mettevate, ed ambivate, mentre ero pur vivo,
35 sposar la mia donna, senza timor né dei Numi che in cielo han sublime dimora, né che degli uomini alcuna vendetta potesse colpirvi! Or su voi tutti incombe la forza dell’ultimo fato». Disse; ed invase tutti tremore livido. Solo
40 prese a parlare Eurimaco, e tali parole gli volse: «Se tu che giungi il re sei proprio, se Ulisse tu sei, tu giustamente gli Achei rampogni di quello che han fatto, tante nequizie6 nella tua casa, tante altre nei campi. Ora, però, spento è l’uomo che fu la cagione di tutto,
45 spento è Antinoo; ché questi con tanti soprusi ti offese, non perché amasse e bramasse Penelope avere consorte, ma vagheggiando ben altro, che il Nume Cronide non volle: d’essere in Itaca re, delle genti e dei vasti palagi, di tendere l’insidia, di mettere a morte tuo figlio.7
50 Ora a ben giusto castigo soccombe; e tu mostrati mite
6 nequizie: “malvagità”.
7 Eurimaco, combinando adulazione e furbizia, cerca di fare appello alla pietà di Ulisse: poiché è re, è giusto che rimproveri chi ha commesso malvagità e ingiustizie in casa sua durante la lunga assenza; ma, siccome Antinoo, il capo di tutti questi approfittatori, è già morto, egli spera che la furia vendicatrice di Ulisse si sia ormai saziata senza bisogno di un’ulteriore strage. Per questo motivo propone all’eroe di scendere a patti. Inoltre Eurimaco svela il reale intento con cui Antinoo (e quindi tutti i Proci) rimanevano nella reggia di Penelope: non tanto per sposarla, quanto per diventare re di Itaca, dopo aver ucciso l’erede Telemaco.
con la tua gente. E noi tutti, tuoi sudditi, a te per ammenda8 di tutto quanto fu mangiato e bevuto in tua casa, qui recheremo un compenso ciascuno di venti giovenchi, e ti daremo oro e bronzo, finché ne sia pago il tuo cuore:
55 prima di ciò, darti biasmo nessuno potrà del tuo cruccio».9
E bieco lo guardò Ulisse e rispose: «Neppure se tutti quanti mi deste, Eurimaco, i beni paterni, quanti n’avete, quanti altri possiate trovarne a impinguarli,10 neppure allor vorrei trattenere le man’ da la strage,
60 prima d’avere tutti puniti i misfatti dei Proci. Ora vi restan due strade: combattere o darvi alla fuga, chi con la fuga potrà schivare il destino e la morte; ma niuno sfuggirà, ne son certo, l’estrema rovina». Così diceva; e a tutti mancarono cuore e ginocchia.
Ha inizio la strage
65 Ma nuovamente parlò Eurimaco, e disse ai compagni: «Amici miei, di certo quest’uomo alle invitte11 sue mani non porrà freno; e poiché stringe in pugno l’arco e il turcasso, piantato su la soglia, ci saetterà, sinché tutti ci abbia veduti morti. Su dunque, pensiamo a lottare.
70 Su, sguainate le spade, vi siano le tavole scudi contro le frecce letali, piombiamo su lui tutti insieme, se lo possiamo sbalzare lontan dalla soglia e dall’uscio, e sparpagliarci per Itaca, alzando le grida al soccorso: l’ultime frecce così forse avrebbe lanciate quest’uomo”.
75 Detto così, sguainò la spada di bronzo, a due tagli, acuminata, e piombò su l’eroe con un orrido grido. Ma, colto il punto,12 scagliò Ulisse divino una freccia,
8 per ammenda: “come riparazione”.
9 darti biasmo nessuno potrà del tuo cruccio: “nessuno potrà rimproverarti per il tuo dispiacere”. Eurimaco, in cambio della mitezza di Ulisse, promette un risarcimento collettivo per tutti i viveri che sono stati consumati; questo non vuol dire che ciascuno dei pretendenti avrebbe dovuto fornire venti buoi, ma un compenso pari a quel valore, allora elevato. Sappiamo infatti che una schiava abile valeva quattro buoi, un’armatura di bronzo nove e un gran tripode dodici.
10 a impinguarli: “per accrescerli”.
11 invitte: “che non sono mai state vinte”, “vittoriose”.
12 colto il punto: “colto il momento opportuno”.
e lo colpì nel petto, sottessa una mamma,13 e il veloce dardo gli conficcò nel fegato. Giù da la mano
80 gli scivolò per terra la spada. E piombò su la mensa barcollante, prono, rovesce mandò le vivande e la profonda coppa, batte’ nell’angoscia di morte la fronte contro il suolo, scalciando con ambe le piante14 fe’ tentennare il trono, su gli occhi gli corse una nebbia.
85 Tratta la spada affilata, Anfinomo allora d’un balzo contro l’eroe s’avventò, se forse il magnanimo Ulisse retrocedesse dal varco. Ma prima Telemaco giunse, che lo colpì fra le spalle, da tergo vibrando la lancia, sì che dal petto gli uscì la punta di bronzo. Piombando
90 fece un rimbombo, e la faccia percosse aspramente la terra. Subito lungi balzò Telemaco, infitta lasciando la lunga lancia nel corpo d’Anfinomo:15 tanto temeva che, se la lancia estraesse, qualcun degli Achei con la spada lo trafiggesse, vibrando su lui, così curvo, un fendente.16
I guerrieri si armano
95 A corsa si spiccò, fu subito accanto a suo padre, e, stando a lui vicino, parlò queste alate parole: «O padre, ora uno scudo ti porto con due giavellotti, ed un elmetto di bronzo, che bene alle tempie s’aggiusti, e d’armi tutto anch’io mi copro, e ne reco al porcaro
100 altre, ed altre al bovaro, ché meglio sarà ripararsi». E gli rispose l’accorto pensiero d’Ulisse, gli disse: «Portale, corri, finché mi restano frecce a difesa, che non dovessero infine sbalzarmi dal varco: son solo!»17
Disse. Del padre udì le parole Telemaco, e pronto 105 su ne la stanza corse, dov’erano l’armi fulgenti.
13 sottessa una mamma: “sotto una mammella”, quindi “nel petto”.
14 Le piante sono le piante dei piedi.
15 Telemaco è dunque rimasto senza armi, avendo lasciato la lancia conficcata nel corpo di Anfinomo. Da qui nasce l’esigenza di procurarsene delle nuove.
16 fendente: “colpo”.
17 son solo: Ulisse è l’unico ad essere armato, perché i suoi due alleati, Eumeo e Filezio, non sono ancora entrati nella lotta, mentre Telemaco sta uscendo dalla sala.
Quivi dai rostri spiccò quattro scudi con otto zagaglie,18 con quattro elmi di bronzo dai fitti cimieri di crini;19 e così carico giunse in un attimo presso a suo padre. Egli per primo si cinse di bronzo per tutte le membra,
110 e i due famigli20 anch’essi si chiuser ne l’armi fulgenti, e stavan presso Ulisse lo scaltro, dall’agile mente. Questi poi, sino a che gli rimasero frecce a difesa, ad uno ad uno i Proci toglieva di mira, e colpiva qua e là per la stanza: cadevano quelli un su l’altro.
115 Ma quando poi le frecce finite gli furono, allora l’arco vicino a un pilastro poggiò della solida porta alla parete lucente, che al suol non cadesse, e lo scudo ad armacollo21 si mise, di cuoio quadruplice,22 e un elmo solido, sopra la testa gagliarda, con l’alto cimiero
120 di crini – paurosa dall’alto ondeggiava la cresta –, ed impugnò due lance dal cuspide aguzzo di bronzo. V’era una porta d’uscita nell’alta parete, e sboccava per un passaggio in un ronco,23 sbarrata di saldi battenti: ma detto aveva Ulisse che il fido porcaro vi stesse 125 sempre vicino a guardia, ché questa era l’unica uscita. Ed Agelao favellò, rivolse ai compagni i suoi detti:
«Perché quell’uscio alcuno di noi non infila, o compagni, per dir tutto alla gente, che presto si chiami al soccorso? Quest’uomo avrebbe allora lanciate l’estreme sue frecce!»24
130 E gli rispose così Melanzio, pastore di capre:
«Stirpe divina, Agelao, possibil non è! La gran porta
18 dai rostri spiccò quattro scudi con otto zagaglie: “staccò dai ganci (rostri) quattro scudi con otto lance (zagaglie)”, in modo che ciascuno di loro avesse due colpi da scagliare.
19 L’elmo era costituito originariamente da un rozzo copricapo di pelle di cane; qui però l’intelaiatura è metallica, quindi si tratta di un elmo più resistente. Il pennacchio, che era di crine di cavallo, sormontava longitudinalmente la cima dell’elmo e conferiva al guerriero un aspetto particolarmente minaccioso.
20 I due famigli sono i due servitori, Eumeo e Filezio.
21 ad armacollo: “a tracolla”.
22 di cuoio quadruplice: “costituito da quattro strati di cuoio sovrapposti”.
23 ronco: “corridoio”. La porta per accedere al corridoio è quella che Eumeo doveva sorvegliare.
24 Qualora i Proci fossero riusciti a fuggire dal palazzo avrebbero organizzato un forte esercito contro Ulisse, il quale avrebbe dovuto rassegnarsi a soccombere: le frecce appena lanciate sarebbero state le sue ultime prima della morte.
troppo è vicina, l’imbocco del varco difficile è troppo, ed un sol uomo, se prode, di lì può respingere tutti.
Ma fra un istante qui spero recarvi, a vestirvene, l’armi,
135 che nella stanza sono disopra, ché qui, non altrove, l’armi deporre solevano Ulisse e il suo fulgido figlio».25
Detto così, Melanzio, pastore di capre, saliva pei corridoi della casa d’Ulisse a la stanza disopra.26 Dodici scudi dai rostri spiccava, e altrettante zagaglie,
140 ed altrettante celate di bronzo,27 crestate di crini; poi si spiccò di lì, tornò, porse il carico ai Proci.
A quella vista a Ulisse mancarono cuore e ginocchi, quando li scorse, d’armi coperti, squassare nel pugno28 le lunghe lance; allora tremenda gli parve l’impresa.
145 Ed a Telemaco subito volse l’alate parole:
«O Telemaco, qui Melanzio il pastore o qualcuna delle fantesche29 contro ci suscita asprissima guerra». E gli rispose l’accorto Telemaco queste parole: «Io, padre mio, questo sbaglio commisi, non darne la colpa
150 a nessun altro: ché l’uscio trovai saldamente sprangato, e lo lasciai dischiuso; ma io pensai fosse pel meglio.
Ma presto, o buon Eumeo, va su, spranga l’uscio di nuovo, e guarda bene, se opera è questa di qualche fantesca, o del figliuolo di Dolio, Melanzio: di lui più sospetto».
155 Tali parole così scambiarono questi fra loro.
[156-199] Melanzio tenta di nuovo di fuggire dalla sala del combattimento per procurare altre armi ai propri compagni, ma viene sorpreso da Eumeo, che chiede consiglio a Ulisse su quale punizione infliggere al traditore. Su ordine
25 Ricompare qui il capraio Melanzio; il suo nome (che significa “dai neri propositi”) è un presagio della sorte che gli toccherà in seguito all’avventata decisione di andare a prendere le armi.
26 Le vie d’uscita dalla sala del combattimento erano due: la prima era una porta piccola e stretta sul fondo della sala, alla quale Eumeo faceva la guardia, ed era perciò impossibile attraversarla incolumi perché il porcaro avrebbe facilmente ucciso chi di volta in volta vi si fosse avvicinato; l’altra era più ampia e presentava un alto gradino (da quest’ultima Telemaco era uscito poco prima per prendere le armi). Da qui Melanzio riesce a uscire per procurare armi ai Proci.
27 celate di bronzo: “elmi di bronzo con visiera”.
28 squassare nel pugno: “agitare in mano”.
29 Ulisse sospetta le serve (fantesche) del tradimento, perché la sala delle armi comunicava con le loro stanze; facilmente quindi avrebbero potuto accedervi e prendere delle armi per i Proci.
dell’eroe, Melanzio subisce una lenta tortura: gli vengono legate le mani e i piedi e viene appeso a una colonna per tutta la durata della notte, prima che gli venga data la morte.
Un aiuto divino
[200-303] Quando compare Minerva con le sembianze di Mentore, fidato amico di Ulisse, l’eroe intuisce subito che si tratta della dea e non esita a chiederle un aiuto nella battaglia. Minerva, però, non concede da subito la vittoria, ma sprona Ulisse a dare il meglio di sé e si ritira sul soffitto della sala per vedere il seguito dello scontro. Poiché l’eroe dimostra di essere molto valoroso, la dea decide di aiutarlo, mandando a segno tutti i suoi colpi e rendendo innocui quelli degli avversari. Così cadono a terra moltissimi Proci, annientati dalla straordinaria potenza di Ulisse.
La supplica di Leiode e di Femio
Or si lanciò Leiode, d’Ulisse abbracciò le ginocchia,
305 e, supplicando, queste gli volse veloci parole: «Io ti scongiuro, e tu abbi pietà, non voler la mia vita.
Mai, te lo giuro, Ulisse, non feci né dissi alcun male nella tua casa con le tue donne, ma anzi solevo dissuader gli altri Proci, se male adoprar li vedessi.
310 Ma non mi davano retta, frenar non sapevano le mani. Essi or soggiacquero al tristo destino pei loro misfatti; io le primizie ardevo soltanto, né mai feci danno.30
Pure morrò, ché non ha compenso chi opera bene». E biecamente guardandolo, Ulisse l’accorto rispose:
315 «Se, come dici, fra quelli le vittime ardevi, di certo più d’una volta, fra queste mie mura, avrai fatto l’augurio che tardi per me l’ora giungesse del dolce ritorno, e che toccasse a te la mia sposa, e ne avessi figliuoli. Ecco perché non potrai fuggire la doglia di morte».
320 Detto così, raccolse da terra una spada – Agelao, colpito a morte, se l’era lasciata sfuggire di mano –,
30 Leiode, finora sfuggito alla strage, supplica Ulisse di risparmiarlo poiché avrebbe sempre tentato di distogliere i Proci dalle loro azioni malvagie e non avrebbe mai partecipato alle loro turpi decisioni, ma solo ai banchetti, in quanto egli era il responsabile dei sacrifici (le primizie) da bruciare agli dèi.
gliela vibrò con pugno gagliardo per mezzo a la nuca, e sul terreno piombò la testa che ancora parlava.
[324-374] Anche il cantore Femio, finora sfuggito alla strage, supplica Ulisse di risparmiarlo poiché gli era sempre stato fedele e aveva cantato per i Proci solo per costrizione.31 Telemaco conferma le parole di Femio e chiede al padre di salvarlo dalla strage, come anche merita di non essere ucciso l’araldo Medonte che sempre si prese cura di Telemaco durante l’assenza del padre. Poiché Ulisse si fida ciecamente dei consigli del figlio, risparmia Femio e Medonte e permette loro di allontanarsi dalla stanza.
La punizione delle ancelle infedeli
375 Ulisse intanto gli occhi volgeva per tutta la stanza, se non vi fosse nascosto, pur vivo, qualcuno dei Proci; ma tutti quanti a mucchi distesi fra polvere e sangue li vide, come pesci che dentro a una gola ricurva, i pescatori dal mare spumante fuor trassero a riva
380 dentro le fitte maglie di sciabica,32 e giacciono tutti sopra la sabbia, guizzando per brama dei flutti marini, sin che cocente la fiamma del sole li tolga di vita, simili a questi, i Proci giacevano l’uno su l’altro.
Ed a Telemaco Ulisse divino così favellava:
385 «Presto, Telemaco, adesso va su, la nutrice Euriclea chiama, che venga da me, ché io debbo darle un comando».
Disse; e il comando del padre Telemaco presto adempieva. Corse alle stanze, dischiuse la porta, e chiamò la nutrice: «Alzati, e vieni qui, vecchietta, che in questo palazzo
390 sei preposta alle donne che prestan servizio, a vegliarle; seguimi, ché mio padre ti chiama per darti un comando». Disse; né furono vane parole; ma l’uscio richiuse, e mosse ove guidava Telemaco, dietro ai suoi passi.
E trovò dunque Ulisse che stava su i corpi trafitti,
31 Femio non solo era stato inoffensivo, ma, essendo un artista, era protetto da una condizione di inviolabilità. Infatti gli aedi erano in qualche modo preferiti dagli dèi, che avevano voluto dare loro il dono del canto; essendo perciò in stretta connessione con le divinità, erano anche “intoccabili”. Il trattamento rispettoso che Ulisse ha nei confronti di Femio contrasta duramente con la spietata uccisione di Leiode.
32 La sciabica è una rete da pesca chiusa all’estremità in forma di sacco.
395 lordo tutto di grumi di sangue. Pareva un leone che da la spoglia sbranata d’un bove sbandato33 si stacca: tutta dinanzi è la giubba cosparsa di sangue, ne goccia34 l’una mascella e l’altra, spettacolo orrendo a vederlo. Così le mani e i piedi d’Ulisse parevano lordi.
400 Come i trafitti ella vide, gl’innumeri fiotti del sangue, fu per alzare un grido di gioia dinanzi a tal gesta. Ma quella sua gran voglia Ulisse frenò, la trattenne, e le parlò, le volse così la veloce parola: «Dentro te, vecchia, t’allegra, ma frenati, ma non gridare, 405 ché millantar sopra genti cadute non è generoso.35
Vittime caddero questi del fato segnato dai Numi, e dei misfatti loro, ché a niuno degli uomini, quanti qui ne giungessero, avevan riguardo, né al tristo né al buono.
Ma delle colpe loro pagato hanno il tristo compenso.
410 Ora, su via, tutte quante le ancelle a me novera,36 e scerni,37 quelle che m’hanno oltraggiato da quelle che sono innocenti».
E gli rispose così la fida nutrice Euriclea:
«Sta bene, tutto il vero ti dico, figliuolo. Cinquanta38 sono di questa casa le ancelle che avevo addestrate
415 a lavorare, filare la lana, prestare servigi.
Dodici sole fra queste da banda hanno messo il pudore, senza né a me né alla stessa Penelope avere rispetto. Quanto a Telemaco, allora veniva crescendo, e la madre non lo lasciava ancora comando impartire a le donne.
420 Ora lascia ch’io salga di sopra alle fulgide stanze, e la tua sposa avverta, che un Dio circonfuse di sonno». E le rispose, le disse l’accorto consiglio d’Ulisse:
33 sbandato: “separato dal resto del branco”.
34 ne goccia: “gocciola di sangue” (il pronome ne si riferisce alla parola sangue).
35 millantar: “vantarsi esageratamente”, “gloriarsi”. Questa battuta piena di umanità contrasta con la ferocia usata da Ulisse fino a questo momento. Non bisogna dimenticare però che quella dell’eroe non è una folle furia omicida, poiché egli ha appena riconosciuto l’importanza di risparmiare Femio e Medonte, che non erano colpevoli.
36 novera: “conta”, “passa in rassegna”.
37 scerni: “discerni”, cioè “distingui”.
38 Può sembrare esagerato il numero delle serve (cinquanta), ma è tipico dei grandi re avere numerosi servitori: altrettante ne possedeva, per esempio, Alcinoo, re dei Feaci.
«No, non destarla per ora.39 Ma imponi alle femmine, a quelle ree di codeste sozzure,40 che scendano giù nella sala».
425 Dicea così. La vecchia si diede a percorrer la casa per avvertire le ancelle, che presto scendesser da Ulisse. Questi frattanto Telemaco e il fido porcaro e il bifolco presso di sé raccolti, parlò queste alate parole: «Or comandate alle donne che portino via questi corpi, 430 poi che le mense e i seggi detergan con l’acqua e le spugne; poi, quando tutto vedrete in ordine dentro la casa, fuor della stanza all’aperto condotte sian tutte le ancelle, e nella vasta corte, fra il muro di cinta e la torre, con le taglienti spade colpitele, sino a che tutte
435 rendano l’anima, e più non pensino al dolce sollazzo».41
[436-491] Giungono nella sala le ancelle infedeli e, in preda a un pianto disperato, trasportano fuori i corpi dei Proci e puliscono poi la stanza, tutta sporca di sangue. In seguito vengono condotte all’aperto e impiccate, dopo essere state appese a delle colonne con un nodo alla gola; anche Melanzio, ancora in vita dopo la tortura, viene ucciso. Ulisse, per portare a compimento la pulizia della sala, chiede a Euriclea di portargli dello zolfo, poiché si credeva che, bruciato, purificasse i luoghi contaminati dal sangue umano. Solo a questo punto il signore di Itaca domanda di poter vedere la propria moglie.
39 Ulisse vieta a Euriclea di svegliare Penelope proprio ora: non vuole apparire agli occhi della moglie come un carnefice tutto sporco di sangue e mostrarle quel macabro spettacolo nella sala.
40 ree di codeste sozzure: “colpevoli di queste azioni empie”.
41 sollazzo: “piacere”.
L’incredulità di Penelope
E nelle stanze eccelse la vecchia1 andò, tutta ridente, per dire alla regina com’era tornato il suo sposo.
Salde le sue ginocchia, veloci salivano i piedi; e stando a capo al letto, le volse così la parola:
5 «O figlia mia diletta, Penelope, sorgi dal sonno, vedi con gli occhi tuoi ciò che tu notte e giorno bramavi!
Tornato è Ulisse, è giunto, sebben dopo tanto,2 al suo tetto, ha morte inflitto ai Proci, flagello di questa dimora, che divoravano i beni, faceano sopruso a tuo figlio».
10 E le rispose così Penelope piena di senno: «Pazza, mia cara nutrice, t’han resa gli Dei, ch’àn potere di rendere demente chi pur possedesse gran senno, e avvian talora, invece, su vie di saggezza lo stolto. Essi t’han leso:3 prima diritta tu avevi la mente.
15 Perché vuoi farmi danno, se tanto già debbo soffrire?
Tali stoltezze per dirmi mi desti perfino dal sonno, che dolcemente or ora coperte m’aveva le ciglia?
Ché mai non ho così dormito dal giorno che Ulisse di qui partì per Ilio, per quella città maledetta.
20 Su via, dunque, discendi, ritorna di nuovo alla sala, ché se delle mie donne qui fosse alcun’altra venuta, e ridestata dal sonno m’avesse per darmi tal nuova, giù nella sala di nuovo di certo l’avrei rimandata con un gran brutto congedo: a te gli anni tuoi fanno schermo».
25 Ed Euriclea, la fida nutrice, così le rispose: «Io non ti faccio danno, figliuola mia cara! Davvero
1 Euriclea.
2 sebben dopo tanto: “anche se dopo molto tempo”.
3 Leso è il participio passato del verbo ledere, “danneggiare”. Penelope insinua che gli dèi possano aver danneggiato la mente di Euriclea, dato che le cose che ella riferisce alla padrona paiono folli.
è ritornato Ulisse, è in casa, come io te lo dico: è lo straniero che tutti qui dentro copriano d’oltraggi. Telemaco da un pezzo sapeva di già ch’era in casa,
30 ma per prudenza tenne nascosti i disegni del padre, per vendicar gli affronti di quei tracotanti Signori».
Così disse. Gioì Penelope, e a terra balzata, strinse la vecchia al seno, dagli occhi versando gran pianto; e a lei rispose, queste parole veloci le disse:
35 «Se tu la verità, nutrice mia cara, m’hai detta, se proprio Ulisse, come tu dici, è tornato al suo tetto, come poté le mani gittare sui Proci sfrontati, s’egli era solo, e gli altri qui ognor se ne stavano a frotte?»4
E le rispose così la fida nutrice Euriclea:
40 «Io non lo so, non ho visto: udito ho soltanto le grida dei Proci uccisi. Noi stavam delle stanze nel fondo, invase di terrore, con gli usci serrati sprangati, sinché venne a chiamarmi, che uscissi alla fine, tuo figlio Telemaco; ed a lui l’aveva ordinato suo padre.
45 E allora Ulisse io vidi, che in mezzo ai cadaveri stava; i corpi intorno a lui giacevan sul sodo impiantito5 l’uno sull’altro. Così lo vidi, fui colma di gioia!
A mucchi quelli adesso, dinanzi alla porta dell’atrio, stanno; e la casa tutta purifica Ulisse col zolfo,
50 ch’arde presso un gran fuoco; e ha me qui mandata a chiamarti. Seguimi, dunque, sicché tu e lui vi possiate allegrare entrambi il cuore, perché, dopo tanti travagli sofferti, vivo è tornato al suo focolare, e te viva ha trovata, e il figlio caro; e quelli che oprarono tanto a suo danno,
55 i Proci, a tutti quanti scontare egli ha fatta la colpa». E a lei queste parole Penelope scaltra rispose: «Non giubilare ancora, non darti, nutrice, alla gioia: tu sai quanto bramato giungerebbe Ulisse al suo tetto, da tutti, e più da me, dal figlio che abbiam generato.
60 Però questa novella non è come tu me la narri, ma dei Celesti alcuno trafisse quei prenci arroganti,
4 a frotte: “in grande numero”.
5 sodo impiantito: “solido pavimento”.
che si sdegnò della loro superbia, e dei loro misfatti, però ch’essi a nessuno degli uomini aveano rispetto, né buoni, né malvagi, che ad essi giungesse. Per questo, 65 per la stoltezza loro, patiron la morte. Ma Ulisse ebbe conteso il ritorno, lontan dalla patria è perito».
E le rispose così la fida nutrice Euriclea: «Qual motto, figlia mia, ti fuggì dalla chiostra dei denti? Lo sposo tuo ch’è dentro, che al tuo focolare è vicino, 70 dici che non è giunto? Incredulo è sempre il tuo cuore!
E allora, un altro segno ti posso mostrare ben certo: la piaga che col bianco suo dente gl’inferse un cinghiale.
Io mentre lo lavavo, la vidi, e volevo a te dirlo, ma egli m’afferrò, su la bocca mi pose la mano, 75 e proibì, saggiamente, che a te ne facessi parola.
Seguimi adesso, ch’io per pegno ti do la mia vita: fammi, se mai t’inganno, morire di misera morte».
E a lei queste parole Penelope scaltra rispose: «Cara nutrice, i consigli dei Numi che vivono eterni
80 ardua cosa è scoprire, chi pure abbia saggia la mente.
Ma, tuttavia, dov’è Telemaco andiamo, ch’io veda spenti i superbi Proci, ch’io veda colui che li uccise».
Detto ciò discese; e il cuor le ondeggiava nel petto, molto, se interrogare dovesse in disparte lo sposo, 85 oppure farglisi presso, le mani baciargli e il capo.
E poiché giunse,6 ed ebbe varcata la soglia di pietra, sedé quivi, ad Ulisse di fronte, alla vampa del fuoco, alla parete di fronte. Vicino ad un alto pilastro quegli sedeva, in terra guardando, attendendo se nulla, 90 ora che innanzi a sé lo vedea, gli dicesse la sposa. Ma muta ella restava, stupore ingombrava il suo petto.
Ed or nel viso a lui lungamente figgeva lo sguardo, or non lo ravvisava, coperto com’era di cenci.
E allor parlò, le volse Telemaco questa rampogna: 95 «O madre, o madre mia cattiva, dall’animo duro, perché dunque dal padre lontana rimani, e non siedi
6 poiché giunse: la subordinata ha valore temporale, “dopo che giunse”.
vicino a lui, né alcuna parola o dimanda gli volgi?
Niun’altra donna avrebbe di certo sì rigido cuore, che dallo sposo lontana restasse, che dopo venti anni,
100 dopo tanti travagli, tornato pur fosse alla patria!
Ma nel tuo petto sempre più duro è d’un sasso il tuo cuore».
E a lui queste parole Penelope scaltra rispose: «Figlio, nel seno mio percosso è il cuor mio di stupore, né posso una domanda rivolgergli, non un accento,
105 neppur gli occhi nel viso fissargli posso io. Se davvero
Ulisse egli è, se questa pur è la sua casa, noi due meglio potremo l’un l’altro conoscere. Abbiamo dei segni nascosti a tutti gli altri, che solo noi due conosciamo».
[109-148] Per il riconoscimento di Penelope Ulisse può ancora attendere, poiché al momento vi sono altre urgenze. Occorre infatti che il popolo non si accorga da subito della strage, che la notizia non giunga già ai familiari dei Proci, cosicché Ulisse e i suoi possano trasferirsi nella tenuta in campagna e lì prepararsi a fronteggiare la vendetta dei parenti degli uccisi. Viene dunque ordinato alle serve di portare tuniche splendenti e al cantore Femio viene chiesto di cantare. Dalla strada i passanti restano ingannati, credendo che all’interno del palazzo si stiano celebrando nozze festose.
Il letto di Ulisse
La dispensiera Eurinome intanto lavava ed ungeva
150 nella sua casa Ulisse magnanimo cuore; ed un manto bello dintorno alle membra gli cinse, e una tunica. E Atena su lui, dal capo ai piedi, profuse celeste bellezza; e dalla vasca uscì che un Nume sembrava all’aspetto, ed a sedere tornò sul trono onde prima era surto,
155 dinanzi alla sua sposa, volgendole queste parole: «O sciagurata, un cuore ti diedero i Numi d’Olimpo duro come a niun’altra fra quante son femmine in terra. Con cuor tanto sicuro nessun’altra donna potrebbe lungi restar dallo sposo che dopo sì fieri travagli,
160 dopo venti anni lunghi, giungesse alla terra materna. Su via, nutrice, adesso preparami il letto, ché anch’io vada a giacere, ché questa nel petto ha un cuore di ferro».
E a lui queste parole rispose Penelope scaltra:
«O sciagurato, non pecco d’orgoglio, né a vile ti tengo,
165 né mi stupisco troppo. So bene qual eri d’aspetto quando Itaca lasciasti sul legno dagli agili remi.
Fuori dal talamo,7 su, distendigli il letto, Euriclea, solido ch’egli stesso foggiava, di salda fattura.
Qui fuori il saldo letto portate, gettatevi sopra, 170 ch’egli vi giaccia, velli, tappeti e cuscini fulgenti».
Così dunque diceva, per metter lo sposo alla prova.
Ma Ulisse, infin crucciato, parlava alla saggia consorte:
«Queste parole che dici davvero m’affliggono il cuore.
Chi mai quel letto altrove porterà? Ben arduo sarebbe
175 anche ad un uomo esperto, se pur non venisse un Celeste, che facilmente potrebbe portarlo anche in terra straniera.
Ma dei mortali nessuno, per quanto fiorente di forze, potrebbe agevolmente rimoverlo: è in esso un segreto ch’io solo so, ch’io solo, senza opera d’altri, l’estrussi.8
180 Crescea dentro il recinto d’ulivo un gran tronco fronzuto, tutto in rigoglio, fiorente, massiccio al par d’un pilastro.
Ed io d’intorno a questo le mura del talamo estrussi, di ben connesse pietre, poi su lo copersi col tetto, e con le porte lo chiusi dai ben connessi battenti.
185 Poi dell’ulivo la chioma di frondi prolissa recisi,9 e su dalla radice lasciato un pedale, con l’ascia lo venni levigando, tirandolo a filo di squadra, sin che ne feci un piede che tutto forai col trivello; e, cominciando a piallare, di qui trassi a termine un letto
190 che d’oro intarsïai tutto quanto, d’argento e d’avorio, e strisce infin di cuoio vi stesi, di porpora tinte. Questo è il segreto, donna, ch’io dunque ti dico. Ed ignoro se il letto ancor si trova dov’era, o se il ceppo d’ulivo altri tagliato l’abbia, altrove abbia il letto portato».
195 Così disse; e alla donna mancarono cuore e ginocchia, quando conobbe il segno sicuro che Ulisse le diede. E allor diritta corse piangendo, ed al collo d’Ulisse
7 talamo: “stanza nuziale”.
8 estrussi: “costruii”.
9 la chioma di frondi prolissa recisi: “tagliai (recisi) la chioma ricca (prolissa) di foglie”.
gittò le braccia, il viso gli coprì di baci, e gli disse: «Non adirarti, Ulisse, con me, tu che avanzi in saggezza
200 gli uomini in ogni cosa. Ci diedero i Numi gli affanni, invidïosi che noi, restandoci l’un presso l’altro, la gioventù godendo, giungessimo agli anni canuti.10
Ora non t’adirare con me, non serbarmi rancore, perché non t’abbracciai così come prima ti vidi,
205 ché sempre il cuore a me di paura gelava nel seno, che alcuno, qui giungendo, dovesse con belle parole trarmi in inganno, ché molti disegnano tristi consigli. Neppure Elena argiva, la figlia di Giove possente, mai si sarebbe stretta di amore ad un uomo straniero,
210 quando saputo avesse che avrebber dovuto gli Argivi di là novellamente condurla alla terra materna.
A compiere quell’atto d’obbrobrio la spinse la Diva, né presentì nel cuore da pria la funesta vendetta, onde anche a noi la doglia dovea primamente venire.11
215 Ma ora, poi che tu m’hai detto il certissimo segno del nostro letto, cui12 niun altro sapea dei mortali, ma tu soltanto ed io, noi soli con l’unica ancella Attòride13 che, quando qui venni, mi diede mio padre, che custodìa per noi del talamo saldo la porta,
220 ora l’animo mio, per quanto restio,14 tu convinci». Disse; ed in lui suscitò più viva la brama del pianto; e sì piangea, stringendo la cara, la saggia sua sposa. Come la terra appare gradita a chi naufrago nuota, quando spezzata gli abbia Posidone l’agile nave
225 sovresso il mar, da venti sbattuta e da masse di flutti –pochi potean sfuggire del mare schiumoso alla riva a nuoto, e molta a loro salsuggine copre le membra,
10 Gli anni canuti simboleggiano la “vecchiaia”.
11 Penelope chiede al marito di non adirarsi per la sua iniziale diffidenza, la quale era dovuta solamente al desiderio di agire con prudenza. Del resto, argomenta Penelope, se la stessa Elena fosse stata più prudente la guerra di Troia, con tutta probabilità, si sarebbe evitata.
12 cui: “che” (pronome relativo con funzione di complemento oggetto).
13 Attoride è un patronimico. Si riferisce a Eurinome, la dispensiera, e significa “figlia di Attore”.
14 restio: “diffidente”.
quando, sfuggiti a morte, riescono infine alla terra –, similemente apparve gradito alla donna lo sposo,
230 né dal suo collo più staccava le candide braccia.
E ancor li avrebbe in pianto trovati l’Aurora di rose, se non formava un altro disegno la Diva occhiazzurra.
Trattenne all’ultimo orlo la notte, e la rese più lunga, e nell’Oceano Aurora frenò, né lasciò che i cavalli
235 agili piedi aggiogasse, che recan la luce ai mortali, Lampo e Fetonte, svelti puledri che recano Aurora.15
E Ulisse allora queste parole rivolse alla sposa: «Donna, di tutte le prove non siamo ancor giunti alla fine, anzi, un travaglio ci resta da compier, difficile, grave
240 senza misura; ed io conviene che tutto lo affronti, perché tanto predetto m’ha l’alma del vecchio Tiresia quel giorno ch’io disceso son giù nella casa d’Averno, per procacciare ai miei compagni il ritorno, e a me stesso. Ma ora vieni, sposa, moviamo al giaciglio, ché infine
245 possa trovar conforto nel dolce sopore del sonno».
E a lui queste parole rispose Penelope scaltra: «Il letto pronto sempre per te sarà, quando lo brami, ora che t’hanno i Numi d’Olimpo concesso il ritorno alla tua casa bene costrutta, alla terra materna.
250 Ma perché tu ben sai, perché te l’ha detto un Celeste, dimmi, su via, di questi travagli, ché in seguito, credo, io li dovrò sapere; né male è ch’io sappia fin d’ora».
E a lei così rispose l’accorto pensiero d’Ulisse: «O disgraziata, perché tu insisti, perché vuoi saperlo?
255 Ebbene, parlerò, ché nulla io ti voglio celare; ma lieto il cuore tuo non ne andrà, né pure io ne fui lieto. Egli per molte e molte città di mortali mi disse che andar dovrei, con me recando un manevole16 remo, sinché giungessi a genti che il pelago mai non han visto,
15 Come il Sole, anche l’Aurora viaggia per il cielo su di un carro dorato tirato da due cavalli divini, Lampo e Fetonte. I versi immediatamente precedenti indicano che gli dèi hanno voluto render più lunga la notte per concedere a Ulisse e Penelope di riposarsi in pace, dopo una così lunga separazione.
16 manevole: “maneggevole”.
260 né cibo mangian mai commisto con grani di sale, che mai non han veduti navigli dai fianchi rubesti,17 né maneggevoli remi che sono come ali alle navi. E questo chiaro indizio mi disse, né a te lo nascondo: quando, imbattendosi in me, un altro che pure viaggi,
265 un volutabro18 mi dica ch’io reco su l’omero saldo, allora il remo in terra, mi disse, dovrai conficcare, ed immolare vittime elette a Posidone, un toro, un arïete, e un verro petulco,19 signore di scrofe.
Ed alla patria quindi tornare, ed ai Numi immortali,
270 ch’ànno nell’ampio Olimpo dimora, offrir sacre ecatombe, a tutti quanti per ordine. E, infine, dal mare una morte placida a me verrà, che soavemente m’uccida, prostrato già da mite vecchiezza; e felici d’intorno popoli a me saranno. Tal, disse, sarebbe il mio fato».
275 E gli rispose queste parole Penelope scaltra: «Se dunque i Numi a te concedon migliore vecchiezza, speme20 pur v’è che tu possa rifugio trovare dai mali».
Queste parole dunque scambiavan Penelope e Ulisse.
E la nutrice ed Eurinome intanto apprestavano il letto
280 con le sue soffici coltri,21 di faci brillanti al fulgore.
E, quando con gran zelo steso ebbero il solido letto, nelle sue stanze di nuovo la vecchia tornò per dormire, e la custode del talamo Eurinome ad essi fu guida,
285 mentre moveano al letto, reggendo due fiaccole in pugno. Quindi partì, poi che li ebbe guidati nel talamo; e quelli lieti ripreser l’uso del letto da tanto deserto.
[288-335] Marito e moglie, finalmente riuniti, si recano nella loro stanza per riposare dopo tanti travagli. Tuttavia nessuno dei due può prendere sonno senza aver prima udito il racconto delle sofferenze patite dall’altro in tutti questi anni di lontananza.
17 rubesti: “rossi”.
18 Il volutabro (o ventilabro) è una pala che i contadini utilizzavano per separare il grano dalla pula.
19 petulco: “aggressivo”.
20 speme: “speranza”.
21 coltri: “coperte”.
Dal mar tosto la Dea suscitò mattiniera,22 dal trono d’oro, perché recasse la luce ai mortali. Ed Ulisse surto dal morbido letto, così favellava alla sposa: «O sposa, entrambi sazî noi siamo oramai di travagli, 340 tu, nell’attesa qui piangendo il mio crudo ritorno, io mentre Giove e gli altri Celesti fra mille iatture lungi tenevan me dal suol della patria diletta. Ma ora, poi ch’entrambi ci unisce di nuovo un sol letto, i beni raduniamo che addotti23 ho con me, nella casa.
345 Ed il bestiame che a me distrutto hanno i Proci arroganti, molto ne avrò, facendone preda, altro ancora gli Achivi me ne daranno, finché riempiute non abbia le stalle. Ed ora, dunque, al nostro podere alberato mi reco, per rivedere il buon padre, che lì giace, immerso nel cruccio.
350 E a te, donna, sebbene sei savia, darò tal consiglio. Presto si spargerà, come il sole s’innalzi, la fama dei pretendenti, come li ho uccisi dentro la reggia. Sali perciò nelle stanze di sopra, conduci le ancelle con te, né alcun guardare, né volger parola ad alcuno».
355 Disse. E l’armi sue belle d’intorno agli omeri cinse. Poscia svegliò Telemaco, il fido porcaro e il bifolco, e ingiunse a tutti e tre che impugnassero l’armi di guerra. Sordi all’invito quelli non furono. Cinsero l’armi, aprirono le porte, uscirono; e Ulisse era guida.
360 Già s’effondea su la terra la luce; ed avvoltili d’ombre velocemente Atena li addusse nei campi lontani.
22 La dea che sorge dal mare portando il nuovo giorno è Aurora.
23 addotti: “condotti”, “portati”.
I Proci scendono nell’Ade
Frattanto Ermete, il Nume Cillenio,1 gli spirti dei Proci fuor dalle membra chiamava. Stringeva nel pugno la verga aurea, bella, con cui degli uomini gli occhi sopisce, quelli che vuole, ed altri ne desta giacenti nel sonno.
5 Le2 sospingea con questa, seguivano quelle stridendo. Come allorché vipistrelli nel cavo di fonda spelonca stridono svolazzando quando un dalla rupe giù cade, donde in catena pendevano, e stretti si tengono a sciame, così stridendo quelle movevano; e a tutte era guida
10 il salvatore Ermete, pei tramiti d’ombra velati. Giunsero presso ai rivi d’Oceano, presso la pietra
Leucade,3 presso le porte del Sole, ed al popol dei sogni giunsero; e tosto di qui pervennero al prato asfodelo,4 dove han dimora l’alme, parvenze di genti defunte.
15 Quivi trovaron l’alma d’Achille figliuol di Peleo, di Patroclo, d’Antiloco scevro di macchie,5 e d’Aiace, che per bellezza di forme, per forza di membra era il primo fra i Danai tutti, dopo l’egregio figliuol di Peleo.
[19-120] Davanti agli occhi delle anime dei Proci avviene un drammatico dialogo tra Achille e Agamennone. Il primo piange la triste sorte del grande sovrano, e con lui quella di tutti i guerrieri che lo hanno seguito nella guerra di Troia. Il secondo, a sua volta, racconta della morte del Pelide, della lotta
1 Mercurio è detto Cillenio in quanto nato sul monte Cillene, a nord dell’Arcadia, la regione che occupa il Peloponneso settentrionale.
2 Il pronome le si riferisce alle anime dei Proci.
3 Secondo gli antichi Greci, la pietra Leucade era un enorme masso bianco che segnava il confine tra il regno dei vivi e quello dei morti.
4 Il prato asfodelo, o prato degli asfodeli, si trovava all’ingresso dell’Ade. Gli asfodeli sono dei fiori simili ai gigli, che anticamente servivano per adornare i sepolcri.
5 scevro di macchie: “senza colpe”. Dal momento che la colpa è considerata una macchia (in latino macula) che sporca l’anima, ancora oggi chi è senza colpe è detto immacolato (in-maculato).
estenuante che gli Achei dovettero sostenere per recuperarne il corpo e dei funerali cui prese parte in mezzo agli uomini la divina madre dell’eroe, Teti. Terminato questo dialogo, Agamennone si avvede della presenza dei Proci, in particolare di Anfimedonte, il cui padre aveva ospitato un tempo l’Atride sull’isola di Itaca. Il giovane itacese fornisce allora al sire Agamennone delle spiegazioni circa le circostanze della morte sua e dei suoi compagni.
«Tutto rammento quello che dici, divino signore, e tutto io ti dirò, senza punto scostarmi dal vero, qual fu la nostra morte, la nostra misera fine. Noi bramavamo la sposa d’Ulisse, da tanto lontano, 125 ed essa né schifava le nozze, né pur le compieva, ché contro noi macchinava la morte e la livida Parca, e la sua mente aguzzò, per ordire un nuovo tranello. Una gran tela ordì nella reggia, ed a tesserla imprese, lunga lunga, e sottile; poi queste parole ci disse:
130 “Giovani miei pretendenti, poiché spento è Ulisse divino, pazienza abbiate, per quanto bramosi di nozze, ch’io compia questo mantello, sì che perduto non vada il già fatto.
Per Laerte l’eroe sudario deve essere, il giorno che de la morte dogliosa la sorte ferale lo colga,
135 ché delle donne Achee rampognarmi taluna non debba che senza manto giaccia, chi tanti conquiderne seppe”. Così disse; e restò conquiso6 il nostro animo altero. Ella, pertanto, di giorno la gran tela a tessere imprese, e poi di notte, accese le fiaccole, tutto sfaceva.
140 Restò tre anni ascoso7 l’inganno, e gabbati8 gli Achivi; ma poi che il quarto giunse, tornando la bella stagione, una delle sue donne c’informò, che tutto sapeva, e la cogliemmo, mentre struggeva la fulgida tela. Così, pur contro voglia, le fu giocoforza finirla.9
145 E quando l’ebbe poi finita, la fece lavare, e un manto ci mostrò che un sole pareva, una luna. E allora un triste demone Ulisse condusse alla patria,
6 conquiso: “persuaso” (letteralmente “conquistato”).
7 ascoso: “nascosto”.
8 gabbati: “ingannati”.
9 le fu giocoforza finirla: “fu obbligata a finirla”.
dove il porcaro aveva la casa, all’estremo dei campi. Frattanto anche Telemaco, il figlio d’Ulisse divino,
150 dalla sabbiosa Pilo giungeva sul negro naviglio; e contro ai Proci entrambi tramando la misera morte, all’inclita10 città pervennero: Ulisse secondo e Telemaco primo, che guida gli fu nel cammino.
E lo condusse, tutto coperto di cenci, il porcaro,
155 che somigliasse a un pitocco che vada errabondo, ad un vecchio.
Né alcun di noi poté riconoscer che Ulisse egli fosse, quando improvviso apparve, neppur quelli ch’eran più annosi; ma lo colpimmo di male parole e investimmo di colpi.
Ma i colpi egli e le ingiurie, sebben fosse sotto il suo tetto,
160 patì con saldo cuore, sinché non fu giunto il momento.
Ma quando poi lo destò de l’Egioco Giove la mente, spiccate via col figlio Telemaco l’armi stupende, le collocò nel talamo, e chiuse sovra esse le imposte.
Alla sua sposa allora suggerì con molta accortezza
165 che proponesse ai Proci la gara dell’arco e dell’asce, ch’esser doveva per noi tapini principio di morte.
Né tendere poté dell’arco possente la corda niuno di noi, ché scarse troppo eran le forze alla prova.
Ma quando l’arco grande fu giunto alle mani d’Ulisse,
170 qui tutti insieme noi levammo la voce, ad imporre non gli si desse l’arco, per chiederlo ch’egli potesse.11
Solo insisté, die’ l’ordin Telemaco ch’egli lo avesse. Quindi in sua mano Ulisse tenace divino lo tolse, e facilmente la freccia scagliò per i fori dell’asce;
175 poscia balzò, si piantò su la porta, versando le frecce,12 terribilmente guardando, colpì prima Antinoo. E poscia scagliò su tutti gli altri dall’arco orribili frecce. Dritto mirava, e quelli cadevano l’uno su l’altro.
Si conosceva bene che un Dio gli era presso, al soccorso.
180 Alla sua furia così soccombendo per tutta la sala, chi qua chi là cadeva, levandosi sconcio fracasso
10 inclita: “famosa”.
11 per chiederlo ch’egli potesse: “per quanto egli potesse chiederlo”.
12 versando le frecce: “rovesciando le frecce (fuori dalla faretra, per terra)”.
delle teste percosse: di sangue fumava il piantito.13 Così dunque morimmo noi tutti, Agamennone, e i corpi giacciono senza onore tuttor nella casa d’Ulisse; 185 ché nulla sanno ancora, d’ognun nella casa, gli amici, che dalle piaghe il sangue detergano, e levino il pianto sovra le salme esposte, ché tale è il diritto dei morti».
[188-201] Agamennone loda allora la beatitudine di Ulisse, che ha avuto la fortuna di avere una moglie fedele, diversamente da quanto capitò a lui.
E quelli,14 usciti dalla città, presto giunsero al campo ben coltivato, bello, del vecchio Laerte. Laerte stesso l’avea guadagnato, col frutto di grandi travagli.
205 Quivi la casa aveva: correan tutto intorno le stanze, dove solean mangiare, dormire, posar dal travaglio15 gli schiavi che attendevan solerti al lavoro16 dei campi. E qui, lontano dalla città, nel podere, una vecchia sicula c’era, e curava con tutto l’amore il vegliardo.
210 Qui tali detti Ulisse rivolse al figliuolo ed ai servi: «Adesso, entrate prima voi tre nella solida casa, e per il pranzo un porco sgozzate, il migliore di tutti; e intanto io cercherò nostro padre, per fare la prova se pur mi riconosce, se san gli occhi suoi ravvisarmi,
215 o s’ei non mi ravvisa, che fui tanto tempo lontano». Dette queste parole, ai servi die’ l’armi di guerra, e quelli, senza indugio, entrarono in casa. Ed Ulisse al fertile podere si fece più presso, cercando.
Né com’egli vi entrò, trovò Dolio, il fedele capoccia, 220 né v’era alcun dei figli rimasto, né alcuno dei servi, ma tutti erano andati lontano, a raccogliere pruni
13 il piantito: “il pavimento”.
14 Ulisse, Telemaco e i due servi, Eumeo e Filezio.
15 posar dal travaglio: “riposare dal lavoro”.
16 attendevan solerti al lavoro. Attendere a un lavoro significa “dedicarsi a un lavoro”, “impegnarsi in un lavoro”. Solerte è detto di chi si adopera con impegno in ciò che fa.
per raggiustare al podere la siepe;17 e lor guida era il vecchio.18
E nel podere, tutto curato, trovò solo il padre, che custodiva una pianta. Vestiva una tunica grama,
225 sudicia, rattoppata. Dintorno agli stinchi gambiere di cuoio, piene anch’esse di toppe, a riparo dei graffi; e nelle mani, a schermire le spine,19 avea guanti; e un berretto di cuoio in capo. Così faceva più misera mostra.
Or, quando Ulisse tenace divino, stentare lo vide
230 disfatto di vecchiaia, con l’animo oppresso dal cruccio, sotto ad un alto pero sostò, bagnò gli occhi di pianto.
E l’animo ed il cuore gli andava ondeggiando fra due: se al cuore egli stringesse, baciasse suo padre, e se tutto gli raccontasse, com’era tornato alla terra materna,
235 oppur se lo provasse, se a lui tutto prima chiedesse.
Questo, com’ebbe pensato, gli parve il partito migliore: volgergli prima parole d’angoscia, per metterlo a prova. E dritto a lui, pensando così, venne Ulisse divino.
A testa bassa quegli zappava dintorno a una pianta;
240 e, a lui fattosi presso, così disse il fulgido figlio: «Vecchio, davvero inesperto non sei d’accudire un podere, anzi la tua perizia da tutto traspare, né pianta
c’è nel verziere20 alcuna, né fico, né vite, né ulivo, né pero, aiuola alcuna non c’è, che non sia ben curata.
245 Altro però devo dirti, né farne tu devi rancura.21
Tu di te stesso cura non prendi, ma insieme t’opprime trista vecchiaia, e irsuto22 sei tu, sei coperto di cenci.
Non per la tua pigrizia così ti trascura il padrone, né, chi ti guardi, da te trapela alcunché di servile
250 alla statura, all’aspetto, ché anzi ad un re tu somigli: a un re dal bagno uscito somigli, quando abbia pranzato,
17 pruni per raggiustare al podere la siepe. Dolio e i suoi figli erano andati a cercare delle sterpaglie (pruni) con cui aggiustare la siepe che recintava il podere.
18 e lor guida era il vecchio. Il riferimento è a Dolio, vecchio servo di Laerte che stava guidando i figli nel lavoro.
19 a schermire le spine: “a proteggere dalle spine”.
20 verziere: “giardino”.
21 né farne tu devi rancura: “non devi provare rancore di ciò”, “non devi adirarti per questo”.
22 Irsuto, se riferito a un uomo, è detto di chi ha la barba incolta.
quando s’accinga al riposo, com’è privilegio dei vecchi. Ma via, dimmi ora questo, favellami senza menzogna. Di chi servo sei tu? Di quale signore è quest’orto?
255 La verità di questo rispondi, ch’io sappia di certo se veramente siam giunti in Itaca, come mi disse quell’uomo ch’ò incontrato testé, mentre qui m’avviavo, che poca mente aveva però, poi che dir non mi volle tutto, e le mie domande non seppe ascoltar, ch’io chiedevo
260 d’un uomo ospite mio, se vivo è, se vede la luce, oppur se morto è già, se sceso è alla casa d’Averno. Ora a te parlerò; tu intendimi, e dammi risposta. Ospite accolsi un giorno un uom nella casa materna, giunto alle nostre contrade, né alcuno degli uomini mai
265 nati in estranea terra riuscì più gradito al mio cuore.
D’Itaca la sua stirpe diceva che fosse: diceva ch’era suo padre l’eroe Laerte, figliuolo d’Arcisio. Sotto il mio tetto dunque lo addussi, ben caro lo tenni ospite nella mia casa, che avea d’ogni bene abbondanza,
270 doni ospitali gli offersi, che più mi sembravano adatti: sette talenti d’oro di fine lavoro gli diedi,23 tutto d’argento un cratere gli diedi scolpito di fiori, poi dodici mantelli a un doppio, e altrettanti tappeti, dodici belle vesti con dodici tuniche, e inoltre
275 gli diedi quattro donne, maestre di egregi lavori, di bello aspetto, quelle che scegliere piacque a lui stesso».
E gli rispose, le guance bagnando di lagrime, il padre: «Straniero, a quella terra che dici tu sei proprio giunto, ch’ora è sotto il dominio di genti arroganti e superbe.
280 Doni ricchi gli offristi, ma furono vani quei doni, ché se tra il popolo d’Itaca vivo l’avessi trovato, non ti lasciava partire, se pria non t’avesse ospitato, offerti cari doni, ché n’ha, chi primo offre, diritto. Ma prima questo dimmi, rispondimi senza menzogna:
285 quanti anni già son corsi, dal dì ch’ebbe ospizio in tua casa l’ospite sventurato, mio figlio? Se fosse ancor vivo,
23 sette talenti d’oro di fine lavoro gli diedi: “gli diedi oggetti d’oro lavorati finemente, del valore di sette talenti”. Il talento corrispondeva a un determinato peso d’oro.
quell’infelice! Ma certo, lontano agli amici e a la patria, l’han divorato i pesci nel pelago, oppur su la terra è divenuto preda d’uccelli, di fiere. E sua madre
290 pianto non l’ha, né curato, né il padre. Ed è pur nostro figlio. Né la sua moglie saggia, Penelope piena di senno, pianse nel letto lo sposo, com’era pur debito, e gli occhi chiuder non gli poté, ch’è l’ultimo dono ai defunti».
[294-311] Laerte chiede allo straniero di presentarsi, e Ulisse, volendolo ancora tenere all’oscuro della propria identità, si presenta come un naufrago di nome Eperito; aggiunge di aver conosciuto Ulisse, ma di non vederlo da ormai cinque anni. A queste parole Laerte si dispera, e di fronte a questo inatteso e triste spettacolo l’eroe non può trattenere la commozione e continuare a nascondersi.
Così disse; e sul vecchio di cruccio una nuvola negra si effuse: ambe le mani rempiute di livida polve, giù per la bianca testa con gemiti lunghi l’effuse.
315 E il cuor balzava in gola a Ulisse, pungea le sue nari empito acerbo,24 così vedendo suo padre; e su lui
si lanciò, l’abbracciò, lo coperse di baci, e gli disse:
«Io stesso sono quello di cui, padre mio, tu mi chiedi: dopo venti anni lunghi son giunto alla terra materna.
320 Ora desisti dal pianto, le lagrime lascia ed i lagni.
In breve io ti dirò, ché molto conviene affrettarsi, ch’entro la nostra casa ho uccisi i Proci arroganti, il sanguinoso oltraggio, gl’iniqui soprusi ho puniti».
E gli rispose Laerte, gli volse così la parola:
325 «Se tu che giungi sei veramente Ulisse mio figlio, un qualche segno dammi, ben chiaro, sì ch’io ne sia certo».
E gli rispose così l’accorto pensiero d’Ulisse:
«A questa piaga, prima di tutto, rivolgi lo sguardo, che nel Parnaso un apro25 m’inflisse col bianco suo dente,
24 pungea le sue nari empito acerbo: “un forte stimolo (empito) gli prudeva le narici”. Questo prurito è un segno che annuncia il pianto imminente.
25 un apro: “un cinghiale”.
330 quando ero lì, ché mia madre, che tu m’avevate inviato al padre di mia madre Autolico, a prendere i doni ch’egli m’avea promesso quando era da noi qui venuto. Gli alberi poi ti dirò nel ben coltivato podere che mi donasti un giorno, quando io te li chiesi fanciullo,
335 uno per uno, nell’orto seguendo i tuoi passi. Tra quelli camminavamo, e tu mi dicevi il nome d’ognuno. Tredici peri tu mi donasti, con dodici meli, quaranta fichi, e poi cinquanta filari di viti mi promettesti che dati mi avresti, e ciascuno era adulto
340 già da far uva, e grappoli in essi fiorian d’ogni specie allor che le stagioni celesti incombeano su loro».
Così disse, ed al vecchio mancarono cuore e ginocchia quando conobbe i segni sicuri che Ulisse gli diede.
Gittò le braccia al collo del figlio suo caro, e svenuto
345 contro il suo cuore Ulisse tenace divino lo accolse. Quando rinvenne poi, riprese lo spirto vitale, di nuovo a lui parlò, gli volse così la parola:
«Oh Giove padre, sì, ci siete voi Numi in Olimpo, se i Proci hanno davvero scontati gl’iniqui soprusi.
350 Ma gran timore adesso il cuore m’invade che presto piombino tutti qui su noi gl’Itacesi, e un messaggio mandino ai Cefalleni, per ogni città, che li aizzi».
E gli rispose così l’accorto pensiero d’Ulisse: «Animo! Queste paure non facciano ingombro al tuo cuore.
355 Ma per la via più breve dell’orto ora a casa torniamo, ch’ivi mandai Telemaco, e il fido porcaro, e il bifolco, perché quanto potevano prima ammannissero26 il pranzo».
[358-408] Ulisse e Laerte tornano nell’abitazione, e così la famiglia può finalmente pranzare riunita. Laerte viene lavato e la dea Minerva lo rende maestoso e splendente. Arriva Dolio, il servo di Laerte, con i suoi figli, e senza domandare spiegazioni capisce di trovarsi di fronte al tanto atteso Ulisse.
ammannissero: “preparassero”.
La battaglia decisiva
[409-465] Intanto in città si è sparsa la notizia della strage dei Proci, e i loro parenti, riunitisi in assemblea, decidono di attaccare Ulisse per vendicare la morte dei propri figli. Nell’Olimpo, però, Atena si rivolge al padre, indecisa se guidare Ulisse a compiere un’ulteriore strage.
E Atena volse a Giove Cronide così la parola:
«O padre nostro, figlio di Crono, supremo signore, rispondi a ciò ch’io chiedo: che cosa cela or la tua mente?
Vuoi che tra questi27 prima si accenda la trista battaglia, 470 l’amara pugna, o vuoi che insieme li stringa amicizia?»
E le rispose Giove che aduna le nuvole in cielo:
«Perché mi volgi questa domanda, figliuola diletta?
Questo disegno forse non l’hai concepito tu stessa, perché, giungendo, Ulisse traesse vendetta dei Proci?
475 Fa’ pur ciò che tu vuoi; ma ciò che dir devo, ti dico. Ora che tratta ha Ulisse divino vendetta dei Proci, stringiamo fidi patti, ché Ulisse rimanga sovrano, e noi Celesti oblio decretiam della strage28 dei figli e dei fratelli: ritorni fra loro l’antica amicizia, 480 e la ricchezza e la pace sian d’Itaca sempre retaggio».29
Atena già bramosa fu spinta da queste parole, e con un lancio balzò vêr la terra dai picchi d’Olimpo. Or, quando Ulisse e i compagni spenta ebber la brama del cibo, così prese a parlare Ulisse tenace divino:
485 «Esca un di voi, faccia guardia, ché alcun di sorpresa non giunga». Così disse; ed il figlio di Dolio s’alzò per uscire.
Stette sopra la soglia, li vide che tutti eran presso, e subito ad Ulisse parlò queste alate parole: «Sono di già vicini: s’impugnino l’armi al più presto».
490 Così diceva. E quelli s’alzarono, cinsero l’armi. Quattro dintorno ad Ulisse; di Dolio i figliuoli eran sei. Ed ecco l’arme presero anch’essi Laerte con Dolio, bianchi di pelo entrambi, ma validi ancora alla pugna.
27 tra questi: Minerva si riferisce alla famiglia di Ulisse e alle famiglie dei Proci.
28 oblio decretiam della strage: “stabiliamo che la strage sia dimenticata”.
29 retaggio: “eredità”.
E poi ch’ebbero cinte le membra col lucido bronzo, 495 aperto l’uscio, fuori balzarono, e guida era Ulisse. E accanto ad essi Atena si pose, la figlia di Giove, che assunta avea la voce di Mentore e il viso. A tal vista s’allegrò molto il cuore d’Ulisse tenace divino, e volse al figlio suo Telemaco queste parole:
500 «Telemaco, ora sappi, movendo tu stesso alla pugna, dove l’un contro l’altro si provano gli uomini egregi, onta non fare alcuna dei prodi alla stirpe,30 ché fummo per forza e per prodezza su tutta la terra famosi».
E gli rispose queste parole Telemaco scaltro:
505 «Padre, di certo vedrai sin che tu vorrai, con che cuore schivar saprò la taccia ch’io rechi disdoro31 alla stirpe». Così disse. E Laerte gioì, disse queste parole: «Numi diletti, questo che giorno è per me! Quanto godo! Gareggian di prodezza fra loro mio figlio e il nepote».
510 E a lui d’accanto, disse la Diva dall’occhio azzurrino: «Figlio d’Arcisio, a me diletto fra tutti gli amici, a Giove padre innalza la prece, ed a Pallade Atena, e poi subito vibra, e avventa la lunga zagaglia». Così disse; e vigore gl’infuse Pallade Atena.
515 Levò prima alla figlia di Giove possente la prece; poi subito vibrò, scagliò la sua lunga zagaglia, ed Eupito32 colpì nelle bronzee gote dell’elmo; né resse questo al colpo, ma il bronzo fuor fuor vi s’immerse. Diede un rimbombo cadendo, su lui rintronarono l’armi.
520 E allor sovressi i primi piombarono Ulisse ed il figlio. E li colpian con le spade, con l’aste bicuspidi.33
E quivi tutti li avrebbero uccisi, né alcuno sarebbe tornato, se la figliuola di Giove, signora de l’egida,34 Atena,
30 onta non fare alcuna dei prodi alla stirpe; dipende dal precedente sappi. Da ordinare così: sappi non fare alcuna onta alla stirpe dei prodi, cioè “sappi non recare vergogna alla tua stirpe”, ovvero “sappi onorare la tua stirpe”.
31 disdoro: “disonore”.
32 Eupito è il padre di Antinoo, il più potente e più insolente di tutti i Proci.
33 bicuspidi: “a due punte”. La lancia aveva una punta su ciascuna estremità: la prima serviva a ferire, la seconda a piantare l’asta in terra, in caso di necessità.
34 L’egida è lo scudo di Minerva.
la voce non alzava, che tutta la turba rattenne.
525 «D’Itaca genti, tregua ponete alla guerra funesta, che senza strage si possa comporre la vostra contesa». Così diceva Atena. Percossi di bianco sgomento stettero quelli, e a tutti giù l’armi piombâr da le mani, caddero l’armi a terra, al suon de la voce divina.
530 E verso la città, fuggendo, cercarono scampo. Quivi il tenace Ulisse, levando un altissimo grido, s’avventò, l’incalzò, come aquila a volo dal cielo.
Ma scagliò allora una fumida35 folgore il figlio di Crono, che cadde innanzi a sua figlia, la Diva dall’occhio azzurrino.
535 E disse allor la Diva dall’occhio azzurrino ad Ulisse: «O figlio di Laerte, divino scaltrissimo Ulisse, frenati, e della guerra pon fine alla rissa funesta, ché Giove, onniveggente di Crono figliuol, non s’adiri». Disse Atena. Ubbidì col gaudio nell’anima Ulisse.
540 E quindi strinse accordi giurati fra entrambe le parti Pallade Atena, la figlia di Giove che l’egida scuote, che avea la voce assunta di Mentore, e tutto l’aspetto.
35 fumida: “fumante”, “che produce fumo”.
inizio riquadro destro
inizio riquadro destro
Erice
Pitecusa
Capua
Cuma
Posidonia
Elea
Palermo
Segesta
Selinunte
Eraclea
Imera
SICILIA LIPARI
Agrigento
Gela
Camarina
Lentini
Acre
Mylae
Zancle
Metaponto
LUCANIA BRUZIO
Siris
Taranto
Sibari
Ipponio
Medma
Reggio
Nasso
Catania
Megara Iblea
Siracusa
Caulonia
Locri Epizefiri
Crotone
L’azione narrata nell’Odissea si svolge complessivamente in quaranta giorni. Ripercorriamo giorno per giorno gli avvenimenti principali.
Nel primo giorno, a seguito delle decisioni del concilio degli dèi, Minerva giunge a Itaca. Qui trova Telemaco, affranto per le insolenze dei Proci, disperato e disilluso. Lo sprona allora a intraprendere un viaggio alla ricerca di informazioni sulla sorte del padre Ulisse (Libro I).
Nel secondo giorno Telemaco, ormai decisosi all’azione, convoca l’assemblea e annuncia la propria partenza, tanto imminente da avvenire durante la notte stessa (Libro II).
Nel terzo giorno Telemaco giunge a Pilo, dove è accolto da Nestore, il quale, però, non è in grado di fornirgli notizie utili sulla sorte del padre. Telemaco viene allora invitato a rivolgersi al sovrano di Sparta, Menelao (Libro III).
Nel quarto giorno Nestore, dopo aver sacrificato agli dèi, congeda il giovane Telemaco, mandandolo a Sparta a cavallo assieme al figlio Pisistrato. Nella notte i due ragazzi faranno scalo a Fere (Libro III).
Nel quinto giorno Telemaco e Pisistrato coprono il tratto di strada che separa Fere da Sparta e, giunti da Menelao, ricevono una prima accoglienza (Libri III, IV).
Nel sesto giorno Telemaco, presentatosi a Menelao, espone il motivo del proprio viaggio; il sovrano di Sparta a sua volta rivela al giovane quanto ha appreso in Egitto da Proteo riguardo al destino di Ulisse. Intanto a Itaca i Proci preparano un’imboscata a Telemaco. Nella stessa giornata Penelope, fino ad allora ignara di tutto, viene informata dalla serva Euriclea del viaggio di Telemaco (Libro IV).
Nel settimo giorno, a seguito di un nuovo concilio degli dèi, Mercurio viene mandato a Ogigia, l’isola di Calipso, per ingiungere alla dea di lasciar partire Ulisse. Calipso, affranta, informa subito l’eroe (Libro V).
Tra l’ottavo giorno e il decimo Ulisse, aiutato da Calipso, costruisce la zattera per affrontare la navigazione, che compie in venti giorni, dall’undicesimo al trentunesimo giorno (Libro V).
Nel trentaduesimo giorno Ulisse naufraga a Scheria e, soccorso da Nausicaa, viene condotto nella città dei Feaci, dove si getta supplice alle ginocchia della regina Arete (Libri VI, VII).
Nel trentatreesimo giorno Ulisse, dopo aver ascoltato il canto di Demodoco e dopo aver preso parte alle gare atletiche organizzate in suo onore, rivela la propria identità e racconta ad Alcinoo e a tutti i Feaci il suo doloroso viaggio di ritorno da Troia (Libri VIII, IX, X, XI, XII, XIII).
Nel trentaquattresimo giorno Ulisse banchetta presso i Feaci, si congeda da loro e nella notte salpa per Itaca, accompagnato da rematori dell’isola su una portentosa nave feacia (Libro XIII).
Nel trentacinquesimo giorno Poseidone, irato con i Feaci che hanno prestato soccorso a Ulisse, li punisce, tramutando la loro nave in pietra. Ulisse nel frattempo si sveglia a Itaca e stenta a riconoscere l’isola. Solo un colloquio con Minerva riesce a rassicurare l’eroe. La dea trasforma Ulisse in un vecchio mendicante e, così travestito, l’eroe giunge alla capanna del guardiano di porci, Eumeo, che lo accoglie. A Sparta, intanto, Minerva sollecita il ritorno di Telemaco, il quale, congedatosi da Menelao, subito riparte, sostando nuovamente a Fere per la notte (libri XIII, XIV, XV).
Nel trentaseiesimo giorno Telemaco giunge a Pilo e subito si imbarca per Itaca (Libro XV).
Nel trentasettesimo giorno Telemaco ritorna a Itaca e giunge alla capanna del porcaro, dove si ricongiunge con il padre. I Proci constatano il fallimento dell’imboscata tesa al giovane figlio di Ulisse (Libri XV, XVI).
Nel trentottesimo giorno Telemaco torna alla reggia e vi introduce anche Ulisse, travestito tuttavia da mendicante. Telemaco, attuando il piano predisposto dal padre, fa togliere dai muri della sala tutte le armi. A palazzo Ulisse subisce insulti e percosse da parte dei Proci e si scontra con Iro, altro mendicante. Riesce ad avere un colloquio con la moglie Penelope, dalla quale tuttavia non vuole farsi riconoscere. Lo riconosce, però, Euriclea, alla quale l’eroe intima di tacere. Nella notte Penelope riceve in sogno il suggerimento di proporre la gara con l’arco (Libri XVII, XVIII, XIX, XX).
Nel trentanovesimo giorno si svolge la gara, la quale presto si trasforma nella strage dei Proci, che Ulisse compie con l’aiuto di Telemaco, Eumeo e Filezio. Terminato il massacro dei pretendenti vengono punite anche le ancelle infedeli. Finalmente Ulisse può rivelarsi a Penelope. I due, dopo tanti anni di separazione, trascorrono la notte assieme (Libri XX, XXI, XXII, XXIII).
Nel quarantesimo giorno Ulisse si reca al podere del padre Laerte, si fa riconoscere da esso e qui respinge l’attacco degli Itacesi, irati per la sorte toccata a molti loro figli, che avevano fatto parte dei Proci. Minerva risolve la battaglia finale, procurando così a Ulisse e a tutta l’isola la pace (Libri XXIII, XXIV).
Il viaggio di ritorno di Ulisse da Troia comprende un lasso di tempo di circa dieci anni. Quella che segue è la ricostruzione del suo viaggio e del tempo dedicato a ogni tappa, sebbene per alcune di esse, soprattutto per i viaggi in mare, l’Odissea non fornisca riferimenti temporali soddisfacenti.
Partito da Troia, Ulisse arrivò nella terra dei Ciconi. Non sappiamo purtroppo quanti giorni furono impiegati in questo viaggio, ma sappiamo che Ulisse e i compagni si fermarono presso i Ciconi per quattro giorni.
Da qui navigarono per nove giorni, fino a raggiungere la terra dei Lotofagi, dove trascorsero una giornata.
Ignoriamo quanto durò il viaggio per raggiungere l’isola delle capre, vicino alla quale sorgeva la terra dei Ciclopi. Ulisse e i compagni stettero un giorno presso l’isola delle capre e per tre giorni vennero invece imprigionati da Polifemo.
Da qui partì e raggiunse in un tempo imprecisato l’isola di Eolo. Presso Eolo Ulisse soggiornò trenta giorni. Di lì partì per Itaca, nelle cui vicinanze giunse dopo dieci giorni di navigazione; tuttavia una tempesta di venti lo riportò all’isola di Eolo, presumibilmente nello stesso numero di giorni, sebbene il libro non dia indicazioni esplicite.
Quando ripartirono dall’isola di Eolo, Ulisse e i compagni giunsero in sei giorni nella terra dei Lestrigoni, dove trascorsero una giornata. Da qui mossero verso l’isola Eea, ma purtroppo non sappiamo quanti giorni durò tale viaggio.
Per tre giorni Ulisse e i suoi uomini rimasero sulla spiaggia dell’isola. In seguito raggiunsero la casa di Circe, dove rimasero per un anno intero. Decisosi infine a ritornare in patria, seguendo il consiglio della maga, Ulisse si recò nell’Ade. Questo viaggio avvenne in un giorno, mentre un giorno ancora l’eroe rimase presso Circe.
La tappa successiva del suo viaggio, raggiunta in un numero imprecisato di giorni, fu l’isola del Sole, dove restò per trentasei giorni. Costretto a fuggire anche da lì, Ulisse approdò in dieci giorni all’isola di Calipso, Ogigia
Ulisse soggiornò presso la dea per sette anni. Lasciato partire, dopo venti giorni di navigazione naufragò a Scheria. Qui rimase tre giorni come ospite del re Alcinoo; di seguito, in un giorno di navigazione (una notte, per la verità) venne accompagnato a Itaca, dove in cinque giorni l’eroe ristabilì l’ordine che si era perduto.
Acaia: è la regione più a nord del Peloponneso. In origine il nome Achei indicava proprio gli abitanti di questa zona, ma poi si è esteso a indicare tutti i Greci che combatterono la guerra di Troia.
Acheronte: letteralmente “il fiume degli affanni”, è uno dei fiumi infernali.
Achille: figlio di un uomo, Peleo, e di una dea marina, Teti, fu il più grande eroe della guerra di Troia. Nacque a Ftia, in Tessaglia, dove regnò. Achille era un eroe estremamente forte e valoroso, noto a tutti anche per la sua velocità. L’origine di queste sue eccezionali qualità è da ricercare in alcuni racconti legati alla sua infanzia. Settimo figlio nato dall’unione tra un uomo e una dea, era anch’egli destinato come i fratelli a una sorte mortale. Negli altri figli la madre Teti aveva provato a cancellare le tracce mortali immergendoli nel fuoco, provocandone tuttavia la morte. Nato dunque Achille, il padre Peleo vigilò e, quando la madre fu sul punto di compiere nuovamente il pericoloso esperimento, l’uomo strappò il figlio dalle braccia di Teti, senza impedire, tuttavia, che il piccolo si bruciasse un pezzo d’osso del piede destro. Offesa per l’agguato del marito, la dea Teti tornò a vivere nel mare e il piccolo Achille venne allevato dal centauro Chirone. Per prima cosa il buon Chirone, abile nell’arte della medicina, dissotterrò il
gigante Damiso, che da vivo era stato famoso per la velocità nella corsa, e mise al posto dell’osso mancante ad Achille l’osso corrispondente del gigante. Ciò spiega la proverbiale velocità di Achille. Chirone addestrò il ragazzo alla lotta, alla caccia, alla medicina, alla musica, e lo nutrì solo di viscere di leoni e di cinghiali, cosicché la forza di questi animali potesse trasmettersi al giovane. La guerra di Troia fu strettamente legata alla sorte di questo personaggio. Egli, con il suo risentito rifiuto di combattere, causò la morte di molti compagni, non ultimo Patroclo, suo fedele servitore e amico. Proprio il dolore per la morte di quest’ultimo convinse Achille ad abbandonare l’ira che nutriva per l’offesa ricevuta da Agamennone e a tornare in battaglia, abbracciando in tal modo il destino a lui profetizzato di una vita breve e gloriosa. Achille poté così piegare la resistenza dei Troiani, infliggendo all’esercito nemico il terribile colpo della morte di Ettore, loro condottiero e baluardo. A Troia, infine, Achille trovò la morte, colpito al tallone da una freccia lanciata da Paride. Un’altra leggenda legata all’infanzia dell’eroe, infatti, racconta che un altro tentativo che la madre Teti fece per procurare l’invulnerabilità al figlio fu immergerlo nelle acque dello Stige, fiume infernale. Tuttavia, il tallone per il quale la madre teneva il bambino non fu bagnato e pertan-
to rimase l’unico punto del corpo vulnerabile. Altri episodi celebri della vita dell’eroe sono la lotta contro Pentesilea, regina delle Amazzoni, e contro Memnone, figlio dell’Aurora.
Ade: fratello di Zeus, è il dio dei morti. Innamoratosi di Persefone, figlia di Demetra, la rapì, ma Zeus non acconsentì a quest’unione. Ade, però, aveva dato da mangiare a Persefone un chicco di melograno prima che questa partisse. Chi avesse visitato il regno dei morti e si fosse nutrito di qualcosa durante la sua permanenza, infatti, non sarebbe mai più potuto andarsene del tutto. Fu così che con l’inganno Ade ottenne che Persefone trascorresse presso di lui metà dell’anno e l’altra metà presso la madre.
Afrodite: dea della bellezza e dell’amore, nacque dalle onde del mare e divenne sposa di Efesto. Nonostante il vincolo matrimoniale, fu protagonista di numerose avventure amorose, la più nota delle quali è certamente quella avuta con Ares. Il marito Efesto, infatti, sospettando l’infedeltà della moglie, tese loro una trappola, preparando nel letto una rete metallica invisibile, nella quale i due amanti rimasero incastrati. Efesto convocò allora tutti gli dèi dell’Olimpo per coprire di vergogna Ares e Afrodite. Un altro celebre episodio legato a questa divinità costituisce l’antefatto della guerra di Troia. Afrodite, Atena ed Era si stavano contendendo una mela d’oro, premio per la dea più bella. Paride, giovane principe troiano, pastore di greggi, era stato scelto come giudice della gara. Afrodite promise a Paride che gli avrebbe consegnato
Elena se lei fosse stata dichiarata vincitrice e il giovane troiano assecondò la proposta della dea, ricevendo così in cambio l’opportunità di rapire la bella moglie di Menelao.
Agamennone: sovrano di Argo, era sposato con Clitemnestra. Il suo matrimonio era iniziato sotto il funesto segno di un delitto, che si rivelò la causa della rovina dell’eroe: Agamennone, infatti, aveva strappato la donna al precedente marito, Tantalo, uccidendo quest’ultimo assieme a un suo figlio. Dall’unione con Clitemnestra nacquero diversi figli: Crisotemi, Laodice, Ifianassa, Ifigenia, Elettra, Oreste. Quando Paride rapì Elena, moglie di Menelao, quest’ultimo chiese al fratello Agamennone un aiuto per riprendersela. Venne dunque organizzata la spedizione a Troia. Partiti senza conoscere la strada, gli Achei stentavano a raggiungere Troia. Per poterla raggiungere, su consiglio di Calcante, Agamennone tornò in patria e sacrificò agli dèi la figlia Ifigenia, alimentando ulteriormente l’odio della moglie. Tornato a casa al termine della guerra, Agamennone venne ucciso da Clitemnestra e dal suo amante Egisto. L’eroe greco in seguito fu vendicato dal figlio Oreste.
Agelao: uno dei Proci, il quale, pur mostrando gentilezza nei confronti di Telemaco all’inizio del racconto, non viene tuttavia risparmiato nella strage finale dei Proci.
Aiace Telamonio: figlio di Telamone, regnava su Salamina. Alto, bello e valoroso, prese sulle proprie spalle il grave peso della guerra contro i Troiani durante l’assenza dalle armi di
Achille. Più volte fu sul punto di uccidere Ettore, ma gli dèi salvarono sempre il condottiero troiano. Si diede la morte perché non gli furono concesse le armi del Pelide, messe in palio per il guerriero più forte tra i Greci. Esse, infatti, vennero consegnate a Ulisse.
Alcinoo: re dei Feaci, regna su Scheria. In quanto figlio di Nausitoo, può vantare una discendenza diretta da Poseidone. Questo spiega il particolare favore che il suo popolo nutre presso gli dèi. Sua figlia Nausicaa per prima assiste Ulisse dopo il suo ultimo naufragio.
Alcippe: serva di Elena a Sparta.
Alfeo (1): è il fiume più importante del Peloponneso.
Alfeo (2): padre di Orsiloco e nonno di Diocle.
Aliterse: figlio di Mastore, è un indovino itacese e predice il ritorno di Ulisse.
Andremone: padre di Toante.
Anfinomo: il più saggio tra i Proci. In più occasioni difende Telemaco e l’ospite misterioso giunto a Itaca (Ulisse), ma nonostante Ulisse gli abbia augurato di andarsene prima della strage, partecipa alla lotta finale e vi trova la morte per mano di Telemaco.
Anfitrite: nereide, cioè divinità marina figlia di Nereo, fu moglie di Poseidone, che se ne innamorò e la fece rapire da dei delfini.
Anticlea: madre di Ulisse e figlia di Autolico. Morì durante l’assenza del figlio, perché distrutta dall’insopportabile mancanza.
Anticlo: uno degli eroi achei chiusi
dentro al ventre del cavallo di Troia. Questi stava per rispondere a Elena, che chiamava gli eroi greci simulando le voci delle rispettive mogli, ma Ulisse lo trattenne e gli impedì di parlare, evitando così la loro rovina.
Antifate: re dei Lestrigoni, divora uno dei compagni di Ulisse e ne mette in fuga altri invece di offrirgli ospitalità.
Antifo: uno dei figli di Egizio che partirono per Troia con Ulisse.
Antiloco: giovane figlio di Nestore che combatté eroicamente nella guerra di Troia. È ricordato soprattutto per la dedizione al padre, che salvò dalla morte facendogli scudo con il proprio corpo e venendo così ucciso.
Antinoo: figlio di Eupito, è il giovane più carismatico tra i pretendenti di Penelope, e loro capo. Brutale e arrogante, trova la morte per mano di Ulisse, colpito da una freccia alla gola mentre si sta accingendo a bere da una coppa.
Apollo: figlio di Latona e Zeus, nacque sull’isola di Delo in seguito a numerose peripezie. Gelosa del marito, Era guardava con ostilità la nascita di questo dio, e pertanto minacciò di distruggere qualsiasi terra avesse ospitato Latona per il parto. Dopo un lungo vagabondare, la madre di Apollo trovò l’isola d’Asteria, che in seguito mutò nome in Delo. Apollo è una divinità molto complessa. È innanzitutto il dio delle arti e delle profezie, che concede agli aedi il dono del canto e la capacità di conoscere tutti gli eventi mitologici successi. Lui stesso è in grado di prevedere gli eventi ed esprime i suoi vaticini at-
traverso una sacerdotessa nel famoso tempio di Delfi, città presso la quale il dio uccise il terribile mostro Pitone, fondando il proprio culto e il proprio santuario. Infine è il dio arciere, un pericolosissimo tiratore, perché dotato di una mira infallibile.
Arcisio: padre di Laerte, quindi nonno di Ulisse.
Ares: figlio di Zeus ed Era, è il dio della guerra. È sempre rappresentato con la corazza e l’elmo, armato di scudo, lancia e spada. Ha una statura sovraumana ed emette grida terribili. Nonostante questo suo spaventoso aspetto, non è un dio invulnerabile, tanto che il mito ricorda alcuni combattimenti nei quali fu sopraffatto, il più celebre dei quali fu quello contro Diomede, eroe acheo che ferì il dio con l’aiuto di Atena.
Arete: moglie di Alcinoo, quindi regina di Scheria.
Argo (1): vecchio e fedele cane di Ulisse, in grado di riconoscere il proprio padrone dopo l’assenza di vent’anni.
Argo (2): patria di Agamennone. La città si trova nella parte nord-orientale del Peloponneso.
Arneo: mendicante vagabondo e provocatore contro cui Ulisse è costretto a lottare per il divertimento dei Proci.
Arpie: personificazioni dei venti tempestosi che rapivano gli uomini. Avevano un corpo mostruoso: l’apparenza era quella di donne, ma avevano ali e zampe da uccelli.
Artemide: figlia di Latona, è la dea della caccia; porta sempre con sé arco e frecce, con le quali colpisce non solo
gli animali, ma anche gli uomini. È infatti responsabile delle morti improvvise che avvengono tra le mura domestiche.
Asteride: è un’isola che nell’immaginario omerico doveva trovarsi tra Itaca e Same. L’unica che corrisponde a questo criterio è quella chiamata oggi col nome di Dascalio, ma in realtà è poco più grande di uno scoglio.
Atena: figlia di Giove. È la dea delle arti e della saggezza, e proprio in virtù di questa qualità viene spesso invocata dal sapiente Ulisse. Il costante aiuto della dea è infatti fondamentale per permettere il ritorno dell’eroe in patria.
Atene: città più importante dell’Attica, tuttora capitale della Grecia.
Atlante: era un titano, il quale si era alleato con Crono, padre di Giove, per tentare la rivolta contro gli dèi dell’Olimpo. Fallito l’attacco, Atlante venne catturato e punito: fu costretto così a reggere sulle proprie spalle la volta del cielo. Fu padre della ninfa Calipso.
Atreo: figlio di Pelope e di Ippodamia, divenne sovrano di Micene dopo uno scontro con l’odiato fratello Tieste. L’elezione a re fu il risultato di una lunga contesa tra i due fratelli, cui prese parte anche Zeus con i suoi inganni. Al termine dello scontro, ben lontano dal riappacificarsi con Tieste, Atreo invitò il fratello a banchetto e a sua insaputa gli cucinò le carni dei tre figli precedentemente uccisi, svelando solo al termine del pasto l’orribile misfatto. Fu padre di Menelao e Agamennone, che per questo vennero chiamati col patronimico Atridi (= “figli di Atreo”).
Atride: patronimico indicante Agamennone o Menelao.
Attoride: è un patronimico; si riferisce a Eurinome, la dispensiera, e significa “figlia di Attore”.
Aurora: appartiene alla generazione delle prime divinità, quelle nate all’epoca dei Titani. È raffigurata come una dea dalle dita color di rosa, immagine indicante i primi colori che nel cielo precedono il sorgere del sole. Le sue vicende sono legate a continui amori, che le valsero l’odio di molte dee, tra cui Afrodite e Giunone, che le imposero di non risiedere nell’Olimpo. Tra i suoi figli troviamo Memnone, che fu ucciso da Achille sotto le mura di Troia.
Autolico: figlio di Ermes e Chione, ereditò dal padre il dono di poter rubare senza essere visto. Fu nonno di Ulisse, padre di Anticlea. Cacciando con lui, il giovane Ulisse si procurò una terribile ferita sulla gamba.
Averno: è il regno dei morti.
Cadmo: padre di Ino.
Calipso: ninfa figlia di Atlante che vive sull’isola di Ogigia e vi trattiene Ulisse per sette anni.
Campi Elisi: luogo ultraterreno al quale potevano accedere solo pochi privilegiati, che avrebbero goduto di una condizione di felicità.
Cariddi: originariamente era una donna, ma poi venne tramutata in mostro da Giove per aver rubato i buoi di Ercole. Cariddi viveva in territorio siculo ed era un pericolo mortale per i naviganti.
Cariti: raffigurate come tre sorelle (Eu-
frosine, Talia e Aglae) sono divinità della bellezza e forze della vegetazione. Hanno il potere di diffondere gioia nella natura e nei cuori di uomini e dèi.
Cassandra: era una bellissima figlia di Priamo, la quale da piccola aveva ricevuto il dono della profezia assieme al fratello gemello Eleno. Andò schiava ad Agamennone dopo la caduta di Troia e fu uccisa nel massacro generale da Clitemnestra, gelosa della sua bellezza.
Ciclope: vedi Polifemo.
Cipro: è tuttora un’isola che si trova a sud dell’odierna Turchia. Essendo molto lontana dalla Grecia, è considerata dai personaggi dell’Odissea un luogo misterioso e ben poco conosciuto.
Circe: è una maga che abita l’isola di Eea, famosa per i suoi filtri in grado di trasformare gli uomini in bestie, come avviene per i compagni di Ulisse, tramutati in maiali. A lei si deve anche la trasformazione in mostro di Cariddi.
Clito: padre di Pireo.
Cocito: letteralmente “fiume dei lamenti”, è uno dei fiumi infernali.
Crataia: madre di Scilla.
Creta: grossa isola a sud del Peloponneso, dalla quale il mendicante Ulisse nei suoi falsi racconti diceva di provenire.
Cronide: patronimico indicante Zeus.
Crono: divinità tra le prime a essere conosciute nel pantheon greco. Figlio di Urano e Gea, prese il potere detronizzando il padre e fu a sua volta spo-
destato da Zeus, figlio che gli generò Rea. Per timore, infatti, che uno dei suoi figli dovesse ucciderlo, Crono li ingoiava tutti non appena questi fossero nati. Rea fuggì a Creta per partorire Zeus e, dopo aver nascosto il piccolo dio, tornò dal marito con una pietra avvolta in panni. Crono divorò il masso credendo di aver ucciso l’ennesimo figlio, ma Zeus, divenuto adulto, scatenò contro il padre una terribile guerra, nella quale ebbe come alleati i Ciclopi e i Centimani.
Ctesippo: uno dei Proci, originario di Same. Dimostrò la sua arroganza scagliando una zampa di bue contro Ulisse, non ancora riconosciutolo.
Ctimene: sorella minore di Ulisse, fu allevata insieme a Eumeo e andò in sposa a Euriloco, compagno di viaggio di Ulisse.
Deifobo: figlio di Priamo e fratello preferito di Ettore, divenne il maggiore capo dei Troiani durante la guerra dopo la morte del valoroso fratello. A lui, inoltre, andò in sposa Elena quando Paride venne ucciso.
Demodoco: aedo dell’isola dei Feaci.
Diana: nome latino di Artemide.
Dinanto: valoroso nocchiero di Scheria. Assumendo le sembianze di una sua figlia, Minerva si mostra a Nausicaa e la invita a recarsi al fiume, dove la ragazza incontra Ulisse.
Diocle: signore della città di Fere, discende dal fiume Alfeo.
Diomede: figlio di Tideo, fu un valoroso eroe della guerra di Troia, dove fu compagno di Ulisse in tutte le missioni più delicate. Tornato in patria senza patire alcuna sofferen-
za, incappò nelle insidie preparate per lui dall’infedele moglie Egialea. Scappato per miracolo, si spostò in Italia, dove combatté prima a servizio e poi contro il re Dauno, per mano del quale trovò infine la morte.
Dodona: città greca dove aveva sede uno dei più importanti oracoli di Apollo.
Dolio: servo fedele di Laerte. Assieme ad alcuni suoi figli combatte a fianco di Ulisse, Laerte e Telemaco nello scontro finale contro i Proci.
Dulichio (o Dulico): una delle isole dalle quali provengono i Proci. Corrisponde probabilmente alla parte meridionale dell’odierna Cefalonia.
Eacide: è un patronimico che indica Achille, non riferendosi tuttavia al padre (Peleo), bensì al nonno paterno (Eaco).
Eaco: nonno paterno di Achille. Era il più pio di tutti i Greci, figlio di Zeus e di una ninfa, Egina. Era nato sull’isola di Enone, che dal nome di sua madre venne in seguito chiamata Egina. Trovandosi solo a vivere su quest’isola deserta e desiderando essere a capo di un popolo, chiese al padre Zeus di trasformare le formiche in guerrieri, e così nacque il popolo guerriero dei Mirmidoni (murmex in greco significa “formica”).
Ebe: figlia di Zeus ed Era, moglie di Ercole, è dea della giovinezza e dispensiera degli dèi, loro servitrice presso la corte dell’Olimpo.
Ecalia: è una città non ben identificata (forse in Tessaglia, in Messenia o in Eubea), sulla quale regna Eurito.
Echeno: vecchio abitante di Scheria che suggerisce al re di accogliere Ulisse quando questi improvvisamente appare nella sala del palazzo.
Echeto: è probabilmente un personaggio immaginario delle leggende popolari, famoso per le proprie crudeltà.
Eea: isola dove vive la maga Circe.
Eeta: fratello di Circe; era il crudele re della Colchide, una regione barbara che si trovava sulle sponde del mar Nero. Eeta possedeva il vello d’oro, donatogli da un certo Frisso in cambio dell’ospitalità ricevuta. A questo vello d’oro, e quindi al re Eeta, è legata l’avventura di Giasone e degli Argonauti, che tentarono di impossessarsi del vello sottoponendosi a molte prove proposte dal sovrano, e che vi riuscirono solo con l’aiuto di Medea, figlia di Eeta.
Efesto: è il dio del fuoco, dei fabbri e degli artigiani. Poiché è dotato di grandissima forza fisica e abilità pratica, tutte le opere costruite da lui risultano perfette. È tradizionalmente raffigurato come uno zoppo. L’origine di questa sua condizione è da ricercare in un litigio tra Zeus e sua madre Era. Efesto prese le parti della madre e per questo Zeus lo punì scagliandolo giù dall’Olimpo. Il dio rotolò per un giorno intero giù dalla montagna, fino a quando cadde sull’isola di Lemno, salvandosi, ma conservando per sempre tale difetto alla gamba.
Egisto: innamorato di Clitemnestra, la moglie di Agamennone, uccise l’eroe quando quest’ultimo ritornò dalla guerra di Troia. L’odio tra Egisto e
Agamennone era stato ereditato dai rispettivi padri: Tieste e Atreo. Tieste, infatti, dopo l’uccisione di tre suoi figli da parte del fratello Atreo aveva generato Egisto, e un oracolo gli aveva predetto che tramite questo figlio avrebbe ricevuto vendetta del fratello. Tale vendetta non cadde su Atreo, ma su un suo figlio, Agamennone.
Egitto: a sud della Grecia, era considerato un paese lontano e dai caratteri fiabeschi.
Egizio: è un vecchio itacese che dialoga con Telemaco quando questi convoca l’assemblea.
Elena: moglie di Menelao. Il suo rapimento da parte del troiano Paride scatenò la vendetta dei Greci, che diedero così inizio alla guerra di Troia. Le vicissitudini del suo rapimento sono note a molti. Afrodite, Atena ed Era si stavano contendendo una mela d’oro, premio per la dea più bella. Paride, giovane principe troiano, pastore di greggi, era stato scelto come giudice della gara. Afrodite promise a Paride che gli avrebbe consegnato Elena se lei fosse stata dichiarata vincitrice, e il giovane troiano assecondò la proposta della dea, ricevendo così in cambio l’opportunità di rapire la bella moglie di Menelao. Irate con il principe troiano, Atena ed Era avrebbero poi combattuto in guerra a fianco degli Achei. Durante la sua permanenza a Troia, Elena mantenne un atteggiamento ambiguo. Pur essendo prigioniera, in più di un’occasione aiutò i Troiani nello sventare gli intrighi macchinati contro loro dall’astuto Ulisse. Liberata con la conquista di Troia, tornò in patria con il marito,
seguendolo nelle peripezie che ne caratterizzarono il viaggio di ritorno.
Elide: è la regione nord-occidentale del Peloponneso, affacciata alla quale vi è l’isola di Itaca. Proprio a causa dell’inadeguatezza all’allevamento del territorio itacese, molti abitanti di Itaca possedevano dei pascoli sulla vicina terraferma.
Ellade: è la Grecia nel suo complesso.
Elpenore: giovane compagno di Ulisse che trova la morte sull’isola di Circe, cadendo da un terrazzo non appena sveglio.
Enopo: padre di Leiode.
Enosigeo: epiteto indicante Poseidone.
Eolia: era un’isola vagante, e precisamente la terra fiabesca in cui abita Eolo, il re dei venti.
Eolo: figlio di Ippota, è il signore dei venti. Soccorre Ulisse nel suo viaggio, offrendogli un otre contenente dei venti, ma la scelleratezza dei compagni dell’eroe vanifica l’aiuto divino.
Epeo: con l’aiuto di Atena costruì il cavallo di Troia. Tornando da Troia naufragò in Italia, dove fondò le città di Metaponto, Lagaria e, più tardi, Pisa. Qui consacrò ad Atena gli attrezzi con cui aveva costruito il cavallo e divenne un abile artigiano.
Eperito: falso nome utilizzato da Ulisse per non farsi riconoscere dal padre Laerte.
Era: moglie di Giove, è una dea potente, gelosa e vendicativa. Perseguita le amanti di Giove, marito infedele, e i figli che da esse gli vengono generati. Da queste persecuzioni nacquero nu-
merosi miti, il più celebre dei quali è certamente quello di Eracle.
Eracle: figlio di Giove e Alcmena. Giunone, gelosa di Alcmena, riuscì con un’astuzia a condannare Ercole a essere servo di Euristeo, che lo espose a gravi e inutili pericoli, ordinandogli le famose dodici fatiche. Queste furono: 1) uccidere il leone di Nemea, la cui pelle non poteva essere scalfita da alcuna arma; 2) uccidere l’Idra di Lerna, mostro dalle teste di serpente che si moltiplicavano ogni qualvolta fossero state mozzate; 3) catturare il cinghiale di Erimanto; 4) catturare la velocissima cerva di Cerinea; 5) disperdere gli uccelli del lago Stinfalo, carnivori e dotati di becco e zampe di bronzo; 6) ripulire in un giorno le stalle del re Augia, i cui animali crescevano a dismisura e della cui pulizia il re non si era mai curato; 7) catturare il toro di Creta; 8) catturare le cavalle di Diomede, divoratrici di carne umana; 9) impossessarsi della cintura di Ippolita, che era regina delle Amazzoni, gigantesche donne combattenti; 10) rubare i buoi di Gerione, gigante a tre teste; 11) rubare i pomi d’oro del giardino delle Esperidi, luogo difeso dal drago Ladone; 12) portare a Micene, vivo, Cerbero, il cane a tre teste che faceva guardia al regno degli Inferi.
Ercole: nome latino di Eracle.
Erebo: è la parte più profonda dell’Averno, nella quale venivano punite le colpe più gravi.
Eretteo: eroe ateniese a cui era dedicato un tempio, di cui ancora oggi si conservano le rovine.
Erimanto: montagna del Peloponneso, famosa per l’abbondante selvaggina che la popola.
Erinni: sono conosciute anche con il nome di Furie e, nate dalle gocce di sangue di Urano, appartengono alla primissima generazione degli dèi. Come le Parche, non obbediscono ad alcuna legge o ad alcun dio e tutti, uomini e divinità, sono loro sottomessi. Sono tradizionalmente note nel numero di tre (Aletto, Tisifone, Megera) e sono raffigurate come geni alati aventi capelli intrecciati di serpenti e recanti in mano torce e fruste. Vivono nell’Inferno e da qui escono per vendicare i crimini. La vittima che cade nelle loro mani subisce orrende torture.
Ermes (o Ermete): è il dio che guida tutti i viandanti durante i loro viaggi e anche le anime dei morti nel loro “viaggio” nell’aldilà. La sua impresa più famosa, l’uccisione del mostro Argo, gli valse il soprannome di Argicida. Molte altre sono le sue qualità, prime fra tutte la scaltrezza e la spregiudicatezza. Il giorno stesso in cui nacque da Zeus e Maia, infatti, Ermes si liberò delle bende e andò a rubare dodici vacche del fratello Apollo. Nello stesso giorno, inoltre, inventò la lira, utilizzando a tal fine il guscio di una tartaruga e gli intestini dei buoi. Padre di Autolico, nonno materno di Ulisse, il dio aiuta l’eroe nell’isola di Calipso e in quella di Circe.
Etolia: regione della Grecia centrale.
Etone: nome falso col quale Ulisse si finge uomo cretese agli occhi di Penelope.
Eubea: grossa isola di forma allungata
che si trova a nord di Atene ed è separata dalla terraferma da una sottile striscia di mare.
Eumelo: re di Fere, sposo di Iftime.
Eumeo: fedele servitore di Ulisse, guardiano dei porci. Figlio di un re della Siria, Ctesio, ancora infante era stato rapito da dei pirati con la complicità di una serva fenicia e venduto come schiavo a Laerte.
Eupito: padre di Antinoo, il più insolente e prepotente di tutti i Proci.
Eurialo: giovane prepotente e provocatore che vive a Scheria.
Euribate: messaggero che partì al fianco di Ulisse nella spedizione per la guerra di Troia.
Euriclea: originariamente comprata come serva da Laerte, diviene nutrice e poi serva fedele di Ulisse e di Telemaco.
Euriloco: uno dei compagni di Ulisse, sposo della sorella Ctimene. Dapprima sull’isola di Circe, poi su quella del dio Sole, Euriloco mostra insofferenza per i comandi di Ulisse ed è causa di sciagure con le sue ribellioni.
Eurimaco: figlio di Polibo, è uno dei più carismatici pretendenti di Penelope a Itaca, assieme ad Antinoo. Si rende protagonista di atti di prepotenza contro Ulisse quando questi è ancora travestito da mendicante. Muore nella strage, colpito da una freccia.
Eurimedusa: serva della reggia di Alcinoo, sull’isola dei Feaci.
Eurimi: padre di Telemo, indovino dei Ciclopi.
Eurinome: figlia di Attore, è la serva
che fa da custode alla camera nuziale di Ulisse e Penelope a Itaca.
Eurinomo: uno dei figli di Egizio che partirono per Troia con Ulisse.
Eurito: re dell’Ecalia, città della Messenia o della Tessaglia, molto abile nell’uso dell’arco. Egli aveva promesso in sposa la figlia Iole a chi lo avesse vinto nella prova dell’arco, ma, superato da Ercole, non mantenne la promessa. Ercole distrusse allora la sua città ed Eurito fu poi ucciso da Apollo, il dio arciere.
Faetusa: ninfa che assieme alla sorella Lampetia custodiva le greggi del Sole.
Fama: veniva immaginata come un mostro alato gigantesco capace di spostarsi con grande velocità, coperto di piume sotto le quali si aprivano tantissimi occhi per vedere. Per ascoltare usava un enorme numero di orecchie e diffondeva le voci facendo risuonare infinite bocche nelle quali si agitavano altrettante lingue.
Fea: città dell’Elide, che si trova nella parte occidentale del Peloponneso.
Febo: epiteto indicante Apollo.
Femio: aedo, cioè cantore, della reggia di Ulisse sull’isola di Itaca.
Fere: corrispondeva all’odierna città di Calamata, posta a metà strada tra Pilo e Sparta.
Fetonte: cavallo divino che assieme a Lampo trainava il carro del Sole.
Fidone: re dei Tesproti, dal quale Ulisse, fintosi mendicante e giunto a Itaca, dice di aver ricevuto notizie di Ulisse.
Filezio: capo mandriano fedele a Ulisse.
Filo: serva di Elena a Sparta.
Filottete: era il capo dei Tessali della Magnesia che navigarono verso Troia. Viene spesso ricordato per la sua fama di arciere: possedeva infatti l’arco e le frecce di Ercole, con le quali colpiva infallibilmente il bersaglio. Partito per la guerra di Troia, non vi giunse mai. Durante il viaggio, infatti, in uno scalo a Tenedo venne morso a un piede da un serpente velenoso. La ferita divenne purulenta e l’odore nauseabondo che essa emanava costrinse i compagni, su consiglio di Ulisse, ad abbandonare l’eroe sull’isola di Lemno. Su quest’isola Filottete visse da solo dieci anni, cibandosi degli uccelli che abbatteva con le sue frecce. Non riuscendo a vincere la guerra di Troia, gli Achei decisero di impossessarsi dell’infallibile arco dell’eroe e pertanto mandarono sull’isola di Lemno un’ambasciata guidata dallo stesso Ulisse. Questi convinse Filottete a tornare a combattere. A Troia l’eroe tessalo venne guarito grazie alle cure mediche di Podalirio.
Forcide: vecchio dio del mare, padre di tutti i mostri marini. Sua figlia, la ninfa Toosa, generò Polifemo.
Forcino (o Forco): è un vecchio dio del mare, padre di tutti i mostri marini. A lui si deve la costruzione del porto di Itaca.
Fronio: padre di Noemone.
Ftia: città della Grecia settentrionale, patria di Peleo e quindi di Achille.
Gea: seconda divinità a essere creata, dopo Caos; generò a sua volta Urano e moltissimi essere divini, tra cui Giganti e Ciclopi.
Giasone: eroe nativo di Jolco. Divenne celebre assieme ai suoi compagni (gli Argonauti) per l’avventurosa conquista del vello d’oro, strappato al re Eeta con l’aiuto di Medea, figlia di quest’ultimo, la quale gli suggerì come superare le prove impossibili cui Eeta lo aveva sottoposto: aggiogare due tori spiranti fuoco e dai piedi di bronzo, per arare con essi un campo in cui Eeta stesso aveva seminato denti di drago, e infine uccidere i guerrieri nati da quella semina prodigiosa.
Giove: nome latino di Zeus.
Giunone: nome latino di Era.
Gorgone: era la Medusa, la cui testa era ricoperta di serpi e il cui sguardo aveva il potere di pietrificare chiunque la guardasse. Pur dopo la morte di Medusa, avvenuta per mano dell’eroe Perseo, la sua testa conservò il proprio mortale potere e venne posta da Atena al centro del proprio scudo.
Grazie: nome latino delle Cariti.
Icario: è il padre di Penelope. Offrì la figlia come premio di una gara di corsa, cui Ulisse partecipò e nella quale risultò vincitore.
Idomeneo: signore di Creta, citato da Ulisse in un suo racconto al porcaro Eumeo.
Idotea: dea marina figlia di Proteo; consigliò a Menelao, trattenuto dagli dèi in Egitto, di consultare il padre, e lo istruì a tal riguardo.
Ifito: famoso arciere, figlio di Eurito, anch’egli ottimo tiratore. Dopo la morte del padre ne ereditò l’arco. L’arco venne un giorno offerto come dono d’ospitalità a Ulisse. Proprio con
quest’arma l’eroe di Itaca compie la strage dei Proci.
Iftime: figlia di Icario e sorella di Penelope, andò in sposa del re di Fere, Eumelo. Atena assume le sue sembianze per parlare in sogno a Penelope.
Ilio: vedi Troia.
Ino (o Leucotea): divinità marina incaricata di portare soccorso ai naviganti in pericolo, come la vediamo fare anche con Ulisse. Fu la seconda moglie di Atamante, dall’unione con il quale nacquero i figli Learco e Melicerte. Dopo la morte della sorella Semele, madre di Dioniso, Ino persuase Atamante ad allevare il piccolo dio, nato dall’unione della sorella di Ino con Zeus. Era, per vendicarsi del tradimento, fece impazzire Ino, la quale uccise Melicerte gettandolo in una pentola d’acqua bollente, e suo marito Atamante, che uccise Learco con uno spiedo, scambiandolo nel delirio per un cervo. Ino, una volta che fu rinsavita, si gettò in mare con il cadavere di Melicerte e i due vennero trasformati in divinità marine.
Iperione: titano, figlio di Urano e Gea, padre del Sole, della Luna e dell’Aurora.
Ippota: padre di Eolo.
Iro: soprannome di Arneo.
Itaca: isola a nord-ovest del Peloponneso e patria di Ulisse, alla quale egli spera di poter tornare.
Itaco: signore che anticamente governò sull’isola di Itaca e le diede il proprio nome.
Lacedemone: antico nome di Sparta.
Laerte: figlio di Arcisio e padre di Ulis-
se. Durante l’assenza del figlio si ritira in campagna con il fedele servo Dolio e qui trascorre tristemente i propri giorni, disinteressandosi di quanto accade a Penelope e a Telemaco. Tornato Ulisse, combatte con gioia al suo fianco contro i Proci.
Lampetia: ninfa che assieme alla sorella Faetusa custodiva le greggi del Sole.
Lampo: cavallo divino che assieme a Fetonte trainava il carro del Sole.
Laodamante: uno dei figli di Alcinoo. Durante le gare di atletica propone a Ulisse di partecipare, ma, a differenza di altri, non lo schernisce per il suo rifiuto.
Latona: dea, madre di Apollo e Artemide, concepiti da Giove. Per partorire i due figli dovette fuggire l’ira di Era e poté ricevere ospitalità solo presso l’isola di Ortigia.
Leiode: figlio di Enopo, è uno dei Proci, propriamente un aruspice, cioè un indovino che basa le proprie previsioni sull’osservazione delle interiora degli animali.
Leocrito: abitante di Itaca con cui Mentore litiga in assemblea; Leocrito parteggia per i Proci, mentre Mentore per il giovane Telemaco.
Libia: terra lontana che nell’immaginario di Omero doveva essere estremamente ricca e feconda. Vi approdò Menelao tornando dalla guerra di Troia.
Maratona: pianura dell’Attica, che si trova a pochi chilometri da Atene.
Marte: nome latino di Ares
Mastore: padre di Aliterse.
Medonte: è l’araldo (cioè il messaggero) dei Proci. Durante l’assenza di Ulisse si prende cura di Telemaco. È lui che corre a rivelare a Penelope il complotto dei pretendenti contro il figlio e per la sua fedeltà viene risparmiato durante la strage finale.
Melampo: indovino, padre di Teoclimeno. Acquistò i suoi poteri da bambino, quando fece sul rogo i funerali di un serpente trovato morto. Per riconoscenza, infatti, i cuccioli di questo serpente gli purificarono lingua e orecchi, così che egli poté da allora comprendere il linguaggio degli uccelli e degli altri animali.
Melanto: una delle serve arroganti e infedeli presenti alla corte di Ulisse in Itaca. Sorella di Melanzio e amante di Eurimaco, viene impiccata assieme alle altre serve infedeli.
Melanzio: figlio di Dolio, è un capraio, un pastore arrogante e amico dei Proci che procura loro delle capre perché essi possano cibarsene a banchetto. Durante il massacro dei Proci tenta di procurare loro delle armi, ma viene catturato. Dopo l’impiccagione delle serve infedeli viene mutilato e lasciato morire in mezzo al cortile.
Menelao: re di Sparta, figlio di Atreo e marito di Elena. Il rapimento di sua moglie originò la guerra di Troia, a capo della quale non fu posto egli, bensì il fratello Agamennone. Terminata la guerra, Menelao si affrettò a tornare in patria, ma un naufragio lo costrinse per cinque anni a sostare in Egitto, da dove ripartì solamente grazie all’aiuto della dea Idotea. Presso di lui si reca Telemaco, nella ricerca del padre Ulisse.
Mente: re dei Tafi, del quale Atena prende le sembianze per aiutare Telemaco a Itaca.
Mentore: fidato amico di Ulisse, di cui Minerva prende spesso le sembianze quando vuole mostrarsi all’eroe e a suo figlio.
Mercurio: nome latino di Ermes.
Micene: antica città non lontana da Argo. Si trovava nella parte nord-orientale del Peloponneso.
Minerva: nome latino di Atena
Minosse: figlio di Giove ed Europa, regnò su Creta, dando ai suoi abitanti un efficiente sistema di leggi; pertanto, dopo la sua morte, divenne uno dei giudici infernali. Sua moglie Pasifae, unendosi a un toro, gli generò il terribile Minotauro.
Muse: figlie di Zeus e Mnemosine, vivevano sul Parnaso ed erano le dee ispiratrici delle arti. Questi i loro nomi: Calliope era la musa della poesia epica, Clio della storia, Erato della poesia amorosa, Euterpe della poesia lirica, Melpomene della tragedia, Polimnia del mimo, Talia della commedia, Tersicore della danza e Urania dell’astronomia.
Naiadi: ninfe, divinità benefiche dei boschi, dei fiumi e delle fonti, che nutrivano le piante e le bestie.
Nausicaa (o Nausica): figlia di Alcinoo, principessa dell’isola dei Feaci. È la prima a soccorrere Ulisse quando questi giunge a Scheria, consentendogli così di trovare favore presso il padre, sovrano dei Feaci.
Nausitoo: padre di Alcinoo, che predisse la distruzione contro gli scogli
di una nave feacia per via dell’ira di Posidone.
Neera: madre di Lampetia e Faetusa.
Neio: il più alto monte di Itaca.
Neleo: antico re di Pilo, al quale Eracle uccise tutti i figli, eccezion fatta per Nestore.
Neottolemo: figlio di Achille, fu un valoroso combattente nella guerra di Troia dopo la morte del padre. Gli Achei, infatti, avevano catturato l’indovino Eleno e avevano saputo da questi che Troia sarebbe caduta solo se il giovane figlio di Achille avesse preso parte agli scontri. Dunque il ragazzo, ormai in età di combattimento, si unì ai guerrieri greci.
Nerito: signore che anticamente governò sull’isola di Itaca e diede il proprio nome al monte più alto di questa (il Nerito).
Nestore: vecchio e saggio re di Pilo che combatté nella guerra di Troia, sopravvivendo al figlio stesso, Antiloco, il quale si sacrificò in sua difesa. Presso di lui si reca Telemaco alla ricerca di notizie del padre Ulisse.
Nettuno: nome latino di Posidone.
Noemone: figlio di Fronio, è il pretendente che concede a Telemaco la nave per partire alla volta di Pilo e Sparta alla ricerca del padre Ulisse.
Oceano: padre di Perse.
Ogigia: isola in cui vive Calipso e dove Ulisse resta prigioniero per sette anni.
Olimpo: è il monte dove vivevano gli dèi.
Oreste: figlio di Agamennone, vendicò la morte del padre uccidendo i
due colpevoli: la propria madre Clitemnestra ed Egisto, l’amante di lei. Per fare questo fece annunciare la propria morte e si recò a palazzo travestito da viaggiatore, per poter così sorprendere i due, ormai certi che il delitto di Agamennone sarebbe rimasto invendicato. Dopo aver compiuto la propria vendetta, Oreste impazzì e, essendosi a sua volta macchiato di un delitto, fu perseguitato dalle Erinni.
Orione: era originariamente un fortissimo cacciatore che abitava la regione della Beozia. Era così bello che fece innamorare di sé la dea Aurora, ed era tanto abile nella caccia da suscitare la gelosia della più abile delle cacciatrici, la dea Artemide, che lo uccise. Dopo la sua morte venne trasformato in una costellazione.
Orsiloco (1): padre di Diocle.
Orsiloco (2): principe cretese che Ulisse, mentendo al figlio Telemaco e fingendosi uno straniero, racconta di aver incontrato e ucciso.
Pallade: epiteto indicante Atena
Pandaro: uomo cretese che, secondo il mito, rubò dal tempio di Giove un cane d’oro, e per questo il dio lo punì. Tuttavia non fu l’uomo a subire alcun male, bensì le tre figlie: Filomena fu indotta con l’inganno a uccidere erroneamente il figlio e venne in seguito tramutata in usignolo; Merope e Cleotera vennero invece rapite da una tempesta, dietro la quale si celavano le Arpie.
Panopeo: era un’antica città della Focide, regione della Grecia centrale, appena a nord del Peloponneso.
Parche: erano le divinità che presiedevano al destino dell’uomo. Erano raffigurate come tre vecchie e scorbutiche tessitrici, vestite con scuri stracci. La prima filava il tessuto della vita, la seconda assegnava i destini a ogni individuo stabilendone anche la durata, e la terza tagliava il filo della vita al momento stabilito. Le loro decisioni erano immutabili: neppure gli dèi potevano cambiarle.
Parnaso: è un monte della Grecia, a nord del Peloponneso, dove risiedeva il nonno di Ulisse e dove, secondo la tradizione, avevano casa le nove Muse.
Patroclo: figlio di Menezio e fedele scudiero di Achille. Chiese all’eroe di poter indossare le sue armi e, gettatosi nella mischia, trovò la morte per mano del troiano Ettore. Il suo sacrificio convinse Achille a deporre l’ira che nutriva nei confronti di Agamennone e a tornare a combattere con gli Achei.
Peleo: sposò Teti, che gli partorì Achille. Zeus e Poseidone, infatti, si stavano contendendo la mano di Teti, quando Prometeo predisse loro che il figlio di Teti sarebbe stato più forte del padre. Così i due, spaventati, abbandonarono la loro intenzione iniziale e risolsero di dare in sposa la dea a un mortale.
Pelide: patronimico indicante Achille.
Penelope: fedele moglie di Ulisse che pazientemente attende il ritorno del marito. Figlia di Icario, venne assegnata a Ulisse in seguito a una gara cui l’eroe prese parte. Durante l’assenza del marito rimane a governare la casa e respinge con astuzia le richieste di
matrimonio che le giungono dai pretendenti. Particolarmente famoso è lo stratagemma della tela che idea a tale scopo: chiede infatti di poter scegliere il proprio nuovo sposo dopo aver terminato un sudario per Laerte, padre di Ulisse, ma ogni notte disfa quanto tessuto durante il giorno, rimandando così in continuazione il momento della propria decisione.
Perimede: uno dei compagni di Ulisse. Lega l’eroe all’albero della nave quando quest’ultimo sta per cedere alle lusinghe delle Sirene.
Perse: madre di Circe e di Eeta.
Persefone: è la figlia di Cerere, dea delle messi. Venne rapita da Plutone, che la rese sua sposa e così la portò con sé nel regno dei morti. Si dice che ella trascorresse col marito nell’Ade sei mesi all’anno (quelli autunnali e invernali) e i restanti sei (primavera ed estate) sulla Terra con la madre.
Pieride: è una regione montuosa che si trova a nord del monte Olimpo, la sede degli dèi.
Pilo: città della Messenia (regione che si trova nella parte sud-occidentale del Peloponneso) sulla quale regna Nestore.
Pireo: figlio di Clito; a lui Telemaco affida temporaneamente l’indovino Teoclimeno quando approda a Itaca, dopo il viaggio alla ricerca del padre Ulisse.
Piriflegetonte: è il “fiume infuocato”, uno dei fiumi infernali.
Pisenore: araldo di Itaca. Ordina gli inter venti nell’assemblea consegnando lo scettro a chiunque abbia diritto di parola.
Pisistrato: figlio di Nestore, accompagna Telemaco nel suo viaggio a Sparta e ne diviene caro amico.
Pito: è l’antico nome di Delfi, città del celebre oracolo di Apollo.
Plutone: nome latino di Ade.
Polibo: padre di Eurimaco, uno dei Proci più sfrontati.
Polifemo: figlio di Poseidone, è un ciclope, cioè un gigante mostruoso con un solo occhio. Quando Ulisse giunge alla sua isola, il ciclope ne divora alcuni compagni, rifiutando di sottomettersi ai doveri dell’ospitalità. Ulisse, a sua volta imprigionato dall’essere mostruoso, riesce a liberarsi e a vendicarsi grazie alla sua astuzia: avendo fatto ubriacare Polifemo, infatti, lo acceca con un palo appuntito. In seguito fugge dalla grotta nascondendosi sotto il ventre di un caprone.
Polite: uno dei compagni di Ulisse; viene trasformato in maiale sull’isola di Circe.
Polittore: uno degli antichi signori che regnava sull’isola di Itaca molto prima di Ulisse.
Pontonoo: il messaggero dell’isola dei Feaci.
Poseidone (o Posidone): è il dio del mare e dei terremoti, fratello di Zeus, con cui è sempre in buoni rapporti. Tra gli dèi è quello che maggiormente si oppone al ritorno in patria di Ulisse, in seguito all’accecamento del proprio figlio Polifemo.
Priamo: vecchio re di Troia durante il periodo della guerra. La tradizione gli attribuisce circa cinquanta figli
e figlie, tra i più noti dei quali figurano Ettore, Paride, Deifobo, Eleno e Cassandra. Quando gli Achei irruppero nella città, fu ucciso da Neottolemo, sorpreso mentre cercava rifugio presso un altare.
Proserpina: nome latino di Persefone.
Proteo: vecchio signore del mare in grado di cambiare repentinamente aspetto pur di non farsi catturare. Egli possedeva il dono della profezia, ma si rifiutava di informare i mortali che lo interrogavano. Tra questi vi fu Menelao, il quale riuscì nel suo intento solo grazie a Idotea, figlia dell’essere divino.
Radamanto: figlio di Giove ed Europa. Famoso per la sua saggezza ed equità, dopo la sua morte divenne il giudice che governava i Campi Elisi.
Ressenore: padre di Arete.
Same: è una delle isole da cui provenivano i Proci e sulle quali una volta si estendeva il potere di Ulisse. Deve probabilmente essere identificata con la parte settentrionale dell’attuale Cefalonia.
Scheria: l’isola dei Feaci.
Scilla: un tempo giovane e bellissima ragazza, venne poi trasformata in terribile mostro da Circe, la quale era gelosa dell’amore che Glauco provava per la fanciulla. Aveva sei teste e dodici piedi e un grido terribile. Scilla abitava un promontorio che si è soliti localizzare lungo lo stretto che separa Reggio Calabria da Messina.
Sicilia: isola nominata da Omero come patria dei Ciclopi, sebbene tale identificazione sia poco probabile.
Sidone: situata lungo le coste orientali del mar Mediterraneo, era una delle città fenicie più importanti.
Sirene: in origine erano delle splendide ninfe, compagne della dea Proserpina. Quando Plutone rapì Proserpina per farne sua sposa nell’Ade, Cerere, madre di quest’ultima, adirata con le ninfe poiché non erano state capaci di difendere la figlia, le tramutò in mostri marini, dal corpo di pesce e il volto di fanciulla. Le Sirene attiravano i naviganti in una trappola mortale attraverso le loro voci soavi.
Sisifo: figlio di Eolo e fondatore della città di Corinto. Uomo molto astuto e malvagio, riuscì a ingannare persino Giove. Venne allora condannato per tutta l’eternità a un lavoro lungo, faticoso e inutile, dato che continuamente richiedeva di essere iniziato daccapo: doveva infatti spingere un enorme masso in cima a un monte e ricominciare quando la pietra, una volta raggiunta la sommità del monte, rotolava giù per il versante opposto.
Sparta: è la città su cui regnava Menelao e verso la quale Telemaco si diresse alla ricerca del padre. Si trovava nel Peloponneso meridionale, non molto lontano da Pilo.
Stige: uno dei fiumi che attraversano l’inferno. Il nome significa “fiume della tristezza”.
Taigeto (o Tegeto): è un monte della Laconia, anticamente ricordato perché ricco di selvaggina.
Tantalo: fu un re della Lidia, amatissimo dagli dèi, i quali spesso si recavano a cena da lui. Un giorno egli volle mettere alla prova i suoi ospiti e, per
provare se essi fossero davvero onniscienti, fece cucinare le carni del proprio figlio Pelope. A causa di questo delitto, riconosciuto dagli dèi come tale, venne condannato a patire eternamente la fame e la sete.
Tebe: città della Beozia nella quale viveva Tiresia.
Telamone: padre di Aiace.
Telemaco: è il figlio di Ulisse e Penelope. A Itaca, durante l’assenza di Ulisse, deve fronteggiare gli insolenti Proci. Aiutato da Minerva si mette alla ricerca di informazioni circa la sorte del padre, recandosi prima a Pilo e poi a Sparta. Certo ormai dell’imminente ritorno di Ulisse, torna in patria e qui, unendosi al padre, che nel frattempo è già tornato in patria, compie la vendetta sugli insolenti e spregevoli pretendenti.
Telemo: indovino che viveva tra i Ciclopi e che predisse a Polifemo che sarebbe stato accecato da Ulisse.
Tenedo: isola del mar Egeo, non lontana da Troia.
Teoclimeno: è un indovino, nipote a sua volta di un altro indovino, Melampo. Viene costretto a fuggire da Argo perché colpevole di aver ucciso un uomo in quella città. Si unisce quindi a Telemaco e fa rotta con lui verso Itaca.
Tidide: patronimico indicante Diomede
Tiresia: era un indovino tebano, reso cieco per aver osato contemplare nuda la dea Minerva. In cambio gli venne data la capacità di prevedere il futuro. Tiresia conservò questo dono
anche nel regno dei morti, dove Ulisse va a cercarlo per conoscere il modo di far ritorno a Itaca.
Tizio: figlio di Gea, era un gigante di enormi dimensioni, il quale fu ucciso da Apollo e Artemide per aver offeso Latona, loro madre. Viene punito nell’Ade con una pena infernale: due avvoltoi gli rodevano in continuazione il fegato.
Toante: figlio di Andremone, fu uno dei soldati achei che combatterono nella guerra di Troia.
Toosa: era una ninfa, madre di Polifemo.
Trasimede: uno dei figli di Nestore, i quali provvedono all’accoglienza di Telemaco a Pilo.
Trinacria: è la Sicilia. Il nome Trinacria significa “tre promontori” e si riferisce a quelli del Pachino, del Peloro e del Lilibeo, che sorgono ai tre vertici dell’isola, che ha appunto forma triangolare.
Troia: città dell’Asia minore nella quale si combatté la famosa guerra tra Achei e Troiani.
Ulisse (o Odisseo): eroe protagonista dell’Odissea, che di ritorno dalla guerra di Troia è costretto a vagare per altri dieci lunghi anni prima di poter rivedere la tanto desiderata patria, Itaca. Figlio di Laerte e Anticlea, vantava tra i suoi progenitori lo stesso dio Ermes, del quale ereditò l’ingegno e l’astuzia. Valoroso condottiero e abile parlatore, Ulisse partecipò alle missioni più importanti durante la guerra di Troia, fossero esse guerresche, di spionaggio o diplomatiche. Decisiva per le sorti
dello scontro con i Troiani fu la sua idea del cavallo di legno, grazie al quale i guerrieri achei riuscirono a introdursi nella città nemica. Sposato con Penelope, al momento della sua partenza per la guerra lasciò a Itaca il figlio Telemaco ancora infante. Il desiderio di rivedere moglie e figlio lo guida o lo sostiene durante i lunghi anni del ritorno, nei quali naufraga in molti luoghi e affronta numerosi pericoli: i Ciconi, i Lotofagi, il Ciclope, Circe, le Sirene, Scilla e Cariddi, l’ira del dio Sole e quella di Posidone, le lusinghe di Calipso; visita numerose isole, percorrendo in lungo e in largo il mare Egeo e il Mediterraneo, giungendo addirittura nel regno dei morti, l’Oltretomba. Guidato da Atena e soccorso dal popolo dei Feaci, l’eroe fa ritorno in patria e qui compie la vendetta dei Proci, giovani pretendenti che insidiano la moglie e il suo trono e che dilapidano le sue ricchezze.
Venere: nome latino di Afrodite.
Vulcano: nome latino di Efesto.
Zacinto: una delle isole, non lontane da Itaca, da cui provenivano i Proci. Probabilmente è da identificare con l’odierna Zante.
Zeus: è il dio più importante, signore dell’Olimpo, la cui volontà non può essere infranta nemmeno dagli altri dèi. Figlio di Crono e di Rea, con l’aiuto della madre sopravvisse al padre, il quale ingoiava tutti i figli nel timore che uno dovesse spodestarlo. Raggiunta l’età adulta, Zeus sconfisse Corno e i Titani suoi alleati avvalendosi dell’aiuto dei Ciclopi e dei Centimani, che per l’occasione andò a liberare dal Tartaro. Conquistato il
potere, Zeus dovette fronteggiare la ribellione dei Giganti, irati per la sorte toccata ai Titani, loro figli. Tra questi il più forte era Tifone, dal quale Zeus venne imprigionato, salvo essersi poi liberato con l’aiuto di Ermes. Stabilito definitivamente l’ordine celeste, Zeus regnò sugli altri dei. Sue prerogative divine erano lo scatenare temporali e l’assicurare la giustizia. Sposatosi con Era, le fu marito infedele, concedendosi numerose avventure amorose dalle quali nacquero altrettanti eroi, primo fra tutti Eracle.
Edizioni dell’Odissea
Omero, Odissea, trad. di E. Romagnoli, Zanichelli, Bologna 1926.
—, Odissea, trad. di E. Villa, Guanda Editore, Parma 1964.
—, Odissea, trad. di G. Tonna, Garzanti, Milano 1974.
—, Odissea, trad. di R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1989.
—, Odissea, trad. di G. Aurelio Privitera, Mondadori, Milano 1991.
Studi
E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi, Torino 1956.
G. Aurelio Privitera, Il ritorno del guerriero. Lettura dell’Odissea, Einaudi, Torino 2005.
J.P. Barron - P.E. Easterling - B.M.W. Knox, La tradizione epica dopo Omero e Esiodo, in La letteratura greca della Cambridge University. I. Da Omero alla commedia, ed. it. a cura di E. Savino, Mondadori, Milano 1989.
M. Bowra, Mito e modernità della letteratura greca, Il Saggiatore, Milano 1966.
C. Brillante, Gli archetipi della poesia e della storiografia, Loescher, Torino 1998.
W. Burkert, Mito e rituale in Grecia, Laterza, Bari 1996.
—, La religione greca di epoca arcaica e classica, Jaca Book, Milano 2003.
R. Cantarella, Breve introduzione a Omero, Sansoni, Firenze 1967.
P. Citati, La mente colorata, Mondadori, Milano 2002.
F. Codino, Introduzione a Omero, Einaudi, Torino 1965.
V. Di Benedetto, Nel laboratorio di Omero, Einaudi, Torino 1998.
F. Ferrari, La porta dei canti. Storia e antologia della lirica greca, Cappelli Editore, Bologna 2000.
P. Grimal, Enciclopedia della mitologia, Garzanti, Milano 1990.
G.S. Kirk, Omero, in La letteratura greca della Cambridge University. I. Da Omero alla commedia, ed. it. a cura di E. Savino, Mondadori, Milano 1989.
B.M.W. Knox, Libri e lettori nel mondo Greco, in La letteratura greca della Cambridge University. I. Da Omero alla commedia, ed. it. a cura di E. Savino, Mondadori, Milano 1989.
A. Meillet, Lineamenti di storia della lingua greca, Einaudi, Torino 2003.
C. Moeller, Saggezza greca e paradosso cristiano, Morcelliana, Brescia 1951.
B. Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo, Einaudi, Torino 1963.
M. Sordi, Il mondo greco dall’età arcaica ad Alessandro, Jaca Book, Milano 2004.
Dizionari e manuali
C. Battisti - G. Alessio, Dizionario etimologico italiano, Giunti Editore, Firenze 1998.
L. Castiglioni - S. Mariotti, Il vocabolario della lingua latina, Loescher, Torino 2007.
M. Cortelazzo - P. Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1999.
T. De Mauro, Il dizionario di italiano compatto, Paravia, Torino 2004.
D. Del Corno, Letteratura greca. Dall’età arcaica alla letteratura cristiana, Principato, Milano 1988.
G. Devoto, Avviamento all’etimologia italiana. Dizionario etimologico, Le Monnier, Firenze 1968.
G. Devoto - G.C. Oli, Il dizionario della lingua italiana, con cd-rom, Le Monnier, Firenze 2002-2003.
G. Guidorizzi, La letteratura greca. L’età arcaica, Einaudi scuola, Milano 1996.
B. Migliorini - A. Duro, Prontuario etimologico della lingua italiana, Paravia, Torino 1949.
F. Montanari, GI - Vocabolario della lingua greca, Loescher, Torino 2006.
R. Paggi - L. Albini - D. Ferrari, Nel suono il senso. Grammatica della lingua italiana ad uso scolastico, Itaca, Castel Bolognese 2007.
O. Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua italiana, Fratelli Melita Editori, La Spezia 1990.
A. Prati, Vocabolario etimologico italiano, Garzanti, Milano 1951.
L. Rocci, Vocabolario greco-italiano, Società editrice Dante Alighieri, Roma 1995.
L.E. Rossi, Letteratura greca, Le Monnier, Firenze 1995.
N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1970.
Altre opere classiche
Apollonio Rodio, Argonautiche, trad. di A. Borgogno, Mondadori, Milano 2007.
Eschilo, Le tragedie, trad. di M. Centanni, Mondadori, Milano 2007 (in particolare sono state consultate le seguenti tragedie: Agamennone, Coefore, Eumenidi).
Esiodo, Teogonia, trad. di G. Arrighetti, Bur, Milano 2004.
Euripide, Le tragedie, trad. di A. Beltrametti, Mondadori, Milano 2007 (in particolare sono state consultate le seguenti tragedie: Alcesti, Medea, Gli Eraclidi, Andromaca, Ecuba, Eracle, Le troiane, Elettra, Ifigenia in Tauride, Elena, Oreste, Ifigenia in Aulide, Ciclope).
Omero, Iliade, trad. di R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990.
—, Inni omerici, trad. di G. Zanetto, Bur, Milano 2000.
Ovidio, Metamorfosi, trad. di P. Bernardini Marzolla, Einaudi, Torino 1994.
Sofocle, Le tragedie, trad. di R. Cantarella - U. Albini - V. Faggi, Mondadori,
Milano 2007 (in particolare sono state consultate le seguenti tragedie: Aiace, Trachinie, Elettra, Filottete).
Virgilio, Eneide, trad. di L. Canali, Oscar Mondadori, Milano 1985.
Edizioni scolastiche
S. Guglielmino, Armi ed eroi. Antologia epica per la scuola media, Principato, Milano 1965.
Omero, Iliade, traduzione di V. Monti, a cura di R. Paggi - F. Francia - D. Ferrari, Itaca, Castel Bolognese 2004.
—, L’Odissea, a cura di G.B. Salinari, Zanichelli, Bologna 1959.
E. Savino, Il ragazzo con la cetra, Mursia, Milano 1993.
G. Ugolini, Il paziente Odisseo, Società editrice La Scuola, Brescia 1925.
5 Introduzione
13
Sezione 1 - L a teLemachia
16 libro I. Minerva prepara il ritorno di Ulisse
Proemio, 16 – Il concilio degli dèi, 16 – Minerva a Itaca, 20 – Il ricordo di Ulisse, 22 – I consigli della dea, 24 – La madre Penelope, 26 – Il diverbio coi Proci, 28 – La notte in attesa, 29
30 libro II. La partenza è decisa
L’assemblea degli Itacesi, 30 – La tela di Penelope, 33 – Il presagio divino, 34 – L’annuncio del viaggio di Telemaco, 36 – La preghiera a Minerva, 38 – La preoccupazione di Euriclea, 39 – La partenza silenziosa, 41
43 libro III. Telemaco incontra Nestore
Lo sbarco a Pilo, 43 – L’accogliente vecchio eroe, 44 – Telemaco, figlio di Ulisse, 45 – Il racconto del ritorno da Troia, 47 – I consigli di Nestore, 49 – Il prodigio di Minerva, 51 – A cavallo verso Sparta, 53
55 libro IV. Il racconto di Menelao
L’accoglienza di Menelao, 55 – Elena riconosce Telemaco, 57 – Il cavallo di Troia, 58 – L’inganno a Proteo, 60 – Itaca, amata terra rocciosa, 63 –Intanto a Itaca…, 64 – Il sogno di Penelope, 65
69 Sezione 2 - i Viaggi di uLiSSe
73 Libro V. La zattera di Ulisse
Il volo di Ermete, 73 – La grotta di Calipso, 74 – L’incontro tra Calipso ed Ermete, 75 – Ulisse è diffidente, 76 – Una proposta allettante, 78 – La costruzione della zattera, 79 – La tempesta, 81 – Il velo di Ino, 82 – Come raggiungere l’isola?, 83 – Finalmente l’approdo, 85
88 Libro VI. L’isola dei Feaci
Minerva escogita un piano, 88 – Le ragazze al fiume, 89 – Ulisse è destato dalle grida, 90 – Nausica si prende cura del naufrago, 93 – Ulisse è condotto in città, 94
98
Libro VII. Nella reggia di Alcinoo
Ulisse arriva in città, 98 – La reggia dorata, 99 – Ulisse chiede aiuto, 101 – Il racconto è solo accennato…, 104
108
Libro VIII. Demodoco, l’aedo dei Feaci
L’assemblea nella piazza, 108 – Demodoco il cantore, 109 – Le gare di atletica, 111 – Le scuse di Alcinoo e le danze, 115 – L’addio di Nausicaa, 115 – Il canto di Demodoco, 116 – La caduta di Troia, 116 – Il pianto di Ulisse, 117
120 Libro IX. Il Ciclope
Ulisse si presenta ai Feaci, 120 – I Ciconi, 121 – I Lotofagi, 121 – La terra dei Ciclopi, 122 – Nella grotta di Polifemo, 123 – La vendetta di Ulisse, 127 – La fuga dall’antro, 131 – La maledizione di Polifemo, 133
136 libro X. Eolo e Circe
L’otre dei venti, 136 – I Lestrigoni, 137 – L’approdo all’isola di Circe, 138 – La caccia al cervo, 138 – L’incantesimo di Circe, 139 – I consigli di Ermete, 141 – Ulisse affronta Circe, 143 – La liberazione dei compagni, 144 – Il timore di Euriloco, 145 – Le istruzioni di Circe per la partenza, 146
151 libro XI. Il viaggio nell’Oltretomba
Il regno spaventoso, 151 – L’ombra di Elpenore, 151 – La profezia di Tiresia, 152 – La madre defunta, 155 – Le antiche eroine, 157 – La preghiera di Arete e Alcinoo, 157 – Agamennone, 158 – Achille, 160 – Aiace, 161 – Le pene dell’Inferno, 162 – La brusca ripartenza, 164
166 libro XII. Le Sirene, Scilla e Cariddi, i buoi del Sole Circe istruisce Ulisse sul viaggio, 166 – Le Sirene, 170 – Scilla e Cariddi, 171 – I buoi del Sole, 172 – Il terribile naufragio, 176
179 Sezione 3 - iL guerriero in patria
182 libro XIII. Finalmente a Itaca
Ulisse si congeda da Alcinoo, 182 – La partenza da Scheria, 183 –Finalmente a Itaca, 184 – L’ira di Nettuno, 186 – Il risveglio di Ulisse, 187 – La falsa storia del soldato cretese, 189 – Ulisse riconosce Itaca, 191 – I consigli di Minerva, 192
195 libro XIV. Eumeo, il devoto servitore
L’arrivo alla capanna, 195 – La fedeltà al padrone disperso, 198 – La falsa storia del mendicante, 200 – Eumeo è incredulo, 201 – Un mantello per la notte, 202
205 libro XV. Il ritorno di Telemaco
Il ritorno è deciso, 205 – Il saluto di Menelao ed Elena, 206 – Il prodigio delle oche, 207 – Alla volta di Itaca, 208 – Ulisse ed Eumeo, 210 – L’arrivo di Telemaco, 214
216 libro XVI. Telemaco riconosce il padre
Telemaco giunge alla capanna, 216 – Ulisse si rivela al figlio, 218 – Il
piano dei due guerrieri, 220 – Il consiglio di guerra dei Proci, 223 –L’ultima notte nella capanna, 226
227 libro XVII. Argo, il cane fedele
L’atteso ritorno di Telemaco, 227 – Ulisse è insultato, 228 – Argo, il cane fedele, 231 – Ulisse resiste alle provocazioni, 233 – Il colloquio con Penelope è rimandato, 235
236 libro XVIII. La lotta con Iro
Due mendicanti a palazzo, 236 – La lotta con Iro, 238 – Penelope si mostra ai Proci, 240 – Ulisse è preso di mira, 244
247 libro XIX. Ulisse e Penelope
Il trasporto delle armi, 247 – Il colloquio con Penelope, 249 – La cicatrice, 253 – Il sogno di Penelope e la prova delle scuri, 256
258 libro XX. L’ultimo banchetto
La notte insonne, 258 – Il doppio presagio, 260 – Una giornata solita…, 260 – Il pastore Filezio, 260 – L’ultimo banchetto dei Proci, 263
269 Sezione 4 - iL riStabiLimento deLL’ordine
271 libro XXI. La prova dell’arco
Penelope indice la gara, 271 – Il tentativo di Telemaco, 274 – I Proci alla prova, 275 – Ulisse si propone come concorrente, 277 – La vittoria del mendicante, 279
282 libro XXII. La strage dei Proci
Ulisse si svela ai Proci, 282 – Ha inizio la strage, 284 – I guerrieri si armano, 285 – Un aiuto divino, 288 – La supplica di Leiode e di Femio, 288 – La punizione delle ancelle infedeli, 289
292 libro XXIII. Il segno segreto
L’incredulità di Penelope, 292 – Il letto di Ulisse, 295 – In campagna, 300
301 libro XXIV. La pace
I Proci scendono nell’Ade, 301 – Nel podere di Laerte, 304 – Ulisse e Laerte, 307 – La battaglia decisiva, 309
313 appendici
315 Le carte storico-geografiche
322 Cronologia dell’Odissea
324 Cronologia del racconto di Ulisse
325 Indice dei nomi e dei luoghi
343 Testi consultati
L’Odissea è uno dei testi fondamentali della cultura classica occidentale. In essa Omero è capace di comprendere nella vita di un uomo, Ulisse, tutto il mondo greco antico e, ponendosi come archetipo del romanzo, è pertanto divenuta una lettura ancor oggi imprescindibile per ogni studente e per chi desideri addentrarsi lungo il sentiero della conoscenza.
Il presente libro, riportato nella traduzione di Ettore Romagnoli, si offre come contributo a questo cammino, garantendo l’integralità della trama, la bellezza del verso poetico e un apparato che facilita la lettura del testo senza mai sostituirsi a esso, suggerendo invece l’immedesimazione del lettore nei personaggi e negli avvenimenti narrati.
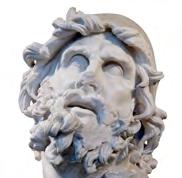
Contenuti digitali integrativi su www.itacascuola.it/odissea
in copertina
Testa di Ulisse
II secolo a.C.
Sperlonga, Museo Archeologico Nazionale
itacascuola.it Sul sito www.seleggo.org la versione digitale ottimizzata del libro per facilitare la lettura