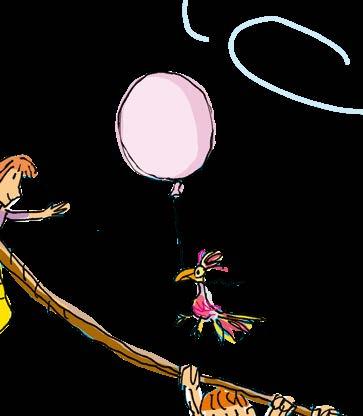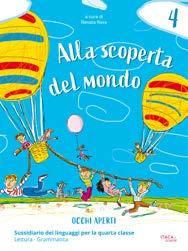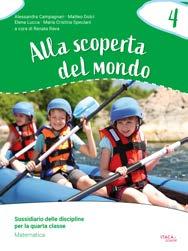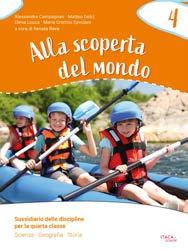Al a sc operta del mon do
4 Al a sc operta del mon do
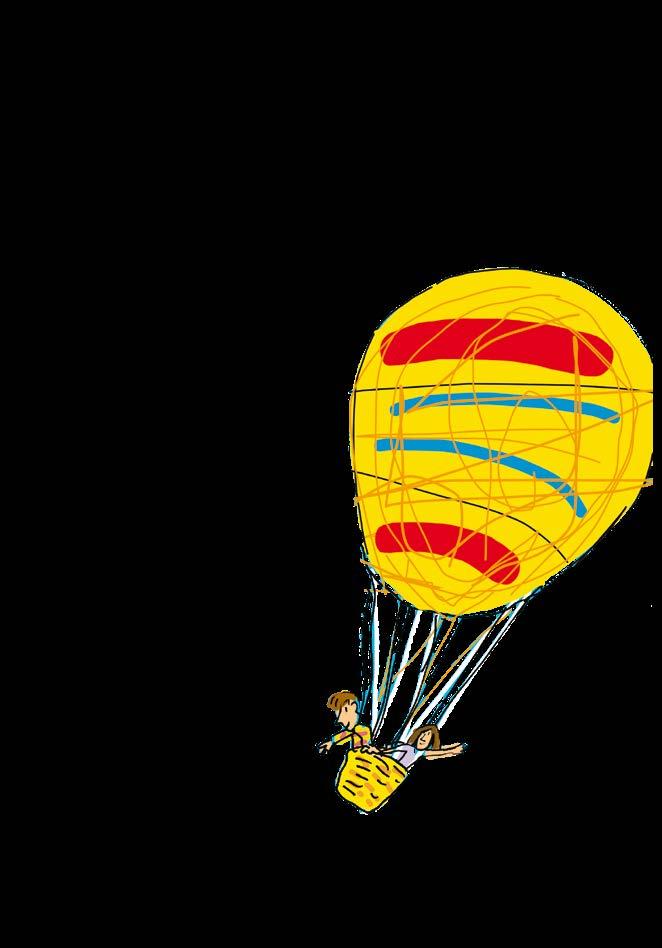
OCCHI APERTI
Sussidiario dei linguaggi per la quarta classe
Lettura · Grammatica
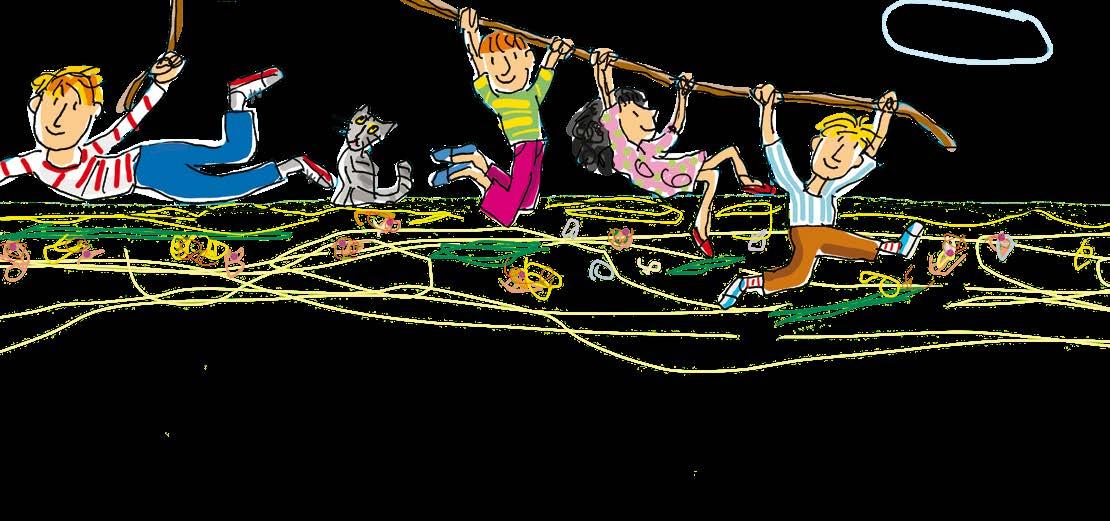

L’edizione di questo sussidiario dei linguaggi dà compiutezza e visibilità al lavoro di un gruppo di insegnanti che in questi anni ha individuato, selezionato e composto testi ed esercitazioni. La loro personale e collegiale ricerca è espressione della consapevole scelta di una proposta di lettura, scrittura e riflessione grammaticale essenziale e significativa nel percorso elementare. Per scoprirne di più, sulla pagina del libro sul sito www.itacascuola.it è disponibile la guida per l’insegnante.
Hanno collaborato: Mirella Amadori, Manuela Callaioli, Maria Teresa Carabelli, Barbara Righetti, Francesca Simonazzi, Giulia Zonca, Carlotta Piatti, Paola Brambilla, Sara Fasoli, Gregorio Curto, Marta Sangiorgio, Anna Pennisi, Cristina Godenzini.
Consulenti: Raffaela Paggi per la riflessione grammaticale, Francesco Grava per la musica, Denise Marchiori per arte e immagine.
L’ESPANSIONE
DIGITALE DEL TUO LIBRO
Sul sito www.itacascuola.it sono disponibili materiali integrativi per docenti e alunni. Inquadra il QR Code per:
registrarti e accedere ai materiali digitali del tuo libro
Alla scoperta del mondo 4. Sussidiario dei linguaggi. Classe 4 www.itacaedizioni.it/scoperta-mondo-4
Prima edizione: marzo 2018
Nuova edizione: maggio 2025
© 2018 Itaca srl, Castel Bolognese
Tutti i diritti riservati
ISBN 978-88-526-0797-4
Progetto grafico: Isabel Tozzi
Coordinamento editoriale: Daniela Dal Pane
Coordinamento redazionale: Cristina Zoli
Impaginazione e cura editoriale: Isabel Tozzi
Illustrazioni: Luciano Mereghetti
Stampato in Italia da Lito Terrazzi, Prato (PO)
accedere alla pagina del tuo libro
Oltre alla versione digitale dei libri sul sito www.itacascuola.it, i nostri testi possono essere richiesti a:
I LIONS IT ALIANI PER LA DISLESSIA
LIBRO IN FORMATO ACCESSIBILE
Grazie alla collaborazione con Seleggo, la versione digitale ottimizzata di questo libro per studenti dislessici può essere ottenuta in download gratuito registrandosi al sito www.seleggo.org ®
Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” www.bibliotecaciechi.it
Biblioteca digitale dell’Associazione Italiana Dislessia www.aiditalia.org
Col nostro lavoro cerchiamo di rispettare l’ambiente in tutte le fasi di realizzazione, dalla produzione alla distribuzione. Questo prodotto è composto da materiale che proviene da foreste ben gestite certificate FSC®, da materiali riciclati e da altre fonti controllate. Utilizziamo inchiostri vegetali senza componenti derivati dal petrolio e stampiamo esclusivamente in Italia con fornitori di fiducia, riducendo così le distanze di trasporto.
Per esigenze didattiche alcuni brani sono stati ridotti e/o adattati.
L’Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, nonché per eventuali involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti. La realizzazione di un libro comporta aspetti complessi, che richiedono particolare cura in ogni sua parte e nei controlli finali. Ciononostante è molto difficile evitare completamente refusi o imprecisioni.
L’Editore ringrazia chi vorrà inviare segnalazioni alla redazione, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: itaca@itacalibri.it
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Referenze fotografiche
Archivio Itaca · The Metropolitan Museum of Art, New York: Fletcher Fund, 1956, 164; Rogers Fund, 1907, 173; Purchase, The Annenberg Foundation Gift, 1993, 177 · Pexels · PxHere · Wikimedia Commons: Flanker83 · Shutterstock.com

«Ogni storia è una storia infinita.»
Michael Ende, La storia infinita
O C CHI APERTI
Canto
Le stoppie aride
Le cose intorno a noi si mostrano ai nostri occhi e alla nostra ragione in una scoperta continua.
Guardo nei campi brulli le stoppie aride e nel canneto osservo levarsi un vol.
Mi chiedo che fanno queste cose intorno: è un sogno, un inganno, questa vita accanto a me? Sei tu, Signor, che ti nascondi: cercano te.
Ascolto
Preludio della Suite 1 per violoncello
J.S. Bach
Il brano suggerisce l’immagine di una passeggiata in cui il protagonista, stupito, guarda tutto ciò che lo circonda; qua e là alcune note lo interrogano, gli pongono una domanda o creano una tensione, ma niente toglie il desiderio di guardarsi intorno, né la capacità di godere di ciò che si ha intorno.

ALLA RICERCA DEL TESORO
Cercarono ancora una volta dappertutto, poi sedettero scoraggiati. Huck non seppe suggerire niente.
Poco dopo, Tom disse: «Guarda lì, Huck. Ci sono impronte di passi e macchie di sego di candela sull’argilla ad un lato della roccia, ma non su quella al lato opposto. Come mai? Scommetto che il tesoro si trova davvero sotto la roccia. Scaverò nell’argilla!».
Il temperino ad una lama saltò subito fuori ed egli non aveva scavato per più di dieci centimetri, quando urtò il legno.
«Ehi, Huck! Hai sentito?».
Huck cominciò a questo punto a scavare e a raspare con le unghie. Rimasero ben presto scoperte alcune assicelle e vennero tolte.
Avevano nascosto un cunicolo naturale che conduceva sotto la roccia.
Tom si infilò nel cunicolo e spinse la candela il più possibile sotto la roccia, ma disse che non riusciva a vedere il fondo.
Di lì a poco, al di là di una stretta curva, esclamò: «Santo cielo, Huck, guarda qui!».
«Ecco il cofanetto del tesoro, lo abbiamo trovato finalmente!» esclamò Huck, affondando le mani tra le monete offuscate. «Mamma mia, siamo ricchi, Tom!».
«Huck, ho sempre saputo che ci saremmo riusciti. Sembra troppo bello per crederci, ma abbiamo il tesoro, sicuro! Senti, non perdiamo altro tempo, filiamocela. Fammi vedere se riesco a sollevare il cofanetto».
Pesava circa venti chili, Tom riuscì a sollevarlo a fatica, ma non sarebbe stato in grado di trasportarlo fino all’uscita. Ben presto le monete vennero a trovarsi tutte nei sacchetti e i ragazzi li portarono su fino alla roccia sotto la croce.
Mentre il sole cominciava a scendere verso l’orizzonte, sciolsero la cima e partirono. Arrivarono poco dopo che aveva cominciato a fare buio.
«E adesso Huck» disse Tom «nasconderemo il denaro nel solaio della legnaia, poi io verrò domattina, lo conteremo e ce lo divideremo e, in seguito, cercheremo un posto nei boschi dove possa essere al sicuro».
Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer, Mondadori
sego: grasso utilizzato per produrre sapone e candele. cunicolo: galleria, passaggio sotterraneo. cima: corda, cavo vegetale.
IL GUSTO DELL’ATTESA
«Oh, Marilla!» esclamò ansando, «la scuola domenicale organizza una merenda sull’erba, la settimana prossima. Sarà nel prato del signor Harmon Andrews, vicino al Lago delle acque lucenti. La signora Rachel, la signora Andrews e la signora Bell prepareranno dei gelati. Gelati, capisci? Mi permetti di parteciparvi, vero? Non è meravigliosa, una merenda sull’erba? Sarebbe la prima volta, per me. L’ho sognata tante volte, non ci sono mai stata».
«Puoi andarci. Sei un’allieva della scuola domenicale e se le tue compagne vi partecipano, lo farai anche tu».
«La mamma di Diana sta cucendo un vestito con le maniche al gomito. Lo indosserà per la merenda. Spero proprio che mercoledì prossimo il tempo sia bello, morirei se non potessi partecipare alla merenda. O forse non morirei, ma porterei in cuore il dispiacere per tutta la vita anche se nel futuro ci saranno tante altre merende. Andremo in barca sul Lago delle acque lucenti e mangeremo gelati. Io non ho mai assaggiato un gelato. Diana ha cercato di spiegarmi com’è il suo sapore, ma io penso che il sapore del gelato vada oltre qualsiasi immaginazione».
«Anna, hai parlato ininterrottamente per dieci minuti», disse Marilla. «Ora vediamo se riesci a stare con la bocca chiusa per un tempo altrettanto lungo».
Anna non parlò più, ma per tutta la settimana, quella merenda dominò i suoi pensieri, i suoi discorsi, i suoi sogni. Il giorno di sabato piovve e Anna entrò in agitazione, temendo che la pioggia sarebbe caduta per tutta la settimana e anche oltre, fino al fatidico mercoledì. Per cercare di distrarla, Marilla le impose di cucire di più del solito.
La domenica mattina, tornata dalla chiesa, Anna confidò a Marilla di aver provato un gran tuffo al cuore, quando il pastore aveva annunciato la merenda dal pulpito.
«Ho sentito un brivido in tutte le ossa, forse perché, fino a quel momento, non avevo creduto che la merenda ci sarebbe stata davvero. Non potevo fare a meno di pensare che fosse solo un sogno… ma quando il pastore fa un annunzio dal pulpito, allora bisogna crederci per forza».
«Ti concentri troppo sulle cose, tu» disse Marilla, sospirando. «E, prima o poi, avrai grosse delusioni».
«Aspettare una cosa è bello quasi quanto averla a portata di mano!
Puoi non ottenerla, ma nessuno può toglierti la gioia di immaginare che l’avrai. Io credo che sia peggio non sperare in niente, che avere qualche delusione ogni tanto».
Maud Montgomery, Anna dai capelli rossi, Bur
fatidico: atteso, aspettato. pulpito: podio, palco.
Ripensa alla tua esperienza. Ti è mai capitato di attendere un evento, l’arrivo di qualcuno o qualcosa di particolare? Racconta. SCRIVI TU!
UN OSPITE INATTESO
La vicenda ebbe un inizio improvviso, come spuntato dal nulla. I fratelli Dollybutt erano usciti a cercare funghi nei boschi e nei prati intorno a casa loro. Emma, che con i suoi quindici anni era la maggiore, aveva capelli biondi e occhi azzurri; i gemelli Conrad e Ivan avevano dodici anni e si assomigliavano come gocce d’acqua, con capelli color delle castagne e piccoli nasi a patatina così cosparsi di efelidi che sembravano uova di tordo.
Avevano raccolto un bel paniere di funghi color panna e stavano tornando a casa quando, improvvisamente, parve che il sole si fosse nascosto dietro una nuvola. Un’ombra enorme calò sul giardino. E con grande meraviglia i ragazzi udirono una voce tonante che li chiamava dall’alto.
– Ehilà! Voi laggiù, bambini! – gridava la voce.
Emma e i gemelli alzarono gli occhi, a bocca aperta, e apparve loro una scena davvero fantastica e sorprendente.
Alta su di loro planava una gigantesca mongolfiera, iridescente come una bolla di sapone. Al pallone era appesa una straordinaria struttura fatta di bambù: pareva un colossale cestone da bucato, ma aveva tanto di finestre, tapparelle e una porta d’ingresso. Il tutto culminava in una sorta di veranda, da cui spuntavano tre grandi telescopi; e lungo uno dei lati facevano capolino una folta barba e due baffoni da tricheco.
– Voi laggiù! – continuò la voce: era simile ad un aspro ruggito, come se il proprietario avesse passato la vita a fare i gargarismi con la ghiaia. – Siete i bambini Dollybutt?
– Sì, siamo noi – rispose Emma. – E lei chi è?
– Sono il vostro prozio Lancelot, naturalmente! Non vi ha mai parlato di me vostra madre?
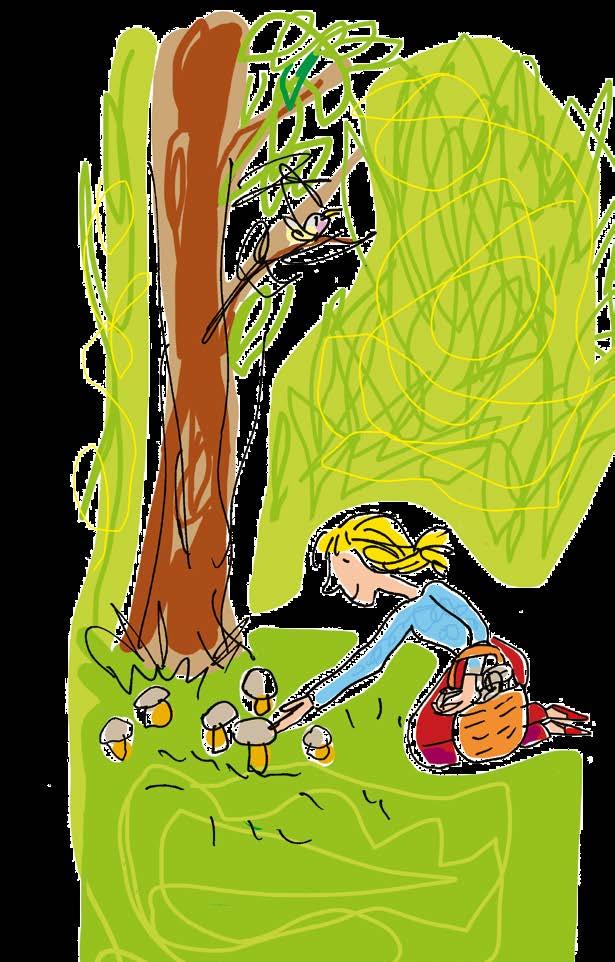
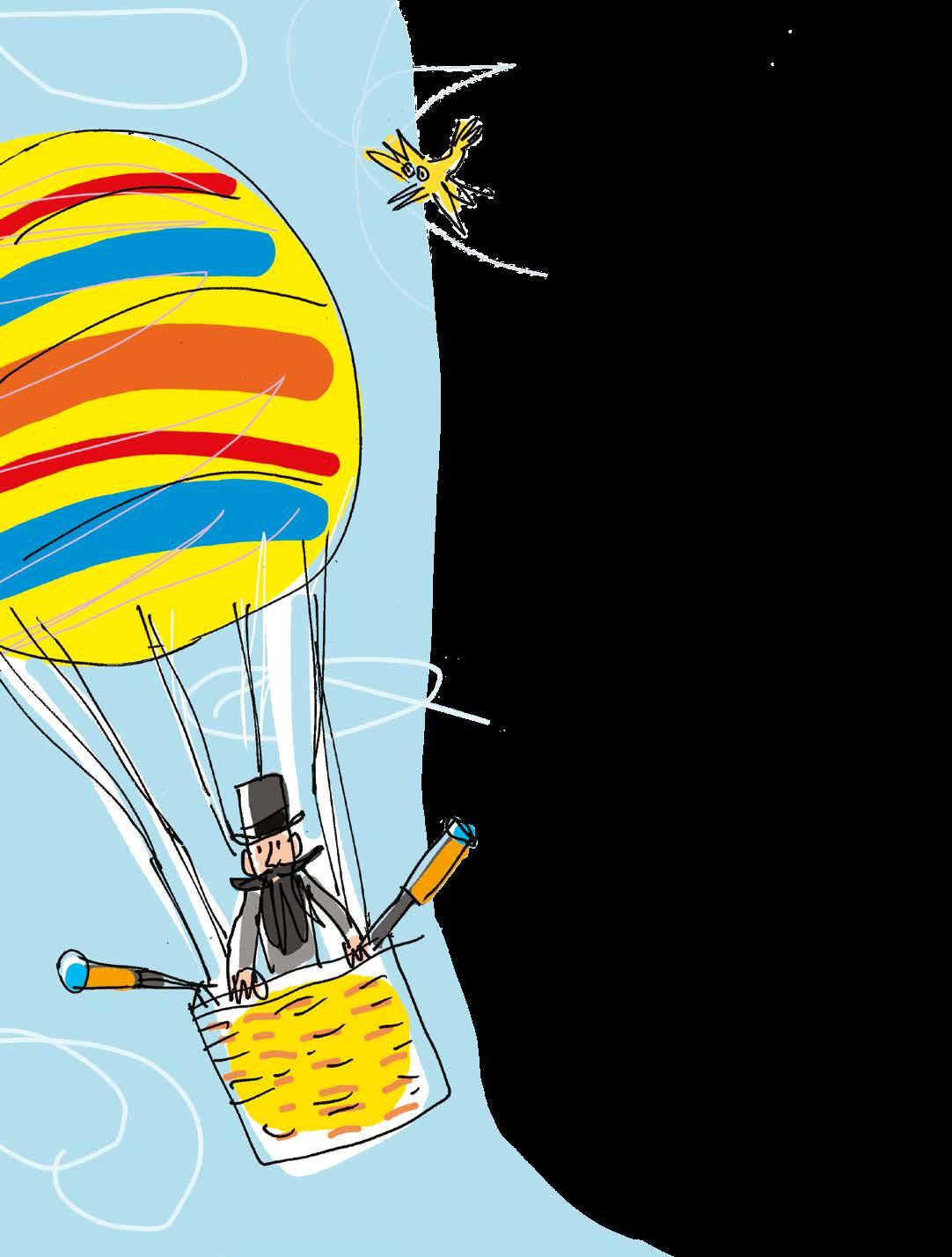
I ragazzi scossero la testa. I baffoni ebbero un fremito d’impazienza.
I ragazzi gli fecero strada verso casa: quando entrarono in cucina la povera signora Dollybutt fu talmente scossa dal rombante saluto di Lancelot che lasciò cadere sul pavimento il vassoio di biscotti che teneva tra le mani.
Lancelot se la strinse fra le braccia e le stampò due sonori bacioni sulle grosse guance.
– Sally, ragazza mia, è bello rivederti! – esclamò scrutandola con affetto.
– Andiamo alla ricerca di Perceval – spiegò Lancelot. – È partito per studiare i gorilla, in Africa, e non s’è più visto.
– Chi è Perceval? – intervenne Conrad.
– Mio fratello, l’altro vostro prozio – spiegò Lancelot. – Sono due anni che è partito, e comincio davvero a preoccuparmi. Intendo andare a cercarlo, e ho bisogno di orecchie e occhi acuti che mi aiutino. Dio sa dove può essere finito. Magari ci toccherà fare il giro del mondo prima di trovarlo!
– Ma in mongolfiera?! – gemette la signora Dollybutt.
– Naturalmente! – ruggì Lancelot –I ragazzi non corrono il minimo rischio. Questa sarà la grande avventura della loro vita e non ammetto una risposta negativa.
Gerald Durrell, Un viaggio fantastico, Mondadori
RICONOSCERE LA STRADA

Quando Joe si svegliò, sembrava che il mondo intero stesse ancora dormendo. La vallata era invasa dalla nebbia e anche il canto mattutino degli uccelli sembrava attutito.
Era tutto immobile, e umido e sapeva di terra.
Joe si muoveva con passo felpato sul tappeto di muschio che cresceva sotto gli alberi, anche se faceva un sacco di rumore con il coltello del papà.
Zac zac. Tagliava gli arbusti spinosi.
Cric croc. Rompeva i rami secchi.
Non sarebbe servito a niente salire in fretta, doveva trovare una strada che gli asini potessero percorrere, e che un giorno avrebbe potuto essere allargata per far passare i carri.
Così procedeva a zig-zag, tornando sui suoi passi ogni volta che la china diventava troppo ripida, e segnava ogni curva con un nastro di seta arancione. Era un lavoro lento.
Dopo un po’ gli alberi si diradarono fino a quando riuscì a vedere dove stava andando e poi il sole spuntò fuori e subito dopo si trovò sopra la linea degli alberi, sopra l’ombra. Il sudore gli scendeva lungo le guance e la nuca bruciava, così si tolse la maglia e se la legò sulla testa. Quando erano partiti, aveva un cappellino per proteggersi dal sole, ma lo aveva perso lungo la strada.
Avanti. In alto. Ci stava mettendo un bel po’ di tempo.
Finalmente, la pendenza diminuì gradualmente. «Ce l’abbiamo fatta, Carrot! Siamo arrivati in cima.»
Fece una panoramica del paesaggio che lo circondava e si mise in ascolto. Non sentiva un rumore a parte lo sgocciolio di un piccolo ruscello che scorreva sotto l’erica, il ronzio di insetti invisibili e un trillo celeste che volava troppo in alto per essere visto. Era l’unica cosa che si stava muovendo in quella landa desolata, a parte Carrot.
Osserva bene ogni cosa, gli aveva detto il papà. Osserva cosa sta crescendo e come sta crescendo, senti la direzione del vento, guarda le ombre, guarda in che direzione scorre l’acqua. Usa Ia bussola e la testa. Lascia sempre dei segnali. E non dimenticarti di voltarti spesso a guardare la strada fatta, così saprai come sarà la via del ritorno.

Il papà diceva sempre che sarebbe stato al fianco di Joe quando avrebbe trovato la sua prima strada. Stare al suo fianco, lasciando che fosse Joe a prendere le decisioni. Era l’unica persona che sapeva cosa volesse dire trovare una strada. Peccato che lui non ci fosse.
Quel giorno camminò per chilometri. La strada per la ferrovia presentava pochi dislivelli, non zigzagava e non incrociava troppi ruscelli da attraversare.
I segnalini erano un problema perché non c’erano alberi ai quali attaccarli, per cui doveva legarli ai cespugli dove non erano sempre facilmente visibili. Spesso doveva tornare sui propri passi togliendo quelli che aveva messo, poi proseguiva un po’ più in alto lungo la china, o più in basso, per evitare uno strapiombo. Era fiero di sé stesso e pensò che se il papà fosse stato lì con lui, gli avrebbe detto: Ben fatto, ragazzo! Stai usando la testa e ti stai ricordando tutto quello che ti ho detto. Bravo!
Tornato al campo, gli facevano male le gambe, aveva lo stomaco sottosopra e avrebbe voluto dormire per una settimana. Ma sapeva di aver trovato la strada migliore in quella grande vallata e di aver tracciato la metà di un buon percorso.
Hunter, La gara dei cartografi, La nuova frontiera
Dopo aver riletto Riconoscere la strada, rispondi alle domande.
1. Dove si trova Joe?
A. In una vallata di montagna.
B. Sulla strada verso casa.
C. In una zona deserta.
2. Chi lo accompagna?
A. Il papà.
B. La mamma.
C. Carrot.
3. Joe sta facendo una passeggiata o ha un compito preciso? Se sì, quale?
4. Quali sono i consigli del papà che Joe ricorda bene?
5. Secondo te Joe riesce nella sua impresa?
Da quali parole lo capisci?
GRAZIE!
Noi non ci accorgiamo, di solito, di ciò che abbiamo, di tutto ciò che ci si ripresenta fedele, che ci si schiera davanti agli occhi ogni mattina. Ma da un po’ di tempo “vedo”, attorno a me, questa casa, e una famiglia, e degli amici, e un lavoro… io mi ricordo, in certi vecchi che ho frequentato da bambina, questa attitudine a saper essere contenti di una mattina di sole, o di un piatto fumante, a tavola, e del suo profumo. Come se ogni mattina gli occhi si aprissero per la prima volta; e ci si meravigliasse delle facce care, delle cose di casa che funzionano, docili, del fido ronzio della lavabiancheria e perfino di un banale frigorifero pieno…
Grazie, dunque, per questa stanza in cui dormo; grazie per quella lama di luce chiara e di freddo tagliente che entrerà aprendo la finestra, insieme al fugace rosa del ciclamino sul balcone, così rosa e vivo, anche dopo la notte d’inverno…
Grazie di questa casa grande, ombrosa, caotica, come in fondo a me piace… quanto amo questa nostra cucina larga, affollata di oggetti che non sappiamo più dove infilare, col grande crocefisso di legno che ci allarga sopra le sue braccia, generoso. Grazie dei vicini e dei negozianti che saluto ogni mattina, nell’enclave cara e consueta che è una via di Milano come tante… grazie anche del mio cane, mezzo sciacallo e mezzo volpe… grazie dei nostri gatti, belli, fieri come enigmatiche sfingi e pasticcioni come bambini…
Marina Corradi, «Tempi», 29 dicembre 2011
si schiera: si mostra. attitudine: capacità, abilità.
enclave: luogo protetto.
SCRIVI TU!
«Noi non ci accorgiamo, di solito, di ciò che abbiamo, di tutto ciò che ci si ripresenta fedele, che ci si schiera davanti agli occhi ogni mattina…». Racconta quali sono le cose, i luoghi e le persone che ti circondano ogni giorno e ringrazia per ciò a cui tieni particolarmente.
Utilizza la costruzione proposta nel testo:
1. Io non mi accorgo…
2. Da un po’ di tempo vedo attorno a me…
3. Grazie dunque per…
4. Grazie di…
GET BACK UP!
Cari ragazzi, sono contento del vostro entusiasmo e sono contento di tutto quello che fate, quello che pensate. Ma mi domando – state attenti alla domanda! – un giovane, può sbagliare? E una persona adulta, può sbagliare?
E un vecchio come me, può sbagliare? Tutti possiamo sbagliare. Tutti.
Ma l’importante è rendersi conto dello sbaglio. Questo è importante. Noi non siamo superman. Noi possiamo sbagliare.
E questo ci dà anche una certezza: che dobbiamo sempre correggerci.
Nella vita tutti possiamo cadere, tutti. Ma c’è una canzone molto bella, mi piacerebbe che voi l’imparaste, è una canzone che cantano i giovani quando stanno salendo sulle Alpi, sulle montagne. La canzone dice così: “Nell’arte di salire, quello che è importante non è non cadere, ma non rimanere caduto”. Avete capito questo? Nella vita tutti possiamo cadere, tutti! È importante non cadere? È importante non cadere? Sì, ma cosa è più importante? [I ragazzi rispondono: get back up!] Non rimanere caduti. E se tu vedi un amico, un compagno, un’amica, una compagna della vostra età che è caduto, che è caduta, cosa devi fare? Ridere di quello? No. Tu devi guardarlo e aiutarlo a rialzarsi. Pensate che noi soltanto in una situazione della vita possiamo guardare l’altro dall’alto in basso: per aiutarlo a sollevarsi. Per aiutarlo a sollevarsi. Siete d’accordo o non siete d’accordo? Se uno di voi è caduto, è un po’ giù nella vita morale, se è caduto, tu, voi, dovete dargli una botta? No! Bravi, bravi. Adesso ripetiamo insieme, per finire. Nella vita l’importante non è non cadere, ma non rimanere caduto a terra.
Papa Francesco, Incontro con i giovani nello Stadio “Sir John Guise” (Port Moresby, Papua Nuova Guinea), 9 settembre 2024

COSA C’È IN UNA STORIA
Nella soffitta era sparsa un po’ dappertutto ogni sorta di ciarpame, c’erano scaffali pieni di raccoglitori e di cartelle, pacchi di incartamenti che non servivano più a nessuno, banchi di scuola accatastati gli uni sugli altri con i ripiani macchiati di inchiostro, uno scheletro umano appeso a un attaccapanni e molte casse e scatole piene di vecchi quaderni e testi scolastici. Bastiano alla fine decise di eleggere a sua dimora le stuoie da ginnastica. Se ci si stendeva sopra all’intera pila, pareva di essere su un sofà. Le trascinò sotto il finestrino del tetto, nel punto in cui arrivava più luce. Lì vicino c’erano, ammonticchiate, alcune vecchie coperte militari grigie, molto polverose e malconce, ma che facevano ottimamente al caso suo.
Bastiano le andò a prendere. Si tolse il cappotto e lo appese al portabiti, accanto allo scheletro, che dondolò un momento su e giù; ma Bastiano di lui non aveva paura, forse perché a casa sua era abituato a vedere cose del genere. Si tolse anche le scarpe, molli d’acqua, e in calzini di lana si lasciò cadere alla turca sulla pila delle stuoie, avvolgendosi le coperte grigie intorno alle spalle. Accanto a sé aveva la sua cartella, e il libro color rame.
Pensò che, di sotto, i suoi compagni avevano adesso giusto la lezione d’italiano. Forse dovevano fare un tema su qualche argomento noioso da morire.
Bastiano guardò il libro. «Mi piacerebbe sapere», mormorò fra sé, «che diavolo c’è in un libro fintanto che è chiuso. Naturalmente ci sono dentro soltanto le lettere stampate sulla carta, però qualche cosa ci deve pur essere dentro, perché nel momento in cui si comincia a sfogliarlo, subito c’è lì di colpo una storia tutta intera. Ci sono personaggi che io non conosco ancora e ci sono tutte le possibili avventure e gesta e battaglie, e qualche volta ci sono delle tempeste di mare oppure si arriva in paesi e città lontani. Tutte queste cose in qualche modo sono già nel libro. Per viverle bisogna leggerlo, questo è chiaro. Ma dentro ci sono fin da prima. Vorrei proprio sapere come».
E d’improvviso si sentì avvolgere da un’atmosfera quasi solenne.
Si sistemò comodamente, afferrò il libro, aprì la prima pagina e cominciò a leggere.
Michael Ende, La storia infinita, Longanesi ciarpame: roba vecchia e inutile.
incartamenti: documenti e fascicoli di carta. ammonticchiate: messe una sopra l’altra.
CARA JOAN…
Lettera a Joan, bambina americana lettrice di «Le cronache di Narnia» che aveva inviato a Lewis un proprio racconto.
2 giugno 1956
Cara Joan,
grazie per la tua lettera del 3 giugno. Descrivi la tua Notte meravigliosa davvero bene. È proprio questo il punto, descrivi il posto e le persone e la notte e la sensazione di tutto questo assieme, molto bene, ma non la cosa in sé: la montatura, ma non la pietra preziosa.
Se diventerai una scrittrice, cercherai di descrivere la cosa per tutta la vita: e sarai fortunata se, in dozzine di libri, una o due frasi, solo per un istante, saranno vicine a farcela davvero.
Quello che ha davvero importanza è:
1. Cerca sempre di usare il linguaggio in maniera tale da rendere abbastanza chiaro cosa vuoi significare e sicuro che la tua espressione non vuole intendere niente di diverso.
2. Preferisci sempre la parola chiara e diretta a quella più vaga e ampia. Non rendere effettive le promesse, ma mantienile
3. Non usare termini astratti quando quelli concreti funzionano. Se vuoi dire: «Più persone sono morte» non dire: «La mortalità è aumentata».
4. Nella scrittura non usare quegli aggettivi che possono solo dirci come tu voglia che noi sentiamo le cose che descrivi. Voglio dire, anziché dirci che una cosa era «terribile», descrivila in maniera da terrorizzarci. Non dire che era «deliziosa»; fai sì che noi arriviamo a dire «deliziosa» quando abbiamo letto la tua descrizione. Capisci, tutte le parole di quel tipo (orribile, meraviglioso, odioso, squisito) sono come dire ai tuoi lettori: «Per favore, vedete di fare il mio lavoro al mio posto».
5. Non usare parole troppo grandi per il soggetto. Non dire «infinitamente» quando intendi «molto»; altrimenti non avrai più parole per quando vorrai parlare di una cosa veramente infinita.
Grazie per le foto. Sia Aslan che tu state davvero bene. Spero che ti piaccia la tua nuova casa.
Con tanto affetto,
tuo
C.S. Lewis
C.S. Lewis, Prima che faccia notte. Racconti e scritti inediti, Bur
vaga: confusa, non chiara.
SCRIVI TU!
Rileggi il punto 4. Prova a descrivere una cosa o una situazione “terribile” o “deliziosa” senza usare questi aggettivi.
PER VEDERE IN PROFONDO…
È per vedere più chiaramente, per vedere ancora più in profondo, ancor più intensamente, ed essere quindi pienamente consapevole e vivo, che disegno le “diecimila cose” che ci circondano.
Il disegno è la disciplina per mezzo della quale riscopro costantemente il mondo.
Ho imparato che le cose che non ho disegnato non le ho mai viste veramente, e che, quando mi metto a disegnare una cosa qualsiasi, essa mi si rivela straordinaria, un puro miracolo.
Libera traduzione da Frederick Franck, The Zen of Seeing. Seeing/Drawing as Meditation, Vintage
Mettiamoci all’opera
Disegniamo…
Prova ad affacciarti ad una delle finestre di casa, quella che ti offre la vista più bella e interessante di ciò che sta fuori.
Su un foglio da disegno traccia con la matita grafite, senza fare troppa pressione con la mano, le linee principali di ciò che vedi in modo da definirne l’ingombro nello spazio che hai a disposizione.

Ricordati che ciò che è più vicino risulterà più grande e ricco di dettagli, mentre ciò che è più lontano sarà più piccolo e indefinito, quindi fai molta attenzione alle proporzioni.
Prosegui disegnando ciò che vedi nel dettaglio e lasciandoti incuriosire da ciò che più ti colpisce. Cerca di non lasciare spazi vuoti e aguzza lo sguardo come farebbe un investigatore sulle tracce importanti per la risoluzione del suo caso, anche ciò che è apparentemente insignificante potrebbe rivelarsi utile e significativo!
Colora con le matite colorate.
Se vuoi puoi decidere di rappresentarti di spalle mentre guardi affacciato alla finestra, accennando anche alla cornice della finestra. In questo caso dovrai colorare te e la cornice di nero, totalmente in ombra e in un forte contrasto con i colori accesi del panorama che hai appena rappresentato.
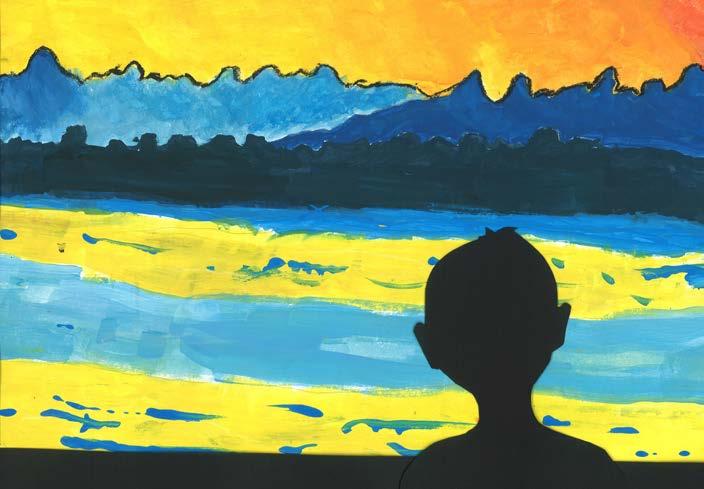
INCON T R I AMO LA POESIA
UNA SCUOLA GRANDE
COME IL MONDO
C’è una scuola grande come il mondo. Ci insegnano maestri e professori, avvocati, muratori, televisori, giornali, cartelli stradali, il sole, i temporali, le stelle. Ci sono lezioni facili e lezioni difficili, brutte, belle e così così… Si impara a parlare, a giocare, a dormire, a svegliarsi, a voler bene e perfino ad arrabbiarsi.
Ci sono esami tutti i momenti, ma non ci sono ripetenti: nessuno può fermarsi a dieci anni, a quindici, a venti, e riposare un pochino. Di imparare non si finisce mai, e quel che non si sa è sempre più importante di quel che si sa già. Questa scuola è il mondo intero quanto è grosso: apri gli occhi e anche tu sarai promosso!
Gianni Rodari
PICCOLA POESIA PER ANDARE
Una poesia a volte, anzi spesso, è questo, semplici sguardi, un sussurrare un certo modo di accarezzare un’ala, la pelle di qualcuno, un carapace, è come saluti ancora questa nave che ha appena aperto gli occhi è come tendi una mano o una banderuola e anche la maniera con cui ti dirai: «Coraggio! Sulla via che ho scelto ecco che vado, ci sono!»
Una poesia non è granché e, al tempo stesso, è tutto l’universo.

COME UN POETA
La poesia è l’arte di scrivere in versi.
I versi non sono altro che le “righe” delle poesie.
Scrivendo in poesia, infatti, non si va a capo quando non si ha più spazio nella riga, ma secondo altri criteri, legati principalmente alla rima al conteggio delle sillabe.
La poesia però è anche altro: è un modo di vedere, di sentire e di esprimersi che va in profondità; coglie la bellezza delle cose e l’intensità degli eventi.
La poesia ci invita a guardare con attenzione, anche le piccole cose.
A volte leggendo una poesia ci sembra che parli di noi o che esprima i nostri pensieri e le nostre emozioni.
Componi da solo o con un amico alcuni versi su un oggetto o un ambiente della scuola.

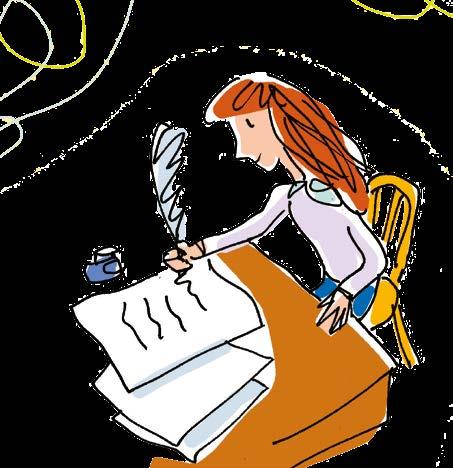
TRA G I O CO E SPORT
Canto
Il Mavalà
Essere amici è conveniente e ciascuno deve fare la sua parte.
Mavalà, se rimaniamo insieme mavalà, non può che andarci bene, mavalà, ti è stato preparato il pasto preferito quello che sognavi tu e molto più!
Ascolto
Aquarela do Brasil
Una coinvolgente musica popolare, una samba con il battito del cuore che dà il ritmo ondeggiante della camminata. E se provassimo anche noi a camminare insieme, muovendoci al ritmo di questa musica?


UN LUOGO DOVE GIOCARE
Non potete capire che cosa sia, che valore abbia, per un ragazzo di Budapest, un’area di “terreno fabbricabile”. Eppure non si tratta che di un’esigua superficie di terreno, limitata da uno steccato di tavole ormai semimarcite e, dove non c’è lo steccato, dai muri di fianco delle case che s’innalzano fino al cielo. Lì c’era un’altra vasta area, affittata ad una importante segheria a vapore che l’aveva riempita di cataste di legname, simili a enormi cubi regolari separati da tante stradette. Un vero labirinto, da non raccapezzarsi.
Ma chi alla fine sapeva uscirne, ecco che sbucava in una sorta di spiazzo dove si trovava il rustico edificio che era sede della segheria a vapore: una costruzione strana, piena di misteri, quasi sgomentevole. D’estate la vite del Canadà la ricopriva totalmente e tra il verde dei tralci si drizzava un sottile fumaiolo nero.
Certo, non ci poteva essere campo più splendido per giocarvi a qualsiasi gioco. Per i ragazzi di città, nessuno avrebbe immaginato o avrebbe chiesto un posto più adatto di quello alle imprese degli indiani. L’area fabbricabile di via Pal era tutta piana e sostituiva alla perfezione le praterie americane. Nel fondo, il deposito di legname rappresentava tutto il rimanente: borghi, foreste, Montagne Rocciose; insomma, quanto veniva fatto di desiderare.
Ferenc Molnár, I ragazzi di via Pál, Bur esigua: piccola. sgomentevole: paurosa.
SCRIVI TU!
Quali sono i giochi che preferisci fare? Spiegali brevemente, raccontando con chi li fai e in quale luogo.
L’AQUILONE
Una di quelle estati fu per noi splendida: l’estate in cui nostro padre decise di prendersi anche lui una vacanza completa.
Ciò significava che egli metteva a nostra disposizione tutte le risorse della sua allegria, della sua inventiva, della sua esperienza. Diventava un nostro compagno maggiore, la nostra guida.
Un giorno papà veniva a casa con un mazzo di canne palustri e da queste, con arte, egli ricavava per noi fischietti, piccoli zufoli e schizzetti.
Un altro giorno vedevamo papà manipolare misteriosamente ogni sorta di stracci: ne venne fuori, con nostra gioia e sorpresa, una bella palla vibrata, cucita solidamente, con un forte manico di stoffa.
Una mattina lo vedemmo davanti alla casa, affaccendato con grandi fogli di carta da pacco, con lunghe stecche ricavate da canne, con barattoli di colla di farina, con gomitoli di spago.
Fu una giornata indimenticabile; il lavoro durò ininterrottamente per ore ed ore.
Il risultato fu un aquilone spettacolare, robusto come un aeroplano, con una coda lunghissima e, per reggerlo, un gomitolo di spago che non ci stava nelle mani. Trasportammo il “drago” sul prato, come un trofeo.
I nostri cuori battevano, quando papà ci dette tutte le istruzioni per il via.
Trepidanti seguimmo il mostro che barcollò, ondeggiò, s’impennò un momento poi, trasportato dal vento, cominciò a salire, salire e ad allontanarsi nel cielo.
Fra lo stupore commosso di noi tutti, si levò più su del campanile.
Lo vedevamo piccolo come un falchetto, superbo nel volo, e il filo vibrava e noi facevamo fatica a trattenerlo.
Il nostro aquilone fu per parecchi giorni la meraviglia del paese e tutti venivano a vederlo.
Giani Stuparich, L’isola e altri racconti, Giulio Enaudi
vibrata: pronta per essere lanciata.
ESPLORA LA SCRITTURA!
Sottolinea i paragoni che l’autore utilizza per descrivere l’aquilone e le sue caratteristiche.
GIOCHI DI LUCE
Un giorno d’agosto Pollyanna era passata di buon mattino a dare un saluto al signor Pendleton, e rimase assolutamente stupefatta notando una banda di luce colorata, blu, verde, rosso e violetto attraversare il guanciale del malato. Stette un po’ ad osservare, quindi esclamò radiosa: «Ecco, signor Pendleton, un arcobaleno in miniatura che è entrato a trovarla! Oh! Com’è bello! Ma come avrà fatto ad entrare?» si chiese incuriosita.
Il signor Pendleton sorrise un po’ controvoglia; quel giorno non era dell’umore migliore. «Beh, penso che sia originato dal bordo sfaccettato del termometro che sta appeso alla finestra» disse con voce stanca. «In questa stagione è sfiorato dal sole al mattino».
«Ma è bellissimo! Ed è il sole a creare quei colori?
Se il termometro fosse mio, lo terrei al sole tutto il giorno».
«Quel termometro non ti servirebbe più a nulla, allora» disse ridendo il signor Pendleton. «Come potrebbe indicare la temperatura esatta se fosse esposto al sole?».
«Non me ne importerebbe nulla» disse Pollyanna sempre più affascinata dalla banda colorata che attraversava il cuscino. «Se potessimo vivere sempre in un arcobaleno, pensa che ci importerebbe molto della temperatura?».
John Pendleton rise di cuore. Osservava con curiosità le varie espressioni sul volto della bambina. Colto da un’idea improvvisa suonò il campanello che aveva accanto a lui.
«Nora», disse quando l’anziana cameriera apparve sulla porta «mi porti, per favore, uno dei candelabri che si trovano sulla mensola del camino del salotto a sud».
«Va bene, signore» disse la donna osservandolo stupita.
Qualche attimo dopo era di ritorno, accompagnata da un leggero tintinnio e, con aria più che mai perplessa, si avvicinò al letto. Erano i pendagli di cristallo che adornavano il candelabro a tintinnare in quel modo.
«Grazie. Lo posi su quel tavolino» disse il signor Pendleton. «Adesso leghi uno spago in modo che vada da un lato all’altro della finestra. È tutto, grazie, può andare» disse, dopo che la donna ebbe eseguito le istruzioni.
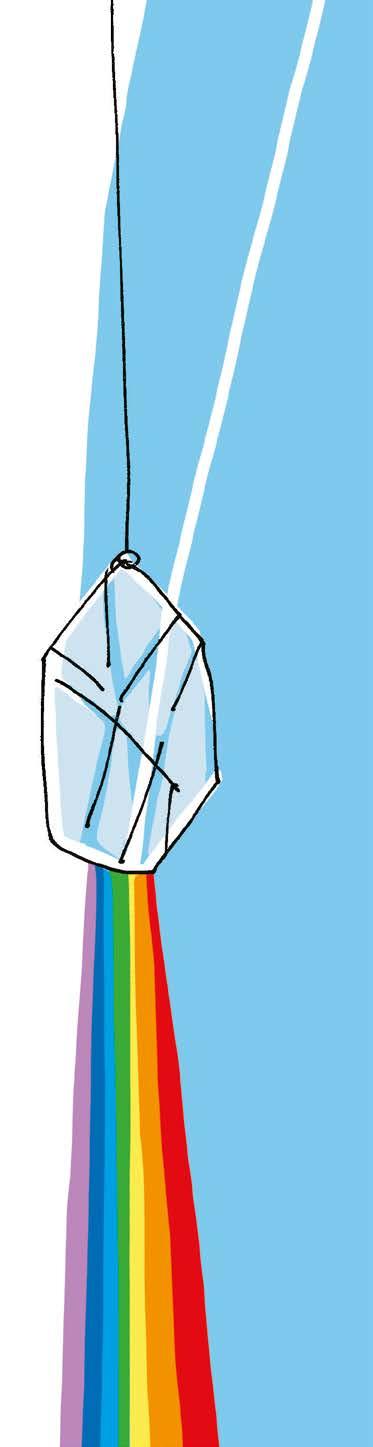
Quindi guardò Pollyanna sorridendo. «Portami quel candelabro, per favore». Pollyanna l’afferrò con tutte e due le mani e glielo portò. Subito dopo John Pendleton cominciò a sfilare uno per uno i pendagli del candelabro finché non furono tutti distesi uno accanto all’altro, una dozzina circa, sul lenzuolo.
«E ora, mia cara, se veramente desideri vivere in un arcobaleno, non vedo altra alternativa che creare un grande arcobaleno in cui vivere! Non ti resta altro da fare che agganciare uno per uno questi pendagli di cristallo allo spago che Nora ha fissato attraverso la finestra».
Pollyanna non aveva appeso che tre di quei pendagli davanti alla finestra illuminata dai raggi del sole, che iniziò a capire quello che stava accadendo. Era così eccitata che riuscì a stento ad appendere il resto delle gocce di cristallo. Ma ben presto ebbe terminato e si ritrasse, lanciando un grido di meraviglia.
Quella stanza sontuosa ma cupa era diventata una sorta di mondo fantastico. Dappertutto danzavano raggi di luce blu, arancione, verde e violetto. La parete, il pavimento, qualche mobile e perfino il letto erano coperti da tante tremolanti strisce colorate.
«Oh, che meraviglia» disse Pollyanna al colmo dell’entusiasmo; e poi, improvvisamente, scoppiò a ridere.
Eleanor H. Porter, Pollyanna, De Agostini
perplessa: incerta, dubbiosa. umore: stato d’animo.
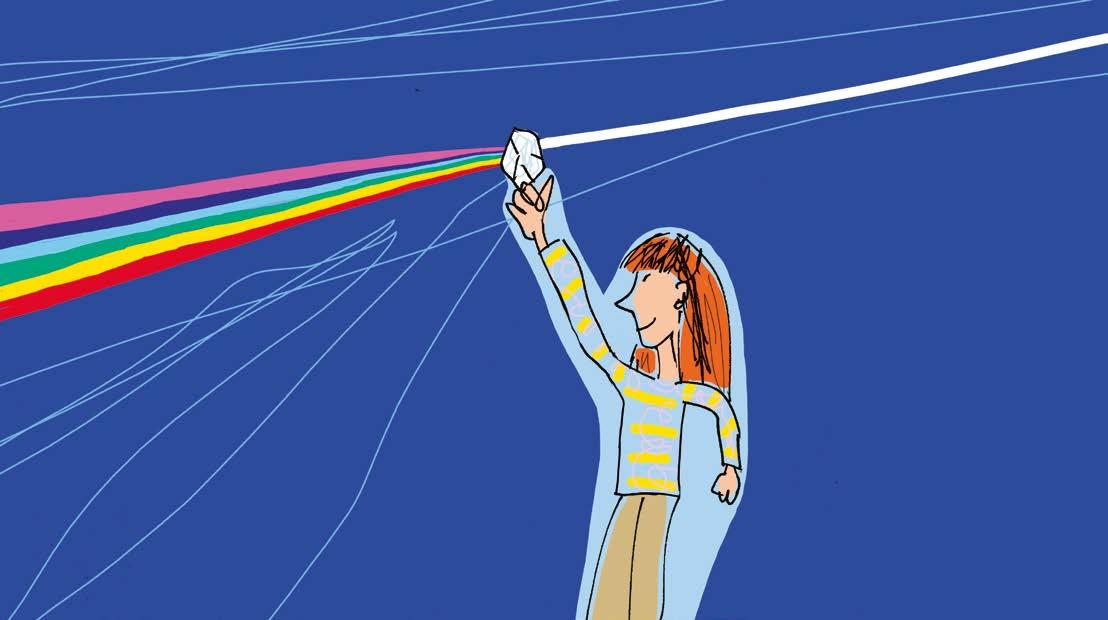
Dopo aver riletto Giochi di luce, rispondi alle domande.
1. Il guanciale è:
A. Un ingrediente degli spaghetti alla carbonara.
B. Un tipo di cuscino.
C. La faccia del signor Pendleton.
2. Da quale oggetto è provocata la banda di luce colorata?
Perché?
3. Dove metterebbe il termometro Pollyanna?
Perché?
4. Com’era l’umore del signor Pendleton, all’entrata in camera di Pollyanna?
5. Quando cambia il suo umore?
Perché?
Che cosa decide di fare?
6. Come ti immagini un pendaglio di cristallo del candelabro? Disegnalo.
7. Ripensando alla lettura metti un aggettivo adatto a questi nomi:
Pollyanna
Signor Pendleton cameriera stanza arcobaleno
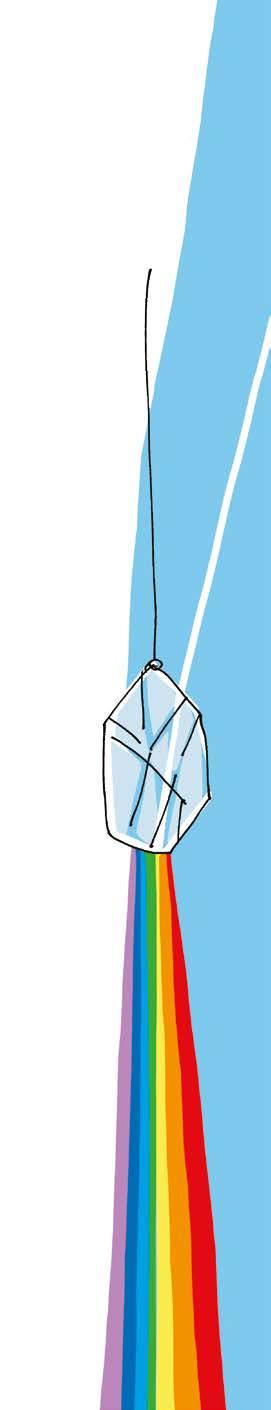
L’AMICIZIA CRESCE
Bastò poco per diventare inseparabili.
Andrea e Nico restavano in casa lo strettissimo necessario, praticamente solo per fare un po’ di compiti e quando i genitori li chiamavano a tavola.
Per il resto del tempo, erano sempre fuori a giocare e chiacchierare nella campagna. Che bello correre a perdifiato nei prati, ogni volta diventava una sfida. Per la prova di resistenza, come la chiamavano loro, avevano fissato una sola regola: partire dal centro esatto dell’aia, col piede destro appoggiato ai sassi dell’aiuola, e correre a più non posso in direzione delle colline, senza fermarsi mai.
La gara finiva quando uno dei due sentiva una fitta forte al fianco sinistro, segno che proprio non ne poteva più. A quel punto raggiungevano il grande faggio dove potevano riposarsi in pace. Quell’albero, così lontano da casa (che vista da là pareva un puntino bianco in mezzo alla vallata verde) aveva delle fronde tanto folte da offrire riparo dalla pioggia d’inverno e dal sole d’estate.
Non era come tutti gli altri: alla base del tronco spuntavano dal terreno delle grosse radici che sembravano uscire alla ricerca di una boccata d’aria o di un pezzettino d’azzurro.
Andrea e Nico vi si sdraiavano in mezzo, con la schiena per terra; mentre tenevano le gambe appoggiate a quegli strani rami striscianti sull’erba si sentivano bene.
Era un posto tutto loro, una specie di luogo protetto, magico, dove potevano parlare di tutto e dove tutto diventava importante.
Un posto dove sentirsi grandi.
perdifiato: senza avere più fiato. aia: spiazzo delle cascine.
Sottolinea tutti i verbi al tempo imperfetto indicativo. Ricopiali sul quaderno volgendoli al tempo passato prossimo.
TROVARE UN AMICO
Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare mio amico, ma non ebbi dubbi sul fatto che, prima o poi, lo sarebbe diventato. Fino al giorno del suo arrivo io non avevo avuto amici. Nella mia classe non c’era nessuno che potesse rispondere all’idea che avevo dell’amicizia, nessuno che ammirassi davvero o che fosse in grado di comprendere il mio bisogno di fiducia, di lealtà.
I miei compagni mi sembravano tutti, chi più chi meno, piuttosto goffi, privi di immaginazione. Erano ragazzi simpatici e io andavo abbastanza d’accordo con tutti. Ma così come non ero animato da particolari simpatie nei confronti di nessuno, nemmeno loro sembravano attratti da me.
Il problema era come attirare l’attenzione di Konradin; avvertivo infatti istintivamente che avrei dovuto trovare il modo di farmi notare.
L’occasione capitò durante le poche ore destinate all’educazione fisica.
Il professore di ginnastica era un ometto energico e chiassoso. Si chiamava Max Loher, meglio conosciuto come Max Muscolo, e perseguiva con ardore l’obiettivo di svilupparci il torace, le braccia e le gambe nel poco tempo a sua disposizione.
Dopo una prima fase di riscaldamento, Max Muscolo andava al suo strumento preferito, la sbarra fissa e si esibiva in alcuni esercizi che, eseguiti da lui
sembravano facili come saltare la corda, mentre alla prova dei fatti si rivelavano estremamente difficili.
Quella volta, appena Max terminò la sua esibizione, mi feci avanti e lo fissai dritto negli occhi. Esitò qualche istante, poi disse: «Schwarz».
Mi avvicinai lentamente alla sbarra, mi misi sull’attenti e balzai in alto.
Mi appoggiai, come lui, all’asta e mi guardai attorno. Sotto di me vidi Max, pronto a intervenire in caso di necessità . I miei compagni mi osservavano in silenzio. Mi protesi prima verso sinistra, poi verso destra, poi mi lasciai penzolare tenendomi con le gambe piegate e presi ad oscillare finché, con un ultimo slancio, tornai ad appoggiarmi alla sbarra. La paura era sparita, sostituita da un unico pensiero: dovevo farlo per lui. Tutt’a un tratto mi sollevai in verticale, mi lanciai oltre la sbarra, e… bum! Almeno ero tornato con i piedi per terra.
Si udirono delle risatine represse, ma poi qualcuno batté le mani. Dopotutto, non erano cattivi i miei compagni… Rimasi immobile e voltai gli occhi verso di lui. Inutile dire che Konradin non aveva riso. Per la verità non aveva nemmeno applaudito. Ma mi guardava. Tre giorni dopo, il quindici marzo, stavo tornando a casa da scuola. Era una sera primaverile, dolce e fresca. I mandorli erano in fiore, i crochi avevano già fatto la loro comparsa, nel cielo si mescolavano il blu pastello e il verde mare. Davanti a me vidi Konradin; pareva esitare come se fosse in attesa di qualcuno. Rallentai – avevo paura di oltrepassarlo – ma dovetti comunque proseguire perché sarebbe stato ridicolo non farlo e lui avrebbe potuto fraintendere la mia indecisione. L’avevo quasi raggiunto, quando si voltò e mi sorrise. Poi con un gesto stranamente goffo ed impreciso, mi strinse la mano tremante. «Ciao, Hans» mi disse e io all’improvviso mi resi conto con un misto di gioia, sollievo e stupore che era timido come me e, come me, bisognoso di amicizia.
Non ricordo più ciò che mi disse quel giorno, né quello che gli dissi io. Tutto quello che so è che sentivo che quello era solo l’inizio e che da allora in poi la mia vita non sarebbe più stata vuota e triste, ma ricca e piena di speranza per entrambi.
Fred Uhlman, L’amico ritrovato, Feltrinelli
goffi: impacciati. protendersi: tendersi in avanti. crochi: specie di fiore viola, giallo.
Racconta un’amicizia inaspettata. SCRIVI TU!
Dopo aver riletto Trovare un amico, rispondi alle domande.
1. Di cosa parla il racconto?
2. Chi sono i due protagonisti?
3. Sottolinea nel testo la frase che ti colpisce maggiormente; ricopiala, poi spiega il motivo della tua scelta.
Questa frase mi è piaciuta perché…
4. Il racconto si conclude con questa affermazione: «La mia vita non sarebbe più stata vuota e triste, ma ricca e piena di speranza per entrambi».
Chi fa questa affermazione?
Cosa significa, secondo te?
NEL PARCO CON CARMEN
Uscito di casa, andai verso la ferrovia, dove il nonno mi portava quando ero piccolo. Volevo veder passare un treno, uno qualsiasi. Cominciai a correre finché arrivai al terrapieno dove passava la ferrovia. Iniziai a salire.
Ero così contento che quando riuscii ad arrivare in cima sollevai le braccia e gridai come se avessi appena conquistato una medaglia alle Olimpiadi. Allora me ne accorsi: la ferrovia non c’era. Chiusi gli occhi, me li stropicciai con forza e guardai di nuovo… ma la ferrovia continuava a non comparire. E mentre me ne stavo lì con la faccia da tonto a guardare per terra chi comparve? La Carmen! Carmen è una bambina della mia classe, ma non è una bambina qualsiasi. Carmen è… Come spiegarlo?
Per esempio, se la maestra, all’improvviso, ha bisogno di un dizionario, Carmen ne ha uno sul banco; se ci interroga a sorpresa su un argomento di cui nessuno si ricorda nulla, Carmen se lo è ripassato la sera prima. Se giochiamo a pallacanestro maschi contro femmine, Carmen fa un sacco di canestri. In più è quella che disegna meglio di tutta la classe. Insomma a noi ragazzi Carmen fa venire un nervoso…
«Ehi, che ci fai tu qui?» disse Carmen. «Speravi di veder passare qualche treno? Ah, ah, ah!».
Era piegata in due dal ridere. Io continuavo a non capire un bel niente, ma mi dava fastidio che mi stesse ridendo proprio sulla faccia.
«Non sai che ormai da quasi un anno il treno non passa più di qui?».
Carmen era così. Sapeva tutto. Non solo non avrei visto passare nessun treno; in più avevo fatto una figura davvero ridicola. Mi venne voglia di mettermi a correre, ma feci soltanto un mezzo giro su me stesso e mi allontanai da lei, con calma, senza dirle nemmeno ciao.
«Ehi, che ti prende? Dai, non arrabbiarti… Che cosa ci fai da queste parti?».
«Oh, beh… stavo passeggiando. E tu?».
«Oh, beh… anch’io…».
Scendemmo entrambi dal terrapieno e cominciammo a camminare nel parco.
«Sei venuto da solo?».
«Ma certo» risposi, dandomi un po’ d’importanza «sono già grande».
«Anch’io sono venuta da sola».
Lo vedete? Carmen è fatta così. Qualunque cosa tu faccia, anche lei la fa almeno bene quanto te…
«Ma sicuramente io abito più lontano» aggiunsi.
«Ah, è poco ma sicuro. Io abito lì, vedi?».
E mi indicò una casa molto vicina, proprio di fianco al posto dove prima c’era la ferrovia.
«Davvero abiti lì? Che fortuna! Avrai visto passare moltissimi treni» le dissi, con un po’ di invidia.
«Certo, li vedevo tutti. Tutti i macchinisti mi conoscevano e mi salutavano quando passavano».
Non avevo mai parlato così a lungo con Carmen. E mi resi conto che se anche mi faceva venire il nervoso, mi piaceva molto parlare con lei.
Stavo per dirle che mio nonno era stato macchinista, ma non lo feci, perché di sicuro lei se ne sarebbe uscita dicendo che il suo era stato capostazione.
«Immagino che abitando così vicino potrai scendere a giocare nel parco tutte le volte che vuoi».
«Certo» rispose Carmen.
«Sono sicuro che sai anche quanti alberi ci sono».
«Certo, sono duemilacentosedici» sorrise. «No, non li ho contati io.
Lo hanno fatto dei vecchietti che vengono qui per passare il tempo. Non ho dovuto fare altro che chiederglielo».
Accidenti alla Carmen! Non potete negare che sia davvero sorprendente.
Fernando Lalana, Il segreto del parco incantato, Piemme
terrapieno: zona piana. macchinisti: conducenti del treno.
1. Come definiresti Carmen in poche parole o con un aggettivo?
2. Perché il protagonista si offende?
3. Che cosa, secondo te, permette a due tipi così diversi di conversare?

NON CEDERE!
Caro amico, anch’io alla tua età volevo smettere di nuotare. Ho sempre amato lo sport, eppure a un certo punto sentivo come te il peso degli allenamenti e delle gare. Ho superato quei momenti e dopo alcuni anni sono diventato campione del mondo, anche grazie all’entusiasmo dei miei genitori e degli amici. Devi sapere che uno dei valori più importanti dello sport è proprio l’amicizia. Se sceglierai di smettere, un giorno potresti rimpiangere le amicizie sincere che, nello sport, lo sono più che altrove, e la possibilità di conoscere tanti ragazzi della tua età, nuovi ambienti e nuove città. Oggi ti potrai sentire stanco, ma domani potrai essere soddisfatto di aver fatto tanti sacrifici in piscina. Se avrai fortuna, come me, di arrivare a grandi risultati, di conquistare una medaglia, sarai ripagato con emozioni forti e uniche. Altrimenti sarai comunque contento di aver imparato a lottare contro le difficoltà e ti sentirai cresciuto. Prova ancora una volta, non cedere. Se i tuoi genitori insistono, come hanno fatto i miei genitori e per questo li ringrazio, lo fanno perché sanno cosa vuol dire lo sport e quanto è importante per la salute. Se avrai bisogno di altro aiuto, cercami. Sono a tua disposizione. Non mollare, faccio il tifo per te.
Giorgio Lamperti, «Popotus» 63 (1977)

IL PORTIERE E L’ERBA
Ho sempre giocato per me stesso.
Andavo in campo e m’inebriava il gusto di sapermi lì, isolato in quella porta, da solo. Poi un giorno è finita. E, quando è finita, mi sono accorto che c’era almeno un altro motivo per cui mi piaceva quello che facevo: il profumo dell’erba.
Solo i portieri sanno che questa non è una frase retorica.
Perché solo i portieri sanno cosa significa davvero il profumo dell’erba.
Gli altri calciatori non ne hanno idea. Perché loro sull’erba corrono, al massimo ogni tanto scivolano oppure, oggi, si rotolano un po’.
Ma il portiere no.
Il portiere ci lavora con l’erba. E praticamente ogni suo gesto, ogni suo intervento finisce sempre allo stesso modo, con il naso dentro l’erba.
E così, piano piano, quell’odore vegetale tanto intenso, pulito e infantile si stratifica sopra tutte le altre sensazioni; l’eccitazione dell’adrenalina, le nevrosi della paura, gli spasimi di dolore avranno per me sempre quell’odore.
E allo stesso modo l’erba vorrà sempre dire eccitazione, paura e dolore.
Dino Zoff, Dura solo un attimo, la gloria. La mia vita, Mondadori
nevrosi: insieme di disturbi. spasimi: sofferenze.
SCRIVI TU!
Anche tu pratichi un’attività sportiva?
Racconta la tua esperienza e descrivi un particolare per te importante.
FARE SQUADRA!
Quando Julio Velasco, allenatore argentino capace di conquistare quattro scudetti consecutivi con la pallavolo Modena, prese in mano la Nazionale italiana, era necessario rifondare da zero un intero mondo, quello del volley.
Tutto iniziò nel 1989. La prima domanda che l’allenatore fece alla squadra e ai dirigenti fu: «Perché perdiamo sempre?». Qualcuno rispose che la colpa era del fatto che gli Italiani riescono bene in giochi come il calcio, ma la pallavolo che richiede concentrazione non fa per loro. Altri dissero che dipendeva dall’educazione fisica nelle scuole. Altri ancora sostennero che chi perde sempre, difficilmente comincia a vincere.
«Tutte scuse!» disse Velasco, arrabbiandosi. Lo guardarono sorpresi. «Nessuno pensa che la spiegazione sia semplicemente che gli altri giocano meglio e noi peggio. Forse dovremmo solo imparare a giocare meglio. Imparare in cosa gli altri sono più forti di noi». Era un ragionamento semplice che escludeva le scuse, gli alibi.
L’alibi è un pretesto, una giustificazione per non assumersi la colpa di qualcosa, di un errore, ad esempio. Ecco, in Italia si cercavano scuse per spiegare perché non si vinceva anziché soluzioni.
Velasco, l’allenatore, spiegò ai suoi giocatori che sbagliare era normale, non era sinonimo di stupidità o di inadeguatezza o di fallimento. «L’errore» ripeteva sempre «fa parte di un percorso di miglioramento. Quando si capisce di aver sbagliato per migliorare è necessario cambiare».
Una delle cose che non volle più sentire in campo era un giocatore che incolpava un altro di aver sbagliato, anche quello era un alibi. «Quando si dà la colpa al compagno, al pubblico, all’arbitro, alla stanchezza, si pensa di non dover cambiare nulla. Invece, quando si sbaglia, si deve cambiare qualcosa. Ognuno, quindi, deve pensare a fare il proprio lavoro al meglio».
Un altro aspetto che Velasco curò nei dettagli fu la convinzione in sé stessi e nella propria squadra, dimostrò ai giocatori che potevano essere più forti e determinati di quanto credevano. «Finché non è finita. Non è finita!» era uno dei suoi motti.
Ci voleva dunque più fiducia in sé stessi, nell’allenatore, nella squadra.
«Quando c’è un errore,» diceva «si deve capire cosa fare, ma tutti insieme come squadra. Fare “gioco di squadra” vuol dire avere tutti lo stesso obiettivo, avere ognuno il proprio ruolo e soprattutto rispettare quello degli altri. Non si deve dire allo schiacciatore come
schiacciare se si è un palleggiatore e il premio finale per tutti è la vittoria». Serviva dunque una mentalità vincente e Velasco la creò dal nulla.
Tutto questo, e forse molto altro, contribuì a formare una squadra incredibile che nel giro di un anno cominciò a vincere tutte le competizioni alle quali partecipava. Dal 1990 al 1996, la Nazionale di Velasco salì sul tetto del mondo vincendo quasi tutto: una Coppa del mondo, tre ori europei, due mondiali, cinque World League.
Nel 1996, Julio Velasco decise di lasciare la nazionale che, grazie a lui, era diventata una vera squadra.
La partita spesso è contro i nostri difetti e i nostri limiti, non tanto contro l’avversario.
SCRIVI TU!
Racconta un episodio di gioco, di sport o di lavoro in cui “hai fatto squadra”.

UN CAMPIONE… DI FAMIGLIA
Ognuno dei suoi allenatori lo ha detto e ribadito: «Una delle grandi fortune di Jannik è la famiglia, con i valori che gli ha trasmesso». E infatti proprio dal papà, cuoco di un rifugio montano, e dalla mamma, professione cameriera, Sinner ha imparato la cultura del lavoro, l’impegno e l’umiltà. Non è un caso che, seguendo l’esempio dei genitori, appena guadagnati i primi soldi con i tornei, abbia voluto per prima cosa comprarsi una macchina per incordare le racchette. Perché a casa la mentalità è questa: autonomia e nessuno spreco.
Il fratello maggiore, Mark, è anche amico e confidente. Mark è come il resto della famiglia, non ama apparire, lavora come istruttore dei Vigili del Fuoco e per il fratellino campione è un grande punto di riferimento: «Lui è una persona su cui posso sempre contare». Amano passeggiare insieme in montagna nei pochi giorni in cui riescono a essere a casa, giocare a golf e magari fare qualche corsa sui kart, se possibile insieme al resto degli amici d’infanzia. Sempre loro, sempre gli stessi, quelli con cui si fa fotografare sul cucuzzolo di qualche montagna a fare un picnic o su una pista con casco e tuta. La natura e gli affetti, niente di più. Sono sempre le cose semplici che fanno grande un campione.
«La Gazzetta dello Sport», 27 novembre 2023
Che cosa ha fatto Sinner con i primi soldi guadagnati nei tornei?
Perché ha fatto quell’acquisto? Pensi che abbia fatto bene?

RONALD HA ROTTO LA CASSETTA K7
Appena entro nell’aula serpeggia la notizia: Ronald ha rotto la cassetta K7 della lezione di musica (questa cassetta è molto importante perché lì sono registrate tutte le canzoni imparate durante l’anno).
Questo fatto diventa l’avvenimento del giorno e tutti vogliono darmene notizia. Solo Ronald, triste, non si muove. «Sì, realmente, è molto spiacevole» dico.
Rimango per un momento a pensare al da farsi.
Sostituire semplicemente la cassetta con una nuova non mi sembra la forma migliore per far loro capire che le cose hanno valore.
Chiedere a Ronald di pagare la cassetta non è giusto dal momento che tutti in classe sono creatori di caos.
Dare una sgridata neppure, non è nel mio stile, anche perché certamente la maestra ha già reagito arrabbiandosi… Così mi passa per la testa qualcosa che mi sembra ragionevole.
Dico che tutti potremmo aiutare Ronald a comprare una nuova cassetta: ciascuno porterebbe una monetina e riuniremmo i risparmi. Per incentivarli prendo alcune monete dalla mia borsa e le consegno a Ronald.
Subito i bambini cominciano a dire che i genitori non hanno soldi e che loro non possono contribuire. Esco dall’aula triste, pensando a come talvolta i bambini siano crudeli! Penso che sperassero che io castigassi Ronald.
Tuttavia, due settimane dopo il fatto di cui mi ero quasi dimenticato, appena entro nell’aula mi accorgo di un clima veramente euforico: nel mezzo del tumulto vedo Ronald che ha le mani piene di monete ricevute dai compagni per comprare la cassetta. Il suo volto si è trasformato e tutta la classe è contenta e orgogliosa.
Anch’io sono felice!
Marco Aurélio Cardoso de Souza, Paolo Amelio, Come può il cielo avere tante stelle? Non è solo mezz’ora di canto, Itaca
SCRIVI TU!
Racconta in tre tappe (tre frasi) che cosa è successo.
INCON T R I AMO LA POESIA
L’AMICIZIA
Non sai nemmeno come dirla, non si riesce a dipingere o a ritrarla.
Inutile che ti metti a spingere, non vengon le parole e nemmeno la punteggiatura.
È quella forza bella, sicura che viene come nella nebbia il sole.
Non sopporta avverbi ed aggettivi, l’amicizia ha solo nomi propri e soprannomi e occhi vivi.
Davide Rondoni
LO SKATEBOARD
È una tavola, si va come sull’onda nel mare che circonda, si va veloci, l’aria tra i capelli uno dei mille giochi più belli.
Sullo skate si traballa, si sguilla si piroetta e si sbirilla.
La strada diviene pista, si supera anche il ciclista.
Ci si può pure sbucciare e così più forti diventare.
Davide Rondoni
LA BICICLETTA
Bicicletta due ruote leggere due pensieri rotondi pieni di luce per capire la strada e sapere dove conduce.
Bicicletta due ruote sottili due idee rotonde piene di vento per pensare discese e sapere la gioia e lo spavento.
Bicicletta due ruote leggere due parole rotonde piene di festa per parlare col mondo e sapere quanto ne resta.
Roberto Piumini
FILASTROCCA DELLA
GIOIA DI RIVEDERE
GLI AMICI
Forte il mio cuore leva il suo canto, perché io non ti vedevo da tanto. Notte più bella, giorno più bravo perché era tanto che non ti abbracciavo. Corvi di nuvole volano via perché finisce la mia nostalgia.
Bruno Tognolini
COME UN POETA
La strofa di una poesia è costituita da un certo numero di versi disposti uno di seguito all’altro. Le poesie comprendono solitamente un certo numero (variabile) di strofe. Un insieme di due soli versi si chiama dìstico (dal greco duo = due e stykos = verso).
Riconosci le strofe nelle poesie della pagina precedente.
Prova a completare il distico, trovando la rima:
Ovunque l’occhio giri l’hai di fronte il vasto irraggiungibile
Con una barca tu puoi ben solcare col vento in poppa l’infinito
A mezzanotte disteso su un prato guardo incantato un bel cielo
Mi aiuta tanto quando son di fretta la mia fedele cara
Mi dà conforto, se mi sento affranto, ascoltar melodioso un dolce
Più bella sei, se dagli ospiti invasa, mia cara dolce, dolcissima
Trova tu un aggettivo adatto per completare.
Funziona meglio se è ben appuntita la mia sottile matita.

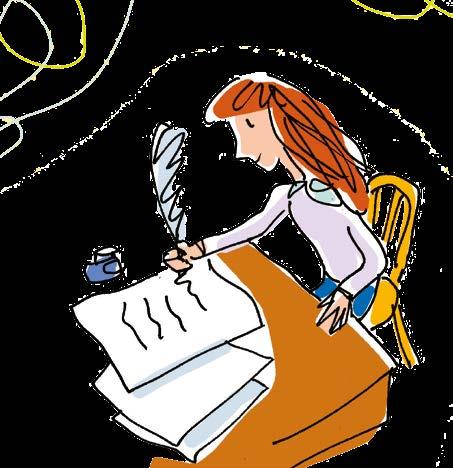
IL M O N D O DEGLI ANIMALI
Canto
Samba
per gli animali
Il gusto di una compagnia con la diversità e originalità di ciascuno e con un sogno comune: un futuro libero in compagnia dei suoi amici.
Samba per gli animali… cantare altro io non so: samba per gli animali rinchiusi dentro uno zoo.
Il volo del calabrone
Questa musica, che fa parte della bella fiaba russa Lo Zar Saltan, racconta del momento in cui lo zar è stato trasformato in calabrone e si aggira in una sala del palazzo per ascoltare di nascosto i discorsi dei suoi avversari. Si alternano momenti in cui il calabrone gira in tondo, altri in cui curva di colpo, cambiando repentinamente direzione, ed altri ancora in cui si avvicina e si allontana dalle persone intorno a lui.

UN VERO CAPOLAVORO
In autunno, molti animali si ritirano nelle tane. Tra di essi vi è anche la marmotta che sa prepararsi una tana che è un vero capolavoro.
La tana della marmotta, infatti, non è un semplice buco nel terreno, ma un insieme di stanze unite fra loro da numerosi corridoi, grandi e piccoli, che si snodano sotto la superficie erbosa a una profondità di circa un metro e mezzo.
All’interno non manca niente: ci sono stanze con la “tappezzeria” di fieno, “servizi” indipendenti, uscite di sicurezza, perfino un ingegnoso sistema per il condizionamento dell’aria.
Ma procediamo con ordine, e proviamo anche noi a seguire il roditore dentro “casa”. Il corridoio che s’incontra in principio è un po’ stretto.
Poi, a poco a poco, si allarga così da permettere a due marmotte di avanzare insieme. Dopo circa dieci metri si arriva ad una camera ovale. È il cuore dell’abitazione, il salotto e la stanza da letto degli adulti, e i roditori, per renderla più confortevole, la foderano interamente d’erba. Fra questa stanza e l’entrata della galleria, vi sono quattro “tappi” dello spessore di 30-40 centimetri, alcuni impastati di fieno e di terra, altri fatti di solo fieno o di sola terra. La loro funzione è in parte ancora misteriosa. Si sa però che prima di cominciare il letargo, la marmotta li chiude tutti dietro di sé.
Non tutti i problemi sono risolti: occorrono locali per i bambini e per gli anziani. Ed ecco la camera da letto dei piccoli e, per ogni vecchio, una celletta singola. Ogni locale, naturalmente, è dotato di “servizi” indipendenti ed è munito di una “porta” di terra che l’animale apre e chiude quando si serve di essi.

D’inverno, in alta montagna la temperatura può scendere a trenta gradi sotto zero. Per certi animali è il pericolo di morte per congelamento. La marmotta, invece, non ha nulla da temere dal freddo: lo strato di terra gelata e la coltre nevosa che ricoprono il terreno isolano la sua tana.
Nelle profondità segrete delle gallerie, la temperatura si mantiene intorno ai tre gradi e c’è un naturale sistema di condizionamento d’aria così perfetto che, dopo sei mesi di letargo, il fieno è freschissimo e profuma di montagna come fosse appena raccolto. «Epoca» si snodano: seguono un percorso sinuoso, tutto a curve.
Dopo aver riletto Un vero capolavoro, rispondi alle domande.
1. Metti la crocetta giusta nella tabella.
La tana della marmotta… V F
è un semplice buco nel terreno. ⬜ ⬜
è un vero capolavoro. ⬜ ⬜
è un insieme di stanze unite tra loro da numerosi corridoi. ⬜ ⬜
è dotata di un corridoio che si allarga a poco a poco verso l’interno.
è dotata di un corridoio che si stringe a poco a poco verso l’interno.
è provvista di un sistema ingegnoso per il condizionamento dell’aria.
2. Qual è il cuore dell’abitazione della marmotta? Di cosa si tratta?
3. Quando d’inverno, in alta montagna, la temperatura scende a trenta gradi sotto zero, la marmotta è in pericolo di morte?
Metti una crocetta e spiega il perché della tua risposta.
Sì, perché
No, perché
4. Perché la tana della marmotta è definita «un vero capolavoro»?
5. Dizionario. Cerca il significato della parola capolavoro.
⬜
⬜
I SEGRETI DEL VOLO

Hai mai pensato a quanto avviene nel corpo di un uccellino quando spicca il volo?
L’uccello ha un ostacolo da vincere: l’aria. La deve tagliare e mandare indietro. Apre le ali e il suo corpo immediatamente cambia forma: era un batuffolo di piume sul ramo, ora ha le ali distese che si muovono su e giù scalando l’aria.
Il suo corpo è contratto e pare rimpicciolito. Ossa, muscoli, nervi, piume e penne sono in azione. Sì, anche tutto il piumaggio. È come una navicella volante con un gran numero di vele sensibilissime al movimento dell’uccello.
Le vele sono le penne e, in parte, anche le piume. Poi ci sono i timoni: le penne della coda. Piume e penne lavorano in pieno accordo obbedendo al comando che viene dall’interno.
Ma non basta avere penne e ali per volare, ci vuole anche il motore che dia la spinta. Nell’interno del corpo dell’uccello che vola sono in azione ossa, muscoli e nervi. Come nel corpo umano, in cui le ossa sono le leve e i muscoli le mettono in moto. La funzione motrice viene, dunque, dai muscoli. Però, come in qualsiasi motore meccanico non può mancare ciò che produce il moto e regola la velocità, così, negli animali, impulso e controllo del moto sono regolati dal cervello.
Il cervello è, dunque, per quanto si riferisce al movimento dell’animale, una centrale perfetta, automatizzata, dalla quale partono e arrivano, in continuazione, comunicazioni con straordinaria rapidità.
Quanto preziosa è la vita, se anche quella di un uccello è così sapientemente congegnata per le sue necessità e per la sua difesa.
funzione motrice: capacità di produrre movimento.
1. Qual è l’ostacolo che deve vincere un uccellino quando spicca il volo?
A. La fatica.
B. La paura.
C. L’aria.
2. Qual è la similitudine usata nel brano per descrivere l’uccellino in volo?
3. Le “vele” della navicella volante a quale parte del corpo dell’uccellino corrispondono? E i “timoni”? E il “motore”?
4. Qual è la similitudine che viene usata per indicare il cervello dell’uccellino, al quale arrivano e da cui partono di continuo e con rapidità tante comunicazioni?
UN NIDO SUL GRATTACIELO
Un attico con vista mozzafiato a 127 metri d’altezza: è il nido d’amore di Gio e Giulia, una coppia di falchi pellegrini “urbani” che dal 2017 ogni anno, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo torna in cima al Grattacielo Pirelli, per nidificare.
I falchi pellegrini in realtà frequentano Milano da alcuni anni, ma è solo nel maggio del 2014 che si ha la prova certa della loro nidificazione: due pulcini vengono casualmente ritrovati durante dei lavori di manutenzione al piano dei servizio tecnici, nel sottotetto del Grattacielo Pirelli dietro al motore di un condizionatore in disuso.
Il tecnico, artefice dalla scoperta, fotografa con il cellulare i due “strani pulcini bianchi ” e mi mostra la fotografia; salgo immediatamente al piano e trovo due pulli impiumati in una posizione disagiata.
Nell’anno successivo scelgo di costruire una cassetta nido che nel 2016 vede la prima occupazione da parte della coppia di falchi.
È solo però dal 2017 che si inizia a monitorare la situazione tramite la webcam collegata ad una connessione internet ed ecco cosa si osserva:
Tra gennaio e febbraio: prime ispezioni del nido da parte del maschio.
14 febbraio: corteggiamenti e scambio di cibo da parte di Gio a Giulia.
10 marzo: deposizione primo uovo.
12 marzo: secondo uovo.
14 marzo: terzo uovo.
16, 17 e 18 aprile: schiusa delle uova.
I falchetti sono pronti al volo dopo circa quaranta giorni!
Diventati ormai ospiti abituali, i falchi pellegrini dispongono ora di un nido artificiale, una vasca in legno con un letto di ciottoli adatta a ospitare la cova. Questo affascinante spettacolo di natura si ripete ogni anno, da quando i due falchi, Gio e Giulia, hanno fatto del tetto del consiglio regionale della Lombardia il loro “nido”.
La coppia di falchi ormai “abitante storica” del Pirellone sono stati chiamati così in ricordo di Gio Ponti, l'architetto che aveva firmato il Pirellone, e della moglie.
Guido Pinoli, tecnico faunistico della Regione Lombardia
pullo: piccolo di animale.



Anzi, c’è spesso, nel comportamento di molti, qualcosa che assomiglia alla comunicazione del pensiero tra gli uomini.
Un singolare linguaggio degli animali è quello delle api, scoperto dallo scienziato naturalista Frisch.
Sapete come si esprimono le api? Ballando!
Proprio così: quando un’ape ha scoperto una buona distesa di fiori, ritorna all’alveare e fa un giro completo su sé stessa, ripetendo questa danza per qualche minuto. Le altre api allora le si avvicinano e assaggiano un po’ del nettare portato da questa come campione della propria scoperta.
Subito dopo si dirigono tutte verso la zona trovata.
Se invece del nettare l’ape operaia trova del polline, allora traccia due semicerchi, poi zampetta e si agita: anche questa volta molte compagne la circondano e, guidate dal profumo del polline, si orientano verso la “miniera”.
Ma se vi capitasse di vedere un’ape che va a zig-zag, lasciatela in pace; vuol dire che è incollerita, dispostissima perciò ad affondare il suo pungiglione aguzzo nelle vostre carni!
Che cos’è la “miniera”? Perché viene chiamata così?
I GIRINI
Che cosa c’è di più affascinante di un girino? Lì, in quei pochi millimetri, è nascosto tutto il segreto della vita: venire al mondo come una minuscola virgola e poi diventare un essere con quattro zampe e un caratterino ben definito, capace di saltare fuori dall’acqua. Non accade anche a noi la stessa cosa? Prima nuotiamo nella pancia di nostra madre, poi usciamo e abbiamo un volto, un nome, un misterioso destino che ci attende.
Che vita faranno i girini nei mesi seguenti? Quella spensierata di tutti i cuccioli. Riuniti in piccole e vivaci «nubi» nere, passano il tempo pascolando tra le alghe e schiacciando pisolini nascosti sul fondale. A differenza dei girini di rana, i piccoli di rospo godono già della protezione degli adulti e della loro ghiandola tossica, per questo si muovono subito con baldanza tra le ninfee, senza timore dei predatori. La loro infanzia durerà tra i due e i tre mesi. Prima spunteranno le zampe posteriori, poi quelle anteriori. La coda sparirà per ultima. Non cade ma semplicemente – si fa per dire – viene riassorbita dal corpo. Entro la fine di giugno, usciranno dall’acqua e, fino al momento della rìproduzione, tre anni dopo, non vi metteranno più zampa. Quanto vive un rospo? In libertà, i più longevi raggiungono i dieci anni, in cattività superano tranquillamente i trenta. Fortunato l’orto in cui abita un rospo! A lui piace tutto ciò che a noi orticoltori non piace: lumache, mosche, formiche, ragni, coleotteri. Benvenuti dunque i rospi! I vostri appetiti sono la nostra salvezza. A chi, per la sua espressione imbronciata, lo ritenesse privo di passioni, dirò che di fronte a qualcosa di succulento da mangiare, i battiti del suo cuore subiscono una gioiosa accelerazione, come succede a noi davanti alla vetrina di una pasticceria. Yum-yum!

IL FORMICALEONE
In un angolo del cortile i muratori avevano lasciato un po’ di sabbia che poi la pioggia aveva sparso. In quella zona sabbiosa un mattino trovai alcuni cerchi perfetti scavati nella sabbia, a forma di imbuto. Erano vicini e sembravano tanti crateri di vulcani spenti. Chi li aveva fatti?
Curioso mi avvicinai e scoprii che sul fondo dell’imbuto di sabbia c’era qualcosa: con uno steccolino spostai la sabbia e vidi che sotto, nascosto, c’era uno strano animaletto armato di tenaglie a punta, frastagliate come piccoli denti, sulla pancia, sul torace e sulla testa. Che ci faceva lì?
Non passò molto tempo che scoprii anche questo: infatti passava di lì una formica rossa che, arrivata sul bordo dell’imbuto, si fermò a osservare. In quel momento dal fondo partì una raffica di granellini di sabbia che fecero franare la parete dell’imbuto e cadere dentro la formica. Fu un attimo: l’insetto la afferrò con le tenaglie e sparì. Dopo un po’ la sabbia si mosse e l’insetto buttò fuori i resti della formica morta.
Allora capii che cosa erano quei cerchi a imbuto nella sabbia: erano trappole costruite da insetti cacciatori che si procuravano così la colazione.
Volevo osservare altre scene di caccia ma arrivò il cane, che cominciò a trafficare lì intorno, e poi le galline presero a razzolare, e in poco tempo tutti i cerchi perfetti furono distrutti. «E adesso –mi chiedevo – che faranno quegli insetti cacciatori? Moriranno di fame?».
Il mattino dopo, prima che la mamma liberasse le galline dal pollaio e mentre il cane era ancora chiuso, andai a vedere: i cerchi erano stati rifatti e i cacciatori erano in fondo all’imbuto, pronti all’attacco.
Vedere la caccia alle formiche e ai ragnetti che capitavano sull’orlo dell’imbuto era uno spettacolo: non appena la preda era a tiro, partiva la raffica, l’animaletto precipitava e il cacciatore di scatto balzava fuori dal nascondiglio e lo stringeva fra le robuste tenaglie. E se lo mangiava, o meglio lo succhiava, perché poi buttava fuori i resti. E ricominciava.
Tutte le volte che mi alzavo presto il mattino, andavo là a vedere le scene di caccia. Ma venne un tempo che i cerchi a imbuto nella sabbia non li trovai più. Eppure le formiche e i ragnetti e
altri animaletti giravano ancora nella zona.
Vedevo invece volare, lì intorno, certi insetti eleganti, dalle lunghe ali macchiate e col corpo cilindrico, che assomigliavano alle libellule blu. E non sapevo che quell’insetto bellissimo con le ali era il formicaleone, il cacciatore dai cerchi a imbuto che da larva vorace si era trasformato in un insetto volante.
razzolare: scavare. vorace: affamato.
SCRIVI TU!
Ti è capitato di osservare il movimento di un insetto, di un uccello o di un animale domestico? Racconta.

MONNA TEOFILA
E IL PAPPAGALLO
Una volta uno dei nostri amici, che partiva per qualche giorno, ci affidò il suo pappagallo perché lo custodissimo durante il periodo dell’assenza.
L’uccello, trovandosi certo un po’ spaesato, era salito, con l’aiuto del suo gran becco, fin sulla cima del trespolo; e volgeva attorno con aria piuttosto sbalordita due occhi simili a borchie di poltrona. Monna Teofila, la gatta, non aveva mai visto un pappagallo e codesto animale, nuovo per lei, le causava una sorpresa evidente. Immobile come un gatto imbalsamato d’Egitto guardava l’uccello con un’aria di meditazione profonda, cercando di richiamare alla memoria tutte le nozioni di storia naturale che aveva potuto apprendere sui tetti, nella corte e in giardino.
«Decisamente è un pollo verde».
Persuasa di ciò, la gatta saltò giù dalla tavola sulla quale aveva stabilito il suo osservatorio e andò a porsi in un angolo della camera: ventre a terra, testa bassa, schiena tesa come una molla.
Il pappagallo seguiva i movimenti della gatta con inquietudine: arruffava le penne, alzava una delle zampe agitando le dita e passava e ripassava il becco sull’orlo della mangiatoia. Gli occhi della gatta, fissi
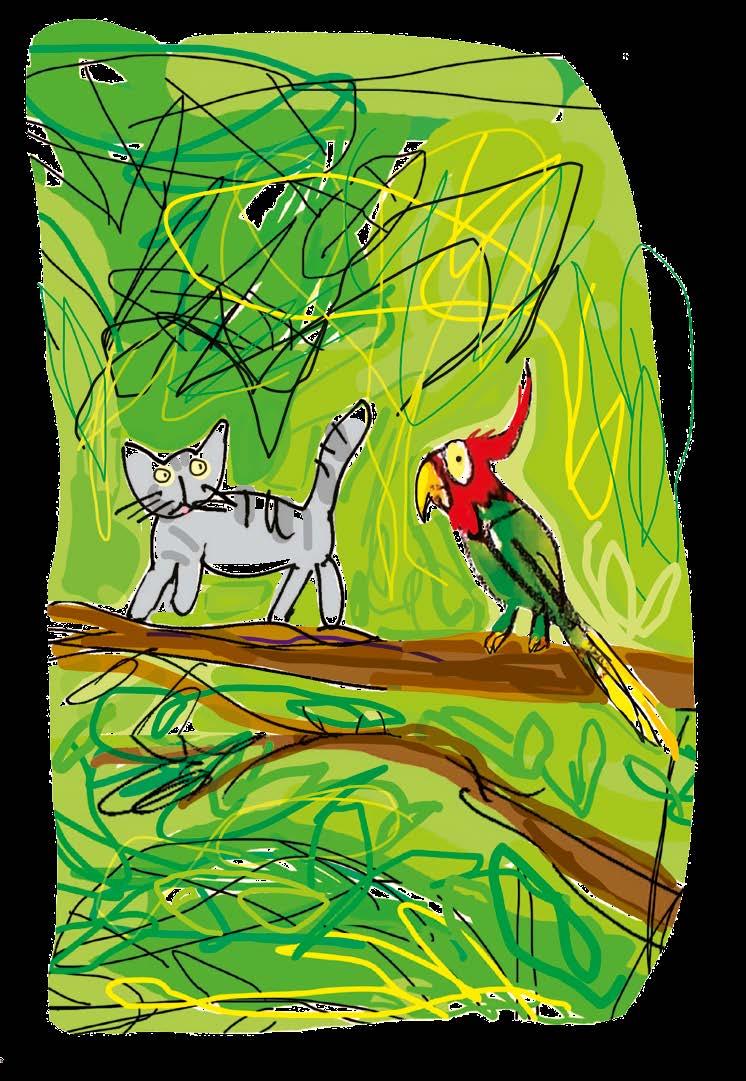
sull’uccello, dicevano in un linguaggio muto ma chiarissimo, e che anche il pappagallo doveva intendere a perfezione: «Sebbene verde, quel pollo dev’esser buono da mangiare».
Noi seguivamo la scena con interesse, pronti a intervenire se ve ne fosse stato bisogno. Monna Teofila si era insensibilmente avvicinata: gli occhi erano semichiusi, gli artigli apparivano e sparivano. Di colpo il suo dorso s’arrotondò come un arco teso ed un balzo vigoroso ed elastico la fece cadere proprio in cima al trespolo. Vedendo il pericolo, il pappagallo, con una voce grave e profonda, gridò improvvisamente: «Hai mangiato, Giacomino?».
Questa frase spaventò oltremodo la gatta che diede un balzo indietro. Tutte le sue idee ornitologiche erano scombussolate.
«E con che? Con l’arrosto del re?» continuò il pappagallo.
La fisionomia della gatta espresse chiaramente: «Non è un uccello. È un uomo! Egli parla!».
«Ho bevuto tanto che tutto gira intorno a me!» cantò l’uccello con degli scoppi di voce assordanti, giacché aveva compreso che lo spavento causato dalle sue parole era la migliore arma di difesa. La gatta gettò un colpo d’occhio pieno d’interrogazioni: ma non avendo ottenuto da noi risposta, andò a rifugiarsi sotto il letto. E di là non fu possibile farla uscire per tutta la giornata. Il giorno dopo Monna Teofila abbozzò un nuovo tentativo, ugualmente respinto. Dopodiché se lo tenne per detto e considerò il pappagallo un uomo anziché un uccello.
Théophile Gautier
Individua e cerchia una decina di coppie nome-aggettivo; poi abbina al nome un aggettivo diverso.
SCRIVI TU!
Rileggi facendo attenzione all’agire della gatta: in quante mosse perfeziona la sua caccia? Individua le sequenze delle sue azioni.
ATTERRAGGIO IN AUSTRALIA
Avevano percorso poco più di un chilometro, quando all’improvviso avvistarono un gruppo di canguri rossi che pascolavano tra gli alberi. Al loro avvicinarsi, il capobranco si rizzò sulle zampe posteriori. I ragazzi furono sbigottiti nel constatare quant’era alto: anche più di Lancelot. Canguro li squadrò con aria di superiorità.
«Ebbene, cosa potrei fare per voi?» chiese in tono professorale.
«Perbacco!» bisbigliò Emma, con una certa soggezione. Quindi aggiunse: «Potrebbe raccontarci qualcosa sul conto di voi canguri?».
«Naturalmente» disse lui. «Dunque, ci sono cinquantuno specie di canguri: i canguri giganti rossi, i wallabi e i canguri delle rocce (questi sono molto più piccoli di noi, naturalmente), poi i canguri-lepre, i ratto-canguri (che sono ancora più piccoli), i canguri arboricoli che, com’è ovvio, vivono sugli alberi…».
«Accipicchia!» lo interruppe frettolosamente Emma. «Non avrei mai immaginato che ci fossero tante specie diverse!».
«Possiamo dare un’occhiata a qualcuno dei vostri piccoli?» intervenne Ivan, prima che Canguro riprendesse la tiritera.
«Certamente» disse lui. Grugnì un ordine e tre femmine saltellarono gentilmente verso di loro. Dentro il marsupio foderato di pelliccia della prima femmina giaceva un neonato tutto rosa, non più grande di un fagiolo.
«Mamma mia com’è piccolo!» esclamò Emma, meravigliata.
«A quest’età è ancora cieco e può usare solo le zampe anteriori» spiegò Lancelot. «Eppure, non appena è nato, riesce ad arrampicarsi sul corpo della madre e a trovare il marsupio».
Il cucciolo della seconda femmina, sebbene ancora roseo e privo di pelo, era un po’ più grande e aveva un aspetto più da canguro.
Poi saltellò avanti la terza femmina: aveva il marsupio rigonfio e dall’orlo spuntava la testa del piccolo, orecchie ritte e occhi scintillanti. Si divincolò dal marsupio: era una versione in miniatura dei genitori, con la sua pelliccia fulva e la lunga coda.
Emma e Ivan lo accarezzarono con delicatezza.
sbigottiti: allibiti, stupiti. soggezione: timore. fulva: dorata, tendente al rosso.
Gerald Durrell, Un viaggio fantastico, Mondadori

Dopo aver riletto Atterraggio in Australia, rispondi alle domande.
1. Che cos’è un capobranco?
2. Spiega il significato della frase al terzo binario: «Al loro avvicinarsi il capobranco si rizzò sulle zampe posteriori»: per quale motivo il capobranco agisce così?
3. Qual è il significato della parola “tiritera”, in questo contesto? Prima di scegliere la definizione, sottolinea le parole, nel brano.
A. Serie di parole in rima.
B. Discorso lungo, noioso, ripetitivo.
C. Lagna, lamentela, sproloquio.
4. Che cosa fa l’ultimo piccolo di canguro, quando si “divincola”?
A. Si muove in varie direzioni.
B. Si libera con uno scatto.
C. Si scioglie dalla presa.
LA CAROVANA ALATA
Qui-quak
Quando mezzo disco di sole fu sparito sotto la liscia superficie del mare, un giovane papero della tribù delle oche selvatiche uscì cautamente dall’intrico delle canne.
Era nato in primavera, e aveva ancora sotto le ali gli spunzoni irti di nido.
Le penne per volare gli erano cresciute durante l’estate in sostituzione dell’arruffata camiciolina di lanugine, ma il papero continuava a seguire le abitudini dell’infanzia: sebbene potesse attraversare a volo con pochi colpi di ala i canneti, si ostinava a nuotare, immergendo il becco a destra e a sinistra per ingozzarsi d’erbe marce, con la speranza di trovare qualche boccone più saporoso, un pesciolino o un girino.
Era stato sempre solo, non sapeva nemmeno che cosa fosse uno stormo. Mamma oca era morta in una splendida giornata d’estate, in un pomeriggio tranquillo.
In queste ore le varie mamme oche conducono fuori dai nascondigli i paperini, e si avvicinano senza far rumore alle rive brulicanti di girini e di larve, lì a disposizione di tutti i becchi affamati.

Sette paperini seguivano mamma oca; Qui-quak era il quinto della fila e muoveva svelto svelto le zampette ancora deboli, cercando di tener dietro ai fratelli. Ogni tanto allungava il collo e scorgeva la grossa sagoma della madre che, in confronto alla prole, pareva un barcone seguito da sette barchettine gialle.
Avevano ormai attraversato una larga cintura d’acqua fonda e si erano avvicinate ai bassifondi vicino a riva, quando a un tratto un’ombra tagliò l’aria sopra di loro e due ali scure si pararono davanti a Qui-quak: erano le ali spiegate di un astore. Sotto quelle ali, in un groviglio di artigli, mamma oca…
In testa alla piccola famiglia non c’era più nessuno. Qui-quak adesso era solo: non c’era più davanti a lui il grosso corpo grigio della madre, dal quale si era sentito fino allora protetto. Adesso era solo: per la prima volta nella sua vita da solo doveva decidersi ad agire.
Si girò su sé stesso parecchie volte guardandosi intorno come se aspettasse qualcuno; non si decideva a muoversi.
La notte aveva già attutito il suono della palude con la sua coltre opaca e Qui-quak aspettava sempre e chissà fin quando sarebbe rimasto là, se non lo avesse riscosso il disperato grido d’uno dei suoi fratelli. Preso da un nuovo terrore Qui-quak si precipitò nel canneto.
Da quel giorno non aveva più abbandonato il suo rifugio perché, inesperto e pauroso, non avrebbe mai osato mettersi a battagliare con gli abitanti della palude.
Così cresceva poco. Non aveva il coraggio di volare in cerca degli altri e continuava a errare solitario.
L’autunno era ormai alle porte.
Vita nello stormo
Di molte cose si dovette stupire Qui-quak in quei primi giorni, mentre cercava di abituarsi alla nuova vita.
Si era aggregato allo stormo dopo un lungo periodo di solitudine.
La tribù delle oche selvatiche aveva una sua disciplina, seguiva delle leggi, vecchie come il mondo, che l’aiutavano a sopravvivere. Per imparare questo le oche non avevano dovuto nemmeno andare a scuola: lo facevano per istinto. Era stata la vita stessa ad insegnare loro che era più prudente vivere insieme.
Invece Qui-quak, benché fosse stato l’istinto a ricondurlo nello stormo, una volta dentro non ci si sapeva ritrovare. L’infastidiva soprattutto il fatto di dover obbedire a bacchetta, mentre prima faceva tutto a modo suo.
Il volo
All’alba lo stormo cominciò a prepararsi per il volo. Poco prima erano partite due vedette in direzione del fiume e Quek aspettava che tornassero per dare il segnale della partenza. Le sagome grigie delle due vedette si profilarono in cielo quando si era già fatto giorno. Lo stormo si radunò in fretta e, prima gli adulti e poi i giovanissimi, a due a due le oche dai lunghi colli cominciarono a staccarsi dall’acqua e a sollevarsi battendo le grandi ali.
Quek volava in testa a tutti. Dietro a lui si allargava, formando un angolo acuto, la lunga colonna delle oche. Qui-quak era tra gli ultimi e sentiva alle sue spalle il quieto e uniforme mormorio del gorgo aereo che si spegneva dietro di loro. Fiù… fiù… e si meravigliava di non provare quella fatica tremenda che aveva sentito tutte le volte che aveva volato da solo sulla palude. Adesso muoveva agilmente le ali senza nessuna stanchezza e desiderava che Quek salisse ancora più in alto, dove il cielo era rosso e cristallino.
Non immaginava neppure che quella facilità del volo dipendeva dalla disciplinata geometria dello stormo: i robusti nocchieri che volavano in testa, vincendo la resistenza dell’aria, facilitavano il volo dei più deboli

disposti alla retroguardia e per primi si scontravano coi rapaci che tentavano di sbarrare il passo. Qui-quak non sapeva ancora nulla di tutto questo.
Bulajic, Carovana alata, Giunti
lanugine: peluria. coltre: strato, manto. disciplinata: ordinata.
astore: rapace che vive in Eurasia e negli Stati Uniti.
Leggi con attenzione la prima frase del brano, poi fai l’analisi grammaticale.
SCRIVI TU!
«… per la prima volta, nella sua vita da solo, doveva decidersi ad agire». Ti è mai capitato di dover prendere una decisione da solo e agire? Quando? Che cosa hai dovuto decidere? Come ti sei sentito? Come Qui-quak, impaurito? O soddisfatto e fiero di avercela fatta? Racconta.

INCON T R I AMO LA POESIA
NEL SOLAIO
UN GIORNO
Se nel solaio un giorno un gatto nero vede un filo di luce e con la zampa lo acchiappa e lo tira e lo aggroviglia e lo ammassa in confusa matassa speriamo davvero che quel filo di luce si strappi prima che disfi il sole il gatto nero.
Roberto Piumini
LA FELICITÀ
C’è un’ape che se posa su un bottone de rosa: lo succhia e se ne va… Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa.
Trilussa
GABBIANI
Non so dove i gabbiani abbiano il nido, ove trovino pace. Io son come loro in perpetuo volo. La vita la sfioro com’essi l’acqua ad acciuffare il cibo. E come forse anch’essi amo la quiete, la gran quiete marina, ma il mio destino è vivere balenando in burrasca.
Vincenzo Cardarelli
perpetuo: continuo, volo senza sosta.
sfiorare: toccare, sentire. acciuffare: catturare, afferrare.
quiete: tranquillità, pace. balenare: brillare per un istante, lampeggiare.
COME UN POETA
Nella poesia Gabbiani il poeta paragona il cammino della sua vita al volo dei gabbiani che non si fermano mai e cercano «la gran quiete marina».
Usa questa similitudine per dire “io sono come loro”.
Proviamo a scoprire il perché, indagando i segreti nascosti in questa immagine.
Cosa hanno in comune?
In perpetuo volo cercano in nido
amano la quiete cercano il cielo
E tu a quale animale ti paragoneresti? Perché?
Cerca di spiegare quali cose hai in comune con l’animale scelto. Componi la tua similitudine.

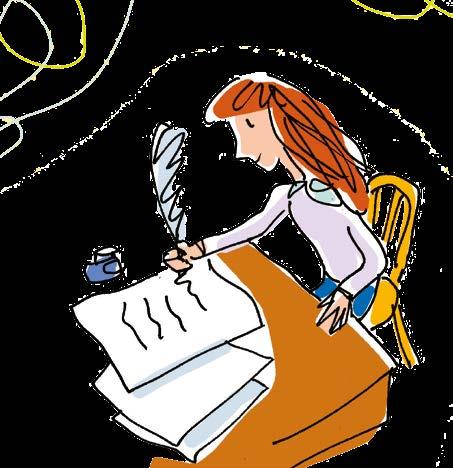
PROVERBI E MODI DI DIRE
PROVERBI
Chi dorme non piglia pesci!
Can che abbaia non morde.
Non dire gatto se non l’hai nel sacco.
1. Sai che cosa è un proverbio? Spiega il significato di questi proverbi legati al mondo animale, poi scrivi un proverbio che senti usare spesso in casa o a scuola.
MODI DI DIRE
Hai una febbre da cavallo!
Sputa il rospo!
Sono rimasto con un pugno di mosche.
Sei la pecora nera del gruppo.
Queste espressioni non sono proverbi ma modi di dire, cioè parole il cui senso è legato a una situazione caratteristica presa dal modo animale.
ESPLORA LA SCRITTURA!
1. Conosci altri modi di dire legati agli animali? Aggiungili all’elenco.
2. Sostituisci il modo di dire con altre parole, mantenendo lo stesso significato.
3. Scegli una di queste espressioni e racconta una storiella o scrivi un breve dialogo in cui possa essere usata.
Mettiamoci all’opera
Gli animali
Approfondisci la conoscenza degli animali, vertebrati e invertebrati, attraverso l’osservazione di alcune belle immagini o fotografie e la successiva rappresentazione con grafite, tempere, acquerelli o pastelli su cartoncino bianco.
Scegli la tecnica da usare tenendo conto delle caratteristiche dell’animale che vuoi rappresentare, ad esempio l’acquerello per l’impalpabilità e la trasparenza della medusa, i colori densi e le linee in grafite per la durezza e la precisione geometrica del guscio della tartaruga, la matita e il carboncino per gli schizzi di mammiferi e di piumaggi di uccelli, i pastelli pastosi per il corpo degli insetti e le ali delle farfalle, e così via.

Puoi migliorare la tua capacità di riprodurre l’immagine se osserverai le linee, i piani, gli spazi che definiscono i tratti di quell’animale e se disegnerai con precisione i particolari, ponendo attenzione anche alla posizione.

STO R I E D I UOMINI
Canto
John Brown
Coinvolgente ballata popolare dedicata a un attivista che si è battuto contro la schiavitù.
Si può giocare a togliere via via le parole della strofa sostituendole con un “verso” musicale o con il silenzio.
John Brown giace nella tomba là nel pian dopo una lunga lotta contro l’oppressor.
John Brown giace nella tomba là nel pian, ma l’anima vive ancor.
Glory, glory, alleluia.
Glory, glory, alleluia. Glory, glory, alleluia. Ma l’anima vive ancor.
Ascolto
Sinfonia n. 3, primo movimento
L. van Beethoven
Questa sinfonia si chiama l’Eroica perché celebra un eroe nel momento della gloria e della disfatta. È dedicata a Napoleone, un eroe per Beethoven, fino al giorno in cui non si proclama imperatore, deludendo il compositore, che quindi compone il secondo movimento come una marcia funebre per la scomparsa del suo eroe.

ARCHIMEDE, IL BAGNO E LA CORONA
Archimede viveva a Siracusa, una città della Sicilia, al tempo degli antichi Romani. Da sempre era considerato un grande scienziato e inventore.
Un giorno d’estate il re della città, di nome Gerone, lo mandò a chiamare perché aveva un grosso problema da risolvere.
«Benvenuto Archimede!» esclamò Gerone appena lo studioso entrò nella sala del trono. «Mi devi aiutare! Penso di essere stato ingannato, ma non sono sicuro!»
«Sono al tuo servizio mio re!» rispose Archimede incuriosito.
«Ho dato al mio gioielliere un pezzo d’oro per fabbricarmi questa corona, ma ora la corona mi sembra troppo leggera! Forse il mio artigiano mi ha tradito e si è rubato un po’ del mio oro? Aiutami a scoprire se è vero!» disse il re sconsolato.
Archimede decise di accettare l’incarico.
Tornò a casa tutto pensieroso perché non sapeva cosa fare per aiutare il re. Andò nel suo laboratorio e si mise al lavoro. Dopo qualche ora, si alzò. Niente, non aveva nessuna idea su come risolvere il problema. Decise allora di andare a fare un bagno fresco e rilassante in un bagno pubblico lì vicino.
Entrò nella vasca di legno e vide che, immergendosi, aveva spostato molta acqua che era uscita dal bordo.
Fu allora che gli venne in mente come risolvere il caso.
«Eureka! Eureka!» gridò e corse subito a casa a sviluppare la sua idea.
Per fortuna abitava vicino ai bagni pubblici, perché era uscito dalla vasca dimenticandosi di essere nudo! Pochi giorni dopo Archimede di presentò di nuovo dal re Gerone con due recipienti pieni di acqua.
«Dammi la tua nuova corona, o re, e un pezzo di oro uguale a quello che hai dato al tuo gioielliere! Vedrai che scopriremo l’inganno!».
Il re all’inizio lo guardò un po’ storto, ma poi gli diede quello che voleva.
«Ora osserva mio re» disse con sicurezza l’inventore. «Ora metterò il pezzo d’oro e vedrai che l’acqua si alzerà nel recipiente». Archimede fece quello che aveva detto e segnò di quanto si era sollevato il livello dell'acqua. Poi
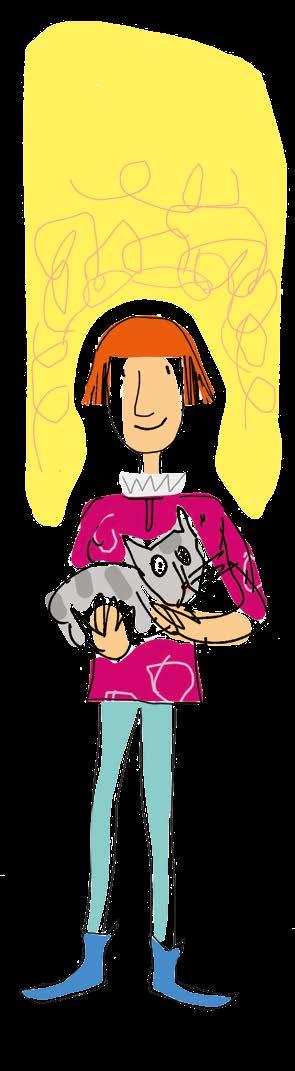
disse con un ghigno soddisfatto : «Ora se metto la tua nuova corona che è fatta con lo stesso oro, l’acqua dovrà salire allo stesso modo! Un corpo pesante sposta tanta acqua, un corpo leggero sposta poca acqua!».
Archimede immerse la corona nel secondo recipiente e segnò anche in questo caso il livello dell’acqua.
Subito Gerone guardò stupito il fenomeno e gridò arrabbiato: «Che imbroglione il mio gioielliere! La corona ha spostato meno acqua! Vuol dire che non è d’oro! Mi ha derubato!»
Gerone mandò ad arrestare l’artigiano e Archimede se ne tornò soddisfatto al suo laboratorio.
Ancora una volta l’intelligenza, la curiosità e la sapienza di Archimede gli avevano permesso di risolvere un grande enigma. Da quel giorno Archimede venne considerato un vero genio.
Sergio Rossi, I più grandi inventori della storia, Gribaudo
Archimede di Siracusa (matematico, fisico e inventore dell’antica Grecia, 287 a.C circa - 212 a.C.) si diverte con la geometria e la fisica, ma sa dare anche risposte concrete a molte domande pratiche del suo tempo… come e perché le navi galleggiano, per esempio, o perché galleggiano più facilmente nelle acque salate e così via. Per i popoli navigatori le scoperte di Archimede saranno un vero tesoro.
BIOGRAFIA

Dopo aver riletto Archimede, il bagno e la corona, rispondi alle domande.
1. Chi è il protagonista di questa storia?
A. Gerone.
B. Archimede.
C. Il gioielliere.
2. Dove avvengono i fatti narrati?
A. Nel palazzo del re, nel laboratorio di Archimede.
B. Nel palazzo del re, nei bagni pubblici.
C. Nel palazzo del re, nei bagni pubblici e nel laboratorio di Archimede.
3. Sottolinea nel testo in blu quelle espressioni che ti fanno capire
DOVE avviene la storia. (Almeno 3)
In che città siamo?
4. Sottolinea nel testo in rosso quelle espressioni che ti fanno capire QUANDO avviene la storia. (Almeno 2)
In che stagione siamo?
5. Secondo te, che cosa significano le parole greche: “Eureka! Eureka!”?
A. “Che freddo! Che freddo!”
B. “Acqua! Acqua!”
C. “Ho trovato! Ho trovato!”
6. Segna con una X la parola, tra le seguenti, che NON viene usata nel testo per indicare Archimede.
A. Genio
B. Inventore
C. Sapiente
D. Scienziato
7. Nel brano si dice che Archimede fece «un ghigno soddisfatto»: il ghigno è un sorriso, ma perché Archimede è soddisfatto e sorride?
8. Sottolinea in giallo la conclusione del racconto.
9. Immagina di essere tu il re di Siracusa, cosa avresti chiesto ad Archimede? Perché?
CHE COSA STAI FACENDO QUI?
Il suono dell’organo tuonava nella notte. Un ragazzetto si fermò nella strada buia e bagnata ad ascoltare. La musica sembrava provenire dalla Cappella di Palazzo, coperta di foglie di vite. Egli si avvicinò al muro esterno, attratto dalla melodia.
Si sentiva molto triste. Amava la musica più di qualunque altra cosa al mondo. Suo padre, cantore, gli aveva insegnato tutto ciò che conosceva di musica; poi un amico di suo padre, cantante all’Opera, gli aveva a sua volta impartito lezioni: da allora più nessuno aveva potuto insegnargli altro.
Il ragazzo aveva fatto una passeggiata sotto la pioggia pensando all’avvenire; e proprio allora aveva sentito il suono dell’organo. Forse, se avesse potuto entrare nella Cappella, ascoltando la musica di quell’organo si sarebbe sentito meglio. Ma una guardia vigilava camminando in su e in giù davanti al cancello di ferro. Come avrebbe potuto passare senza farsi vedere? La guardia si girò. Il ragazzo si appiattì contro il muro: sentiva le foglie ed i tralci della vite vellicargli il dorso.
La musica dell’organo continuava. Doveva assolutamente entrare nella Cappella per ascoltarla da vicino!
Decise che la prossima volta in cui la guardia si sarebbe girata, avrebbe cercato di arrampicarsi sul muro di cinta. Valeva la pena di tentare.
Ecco: la guardia adesso volgeva le spalle. Il ragazzo si aggrappò ai tralci e cominciò a salire.
Quando raggiunse la sommità del muro, la guardia urlò: «Alt! Chi va là?!».
Il ragazzo stette immobile sulla cima del muretto trattenendo il respiro.
La guardia era proprio sotto di lui ma, dopo essersi guardata intorno, non vedendo nessuno, ritornò al suo posto davanti al cancello.
Sull’altro lato del muro non c’erano tralci di vite. Il ragazzo capì che avrebbe dovuto saltare: si penzolò dal muro aggrappandosi con le mani e allungandosi più che poteva; quindi, con un balzo si staccò e cadde al suolo.
Un ramoscello scricchiolò sotto i suoi piedi. Si fermò, senza fiato.
Se la guardia lo avesse sentito? Ma dall’altra parte del muro non proveniva alcun rumore.
La musica dell’organo aumentava man mano che il ragazzo si avvicinava alla Cappella: adesso era veramente tuonante, sembrava traboccare fuori dalla porta semiaperta. Il ragazzo scivolò dentro. La Cappella era illuminata da una torcia che gettava grandi ombre tremolanti contro le pareti di pietra.
Guardò verso la loggia del coro e vide un vecchio seduto all’enorme organo.
L’uomo sembrava perduto nella bellezza della musica.
Intorno non vi era nessun altro.
Lentamente, il ragazzo cominciò a strisciare verso la parte posteriore della Cappella. La porta che immetteva nella galleria del coro era aperta.
Salì, un gradino per volta, la lunga scala buia.
Quando giunse a metà la musica cessò. Il ragazzo esitò.
Forse l’organista lo aveva sentito? Lo avrebbe consegnato alla guardia perché aveva osato introdursi nella Cappella di Palazzo?
Ma in quel momento la musica ricominciò e il ragazzo respirò di sollievo. Giunto in cima alle scale, scivolò silenziosamente nella galleria del coro.
La musica lo circondava, gli riempiva le orecchie. Quant’era diverso l’organo dal violino e dal cembalo che aveva suonato fino a quel giorno! Com’era grande e potente! Come estasiava e trascinava!
Chiuse gli occhi ed ascoltò con tutto il cuore e con tutta la mente. Si perdette nella musica meravigliosa con tale trasporto che non si accorse di venir fuori dall’ombra e di avvicinarsi all’organo sotto la tenue luce delle candele.
Improvvisamente la musica tacque.
«Ehi, tu,» disse l’organista «che cosa fai qui?».
Il ragazzo non riuscì neppure a parlare. Si volse, urtando contro le panche e cercò di raggiungere la porta. L’organista lo inseguì.
«Fermati» gridò. «Fermati, ho detto!».
Il ragazzo non voleva essere preso.
Non avrebbe mai dovuto scavalcare il muro di cinta!
Scendendo le scale buie inciampò e cadde.
Due forti mani lo raggiunsero e lo agguantarono. L’organista lo prese per il braccio e lo trascinò nella galleria, mentre il ragazzo scalciava e si dibatteva. Ma l’uomo lo tenne stretto e lo afferrò per un orecchio.
«Adesso, giovanotto, se vuoi essere così gentile da dirmi che cosa stai facendo qui…».
Il ragazzo era troppo spaventato per parlare. Guardava fisso in faccia l’organista.
«Non sai di essere in una proprietà privata? Sei entrato scavalcando il muro di cinta con l’intenzione di rubare qualcosa, vero?» continuò l’altro severamente.
«Oh, no, signore!» disse ansimando il ragazzo. «Ho udito l’organo passando nella strada. Io volevo soltanto ascoltare la musica più da vicino! Per questo mi sono arrampicato sul muro di cinta mentre la guardia non vedeva».
La faccia dell’organista s’illuminò di un sorriso.
«E perché volevi ascoltare la musica più da vicino?».
«Mio padre mi ha insegnato un poco a suonare il violino e il cembalo» disse il ragazzo. «Oggi, dopo essere vissuto per un anno in casa nostra, il mio maestro ha detto a mio padre che anch’egli mi ha già insegnato tutto quello che sa. Che cosa farò adesso? C’è tanto da imparare e non ho nessuno che mi insegni».
L’organista circondò col braccio le spalle del ragazzo e lo condusse verso il sedile dell’organo.
«Non aver paura» disse gentilmente. «Siediti».
Il ragazzo sedette. Le sue gambe corte penzolavano dal sedile dell’organo.
«Come ti chiami?» chiese l’organista.
Il ragazzo disse all’uomo il suo nome e cognome. Questi sorrise.
«Avrei dovuto riconoscerti! Ero amico di tuo nonno, molti anni fa».
Gli occhi neri del ragazzo si illuminarono.
«Davvero?» chiese. «Allora mi perdonate per avervi interrotto?».
L’organista disse con calore:
«Farò di più. Ti insegnerò a suonare l’organo. E poi, chissà? Un giorno, se sarai abbastanza bravo, potresti divenire l’organista di corte!».
Il ragazzo si eccitò tanto da cadere quasi dal sedile.
«Oh, come potrò mai ringraziarvi?». «Lavorando sodo come un bravo allievo» replicò l’organista. «Dovrai studiare molto e per lungo tempo. Ma se ami la musica come tu dici, ne varrà la pena!». Robert M. Savage
vellicargli: sfiorarlo provocando solletico.
SCRIVI TU!
Rileggi il testo e rispondi alle domande in forma completa sul tuo quaderno.
1. Chi è il protagonista di questo racconto? Quali caratteristiche può avere? Utilizza tre aggettivi per descriverlo.
2. Perché il ragazzo scavalca il muro ed entra nella cappella?
3. Nel testo si legge «...adesso il suono era veramente tuonante, sembrava traboccare fuori dalla porta semiaperta», spiega questa espressione.
4. Il vecchio organista non è molto felice di vedere il ragazzo nella cappella, perché?
5. Perché il vecchio organista cambia idea? Cosa decide di fare?
6. Il brano si conclude con questa frase: «Dovrai studiare molto e per lungo tempo. Ma se ami la musica come dici tu, ne varrà la pena!». Anche tu hai una passione come questo ragazzo per cui sei disposto a studiare per lungo tempo? Qual è?
Il ragazzo di cui si parla in questo racconto era Ludwig van Beethoven, uno dei più grandi compositori del mondo.
Questo episodio ebbe luogo a Bonn, in Germania, nel 1781, quasi due secoli or sono. Ludwig imparò a suonare l’organo e dopo quattro anni di studio divenne organista di Corte. In seguito andò a Vienna, dove dette concerti di pianoforte riscuotendo molto successo.
Poi s’accorse che stava perdendo l’udito. Non dette più concerti e dedicò tutto il suo tempo a comporre musica. A cinquant’anni era ormai completamente sordo, ma nella sua mente poteva ancor sentire la bellezza della musica. Ed è proprio nel periodo di sordità totale che compose alcuni dei più grandi capolavori musicali del mondo.
Se non avesse perduto l’udito, Ludwig van Beethoven sarebbe probabilmente rimasto soltanto un ottimo concertista: ma, poiché riuscì ad ergersi al di sopra della sua menomazione, la sua splendida musica sarà ricordata per sempre.

IL LIBRO DELLA NATURA
«Piano! Stai attento!» esclama Antonia, mentre arrivano al torrente di Riudoms. Non vuole che il figlio Antonì cada dal mulo. Francesco scende dal suo ronzino, prende giù il fratello più piccolo e lo tiene in braccio per attraversare a piedi il corso d’acqua. Antonia accarezza la testa del figlio malato. Lui sopporta con un sorriso il dolore che il reumatismo gli provoca nelle articolazioni.
Poco dopo arrivano al Mas de la Calderera, la fattoria di famiglia. Hanno deciso di trasferirsi nella casetta di campagna per passarvi l'intera stagione, fino a che Antonì non migliorerà. Francesco dovrà poi fare ritorno al suo lavoro di fabbro a Reus, lasciando Antonia sola col suo ultimo figlio. Antonì è il quinto. I primi due, Maria e Francesco, morirono da piccoli. I due successivi, Rosa e il secondo Francesco, crescono sani e robusti. Invece al più piccolo il reumatismo impedisce di camminare e gli causa dolori molto forti, tanto forti da dover smettere di frequentare la scuola di Berguer, di via Monterols.
I suoi amici, Francesc Berenguer e Eduard Toda, lo avevano salutato con affetto e gli avevano promesso che sarebbero andati a trovarlo una domenica.
Antonia è preoccupata, perché Antonì non potrà proseguire gli studi come tutti gli altri. «Cosa ne sarà della vita di un bambino malato?» pensa, osservandolo.
Il piccolo Antonì prende una chiocciola e la tiene per un po’ tra le mani. «Mamma, guarda. Cos'è?».
«Una chiocciola, Antonì».
Sua madre si accorge che il figlio non sta giocando con la chiocciola. La sta studiando.
E lo stesso gli accade davanti alla gallina, quando scorrazza nel cortile, alla rondine che attraversa il cielo, ai mandarini che aveva piantato il nonno davanti alla porta della piccola casa, alle pietre del terreno o alle montagne dei Pareis, che chiudono l’orizzonte a nord.
«Questi saranno i suoi libri» riflette Antonia «invece di quelli di scuola. E Dio poi ci penserà».
Libera traduzione da Josep Maria Tarragona Clarasó, Antoni Gaudí. Un arquitecto genial, Editorial Casals
Che cosa vuole dire la mamma di Antonì quando dice «questi saranno i suoi libri»?
Antoni Gaudí (1852-1926)
è conosciuto in tutto il mondo come il geniale architetto della Sagrada Família, il tempio cristiano diventato l’edificio simbolo di Barcellona, in Spagna. Questo capolavoro è stato definito un poema in pietra per la ricchezza e varietà delle sue forme e delle sue immagini.

L’UOMO VOLERÀ!
Quando al limite della verdeggiante pianura lombarda vide per la prima volta apparire la chiostra nevosa delle Alpi, Leonardo sentì che per lui iniziava una nuova vita. Così, ascendendo l’erta faticosa del monte Albano, riviveva il ricordo dei cinquant’anni della sua esistenza. Leonardo saliva sempre più in alto e uno strano senso di gioia gli riempiva l’animo: gli pareva di essere il conquistatore di quelle tetre arcigne vette flagellate dai venti e ad ogni passo lo sguardo gli si faceva più penetrante, fisso sull’orizzonte che sempre più vasto si apriva innanzi a lui. Gli pareva di sfiorare appena i ciottoli dello scosceso sentiero, di sentirsi più lieve man mano che saliva, di staccarsi dal suolo come sorretto da ali gigantesche. Leonardo ricordò come da piccolo seguiva il volo delle cicogne versando lacrime di invidia all’udir le loro grida lontane che parevano invitarlo a seguirle; ricordò il racconto del monaco suo maestro di scuola su Icaro figlio di Dedalo, il quale aveva voluto tentare il volo con ali tenute insieme da cera e si era ucciso piombando nel mare e quando in seguito il maestro gli aveva domandato chi fosse il più grande eroe dell’antichità ed egli aveva risposto senza esitare: «Icaro, il figlio di Dedalo».
«Le ali» pensò. «Possibile che anche questo debba perire come tutto ciò che faccio?». Alzò la testa, strinse ancora di più le labbra, aggrottò le sopracciglia e riprese la scalata vincitore del vento e della montagna. Il sentiero era ormai scomparso. Adesso Leonardo si inerpicava a caso tra le nude rocce dove forse mai nessuno prima di lui aveva posto piede.
Ancora uno sforzo, ancora un passo e si fermò sull’orlo del precipizio. Non si poteva andare più avanti: ci sarebbero volute le ali! La roccia finiva in un altissimo strapiombo che si immergeva in uno strato di fluttuanti vapori dai toni violetti e pareva che laggiù non vi fosse terra ma lo stesso vuoto, la stessa infinità celeste, laggiù sotto i piedi come lassù sopra la testa. Leonardo si curvò in avanti scrutando l’abisso e di colpo, forte come non mai, il sentimento della necessità assoluta del volo umano, quel sentimento che fin dall’infanzia l’assillava, gli pervase l’animo.
«Le ali verranno» mormorò. «Verranno! Se non per merito mio, per merito di un altro, ma l’uomo volerà! Lo spirito non ha mentito: chi saprà, chi volerà sarà simile a Dio!».
Provò ad immaginarsi re dell’aria, vincitore dello spazio e della gravità, figlio dell’uomo, in tutta la sua gloria e la sua potenza, il Grande Cigno dalle immense, candide ali scintillanti come neve nell’azzurro del cielo.
E nel suo cuore avvampò una gioia strettamente confinante con il terrore… Mentre Leonardo scendeva dal monte, il sole era ormai al tramonto.
Si fermò, trasse di tasca il taccuino e scrisse: «Se la pesante aquila può sostenersi volando nell’aria rarefatta, se le grosse navi possono, con l’aiuto delle vele muoversi sul mare, perché non potrebbe l’uomo, solcando l’aria con ali, signoreggiare i venti e levarsi in alto da vincitore?».
A fianco era disegnata la macchina: un timone al quale erano fissate due ali, mediante aste di ferro, azionate da un sistema di corde.
Dimitri Mereskovskij,
Rispondi alle seguenti domande di comprensione.
1. Quale ricordo affiora nella mente di Leonardo «ascendendo l’erta faticosa del monte Albano»?
2. Quali animali osservava Leonardo quando era piccolo e che cosa invidiava di loro?
3. Quale racconto ricorda Leonardo del monaco e suo maestro di scuola?
4. Quale affermazione fa Leonardo quando si ferma sull’orlo del precipizio, là dove la roccia finiva in un altissimo strapiombo?
5. Cosa scrisse Leonardo sul suo taccuino, mentre scendeva dal monte Albano e il sole era ormai al tramonto? Cosa disegnò a fianco di ciò che aveva scritto?
BIOGRAFIA
Leonardo da Vinci (pittore, architetto, scienziato, 1452-1519) è noto non solamente per le sue capacità pittoriche, ma anche come sperimentatore dotato di curiosità vivace e interesse su ogni aspetto della realtà. Osservare la natura affascina moltissimo Leonardo; ha l’abitudine di prendere appunti per fissare idee e curiosità su ciò che vede o immagina, prima che nuovi ed eccitanti pensieri spazzino via quelli di prima. Quei grandi fogli pieni di schizzi, scritte e rebus – Leonardo era appassionato di giochi di parole – sono arrivati fino a noi e ci mostrano gli interessi di Leonardo per tutte le materie: botanica, anatomia, zoologia, ingegneria, idraulica e architettura.
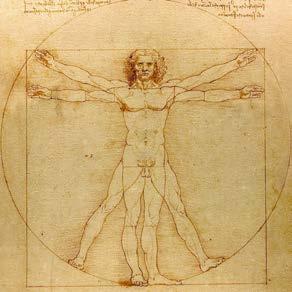
LA GRANDE IDEA
Non ho dormito per due notti di seguito. E neppure i miei collaboratori. Siamo rimasti svegli a guardare la nostra lampadina ardere senza bruciare per 45 ore!
Avevo estratto l’aria da un bulbo di vetro e saldato all’interno un filo carbonizzato di cotone da cucire. Poi l’avevo collegato alla corrente.
La lampadina ha continuato a illuminare il laboratorio per quasi due giorni, prima di consumare il filamento. Funziona! Si può fare!
Ora sono sicuro di poter costruire una lampadina che duri centinaia di ore.
Cambierà il modo di vivere e… di dormire. Ho investito migliaia di dollari per i miei esperimenti sull’illuminazione elettrica e migliaia di ore di lavoro.
Ho provato di tutto, persino, come filamento carbonizzato, i peli della barba rossa del mio collaboratore Mackenzie!
Ma ora, alla fine, so di aver creato non solo un nuovo tipo di lampada, ma un sistema che funziona.
Infatti ho dovuto inventare tutto quello che serve per far funzionare la lampadina: una dinamo che produce corrente elettrica a basso costo, reostati, contatori, interruttori, valvole, portalampada, conduttori sotterranei e aerei, derivazioni, e tutti gli accessori, compreso… il nastro isolante. Prima c’era solo il filo di rame, che ho dovuto ricoprire di isolante.
Ora a Menlo Park c’è il primo impianto di illuminazione della storia: venticinque lampade illuminano il laboratorio, otto gli uffici, e altre venti illuminano le strade adiacenti. Ho deciso di inaugurarlo ufficialmente il giorno di San Silvestro. Sarà il Capodanno più straordinario della mia vita.
La notte di San Silvestro 1879 ho aperto le porte di Menlo Park ai visitatori.
Ne sono arrivati tremila. Una vera folla: uomini, donne, ragazzi, operai, agricoltori, banchieri, operatori di borsa… Sono arrivati con tutti i mezzi: a cavallo, a piedi, su carri e carrozze. Da New York sono stati organizzati persino dei treni speciali per venire a vedere quella che un giornalista ha definito l’ottava meraviglia del mondo: la Fabbrica delle Invenzioni illuminata a giorno da decine di lampadine elettriche. Quello che fa impressione è il fatto che premendo un interruttore non si illuminano a giorno solo il laboratorio e il mio ufficio, ma anche la mia casa e tutti gli edifici e le strade entro un quinto di miglio dalla centrale elettrica.
Luca Novelli, Edison, come inventare di tutto e di più…, Editoriale Scienza
Thomas Alva Edison (inventore statunitense, 1847-1931) è stato definito «l’uomo che inventò il futuro». Fu lui che cominciò a distribuire l’energia elettrica nelle case e nelle fabbriche, fu lui a inventare la lampadina a incandescenza e a scoprire il modo di riprodurre la voce e la musica. Grazie a lui, oggetti come il telefono e la radio raggiunsero un gran numero di persone, cambiando il nostro modo di vivere.
MARGHERITA “CALAMITA”
Quand’ero piccola sapevo poche cose delle stelle.
Il mio babbo m’insegnava i nomi dei pianeti, sfogliava insieme a me certi libroni che non riuscivo neanche a tenere in braccio.
Erano vecchi, sapevano di polvere e avevano le pagine ingiallite che scrocchiavano come foglie secche. Di quei libri io guardavo le figure. Avevo cinque anni e sapevo già leggere, ma le parole erano molto più noiose delle immagini del Sole e dei pianeti.
Tutti dicevano: «Ah, che bambina sveglia! Sarà bravissima a scuola!». Ma mica tanto. Ho sempre studiato, certo, perché dovevo. Il babbo lavorava, la mamma lavorava, quindi anch’io dovevo darmi da fare. E il mio lavoro era: prendere voti decenti. Però la mia forza non erano i voti. La mia forza era la curiosità. Mamma mia, quant’ero curiosa! M’interessava tutto, «Margherita calamita» mi chiamavano. Avevo la testa che friggeva di domande e leggevo tantissimi libri. Tarzan delle Scimmie, Pinocchio, I ragazzi della via Pál… Leggere mi piaceva da morire, mi faceva vivere tante vite e mi addestrava a sognare. Quando lessi i romanzi di Scart e Jules Verne, con tutti quei pirati, sottomarini e capitani, decisi: «Da grande farò l’esploratrice della terre selvagge!».
E in effetti, a pensarci, non mi sbagliavo poi di molto.
Mi chiamo Margherita Hack.
Margherita come il fiore, e Hack come Hack.
Margherita Hack (scienziata e astrofisica, 1922-2013) era chiamata la “donna delle stelle”. Nata a Firenze, in via Centostelle, la sua vita fu segnata fin da subito dalla sua passione per le stelle specialmente le più brillanti che studiava perché la loro bellezza cambia nel corso del tempo. Ciò che ha sempre affascinato Margherita, e l’ha portata a dirigere l’Osservatorio Astronomico italiano e a collaborare con la NASA e l'ESA, è l’infinità dell’Universo che nasconde tante domande che spingono l’uomo a cercare sempre più in là (“Che cosa c’era prima? Che cosa ci sarà dopo? Che cosa c’è fuori?”).

AGATHA CHRISTIE, UNA STORIA
DI STRAORDINARIA DISLESSIA
Non si conosce molto riguardo a donne del passato che sono state dislessiche, perché in passato le donne non andavano a scuola. Però vi vogliamo raccontare di una grande scrittrice di gialli, che poi sono diventati anche dei film: Agatha Christie.
Agatha nacque alla fine del 1800 in Inghilterra. Fu educata in casa dalla madre e dalle governanti. Clara, la mamma, le insegnò a leggere e scrivere. A casa dei signori Christie c’erano sempre ospiti illustri, fra cui alcuni scrittori. Mamma e figlie si dilettavano, così, nella scrittura di racconti. Agatha quindi provò a scrivere, anche lei, il suo primo racconto.
Eppure lei stessa racconta che in famiglia era considerata «tardiva».
La scrittura e l’ortografia erano terribilmente difficili per lei e rimasero sempre i suoi punti deboli. Ciononostante la sua dislessia non le ha impedito di diventare la più grande scrittrice di gialli del mondo!
Da piccola visse a Parigi e cominciò a studiare canto e pianoforte; aveva sviluppato una forte passione per la musica e voleva diventare una cantante lirica. Purtroppo (o per fortuna, dal punto di vista della storia della letteratura), non ottenne molti riscontri positivi come cantante e la paura del palcoscenico la terrorizzava. Così sua madre la portò in viaggio in Egitto per consolarla e, poi, tornarono in Inghilterra.
L’idea per il suo primo romanzo giallo sul commissario Poirot le nacque lavorando in un ospedale, come infermiera volontaria, durante la Prima guerra mondiale. A contatto con farmaci e veleni le venne in mente quel magnifico personaggio, misto di furbizia e raffinatezza, un po’ fuori dagli schemi, e con uno spirito di osservazione incredibile.
Un viaggio in treno per Baghdad, invece, le ispirò Assassinio sull’Orient Express, uno dei suoi romanzi più famosi.
Un’altra figura caratteristica dei suoi gialli è quella dell’anziana Miss Marple, che pare sia stata ispirata alla stessa nonna della Christie. Di fantasia ne aveva da vendere! Probabilmente nascondeva un po’ di lei in tutti i suoi personaggi, andando a scegliere le caratteristiche a seconda della storia che voleva raccontare. Quando cominciò a scrivere fu stimolata anche da una sorta di scommessa che aveva fatto con sua sorella, la quale riteneva che non sarebbe riuscita a diventare una scrittrice di gialli. Sembra che i dislessici, quando vengono “colpiti” nel loro amor proprio, facciano emergere tutto il meglio di sé per dimostrare quello che sono capaci di fare! E fu così che a soli venticinque anni firmò il suo primo romanzo. Nella sua vita viaggiò moltissimo, in diverse parti del mondo. Un intero genere letterario come il giallo non sarebbe lo stesso senza gli eroi di Agatha. La sua fantasia poteva mettere insieme storie incredibilmente intrecciate e sempre diverse, omicidi intricati e moventi altrettanto difficili da scovare, ma era anche in grado di lasciar trovare sempre la soluzione ai suoi eroi perché scoprissero tutto in modo a dir poco geniale e fuori dagli schemi. Il metodo che usava per scrivere i gialli era quello di far prendere forma alla storia dapprima nella sua testa, partendo dal crimine. Spesso lavorava contemporaneamente a due libri, così da non rimanere mai senza idee! Agatha Christie in vita guadagnò circa 20 milioni di sterline, cioè poco più di 23 milioni di euro.
Ancora oggi è la scrittrice inglese più tradotta, anche più di Shakespeare. Nella lingua originale i suoi libri sono stati venduti in un miliardo di copie e nello stesso numero in almeno 45 lingue differenti.
Rossella Grenci, Daniele Zanoni, Storie di straordinaria dislessia. 15 dislessici famosi raccontati ai ragazzi, Erickson
dislessia: difficoltà nel leggere. si dilettavano: si divertivano. tardiva: lenta e in ritardo.
SCRIVI TU!
Agatha nascondeva nei suoi personaggi un po’ di sé e delle persone che incontrava. Prova a immaginare il protagonista di un tuo libro giallo, come potrebbe essere? Prova a descriverlo e a disegnarlo. Ricordati, deve avere un po’ di te!
BIOGRAFIA
Agatha Mary Clarissa Miller o Agatha Christie (scrittrice di libri gialli, 1890- 1976) fu la regina dei “romanzi gialli”. È una delle scrittrici più famose al mondo e i suoi libri sono ricchi di personaggi e di storie nate durante i suoi tanti viaggi o da fatti reali accaduti nella sua vita, ma poi trasformati dalla sua fervida e viva fantasia.
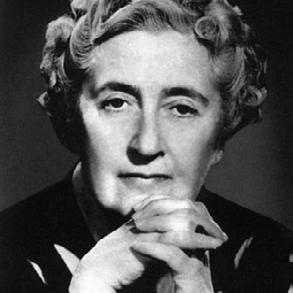
STA G I O NI E RICORRENZE
Canto
Vento sottile
Una canzone di origine francese che descrive la danza del vento tra gli alberi. Possiamo cantare a canone a più voci per immedesimarci con il movimento e il suono del vento.
Vento sottile, vento del mattino
Vento che scuoti la cima del mio pino
Vento che danzi, che balli la gioia tu ci porti, vento sottile
Ascolto
Campanas de Belén
Canto popolare spagnolo. Il ritmo e il tono delle voci suonano insieme alla musica in una sinfonia di campane che porta l’annuncio della nascita di Gesù a tutta la città.

SOLE D’OTTOBRE

In questi giorni di ottobre sembra di essere tornati in primavera: la natura mostra gli ultimi fiori e le forme incredibili dei funghi.
Le foglie degli alberi, intirizzite dai primi venti freddi, assumono colori meravigliosi: rosso, arancione, giallo, rame, bruno, che spiccano nel cielo lavato dalle piogge.
Gli animali sono tutti in movimento: partono gli uccelli migratori estivi e giungono quelli autunnali; i grandi mammiferi cambiano il pelo e assumono una folta pelliccia invernale, mentre gli animali che vanno in letargo si danno da fare ad accumulare riserve di grasso. E in questi ultimi giorni di sole prima delle nebbie invernali, ricci e ghiri, tassi e serpenti, tartarughe e rospi girano tra l’erba e il sottobosco in cerca di cibo.
Se andrete in campagna potrete avere sorprese bellissime: raccogliere le noci e le castagne che nessuno ha scoperto; scoprire che ora fioriscono la mentuccia profumata e i ciclamini autunnali.
MATTINO D’AUTUNNO
Il cielo era tutto sereno; di mano in mano che il sole s’alzava dietro il monte, si vedeva la sua luce, dalla sommità dei monti opposti, scendere, come spiegandosi rapidamente, giù per i pendii, e nella valle.
Un venticello d’autunno, staccando dai rami le foglie appassite del gelso, le portava a cadere qualche passo distante dall’albero.
A destra e a sinistra, nelle vigne, sui tralci ancor tesi, brillavan le foglie rosseggianti a varie tinte; e la terra, lavorata di fresco, spiccava bruna e distinta nei campi di stoppie biancastre e luccicanti dalla guazza del mattino.
NEBBIA IN CITTÀ
Camminare dentro la nebbia è come curiosare nel sogno della natura: gli uccelli fanno voli corti per non perdere l’orientamento, scompaiono i segnali nelle strade di città, i veicoli vanno piano e si fa appena in tempo a riconoscerli che spariscono. Le luci verdi, rosse e gialle dei semafori colorano nella notte vaste masse di nebbia, e tutto diventa irreale.
Munari, Nella nebbia di Milano, Emme Edizioni
ESPLORA LA SCRITTURA!
Scegli una frase, che secondo te è espressiva, di questi brani e ricopiala con cura e bella grafia sul tuo quaderno.
AUTUNNO
Prima di cadere le foglie assumevano – in una sorta di festa d’addio alla loro esistenza così breve – le tinte più belle: l’oro o il rosso, o il giallo delicato, o il ruggine o il bruno, ciascuna secondo la propria specie. Per più giorni da nord-est, cioè dalla stessa direzione del vento, giunsero anche e si susseguirono – alte nel cielo – schiere di anitre migranti: volavano in formazione a V o in semplici righe oblique, con strida insistenti.
Terminato il passo delle anitre egli assistette a un altro passo, davvero impensato: quello dei ragni. Sulle sporgenze dei fortini, sui lunghi fili del telefono da campo, su ogni stelo secco e in cima alle erbe più alte, comparvero dei fili di ragnatela che raffittirono sempre più. Dapprima nessuno ci badava, poi di notte una vedetta s’accorse, alzando gli occhi alla luna, che nell’aria navigavano innumerevoli fili. Chiamò a mezza voce un paio di compagni, che venissero a vedere. Udendo le esclamazioni di meraviglia di costoro altri bersaglieri uscirono dai ricoveri, uscì anche Stefano e vide: nell’aria sopra la trincea miriadi di fili – lunghi da un palmo a qualche braccio – procedevano orizzontalmente, paralleli fra loro, trasportati dalla brezza, e su ogni filo viaggiava un minuscolo ragno.
Eugenio Corti, Il cavallo rosso, Ares

GIORNATA NUVOLOSA
È bella una giornata di sole, ma io preferisco queste giornate nuvolose, che hanno l’aria di raccoglimento. Nulla può fare abbastanza degnamente spendere una giornata di sole; per quanto si faccia, si finisce per sprecarla, se non addirittura per farne un cattivo uso; mentre ci vuole così poco per impiegare bene una giornata nuvolosa. Basta leggere un libro, basta scrivere una lettera, basta starsene tappati in casa, col naso contro i vetri a guardare le strade grigie; anche un buon impiego d’una giornata nuvolosa è restarsene in letto, magari per alzarsi soltanto verso sera, quando la luce artificiale non vi parla più né di tempo bello, né di tempo brutto; starsene a letto a riordinare i propri scartafacci, ecco quello che ci vuole per spendere bene una giornata grigia.
Achille Campanile, Cantilena all’angolo della strada, Bur
SCRIVI TU!
Ci vuole così poco per impiegare bene una giornata nuvolosa!
Racconta come sei solito impiegare le grigie giornate autunnali, soffermandoti in modo particolare su una di esse, che è stata per te speciale.
INCON T R I AMO LA POESIA
NEBBIA
La nebbia arriva su zampine di gatto. S'accuccia e guarda la città e il porto sulle silenziose anche e poi se ne va via.
Carl Sandburg
TEMPO D’AUTUNNO
Gialle e rosse son le foglie passa il vento e le raccoglie, fanno un manto largo e lungo e lì sotto spunta un fungo. Torna il gesso alla lavagna e sul fuoco la castagna, nell’armadio maglioni pesanti con le calze, sciarpe e i guanti. Vola in cerca di calore ogni uccello migratore, gli animali, tra gli sbadigli, vanno a nanna nei giacigli. Le giornate si fan corte e l’autunno è ormai alle porte, voglio esser riscaldata da una tazza di cioccolata.
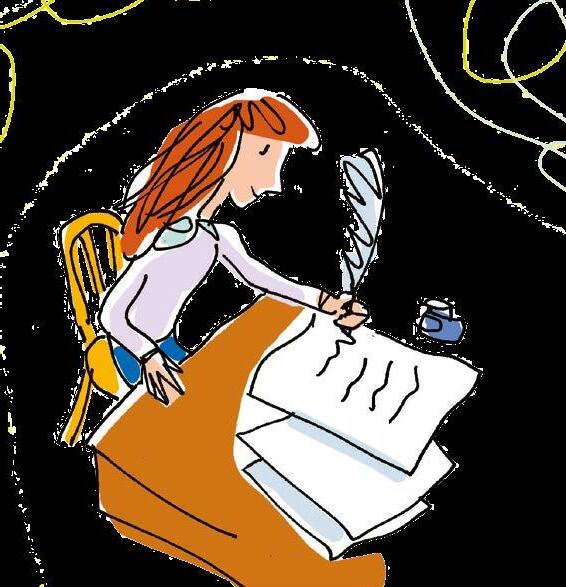
Monica Sorti
NATALE
Maria dentro la grotta si posò e Giuseppe a Betlemme si avviò. Ma un momento sentì, che, mentre andava, a mezzo il passo il piè gli s’arrestava. Vide attonita l’aria e il cielo immoto; e gli uccelli starsi fermi in mezzo al vuoto; e poi vide operai sdraiati a terra, e posata nel mezzo una scodella: e chi mangiava, ecco non mangia più; chi ha preso il cibo, non lo tira su; chi levava la man, la tien levata, e tutti al cielo volgono la faccia. Le pecore condotte a pascolare, sono lì che non possono più andare; fa il pastor per colpirle con la verga e gli resta la man sospesa e ferma; e i capretti che all’acqua aveano il muso ber non possono al fiume in sé rinchiuso. E poi Giuseppe vide in un momento ogni cosa riprender movimento.
Tornò sopra i suoi passi: udì un vagito; Gesù era nato: il fiore era fiorito.
Diego Valeri
I RE MAGI
Era una notte azzurra con tante stelle in cielo; sopra le dune sparse palme dal lungo stelo.
Dolce silenzio. I Magi sopra cammelli bianchi seguivan la cometa… felici e un poco stanchi.
Venivan da lontano, da regni d’oltremare, scrutavan l’orizzonte.
Ecco Betlemme alfine; ecco, nella capanna, un tenero Bambino in braccio alla sua Mamma.
I vecchi Re si prostrano e ognuno di loro offre un suo dono splendido: incenso, mirra e oro.

Cantano intorno gli angeli: “All’umile Giudeo s’inchinano i potenti: Gloria in excelsis Deo!”.
Giuseppe Fanciulli
IL PRESEPE DI GRECCIO
È degno di perenne memoria e di devota celebrazione quello che il Santo realizzò tre anni prima della sua gloriosa morte, a Greccio, il giorno del Natale del Signore.
C’era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita anche migliore, ed era molto caro al beato Francesco perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito che quella della carne.
Circa due settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse: «Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico: vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello». Appena l’ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l’occorrente, secondo il disegno esposto dal Santo.
E giunge il giorno della letizia, il tempo dell’esultanza! Per l’occasione sono qui convocati molti frati da varie parti; uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s’accese splendida nel cielo la Stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco: vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio, ed è raggiante di letizia.
Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l’asinello. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l’umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali!
La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al nuovo mistero.
La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano scelte lodi al Signore, e la notte sembra tutta un sussulto di gioia.
Tommaso da Celano, Vita prima
ESPLORA LA SCRITTURA!
Cerca nel vocabolario le seguenti parole tratte dal racconto e ricopia nel quaderno il significato che ti sembra più adatto: contrada, fama, greppia, designato, approntare, casolari, raggiante, gaudio, selva.

LA NOTTE SANTA
Era il Natale. Tutti erano andati in chiesa meno la nonna ed io; credo che noi due fossimo le sole persone rimaste a casa. Non eravamo andate con gli altri, l’una perché troppo giovane, l’altra perché troppo vecchia.
E s’era tutte e due tristi di non poter ascoltare il coro mattutino e veder i lumi di Natale. Ma mentre stavamo sedute in quella solitudine, la nonna cominciò a raccontare:
«C’era una volta un uomo, che uscì fuori nella notte per cercare del fuoco. Andò di casa in casa picchiando:
“Oh, buona gente, apritemi! La mia donna ha dato alla luce un bambinello ed io devo aver del fuoco per scaldare lei e il piccino”
Ma era notte profonda, tutti dormivano, nessuno ascoltava.
L’uomo camminò a lungo, a lungo; quando, lontano, vide un chiarore. Rivolse i passi verso quella parte e vide un gran fuoco bruciare all’aperto; e intorno al fuoco un gran numero di pecore bianche addormentate e un vecchio pastore a guardia del gregge. Quando l’uomo si avvicinò alle pecore vide tre grossi cani ai piedi del pastore: si destarono, spalancarono le fauci per abbaiare, ma non si udì alcun latrato; poi arricciarono il pelo, mostrarono le zanne scintillanti al fuoco e si gettarono su l’uomo. Egli sentì che tentavano

di addentarlo alla gola, alle mani, alle gambe, ma le zanne non obbedivano al morso e l’uomo non ebbe alcun impedimento.
Volle allora avvicinarsi al fuoco; ma le pecore giacevano così fitte dorso a dorso, che egli non poteva passare. Ma poi passò sui corpi delle pecore addormentate e nessuna si destò e neppure si mosse».
A questo punto la mia curiosità non poté più frenarsi e interruppi la nonna:
«Perché, nonna, le pecore non si muovevano?».
Ma essa rispose:
«Aspetta un poco e lo saprai» e continuò:
«Quando l’uomo giunse vicino al fuoco il pastore alzò gli occhi. Era costui un vecchio burbero e arcigno, duro verso tutti. Vedendo lo straniero afferrò il lungo bastone acuminato e glielo lanciò contro; ma il bastone sibilò per l’aria e quando stava per colpirlo, deviò andando a cadere lontano sul campo».
Qui dovetti interrompere di nuovo la nonna:
«Perché, nonna, il bastone non voleva colpire quell’uomo?» ma la nonna non pensò nemmeno di darmi retta e continuò:
«Ora l’uomo si fece vicino al pastore e gli disse:
“Amico, aiutami e dammi un po’ di fuoco. La mia donna ha dato alla luce un bambinello e devo scaldar lei e il piccino”.
Il pastore avrebbe voluto dirgli di no: ma pensando che i cani non lo avevano morso, che le pecore non si erano mosse, che il bastone non l’aveva colpito, fu preso da timore e non osò negarglielo.
“Prendine quanto ne vuoi” disse. Ma non c’era né un ceppo acceso, né un ramo, solo un grande braciere; e lo straniero non aveva né pala né orciuolo per prendere e portar via la brace.
Quando il pastore se ne accorse ripeté con gioia cattiva:
“Prendine quanto ne vuoi”. E pensava: “Non potrà prendere nulla”.
Ma l’uomo si chinò e con le mani prese i carboni più accesi e li mise nel mantello. I carboni non gli bruciarono né le mani né il mantello ed egli li portò via come fossero noci e mele».
Qui interruppi la nonna per la terza volta:
«Perché, nonna, i carboni non volevano bruciare quell’uomo?».
«Lo saprai» rispose la nonna, e continuò:
«Quando il vecchio pastore, burbero e arcigno, vide questo strano caso, cominciò a stupirsi:
“Che notte può essere questa che i cani non mordono, le pecore non si spaventano e il fuoco non brucia?”.
E richiamò indietro lo straniero:
“Che notte è questa? E come avviene che tutte le cose hanno pietà di te?”.
“Non te lo posso dire se non lo vedi da te” e riprese la via del ritorno per portare il fuoco alla donna e al bambinello.
Ma il pastore pensò di non perderlo d’occhio per sapere il perché di quei casi così strani, e si levò per seguirlo sino alla sua dimora.
Vide che l’uomo non aveva nemmeno una capanna, e la donna e il bambinello giacevano in una grotta ove non erano che nude pareti di pietra.
Allora il pastore pensò che l’innocente poteva morire di freddo in quella grotta e, sebbene duro di cuore, si commosse e volle difendere il neonato dal freddo. Sciolse il sacco, tolse una morbida e candida pelle di pecora e la diede allo straniero per fare un giaciglio al bambinello.
Nel momento in cui anch’egli sentiva la pietà, vide ciò che non aveva potuto veder prima e udì ciò che non aveva potuto udir prima. Intorno a lui era una fitta schiera di piccoli angeli, con le ali d’argento. Tutti avevano un liuto e cantavano ad alta voce che nella notte era nato il Salvatore. Colui che doveva salvare il mondo dai peccati.
Allora comprese perché tutte le cose non volevano far male ed erano così soavi. E non solo intorno al pastore vedeva gli angeli, ma li vedeva ovunque: nella grotta, sul monte e a volo sotto la volta celeste. Venivano a frotte e passando sostavano e gettavano uno sguardo al bambinello.
Era grande giubilo, grande letizia e canti e suoni nella notte oscura, dove egli prima non aveva potuto veder alcuna cosa.
Ed era così felice che i suoi occhi ora fossero aperti e potessero vedere, che cadde in ginocchio e ringraziò Iddio».
Qui la nonna sospirò:
«Ciò che il pastore vide, potremmo vederlo anche noi, perché ogni notte di Natale gli angeli volano sotto la volta del cielo, e se sapessimo vedere, li vedremmo anche noi».
E la nonna mi posò ancora la mano sul capo e disse:
«E questo lo devi sempre rammentare, perché è vero come io vedo te e tu vedi me. Non dipende né da lumi o da lampade, né dalla luna o dal sole, ma soltanto dai nostri occhi, poter vedere lo splendore di Dio».
Selma Lagerlöf, La leggenda della rosa di Natale, Iperborea
1. In questo racconto si alternano il dialogo fra l’autrice bambina e la nonna e la storia del pastore. Con una matita colorata circonda le parti che riguardano la storia e sottolinea la frase che ti fa capire il cambiamento che accade nel pastore.
2. Spiega con le tue parole il motivo degli strani casi che accadono.
LA “MAGIA” DELL’INVERNO
Nei giorni d’inverno, quando mi svegliavo, c’erano “fiori” bianchi di gelo, ai vetri delle finestre. Allora la mamma mi avvolgeva in una coperta di lana e mi portava giù, in cucina.
E da lì io vedevo la “magia”.
Sul piano del focolare posava un po’ di carta, sopra la carta metteva dei ramoscelli secchi ben ordinati, e su questi qualche pezzo di legno più grosso.
Poi prendeva da una scatolina uno steccolino di legno e zac! Lo strofinava e nasceva all’improvviso una fiammella. Avvicinava la fiammella alla carta e subito si sprigionava il fuoco. Il fuoco, con le sue fiamme dai colori diversi, era per me un mistero.
Osservavo a lungo, sotto il paiolo della polenta, mentre la mamma rimestava la farina, le lunghe fiamme che salivano da ogni parte e parevano vive, con quei colori mai uguali: rosso, violetto, giallo e persino verde e azzurro…
Nelle sere d’inverno, la mamma metteva sul focolare un grosso pezzo di legno che bruciava lento. Io mi avvicinavo, lo toccavo con la paletta e lui mandava fuori scintille simili a stelline che salivano dentro il camino.
Mario Lodi, Il cielo che si muove. 15 storie di natura, Editoriale Scienza
ESPLORA LA SCRITTURA!
Leggi il brano La “magia” dell’inverno, rispondi e completa.
1. Cosa sono i “fiori” bianchi di cui parla l’autore del brano?
2. Qual è la “magia” di cui parla l’autore?
3. Pensa all’inverno di quest’anno, completa le frasi imitando l’autore e racconta la tua esperienza.
• «Nei giorni d’inverno, quando mi sveglio…»
Cosa vedi dalla finestra? Cosa fai?
• «Osservo a lungo…».
Cosa ami osservare durante il tragitto che fai per venire a scuola?
• «Nelle sere d’inverno…».
Cosa ami fare nelle sere invernali?
LA BRINA
Tutto tace nella campagna. I ruscelli scorrono senza mormorio sotto il ghiaccio, quasi sotto una volta di cristallo smerigliato; i torrenti sono gelati od asciutti; le mandrie fumano sdraiate nelle tiepide stalle; i cani giacciono accovacciati in uno stato di dormiveglia; i gatti fan le fusa accosciati in un angolo del focolare.
Tutto tace di nuovo, e il silenzio si accorda con l’uniformità dell’immenso bagliore che copre come un magico velo il monte, il piano, la valle, i villaggi, le città.
Tutto investe, tutto penetra la brina, a quella guisa che il musco riveste i tronchi dal lato che guardano a settentrione.
Volgiamoci alla città. La brina ha, con ogni più scrupolosa diligenza, ricoperti di candidissima vellutatura gli spigoli dei tetti, delle facciate dei monumenti.
Cornici, barre, cancelli, tutto è disegnato in rilievo da essa.
Anche i fili telegrafici s’ingrossano in funi di cristallo.
La brina ha ingemmato tutte le cose, stendendo su di esse il suo luccicante velo di cristallo e ne ha mutato il solito aspetto in altro degno di un paesaggio fiabesco.

LA CITTÀ SEPOLTA NELLA NEVE
Quel mattino lo svegliò il silenzio. Marcovaldo si tirò su dal letto col senso di qualcosa di strano nell’aria.
Non capiva che ora era, la luce tra le stecche delle persiane era diversa da quella di tutte le ore del giorno e della notte.
Aprì la finestra: la città non c’era più, era stata sostituita da un foglio bianco.
Aguzzando lo sguardo, distinse, in mezzo al bianco, alcune linee quasi cancellate che corrispondevano a quelle che vedeva abitualmente: le finestre, i tetti e i lampioni lì intorno, ma perdute sotto tutta la neve che c’era calata sopra nella notte.
«La neve!» gridò Marcovaldo alla moglie, ossia fece per gridare, ma la voce gli uscì attutita. Come sulle linee e sui colori e sulle prospettive, la neve era caduta sui rumori, anzi sulla possibilità stessa di far rumore; i suoni, in uno spazio imbottito, non risuonavano, non avevano né rimbombo né eco.
Andò al lavoro a piedi, i tram erano fermi per la neve.
Per la strada, aprendosi lui stesso la sua pista, si sentì libero come non s’era mai sentito.
Nelle vie cittadine ogni differenza tra marciapiedi e carreggiata era scomparsa, veicoli non ne potevano passare e Marcovaldo, anche se affondava fino a mezza gamba a ogni passo e si sentiva infiltrare la neve nelle calze, era diventato padrone di camminare in mezzo alla strada, di calpestare le aiuole, d’attraversare fuori dalle linee prescritte, di avanzare a zig-zag.
Italo Calvino, Marcovaldo, Mondadori

Dopo aver riletto La città sepolta nella neve, rispondi alle domande.
1. Da che cosa viene svegliato Marcovaldo una mattina?
2. Qual è la prima cosa diversa che nota?
3. Che cos’è il foglio bianco che vede dalla finestra?
4. Quale effetto fa sui rumori la novità accaduta?
5. Di solito come va al lavoro Marcovaldo?
6. Come si sente Marcovaldo mentre procede per la strada? Secondo te perché?
INCON T R I AMO LA POESIA
CANZONE D’INVERNO
Quando i ghiaccioli pendono dall’orlo dei muri, e il pastore Dick si soffia sulle dita, e Tom ammucchia i ceppi nell’atrio, e il latte gela nel secchio, quando il sangue si intorpidisce e le strade diventano fangose, allora, di notte, canta la chiassosa civetta: tu-u tu-u, tu-u, allegra nota, mentre la grassa Gianna rimesta la pentola.
Quando il vento soffia più rumoroso, e la predica del parroco annega la tosse, e gli uccelli stanno accovacciati nella neve e il naso di Marianna è rosso e screpolato e le mele cotte sibilano nella teglia, allora, di notte, canta la chiassosa civetta: tu-u, tu-u, tu-u, allegra nota, mentre la grassa Gianna rimesta la pentola.
William Shakespeare
ASCOLTAMI INVERNO
Ascoltami inverno non sognarti di entrare. Mi piaci sui rami sdraiato nel cielo disteso sul mare seduto nel prato ma ascoltami inverno non ti voglio qui dentro.
Se bussi sui vetri ti soffio sul naso.
Se suoni alla porta non ti aprirò. Ascoltami inverno non ti voglio qui dentro.
Però aspettami fuori. Non andare lontano. Adesso esco io. Possiamo giocare.
Mi piace trovarti sull’uscio di casa sentir sulla faccia le tue dita gelate ma ascoltami inverno non ti voglio qui dentro. Qui dentro è il mio cuore.
Giusi Quarenghi
COME UN POETA
In queste poesie ci sono delle parole che si ripetono dando un ritmo alle strofe.
Si chiama anafora la ripetizione della parte iniziale del verso. Questa ripetizione sottolinea e rafforza un concetto o un’immagine che il poeta desidera comunicare.
Prova anche tu ad usare l’anafora.
Scegli una delle due poesie e prosegui tu, raccontando nella stessa modalità dell’autore, cioè incominciando con il verso che viene ripetuto.

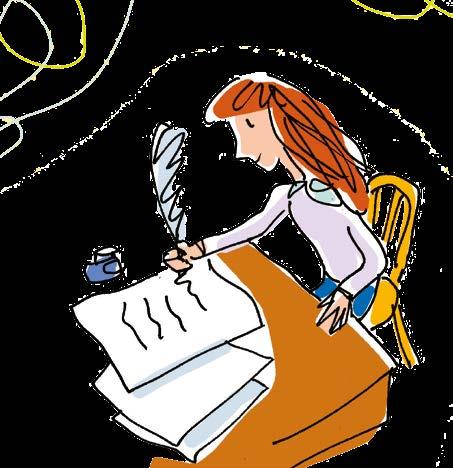
LA FUGA DELL’AMMALATO
Una sera i signori De Servi chiamarono con urgenza il medico, perché il nonno stava male.
Dopo un’ora, grasso, tronfio, tutto vestito di nero, con un grosso naso ed un gran cappello arrivò il dottor Balanzone di Bologna.
Si avvicinò con aria solenne al letto del nonno e incominciò:
«Questo est il paziente, l’ammalato, l’uomo dalla salute cagionevole?».
«Sì, Eccellenza…».
«Volete che gli parli in italiano, in dialetto bolognese o in latino latinorum?».
«Ma… veramente.., per noi…».
«Desiderate che io scriva, parli, danzi, faccia smorfie, balbettii? Posso scegliere il linguaggio che più vi aggrada poiché io sono dottissimo: ho studiato all’Accademia degli Asinelli, all’Università dei Merli, alla Grande Scuola dei Pomodori Ripieni. Io sono Laureato in Larghezza, Altezza, Lunghezza. Io sono un GRANDE DOTTORE, un MAGNO DOLOREM. Toh… a proposito… magno anche subito se volete!».
«Ma come volete che si pensi a mangiare in un momento come questo» esclamarono indignati i De Servi. «Non vedete che il nonno è gravissimo? Presto…». «Calma, calma» replicò Balanzone. «Ora mi accingerò a… visitare l’ammalato.
Volete che gli tocchi il polso sinistro od il destro? La gamba od il torace? Gli faccio una puntura, cento punture? Volete che gli tolga il fegato?».
«IL FEGATO!!!???».
«Oppure desiderate che gli tolga la milza, il cuore, i polmoni, l’orecchio destro, il ginocchio sinistro?».
A questo punto il nonno, stanco di tutti quegli spropositi, si alzò e così in camicia come era andò all’osteria a scolarsi una bottiglia di Lambrusco, lasciando il dottor Balanzone… in eredità ai parenti!
Angeli Crepaldi, Le maschere, Piccoli
Formate piccoli gruppi, dividetevi le parti (narratore, dottor Balanzone, i De Servi) ed esercitatevi nella lettura espressiva del brano.
STORIE DA RIDERE
AHI AHI AHI!
Un tale prende a noleggio un cammello e gli viene spiegato che per guidarlo deve dire queste poche parole: «ouf» per farlo partire, «ouf ouf» per farlo galoppare, «amen» per farlo fermare.
Il turista dice «ouf» e il cammello si incammina.
Inebriato dalla velocità, l’uomo grida «ouf ouf» e la bestia si mette a correre come il fulmine e non rallenta nemmeno quando si vede in lontananza avvicinarsi un burrone.
Il turista non ricorda più le parole per fermare il cammello e si mette a pregare concludendo con la parola «amen». È a questo punto che il cammello si blocca sull'orlo del precipizio. Il turista sospira «ouf»!
LE VIRGOLE
La maestra spiega agli alunni le virgole. Ecco il risultato del primo dettato dopo la spiegazione:
«L’uomo entrò nella casa sulla testa, portava un cappello grigio ai piedi, grossi stivali sulla faccia, un maschio sorriso in mano, un bastone d’ebano nell’occhio, uno sguardo penetrante».
ESPLORA LA SCRITTURA!
Segna con un colore le virgole al posto giusto.
Fai il disegno dell’uomo così come è descritto.
INCON T R I AMO LA POESIA
PICCOLA NUVOLA DI PRIMAVERA
Dopo l’acquata le nuvole, pronte, pigliano il volo, scavalcano il monte. Or con la gonna di velo sottile, la più pigra s’impiglia al campanile. «Lasciami con codesta banderuola, mi strappi tutta! Son rimasta sola!». Ma il campanaro senza discrezione le risponde col campanone!
Che sobbalzo, che sgomento!
Per fortuna c’era il vento che con tutta galanteria la piglia e se la porta via. La porta a spasso lieve lieve sul torrente, sulla pieve; tutto il mondo le fa vedere, tetti rossi, maggesi nere…
E che brillìo di vetri e foglie!
Quanti bambini lungo il rio! Quante vecchie sulle soglie!
Che festa, che chiacchierio!
Bimbi e rondini a strillare, e bucati a salutare, e ragazze alla finestra… e il poeta a stillarsi la testa!
O primavera, uccelletto fuggitivo, tu canti, io scrivo.
Ugo Betti
PASQUA DI RESURREZIONE
E con un ramo di mandorlo in fiore, a le finestre batto e dico: «Aprite!
Cristo è risorto e germinan le vite nuove e ritorna con l'april l'amore
Amatevi tra voi pei dolci e belli
sogni ch'oggi fioriscon sulla terra, uomini della penna e della guerra, uomini della vanga e dei martelli.
Aprite i cuori. In essi irrompa intera di questo dì l'eterna giovinezza».
Io passo e canto che la vita è bellezza.
Passa e canta con me la primavera.
Ada Negri
IL RISVEGLIO DEL VENTO
Nel colmo della notte, a volte, accade che si risvegli, come un bimbo, il vento.
Solo, pian piano, vien per il sentiero, penetra nel villaggio addormentato.
Striscia, guardingo, sino alla fontana; poi si sofferma, tacito, in ascolto.
Pallide stan tutte le case, intorno; tutte le querce mute.
Rainer Maria Rilke
COME UN POETA
Scrivere poesie è anche giocare con un certo numero di sillabe, scegliere il ritmo.
Il ritmo più armonioso e principale della metrica italiana è l’endecasillabo, formato da undici sillabe. Le sillabe su cui cade l’accento, o si appoggia la voce, si chiamano toniche.
In questa tabella sono riportati i versi della poesia Il risveglio del vento: puoi osservare il conteggio delle sillabe.
Nel col- mo del- la not- te a vol- te ac- ca- de
che si ri- sve- glia co- me un bim- bo il ven- to
So- lo pian pia- no vien per il sen- tie- ro
Pe- ne- tra nel vil- lag- gio ad- dor- men- ta- to
Scopriamo gli endecasillabi.
1. Completa l’inserimento delle “sillabe toniche” nella tabella e conta le sillabe di ogni verso.
2. Recita la poesia, accompagnato dal ritmo delle mani o di uno strumento ritmico, che cadenzi le sillabe toniche individuate.

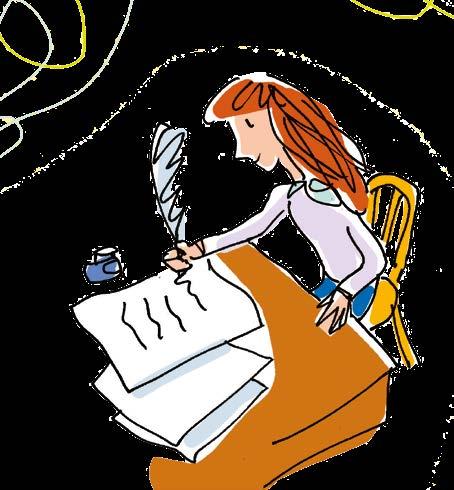
Gioco a gruppi “A caccia di endecasillabi”
Ci si divide in gruppi e ogni gruppo ha a disposizione 11 sassi e 11 foglietti di carta. Ogni gruppo sistema in riga gli undici sassi per terra e si ricrea il primo endecasillabo del componimento, riscrivendo con un pennarello le sillabe toniche del primo verso «Nel colmo della notte, a volte, accade» sui sassi. Ogni gruppo inventa poi un nuovo endecasillabo, che sia il proseguimento del primo e rispetti il ritmo, disponendo le sillabe sotto ai sassi.

A turno, ogni gruppo, seguendo il ritmo dei legnetti o delle mani della maestra, legge ai compagni il proprio endecasillabo e mostra la suddivisione delle sillabe toniche sotto ai sassi.
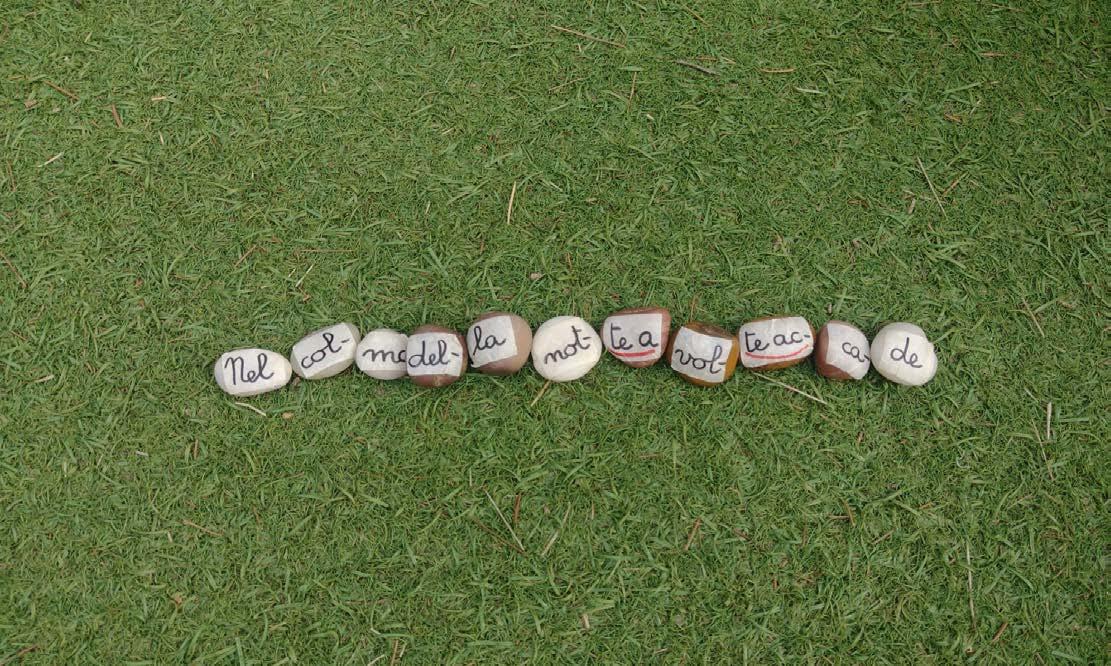
PROMESSA A FINE MARZO
Splendidi, i boschi silenziosi e bianchi, dove i nostri passi suonano secchi sul terreno duro; ma sembra, ecco, che tutto, attorno, sia stato rappreso per sempre in un rigore di morte.
Ma non bisogna crederci. L’acqua del ruscello qui sotto ricomincerà a lambire la neve, con quel gorgoglio insistente e gentile che dice: andiamo, è ora di tornare a correre. Dai rami neri spunteranno gonfie, gravide le gemme.
Si moltiplicheranno sull’ultima neve le tracce di passi timidi, di marmotte, di lepri indaffarate a cercare cibo; fruscii, squittii, richiami.
Questa notte così fredda e nera e ostile, così trionfante, avrà perso una volta ancora la sua guerra.
Ciò che sembrava secco germoglia. Quello che era sepolto rinasce.
Promessa mantenuta, giuramento perenne e fedele. Bisognerebbe guardare attentamente questi prati grigi, cogliere l’istante in cui la terra vive di nuovo. Basta aprire gli occhi, alla fine di marzo, per vedere.
Qual è la promessa di fine marzo di cui parla la scrittrice?


PRIMAVERA
Mattina limpida, di domenica.
Le campane della chiesa dei frati suonavano l’ora di Messa: dai vetri dei balconi il sole invadeva il mio studio: di là dai vetri scorgevo la neve scintillare sui tetti delle case di faccia, quasi rosea al filo dell’azzurro, con spolverate di brillanti, e trine e rabeschi di ghiaccio all’altezza delle grondaie. Nel tepore della piccola stanza indovinavo il salubre e frizzante vibrare dell’aria esterna…
Ancora dunque, la certezza di una primavera: giornate che si allungano, aria che si riscalda, prati che rinverdiscono, primule senza gambo che, se le vuoi cogliere, le strappi con la terra e tutto: così fresca la terra nelle mani.
E ancora gli alberi da frutto che si fanno bianchi e rosa come le nuvole.
E ancora, ancora, per noi, forza da riprendere, lavoro da compiere, promesse da mantenere, anime da conoscere, sangue da rinnovare: vita, insomma, da vivere.
SONO
NATE LE VIOLE
E dove mai se ne stavano nascoste tutte queste mammole?
Proprio come le stelle che fino a una certa ora della sera non ci si pensa: poi, a un tratto, se levi lo sguardo, il cielo ti trafigge gli occhi con miriadi di spilli.
Dappertutto mammole: nella prateria dietro la casa, lungo i cigli dei viali, sulle prode del laghetto, all’ombra dei pini e dei pioppi.
Non v’è tronco che non abbia, alla radice, tra i fili dell’erba, e i ciuffi dell’edera, la sua corona di mammole. Brune di un bruno intenso, voluttuoso, di ciglia abbassate: timide e pur d’un rilievo schietto tra le fogliuzze a cuore; e d’una fragranza sì penetrante nella sua tenuità, che le narici la sentono prima che l’occhio le scopra.
Se mi curvo su di loro, le distinguo una per una, e nessuna è uguale all’altra: quale più oscura e quale più smorta, quale socchiusa e quale troppo aperta; ma tutte col gambo debole e corto, la testina che si piega, una grazia occulta più espressiva della parola. Sto bene accanto a loro seduta sull’erba.
SCRIVI TU!
1. Nei due brani la scrittrice descrive i segnali dell’arrivo della primavera. Quali elementi del paesaggio prende in considerazione? Cerchiali nei testi.
2. In ogni brano è presente una similitudine. Sottolineale, scegline una, ricopiala nel quaderno, spiegala con le tue parole e rappresentala con il disegno.
3. Qual è stato il primo segno dell’annuncio della primavera che hai osservato quest’anno (un ramo, un fiore, una siepe, il tuo giardino che ha mutato aspetto…)? Descrivilo utilizzando aggettivi e similitudini.
IL DONACIBO: UNA PROPOSTA PASQUALE
La maestra ha proposto a tutti i bambini della mia classe di partecipare alla raccolta del cibo per le persone bisognose, un’iniziativa denominata “Donacibo”.
Inizialmente avevo pensato di chiedere il cibo ai miei compagni del catechismo, ma non essendoci andata ero abbastanza triste, perché mi sarebbe piaciuto fare la proposta a qualcuno e non sapevo a chi chiederlo.
La mamma mi ha detto: «Perché non lo chiedi al nonno?».
Io lì per lì mi sono un po’ spaventata. Dovete sapere che purtroppo, da quando è morta la mia cara nonna, lui è molto triste e, non credendo tanto in Gesù, certe volte si sente che borbotta: «Ma perché, cos’ho fatto?».
Io sono molto timida e non riesco ad avere il coraggio neanche di andargli a parlare, a mala pena rispondo alle sue domande! Allora, un po’ spaventata mi sono avvicinata e gli ho spiegato che cosa fosse il Donacibo. Lui è stato zitto due secondi e poi, subito, di colpo, mi ha detto: «Ma certo, vieni giù, a casa mia, che ti do un bel sacchetto di pasta e due o tre scatolette di legumi».
Io ero contentissima che il nonno mi aiutasse per la raccolta del Donacibo e poi ero contenta perché, sempre grazie a questa iniziativa, ero riuscita a parlare un po’ di più con il nonno.
Mi piace e mi è sempre piaciuto aiutare chi ha bisogno!
SCRIVI TU!
Racconta quando hai avuto l’occasione di partecipare a un gesto di solidarietà e che cosa hai imparato.
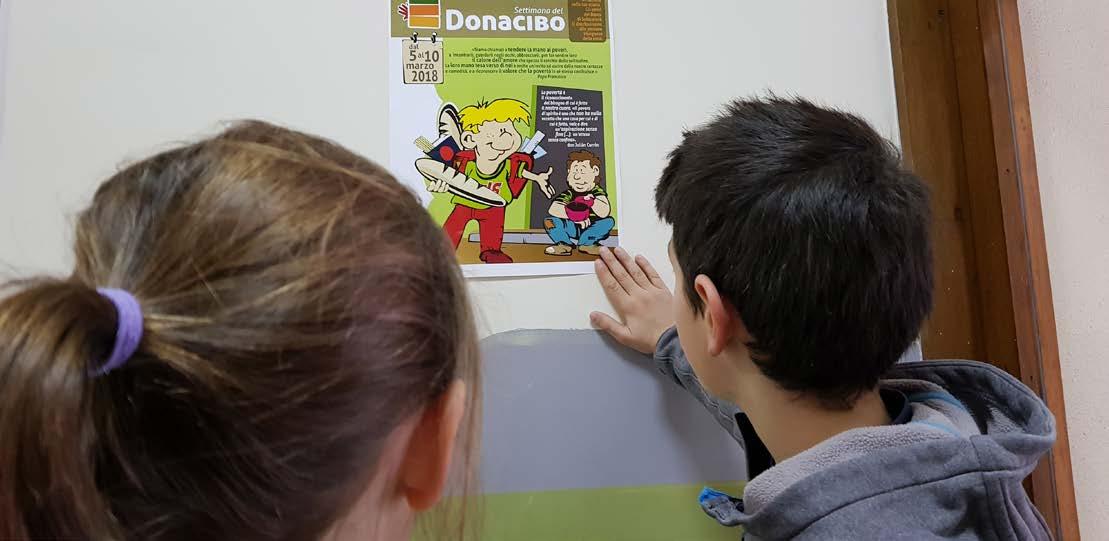
LA LEGGENDA DELL’ULIVO
Un tempo l’ulivo era dritto e liscio come il pioppo.
Quando Caifa, il sommo sacerdote di Gerusalemme, poté ottenere la condanna di Gesù, mandò in giro per la campagna alcuni sgherri a cercare un albero per farne la croce.
Gli sgherri uscirono dalla città armati di scure e si diressero verso il bosco. Il bosco, come preso da un uragano, cominciò ad agitarsi.
Gli alberi invocavano la morte, chiamavano su di sé il fulmine, chiedevano di diventare cenere.
Quando i quattro sgherri giunsero al bosco, un gran silenzio pesava intorno.
Non si sentiva uccello cantare, né fruscio di fronda.
Ogni albero in sé pregava il cielo che gli fosse risparmiato un così terribile destino.
Infine uno degli sgherri disse:
«Né palma né cedro fanno al caso nostro. L’ulivo ci vuole!».
Cedri e palme trassero un gran sospiro di sollievo.
Gli ulivi invece si sentirono perduti. Tentarono di sradicarsi dal terreno, si torsero, ingobbirono, si spaccarono. Alla fine rimasero fermi, impotenti a fuggire, ma inutili per sempre ad essere legno di croce.
Invano gli sgherri cercarono per tutto il giorno un ulivo diritto.
Da allora l’albero dalle foglie d’argento vive felice d’essere brutto.
sgherri: uomini armati prepotenti.
ESPLORA LA SCRITTURA!
1. A quale fatto realmente accaduto è legata questa leggenda?
2. Quale caratteristica dell’ambiente naturale vuole farci comprendere?

LA TORTA DI PASQUA
In alcune zone d’Italia si usa ancor oggi mangiare nel giorno di Pasqua una torta fredda, fatta con farina, spinaci, uova e formaggio.
È una tradizione molto antica, che risale al Medioevo.
Ecco come viene raccontata.
Riportiamoci ora con la fantasia ai tempi in cui i castelli feudali proteggevano e sorvegliavano le valli.
In ogni castello c’era un signore, da cui dipendevano i poveri villaggi sottostanti. E tra gli altri signori ce n’era uno che era più coraggioso e più buono di tutti. Egli aveva una sposa dolce e gentile, che si preoccupava di aiutare e soccorrere i contadini dei paesi vicini, ed era perciò molto amata.
Per questo motivo, in una splendida mattina di Pasqua, mentre le campane suonavano e da ogni villaggio i contadini salivano a porgere i loro auguri ai signori, affluiva a quel castello una folla che portava doni alla buona signora.
Il castellano, ritto nella grande corte con a fianco la sua sposa, accoglieva tutti con bontà, stringeva a ciascuno la mano dura e callosa e ringraziava con un sorriso per i doni: un cestello di uova, un poco di burro, una ricottina, ricambiando ogni offerta con monete e capi di vestiario.
La castellana intanto si tratteneva con le donne, chiedeva della casa, dei bambini, e accarezzava i piccini che le si stringevano intorno.
In un angolo, un gruppo di giovani donne bisbigliava: ridevano sommesse, si spingevano, si davano di gomito e trascinavano una di loro, che reggeva una larga teglia coperta da un panno.
Costei pareva intimidita e non osava avanzare, nonostante le sollecitazioni delle compagne.
La signora si accorse di questa piccola scena e interrogò le donne con un sorriso. Allora finalmente quella che portava l’involto fece qualche passo avanti e, porgendo la teglia con gesto goffo, mormorò: «Ecco, prendete!».
«È per me?» interrogò la castellana.
Ora che il ghiaccio era rotto, pareva che ogni donna volesse dire la sua e parlavano tutte insieme, senza più mostrare timidezza.
«È per voi, sì, per quello che avete fatto per il mio uomo…».
«E per mio figlio, quando era malato…».
«E per il denaro che mi avete dato…».
«Che cos’è?» le interruppe la signora, un po’ imbarazzata da tutte quelle lodi.
«È una torta…».
«L’abbiamo fatta noi…».
«È roba da poveretti… ma l’abbiamo fatta con il cuore…».
«Forse vi piacerà…».
E infatti quella torta fredda, fatta con farina, spinaci, uova e formaggio («roba da poveretti», avevano detto le donne) piacque molto ai castellani, e da allora ogni anno le contadine ne offrirono loro una simile, nella mattina di Pasqua.
E l’abitudine rimase: anche oggi si mangia quel piatto tradizionale, benché non ci siano più i feudatari cui regalare la torta fredda di Pasqua.
C. Ferri, La veglia, Bietti
SCRIVI TU!
1. Presenta una tradizione o un piatto tipico legato alla festa di Pasqua.
2. Riassumi la leggenda in una o due frasi, usando al massimo venti parole.

LA VOCE DELL’ESTATE
All’imbrunire, Rasmus e Oscar fecero sosta vicino ad un piccolo lago. Era stata una giornata calda e avevano vagato a lungo; Rasmus era stanco e tutto quel che desiderava era mettersi lungo disteso su una roccia piatta e riposarsi, ma la lusinga di un bagno prese il sopravvento.
Andò dietro i cespugli e si sfilò rapidamente i vestiti. L’acqua scorreva calda e morbida intorno al suo corpo; era bello muoversi in quel liquido campo e sentire andarsene tutta la stanchezza. Le ninfee ondeggiavano, quando giungeva loro accanto; erano belle e così bianche da sembrare luminose. Era forse quello il giardino privato del re degli Elfi, dov’egli coglieva le rose nelle notti d’estate?
Si girò sul dorso e galleggiò così, per qualche istante guardandosi filosoficamente gli alluci che spuntavano dall’acqua.
Era silenzio, a riva. Lontano, dall’altra parte del lago, un cuculo cantava e il suo canto risuonava così dolce e malinconico che bisognava, per forza, sentirsi buoni. Nel pascolo accanto, delle mucche camminavano e la mucca con la campana (in Svezia, solo la mucca più docile porta la campana e guida le altre) avanzò vasta e massiccia nell’acqua e bevve facendo risuonare dolcemente il suo campanaccio.
Ecco la voce dell’estate, pensò Rasmus. Mentre era disteso nell’acqua e diguazzava, non udiva nient’altro che il tintinnio della campana, il lontano canto del cuculo dall’altra parte del lago e il rumore dell’acqua mossa, e tutto ciò, per lui, simboleggiava la voce dell’estate.
Astrid Lindgren, Rasmus e il vagabondo, Salani

LAMPI E TUONI
Una calda sera d’agosto, con afa e zanzare, mio padre era fuori e mia madre rimestava in un pentolone, sulla stufa, i pomodori raccolti nell’orto per fare la conserva. Mise nella stufa un altro pezzo di legna e mi disse: «Andiamo in cantina a prendere le bottiglie da lavare».
La cantina era fuori, bisognava attraversare un pezzo di cortile, entrare sotto un portichetto, aprire la portoncina e scendere. La mamma mi affidò un candeliere, accese la candela e uscimmo.
Che buio nel cortile! Il cielo era nero, senza nemmeno una stella. All’improvviso una raffica di vento ci investì e spense la candela.
«Facciamo presto» disse la mamma, e accelerò il passo. Aprì la porticina, scendemmo i gradini adagio, nel buio. Poi la mamma accese la candela, posò il candeliere su una botte e cominciò a scegliere le bottiglie e a posarle con ordine in un cesto.
Improvvisamente arrivò fino a noi il rombo di un tuono.
«Il temporale» disse la mamma «affrettiamoci».
Raccolse il cesto, mi consegnò il candeliere, salì fino alla porticina. Come l’apri, il vento gliela chiuse di botto. In quell’attimo il cielo si riempì di tanta luce e tutta la cantina fu illuminata. La candela si spense.
Ci mettemmo a correre verso casa, ma il vento, a tratti, ci fermava di colpo. Volavano dappertutto le foglie strappate dagli alberi, il cielo si accendeva e si spegneva, mentre la voce cupa dei tuoni rimbombava tra le nuvole nere ed enormi che lo riempivano tutto. Io ero incantato da quello spettacolo: non avevo mai visto un temporale di notte così grande, così misterioso.


Una lingua di fuoco si accese nel punto più alto, attraversò il cielo come una biscia e si buttò sulla terra con uno scoppio che fece tremare i vetri delle finestre. La mamma entrò in casa con il cesto tintinnante, poi mise fuori una mano, mi afferrò e mi portò dentro. Ma io volevo vedere ancora il cielo pieno di lampi di tuoni. Mi affacciai alla finestra: vidi il grande spettacolo del cielo che cambiava ogni momento, mentre il vento sulla terra faceva tremare lamiere, sbattere porte, piegava gli oleandri fin quasi a terra. Lampi, tuoni, saette, raffiche di vento, schianti e poi acqua. Era bello e metteva paura. Ma forse non era paura. Era che mi sentivo piccolo piccolo e debole di fronte alla forza della natura.
Ma da dove veniva quella forza? Chi mandava il vento come un lupo di corsa a far fischiare i fili della luce? Era un mistero.
Mario Lodi, Il cielo che si muove. 15 storie di natura, Editoriale Scienza
Dopo aver riletto Lampi e tuoni, rispondi alle domande.
1. Chi sono i protagonisti del racconto?
2. Perché devono andare in cantina?
3. In quale momento della giornata si svolge il racconto e perché il cielo era nero?
4. Perché la mamma vuole fare in fretta?
5. Che cos’è la «lingua di fuoco»?
6. «Il grande spettacolo del cielo che cambiava ogni momento» come te lo immagini? Illustra.
R A CCONTI E FIABE
Canto
La famiglia dei gobboni
Filastrocca veneta in cui si racconta la storia di una famiglia con una caratteristica particolare.
Gobbo so pare, gobba so mare, gobba la figlia e la sorella, era gobba pure quella, la famiglia dei gobbon!
Ascolto
Lo Schiaccianoci
P.I. Tchaikovsky
È un balletto molto godibile, anche nella versione cartone animato, che narra una fiaba russa.

CHICHIBIO E LA GRU
C’era una volta, a Firenze, Messer Corrado, un nobile famoso per la passione della caccia e per le feste che dava nel suo palazzo. Un giorno, avendo catturato col falcone una bella gru, la dette a Chichibio, il suo cuoco, con l’ordine di arrostirla con ogni cura. Il cuoco aveva quasi portato a termine la cottura, quando passò a trovarlo in cucina una bella ragazzotta della contrada, di cui era innamorato. Nel sentire il profumo invitante dell’arrosto, la ragazza tanto fece, finché Chichibio gliene diede una coscia.
La gru fu quindi portata alla mensa di Messer Corrado e subito Chichibio fu chiamato per sapere cosa fosse avvenuto della coscia mancante. Il brav’uomo imbarazzato rispose: «Signore, le gru hanno una gamba sola!». «Come, una sola gamba?» domandò Messer Corrado, «Credi che sia la prima gru che vedo?». Chichibio si sentì obbligato ad insistere: «Eh proprio così! Se avessi degli uccelli vivi, ve lo potrei dimostrare!». Messer Corrado, per rispetto verso gli invitati, non volle continuare la discussione e concluse: «Va bene, domattina andremo a vedere, ma se non sarà come dici tu, te ne pentirai amaramente!». Il mattino dopo al levar del sole, Messer Corrado, a cui durante la notte, la rabbia invece di diminuire era aumentata, si alzò pieno di stizza ordinando di sellare i cavalli. «Adesso vedremo chi di noi due ha mentito!» disse minaccioso. Chichibio, impaurito se la sarebbe data volentieri a gambe e non sapeva cosa fare.
Arrivati però vicino al fiume, riuscì a vedere prima degli altri un gruppo di gru che, ancora addormentate, se ne stavano su una gamba sola, come fanno di solito quando riposano.

«Messere! Messere! Guardate» urlò subito. «Guardate! Avevo ragione io! Vedete che hanno una gamba sola!». «Ah, sì! Adesso ti farò vedere!» e Messer Corrado battendo le mani urlò: «Oh! Oh!». A quel grido le gru posarono a terra l’altra zampa e scapparono.
«Che te ne pare, furfante! Hai visto che hanno due gambe?».
Chichibio pronto rispose: «Mio signore, ieri sera a tavola dovevate gridare “Oh! Oh!” e anche quella avrebbe tirato giù la zampa!».
Nel sentire la divertente risposta, l’ira di Messer Corrado si tramutò in allegria: «Hai ragione, Chichibio, dovevo proprio fare così!», gli disse battendogli la mano sulla spalla. E pace fu fatta.
Peter Holeinone, Il grande libro delle fiabe d'oro, Dami Editore
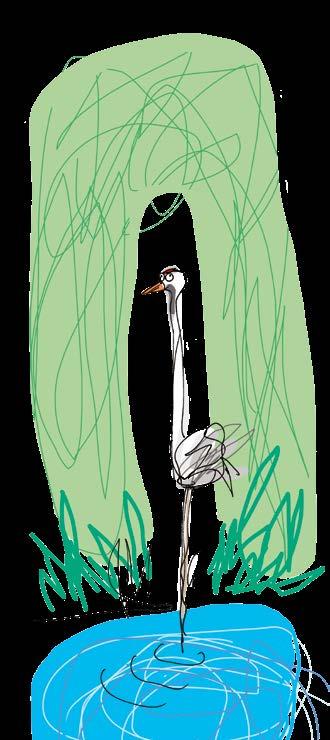
NOÈ E LE TARTARUGHE
Il vecchio Noè se ne stava affacciato alla finestra dell’Arca a godersi quel coloratissimo spettacolo. Era una specie di vivente arcobaleno di groppe e pellicce, ali, squame e piume. Sorrideva e salutava col braccio zebre, gazzelle, cammelli che tornavano a correre e a mordere i morbidi prati del mondo.
Quando gli ultimi animali se ne furono andati scese nelle stanze vuote e disse tra sé:
«Peccato! Ora non si lasceranno più avvicinare, diventeranno di nuovo selvaggi, affamati, paurosi, nemici fra loro e la morte regnerà sulla terra».
Allora, la voce di Dio entrò come il vento ed echeggiò nelle navate dell’Arca:
«Un giorno, quando la storia del mondo sarà alla fine, io pianterò un nuovo giardino a Oriente, un luogo tanto grande da ospitare ogni specie di uomini e animali. Tutti torneranno a vivere in pace come fu all’alba dei tempi: il leone giocherà con l’agnello e i viventi vivranno per sempre senza conoscere la morte».
«Sì, Signore» rispose Noè «io so che tu farai quello che hai detto, però mi piacerebbe che anche gli animali lo sapessero».
Allora si levò di nuovo la voce di Dio come una brezza leggera:
«Ti concedo la facoltà di parlare agli animali. Porta tu stesso la notizia. Dì loro che quando saranno morti la loro anima vivrà e un giorno entreranno tutti nel mio giardino perché nulla andrà perduto di quanto sulla terra ha respirato.
Noè ringraziò e si precipitò fuori con quella bella notizia, ma ormai sull’Arca non c’era più nessuno.
Il vecchio sferrò un calcio a un sasso ed esclamò: «Troppo tardi!».
«Leopardi?» disse il sasso.
«Ci sono dei cardi?» chiese un altro sasso.
Noè sgranò gli occhi: adesso non solo parlava la lingua degli animali, ma addirittura capiva i minerali! Si avvicinò a quei due sassi e li vide muoversi. Guardò meglio e… altro che sassi, erano tartarughe! Mentre tutti gli animali erano usciti in fretta, le tartarughe se l’erano presa comoda e come al solito erano in ritardo…
«Dov’è il leopardo?».
«Trovarvi è una vera fortuna!» disse Noè.
«No, grazie, niente laguna!» rispose una delle due tartarughe.
«Ne abbiamo avuto abbastanza di acqua» concluse l’altra.
Noè si avvicinò per farsi sentire meglio:
«Sono contento che siate ancora qua!».
«Sarà lei un gran baccalà!».
«Non avete capito…».
«A chi scimunito?!».
«Signora tartaruga, sono Noè».
«Chi è?».
«Noè» ripeté il vecchio.
«Cosa non è?».
«Non ho detto non è, ma Noè!».
«Dov’è?».
«Chi?».
«Il caffè».
«Ma che caffè! Ci sono solo io!».
«C’è anche suo zio?».
«Non c’è nessuno zio!».
«Non crede in nessun Dio?».
«Ma sì!!».
«L’ha fatta qui?».
«Cosa?».
«La pipì».
«Ma no!».
«Sul comò? Maleducato!».
«Sul comò cosa c’è?».
«No. Io sono Noè!!!».
«Ha parlato con te».
«C’è o non c’è questo caffè?».
«Ma che tè e caffè, siete sorde!?».
«Ha detto che morde?».
«No. Chiude le porte».
«Non porte, sorde!!!».
«Anche lui parte?».
«Non parto, dico che voi siete sorde!».
«No, grazie a Dio non siamo morte!».
«Noi tartarughe campiamo cent’anni».
«Sì, anch’io ho certi malanni!».
«Lo so. Chi va piano, va sano e va lontano».
«Lo sappiamo che c’è un gran pantano!».
«Un gabbiano che becca un banano?».
«Non c’è nessun banano».
«E il gabbiano?».
«Nemmeno».
«Chi tira il freno?».
«Nessuno».
«Si chiama Bruno?».
«No, di nome faccio Noè!!!».
«A chi faccia da scimpanzé?».
«Io divento matto!».
«Gli è morto il gatto?».
«Poveretto!».
Noè stava per perdere la pazienza in quel bislacco dialogo con quelle due tartarughe. Provò a strillare con tutto il fiato che aveva: «Potreste portare una notizia agli animali?».
«Perché la liquirizia ai maiali?».
«Non ai maiali, a tutti gli esseri viventi!».
«Ha mal di denti!».
«Ecco perché il vecchio strilla!».
«C’è un vecchio gorilla?».
«Anche il gorilla vuol la liquirizia?».
«Notizia, non liquirizia! Siete sorde come campane!».
«Noi non siamo due vecchie befane!».
«Piuttosto lei chi è?».
«Sono Noè!!!».
«Il re di ché?».
«Di niente!».
«Viene gente?».
«Meglio andar via!».
«Si va da tua zia? Viene anche lei Bruno?».
«Non sono Bruno, andate pure!».
«Ha le crostate di more?».
«Non ho le crostate!!!!».
«Le ha mangiate?».
«Ci dà le martellate?».
«No, sta tranquilla».
«Non mi va la camomilla».
Noè rinunciò alle tartarughe e con un sospiro disse:
«Va beh, cercherò qualcun altro».
«Ancora un leopardo?».
«Non c’è nessun leopardo. Andiamo. Siamo in ritardo».
Così le due tartarughe se ne andarono lentamente e Noè rimase a pensare fra sé.
Giampiero Pizzol, Ali di farfalle, Fatatrac
pantano: fango, melma.
NEL LUOGO
DELLE COSE PERDUTE
Il manichino aveva parlato in modo enigmatico. Ma adesso i due capi sembravano tranquilli, così Carl li seguì con Timo. Scoprì che il manichino si chiamava Figurino e lo spaventapasseri Spavento. Il manichino era stato abbandonato sul ciglio della strada da un vetrinista che un giorno l’aveva gettato giù dal suo furgone solo perché aveva un piede rotto.
Lo spaventapasseri, invece, aveva passato tutto l’inverno nell’orto di un uomo che a primavera si era trasferito e l’aveva dimenticato lì.
E così erano arrivati entrambi nel luogo segreto.
Attorno a ogni falò si era raccolto un gruppo di cose scomparse.
Al primo c’erano ombrelli e bastoni. La maggior parte degli ombrelli erano chiusi ma alcuni, soprattutto i più grandi, saltellavano aperti su e giù, oppure si chiudevano e si riaprivano, balzavano in aria per poi planare verso terra come se fosseno paracaduti.
«Un umano! Un umano!» parve di sentire a Carl in mezzo a tutto quello sbatacchiare. E poi: «Deve andarsene! Deve andarsene!».
«È tutto a posto!» gridò loro Figurino. «Ha un’autorizzazione. Lasciateci passare!».
Malvolentieri, gli ombrelli fecero largo.
Attorno al falò successivo c’era un mucchio di maglioni di tutte le misure che muovevano le maniche come se
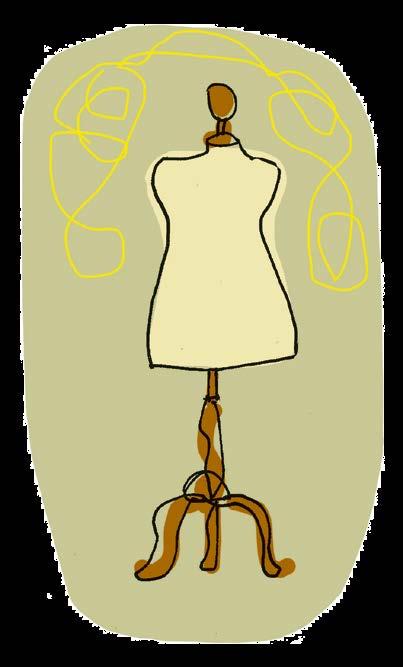

volessero afferrare Carl. Davano l’impressione di essere un’unica creatura lanosa con migliaia di braccia. Carl e Timo oltrepassarono sani e salvi anche i maglioni. Le magliette radunate attorno al terzo falò non avevano le maniche così lunghe. In compenso gonfiarono il petto e i disegni che vi erano stampati o cuciti sopra presero vita. Piccoli coccodrilli che battevano i denti, gatti che miagolavano, volti di pirati che gridavano frasi incomprensibili, uno scheletro che scrollava le ossa. Carl avrebbe voluto fare dietrofront. Invece tenne Timo per il collare e rimase fermo dov’era. Sentì Figurino urlare: «Silenzio! Adesso basta!». Le magliette ammutolirono.
Arrivarono a un’enorme montagna di borsellini, grandi e piccoli, piatti e gonfi, di pelle e di plastica, c’erano anche veri e propri portafogli. In men che non si dica Timo scovò il borsellino rosso con i brillantini di Carl. Glielo portò stretto tra i denti, e per ricompensa ricevette molte lodi e un biscotto. Dentro il portamonete c’era ancora tutto quanto, i soldi, le figurine dei calciatori e persino la carta d’alluminio appallottolata che sembrava una moneta d’argento.
Arrivarono a un mucchio di giocattoli. C’erano macchinine, macchine grandi a pedali, tricicli, vagoni di trenini, biglie di vetro. C’erano animali di plastica, palline di gomma, palloni di cuoio.
In men che non si dica, Timo recuperò il dinosauro di plastica verde e la palla rossa.
«Adesso però voglio andare dal mio Kasper», disse dopo aver sistemato nello zaino le cose ritrovate.
«Pazienza, pazienza!» lo ammonì Spavento dondolando la faccia di scopa. Prima dovettero oltrepassare le bambole e i pupazzi di peluche. Molti erano rotti. Avevano braccia torte, nasi schiacciati, pance tagliate o teste pelate. Si lamentavano e imploravano: «Riparaci, umano!».
Carl provò pena per loro, ma Figurino intervenne con la sua voce nasale: «Non ascoltarli, dicono tanto per dire. Qui stanno meglio che da voi».
Timo drizzò le orecchie, poi si infilò tra i burattini e si fece strada gettandoli di qua e di là. Rispuntò in mezzo al mucchio e scomparve di nuovo. Carl iniziò a sentire un borbottio di protesta che si fece sempre più forte: «Allora! Che modi sono! Qui non si spinge, capito?». Poi Timo abbaiò trionfante. Saltò fuori dal mucchio con un Kasper tra i denti, trottò fino a Carl e appoggiò il burattino ai suoi piedi. Era il suo vero Kasper? O forse no?
Carl infilò la mano destra sotto il vestito. Kasper sollevò la testa e lo guardò.
Lukas Hartmann, Tutte le cose perdute
Dopo aver riletto Il luogo delle cose perdute, rispondi alle domande.
1. Qual è il luogo delle cose perdute?
2. Quali sono le cose perdute di cui si parla nel racconto?
3. Quali oggetti ha perduto il protagonista del racconto? Descrivili.
4. Chi li ritrova?
SCRIVI TU!
Ti è mai capitato di perdere un oggetto a cui eri particolarmente affezionato? Racconta cosa è accaduto, mettendo in evidenza il motivo del tuo attaccamento alla “cosa perduta”. Spiega infine come ti sei sentito quando l’hai ritrovata oppure come ti senti ora che non ce l’hai più.
LO SPECCHIO
Quel che Harry temeva di più era di non riuscire a ritrovare la stanza dello specchio. La notte seguente, con Ron sotto il Mantello insieme a lui, dovette camminare molto più lentamente. Vagarono per circa un’ora nei corridoi immersi nel buio, nel tentativo di ritrovare la strada che aveva percorso Harry partendo dalla biblioteca.
«Sto morendo di freddo» disse Ron a un certo punto. «Lasciamo perdere e torniamo indietro».
«No!» sibilò Harry. «So che è qui, da qualche parte».
Proprio quando Ron ricominciava a lamentarsi dei piedi gelati, Harry scorse l’armatura.
«È qui… proprio qui… sì!»
Aprirono la porta. Harry si lasciò cadere il Mantello dalle spalle e corse verso lo specchio.
Erano tutti lì. Quando lo videro, suo padre e sua madre si illuminarono.
«Hai visto?» sussurrò Harry.
«Non vedo un bel niente».
«Guarda! Guarda quanti sono…»
«Ma io vedo solo te».
«Ma no, guarda bene! Dai, mettiti dove sono io».
Harry si fece da parte, ma con Ron davanti allo specchio non riusciva più a vedere la sua famiglia; c’era solo Ron con il suo pigiama a pallini.
Ron contemplava la propria immagine come pietrificato.
«Ehi, quello sono io!» esclamò poi.
«E vedi tutta la tua famiglia intorno a te?»
«No… sono solo… Ma sono diverso… sembro più grande… sono Caposcuola!»
«Che cosa?»
«Sono… Porto il distintivo, uguale a quello di Bill… e ho in mano la Coppa delle Case, e la Coppa di Quidditch… Sono anche Capitano della squadra!»
Ron distolse a forza lo sguardo da quella visione prodigiosa e guardò Harry tutto emozionato.
«Pensi che questo specchio mostri il futuro?»
«E com’è possihile? I miei sono tutti morti… Fammi guardare un’altra volta».
«Ehi, non mi spingere!»
Un rumore improvviso, fuori nel corridoio, mise fine a quella discussione. Non si erano resi conto che avevano parlato a voce molto alta.
«Svelto!»
Harry riuscì a coprire sé e l’amico col Mantello, proprio nel momento in cui apparivano sulla porta gli occhi fosforescenti di Mrs Norris.
E Ron spinse Harry fuori della stanza.
Ma Harry aveva un chiodo fisso in testa: tornare davanti allo specchio. E non sarebbe stato certo Ron a fermarlo.
Quella terza notte, riuscì a trovare la strada molto più rapidamente delle precedenti. Camminava così in fretta da fare più rumore di quanto consigliasse la prudenza, ma non incontrò nessuno.
Ed ecco di nuovo sua madre e suo padre che gli sorridevano, e uno dei nonni che gli faceva cenno col capo, tutto allegro. Niente gli avrebbe impedito di restarsene lì tutta la notte con la sua famiglia. Niente di niente.
Tranne…

«Allora… di nuovo qui, Harry?»
Harry sentì le budella congelarglisi dentro la pancia. Si guardò alle spalle. Seduto su uno dei banchi appoggiati al muro c’era Albus Silente in persona.
«Allora» riprese Silente scendendo dal banco per sedersi a terra accanto a Harry. «Tu, come centinaia di altri prima di te, hai scoperto le dolcezze dello Specchio delle Emarb».
«Non sapevo che si chiamasse così, signore».
«Suppongo però che ormai tu abbia capito che cosa fa».
«Sì… be’… ci vedo la mia famiglia…»
«E il tuo amico Ron ci si è visto Caposcuola».
«E lei come lo sa…?»
«Io non ho bisogno di un mantello per diventare invisibile» disse Silente con dolcezza.
«Capisci adesso che cos’è che noi tutti vediamo nello Specchio delle Emarb?»
Harry ci pensò su. Poi disse lentamente: «Ci vediamo dentro quel che desideriamo… le cose che vogliamo…»
«Sì e no» disse Silente tranquillo. «Ci mostra né più né meno quello che bramiamo più profondamente e più disperatamente nel nostro cuore. Tu, che non hai mai conosciuto i tuoi genitori, ti vedi circondato da tutta la famiglia.
Ronald Weasley, che è sempre vissuto all’ombra dei suoi fratelli, si vede solo, come il migliore di tutti. E tuttavia questo Specchio non ci dà né la conoscenza né la verità. Ci sono uomini che si sono smarriti a forza di guardarcisi, rapiti da quel che avevano visto; e uomini che hanno perso il senno perché non sapevano se quello che mostrava fosse reale o anche solo possibile.
«Domani, lo Specchio delle Emarb verrà portato in una nuova dimora, Harry, e io ti chiedo di non cercarlo mai più. Se mai ti ci imbatterai di nuovo, sarai preparato. Ricorda: non serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere. E ora, perché non ti rimetti addosso quel meraviglioso mantello e non te ne torni a letto?»
J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale, Salani
Dopo aver riletto Lo specchio, rispondi alle domande.
1. Cosa vede Ron nello specchio? Perché?
2. Cosa vede Herry Potter nello specchio? Perché?
3. Cosa significa la frase: «E tuttavia questo Specchio non ci dà né la conoscenza né la verità»?
4. Qual è “la magia” dello Specchio delle Emarb? Sottolinea le frasi del racconto che la spiegano.
SCRIVI TU!
Se avessi in mano uno specchio magico capace di “mostrare i tuoi desideri”, che cosa vedresti?
Racconta il comparire nello specchio delle immagini e delle scene che descrivano un desiderio che hai in questo momento.
IL GIGANTE EGOISTA
Ogni pomeriggio, al ritorno della scuola, i bambini andavano a giocare nel giardino del gigante.
Era un grande delizioso giardino, pieno di soffice erbetta verde.
Qua e là sul prato spuntavano bellissimi fiori simili a stelle e c’erano anche dodici alberi di pesche che, in primavera, si coprivano di una dolce fioritura color di rosa e di perla e, in autunno, donavano frutti succosi.
Gli uccellini si posavano sugli alberi e cantavano così dolcemente che i bambini lasciavano i loro giochi per poterli ascoltare.
«Come siamo felici!» gridavano allegramente.
Ma un bel giorno il gigante ritornò. Era stato a far visita all’orco suo amico e si era fermato da lui sette anni.
Trascorsi che furono, egli, di natura poco chiacchierone, non trovò più niente da dire e decise di far ritorno al suo castello. Quando giunse, vide tutti i bambini che giocavano nel suo giardino.
«Che cosa fate qui?» gridò con il suo vocione.
Ed essi scapparono via.
«Questo giardino è solo mio!» disse il gigante. «Voglio che tutti lo sappiano e non permetterò più a nessuno di venire a giocare qui».
E subito costruì un alto muro di cinta e attaccò un cartello con questa scritta:
VIETATO L’INGRESSO: I DISOBBEDIENTI SARANNO PUNITI.
Egli era infatti un gigante molto egoista.
I poveri bambini non sapevano più dove giocare; cercarono di andare in strada, ma c’erano tanta polvere e tante pietre aguzze e non riuscirono a divertirsi. Terminate le lezioni, presero l’abitudine di gironzolare intorno all’alto muro, parlando del bel giardino ormai chiuso.
«Com’eravamo felici là dentro!» dicevano fra loro.
Finalmente giunse la primavera e in tutta la campagna c’erano boccioli e uccellini: solo nel giardino del gigante egoista c’era ancora l’inverno.
Gli uccellini, non vedendo i bambini, non cantavano e gli alberi si erano dimenticati di fiorire.
Un giorno un bel fiore mise il capo fuori dall’erba, ma quando vide il cartello, fu così triste per quei poveri bambini che scivolò di nuovo nella terra e si mise a dormire.
Solo la neve e il ghiaccio erano soddisfatti.
«La primavera ha dimenticato questo giardino» esclamarono «perciò noi abiteremo qui tutto l’anno».
La neve copriva l’erba con il suo grande manto bianco e il ghiaccio dipingeva d’argento tutti gli alberi.
Poi invitarono il vento del Nord. Esso venne avvolto in una pesante pelliccia e tutto il giorno fischiava per il giardino e abbatteva i camini.
«È un posto delizioso» disse «dobbiamo invitare anche la grandine».
E la grandine venne. Tre ore al giorno essa picchiava sul tetto del castello finché ruppe le tegole; poi, quanto più veloce poteva, scorrazzava per il giardino.
Era vestita di grigio, e il suo fiato era freddo come il ghiaccio.
«Non riesco a capire perché la primavera tardi tanto a venire» disse il gigante egoista mentre, seduto presso la finestra, guardava il suo giardino gelato e bianco, «mi auguro che il tempo cambi».
Ma la primavera non venne mai e nemmeno l’estate. L’autunno diede frutti d’oro a tutti i giardini, ma nemmeno uno a quello del gigante.
Era sempre inverno laggiù e il vento del Nord, la grandine, il gelo e la neve danzavano tra gli alberi.
Una mattina il gigante udì dal suo letto una dolce musica: risuonava tanto dolce alle sue orecchie che pensò fossero dei musicanti del re che passavano nelle vicinanze. Era solo un merlo che cantava fuori dalla sua finestra, ma da tanto tempo non udiva un uccellino cantare nel suo giardino, che gli parve la musica più bella del mondo.
La grandine cessò di danzare sulla sua testa, il vento del Nord smise di fischiare e un profumo delizioso giunse attraverso la finestra aperta.
«Credo che finalmente la primavera sia venuta» disse il gigante; balzò dal letto e guardò fuori della finestra.
Che vide? Una visione meravigliosa. I fanciulli erano entrati attraverso un’apertura del muro e sedevano sui rami degli alberi. Su ogni albero che il gigante poteva vedere c’era un bambino. Gli alberi, felici di riavere i fanciulli, s’erano ricoperti di fiori e gentilmente dondolavano i rami sulle loro testoline.
Gli uccellini svolazzavano intorno cinguettando felici e i fiori sollevavano il capo per guardare di sopra l’erba verde e ridevano. Era una bella scena. Solo in un angolo regnava ancora l’inverno.
Era l’angolo più remoto del giardino, e vi stava un bambinetto. Era tanto piccolo che non riusciva a raggiungere il ramo dell’albero e vi girava intorno piangendo disperato. Il povero albero era ancora coperto dal gelo e dalla neve e sopra di esso il vento del Nord fischiava.
«Arrampicati piccolo» disse l’albero e piegò i suoi rami quanto più poté: ma il bimbetto era troppo piccino. A quella vista il cuore del gigante si intenerì.
«Come sono stato egoista!» disse. «Ora so perché la primavera non voleva venire. Metterò quel bambino in cima all’albero poi abbatterò il muro e il mio giardino sarà, per sempre, il campo di giochi dei bambini».
Era veramente addolorato per quanto aveva fatto.
Scese adagio le scale e aprì la porta d’ingresso. Ma quando i bambini lo videro, si spaventarono tanto che scapparono, e nel giardino regnò di nuovo l’inverno. Soltanto il bambinetto non scappò; i suoi occhi erano così colmi di lacrime che non vide venire il gigante. E il gigante giunse di soppiatto dietro a lui, lo prese delicatamente nella sua mano e lo mise sull’albero. E l’albero fiorì, gli uccellini vennero a cantare e il bambino allungò le braccine, si avvicinò al collo del gigante e lo baciò. Non appena gli altri bambini videro che il gigante non era più cattivo, ritornarono di corsa e con essi venne la primavera.
«Ora questo è il vostro giardino, bambini» disse il gigante e, presa una grande ascia, abbatté il muro. A mezzogiorno la gente che andava al mercato vide il gigante giocare con i bambini nel giardino più bello che avessero mai veduto. Giocarono tutto il giorno e la sera i bambini salutarono il gigante.
«Dov’è il vostro piccolo amico? Il bambino che io ho messo sull’albero?» chiese.
Il gigante l’amava più di tutti perché l’aveva baciato.
«Non lo sappiamo,» risposero i bambini «se n’è andato».
«Dovete dirgli che domani deve assolutamente venire» disse il gigante. Ma i bambini risposero che non sapevano dove abitasse e che prima non l’avevano mai veduto, e il gigante si sentì molto triste.
Ogni pomeriggio, finita la scuola, i bambini venivano a giocare con il gigante. Ma il bambinetto che il gigante prediligeva non si vide più.
Il gigante era molto buono con tutti, ma desiderava il suo piccolo amico e spesso parlava di lui.
«Quanto mi piacerebbe vederlo» diceva sovente.
Gli anni passarono, e il gigante divenne vecchio e debole. Non poteva più giocare; sedeva in una grande poltrona e osservava i bambini mentre giocavano e ammirava il suo giardino.
«Ho molti bei fiori» diceva «ma i bambini sono i fiori più belli».
Una mattina d’inverno, mentre si vestiva, guardò fuori dalla finestra.
Ora non odiava più l’inverno perché sapeva che era soltanto la primavera addormentata e che i fiori si riposavano. Ad un tratto si fregò gli occhi sorpreso e si mise a guardare intensamente. Era una cosa veramente meravigliosa.
Nell’angolo più remoto del giardino v’era un albero interamente ricoperto di fiori bianchi. Dai rami d’oro pendevano frutti d’argento, e sotto di essi stava il bambinetto ch’egli aveva amato. Il gigante scese di corsa e, tutto acceso di gioia, uscì nel giardino. Si affrettò sull’erba e s’avvicinò al bambino.
Quando gli fu vicino, si fece rosso di collera e disse:
«Chi ha osato ferirti?» perché il bambino aveva il segno di due chiodi sul palmo delle mani e sui piedi.
«Chi ha osato ferirti?» esclamò il gigante «Dimmelo e io prenderò la mia grossa spada e l’ammazzerò».
«No» rispose il bambino «queste sono soltanto le ferite dell’amore».
«Chi sei?» chiese il gigante, e uno strano stupore s’impadronì di lui e s’inginocchiò dinanzi al bambino. Il bambino gli sorrise e disse:
«Un giorno mi lasciasti giocare nel tuo giardino, oggi verrai a giocare nel mio giardino, che è il Paradiso».
Quando nel pomeriggio i fanciulli entrarono di corsa nel giardino trovarono il gigante morto, ai piedi dell’albero tutto coperto di fiori candidi.
SCRIVI TU!
Secondo te perché il gigante cambia atteggiamento?
Sottolinea la parte di testo in cui riconosci questo cambiamento.
Oscar Wilde
LA GOLA DELLA BALENA
Una volta c’era nel mare una balena che mangiava i pesci. Mangiava il carpione e lo storione, il nasello e il pesce martello, il branzino e il delfino, i calamaretti e i gamberetti, la triglia e la conchiglia, e la flessuosa anguilla con sua figlia e tutta la sua famiglia con la coda a ronciglio. Tutti i pesci che poteva trovare in tutto il mare, essa li mangiava con la bocca… così! Tanto che non era rimasto in tutto il mare che un solo pesciolino, un Pesciolino-pieno-d’astuzia che nuotava dietro l’orecchio destro della balena, per tenersi prudentemente fuor di tiro.
Allora la balena si levò ritta sulla coda e disse: «Ho fame».
E il Pesciolino-pieno-d’astuzia disse con una vocina parimenti piena d’astuzia: «Nobile e generoso cetaceo, hai mai mangiato l’uomo?». «No» disse la balena. «Com’è?».
«Squisito!» disse il pesciolino-pieno-d’astuzia, «Squisito ma nodoso».
«Allora portamene un paio» disse la balena, e con la coda fece spumeggiare il mare.
«Uno per volta basta» disse il Pesciolino-pieno-d’astuzia. «Se tu nuoti fino al cinquantesimo grado di latitudine nord e quaranta di longitudine ovest, (questo è magia) troverai, seduto su una zattera, in mezzo al mare, con nulla addosso eccetto un paio di calzoni di tela azzurra, un paio di bretelle (non dovete dimenticare le bretelle, cari miei) e un coltello da tasca, un marinaio naufragato, che – è bene tu ne sii avvertito – è un uomo d’infinite-risorse-esagacità».
Così la balena nuotò e nuotò fino al grado cinquantesimo di latitudine nord e quarantesimo di longitudine ovest, più rapidamente che poté, e su una zattera, in mezzo al mare, con nulla indosso eccetto un paio di calzoni di tela azzurra, un paio di bretelle (dovete ricordare specialmente le bretelle, cari miei) e un coltello da tasca, essa vide un unico e solitario marinaio naufragato, coi piedi penzoloni nell’acqua. (Egli aveva avuto da sua madre il permesso di guazzare nell’acqua; altrimenti non l’avrebbe fatto, perché era un uomo d’infinite-risorse-e-sagacità).
Allora la balena aprì la bocca e la spalancò che quasi si toccava la coda, e inghiottì il marinaio naufragato, con tutta la zattera su cui sedeva, col suo paio di calzoni di tela azzurra, le bretelle (che non dovete dimenticare) e il coltello da tasca. Essa inghiottì ogni cosa nella credenza calda e buia dello stomaco, e poi si leccò le labbra… così, e girò tre volte sulla coda.
Ma il marinaio, che era un uomo di infinite-risorse-e-sagacità, non appena si trovò nel capace e buio stomaco della balena, inciampò e saltò, urtò e calciò, schiamazzò e ballò, urlò e folleggiò, picchiò e morsicò, strisciò e grattò, scivolò e passeggiò, s’inginocchiò e s’alzò, strepitò e sospirò, s’insinuò e gironzò, e danzò balli alla marinara dove non doveva, e la balena si sentì veramente molto infelice. (Avete dimenticato le bretelle?).
Così disse al Pesciolino-pieno-d’astuzia: «Quest’uomo è molto indigesto, e mi fa venire il singulto. Che cosa debbo fare?».
«Digli di uscire» disse il Pesciolino-pieno-d’astuzia.
Così la balena gridò dal fondo della gola al marinaio naufragato: «Esci fuori e comportati onestamente. M’hai messo il singulto».
«No! No!» disse il marinaio. «Non così; in maniera molto diversa. Portami alla sponda natìa, ai bianchi scogli di Albione, e ci penserò».
E continuò a ballare più che mai.
«Faresti meglio a portarlo a casa» disse il Pesciolinopieno-d’astuzia alla balena. «Io ti ho avvertito che è un uomo di infinite-risorse-e-sagacità».
Così la balena si mise a nuotare, a nuotare con le due natatoie e la coda, come meglio le permetteva il singulto; e finalmente vide la sponda nativa del marinaio e i bianchi scogli di Albione, si precipitò sulla spiaggia, spalancò tutta quanta la bocca e disse:
«Per Winchester, Ashuelot, Nasua, Keene e le stazioni della ferrovia di Fitchburg si cambia».
E mentre diceva «Fitch» il marinaio sbucava dalla bocca. Ma mentre la balena era stata occupata a nuotare, il marinaio, che era davvero una persona piena-diinfinite-risorse-e-sagacità, aveva preso un coltello da tasca e tagliata dalla zattera una cancellata a sbarre incrociate, l’aveva saldamente legata con le bretelle (ora sapete perché non si dovevano dimenticare le bretelle) e poi l’aveva incastrata nella gola della balena, recitando il seguente distico, che, siccome non lo conoscete, qui vi trascrivo:
Con le sbarre della grata nel mangiar t’ho moderata. E saltò sulla ghiaia, e si diresse a casa della mamma, che gli aveva dato il permesso di guazzare nell’acqua; e s’ammogliò e d’allora in poi visse felicemente. Com’anche la balena. Ma da quel giorno ad oggi, la grata in gola che essa non può né espellere, né inghiottire, le impedì di mangiar tutto quello che voleva, eccetto i minuti pesciolini, ed è questa la ragione perché le balene non mangiano più uomini, bambine e bambini. Il Pesciolino-pieno-d’astuzia se la svignò e si nascose sotto la soglia dell’Equatore. Temeva che la balena fosse grandemente adirata con lui. Il marinaio portò a casa il coltello da tasca. Aveva indosso soltanto il paio di calzoni di tela azzurra quando s’era messo a camminare sulla ghiaia. Le bretelle l’aveva lasciate strette alla cancellata; e questa è la fine di questo racconto.
Rudyard Kipling, Il libro delle bestie, Prìncipi & Princípi
parimenti: nello stesso modo, ugualmente. sagacità: acume, astuzia, abilità. natatoie: pinne nei cetacei.
SCRIVI TU!
Che cosa può mangiare oggi la balena, secondo il racconto? E all’inizio di questa storia? Racconta brevemente che cosa è successo alla balena, il motivo per cui non può più mangiare tutto quello che vuole.
Dopo aver riletto La gola della balena, rispondi alle domande.
1. Chi sono i protagonisti principali della storia?
2. «Un uomo d’infinite-risorse-e-sagacità». Qual è il significato del termine sagacità?
A. Intelligenza e perspicacia.
B. Forza e coraggio.
C. Bellezza.
3. Sottolinea gli aggettivi presenti nella seguente frase e analizzali. «Nobile e generoso cetaceo, hai mai mangiato l’uomo?».
4. Perché il pesciolino consiglia al cetaceo di mangiare l’uomo?
5. Nella frase all’interno delle parentesi «non dovete dimenticare le bretelle, cari miei», chi parla?
A. Il marinaio naufragato.
B. Il pesciolino.
C. Il narratore.
6. Perché sono importanti le bretelle del marinaio?
7. A quale tempo sono coniugati i verbi presenti nella seguente frase?
«Essa inghiottì ogni cosa nella credenza calda e buia dello stomaco, e poi si leccò le labbra… così, e girò tre volte sulla cosa».
8. Individua nel testo e sottolinea le azioni che compie il marinaio quando viene inghiottito dalla balena.
9. «Con le sbarre della grata nel mangiar t’ho moderata». Con questa frase, quale messaggio vuole comunicare il marinaio alla balena?
10. «Temeva che la balena fosse grandemente adirata con lui». Qual è il significato del termine adirata?
I CIGNI SELVATICI
«Miei cari ragazzi» annunciò il re, «entro pochi giorni mi risposerò…».
A questa notizia, Lisa e i suoi undici fratelli ebbero lo stesso presentimento: la loro esistenza viziata di principi felici stava per terminare.
Quando videro la nuova regina, con l’aria dura e lo sguardo glaciale che rivelava egoismo e cattiveria, i loro timori furono confermati.
Lisa fu la sua prima vittima. Il giorno immediatamente successivo alle nozze, la matrigna mandò Lisa presso una famiglia di contadini che la fecero vivere come la gente rude di campagna. Questa cattiva matrigna aveva persuaso il re che il soggiorno sarebbe stato benefico, anche se in realtà la bambina era trattata come una sguattera.
In seguito cominciò a denigrare gli undici fratellini: ci mise tanto rancore e accanimento che, rapidamente, il re fece allontanare i suoi figli.
«E ora volate con le vostre ali» aggiunse la perfida donna «volate, volate fino in capo al mondo!».
A queste parole, i principi si trasformarono in undici magnifici cigni immacolati e presero subito il volo.
A quindici anni la principessa ritornò al palazzo, con gran dispiacere della matrigna che credeva di essersene sbarazzata per sempre. Quando vide quella bella adolescente,
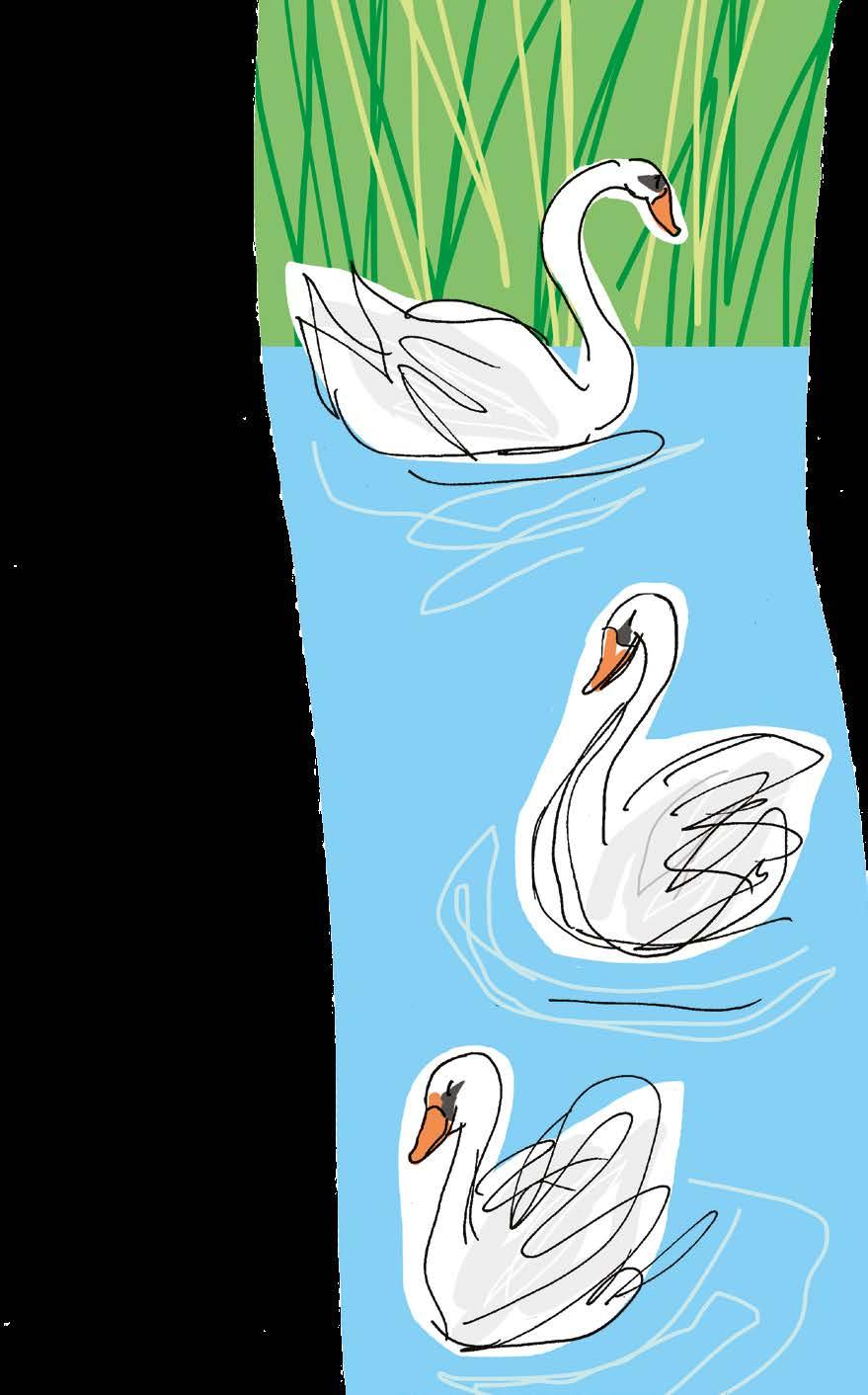
dolce, intelligente, sentì raddoppiare il suo odio. Invidiosa di tutte le qualità riunite in una sola ragazza, architettò un piano machiavellico per eliminarla definitivamente e attese pazientemente il momento opportuno per eseguirlo.
La ragazza apprezzava in modo particolare un lussuoso salone di marmo.
Al centro c’era una vasca d’acqua dove le piaceva specchiarsi, seduta su morbidi cuscini di seta e di broccato, sfiorando l’acqua con le dita esili.
La megera vide in quell’acqua lo strumento della sua vendetta.
Mise nella vasca tre enormi rospi pieni di pustole e ordinò loro:
«Saltale sulla testa, attaccati ai capelli e trasmettile la tua incredibile stupidità» disse al primo.
«Saltale in faccia» disse al secondo «e falla diventare brutta e foruncolosa come te!».
«In quanto a te, che sei il terzo, rendila crudele, fai in modo che il suo cuore sia duro come la roccia, che la sua vita sia solo sofferenza!».
Quando la principessa arrivò, per approfittare di un po’ di calma e di freschezza, i tre rospi vollero attuare il sinistro incarico.
Ma il contatto di una ragazza così pura e innocente ruppe il sortilegio.

Le immonde bestiole si trasformarono in tre splendide rose, soavemente profumate. Allora la regina, colma di rabbia, si gettò sulla poveretta, sporcò il suo visino con la fuliggine e ridusse i suoi capelli come una zazzera ruvida come la canapa. In un momento diventò irriconoscibile persino al padre che, credendola una mendicante, la fece scacciare dal castello.
Trionfante, la spaventosa strega gioì in segreto per non destare sospetti nel sovrano. Nel frattempo, l’infelice ragazza aveva incominciato il suo triste errare. Lisa camminò tutto il giorno.
Quando giunse la sera, in mezzo ad una profonda foresta, si dissetò alla sorgente di un ruscello, si lavò il viso e i capelli prima di addormentarsi, sfinita. Ahimè! Brutti incubi rovinarono il suo sonno: che cosa era accaduto ai suoi fratelli? Al risveglio, incontrò una vecchia che le parlò di undici cigni in un lago vicino. La ragazza vi arrivò troppo tardi, ma coraggiosamente, continuò le ricerche. Arrivata sulle rive dell’oceano, il rumore di ali possenti che fendevano l’aria le resero un po’ di speranza. Undici uccelli apparvero all’orizzonte: le dita palmate dei volatili sfioravano la sabbia.
All’improvviso, ripresero l’aspetto umano. L’incontro fu commovente, pieno di gioia e di tristezza. Parlarono lungamente: la principessa raccontò le sue avventure, il più grande dei fratelli fece lo stesso: «Condannati all’esilio eterno in un magnifico paese che non sostituirà mai la nostra amata patria, dobbiamo, ogni sera, ritornare sulla terra per ridiventare uomini. All’alba, il nostro regno diventa ancora il cielo!». «Perché siete qui, allora?» domandò Lisa.
«Qualche giorno all’anno siamo autorizzati a volare sul palazzo di nostro padre a rivedere il luogo della nostra felice giovinezza. Domani torneremo in esilio. Vieni anche tu con noi?».
La ragazza non esitò. Al mattino, Lisa si mise in una solida tela di lino tenuta fermamente dai becchi di tre suoi fratelli e intraprese un lungo viaggio sopra i mari. Gli altri ragazzi, anche loro trasformati in cigni, le fecero da scorta.
Al tramonto, arrivati a destinazione, deposero il loro prezioso carico all’entrata di una grotta che era il loro rifugio.
Il freddo della sera, la stanchezza e le emozioni del viaggio spossarono Lisa che si addormentò facilmente.

Ma una grande preoccupazione tormentava i suoi sogni: come avrebbe potuto aiutare i fratelli a riprendere definitivamente le sembianze umane? In un sogno, apparve una fata. Malgrado la sua giovinezza e la sua bellezza, la principessa riconobbe la vecchia donna che l’aveva guidata nella foresta, quando stava cercando i fratelli.
«Conosco il tuo desiderio» le disse «e posso esaudirlo, ma ti occorrerà molta volontà e tenacia. Sei pronta a sopportare silenziosamente alcune prove terribili?».
«Sì, sono pronta! Niente mi fermerà!».
«Dovrai raccogliere molte ortiche, filarle come la lana, tesserle e cucire il tessuto ottenuto per confezionare undici abiti. Quando saranno
terminati, li getterai sui cigni e il cattivo sortilegio scomparirà immediatamente. Durante questo lavoro resterai sempre zitta. Un solo suono uscito dalla tua bocca renderà inutile il tuo sacrificio e abbrevierà la vita dei tuoi cari che vuoi salvare. La liberazione dei tuoi fratelli ha questo prezzo…».
Al suo risveglio, Lisa si mise attivamente all’opera, colse le piante irritanti che inflissero alle sue mani bruciori lancinanti. Con la bocca chiusa, soffocò singhiozzi di dolore. Come ogni sera, i cigni ritornarono a terra e ripresero il loro aspetto principesco. Interrogarono la sorella sulla causa delle sua mani gonfie e degli occhi pieni di lacrime, ma Lisa non disse nemmeno una parola. E continuò con ostinazione il suo lavoro doloroso.
Un giorno in cui Lisa stava facendo provviste di ortiche, alcuni cacciatori si fermarono per chiederle la strada. Erano condotti dal sovrano del paese, giovane e seducente, che fu immediatamente conquistato dal suo fascino e dalla sua grazia. Il continuo silenzio della ragazza lo imbarazzò ma, preso dall’improvvisa passione, la mise in groppa al suo cavallo e la portò nel suo palazzo. Vestita di broccato e di seta, adorna di suntuosi gioielli, Lisa fu presentata a corte. Lacrime di sofferenza bagnarono i suoi occhi e tutti crederono fossero lacrime di felicità!
Il matrimonio inaspettato, suscitò rancori e gelosie: da dove arrivava questa sconosciuta? Aveva soggiogato il re, era una strega!
Per farle ritornare il sorriso e la voce, il giovane re ebbe la delicatezza di riportarla alla grotta dalla quale l’aveva portata via così bruscamente.
C’era tutto; i vestiti già cuciti, il necessario per cucire gli altri.
Lisa riprese il lavoro con entusiasmo… ma un giorno le ortiche finirono.
Allora andò a coglierne al vicino cimitero, ricco di quelle pianticelle.
Ahimè, un cortigiano invidioso del suo felice destino la seguì, scoprì il segreto e corse a rivelarlo al giovane marito.
Il poveretto, malgrado il suo amore, dovette cedere alle insistenze della sua corte che accusava la sfortunata. Lisa, con il suo silenzio, non poté difendersi dall’accusa di stregoneria e fu gettata in prigione. Per miracolo, vi trovò il suo lavoro e poté terminarlo, all’insaputa delle guardie.
Condannata ad essere bruciata viva, la poveretta camminò stoicamente verso il rogo, stringendo disperatamente fra le braccia i preziosi vestiti.
Incuriositi dal rumore della folla, gli undici cigni si posarono nel luogo del supplizio e con grande emozione della folla ripresero l’aspetto umano appena Lisa ebbe lanciato i vestiti magici.
Liberata dal giuramento, la principessa poté infine raccontare la sua storia e quella dei suoi fratelli. Di buon cuore, Lisa perdonò il suo sposo e, felice, ritornò con lui a palazzo.
Hans Christian Andersen
rancore: odio, astio, risentimento. machiavellico: astuto, ingegnoso. seducente: affascinante, attraente.
Qual è il piano maligno che escogita la matrigna per allontanare Lisa e i suoi fratelli?
Quali prove dovrà affrontare Lisa per salvare i suoi fratelli?

IL ROSPO
Il pozzo era profondo, quindi la corda era lunga e la carrucola girava a fatica quando bisognava sollevare il secchio pieno d’acqua fino oltre il bordo del pozzo. Il sole non riusciva mai a specchiarsi nell’acqua, sebbene questa fosse trasparente, ma fin dove riusciva a brillare cresceva il verde tra le pietre.
Al pozzo abitava una famiglia di rospi, emigrati, in realtà giunti lì a capofitto con una vecchia madre rospo che ancora viveva; le verdi rane che vi abitavano da moltissimo tempo e nuotavano nell’acqua li riconobbero come cugini, ma li considerarono soltanto ospiti venuti a passare le acque, mentre loro avevano tutta l’intenzione di rimanere lì: vivevano molto meglio all’asciutto, come chiamavano quelle pietre bagnate.
Mamma rana una volta aveva viaggiato, si era trovata nel secchio che veniva tirato su, ma c’era troppa luce per lei e le aveva causato una lesione agli occhi; fortunatamente riuscì a saltar fuori dal secchio, cadde in acqua con un tonfo terribile e rimase a letto per tre giorni con il mal di schiena. Non sapeva raccontare molto del mondo che c’era fuori, ma sia lei che tutti gli altri sapevano che il pozzo non era tutto il mondo. Mamma rospo avrebbe potuto raccontare molto di più, ma non rispondeva mai quando le veniva chiesto qualcosa, e così non le si chiedeva mai nulla.
«È grassa, brutta e tozza!» dicevano le giovani rane verdi. «I suoi piccoli diventeranno altrettanto grassi!».
«È probabile!» rispondeva mamma rospo. «Ma uno di loro ha una gemma preziosa nella testa, o forse ce l’ho io».
Le verdi rane ascoltarono e spalancarono gli occhi, ma dato che a loro la cosa non piaceva, fecero le smorfie e tornarono sul fondo. I giovani rospi invece tesero la zampette di dietro con grande fierezza. Ciascuno di loro credeva di avere la gemma preziosa; e così tennero per un po’ la testa immobile, ma alla fine chiesero di che cosa dovevano essere fieri e che cosa fosse in realtà una tale gemma.
«È qualcosa di splendido e di prezioso!» disse mamma rospo. «Ma io non posso descrivervelo, è qualcosa che dà piacere
a chi la possiede e fa rabbia agli altri, ma non chiedete, io non rispondo».
«Io non ho la gemma preziosa» esclamò il rospo più piccolo, che era tanto brutto. «Perché dovrei avere io una tale bellezza? Se poi questa fa arrabbiare gli altri, come farei a esserne felice? No, io desidero solo poter arrivare una volta in cima al pozzo a guardare fuori; deve essere bello!».
«È meglio che resti dove sei!» disse la vecchia. «Questo posto lo conosci ormai, sai com’è! Stai attento al secchio: quello ti schiaccia. E se anche riesci a entrarci, puoi caderne fuori male, non tutti cadono bene come me, che ho conservato le membra intatte e anche tutte le uova».
«Cra!» disse il piccolo, e questo corrisponde al nostro «Ahimè!».
Il piccolo rospo aveva una gran voglia di uscire sull’orlo del pozzo, di guardare fuori, sentiva una specie di nostalgia per il verde che c’era lassù: così quando il mattino dopo per caso il secchio pieno d’acqua si fermò un attimo davanti alla pietra dove si trovava lui, si emozionò tanto che saltò dentro nel secchio pieno e cadde in fondo all’acqua che, una volta tirata su, venne versata.
«Uh, che orrore!» gridò il garzone che lo vide. «È la cosa più schifosa che abbia mai visto» e gli diede un calcio con lo zoccolo e il rospo rischiò di rimanere storpio, ma riuscì a scamparla rifugiandosi tra le alte ortiche. Vide gli steli, uno vicino all’altro, e guardò anche in su: il sole brillava tra le foglie trasparenti, e lui provò la stessa sensazione che proviamo noi uomini quando improvvisamente ci troviamo in un grande bosco dove il sole brilla tra i rami e le foglie.
«Qui è molto più bello che giù nel pozzo! Qui si può avere voglia di rimanere per tutta la vita!» esclamò il piccolo rospo. Rimase lì un’ora, forse due. «Che cosa ci sarà là fuori?
Se sono arrivato fin qui, devo guardare oltre» così strisciò più in fretta che poté e uscì sulla strada, dove il sole brillava e dove la polvere lo ricoprì, mentre attraversava la via.
«Qui sì che ci si trova all’asciutto!» commentò il rospo «Si sta fin troppo bene, ho un solletico!».
Arrivò al fosso dove crescevano i non-ti-scordar-di-me e le spiree, c’erano siepi di sambuco e di biancospino, cresceva il convolvolo arrampicandosi sulle piante; c’erano tanti
colori, volava anche una farfalla, ma il rospo credette che quello fosse un fiore alzatosi dallo stelo per vedere meglio il mondo, e sarebbe stato così naturale!
«Se solo potessi essere veloce come lei!» pensò il rospo. «Cra! Cra! che bellezza!».
Rimase otto giorni e otto notti vicino al fosso e non gli mancava certo il cibo. Il nono giorno pensò: «Avanti!» ma che cosa si poteva trovare di più bello? Forse una rospetta o qualche rana verde! L’ultima notte gli era parso di sentire, col vento, come un suono di parenti nelle vicinanze.
«Che bello vivere! Uscire dal pozzo, stare tra le ortiche strisciare lungo la strada impolverata e riposarsi vicino al fosso! Ma avanti! Cerchiamo di trovare una rana o una rospetta, non si può farne a meno, la natura da sola non è abbastanza!». E così ricominciò a viaggiare.
Arrivò in un campo vicino a un grande stagno circondato di salici e cercò lì dentro.
«Forse qui è troppo umido per lei?» chiesero le rane. «Ma lei è benvenuto. Lei è un signor rospo o una signora? Comunque non importa, è benvenuto ugualmente».
Così venne invitato al concerto della sera, un concerto di famiglia: grande entusiasmo e vocine flebili! Noi conosciamo bene queste cose. Non c’era niente da mangiare, solo bibite a volontà, tutto lo stagno, se si voleva.
«Proseguiamo nel viaggio!» si disse il piccolo rospo, sentiva sempre il bisogno di qualcosa di meglio.
Vide le stelle che brillavano, grandi e luminose, vide la luce della luna nuova, vide il sole sorgere sempre più alto.
«Io mi trovo ancora in un pozzo, in un pozzo più grande; devo andare ancora più su! Sono così inquieto e ho una tale nostalgia!» E quando la luna divenne piena, il povero animale pensò: «È forse quello il secchio che viene calato e nel quale io devo saltare per arrivare più in alto? O è forse il sole il grande secchio? Com’è grande, com’è pieno di raggi, come ci contiene tutti! Non devo perdere l’occasione! Come brilla sulla mia testa! Non credo che la gemma preziosa possa brillare di più!
Ma io non ce l’ho e non piango certo per questo; no, devo andare più su nel bagliore e nella gioia! Ho una certezza, e pure una paura, è difficile fare un passo simile, ma bisogna! Avanti, avanti per la strada maestra!». E si rimise a camminare
come può fare un animale strisciante e giunse sulla strada dove abitavano gli uomini; c’erano giardini pieni di fiori e orti di cavoli, lui si riposò vicino a un orto di cavoli.
«Oh, quante strane creature che non ho mai visto! E come è grande e benedetto il mondo! Ma uno naturalmente deve guardarsi intorno, non può rimanere seduto sempre in un posto» e così saltò dentro l’orto di cavoli. «Com’è verde! Com’è bello!».
«Lo so!» disse un bruco che stava su una foglia. «La mia foglia è la più grande qui. Nasconde mezzo mondo, ma ne posso fare a meno».
«Glo, glo!» si sentì: arrivavano le galline, saltellando. La prima che sopraggiunse era presbite, vide il bruco su quella foglia arricciata e lo beccò, così quello cadde a terra, cominciando a contorcersi per la rabbia. La gallina allora prima guardò con un occhio, poi con l’altro perché non capiva che cosa fosse tutto quel contorcersi.
«Non lo fa certo per compiacere!» pensò la gallina e sollevò la testa per beccarlo. Il rospo si spaventò moltissimo e le si mise proprio davanti.
«Ah, ha le truppe ausiliarie!» si disse quella. «Guarda che tipo!» e se ne andò. «Non mi interessa proprio questo bocconcino verde che mi fa solo solletico nel collo». Le altre galline erano della stessa opinione, così se ne andarono.
«Mi sono salvato con le mie contorsioni!» disse il bruco.
«È un bene avere presenza di spirito, ma la cosa più diffìcile ora è ritornare sulla mia foglia di cavolo. Dov’è?».
Arrivò il rospetto e gli espresse la sua simpatia. Era felice che la sua bruttezza avesse spaventato le galline.
«Che cosa dice?» chiese il bruco. «Io mi sono salvato da solo. Lei è molto brutto! E ora posso ritornare a casa mia? Sento odore di cavolo, ora so dov’è la mia foglia. Non c’è niente di più bello che la propria casa. Ma io devo andare più su!».
«Sì, più in su!» ripeté il piccolo rospo. «Più in su! Sente proprio come me! Ma non è di buon umore oggi; forse sarà per lo spavento. Tutti vogliamo andare più in su!» e guardò in alto più che poté.
La cicogna si trovava nel nido sul tetto della casa del contadino, gloterava e anche mamma cicogna gloterava.
«Come abitano in alto!» pensò il rospo. «Felice chi può arrivare così in alto!». Nella casa del contadino abitavano due studenti, uno era poeta, l’altro scienziato, uno cantava e scriveva pieno di gioia di tutte le cose che Dio ha creato e che si rispecchiavano nel suo cuore, cantava in modo breve e chiaro e in versi armoniosi; l’altro invece si impossessava della cosa in sé, l’apriva quando era necessario. Considerava l’opera del Signore come un grande calcolo, sottraeva, moltiplicava, voleva conoscere tutto di dentro e di fuori e parlarne con intelligenza; in realtà era pura intelligenza, parlava con gioia e conosceva tutto. Entrambi erano due bravi giovani.
«Guarda, c’è un ottimo esemplare di rospo!» disse lo scienziato. «Dovrei metterlo sotto spirito».
«Ne hai già due!» disse il poeta. «Lascia che si diverta in pace!».
«Ma è così deliziosamente brutto!» disse l’altro.
«Già, se potessimo trovargli la gemma preziosa nella testa» disse il poeta «allora vorrei essere presente quando lo squarcerai!».
«La gemma preziosa!» rispose l’altro. «Conosci bene, tu, la storia naturale!».
«Non c’è forse qualcosa di meraviglioso in questa tradizione popolare, nell’idea che il rospo, l’animale più brutto in assoluto, spesso nasconda nella testa una preziosissima gemma? Non succede lo stesso anche con gli uomini? E che pietra preziosa aveva Esopo, e poi Socrate!».
Il rospo non sentì altro, ma non capì neppure la metà di quel discorso. I due amici se ne andarono e lui riuscì a non finire sotto spirito.
«Hanno anche parlato della gemma preziosa!» disse il rospo. «Per fortuna non ce l’ho, altrimenti avrei avuto dei problemi!».
Intanto si gloterava sul tetto della casa dei contadini, papà cicogna teneva un discorso alla famiglia e guardava storto i due giovani nell’orto dei cavoli.
«L’uomo è la creatura più presuntuosa!» esclamava. «Senti come muovono il becco! E in realtà non sanno nemmeno fare un verso giusto. Si vantano della loro capacità di parlare, della loro lingua! È proprio una bella lingua: se noi viaggiamo un solo giorno la sentiamo parlare in modo incomprensibile: uno non capisce l’altro. La nostra lingua invece la parliamo su tutta la terra, sia in Danimarca che in Egitto. E poi gli uomini non sanno neppure volare. Prendono velocità con un’invenzione che chiamano “ferrovia” ma spesso si rompono anche il collo. Mi vengono i brividi nel becco quando ci penso; il mondo potrebbe benissimo sopravvivere senza uomini. Potremmo fare a meno di loro: basta che ci siano le rane e i vermi».
«È proprio un bellissimo discorso!» pensò il rospetto. «Deve essere un grand’uomo, e come siede in alto, dove io non ho mai visto sedere ancora nessuno, e come sa nuotare!» esclamò quando la cicogna s’innalzò nell’aria spiegando le ali. Mamma cicogna continuò a parlare nel nido, raccontò della terra d’Egitto, dell’acqua del Nilo e di tutte quelle meravigliose paludi che si trovavano nel paese straniero. Le sue parole suonarono nuove e interessanti al piccolo rospo. «Devo andare in Egitto!» disse. «Se solo la cicogna volesse portarmi con sé, o uno dei suoi piccoli. Io li ricambierò servendoli il giorno del loro matrimonio. Ah, se arrivassi in Egitto sarei proprio felice! Ho tanti desideri e una tale voglia, e certo valgono più di una gemma preziosa in testa!».
E invece aveva proprio quella gemma preziosa: quell’eterna
nostalgia e quella voglia di andare in alto, sempre più in alto! Gli brillava dentro, si esprimeva nella gioia, si irraggiava nel suo desiderio.
In quel momento sopraggiunse la cicogna; aveva visto il rospo tra l’erba, si precipitò in basso e prese quel piccolo animaletto senza troppo garbo. Il becco stringeva, il vento soffiava, non era certo piacevole; ma intanto lui andava in alto, in alto verso l’Egitto, lo sapeva bene; e per questo gli brillavano gli occhi, e sembrò che ne uscisse una scintilla.
«Cra! Cra! Ahimè!».
Il corpo era morto, il rospo ucciso. Ma la scintilla che proveniva dai suoi occhi, di quella che accadde?
Il raggio del sole la prese, il raggio del sole portò via la gemma preziosa dalla testa del rospo. Ma dove la portò?
Non devi chiederlo allo scienziato, chiedilo piuttosto al poeta; lui te lo racconterà come una favola, e ci sarà il bruco, e la famiglia delle cicogne. Pensa! Il bruco si è trasformato ed è diventato una bella farfalla; la famiglia delle cicogne vola oltre le montagne e il mare fino alla lontana Africa
e ciò nonostante trova la strada più breve per tornare di nuovo nella terra danese, nello stesso posto, sullo stesso tetto! Sì, è proprio tutto come una favola, eppure è vero! Puoi chiederlo allo scienziato, lui lo dovrà ammettere; e tu stesso lo sai, perché l’hai visto.
Ma la gemma preziosa nella testa del rospo?
Cercala nel sole! Guardalo, se sei capace!
Il bagliore è troppo forte. Noi non abbiamo ancora gli occhi in grado di guardare in tutta quella gloria creata da Dio, ma li avremo, e allora diventerà la favola più bella, perché anche noi ci saremo.
presbite: qualcuno che vede male da vicino. ausiliario: sussidiario, accessorio, d’appoggio. gloterava: da “gloterare”, verso della cicogna.
Dopo aver riletto Il rospo, rispondi alle domande.
1. Chi viveva nel profondo di un pozzo?
A. Una famiglia di rospi.
B. Delle rane verdi.
C. Una famiglia di rane e una famiglia di rospi emigrati.
2. Che cosa ha in testa uno dei piccoli di mamma rospa?
A. Una gemma preziosa.
B. Una preziosa corona.
C. Una profonda ferita, provocata dalla caduta nel pozzo.
3. Come fece il rospo più piccolo ad uscire dal pozzo?
A. Il rospo si arrampicò alla lunga catena e raggiunse l’orlo del pozzo, quindi si tuffò sull’erba vicino al piede di un garzone.
B. Il rospo si fece accompagnare dalla mamma rospa, che conosceva una via segreta, fino all’orlo del pozzo.
C. Il rospo saltò dentro al secchio pieno d’acqua che, una volta tirata su, venne versata insieme al piccolo rospo sull’erba.
4. Giunto in un fosso, il rospo ammirò i fiori meravigliosi e vide una farfalla. Che cosa pensò della farfalla?
A. Il rospo pensò che la farfalla fosse un fiore alzatosi sullo stelo per osservare il mondo.
B. Il rospo pensò che quella farfalla fosse l’insetto più bello che lui avesse mai visto.
C. Il rospo pensò che quella farfalla fosse un insetto da rispettare per la sua bellezza.
5. Qual è il “grande pozzo” di cui parla il rospo quando afferma: «Io mi trovo ancora in un pozzo»?
A. La nostra Terra.
B. È un pozzo molto grande, profondo e pieno d’acqua.
C. È il pozzo in cui abitava il rospo con la sua famiglia.
6. Cosa significa “gloterare”?
A. Costruire il proprio nido.
B. Tremare di paura.
C. Fare il verso della cicogna.
7. Quando il rospo incontra la cicogna, cosa desidera fare?
A. Vorrebbe volare e andare con lei in Egitto.
B. Vorrebbe servire la cicogna nel giorno del suo matrimonio.
C. Vorrebbe vivere con lei e con i suoi piccoli.
8. Metti la crocetta giusta nella tabella. V F
Il piccolo rospo ha la gemma preziosa. ⬜ ⬜
Il piccolo rospo non sa di avere la gemma preziosa. ⬜ ⬜
La gemma preziosa è la voglia di andare in alto, sempre più in alto! ⬜ ⬜
La gemma preziosa è la capacità di accontentarsi di poco.
La gemma preziosa è la gioia di vivere nel profondo di un pozzo e pensare che il mondo sia tutto lì.
Il piccolo rospo è felice di vivere nel pozzo con la sua bella famiglia, anche se sa che il mondo non è tutto lì.
9. Metti la crocetta giusta nella tabella.
La cicogna, afferrando il rospo senza troppo garbo, lo uccise.
La cicogna trattò il piccolo rospo con garbo e lo portò a giocare coi suoi piccoli.
Un soffio di vento strappò dalla testa del rospo la gemma preziosa, la portò lontano ed essa si disperse nel nulla.
Un raggio di sole portò via la gemma preziosa dalla testa del rospo e la gemma arrivò fino al sole.
Quando saremo in Paradiso, i nostri occhi saranno capaci di vedere la gemma preziosa, nonostante il bagliore del sole.
R A CCONTI STORICI
Gli antichi Greci hanno contribuito in modo particolare alla nostra civiltà europea: hanno dato alla città la forma della democrazia (governo); hanno formulato teorie matematiche e fisiche; ci hanno lasciato poemi, tragedie e racconti con una ricca e profonda riflessione sulla vita dell’uomo: le gioie, i dolori, le amicizie e anche gli odi.

STORIA DI UN CAVALLO DI LEGNO
Achille era morto e i generali si riunirono a consiglio per decidere su quello che si dovesse fare. Ulisse astuto e saggio, re di Itaca, prese la parola.
«Generali, il nostro guerriero più forte, Achille figlio di Peleo, è morto. È morto Achille il migliore di tutti noi! E noi non possiamo più sperare di vincere i Troiani in guerra aperta, ma forse con un’astuzia potremo riuscire. Se non troviamo il modo di ingannare i nostri nemici e sorprenderli quando meno se l’aspettano, io ho paura, o generali, che dovremo tornarcene a casa con gran vergogna, e la gente dirà: “Dieci anni sono stati lontani quei forti guerrieri, dieci anni hanno combattuto per riavere Elena, ma Elena è rimasta a Troia ed essi son tornati a mani vuote!”. Ora io vi dico, o generali, che a qualunque costo dobbiamo vincere, e qualunque strada è buona purché si vinca!».
«Dici bene» rispose Agamennone «ma è appunto la strada che non sappiamo trovare!».
«Ci ho pensato molto e mi pare di averla trovata. Ascoltate. Fabbricheremo un cavallo di legno, ben lavorato, tutto dipinto e grande abbastanza da contenere nel suo interno otto o dieci persone. Lo faremo portare a Troia, e nel mezzo della notte i guerrieri nascosti dentro il cavallo usciranno, apriranno le porte e Troia sarà invasa dai nostri. Non vi pare che così si potrebbe riuscire?».
«Certamente! Ecco una buona strada!» rispose Agamennone.
Laura Orvieto, Storie della storia del mondo, Giunti Junior
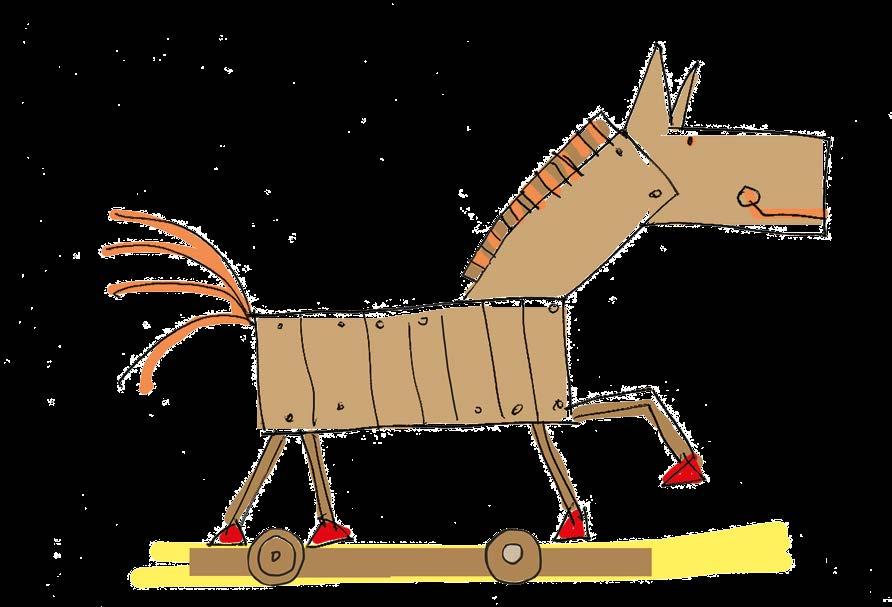
PITAGORA
Dopo Eraclito, fece la sua comparsa nella storia Pitagora, il quale sarebbe divenuto non solo un grande filosofo, ma anche un grande maestro.
Un maestro che, a differenza dei primi filosofi (Talete, Anassimandro, Anassimene ed Eraclito) non visse in Grecia, ma nella Magna Grecia, che altro non era che una colonia fondata dai Greci nell’Italia meridionale.
Pitagora, proprio in Magna Grecia, inaugurò una sua scuola. Questa scuola non somigliava per nulla a quella a cielo aperto di Talete, Anassimandro e Anassimene: era una scuola a tutti gli effetti, con banchi, aule, professori preparati e seri, e tanti alunni.
Le materie che venivano insegnate erano tantissime, ma noi sappiamo davvero poco di quel che gli studenti della scuola di Pitagora studiavano. Tutti gli alunni di Pitagora, infatti, erano tenuti a mantenere il segreto su ciò che veniva loro insegnato. Ma si sa che è difficile mantenere un segreto; e qualcuno, per nostra fortuna, raccontò qualcosa di quel che aveva imparato. Così possiamo anche noi avere qualche notizia di ciò che studiavano i pitagorici, ossia gli studenti di quella scuola. Sappiamo, per esempio, che i pitagorici avevano una grande passione per la matematica e la geometria. E che Pitagora era convinto che con i numeri si potesse spiegare ogni cosa.
Un giorno, entrando in classe, Pitagora disse: «Cari ragazzi, dovete sapere che il quattro non è solo il numero 4, ma è il numero delle stagioni, delle ruote di un carro, degli arti di un uomo, dei lati di un quadrato, delle gambe di una sedia… Il dodici, è il numero della dozzina, dei mesi di un anno… Il due è il numero degli occhi di un uomo (a meno che sia un ciclope, cioè un mostro con un occhio solo), e delle facce della stessa medaglia…». Un altro giorno portò uno strano strumento musicale a scuola e incominciò a suonarlo (lo strumento era la lira, che ai tempi di Pitagora non era la vecchia moneta italiana, oggi peraltro sostituita dall’euro, ma una specie di arpa). Nel vivo dell’esecuzione, quando tutti a bocca aperta seguivano meravigliati una melodia incantevole, Pitagora s’interruppe bruscamente; egli mostrò come il suono di ogni corda è differente perché una misura 10 centimetri, l’altra 12, un’altra ancora 14.
Di questi esempi il maestro ne faceva tantissimi; la realtà per lui era come un gioco fatto di numeri. Anzi, secondo Pitagora, tutta la realtà è fatta di numeri, e i numeri sono una cosa reale come le montagne, il sole che sorge e la luna che spunta quando se ne va il sole. E a volte sembrava che Pitagora, a forza di parlarne, desse davvero i numeri!
Gli studenti erano affascinati da questo maestro: Pitagora trovava per ogni cosa un numero e tutto per lui era ordinato. Il mondo, per i pitagorici, era così pieno di numeri e ordinato che alla fine gli diedero il nome di
“cosmo”, che in greco significa appunto “ordine”.
La natura e le cose che ci circondano sono sempre disposte secondo un ordine preciso, ed è l’uomo che introduce il disordine. Questo è quello che Pitagora continuava a sostenere nei suoi discorsi. Proviamo, per intenderci, a immaginare un bel prato pieno di fili d’erba, tutti disposti come soldatini che camminano l’uno dietro l’altro: ecco, per Pitagora il mondo è come quel prato. Ma poi arriva l’uomo e, calpestandolo, crea il caos (che è un’altra parola greca che significa “disordine”).
Pitagora e i suoi alunni avevano una vera e propria venerazione per l’ordine. Per il maestro rispettare l’ordine e studiare la matematica erano l’unico modo per essere veri. Per i pitagorici chi è ignorante e non rispetta l’ordine che c’è nella natura non è davvero uomo.
Così gli alunni della scuola di Pitagora dovevano imparare a far di conto, ma anche sapere che l’unico modo per crescere è rispettare il cosmo.
E che cos’altro insegnava Pitagora ai suoi scolari? Ricordava loro che chi non impara queste cose non solo non diventa uomo, ma diventa come un animale o, peggio, una cosa.
La scuola di Pitagora – lo si capisce bene – era anche una scuola di vita.
A.J. Geis, La grande corsa di Maratona, in I quindici, Field Educational Italia
filosofo: pensatore, colui che ricerca il sapere.
arto: membro, braccia, gamba. venerazione: rispetto, ossequio, reverenza.
SCRIVI TU!
Proviamo a riassumere, cioè a dire in breve il “succo della storia”.
1. Rileggiamo il testo e proviamo a dividere in sequenze, in parti: facciamoci aiutare da queste domande.
• Pitagora: chi era? Dove viveva?
• La scuola di Pitagora: come era la scuola di Pitagora? Cosa si studiava?
• La realtà e il mondo secondo Pitagora e i suoi allievi: quale idea avevano del mondo? Come lo chiamavano?
• Una scuola di vita: quale era l’unico modo per essere veri uomini per Pitagora?
2. Ora in ogni sequenza troviamo le informazioni essenziali.
3. Ora proviamo a riscrivere in breve queste informazioni. Attenzione! Il nostro riassunto non può essere lungo più di una pagina di quaderno.
IL PIÙ VELOCE
Il giovane greco si era appena buttato nel suo lettuccio di paglia, quando un lembo della sua tenda si sollevò: era il suo amico Marcello.
«Filippide, ti ho cercato dappertutto!» esclamò. «Su, vieni con noi a celebrare la vittoria».
«No grazie» rispose Filippide. «Io ho già iniziato le celebrazioni con un bel sonnellino. Sono appena tornato da Sparta. Ho dovuto portare un messaggio ai nostri alleati».
«È un vero peccato che tu non abbia potuto assistere alla battaglia» disse Marcello. «Sulle prime anche noi non sapevamo come sarebbe andata a finire. Avresti dovuto vedere come si agitava Milziade e come incitava a combattere con tutte le nostre forze per la gloria della Grecia». Marcello rise al ricordo del generale Milziade durante il combattimento.
«È stata davvero una grande vittoria» disse Filippide. «Ho sentito dire che i Persiani hanno gettato archi e frecce e si sono rifugiati presso le loro navi».
«Questo è stato dopo che avevano perso circa seimila uomini. Non credo che daranno più fastidio ai Greci» rispose Marcello.
Improvvisamente la tenda si sollevò ed entrò un soldato.
«Cosa succede adesso?» domandò Filippide mettendosi a sedere sul letto.
«Il generale Milziade vuole vederti, pare che si tratti di un caso di emergenza!» disse il milite.
«Io pensavo che casi di emergenza si fossero esauriti con la disfatta dei Persiani!» disse Marcello.
«Non so di cosa si tratti, ma è meglio che ti sbrighi» replicò il soldato.
Se ne andò e Filippide si alzò in piedi.
«Ci risiamo» sospirò. Batté amichevolmente sulla spalla dell’amico e disse: «Sarà opportuno rimandare le celebrazioni e… il mio sonnellino!». Poi uscì.
Milziade stava camminando avanti e indietro per la sua tenda quando Filippide entrò.
«Finalmente sei arrivato!» gridò il generale alzando le braccia. «Entra, entra. Filippide, ho una missione molto importante da affidarti. Devi andare immediatamente ad Atene».
«Ma sono appena rientrato da Sparta!» protestò il giovane.
«Lo so, lo so» rispose Milziade, «ma i Persiani, nel loro cammino verso Atene, possono attaccare la città prima del nostro arrivo. Gli Ateniesi non sono al corrente della vittoria, e può anche darsi che si arrendano al nemico. Bisogna assolutamente dare loro la notizia che abbiamo vinto a Maratona; così essi resisteranno fino al nostro arrivo».
Il generale si accarezzò il mento con aria pensosa. «Tu sei il mio messaggero
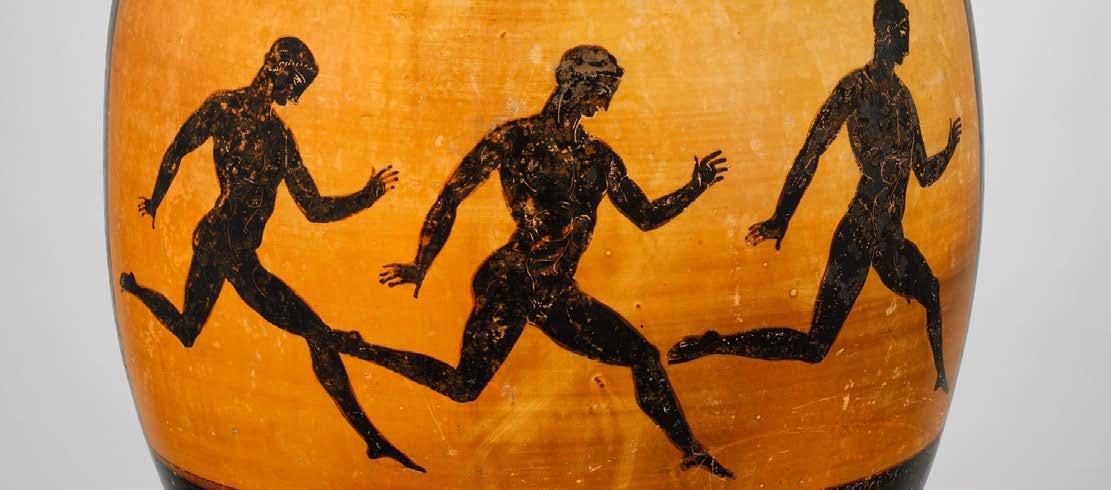
più veloce. Tu devi portare la notizia ad Atene. Tu solo sei in grado di raggiungere la città in tempo».
Filippide annuì. Era terribilmente stanco. Ma si rendeva anche conto dell’estrema importanza di quella missione.
«Capisco» disse.
Milziade sorrise e disse: «Bravo, sapevo che non mi avresti deluso. Parti subito e buona fortuna».
Il giovane salutò e scomparve. Il sole bruciava: Filippide cercò la borraccia per l’acqua. Poi si ricordò che l’aveva lasciata nella sua tenda. Tornò indietro, la prese, la riempì nuovamente dopo aver bevuto a lungo e la legò saldamente alla cintura. Atene distava una quarantina di chilometri.
«Bene! Almeno non è lontana come Sparta!» pensò, mentre attraversava il campo, in mezzo ai soldati raggianti per la vittoria. Inciampò nel piolo di sostegno di una tenda e poco mancò che non finisse a terra. Era proprio stanco.
«Aspetta, Filippide!». Si voltò e vide Marcello correre verso di lui.
«Dove stai andando?» gli domandò l’amico.
«Ad Atene!» rispose. «Vuoi che porti qualche messaggio alla tua famiglia?».
«No!» disse l’altro. «Ma, se fossi in te, andrei adagio. Hai l’aria stanca».
Filippide scrollò le spalle.
«Tutto in un sol giorno!» sospirò. Abbracciò l’amico e riprese il cammino.
«A presto!» gridò.
L’esercito era accampato ai piedi di una collina. Decise di scalare la collina invece di prendere la strada più lunga che le girava intorno.
Si arrampicò tra rocce, alberi e cespugli. Quando fu in cima al colle si fermò
per prendere fiato. Poi prese la strada che conduceva ad Atene. Qui rallentò il passo: avrebbe seguito il consiglio di Marcello e sarebbe andato adagio, in modo da conservare le forze fino all’ultimo; poi avrebbe fatto appello a tutte le sue energie per correre velocemente verso la città. Dopo un’ora il sudore colava dalla sua fronte, ma Filippide non avvertiva la stanchezza.
Camminava a passi lunghi e regolari. Cominciò a correre per la strada polverosa sollevando con i piedi nugoli di polvere. Gli piaceva correre: si sentiva libero e leggero.
Pensò a Milziade. Il generale lo aveva chiamato il più veloce dei suoi messaggeri. E questa era una missione molto importante: il destino di Atene era nelle sue mani.
«Bisogna che arrivi prima dei Persiani» pensò. «Bisogna che corra più in fretta».
I chilometri volavano sotto i suoi piedi. Quindici, venti, venticinque.
Ce l’avrebbe fatta? Adesso era molto stanco.
Improvvisamente Filippide tossì. La polvere lo ricopriva: riusciva a respirare a stento. Cercò di non fermarsi, ma fu impossibile: la tosse non accennava a smettere. Si portò sul ciglio della strada sotto un ulivo.
Cercò la borraccia, ma si rese conto che era meglio non bere: sarebbe stato peggio. Prima bisognava riposare. Poi sarebbe stato più facile respirare.
L’ombra si posava piacevolmente sul corpo stanco: Filippide cominciava a sentirsi meglio. Prese la borraccia dalla cintura, si sciacquò la bocca, poi bevve alcuni sorsi di acqua fresca. Ricordò la missione che doveva compiere.
L’intero esercito si trovava a Maratona con Milziade. Pochi uomini erano rimasti a difendere Atene: si sarebbero arresi ai Persiani?
Si rendeva conto che non poteva riposare ancora. Forse anche le navi persiane si stavano avvicinando al porto di Atene. Si asciugò il sudore dal viso e dal collo. Fece il conto della distanza che aveva già percorso e decise che gli rimanevano ancora pochi chilometri.
Si alzò e stirò i muscoli delle gambe. Lentamente si rimise in cammino. Nonostante il riposo, le gambe erano stanche, ma un po’ per volta riuscì a riprendere velocità.
Era quasi arrivato. Era il momento per lo scatto finale. Fece forza sulle lunghe gambe, spinse il corpo in avanti. Le braccia, un poco sollevate, rispondevano ritmicamente al movimento degli arti inferiori.
Pensava che presto si sarebbe sentito pieno di energia: gli capitava sempre così, dopo aver camminato a lungo. E invece, questa volta pareva che le forze volessero abbandonare il suo corpo.
Ad ogni passo gli sembrava di andare più adagio. Si impegnò con tutte le sue energie. Doveva raggiungere Atene prima dei Persiani.
Cominciò a scorgere le prime fattorie alla periferia di Atene. Non appena le raggiunse molti sollevarono il capo per guardarlo. Ma non si fermò.
Il cuore gli batteva forte nel petto. Alberi e campi gli passavano confusamente davanti agli occhi. Correva con la bocca spalancata, per “succhiare” l’aria.
Attraversò la grande porta di ingresso in Atene. Finalmente, sbucò nel centro della piazza del mercato.
Sentiva il mormorio della gente intorno a lui; qualcuno gli toccò il braccio. Molto confusamente, riuscì a riconoscere uno dei capi della città. «Filippide, che cosa è successo?» gridò l’uomo, precipitandosi verso di lui.
Il giovani sentì che le sue gambe non avevano più forza. Si piegò sulle ginocchia, respirava a fatica. Quasi in un soffio, mormorò: «Rallegratevi! Abbiamo vinto!».
Poi cadde al suolo. Il governatore si chinò e ascoltò il cuore del ragazzo. Era fermo. Allora guardò la gente che si era affollata lì vicino. «È morto» disse. «Egli ci ha portato le notizie di Maratona, ma ha perso la vita. I nostri soldati hanno sbaragliato i Persiani a Maratona. Grazie al coraggio di questo giovane, noi siamo a conoscenza della vittoria e non ci arrenderemo al nemico».
A.J. Geis, La grande corsa di Maratona, in I quindici, Field Educational Italia
nugolo: frotta, nuvola, gran quantità.
Dopo aver riletto Il più veloce, rispondi alle domande.
1. In che periodo storico è ambientato questo racconto? Sai l’anno preciso?
2. Dove avvengono le vicende raccontate?
3. Chi sono i personaggi di questo racconto?
4. Quale missione viene affidata a Filippide?
5. Perché viene scelto proprio Filippide?
6. Quanti chilometri percorre il soldato greco di corsa per arrivare ad Atene?
7. Quali parole usa Filippide per compiere la sua missione?
8. Perché è così importante per Filippide compiere la missione?
9. Cosa pensi di questo “sacrificio” di Filippide? Tu avresti fatto la stessa cosa? Perché?
ATENA E ARACNE
Viveva in Grecia la più abile allieva di Atena, Aracne, la ricamatrice.
Fiera della sua arte, decise di ricamare su un arazzo la storia degli dèi, poi espose il suo capolavoro.
Molti accorrevano ad ammirarlo e si complimentavano con l’artista.
«Nemmeno Atena potrebbe fare di meglio» dicevano.
Questi commenti arrivarono all’orecchio della dea, che andò subito a vedere il lavoro dell’allieva.
Vedendola arrivare, Aracne s’inginocchiò davanti a lei tremando: troppo si era vantata di ciò che sapeva fare.
Atena le sorrise, benevola, ma appena posò gli occhi sullo stupendo arazzo, aggrottò la fronte, irritata: la sua allieva l’aveva davvero superata!
Afferrò la tela ricamata e la stracciò con rabbia.
Aracne lanciò un urlo e scappò via. In un attimo era stato distrutto il suo lavoro più bello.
Fuggì nella foresta e Atena, che l’aveva seguita, forse pentendosi del suo gesto crudele, la ritrovò morta.
La dea pianse sul corpo senza vita dell’allieva, e pian piano quel corpo rimpicciolì e riprese a muoversi: era diventato un ragno, che subito cominciò a tessere la sua tela.
Silvia Benna Rolandi, Dei ed eroi dell’Olimpo, Dami Editore
arazzo: panno tessuto a figure.
L’INGRESSO DEI PERSIANI
Il cerimoniere ordinò di dare fiato alle trombe e i dignitari persiani fecero il loro ingresso solenne nella sala del trono. Il capo della delegazione era Arsames, il satrapo della Frigia, accompagnato dal suo governatore militare e da altri maggiorenti che seguivano a qualche passo dietro di lui.
Erano fiancheggiati da un scorta di dodici Immortali, i soldati della guardia imperiale. Alti quasi sei piedi di colorito olivastro, avevano barbe nerissime e crespe e capelli sontuosamente acconciati e arricciati. Portavano a tracolla i micidiali archi a doppia curvatura e le faretre di cedro intarsiate d’avorio e di lamine d’argento.
Incedevano a passo cadenzato appoggiando in terra le aste delle lance coi pomoli d’oro. Dal loro fianco pendeva l’abbagliante akinake, la daga d’oro massiccio. Il fodero, anch’esso d’oro, era sospeso a un nottolino agganciato al cinturone, cosicché l’arma oscillava liberamente a ogni passo dei maestosi guerrieri.
daga: spada.
nottolino: anello a forma di becco di civetta. dignitario: nobile, capo.
faretre: turcasso, astuccio di legno leggero, talvolta di avorio o di metallo, in cui gli arcieri tenevano le frecce.
BUCEFALO
Filippo si girò verso il figlio e gli disse: «Ti ho portato un regalo».
Raggiunsero la sommità del colle e Alessandro si arrestò stupefatto: in basso, davanti ai suoi occhi, uno stallone nero s’impennava con un guizzo delle reni sulle zampe posteriori, lucido di sudore come una statua di bronzo sotto la pioggia, tenuto da cinque uomini attaccati a lacci e briglie, che cercavano di controllarne la formidabile possanza.
Era più nero di un’ala di corvo e aveva una stella bianca in mezzo alla fronte a forma di cranio di bue. A ogni movimento del collo o delle terga scaraventava a terra gli stallieri e li trascinava sull’erba come pupazzi inerti. Poi ricadeva sugli zoccoli anteriori, scalciava all’indietro furibondo, flagellava l’aria con la coda, scrollava la lunga criniera luccicante.
Alessandro, come l’avesse colpito una frustata, si riscosse improvvisamente e gridò: «Lasciatelo! Lasciate libero quel cavallo, per Zeus!».
Filippo gli appoggiò una mano sulla spalla. «Aspetta ancora un poco, ragazzo, aspetta che l’abbiano domato. Solo un po’ di pazienza e sarà tuo».
«No!» esclamò Alessandro. «No! Soltanto io lo posso domare. Lasciatelo!
Vi dico di lasciarlo».
«Ma fuggirà!» gli fece notare Filippo. «Ragazzo mio, l’ho pagato una fortuna!». «Quanto?» chiese Alessandro. «Quanto l’hai pagato, papà?».
«Tredici talenti».
«Ne scommetto altrettanti che riesco a domarlo! Ma di’ a quegli sciagurati di lasciarlo! Ti prego!».
Filippo lo guardò e lo vide quasi fuori di sé per l’emozione, le vene del collo turgide come quelle dello stallone infuriato. Si volse agli uomini e ordinò: «Liberatelo!».
Obbedirono. Uno dopo l’altro sciolsero i lacci e gli lasciarono solo le briglie sul collo. E subito l’animale si allontanò correndo nella pianura.
Alessandro si lanciò all’inseguimento di corsa e gli si affiancò sotto l’occhio stupito del re e dei suoi stallieri.
Il sovrano scosse la testa mormorando: «Oh, dei, gli scoppierà il cuore a quel ragazzo, gli scoppierà il cuore».
Ma gli uomini fecero un cenno come per dire “ascolta”. Sentivano che gli parlava nell’ansimare della corsa, gli gridava qualcosa, parole che il vento si portava via assieme ai nitriti dell’animale che quasi pareva rispondergli.
E improvvisamente, quando sembrava che il giovane crollasse a terra per lo sforzo, il destriero rallentò la sua corsa, trotterellò per un poco e poi si mise al passo scuotendo la testa e sbuffando.
Alessandro allora gli si avvicinò piano, mettendosi dalla parte del sole.
Poteva vederlo ora, illuminato in pieno, poteva vedere la sua fronte ampia e nera e la macchia bianca a forma di cranio di bue. «Bucefalo» sussurrò. «Bucefalo…
Ecco, è questo il tuo nome… È questo. Ti piace, bello? Ti piace?». E gli si accostò fin quasi a toccarlo.
L’animale scrollò la testa, ma non si mosse e il ragazzo stese la mano e lo accarezzò sul collo, con delicatezza, e poi sulla guancia e sul muso, morbido come muschio. «Vuoi correre con me?» gli domandò. «Vuoi correre?».
Il cavallo nitrì alzando la testa fierissima e Alessandro capì che assentiva.
Lo guardò fisso negli occhi ardenti e poi con un balzo gli fu in groppa e gridò: «Vai! Bucefalo!».

possanza: forza, potere, potenza. terga: schiena.
turgide: gonfie, tumefatte, grosse.
SCRIVI TU!
Riesponi in breve l’episodio narrato e dai un nuovo titolo al racconto:
MODI DI DIRE TRATTI DAI MITI GRECI
I miti si sono tramandati attraverso molte generazioni, e sono stati spesso usati per insegnare come vivere in situazioni diverse, anche molto normali e quotidiane. Da molti miti, così, sono nati brevi modi di dire che descrivono semplici situazioni in cui è facile trovarsi tutti i giorni.
Se pensi al fatto che il tuo punto debole sia anche chiamato il tuo “tallone d’Achille”, ad esempio, puoi pensare come il mito della guerra di Troia incida anche su come descrivi te stesso o gli altri.
Così anche l’Odissea, titolo dell’opera che descrive le avventure di Ulisse (Odisseo), è diventato un modo di dire molto utilizzato: «Il mio viaggio è stata una vera e propria Odissea!».
La moglie Penelope, attendendolo, prendeva tempo cucendo una tela, la nota “tela di Penelope”, appunto, cioè l’iniziare un lavoro per prendere tempo, come alibi, non con l’intenzione di portarlo a compimento.
E davanti a quanti impedimenti puoi esclamare: «La speranza è l’ultima a morire»? Forse non lo sai, ma stai parlando del mito di Pandora, che fece fuggire dal suo vaso, dono di Zeus, tutti i mali del mondo e riuscì a trattenervi solamente proprio la speranza.
Più stupefacente ancora può essere per te scoprire che quando dici “essere piantato in asso”, nel senso di essere lasciato solo all’improvviso, in realtà vorresti dire “essere piantato in Nasso”, modo di dire che deriva dalla mitica storia di amore tra Teseo ed Arianna, che finisce proprio così.
Così quando non hai studiato e la maestra sta per chiamare per l’interrogazione, puoi forse pensare alla famosa “spada di Damocle”, ma Damocle si è trovato realmente con una spada appesa sulla sua testa con un crine di cavallo dal tiranno di Siracusa Dionigi che voleva fargli comprendere la pericolosità della condizione in cui si trova chi ha in mano il potere.
Ora che hai superato la fatica di leggere la storia di questi modi di dire, che è stata forse pari ad una delle “dodici fatiche di Ercole”, puoi finalmente riposarti, abbandonandoti “tra le braccia di Morfeo”.
Ma non dormire sonni troppo tranquilli! I mezzi informatici che credi così sicuri potrebbero subire l’attacco di un “cavallo di Troia”, che oggi è un famoso tipo di virus del computer.
ESPLORA LA SCRITTURA!
Trascrivi sul quaderno i modi di dire contenuti nella lettura e prova a spiegare il significato.
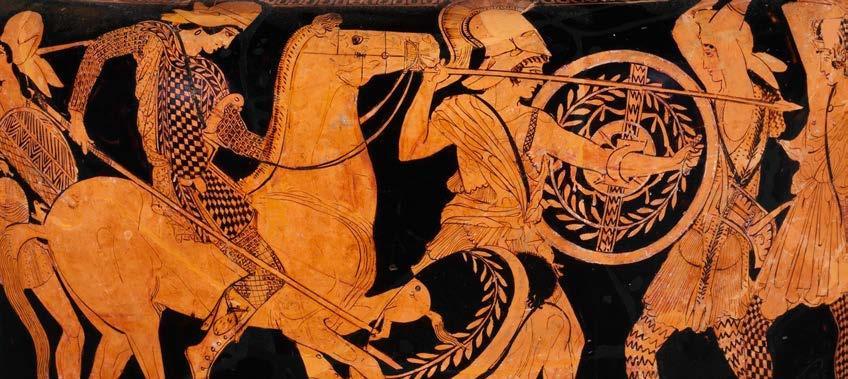
Mettiamoci all’opera
Il graffito
La tecnica a figure nere degli abili artigiani greci consisteva nel graffiare la superficie del vaso per disegnare decorazioni e particolari delle scene precedentemente dipinte di nero.
Prova anche tu ad utilizzare questa tecnica per rappresentare un mito e una decorazione alla maniera greca.
Prendi un cartoncino grande circa la metà di un foglio A4, coloralo ricoprendolo completamente con un pastello a cera o a olio arancione. Successivamente passa uno strato di tempera nera mescolata a una piccola quantità di sapone liquido.
Una volta asciutto potrai procedere alla decorazione scegliendo il motivo mitologico che più ti piace graffiandolo con uno stuzzicadenti al centro del cartoncino. Alcune parti potrai colorarle graffiando. Realizza sopra e sotto delle “grechine” decorative.
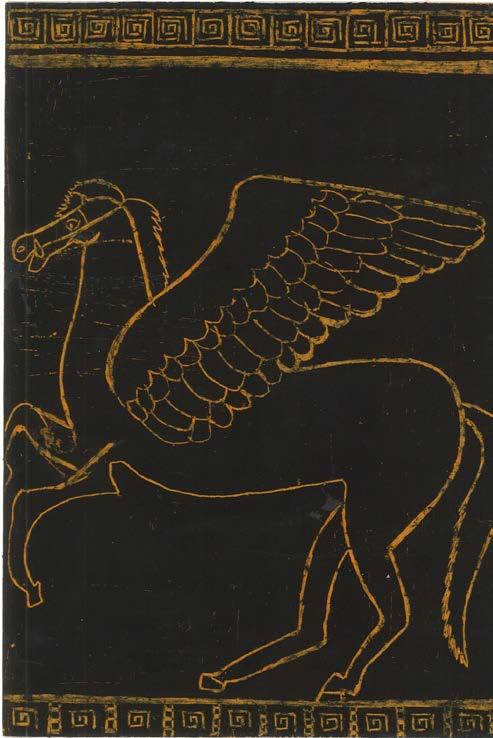
INCONTR I A M O GLI SCRITTORI ANTICHI
IL BUON AMICO
Se qualcuno ti loda tutto il tempo che ti ha sotto gli occhi, e appena è lontano sputa parole maligne, no, un uomo così non ti è buon amico, chi dice buone parole e pensa diversamente. Voglio un amico che conosca il carattere dell’amico e lo sopporta anche quando è difficile, come un fratello. Pensa, dunque, mio caro, a queste cose e ti ricorderai di me nel futuro.
Teognide (fine VI - inizi V secolo a.C., Attica), Elegie, 87-100, Bur
IL VENTO TRA I RAMI DEI MELI
C’è un bosco di meli grazioso e ci sono altari che fumano incenso; si sente il rumore dell’acqua fresca tra i rami dei meli, e tutto il luogo è ombreggiato di rose, e lo stormire delle foglie invita al sonno.
C’è un pascolo rigoglioso di fiori … e soffiano brezze soavi.
Saffo (fine VII - prima metà VI secolo a.C, isola di Lesbo), frammento 2
IL LEONE INVECCHIATO E LA VOLPE
Un leone invecchiato, che non era più in grado di procurarsi il cibo con la forza, capì che doveva procurarselo con l’intelligenza. Si ritirò quindi in una caverna, e giaceva, fingendo di essere malato. In questo modo tutti gli animali che venivano a fargli visita li afferrava e se li mangiava. E già ne aveva uccisi parecchi, quando arrivò la volpe, che aveva capito lo stratagemma e, tenendosi lontana dalla grotta, gli chiese come stava.
«Male», rispose il leone, e le domandò come mai non entrava.
E lei: «Sarei entrata, se non avessi visto molte orme che entrano e nessuna che esce».
Così gli uomini ragionevoli in base agli indizi riescono a prevedere i pericoli e a sfuggirli.
Esopo (VI secolo a.C., schiavo a Samo),
ELOGIO DI ATENE
Lo stratega Pericle, dopo il primo anno della guerra contro Sparta, tiene un discorso per ricordare i primi soldati greci caduti in battaglia. Celebrandone il coraggio, esalta i valori della città di Atene in cui i giovani sono cresciuti e si sono formati, dandoci un ritratto della città greca e dei principi su cui era basata: la democrazia, la responsabilità dei cittadini per il bene pubblico, l’amore per la libertà, la bellezza e la ragione.
[Noi Ateniesi] amiamo il bello con misura e cerchiamo il sapere senza debolezza. Usiamo la ricchezza più come occasione per agire che per vantarcene a parole; e non è vergogna ammettere la propria povertà, quanto piuttosto non evitarla con l’azione.
Decidiamo e discutiamo tra di noi le questioni, ritenendo che danneggi l’azione non il discorso, ma piuttosto il non essere informati attraverso il discorso prima che si arrivi all’azione. Infatti siamo diversi dagli altri anche perché siamo capaci della massima audacia e contemporaneamente siamo capaci di prevedere ciò che dovremo affrontare, mentre per gli altri il coraggio viene dall’ignoranza, l’esitazione viene dal calcolo. Ma è giusto considerare superiore nell’anima chi, conoscendo con la massima chiarezza il bene e il male, non si tira indietro dai pericoli per questo. Anche per ciò che riguarda la virtù, noi Ateniesi ci comportiamo in modo diverso dalla maggior parte degli uomini: ci facciamo degli amici non ricevendo del bene, ma facendolo. Chi ha fatto del bene è un amico più sicuro perché con la sua benevolenza deve mantenere la gratitudine in colui a cui ha fatto del bene; chi lo ricambia è più fiacco, perché restituendo il bene ricevuto non compie un atto di virtù, ma paga un debito. E siamo i soli a fare del bene senza paura, non per il calcolo del profitto che può venirne, ma con la fiducia che viene dalla libertà.

Tucidide (V secolo a.C., Atene), Storie. Libro II, in Il racconto della letteratura greca, a cura di G. Paduano, Zanichelli
DESCRIZIONI
Canto
La Visaille
Canto valdostano che descrive la meraviglia dell’ambiente montano e ci porta dentro lo spettacolo misterioso delle valli incontaminate.
Ma nel mister del bosco ner canta un ruscel un ritornel!
Ma nel candor di nevi al sol si leva un cantico d'amor.
Ascolto
Le onde
Ludovico Einaudi
Il pianoforte ci fa immedesimare in una passeggiata sul bagnasciuga del mare, nel continuo andare e tornare delle onde che ci bagnano i piedi.

PAESAGGI NATURALI
DESCRIVERE CON GLI OCCHI DI UN PITTORE
«I cipressi sono belli come linee e come proporzioni e assomigliano a un obelisco egiziano. Il verde è un colore così distinto. Rappresenta la macchia nera in un paesaggio sotto il sole. Ora bisogna vederli qui contro il blu, nel blu per meglio dire… gli alberi sono molto grandi e massicci. Dietro delle colline viola, un cielo verde e rosa con una falce di luna».
«Finalmente il cielo stellato dipinto la sera sotto un lume a gas. Il cielo è azzurro verde, l’acqua è blu reale, la città è blu e viola, la lampada a gas è gialla e i riflessi sono di un oro rosso e arrivano fino al bronzo verde».
«… un cielo notturno con una luna senza splendore, una falce sottile che emerge dall’ombra opaca, una stella con uno splendore esagerato, se vuole, uno splendore dolce di rosa e verde in un cielo oltremare sul quale corrono le nuvole. In basso una strada bordata di alte canne gialle e un altissimo cipresso dritto e cupo».
«Ho passeggiato una notte lungo il mare sulla spiaggia deserta, non era ridente, ma neppure triste, era… bello. Il cielo di un azzurro profondo era punteggiato di nuvole d’un azzurro più profondo del blu base, di un cobalto intenso, e di altre nuvole d’un azzurro più chiaro, della lattiginosa bianchezza delle vie lattee.
Sul fondo azzurro scintillavano delle stelle chiare, verdi, gialle, bianche, rosa chiare, più luminose delle pietre preziose di quelle che vediamo anche a Parigi, perciò era il caso di dire: opali, smeraldi, lapislazzuli, rubini, zaffiri.
Il mare era di un blu oltremare molto profondo, la spiaggia di un tono violaceo e mi pareva anche rossastra, con dei cespugli sulla duna (la duna è alta cinque metri), dei cespugli color blu di Prussia».
«Il mare prima della tempesta era quasi ancor più impressionante che durante la tempesta stessa. Le onde si susseguivano così rapidamente che l’una si abbatteva sull’altra creando una sorta di schiuma, mentre la sabbia trasportata dal vento avvolgeva il mare in primo piano in una specie di velo.
Proprio lì c’era una barca da pesca, l’ultima della fila, e alcune piccole figure scure…».
Vincent van Gogh al fratello Theo Vincent a Theo. Van Gogh in parole e colori, a cura di A. Rovetta, Edizioni di Pagina
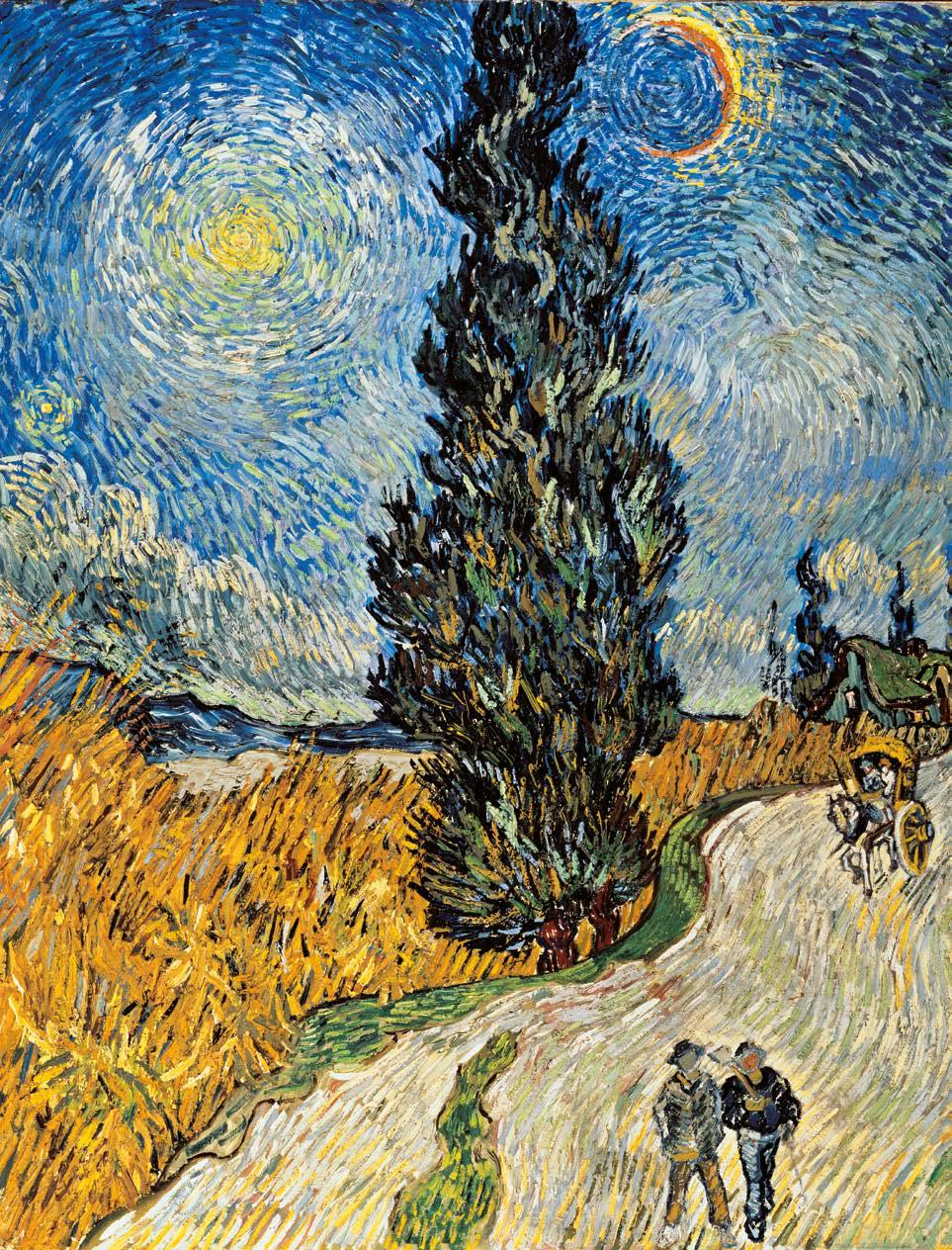
GUARDANDO L’ACQUA
Il Torrente
Lo Zai è il torrente più bello del mondo: con il suo riso, le sue cascate, la sua acqua limpidissima dalla sorgente; burrascoso, irruento, spavaldo, dalle onde color cenere piombo.
Franceschini, La valle più bella del mondo, Vita e Pensiero
La Cascata
Una svolta della strada rese visibile il burrone boscoso e roccioso ove l’acqua andava a cascare. Nell’atto in cui quella vista si presentò ai loro occhi, essi udirono anche il rumore in tutta la sua forza.
Le masse d’acqua cadevano in linea. Precipitavano con fragore mescolando ogni sorta di rumori e di suoni: echi di tuoni, ruggiti, urla, strombettii, schianti, rimbombi.
Era una cosa che sbalordiva.
Sfiorati da un’aria umida, spruzzati, avvolti nel polverio d’acqua, con le orecchie ovattate di rumore, contemplavano lo spettacolo di quella continua catastrofe fatta di spuma e di fragore il cui rombare li assordava.
Mann, La montagna incantata, Tea
La Pioggia
Già la pioggia è con noi, scuote l’aria silenziosa. Le rondini sfiorano le acque spente presso i laghetti lombardi, volano come i gabbiani sui piccoli pesci, il fieno odora oltre i recinti degli orti.
Salvatore Quasimodo


La Pioggia
Poi il profumo della terra bagnata si fece più intenso. L’odore del legno umido cominciò a impregnare l’aria. Ogni foglia, ogni erba emanava una fragranza meravigliosa, forte e fortificante.
Felix Salten, Bambi, Garzanti
Il Mare
Il mare mi apparve che era infinito, tranquillo. Era azzurro infinito e, lontano, grandi strisce d’argento lo imbiancavano lunghe fino agli estremi orizzonti.
La luce saliva nell’aria. Il mare era quieto e sicuro, solo un tremante margine di spuma sul lido, tradiva il suo piacere di vivere. Azzurro e luce volavano sopra la terra. Il mare e il cielo respiravano luce e calore e ne inondavano il mondo. I miei occhi si riempirono di lacrime tenere.
Massimo Bontempelli, La donna dei miei sogni, Arnoldo Mondadori
Il Mare
Fin dove giungeva l’occhio, più in là verso l’infinito, si stendeva ondeggiando l’acqua azzurra, ma con infinite gradazioni di turchino, di verde, di viola, con sfumature di rosa e di arancio leggere leggere.
E su quello sconfinato piano, che si congiungeva in un immenso cerchio con il cielo, correvano palpitando le onde, si avvicinavano, con rapido galoppo si gonfiavano, si sollevavano, si lanciavano con impeto fragoroso sugli scogli, si frangevano impetuosamente in flutti di spume, in turbini di spruzzi candidi che si scagliavano contro il cielo e ricadevano in pioggia di gocce iridescenti.
Virgilio Brocchi
ALBA SUL MARE
Mi piace remare la mattina presto, sul mare.
Il mare ha un odore fresco di alghe verdi e ci volano sopra le farfalle bianche, a due a due, come sui prati in campagna.
Il mare è liscio, di un blu di vetro; io remo piano, raggiungo la costa e prendo a remare vicino alle rocce.
Ogni tanto mi fermo e guardo nell’acqua; vedo che è trasparente e posso scorgere dei pesciolini che nuotano nello scintillio del sole, scodinzolanti, argentei, con una riga nera dentro il corpo di vetro e la pallina nera dell’occhio nella testa.
ESPLORA LA SCRITTURA!
1. Quali aggettivi associa lo scrittore ai nomi:
MARE:
ACQUA:
PESCI:
2. Quali azioni (verbi) si riferiscono allo scrittore?

LE DOLOMITI
Quando ero piccola mia madre mi ha detto che le dolomiti sono rocce lasciate da un oceano che si è, in tempi antichissimi, ritratto; e che sono fatte di conchiglie e creature del mare, accumulatesi negli abissi nel corso di centinaia di migliaia di anni. E che negli strati di roccia si trovano dunque resti di molluschi e impronte di crostacei, e volute di remote conchiglie.
Questa storia dell’oceano scomparso mi sbalordisce profondamente.
Guardo la valle verde di boschi e prati davanti a me e cerco di immaginarmela sommersa dalle acque. Quanto tempo fa?

LA MONTAGNA È VIVA

Dal fondo valle non abbiamo più visto né udito essere umano, e pure non ci sentiamo affatto soli. La grande montagna sulla quale stiamo faticosamente arrancando è più viva che mai; ce lo fa sentire la voce allegra e a volte fragorosa dei suoi torrenti, delle sue cascate d’acqua, il cinguettio degli uccelli, il fischio lontano della marmotta e il ronzio dei mille insetti attirati fin quassù dagli odorosi fiori. Ed è una continua scoperta di aromi, suoni e colori durante tutta l’ascesa alla vetta, finché scende la sera e tutto si posa. Giù nelle valli la notte è già scesa profonda. Dove fino a poco tempo fa si scorgevano lontani paesi e villaggi, ora si sono accesi gruppetti di lumicini che brillano tremolanti rompendo qua e là la nera distesa ondulata delle montagne circostanti.
Walter Bonatti, Le mie montagne, Zanichelli
SCRIVI TU!
Anche tu avrai fatto una gita in montagna, ricordi il paesaggio? Descrivi la vista e ciò che ricordi dei suoni e dei rumori della montagna.
SERA SUL LAGO
Chi ha vissuto una sera d’estate in riva al lago sa che cosa sia la beatitudine. Un calore fermo, avvolgente, sale in quell’ora dalle acque che sembrano lasciate lì, immobili e qua e là increspate dall’ultimo fiato di vento.
Si prova allora, più che in qualunque altro istante della giornata, quella dolce infinita sensazione di riposo auditivo che danno le lagune, dove i rumori non giungono che ovattati.
Come sanno d’acqua le parole che dicono i barcaioli che a quell’ora stanno a chiacchierare sulla scaletta!
Come rimbalzano chiocce nell’aria!
I rintocchi delle squille lontane arrivano all’orecchio, scivolano dall’alto del cielo.


LA VALLE PIÙ BELLA
DEL MONDO
L’animale fece cenno che lo seguissi; e lo vidi, subito dopo, scomparire.
Stupito, cercai e trovai, assolutamente nascosto e invisibile ai piedi della parete, l’imbocco di una caverna, ma così stretta che ci passavo appena.
M’introdussi… e dopo pochi metri fu notte fonda.
Continuai come un cieco, appoggiandomi con le mani alle pareti umide e scivolose; andavo a tentoni nel buio. Quanto durò quell’andare a tentoni?
Non lo so. So solo che a un certo momento quel tunnel nero finì.
Mi stropicciai gli occhi.
Li riaprii… e mi trovai davanti alla più bella valle del mondo.
Non grande.
Una cascata precipitava garrula in basso, formando un limpidissimo lago, cinto da prati verdi e difeso da quattro enormi abeti secolari; scoiattoli e uccelli di ogni genere, dappertutto.
Ginepri con bacche mature, mirtilli neri e rossi.
Ma ciò che mi colpì, più di ogni altra cosa, furono i galli cedroni di ogni età: ma erano stranamente fermi, davanti a me… stranamente fermi.
«Dev’essere il paradiso» dissi fra me, «il paradiso dei cedroni».
Ezio Franceschini, La valle più bella del mondo, Vita e Pensiero
AMBIENTI PARTICOLARI
IL GIARDINO
La casa aveva un’aria alquanto trasandata.
Avrebbe avuto bisogno di una bella tinteggiatura, qualche intervento alle finestre e alle persiane e, soprattutto, di un giardino volenteroso.
In effetti, quello che circondava la casa non era affatto un giardino.
Sembrava piuttosto una giungla. Mancava soltanto qualche tigre, oppure una scimmia su uno degli alberi vicini all’ingresso, e sarebbe stato perfetto per girare il film di Tarzan.
I cespugli di rose erano cresciuti fino al tetto della veranda, e le siepi erano diventate larghe e alte come alberi.
Intorno e sopra ogni pianta si era arrampicata una quantità incredibile di rami di more e di edera. Quest’ultima, poi, aveva anche coperto non solo la facciata della casa, ma persino il tetto fino al camino.
Georg Maag, Il misterioso viaggio nel Medioevo, Piccoli trasandata: trascurata, senza ordine e cura.
LA CASA PIÙ STRANA DEL MONDO
Che meraviglia! Era un posto d’incanto, un luogo di quelli che si vedono solo in sogno o si creano nella fantasia quando si leggono i racconti che descrivono le dimore delle Fate.
Era il regno delle rose; i muri che racchiudevano il giardino ne erano ricoperti e i rami rampicanti si intrecciavano talmente fitti che l’intonaco non era più visibile, sotto quella coltre verde; le piante a cespuglio si erano moltiplicate, dalle aiuole avevano invaso i viali e i vialetti e spuntavano ovunque dal terreno coperto di foglie secche: Mary sapeva che erano rosai benché non fossero in fiore, perché anche in India ci sono piante di rose e lei ne aveva viste molte. Dagli alberi alti, scendeva una vera cascata di rami di rosai rampicanti che talvolta, dalla cima o dai rami, si erano spinti a ricongiungersi da pianta a pianta, formando boschetti, pergolati, festoni. Ma ciò che rendeva quel giardino singolare, diverso da qualsiasi altro, era la rete che formavano sul terreno i rami che, senza sostegno, si erano allungati e intrecciati: erano prive di fiori e di gemme, ma non avevano l’aria di essere piante morte. Oh, certo Mary non aveva mai visto nulla di simile, e certo nessun altro aveva visto un giardino come quello!
«Che silenzio!» sussurrò la bambina. «Che silenzio!».
Si arrestò un istante e tese l’orecchio; ma tutto taceva all’intorno, perfino il pettirosso, che si era posato come al solito in cima all’abete più alto del giardino e aveva smesso di gorgheggiare la sua canzone. Non agitava le alucce, non si puliva le zampette: stava immobile, e guardava giù verso la bambina come per osservare i suoi movimenti.
«Certo che è silenzioso» mormorò Mary, parlando a se stessa. «Da dieci anni nessuna voce è più risuonata qua dentro! Io sono la prima persona che dopo tanto tempo cammina per questi viali!».
Avanzava lentamente, in punta di piedi, badando a non far rumore, come se temesse di svegliare – che so? – la Bella Addormentata nel Bosco, ed era contenta che i suoi passi non frusciassero nell’erba di quel luogo. Si fermò sotto una specie di basso pergolato ed osservò attentamente l’intrico dei rami sopra il suo capo.
«Non mi sembrano morti questi rosai», disse tra sé. «I rami sono verdi! Oh, come vorrei che le piante vivessero ancora!».
Se Ben Weatherstaff fosse stato lì, avrebbe potuto stabilire, osservando i tronchi, se i rosai erano vivi, ma Mary aveva qualche dubbio, perché non vedeva né gemme né foglie. Ma forse era ancora presto, dato che i rosai fioriscono in maggio. Intanto, aveva fatto un primo passo: era entrata nel giardino e lì avrebbe potuto ritornare a piacer suo, senza altra compagnia che quella dell’uccellino che le aveva mostrato la strada: era come se avesse trovato un mondo fatto per lei!
Il sole splendeva gettando il mantello d’oro dei suoi raggi sui viali di quel luogo incantato, e l’azzurro indaco del cielo sembrava più vivo sui giardini, sugli orti di Misselthwaite che sulla brughiera poco distante. Il pettirosso era sceso dall’albero e saltellava qua e là, come per fare gli onori di casa e mostrare all’ospite tutte le meraviglie del suo regno. Chissà, pensava Mary, se quelle rose sarebbero fiorite a primavera! Ce ne sarebbero state a migliaia, da ogni parte, sui muri, sugli alberi, nei cespugli, nelle aiuole, nei viali!

Si avrebbe avuta l’impressione di trovarsi in mezzo a un immenso canestro di fiori!
Hodgson Burnett, Il giardino
Dopo aver riletto La casa più strana del mondo, rispondi alle domande.
1. “Era un posto d’incanto”, a quale ambiente si riferisce?
A. Alla dimora delle Fate.
B. Al giardino.
C. A un luogo immaginato in un sogno.
2. Perché Mary sapeva riconoscere le piante di rose?
A. Perché era esperta in botanica.
B. Perché aveva visto le stesse piante in India.
C. Perché in India aveva fatto un corso di giardinaggio.
3. Che cosa si intende con l’espressione “giardino singolare”?
A. Un solo giardino.
B. Un giardino comune a tanti altri.
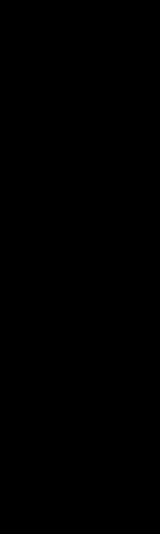
C. Un giardino particolare.
4. Quando Mary pronuncia le parole “Che silenzio!”, con chi sta parlando?
A. Con il pettirosso.
B. Con Ben Weatherstaff.
C. Con se stessa.
5. Quali sono gli elementi che fanno capire a Mary che i rosai non sono morti?
A. I rami verdi.
B. È maggio.
C. La presenza di gemme e foglie.
6. La vista di questo luogo che cosa suscita in Mary?
A. Inquietudine.
B. Attesa.
C. Imbarazzo.
8. Metti la crocetta giusta nella tabella. V F
Nel giardino si trovava una fresca cascata d’acqua. ⬜ ⬜
Mary ha già visto molti giardini come quello. ⬜ ⬜
Il pettirosso, appena posato sull’abete, si muove con frenesia. ⬜ ⬜
Mary non è sicura che il giardino sia ancora vivo. ⬜ ⬜
LA SOFFITTA
La soffitta era grande e buia.
Odorava di polvere e di naftalina.
All’infuori del tambureggiare leggero della pioggia sulle lastre di rame del gran tetto, non si sentiva volare una mosca.
Travi possenti, nere di vecchiaia, si levavano a intervalli regolari dal pavimento, e si incontravano più in alto con altre travi del tetto, per perdersi poi da qualche parte nel buio.
Qua e là pendevano dal soffitto ragnatele grandi come amache, che si muovevano avanti e indietro nella corrente d’aria, lievi e silenziose come spiriti.
Dall’alto di un finestrino che si apriva sul soffitto scendeva un lattiginoso raggio di luce.
Nella soffitta era sparsa un po’ dappertutto ogni sorta di ciarpame; alle pareti c’erano scaffali pieni di raccoglitori e di cartelle, pacchi di incartamenti che non servivano più a nessuno.
Nel mezzo erano accatastati banchi di scuola, gli uni sugli altri, con i ripiani macchiati d’inchiostro; un cavalletto da cui pendevano vecchie carte geografiche e parecchie lavagne e alcuni animali impagliati mangiati dalle tarme.
In un angolo del pavimento erano stese vecchie e macchiate stuoie da ginnastica e alcune coperte militari grigie, molto polverose e malconce.
Michael Ende, La storia infinita, Tea
lattiginoso: di colore bianco simile a quello del latte. ciarpame: cianfrusaglie, insieme di oggetti inutili.
Mettiamoci all’opera
In soffitta
Rileggi con attenzione
La soffitta, immagina lo spazio della soffitta e gli elementi descritti all’interno.
Disegna la soffitta e ciò che contiene su un foglio bianco con la matita grafite, ricalca il disegno su un acetato trasparente dello stesso formato del foglio di partenza, con un pennarello indelebile.
Sovrapponi l’acetato a un cartoncino nero dello stesso formato e uniscili sul lato lungo in alto con una striscia di scotch.
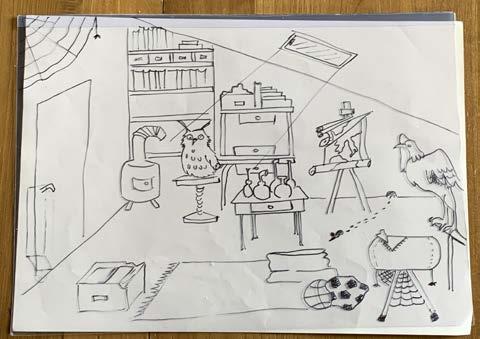

A questo punto puoi realizzare la torcia di cartoncino bianco colorando il manico. Infilando la torcia tra l’acetato e il cartoncino nero ti sembrerà di perlustrare la soffitta al buio! Volendo con dei pennarelli rigorosamente indelebili è possibile rendere tutto a colori.
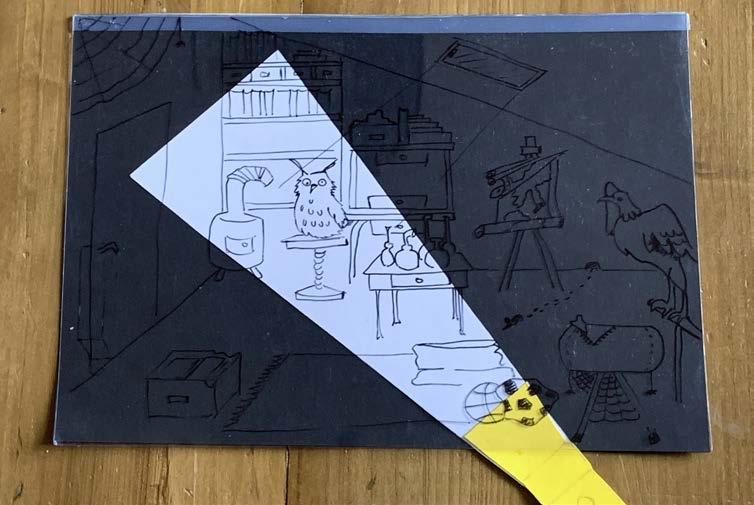
LA STANZA DI SANDOKAN
Una stanza di quell’abitazione è illuminata, le pareti sono coperte di pesanti tessuti rossi, di velluti e di broccati di gran pregio, ma qua e là sgualciati, strappati e macchiati, e il pavimento scompare sotto un alto strato di tappeti di Persia, sfolgoranti d’oro ma, anche questi lacerati e imbrattati. Nel mezzo sta un tavolo d’ebano, intarsiato di madreperla e adorno di fregi d’argento, carico di bottiglie e di bicchieri del più puro cristallo; negli angoli si rizzano grandi scaffali in parte rovinati, zeppi di vasi riboccanti di braccialetti d’oro, di orecchini, di anelli, di medaglioni, di preziosi arredi sacri, contorti o schiacciati, di perle provenienti senza dubbio dalle famose peschiere di Ceylon, di smeraldi, di rubini e di diamanti che scintillavano come astri, sotto i riflessi di una lampada dorata appesa al soffitto. In un canto sta un divano turco con le frange qua e là strappate; in un altro un armonium di ebano con la tastiera sfregiata, e all’ingiro, in una confusione indescrivibile, stanno sparsi tappeti arrotolati, splendide vesti, quadri, lampade rovesciate, bottiglie ritte o capovolte, bicchieri interi o infranti e poi carabine indiane arabescate, tromboni di Spagna, sciabole, scimitarre, accette, pugnali, pistole.
LE CASETTE DI BELVEDERE DEI TIGLI
In un grande bosco di castagni tra le montagne c’era una grande quercia che aveva intorno dei tigli profumati. Ma intorno agli alberi di tiglio non c’erano soltanto i castagni, c’erano anche molte casette con il tetto dipinto di un bel colore verde. La quercia e i tigli, insomma, crescevano proprio nella piazza di un villaggio di boscaioli che, come puoi ben capire, si chiamava Belvedere dei Tigli.
I muri delle casette, però, non erano mica verdi. Anzi, erano di tanti colori, perché i boscaioli li avevano dipinti come preferivano.
Per esempio, c’era una casetta che aveva i muri blu come il mare; difatti c’erano dipinti anche molti pesci. Ma in quella casa non ci stava mica il pescivendolo. Ci stavano il boscaiolo Serafino, sua moglie Sibilla, i loro cinque bambini e quattro mucche. Però Serafino aveva uno zio pescatore che viveva lontano, sul mare; tutti gli anni decideva di andarlo a trovare, ma nasceva ogni volta un nuovo bambino e non poteva più.
Lì vicino c’era una casetta su cui erano dipinti tanti formaggi: pecorini, provoloni, caciotte, mozzarelle, fontine, ricotte, e tanti omini, donnine, bambini e gatti che se li mangiavano. In quella casa vivevano il boscaiolo Silvestro, sua moglie Belinda, i loro quattro bambini e due gatti, e erano tutti molto golosi dei formaggi. E ogni volta che mangiavano un formaggio nuovo lo dipingevano sulla casa insieme a loro che se lo mangiavano.
Poi c’era la casetta dove viveva un vecchio boscaiolo e la sua vecchia moglie. Lui si chiamava Ciccio, lei Ciccia e piangevano sempre. Lui piangeva mentre spaccava la legna nel bosco e lei mentre rimestava la polenta, poi piangevano insieme mentre mangiavano, e anche a letto prima di addormentarsi. Nei giorni di festa, continuando a piangere, si mettevano fuori della casa a dipingere sui muri tante ballerine che ballavano: perché l’anno prima l’unica figlia che avevano, la bella Fiorina, se n’era andata tutta sola chissà dove a fare la ballerina. Per questo piangevano.
Vicini a Ciccio e Ciccia abitava solo soletto il sarto Camillo e sulla sua casa c’era dipinto il Polo Nord: ghiaccio e neve con gli orsi bianchi, le foche e i trichechi. Sai perché? Perché Camillo era un gran freddoloso e non voleva mai uscire di casa. Se qualcuno lo chiamava, lui sporgeva la testa dalla porta, guardava il Polo Nord dipinto sulla sua casa e diceva: «Brrr… che freddo! Fa così freddo che sembra di essere al Polo Nord! Non posso uscire, non posso uscire, se no chissà che raffreddore mi prendo!».
Pensa poi che in ogni stanza aveva tre stufe e due camini sempre accesi; per questo sul suo tetto c’erano moltissimi comignoli che fumavano continuamente. Camillo faceva il sarto così poteva farsi tanti vestiti per poter stare sempre più caldo.
In un’altra casetta vivevano due boscaioli fratelli che si chiamavano Giacomino e Giacomone. Siccome un loro cugino era emigrato in America, sulla casa avevano dipinto tanti ippopotami e giraffe, perché credevano che gli ippopotami e le giraffe vivessero in America.
Ma la casa più bella di tutte era quella di Marianna e Nemorino. Marianna era una donnina piccina bianca e rosa, mentre Nemorino era un boscaiolo alto come un albero e coraggioso come un leone.
La casa di Marianna e Nemorino era bella perché era piena di fiori di bosco, nelle stanze, sulle finestre, sulla terrazza, in cima al tetto, e poi era tutta dipinta di fiori di ogni colore sicché non si sapeva più quali fiori fossero dentro e quali fossero fuori. Ma quella casa era bella soprattutto perché Marianna e Nemorino avevano due figlie gemelle, che si chiamavano Bella e Linda, belline e intelligenti che non ti dico, insomma come tutti i bambini.
Proprio accanto alla casetta di Marianna e Nemorino, c’era un palazzo nero e buio dove non c’era dipinto niente. Le sue finestre erano sempre chiuse tappate, fuorché una in cima che aveva davanti un balcone di legno: quel balcone aveva la forma di un’aquila arrabbiata con le ali aperte.
Il padrone del palazzo, che si chiamava Bertoldo Panciolini, si metteva tutti i momenti affacciato a quel balcone a guardare quello che faceva la gente, insomma a spiarla.
La notte era profonda e non c’era vento. Nel bosco di Belvedere c’era un gran silenzio. A un tratto, fra gli alberi del bosco, apparve un omaccione che aveva addosso un lungo mantello nero e in testa un cappuccio nero. La sua faccia era bianca e cattiva, i suoi occhiacci parevano dei chiodi neri e i suoi lunghi baffi, rivolti all’insù, sembravano due uncini neri. In una mano aveva una lunga frusta…
L’omaccione si tolse il mantello nero: sotto aveva una divisa da domatore tutta rossa, con le cordicelle e i bottoni d’oro sul petto.
Intorno alla quercia venne su la casa più strana che si fosse mai vista. Aveva una quantità di finestre, quadrate, rotonde, triangolari, dritte e storte, grandi e piccole, in alto e in basso. E c’erano almeno dieci porte, larghe, strette, alte, basse. Il tetto era alto. Sul tetto c’erano abbaini, comignoli, terrazzini, finestrine e molte scalette.
E dentro la casa c’era una quantità di stanze piccole e grandi, quadrate
e rotonde, larghe e bislunghe, piccole e storte. C’erano armadietti dappertutto, anche in mezzo alle stanze. C’erano corridoi che salivano, scendevano, giravano. E c’erano lanternine in ogni angolo.
A un certo punto Celestino disse: «Adesso la casetta è finita. È bellissima».
Carpi, Il paese dei maghi, Piemme rimestava: rimescolava.
Metti la crocetta giusta nella tabella.
F
I muri delle casette a Belvedere dei Tigli sono tutti verdi. ⬜ ⬜
Nella casa su cui erano dipinti molti pesci vivevano dei pescivendoli. ⬜ ⬜
Silvestro e Belinda ogni volta che mangiavano un formaggio lo dipingevano sulla casa. ⬜ ⬜
Ciccio e Ciccia erano due boscaioli malinconici. ⬜ ⬜
Il sarto Camillo amava il freddo e per questo ha dipinto il Polo Nord sulla sua casa. ⬜ ⬜
La casa più bella di tutte è quella di Giacomino e Giacomone. ⬜ ⬜
La casa di Marianna e Nemorino è bella soprattutto perché c’erano le loro due figlie gemelle. ⬜ ⬜
La casa più strana che si fosse mai vista era quella di Bertoldo Panciolini. ⬜ ⬜
Gli occhiacci dell’omaccione sembravano due uncini neri e i suoi lunghi baffi parevano dei chiodi neri. ⬜ ⬜
La casa più strana aveva finestre, porte e stanze di diverse forme e dimensioni. ⬜ ⬜
I NOSTRI OGGETTI PARLANO DI NOI
Buongiorno, sono il violino di Giulia, ci siamo conosciuti il 16 maggio del 2015. Prima appartenevo alla sua maestra che si chiama Silvia. Insieme, Giulia ed io, abbiamo fatto molta strada e abbiamo capito che siamo fatti l’uno per l’altra.
Per suonarmi, Giulia usa il mio fratellino archetto: siamo proprio un bel trio!
La mia padrona mi adora perché insieme facciamo una musica stupenda e dolce e quando mi suona si toglie via tutti i pesi che ha in testa!
Mi tratta abbastanza bene, mi conserva nella mia custodia dove mi sento al calduccio. Con me Giulia è buona: quando mi scordo, lei subito mi aiuta. Io e lei andiamo d’accordo e, quando sbaglia la nota, la perdono perché non lo fa apposta. A me piace il suono che produciamo e insieme siamo un’ottima squadra!
Sono nastro e sono l’oggetto preferito di Chiara. Sono viola, molto morbido, di una stoffa scintillante e profumata; ho attaccato un bastoncino che serve alla mia amica per darmi la mano. Non sono mai da solo: quando Chiara non mi usa, mi mette in un sacchetto con i miei migliori amici, cioè Palla, Fune, Cerchio, Clavette, che servono a Chiara per fare ginnastica ritmica.
Siamo una squadra vincente! Ho degli esercizi preferiti che, quando la piccola ginnasta me li fa fare, mi divertono un mondo, per esempio quando mi solleva in aria e mi fa girare così forte che finisco per abbracciarla.
Chiara e io abbiamo delle cose in comune: siamo giocherelloni, semplici e simpatici!
Ciao! Mi presento, sono la chitarra di Jacopo, sono una tipa rock, soprattutto quando Jacopo mi inserisce il cavo. Il mio proprietario non mi usa molto spesso, ma quando lo fa, mi pizzica le corde, mi fa molto solletico. Sono di legno, di color rosso, bianco, marrone e argento, ho una forma irregolare.
Una volta Jacopo e io siamo saliti su un palco, mi sentivo molto agitata, ma alla fine, anche se lui ha fatto alcuni errori, è andata benissimo.
Sono la racchetta da tennis di Elisa, mi piace giocare a tennis con lei, anche se, quando la pallina mi viene incontro, mi faccio un po’ male. Elisa e io ci siamo conosciute in un negozio consigliato dal suo papà perché, fortunatamente per me, doveva cambiare racchetta. Non ero preoccupata perché la scelta era tra me e un’altra racchetta gialla e nera poco bella e quindi sapevo che mi avrebbe preferita! La prima volta che mi ha usata, non riusciva bene a colpire la pallina, ma poi ci siamo allenate e adesso sconfiggiamo tutti. Insieme abbiamo vinto alcuni tornei di tennis. Sono contenta del mio lavoro!
Elisa, classe IV
Sono l’armonica di Michele e sono con lui dall’anno scorso, quando mi ha trovato nel cassetto della camera di suo padre, a cui appartenevo quando era piccolo. Sono di metallo e plastica, ho un amico rosso: è il mio astuccio che mi trasporta durante i viaggi e mi tiene al sicuro. Ho dieci minuti buchini, in cui Michele soffia con delicatezza e io emetto suoni dolci e duri, compongo canzoni liete e allegre.
SCRIVI TU!
Pensa a un oggetto a te caro, prova a immedesimarti in esso e a farlo parlare di te.
Michele, classe IV
IN CITTÀ
CITTÀ PRESENTE
Sia che si tratti di persone, di oggetti o di luoghi, ciò che amiamo non ci stanca mai e ci chiama ad una continua rivelazione di sé. La stessa cosa vale per la città che abitiamo o anche quella che visitiamo, se il nostro viverla è animato da curiosità e desiderio di scoperta.
Anche Cesena, che pure non è mai stato un centro di grande flusso turistico, è rappresentata dai suoi monumenti più considerevoli; eppure anche essa ha un volto meno conosciuto che un visitatore, ma anche un cittadino, deve voler scoprire. Nulla di misterioso né di peculiare, lo stesso discorso lo si può fare per ogni comune d’Italia. Ovunque infatti c’è una serie di stradine secondarie,
di cortili, di androni, di angoli che vale la pena scovare, in cui si può trovare uno scorcio di bellezza, un reperto che ha attraversato indenne i secoli, un luogo appartato che aveva in passato funzioni particolari.
Gianfranco Lauretano, Cesena nello sguardo, nella mente, nel cuore, Il Vicolo
itinerari: percorsi, strade, tragitti. androni: entrate, ingressi.
SCRIVI TU!
Nel luogo dove risiedi o in vacanza hai scoperto una via, un giardino o un monumento che ti è sembrato bello? Descrivilo cercando di far capire che cosa lo rende particolare.

Mettiamoci all’opera
La città
Se osserviamo la nostra città con sguardo curioso e creativo, possiamo riconoscere alcuni suoi elementi tipici: palazzi, case, tram, auto, giardini, monumenti.
Cerca sulle riviste alcune immagini di questi elementi e ritaglia o riproduci alcuni di essi poi mettiti all’opera incollando le immagini e “legandole” insieme con strade, ponti, semafori in un unico quadro. Scegli un colore per il cielo e completa.

TRA LE BANCARELLE
È un esercito ordinato quello che si è geometricamente disposto: carciofi, zucchine, lattughe dal cuore pallido, fragole turgide, mele d’oro; e questi peperoni ardenti, queste collane d’aglio appese come monili, e il profumo del primo basilico che ti lambisce mentre passi?
Che abbondanza splendente; ti incanti a guardarla, così offerta per pochi euro al primo che allunghi la mano. Sorridiamo di quelle zucchine col fiore giallo, allineate come gioielli, e dell’oro caldo delle ultime arance. E poi anche dei piccoli sandali incolonnati su un banco, come vogliosi di essere calzati da bambini, e di poter correre.
Sorridiamo e compriamo anche cose quasi inutili: sacchetti di lavanda per la biancheria, ombrelli cinesi che dureranno il tempo di un acquazzone.
Marina Corradi
monili: gioielli.
lambisce: tocca, sfiora.
SERA IN CITTÀ
Scende la sera.
Il cielo, poco fa rosso per gli ultimi bagliori del sole, diventa turchino.
I colori si confondono in un’ombra sempre più cupa, i muri delle case prima gialli, rosati, bianchi, si ingrigiscono ora tristemente.
Ad un tratto una finestra si illumina di scatto; un’altra; un’altra ancora.
Poi, è la volta delle lampade nelle strade; s’accendono contemporaneamente e sembra che all’apparire del loro giallo chiarore, il cielo divenga più nero.
In poco tempo la città è un fulgore di luci; le vetrine dei negozi ne riversano a fasci, bianca, dorata, sul selciato del marciapiede.
Le insegne pubblicitarie scintillano, rosse, azzurre, verdi… Si accendono e si spengono, tremolano, si muovono, sembrano correre da un lato all’altro dei palazzi… Sono luci e luci: lampade, tubi fluorescenti, scritte al neon…
In meno di un’ora la città ha cambiato aspetto.
bagliori: lampi, chiarori, luci improvvise. fulgore: splendore, lucentezza.
Gino Di Rosa

Mettiamoci all’opera
Il mercato
Ti è capitato di osservare la vivacità dei colori delle bancarelle dei mercati?
Cerca le immagini del mercato della tua città o dei mercati visitati in altre città e soffermati sui particolari delle forme e dei colori, ad esempio della frutta o della verdura.
Scegli una immagine e prova a ricopiarla, attento a rendere i vivaci colori della merce con i pastelli o con le tempere.
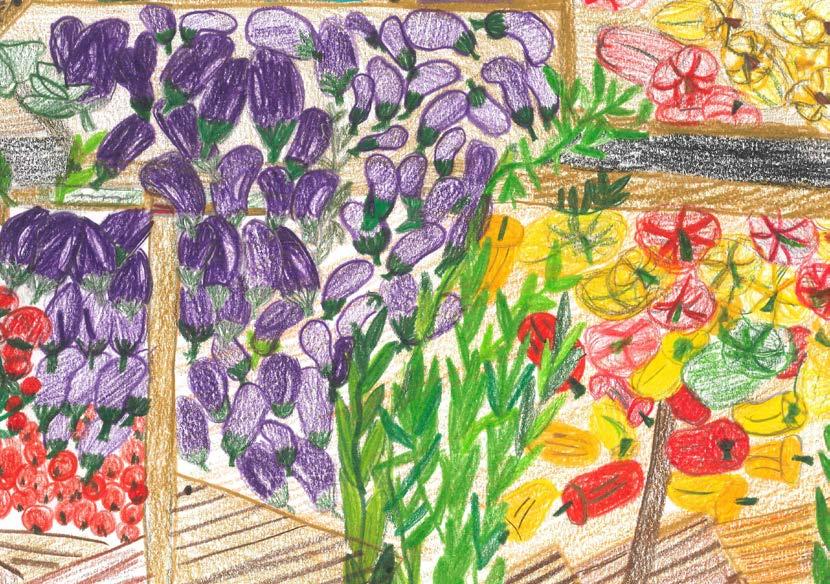
IN CITTÀ AL MATTINO
L’automobile bisogna pur lasciarla in qualche posto e alle otto del mattino trovare un posto libero lungo il marciapiede è quasi impossibile… Il mio prossimo, donne e uomini, formicola già per le strade del centro; e le vie lunghissime e diritte hanno purtroppo da una parte e dall’altra una ininterrotta fila di macchine ferme e vuote, a perdita d’occhio.
Dove troverò un posto per la mia? Ansiosamente esploro una via dopo l’altra, in cerca di un rifugio. Meno male: là c’è una signora che sembra stia per risalire in macchina. Rallento, aspettando che lei parta per occupare il suo posto.
Ma, mentre io cerco di dominare in tutti i modi l’impazienza che mi spingerebbe a sollecitare con un colpetto di clacson la partenza dell’automobile di quella signora, un coro frenetico di strombettii si scatena alle mie spalle.
Intravedo, voltandomi, la faccia congestionata di un camionista che si sporge in fuori, mi urla ingiuriose parole e con il pugno pesta sullo sportello, per dar rumore alla sua collera.
Sono costretto a proseguire. E quando, fatto l’intero giro dell’isolato, torno sul posto, la signora se ne è andata, è vero, ma già nello spazio libero qualcun altro sta infilando la sua auto.
congestionata: bloccata, ferma.
SCRIVI TU!
Dalla finestra o dal balcone osserva il luogo in cui abiti e la zona intorno alla tua casa in due momenti, al mattino e alla sera. Descrivi quello che vedi, mettendo in evidenza cosa cambia.

LA STRANA MERAVIGLIA DEI TRENI
Il treno per Milano è in partenza dal nono binario.
Il muso affusolato ed elegante dell’Eurostar è immobile, il parabrezza rigato di pioggia.
Corrono i viaggiatori in ritardo mentre la voce anonima dell’altoparlante annuncia che è l’ora.
Il capotreno si sporge dal predellino del primo vagone, getta un’occhiata al marciapiede dove non c’è più nessuno, con un ampio gesto del braccio sventola il berretto, il fischio taglia l’aria. È il segnale, con un soffio meccanico le portiere si chiudono, il locomotore si muove con lenta dolcezza, e trascinandosi dietro la lunga colonna di vagoni entra nella notte.
È strano. Un treno che parte è qualcosa che resti a guardare. Forse è per via del sapiente orientarsi del locomotore nella ragnatela di scambi? Quei secchi scatti, e il serpente sferragliante che trova la strada come un animale che riconosce il suo sentiero.
O forse è per lo stringersi nelle carrozze, sotto a una luce fredda, di tante facce di uomini, così vicini e così stranieri? Poi quando il treno corre, le case e i paesi lungo i binari fuggono via in un baleno.
Oppure ciò che segretamente ci riguarda è la via già tracciata da quei binari lucenti: il treno non decide la sua strada, ma segue quella che gli è stata data. Allora dopo la lunga corsa scoccano, nel labirinto nero e scintillante sotto ai fari, gli scambi giusti, e adagio le carrozze approdano sulla banchina.
Marina Corradi, Prima che venga notte, Marietti
SCRIVI TU!
Treni, tram, autobus
Ti sarà capitato di fare un viaggio con uno di questi mezzi o anche con altri. Ripensa alla tua esperienza e racconta descrivendo ciò che hai visto, udito, provato (immagini, rumori, odori, emozioni, …).

LA GRANDE GUGLIA

Quando parlo della Grande Guglia, non parlo di una guglia tra le altre, ma della guglia più guglia di tutte, la guglia per eccellenza, la prima che tutti guardiamo, sempre, quella che caratterizza maggiormente l’edificio che a sua volta caratterizza, cento volte più di qualunque altro, la nostra città.
Quando io penso al centro di Milano, penso al Duomo, e quando penso al Duomo penso alla Madonnina, che poggia sulla Grande Guglia. Non esiste nulla a Milano che catalizzi gli sguardi di tutti, ma soprattutto di chi ci vive, come questa guglia. Se potessimo contare gli sguardi che si posano su ciascun edificio, parte di edificio, monumento, opera o semplice oggetto della nostra città, su qualsiasi elemento del patrimonio cittadino, io credo che la Grande Guglia del Duomo supererebbe di parecchie lunghezze qualunque altra cosa.
Perché Milano è fatta così, Milano è fatta affinché i nostri occhi salgano verso quel punto. La sua struttura a raggi è fatta perché chi procede verso il centro di Milano guardi quel punto. Tutto lo spazio della città, nonostante i molti rimaneggiamenti, rimodernamenti, bombardamenti, dismissioni eccetera, mantiene questa struttura originaria.
I passi, seguendo lo sguardo, si avvicinano a quella meraviglia. La Madonnina è lassù, leggera e scintillante. Poi, una volta giunti, ecco il Duomo tutto intero, la sua potenza ora ci si mostra tutta dopo la leggerezza che ce l’aveva annunciato. Il poeta Clemente Rebora ha ben sintetizzato, in una sua celebre quartina, il sentimento di noi tutti di fronte al Duomo: Il portentoso Duomo di Milano / non svetta verso il cielo / ma ferma questo in terra in armonia / nel gotico bel di Lombardia.
La caratteristica del Duomo non è di svettare, ma di tirare giù il cielo, di tirarlo in terra. Visto in mezzo alle case, sembra che voglia correre lassù, perché quella che vediamo è solo la guglia che regge la Madonnina. Ma quando ci si va vicino la prospettiva si modifica. Le altre città hanno perlopiù centri molto grandi. Pensiamo a Roma, a Parigi, a Londra. Esistono però città in cui il centro coincide con una cosa sola. Un esempio è Siena; un altro, il più clamoroso, è Milano. Il centro di Milano è un punto, non ha quasi spazio, e al tempo stesso è tutta la città, e il suo tetto si stende come un immenso telo appoggiato sul filo, sugli infiniti fili dei nostri sguardi che salgono fin lassù. Il Duomo volle essere fin dal primo istante la Casa dei milanesi. Tutta Milano è come dentro il Duomo, e io credo che non esista nessun’altra città al mondo capace di incarnare un’idea di spazio simile a questa.
Luca Doninelli, Milano è una cozza. Storie di trasformazioni, Guerini e associati
catalizzi: attiri, catturi.
ROMA

Roma: non sarebbe meglio metterlo al plurale questo nome? In Roma esistono infatti tante città. Vi è la Roma repubblicana e quella dei Cesari, la Roma dei primi cristiani, dei martiri e delle catacombe; la gloriosa Roma papale e quella di Michelangelo e del Bernini; la grandiosa città dei sette colli, delle basiliche maggiori, del Colosseo e del Palatino; la deliziosa piccola Roma delle straducole scure…; vi è la Roma dei giardini e dei palazzi, con i suoi pini, le fontane, gli archi; e infine, c’è la Roma capitale dell’Italia. Eppure, tutte queste città non sono che una Roma sola: sovrapposte, mescolate le une alle altre, esse formano, tutte assieme, questo luogo unico al mondo dove, in un paesaggio armonioso, si fondono venti secoli di civiltà… Il Tevere non le separa, anzi le unisce se dall’alto del Campidoglio si contempla, in fondo alla valletta, il Foro simile ad una culla, si può veramente dire che si tratta di una culla; quella del diritto, delle leggi reggenti i rapporti fra individui e società. E quando, sull’altra riva del fiume, ci si trova sotto la cupola di San Pietro, si domina la tomba del primo Apostolo al quale Cristo disse: «Tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la mia chiesa». Il Foro romano ci ha insegnato la nozione dell’ordine; il messaggio cristiano ci ha insegnato che l’ordine non esiste senza la carità evangelica. Tutta la nostra civiltà è racchiusa in questa armonia.
Wladimir d’Ormesson
INCON T R I AMO LA POESIA
A FIRENZE
Arno gentil, fiorenti prati de le Cascine, leggiadre palazzine, superbi monumenti, bianche ville ridenti sparse per le colline, vezzose fiorentine dai musicali accenti,
bella città dei fiori piena di glorie sante, cinta d’eterni allori;
culla immortal di Dante che l’universo onori, t’amo come un amante.
Edmondo De Amicis
VENEZIA
C’è una città di questo mondo, ma così bella, ma così strana, che pare un gioco di fata morgana o una visione del cuor profondo.
Avviluppata in un roseo velo, sta con sue chiese palazzi giardini tutta sospesa tra due turchini, quello del mare, quello del cielo.
Diego Valeri
LA MIA CITTÀ
La mia città è come una persona, un po’ la conosco e un po’ la ignoro, ha lati misteriosi la sua storia, fatta di fatica e oro.
Le sue vie larghe o strette, i monumenti, le chiese, i palazzi o le casette sono come l’espressione del viso delle persone.
Com’è bello girarla scoprirla nei suoi angoli, impararla nei suoi vicoli.
Chissà che cosa sogna la mia città… Nel petto un cuore ha, e sotto il cielo la sua vita come un grande fiume va… Davide Rondoni
COME UN POETA
Nella poesia La mia città possiamo facilmente riconoscere delle similitudini e delle metafore.
La similitudine è un paragone tra due elementi, espresso dalla parola
Le vie e le case sono come l’espressione del viso
La vita della città è come un grande fiume
Le metafore sono dei paragoni “senza come”, cioè parole trasportate in un contesto diverso da quello abituale.
La città sogna
La città ha un cuore
La città diventa come una persona.
Questo tipo di metafora di facile costruzione permette di personificare oggetti ed elementi naturali.
Proviamo a personificare:
Il vento urla, corre, gioca,
La luna sorride, si nasconde,
La casa abbraccia,
La strada

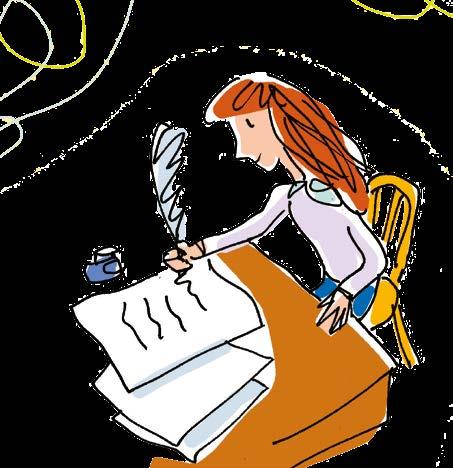
TESTI DI NARRATIVA PER LA LETTURA INTEGRALE IN CLASSE
FANTASY:
LE CRONACHE DI NARNIA · C.S. Lewis
Il ciclo di storie rappresenta un valido e coinvolgente contesto narrativo che fa riferimento alla storia dell’umanità, la creazione del mondo, la presenza del male, la redenzione e il trionfo del bene assecondando i temi della rivelazione cristiana. Le storie, per il fantasioso contenuto e il carattere avventuroso e mitologico, sono facilmente comprensibili e godibili. Offrono un viaggio verso la realtà che permette di riflettere su di sé e sulla vita.
IL MAGO DI OZ · Frank Baum
Il libro narra la storia di una bambina, Dorothy, che a causa di un ciclone si trova a vivere un’avventura nel Regno di Oz. Per poter tornare dagli zii nel Kansas deve chiedere aiuto al famoso mago di Oz. Nel suo viaggio incontra compagni che a loro volta hanno un dono da chiedere al mago. Si scoprirà che tutti possiedono già ciò che vorrebbero chiedere, ma solo dopo il cammino impareranno a utilizzarlo.
AMICIZIA:
I RAGAZZI DELLA VIA PAL · Ferenc Molnár
Il libro racconta una bella storia di amicizia, con le avventure tipiche della vita dei ragazzi e le esperienze familiari e sociali a loro comuni. Due bande di quartiere si incontrano affrontando situazioni diverse: il gioco, la battaglia, il tradimento, il perdono e la morte di un compagno. Il susseguirsi di avvenimenti nella vita della banda dei “Ragazzi di Via Pal” si integra a belle descrizioni di personaggi e luoghi. La prosa rende bene i sentimenti e favorisce l’immedesimazione.
LA BANDA DEI CINQUE · Enid Blyton
Tre fratelli si uniscono a una strana cugina aiutandola a ritrovare il tesoro appartenuto a un suo avo e a scoprire sé stessa attraverso la loro generosa amicizia.
AVVENTURA:
UN VIAGGIO FANTASTICO · Gerald Durrell
Il prozio Lancelot coinvolge i suoi tre giovani nipoti in uno straordinario viaggio alla ricerca del fratello Parceval, famoso scienziato scomparso. In ogni tappa si troveranno immersi nella diversità della vita animale e degli ambienti naturali. I ragazzi dovranno avere «il naso preparato agli odori e la lingua ai sapori, le dita pronte a toccare e le orecchie e gli occhi ben aperti, per esplorare e godere tutto».
LA STORIA DI ULISSE E ARGO · Mino Milani
Il libro narra la vita di Ulisse, da ragazzino pauroso a eroe greco. La sua vita è costellata di sfide e rapporti che lo aiutano a crescere, solo grazie a tale percorso riesce a non arrendersi di fronte agli imprevisti che caratterizzano la sua esistenza. Il testo può essere utilizzato come inizio del percorso di storia in merito alla civiltà greca.
Le letture che hai fatto o che hai ascoltato, i racconti dei compagni e dei maestri, le tue esperienze sono un bagaglio prezioso.
Come nel viaggio il bagaglio è utile per avere con sé quello che serve, così nel tuo percorso gli incontri e le letture svolte ti possono servire e aiutare.
Adesso che hai imparato a scrivere parole e frasi, esprimerti in autonomia può essere una bella occasione per osservare con attenzione, ricordare e fissare le cose che ti accadono.
Se scrivi un pensiero o un racconto usi le parole per comunicare, cioè per dare ad un altro qualcosa di tuo: questo accade perché quando scrivi tu condividi ciò che hai incontrato, ciò che hai visto o sentito, che hai provato e conosciuto.
Esprimerti in un testo ti aiuterà ad accorgerti di quello che capisci; infatti, mentre scriviamo pensiamo e ragioniamo, scegliamo cosa dire e riflettiamo su ciò che è prezioso.
È vero: scrivere non è sempre facile, prova a farlo spesso annotando le tue osservazioni e scrivendo i tuoi pensieri o brevi testi, magari abbozzi di racconti immaginati insieme agli amici, ti accorgerai che la scrittura diventerà per te un’attività familiare.
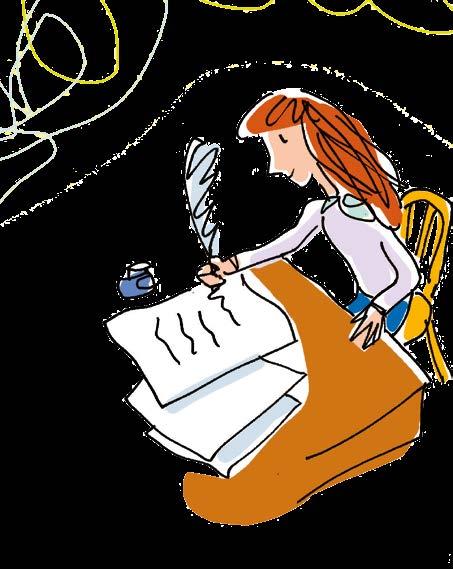
RACCONTARE
Quando scrivi puoi raccontare ciò che hai incontrato, ciò che ti è capitato, ciò che ti ha colpito e che ti sembra valga la pena trattenere e condividere.
La tua esperienza è unica, originale e nuova. Puoi raccontare di una gita scolastica o con la famiglia, di uno sport, di un’attività extrascolastica, degli incontri e delle amicizie, di un evento, di una festa, di una situazione in cui ti sei trovato e puoi raccontare le tue emozioni e le tue scoperte.
Per scrivere un buon testo, occorre introdurre il discorso in un quadro generale:
• Di chi stiamo parlando?
• Di quale evento si tratta?
• Dove e quando accade?
• Come si svolgono i fatti?
Attento però a non scrivere ciò che è ovvio e per questo poco interessante; non essere frettoloso e cerca di raccontare in modo da far immaginare bene al lettore fatti e personaggi.
Per spiegarti bene puoi anche motivare ciò che scrivi affinché chi legge comprenda meglio.
In chiusura, puoi comunicare un pensiero personale, una riflessione, fare un commento che chiarisca apertamente ciò che ritieni importante che il lettore sappia.
Spesso nelle sezioni di questo libro ti viene chiesto di raccontare la tua esperienza, dopo aver incontrato, attraverso la lettura, l’esperienza di un altro.
Pagine: 5, 12, 22, 29, 35, 36, 50, 56, 89, 110, 112, 125, 128, 196.
DESCRIVERE
Se osservi con attenzione quello che c’è intorno a te, puoi farlo vedere agli altri attraverso le parole.
Sono soprattutto i nomi e i verbi appropriati che rendono presente, a chi ascolta o legge, l’oggetto, il paesaggio, la situazione che descrivi. Inoltre, quando si descrive occorre fare attenzione anche agli aggettivi che si scelgono, i quali esprimono le caratteristiche degli oggetti e delle persone nominati così che il lettore possa immaginarli con esattezza.
Ciò è importante solo per chi leggerà la tua descrizione? No, anche per te!
Sì, perché mentre scrivi, come mentre disegni, ti capiterà di scoprire e cercare di nominare aspetti a cui prima non avevi fatto caso, di chiarirti i pensieri e le immagini che hai in mente.
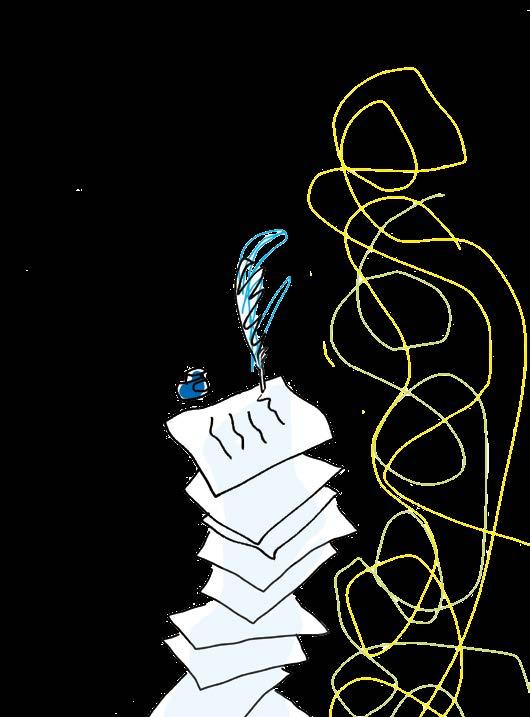
Puoi prendere spunto ed esempio da alcuni scrittori in diverse pagine di questo libro e in una sezione interamente dedicata a questo “sguardo”.
: 15, 70, 82, 109, 184, 198, 202, 203.

SCRIVI TU!
RIASSUMERE
Per raccontare quello che hai letto è necessario capire bene il senso della storia.
Per questo è importante cogliere il punto centrale che l’autore intende comunicare. Lo puoi capire facendo attenzione al significato delle parole e delle espressioni, ma anche comprendendo le azioni dei protagonisti, i luoghi e i tempi in cui la vicenda si snoda.
Per riassumere un brano, cioè per dire in breve l’essenziale, ci sono diversi segnali che ti indicano la strada.
Il titolo: leggi attentamente il titolo del racconto, a volte il titolo del racconto esprime già il contenuto, oppure indica il protagonista.
L’evento: individua e sottolinea il momento di svolta della storia, cioè il punto in cui succede qualcosa che cambia la situazione e che quindi è assolutamente necessario dire.
Le sequenze: riconosci i momenti della storia, in una vicenda narrata ci sono delle tappe che ti permettono di seguire un percorso che ti conduce al finale.
A volte puoi riconoscerle perché arriva un personaggio nuovo, a volte perché cambiano il tempo o l’ambiente cui si svolgono i fatti.
Alcuni esercizi per imparare a riassumere si trovano alla fine di diverse letture.
Pagine: 39, 52, 93, 112, 132, 136, 142, 161, 170.
SCRIVI TU!
ESPLORARE LA SCRITTURA
Troverai altre proposte di scrittura su lessico, espressioni e svolgimento del testo.
Pagine: 23, 46, 62, 70, 86, 87, 92, 96, 103, 111, 172, 182.
ADESSO ALL’OPERA…
Per scrivere un testo occorre immaginare un dialogo particolare in cui tu dici e l’altro… legge!
Che cosa occorre in un testo?
1. Rivolgersi a qualcuno.
2. Avere un motivo: una domanda a cui rispondere, il desiderio di comunicare qualcosa di importante…
3. Osservare e riflettere, cercare idee, ordinare i pensieri per far capire e per dire la tua esperienza.
4. Trovare le parole migliori per esprimersi.
1. Può essere che si scriva all’insegnante, a un compagno, alla classe, a un parente, a un amico vicino o lontano, insomma si scrive per comunicare.
2. Di che cosa si scrive? Di tutto!
Può essere un’esperienza da raccontare, una descrizione da fare, un riassunto ma anche un pensiero, un commento, un’idea, una domanda che nasce da quello che incontri, una cosa che vuoi comunicare o trattenere.
Può aiutare l’attenzione che si pone a quello che capita e a quello che si legge; si diventa più consapevoli anche esprimendo oralmente le proprie osservazioni ed esperienze, mettendole in comune con i compagni e ascoltando le loro.
3. In seguito, si passa all’esposizione ordinata dei fatti o degli aspetti da descrivere. Ogni pensiero può essere scritto in una frase, chiusa da un punto fermo.
4. Si pone attenzione all’uso delle parole (nomi, aggettivi, avverbi) per dare sfumature e far capire la situazione o il proprio parere. Sono molto efficaci anche alcune espressioni, immagini o esempi che hai incontrato leggendo.
Per alcuni testi è bene fare una prima stesura, per poi revisionare con attenzione.
A testo concluso è d’obbligo la rilettura per controllare se effettivamente il messaggio è chiaro e comprensibile. Anche l’ortografia va controllata: punto e maiuscola, doppie, accenti,

, la ricopiatura in bella scrittura: in corsivo, curato e facilmente leggibile.

ORTOGRAFIA
ORTO + GRAFIA = CORRETTA SCRITTURA
PER SCRIVERE
CORRETTAMENTE
OCCORRE STARE
ATTENTO AI SEGNI.
E ANCHE AI SUONI!
RIPASSIAMO I SEGNI
I segni dell’alfabeto hanno un carattere stampato, che troviamo sui libri e con cui scriviamo con le tastiere, e un carattere corsivo che usiamo per scrivere a mano.
Ogni lettera dell’alfabeto ha una sua grafia che deve essere ben leggibile.
L'ALFABETO
STAMPATO CORSIVO
LA MAIUSCOLA
MAIUSCOLA Si usa per nomi propri, sacri e di cariche, nomi geografici e di popoli, a inizio della frase e nel discorso diretto.
RIPASSIAMO I SUONI
SUONI DOLCI-SUONI DURI
SUONI DOLCI CIA ciambella CE cerotto CIO cioccolato CI cinema CIU ciuffo
SUONI DURI CA casa CHE chela CHI chicco CO colomba CU cupola
SUONI DOLCI GIA giallo GE gelato GI giraffa GIO gioco GIU giullare
SUONI DURI GA gallo GHE gheriglio GHI ghiro GO gorilla GU guscio
Ricorda! per fare i plurali: se prima di C o G c’è una consonante:
CE pancia › pance
GE frangia › frange se prima di C o G c’è una vocale:
CIE camicia › camicie
GIE valigia › valigie
QUA, QUE, QUI, QUO-CU
QUA quaderno QUE questo, quello QUI quindi QUO obliquo CU + CONSONANTE culla, cura, custode, cuscino, cucina
Ricorda! alcune parole sono originali: cuore, cuoio, scuola, cuoco, cuocere, percuotere, scuotere, riscuotere, taccuino, circuito
QUI
Qui al sole si sta proprio bene!
CQU
QUI, CUI-CQU-QQ
CUI il ragazzo a cui ho prestato il libro non me lo ha più restituito.
acqua e parole derivate acquistare, acquisto, nacque, piacque, giacque
QQ soqquadro
SUONI DIFFICILI
GLI
maglione, conchiglia, biglia, aglio, foglia
GNA castagna GNE montagne
GNI cigni
LI ciliegia, oliera, petrolio, candeliere
GNO signore GNU ognuno
Ricorda! compagnia, disegniamo, accompagniamo, impegniamo, guadagniamo, consegniamo, vergogniamo
SCE ascensore, ruscello, discesa, mascella, scettro
Ricorda! scienza e coscienza e le parole che derivano da esse
MB bambola, tamburo MP pompiere, lampada
ZIA spaziale ZIE pazienza ZIO stazione
DOPPIE E DIVISIONE IN SILLABE
i gruppi gn, sc, ch, gh, gl non si dividono mai: gno-mo, bar-che
La s non si separa mai dalla consonante che la segue: de-sti-no
Le consonanti doppie (anche cq) si dividono sempre in due sillabe: sas-so, ac-qua
Le vocali che si pronunciano separatamente formano una sillaba e si separano: ma-e-stra, o-ce-a-no
Le consonanti l, m, n, r si separano dalla consonante che le segue: el-mo, len-to
ACCENTO E APOSTROFO
ACCENTO Nella lingua italiana l’accento si scrive solo quando cade sulla vocale finale: città, bontà, caffè
MONOSILLABI ACCENTATI
dà verbo ↔ da preposizione semplice
dì nome = giorno ↔ di preposizione semplice
è verbo ↔ e congiunzione
là avverbio ↔ la articolo
lì avverbio ↔ li pronome
né avverbio = e non ↔ ne pronome
sé pronome ↔ se congiunzione
sì avverbio ↔ si pronome
tè nome ↔ te pronome
APOSTROFO un albero, un’aquila (una), c’è, c’era
Ricorda! qual è si scrive senza apostrofo!
TRONCAMENTO un poco un poco un po’
Ricorda! fu tre re me ne so va sta fa sto mai accenterò!
Sul qui e sul qua l’accento non va!
a preposizione claudio va a casa sua. ha verbo Matteo ha gli occhi celesti. ah esclamazione Ah, che bella giornata!
ai preposizione articolata Stefano va ai giardini. hai verbo tu hai un cuore generoso. ahi esclamazione Ahi, mi hai fatto male!
anno nome
L’anno scorso sono stato in Francia. hanno verbo i bambini hanno cantato bene! o congiunzione partirò stasera o domani. ho verbo Oggi ho poco appetito. oh esclamazione Oh, finalmente sei tornato!
Ricorda! l’ho gliel’ho l’hai gliel’hai l’ha gliel’ha l’hanno gliel’hanno
I SEGNI E I SUONI
1. Metti in ordine alfabetico ogni serie di parole.
1. cassetta, tuono, grandinata, motorino, renna, ancora, servizio, barile, doccia, cesto, fune, uccello, elefante, ferita, dado, poltrona, gita.
2. duca, divino, daino, dritto, destra, dottore, destino, desiderio, desto, destare.
3. scrittura, scacchiera, scricchiolio, scremare, scrocchiare, scrigno, rincuorare, rinnovare, rinoceronte, rimpallo, rimbalzo.
2. Metti la lettera maiuscola dove occorre. l’italia si protende nel mediterraneo come una penisola a forma di stivale e comprende anche le isole di sicilia e sardegna. il territorio è per lo più occupato da colline e montagne. le vette innevate delle alpi attraversano l’italia settentrionale, mentre gli appennini si snodano come una spina dorsale lungo il centro della penisola. a nord si estende la pianura padana, attraversata dal po, il fiume più lungo del paese. le principali coltivazioni sono viti, limoni, peri, ulivi, aranci e grano.
A-Z. L’enciclopedia dei ragazzi, EdiBimbi
3. Domino di parole.
4. Riscrivi in corsivo.
5. Sottolinea le parole straniere: sushi, arrosto, brioche, software, brocca, okay, grazie, news, pavido, look.
6. Separa rispetto al suono. Mago, giostra, panca, dolce, canto, cerniera, chiodo, gente, guarito, cemento, ghermire, pace.
DOLCE
DURO
7. Volgi al plurale.
Focaccia farmacia mancia faccia freccia arancia bilancia grigia spiaggia frangia pioggia scheggia medico sporco mago stratega dialogo farmaco amico antico
8. Riscrivi le frasi al plurale, facendo attenzione ai suoni duri e dolci.
1. Nel paese vicino al lago c'è la farmacia.
2. La corteccia dell'albero protegge la pianta.
3. Nel cestino c'è una ciliegia
4. La camicia bianca è scucita nella manica.
5. La spiaggia è circondata da roccia.
9. Completa le parole con CU, QU o CQU. indici, stode, ffia, adrato, aderno, rare, Pas ale, a ila, a azzone, s adra, a istare, a ilone, a aragia, a leo, intale, gino, alità, scino, e ilibrio, in batrice, riscia are, s adra, esto, ello
10. Scrivi una frase per ogni parola “originale”: cuore, cuoio, scuola.
11. Completa le parole con GLI o LI.
bi etto, evito, venta o, petro era, Sici a, sbadi o, Ita a, sve a, sco o, mi one
12. Completa le parole con GN o NI.
so o, cer era, gera o, monta a, pru e, ma ere, se ale, spu a, inse ante, macedo a
13. Completa le parole con SCE o SCIE . ndere, a nsore, ntifico, stri , cono re, nze, na re, ru llo, nziato, co nza
14. Ricordi le parole che derivano da scienza e coscienza? Scrivile.
15. Trova almeno tre parole che inizino con i suoni nella tabella.. IMP IMB COMB COMP
16. Completa le parole, facendo attenzione alle doppie.
T o TT
bara olo, aspe are, au ista, reci azione, con a o, a enzione, scri o, pi ura
B o BB a assare, a ete, ra ia, a astanza, a ito, rom o, arra iarsi, a ellire
P o PP ca otto, ca ire, do io, te ore, tro o, tra ola, co erta, ri orto
R o RR bi a, acca ezzare, co azza, fe o, te ito io, ba iera, mu aglia, ma inaio
Z o ZZ acqua one, atten ione, pin a, pi a, ta a, a erare, cola ione, cora a
G o GG spia ia, gre e, inda ine, vora ine, man iare, oma io, fa iolo, assa iare
17. Riscrivi qui i nomi delle materie divisi in sillabe.
Aritmetica inglese
grammatica religione
italiano scienze
storia motoria
geografia tecnologia
musica geometria arte educazione civica
18. Riscrivi le parole, dividendole in sillabe. Sciarpa, località, frizzante, attaccare, goccia, spiaggia, freccia, compagno, agnello, radio, dieci, manica, sbadiglio, maglione, chiaro, rischiare, opera, acquerelli, maschera, castoro, ombrello, cambio, cantare, fantasia, edera.
19. Scrivi tre parole di:
una sillaba due sillabe tre sillabe quattro sillabe
20. Scrivi tu la domanda che corrisponde alla frase di risposta.
1. No, non ce n’è più.
2. Sono io.
3. Me ne importa molto, invece.
4. Con me c’è Dario.
5. L’ho visto sul tablet.
21. Completa le frasi con il monosillabo corretto.
Ci vediamo come al solito.
LA o LÀ
DA o DÀ
SI o SÌ
SE o SÉ
LI o LÌ
TE o TÈ
sera il sole tramonta molto tardi.
Per andare casa mia alla tua occorrono pochi minuti.
Mi fastidio il rumore del vento.
I bambini rincorrono nel cortile. , ho capito!
non mi ascolti, non potrai capire!
Ha portato con anche sua sorella.
ho aspettati a lungo, ma non sono arrivati.
Guarda , sta per cadere un masso.
Siediti, ho preparato una buona tazza di .
Quest’estate verrò con al lago.
22. Riscrivi le frasi sul quaderno inserendo l’apostrofo dove occorre.
1. Quello elefante si abbevera nella acqua dello enorme fiume.
2. Nella aiuola la edera è ricoperta di parassiti.
3. Lo scienziato versava la acqua distillata nella ampolla.
23. Volgi al femminile le seguenti espressioni.
1. Un atleta eccezionale
2. Un autista spericolato
3. Un insegnante paziente
4. Un amico simpatico
5. Un allievo volenteroso
6. Un astronauta famoso
24. Osserva e completa.
1. Perché non vuoi venire con ?
ME oppure M’È
2. Il numero del mago piaciuto molto.
3. ne porti una fetta per favore?
1. venuto in mente il titolo del film che hai visto?
TE oppure T’È
2. Non ti ricordi? ne ho parlato ieri.
3. scappata una risata contagiosa!
1. Il papà dimenticato il giornale in macchina.
SÉ oppure S’È
2. Chi fa da fa per tre!
3. Non più visto agli allentamenti!
1. Noi ne andremo dopo la partita.
CE oppure C’È
2. Mamma! l’anatra nello stagno del parco?
3. qualcosa che mi state nascondendo!
1. Non alcun motivo per preoccuparsi!
VE oppure V’È
2. Non vi preoccupate, lo rispiegherò domani.
3. l'avevo detto che era fragile!
1. Oggi non dobbiamo leggere studiare.
NÉ oppure N’È
2. Come mai Arianna se andata?
3. Ce rimasta o no per me?
25. Completa.
1. È tuo il libro? lo presti?
2. Tuo fratello corso incontro.
3. Lo ha stretto a .
4. Oggi non un filo d’aria.
5. Cosa ne pare?
6. Ce ancora di pane?
26. Completa le frasi con L’HA (possedere, agire, sentire) o con LA (articolo o pronome personale).
1. verifica era difficile.
2. Il cane ha rincorso palla, presa e riportata a casa.
3. Nicodemo ha portato in gita sua macchina fotografica e rotta.
4. Il nonno ha coltivato lattuga e raccolta quando è cresciuta.
5. Federico ha chiamato zia quando vista al supermercato.
27. In ogni frase inserisci GLIELO o GLIEL’HO, GLIELA o GLIEL’HA .
1. Non dire tu, ci penserò io ad informarlo.
2. Io detto più volte, ma lui non vuole ascoltarmi.
3. Questo è l’album di mio fratello, se prendo si arrabbia molto.
4. Quando direte, Davide sarà felice per la lieta notizia.
5. Vuole parlare col dottore? Un attimo che chiamo subito.
28. Leggi le frasi e correggi gli errori, se presenti.
1. Gliela chiese in prestito molto tempo fa e finalmente gliel’ha restituita.
2. Lucia parla proprio bene! Gliela insegnato la sua maestra.
3. Ma chi gliel’ha fatto fare di cambiare lavoro!
4. Questo gioco è di Luca, andiamo da lui e gliel’ho restituiamo.
5. Quando restituirai il libro al tuo compagno? Glielo darò domani!
29. Metti al posto dei puntini AI oppure HAI:
1. scritto la lettera nonni?
2. Torneremo in città primi di settembre.
3. Mi già raccontato questa storia.
4. mai giocato quattro cantoni?
5. promesso tuoi genitori di studiare di più; ma vedo che non intenzione di stare patti.
30. Metti al posto dei puntini A oppure HA :
1. La mamma preparato la torta per il mio compleanno.
2. Mio fratello mi accompagnerà scuola.
3. Michele una bicicletta nuova.
4. Francesco comprato il suo pallone Milano.
5. Sara dormito casa di Giulia.
31. Metti al posto dei puntini O oppure HO:
1. intenzione di partire domani dopodomani.
2. disegnato un cerchio rotondo come quello di Giotto.
3. Hai capito no?
4. Mandami l’uno l’altro; non preferenze.
5. Vi pregati di far silenzio.
32. Metti al posto dei puntini A oppure HA, ANNO oppure HANNO:
1. Quest’ la neve tardato venire.
2. Mia sorella non più la febbre.
3. Verremo trovarvi Natale.
4. È già passato un da quella sera.
5. Lo zio regalato suo nipote una scacchiera.
33. Completa con A/HA , O /HO, AI/HAI, ANNO/HANNO.
1. Ieri Luca è venuto casa mia giocare.
2. Lorenzo e Giorgio incontrato Cecilia giardini pubblici.
3. Io appena finito di leggere il quinto libro della biblioteca.
4. Non fare tardi, perderai il treno!
5. Quest’ frequento la quarta.
34. Scegli e completa con con A/HA/AH, O /HO/OH, AI/HAI/AHI.
1. , che male! Mi hai pestato il piede!
2. Tu svolto correttamente i compiti.
3. Non abbiamo chiesto nonni se vogliono venire a pranzo da noi.
4. Vuoi il latte il tè per colazione?
5. Torna subito casa!
I SEGNI DI PUNTEGGIATURA
QUANDO SI SCRIVE, I SEGNI
DI PUNTEGGIATURA AIUTANO
CHI LEGGE A CAPIRE
IL SENSO DELLA FRASE.
PUNTO
PUNTO E A CAPO
PUNTO INTERROGATIVO
Sempre alla fine della frase
Quando la frase è conclusa e cambia l’argomento
Quando devi porre una domanda
PUNTO ESCLAMATIVO
Quando la frase è un’esclamazione ,
VIRGOLA
Quando
• fai un elenco di parole
• fai un elenco di frasi
• devi separare i diversi sintagmi di tempo, luogo o modo
• prima della congiunzione ma
• per inserire un inciso ;
PUNTO E VIRGOLA
DUE PUNTI
Ricorda!
Mai la virgola tra soggetto e verbo.
Quando, nella frase, un pensiero è concluso, ma la frase continua con lo stesso argomento :
PARENTESI
Quando spieghi e per introdurre il discorso diretto
aprono e chiudono il discorso diretto si usano anche le lineette – –o le caporali « » ( )
Quando devi inserire qualche parola o frase che spieghi meglio
PUNTEGGIATURA
1. Sposta la virgola al posto giusto.
1. La pasta sta cuocendo nella pentola Mara, sistema i bicchieri sulla tavola.
2. Nell’aula gli scolari leggono la maestra, li ascolta.
3. Maria e Giulia corrono, a gambe levate Martina le guarda.
4. Mentre Paolo gioca la nonna, lavora a maglia.
2. Metti la virgola al posto giusto.
1. Nel cortile della scuola c’è molta confusione: alcuni scolari parlano altri si spingono altri ancora si rincorrono.
2. Verrei con te ma la mamma mi aspetta a casa.
3. Ieri mentre andavo a scuola sono scivolato.
4. Mentre Elvira chiacchierava con Luisa Angelo le scarabocchiava il quaderno.
3. Metti i due punti e le virgolette quando occorrono.
1. Clara disse alla mamma Comprami un quaderno a quadretti e una penna.
2. L’insegnante chiese Chi di voi non ha risolto il problema?
3. Posso guardare la televisione? chiese Federica.
4. La bambina chiese alla mamma Posso giocare in cortile?
4. Inserisci i segni di punteggiatura opportuni.
C’erano fattorie e case alberi e animali All’improvviso la pecora Fortunata si fermò davanti a lei bivaccava un’enorme mucca
Fortunata ne aveva già viste ma la novità era che quella mucca somigliava a lei bianca a macchie nere È una mucca spiegò la rana
A macchie commentò Fortunata
La mucca sentendosi al centro dell’attenzione e al centro della strada si alzò e muggì
5. Scrivi un bel pensiero sulla giornata di oggi utilizzando la punteggiatura che conosci.
NOMI
MORFO + LOGIA = FORMA della PAROLA
LE PAROLE HANNO TANTE FORME, CHE POSSIAMO RACCOGLIERE IN GRUPPI O PARTI.
ARTICOLI
Le parole che usiamo hanno diverse funzioni: dicono, nominano, aggiungono, legano…
VERBI
A seconda della funzione che hanno le parole vengono suddivise in classi: queste classi sono dette PARTI DEL DISCORSO.
Alcune classi di parole si combinano fra loro prendendo diverse FORME. Sono le parti variabili del discorso.

ARTICOLI
AGGETTIVI
NOMI PRONOMI CONGIUNZIONI AVVERBI
VERBI
PARTI VARIABILI
ARTICOLO determinativo il, la, lo, l’, i, gli, le
NOME primitivo casa derivato cartolaio alterato stradina collettivo gregge composto capotreno
AGGETTIVO qualificativo buono, immenso possessivo mio indefinito alcuni dimostrativo questi numerale tre interrogativo che? quale? quanto? esclamativo che! quale! quanto!
numero variano indeterminativo un, un’, uno, una dei, degli, delle
PRONOME personale io, tu, noi, mi, ti, ci possessivo mio indefinito alcuni dimostrativo questi numerale tre interrogativo chi? che cosa? quale? quanto? esclamativo chi! che cosa! quale! quanto!
VERBO coniugazione propria essere, avere Modo, tempo, persona 1a , 2a , 3a coniugazione andare, vedere, sentire
PARTI INVARIABILI
PREPOSIZIONI semplici di, a, da, in, con…
CONGIUNZIONI e, o, ma, perciò, infatti, quindi…
AVVERBI volentieri, sempre, vicino, troppo, certamente, forse…
ESCLAMAZIONI ah, eh, oh, uffa, boh…
Non variano
LE PARTI VARIABILI
L’ARTICOLO
I corvi passano sotto il cielo azzurro e terso. All’improvviso quello che sta alla testa rallenta e traccia un grande cerchio. Gli altri girano dietro a lui. Sembra che danzino in tondo per ingannare la noia della strada, e che facciano moine con le ali tese come le pieghe di una gonna.
J. Renard
Le parole sottolineate sono articoli. Gli articoli sono le piccole parole (articolo = piccolo arto) che precedono il nome.
Determinativi
Indeterminativi
Ricorda!
DEI, DEGLI e DELLE possono essere usati come articoli indeterminativi plurali: un aquilone degli aquiloni
L’ARTICOLO
1. Sottolinea in verde gli articoli determinativi e in giallo quelli indeterminativi. Voleva rubare un pappagallo in un negozio di animali, ma il pappagallo ha reagito con una violenta mossa e ha usato le ali e il becco per difendersi. La reazione del pappagallo ha bloccato il ladro, la negoziante e i clienti sono intervenuti prontamente.
2. Volgi al plurale.
lo sportivo la biologa il paleontologo l'esploratrice un bibliotecario una geologa un archeologo un'esperta uno storico una scienziata
3. Metti l’articolo indeterminativo opportuno. chiesa, adulto, edificio, opera, strappo, aereo, scatola, altalena, zoccolo, scivolo, impronta.
4. Aggiungi l’apostrofo quando è necessario.
• Un albero, un asino, un aquila, un oca, un biscotto, un arancia, • un atleta agilissimo, un interessante impegno, un inutile discussione.
5. Volgi al femminile. il maestro un astronauta il banchiere lo scrittore un architetto un cantante un idraulico un attore uno studente un artista
IL NOME
Aprendo la finestra , Giovanni vide che era piovuto un poco durante la notte : il terrazzino aveva le mattonelle bagnate e le foglie dei platani e l’erba del giardino erano umide. Ora non pioveva più, ma il tempo radioso dei tempi precedenti si era mutato in un tempo lattiginoso, col cielo semicoperto se non proprio nuvoloso, attraverso cui la luce del sole riusciva a filtrare debolmente.
Le parole sottolineate sono nomi. Il nome identifica e distingue ogni cosa.
I NOMI COMUNI E I NOMI PROPRI
I nomi si suddividono in comuni e propri; i nomi propri si scrivono con la lettera iniziale maiuscola. Sono nomi propri anche:
• i nomi geografici (Milano, Po, Tevere, Italia…)
• i nomi di popoli (Romani, Fenici, Sumeri, Italiani…)
Ricorda!
Quando questi ultimi sono aggettivi si scrivono con la minuscola!
Gli Egizi (nome proprio) adoravano molti dei. Gli dei egizi (aggettivo) erano numerosi.
IL GENERE DEI NOMI
UNA RANA DUE RANE.
Il genere dei nomi può essere maschile o femminile
• Solo i nomi di persona o di animale hanno il maschile o il femminile: nonno nonna, gatto gatta
• Solitamente si cambia il genere del nome cambiando la sua ultima lettera (= desinenza): nonno nonna
• A volte il femminile si ottiene mettendo il finale -essa o –trice: dottore dottoressa, pittore pittrice
• Molti nomi hanno una sola forma sia per il genere maschile sia per il femminile (è necessario guardare l’articolo): il cantante la cantante, il barista la barista
• Alcuni nomi hanno il femminile del tutto diverso dal maschile: fratello sorella, bue mucca
• Molti nomi, cambiando il genere, cambiano il significato: il collo la colla, il mostro la mostra
IL NUMERO DEI NOMI
Il numero dei nomi può essere singolare o plurale
• Per molti nomi è facile fare il plurale, basta cambiare l’ultima lettera: finestra finestre; nuvola nuvole.
• Alcuni nomi maschili al plurale diventano femminili: uovo uova; paio paia.
• Alcuni nomi hanno il plurale uguale al singolare (è necessario guardare l’articolo): la città le città; l’auto le auto.
• Alcuni nomi mancano del singolare o del plurale: occhiali, pantaloni, forbici mancano del singolare fame, sete, latte mancano del plurale.
• Alcuni nomi al plurale hanno due significati diversi: ciglio i cigli = margini, le ciglia = quelle degli occhi.
I NOMI COLLETTIVI
UN
UCCELLO UNO STORMO
È arrivato il gregge . Un mese fa era in pianura, ora è diretto ai monti. Un gruppo di bambini lo osserva curiosamente, mentre su tutto il branco vigila il cane del pastore. La famiglia del pastore porta con sé un po’ di ricotta al paese vicino, per raggranellare il piccolo gruzzolo necessario alle spese giornaliere.
I nomi gregge, gruppo, branco, famiglia, gruzzolo… si chiamano nomi collettivi, perché, pur essendo al singolare, indicano un insieme di persone, di animali, di cose.
I NOMI PRIMITIVI, DERIVATI E ALTERATI
La piazzetta del paese era quasi deserta, solo un gruppo di ragazzini giocava sotto i portici , vicino ai tavolini del bar. I negozianti sistemavano le ultime cose in attesa dei rintocchi che indicavano il vespero . Al suono della campana il giornalaio chiuse la sua botteguccia , salutò il barista e si diresse verso casa .
Osserva i nomi paese, gruppo, bar, cose, vespero, suono, campana, casa: sono nomi primitivi.
Sono nomi primitivi i nomi formati dalla radice e dalla desinenza.
NOMI PRIMITIVI
Portici, negozianti, attesa, rintocchi, giornalaio, barista sono nomi derivati da altri nomi o verbi: portici (porta), negoziante (negozio), attesa (attendere), rintocchi (tocco), giornalaio (giornale), barista (bar).
Sono nomi derivati quei nomi che si sono formati dalla radice di altri nomi o verbi aggiungendo all’inizio o alla fine dei suffissi. Le parti che si aggiungono alla radice modificano il significato di partenza. Ad esempio dal nome “giorno” derivano “giorn-ale” e “giorn-al-aio”. Dal verbo “tornare” deriva “ri-torno”.

Piazzetta, ragazzini, tavolini, botteguccia sono nomi alterati.
Sono nomi alterati quei nomi che indicano lo stesso significato ma sottendono degli aggettivi (grande, piccolo, bello, brutto).
Ci sono quattro forme di alterazione:
ACCRESCITIVO nome + aggettivo grande librone
DIMINUTIVO nome + aggettivo piccolo libriccino
VEZZEGGIATIVO nome + aggettivo bello libretto
DISPREGIATIVO nome + aggettivo brutto libraccio
Ricorda! ci sono dei falsi alterati: il mulino non è un piccolo mulo
I NOMI COMPOSTI
inserire disegno
Alla stazione, nell’andirivieni dei sottopassaggi e dei marciapiedi , le macchine gialle dei portabagagli si agitano senza posa.
Il capostazione , col suo fischietto, dirige i convogli sulla ferrovia .
I nomi sottolineati sono formati da due parole unite, si dicono nomi composti.
Sottopassaggio = sotto (avverbio) + passaggio (nome)
Marciapiedi = marcia (verbo) + piedi (nome)
IL GENERE E IL NUMERO DEI NOMI
1. Sottolinea gli articoli in blu e i nomi in rosso.
Nel cortile della scuola
Un merlo scende a terra dall’albero, becca svelto svelto il terreno, alza la testa, vede i bambini, vola via oltre il muretto. Un gatto bianco e nero cammina sul muretto, si ferma, fiuta in giro e riprende la sua passeggiata. Il custode Annibale spazza il cortile, raccatta cartacce e foglie e le butta in un grande sacco nero, scuote la testa e brontola: «Ah, questi bambini! Quando impareranno a buttare le carte nei cestini?».
2. Sottolinea i nomi.
Tavolo, cucinare, popolo, giardino, ditale, pronto, simpatico, topolino, anatroccolo, lavandini, latte, mungere, tessere, telaio, bosco, tagliare, sbadatamente, diario, unghie, orologio, zoccolo, gnocco, cacciare, ridi.
3. Volgi al femminile i nomi delle seguenti frasi, dove possibile.
1. Il nonno legge una fiaba ai suoi nipotini mentre il gatto fa le fusa.
2. Il maestro interroga lo studente preparato.
3. Il famoso cantante si esibisce sul palcoscenico.
4. I bambini maschi con la maglia blu vadano nella squadra B.
5. Luca si è fatto male al piede facendo una rovesciata in campo.
4. Sottolinea i nomi, trascrivili e scrivi il genere e il numero. Nell’aria tersa e sottile delle grandi altezze Musco guardò per un istante il sole e gli parve luminoso e splendente come non mai. Il profumo di rugiada mattutina arrivava fino ai rifugi. Sui pendii la neve era quasi scomparsa del tutto, resisteva nelle cime più a nord e sui canaloni battuti dal vento della notte. Per la bellezza del mattino, per la terra che luccicava in quel grande silenzio, per quelle montagne nitide e azzurre che chiudevano l’orizzonte, per quelle foreste verdeggianti che salivano piano, Musco si sentì veramente felice come non gli accadeva da tanto tempo. Dimenticò la sua abituale diffidenza e corse per il pendio dove Petunia stava assaporando i primi teneri germogli.
5. Volgi nell’altro genere i nomi di persona sottolineati.
1. Il nipote di Francesco ha quattro anni.
2. La violinista studia al conservatorio.
3. Federico è mio parente.
4. Il cantante ebbe molti applausi.
6. Scrivi sul quaderno le frasi, trasformando le parole sottolineate al femminile.
1. Ho visto un uomo altissimo.
2. Paolo è uno studente
3. Aiuta tuo padre.
4. Gioco con mio fratello.
5. Mio padre è il genero di mio nonno
6. Pranzava con il marito.
7. Mi hanno presentato l’autore.
7. Componi una frase per ognuno di questi nomi.
• foglia:
• foglio:
• casa:
• caso:
• manica:
• manico:
• pesca:
• pesco:
8. Completa.
un bosco antico tanti
un mago simpatico quattro
lo stecco secco alcuni
l’arco artistico gli
il i medici scolastici lo gli sporchi trucchi
un i funghi bianchi
un tanti lunghi portici
9. Completa.
una giacca larga alcune
una lunga barca tre
un’amica ricca diverse
un’orca bianca tante
una due lunghe stringhe
una delle vasche etrusche la le pesche fresche
l’ le epoche storiche
I NOMI COLLETTIVI
1. Spiega il significato dei seguenti nomi collettivi:
folla insieme di persone
biancheria insieme di ,
clientela insieme di ,
mobilia insieme di ,
esercito insieme di ,
scolaresca insieme di ,
sciame insieme di ,
fogliame insieme di , fauna insieme di , flora insieme di ,
gregge insieme di , gente insieme di .
2. Come si chiama un gruppo di…?
pecore
uccelli
insetti
navi
libri
3. È un gruppo di…
risma
coro
mandria
pineta
battaglione
quadri
giocatori
persone
scolari
querce
gente
argenteria
equipaggio
costellazione
oliveto
I NOMI PRIMITIVI, DERIVATI, ALTERATI
1. Ecco una serie di nomi derivati, scrivi il nome primitivo:
giornalista muratore
fornaio vetraio
panettiere scolaro
libreria pastificio
canile salumificio
2. Tra i seguenti nomi, distingui i derivati (di ognuno scrivi anche il nome primitivo) e gli alterati (di ognuno aggiungi l’aggettivo sottinteso):
NOMI DERIVATI ALTERATI PRIMITIVO o AGGETTIVO
pesciolino ⬜ ⬜ piccolo
storico ⬜ ⬜ storia
cavalluccio ⬜ ⬜
orologiaio ⬜ ⬜
panino ⬜ ⬜
barcaiolo ⬜ ⬜
barcaccia ⬜ ⬜
barchetta ⬜ ⬜
libretto ⬜ ⬜
autista ⬜ ⬜
legnaia ⬜ ⬜
legnetto ⬜ ⬜
ortolano ⬜ ⬜
scarpetta ⬜ ⬜ X X
3. Da quale nome derivano i seguenti nomi?
muraglia fumata
pescatore calciatore
ghiacciolo scarpiera
braccialetto collare
guanciale cartolina
maniglia fruttiera
lattiera salumeria
lanificio frutteto
4. Completa con il nome derivato.
piccolo pensiero pensierino
grande serata brutto posto
buona zuppa piccola palla bel fiocco
5. Colora i “falsi alterati”.
bambino bambinetto ragazzina nonnina
padrone lettone patatina setaccio
mattone burrone pedone scarpetta
cugino mattino macchinina mulino
macchiolina tapparella tacchino girino
6. Di ogni nome alterato aggiungi l’aggettivo sottointeso.
paperella , omone , manaccia , gattaccio , venticello , gattone
grembiulino ,
I NOMI COMPOSTI
1. Scrivi alcuni nomi composti. -strada palla- cavol-cane bagno-




2. Collega i nomi per formare i nomi composti.
cassa apri lava sempre aspira
spazza apri spremi
verde
camino
bottiglie
stoviglie
agrumi
scatole forte polvere
3. Classifica i seguenti nomi mettendo una crocetta secondo le loro caratteristiche.
capostazione ruscelletti sincerità musicista stormo Antonio libri
libreria librone sciame spremiagrumi cacciatore
balletto orso cagnolino orto ortolano scolaresche omacci collinetta orticultura maggiolino fuggifuggi schiaccianoci
L’AGGETTIVO
Il nonno è un vecchietto magro e arzillo . Il viso, scarno e allungato , è valorizzato da bianchi e morbidi baffi. Indossa occhiali rotondi e vistosi per l’età. Non ha molti capelli, cioè è quasi calvo , e la sua fronte è solcata da rughe profonde . Con il suo panciotto grigio da casa, se ne sta seduto in poltrona con le mani incrociate e telefona beatamente ai nipoti. Su quella grande e comoda poltrona il nonno schiaccia spesso un pisolino.
Le parole sottolineate sono aggettivi.
L’aggettivo arricchisce il nome: è una parola che si aggiunge al nome per attribuirgli una caratteristica.
L’aggettivo concorda sempre col nome a cui è riferito: ha cioè lo stesso genere e numero.
Articolo, nome e aggettivo concordano e si possono analizzare insieme.
L’AGGETTIVO QUALIFICATIVO
Più il tempo passava, più mi facevo bello . Avevo un piede bianco e una graziosa stella sulla fronte, bianca anche quella. Ero considerato uno splendido animale.
Anna Sewell, Black Beauty
Si dice aggettivo qualificativo la parola aggiunta a un nome per determinarne la qualità (forma, colore, natura, condizione…).
FIORI PROFUMATI
TORTA GRANDE E DELIZIOSA
IL GRADO COMPARATIVO
La qualità di molti aggettivi qualificativi ha diversi gradi e si possono confrontare.
• Marco è alto.
• Marco è meno alto di Stefano.
• Marco è più alto di Paolo.
• Marco è alto come Angelo.
Nella prima frase “alto” è usato normalmente, senza fare confronti, cioè al grado positivo.
Nelle altre frasi, invece, l’aggettivo qualificativo “alto” è messo a confronto fra persone (si possono confrontare anche animali e cose). Si formano così i gradi comparativi (comparare = confrontare).
Comparativo di minoranza › meno di…
Comparativo di maggioranza › più di…
Comparativo di uguaglianza › come…
IL GRADO SUPERLATIVO RELATIVO E ASSOLUTO
• «Il libro “L’incredibile storia di Lavinia” è bellissimo» dice Jacopo.
• «Il libro “Cion Cion Blu” è il più bello tra i libri che ho letto» dice Giovanna.
Bellissimo è detto superlativo assoluto perché esprime la qualità del libro al grado massimo, senza confronto con altri libri; Il più bello è detto superlativo relativo perché il libro Cion Cion Blu è messo in relazione (confrontato) con gli altri libri letti da Giovanna.
Il superlativo assoluto si può formare anche con i prefissi ultra-, arci-, stra-…; con le parole molto e assai; oppure ripetendo due volte l’aggettivo.
PAOLO SONO PIÙ
ALTO DI TE.
MARCO SEI ALTISSIMO!
Ricorda! alcuni aggettivi, insieme a quelle regolari, possiedono forme irregolari di comparativi di maggioranza e superlativi assoluti. Si tratta di forme derivate dal latino.
buono più buono buono migliore buonissimo ottimo cattivo più cattivo cattivo peggiore cattivissimo pessimo grande più grande grande maggiore grandissimo massimo piccolo più piccolo piccolo minore piccolissimo minimo
L’AGGETTIVO
1. Segui l’esempio dell’autore di questo brano e descrivi brevemente la tua stanza o un’altra della tua casa, usando opportunamente gli aggettivi e i nomi (alterati, derivati, collettivi…).
«Vedi, Lottie, questa soffitta è così piccola e allo stesso tempo così in alto che sembra quasi un nido su un albero. Il soffitto inclinato è divertente.
Vicino alla parete non si riesce neanche a stare in piedi. Quando al mattino comincia ad albeggiare io, sdraiata sul letto, mi godo la vista del cielo attraverso la finestra sul soffitto. Sembra una toppa quadrata di luce. Se c’è il sole osservo le nuvole rosa muoversi pigre nel cielo e mi sembra quasi di poterle toccare; se piove, le gocce picchiettano sui vetri come se stessero raccontando qualcosa di divertente. Di notte, infine, quando ci sono le stelle, ci si può sdraiare e cercare di contare quante se ne vedono in quel pezzo di cielo. Ce ne stanno tante, sai? Guarda la piccola griglia del camino: è corrosa dalla ruggine, ma se venisse lucidata, e nel camino ardesse il fuoco, sarebbe bellissima. Insomma, non trovi anche tu che questa stanzetta sia proprio graziosa?»
F.H. Burnett, La piccola principessa
2. Sottolinea con colori diversi nomi e aggettivi.
1. Fabio gioca con un pallone nuovo.
2. L’astuccio è pieno di diverse matite colorate.
3. La bambina bionda si pettina i lunghi capelli biondi.
4. Il cavallo bianco e nero corre veloce nel prato.
5. Le mele verdi che abbiamo raccolto sono aspre, ma buone.
3. Individua gli aggettivi qualificativi, collegali al nome cui si riferiscono e analizzali sul tuo quaderno. Il negozio più bello della mia città si trova in via Cavour. Già a guardare la vetrina, ultrascintillante di luci e colori, rimani senza fiato. È un negozio di giocattoli, i giocattoli più straordinari che ci siano! Il reparto più affascinante è quello dei giocattoli antichi: ci sono le bambole di porcellana che hanno abiti ricchissimi e i capelli morbidi morbidi. Poi ci sono le macchinine di latta e i cavalli a dondolo di legno lucidissimo.
4. Analizza gli aggettivi qualificativi evidenziati indicando il grado comparativo.
MINORANZA MAGGIORANZA UGUAGLIANZA
Achille fu l’eroe più valoroso fra tutti i Greci ⬜ ⬜ ⬜
La Sicilia è la regione più estesa d’Italia . ⬜ ⬜ ⬜
Francesco è il più veloce della classe. ⬜ ⬜ ⬜
Il libro Cion Cion Blu è il più bello tra i libri che abbiamo letto. ⬜ ⬜ ⬜
Le cronache di Narnia è un libro bellissimo. ⬜ ⬜ ⬜
Ulisse è un re astutissimo ⬜ ⬜ ⬜
Polifemo è un ciclope molto empio. ⬜ ⬜ ⬜
Il ragno palombaro è piccolo piccolo ⬜ ⬜ ⬜
La giornata di ieri è stata stradivertente! ⬜ ⬜ ⬜
5. Sottolinea l’aggettivo qualificativo usato nei suoi vari gradi.
1. Questo tratto è il più faticoso di tutto il percorso.
2. La gita al parco avventura è stata divertentissima.
3. L’argento è meno prezioso dell’oro.
4. La gazzella è veloce come il vento.
5. Linda è la più giovane di tutti voi.
6. Il sapore di un panino è più buono di quello delle merendine.
7. Il più caro di tutti i miei amici sei tu, Marco.
8. Questa crostata è più friabile di quella.
9. Giulia è la più vivace di tutta la classe.
10. Sei golosa come tuo fratello.
6. Sottolinea gli aggettivi e collegali con una freccia al nome che accompagnano.
1. Le foglie gialle coprivano il vialetto che conduceva alla solitaria cascina.
2. Quante fragole hai raccolto questo pomeriggio?
3. Maria è nata il primo marzo.
4. Queste scarpe che indosso sono comodissime.
5. Quella torta alla crema è quasi finita, assaggerò questa al cioccolato.
6. Ho scordato a casa il mio grembiule.
7. Ognuno di noi ha scelto l’argomento da studiare per la propria interrogazione finale.
8. Tra qualche mese partirò con i miei amici per un’incantevole isola greca
7. Trova gli aggettivi, poi scrivili sul quaderno e indicane il tipo.
1. Luca e Pietro guardano il vostro divertentissimo video di carnevale.
2. Giacomo, Paolo e Simone sono tre bambini della nostra classe.
3. Il primo libro che leggeremo sarà di Lewis.
4. Quale film preferisci?
5. Questa penna blu è di Matilde.
6. Alcuni bambini hanno avuto la febbre alta.
7. Francesco è stato il secondo bambino ad arrivare in classe.
8. Quelle piante sono cresciute in fretta.
9. Qual è il tuo diario?
8. Sottolinea gli aggettivi poi indica con una freccia il nome che accompagnano.
1. Mia mamma ha comprato due quaderni blu.
2. Questo triangolo è scaleno e ha tre lati diversi.
3. La nostra classe è la sesta aula del corridoio.
4. Gaia è stata la prima bambina a tagliare il traguardo.
5. Caterina ha due sorelle che frequentano la seconda media.
6. Durante l’intervallo mattutino ho segnato un goal spettacolare!
7. Con i miei amici parteciperò al nuovo laboratorio espressivo.
8. Alle verdi pareti della classe abbiamo appeso i nostri colorati e utili cartelloni.
IL PRONOME
Un astronomo aveva l’abitudine di uscire tutte le sere in aperta campagna per studiare gli astri. Una notte, mentre passeggiava con gli occhi rivolti alle stelle e le guardava assorto, cadde inavvertitamente in una buca. Mentre egli si lamentava e gridava, un passante lo udì e gli si avvicinò. Quando lo vide, gli chiese che cosa fosse successo, poi, scuotendo la testa, gli disse: “Caro mio, forse tu sai scrutare gli astri e le costellazioni che stanno nel Cielo, però non sai guardare neppure dove posi i piedi qui sulla Terra!”.
Le parole sottolineate sono pronomi
Il pronome si usa al posto del nome e serve a sostituirlo.
I pronomi personali servono per sostituire un nome indicante una persona, ma anche un animale o un oggetto, al fine di evitare le ripetizioni. In una frase possono avere la funzione di soggetto o di complemento.
Soggetto
Complemento io me mi (a me) tu te ti (a te)
egli - esso
ella - essa
lui - lo gli (a lui)
lei - la le (a lei)
noi noi ci (a noi)
voi voi vi (a voi)
essi
esse loro - li loro le
Ricorda!
Lui e lei come soggetto sono usati con valore rafforzativo (es. È stato lui!), lo stesso vale per loro (es. Hanno vinto loro!).
Lo – la – gli – le sono pronomi quando sostituiscono un nome; sono articoli determinativi quando precedono un nome.
Gli = a lui; le = a lei; loro = ad essi.
Ricorda!
Vado da Roberto e gli parlo (parlo a lui).
Vado da Stefania e le parlo (parlo a lei).
Vado da Roberta e Stefania e parlo loro (parlo a loro).
GLI AGGETTIVI E I PRONOMI POSSESSIVI
Il ragazzo s’incamminò con il suo passo deciso lungo il sentiero che saliva in collina. Il bosco era umido e ombroso. Gli alberi piegavano leggermente i loro lunghi rami al soffio leggero del vento, mentre le loro foglie gialle si staccavano una dopo l’altra, dolcemente, e si depositavano a terra formando un tappeto giallo e rossiccio. L’autunno avanzava giorno dopo giorno, con il suo cielo carico di umidità, le sue piogge frequenti e i suoi nuovi colori.
Le parole sottolineate sono aggettivi possessivi
I possessivi, proprio come dice il loro nome, indicano un possesso, cioè dicono a chi appartiene una certa cosa, persona o animale.
mio mia miei mie tuo tua tuoi tue suo sua suoi sue
nostro nostra nostri nostre vostro vostra vostri vostre loro proprio propria propri proprie altrui
Osserva le seguenti frasi:
• Il mio cappello è blu, il TUO è rosso.
• La vostra insegnante è più giovane della NOSTRA
• Il suo quaderno è ordinato, il VOSTRO no.
Le parole sottolineate indicano sempre un possesso, ma quelle in minuscolo sono aggettivi (c’è il nome di fianco) mentre quelle in maiuscolo sono pronomi possessivi. Essi si dicono pronomi perché stanno al posto del nome. Dunque, distinguere l’aggettivo dal pronome non è difficile: l’aggettivo è sempre riferito ad un nome, il pronome, invece, lo sostituisce (pronome = al posto del nome).
Il mio cappello è blu, il tuo è rosso › mio = aggettivo, tuo = pronome
GLI AGGETTIVI E I PRONOMI DIMOSTRATIVI
QUESTO LIBRO È IL MIO PREFERITO FRA QUELLI
CHE STO LEGGENDO.
L’aggettivo e il pronome dimostrativi sono le parole che, nella frase, hanno la funzione di mostrare, indicare, ciò di cui si parla.
I più usati, nei vari generi e numeri, sono questo e quello
Alcuni dimostrativi sono soltanto pronomi:
• costui, costei, costoro, colui, colei, coloro, ciò;
• questi e quegli (maschile singolare).
GLI AGGETTIVI E I PRONOMI INDEFINITI
L’aggettivo e il pronome indefiniti esprimono la quantità di persone, animali o cose senza numerarla.
Gli indefiniti più usati, nei vari generi e numeri, sono:
• alcuno, molto, poco, parecchio, tutto, tanto, nessuno, altro, ogni, ognuno, ciascuno
GLI AGGETTIVI E I PRONOMI NUMERALI
Le parole uno, due, tre… si dicono aggettivi (o pronomi) numerali cardinali poiché indicano una quantità numerica precisa e costituiscono i “cardini” (= le basi) della nostra numerazione.
Le parole primo, secondo, terzo… si dicono aggettivi (o pronomi) numerali ordinali in quanto indicano il posto d’ordine occupato in una serie.
Ricorda!
Decina, paio, cinquina… indicano una quantità, ma sono nomi. Migliaio si scrive con “GL” ; milione e miliardo si scrivono con la sola “L”.
Tre si scrive senza accento, ma i numeri che finiscono con il tre vogliono l’accento (trentatré).
GLI AGGETTIVI E I PRONOMI INTERROGATIVI ED ESCLAMATIVI
Con quale treno parte Luigi?
Che squadra tifa Tommaso?
Quali mammiferi conosci?
Quale gusto vuoi?
Quanti bei fiori hai nel tuo giardino!
Che bella sorpresa mi hai fatto!
Che, quanto, quale si definiscono aggettivi interrogativi o esclamativi quando precedono un nome nelle forme interrogative o esclamative. Naturalmente, interrogativi ed esclamativi assumono la funzione di pronome se, invece di accompagnarsi ad un nome, lo sostituiscono.
Che bella biblioteca!
Dei libri in questo scaffale, quali hai letto?
CHE BELLA BIBLIOTECA!
I PRONOMI E GLI AGGETTIVI
1. Sottolinea i pronomi personali e scrivi a cosa corrispondono.
Mi hai fatto davvero un favore! a me
1. Le portai un ricordo da Londra.
2. Guardami negli occhi: chi ride per primo ha perso.
3. Li ho portati al parco perché si divertono sempre molto.
4. Diego viene alla festa, lo accompagna Roberto.
5. Ci piace molto andare a cavallo.
6. Scrivigli una lettera e spediscila!
7. La maestra vi ha chiesto di distribuire le schede.
8. Lucia ha distribuito i biglietti della lotteria, io ne ho preso solo uno.
2. Qual è il pronome personale corretto tra quelli indicati?
1. (Tu-Te) sei un bambino simpatico.
2. Ho visto Sara e (gli-le) ho chiesto di giocare con me.
3. Ho parlato con Stefano e (gli-le) ho chiesto se vuole giocare con noi.
4. Non sei (tu-te) la prima della fila?
5. Ho incontrato Francesco e ho fatto una bella passeggiata con (gli-lui).
3. Le frasi seguenti sono piene di ripetizioni. Riscrivile sul tuo quaderno sostituendo ai nomi ripetuti i pronomi personali giusti.
Il maestro Gabriele è un violinista. Gabriele oggi ha tenuto un concerto. Il maestro Gabriele è un violinista. Egli oggi ha tenuto un concerto.
1. Ho incontrato la tua mamma e ho parlato alla tua mamma di te.
2. Io lavo la bambola e pettino la bambola .
3. Ho comprato una pista e ho montato la pista .
4. Riccardo ha portato a scuola un libro sugli animali; Riccardo ci ha detto che è molto interessante.
5. La mamma è tornata a casa e io ho raccontato alla mamma le cose belle imparate a scuola.
6. Mi piacciono molto le fragole; io mangio spesso le fragole con la panna.
4. Completa le frasi usando i pronomi personali
1. piace il gelato alla frutta.
2. Ho telefonato alla zia e ho detto di venirci a trovare al mare.
3. Ho incontrato gli amici di Rebecca e ho detto che le stiamo organizzando una festa a sorpresa.
4. Anche a piace andare a lezione di pianoforte?
5. Anche dovete venire con noi al corso di inglese.
5. Sottolinea in verde gli aggettivi possessivi e in blu i pronomi possessivi. Collega sempre gli aggettivi al nome cui si riferiscono.
1. Voi disponetevi nella vostra metà del campo e noi nella nostra.
2. Ognuno prenda il proprio zaino.
3. Vuoi i miei pattini? Oppure usi i tuoi?
4. Il tuo giaccone è identico al mio.
5. La loro casa è più ampia della nostra.
6. Sottolinea gli aggettivi possessivi e i pronomi possessivi.
1. Le nostre biciclette sono molto simili: spesso confondo la mia con la tua.
2. Prima di criticare i difetti altrui, bisogna considerare i propri.
3. Ti consideriamo uno dei nostri!
4. I loro interessi coincidono con i miei.
5. Desidero avere tue notizie e sapere come va la tua scuola.
6. La mia sorellina è più vivace della loro.
7. Trascorreremo le vacanze dai nostri amici al mare.
7. Costruisci cinque frasi con gli aggettivi possessivi pensando alla tua classe.
8. Completa le frasi, aggiungendo l’aggettivo possessivo adatto.
1. «Chiara, qual è il libro preferito?» «Il è Piccole donne»
2. Il lavoro di scienze è il migliore della classe, abbiamo lavorato bene!
3. Lo scoiattolo ha nascosto le noci nella tana.
4. Luca e Diletta, i biscotti sono pronti!
5. Le voci sembrano una sola quando cantano in coro.
9. Sottolinea gli aggettivi dimostrativi
Riordiniamo quest’aula di arte. Io raccolgo questi album, tu puoi sistemare quei disegni? Quelle matite vanno rimesse con le penne, queste tempere vanno insieme a quei pennelli. Bene, direi che questo lavoro è finito!
10. Inserisci l’aggettivo dimostrativo in modo opportuno.
1. sera ceneremo al ristorante.
2. Sono passati anni, ma non dimenticherò mai viaggio in aereo.
3. Con aria gelida ci prenderemo un malanno.
4. Ho trovato facile esercizio
5. rimprovero mi fece capire che avevo sbagliato.
6. volta, hai ragione!
11. Sottolinea in verde gli aggettivi indefiniti e in arancione i pronomi indefiniti. Collega sempre gli aggettivi al nome cui si riferiscono.
1. Qualcuno deve raccontarmi della gita!
2. Tutti sanno che la nostra Nazionale ha la maglia azzurra.
3. Alcuni ragazzi sono arrivati tardi a scuola.
4. Tutti i bambini di quarta parteciperanno alla festa di fine anno.
5. Parecchi di loro canteranno nel coro.
6. Nessuno mancherà.
7. In teatro c’è poco spazio, ma ognuno avrà una sedia.
8. Abbiamo imparato tanti canti nuovi.
12. Leggi con attenzione le seguenti frasi, poi sottolinea in rosso gli aggettivi indefiniti e in blu i pronomi indefiniti.
1. In cortile alcuni ragazzi giocano a calcio, altri a pallacanestro.
2. Ogni volta che vado al mare, incontro qualche vecchio amico.
3. Qualcuno ha bussato?
4. Gli agrumi non sono tutti uguali: alcuni sono più aspri di altri.
5. Ciascuno metta a posto i propri giocattoli!
6. Il papà ha comperato le pere, ma solo alcune erano mature.
7. Non mi ha detto nulla della sua giornata a scuola.
13. Completa con aggettivi o pronomi indefiniti adatti. Indica se si tratta di aggettivi o pronomi.
1. fiori sono stati rovinati dalla furia del vento, solo rose si sono salvate.
2. Oggi si prevede pioggia sul Piemonte e bel tempo sulle regioni.
3. Oggi sono assenti alunni: è malato, sono in gita.
4. paura! Ci sono io a farvi compagnia e a darvi coraggio.
5. Durante la ricreazione ragazzi leggono, giocano a scacchi.
6. Stanotte è caduta neve e le scuole sono rimaste chiuse.
7. di voi dovrebbe spiegarmi che cosa è successo.
14. Sottolinea nel brano gli aggettivi numerali in rosso e i pronomi numerali in blu.
Le piramidi
Le piramidi sono enormi edifici a pianta quadrata con i lati triangolari che si incontrano in corrispondenza del vertice. Gli Egizi costruivano piramidi come tombe per i loro sovrani. La prima piramide, eretta attorno all’anno 2650 a.C. a Sakkara, è alta 62 metri. Le tre piramidi più famose si trovano nei pressi di Giza. La Grande Piramide, fatta costruire attorno al 2600 a.C. dal faraone Cheope, è alta 137 m. Chefren, che succedette a Cheope, fece costruire la seconda, alta 136 m, mentre la terza, realizzata da Micerino, successore di Chefren, è alta 73 m. In Egitto si trovano ancora ottanta piramidi circa. Anche le popolazioni native dell’America centrale e meridionale costruirono templi a forma di piramide nei primi sei secoli dopo Cristo: un esempio famoso è l’enorme piramide di Choula, nei pressi di Città del Messico, alta circa 54 m.
A-Z. L’enciclopedia per ragazzi, EdiBimbi
15. Sottolinea in blu gli aggettivi e in giallo i pronomi.
1. Questa borsa è più grande della mia.
2. I miei genitori hanno conosciuto i tuoi.
3. Ciascuno prenda il proprio quaderno.
4. Prendi quella penna; questa è scarica.
5. La loro casa è molto accogliente, ma io preferisco la nostra.
6. Tutti sanno che è importante nutrirsi correttamente.
7. Quante foglie hai raccolto in giardino? Io diverse.
8. Quello stormo è più numeroso di quello laggiù. Ora analizza sul tuo quaderno i pronomi.
IL VERBO

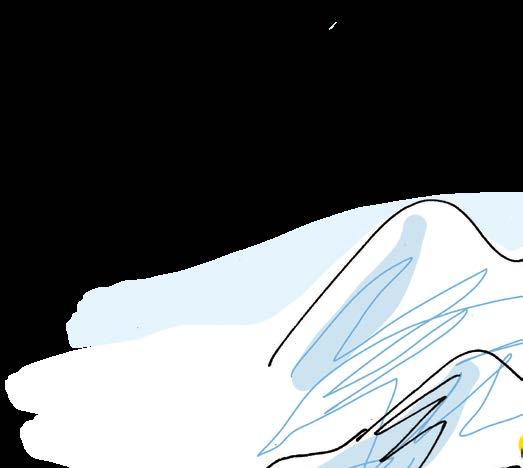
Il cielo era tutto sereno: di mano in mano che il sole s’ alzava dietro il monte, si vedeva la sua luce, dalle sommità dei monti opposti, scendere . Un venticello d’autunno, staccando dai rami le foglie appassite del gelso, le portava a cadere qualche passo distante dall’albero.
Manzoni
Le parole sottolineate sono verbi. Il verbo è la parte fondamentale della frase. È la parte più variabile. Il verbo varia indicando la persona, il tempo e il modo.
LE CONIUGAZIONI
I verbi si raggruppano in tre coniugazioni: AMARE, ASCOLTARE, CANTARE, GOCARE… prima coniugazione - are TEMERE, VEDERE, BERE… seconda coniugazione - ere PARTIRE, CAPIRE, SENTIRE, FINIRE… terza coniugazione - ire
I verbi essere e avere hanno una coniugazione propria. Sono verbi ausiliari perché sono di aiuto alla formazione dei tempi composti di altri verbi (vedi tabelle in fondo al libro)
LA RADICE E LA DESINENZA
Se togliamo al verbo all’infinito la desinenza, otteniamo la radice:
AM - ARE desinenza radice
Il verbo è così pronto a ricevere tutte quelle “terminazioni” (uguali per i verbi della stessa coniugazione) che ci danno tante informazioni: la persona, il tempo e il modo.
OGGI DESIDERO
PATTIN ARE E LEGG ERE , MA HO COSÌ POCO TEMPO CHE PER RIUSC IRE A FARE TUTTO DOVRÒ LEGGERE PATTINANDO! AHAHAH!!!
Desidero = I persona singolare, tempo presente, modo indicativo.
Ricorda!
i verbi fare, dire e produrre appartengono alla seconda coniugazione perché mantengono la forma del verbo latino (facere, dicere e producere).
I MODI DEL VERBO
Sappiamo già che un verbo esprime la persona e il tempo in cui avviene l’azione.
Andrea legge un libro.
Legge = terza persona singolare, tempo presente.
Ricorda!
tutti i verbi della prima e della seconda coniugazione, che hanno “gn” prima di -are e -ere, nella prima persona plurale del tempo presente mantengono la “i” della desinenza (-iamo): sogniamo, accompagniamo, spegniamo…
Ma il verbo esprime anche altre importanti distinzioni. In queste frasi la situazione è sempre la stessa, ma con notevoli diversità:
Andrea legge un libro.
Ah, se Andrea leggesse un libro…
Andrea leggerebbe un libro se lo avesse!
«Andrea, leggi un libro!» dice la maestra.
viene descritta un’azione certa, reale modo INDICATIVO
viene espresso il desiderio che sia compiuta tale azione modo CONGIUNTIVO
viene espressa la possibilità che l’azione venga compiuta
modo CONDIZIONALE
si ordina che l’azione venga compiuta modo IMPERATIVO
I modi indicativo, congiuntivo, condizionale e imperativo sono detti MODI FINITI e indicano sempre la persona, il numero e il tempo.
IL MODO INDICATIVO
Il modo indicativo esprime (indica) l’azione o lo stato in modo reale, certo. Comprende otto tempi: quattro semplici e quattro composti. I tempi semplici sono: presente, imperfetto, passato remoto e futuro semplice. I tempi composti sono: passato prossimo, trapassato prossimo, trapassato remoto e futuro anteriore.
ANDREA, LEGGI UN LIBRO! ANDREA LEGGE UN LIBRO.
IL MODO CONGIUNTIVO
Abbiamo visto che l’indicativo serve generalmente per parlare di fatti e situazioni certe, reali.
Il modo CONGIUNTIVO, invece, sta di solito ad indicare che non parliamo di fatti e situazioni reali; è il modo della possibilità, del dubbio, del desiderio.
Giovanni sa che sua mamma è al lavoro. è = modo indicativo, indica che è un fatto reale che Giovanni conosce.
Giovanni pensa che sua mamma sia al lavoro. sia = modo congiuntivo, è una fantasia, un’opinione di Giovanni.
Il congiuntivo è, di solito, usato nelle frasi congiunte, legate ad altre frasi.
• La mamma desidera che Sofia faccia il suo letto alla mattina.
• L’allenatore fece allenare molto la squadra affinché vincesse il campionato.
Certe volte, però, si usa anche da solo.
Magari oggi piovesse!
I tempi semplici sono: presente e imperfetto.
I tempi composti sono: passato e trapassato.
IL MODO CONDIZIONALE
Il modo CONDIZIONALE è quello che esprime un desiderio: Vorrei la palla per giocare
oppure una condizione: Se fossi al parco, giocherei con la palla!
Come abbiamo visto, se le condizioni sono espresse si usa il congiuntivo (avessi).
Il modo condizionale è anche il modo della cortesia: Potresti prestarmi la palla per giocare?
Il tempo semplice è: presente.
Il tempo composto è: passato.
IL VERBO
1. Sottolinea in rosso le voci del verbo essere quando è usato in senso proprio e in blu quando è usato come ausiliare.
1. È partito ieri col treno.
2. Tu sei un caro ragazzo.
3. C’è un tuo compagno che ti cerca.
4. È arrivato il treno da Roma.
5. Carlo e Mario sono a Milano.
6. Tuo fratello è un tipo sportivo.
7. Il mare Adriatico è poco profondo.
8. Voi siete arrivati per primi.
9. Noi siamo scesi alla stazione centrale.
10. Voi siete generosi nei miei confronti.
2. Sottolinea in rosso le voci del verbo avere quando è usato in senso proprio e in blu quando è usato come ausiliare.
1. In biblioteca ho tanti libri di scienze.
2. Tu hai uno zaino molto pesante.
3. Avevo saputo tutto da tuo zio.
4. Tutti hanno il biglietto per la mostra.
5. Maria ha vinto una bella somma.
6. Non hai avuto fortuna!
7. Che cosa hai trovato nella valigia?
8. Noi abbiamo comprato una casa.
9. Giovanni non ti ha ascoltato.
10. Abbiamo festeggiato il tuo arrivo.
11. Forse ha telefonato il mio amico.
12. Non ho incontrato nessuno oggi.
3. Analizza i seguenti verbi indicando solo modo e tempo.
VERBI
partii indicativo passato remoto avessimo rotto ebbero siate abbia cucito
4. Leggi il brano e trascrivilo trasformando le azioni al tempo passato prossimo, al tempo futuro semplice e al tempo passato remoto. Un corvo ruba un pezzo di carne e va a posarsi sul ramo di un albero. Lo vede la volpe e comincia a tessere grandi lodi del suo corpo perfetto e della bellezza della sua voce. Il corvo si mette a gracchiare e lascia cadere la carne. La volpe afferra la carne e se ne va di corsa.
5. Analizza i seguenti verbi indicando il tempo e la persona.
VERBI TEMPO PERSONA
ebbero passato remoto III plurale
hai avuto ha avevo avuto
avranno avevi
ebbe avuto avesti abbiamo
avrò avuto
avesti avuto avevano hanno avemmo avuto
6. Trascrivi il brano volgendo i verbi dall’imperfetto al presente.
Era l’alba
Il cielo aveva un meraviglioso colore dorato; i campi e le strade avevano catturato i primi raggi e avevano assunto una sfumatura incerta tra il verde, l’azzurro e il grigio.
La rugiada, che aveva bagnato l’erba durante la notte, aveva un riflesso luminoso e brillante, come un piccolo specchio che riflettesse i colori del cielo.
7. Trascrivi il brano Era l’alba volgendo i verbi dal trapassato prossimo al passato prossimo.
8. Ricopia sul quaderno le frasi concordando i verbi con le persone che compiono l’azione. Usa i vari tempi del modo indicativo.
Io e te (leggere) leggiamo con passione i fumetti.
1. Io e te (leggere) con passione i fumetti.
2. Al mare con te (restare) i nonni.
3. Io e Carlo (passeggiare) ogni sera fino a tardi.
4. La zia e i suoi figli (arrivare) domani.
5. L’anno prossimo io (venire) con te a Parigi.
6. L’anno scorso noi (andare) in montagna.
7. Io e voi l’anno prossimo (vedersi).
8. Ieri io e la mamma ti (telefonare).
9. I miei compagni di classe, Luigi e Francesca (restare assenti) per una settimana a causa dell’influenza.
9. Indica se le seguenti voci del modo indicativo sono al tempo futuro semplice o al tempo passato remoto.
andrò ⬜ ⬜ sognò ⬜ ⬜
attraversò ⬜ ⬜ tornò ⬜ ⬜ proseguì ⬜ ⬜ verrò ⬜ ⬜ giocherà ⬜ ⬜ scappò ⬜ ⬜ partirò ⬜ ⬜ suonerà ⬜ ⬜ attraverserà ⬜ ⬜ finirò ⬜ ⬜
10. Analizza le forme verbali: avevo avuto: voce del verbo avere, II coniug., modo indic., tempo trap. pros., I p.s.
1. disegniamo
2. avranno mangiato
3. avevate dormito
4. fu
5. avrà
6. cantai
7. sei stato
8. andasse
9. avessi tolto
10. ebbi scritto
11. tossisce
12. scoprirete
13. ebbi
14. aveste avuto
11. Completa le tabelle.
VOCE DEL VERBO CONIUGAZIONE TEMPO PERSONA
eravate stati
avemmo credevano coloraste ho avuto bevono aveste sorriso ricevemmo
avrai scritto
era stato ha dormito hanno fatto crederanno hanno detto fui andato leggemmo
VOCE DEL VERBO CONIUGAZIONE TEMPO PERSONA
12. Individua le forme verbali, osservando dall’analisi.
1. Voce del verbo partire, III coniugazione, modo indicativo, tempo passato remoto, II persona singolare
2. Voce del verbo scrivere, II coniugazione, modo congiuntivo, tempo trapassato, II persona plurale
3. Voce del verbo mangiare, I coniugazione, modo indicativo, tempo imperfetto, III persona plurale
4. Voce del verbo dipingere, II coniugazione, modo indicativo, tempo passato remoto, I persona plurale
5. Voce del verbo ascoltare, I coniugazione, modo congiuntivo, tempo presente, I persona singolare
13. Individua le forme verbali, osservando dall’analisi.
1. Voce del verbo avere, coniugazione propria, modo congiuntivo, tempo imperfetto, III persona singolare
2. Voce del verbo giocare, I coniugazione, modo congiuntivo, tempo presente, II persona plurale
3. Voce del verbo tossire, III coniugazione, modo congiuntivo, tempo passato, I persona singolare
4. Voce del verbo cedere, II coniugazione, modo congiuntivo, tempo trapassato, III persona plurale
5. Voce del verbo capire, III coniugazione, modo congiuntivo, tempo imperfetto, II persona singolare
14. Inserisci il verbo tra parentesi al modo congiuntivo.
1. Se Luca la televisione, non studierebbe storia. (guardare)
2. Se Veronica una collana, sarebbe più elegante. (indossare)
3. Credevo che tu il treno per Torino. (prendere)
4. Maria e Sofia pensavano che Matteo le alla sua festa. (invitare)
5. Se tu alta come me, sembreresti anche tu un gigante! (essere)
6. Se voi la maestra, sarebbe stato più facile studiare. (ascoltare)
7. Penso che i cagnolini di Vanessa e Valentina buffi. (essere)
15. Completa la tabella al modo indicativo.
VOCE DEL VERBO TEMPO
PERSONA
vincere passato remoto III singolare sarà partito
dare passato remoto III plurale
leggere imperfetto I singolare
sentire trapassato prossimo II plurale
barare presente III singolare
16. Analizza i verbi crocettando il tempo corretto. TEMPO
eravamo andati
hai colorato
chiuderanno
ho avuto
fui
eri stato avevate hanno avuto era stato sono saranno stati ebbe sarete avemmo avuto abbiamo
LE PARTI INVARIABILI
LE PREPOSIZIONI
Quel giorno mi ritrovai in mezzo alla campagna, in una zona di campi verdeggianti dove brucavano mucche dal muso dolce e mite.
Tra le siepi erbose crescevano viole e primule selvatiche e, quando uscì il sole, il colore dell’ erba rigogliosa si trasformò e divenne verde smeraldo.
Rosamunde Pilcher
Le parole sottolineate sono preposizioni
Sono brevi parole che si premettono ad altre per metterle in relazione.
A, di, da, in, con, su, per, tra, fra sono preposizioni semplici
Le preposizioni semplici si uniscono agli articoli e formano le preposizioni articolate.
IL LO L’ LA I GLI LE
A al allo all’ alla ai agli alle
DI del dello dell’ della dei degli delle
DA dal dallo dall’ dalla dai dagli dalle
IN nel nello nell’ nella nei negli nelle
SU sul sullo sull’ sulla sui sugli sulle
LE PREPOSIZIONI
1. Distingui sottolineando con colori diversi le preposizioni semplici, quelle articolate e gli articoli.
1. Marta ha raccolto delle margherite nel cortile della scuola.
2. Delle tegole del tetto sono volate via a causa del forte vento.
3. Dei miei compagni sono a casa con la febbre.
4. Il boscaiolo raccolse dei porcini squisiti.
5. Matilde ha delle nuove scarpette rosse.
6. Ho inserito dei fogli nuovi nel raccoglitore delle materie di studio.
7. Ho scoperto che delle muffe non sono nocive per l’uomo.
8. La maestra ha sostituito dei libri della biblioteca.
2. Completa le frasi usando le preposizioni adatte.
1. Vuoi una fetta formaggio o prosciutto?
2. Mara gioco pallavolo, Stefania vado catechismo.
3. Saremo nonni circa un’ora.
4. Vai camera finire i compiti cura.
3. Analizza le seguenti preposizioni articolate.
1. Dalla
2. Nel
3. Degli
4. Allo
5. Delle
6. Sui
4. Completa le frasi con parole adatte a tua scelta.
1. Marco gioca a con .
2. Vengo ogni giorno da per .
3. Ci sono gli amici di in
LE CONGIUNZIONI
La nonna e la zia verranno da noi questo pomeriggio, ma non potranno fermarsi molto né restare a cena, nonostante l’avessero promesso, perché l’hotel non aveva stanze libere.
Le parole sottolineate sono congiunzioni.
Le congiunzioni uniscono (congiungono) parole o frasi. Come gli articoli e le preposizioni, sono parole che da sole non riescono a significare nulla, ma hanno nella frase il compito di legare in modo significativo altre parole.
Le principali congiunzioni sono: e, ma, pure, né, neppure, o, oppure, però, anche, tuttavia, anzi, cioè, infatti, dunque, quindi, perciò, perché, allora, mentre…
LE CONGIUNZIONI
1. Completa con una congiunzione adatta.
1. Porto la sacca metto la tuta.
2. Viene mia sorella.
3. Ho comprato un pallone non l’ho ancora usato.
4. Vuoi latte tè? uno l’altro, ho già fatto colazione
2. Completa le frasi.
1. Vengo da te, ma .
2. Ho trovato il mio zaino, dunque
3. Sono stato contento della gita, eppure .
4. Tua zia è simpatica perché .
3. Sottolinea le congiunzioni e il congiuntivo che introducono.
1. La maestra ripeteva ogni giorno le tabelline, affinché noi le imparassimo.
2. Benché ci sia il sole, fa freddo.
3. Puoi andare agli allenamenti, purché tu sia guarita.
4. La mia squadra non parteciperà ai campionati, malgrado si sia impegnata tantissimo.
5. Ti presterò la mia gomma, purché tu me la restituisca.
GLI AVVERBI
Davanti vide un lungo corridoio, nel quale camminava il Coniglio bianco frettolosamente . Non c’era tempo da perdere: Alice, come se avesse le ali, gli corse dietro, e lo sentì esclamare: – Perdinci! veramente ho fatto tardi !
Alice nel Paese delle Meraviglie
Le parole sottolineate sono avverbi
Gli avverbi precisano e modificano il significato di un verbo, ma possono riferirsi anche ad altre parti del discorso.
Ecco i principali avverbi:
• di modo (come?): bene, male, lentamente, velocemente…
• di tempo (quando?): ieri, oggi, domani, adesso, ora, prima, poi, mai…
• di luogo (dove?): lì, là, qui, qua, lassù, vicino, lontano, sopra, sotto, fuori, dentro…
• di quantità (quanto?): poco, tanto, molto, più, meno, niente…
• di negazione: no, non, neppure…
• di affermazione: sì, certo, certamente…
• di dubbio: forse, probabilmente, magari…
GLI AVVERBI
1. Sottolinea con il colore rosso gli avverbi.
1. Il mio fratellino sta meglio.
2. La farfalla si posò leggermente sul fiore.
3. Andate piano.
4. Nella gara Riccardo correva forte.
5. Verrò volentieri a casa tua.
6. Esponi brevemente il tuo pensiero.
7. Paolo è arrivato improvvisamente da Parigi.
8. Luigi cammina lentamente.
2. Spiega il significato di questi avverbi poi usali per comporre tre frasi.
1. Gentilmente
2. Coscientemente
3. Ininterrottamente
3. Riconosci se l’avverbio è di luogo, di tempo o di modo.
Adesso
Quassù
Pian piano
Attentamente
Dappertutto
Sempre
Tranquillamente
4. Sostituisci le parole tra parentesi con un avverbio.
1. Arrivo (con velocità) a casa .
2. Ha segnato un gol (in questo momento) .
3. (In breve tempo) abbiamo ripassato storia
4. La nonna mi parla sempre (con dolcezza) .
LE ESCLAMAZIONI
Ehi , amico, vieni con me allo stadio?
Evviva ! È proprio quello che volevo fare.
Oh ! Finalmente qualcuno che mi capisce.
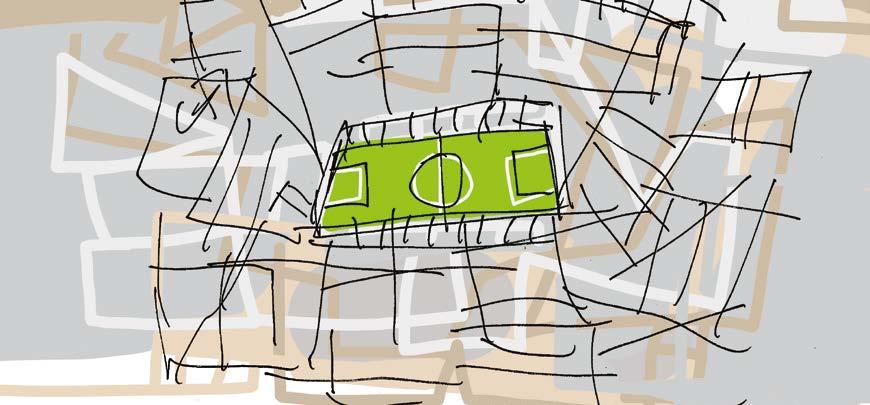
Le parole sottolineate sono esclamazioni.
Le esclamazioni sono parole invariabili che servono ad esprimere emozioni e sensazioni (gioia, esultanza, dolore, paura…).
Eccone alcune: Ahi, oh, uffa!
Sono spesso seguite dal punto esclamativo.
LE ESCLAMAZIONI
1. Completa con esclamazioni appropriate.
1. , com’è difficile questo esercizio.
2. , finalmente un po’ di silenzio.
3. , ci hai creduto!
4. che male!
L’ANALISI GRAMMATICALE
1. Scegli dei colori per ogni parte del discorso. Poi individua nelle frasi ogni parte e sottolineala con il colore scelto.
☐ articoli
☐ pronomi
☐ nomi ☐ aggettivi
☐ verbi ☐ preposizioni
☐ congiunzioni ☐ avverbi ☐ esclamazioni
• Evviva! Guardate come nevica! Andiamo subito in giardino a fare un grande pupazzo di neve!
• Scegli dei colori per ogni parte del discorso. Poi individua nelle frasi ogni parte e sottolineala con il colore scelto.
☐ articoli
☐ pronomi
☐ nomi ☐ aggettivi
☐ verbi ☐ preposizioni
☐ congiunzioni ☐ avverbi ☐ esclamazioni
1. Annalisa ha piantato, sul suo balcone, dei bellissimi gerani bianchi simili ai tuoi.
2. Ci tuffammo con allegria nel vasto Oceano Pacifico, poiché per tutti era la prima volta che lo vedevamo.
3. Chiunque abbia partecipato alla lezione, dovrà avvisare con tempestività gli esperti maestri di sci.
4. Caterina è più generosa di suo fratello Anselmo, sebbene siano due ragazzi molto gentili.
5. I pescatori lavorano tutta notte in mare e alle prime luci dell’alba scaricano, dalle loro imbarcazioni, reti colme di prelibati pesci per venderli al mercato.
2. Svolgi l’analisi grammaticale di tutte le frasi con le matite colorate.
1. Dei bambini dispettosissimi ci rovinarono alcune aiuole fiorite.
2. Queste rossissime fragole sono più mature di quelle sul tavolo della cucina.
3. Nonostante avessimo tempo per prendere il nostro treno, temevo di perderlo.
3. Svolgi l’analisi grammaticale scritta sul quaderno. Questi coloratissimi fiori sono più profumati di quelli nel vaso del negozio.
4. Leggi bene le frasi, individua ogni parte con i colori. Poi fai l’analisi scritta delle parole sottolineate (scrivi tutto ciò che sai).
Il fratellino di Beatrice quest’anno ha frequentato la classe prima, lei la quarta.
Tutti hanno svolto i compiti di matematica e quelli di italiano.
La nostra festa è stata più divertente della loro.
Ti ho versato la spremuta, l’hai bevuta?
5. Individua ogni parte del discorso con colori diversi, poi evidenzia la concordanza.
I nuovi vicini abitano in questa casa da pochi giorni.
1. La signora Luisa ci ha aiutato molte volte coi compiti del doposcuola.
2. Questa mattina sarei arrivato puntuale a scuola se avessi preso il mio solito autobus.
3. Un ragazzino surfava nell’incerta luce del crepuscolo e la sua figura così snodata faceva pensare a un punto interrogativo.
6. Svolgi l’analisi grammaticale scritta delle seguenti frasi, evidenziando le concordanze, come nell’esempio.
HO LETTO voce del verbo leggere, II coniugazione, modo indicativo, tempo passato prossimo, I persona singolare
UN articolo indeterminativo
LIBRO nome comune
INTERESSANTE aggettivo qualificativo
1. È arrivata
Cecilia
dall’
Argentina
è
una
direttrice
simpatica e
attenta
2. Il
tuo
testo
è
completo le
parole
sono
tutte
corrette maschile singolare
LA COMBINAZIONE LOGICA
Le parole che abbiamo conosciuto (articoli, nomi, aggettivi, verbi…) si accordano e si combinano per formare le frasi, espressioni che hanno un senso.
Le composizioni delle parole che costruiscono una frase di senso compiuto si chiamano SINTAGMI.
Il cane / della zia Michela / abbaia / tutto il giorno / alle persone / del vicinato.
BAU BAU BAU BAU BAU!
Nella frase ogni sintagma svolge una funzione particolare e contribuisce a costruire il significato complessivo.
I sintagmi fondamentali sono il sintagma nominale e il sintagma verbale, che hanno innanzitutto il compito di svolgere la funzione di soggetto e di predicato.
IL PREDICATO
Il cane / della zia Michela / abbaia / tutto il giorno / alle persone / del vicinato.
Il verbo è la parola più importante della frase perché ha il compito di organizzarla.
che cosa si dice?
predicato - sintagma verbale
Per capire la combinazione logica di una frase occorre dunque partire dal verbo. Intorno al verbo si costruisce innanzitutto il sintagma verbale che svolge il compito di PREDICATO
Per individuare il sintagma verbale - predicato può essere utile farsi la domanda: che cosa si dice?
IL SOGGETTO
Ricorda! il verbo ha una funzione così forte che in alcuni casi forma da solo una frase: Piove.
Il cane / della zia Michela / abbaia / tutto il giorno / alle persone / del vicinato.
di chi parla il verbo? a quale sintagma si riferisce? soggetto - sintagma nominale
L’altro sintagma indispensabile è quello che si costruisce intorno a un nome: il sintagma nominale. È questo il sintagma che svolge il compito di SOGGETTO quando concorda con il verbo.
Per individuare il sintagma nominale - soggetto si può porre la domanda: di chi parla il verbo? a quale sintagma si riferisce?
Il soggetto infatti è espresso dal sintagma che determina il numero e la persona del sintagma verbale - predicato. Il sintagma con funzione di soggetto può anche non essere espresso quando il verbo lo rivela chiaramente; in questo caso si ha il soggetto sottointeso. Gioco volentieri a calcio › il soggetto sottointeso è io.
Ricorda! Qualsiasi parte del discorso può svolgere la funzione di soggetto. Leggere è utile il soggetto è un verbo all’infinito.
Soggetto e predicato (di chi si parla e che cosa si dice) sono gli elementi essenziali della combinazione logica della frase.
I sintagmi nominale e verbale che li rappresentano concordano tra loro e costituiscono insieme la frase minima
IL PREDICATO VERBALE E NOMINALE
Ogni giorno / molti bambini / VANNO / a scuola.
Durante le vacanze natalizie / Riccardo / È ANDATO / in montagna.
Tutte le ballerine / AVEVANO RACCOLTO / i capelli.
Lucia / è bella .
La sorella / di Marta / è una bambina simpatica . Il papà / del mio amico Franco / è un vigile urbano .
Esistono due tipi di predicato: predicato verbale e predicato nominale.
• PREDICATO VERBALE che è formato solo da una voce verbale (come quelli scritti in stampato e sottolineati);
• PREDICATO NOMINALE che è formato dal verbo essere più nome e/o aggettivo (come quelli scritti in corsivo e sottolineati).
Ricorda!
Quando il verbo essere ha il significato di stare, trovarsi, appartenere, esistere è un predicato verbale.
Lucia è in casa
L’ANALISI LOGICA
1. DURANTE LE VACANZE NATALIZIE / RICCARDO / È ANDATO / IN MONTAGNA.
3. di chi parla il verbo? soggetto 2. che cosa si dice? predicato verbale
Per capire ed eseguire correttamente l’analisi logica devi:
• 1. dividere la frase in sintagmi, le combinazioni di parole che sono unite perché svolgono una funzione nella frase:
DURANTE LE VACANZE NATALIZIE / RICCARDO / È ANDATO / IN MONTAGNA.
• 2. individuare il predicato, cioè il sintagma del verbo che ti permette di capire che cosa si dice:
DURANTE LE VACANZE NATALIZIE / RICCARDO / È ANDATO / IN MONTAGNA.
• 3. riconoscere il soggetto, cioè il sintagma di cui parla il predicato e con cui concorda:
DURANTE LE VACANZE NATALIZIE / RICCARDO / È ANDATO / IN MONTAGNA.
I COMPLEMENTI
Le frasi sono solitamente formate da altri sintagmi che hanno la funzione di completare la frase minima. Questi sintagmi si chiamano COMPLEMENTI
IL COMPLEMENTO DIRETTO
LUCIA / RACCONTA / A MARCO / LA SUA IDEA
chi? che cosa?
racconta la sua idea
complemento diretto o complemento oggetto
• Fra i vari complementi si distingue il sintagma che spesso completa la frase minima: è il complemento diretto (o complemento oggetto). Si chiama diretto quel complemento che è direttamente legato al verbo, in quanto l’azione espressa dal predicato “cade” direttamente sull’oggetto nominato in questo complemento. Di solito questo complemento è formato da un nome preceduto dall’articolo.
I COMPLEMENTI INDIRETTI
• Quando i sintagmi che completano la frase sono introdotti da una preposizione sono complementi indiretti Ogni complemento indiretto esprime diversi significati. Ad esempio può esprimere un’indicazione di tempo (Luca è arrivato in ritardo), di luogo (Piero è entrato in classe), di modo (Anna parla in modo incomprensibile).
QUESTA MATTINA / GIULIA / PARTE / PER MILANO / CON IL TRENO
Quando?
Questa mattina complemento indiretto
per dove?
per Milano complemento indiretto
con che mezzo? con il treno complemento indiretto
LA COMBINAZIONE LOGICA
1. Dividi in sintagmi e poi sostituisci ogni sintagma formando una frase nuova.
Questa sera / Marco e Alice / mangeranno / da noi.
Domani / i miei amici / dormiranno / dai nonni.
1. La mamma di Diletta prepara un maglione di lana.
2. Questa sera guarderemo alla televisione la partita dell’Italia.
3. Il treno per Rimini partirà alle 16:00 dal secondo binario.
4. Marta era felice per il regalo.
5. Francesco è a casa di Anna.
2. Dividi in sintagmi e poi sostituisci ogni sintagma formando una frase nuova.
1. Silvia è una bambina simpatica.
2. Domani la maestra farà domande di geografia a tutti.
3. È un cane simpaticissimo Argo.
4. I viaggi di Ulisse furono avventurosi.
5. Quest’anno in matematica le classi quarte hanno affrontato le frazioni.
3. Dividi in sintagmi, poi sottolinea il predicato e il soggetto.
1. Un cane giocherellone riporta il bastone al suo padrone.
2. A pranzo Stefano ha mangiato un grosso panino.
3. Le tue calze sono nel secondo cassetto del tuo comodino.
4. Al sabato pomeriggio disputiamo una partita di basket.
5. Questa mattina Martina è andata a scuola con i nonni.
6. Il giocattolo preferito di Luca è rotto.
7. Nella sua culla dorme Mattia.
8. Il papà di Paola è un ingegnere aeronautico.
9. La prossima estate andremo in Spagna con i nostri cugini.
10. Ogni sera Lucia legge alcune pagine di un libro di avventure.
11. Chiara ha mangiato una porzione di pizza.
12. Lo zio di Stefania ha comprato un pacco di ciambelle.
13. Pranzi con me?
14. Le bugie hanno le gambe corte.
15. La fata Turchina aiutò Pinocchio.
16. Marco ha superato con facilità la prova di atletica.
17. Ho messo i quaderni nuovi nel primo cassetto della mia stanza.
18. Il mio compagno di banco per il suo compleanno ha ricevuto in regalo da sua zia una pista di biglie.
19. I miei genitori comprano a Sulmona dei buonissimi confetti.
20. Una mela al giorno toglie il medico di torno.
21. Il Piemonte confina con la Liguria.
22. Questa mattina avevo molta fame.
23. Lunedì rimarremo a casa per la festa del patrono.
24. La lezione di geometria riguarderà la misurazione degli angoli.
25. Con la maestra Irene abbiamo preparato il presepe della scuola.
26. Il succo delle arance previene il raffreddore.
27. Narciso era un giovane bellissimo e amava specchiarsi nell’acqua dei torrenti.
28. Molti fiori hanno petali profumati.
29. Alcune lunghe radici uniscono tra loro le violette selvatiche.
30. Ogni settimana il maestro insegna loro una nuova canzone.
4. Leggi le frasi, dividi in sintagmi, scrivi le domande e sottolinea soggetto e predicato. Dove serve scrivi il soggetto sottinteso.
Le stringhe / delle scarpe / di Matteo / sono slacciate.
Di che cosa? Di chi?
1. Allo zoo i ragazzi si fermarono per molto tempo davanti alla giraffa.
2. Martedì il compito di geometria era molto impegnativo.
3. Paolo ha fatto un lungo viaggio con l’automobile nuova di suo zio.
4. Sul pesco del mio giardino a marzo spunteranno i primi fiorellini rosa.
5. Leggi le frasi, dividi in sintagmi, scrivi le domande e sottolinea soggetto e predicato. Dove serve scrivi il soggetto sottinteso.
1. All’orizzonte la luce del sole inonda ogni cosa.
2. Domenica sera allo stadio i tifosi interisti applaudivano la propria squadra.
3. Nelle vasche dell’acquario guizzano tanti pesci tropicali.
4. La libreria nello studio della mamma è stracolma di libri.
5. Domenica pomeriggio Laura ha visitato una bellissima mostra di pittura.
6. Leggi le frasi, dividi in sintagmi, scrivi le domande e sottolinea soggetto e predicato. Dove serve scrivi il soggetto sottinteso.
1. Hai eseguito con molta cura i compiti di geometria.
2. Quel bellissimo fiore nel vaso sul tavolo della cucina è una camelia.
3. Stanotte nel cielo stellato splendeva una meravigliosa luna piena.
4. La vecchia carrozzina di Elisa è in cantina.
5. Sabato scorso la maestra Paola è andata a Bologna.
7. Leggi le frasi, dividi in sintagmi, scrivi le domande e sottolinea soggetto e predicato. Dove serve scrivi il soggetto sottinteso.
1. La parte femminile del fiore accoglie il polline maschile.
2. Per la mia festa di compleanno il cuoco Matteo cucinerà una succulenta pasta al forno.
3. Ogni settimana il maestro Sergio e la maestra Giovanna preparano una impegnativa lezione di nuoto per noi.
4. Dormi?
8. Dividi in sintagmi, poi sottolinea soggetto e predicato.
1. L’albero fiorito nel giardino del mio condominio è una magnolia.
2. Mi hai detto una bugia.
3. Ieri i miei genitori mi hanno accompagnato al cinema.
4. Per cena, papà ti ha preparato la pizza.
5. Ne parlate sempre.
6. Me la presti?
7. A Natale ti regalerò del cioccolato.
8. Vi inviterò alla mia festa di compleanno.
9. Le ho nascosto il suo astuccio.
10. Domenica gli ho telefonato.
9. Sottolinea la frase minima e riscrivila.
1. Dai rami dell’albero sono cadute alcune foglie.
2. Sul balcone della mia vicina sbocciarono i primi fiori.
3. Giochiamo a nascondino?
4. Ho finito!
5. Ieri in gita io e la mia classe abbiamo osservato le bellezze di Milano.
6. Ascolto con piacere le canzoni di Sanremo.
7. Domenica in oratorio inizieranno le gare sportive.
8. Ogni inizio dell’anno tutte le classi partecipano al tiro alla fune.
9. A tavola mancano solamente i cuginetti di Lara.
10. Sottolinea la frase minima.
1. Io e Giacomo questa settimana andremo al cinema.
2. Nel cielo ceruleo volavano con agilità le piccole rondini.
3. Chiara, Giovanna e Irene hanno mangiato con me in mensa.
4. Le cugine delle gemelle Margherita e Clara sono andate in Spagna con le loro famiglie.
5. Sabato la mamma di Gaia, con molta pazienza, ha preparato gli gnocchi alla zucca.
11. Sottolinea il predicato verbale e il predicato nominale.
1. Le affascinanti piramidi sono in Egitto.
2. L’estate scorsa sono stato in America con la famiglia.
3. Chiara è una bambina silenziosa.
4. Ieri il cielo era limpido.
5. Saremo a scuola tutto il giorno.
6. La mia casa è molto accogliente.
7. Il fiume Po nasce dal Monviso e sfocia nel Mar Adriatico.
8. La gita di settimana prossima sarà interessante.
9. La limonata è la mia bevanda preferita.
10. Fummo contenti per la sorpresa della zia.
12. Sottolinea il predicato e nelle parentesi scrivi di quale si tratta.
1. Ieri sera dopo la scuola sono andato in pizzeria con i miei genitori. ( )
2. L’ultimo film di Harry Potter è bellissimo. ( )
3. Il cagnolino ha rubato le scarpe di Sofia. ( )
4. Sabato a casa del nonno Gino abbiamo fatto una festa a sorpresa alla mamma. ( )
5. Il pavimento della sala è lucido. ( )
13. Sottolinea il soggetto o scrivilo nelle parentesi quando è sottointeso.
1. Le mie due compagne di banco si chiamano Annalena e Camilla. ( )
2. Al mare ho incontrato la famiglia di Giorgio. ( )
3. Quella felpa è meravigliosa! ( )
4. Ti ho visto, nascondevi qualcosa. ( )
5. La partita di calcio di questa sera finirà in parità. ( )
6. Questa settimana festeggiamo il Carnevale. ( )
7. Giovedì andrò a sciare con mia sorella e una sua cara amica della montagna. ( )
8. Temevo avessi avuto l’influenza. ( )
14. Svolgi l’analisi logica. Dividi in sintagmi. Sottolinea in verde il predicato e scrivi se è PN o PV. Sottolinea in rosso il soggetto o scrivi a fine frase se è sottinteso.
1. Il film al cinema era incredibile!
2. Ieri, nel giardino del nonno, Tommaso ha trovato la tana di un riccio.
3. Il Gran Sasso è un monte dell’Abruzzo.
4. L’anno scorso, su una spiaggia della Toscana, ho costruito con Lucrezia un bellissimo castello di sabbia con delle conchiglie bianche.
5. Gli spaghetti sono squisiti!
6. Carlotta è nella casa in collina della zia Guglielmina.
7. Caterina è la sorella maggiore di Pietro.
8. Mi aspetti in oratorio?
9. Emanuele e Matteo sono compagni di scuola.
10. Hanno innaffiato l’insalata nell’orto?
11. Tutte le mattine Carlo prepara la sua cartella arancione.
12. Biancaneve addentò la mela rossa.
13. Adoro la torta al cioccolato di nonna Lina!
14. Alla fine dell’anno scolastico io e i miei genitori andremo sulla Grignetta.
15. Settimana prossima lavoreremo in piccoli gruppi.
15. Sottolinea in rosso il complemento diretto e in blu i complimenti indiretti di ogni frase:
Prendi / con te / lo zaino / di scuola.
1. Il nonno abitava in un piccolo paesino siciliano in riva al mare.
2. Un pesce spada abboccò alla lenza.
3. I cipressi ondeggiavano nella brezza primaverile.
4. I sentieri di ciottoli bianchi serpeggiano tra le aiuole.
5. Nei primi giorni di maggio il paesaggio montuoso meridionale conosce i suoi giorni più belli.
6. Lara e Carla chiacchierano sul muretto davanti casa.
7. Quella penna colorata è di mio cugino Michele.
TABELLE DEI VERBI
IL VERBO ESSERE
MODO INDICATIVO
MODO CONGIUNTIVO
presente passato prossimo presente passato
io sono io sono stato che io sia che io sia stato
tu sei tu sei stato che tu sia che tu sia stato egli è egli è stato che egli sia che egli sia stato noi siamo noi siamo stati che noi siamo che noi siamo stati voi siete voi siete stati che voi siate che voi siate stati essi sono essi sono stati che essi siano che essi siano stati
imperfetto trapassato prossimo imperfetto trapassato io ero io ero stato che io fossi che io fossi stato tu eri tu eri stato che tu fossi che tu fossi stato egli era egli era stato che egli fosse che egli fosse stato noi eravamo noi eravamo stati che noi fossimo che noi fossimo stati voi eravate voi eravate stati che voi foste che voi foste stati essi erano essi erano stati che essi fossero che essi fossero stati
passato remoto trapassato remoto io fui io fui stato tu fosti tu fosti stato egli fu egli fu stato noi fummo noi fummo stati voi foste voi foste stati essi furono essi furono stati
MODO CONDIZIONALE
Futuro semplice Futuro anteriore presente passato io sarò io sarò stato io sarei io sarei stato tu sarai tu sarai stato tu saresti tu saresti stato egli sarà egli sarà stato egli sarebbe egli sarebbe stato noi saremo noi saremo stati noi saremmo noi saremmo stati voi sarete voi sarete stati voi sareste voi sareste stati essi saranno essi saranno stati essi sarebbero essi sarebbero stati
IL VERBO AVERE
MODO INDICATIVO
MODO CONGIUNTIVO
presente passato prossimo presente passato
io ho io ho avuto
tu hai tu hai avuto
che io abbia che io abbia avuto
che tu abbia che tu abbia avuto
egli ha egli ha avuto che egli abbia che egli abbia avuto noi abbiamo noi abbiamo avuto che noi abbiamo che noi abbiamo avuto
voi avete voi avete avuto
essi hanno essi hanno avuto
che voi abbiate che voi abbiate avuto
che essi abbiano che essi abbiano avuto
imperfetto trapassato prossimo imperfetto trapassato
io avevo io avevo avuto che io avessi che io avessi avuto tu avevi tu avevi avuto
che tu avessi che tu avessi avuto
egli aveva egli aveva avuto che egli avesse che egli avesse avuto noi avevamo noi avevamo avuto che noi avessimo che noi avessimo avuto voi avevate voi avevate avuto che voi aveste che voi aveste avuto
essi avevano essi avevano avuto che essi avessero che essi avessero avuto
passato remoto trapassato remoto
io ebbi io ebbi avuto
tu avesti tu avesti avuto
egli ebbe egli ebbe avuto
noi avemmo noi avemmo avuto
voi aveste voi aveste avuto
essi ebbero essi ebbero avuto
MODO CONDIZIONALE
Futuro semplice Futuro anteriore presente passato io avrò io avrò avuto io avrei io avrei avuto tu avrai tu avrai avuto tu avresti tu avresti avuto egli avrà egli avrà avuto egli avrebbe egli avrebbe avuto noi avremo noi avremo avuto noi avremmo noi avremmo avuto
voi avrete voi avrete avuto voi avreste voi avreste avuto
essi avranno essi avranno avuto essi avrebbero essi avrebbero avuto
IL VERBO AMARE
MODO INDICATIVO
MODO CONGIUNTIVO
presente passato prossimo presente passato io amo io ho amato che io ami che io abbia amato tu ami tu hai amato che tu ami che tu abbia amato egli ama egli ha amato che egli ami che egli abbia amato noi amiamo noi abbiamo amato che noi amiamo che noi abbiamo amato voi amate voi avete amato che voi amiate che voi abbiate amato essi amano essi hanno amato che essi amino che essi abbiano amato
imperfetto trapassato prossimo imperfetto trapassato io amavo io avevo amato che io amassi che io avessi amato tu amavi tu avevi amato che tu amassi che tu avessi amato egli amava egli aveva amato che egli amasse che egli avesse amato noi amavamo noi avevamo amato che noi amassimo che noi avessimo amato voi amavate voi avevate amato che voi amaste che voi aveste amato essi amavano essi avevano amato che essi amassero che essi avessero amato
passato remoto trapassato remoto io amai io ebbi amato tu amasti tu avesti amato egli amò egli ebbe amato noi amammo noi avemmo amato voi amaste voi aveste amato essi amarono essi ebbero amato
MODO CONDIZIONALE
Futuro semplice Futuro anteriore presente passato io amerò io avrò amato io amerei io avrei amato tu amerai tu avrai amato tu ameresti tu avresti amato egli amerà egli avrà amato egli amerebbe egli avrebbe amato noi ameremo noi avremo amato noi ameremmo noi avremmo amato voi amerete voi avrete amato voi amereste voi avreste amato essi ameranno essi avranno amato essi amerebbero essi avrebbero amato
IL VERBO TEMERE
MODO INDICATIVO
MODO CONGIUNTIVO
presente passato prossimo presente passato io temo io ho temuto che io tema che io abbia temuto tu temi tu hai temuto che tu tema che tu abbia temuto egli teme egli ha temuto che egli tema che egli abbia temuto noi temiamo noi abbiamo temuto che noi temiamo che noi abbiamo temuto voi temete voi avete temuto che voi temiate che voi abbiate temuto essi temono essi hanno temuto che essi temano che essi abbiano temuto
imperfetto trapassato prossimo imperfetto trapassato io temevo io avevo temuto che io temessi che io avessi temuto tu temevi tu avevi temuto che tu temessi che tu avessi temuto egli temeva egli aveva temuto che egli temesse che egli avesse temuto noi temevamo noi avevamo temuto che noi temessimo che noi avessimo temuto voi temevate voi avevate temuto che voi temeste che voi aveste temuto essi temevano essi avevano temuto che essi temessero che essi avessero temuto
passato remoto trapassato remoto io temetti/ei io ebbi temuto tu temesti tu avesti temuto egli temé (temette) egli ebbe temuto noi tememmo noi avemmo temuto voi temeste voi aveste temuto essi temerono essi ebbero temuto
MODO CONDIZIONALE
Futuro semplice Futuro anteriore presente passato io temerò io avrò temuto io temerei io avrei temuto tu temerai tu avrai temuto tu temeresti tu avresti temuto egli temerà egli avrà temuto egli temerebbe egli avrebbe temuto noi temeremo noi avremo temuto noi temeremmo noi avremmo temuto voi temerete voi avrete temuto voi temereste voi avreste temuto essi temeranno essi avranno temuto essi temerebbero essi avrebbero temuto
IL VERBO PARTIRE
MODO INDICATIVO
MODO CONGIUNTIVO
presente passato prossimo presente passato io parto io sono partito che io parta che io sia partito tu parti tu sei partito che tu parta che tu sia partito egli parte egli è partito che egli parta che egli sia partito noi partiamo noi siamo partiti che noi partiamo che noi siamo partiti voi partite voi siete partiti che voi partiate che voi siate partiti essi partono essi sono partiti che essi partano che essi siano partiti
imperfetto trapassato prossimo imperfetto trapassato io partivo io ero partito che io partissi che io fossi partito tu partivi tu eri partito che tu partissi che tu fossi partito egli partiva egli era partito che egli partisse che egli fosse partito noi partivamo noi eravamo partiti che noi partissimo che noi fossimo partiti voi partivate voi eravate partiti che voi partiste che voi foste partiti essi partivano essi erano partiti che essi partissero che essi fossero partiti
passato remoto trapassato remoto io partii io fui partito tu partisti tu fosti partito egli partì egli fu partito noi partimmo noi fummo partiti voi partiste voi foste partiti essi partirono essi furono partiti
MODO CONDIZIONALE
Futuro semplice Futuro anteriore presente passato io partirò io sarò partito io partirei io sarei partito tu partirai tu sarai partito tu partiresti tu saresti partito egli partirà egli sarà partito egli partirebbe egli sarebbe partito noi partiremo noi saremo partiti noi partiremmo noi saremmo partiti voi partirete voi sarete partiti voi partireste voi sareste partiti essi partiranno essi saranno partiti essi partirebbero essi sarebbero partiti
INDICE
LETTURA
z Lo specchio
Il gigante egoista
z La gola della balena
I cigni selvatici
z Il rospo
Racconti storici
Storia di un cavallo di legno
Pitagora
z Il più veloce
Atena e Aracne
L’ingresso dei persiani
Bucefalo
Modi di dire tratti dai miti greci
z Il graffito
Incontriamo gli scrittori atichi
Il buon amico
Il vento tra i rami dei meli
Il leone invecchiato e la volpe
Elogio di Atene
Descrizioni
z La Visaille
z Le onde
Paesaggi naturali
Descrivere con gli occhi di un pittore
Guardando l’acqua
Alba sul mare
Le Dolomiti
La montagna è viva
Sera sul lago
La valle più bella del mondo
Ambienti particolari
Il giardino
z La casa più strana del mondo
La soffitta
z In soffitta
La stanza di Sandokan
Le casette di Belvedere dei Tigli
I nostri oggetti parlano di noi
In città
Città presente
z La città
Tra le bancarelle
Sera in città
z Il mercato
In città al mattino
La strana meraviglia dei treni
Testi di narrativa per la lettura integrale in classe
Le cronache di Narnia
La radice e la desinenza
Gli avverbi
Le esclamazioni
L’analisi grammaticale
La combinazione logica
Il predicato
Il soggetto
Il predicato verbale e nominale
INDICE RAGIONATO
PERCORSI DISCIPLINARI
Educazione civica Grazie
cedere!
Ronald ha rotto la cassetta K7
Un nido sul grattacielo
La carovana alata
Il libro della
Agatha
Storia
z Musica (canti e ascolti)
z Comprensioni del testo
z Arte e immagine (attività espressive)
z Poesia
Sinfonia n. 3, primo movimento L. van Beethoven 64
Campanas de Belèn 84
Lo Schiaccianoci P.I. Tchaikovsky
Le onde L. Einaudi
LEGGERE, COMPRENDERE, SCRIVERE
Comprensioni del testo
Riconoscere la strada 9
Giochi di luce
Trovare un amico
Un vero capolavoro
Atterraggio in Australia
Archimede, il bagno e la corona
La città sepolta nella neve
Lampi e tuoni 115
Nel luogo delle cose perdute
Lo specchio
La gola della balena
Il rospo
Il più veloce
La casa più strana del mondo
Raccontare
Il gusto dell’attesa 5
Grazie! 12
Un luogo dove giocare
Trovare un amico
Il portiere e l’erba
Fare squadra!
Il formicaleone
La carovana alata
Giornata nuvolosa
Il Donacibo: una proposta pasquale
La torta di Pasqua
Nel luogo delle cose perdute
Lo specchio
I nostri oggetti parlano di noi
Descrivere Cara Joan…
Che cosa stai facendo qui?
Agatha Christie, una storia di straordinaria dislessi
Sono nate le viole
Ronald ha rotto la cassetta K7
Teofila e il pappagallo
Esplorare la scrittura
segreti del volo
e modi di dire
cosa stai facendo qui?
Comporre poesia
Proposte di lavoro Come un poeta: comporre versi
Come un poeta: strofe e dittici
un poeta: similitudine
un poeta: anafora
Come un poeta: sillabe nei versi
MONDO
ALLA SCOPERTA DEL MONDO
DI TESTO LA
LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA

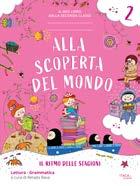
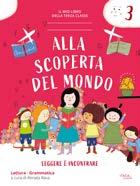
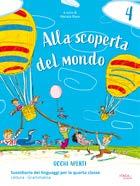
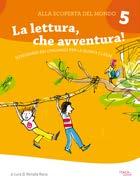
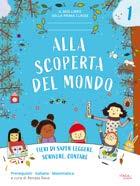
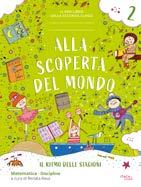
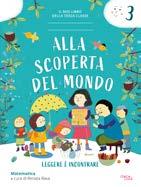
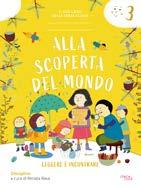
ALLA SCOPERTA DEL MONDO 1
Classe 1
Fieri di saper leggere, scrivere, contare
Tre volumi indivisibili:
• Lettura · Percorsi disciplinari
• Prerequisiti · Italiano · Matematica
• Quaderno del corsivo
• Sillabario + Segnalibri didattici
ALLA SCOPERTA DEL MONDO 2
Classe 2
Il ritmo delle stagioni
Due volumi indivisibili:
• Lettura · Grammatica
• Matematica · Discipline


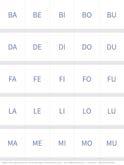
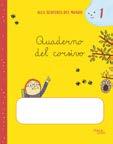

SCOPRI DI PIÙ SU ITACASCUOLA.IT
ALLA SCOPERTA DEL MONDO 3
Classe 3
Leggere è incontrare
Tre volumi indivisibili:
• Lettura · Grammatica
• Matematica
• Discipline
• Segnalibri didattici
ALLA SCOPERTA DEL MONDO 4
Classe 4
Occhi aperti
Sussidiario dei linguaggi
• Lettura · Grammatica


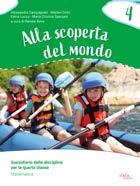
ALLA SCOPERTA DEL MONDO 5
Classe 5
La lettura, che avventura!
Sussidiario dei linguaggi
• Lettura · Grammatica
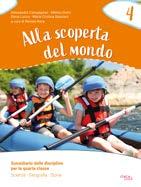
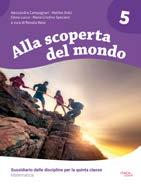
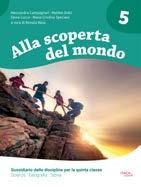
e sul Canale ITACASCUOLA su Itacaeventi!

ALLA SCOPERTA DEL MONDO 4
Classe 4
Sussidiario delle discipline
Due volumi indivisibili:
• Matematica
• Scienze · Geografia · Storia
ALLA SCOPERTA DEL MONDO 5
Classe 5
Sussidiario delle discipline
Due volumi indivisibili:
• Matematica
• Scienze · Geografia · Storia
ALLA SCOPERTA DEL MONDO 4
PERCORSO PER LA SCUOLA PRIMARIA
• Sussidiario dei linguaggi
- Lettura · Grammatica
• Sussidiario delle discipline
- Matematica
- Scienze · Geografia · Storia
Il segreto verrà fuori da solo. Tenete gli occhi aperti. C.S. Lewis