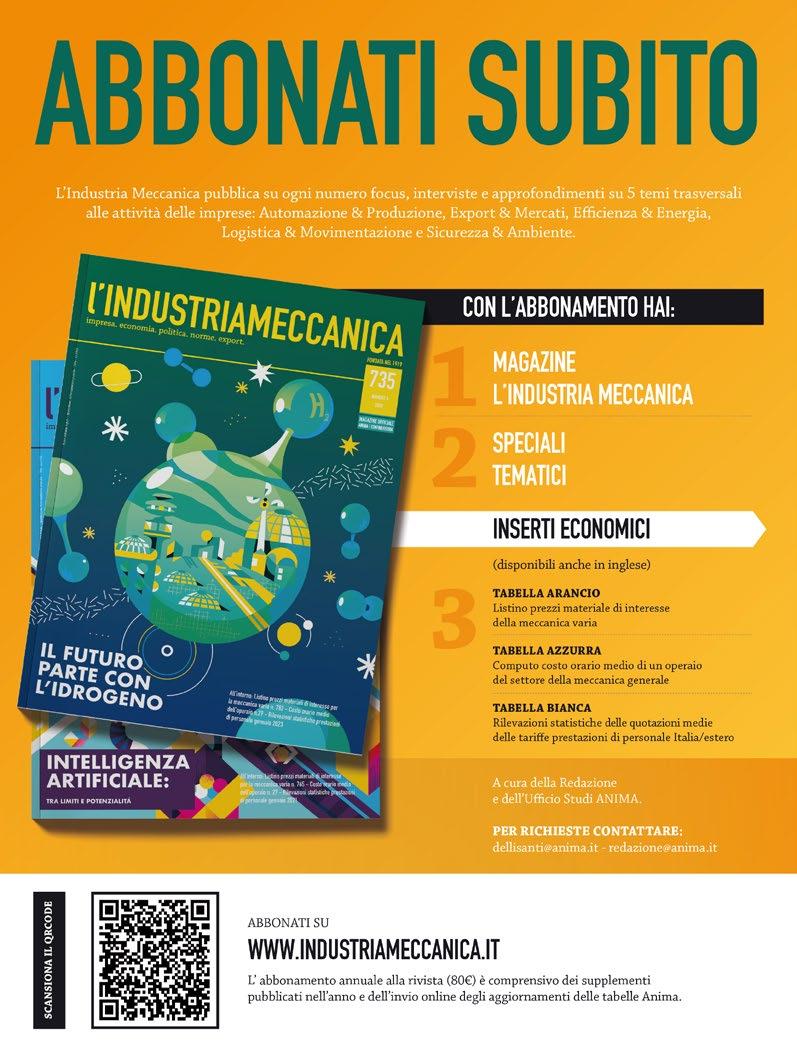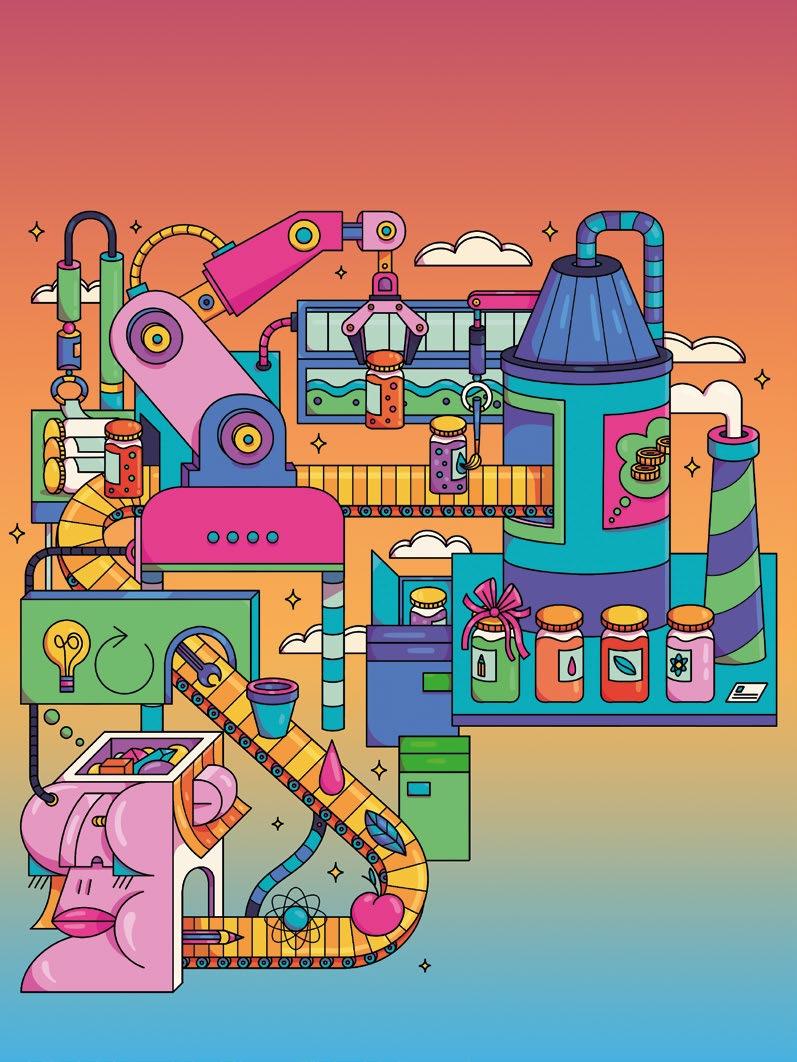
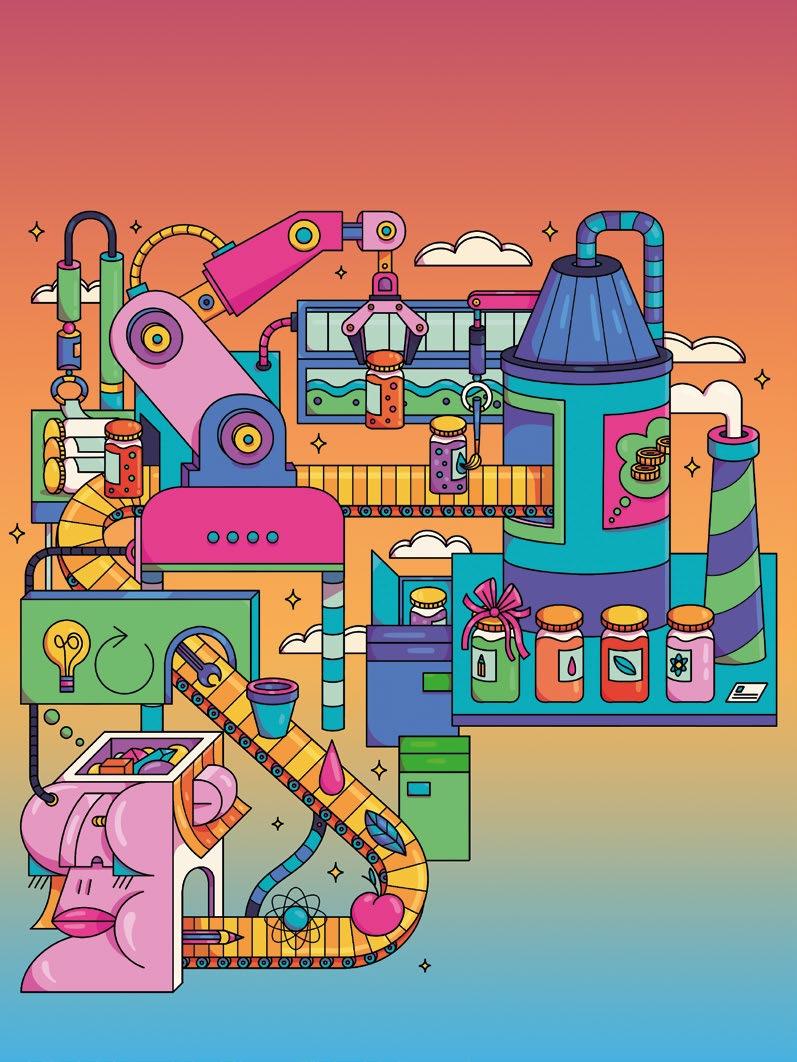
LE IDEE FANNO L’INDUSTRIA
All’interno: Listino prezzi materiali di interesse per la meccanica varia n. 805 - Costo orario medio dell’operaio n.31- Rilevazioni statistiche prestazioni di personale gennaio 2025

Tu e i bambini. Dalla stessa parte.
Con il tuo 5x1000, ci aiuti ad assicurare protezione, accoglienza e sostegno a 900 persone in Italia, tra bambini, ragazzi e famiglie.
Nella tua dichiarazione dei redditi firma in favore di SOS Villaggi dei Bambini e resta accanto ai bambini più vulnerabili, che hanno perso o rischiano di perdere le cure della loro famiglia.
È gratuito per te e molto semplice:
1. Metti la tua firma nella dichiarazione dei redditi (CU, 730 o Unico) nel riquadro “Sostegno degli Enti del Terzo Settore delle Onlus iscritte all’anagrafe”.
2. Inserisci sotto la tua firma, il codice fiscale di SOS Villaggi dei Bambini 80017510225.
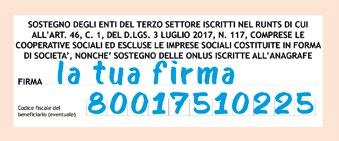
Tu e i bambini.
“Nel Villaggio SOS trovi l’affetto, la serenità, chi si dedica a te nel fare i compiti, nell’ascoltarti, nell’accompagnarti a fare sport. Non sempre da una brutta esperienza nasce qualcosa di negativo. Io ho lavorato su me stessa e oggi guardo al mio futuro con fiducia”.
─ Teresa
“Sono rimasta al Villaggio SOS finché il mio compagno è stato allontanato. Una volta partito, siamo potuti tornare a casa, riprendere la nostra quotidianità, fare la pasta, le lavatrici, vedere un film insieme. Abbiamo iniziato una nuova vita. Oggi mi sento una donna nuova e i miei bambini stanno bene”.
─ Fernanda

LA TUA FIRMA CAMBIA LA VITA DEI BAMBINI RIMASTI SOLI
INSERISCI IL CODICE FISCALE
80017510225
a te i bambini saranno seguiti da un educatore nel proprio percorso scolastico
Grazie a te i bambini potranno superare i traumi subiti e ritrovare la fiducia in se stessi e negli altri
NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Con il tuo 5x1000, ci aiuti ad assicurare protezione, accoglienza e sostegno a 900 persone in Italia, tra bambini, ragazzi e famiglie.
Nella tua dichiarazione dei redditi firma in favore di SOS Villaggi dei Bambini e resta accanto ai bambini più vulnerabili, che hanno perso o rischiano di perdere le cure della loro famiglia.

L’Industria Meccanica
Pubblicazione periodica di ANIMA/Confindustria
Registrazione Tribunale di Milano N.427 del 17.11.73

L’EXECUTIVE SEARCH SARTORIALE E INNOVATIVA
Direttore responsabile
Alessandro Durante – durante@anima.it
Direttrice editoriale
Lucrezia Benedetti – benedetti@anima.it
Comitato tecnico-scientifico
Pierangelo Andreini, Antonio Calabrese, Roberto Camporese, Alessandro Clerici, Rodolfo De Santis, Marco Fortis, Ennio Macchi, Giovanni Riva, Pietro Torretta, Giuseppe Zampini, Marco Dall'Ombra, Armando Carravetta, Giovanni Di Bartolomea, Stefano Casandrini, Marco Manchisi
In redazione
Simone Gila – gila@anima.it
Antonio Passarelli – passarelli@anima.it
Davide Rosti - rosti@anima.it
Federica Dellisanti – dellisanti@anima.it (segreteria di redazione)
In copertina
Lucrezia Viperina - lucrezia.viperina@gmail.com
Impaginazione
Alessio Monzani – hello@alessiomonzani.com
Raccolta pubblicitaria
Simonetta Galletti – adv@anima.it
Direzione e redazione
ANIMA Confindustria Meccanica Varia Via Scarsellini 11/13 – 20161 Milano Tel. 02 45418.500 – Fax 02 45418.545 www.anima.it – anima@anima.it Online: www.industriameccanica.it | X: @IndMeccanica |
Instagram: @industriameccanica
Gestione, amministrazione, abbonamenti e pubblicità
A.S.A. Azienda Servizi ANIMA S.r.l. Via Scarsellini 11/13 – 20161 Milano – Tel. 02 45418.500
Abbonamento annuo
Italia 80 euro – Estero 110 euro
Avvalendosi del contenuto dell’art. 74 lettera C del D.P.R. 26.10.1972 N. 633 e del D.M. 28.12.89,
A.S.A. S.r.l. non emetterà fatture relative agli abbonamenti
Stampa
New Press Edizioni srl Lomazzo (CO)
È vietata la riproduzione di articoli e illustrazioni de “L’Industria Meccanica” senza autorizzazione e senza citarne la fonte.
La collaborazione alla rivista è subordinata insindacabilmente al giudizio della Redazione.
Le idee espresse dagli autori e delle autrici non impegnano né la rivista né ANIMA Confindustria e la responsabilità di quanto viene pubblicatorimane delle autrici e degli autori stessi.

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana ROC N. 4397
Le aziende sono fatte di persone, e sono sempre le persone a fare le aziende. Scegliere i professionisti giusti è fondamentale.
W Executive è l’Executive Search sartoriale e innovativa: consulenza mirata per ogni cliente, anche grazie al W Leadership Index e W Digital Index, strumenti proprietari ad alta innovazione tecnologica, per una ricerca ancora più puntuale, sostenibile e decisiva nel tempo.
wexecutive.eu info@wexecutive.eu

Numero 743
In copertina Lucrezia Viperina
10 RUBRICA: i 400 caratteri
13 Lavoro al femminile:cresce l’occupazione, ma il gap resta profondo di Lucrezia Benedetti

16 Dazi commerciali. C’è un vincitore? di Mauro Ippolito, iBan First
21 Cala la fiducia dell’industria meccanica italiana: incertezza e margini in calo nel secondo semestre 2025 di Davide Rosti
24 Mercato USA e meccanica italiana: dazi, innovazione e nuove sfide doganali di Easyfrontier

30 Le idee fanno l’industria di Daniele Bettini

46 Novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025: la nuova formazione del datore di lavoro
di Marco Albanese, Responsabile Sicurezza Anima Confindustria
50 L’obbligo di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro
di Rolando Dubini, Avvocato Cassazionista, Foro di Milano
56 Speciale Food Tech

59 Cyber Resilience Act: la nuova sicurezza digitale per un settore sempre più connesso di Marco Carleo, Funzionario Tecnico Anima Confindustria
60 Arriva la prima norma europea per misurare i consumi delle macchine da caffè di Giorgio Beretta, Technical Manager Anima Confindustria
64 Le novità del Decreto Legislativo 19 Giugno 2025, n. 102 di Alberto Spotti, Technical Manager Anima Confindustria
66 ReMaF e nuova DWD: cosa cambia per bar, ristoranti e hotel di Elisabetta Orlando, Sales Support ICIM SpA
68 Acqua del rubinetto, fiducia in crescita di Giusy Palladino, Association Manager Aqua Italia
70 La finitura nel mondo del food. Funzione, estetica e sicurezza per una filiera più competitiva di Manuela Casali, Association Manager UCIF
76 RUBRICA: Tecnologia, novità da tenere d'occhio
81 Tabelle ANIMA: Bianche, Blu, Arancio
Ricerca
Motori di ricerca e media tradizionali più affidabili dei social
Un recente studio internazionale su 23 mercati conferma che i motori di ricerca e i media tradizionali sono ancora le fonti di informazione più affidabili per la maggioranza degli utenti. Il 61% degli intervistati dichiara di avere maggiore fiducia in queste piattaforme rispetto ai social media, spesso considerati meno attendibili, specialmente per notizie di attualità e politica. Questo dato riflette la crescente consapevolezza dell’importanza della verifica delle fonti in un contesto caratterizzato da disinformazione e fake news.
Trend
Cresce la domanda di cibi sostenibili e tracciabili
Secondo un recente report di NielsenIQ, il 68% dei consumatori a livello globale preferisce acquistare alimenti prodotti con metodi sostenibili e con una chiara tracciabilità degli ingredienti. La pandemia ha accelerato l’attenzione verso la qualità e la sicurezza alimentare, con una crescente richiesta di prodotti biologici e a basso impatto ambientale. Il trend è particolarmente forte tra i giovani e le famiglie, che considerano la sostenibilità un criterio decisivo di acquisto. Le aziende stanno quindi investendo in filiere trasparenti e certificazioni per rispondere a questa domanda in crescita.
Ecologia
Riduzione degli sprechi alimentari: nuove strategie e tecnologie
Lo spreco alimentare rappresenta un problema globale: ogni anno si getta un terzo del cibo prodotto, con pesanti impatti ambientali ed economici. Un report della FAO evidenzia come l’adozione di tecnologie innovative, come l’intelligenza artificiale per la gestione delle scorte e i packaging intelligenti, stia contribuendo a ridurre le perdite lungo la filiera. Inoltre, sempre più aziende e consumatori si impegnano in iniziative di redistribuzione e donazione. Ridurre lo spreco è diventato un imperativo per migliorare la sostenibilità del settore agroalimentare.
Energia
Transizione energetica: boom degli investimenti nelle rinnovabili
Il settore energetico sta vivendo una svolta epocale: nel 2024, gli investimenti globali in energie rinnovabili hanno superato per la prima volta quelli nei combustibili fossili, con una crescita del 12% rispetto all’anno precedente, secondo l’International Energy Agency (IEA). L’aumento è guidato dalla domanda di elettricità verde e dalle politiche governative di decarbonizzazione. Solare, eolico e idroelettrico dominano il mercato, mentre si intensifica la ricerca su batterie più efficienti e reti intelligenti. Questa transizione rappresenta un pilastro chiave per raggiungere gli obiettivi climatici entro il 2030.

Trend
Google Search perde terreno tra giovani e adulti USA
Un sondaggio condotto da Vox Media rivela che il 42% degli adulti statunitensi percepisce Google Search come meno utile rispetto al passato. Tra i giovani della Gen Z, il 61% preferisce utilizzare chatbot basati su intelligenza artificiale per cercare informazioni, mentre il 52% si affida a piattaforme alternative come TikTok. I Millennials mostrano una tendenza simile, con il 53% che sceglie metodi diversi dai motori di ricerca tradizionali. Questo cambiamento segna una trasformazione nel modo in cui le nuove generazioni cercano e consumano informazioni.

Tecnologia
Lavoratori USA preoccupati per l’impatto dell’IA sul lavoro
Il report AI Disruption 2025 di Resume Now evidenzia che l’89% dei lavoratori statunitensi teme per la propria sicurezza lavorativa a causa della crescente diffusione dell’intelligenza artificiale. Il 43% conosce persone già state licenziate o sostituite da tecnologie automatizzate. Le preoccupazioni sono particolarmente forti nei settori impiegatizi, customer service e attività ripetitive, dove l’automazione è più diffusa. Le aziende sono chiamate a gestire la transizione con programmi di formazione e supporto al personale.
Lavoro al femminile: cresce l’occupazione, ma il gap resta profondo
Negli ultimi anni l’occupazione femminile in Italia ha registrato segnali positivi, ma il divario con gli uomini e con la media europea resta ancora profondo. Secondo quanto riportato da un’analisi congiunta CNEL-ISTAT “Il lavoro delle donne tra ostacoli e opportunità”, il tasso di occupazione femminile è aumentato di 6,4 punti percentuali tra il 2008 e il 2024, ma permane una distanza strutturale rispetto agli altri Paesi europei.
Nello stesso periodo, ad esempio, l’occupazione femminile nella fascia over 50 è cresciuta di quasi 20 punti, mentre tra le giovani tra i 25 e i 34 anni l’incremento si è fermato appena a 1,4 punti. Un dato che suggerisce quanto le difficoltà per le donne in età fertile siano ancora molto forti, probabilmente legate al tema della maternità e alla carenza di politiche di conciliazione tra lavoro e vita privata.
Secondo l’ISTAT, nel primo trimestre 2025 il tasso di occupazione complessivo è salito al 62,5%, con un aumento tendenziale di 432mila occupati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, a fronte di questo miglioramento generale, la composizione del mercato del lavoro continua a penalizzare le donne: solo il 53,9% delle occupate ha un impiego “standard”, ossia stabile o autonomo con dipendenti, mentre per gli uomini la percentuale sale a circa il 70%. La vulnerabilità occupazionale colpisce in particolare le giovani, le donne del Sud e quelle con basso livello di istruzione.
A preoccupare è anche la persistenza del part-time involontario, che riguarda una larga fetta della forza lavoro femminile, con ricadute negative in termini di reddito, carriera e pensione futura. In un contesto in cui la crescita dell’occupazione femminile è fondamentale per sostenere l’economia e contrastare il calo demografico, il su-
peramento di questi ostacoli dovrebbe diventare una priorità. Il divario con la media europea, che si attesta intorno ai 12,6 punti percentuali, rende evidente quanto lavoro resti ancora da fare. È necessario investire in politiche attive del lavoro, welfare familiare e parità salariale per costruire un mercato del lavoro più equo e inclusivo.
di Lucrezia Benedetti

Dazi commerciali. C’è un vincitore?
di Mauro Ippolito – iBan First

L’accordo siglato ad agosto tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti ha posto la fine delle tensioni sui dazi commerciali avviate con l’insediamento del presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Se da un lato gli accordi hanno messo fine ad un’incertezza legata al commercio transatlantico, dall’altro lato hanno aperto un nuovo capitolo nelle relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea. Ma prima di analizzare questo nuovo accordo e gli effetti politici che ne conseguono, bisogna fare un passo indietro per capire il perché si è arrivati a questo dopo mesi di tensioni.
La decisione da parte della Commissione Europea di sedersi al tavolo con gli Stati Uniti è stata determinata dall’accordo sui dazi siglato a fine luglio tra Giappone e Stati Uniti. Questo prevede imposte sull’export giapponese verso gli Stati Uniti al 15%, in calo rispetto al 25% precedentemente minacciato da Trump, in cambio di investimenti per 550 miliardi di dollari da parte del Giappone negli USA.
Il Giappone ha inoltre accettato di aprire il proprio mercato all’importazione di prodotti agricoli americani, in particolare il riso, e di firmare una joint venture per un progetto di gas naturale liquefatto (GNL) in Alaska. Tuttavia, è riuscito a includere nell’accordo anche il settore automotive, che da solo rappresenta un quarto dell’export giapponese verso gli Stati Uniti, ottenendo un notevole sconto rispetto al
27,5% di tariffe precedenti.
Dopo questo accordo, l’Europa ha compreso i margini di manovra con l’amministrazione Trump e ha proposto un incontro con gli Stati Uniti. Ursula von der Leyen ha presentato una proposta finale: l’Europa accetta una tariffa minima del 15% sulle importazioni statunitensi di prodotti europei, con alcune eccezioni. La regola prevede che, se il dazio storico è inferiore al 15%, venga portato a tale soglia; se è già pari o superiore, resta invariato. L’aliquota media, che era del 4,8%, viene così triplicata.
Un dato positivo è l’inclusione del settore automotive nell’accordo, con una nuova aliquota fissata al 15%, una riduzione rispetto alle minacce del 27,5%. La misura ha effetto retroattivo dal 1° agosto 2025.
Il Giappone ha accettato di aprire il proprio mercato all’importazione di prodotti agricoli americani, in particolare il riso, e di firmare una joint venture per un progetto di gas naturale liquefatto (GNL) in Alaska. È riuscito ad includere nell’accordo anche il settore automotive, che da solo rappresenta un quarto dell’export giapponese verso gli Stati Uniti, ottenendo un notevole sconto rispetto al 27,5% di tariffe precedenti
Concessioni, critiche e divisioni interne
Nonostante l’accordo, per l’Europa è difficile festeggiare. La Commissione Europea ha presentato l’intesa come un successo diplomatico, offrendo “certezza” e “prevedibilità” alle imprese. Tuttavia, una lettura attenta evidenzia ampie concessioni agli Stati Uniti. Von der Leyen ha definito Trump “un negoziatore duro ma un dealmaker”, sottolineando che il 15% era “il massimo ottenibile” per garantire stabilità. Antonio Tajani ha dichiarato che si tratta del miglior accordo possibile in quel momento.
L’Europa ha dovuto accettare impegni finanziari e strategici pesanti: l’acquisto di 750 miliardi di dollari in prodotti energetici americani (GNL e petrolio), investimenti per 600 miliardi di dollari nell’economia statunitense (con settori e tempistiche non chiariti), e l’acquisto di equipaggiamenti militari americani per centinaia di miliardi, in parte destinati a Kiev. Inoltre, è stata decisa la cancellazione dei dazi su tutti i beni industriali statunitensi, con una perdita stimata di 4,6 miliardi di euro all’anno in entrate doganali.
L’Unione Europea è apparsa divisa. Sebbene fosse pronta una lista di contro-dazi da 93 miliardi di euro, la mancanza di unanimità tra i Paesi membri ha impedito una risposta compatta. Francia e Spagna spingevano per una linea dura, mentre Germania e Italia, fortemente orientate all’export, preferivano una soluzione negoziata. Questa frammentazione e la competizione tra Stati membri per la leadership hanno indebolito la posizione europea, portando ad accettare un accordo definito da molti come un “compromesso” o una “resa totale”. Alcuni lo hanno etichettato come “profondamente asimmetrico” e “squilibrato”.
Conseguenze economiche e geopolitiche
Per l’Italia, il conto è particolarmente pesante. Secondo studi di Confindustria e Confcommercio, le perdite economiche previste sono tra 6,5 e 22 miliardi di euro, ovvero tra il 10% e il 30% dell’export verso gli USA. Si stima un rischio occupazionale fino a 100.000 posti di lavoro. L’Italia espor-

L’Europa, firmando l’accordo con gli USA, ha dovuto accettare impegni finanziari e strategici pesanti: l’acquisto di 750 miliardi di dollari in prodotti energetici americani (GNL e petrolio), investimenti per 600 miliardi di dollari nell’economia statunitense (con settori e tempistiche non chiariti), e l’acquisto di equipaggiamenti militari americani per centinaia di miliardi, in parte destinati a Kiev. Inoltre, è stata decisa la cancellazione dei dazi su tutti i beni industriali statunitensi, con una perdita stimata di 4,6 miliardi di euro all’anno in entrate doganali
CALA LA FIDUCIA DELL’INDUSTRIA MECCANICA ITALIANA: INCERTEZZA
E MARGINI IN CALO
NEL SECONDO SEMESTRE 2025
ta verso gli Stati Uniti circa il 10% del proprio export totale, primo mercato extra UE.
L’obiettivo delle misure americane, però, non sembra essere la correzione del deficit commerciale, che è legato a problemi interni come gli interessi sul debito USA, saliti al 20% del debito stesso. La prima amministrazione Trump ha già dimostrato che i dazi non riducono il deficit commerciale, ma gravano su consumatori e imprese americane attraverso l’aumento dei prezzi. I dazi sembrano piuttosto essere strumenti di pressione geoeconomica, parte della strategia chiamata “escalate to de-escalate”.
Parallelamente, gli Stati Uniti hanno eliminato l’esenzione doganale “de minimis” per spedizioni sotto gli 800 dollari, a partire dal 29 agosto 2025. Questo vale per tutte le merci in arrivo da Paesi esteri, giustificato con motivi di sicurezza nazionale e per frenare l’importazione illegale di fentanyl. Sebbene non direttamente collegata all’accordo con l’UE, è parte della stessa agenda protezionistica americana.
In conclusione, se si volesse tracciare una linea tra vincitori e vinti, gli Stati
Uniti sembrano aver ottenuto il maggior vantaggio. Le concessioni europee, in particolare nel settore energetico e militare, indicano una posizione più debole. Gli USA hanno protetto settori strategici (acciaio, alluminio) e aperto la strada per eliminare barriere normative europee su prodotti agricoli e automotive. Per l’Europa, si tratta di un “male minore”, accettato per evitare uno scontro diretto in un momento delicato anche sul piano geopolitico, segnato dalla crisi ucraina e dall’assenza di aiuti militari americani.
La guerra dei dazi ha mostrato ancora una volta la fragilità dell’Unione Europea nel prendere decisioni comuni. I Paesi membri hanno difeso i propri interessi nazionali, dimostrando l’incapacità di parlare con una voce sola. Lo scopo geopolitico degli Stati Uniti di dividere l’Europa sembra, almeno in parte, riuscito.
In definitiva, non ci sono veri vincitori. La guerra dei dazi rappresenta un fallimento del libero mercato e avrà ricadute negative sui consumatori e sull’economia globale, con il rischio di un rallentamento dei flussi commerciali mondiali.
di Davide Rosti
Nel secondo semestre del 2025, le imprese italiane della meccanica si trovano ad affrontare uno scenario difficile; ad evidenziarlo l’ultima indagine condotta dall’Ufficio studi di Anima Confindustria, che restituisce un quadro di progressiva fragilità per il settore. Le previsioni di molte aziende parlano apertamente di un calo del fatturato, con circa una su quattro che stima una riduzione superiore al 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita appare un’ipotesi lontana, frenata da un mercato ancora instabile e da criticità operative sempre più pressanti.
Le esportazioni, da sempre uno dei motori più solidi per la meccanica italiana, mostrano segnali di contrazione. Secondo il sondaggio, solo una piccola parte del campione prevede un aumento significativo delle vendite all’estero, mentre prevalgono stime di stagnazione o di lieve calo. In particolare, il 27,5% delle aziende segnala la possibilità di un arretramento dell’export fino al 5%. Il rallentamento della domanda internazionale continua dunque a pesare sulle prospettive di crescita, soprattutto nei mercati storicamente rilevanti per il comparto.
Un altro nodo critico riguarda i margini, che risultano in sofferenza per oltre la metà delle imprese intervistate. In
molti casi si parla di una riduzione superiore al 5% nell’ultimo anno. Solo una minoranza ha riscontrato miglioramenti. Tra le cause principali vengono indicati l’aumento dei costi energetici, l’instabilità delle materie prime e le crescenti tensioni geopolitiche, fattori che stanno comprimendo la redditività e limitando la capacità di investimento delle aziende. La pressione esterna è sempre più forte: l’instabilità politica internazionale, i conflitti in corso e le tensioni commerciali tra grandi potenze economiche rendono difficile garantire la regolarità delle forniture e la prevedibilità dei costi, mettendo a dura prova la gestione operativa del settore.
«Nell'attuale scenario la meccanica italiana è stretta in una morsa caratterizzata da un lato dall'incertezza geopolitica, che pesa sulle previsioni di crescita, dall'altro lato pesano l'imprevedibile postura statunitense e l’instabilità del governo francese. I dazi sui prodotti in acciaio al 50% imposti dal governo americano danno un ulteriore colpo alla nostra bilancia commerciale negli Usa, che ricordiamo essere stata la prima meta di destinazione della meccanica rappresentata da Anima nel 2024. Tutti questi fattori generano una crescente preoccupazione nelle imprese, soprattutto sul fronte dell’export e per le quali tutto ciò si traduce in una riduzione degli scambi commerciali con l’estero. Ma a preoccupare di più è il calo della marginalità per la maggior parte delle aziende della meccanica rappresentata da Anima, causato principalmente da un aumento dei costi di produzione»
In questo contesto, il presidente di Anima Confindustria, Pietro Almici, ha espresso grande preoccupazione «Nell'attuale scenario la meccanica italiana è stretta in una morsa caratterizzata da un lato dall'incertezza geopolitica, che pesa sulle previsioni di crescita, dall'altro lato pesano l'imprevedibile postura statunitense e l’instabilità del governo francese. I dazi sui prodotti in acciaio al 50% imposti dal governo americano danno un ulteriore colpo alla nostra bilancia commerciale negli Usa, che ricordiamo essere stata la prima meta di destinazione della meccanica rappresentata da Anima nel 2024. Tutti questi fattori generano una crescente preoccupazione nelle imprese, soprattutto sul fronte dell’export e per le quali tutto ciò si traduce in una riduzione degli scambi commerciali con l’estero. Ma a preoccupare di più è il calo della marginalità per la maggior parte delle aziende della meccanica rappresentata da Anima, causato principalmente da un aumento dei costi di produzione».
Secondo Almici, è urgente invertire la rotta. «L'Ue ha inseguito per anni una politica di "idee", senza promuovere realmente il comparto manifatturiero locale. A questo va aggiunto il recente accordo con gli Stati Uniti, i cui termini prevedono centinaia di miliardi di euro diretti oltreoceano. Ora è tempo di arretrare da questa impostazione della politica economica e capire se veramente le istituzioni europee hanno la volontà di supportare le nostre imprese. Per cambiare direzione è necessario rivolgere un appello alle istituzioni, al fine di supportare il comparto manifatturiero e tutelare la produzione e il commercio dei nostri prodotti». In uno scenario globale sempre più complesso, il comparto della meccanica italiana guarda al futuro con preoccupazione, in attesa di risposte concrete dalle istituzioni europee e nazionali. Senza un piano di sostegno strutturale, le prospettive per la seconda metà dell’anno restano incerte, con un settore che rischia di perdere slancio proprio mentre si gioca la partita della transizione tecnologica ed ecologica.
Pietro Almici, Presidente Anima Confindustria
MERCATO USA E MECCANICA ITALIANA:
DAZI, INNOVAZIONE
E NUOVE SFIDE DOGANALI
di Easyfrontier
Il mercato statunitense rappresenta da sempre un orizzonte strategico per la meccanica italiana, tuttavia l'accesso a questo sbocco commerciale non è mai stato esente da complessità doganali. Negli ultimi anni, l’HTSUS (la tariffa doganale applicata dagli Stati Uniti) è stata oggetto di interventi sempre più frequenti, utilizzati come veri e propri strumenti di politica commerciale: tale cambio di paradigma ha trasformato i dazi da una semplice voce di costo a una variabile strategica, capace di ridefinire le catene di fornitura e la competitività stessa delle imprese esportatrici.
Per chi opera nel settore meccanico, ciò comporta che la valutazione di impatto che i dazi imposti a destino possono avere nelle transazioni internazionali, non può limitarsi alla verifica della voce tariffaria applicabile al prodotto finito, ma deve includere un’analisi complessiva che tenga conto di misure straordinarie, dell’origine dei componenti e di possibili revisioni regolamentari. In tale contesto, la pianificazione doganale diventa parte integrante della strategia commerciale e industriale.
Il quadro tariffario statunitense è oggi caratterizzato da una combinazione di regole ordinarie e misure specifiche. I dazi “di base” si applicano seguendo il trattamento della c.d. Most Favoured Nation (MFN – clausola della nazione più favorita), previsto nell'ambito della WTO (World Trade Organization) che assicura a tutti i Paesi, tra cui l'Unione, aliquote generalmente contenute. Per i macchinari industriali, il dazio MFN si colloca mediamente tra lo 0% e il 5%.
Le misure specifiche sono state adottate sulla base di diverse tipologie tecnico-politiche, connesse da un lato alla normativa statunitense in materia di politica commerciale e, dall’altro, a esigenze di tutela di sicurezza nazionale. L’amministrazione USA ha quindi adottato, sulla base della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962, misure per proteggere la sicurezza nazionale da importazioni che minacciano l'industria interna. Nel 2018, proprio sulla base della Section 232, l'amministrazione Trump ha imposto dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio.
A partire dal 4 giugno 2025, con una nuova Proclamazione Presidenziale, le aliquote sui prodotti in acciaio e alluminio e loro derivati, sono state aumentate al 50% ad valorem (sempre sulla base della Section 232): il dazio si applica sull’intero valore della merce per i prodotti c.d. non derivative (ad esempio una lastra grezza di acciaio, VD 7207 ) ed esclusivamente sul valore del contenuto di acciaio e alluminio per i prodotti derivative (prodotti laminati piatti rientranti nelle VD 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 o 7226).
Per prodotti derivative si intendono solo ed esclusivamente i prodotti listati nella Presidential Proclamation 9980 e non tutti i prodotti che contengono acciaio e alluminio. La merce assogget-
tata ai dazi su acciaio e alluminio deve essere accompagnata da una dichiarazione precisa e certificata del valore del contenuto di acciaio o alluminio. L'Unione è attualmente soggetta a questa nuova aliquota, a differenza del Regno Unito, che mantiene un'aliquota del 25%, peraltro, alle stesse condizioni fissate per l’UE e gli altri Paesi. Limitatamente ai prodotti derivative e non derivative che contengono alluminio russo – in qualsiasi misura – essi restano soggetti per l’intero valore del prodotto ad un’aliquota del 200%. Alla stessa aliquota, saranno assoggettati anche quei prodotti, derivative e non derivative, contenenti alluminio, per i quali non sia possibile dimostrare l’origine dell’alluminio e che l’alluminio non sia stato “smelt and cast” in Russia.
A partire dal 1° agosto 2025, è entrato in vigore, sempre sulla base della Section 232, un dazio ad valorem aggiuntivo del 50% sul contenuto di rame per una vasta gamma di prodotti rientranti nei capitoli 74 e in quattro codici del capitolo 85 dell’HTSUS. Il dazio aggiuntivo sul contenuto in rame non si applica, ad esempio a tutto il valvolame e rubinetteria (capitolo 84), né ad altri prodotti classificati nel medesimo capitolo. Il dazio si applica a prodotti come rame raffinato, leghe, semilavorati, tubi, barre e conduttori elettrici. È fondamentale
notare che l'onere fiscale è calcolato esclusivamente sul valore del contenuto di rame, mentre il valore residuo del prodotto (materiali non in rame) rimane soggetto ai dazi standard. Le dichiarazioni doganali devono quindi specificare in modo distinto il valore del contenuto in rame e il valore non in rame, applicando le rispettive aliquote.
Il 5 settembre 2025 è stato emesso l’Executive Order 14346 (“Modifying the Scope of Reciprocal Tariffs and Establishing Procedures for Implementing Trade and Security Agreements”) che ridefinisce il processo di esenzione per le tariffe delle Section 232. L'Ordine Esecutivo modifica l'Allegato II del precedente Executive Order 14257, che elencava i prodotti esentati dai dazi reciproci. Sono state aggiunte nuove esenzioni per categorie di beni considerati strategici, come alcuni minerali critici, metalli preziosi in polvere e specifici prodotti farmaceutici che sono già oggetto di indagini della Sezione 232. Allo stesso tempo, alcuni prodotti precedentemente esentati, come l'idrossido di alluminio, resine e silicone, sono stati rimossi dall'elenco e sono ora soggetti ai dazi.
Implicazioni per le imprese della meccanica
Per le imprese italiane della meccanica, in particolare per quelle che si affacciano per la prima volta sul mercato statunitense, la variabile doganale è fondamentale: la corretta classificazione tariffaria, la gestione delle regole di origine non preferenziale, l’individuazione di eventuali esenzioni e l’utilizzo degli strumenti di accertamento formale (ITV, IVO e binding ruling negli USA) rappresentano passaggi decisivi per garantire, laddove possibile, un altro grado di competitività.
In tale scenario, la compliance doganale diventa parte integrante della strategia industriale. È cruciale che la pianificazione doganale tenga conto del processo di fabbricazione e dell'origine dei singoli componenti. Un'analisi accurata e preventiva della supply chain permette di evitare dazi non previsti, trasformando la capacità di anticipare l'impatto delle regole commerciali in maggiore stabilità e competitività sui mercati.
Programmi di compliance USA: CTPAT e ACE
Oltre alla gestione strategica dei dazi, l'efficienza delle operazioni doganali negli Stati Uniti dipende sempre più dall'adesione a specifici programmi di sicurezza e semplificazione.
Il Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) è un programma di partnership volontaria promosso dal Customs and Border Protection (CBP) statunitense. Sebbene le im-
prese italiane non possano aderirvi direttamente, possono ottenere gli stessi vantaggi grazie all'accordo di Mutuo Riconoscimento (MRA) siglato tra USA e UE. Questo accordo stabilisce che le aziende europee in possesso della certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), rilasciata dalle autorità doganali UE, siano considerate equivalenti ai partner CTPAT. Per un'impresa meccanica italiana, ottenere l'attestato AEO-S (Security) o AEO-F (Full) significa essere riconosciuti come partner a basso rischio dal CBP, con conseguente riduzione dei controlli ispettivi, tempi di sdoganamento più rapidi e priorità di elaborazione in caso di interruzioni della catena logistica. Non è solo una scelta di sicurezza, ma un fattore strategico che snellisce le operazioni e rafforza la credibilità nei confronti dei clienti americani.
Un secondo pilastro è rappresentato dall'Automated Commercial Environment (ACE), un'unica piattaforma digitale sviluppata dal CBP per gestire tutte le operazioni doganali. L'ACE funge da "single window" per l'invio e la gestione di dati commerciali, consentendo a importatori, esportatori e spedizionieri di sottoporre elettronicamente tutta la documentazione necessaria per lo sdoganamento delle merci. Questo include non solo la dichiarazione di importazione (Entry Summary Declaration), ma anche la gestione dei manifesti di carico, delle licenze e delle altre informazioni richieste da circa 47 agenzie governative USA (Partner Government Agencies). Per le imprese esportatrici, l'utilizzo di ACE rende obbligatorio fornire dati completi e coerenti in formato digitale. L'integrazione dei propri sistemi gestionali con la piattaforma ACE è quindi un requisito tecnico essenziale per garantire efficienza e continuità nelle operazioni di esportazione, riducendo al minimo errori e potenziali ritardi.
Transizione digitale e dazi USA
L’utilizzo di strumenti digitali dedicati come quelli sviluppati da Easyfrontier Technologies nell’ambito della piattaforma EasyDownload e quelli messi a disposizione da altri operatori per la gestione di classifica, origine e dichiarazioni doganali, può svolgere una funzione pivotale, quantomeno in termini di certezza e verificabilità delle informazioni fornite, automazione dei processi di sdoganamento (che possono essere accelerati anche del 100%) e condivisione e accessibilità a banche dati e strumenti di accertamento di origine, classifica e valore.
La transizione digitale, che interessa l'intera filiera della meccanica, si estende anche alla gestione delle operazioni doganali: i dati commerciali e tecnici, che un tempo venivano trattati in modo frammentario, diventano oggi una risorsa strategica da gestire in maniera integrata e in tempo reale. L'adozione di soluzioni digitali per la compliance doganale permette di automatizzare processi, ridurre il rischio di errori umani che possono portare a sanzioni e ottimizzare i costi operativi. Più che un semplice adeguamento tecnologico, la digitalizzazione della logistica e della compliance doganale si configura come un fattore di competitività, posizionando le aziende come partner affidabili in mercati complessi come quello statunitense.
Il "nuovo" della meccanica si esprime non solo nell'innovazione tecnologica dei prodotti o nella trasformazione digitale dei processi produttivi, ma anche nella capacità di affrontare scenari doganali sempre più articolati. Per le imprese associate ad Anima Confindustria è attivo il servizio Dogana Facile, che potrà fornire indicazioni e soluzioni sia in merito alle tematiche connesse a dazi e restrizioni nel commercio internazionale sia in materia di snellimento delle procedure doganali.
EASYDOWNLOAD: LA DOGANA DIGITALE
IN UN CLICK
La leva digitale per gestire la dogana
In un contesto industriale sempre più integrato con i mercati internazionali, una gestione efficiente e tracciabile delle operazioni doganali rappresenta una leva fondamentale per le imprese della meccanica che operano con l’estero.
Per questo, Easyfrontier, società di consulenza specializzata in materia doganale e partner tecnico del servizio Dogana Facile di Anima Confindustria, ha sviluppato EasyDownload, una soluzione software pensata per semplificare e ottimizzare la gestione delle dichiarazioni doganali elettroniche.
Con EasyDownload, le aziende possono accedere direttamente alla documentazione doganale, senza doverla richiedere a soggetti terzi come trasportatori, spedizionieri o corrieri espresso.

Il Visto uscire a portata di mano
Funzionalità tecniche
Il software dispone di numerose funzionalità tecniche, che permettono di:
• recuperare in autonomia le dichiarazioni doganali in formato .xml presenti sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM);
• consultare facilmente a video i dati principali delle dichiarazioni (MRN, data, classificazione doganale, ecc.);
• scaricare le dichiarazioni in formato .pdf o i dati in esse contenuti in formato .xls o .csv;
• scaricare massivamente tutti i documenti doganali con un solo click;
• conservare e archiviare i file in qualsiasi modalità;
La versione Silver del software consente, inoltre, di scaricare, in formato .xml e .pdf, il visto uscire elettronico (Ivisto), un documento necessario per la corretta gestione delle esportazioni. Lo strumento permette, pertanto, di ottenere una visione completa e aggiornata dei flussi doganali, rafforzando il controllo sulle attività di import e di export, al fine di garantire una corretta compliance normativa.
Grazie alle sue funzionalità in continua evoluzione, EasyDownload è la scelta ideale per una dogana più smart, controllata e integrata nei processi aziendali.

PER INFORMAZIONI:
Carmela Massaro - Responsabile Dogana Facile ANIMA Confindustria, Via Scarsellini 13, Milano Tel. 02.45418305 E-mail: massaro@anima.it

Le idee fanno l’industria

L’Italia importa oggi oltre il 90% delle materie prime critiche necessarie alla sua manifattura avanzata, con un tasso di raccolta dei RAEE fermo al 30% contro il 65% richiesto dall’Europa. Una dipendenza che mette a rischio settori ad alto valore aggiunto come aerospazio, robotica, semiconduttori ed elettromedicale, e che rischia di rallentare la transizione ecologica. Eppure, nei rifiuti e nelle risorse naturali del Paese si nasconde una parte importante della risposta.
Lo dimostra lo studio realizzato da TEHA e Iren, secondo cui con 1,2 miliardi di investimenti l’Italia potrebbe tagliare del 31% le importazioni entro il 2040. Una sfida che passa da tre leve decisive: aumentare la raccolta e il trattamento dei RAEE, sviluppare impianti innovativi di raffinazione e riciclo e creare un mercato domestico delle materie prime seconde. È in questa direzione che si muove Iren, con progetti come il nuovo impianto in Valdarno per il recupero di oro, argento, rame e palladio dalle schede elettroniche, o l’osservatorio RigeneRare che punta a mappare e condividere i dati sulla filiera.
Accanto ai grandi player, un tessuto di startup e PMI italiane e mondiali sta trasformando l’urban mining in realtà industriale. AraBat utilizza bucce d’arancia e scarti agricoli
per estrarre litio e cobalto da batterie esauste; RarEarth recupera terre rare dai motori elettrici di scooter e monopattini; f3nice ricava da rottami metallici polveri per la stampa 3D, riducendo del 70% le emissioni rispetto ai processi convenzionali. Un movimento in crescita che, dalle discariche ai laboratori high-tech, sta dimostrando come l’innovazione possa ridisegnare l’approvvigionamento di materie prime.
Parallelamente, la bioeconomia circolare si afferma come altro grande pilastro industriale: in Italia vale già quasi 450 miliardi di euro, pari al 10% del PIL, e rappresenta il 14% del totale europeo. Bioplastiche, biocarburanti, materiali bio-based per edilizia, automotive e cosmesi stanno sostituendo derivati fossili e materie critiche, generando occupazione e rilancio territoriale. Il settore, tuttavia, chiede una governance più stabile e strumenti normativi adeguati per sprigionare appieno il suo potenziale.
Insieme, questi percorsi delineano una traiettoria chiara: l’Italia può rafforzare la propria autonomia industriale e competitività ripensando il valore dei rifiuti e delle risorse rinnovabili. Un cambio di paradigma che intreccia ricerca, impianti industriali, startup e bioeconomie territoriali, con l’obiettivo di trasformare scarti e sottoprodotti in asset strategici per il futuro.

La bioeconomia circolare si afferma come altro grande pilastro industriale: in Italia vale già quasi 450 miliardi di euro, pari al 10% del PIL, e rappresenta il 14% del totale europeo
di Daniele Bettini
Materie prime:
l’Italia spreca i suoi RAEE, ma il litio geotermico può cambiare la partita
Solo il 30% dei rifiuti elettronici viene raccolto e oltre il 90% dei materiali più preziosi prende la via dell’estero. Lo studio Iren–TEHA denuncia i colli di bottiglia della filiera nazionale, ma apre anche scenari di rilancio: dall’urban mining al litio nascosto sotto i nostri territori, fino a un’industria del riciclo in grado di ridurre del 31% le importazioni entro il 2040. Una sfida che l’Italia non può più rinviare. Ne parliamo con Nicolò Serpella, Senior Professional, Area Energy e Utility TEHA Group.
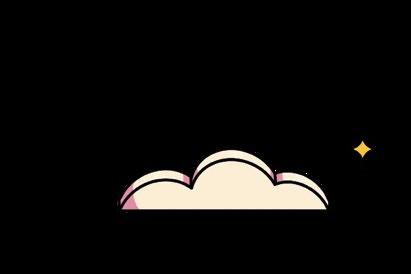
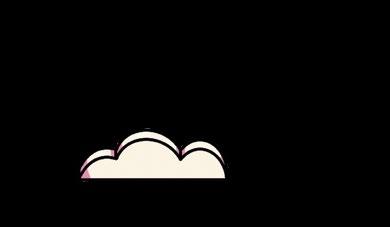
Uno dei temi chiave è lo scale-up industriale: che ruolo possono giocare i centri studi e di scenario come TEHA nel far dialogare ricerca, imprese e policy-maker su questi fronti? Dove si rompe oggi la catena tra tecnologia disponibile, investimenti e attuazione normativa?
«Sul fronte RAEE, il vero collo di bottiglia è a monte: in Italia la raccolta si è fermata al 30% (contro un target europeo del 65%), con procedure d’infrazione già avviate e una dotazione impiantistica insufficiente nelle fasi avanzate» risponde così alla nostra prima domanda Nicolò Serpella, Senior Professional, Area Energy e Utility TEHA Group «Ne deriva, aggiunge, che oltre il 90% delle frazioni a maggior valore lascia il Paese dopo un pre-trattamento meccanico, senza consolidare una filiera nazionale delle materie prime seconde (MPS). La priorità indicata dal nostro ultimo Studio Strategico (la roadmap italiana per le materie prime critiche: proposte operative per sostenere la competitività industriale del paese e le opportunità offerte dalle materie prime critiche) è far crescere volumi e qualità della raccolta,
ambito in cui l’IA può essere una leva interessante per migliorare il tracciamento dei rifiuti raccolti». Parallelamente, occorre sviluppare impianti “innovativi” e creare un mercato domestico delle MPS (criteri end-of-waste, stimoli all’impiego), per promuovere l’economia circolare dei RAEE. In parallelo, il “green mining” nei giacimenti dismessi è un’opzione praticabile se supportata da una mappatura aggiornata della disponibilità di materie prime nei giacimenti in Italia e procedure di autorizzazione stabili. Lo Studio sottolinea il potenziale di estrazione di litio da salamoie geotermiche come opportunità per il Paese, con concentrazioni rilevanti nel corridoio Lazio–Toscana–Campania e progetti in sviluppo nell’area di Cesano.

Una criticità della catena riguarda gli investimenti in capacità di raffinazione e processing delle materie prime, in cui l’Europa registra una quota limitata di investimenti rispetto ai competitor. Senza una specializzazione domestica nel processing, l’estrazione o l’urban mining non si traducono in autonomia di filiera. La Roadmap suggerisce di individuare aree di specializzazione (ad esempio in connessione al potenziale del litio geotermico) e di coordinare a livello UE per non disperdere economie di scala. Nel percorso di scale-up industriale, centri studi come TEHA possono giocare un ruolo chiave per individuare ambiti industriali e di policy su cui è prioritario intervenire per promuovere l’economia circolare in Italia e il dialogo tra centri di ricerca, imprese e policy-maker in modo tale da convergere su priorità condivise. Infatti, le attività di analisi come le nostre quantificano esposizione e dipendenza del sistema produttivo dalle materie prime critiche, mappando dove si genera valore e dove si annidano i colli
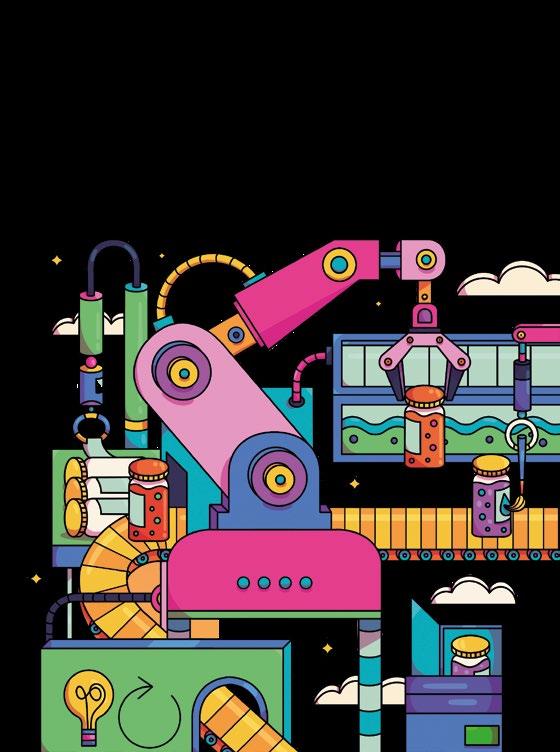

di bottiglia. La metodologia dello Studio con Iren mira proprio a questo: integrazione di quadro normativo europeo e nazionale, individuazione di best practices, analisi della dipendenza industriale italiana di materie prime grezze e semilavorati e la valutazione della produzione “a rischio” e di filiere strategiche in cui l’approvvigionamento di CRM (critica row material) risulta essenziale.
Quali Paesi esteri — europei o extraeuropei — offrono i modelli più utili da cui prendere spunto per costruire una filiera nazionale delle CRM? Germania, Francia e i grandi player asiatici sembrano aver imboccato strade diverse. Qual è la più adatta all’Italia?
Guardando ai modelli esteri, si delineano tre approcci da cui l’Italia può attingere in modo selettivo. Germania e Francia stanno spingendo su una catena integrata — dall’estrazione al riciclo — con un focus esplicito sulla circolarità e una forte concentrazione dei nuovi progetti europei di raffinazione del litio proprio nei loro ecosistemi industriali (oltre 20 iniziative in UE, con cluster in Germania e Francia). Al polo opposto, la Finlandia dimostra una forte specializzazione nel processing: oggi raffina una quota rilevante del fabbisogno europeo di cobalto e, grazie a processi avanzati, evidenzia anche un vantaggio ambientale rispetto a competitor extra-UE. È la prova che ancorare la filiera sul mid-stream vicino ai mercati finali riduce rischio, tempi logistici e opacità sugli standard ambientali. Una terza via è quella del Giappone, imperniata su una regia pubblico-industriale stabile (JOGMEC): supporto finanziario lungo l’intera catena, partenariati esteri e stockpiling selettivo; un modello pensato per economie manifatturiere aperte che devono compensare l’assenza di risorse domestiche con capacità di trasformazione e strumenti di garanzia. Sullo sfondo, la dominanza cinese nelle fasi di processing resta il discrimine strategico: senza una risposta coordinata su investimenti e specializzazioni europee, la dipendenza persiste.
Per l’Italia, lo Studio con Iren sottolinea la priorità di capitalizzare il nostro know-how chimico-metallurgico — puntando su processing e raffinazione da sviluppare parallela-

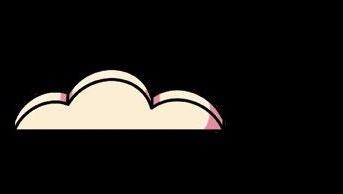
mente alla capacità estrattiva in materie prime strategiche su cui l’Italia può valorizzare un potenziale estrattivo rilevante, come ad esempio il litio geotermico. Fondamentale sarà anche coordinare questa strategia con urban mining e un mercato domestico delle materie prime seconde, in modo tale da valorizzare le CRM contenute nei RAEE che ad oggi vengono esportate all’estero. A questo va affiancata una politica estera industriale coerente: partnership mirate – anche nel quadro Piano Mattei e degli accordi già siglati con Francia e Germania — per co-sviluppare prime lavorazioni in loco, allineando sostenibilità e sicurezza degli approvvigionamenti.
Quanto è concreta — nei numeri — la possibilità di ridurre le importazioni italiane grazie allo sviluppo interno di filiere e tecnologie di riciclo?
Il vostro studio parla di un taglio del 31% con 1,2 miliardi di investimenti entro il 2040. Ci sono scenari alternativi? Qual è, oggi, lo scenario “realistico” e quello “ottimistico”?
Una delle leve principali per ridurre le importazioni italiane è l’urban mining: oggi solo il 30% dei RAEE è raccolto correttamente e oltre il 90% delle componenti a maggior valore viene esportato dopo un pre-trattamento, segno di una filiera che non è adeguata a valorizzare il contenuto delle materie prime critiche nei RAEE. L’uso delle materie prime seconde nel manifatturiero è una condizione abilitante (anche tramite incentivi) per valorizzare tali volumi riciclati, riducendo il gap di costo rispetto alle materie prime vergini e in tal modo sostenendo lo sviluppo di una capacità industriale di riciclo delle materie prime con costi competitivi.
In questo quadro, definiremmo “realistico” il conseguimento del 31% entro il 2040 a condizione di attuare integralmente le tre leve indicate, ovvero raccolta/logistica, impianti di trattamento e mercato MPS e di ridurre l’attuale dispersione di valore post-pretrattamento; è lo scenario quantitativamente esplicitato nello Studio. Per contro, uno scenario “ottimistico” potrebbe coincidere con la piena specializzazione nel mid-stream e il riassorbimento dei flussi oggi esportati, che permetterebbe di azzerare le importazioni in alcune categorie (es. tungsteno, nichel, stagno) e di superare nettamente il 31% sui alcuni singole materie prime critiche.
Urban mining e riciclo al centro della strategia italiana
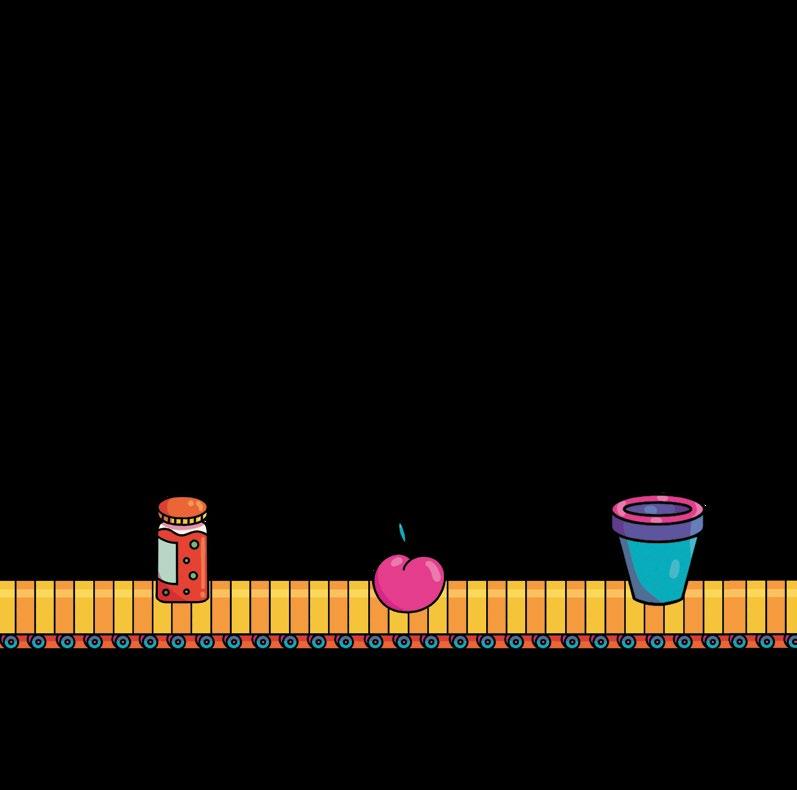
Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren, in quest’intervista evidenzia come l’Italia possa ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie prime critiche puntando sull’urban mining, sul recupero da RAEE e batterie e sulla bio-raffinazione. Settori strategici come aerospazio, robotica, semiconduttori ed elettromedicale sono i più vulnerabili, ma anche quelli che beneficerebbero maggiormente da una filiera nazionale. Restano da superare ostacoli legati a raccolta, autorizzazioni e competenze, mentre Iren si pone come attore di riferimento con progetti concreti e impianti innovativi già operativi.
Qual è oggi la strategia più efficace per ridurre la dipendenza dell’Italia dalle importazioni di materie prime critiche (CRM)? Nel documento si evidenziano quattro linee di sviluppo: estrazione, raffinazione, urban mining e partnership. Quale tra queste ha il potenziale più immediato per produrre impatti concreti nei prossimi 3-5 anni?
Le quattro linee di sviluppo indicate sono tutte fondamentali per ridurre la dipendenza dell’Europa verso l’estero. Tuttavia, l'urban mining, il processo che estrae materie prime secondarie dai rifiuti, ha a mio avviso il potenziale più immediato, grazie alla disponibilità di materie prime critiche già presenti nei flussi di rifiuti, come i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Questo approccio potrebbe essere scalato rapidamente nei prossimi 3-5 anni, poiché l'Italia ha una forte base industriale per il trattamento dei rifiuti e l'economia circolare. Nel breve-medio termine, la priorità deve essere la ricostruzione delle competenze minerarie e la promozione di un piano di esplorazione mineraria nazionale che quantifichi l’effettivo potenziale dei siti italiani.
Quali tecnologie – tra green mining, bio-raffinazione, recupero dai RAEE o altre – risultano oggi più promettenti in termini di efficienza, scalabilità e impatto ambientale? In particolare, vorremmo sapere se il recupero da RAEE e batterie può realmente coprire una parte significativa del fabbisogno italiano entro il 2030?
La bio-raffinazione e il recupero dai RAEE si dimostrano particolarmente promettenti. Il recupero da RAEE è cruciale, poiché permette di riutilizzare materiali critici come il litio, il cobalto e il rame, con un impatto ambientale ridotto rispetto all'estrazione primaria. Secondo lo studio realizzato da Iren insieme a TEHA Group, il recupero dai RAEE e dalle batterie potrebbe coprire una parte rilevante del fabbisogno italiano entro il 2030, a condizione però di migliorare i tassi di raccolta e il trattamento. Ricordiamo che l’Italia risulta il terzultimo Paese in UE per tasso di raccolta di questi materiali, con solo il 30% dei volumi raccolti rispetto ad una media europea del 46%.
Quali materie prime critiche si prestano meglio al recupero e riciclo secondo i dati attuali? Il documento cita gallio, indio, terre rare, niobio e tungsteno: sono davvero “riciclabili” su scala industriale? Quali ostacoli rimangono? qual è il risparmio in termini economici e come quantificate il "risparmio ambientale"?
Materie come rame, nichel, alluminio e terre rare sono già riciclabili su scala industriale, seppure con alcuni ostacoli legati ai processi tecnologici e alla quantità disponibile nei
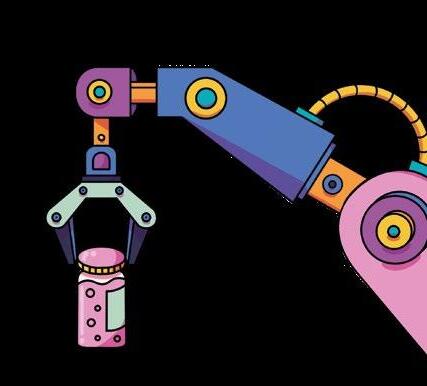
flussi di rifiuti. La sfida maggiore riguarda la bassa efficienza della raccolta dei RAEE in Italia, ma migliorando la capacità impiantistica e i sistemi di tracciabilità, il recupero di queste materie prime critiche può diventare un pilastro fondamentale. Un’altra sfida riguarda le tecnologie necessarie per recuperare tali materiali, poiché le proprietà chimiche simili tra i metalli rendono difficile una separazione efficiente. Le multiutility come IREN sono però le sole che possono indirizzare gli investimenti in questa direzione, promuovendo quindi impianti avanzati per il trattamento dei RAEE necessari per promuovere un sistema circolare, e coinvolgendo gli stakeholder pubblici e privati legati a tali filiere.
Quali sono i settori industriali italiani che si avvantaggerebbero maggiormente da una filiera nazionale delle CRM? Il focus è su settori ad alto valore aggiunto (aerospazio, robotica, semiconduttori, elettromedicale): qual è oggi la loro vulnerabilità e priorità di intervento?
I settori ad alto valore aggiunto come aerospazio, robotica, semiconduttori ed elettromedicale sono quelli che trarrebbero i maggiori benefici. La loro vulnerabilità è alta poiché dipendono da materie prime critiche come gallio, indio e tungsteno, che sono importati in volumi limitati ma essenziali per la loro produzione. Per esempio, un potenziale blocco delle importazioni di gallio e indio, con solo 90 tonnellate importate per un valore di 5,7 milioni di euro, potrebbe mettere a rischio quasi 16 miliardi di Euro di produzione nei settori della robotica e dei semiconduttori.
A che punto è realmente l’Italia nella roadmap delle CRM? Quali sono i player industriali e territoriali più avanzati e quali mancano all’appello? Sono citati im-
pianti pilota, progetti geotermici, giacimenti dismessi: quali sono i progetti già finanziati e operativi? Quale Paese ha già percorso questa strada con successo, ci si può ispirare a qualcuno in questo senso?
L'Italia ha fatto progressi significativi, ma sono ancora necessari investimenti in infrastrutture e competenze. L'approvazione del Decreto Materie Prime Critiche nel 2024 rappresenta un passo importante, ma la creazione di impianti pilota e l'attivazione di progetti strategici sono ancora in fase di sviluppo e, inoltre, i finanziamenti attualmente messi in campo sono ancora ridotti per poter pensare a una strategia di accelerazione strutturale della filiera. Guardando oltre i confini nazionali, il Giappone rappresenta sicuramente un caso studio, con l’istituzione di un ente governativo per la sicurezza dei metalli e dell’energia (JOGMEC) che sostiene le imprese attive nella raffinazione e del processing delle CRM. In Europa, Francia e Germania hanno istituito fondi specifici per rafforzare l'intera supply chain delle Materie Prime Critiche.
Il documento stima che 1,2 miliardi di euro di investimenti potrebbero ridurre la dipendenza italiana del 31% entro il 2040. È una stima realistica? Come si distribuiscono questi investimenti tra impianti, ricerca, esplorazione e riciclo? Quali strumenti (Fondo Made in Italy, Piano Mattei) stanno realmente entrando in funzione?
La stima è realistica, ma richiede un piano ben strutturato che distribuisca gli investimenti tra estrazione, raffinazione, ricerca e riciclo. Sebbene la cifra sia ambiziosa, se destinata correttamente e se supportata da fondi strategici come il Fondo Made in Italy, può ridurre sostanzialmente la dipendenza.
Quali sono i principali rischi e nodi critici da affrontare per costruire una strategia italiana vincente sulle CRM? Si parla di ritardi autorizzativi, mancanza di mappature minerarie, scarsi volumi RAEE raccolti, gap di competenze: qual è il punto più urgente da sbloccare e da dove dovrebbe partire la politica industriale?
I principali ostacoli includono ritardi autorizzativi e la scarsa raccolta dei RAEE. Il nodo critico immediato da affrontare riguarda la creazione di un sistema di raccolta più ef- fi -
ciente e una politica di gestione delle risorse minerarie che favorisca un'estrazione e un riciclo sostenibile. In particolare, al centro delle priorità c’è la necessità di processing, che garantisca maggiore trasparenza sulle modalità di lavorazione del materiale e sul rispetto degli standard ambientali e dei diritti umani. In questo contesto, l’Italia dispone di un solido know-how industriale nel trattamento chimico e fisico che può essere valorizzato per la raffinazione delle Materie Prime Critiche grazie alle competenze sviluppate nei settori chimico e metallurgico.
Qual è stato e quale sarà il ruolo di Iren nell’attuazione della roadmap italiana per le Materie Prime Critiche? In qualità di utility multi-servizi con forti competenze nel trattamento rifiuti e nell’economia circolare, quali progetti concreti sta portando avanti Iren (es. RAEE, impianti pilota, urban mining)? Quale contributo può offrire un soggetto come Iren per accelerare la creazione di una filiera nazionale delle CRM? In quale modo sarebbe importante riuscire a connettere con questo percorso i cittadini e l'Europa?
Iren, con le sue competenze nel trattamento dei rifiuti e nell'economia circolare, è già oggi apripista di un percorso di sviluppo nazionale. Oltre alla collaborazione con TEHA Group sullo studio e sulla formulazione di una strategia sulle MPC, nel luglio 2024 il Gruppo ha infatti lanciato RigeneRare, l’osservatorio che intende sviluppare, attraverso il coinvolgimento dei diversi attori la raccolta, sistematizzazione e la messa a fattor comune di dati ed informazioni inerenti lo stato dell’arte della filiera. Nel dicembre dello stesso anno, inoltre, il Gruppo ha inaugurato in Valdarno il primo impianto per il trattamento delle schede elettroniche provenienti dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’impianto consente l’estrazione, la selezione e il recupero di metalli quali oro, argento, palladio e rame, introducendo un nuovo paradigma di sostenibilità a filiera corta votato all’economia circolare. Le attività dell’impianto consentiranno infatti di creare sinergie con il vicino distretto orafo aretino, attraverso il recupero dei metalli lavorati nella struttura, generando concretamente valore aggiunto per il territorio.
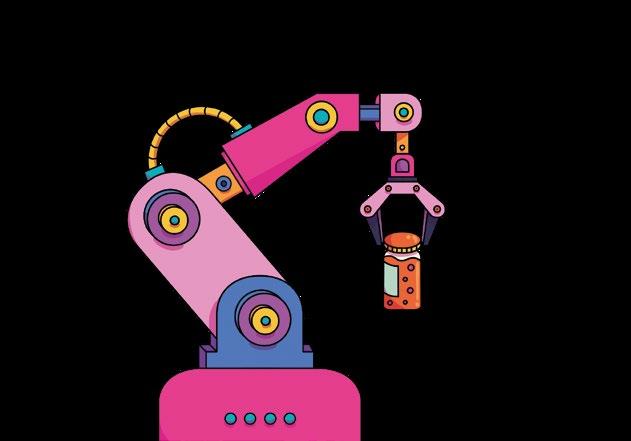
Dalle discariche miniere urbane.
Il futuro è già qui.
Nei film di fantascienza le discariche si allargano fino a coprire tutta la Terra, diventando oasi per reietti o luoghi di fantomatici scontri tra miserabili. Raramente gli sceneggiatori hanno sbagliato più clamorosamente. Se i rifiuti organici sono già preziosi e, debitamente lavorati, diventano biocarburanti e fertilizzanti, le discariche di domani, se ben gestite e organizzate, saranno vere e proprie miniere. Anzi, probabilmente non ci saranno neppure più, dal momento che molti si stanno organizzando per ritirarli prima che diventino tali.
Se infatti pensiamo in un’ottica circolare e inseriamo la servitizzazione, tutti i prodotti o i mezzi di produzione “affittati” potrebbero essere ritirati a fine vita dal produttore stesso, pronto ad aggiornarli, magari a smembrarli e a rimetterli in circolazione dopo aver riutilizzato quanto possibile.
Uno scenario radicale e lontano, ma che già oggi si sta realizzando in alcuni suoi aspetti: molte PMI e startup lavorano nel recuperare materie prime preziose da scarti industriali e non.
La pugliese AraBat è una di queste: utilizza scarti alimentari, come bucce d’arancia e foglie di carciofo, per innestare processi di idrometallurgia verde che consentono di estrarre metalli preziosi — come litio, cobalto e nichel — da batterie esauste e RAEE. Materie prime seconde sulle quali magari non potremo contare come sistema Paese, ma che potranno presto acquistare un peso significativo. RarEarth, fondata nel 2023 da due giovani italiani, estrae terre rare dai rifiuti elettronici tramite tecnologie brevettate, per realizzare magneti NdFeB (molto utilizzati nei motori elettrici ad alta efficienza). Lavorano su motori elettrici di scooter, biciclette e monopattini e studiano come estrarre questi elementi anche da turbine eoliche, batterie d’auto e dagli scarti prodotti durante la fabbricazione dei magneti (che rappresentano circa il 30 % del materiale totale).
Sono solo due esempi, ma in Italia e nel mondo è un trend che si declina in tutti i settori e con tutte le materie prime seconde. BiRex estrae cellulosa per carta e packaging, ma anche per oggetti di design, da rifiuti agroalimentari derivati dalla produzione di birra e caffè, e chitina da gusci di gamberi. Come Coffeefrom, che — partendo dai fondi di caffè — realizza nuovi materiali termoplastici, riciclati e biobased. In UK, Bioscope usa il bioleaching microbico (tecnica che prevede l’impiego di microbi per separare metalli preziosi dai rifiuti elettronici) per estrarre oro e terre rare dalle schede elettroniche; Brain AG in Germania ha creato il modulo BioXtractor, un'unità containerizzata che usa microrganismi per estrarre oro, argento, platino e palladio da ceneri industriali e RAEE. Mine Innovation in Nuova Zelanda e Phoenix Tailings (USA) fanno più o meno la stessa cosa, così come Noveon Magnetics (USA), Renewables Metals (Filippine), Nth Cycle (USA), Remretech (Svizzera) e Metaloop (Austria): tutte focalizzate sul recupero di metalli critici da RAEE e batterie.
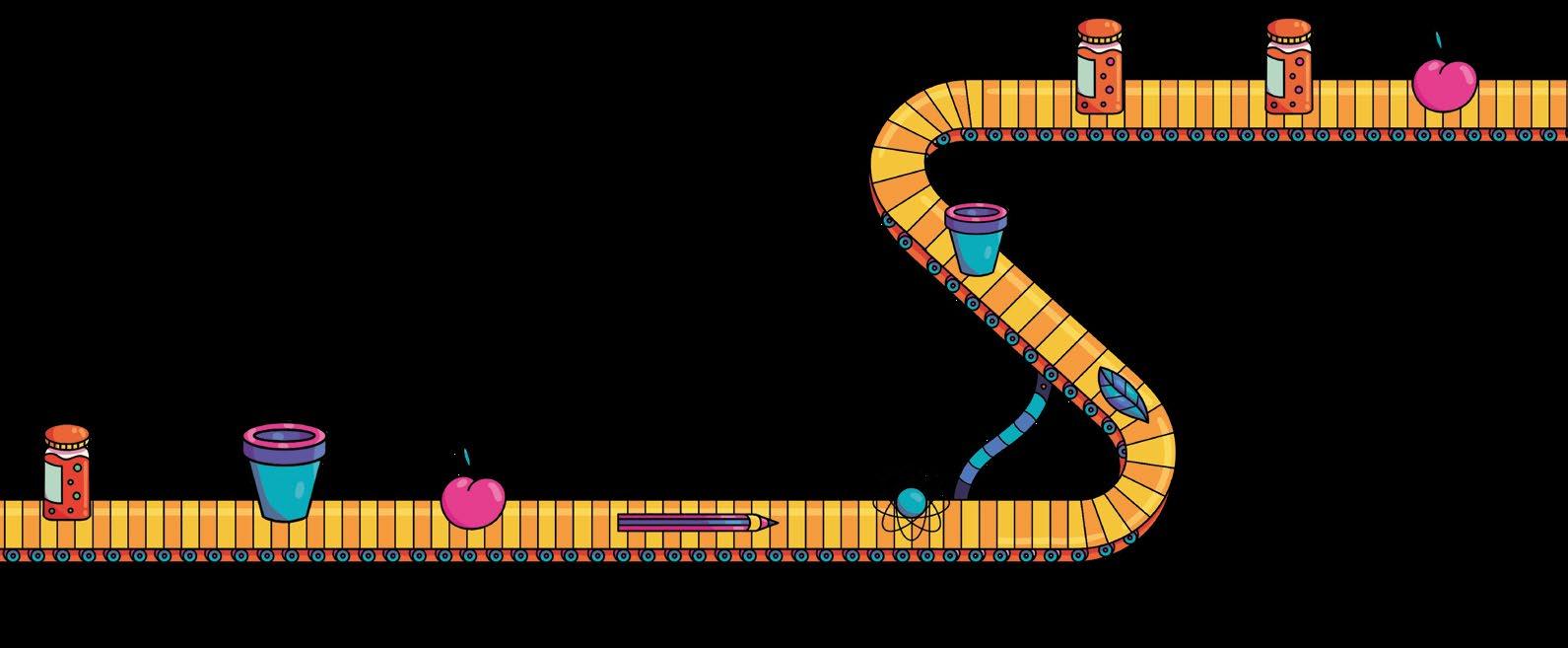
Un’idea interessante è quella dell’italiana f3nice, che ricicla scarti metallici industriali trasformandoli in polveri per stampa 3D (SLM) e nuovi materiali. «Oggi f3nice è in grado di recuperare e trasformare in polvere una vasta gamma di metalli: leghe di nichel (come l’Inconel, molto usato nell’oil & gas), acciai inox, leghe di rame, alluminio e perfino leghe customizzate per applicazioni specifiche», spiega Luisa Elena Mondora, cofounder di f3nice. «La materia prima non è “vergine”: recuperiamo scarti industriali, componenti dismessi e perfino vecchie polveri fuori specifica. Quanto all’approvvigionamento: in questi anni ci siamo strutturati per lavorare direttamente con gli stock dismessi dei nostri partner industriali. Non siamo una fonderia con grandi volumi, ma un centro di R&D e produzione selettiva, con una rete di fornitori che ci garantisce materiale pulito, tracciabile e adatto all’atomizzazione».
Qual è l’impatto ambientale che “risparmiate”? E quali materiali sostituite recuperando gli scarti?
«Parliamo spesso del fatto che l’Additive Manufacturing riduce gli scarti in fase di stampa — ed è vero — ma f3nice lavora prima, nella produzione della polvere. Grazie a un’analisi LCA (Life Cycle Assessment) sul nostro processo, abbiamo dimostrato che produrre polvere da scarto metallico permette di tagliare fino al 70 % delle emissioni di CO₂ equivalente rispetto alla produzione convenzionale. Questo significa meno estrazione mineraria, meno trasporto intercontinentale e meno energia. In termini pratici, se recuperiamo componenti in acciaio inox da una lavorazione meccanica o rame da un cavo offshore, evitiamo l’estrazione primaria e sostituiamo polveri prodotte da minerale o lingotto vergine. È un passo concreto verso l’economia circolare».
Quali sono le caratteristiche del materiale che producete? Per cosa può essere utilizzato?
«Produciamo polveri sferiche con distribuzioni granulometriche adatte alle principali tecnologie AM: dal Laser Powder Bed Fusion (LPBF) al Binder Jetting e al Directed Energy Deposition (DED). Le caratteristiche morfologiche, chimiche e meccaniche sono validate attraverso test interni e in collaborazione con università e clienti industriali. Per quanto riguarda gli impieghi, alcuni dei materiali che produciamo sono pensati specificamente per settori molto
esigenti: oil & gas, aerospazio, automotive. f3nice nasce proprio nel contesto oil & gas, anche grazie all’esperienza dei founder nel mondo energy. È per questo che mettiamo una cura quasi maniacale nella qualità e tracciabilità di ogni batch di polvere. Oggi, in parallelo, sviluppiamo anche leghe su misura per applicazioni in idrogeno e in ambienti estremi».
Quali altre startup o aziende avete incontrato in ambiti simili? Ritenete che le discariche di oggi saranno le miniere di domani?
«Assolutamente sì, ed è proprio da questa visione che è nata f3nice. La “miniera urbana” — fatta di rottami, impianti dismessi e materiali oggi destinati alla discarica — è un asset sottovalutato. Con i giusti strumenti di separazione, pulizia e atomizzazione può diventare la base di una filiera sostenibile per il manifatturiero avanzato. A livello europeo ci sono altri attori che si stanno muovendo: dai produttori di polveri green alle fonderie digitali, ma ancora poche realtà hanno una visione endtoend come la nostra. Collaboriamo con università, competence center, end users internazionali e grandi aziende; il nostro tratto distintivo resta lo sviluppo interno dell’intero processo — dalla selezione dello scarto alla validazione del materiale stampato».
Bioeconomia circolare: una via strategica per l'autosufficienza industriale
La bioeconomia circolare emerge come una risposta strategica alle sfide globali e nazionali, offrendo soluzioni concrete per la sostenibilità ambientale e la sicurezza economica dell'Italia. In un contesto caratterizzato da tensioni geopolitiche e da una crescente dipendenza da materie prime critiche importate, l'Italia si trova nella necessità di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento e ridurre la vulnerabilità delle proprie filiere produttive. La valorizzazione delle risorse biologiche rinnovabili, provenienti da agricoltura, silvicoltura, mare e scarti agroindustriali, rappresenta un'opportunità per sviluppare un'economia più resiliente e meno esposta a rischi esterni. In questo scenario, la bioeconomia circolare non solo contribuisce alla transizione ecologica, ma si configura anche come un motore di innovazione, occupazione e competitività industriale, in particolare per le aree rurali e marginali del Paese. Mario bonaccorso, direttore.
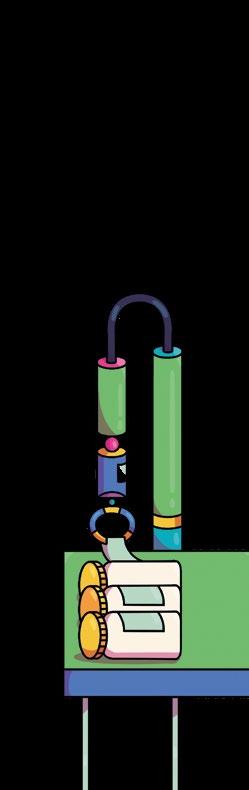
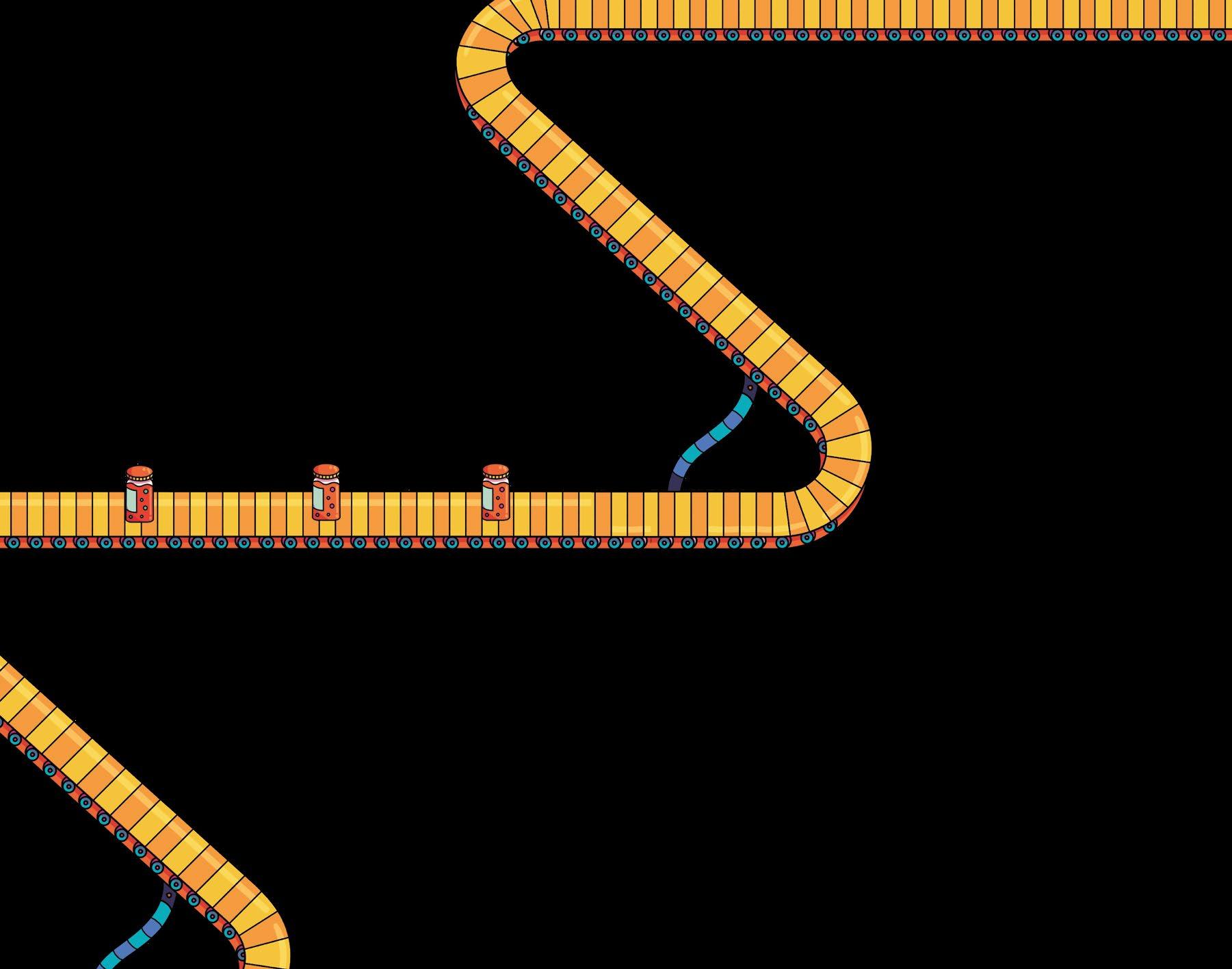
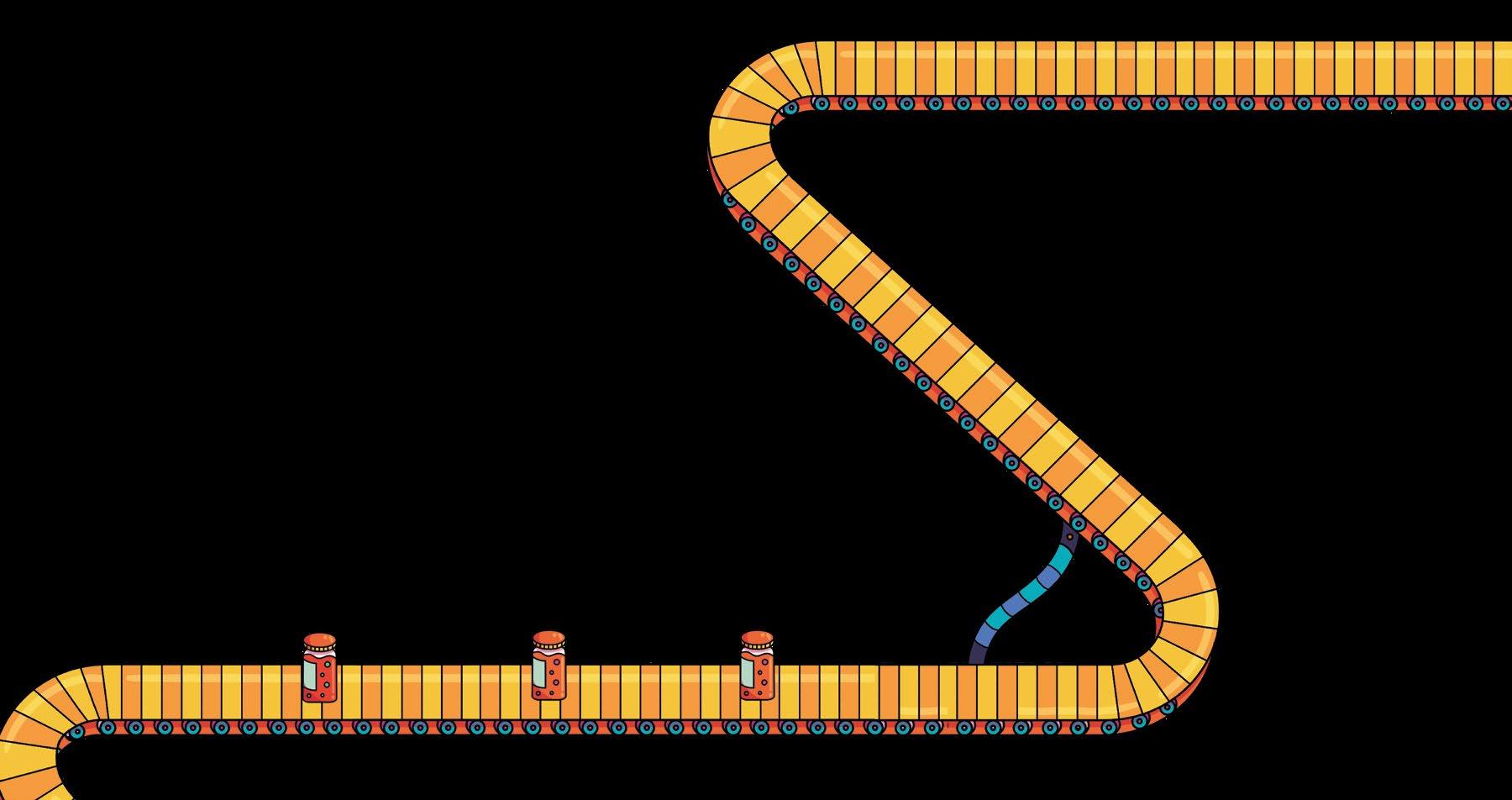
Che cos'è la bioeconomia e perché oggi può essere considerata una leva strategica per la sicurezza economica e industriale dell'Italia, oltre che per la sostenibilità ambientale?
La bioeconomia circolare è un sistema socio-economico basato sull’uso di risorse biologiche rinnovabili provenienti da terra e mare – come colture agricole, foreste, alghe – ma anche su scarti, residui e sottoprodotti, impiegati come materie prime per produrre alimenti, mangimi, materiali, energia e prodotti industriali. Pilastri della transizione ecologica, la bioeconomia e la sua dimensione circolare sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi climatici e ambientali, ma rappresentano anche una leva strategica per l’economia nazionale. In Italia, dove la dipendenza da materie prime fossili e critiche è ancora molto alta, investire nella bioeconomia significa, infatti, ridurre le importazioni, valorizzare risorse già disponibili sul territorio – come i sottoprodotti agricoli, la filiera forestale o i rifiuti organici – e generare nuova occupazione, innovazione e competitività industriale.

Tra i settori più rilevanti spicca la chimica bio-based, che utilizza zuccheri, oli vegetali o lignina per produrre molecole in grado di sostituire derivati petrolchimici. Le bioplastiche, biodegradabili e compostabili, trovano applicazione nel packaging e nei prodotti monouso, contribuendo a ridurre la plastica convenzionale.
Altro settore chiave è quello dei biocarburanti e del biometano, utilizzati nei trasporti pesanti, in agricoltura e persino in aviazione. Essi rappresentano un'alternativa concreta all’importazione di gasolio o gas naturale.
Oltre ai benefici ambientali – riduzione delle emissioni, minore produzione di rifiuti, riconversione di impianti dismessi – la bioeconomia offre concrete opportunità di sviluppo per le aree rurali e marginali, contribuendo alla rigenerazione territoriale, al rilancio di filiere locali e alla crescita di un’economia più resiliente.
In quali settori industriali la bioeconomia può ridurre concretamente la dipendenza da materie prime critiche o importate?
In Italia sono già attivi numerosi dimostratori industriali ad approccio circolare, fortemente radicati nei territori, che hanno raggiunto una scala nazionale ed europea.
Anche i materiali compositi bio-based – come quelli a base di fibra di canapa, lino o cellulosa – stanno trovando applicazione nell’edilizia, nell'automotive e nell’arredo. Gli enzimi industriali, invece, sono utilizzati per rendere più sostenibili i processi nei settori tessile, alimentare e chimico. Infine, prodotti come biolubrificanti, bioerbicidi, ingredienti cosmetici biodegradabili e detergenti naturali, se sviluppati all’interno di progetti territoriali integrati, coinvolgendo comunità e stakeholder locali, possono trasformare modelli produttivi tradizionali in occasioni concrete di crescita e innovazione sostenibile.
Biocarburanti e bioplastiche: quanto sono realmente scalabili oggi e quali settori ne beneficiano?
Biocarburanti e bioplastiche sono tra le applicazioni più mature della bioeconomia e già oggi trovano impieghi su larga scala in vari settori. Tuttavia, la loro scalabilità dipende da diversi fattori: competitività dei costi, disponibilità di materie prime, infrastrutture industriali adeguate e –soprattutto – un quadro normativo favorevole.
In Italia esiste un portafoglio crescente di prodotti bio-based che stanno trasformando anche settori tradizionali, come quello agricolo, offrendo soluzioni come biolubrifi-

canti per macchine agricole, pacciamature biodegradabili, biofitosanitari, biostimolanti, prodotti per la concia dei semi o per il rilascio controllato di fertilizzanti. Tuttavia, l’assenza di una governance sistemica e di strumenti normativi adeguati – come codici Ateco e NACE specifici per le bioraffinerie e i bioprodotti – frena lo sviluppo del settore, nonostante le grandi potenzialità esistenti.
Quali materiali bio-based o tecnologie emergenti potrebbero affermarsi nel prossimo futuro come alternativa reale alle materie prime critiche oggi importate?
Secondo l’XI Rapporto sulla Bioeconomia pubblicato a giugno 2025 da Intesa Sanpaolo con il Cluster SPRING, nel 2024 la bioeconomia ha generato un output pari a 3.042 miliardi di euro nell’UE27 (8,7% del PIL), impiegando oltre 17 milioni di persone. In Italia, il valore della produzione ha raggiunto i 426,8 miliardi di euro, pari a circa il 10% dell'economia nazionale e al 7,7% dell'occupazione. L’Italia risulta specializzata in questo ambito, rappresentando il 14% dell’intera bioeconomia europea, un peso superiore rispetto al suo contributo complessivo all’economia UE (12,4%).
Le bioraffinerie italiane, già oggi attive nella produzione di bioprodotti, hanno un elevato potenziale di crescita. Le nuove tecnologie in fase di sviluppo – dalla fermentazione microbica all’uso di miceli, scarti organici, alghe e fibre naturali – potranno espandere l'offerta di materiali innovativi nei settori tessile (es. ortica, canapa, micelio), edilizia, design, automotive, packaging, agricoltura e cosmesi.
Per liberare appieno questo potenziale, è però indispensabile superare l’attuale logica “a silos” e favorire un approccio olistico e integrato, supportato da un quadro normativo stabile e coerente. In particolare, la definizione della bioeconomia all’interno di una legge nazionale – come avvenuto per l’economia circolare – rappresenterebbe un passaggio fondamentale per consolidare una visione strategica e abilitare uno sviluppo industriale diffuso.
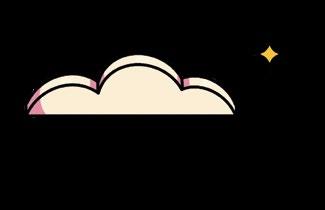

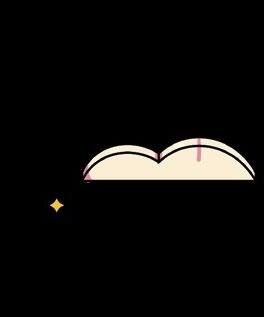



Novità dell’Accordo
Stato-Regioni 2025: la nuova formazione del datore di lavoro
di Marco Albanese, Responsabile Sicurezza Anima Confindustria
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 segna una svolta nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al ruolo del datore di lavoro. L’articolo analizza le novità normative, il legame con la giurisprudenza e il contributo delle figure professionali coinvolte, evidenziando come la formazione diventi uno strumento strategico per la tutela dell’azienda e dei lavoratori.
Dal 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un documento molto atteso, che segna un cambiamento importante, soprattutto nel modo in cui viene affrontata la formazione del datore di lavoro.
Non è semplicemente un aggiornamento normativo, ma rappresenta un vero e proprio cambiamento culturale: fino ad oggi la formazione è stata spesso vissuta come un obbligo da adempiere, un passaggio formale da completare per essere in regola. Questo Accordo segna un cambiamento nel modo di vedere la formazione. Formare chi ha la responsabilità di guidare un’impresa non è più solo un dovere imposto dalla legge, ma diventa una necessità concreta per proteggere l’azienda, tutelare i lavoratori e garantire la continuità dell’attività nel tempo. In effetti, il testo introduce una visione più ampia, in cui la formazione
diventa uno strumento strategico di prevenzione, gestione e organizzazione del lavoro. Viene sottolineata l’importanza di percorsi formativi di qualità, efficaci, specifici e misurabili nel tempo. In questo contesto il datore di lavoro non è più solo un destinatario passivo delle norme, ma un soggetto attivo che, se adeguatamente formato, può orientare le scelte aziendali in modo più sicuro e responsabile. Al riguardo è opportuno ricordare che, oltre all’introduzione della formazione obbligatoria per il datore di lavoro, il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 (Schema 1) introduce una serie di novità rilevanti. In particolare si segnalano importanti cambiamenti relativi alla durata e periodicità degli aggiornamenti, all’introduzione di nuovi corsi specifici per figure professionali e attrezzature, nonché alla definizione più rigorosa dei requisiti per i soggetti formatori e delle modalità di erogazione della formazione. Di fatto, il nuovo Accordo mira a integrare la sicurezza
nel cuore della gestione aziendale, evitando approcci formali e puntando su strumenti concreti.
Nel contesto attuale la formazione non è più soltanto un adempimento formale, ma si configura come uno strumento strategico di prevenzione e protezione, capace di incidere in modo concreto sulla gestione del rischio in azienda. La sua efficacia si misura non solo nei risultati in termini di riduzione degli infortuni, ma anche nella capacità di rafforzare la cultura organizzativa e di responsabilizzare tutte le figure coinvolte.
Se formare correttamente i lavoratori significa ridurre la probabilità di incidenti, formare il datore di lavoro in modo consapevole permette di costruire un sistema di prevenzione coerente, attivo e integrato nei processi aziendali. L’Accordo Stato-Regioni 2025 evidenzia proprio questo aspetto: la responsabilità del datore di lavoro non si esaurisce nella nomina di un RSPP o nella predisposizione dei

documenti di valutazione dei rischi. Al contrario, è chiamato a comprendere i pericoli specifici della propria attività, a valutare gli scenari di rischio e a intervenire direttamente nelle scelte organizzative e gestionali.
Inoltre, la formazione è anche uno strumento concreto di tutela giuridica. In molte sentenze, la giurisprudenza ha infatti sottolineato che, quando si verificano incidenti, la mancanza di un’adeguata formazione può comportare una responsabilità diretta per il datore di lavoro, anche nel caso in cui l’errore sia stato commesso dal lavoratore. Per questo motivo, formare in modo corretto non significa solo prevenire, ma anche essere in grado di dimostrare di aver agito con la necessaria attenzione e responsabilità nella conduzione dell’impresa.
Altro aspetto rilevante è la stretta integrazione tra formazione e vigilanza che si evince dal nuovo Accordo. Non basta più limitarsi all’erogazione di un corso, è essenziale che le competenze acquisite vengano realmente applicate nella quotidianità lavorativa. La sicurezza sul lavoro non è un compito che riguarda solo pochi soggetti, ma un sistema in cui tutti i protagonisti dell’azienda devono essere coinvolti e partecipare attivamente, ciascuno con il proprio ruolo e responsabilità (Schema 2).
In questo quadro la formazione del preposto assume un ruolo strategico e complementare rispetto a quella del datore di lavoro. Grazie a una preparazione specifica e mirata, il preposto può svolgere efficacemente il controllo sul campo, individuando tempestivamente situazioni di rischio e segnalando eventuali irregolarità. Questo consente di assicurare che le misure di sicurezza stabilite dal datore di lavoro vengano concretamente rispettate.
La formazione del datore di lavoro rappresenta la base su cui si fonda l’intero sistema di prevenzione, definendo responsabilità e obiettivi. A sua volta, il preposto, attraverso un percorso for-
mativo dedicato, traduce queste direttive in azioni pratiche, diventando un punto di raccordo fondamentale tra teoria e pratica.
Questo collegamento tra i due livelli formativi garantisce una vigilanza efficace che, oltre a prevenire gli infortuni, rafforza la posizione dell’azienda in caso di ispezioni o contenziosi, dimostrando un impegno concreto e continuo nella tutela della salute e sicurezza.
In sintesi, il nuovo approccio valorizza la sinergia tra formazione e vigilanza, considerandole elementi interdipendenti di un unico sistema. La preparazione del preposto, strettamente collegata a quella del datore di lavoro, è fondamentale per mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e promuovere una cultura della prevenzione efficace e condivisa.
Verso una formazione realmente utile
Una delle innovazioni più significative dell’Accordo 2025 riguarda la personalizzazione dei percorsi formativi. Viene infatti superata la logica tradizionale, basata su corsi generici e standardizzati, validi per ogni tipo di azienda o lavoratore, in favore di un modello basato su contenuti su misura, coerenti con i rischi specifici e reali dell’attività svolta.
Ciò significa che oggi non basta più trattare i concetti generali di sicurezza o elencare norme e procedure. Serve invece costruire percorsi formativi in grado di affrontare situazioni operative concrete, tipiche del settore produttivo di riferimento. La formazione diventa così uno strumento utile, applicabile nella quotidianità, e non solo una voce da spuntare su una checklist normativa.
Anche per il datore di lavoro si impone un cambio di prospettiva, poiché è necessario che acquisisca una visione integrata in grado di tenere insieme la dimensione operativa, quella normativa
e quella organizzativa della sicurezza. Solo adottando questo approccio completo potrà guidare con competenza e consapevolezza un sistema efficace di prevenzione.
Rispetto al passato, il nuovo modello formativo comporta tre cambiamenti principali:
1. I contenuti sono mirati, progettati in base a mansioni, processi e rischi specifici.
2. La formazione è orientata all’applicazione pratica, non più solo alla trasmissione teorica di norme.
3. La verifica dell’apprendimento non si esaurisce con un test finale, ma si estende a un monitoraggio continuo dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (schema 3).
Questa trasformazione rappresenta soprattutto un cambiamento culturale profondo perché non basta modificare i contenuti della formazione, è necessario rivoluzionare l’intero approccio alla sicurezza, facendo della formazione uno strumento concreto e operativo, parte integrante della gestione aziendale, e non semplicemente un obbligo da assolvere.
Formazione, organizzazione e sostenibilità d’impresa
Come accennato, il nuovo Accordo Stato-Regioni si collega esplicitamente anche alla gestione complessiva dell’impresa, richiamando in modo diretto l’art. 2086 del Codice Civile, che impone all’imprenditore di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Questo significa che anche la gestione della sicurezza e della formazione rientra pienamente tra le leve strategiche del governo aziendale.

La conoscenza dei rischi, la capacità di gestirli e la vigilanza sul comportamento dei lavoratori non sono più viste come funzioni isolate o “tecniche”, ma come elementi fondamentali per garantire la continuità aziendale, migliorare la governance e contribuire alla sostenibilità complessiva dell’impresa.
Un sistema formativo ben progettato e documentato consente di:
• Prevenire responsabilità giuridiche, anche nel quadro del D.Lgs. 231/2001;
• Contribuire al raggiungimento degli obiettivi ESG, soprattutto nella componente “Social” legata alla tutela del capitale umano;
• Allinearsi ai requisiti dei sistemi di gestione certificabili, come la norma ISO 45001 o i Modelli di Organizza-
zione e Gestione (MOG) previsti dalla normativa italiana.
In questo senso, la formazione diventa uno strumento di gestione, controllo e valorizzazione aziendale, e non solo un obbligo imposto dalla legge.
La giurisprudenza come guida per una formazione consapevole
Infine, un elemento spesso sottovalutato ma di grande utilità pratica è l’impiego della giurisprudenza come strumento formativo. Analizzare casi reali, sentenze significative e interpretazioni consolidate aiuta a tradurre la norma in comportamenti concreti, comprensibili e coerenti con le aspettative del sistema giudiziario. Integrare esempi tratti da vicende giudiziarie all’interno dei percorsi formativi consente di rafforzare la consa-
pevolezza delle responsabilità, evitare errori comuni e sviluppare una cultura della sicurezza più solida e realistica. È possibile affermare che il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 non si limita a introdurre nuove regole, ma apre la strada a un modo diverso di intendere la formazione, più vicino alle esigenze delle imprese e più efficace nel raggiungimento degli obiettivi di prevenzione. Formare il datore di lavoro non rappresenta più soltanto un obbligo, ma diventa una leva per migliorare l’organizzazione, rafforzare la capacità di affrontare il cambiamento, tutelare i lavoratori e proteggere l’azienda da responsabilità evitabili. In questo scenario, la formazione si configura come un vero investimento sul futuro dell’impresa, sulla sua resilienza, competitività e sostenibilità nel tempo.
Entrata in vigore Accordo del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025. Sostituisce integralmente gli accordi precedenti. Previsto un periodo transitorio di 12 mesi per adeguamenti.
Datori di lavoro (non RSPP)
Lavoratori neo-assunti
Introdotto obbligo formativo: 16 ore + 6 ore aggiuntive per attività in cantieri. Aggiornamento ogni 5 anni (minimo 6 ore). Completamento obbligatorio entro 24 maggio 2027.
Formazione obbligatoria prima dell’inizio dell’attività (non più entro 60 giorni).
Preposti Corso base aumentato da 8 a 12 ore. Aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni (minimo 6 ore). Consentite solo modalità in presenza o videoconferenza sincrona (no e-learning).
Dirigenti Corso ridotto a 12 ore. Modulo aggiuntivo (6 ore) obbligatorio per imprese edili.
Spazi confinati Corso specifico introdotto: 12 ore (4 teoriche + 8 pratiche). Obbligatorio aggiornamento ogni 5 anni (min. 4 ore), solo in presenza.
Attrezzature (nuove categorie)

Soggetto
Datore di lavoro
Dirigente
Preposto
RSPP (Responsabile SPP)
Medico Competente
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
Lavoratore
Ruoli e responsabilità nella gestione della sicurezza (D. Lgs 81/2008)
Ruolo e funzione nella gestione della sicurezza
Responsabile principale della sicurezza in azienda. Organizza la prevenzione, fornisce formazione adeguata, valuta i rischi, adotta misure idonee. Risponde legalmente in caso di omissioni.
Attua le direttive del datore di lavoro, organizza le attività lavorative in modo sicuro, assicura l’applicazione delle procedure e la formazione del personale sotto la propria responsabilità.
Sorveglia sul comportamento dei lavoratori; interviene in caso di comportamenti non conformi; promuove l’applicazione concreta delle regole e delle misure di prevenzione.
Supporta il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, nell’elaborazione del DVR, nella definizione di misure preventive e nella progettazione della formazione.
Valuta l’idoneità dei lavoratori; attua la sorveglianza sanitaria; partecipa alla valutazione dei rischi e collabora alla formazione su aspetti di salute e medicina del lavoro.
Rappresenta lavoratori su temi di salute e sicurezza; partecipa attivamente alla valutazione dei rischi; può accedere ai luoghi di lavoro, ricevere informazioni e fare proposte.
Riceve la formazione e la applica; utilizza correttamente i dispositivi di protezione; collabora alla prevenzione; segnala situazioni di rischio o incertezza.
Evoluzione del modello formativo secondo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
Approccio precedente (superato)
Corsi standard uguali per tutti
Contenuti prevalentemente teorici
Verifica finale formale (test scritto)
Formazione scollegata dalla vigilanza
Ruolo passivo del datore di lavoro
Introdotti nuovi corsi abilitanti per attrezzature come caricatori frontali, carroponti, macchine agricole.
Formatori Requisiti più stringenti: esperienze documentate, accreditamento, o appartenenza a enti riconosciuti.
Modalità didattiche
Verifica apprendimento
Tracciabilità e attestati
Ammessa la videoconferenza sincrona e la formazione mista, con tracciabilità e controllo accessi. E-learning consentito solo in casi specifici.
Obbligatoria per ogni corso (test, prove pratiche, colloqui). Deve essere redatto e conservato un verbale.
Rafforzato l’obbligo di documentare, archiviare e monitorare la formazione. Attestati con validità su tutto il territorio nazionale.
Nuovo approccio (Accordo 2025)
Percorsi formativi personalizzati su rischi aziendali reali
Contenuti pratici, applicabili alle attività quotidiane
Monitoraggio continuo dell’efficacia durante il lavoro
Integrazione tra formazione, vigilanza e controllo operativo
Coinvolgimento attivo nella gestione e nel controllo dei processi di sicurezza

Ambito / Figura Principali Novità
L’obbligo di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro
di Rolando Dubini, Avvocato Cassazionista, Foro di Milano
I. QUADRO NORMATIVO VIGENTE
L'obbligo di formazione in materia di sicurezza sul lavoro si fonda su un articolato sistema normativo costituito da:
1. D.Lgs. 81/2008, art. 37, che stabilisce i principi fondamentali
2. Accordi Stato-Regioni attualmente vigenti:
- Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. Atti n. 221/CSR) sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti
- Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. Atti n. 223/CSR) sulla formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP
- Accordo del 25 luglio 2012 sulle linee applicative degli Accordi del 21/12/2011
- Accordo del 22 febbraio 2012 sulla formazione per l'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro
- Accordo del 7 luglio 2016 sulla formazione di RSPP/ASPP
3. Ulteriori disposizioni specifiche:
- DM 10/03/1998 (ora sostituito dal D.M. 2 settembre 2021) per addetti antincendio
- DM 388/2003 per addetti al primo soccorso
- D.Lgs. 81/2008 art. 98 e Allegato XIV per coordinatori sicurezza cantieri
- DPR 177/2011 per lavori in ambienti confinati
II. CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO
1. Caratteristiche essenziali della formazione
A. Sufficienza e adeguatezza (art. 37 c.1)
La Cassazione ha ripetutamente chiarito che la formazione deve essere:
- Effettiva e non meramente formale
- Correlata alla valutazione dei rischi
- Verificata nell'apprendimento e nell'efficacia
Come stabilito dalla Cassazione Penale Sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007: "La formazione dei lavoratori deve essere effettiva e non può esaurirsi in un adempimento solo formale. Il datore di lavoro deve verificare che il lavoratore abbia non solo ricevuto, ma anche compreso l'informazione e la formazione in materia di sicurezza."
B. Specificità rispetto ai rischi (art. 37 c.3)
La Cassazione Penale sez. IV, 12/04/2018, n.22034 ha precisato che "l'obbligo di formazione e informazione gravante sul datore di lavoro riguarda tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, anche non specificamente connessi alle mansioni affidate ai lavoratori."
C. Comprensibilità e adattamento alle capacità dei destinatari (art. 37 c.13)
La Cassazione Penale sez. IV, 28 gennaio 2008, n. 4063 ha evidenziato la necessità di:
- Verificare la comprensione della lingua per i lavoratori stranieri
- Adattare i contenuti alle capacità dei destinatari
- Prevedere strumenti di verifica dell'apprendimento
D. Gratuità e svolgimento in orario di lavoro (art. 37 c.12)
La Cassazione Lavoro ha ribadito che:
- La formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro
- Non può comportare oneri economici per i lavoratori
- Il tempo dedicato alla formazione è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti
2. Conseguenze dell'inadempimento
La Cassazione Penale sez. IV, 13/02/2020, n. 8163 ha stabilito che: "il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi".
3. Non surrogabilità dell'obbligo
La Cassazione Penale sez. IV, 23 settembre 2014, n. 38966 ha chiarito che: "l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori”.
4. Verifica dell'efficacia
Come stabilito dalla Cassazione Penale Sez. 4, 27/06/2017, n. 45808: "il datore di lavoro deve verificare non solo l'erogazione della formazione ma anche la sua efficacia attraverso il controllo dell'effettiva comprensione e applicazione delle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori”.
5. Correlazione con la valutazione dei rischi
La formazione deve essere: - Coerente con il DVR

- Aggiornata in base all'evoluzione dei rischi
- Verificata nella sua efficacia pratica
6. Momenti formativi obbligatori (art. 37 c.4)
6.1 Obblighi fondamentali
L'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 individua precisi momenti in cui la formazione deve essere obbligatoriamente erogata. Analizziamoli alla luce della giurisprudenza:
A. Costituzione del rapporto di lavoro La Cassazione Penale sez. IV, 14/01/2014, n. 1096 ha stabilito che: "La formazione deve essere erogata prima dell'adibizione del lavoratore alle mansioni e non può essere differita, costituendo un prerequisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa in sicurezza."
Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione Penale sez. IV, 11/02/2016, n. 5858: "L'obbligo formativo sorge contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o dell'utilizzazione del lavoratore e la sua violazione non è sanabile retroattivamente."
B. Trasferimento o cambio mansioni
La Cassazione Penale sez. IV, 27/06/2017, n. 45808 ha precisato che: "il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi relativi alla formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte”.
In particolare, la Corte ha evidenziato che:
- La formazione deve precedere l'adibizione alle nuove mansioni - Deve essere specifica rispetto ai nuovi rischi
- Non può essere surrogata dall'esperienza pregressa
C. Introduzione di nuove attrezzature/ tecnologie/sostanze
La Cassazione Penale sez. IV, 23/01/2019, n. 3282 ha stabilito che: "L'introduzione di nuove attrezzature o sostanze richiede una specifica attività formativa preventiva, non essendo sufficiente la mera consegna di manuali o istruzioni”.
Questo principio è stato ulteriormente specificato dalla Cassazione Penale sez. IV, 12/05/2021, n. 35816 secondo cui: "in tema di infortuni sul lavoro, non è sufficiente, per far ritenere adempiuti gli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione dei lavoratori di manuali di istruzione per l'uso dei macchinari”.
6.2 Elementi comuni a tutti i momenti formativi
1. Tempestività
La Cassazione ha costantemente ribadito che la formazione deve essere:
- Preventiva rispetto all'esposizione al rischio
- Non differibile
- Non sanabile ex post
2. Specificità
Come stabilito dalla Cassazione Penale sez. IV, 13/02/2020, n. 8163: "La formazione deve essere specifica e concreta, calibrata sulle effettive mansioni e sui rischi connessi."
3. Verifica dell'apprendimento
La Cassazione Penale Sez. 3, 28/01/2008, n. 4063 ha evidenziato la necessità di:
- Definire obiettivi specifici
- Strutturare moduli didattici
- Prevedere strumenti di verifica dell'apprendimento
4. Documentazione
È necessario:
- Documentare l'attività formativa
- Registrare le verifiche di apprendimento
- Conservare le evidenze dell'avvenuta formazione
La giurisprudenza ha quindi delineato un sistema in cui la formazione deve essere:
- Tempestiva
- Specifica
- Verificata
- Documentata
7. Aggiornamento
L'aggiornamento della formazione in materia di sicurezza sul lavoro si articola su diversi livelli e tempistiche, come emerge dalla normativa e dalla giurisprudenza.
Il principio generale è stabilito dall'art.
37 comma 6 del D.Lgs. 81/2008, che prevede l'obbligo di aggiornamento pe-
riodico della formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione penale n. 39489/2022, che ne ha sottolineato l'importanza nel sistema di prevenzione aziendale.
Per quanto riguarda specificamente i preposti, l'art. 37 comma 7-ter del D.Lgs. 81/2008 stabilisce requisiti più stringenti, prevedendo:
- Un aggiornamento obbligatorio con cadenza almeno biennale
- Lo svolgimento esclusivamente in presenza
- L'obbligo di ripetizione anche al di fuori della cadenza biennale qualora necessario per l'evoluzione o l'insorgenza di nuovi rischi
La giurisprudenza, in particolare la Cassazione penale n. 27242/2020, ha specificato che l'aggiornamento deve essere effettuato in diverse occasioni specifiche, tra cui:
- Alla costituzione del rapporto di lavoro
- In caso di trasferimento o cambiamento di mansioni
- Per l'introduzione di nuove attrezzature o tecnologie
- In caso di utilizzo di nuove sostanze e miscele pericolose Il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 1436/2007 ha inoltre evidenziato che l'aggiornamento della formazione non è una mera formalità ma un obbligo sostanziale, la cui violazione può comportare responsabilità penali in caso di infortunio.
È importante notare che l'aggiornamento deve essere documentato e registrato, e deve sempre svolgersi durante l'orario di lavoro senza oneri economici per i lavoratori. Il contenuto dell'aggiornamento deve essere specifico e adeguato ai compiti in materia di salute e sicurezza, garantendo l'acquisizione delle competenze necessarie in forma comprensibile per i destinatari.
L'analisi dell'aggiornamento della formazione in materia di sicurezza sul lavoro richiede una distinzione fondamentale tra le diverse figure coinvolte.

Per quanto riguarda i lavoratori, la situazione normativa è chiara e definita. L'art. 37 comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono disciplinati dagli accordi vigenti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Questi accordi sono pienamente operativi e forniscono un quadro normativo completo per la formazione dei lavoratori, inclusi i criteri per l'aggiornamento quinquennale.
La situazione è invece problematica per dirigenti e preposti. L'art. 37 comma 7 rinvia la disciplina della loro formazione all'accordo di cui all'art. 37 comma 2, secondo periodo, che però non è ancora stato approvato. Questo crea un vuoto normativo specifico per queste figure, per le quali l'obbligo formativo è chiaramente affermato ma privo di una regolamentazione operativa.
La situazione è particolarmente critica per i preposti, per i quali l'art. 37 comma 7-ter prevede requisiti specifici come:
- L'aggiornamento biennale obbligatorio
- Lo svolgimento esclusivamente in presenza
- L'obbligo di ripetizione in caso di evoluzione o insorgenza di nuovi rischi
Tuttavia, in assenza dell'accordo di riferimento, mancano indicazioni precise su contenuti, durata e modalità concrete di svolgimento di questa formazione. Analogamente, per i dirigenti, pur essendo previsto l'aggiornamento quinquennale, manca una disciplina specifica che ne definisca contenuti e modalità.
Questa asimmetria normativa crea una situazione paradossale in cui:
- I lavoratori godono di un quadro normativo completo e definito
- Dirigenti e preposti, figure chiave nel sistema di prevenzione aziendale, sono soggetti a obblighi formativi privi di una regolamentazione operativa
La Cassazione penale n. 39489/2022 ha ribadito l'importanza fondamentale della formazione nel sistema di prevenzione, ma anche questa pronuncia non può colmare il vuoto normativo esistente
sulla concreta attuazione della formazione per dirigenti e preposti.
III. L'OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO
1. Quadro normativo L'articolo 37 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che "L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato."
2. Caratteristiche essenziali dell'addestramento
Dall'analisi della norma e della giurisprudenza emergono le seguenti caratteristiche fondamentali:
A. Deve essere effettuato da persona esperta
La Cassazione Penale sez. IV, 12/05/2021, n. 35816 ha chiarito che "la persona esperta deve possedere competenze tecniche specifiche e documentate relative all'attrezzatura o procedura oggetto dell'addestramento, non essendo sufficiente una generica esperienza lavorativa."
B. Deve svolgersi sul luogo di lavoro Come stabilito dalla Cassazione Penale sez. IV, 23/01/2019, n. 3282: "L'addestramento deve necessariamente avvenire nel contesto lavorativo reale dove verranno utilizzate le attrezzature o applicate le procedure, non potendo essere surrogato da simulazioni in ambienti diversi."
C. Deve prevedere una prova pratica
La Cassazione Penale sez. IV, 27/06/2017, n. 45808 ha evidenziato che "l'addestramento deve necessariamente includere l'esecuzione pratica delle operazioni da parte del lavoratore sotto la supervisione della persona
esperta, non essendo sufficiente una mera dimostrazione”.
3. Contenuti dell'addestramento
L'addestramento deve riguardare:
- Uso corretto e in sicurezza di attrezzature
- Utilizzo di macchine
- Gestione di impianti
- Manipolazione di sostanze
- Impiego di dispositivi, inclusi i DPI
- Procedure di lavoro in sicurezza
4. Documentazione e tracciabilità
Come stabilito dalla norma e confermato dalla Cassazione Penale sez. IV, 13/02/2020, n. 8163, è necessario:
- Documentare gli interventi di addestramento in un apposito registro
- Tracciare per ogni sessione: data, durata, contenuti, nominativi di addestratore e addestrato
- Conservare le evidenze dell'avvenuto addestramento
- Prevedere verifiche dell'efficacia dell'addestramento
5. Conseguenze dell'inadempimento
La Cassazione Penale sez. IV, 14/06/2018, n. 49593 ha stabilito che "la mancata o inadeguata erogazione dell'addestramento pratico configura una violazione degli obblighi di sicurezza che comporta la responsabilità diretta del datore di lavoro per gli infortuni causalmente riconducibili a tale carenza, non potendo essere surrogata da altri tipi di formazione teorica o dall'esperienza pregressa del lavoratore”.
6. Periodicità e aggiornamento
L'addestramento deve essere:
- Ripetuto periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi
- Aggiornato in caso di:
- Modifiche delle attrezzature/procedure
- Introduzione di nuove tecnologie
- Cambiamento di mansioni
- Lungo periodo di assenza del lavoratore
7. Verifica dell'efficacia
Come stabilito dalla Cassazione Penale Sez. 4, 27/06/2017, n. 45808: "il datore di lavoro deve verificare non solo l'erogazione dell'addestramento ma anche la sua efficacia attraverso il controllo

dell'effettiva capacità del lavoratore di eseguire correttamente e in sicurezza le operazioni oggetto dell'addestramento."
L'addestramento costituisce quindi un obbligo specifico e autonomo rispetto alla formazione teorica, caratterizzato da contenuti pratici e operativi che devono essere erogati nel contesto lavorativo reale sotto la supervisione di personale esperto, con adeguata documentazione e verifica dell'efficacia.
IV. RESPONSABILITÀ E CONSEGUENZE
DELL'INADEMPIMENTO
La Corte di Cassazione ha elaborato un consolidato orientamento in materia di obblighi formativi in ambito di sicurezza sul lavoro, delineando con precisione sia la natura dell'obbligo che le conseguenze del suo inadempimento.
L'obbligo formativo, pur essendo un dovere fondamentale del datore di lavoro, non rientra tra gli obblighi non delegabili previsti dall'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, che individua come tali esclusivamente la valutazione dei rischi con elaborazione del DVR e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La formazione si caratterizza comunque per specifiche caratteristiche essenziali che ne definiscono la corretta attuazione. In particolare, l'obbligo formativo non può essere considerato assolto sulla base della mera esperienza lavorativa pregressa del dipendente. Come stabilito dalla Cassazione penale n. 21242/2014, "la formazione non può essere surrogata dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per esperienza operativa o per il travaso di conoscenze che si realizza nella collaborazione tra lavoratori".
Tale principio è stato ulteriormente rafforzato dalla Cassazione penale n. 30235/2017, che ha precisato come la formazione debba essere "specifica e documentata, non potendo essere sostituita dalla mera presenza di avvisi o istruzioni a bordo delle attrezzature o dalla
trasmissione verbale di nozioni".
In caso di inadempimento degli obblighi formativi, le conseguenze per il datore di lavoro sono particolarmente severe.
La Cassazione penale n. 8163/2020 ha stabilito che "il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che ponga in essere condotte imprudenti".
Tale responsabilità sussiste anche quando l'infortunio sia stato causato da un comportamento colposo del lavoratore, come chiarito dalla Cassazione penale n. 43708/2023, secondo cui tale comportamento è da considerarsi "conseguenza diretta e prevedibile dell'inadempimento degli obblighi formativi".
L'unica ipotesi in cui la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa è quella del comportamento abnorme del lavoratore. Come precisato dalla Cassazione penale n. 23049/2024, ciò può avvenire solo quando la condotta del lavoratore risulti "del tutto abnorme, esorbitante e imprevedibile rispetto alle mansioni affidate e alle direttive ricevute".
Sul piano civilistico, la Cassazione civile n. 20259/2023 ha stabilito che "il mancato completamento della formazione obbligatoria [il lavoratore che rifiuta di partecipare alla formazione obbligatoria], senza giustificato motivo, può legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo".
Inoltre, come evidenziato dalla Cassazione civile n. 12790/2024, l'obbligo formativo deve essere adempiuto durante l'orario di lavoro, "inteso in senso ampio come comprensivo anche di prestazioni di lavoro supplementare o straordinario".
La responsabilità del datore di lavoro si estende anche alle situazioni di rischio non ordinarie. La Cassazione penale n. 45492/2016 ha infatti stabilito che l'obbligo formativo comprende anche "le situazioni di rischio derivanti dall'interferenza con attività lavorative diverse da quelle ordinariamente espletate". Infine, la Cassazione penale n. 20035/2022 ha
ribadito che la violazione degli obblighi formativi può comportare responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio, anche in presenza di una condotta colposa del dipendente.
V. PROSPETTIVE FUTURE
L'approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro, originariamente prevista entro il 30 giugno 2022 dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, si trova in una situazione di significativa incertezza. Nonostante il termine sia ampiamente scaduto, ad oggi non vi sono indicazioni concrete sulla sua imminente adozione, creando un vuoto normativo rispetto alle aspettative di aggiornamento e semplificazione della materia. Come evidenziato dalla sentenza TAR Sicilia n. 72/2024, l'attuale sistema degli Accordi Stato-Regioni, pur necessitando di aggiornamento, mantiene piena efficacia e non richiede ulteriori provvedimenti amministrativi per la sua applicazione. Questo principio assume particolare rilevanza nell'attuale fase di stallo, garantendo la continuità del sistema formativo.
Il nuovo Accordo, qualora venisse approvato, dovrebbe perseguire obiettivi ambiziosi:
1. Accorpamento e razionalizzazione degli accordi esistenti, per superare la frammentazione normativa attuale
2. Implementazione di meccanismi più efficaci di verifica dell'apprendimento e dell'efficacia della formazione
3. Introduzione di modalità formative innovative, nel rispetto dei limiti all'e-learning confermati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8227/2023

4. Definizione di criteri più stringenti per il monitoraggio e il controllo delle attività formative
5. Aggiornamento dei contenuti formativi alla luce delle nuove tecnologie e dei rischi emergenti
La mancata approvazione del nuovo Accordo genera alcune criticità significative:
- Persistenza di un quadro normativo frammentato e non pienamente rispondente alle esigenze attuali
- Difficoltà nell'implementazione delle nuove disposizioni introdotte nel 2023 all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008
- Incertezza sulle modalità di verifica dell'efficacia della formazione durante il lavoro
- Mancato aggiornamento dei criteri di qualificazione della figura del formatore In questo contesto di incertezza, come sottolineato dalla Corte d'Appello di Messina n. 450/2023, resta fondamentale garantire la tempestività e l'adeguatezza della formazione, indipendentemente dall'evoluzione del quadro normativo.
La situazione attuale richiede particolare attenzione anche in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti. L'art. 300 del D.Lgs. 81/2008, modificando l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, prevede infatti sanzioni particolarmente severe per le violazioni che causano infortuni, incluse quelle relative agli obblighi formativi. Questo aspetto rende ancora più urgente l'esigenza di un quadro normativo chiaro e aggiornato.
Fino all'approvazione del nuovo Accordo, gli operatori del settore devono quindi:
- Continuare ad applicare scrupolosamente la disciplina vigente
- Mantenere elevati standard formativi
- Documentare accuratamente le attività formative svolte
- Garantire l'aggiornamento continuo dei contenuti formativi
- Prestare particolare attenzione alle verifiche dell'apprendimento
La prospettiva di un nuovo Accordo, seppur incerta nei tempi, non deve quindi distogliere l'attenzione dall'importanza di una formazione efficace e conforme alle disposizioni vigenti, anche alla luce del sistema sanzionatorio previsto dall'art. 301 del D.Lgs. 81/2008 per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
VI. SINTESI FINALE
L'obbligo formativo in materia di sicurezza sul lavoro si configura come elemento cardine del sistema prevenzionistico, la cui rilevanza è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza.
Come affermato dalla Cassazione penale n. 8163/2020, la formazione rappresenta "un dovere inderogabile del datore di lavoro, la cui violazione si configura come colpa specifica in caso di infortunio".
La formazione, per essere conforme al dettato normativo dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008, deve presentare caratteristiche precise e verificabili. Come stabilito dalla Cassazione penale n. 30235/2017, deve essere "specifica e documentata", non potendo essere sostituita da prassi informali o dall'esperienza sul campo. L'efficacia della formazione deve essere verificata sia nell'immediato che nel lungo periodo. La Corte d'Appello di Messina n. 450/2023 ha sottolineato l'importanza di un sistema di verifica che comprenda:
- Test di apprendimento iniziale
- Verifiche periodiche dell'efficacia
- Monitoraggio continuo dell'applicazione pratica
La documentazione dell'attività formativa assume un ruolo cruciale. Come precisato dalla Cassazione civile n. 12790/2024, è necessario mantenere un sistema documentale completo che includa:
- Registri delle presenze
- Programmi formativi dettagliati
- Verifiche dell'apprendimento
- Attestati di partecipazione
- Curriculum dei formatori
In attesa del nuovo Accordo Stato-Regioni, la cui approvazione resta incerta nonostante la previsione normativa del 30 giugno 2022, gli operatori devono continuare ad applicare scrupolosamente la disciplina vigente. Come evidenziato dalla sentenza TAR Sicilia n. 72/2024, l'attuale quadro normativo
mantiene piena efficacia e richiede:
- Rispetto dei contenuti minimi formativi
- Aggiornamento periodico secondo le scadenze previste
- Documentazione puntuale delle attività svolte
- Verifica dell'efficacia degli interventi formativi
La formazione rappresenta quindi non solo un obbligo giuridico ma un investimento fondamentale per la prevenzione degli infortuni. Come sottolineato dalla Cassazione penale n. 20035/2022, la sua corretta attuazione costituisce un presidio essenziale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui violazione può comportare gravi conseguenze sia sul piano penale che civile.
L'evoluzione normativa attesa con il nuovo si inserirà all’interno di questi principi consolidati, puntando a rafforzare ulteriormente l'efficacia del sistema formativo attraverso:
- maggiore integrazione tra formazione teorica e pratica;
- implementazione di sistemi di verifica più stringenti;
- aggiornamento dei contenuti alle nuove tecnologie;
- rafforzamento dei meccanismi di controllo e monitoraggio.
La formazione sulla sicurezza si conferma come elemento imprescindibile del sistema prevenzionistico, la cui corretta attuazione richiede un approccio sistematico, documentato e orientato all'efficacia pratica degli interventi formativi.

Universo Gold Il 1° network dell’Antincendio in Italia

I manutentori della rete Universo Gold sono una garanzia di qualità e affidabilità nell’antincendio.
Grazie alla formazione costante e al supporto del C.I.A.B (Continous Improvement Advisory Board), i nostri affiliati ti supportano nella scelta e nell’installazione delle soluzioni antincendio più adatte alla tua realtà.
Con i manutentori Universo Gold scegli il meglio della sicurezza antincendio per la tua azienda.
Scopri gli affiliati della rete su www.universogold.com e trova quello più vicino a te.

TECNOLOGIE FOOD A HOST 2025:
INNOVAZIONE E MERCATI A CONFRONTO
Il comparto delle tecnologie food si conferma tra i più dinamici dell’industria meccanica. Secondo ExportPlanning, nel 2024 la produzione mondiale ha raggiunto quota 245,5 miliardi di euro (+27% sui livelli pre-pandemici), con l’Italia leader in diversi settori quali Macchine per panificazione e pasticceria per 1,1 miliardi di euro di produzione nel 2024, Macchine da caffè e vending grazie alla co-leadership con gli Stati Uniti a 1,89 miliardi di euro per l’Italia, 1,96 per gli USA, o Macchine per gelato e refrigerazione, nelle quali l’Italia è il terzo produttore mondiale con 2,8 miliardi di euro nel 2024.
Una crescita spinta anche dall’evoluzione dei consumi: locali e punti vendita si trasformano in esperienze, mentre le contaminazioni culturali introducono sapori esotici e reinterpretazioni contemporanee. A queste richieste rispondono macchinari sempre più automatizzati, digitalizzati e attenti all’efficienza energetica, con un ruolo crescente dell’AI generativa nell’ottimizzazione dei processi.

Host 2025: l’hub mondiale dell’innovazione food
In questo scenario, Host 2025, a Fiera Milano dal 17 al 21 ottobre prossimi, sarà l’hub internazionale dove scoprire in anteprima le soluzioni che ridisegnano il settore. Uno dei grandi protagonisti sarà il mondo delle tecnologie per l’Arte Bianca, che trova la sua piattaforma nel rinnovato MIPPP con l’arena di eventi di Bakery Square.
Tra i nuovi eventi nel palinsesto di Host 2025 si segnala sCIOCk, progetto dedicato al mondo del cioccolato curato da Davide Comaschi, mentre fra le grandi competizioni internazionali spiccano il Panettone World Championship, che vedrà sfidarsi team provenienti da tutto il mondo, e il World Barista Championship, il più prestigioso appuntamento al mondo sull’arte del caffè, che a scelto Host 2025 per il suo atteso ritorno a Milano.
Le aziende capaci di dettare nuovi trend tecnologici saranno protagoniste anche di Smart Label – Host Innovation Award, un riconoscimento che rafforza il ruolo di Host Milano come hub globale dell’innovazione e piattaforma di business per chi investe nelle tecnologie food.

CYBER RESILIENCE ACT: LA NUOVA SICUREZZA DIGITALE PER UN SETTORE SEMPRE PIÙ CONNESSO
di Marco Carleo, Funzionario Tecnico Anima Confindustria
La trasformazione digitale sta cambiando anche il mondo dell’hospitality e della ristorazione professionale. Cucine intelligenti, macchine connesse, sistemi di pagamento contactless, soluzioni IoT per la gestione energetica e del magazzino: ormai la tecnologia è parte integrante dell’esperienza quotidiana. Questa evoluzione porta con sé enormi opportunità, ma anche nuove sfide sul fronte della sicurezza informatica.
Per rispondere a queste esigenze l’Unione Europea ha introdotto il Cyber Resilience Act (CRA), una normativa che stabilisce regole precise per garantire che i prodotti digitali immessi sul mercato siano sicuri “by design”, ovvero progettati fin dall’inizio con requisiti di protezione da cyber attacchi e vulnerabilità.
Il CRA nasce con un obiettivo chiaro: innalzare il livello di sicurezza dei prodotti connessi in tutta l’Unione Europea, riducendo i rischi di incidenti che possono compromettere non solo i dati, ma anche la continuità operativa delle imprese.
In sintesi, la normativa:
• introduce obblighi di sicurezza per i produttori di hardware e software;
• prevede responsabilità dirette per chi immette sul mercato dispositivi connessi, tramite un’apposita valutazione rischi da inserire nella documentazione tecnica;
• richiede maggiore trasparenza sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
• impone aggiornamenti e patch tempestive per risolvere vulnerabilità.
Il messaggio è chiaro: in un mondo dove tutto è connesso, la sicurezza non può più essere un optional, ma un requisito fondamentale al pari della qualità o dell’efficienza energetica.
Implicazioni per il settore hospitality
Il Cyber Resilience Act non riguarda solo i grandi player tecnologici: anche le aziende che operano nella ristorazione e nell’hotellerie saranno toccate da questa normativa. Pensiamo a:
• Cucine intelligenti e macchinari IoT: forni, abbattitori, frigoriferi e macchine da caffè connessi che comunicano dati in tempo reale. Se non adeguatamente protetti, possono diventare porte d’ingresso per attacchi informatici.
• Sistemi di pagamento digitali: oggi sempre più diffusi e integrati con le casse automatiche. Una violazione potrebbe esporre dati sensibili dei clienti.
• Soluzioni di gestione energetica e impiantistica: spesso collegate a piattaforme cloud per ottimizzare i consumi, ma vulnerabili a intrusioni.
In tutti questi casi, il CRA introduce garanzie di affidabilità, i produttori dovranno certificare che i dispositivi rispettano standard di sicurezza riconosciuti a livello europeo. Questo significa maggiore tutela per le aziende utilizzatrici e per i clienti finali.
Opportunità per le imprese
Se da un lato il Cyber Resilience Act rappresenta una sfida in termini di adeguamento, dall’altro offre importanti opportunità:
• Aumento della fiducia: un cliente che utilizza dispositivi certificati come sicuri percepisce maggiore affidabilità e professionalità.
• Competitività internazionale: le aziende che si adeguano rapidamente potranno proporsi come partner di riferimento anche sui mercati esteri.
• Riduzione dei rischi e dei costi: prevenire incidenti informatici è sempre meno oneroso che subirne le conseguenze (fermi macchina, danni reputazionali, sanzioni).
• Spinta all’innovazione: progettare “security by design” stimola nuovi modelli di business e soluzioni digitali più evolute.
In altre parole, la compliance al CRA non deve essere vista come un mero adempimento normativo, ma come un fattore strategico di crescita e differenziazione. La digitalizzazione dell’hospitality non si ferma: ogni giorno nascono nuove soluzioni che rendono più efficienti le cu-
cine, più confortevole l’esperienza del cliente e più sicura la gestione dei dati. In questo scenario, il Cyber Resilience Act diventa un alleato prezioso per garantire che innovazione e sicurezza vadano di pari passo.
Prepararsi ora al CRA significa non solo evitare rischi futuri, ma anche costruire un vantaggio competitivo basato su fiducia, credibilità e resilienza digitale. Perché in un settore sempre più connesso, la vera eccellenza non si misura solo nelle performance, ma anche nella capacità di proteggere ciò che conta di più: i dati, i processi e la fiducia dei clienti.

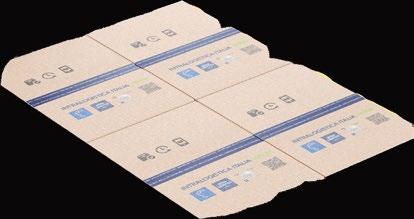
ASPETTANDO
INTRALOGISTICA ITALIA
FIERAMILANO,








Ready for the Future


La Fiera B2B interamente dedicata a movimentazione industriale, gestione del magazzino, stoccaggio, smistamento e sollevamento dei materiali.





ARRIVA LA PRIMA NORMA EUROPEA
PER MISURARE I CONSUMI DELLE MACCHINE DA CAFFÈ
Di Giorgio Beretta, Technical Manager Anima Confindustria
Ucimac e Anima protagoniste della normazione tecnica europea. In arrivo nuovi progetti su sicurezza e igiene.
Ad aprile 2025 è stata ufficialmente pubblicata la norma CEI EN 50730:2025-05, il primo standard europeo che definisce i metodi di misurazione del consumo energetico e della produttività delle macchine da caffè professionali e commerciali, sia tradizionali sia superautomatiche.
Il documento rappresenta un traguardo di grande importanza per il settore della preparazione professionale del caffè. La norma è stata sviluppata grazie al lavoro coordinato di esperti provenienti da diversi Paesi europei, sotto la guida del working group 21 del TC 59X del CENELEC, la cui segreteria tecnica è affidata a Ucimac (Unione Costruttori Macchine e Attrezzature per Caffè, professionali e semi professionali), associazione federata ad Anima Confindustria.
La nuova normativa stabilisce parametri comparabili e oggettivi per valutare l’efficienza energetica e la produttività delle macchine, basandosi su tre indicatori fondamentali per ogni bevanda erogata: temperatura, quantità e tempo di erogazione.
Grazie a questi criteri, produttori, gestori e utilizzatori professionali potranno disporre di strumenti affidabili per orientare le proprie scelte di acquisto e investimento, in un’ottica di maggiore trasparenza e competitività del mercato.
Le imprese associate a Ucimac hanno partecipato attiva mente alla definizione della norma e ora sono impegnate nelle fasi di test dei prodotti. I dati raccolti, per la speci ficità delle macchine e la varietà dei modelli, saranno resi disponibili progressivamente.
Nei prossimi mesi prenderanno avvio campagne di misura zione e comparazione su larga scala, con l’obiettivo di for nire dati affidabili, stimolare un innalzamento della qualità dei prodotti e ridurre consumi e costi di gestione.
«Questa norma rappresenta un traguardo fondamentale per il nostro comparto» ha commentato Roberto Nocera, presidente di Ucimac «e dimostra la capacità della nostra associazione di valorizzare le competenze delle aziende ita liane nei contesti tecnici europei».
Sono in fase di avvio nuovi progetti normativi europei che riguardano sicurezza e igiene delle macchine da caffè pro fessionali e dei macinacaffè. Queste iniziative mirano ad aggiornare le prescrizioni vigenti, includendo aspetti legati alla sicurezza meccanica, alla progettazione igienica delle superfici e dei circuiti, e all’ergonomia.
Anche in questo percorso Ucimac, federata Anima Confin dustria, avrà un ruolo da protagonista, confermando l’im pegno dell’associazione nella normazione tecnica europea e il riconoscimento del contributo delle imprese italiane nei tavoli decisionali internazionali.

Presso lo stand di Anima Confindustria (Pad. 8 Stand G07-H08) tutti i giorni, dalle 16:30 alle 17:30, i nostri esperti presente ranno i requisiti salienti di questa norma.

LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO
19 GIUGNO 2025, N. 102
di Alberto Spotti, Technical Manager Anima Confindustria
Il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102, rappresenta un'evoluzione cruciale per il quadro normativo che tutela le acque destinate al consumo umano. Agendo come un correttivo e integrativo del precedente D.Lgs. n. 18 del 2023, il provvedimento mira ad affinare il sistema di controllo in linea con gli standard europei più recenti. Entrato in vigore il 19 luglio 2025, questo decreto si concentra su aspetti fondamentali: la gestione di inquinanti emergenti e la regolamentazione dei materiali a contatto con l'acqua, due elementi chiave per garantire una sicurezza idrica sempre maggiore.
Una delle novità più significative e attese rispetto al Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102, riguarda l'introduzione di nuovi parametri per garantire la sicurezza dell'acqua che beviamo. Il decreto stabilisce valori limite specifici per i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) e, per la prima volta in Italia, introduce il parametro TFA (trifluoroacetato). La decisione di includere queste sostanze riflette una consapevolezza crescente dei rischi che i cosiddetti "inquinanti emergenti" possono rappresentare per la salute pubblica. I PFAS, noti anche come "forever chemicals", sono composti persistenti che si degradano molto lentamente nell'ambiente, mentre il TFA è un sottoprodotto di alcuni refrigeranti e pesticidi, la cui presenza nelle acque sta diventando sempre più rilevante a livello globale. L'inclusione di questi parametri è un passo fondamentale per allineare la normativa italiana con la scienza più aggiornata.
Parallelamente, la gestione dei materiali che entrano in contatto con l'acqua è stata oggetto di una revisione sostanziale. Il decreto stabilisce requisiti più severi per tubature e raccordi, con l'obiettivo di prevenire la contaminazione del liquido trasportato. Spesso, infatti, l'invecchiamento delle infrastrutture idriche o l'utilizzo di materiali non idonei possono rilasciare sostanze nocive nell'acqua. Per contrastare questo fenomeno, il decreto prevede l'adozione di un sistema di "elenchi positivi" a livello europeo, che identificheranno i materiali autorizzati. Questa misura non solo assicura la qualità dell'acqua dalla fonte fino al rubinetto, ma fornisce anche un quadro chiaro e armonizzato per produttori e operatori, riducendo i rischi di contaminazione chimica e biologica.

Ufficio tecnico: tech@microtem.it
Ufficio commerciale: sales1@microtem.it
Numero Verde microtem.com
ReMaF e nuova DWD:
cosa cambia per bar, ristoranti e hotel
di Elisabetta Orlando, Sales Support ICIM SpA
In un settore in cui il gusto del caffè, la purezza dell’acqua e la sicurezza del ghiaccio incidono direttamente sulla soddisfazione dell’ospite, la conformità dei mezzi filtranti non è più un dettaglio tecnico ma un requisito competitivo e un elemento di reputazione. In questo contesto i ReMaF - Reagenti chimici e Materiali Filtranti - come resine a scambio ionico, carboni vegetali/attivi e membrane a osmosi inversa, sono oggetto delle novità introdotte dalla Direttiva europea sulle acque potabili (DWD).
Macchine, impianti e attrezzature che utilizzano acqua potabile trattata (es. erogatori d’acqua e distributori di ghiaccio) rientrano pienamente nel perimetro della Drinking Water Directive (DWD) quando impiegano ReMaF. Questo si traduce in prescrizioni più stringenti su idoneità al contatto con acqua destinata al consumo umano, sul controllo dei sottoprodotti di filtrazione e della stabilità delle prestazioni nel tempo. È necessario sottostare a specifiche d’acquisto più rigorose, protocolli di lavaggio e sanificazione, sostituzione periodica dei media, test di migrazione/rilascio, qualifica dei fornitori e validazione delle performance in campo. L’obiettivo è duplice: garantire il mantenimento della sicurezza e mantenere costante l’esperienza sensoriale delle bevande.
Nei contesti Ho.Re.Ca. i sistemi di filtrazione e trattamento dovranno essere realizzati con materiali inclusi nelle
Liste Positive Europee (EUPL), e rispettare una stringente conformità documentale. Per gli operatori significa pretendere dichiarazioni di conformità aggiornate, identificazione univoca dei componenti, rintracciabilità dei lotti, manuali con condizioni di impiego (temperatura, portata, pressione, capacità) e limiti chiari di fine vita del mezzo
filtrante. Per i buyer, la differenza la fa un capitolato che lega la fornitura a prove di laboratorio riconosciute e ad un piano di manutenzione tracciato.
La trasparenza verso il consumatore è un principio forte introdotto dalla DWD: non basta servire acqua sicura, bisogna comunicarlo. Ristoranti e hotel sono chiamati a fornire informazioni chiare sul trattamento applicato e sulla qualità percepita dell’acqua servita. Questo si traduce anche nell’indicare nella carta del menu l’origine dell’acqua (rete, microfiltrata, osmosi con remineralizzazione), rendere consultabili - anche tramite l’utilizzo di QR code - i parametri essenziali e la data degli ultimi controlli, formare il personale per rispondere con competenza su sicurezza e caratteristiche organolettiche.
La fiera HOST - International Hospitality Exhibition - rappresenta per gli operatori il punto d’incontro fra tecnologia e conformità: ReMaF conformi alle liste positive europee, sensori per il monitoraggio della capacità residua, piani HACCP integrati, contratti di service orientati alla prevenzione. Il percorso consigliato? Audit iniziale per la verifica degli impianti, mappatura dei ReMaF utilizzati, piano di
adeguamento con timeline definite, formazione del personale e predisposizione di un kit di comunicazione dedicato al cliente finale.
La DWD non è solo un obbligo, è un’opportunità per elevare standard e fiducia. Acqua e ghiaccio più sicuri, caffè più costante, zero sorprese in ispezione e un racconto trasparente al cliente. Chi investe ora su ReMaF conformi e sulla buona informazione sarà, domani, un punto di riferimento per l’intero settore.
Grazie a una consolidata esperienza nel settore water contact, le società di ICIM Group uniscono competenze normative, tecniche e di laboratorio per offrire un servizio integrato, in grado di affiancare le imprese del comparto in ogni fase del percorso verso la conformità. Dalla formazione alla consulenza, fino alla realizzazione delle prove e al rilascio delle certificazioni, ICIM Group garantisce un processo strutturato, efficiente e conforme ai requisiti nazionali e internazionali, attraverso un approccio tecnico, normativo e documentale completo.


Acqua del rubinetto, fiducia in crescita
di Giusy Palladino, Association Manager Aqua Italia
Il consumo di acqua trattata del rubinetto sta diventando una scelta sempre più consapevole da parte degli italiani, anche al di fuori delle mura domestiche. Secondo l’indagine 2024 condotta da Open Mind Research per Aqua Italia – l’associazione di Anima Confindustria che riunisce i costruttori di impianti per il trattamento delle acque primarie – cresce la fiducia dei consumatori nei confronti dell’acqua del rubinetto opportunamente trattata, anche quando viene servita nei ristoranti.
Un dato significativo riguarda proprio il comportamento dei clienti nei locali pubblici: solo il 16,9% delle persone dichiara oggi di rifiutare l’acqua trattata del rubinetto al ristorante. È un leggero ma significativo calo rispetto al 17,4% rilevato nel 2021, segnale di un’evoluzione culturale in corso. Il cambiamento è ancora più evidente nel Sud Italia e in Sicilia, dove la quota di chi esprime diffidenza verso quest’abitudine è scesa al 19,1%, con un calo di oltre tre punti percentuali in soli tre anni. Secondo Lorenzo Tadini, presidente di Aqua Italia, questi dati sono incoraggianti, ma indicano anche la necessità di continuare a investire in formazione e informazione. I gestori dei locali, in particolare, possono giocare un ruolo chiave nel promuovere una maggiore trasparenza e fiducia verso l’acqua trattata. «Gli esercizi commerciali possono fare la differenza», afferma Tadini, sottolineando come una corretta comunicazione della qualità e della sicurezza dell’acqua servita possa contribuire in modo concreto a diffondere pratiche più sostenibili. In quest’ottica si inserisce anche la nuova iniziativa lancia-
ta da Aqua Italia: un video promozionale che ha come protagonista d’eccezione Leonardo da Vinci. Il progetto, concepito per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del consumo di acqua del rubinetto – a casa come al ristorante – propone una visione moderna e sostenibile del tema, capace di coniugare tradizione e innovazione. Attraverso la figura del genio rinascimentale, il video mira a stimolare una riflessione profonda sui benefici ambientali ed economici dell’acqua del rubinetto.
«L’acqua del rubinetto è un’opzione che migliora la gestione degli spazi, ottimizza l’igiene e riduce i costi operativi», spiega Tadini. E nel video Leonardo lo ricorda con semplicità ed efficacia: “Fa bene a chi la serve, a chi la beve, al nostro pianeta, ed è pure buona!”.
Con questa iniziativa, Aqua Italia intende coinvolgere cittadini e imprese, rafforzando una cultura del consumo responsabile e sostenibile dell’acqua. Una risorsa preziosa, spesso sottovalutata, ma che può fare davvero la differenza – per l’ambiente, per la salute e per il futuro di tutti.
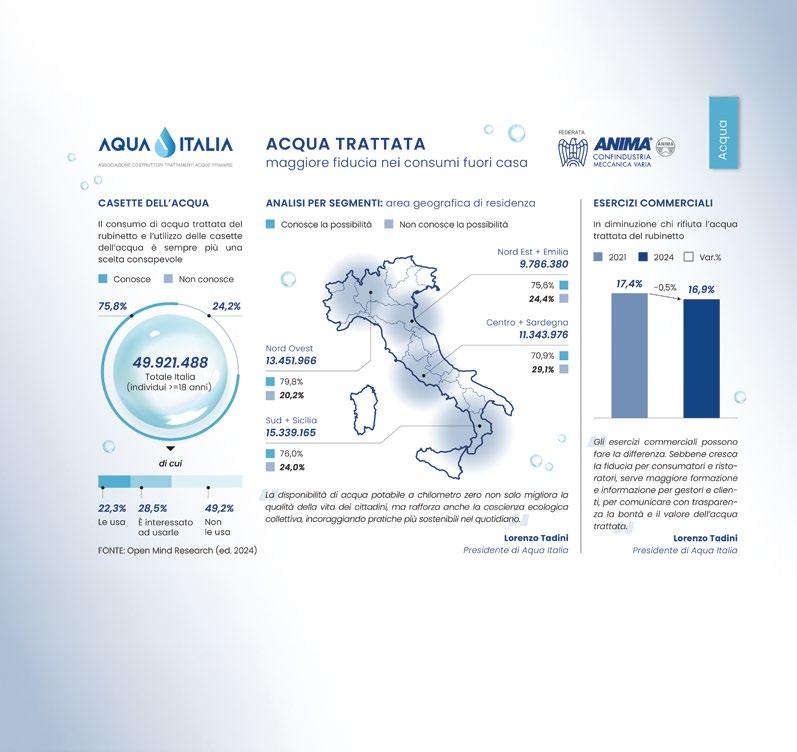
La finitura nel mondo del food
Funzione, estetica e sicurezza per una filiera più competitiva
di Manuela Casali, Association Manager UCIF
La finitura viene spesso considerata un passaggio “tecnico” o secondario, ma in realtà è ciò che determina la qualità finale di un prodotto, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Nel mondo di Anima Confindustria, Ucif (Unione Costruttori Impianti Finitura), attiva dal 1973 e rappresentante di oltre il 50% della produzione italiana di macchinari e impianti per il trattamento delle superfici, conosce bene questa realtà. In particolare, nel settore alimentare, l'importanza della finitura è ancora maggiore: qui la superficie non deve solo essere esteticamente gradevole, ma deve soprattutto garantire igiene, sicurezza e resistenza nel tempo. Pensiamo, ad esempio, a una posata, a un utensile professionale da cucina o a un componente di una macchina destinata alla trasformazione alimentare. Dopo lo stampaggio, la presenza di bave, spigoli o imperfezioni può non solo compromettere l’aspetto, ma rappresentare un rischio per l’utilizzo quotidiano. Allo stesso modo, un rivestimento poco performante può tradursi, dopo pochi mesi di impiego, in superfici segnate, opache o con difetti visivi che incidono sull’esperienza del consumatore e sull’immagine del brand.
Per questo la finitura post stampo e le tecnologie di rivestimento giocano un ruolo determinante: la prima elimina difetti e imperfezioni, garantendo funzionalità e sicurezza d’uso; la seconda protegge e preserva la superficie nel tempo, assicurando che l’oggetto rimanga visivamente e
qualitativamente ineccepibile anche dopo numerosi cicli di utilizzo e lavaggio.
La finitura, quindi, non è solo estetica: è funzionale e contribuisce a stabilire la reputazione di un prodotto e di un marchio. In un mercato come quello del food — dove il consumatore associa la brillantezza di una posata, la pulizia di un utensile o l’igiene di un contenitore alla qualità complessiva — gli impianti di trattamento delle superfici diventano strumenti strategici. Oggi, le tecnologie disponibili consentono di affrontare in modo efficace sia le esigenze di igiene e sanificazione sia quelle di efficienza produttiva. Impianti moderni, compatti e automatizzati permettono di ridurre tempi, costi e manodopera, garantendo al contempo standard qualitativi elevati e certificazioni compatibili con l’uso alimentare. È su questo terreno che operano realtà come Kenosistec, Rösler Italiana e Rollwasch, che hanno sviluppato soluzioni mirate per il settore food, capaci di coniugare efficienza, innovazione e sicurezza.
Kenosistec. Finiture PVD: farsi notare nel settore Ho.Re.Ca.
Possiamo considerare il brand come la somma di ogni singola percezione che il cliente sperimenta. Molto prima di assaggiare un piatto o provare un servizio, il cliente tocca il brand, sente il peso di una forchetta, sperimenta la finitura
impeccabile di un rubinetto in bagno, percepisce la sensazione di solidità di una maniglia: questi sono i primi segnali della vostra proposta di valore. "La prima impressione non è tutto, ma dice tanto." L’occasione speciale è tutti i giorni.
Investire in una finitura come il PVD è innanzitutto una scelta strategica che si traduce in una percezione migliorata del brand. Questa tecnologia permette di comunicare al cliente un valore immediato e tangibile.
Oltre all’impatto iniziale, il PVD è uno strumento fondamentale per creare coerenza visiva. La sua capacità di offrire una palette di colori stabili e perfettamente replicabili consente di costruire un’identità di brand solida e riconoscibile. Immaginiamo, ad esempio, di declinare la stessa tonalità “Antracite” sulle posate, sul lampadario in sala, sulla rubinetteria dei bagni, sui profili delle docce nelle camere e sui più piccoli dettagli degli accessori: si crea un fil rouge estetico che lega ogni ambiente.
Infine, il PVD garantisce longevità all’immagine. Un marchio di qualità deve apparire tale ogni giorno, senza compromessi. Mentre le finiture economiche si graffiano, si macchiano e si rovinano, la straordinaria resistenza del PVD all’usura e ai lavaggi continui protegge l’investimento iniziale, mantenendo l’aspetto impeccabile nel tempo e salvaguardando la percezione di qualità e valore.
Finiture nobili su materie plastiche Il PVD su metallo è il vertice della qualità, ma la sfida è sempre stata coniugare estetica, leggerezza e controllo dei costi, specialmente per oggetti di forme complesse o sensibili al peso. Nuovi processi consentono oggi di ottenere finiture metalliche impeccabili anche su substrati polimerici, aprendo scenari rivoluzionari. Si ottengono così vantaggi di:
• leggerezza ed ergonomia: manici leggeri per coltelli e piccoli elettrodomestici senza rinunciare all’aspetto premium.
• libertà di design: forme elaborate e personalizzazioni prima impensabili.
• ottimizzazione dei costi: materiali polimerici rivestiti con finiture metalliche avanzate per un risultato estetico e funzionale eccellente.
Il PVD rappresenta molto più di una semplice finitura tecnologica: è una scelta strategica che fonde estetica, funzionalità e durabilità per costruire un’identità di brand forte e riconoscibile nel settore Ho.Re.Ca. Grazie a questa tecnologia, i marchi possono offrire un valore immediato e tangibile al cliente, trasmettendo lusso, cura e attenzione al dettaglio in ogni elemento, dalla posateria agli accessori bagno.
La coerenza visiva creata dal PVD genera un fil rouge estetico che unisce ogni ambiente, dalla sala alla cucina, fino all’area bagno, rafforzando la percezione di qualità e affidabilità che perdura nel tempo. Investire in PVD significa proteggere l’immagine del brand ogni giorno, mantenendo intatto l’aspetto impeccabile del primo giorno e sostenendo posizionamenti premium.
Antonio Angolemme, Sales & Marketing Director di Kenostenic, riassume con passione questa visione «Design Finishes Here» una frase nata insieme a Simone Colombo, alleato in questa crociata intrapresa insieme in Kenostenic per educare sul PVD.
Antonio sottolinea come oggi le sfide nel mondo delle finiture siano legate a un equilibrio raffinato tra bellezza, tecnologia, innovazione e valore. Anche prodotti classici, come la posateria e l’arredo in argento, simboli di raffinatezza e classe, traggono enormi vantaggi dal PVD, che allunga la vita dell’articolo, ne preserva la qualità e, talvolta, ne rende più accessibile l’uso. «Prezioso non è soltanto il metallo con cui si crea l’articolo, ma tutta l’arte produttiva che oggi le tecnologie permettono di esprimere». Anche un semplice ferma tovaglia o una lampada da tavola in acciaio inox possono diventare elementi iconici di valore, grazie all’applicazione del PVD, che ne esalta resistenza ed estetica.
Rösler Italiana
Le posate lucenti e prive di macchie non sono soltanto un dettaglio estetico: sono un vero e proprio biglietto da visita per ristoranti, mense e società di catering. L’asciugatura manuale di coltelli, forchette e cucchiai, oltre a richiedere molto tempo e manodopera, comporta costi elevati e rischia di lasciare aloni poco gradevoli. Per rispondere a queste esigenze, Rösler Italiana ha sviluppato sistemi automatici per la pulizia, l’asciugatura e la lucidatura delle posate, capaci di trattare fino a 8.000 pezzi all’ora. Le macchine Cutlery Dryer CD, impiegano media granulari naturali e sterili che, combinati a una lampada UVC, garantiscono superfici brillanti, asciutte e igienizzate.
Accanto a questi impianti, la macchina Cutlery Cleaning RCC, combinata con la RCD, permette di rimuovere delicatamente anche i residui secchi di cibo senza necessità di pre-lavaggio manuale. Questo processo, oltre a ridurre il personale necessario, consente un risparmio significativo di acqua, energia e detergenti.
I sistemi Rösler, inoltre, non si limitano alla semplice pulizia: grazie al processo Keramo-Finish® e a trattamenti di vibrofinitura dedicati, è possibile eliminare graffi e segni di ossidazione, il tutto nel rispetto degli standard di igiene più rigorosi, come la normativa DIN 10510.2008-06. Le soluzioni Rösler si concentrano sulla pulizia e lucidatura delle posate con sistemi modulari e automatizzati; un altro fronte cruciale nel settore food è quello della pulizia profonda e versatile di componenti complessi: qui entra in gioco la tecnologia di Rollwasch, che ha unito vibrofinitura e ultrasuoni per offrire un approccio innovativo al lavaggio industriale.
Rollwasch
Con Ecosonic, Rollwasch ha sviluppato una soluzione che integra lavaggio, risciacquo e asciugatura in un unico ciclo automatico, riducendo tempi, costi e ingombri rispetto agli impianti tradizionali. Questa tecnologia si distingue per la sua natura multidisciplinare, frutto della collaborazione con partner europei e dell’esperienza maturata nella vibrofinitura.
Il cuore del sistema è la vasca circolare di vibrofinitura, che mette in movimento i pezzi in modo tridimensionale grazie a speciali media vettoriali. A questo movimento viene abbinata l’azione di sonotrodi in titanio, che generano ultrasuoni multifrequenza da 20 a 135 kHz. L’effetto combinato produce una cavitazione controllata che rimuove impurità, residui e contaminanti anche dalle geometrie più difficili, con risultati di pulizia e sanificazione estremamente profondi.
Le vasche di lavaggio e risciacquo, riscaldate e termo-controllate, alimentano l’impianto con liquidi costantemente filtrati. A fine ciclo, un sistema di insufflazione di aria calda — eventualmente preceduto da un getto di vapore saturo additivato con perossido di idrogeno — assicura asciugatura e igienizzazione, riducendo al minimo il rischio di contaminazioni residue.
La finitura nel food non è un passaggio secondario, ma una tecnologia abilitante che abbraccia dimensioni diverse: l’estetica e il branding, con le soluzioni PVD di Kenosistec; l’igiene e la brillantezza quotidiana, con i sistemi automatici di Rösler Italiana; la pulizia profonda e sostenibile dei componenti, con la tecnologia ECOSONIC di Rollwasch. Tre approcci differenti ma complementari,
che dimostrano come la finitura sia oggi il punto di incontro tra funzione, bellezza e sicurezza. Investire in impianti e processi performanti significa proteggere il valore dei prodotti e del brand, rispondendo alle esigenze di un mercato che non ammette compromessi.
La riflessione sulle tecnologie per il food si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione della finitura, dove innovazione, sostenibilità e digitalizzazione diventano driver strategici per tutta la filiera. In questo scenario, UCIF – Unione Costruttori Impianti di Finitura, associazione di Anima Confindustria che rappresenta oltre il 50% della produzione italiana di macchinari e impianti per il trattamento delle superfici, svolge un ruolo fondamentale nel dare voce alle imprese del settore, promuovendone lo sviluppo e la competitività sui mercati internazionali.
Tra le iniziative più rilevanti vi è il convegno SMART’26, che si terrà a Milano il 20 maggio 2026: un appuntamento che vuole essere momento di aggiornamento e networking per i player più attenti della filiera, attraverso il confronto diretto fra aziende, istituzioni e mondo accademico. Casi concreti, testimonianze e progetti saranno al centro di un dibattito che mira a delineare le traiettorie future del settore.
Accanto al convegno, UCIF ha avviato ulteriori progetti di divulgazione e valorizzazione della cultura della finitura, tra cui il portale SMART – Surface Manufacturing Advanced Research Trends, pensato come punto di raccolta e di condivisione di contenuti, esperienze e riflessioni legate al mondo del trattamento delle superfici. Uno strumento a disposizione di imprese, professionisti e ricercatori per creare una community aggiornata e proiettata verso l’innovazione.
UCIF vanta inoltre un legame profondo con il mondo accademico: è infatti socio fondatore di Poliefun, l’associazione che funge da ponte tra università e industria nel campo del trattamento delle superfici. Questo legame sottolinea l’importanza di essere presenti nei luoghi dove si formano i futuri attori del settore, contribuendo al percorso formativo delle nuove generazioni e mettendo a disposizione delle imprese un ruolo di counseling, utile a orientare studenti e giovani ricercatori verso le reali esigenze del mercato. Con queste iniziative, UCIF conferma la propria missione di rappresentanza e di supporto alla crescita del settore, creando occasioni concrete di dialogo, collaborazione e visione comune sul futuro della finitura.


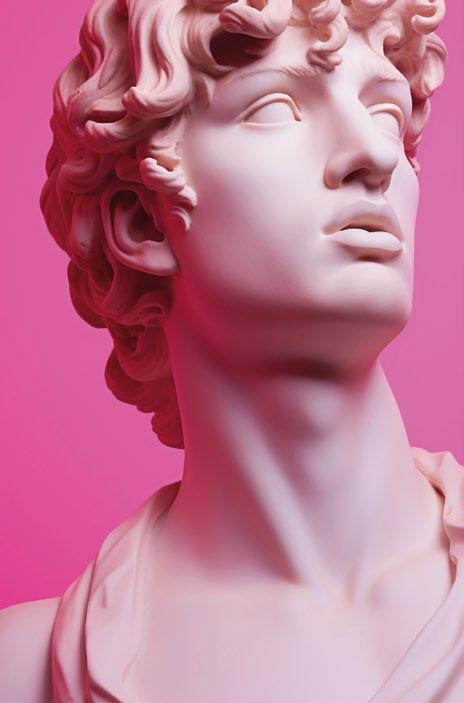


SOSTENIBILITÀ













WWW.SMART-UCIF.IT


UCIF annuncia la prossima edizione di SMART, il convegno biennale dedicato all’innovazione nel trattamento delle super ci. Un evento che, da anni, rappresenta il punto di riferimento per analizzare lo stato dell’arte tecnologico e per esplorare le evoluzioni industriali e culturali del settore.


















We deliver excellence
Raffreddamento modulare
Torre evaporativa
MITA Cooling Technologies presenta la nuova torre evaporativa a circuito aperto PME-XL, ideale per elevate necessità di raffreddamento. Una singola cella PME-XL può smaltire fino a 5 MW di potenza termica, offrendo modularità ed efficienza con un unico ventilatore e la propria vasca di raccolta acqua in vetroresina. Pre-assemblaggio in fabbrica: ideale per una rapidissima installazione e facilità di manutenzio
www.mitacoolingtechnologies.com

Intralogistica
Realtà virtuale nell'intralogistica
Ideata da CLS iMation, GEMINI è la nuova suite immer
siva di realtà virtuale per la progettazione di soluzioni nell’ambito dell’intralogistica e della logistica di fab brica. La nuova soluzione va oltre il concetto di simu lazione e comprende strumenti che offrono ai clienti un’esperienza immersiva e coinvolgente già nella fase di progetto, consentendo di progettare e configurare soluzioni su misura, massimizzando il valore delle ope razioni nell’impianto e minimizzando costi e tempi di installazione.
www.cls-imation.com

Centrali frigorifere
Globo
Globo, centrale frigorifera a CO2 operante in ciclo transcritico, è ideale per le superfici di piccole dimensioni. Combina la refrigerazione per normale e bassa temperatura sullo stesso telaio, offrendo massime prestazioni. Se installata all’esterno, garantisce sicurezza e silenziosità tramite pannelli isolanti acustici.
Mini Booster
Mini Booster, la centrale transcritica a CO2, è ideale per impianti a normale e bassa temperatura in punti vendita di medie dimensioni. Offre massima adattabilità, avendo un minor numero di compressori e dimensioni contenu te. Disponibile nella versione aperta e chiusa, può recuperare calore per otte nere acqua calda sanitaria e riscaldare il negozio.
www.arneg.com

Tenuta meccanica Microtem MTM111
La MTM111 è una tenuta meccanica bilanciata con camicia d’albero incorporata, bidirezionale con multi-molla. Grazie alla geometria con cui è stata progettata questa tenuta meccanica, le molle della MTM 111 non lavorano mai a contatto con il prodotto, rendendola adatta a tutti gli impieghi con liquidi altamente viscosi e parti solide in sospensione. È prevista in differenti configurazioni di materiali ed è realizzata per adattarsi al meglio a moltissime tipologie di macchinari.
www. microtem.com

Limiti d’impiego
d = da 20 mm (0,78 mm) fino 100 mm (4″) *

p1 = 25 bar (363 psi)
T = da -40°C (-40°F) a +220°C (+428°F)
vg = 20 m/s (66 ft/s)
Movimento assiale : +/-1,0 mm
* Disponibile anche in pollici
Robot industriali
Applicazioni
Convenzioni per i soci anima MENO SPESE, PIÙ VALORE!
ANIMA Con ndustria ha sviluppato un esclusivo programma di proprie convenzioni e accordi con partner strategici di business. I settori coinvolti sono i più vari e ciascuno contribuisce a un concreto supporto nell’attività aziendale quotidiana dei Soci di ANIMA. Le schede dettagliate delle convenzioni sono disponibili per i Soci all’interno dell’area riservata del sito ANIMA (inserendo le chiavi di accesso).
Inoltre tutti i soci usufruiscono in modo automatico anche dei vantaggi legati alle Convenzioni di Con ndustria, in quanto ANIMA appartiene al Sistema Con ndustria.
AMBIENTE - EFFICIENZA ENERGETICA
Ecoped (RAEE) Ridomus (RAEE)
ERP ITALIA (Gestione ri uti speciali professionali)
SERVIZI PER L’EXPORT
Desk ANIMA AFRICA - Kili Partners
Desk ANIMA MEDIO ORIENTE e INDIA - Winh
Desk ANIMA EU - Multi
Desk ANIMA EXPORT FINANCE - Golden Group
Desk ANIMA IRAN - IB Market
Desk ANIMA USA - BMV Law Tax Finance
Dogana Facile - Easyfrontier
Export USA (Consulenza USA)
CONSULENZA E SERVIZI PER LE AZIENDE
AIPSA (Associazione Sicurezza - Cyber Security)
Atradius Collections (Recupero crediti)
AWMS (Gestione Forza Lavoro)
Cribis (Informazioni societarie)
DDocuments Gruppo INAZ (digitalizzazione documenti)
Doxinet (soluzioni IT)
Expense Reduction Analysts (Gestione costi e fornitori)
FI-Group (Consulenza Agevolazioni Fiscali)
Imagine Traduzioni
Matchplat (Analisi di mercato)
Pellegrini Welfare (Welfare - Ristorazione aziendale)
Sanmarco Informatica (Consulenza e soluzioni tecnologiche)
Sharp (Soluzioni e dispositivi elettronici)
Sicuritalia (Security Solutions)
Studio Maldera (INAIL)
Modello RS025N di Kawasaki Robotics
Sicuritalia (Travel Security)
Acque bianche e acque grigie
Industria di processo
Industria chimica
Industria alimentare
Industria cartaria
Industria petrolifera
Industria energetica
Zuccherifici
Pompe centrifughe
Pompe Marine
Migliorano le caratteristiche tecniche con l’aumento dell’area di lavoro a 1.885 mm, della portata a 25 kg e della velocità. Il livello di protezione del braccio è interamente IP67, è pressurizzabile e dispone di una serie di utenze già installate di serie all’interno del braccio come una valvola bistabile, ingressi e uscite personalizzabili e il Power over Ethernet PoE. RS025N dispone del controllore Kawasaki F02 e di una nuova tastiera di programmazione con performance e funzioni evolute.
Pompe a viti
Elevato contenuto di solidi e abrasivi
www.tiesserobot.it
Elevata viscosità
Temperature elevate
info@microtem.it Ufficio tecnico: tech@microtem.it Ufficio commerciale: sales1@microtem.it microtem.com
ORGALIM (Condizioni generali - pubblicazioni legali)
STUDI LEGALI
Lexant Studio Legale
Studio Legale Iureconsulti
Studio Legale Pavia e Ansaldo
Studio Legale Cartwright - Pescatore Valla & Associates, Inc. P.C.
ICIM Spa
ICIM Consulting CEI (Consultazione norme tecniche)
Traslo (Traduzioni)
Valyouness (Welfare)
GALLETTI galletti@anima.it www.anima.it/convenzioni-anima
presso il partner.
ALBERGHI