
8 minute read
Realtà aumentata e didattica curricolare Giuseppe Alessandri
REALTÀ AUMENTATA E DIDATTICA CURRICOLARE
di Giuseppe Alessandri
PAROLE CHIAVE: REALTÀ VIRTUALE, REALTÀ AUMENTATA, HEAD-MOUNTED DISPLAY, HAND-HELD DISPLAY, COMBINAZIONE, IPERTESTUALITÀ
La Realtà Aumentata (AR) è una combinazione di tecnologie quali la Realtà Virtuale e l’ipertestualità. È fruibile con dispositivi indossabili (HMD: Head-Mounted Display) o su mobile device (HHD: Hand-Held Display). Consiste nella visione “aumentata” di una parte di mondo reale mediante l’inserimento fra noi e il mondo di uno strato di informazioni virtuali (HMD) oppure attraverso la visualizzazione sul display del device (HHD) di informazioni che si sovrappongono o che descrivono il mondo inquadrato.
1. Realtà Virtuale e Realtà Aumentata
Le tecnologie possono essere considerate come combinazioni di altre 1
e la Realtà Aumentata (AR:
Augmented Reality) è almeno combinazione della Realtà Virtuale (VR: Virtual Reality) e dell’ipertestualità. Nasce nei laboratori della Boeing, nel 1990 2 quando, per ottimizzare il montaggio dei circa cinque milioni di pezzi del Boeing 747, si pensò di utilizzare tecniche di VR, invece di ricorrere all’uso di una miriade di manuali cartacei. Le esperienze di VR 3 si realizzavano facendo indossare agli esseri umani dei dispositivi, in genere un casco la cui visiera fungeva da video. Su di essa si proiettava una generata realtà tridimensionale; la prospettiva era focalizzata sul punto di vista dell’indossatore e teneva conto degli spostamenti del suo capo; in questo modo colui che indossava il casco vedeva rimodellata continuamente la realtà ricreata. Il passo che portò alle prime realizzazioni di AR fu il rendere trasparente la visiera cosicché il lavoratore, addetto al montaggio, vedeva la parte reale sulla quale stava lavorando e, proiettata sulla visiera, una realtà costruita digitalmente che indicava le azioni da fare. La sovrapposizione avveniva perché il casco era dotato di una telecamera che digitalizzava continuamente quanto veniva inquadrato inviando frames a un software, in un server. Il software, che aveva proprie collezioni di frames con delle informazioni digitali collegate, confrontava continuamente i propri con quelli ricevuti e quando verificava un’uguaglianza, inviava all’utente le informazioni collegate che venivano visualizzate sullo schermo, generando una rappresentazione sovrapposta al mondo reale. Oggi il casco è stato sostituito da speciali occhiali dotati di telecamera ma il funzionamento è rimasto identico 4 . Tale modalità di fruizione, chiamata Head-Mounted Display (HMD), dispone, lungo la linea della nostra visione, uno strato intermedio di informazioni digitali che si sovrappone al mondo reale. Quindi la AR si basa sulla sovrapposizione di due livelli di “ Le esperienze di VR si realizzavano facendo indossare agli esseri umani dei dispositivi, in genere un casco la cui visiera fungeva da video. Su di essa si proiettava una generata realtà tridimensionale; ”
1 Cfr. Arthur 2011, p. 16. 2 Cfr. Communication Strategies Lab 2012, cap. 1. 3 In questo contesto si fa riferimento alla VR immersiva; esistono anche quelle semi-immersiva e non immersiva. 4 Un esempio: https://www.youtube.com/ watch?v=3e4wHsZOr2g; ultima visualizzazione: 05/07/2020.
presentazione: al livello della realtà viene sovrapposto quello che fornisce informazioni digitali aggiuntive. Nel tempo, l’AR è divenuta fruibile anche su dispositivi mobili (HHD: Hand-Held Display) nelle due modalità: Vision based AR e Location based AR. Nel primo caso quando si inquadrano oggetti, ambienti, immagini o codici (QR CODE: Quick Response CODE) con la telecamera di un dispositivo mobile, le applicazioni AR rintracciano le informazioni collegate e le presentano sul video del dispositivo; nel secondo caso i sensori del dispositivo rilevano la posizione, l’orientamento e l’inclinazione dello stesso e se esiste, nella collezione, un punto con analoghe “coordinate” vengono visualizzate sul video le informazioni collegate a quel luogo. Sia la Vision che la Location based AR, una volta individuato con la telecamera del dispositivo un segmento di mondo, permettono di visualizzarlo sul display insieme a un sovrapposto strato artificiale (inquadrando un mobile è possibile vederlo arredato con dei soprammobili) o di vedere un “nuovo mondo” sul display (inquadrando il Palazzo degli Uffizi a Firenze è possibile vedere dei percorsi virtuali lungo i vari piani e stanze). Nella nota 5 è indicato l’url di un ebook che presenta un itinerario per costruire un’esperienza del secondo tipo 5 .
2. Didattica e Realtà Aumentata
Nelle linee generali possiamo individuare due modalità di approcciarsi alla AR: si può fruire di una esperienza di AR già realizzata oppure si può costruirne una. In riferimento alla Didattica, nel primo caso, analizzeremo situazioni che privilegiano l’utilizzo del libro di testo ed espressioni di didattica laboratoriale attraverso le simulazioni e, nel secondo, situazioni che rimandano al sempre valido orientamento alla costruzione nell’apprendimento. Il libro di testo fornisce un aiuto agli studenti affiancandoli nella quotidiana attività scolastica e nei momenti di studio individuale. Tuttavia il modello costitutivo di un libro esplicita un sapere codificato e verbalizzato in forma testuale che rimanda a una simbolizzazione della conoscenza e

a continue decodificazioni e ricostruzioni di significati, faticose e anche foriere di fraintendimenti. Sono, allora, opportuni dei sostegni per facilitare la capacità di comprensione e di concettualizzazione che esse richiedono. In tal senso possono essere significative le esperienze di AR del tipo Hand-Held Display. Attraverso un’immagine-ancora in un libro, a un contenuto se ne sovrappone un secondo che arricchisce l’orizzonte conoscitivo della situazione che si sta osservando e svela percorsi diversi che possono facilitare l’assimilazione dei contenuti. Tanto più gli itinerari di apprendimento sono sostenuti da finestre abilitanti la propria capacità di comprensione, tanto più si evitano risvolti ripetitivi e mnemonici. A margine ricordiamo che quanto presentato può essere un esempio di BYOD 6 della Buona Scuola. Per quanto concerne l’approccio laboratoriale attraverso le simulazioni, possono essere utili esperienze AR del tipo Head-Mounted Display. «Una simulazione è una teoria dei meccanismi, dei processi e dei fattori sottostanti a certi fenomeni, tradotta in un programma per computer» 7 .
5 Cfr. http://www.didafor.com/ar/index.htm; ultima visualizzazione: 05/07/2020. 6 BYOD: Bring Your Own Device.
In questo caso un programma per computer è un’esperienza di AR. In laboratorio si ricostruisce una situazione reale che viene aumentata attraverso opportuni oggetti da indossare (ad es. occhiali AR); l’insieme restituisce nuovi significati, veicola nuove prospettive che aiutano nella comprensione di fenomeni; si vive un “apprendimento in azione”. Il lavoratore del video indicato nella nota 4 non conosce la soluzione, ma operando risolve il problema, impara facendo: ma è proprio vero?! Occorre precisare che si “apprende in azione” quando costantemente si riflette durante l’azione: non si può solo ripetere un suggerimento, ma occorre confrontarlo con ciò che si ha intenzione di fare, occorre cioè conoscere l’intero progetto per dare senso a quello che si sta facendo. Inoltre è parimenti importante la riflessione sull’azione: dopo aver eseguito l’attività, occorre riflettere su ciò che è stato fatto e spiegare a se stessi e agli altri il significato del proprio percorso. Esperienze di questo genere possono essere realizzate anche con Hand-Held Display AR ottenendo sul display del dispositivo quello che si vedrebbe sugli occhiali. A completamento, ci soffermiamo sulla possibilità di costruire esperienze di AR. Il mai dimenticato Papert ci dice che è maggiormente stabile un apprendimento se questo passa attraverso la costruzione di un artefatto. Una fra le tante possibilità, ricordando quanto scritto precedentemente, è quella di costruire esperienze di Hand-Held Display AR per “aumentare” i libri di testo individuando i punti che meritano degli approfondimenti. Ciò rimanda alle realizzazioni ipertestuali, infatti l’integrazione di conoscenza di un oggetto con un insieme di informazioni che ne completano l’orizzonte, tipica dell’AR, realizza uno dei

principali obiettivi delle creazioni ipertestuali 8 . Esiste tuttavia una sostanziale differenza; negli ipertesti occorre digitalizzare tutto il mondo che si sta prendendo in considerazione mentre nell’AR, si ha una situazione ibrida: parti di mondo o contenuti su carta sono collegati a informazioni digitalizzate, richiamate all’esigenza. La costruzione di esperienze è facilitata dall’utilizzo di ambienti di building che diverse case di software mettono a disposizione. Uno di questi è Blippar utilizzato nel percorso esposto nella nota 5. È auspicabile che i docenti divengano costruttori di esperienze di AR insieme agli studenti piuttosto che

ricercatori di qualcosa che già esiste che però si rischia di propinare senza la dovuta personalizzazione.
3. Una considerazione finale
Le esperienze Hand-Held Display si fruiscono con dispositivi esterni, non indossabili, e ciò segna un distacco dal modo consueto di vedere la realtà, che mette in evidenza che si sta gestendo qualcosa di artificiale. Però se ci abituassimo a viverle attraverso degli occhiali o delle lenti a contatto che ricostruiscono nella nostra retina segmenti
7 Cfr. Parisi 2001 in Bertacchini 2006, p. 68. 8 Una conferma di quanto affermato da Arthur in merito a tecnologie come combinazione di altre tecnologie.
di mondo 9 , finiremmo per avere la percezione che ciò che stiamo osservando sia una normale e vera realtà e avremmo una visione del mondo diversa da quella degli altri. La conseguenza sarebbe «l’apoteosi di una nuova prospettiva: la realtà “super-soggettiva”, una realtà che è più soggettiva di quanto non lo sia mai stata» 10 .
9 Cfr. Kaku 2012, p. 33. 10 Cfr. Communication Strategies Lab 2012, p. 111.
Bibliografia
• Bertacchini 2006: Bertacchini P.A., Apprendere con le mani, Franco Angeli. Milano 2006. • Arthur 2011: Arthur B., La natura della tecnologia. Che cos’è e come evolve, Codice Edizione, Torino 2011. • Communication Strategies Lab 2012: Communication Strategies Lab, Realtà Aumentate. Esperienze, strategie e contenuti per l’Augmented Reality, Apogeo, Milano 2012. • Kaku 2012: Kaku M., Fisica del futuro, Le Scienze, Roma 2012. • Morganti Riva 2006: Morganti F., Riva G., Conoscenza, comunicazione e tecnologia. Aspetti cognitivi della realtà virtuale, LED Edizioni Universitarie, Milano 2006. • Parisi 2001: Parisi D., Simulazioni. La realtà rifatta al computer, Il Mulino, Bologna 2001.
GIUSEPPE ALESSANDRI
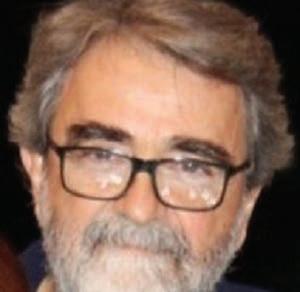
È docente universitario in quiescenza. Ha insegnato Didattica generale, Tecnologie didattiche e Fondamenti di Informatica presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di Macerata. Si è occupato di Tecnologie e di Informatica nel loro rapporto con la Didattica. Ha pubblicato diversi testi ed articoli in questi settori.











