









Accoglienza
Riflessione linguistica
Riassunto
Tipologie testuali
Antologia
Compiti di realtà
Logica linguistica
Laboratorio di scrittura (WRW)
Gruppo Editoriale ELi
Gruppo Editoriale
ELi
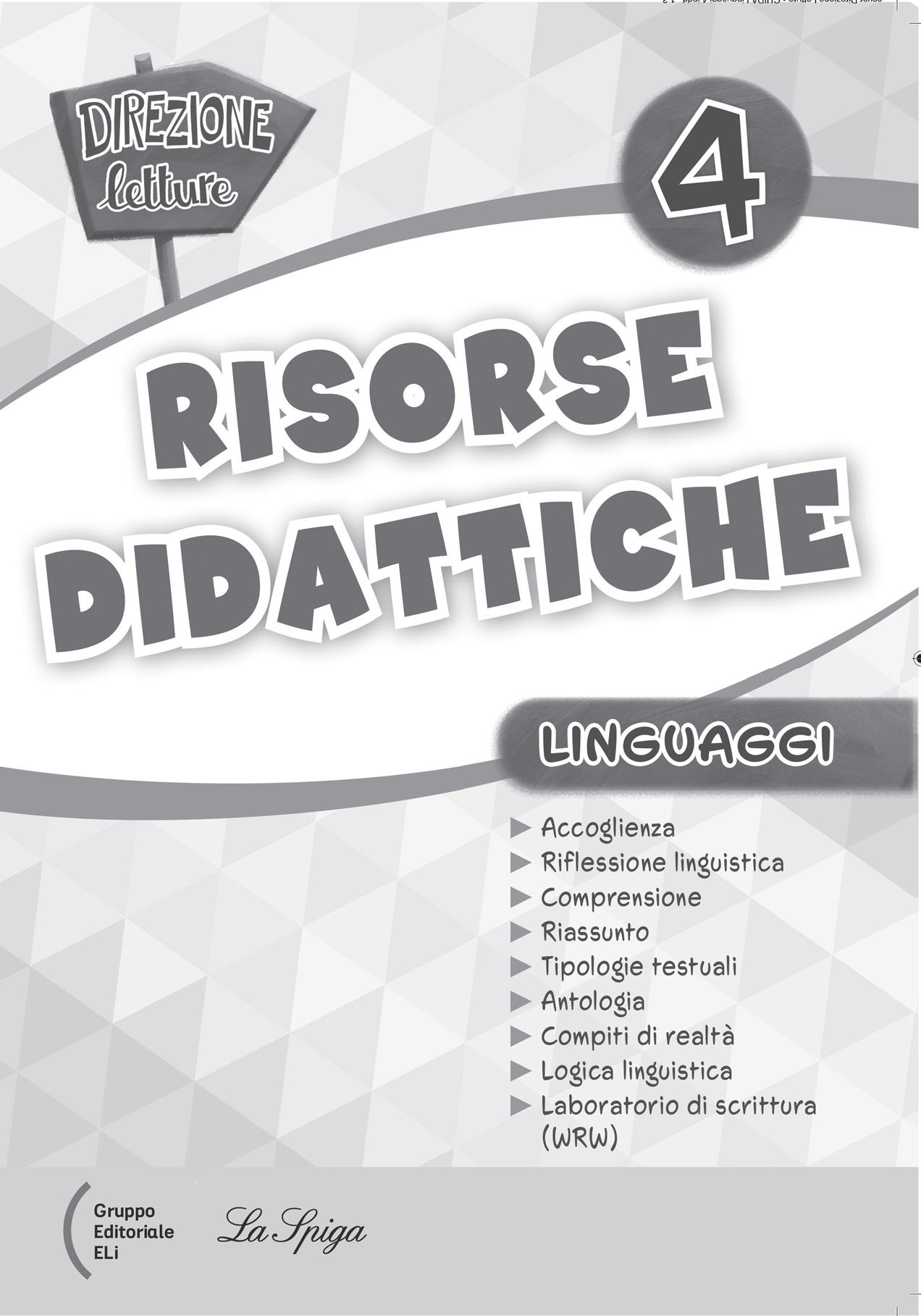
Il piacere di apprendere
3 accoglienza
6
16 Scheda personale per la rilevazione delle abilità socio-relazionali
17 Scheda personale per la rilevazione delle abilità cognitive iniziali
18 Scheda per la rilevazione delle abilità cognitive iniziali
19 Riflessione sulla lingua
20 Attività e consigli per l’insegnante
21 Dettati
38 comprensione
38 La comprensione del testo 40 Schede operative
48 riassunto
48 Il riassunto
50 Schede operative 66 tipologie testuali
66 Le tipologie testuali
67 Il testo narrativo: realistico e fantastico 68 Schede operative 78 Il racconto d’avventura
79 Schede operative 84 Il racconto fantasy 85
operative
Il racconto biografico e autobiografico
129 antologia
130 Re Artù, il cuore e la spada
133 I viaggi di Ulisse
138 TomTom e i predoni vichinghi
143 compiti di realtà
144 Il compito di realtà
145 La bacheca
146 Gara di dizione
147 L’angolo della letteratura
148 Teatro sulle onde radio
151 Fitness sulle onde radio
153 logica linguistica
154 Lo sviluppo intellettivo nella Scuola Primaria
155 La logica: un mezzo, non un fine • Perché un percorso di logica linguistica?
156 La metodologia
157 Programmazione
158 Primo Step • Indicazioni metodologiche
159 Schede operative
183 Secondo Step • Indicazioni metodologiche
184 Schede operative
208 Soluzioni degli esercizi
213 laboratorio di scrittura
214 Laboratorio di scrittura: Writing and Reading Workshop
215 I principi-chiave del WRW
216 Il laboratorio di scrittura
219 La nostra idea di laboratorio di scrittura: la bottega rinascimentale
220 IL setting: come organizzare l’ambiente
223 L’uso del taccuino
224 La valutazione nel laboratorio di scrittura
225 L’autovalutazione
229 Laboratorio introduttivo con mini-lezioni
232 Il percorso
237 Mini-lezioni
249 Schede-ancoraggio
informativo-espositivo
Il testo regolativo
119 Schede operative
128 Mappa delle tipologie testuali
Che cos’è un anno scolastico?
Oltre a essere un periodo di tempo stabilito per legge dal Ministero, l’anno scolastico è il periodo di tempo in cui i protagonisti/le protagoniste cercano di dare una risposta ai bisogni che questa ”esperienza comune” suscita. Quali sono i bisogni a inizio anno scolastico?
• Sicurezza: esprimere e riconoscere le emozioni legate al rientro a scuola.
• Ritrovare/Stabilire legami e relazioni con i pari e con gli adulti.
• Valorizzare il proprio vissuto.
• Considerare e valorizzare le proprie competenze.
• Condividere il proprio vissuto e le proprie emozioni con i pari e con gli adulti.
• Sentirsi partecipi e coinvolti.
• Ricevere informazioni, conferme e rassicurazioni.
• Ritrovare/Stabilire relazioni con gli altri genitori e con gli insegnanti.
• Costruire un percorso di fiducia con gli insegnanti per poter affrontare i problemi legati alla crescita dei propri figli.
• Conoscere i percorsi educativi e didattici.
• Conoscere le competenze del proprio bambino.
• Conoscere gli interessi dei bambini per poter progettare e/o programmare.
• Conoscere i contesti in cui le competenze si sono consolidate, per valorizzarli e inserirli nel proprio progetto.
• Stabilire/Ritrovare relazioni con i bambini e le famiglie.
Accoglienza
Obiettivi
Stare bene in classe
L’attività di accoglienza ha una valenza estremamente rilevante, perché il momento iniziale dell’esperienza scolastica è determinante per riannodare “i fili” della conoscenza, della condivisione delle esperienze, per poter, in modo proficuo, costruire il processo formativo di alunni e alunne, che stanno peraltro entrando in una fase particolare della loro crescita.
Costruire un clima sereno nella classe.
Stabilire relazioni tra bambini/e e tra bambini/e e adulti/e.
Rendere gli allievi e le allieve partecipi e coinvolti nelle attività scolastiche.
Le attività proposte nei primi giorni di scuola dovranno essere stimolanti e coinvolgenti. Questo non vuol dire che non debbano essere impegnative, ma serviranno a rassicurare gli alunni e le alunne, a passare il messaggio che l’apprendimento è piacere e soddisfazione. Dedicare spazio all’ascolto delle esperienze degli allievi e delle allieve non sarà “perdere tempo”. Se l’insegnante continuerà, come avrà già fatto negli anni precedenti, a costruire un clima sereno, a stabilire relazioni positive tra bambini/e e tra bambini/e e adulti/e e a motivare all’apprendimento, il percorso didattico dell’intero anno scolastico sarà facilitato.
Imparare insieme (cooperative learning)
Creare un’atmosfera serena di lavoro collettivo è fondamentale per mettere le basi per attuare in classe l’ apprendimento cooperativo .
Questa strategia di lavoro è fondamentale per stimolare gli alunni e le alunne alla discussione mirata all’individuazione di una soluzione condivisa di una situazione problematica, all’attuazione di strategie risolutive che coinvolgono anche chi ha scarsa fiducia nelle proprie possibilità. È il punto di partenza per l’attuazione della didattica inclusiva .
Funzione didattica
L’inizio di un nuovo percorso didattico deve fondarsi su una valida piattaforma di conoscenze e competenze.
Valutare quali siano le abilità, le conoscenze e le competenze iniziali degli alunni e delle alunne permette di avere a disposizione informazioni decisive per favorire il processo di insegnamento/apprendimento.
La valutazione scolastica costituisce una fase fondamentale, in quanto può offrire all’insegnanti informazioni essenziali per calibrare i percorsi formativi sulla base delle caratteristiche cognitive, affettive e motivazionali di ogni alunno/a e del gruppo classe.
I test di ingresso si collocano nell’ambito della valutazione diagnostica , cioè della valutazione mirata alla rilevazione dell’adeguatezza della preparazione degli alunni e delle alunne in relazione alla programmazione di nuove attività didattiche. Corrisponde all’intervento del medico che raccoglie i dati sull’ammalato per poi stabilire la cura e il dosaggio dei farmaci. Questa valutazione va effettuata anche per accertare, dopo la lunga pausa delle vacanze estive, il livello di mantenimento delle conoscenze e delle competenze dell’anno scolastico precedente, che costituiscono prerequisiti indispensabili per il nuovo anno scolastico. Accertare il possesso da parte degli alunni e delle alunne dei prerequisiti necessari ad affrontare adeguatamente le attività che verranno proposte permette di adattare e calibrare il nuovo percorso in tappe che siano rispettose dei ritmi personali e dunque più proficue.
Obiettivi
La rilevazione delle conoscenze e delle abilità
Si possono utilizzare molte tipologie di prove per valutare le diverse caratteristiche degli alunni e delle alunne, che durante le vacanze possono essere cambiati.
La somministrazione di prove di ingresso deve avere i seguenti obiettivi di valutazione: la motivazione scolastica; gli aspetti socio-relazionali; l’autonomia; i livelli di attenzione; gli interessi; le capacità cognitive; gli stili di apprendimento; le abilità relative ai diversi contenuti della programmazione.
Fatta eccezione per gli alunni e le alunne con DSA o BES, in questa Guida sono proposte prove standardizzate, perché esse permettono di rilevare come si colloca la prestazione di ogni alunno/a e di valutare il livello della classe nel suo insieme.
Per la rilevazione del livello delle conoscenze e delle abilità iniziali, in questa Guida sono presenti alcune schede relative ai seguenti aspetti specifici.
Lettura : i due testi per la prova di lettura servono a rilevare due aspetti differenti: la velocità nella lettura e l’espressività nella lettura.
La rapidità di lettura si calcola dividendo il tempo impiegato in secondi per il numero di sillabe del racconto letto.
Non è una rilevazione diagnostica, ma può dare l’idea della velocità media di lettura che hanno i singoli alunni e le singole alunne, per poter poi adeguare il lavoro da svolgere con l’intera classe. L’espressività nella lettura si rileva osservando se gli alunni e le alunne: leggono scorrevolmente, rispettano la punteggiatura, danno intonazione al testo.
Correttezza ortografica : dettati di parole e frasi. Le modalità sono indicate prima di ogni batteria di parole e frasi.
Comprensione : testo letto dall’insegnante; testo letto individualmente. Si consiglia di stabilire e comunicare agli alunni e alle alunne un tempo massimo per l’esecuzione della prova, calibrato sul livello raggiunto dalla classe.
Tipologie testuali : la scheda serve per rilevare il livello di conservazione delle conoscenze pregresse, perché nel Libro di Lettura sono riproposte tipologie studiate lo scorso anno.
Riassunto : un brano breve in cui il bambino è aiutato nello smontaggio. Anche in questo caso, va assegnato un tempo per l’esecuzione.
Scrivere : produzione di un testo su un’esperienza vissuta, sulla base di una scaletta.
Riflessione sulla lingua : conoscenza delle principali categorie grammaticali.
LETTURA ESPRESSIVA
Domani è la festa di un mio compagno di classe. Si chiama Sandro e vorrebbe tanto i roller. Non fa che dirlo a tutti, sembra quasi che chieda a noi di regalarglieli. Ma i roller costano cari. È stata Luisella a dire: – Perché non ci mettiamo insieme tutti, invece che fare ognuno il suo regalino?
Che bella idea. L’ho detto in casa e il babbo ha commentato: – Dev’essere una socia della Coop.
– Perché?
– Perché l’unione fa la forza.
Era un po’ misterioso, il babbo. Ma effettivamente tutti insieme abbiamo potuto comprare i roller per Sandro.
Ma guarda se dovevo nascere d’estate! Chissà se anche i grandi sarebbero capaci di unirsi per farmi un bel regalo… Ma il regalo che vorrei io forse non possono comprarmelo. Io vorrei la nonna.
Lucia Tumiati, Vorrei volare sulla neve, Giunti Junior
Sssh! Ascolta…
Viviamo in un mondo pieno di rumore. I suoni ci inseguono ovunque, dentro e fuori casa. In ogni negozio o bar o stazione c’è un sottofondo musicale, spesso a volume altissimo. In casa, le nostre voci lottano spesso contro la tivù o contro il frastuono che proviene dall’esterno. E per la strada, chi corre per sport, chi si affretta verso la fermata dell’autobus, chi semplicemente passeggia, ha spesso due cuffiette dentro l’orecchio. Come se il silenzio ci facesse paura. Certo, ci sono rumori fastidiosi, e ci sono suoni armoniosi e gradevoli. Ci sono rumori violenti o ossessivi, e suoni carezzevoli e rilassanti. Ma la maggior parte dei suoni che arrivano al nostro orecchio, e da lì al nostro cervello, è soltanto rumore.
Viviamo in un mondo pieno di voci. Mai come nella nostra epoca si parla: si comunicano i propri pensieri sulle chat e sui social network, ci si scambia messaggi, si ricevono e commentano informazioni. Siamo parte di un immenso auditorio, dove tutti parlano, ma dove forse si ascolta pochissimo.
Shakespeare fece dire al personaggio di una sua opera: “Porgi a tutti l’orecchio, a pochi la tua voce”. Ascolta le opinioni altrui, ma pensa con la tua testa.
Anna Vivarelli, Pensa che ti ripensa - Filosofia per giovani menti, Piemme
Suoni omologhi
Difficoltà ortografiche (doppie, mb, mp, cvc, vcccv, qu, gn, gli)
Le parole contenute nel gruppo sulla distinzione di suoni omologhi sono state scelte appositamente tra parole poco conosciute dai bambini e dalle bambine, perché durante la dettatura essi devono concentrarsi sulla distinzione del suono.
Dettare una parola per volta, evidenziando il suono sottolineato, senza però accentuarlo troppo.
catino badile ebano epico bifora evaso geriatra locale migale favore dentiera bipede fanfara tracciato
Le parole contenute nel gruppo sulle difficoltà ortografiche sono state scelte appositamente tra parole assonanti, perché durante la dettatura i bambini e le bambine devono concentrarsi sulla pronuncia della parola nel suo insieme e sulla divisione in sillabe per la corretta scrittura.
Dettare una parola per volta, in modo naturale, senza evidenziare il raddoppio della consonante.
pallina melina boccino vicino addizione acquazzone lampadina ombrello partito castello inchiostro bistecca piastrella pigliare abbaiare niente ognuno qualunque straniero estraneo
Leggere prima tutte le frasi.
Dettatura di frasi
Il dettato può essere effettuato con due modalità diverse: per verificare solo la correttezza ortografica: si dettano al massimo tre parole per volta; per controllare la capacità di memorizzare una frase e procedere all’autodettatura: si detta la frase completa.
Rileggere le frasi affinché i bambini e le bambine possano autocorreggersi.
Invitarli a rileggere e a procedere nell’autocorrezione. Il dettato è diviso in due livelli di difficoltà.
La finestra è aperta.
Mio fratello l’ha chiusa.
Prepara la tua cartella.
La bottiglia dell’olio è sul tavolo.
L’attore è sul palcoscenico.
L’auto del papà è parcheggiata in giardino.
Il mio vicino di casa ha comprato un computer nuovo.
In montagna s’è ghiacciata l’acqua del ruscello.
Andrea ha dimenticato l’astuccio e la nonna gliel’ha portato.
I materassi delle streghe non sono imbottiti di lana, e neppure di crine o di gommapiuma come quelli dei comuni mortali. Ogni strega ha bisogno di un’imbottitura personale, specialissima, senza la quale non potrà mai godere sonni tranquilli.
Per sapere qual è l’imbottitura più adatta, prima ancora che la streghetta nasca, sua madre va a consultare uno specialista che risponde allo strano nome di Duermetenignaquerida.
Dunque, il Duermetenignaquerida misura con un nastro azzurro a pallini rosa la pancia della mamma strega in attesa, poi le fa il solletico sotto il naso con una fogliolina di menta selvatica. Fa la somma dei centimetri della circonferenza della pancia col numero degli starnuti, getta altrettanti pizzichi di borotalco in un bicchiere di latte di cocco, mescola il tutto, lo agita e recita la formula magica. Poi, a seconda di come gli prude il ditone del piede sinistro, il Duermetenignaquerida fa la sua prescrizione: “Il materassino della neonata dovrà essere imbottito con capelli rossi raccolti dal pettine di una baronessa” oppure “con petali secchi di fiore di cactus” o “con calze di nailon vecchie di una portinaia francese”, “con cenere di unghie di rana” e altre stranezze del genere, che le mamme streghe devono procurarsi al più presto, se non vogliono che la creatura appena nata si riempia di eczemi e di croste e pianga disperata giorno e notte rompendo i timpani a tutta la famiglia.
Alla madre di Etrusca il Duermetenignaquerida aveva prescritto un’imbottitura di penne di spiumaccione. Forse non avete mai sentito parlare di questo strano uccello, o meglio, di questo gallinaceo, perché lo spiumaccione, nonostante abbia due belle e lunghe ali, non è capace di sollevarsi in volo. Le sue origini sono antichissime. Qualcuno sostiene che risalga addirittura al tempo dei dinosauri.
Se non si è estinto come gli altri animali alati, per esempio gli pterodattili, è perché possiede un formidabile sistema di difesa.
Infatti quando si sente in pericolo questo gallinaceo preistorico non si limita a sbatter le ali e a starnazzare. Nossignore. Lo spiumaccione è capace di scagliare contro l’aggressore le penne più dure e appuntite, proprio come l’istrice fa con gli aculei, mentre con le piumette, che ha fittissime e leggere, crea attorno a sé una specie di nebbia che confonde ancora di più l’avversario e gli consente di battersela in men che non si dica. E il bello è che, appena lo spiumaccione è fuori pericolo, penne e piumette gli ricrescono immediatamente. – Meno male! – aveva commentato la mamma di Etrusca, che era amante degli animali e rispettosa della natura. – Così non dovremo uccidere né spennare vivo nessun volatile. Basterà fargli buh! E poi raccogliere con una paletta il piumaggio che ci scaglierà contro prima di scomparire.
Bianca Pitzorno, A cavallo della scopa, Mondadori
Nome e cognome
Data
Segna con una X lo spiumaccione.

Rispondi segnando con una X
Come si chiama lo specialista dei materassi?
Cinquantatenignaquerida.
Duermetenignaquerida.
Duarmatanignaquarida.
Perché le streghe che aspettano un bambino vanno dallo specialista?
Per scegliere il colore del materasso del bambino.
Per scegliere l’imbottitura del materasso del bambino.
Per scegliere un materasso per la mamma.
Che cosa utilizza lo specialista quando visita le mamme in attesa?
Menta selvatica, borotalco, latte di capra.
Rosa selvatica, borotalco, latte di soia.
Menta selvatica, borotalco, latte di cocco.
Chi è Etrusca?
Una specialista.
Una piccola strega.
Una mamma strega.
Disegna il nastro che usa lo specialista per misurare la pancia della strega in attesa.
Lo specialista su che cosa basa la scelta dell’imbottitura del materasso?
Prurito al ditone del piede destro.
Prurito al ditino del piede sinistro.
Prurito al ditone del piede sinistro.
Nome e cognome Data
Il gatto si chiamava Timmy. L’abbiamo portato a casa da un gattile. Era un micino. E aveva il raffreddore. Non mangiava, non beveva e non si muoveva. La sua pelliccia era come quella di una tigre, ma senza le strisce. Anche se si vedeva benissimo dove avrebbero dovuto essere le strisce. Aveva il pelo corto e ispido e quando lo accarezzavo era come passare la mano sulla paglia. Lo tenevo sempre in braccio o sulle ginocchia. Volevo metterlo sul cuscino quando dormivo, ma mamma e papà non me lo hanno permesso perché avevano paura che svegliandomi avrei scoperto che era morto.
I primi due giorni papà ha fatto almeno dieci telefonate al ricovero per animali. Ogni volta che riagganciava il telefono era più triste. – Che cosa hanno detto? – chiedevamo io o mamma, e tutte le volte papà rispondeva: – Hanno detto: “Non c’è da preoccuparsi”.
Come se “non c’è da preoccuparsi” fosse una specie di maledizione, come se per Timmy non ci fosse più speranza. Mi faceva venire voglia di piangere.
Mamma mi abbracciava e si arrabbiava con papà. Mi diceva: – Vedrai che starà bene, te lo prometto.
Mamma, papà e persino mia sorella Halley davano da mangiare a turno a Timmy con un contagocce. Lui rimaneva sempre immobile, se ne stava sdraiato tutto il giorno nello stesso punto del tappeto dove il sole del mattino entrava dalla finestra.
Ci sono volute due settimane e tre visite dal veterinario. Papà gli ficcava in gola certe pastiglie. Timmy le sputava. Allora papà gliele ficcava di nuovo in gola e gli teneva chiusa la bocca e gli accarezzava la gola come gli aveva insegnato il veterinario. Io, mamma e Halley stavamo a guardare e dicevamo: – Bravo, Timmy.
Ma era inutile. Sputava tutte le pastiglie. Era come se non gliene importasse niente di guarire. Importava solo a noi.
Poi una mattina mi sono svegliata e Timmy sembrava due volte più grande del giorno prima e si faceva le unghie su una gamba del divano.
Mamma ha gridato: – Ucciderò quel gatto!
Ma noi altri eravamo felici, soprattutto io.
Jules Feifffer, La mia stanza è uno zoo!, Piemme Junior
Nome e cognome Data
Segna con una la sequenza in cui viene descritto il gatto.
Rispondi e completa segnando con una X .
Che cos’è un gattile?
Un negozio di animali che vende solo gatti. Un ospedale specializzato nella cura dei gatti. Un luogo dove vengono accolti i gatti senza padrone.
Il ricovero per animali a cui telefona il papà è: il luogo dove è stato preso il gattino. un ospedale veterinario della città. il negozio in cui vendono gatti.
Perché il papà è sempre più triste quando telefona al ricovero?
Perché non gli danno una cura che faccia guarire subito il gattino.
Perché gli rispondono: “Non c’è da preoccuparsi”.
Perché gli rispondono piangendo.
Alla riga 18 si legge “se ne stava sdraiato”. L’espressione si riferisce: al gatto. al papà. al contagocce.
Che cosa fa capire che il gattino è guarito?
Si capisce dal fatto che il gatto: si fa le unghie sulla gamba del divano. sputa le pastiglie.
è sdraiato al sole.
Perché la mamma esclama “Ucciderò quel gatto!” (riga 30)?
La mamma dice ciò perché il gatto: sta sul tappeto. rovina il divano.
è sempre malato.
Alle righe 21-22 si legge “Papà gli ficcava in gola certe pastiglie”.
Questa frase indica che la bambina: sa che sono pastiglie speciali. non sa che tipo di pastiglie siano. conosce bene la quantità di pastiglie che viene data al gatto.
Nome e cognome Data
Segna con una X il contenuto di ogni tipologia di testo.
Testo narrativo
Una storia vissuta da uno o più personaggi realistici o immaginari.
Una serie di informazioni su un argomento.
Una serie di istruzioni per realizzare un oggetto.
Favola
Un racconto a lieto fine.
Un racconto che vuole spiegare l’origine del mondo.
Un racconto che vuole dare un insegnamento.
Fiaba
Le avventure, in genere a lieto fine, di un per sonaggio che deve superare delle difficoltà.
Il racconto di avventure di animali che insegnano le regole di comportamento.
Il racconto di fatti realmente avvenuti.
Mito
Un racconto fantastico che vuole spiegare l’origine del mondo.
Un racconto realistico che spiega l’origine del mondo.
Un testo scientifico che dà informazioni sull’origine del mondo.
Leggenda
Un racconto realistico che spiega la trasformazione di animali e ambienti naturali.
Un racconto che vuole spiegare in modo fantastico l’origine di animali, piante, elementi naturali, o le loro caratteristiche.
Un testo scientifico che dà informazioni su animali e ambienti naturali.
Nome e cognome
Era una fresca mattina d’estate e i fiori dalle belle e coloratissime corolle non volevano vicino un fiore brutto e triste. Tutti quanti temevano che la sua bruttezza li danneggiasse e li facesse apparire meno splendenti e profumati.
Anche tutti gli animali del cortile lo schernivano, gli facevano dispetti e lo chiamavano “brutto sgorbio”.
Il povero fiore soffriva molto, ma, in silenzio, senza lamentarsi, guardava il Sole, che amava e ammirava con tutte le sue forze.
Il Sole, sebbene fosse molto lontano, se ne accorse e decise di premiarlo: volse i suoi raggi splendenti intorno all’umile fiore finché alcuni di essi rimasero impigliati, creando una stupenda aureola d’oro. Allora il fiore crebbe, crebbe, e, con grande sorpresa, superò tutti gli altri suoi compagni, proteso verso il Sole.
– D’ora in poi tu porterai il mio nome – gli disse il Sole – e sarai il mio amico prediletto e nessuno oserà più prenderti in giro.
Con i tuoi petali d’oro gli uomini tingeranno le loro stoffe e ricaveranno un olio utile per cucinare; con i tuoi semi gli uccelli si nutriranno a volontà. Non sarai solo bello, ma anche tanto utile a tutti.
M. Spano, Enciclopedia della fiaba, Principato
Il brano è stato suddiviso in cinque sequenze. Completa le frasi chiave che indicano il fatto principale di ognuna.
1. Un fiore veniva preso in giro
da
2. Il fiore
3. Il Sole lo premia
4. Da allora il fiore portò il nome
5. Il fiore divenne utile per

1. Proporre agli alunni e alle alunne la stesura di questo testo. Lo sport che vorrei praticare quest’anno.
2. Introdurre l’argomento attraverso una conversazione con gli alunni e le alunne.
Chiedere loro se:
• amano lo sport;
• praticano già uno o più sport;
• hanno interrotto la pratica dello sport;
• ritengono utile la pratica sportiva (a che cosa può essere utile);
• i loro genitori li hanno avviati alla pratica dello sport da loro preferito;
• i genitori non sono d’accordo con la loro scelta; quali motivazioni possono portare per convincerli.
3. Proporre poi questa scaletta .
- Quale sport vorresti praticare.
- Le motivazioni per cui hai scelto questo sport.
- In quale giorno o in quale periodo dell’anno vorresti praticare questo sport.
- Con chi ti piacerebbe praticarlo.
- In quale luogo o con quale società sportiva vorresti praticare questo sport.
Che cosa valutare nella produzione del testo
Nella valutazione tenere presente se gli alunni e le alunne:
• hanno sviluppato tutti i punti della scaletta;
• strutturano le frasi in modo semplice, ma completo;
• arricchiscono le frasi per rendere più esauriente l’esposizione del loro pensiero;
• organizzano il loro pensiero e il testo in modo logico e cronologico;
• usano in modo corretto la punteggiatura;
• fanno errori ortografici;
• hanno una buona ricchezza lessicale.
Nome e cognome
Data
In ogni gruppo di parole ce ne sono tre che non appartengono alla categoria grammaticale evidenziata. Colorale.
Nomi
Aggettivi
Verbi
Articoli
Alpi forse verde ieri in la un le una gli per i alla uno giocava ascolterà
librerie questo Rosa velocissimo cascò dici scrittrice scrittura sporco colorato però fresca leggere rumore ormai affettuoso tosse ho visto letto civiltà bellino famoso fosse abbia mangiato
Per ogni frase, scrivi se il verbo è al presente, al passato o al futuro.
Il nonno da piccolo abitava in campagna.
Camilla andrà in gita a Roma.
Lorenzo, un giorno, perse le chiavi di casa.
Il fratello di Mauro vive in Toscana.
La campanella suona all’inizio delle lezioni.
Il papà mi accompagnerà al museo.
Nelle seguenti frasi, sottolinea in rosso il soggetto e in verde il predicato.
Domani Luigi partirà.
Il grillo saltella nel prato.
In garage è parcheggiata la moto.
Ieri Lidia ha letto un libro.
La mamma ha cucinato il pollo con le patate.
In autunno cadono le foglie.
Valutazione
Alunno/a
ABILITÀ INIZIALI INDAGATE Sì No In parte
ATTEGGIAMENTI AFFETTIVO-EMOTIVI
Manifesta:
1. controllo dell’emotività
2. sicurezza e fiducia in sé
3. instabilità
4. disinteresse verso gli altri/le altre
5. disinteresse verso le proposte degli altri/delle altre
6. impulsività
Reagisce al successo:
7. esprimendo gioia
8. mostrando indifferenza
Reagisce agli insuccessi:
9. manifestando autocontrollo
10. manifestando preoccupazione
11. manifestando indifferenza
ATTEGGIAMENTI SOCIALI
Nelle attività ludiche dimostra:
12. accettazione degli altri/delle altre
13. accettazione delle regole
14. partecipazione
15. aggressività
16. tendenza alla leadership
Nelle attività scolastiche dimostra:
17. collaborazione
18. dipendenza
19. indipendenza
20. partecipazione
21. intolleranza
22. sottomissione
23. isolamento
Alunno/a
ABILITÀ INIZIALI INDAGATE Sì No In parte
Lettura
Ascolto e comprensione
Lettura e comprensione
Tipologie testuali
Lettura e riassunto
Scrittura
Riflessione sulla lingua
1. Legge a voce alta in maniera scorrevole un breve testo.
2. Legge a voce alta con espressione, rispettando la punteggiatura, un breve testo.
3. Mantiene l’attenzione durante l’ascolto di un brano letto dall’insegnante.
4. Risponde a domande su aspetti specifici del testo letto dall’insegnante.
5. Legge autonomamente e comprende un testo.
6. Conosce le caratteristiche delle tipologie testuali studiate.
7. Legge e completa le frasi chiave di un racconto diviso in sequenze.
8. Scrive correttamente sotto dettatura parole con suoni omologhi.
9. Scrive correttamente sotto dettatura parole con difficoltà ortografiche.
10. Scrive correttamente sotto dettatura sintagmi di una frase.
11. Scrive correttamente sotto dettatura una frase complessa.
12. Scrive un testo seguendo la scaletta in modo coerente e coeso.
13. Riconosce articoli, verbi, nomi, aggettivi.
14. Identifica i tempi dei verbi: passato, presente, futuro.
15. Individua sogget to e predicato.
16.
17. 18.
Classe 4a
La scoperta
Le regole grammaticali devono essere “una scoperta” per gli alunni e le alunne. Per questo non si può trasformare la grammatica solo in una “materia di studio”. Gli alunni e le alunne devono costruire le loro conoscenze grammaticali mettendo in atto capacità di: osservazione (quali parole trovo in questa frase? A che cosa servono? Che cosa mi fanno capire?);
classificazione (ho osservato che questo tipo di parola mi indica persone, animali, cose, azioni, caratteristiche);
confronto (alcune parole cambiano nel contesto, mi indicano una cosa o tante, stanno al posto di un nome, possono indicare un’azione che è avvenuta o che avverrà); categorizzazione (tutte le parole che mi indicano persone, animali, cose posso inserirle in una categoria; i verbi “terminano” con una desinenza diversa e posso raggrupparli in tre gruppi).
Questo modo di procedere nella scoperta di una conoscenza è trasversale a tutte le discipline e ha una valenza formativa che porta all’acquisizione di competenze
Con un percorso di questo tipo si promuove la motivazione , perché è l’alunno/a che scopre la regola, risolve il problema di categorizzare le parole.
Brain storming e Cooperative
Learning
La discussione, la formulazione di ipotesi, il confronto tra le diverse ipotesi formulate dal gruppo su un’ipotesi di regola, di funzione di una parola, di categorizzazione possono essere un passaggio fondamentale della metodologia della “ricerca” delle regole grammaticali. È uno scambio cognitivo che fa progredire le conoscenze di tutti.
Due percorsi
Insegnare la grammatica : si parte da una regola della lingua, la si propone agli alunni e alle alunne, la si spiega, si propongono esercizi strutturati, si fa ritrovare la regola e la si fa applicare per mezzo di altri esercizi strutturati.
Riflettere sulla lingua : si parte da un testo (verbale o scritto), si riflette sulla funzione di una o più parole, le si confronta, si arriva a estrapolare una regola, si applica la regola in esercizi strutturati.
Insegnamento della grammatica
La funzione alunno/ insegnante
Le grammatiche
Alunno/a
Ha un ruolo passivo: impara le regole dall’insegnante, si esercita su esercizi strutturati che riguardano solo la regola appresa, non sperimenta la presenza della struttura della lingua in testi.
Insegnante
Presenta le regole secondo una precisa scansione temporale e di consuetudine (in genere nome, articolo, aggettivo, verbo). Propone esercizi mirati che però non permettono di riflettere sulla struttura della lingua. Si tratta di classificare e catalogare parole.
La grammatica è: fonologia-ortografia, morfosintassi e grammatica del testo. Si presentano liste di regole morfologiche, di meccanismi di riconoscimento delle categorie grammaticali. Prevale la classificazione della parola sulla sua funzione.
Riflessione sulla lingua
Alunno/a
Con l’aiuto dell’insegnante osserva frasi e brevi testi, elabora e verifica ipotesi sulla funzione delle parole, le confronta, le classifica, ipotizza categorie grammaticali, si esercita infine con esercizi applicativi strutturati.
Insegnante
È il “direttore d’orchestra”: propone frasi e testi su cui lavorare (anche presi dal libro di testo), guida le riflessioni che fanno gli alunni e le alunne, ascolta le ipotesi, guida l’elaborazione della “regola” e il completamento dello schema delle diverse categorie grammaticali.
La grammatica diventa la comprensione della struttura della lingua che usiamo per giungere alla competenza grammaticale “tradizionale”.
Riflettere sulla lingua, quindi capire il suo funzionamento, vuol dire vedere lo strumento linguistico che utilizziamo da versanti diversi. Per questo oggi si parla di grammatiche e non più solo di grammatica.
In questo testo, pur mantenendo principalmente l’approccio tipico della grammatica esplicita , si sono volute aprire piccole finestre sulle altre grammatiche ( funzionale e valenziale ) perché gli alunni e le alunne abbiano la possibilità di rendersi consapevoli del funzionamento della lingua italiana.
Grammatica funzionale
Le frasi che noi componiamo per esprimere un’idea sono formate da parole che hanno un significato per se stesse anche se inserite in contesti diversi. Perché la nostra frase “significhi qualcosa” occorre combinare le parole in una determinata relazione e in un determinato ordine in modo che la nostra frase abbia un senso.
La funzione didattica degli esercizi strutturati
Ecco dunque che in una frase ogni parola ha una propria funzione, cioè contribuisce in modo diverso alla costruzione del senso della frase.
È importante che il bambino capisca che ci sono parole che hanno un senso compiuto (verbi, nomi), altre che invece non hanno un senso preciso, ma servono a determinare la parola che segue (per esempio, l’articolo ci fa capire se la parola che segue è maschile o femminile), altre ancora che modificano parzialmente la parola a cui si riferiscono (per esempio, l’aggettivo: casa bella/casa brutta).
Nella riflessione sulla lingua la grammatica funzionale aiuta gli alunni e le alunne a capire a che cosa servono le parole e dunque ad acquisire la consapevolezza dell’uso dello strumento linguistico anche nella produzione autonoma.
Grammatica valenziale
È la grammatica che mette al centro il verbo e tutti gli elementi che sono necessari perché esso possa avere un valore significante e completo. Ci sono: verbi che si completano da soli (per esempio, piove); verbi che hanno bisogno di un elemento per rappresentare un’idea (per esempio, piange in sé è solo un’azione, ma per significare un’idea precisa occorre mettere un soggetto); verbi che hanno bisogno di più argomenti (per esempio, mangia: in questo caso occorre chiarire chi mangia e che cosa mangia).
Questa grammatica aiuterà gli alunni e le alunne ad avere maggiore coerenza e coesione nella produzione dei loro testi.
Gli esercizi strutturati forniti in questa Guida hanno valore “universale” e valgono per qualunque tipo di percorso l’insegnante abbia deciso di intraprendere. Che si privilegi la riflessione sulla lingua o l’”insegnamento della grammatica”, l’esercizio strutturato serve per verificare le conoscenze e le abilità.
Queste schede di esercizio possono essere somministrate agli alunni e alle alunne come momento riassuntivo di un argomento o come verifica. Il livello degli esercizi è leggermente più alto di quello presente nel libro di testo perché le schede possono essere utilizzate anche come sviluppo di argomenti già conclusi.
Questi dettati possono mettere in evidenza le difficoltà ortografiche non ancora superate dagli allievi e dalle allieve nella scrittura non spontanea.
Suoni omologhi
Aldo è un ragazzo molto alto.
Il papà ha comperato una confezione di budini.
Nel vaso ci sono i fiori freschi.
Sul divano c’è la tenda stirata.
Un vento fresco entra dalla finestra.
Ho portato in spiaggia le palline e le biglie.
Suoni GL • GN • LI • NI
I fari dell’auto abbagliano gli occhi degli automobilisti.
Nella grande fattoria, situata nella campagna della pianura Padana vicino a Piacenza, si coltivano granoturco, foraggio, alberi da frutto.
Il disegnatore di fumetti ha fatto il disegno di gnomi impigliati in una gigantesca ragnatela.
Nella giungla le liane dondolano lievi spostate dal vento.
Niente mi farebbe più piacere che stare in compagnia della mia compagna di banco dello scorso anno. Il cognato di Ignazio ha avvolto l’asciugamano bagnato attorno alla bottiglia per tenere fresca l’acqua.
Suoni SC • SCH
Ho visto un film in cui persone vestite da scheletri si scambiavano scherzi orribili.
Mio nonno dice che quando era piccolo i pattini venivano chiamati schettini. Alcuni scienziati sostengono che gli uomini discendono dalle scimmie, ma io mi sono guardato allo specchio e mi sembra che abbiano preso un grosso abbaglio.
Questo è il testo di una vecchia canzone:
Dal cucuzzolo della montagna con la neve alta così per la valle noi scenderemo con ai piedi un paio di sci.
E io aggiungo: – Scivolando e fischiettando scieremo in allegria.
Suoni CU • QU • CQU
Qualcuno ha bussato alla porta.
Lo zio vuole cuocere i cuori di carciofo.
Il boscaiolo scuote i rami della quercia per far cadere le ghiande. Quando vedo una bella pizza mi viene l’acquolina in bocca.
Uso dell’H
Ho accompagnato Giulia al maneggio perché a lei piace tanto andare a cavallo.
Lo scorso anno hai trascorso gran parte del tuo tempo libero ai giardini a giocare a pallone.
Quest’anno, invece, hai deciso di iscriverti a un corso di nuoto.
I miei genitori avevano deciso di andare a trovare i loro amici a Roma, ma hanno dovuto rinunciare perché la mamma non aveva ferie.
Quando ho letto il libro che hai regalato a mio fratello ho pensato: “Oh, che bella storia!”.
Vorrei farti un regalo. Puoi scegliere: o un libro o un gioco in scatola.
Ahi, che male! Non ho fatto attenzione ai gradini e ho fatto un bel ruzzolone!
Nome e cognome
Sottolinea la parola scritta nel modo corretto e cancella quella sbagliata.
Per assistere alla partita della nazionale, molti italiani/itagliani si sono recati in Spania/Spagna.
Nella Valle dei Templi, in Siciglia/Sicilia, si possono ammirare resti risalenti all’epoca della Magna/Magnia Grecia.
I bambini stranieri/stragneri che frequentano la mia scuola provengono soprattutto da Paesi orientali.
Tutti i mercoledì utilizziamo l’aula di disegno/disegnio.
Gli aglievi/allievi della scuola di pianoforte hanno dato un saggio musicale per le loro famiglie/familie.
Il cigliegio/ciliegio in giardino è ricoperto di fiori bianchi.
Sul ciglio/cilio della strada c’è un’automobile abbandonata.
Scrivi la parola che corrisponde alla definizione. Poi riporta le lettere nello schema in basso. Apparirà il nome di un eroe dei fumetti!
Il settimo mese dell’anno.
di nulla.
risultato di 10 x 100 000.
Un persona super precisa.
Il seme della pigna che viene utilizzato per fare il pesto.
Per ogni suono, scrivi due parole.
Nome e cognome Data
Per ogni frase, sottolinea la parola scritta in modo sbagliato e scrivila nel modo corretto. Ieri per strada ho assistito a una sciena, triste e comica allo stesso tempo: un signore è scivolato su una buccia di banana. La maestra ci ha dato uno sciema per memorizzare le preposi zioni e gli articoli.
Che schiagura! Il pesciolino rosso è saltato fuori dall’acquario. In teatro, sul palcoscienico, gli attori stanno recitando il terzo atto di una divertente commedia.
I passeggeri sono sciesi dall’aereo e si avviano al ritiro dei bagagli.
L’uschita di emergenza è ben segnalata, ma è difficile da raggiungere.
Scrivi la parola che corrisponde alla definizione.
Poi riporta le lettere nello schema in basso. Apparirà un nome. Sei capace di darne la definizione?
Un gruppo di api. 4
Lo usano i vigili e gli arbitri.
Animaletto dalla lunga coda che si arrampica sugli alberi.
Un tipo di scimmia.
Si mette attorno al collo per ripararsi dal freddo.
La fai quando devi decidere tra due cose.
Se la mettevano sulla faccia gli attori nel teatro greco.
Lo era Albert Einstein.
Definizione:
Scrivi due parole con:
SC (suono della parola pesce)
SC (suono della parola scatola)
SC (suono della parola schiena)
Nome e cognome
Data
Per ogni frase, sottolinea la parola scritta nel modo sbagliato e scrivila nel modo corretto.
La mamma, quando va al supermer cato, aquista sempre il latte fresco.
Il nonno, cualche volta, quando guarda la televisione, si addor menta.
La nostra vicina di casa aspetta un bambino e ha comperato una qulla per quando nascerà.
La quriosità aiuta a conoscere cose nuove.
Ti serve un quaderno? Prendine uno cualunque nel cassetto!
Quasi ogni giorno salta la corrente, per ché si verifica un cortocirquito nell’impianto elettrico.
Scrivi la parola che corrisponde alla definizione. Poi riporta le lettere nello schema in basso. Apparirà il nome di una persona che usa la maschera, ma non a Carnevale.
Il rapace che vive sulle vette delle montagne. 2
L’azione che fa il cuoco in cucina. 5 8
Lo trovi sul letto, sul divano e… sotto il gatto. 1 9
Si usa sotto le scarpe, per le borsette e per le cinture. 7
Sono differenti quelli per i pesci di mare e quelli per i pesci di acqua dolce. 6
Quelli di ghiaccio stanno nel freezer o nelle bibite. 3
Prima di imboccarla, bisogna diminuire la velocità. 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Per ogni suono, scrivi due parole.
Nome e cognome Data
Completa. Poi colora: in rosa se hai inserito un verbo; in verde se hai inserito una congiunzione; in giallo se hai inserito una preposizione; in azzurro se hai inserito un nome.
Non so se offrire una fetta di torta un gelato. insegnato tuoi genitori come utilizzare il nuovo cellulare.
I genitori della scuola firmato una petizione perché per l’ prossimo venga costruito un campo da calcio da pallacanestro.
I bambini partecipato un corso di nuoto e ricevuto un attestato.
La mamma regalato mia sorella un bellissimo ombrellino pois.
Leandra detto tuo fratello che andrà Torino visitare il Museo Egizio.
Completa inserendo la forma corretta tra quelle indicate tra parentesi. Sandro è tornato a Milano: ( lo/l’ho) incontrato ieri. La mamma ha comperato ( la/l’ha) verdura e ( la/l’ha) lavata prima di cucinarla.
La nonna aveva una brutta tosse e ( la/l’ha) curata con una nuova medicina. Guarda quella casa: ( l’anno/l’hanno) ridipinta completamente ( l’anno/l’hanno) scorso. ( Lo/L’ho) scoiattolo è salito sul ramo e il turista ( la/l’ha) fotografato. Il papà ha portato ( la/l’ha) macchina dal meccanico che ( la/l’ha) riparata e poi ( la/l’ha) riverniciata.
Nome e cognome Data
GRAMMATICA FUNZIONALE
Colora solo i nominali.
la biciclette in bagnino dalla camaleonte raggio
scrive comunque uno ballano marmotte squadra ballerine mai
Completa segnando con una X .
I nominali hanno la funzione di: indicare animali, persone, cose, sentimenti. far capire se l’oggetto indicato è maschile o femminile. indicare le caratteristiche di ciò di cui si parla.
I nominali sono: i nomi.
gli aggettivi. gli articoli.
GRAMMATICA ESPLICITA (MORFOLOGIA)
Per ogni affermazione, segna V (vero) oppure F (falso).
Tutti i nomi hanno la radice. V F
Tutti i nomi hanno il prefisso. V F
Solo alcuni nomi hanno la desinenza. V F
Alcuni nomi possono avere prefisso e suffisso. V F
Nessun nome può avere il suffisso. V F
Cancella le parole sbagliate.
Il nome è una parte variabile/invariabile del discorso. Il nome si può chiamare anche sostantivo/predicato In un nome si analizza il genere/la coniugazione
Il nome non cambia/cambia di numero.
Nome e cognome
Data
Completa le tabelle segnando con delle X .
Comune Proprio Maschile Femminile Singolare Plurale infermiere
poeta cognata
Barbie fiore lavatrice lance
Italia pescispada mandria
Dante presidi
Primitivo
tavolo
gambetta gamba
portavaso tacchino gregge
gambale tacchetto fratellanza tavolata
serpentello fratellastro
Nome e cognome
Data
Completa la frase colorando la scelta corretta.
I nomi maschili che terminano: in O oppure E fanno il plurale in I E in A fanno il plurale in E I
I nomi femminili che terminano: in A fanno il plurale in E A in E fanno il plurale in I E
Colora in rosso il quadratino accanto ai nomi di genere indipendente, in blu quello accanto ai nomi di genere promiscuo, in arancione quello accanto ai nomi di genere comune.
nuora musicista canguro nipote frate custode fratello cantante tigre moglie insegnante struzzo
Cancella le parole sbagliate.
I nomi variabili cambiano/non cambiano dal singolare al plurale.
I nomi invariabili cambiano/non cambiano dal singolare al plurale.
I nomi difettivi possono essere usati solo al singolare o solo al plurale/solo al singolare
Per ogni nome, scrivi se è variabile (V), invariabile (I), difettivo (D), sovrabbondante (S). tenebre caffè sangue metropoli fame specie cinema equatore filo ferie orecchio bontà re morbillo biologia tavolo forbici foto ciglio gru
Nome e cognome Data
Completa segnando con una X .
I modificanti sono: i nomi e gli aggettivi.
Colora solo i modificanti. sinceramente sincero sincerità veloce velocità velocemente teatro buono gioca in colorato la ieri non luna
Completa la tabella inserendo al posto giusto i modificanti che hai colorato nell’esercizio precedente.
Aggettivi
Avverbi
Completa segnando con una X .
I modificanti hanno la funzione di: indicare le caratteristiche dei nomi e dei verbi. indicare animali, persone, cose, sentimenti. indicare il tempo e il luogo.
Sottolinea i modificanti.
Il commesso rispose cortesemente alla signora.
Il famoso direttore d’orchestra ricevette gli applausi del pubblico. Mio fratello non verrà alla festa.
Il famoso atleta ha vinto meritatamente la medaglia. Ieri ho comperato un vestito nuovo. i verbi e i nomi. gli aggettivi e gli avverbi.
Nome e cognome
Per ogni affermazione, segna V (vero) oppure F (falso).
Tutti gli aggettivi sono qualificativi.
I gradi dell’aggettivo qualificativo sono: positivo, comparativo, superlativo.
L’aggettivo possessivo può avere il grado superlativo.
L’aggettivo può avere il prefisso.
L’aggettivo non può avere il suffisso.
L’aggettivo può svolgere il ruolo di sostantivo.
Cancella le parole sbagliate.
L’aggettivo è una parte invariabile/variabile del discorso.
L’aggettivo è sempre/può essere accompagnato dall’articolo.
L’aggettivo concorda/non concorda con il nome a cui si riferisce.
L’aggettivo non può cambiare/può cambiare di genere e di numero.
Per ogni affermazione, segna V (vero) o F (falso).
Gli avverbi possono essere di modo, tempo, luogo, quantità, affermazione, negazione, dubbio. V F
Gli avverbi si aggiungono solo ai verbi.
V F
Gli avverbi si aggiungono a verbi, aggettivi, avverbi. V F
Le locuzioni avverbiali hanno la stessa funzione degli avverbi. V F
Cancella le parole sbagliate.
L’avverbio è una parte variabile/invariabile del discorso.
L’avverbio accompagna sempre/talvolta il verbo.
L’avverbio può/non può cambiare di genere e numero.
L’avverbio concorda/non concorda con la parola che accompagna.
Sottolinea in rosso gli aggettivi e in blu gli avverbi.
Il fratello di Filippo piange sempre.
La signora Martina abita al primo piano.
Rocco non trova il quaderno nuovo.
Il ghiro pigro entrò velocemente nella tana.
Ogni mattina esco presto di casa.
Nome e cognome
Data
Completa la tabella segnando il grado di ogni aggettivo con delle X .
Comparativo Superlativo
Positivo Maggioranza Minoranza Uguaglianza Assoluto Relativo stratopico
bugiardo
più stanco
il più stanco brava come meno piccolo di ottimo
Completa inserendo l’aggettivo possessivo adatto.
Michela è andata in montagna con i amici.
Alla fine della lezione ogni bambino ha messo il quaderno nell’armadio. Ho incontrato Ada, Carlo e i genitori.
Ti conosco bene e so che i passatempi preferiti sono gli scacchi e i giochi enigmistici.
Scusateci, abbiamo preso i zaini, anziché i nostri.
Completa segnando con una X .
Nell’ultima frase dell’esercizio precedente il termine nostri è: un nome. un aggettivo. un pronome.
Colora in giallo gli aggettivi dimostrativi, in azzurro gli aggettivi numerali, in rosa quelli indefiniti.
questo qualche quello nessuna terzo centoventidue medesimo parecchio tre alcune
Nome e cognome Data
Per ogni affermazione, segna V (vero) oppure F (falso).
Il verbo è una parte invariabile del discorso.
I verbi hanno solo la forma attiva.
I verbi ausiliari hanno una coniugazione propria.
I verbi della seconda coniugazione hanno l’infinito che termina in -ere.
I modi dei verbi possono essere finiti o indefiniti.
F
F
F
F
F
Il modo indicativo si usa per esprimere un dubbio, un’incertezza. V F
Cancella le parole sbagliate.
I tempi composti di un verbo si formano con un ausiliare/una coniugazione.
Il modo indicativo indica azioni reali, certe/ incerte, possibili.
Il modo congiuntivo indica azioni reali, certe/ incerte, possibili
I modi infiniti hanno/non hanno la persona.
Completa la tabella inserendo le voci verbali al posto giusto. sia • sei • ebbi • abbia • mangiassimo • mangiammo • giocò • giocasse • ebbe cantato • abbia cantato • hanno ballato • avessero ballato
Indicativo
Scrivi il tempo di ogni voce verbale (modo indicativo).
Io andrò
Egli andò
Tu avevi sentito
Noi abbiamo cantato
Essi partirono
Voi avrete giocato
Congiuntivo
Nome e cognome
Data
Completa la tabella inserendo le voci verbali al posto giusto.
avrei • avesse • fossimo stati • sareste stati • sarebbe • sia • dormirebbe • dormisse • sia venuto • sarebbero venuti • fuggissimo • fuggiremmo
Condizionale
Congiuntivo
Completa la tabella segnando con delle X , come nell’esempio.
Tempo Modo indicativo Modo congiuntivo Tempo semplice Tempo composto presente X X X
passato prossimo trapassato trapassato prossimo passato imperfetto
Volgi ogni voce verbale al modo e tempo richiesto, come nell’esempio.
Io ho visto congiuntivo presente che io veda
Noi abbiamo avuto congiuntivo imperfetto
Io dormirò congiuntivo passato
Voi saltaste congiuntivo trapassato
Che tu mangi indicativo presente
Che voi aveste salutato indicativo futuro semplice
Che essi abbiano visto indicativo passato remoto
Che tu abbia sognato indicativo passato prossimo
Nome e cognome
Data
Studia la coniugazione di alcuni verbi irregolari della 1 a coniugazione .
indicativo congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente vado vai va andiamo andate vanno andrò andrai andrà andremo andrete andranno andai andasti andò andammo andaste andarono vada vada vada andiamo andiate vadano andassi andassi andasse andassimo andaste andassero andrei andresti andrebbe andremmo andreste andrebbero
va’ vada andiamo andate vadano
indicativo congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente do dai dà diamo date danno darò darai darà daremo darete daranno
diedi/detti desti diede/dette demmo deste diedero/dettero dia dia dia diamo diate diano dessi dessi desse dessimo deste dessero darei daresti darebbe daremmo dareste darebbero da’ dia diamo date diano
indicativo congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente sto stai sta stiamo state stanno starò starai starà staremo starete staranno stetti stesti stette stemmo steste stettero stia stia stia stiamo stiate stiano stessi stessi stesse stessimo steste stessero starei staresti starebbe staremmo stareste starebbero sta’ stia stiamo stiate stiano
Nome e cognome Data
Studia la coniugazione di alcuni verbi irregolari della 2 a coniugazione .
indicativo
congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente paio pari pare paiamo parete paiono parrò parrai parrà parremo parrete parranno parvi paresti parve paremmo pareste parvero paia paia paia paiamo paiate paiano paressi paressi paresse paressimo pareste paressero parrei parresti parrebbe parremmo parreste parrebbero
indicativo
congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente pongo poni pone poniamo ponete pongono porrò porrai porrà porremo porrete porranno posi ponesti pose ponemmo poneste posero ponga ponga ponga poniamo poniate pongano ponessi ponessi ponesse ponessimo poneste ponessero porrei porresti porrebbe porremmo porreste porrebbero poni ponga poniamo ponete pongano
indicativo
congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente posso puoi può possiamo potete possono potrò potrai potrà potremo potrete potranno potei potesti poté potemmo poteste poterono possa possa possa possiamo possiate possano potessi potessi potesse potessimo poteste potessero potrei potresti potrebbe potremmo potreste potrebbero
Nome e cognome
Data
Studia la coniugazione di alcuni verbi irregolari della 3 a coniugazione
MORIRE
indicativo
congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente muoio muori muore moriamo morite muoiono morirò morirai morirà moriremo morirete moriranno morii moristi morì morimmo moriste morirono muoia muoia muoia moriamo moriate muoiano morissi morissi morisse morissimo moriste morissero morirei (morrei) moriresti (morresti) morirebbe (morrebbe) moriremmo (morremmo) morireste (morreste) morirebbero (morrebbero) muori muoia moriamo morite muoiano
indicativo congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente salgo sali sale saliamo salite salgono salirò salirai salirà saliremo salirete saliranno salii salisti salì salimmo saliste salirono salga salga salga saliamo saliate salgano salissi salissi salisse salissimo saliste salissero salirei saliresti salirebbe saliremmo salireste salirebbero sali salga saliamo salite salgano
indicativo
congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente vengo vieni viene veniamo venite vengono verrò verrai verrà verremo verrete verranno venni venisti venne venimmo veniste vennero venga venga venga veniamo veniate vengano venissi venissi venisse venissimo veniste venissero verrei verresti verrebbe verremmo verreste verrebbero vieni venga veniamo venite vengano
Attività e consigli per l’insegnante
L’abilità nella lettura e la lettura scorrevole sono il primo passo per la comprensione di ciò che si legge.
La comprensione di un testo letto rientra nell’ambito della metacognizione, cioè della consapevolezza dello scopo per cui leggo, del modo in cui leggo, della strategia che metto in atto per leggere e infine capire se “ho capito” ciò che ho letto. Si legge per essere informati, per rilassarsi, per comunicare, per comprendere a quale fermata dell’autobus scendere…
Un approccio metacognitivo alla lettura permetterà di raggiungere tre obiettivi importanti: affinare le strategie per ottimizzare la lettura ; comprendere gli scopi della lettura ; acquisire la consapevolezza delle caratteristiche dei diversi testi (tipologie testuali).
Giunti nell’ultimo biennio della Scuola Primaria gli allievi e le allieve dovrebbero aver acquisito la capacità di leggere in modo fluido e veloce.
Se così non fosse, sarà necessario invitarli a leggere a voce alta brani inizialmente brevi e poi via via sempre più lunghi.
Per coinvolgerli maggiormente, invitarli a: drammatizzare una scena teatrale, leggendo con intonazioni differenti le varie parti; immaginare di essere uno/a speaker radiofonico/a o televisivo/a, che deve essere chiaro/a nella lettura e espressivo/a per poter mantenere alto il livello di attenzione di chi ascolta; ascoltare la lettura dell’insegnante perché essa offre ai bambini e alle bambine un modello di lettura espressiva, con un uso corretto delle pause e la giusta modulazione della voce.
La comprensione del testo
La comprensione di un testo è un processo dinamico che mette in collegamento le informazioni date dal testo con quanto gli alunni e le alunne già conoscono: è dunque un processo complesso, ma fondamentale; e il compito della scuola è proprio quello di fornire agli allievi e alle allieve i mezzi adeguati per effettuare queste operazioni mentali.
Perciò è importante che gli allievi e le allieve siano stimolati con molte e differenti attività di comprensione del testo: riconoscimento degli elementi fondamentali e dei collegamenti tra le parti, inferenze semantiche, deduzione dal contesto del significato lessicale di parole sconosciute.
Per chiarire quali siano le attività di comprensione che vanno scandite durante il percorso è utile rifarsi al Quadro di Riferimento Invalsi
Attività e consigli per l’insegnante
Macro aspetti della comprensione desunti dal Quadro di Riferimento Invalsi
Individuare, con una lettura selettiva, le informazioni richieste, anche espresse in codici diversi.
Localizzare e individuare informazioni all’interno del testo
Ricostruire il significato del testo, a livello locale o globale
Effettuare confronti e distinguere l’informazione che risponde in modo pertinente alla domanda da informazioni concorrenti presenti nel testo e/o richiamate nei distrattori.
Riconoscere l’informazione richiesta presentata in una forma parafrastica.
Individuare informazioni discriminando l’informazione richiesta da altre informazioni.
Ricavare il significato di parole o espressioni dal contesto. Identificare il riferimento testuale che lega fra loro frasi o parti del testo.
Ricostruire la sequenza, temporale e/o logica, di fatti, anche quando l’intreccio non la rispetta.
Mettere in relazione informazioni, implicite o esplicite.
Fare inferenze semplici o complesse.
Riconoscere il tema o l’argomento principale di un testo.
Cogliere le intenzioni, il punto di vista dell’autore o lo scopo per cui il testo è stato scritto.
Cogliere il messaggio che il testo vuole comunicare.
Riflettere sul contenuto o sulla forma del testo
Cogliere la struttura e l’organizzazione formale del testo.
Riconoscere nel testo argomentativo tesi, obiezioni e controobiezioni e le loro relazioni reciproche.
Riconoscere tipo, genere e forma del testo.
Riconoscere figure retoriche e usi figurati del linguaggio.
Riconoscere la funzione logico-sintattica di frasi o la relazione tra frasi o parti del testo.
Gli ambiti su cui vertono i quesiti di riflessione sulla lingua sono: ortografia morfologia formazione delle parole lessico e semantica sintassi testualità
Oltre agli esercizi di comprensione del testo che sono proposti in modo organico e per step successivi in tutti i volumi di questo corso, si consigliano agli insegnanti altre attività: discussione libera su libri letti collettivamente: in questo modo si favorisce il confronto e la capacità di esprimere le proprie conoscenze; pro e contro : gli allievi e le allieve saranno suddivisi in due gruppi: un gruppo esporrà gli aspetti positivi di quanto letto, l’altro quelli negativi; emozioni e fatti: gli allievi e le allieve saranno suddivisi in due gruppi: un gruppo riassumerà i fatti esposti nel testo, l’altro le emozioni che il testo voleva suscitare; cut up: è una tecnica particolare che prevede il taglio della storia in sequenze che vengono poi mescolate in un ordine diverso; i bambini e le bambine potranno così inventare nuove storie; frammenti : raccolta, in un cartellone, di frasi o di paragrafi tratti dai testi letti che hanno suscitato maggiori emozioni.
Nome e cognome Data
La mamma si era raccomandata: – Assaggia tutto, non avanzare nulla.
La bambina aveva annuito, anche se sperava che in tavola non ci fosse il riso.
“Il riso non mi piace, non mi è mai piaciuto” disse tra sé. “Il riso lo mangiano i merli!”.
Ma a casa di Sunita, come aveva temuto, c’erano riso, lenticchie e ceci.
“Tutti semi” pensò la bambina.
La bambina, che si chiamava Luisa, non sapeva come comportarsi. Non voleva essere scortese con i genitori indiani della sua compagna di scuola, che erano giunti in Italia da poco tempo e non conoscevano ancora bene l’italiano, ma i semi proprio non le piacevano.
“Non sono un merlo” continuava a pensare.
Sunita, che aveva imparato l’italiano in pochi mesi, ma che aveva anche imparato a riconoscere da un solo sguardo ciò che pensavano le persone, provò ad aiutare l’amica.
– Vuoi qualcos’altro? Piselli, spinaci, insalata?
La lista era lunga, ma non comprendeva la carne, di cui Luisa era ghiotta.
– Noi siamo vegetariani – disse Sunita.
I genitori di Sunita guardavano Luisa e pensavano che fosse timida.
– Mangia, cara, serviti di tutto quello che vuoi! – le dicevano. – Poi andrete a giocare.
Ma Luisa esitava. Non si era ancora servita.
Non sapeva come fare a rifiutare, senza offendere gli ospiti che continuavano a guardarla e a incoraggiarla con tanta gentilezza.
Fu allora che Sunita ebbe l’idea. Si versò due cucchiaiate di riso e tracciò nel piatto con la forchetta strani segni che a Luisa parevano geroglifici.
– Ho scritto in hindi, la mia lingua, – disse.
– Cosa hai scritto?
– Vuoi saperlo? – chiese Sunita ridendo. – Dammi il tuo piatto.
Luisa porse il piatto e Sunita vi versò il riso. Poi iniziò a scrivere in italiano la stessa frase, disponendo i chicchi a forma di lettere dell’alfabeto.
Scrisse: IL RISO FA RIDERE.
– Il riso fa ridere? – domandò Luisa.
– Sì.
– E gli uccelli non lo sanno? – chiese.
– Non lo so – rispose Sunita. – Tu che cosa pensi?
– Penso che non lo sappiano, perché sono merli – rise Luisa. All’improvviso le era venuta una gran fame.
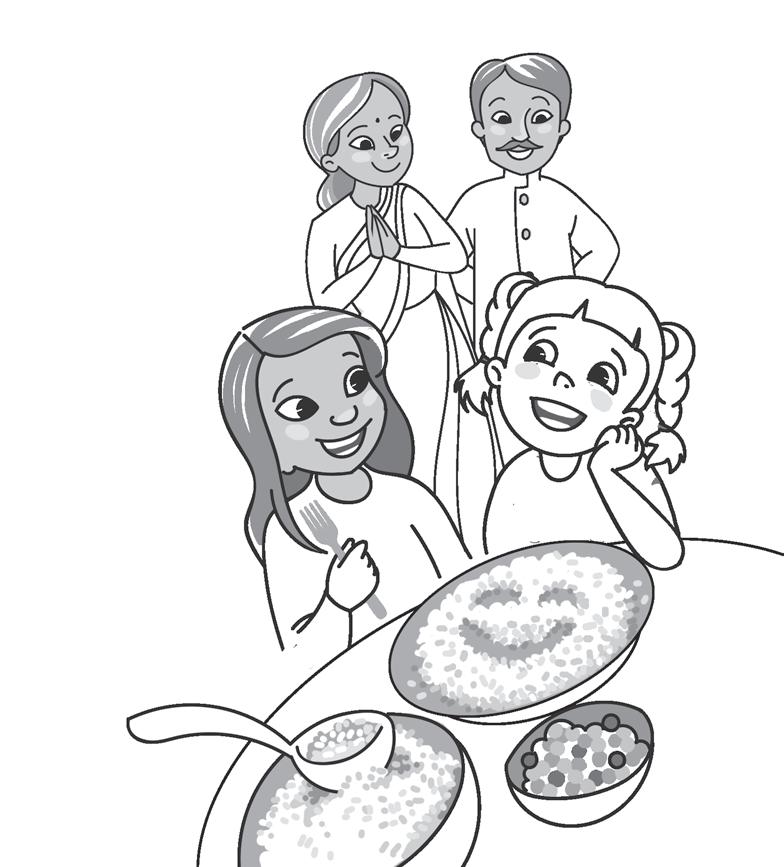
Non aveva mai voluto assaggiare il riso, ma davanti ai genitori di Sunita che la guardavano gioiosi, Luisa pensò che avrebbe potuto provare: infilò la forchetta nel piatto e si mise in bocca, una dopo l’altra, la R, la L, la S e la O. In due morsi addentò l’articolo IL e il verbo FA.
La parola RIDERE fu lasciata per ultima, ma le sembrò che fosse quella che le piaceva di più.
E. Nava, Bambini del mondo, Einaudi Ragazzi
LE INFORMAZIONI ESPLICITE
Rispondi.
Perché Luisa pensa che il riso non sia un cibo adatto a lei?
Perché Luisa non sapeva come comportarsi a casa di Sunita?
Perché i genitori di Sunita non cucinano la carne?
Quale idea trova Sunita per invogli are Luisa a mangiare?
LE RELAZIONI TRA GLI ELEMENTI DEL TESTO
Con quali parole puoi sostituire quella evidenziata?
Luisa porse il piatto e Sunita vi versò il riso.
Nell’alfabeto. Nel piatto. Nel riso.
E gli uccelli non lo sanno?
IL SIGNIFICATO LETTERALE DELLE PAROLE
Scrivi il significato di ogni parola.
Annuire:
Vegetariano:
Geroglifico:
L’ hindi è: un dialetto italiano. la lingua indiana. un’antica lingua che si parlava in Italia.
IL SIGNIFICATO FIGURATO DELLE PAROLE
Con quali parole puoi sostituire quella evidenziata? Segna con una X .
Dire a una persona sei un merlo significa dire: sei molto intelligente. sei vegetariano. sei un credulone.
Nome e cognome
Tutti i sabati la stessa storia: megaspesa al supermercato.
– Come fate a dire che è divertente riempire il carrello della spesa con decine di barattoli di conserva, montagne di carta igienica e tonnellate di pacchi di pasta? – brontola Sara, seduta sul sedile posteriore della macchina, durante il tragitto di ritorno dal supermercato.
Oggi fare la spesa è stato anche peggio del solito.
Prima di uscire di casa, Sara aveva chiesto di poter comprare uno zaino nuovo.
– Vedremo – aveva risposto la mamma distrattamente.
“Vedremo equivale a un sì”, aveva concluso Sara tra sé. E così, una volta tanto, aveva seguito i suoi nella maratona tra un reparto e l’altro senza lamentarsi del male ai piedi o di non poter vedere il suo telefilm preferito.
E una volta nel reparto “articoli scolastici”, che gioia vederlo là: lo zaino dei suoi sogni, rosa e con le tasche a forma di cuore…
Ma proprio mentre, al colmo della soddisfazione, stava per metterlo nel carrello della spesa, ecco che suo padre l’aveva bloccata:
– Posa immediatamente quella roba!
– Ma perché, papà? Ne ho assolutamente bisogno!
– Come fai ad aver bisogno di uno zainetto nuovo? – era intervenuta la mamma. – Che mi dici di quello che ti ho comprato l’anno scorso?
– Ma uno zainetto verde mela con tanto di orsetti in pigiama è da poppanti! Alla mia età non va più bene!
– Di’ un po’, signorina, ti sei dimenticata le storie che avevi fatto per avere quello zainetto? – le aveva ricordato la mamma.
– Ma è passato un mucchio di tempo!
– Adesso ascoltami bene! – aveva tagliato corto il papà. – La verità è che tu desideri uno zainetto nuovo, ma non tentare di convincerci che ne hai bisogno!
L. Jaffé - L. Saint-Marc, Il denaro, Il Capitello
Rispondi segnando con una X .
Perché a Sara non piace andare al supermercato?
Perché deve stare seduta sul sedile posteriore dell’automobile.
Perché lei lo ritiene noioso.
Perché è peggio del solito.
Perché Sara in questa occasione segue i genitori senza lamentarsi?
Sara non ha male ai piedi.

Oggi non ci sono telefilm interessanti alla televisione.
Sara è convinta che i genitori le compreranno uno zainetto nuovo.
Perché Sara afferma di avere assolutamente bisogno di uno zaino nuovo?
Perché quello precedente è rovinato.
Perché ritiene che quello che possiede sia adatto solo a bambini piccoli.
Perché tutte le sue compagne hanno zainetti rosa.
Perché i genitori non comprano lo zainetto a Sara?
Perché non hanno molti soldi da spendere.
Perché sono convinti che Sara non ne abbia bisogno.
Perché Sara non aveva chiesto di mettere lo zainetto nel carrello.
Che cosa ricorda la mamma a Sara?
La mamma dice che Sara fa sempre un sacco di storie per nulla.
La mamma le dice che già l’anno precedente aveva insistito per avere un altro zainetto.
La mamma le dice che non serve prendere lo zaino nuovo.
Che cos’è una maratona?
Una corsa a ostacoli.
Un modo per definire il momento della spesa.
Una camminata lunga e faticosa.
GRAMMATICA
Completa segnando con una X
Megaspesa e supermercato sono due nomi che hanno: un prefisso. un suffisso.
Articolo è una parola polisemica, cioè che ha molti significati.
Segna con quattro X i diversi significati della parola articolo.
Ciascuno degli scritti di cui si compone un giornale.
Categoria grammaticale.
Una pagina di quaderno.
Ciascuna delle parti che compongono una legge o un regolamento.
Una merce.
Un capitolo di un libro.
Nel testo è presente un flashback. Sottolinealo.
LE INFERENZE
Secondo te, la richiesta di uno zaino nuovo è un desiderio di Sara o un reale bisogno? Motiva la tua risposta sul quaderno.
Nome e cognome Data
La nonna che sta in città vuole sempre sapere tutto delle vacanze di Giulia. E quando Giulia ha finito di raccontare, ogni volta le domanda: – Sì, ma la cosa più bella quale è stata? È difficile rispondere perché di cose belle ne succedono così tante!
Sono belle le torte di sabbia e sono belli i buchi nella spiaggia che ci stai dentro con i piedi, i tuffi nel mare, e gli spruzzi che fai quando corri sul bagnasciuga.
Sono belle le onde alte, è bello il vento, sono belli i pesci sul banchetto di Carlone, anche se i polpi fanno un po’ pena. È bello l’odore del gelsomino e cercare le chiocciole in giardino dopo la pioggia è bellissimo.
Sono belli i gabbiani e, quando i gabbiani volano via, sono belle le piccole impronte che lasciano sulla spiaggia.
Raccogliere i sassi e i vetri lisci è bello, trovare un osso di seppia o un guscio di riccio è bello.
Insomma, tutto è bello, e dire quale è stata la cosa più bella è difficile, difficilissimo. Però questa volta Giulia lo sa quale è stata la cosa più bella e non ha bisogno di pensarci tanto.
– La cosa più bella è stato il giro in barca che ho fatto con Carlone, anche se ho dovuto alzarmi così presto che avevo un sonno che quasi non riuscivo a tenere gli occhi aperti.
– Allora finalmente sei andata sull’isola! – dice la nonna.
– No – risponde Giulia. – All’isola non ci sono andata. Carlone ci voleva andare, ma io gli ho detto di fare un altro giro. Sai, mi ha insegnato a pescare.
– Non ti sei fatta portare all’isola? Come mai? Dicevi sempre di volerci andare per scoprire se lì abitava un vecchio marinaio che da giovane era un pirata. – Siamo andati un po’ vicino, ma non tanto. Non volevo disturbare il vecchio marinaio che abita nel faro...
– Hai fatto bene, non è educato disturbare i vecchi marinai al mattino presto – dice la nonna. E naturalmente dice così perché ha capito: certi marinai, che da giovani sono stati pirati, con la maglia a righe bianche e rosse e dodici cuori sul braccio, esistono solo se nessuno li va a cercare.

– Vieni – dice la nonna. – Andiamo a fare una passeggiata, ti voglio raccontare la storia di un pirata che tutti chiamavano il Corsaro Nero. Fuori, la città si accende di mille luci. G. Quarzo, Giulia e il pirata, Motta Junior
LE INFORMAZIONI ESPLICITE
Rispondi.

Perché per Giulia, quando ritorna dalle vacanze, è difficilissimo raccontare alla nonna la cosa che le è piaciuta di più?
Perché, invece, questa volta, riesce a farlo?
Qual è l’avvenimento che Giulia racconta alla nonna?
Perché Giulia voleva andare sull’isola?
Perché, invece, non ci è andata?
LE INFERENZE
La frase “certi marinai, che da giovani sono stati pirati, con la maglia a righe bianche e rosse e dodici cuori sul braccio, esistono solo se nessuno li va a cercare”, significa che:
non si devono cercare questi pirati perché è bello solo immaginarli. non si devono cercare questi pirati perché non esistono. non si devono andare a cercare questi pirati perché sono pericolosi.
IL CONTESTO
Completa.
I personaggi del racconto sono
I personaggi dell’episodio ricordato sono
Il luogo in cui si svolge la storia è
Il luogo in cui si svolge l’episodio raccontato è
L’argomento è
GRAMMATICA
Scrivi se si tratta di superlativo assoluto o superlativo relativo.
Difficilissimo:
La cosa più bella:
Nome e cognome Data
Ulisse, sulla sua barca a vela, dopo aver tanto navigato, stanco di onde, stanco di pesci, stanco di sale, voleva tornare a casa, ma non soffiava un filo di vento: la barca era in mezzo al mare.
A un tratto le onde si mossero e uscì la testa bianca di Nettuno, dio del mare.
– Che cosa fai, Ulisse? – chiese.
– Aspetto il vento, e mi annoio – rispose Ulisse.
– Mi annoio anch’io – disse Nettuno.
– Facciamo una gara: tu con la barca, io a nuoto.
– A remi? – disse Ulisse. – Non ce la posso fare contro di te!
– No, con un po’ di vento – disse Nettuno. – Vediamo chi arriva prima all’isolotto.
– Se vinco, che cosa avrò? – chiese Ulisse.
– Vento sicuro fino a casa. Ma, se perdi, resterai sempre in mare. Accetti?
Ulisse pensò un poco, poi disse: – Accetto! Dammi un po’ di vento.
Nettuno allora soffiò in una conchiglia e chiamò Noto, un venticello che dormiva su un’isola poco lontano.
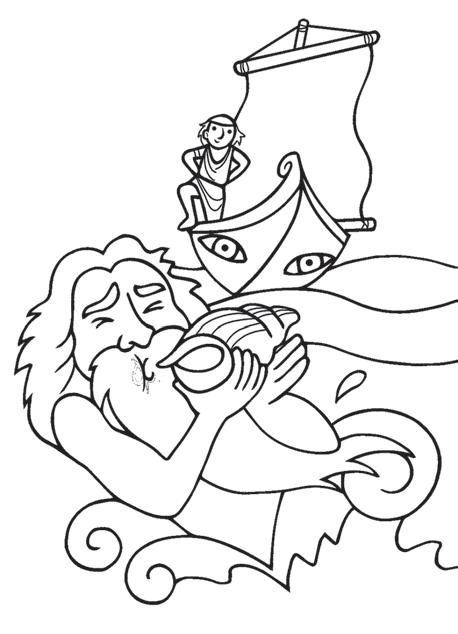
– Mettiti dietro la barca di Ulisse e soffia un pochino – disse Nettuno. – Soffia leggero come di solito fai: quanto basta perché la barca vada.
– Obbedisco, padre – disse Noto, e cominciò a soffiare leggero sulla vela di Ulisse, che si tese mentre la prua cominciava a tagliare l’acqua marina.
– Via! – gridò Nettuno, e cominciò a nuotare con gran potenza, mentre Ulisse, manovrando vela e timone, sfruttava il venticello. Ulisse era un bravissimo marinaio: ma Nettuno, con le lunghe braccia e gambe, fuggiva avanti nell’acqua.
– Soffia un po’ di più, Noto, per favore! – diceva Ulisse al vento.
– Non posso, Ulisse – diceva Noto. – Non posso disobbedire a Nettuno. Vuoi che mi rinchiuda per punizione in un vaso, come ha fatto l’altro giorno con mio fratello Maestrale, che gli aveva disobbedito?
– Eh, già, non puoi disobbedire: devi restare sempre dietro la barca, ricorda! – disse Ulisse, e prese dal fondo della barca un sacchetto di pepe di Rodi, e lo lanciò nell’aria.
– EEEEEEETCIUUM! – starnutì Noto, mandando un potentissimo soffio sulla vela: la barca balzò avanti, raggiungendo Nettuno.
Ulisse buttò altro pepe.
– EEEEEEETCIUUM! – starnutì Noto, gonfiando la vela, e la barca filava tre volte più veloce di prima.
Con sette manciate di pepe, Ulisse arrivò all’isolotto, e aspettò Nettuno.
– Come hai fatto ad arrivare così presto, con così poco vento? – chiese il dio. – Forse Noto mi ha disobbedito?
– No, certo! – disse Ulisse. – Si è messo a fare starnuti. Deve aver preso il raffreddore! Nettuno, che forse sapeva che cos’era accaduto o forse no, scoppiò a ridere e ordinò ai venti di spingere la barca di Ulisse fino a Itaca, dov’era la sua casa.
Roberto Piumini, Mi leggi un’altra storia? Edizioni EL
IL CONTESTO
Completa segnando con una X .
I personaggi del racconto sono: verosimili. reali. fantastici.
Il tempo in cui è ambientato il racconto è: indefinito. reale.
I luoghi in cui è ambientato il racconto sono: reali. fantastici. verosimili.
LE INFERENZE
Completa segnando con una X . Il protagonista supera la difficoltà : con la forza. con l’astuzia. con il coraggio.
LE INFORMAZIONI ESPLICITE
Rispondi.
Perché Nettuno propone una gara a Ulisse?
Perché il venticello Noto non vuole disubbidire a Nettuno?
Perché Ulisse si annoia?
GRAMMATICA
EEEEEEETCIUUM! è un’ onomatopea . Segna con delle X solo le onomatopee.
BRRR! CIAO! SLAMM! SIGH! HO Completa.
Venticello e isolotto sono nomi: alterati. derivati. composti.
La funzione didattica
Imparare a riassumere è un’attività che richiede molte e complesse abilità, che devono essere acquisite in modo graduale e consapevole.
La capacità di sintetizzare è una competenza fondamentale per la costruzione di un efficace metodo di studio.
Un buon metodo di studio, infatti, non si insegna e non si impara: “si costruisce” mettendo in atto abilità, conoscenze e competenze.
Il metodo di studio rientra nell’ambito della metacognizione proprio perché implica una consapevolezza della finalità, della capacità di comprensione, dell’utilizzo delle proprie conoscenze.
Abilità
Attività e consigli per l’insegnante
Strategie Scopo Fatti Inferenze Sintesi Mappa
COMPETENZE
METODO DI STUDIO
ACQUISIRE INFORMAZIONI
ELABORARE INFORMAZIONI
RIPETERE INFORMAZIONI
Anche il percorso per arrivare all’abilità di “fare un riassunto” dovrebbe nascere dalla motivazione.
Per questo, prima di affrontare le diverse tappe, si potrebbe ricorrere al “problem solving”. Leggere un testo narrativo agli alunni e alle alunne chiedere loro di raccontare brevemente la trama.
Si potrebbe anche farli lavorare in gruppo e sentire a quali conclusioni giunge ciascun gruppo.
Solo dopo che gli allievi e le allieve avranno cercato di trovare delle risposte personali per risolvere il problema, l’insegnante potrà raccogliere le loro idee e sistematizzarle, integrando gli eventuali passaggi omessi dagli allievi e dalle allieve. In questo modo ci si renderà conto di quali siano i passaggi meno riconosciuti e si potrà impostare il lavoro in modo proficuo. Molti allievi e allieve, se non opportunamente guidati, nel fare i riassunti non eliminano il discorso diretto o cercano di sintetizzare anche le parti descrittive.
Si introduca il concetto che per “fare un buon riassunto”, cioè per trasformare il testo letto o ascoltato in un racconto molto più breve che, però, fornisca tutte le informazioni fondamentali, servono “strumenti” che ci aiutino.
Per portare gli alunni e le alunne a raggiungere la competenza di fare un riassunto bisogna aiutarli a percorrere diverse tappe: capire l’argomento; capire la trama; suddividere il racconto in sequenze narrative, temporali e logiche; distinguere le sequenze narrative rilevanti da quelle meno essenziali e trattenere solo quelle indispensabili per la comprensione della trama; eliminare le sequenze descrittive e riflessive; individuare il fatto principale di ciascuna sequenza e sintetizzarlo in una frase chiave (smontaggio); collegare le frasi chiave per trasformare lo smontaggio in una narrazione breve ed essenziale.
Per redigere un riassunto in modo corretto occorre anche tenere presenti alcune regole che riguardano la struttura e la forma. Bisognerà aiutare gli alunni e le alunne a: organizzare le informazioni in forma sintetica e coerente con il testo originale; trasformare i dialoghi in sequenze narrative attraverso il passaggio dal “discorso diretto” al “discorso indiretto”; scrivere le frasi chiave in terza persona; utilizzare sempre lo stesso tempo nelle voci verbali (nello smontaggio è preferibile l’uso del presente).
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
Plic la lacrima era sempre triste, perché era nata dal pianto di un bambino che si chiamava Oreste.
Scese giù giù lungo una guancia di Oreste, cadde a terra e si addormentò.
Quando si risvegliò, correva insieme a tante altre gocce in un fiume.
Quando però i pesci rossi si accorsero che Plic era triste, le chiesero: – Perché non sorridi? Che cosa ti è successo, amica gocciolina?
– Niente – rispose Plic, – è solo che io sono una lacrima di pianto e non so proprio che cosa sia la felicità…
– Non ti preoccupare: la felicità è facile, ora te la insegniamo noi! – dissero i pesci in coro e si misero a cantare una canzoncina così allegra, che persino le trote non riuscivano a trattenere le risate.
Plic però non rise.
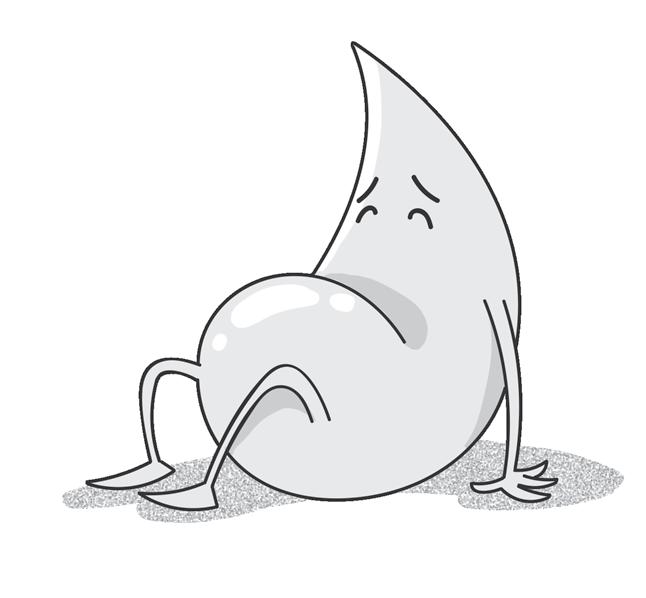
Il fiume poi la portò al mare e qui la piccola lacrima, persa in tutta quell’immensità d’acqua, si sentì ancora più triste.
Poi accadde che i raggi del sole la rapirono e la portarono sulle nuvole.
Queste provarono a far ridere la piccola lacrima, facendole il solletico con lunghi sbuffi di vapore. Provò anche il vento, suonando una musica forte e allegra. Plic però rimase seria e triste. Un giorno, infine, si sentì un tuono: Boom! Cominciò un temporale e le nuvole correvano come impazzite da tutte le parti.
Plic cadde giù, come una goccia di pioggia, e si ritrovò di nuovo nel fiume dov’era già finita una volta.
Stavolta però non giunse al mare: una pompa la risucchiò e la costrinse a correre in un tubo di metallo. Il tubo era lungo e buio, e sembrava non finire mai.
Invece, proprio quando Plic cominciava a disperare, la lacrimuccia uscì da un rubinetto aperto per finire in un bicchiere. Era il bicchiere di un bambino che lei conosceva già. Era proprio il bicchiere di Oreste.
Il bambino bevve tutta l’acqua e Plic si ritrovò là dov’era partita, dentro gli occhi di Oreste. Ma ci restò pochissimo: il bambino stava guardando dei cartoni animati così divertenti, ma così divertenti, che gli venne da ridere fino alle lacrime.
Allora Plic uscì dagli occhi di Oreste per la seconda volta, ma ora non era più triste, ora era felice…
S. Bordiglioni, Omero e l’Acchiappastorie, Einaudi Ragazzi
Osserva le immagini che rappresentano la trama del racconto e disegna le sequenze mancanti.
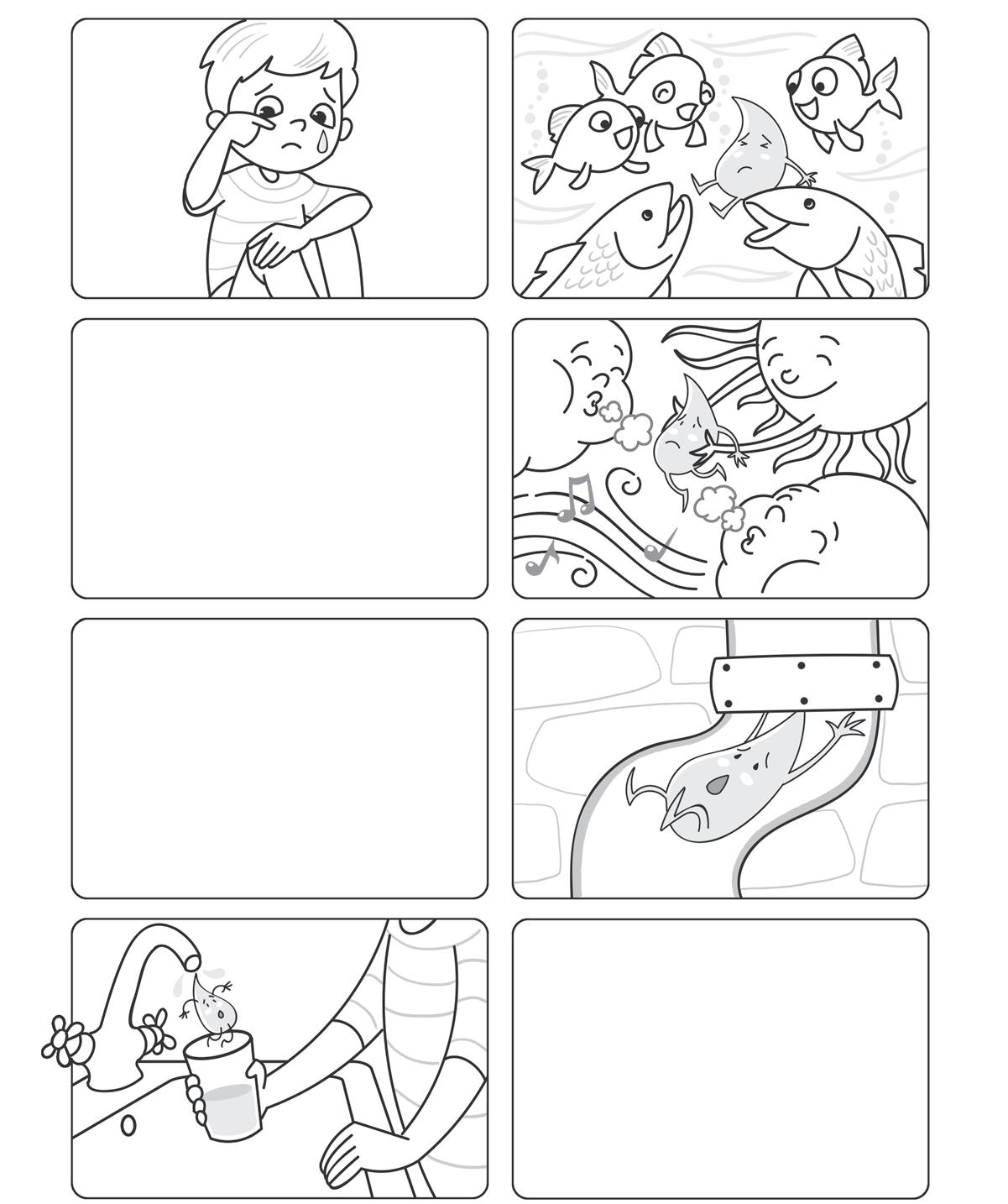
Nome e cognome Data

Leggi con attenzione.
Un giorno un uccellino fuggì dalla gabbia.
Quando sentì i canti che provenivano dal bosco, l’uccellino fu certo che là avrebbe trovato qualcuno della sua famiglia. Ma nessuno degli uccelli lo riconobbe e lo accettò tra loro. Così l’uccellino si sentì triste e solo.
Quando, la mattina dopo, si svegliò, l’uccellino fu abbagliato da una coltre bianca che ricopriva ogni cosa.
Era dunque arrivato il temuto inverno? Non era poi così ostile, pensò, con tutti quei fiocchi che svolazzavano nell’aria.
Anch’egli si mise a svolazzare nella radura, rincorrendo i fiocchi.
Fin quando, a un tratto, vide lupi e volpi in cerca di cibo. – Qui sono troppo allo scoperto. È meglio che torni nel folto del bosco – si disse.
Mentre si addentrava tra gli alberi, sentì un gemito venire da una grossa tana. Era il gemito dell’orso.
– Non riesco ad andare in letargo. Mi si è conficcata una spina nella zampa – si lamentava l’orso. – Chi può soccorrermi?
L’uccellino non esitò e volò dritto verso la tana… e piano piano estrasse la spina dalla zampa dell’orso.
Era una grossa spina. Un po’ di sangue gli colò sul petto, macchiandolo di rosso, ma lui non se ne accorse. L’orso sì, e se ne scusò. Poi si leccò la ferita, invitò l’uccellino a ripararsi dal freddo nella sua tana e cadde subito in un profondo sonno.
Solo quando la neve cominciò a sciogliersi e spuntarono i primi fiori, si risvegliò. Si stiracchiò e uscì a rotolarsi nella neve, per ripulirsi il pelo dalle foglie su cui aveva dormito. Ma, quando scorse l’uccellino che gli svolazzava accanto, dispiaciuto, disse: – Il tuo petto è rimasto macchiato di sangue. Che peccato!

– No, io… in realtà… sono rosso per l’emozione di rivederti – fece l’uccellino. – Sono così felice di rivedere un amico che mi viene voglia di cantare.
Appena lo sentirono, gli altri uccelli del bosco si chiesero chi fosse quell’uccellino, mai visto prima, che eguagliava, anzi superava tutti nel loro canto.
– Lui è il mio amico pettirosso – diceva a tutti l’orso.
E questo è il nome che gli è rimasto fino a oggi.
A. D’Este, Una fiaba nel bosco, Edizioni Arka

Qual è la trama corretta del racconto? Rispondi segnando con una X .
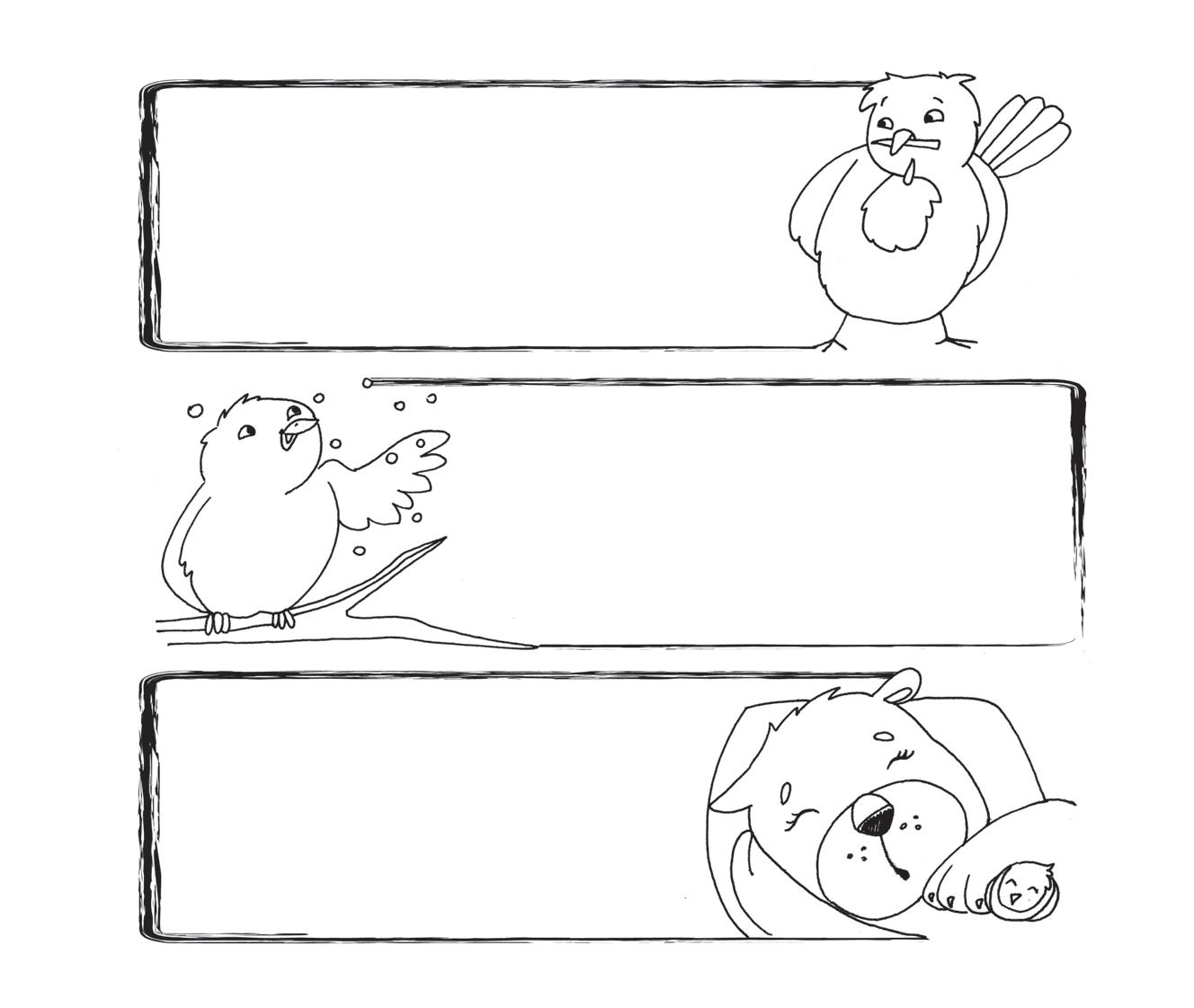
Un uccellino non viene accolto dagli altri uccelli.
Scappa dalla gabbia.
Si rifugia nella tana dell’orso.
Toglie la spina dalla zampa di un orso.
Si macchia il petto con il sangue dell’orso.
L’uccellino si mette a cantare.
L’uccellino viene chiamato “pettirosso”.
Un uccellino scappa dalla gabbia.
È convinto di aver trovato qualcuno della sua famiglia.
Si accorge che è arrivato l’inverno.
Un orso si lamenta per la spina conficcata nella zampa.
Quando l’orso si risveglia l’uccellino diventa rosso per l’emozione di rivedere un amico.
L’uccellino viene chiamato “pettirosso”.
Un uccellino scappa dalla gabbia.
Non viene accolto dagli altri uccelli.
Toglie la spina dalla zampa di un orso.
L’orso va in letargo e l’uccellino rimane con lui.
Quando l’orso si risveglia, l’uccellino diventa rosso per l’emozione di rivedere un amico.
L’uccellino viene chiamato “pettirosso”.
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione. Sulla pagina successiva, osserva le immagini che rappresentano le sequenze . Ritagliale e incollale accanto alla sequenza corrispondente.
Tom e Huck, con il piccone e il badile in spalla, raggiunsero la casa abbandonata: c’era un’atmosfera così paurosa che per un istante ebbero timore di proseguire.
Avanzarono fino alla porta e videro una stanza senza pavimento. Entrarono con il cuore che batteva forte.
A poco a poco la loro paura scomparve. Salirono di sopra a curiosare.
Stavano per scendere quando… – Hai sentito? – fece Tom. – Sì, scappiamo! – mormorò Huck. – Fermo, vengono verso la porta.
I ragazzi si sdraiarono sul pavimento di assi, guardando impauriti attraverso le fessure. Entrarono due uomini: i due erano dei pericolosi assassini.
Parlarono per un po’, poi si addormentarono. La casa era il loro rifugio.
Tom sussurrò: – È il momento buono: filiamo! Si alzò adagio e mosse il primo passo, ma il pavimento scricchiolò così forte che si lasciò ricadere giù, morto di paura.
A un certo punto i due cominciarono a mangiare. Mentre mangiavano, uno notò il piccone e il badile e disse: – Chi avrà portato qui quegli arnesi?
I due ragazzi rimasero senza fiato.
L’individuo portò la mano al coltello e si girò verso la scala. La scala scricchiolava sotto il suo peso… quando si udì un rovinio di legname marcio.
L’uomo precipitò a terra. Tom e Huck si alzarono in piedi e uscirono velocemente dalla casa.
M. Twain, Le avventure di Tom Sawyer, Rizzoli
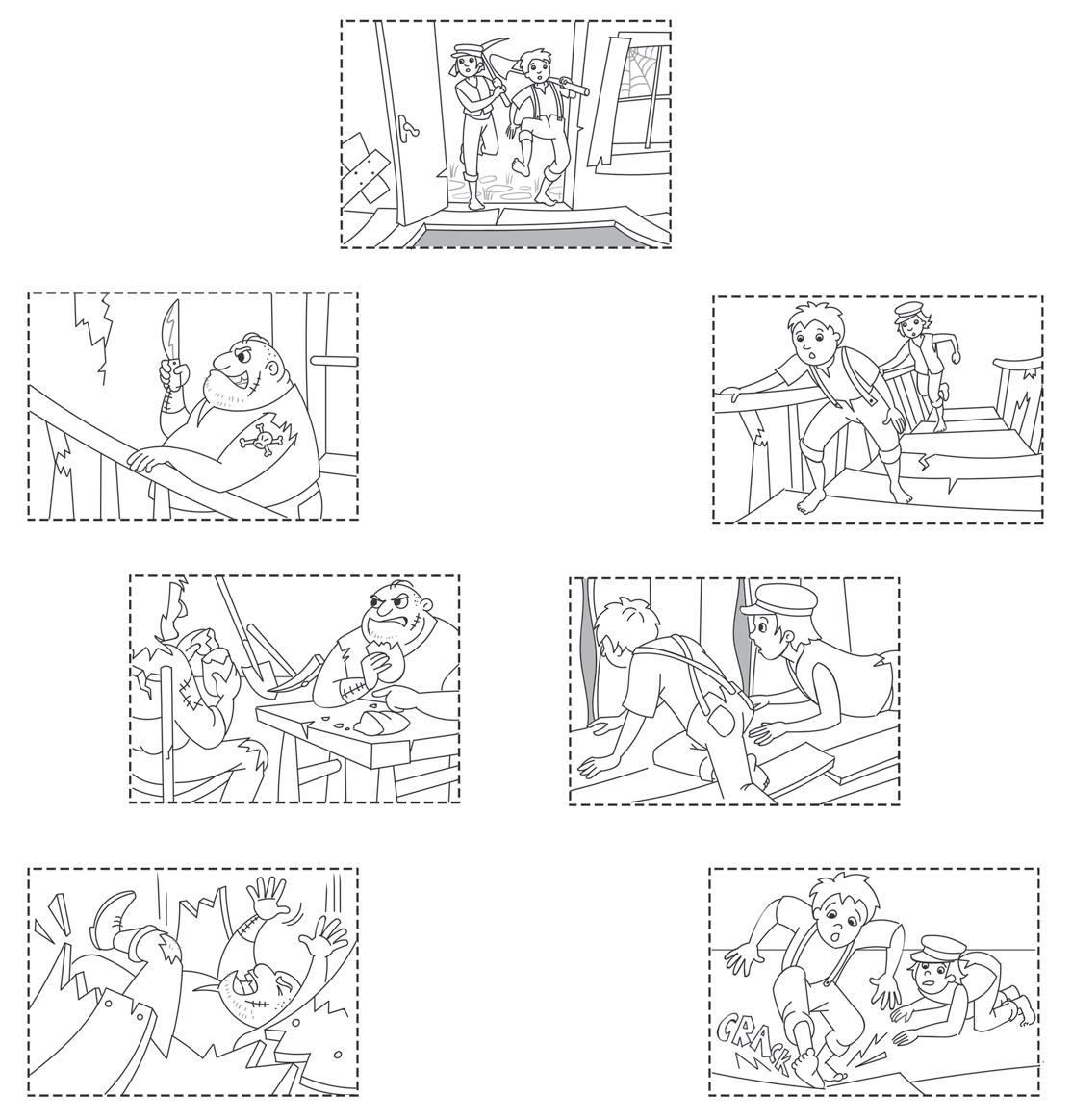
Nome e cognome
Leggi con attenzione.
In una città lontana viveva un vecchio omino che tutti chiamavano papà Guglielmo. Egli era buono e sempre pronto ad aiutare gli altri.
Alcune persone, però, lo credevano un po’ matto: egli, infatti, sosteneva di conoscere il linguaggio degli uccelli.
Un giorno, mentre si recava nel bosco, papà Guglielmo si sentì chiamare. Si guardò intorno e scorse un grosso corvo che cercava di attirare la sua attenzione.
L’omino comprese ciò che l’uccello voleva dirgli, e lo seguì immediatamente.
Il corvo lo guidò a una radura in cui giaceva una povera volpe ormai in fin di vita. Papà Guglielmo tentò di curarla, ma le ferite erano troppo profonde e gravi.
Proprio in quel momento si trovava a passare di lì il guardiacaccia.
Vedendo la volpe nella trappola, si rivolse all’omino dicendogli: – Ora capisco cosa vieni a fare nel bosco: dai la caccia alle volpi per vendere la loro pelliccia!
Il guardiacaccia gli mise le manette e lo costrinse a seguirlo in città.
Lì Guglielmo fu condotto davanti al giudice, che l’interrogò.
Quando egli affermò di comprendere il linguaggio degli uccelli, tutti scoppiarono a ridere.
Le prove sembravano tutte a sfavore di papà Guglielmo, ma il giudice non lo riteneva capace di un’azione così crudele.
Prima di prendere una decisione, quindi, volle riflettere e, siccome per legge non poteva lasciare libero il vecchietto, lo fece mettere in prigione in attesa del giorno successivo.
Ma durante la notte, sulla finestra della cella si appollaiò lo stesso corvo che già una volta lo aveva avvertito. Guglielmo alzò la testa e ascoltò.
Un bracconiere stava preparando altre trappole nel bosco. Non c’era un minuto da perdere, se si voleva salvare la vita di qualche altro povero animale!
Guglielmo fece subito chiamare il giudice e gli raccontò ciò che gli aveva rivelato il corvo.
– Voglio darti fiducia – disse il giudice. – Manderò le guardie a controllare.
Le guardie, giunte nel bosco, scorsero il bracconiere con un grosso sacco sulle spalle.
Nel sacco c’era la volpe caduta nella trappola il giorno prima.
Così, papà Guglielmo fu liberato e il bracconiere messo in prigione al suo posto.
Nel bosco trovò ad attenderlo tutti i suoi amici uccelli, che gli avevano preparato una gran festa di voli e canti per ringraziarlo di aver sconfitto il temibile bracconiere.
Salvatore Sciascia - Gloria Sartori, Papà Guglielmo e gli uccelli, Edizioni San Paolo
Nel testo puoi individuare questa successione di sequenze : colora le parentesi nel modo indicato. la situazione iniziale: arancione interviene un nuovo personaggio: rossa cambia il luogo dove accadono i fatti: verde interviene un nuovo personaggio: rossa cambia il luogo dove accadono i fatti e interviene un nuovo personaggio: verde cambia il tempo in cui si svolge la vicenda: blu accade un fatto nuovo: viola la vicenda si conclude: arancione
Leggi le frasi chiave e collegale alle sequenze corrispondenti, scrivendo i numeri.
1. Il guardiacaccia porta Guglielmo dal giudice.
2. Il corvo guida Guglielmo da una volpe ferita.
3. Durante la notte il corvo dice a Guglielmo che nel bosco c’è un bracconiere.
4. Guglielmo conosce il linguaggio degli uccelli.
5. Un guardiacaccia scambia Guglielmo per un cacciatore.
6. Guglielmo guida le guardie nel bosco.
7. Nel bosco un corvo chiama Guglielmo.
8. Guglielmo viene liberato e il bracconiere viene arrestato.

Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
MICIO
Micio era molto affezionato ad Alessandro, il suo padroncino. Si sa che i gatti sono affettuosi. Certo, non così affettuosi come i cani, ma comunque affettuosi. Micio però era un gatto speciale: lui soffriva davvero la mattina, quando Alessandro si preparava e andava a scuola.
Così, decise un giorno di seguirlo: aspettò che il suo padroncino uscisse, poi svelto svelto aprì l’armadio di Alessandro, tirò fuori un paio di calzoni a quadrettini azzurri con le bretelle e una maglietta scura, e li indossò.
Si guardò un attimo allo specchio: così vestito sembrava un bambino anche lui.

Raggiunse la scuola in quattro balzi, senza dare troppo nell’occhio, come solo i gatti sanno fare. Sgattaiolò dentro alla classe di Alessandro e si sedette nell’ultimo banco.
La maestra intanto era entrata e aveva già tirato fuori il registro per fare l’appello. Quando però ebbe chiamato l’ultimo nome sul registro, la maestra si accorse che c’era un bambino che non si era ancora alzato in piedi a dire “presente”. Era un bambino che non aveva mai visto…
– Senti, bambino là in fondo, tu chi sei?
– Miao! – rispose il gattino educatamente, alzandosi.
Alessandro riconobbe subito il suo micetto e spalancò la bocca stupito: non riusciva a capire come mai si trovasse lì in classe con i suoi vestiti addosso. Era così meravigliato che non disse niente.
La maestra vide la lunga coda, i baffi e le orecchie a punta di quello strano bambino e capì subito la situazione.
– Chi è il padrone di questo gattino? – chiese senza arrabbiarsi.
Alessandro alzò la mano un po’ preoccupato: si aspettava una sgridata.
Ma la maestra disse solo: – Siediti vicino a lui, Alessandro. Per oggi può restare, ma domani ti dovrà aspettare a casa.
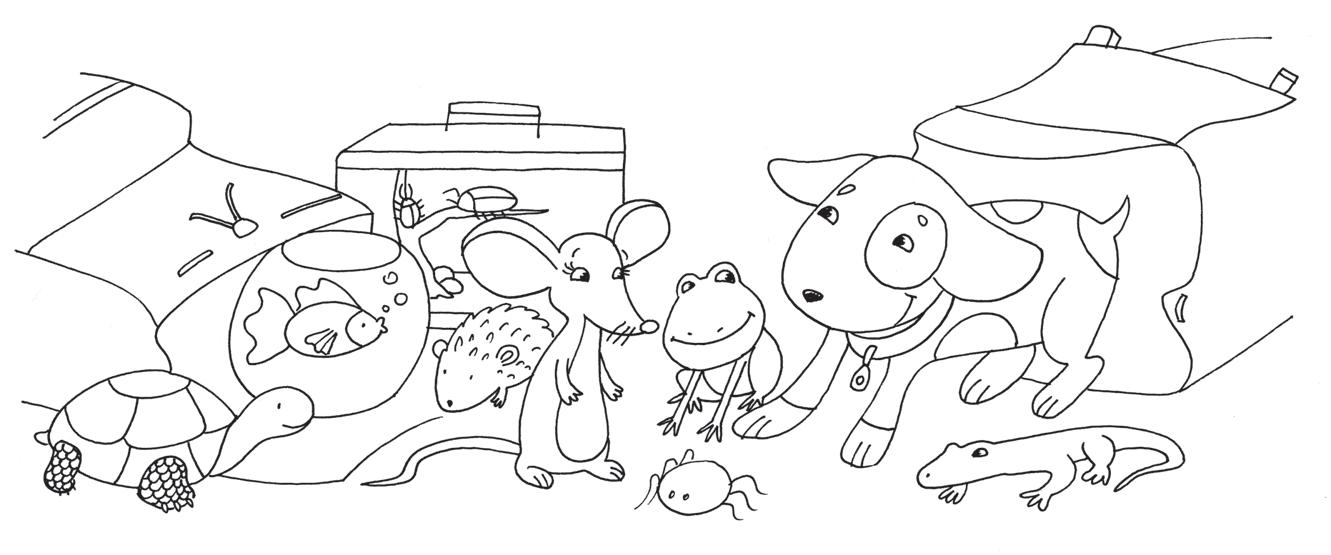
Alessandro cambiò banco tutto contento, poi la brava maestra si mise a fare lezione come se niente fosse: in tanti anni di scuola i bambini le avevano portato in classe lucertole, rane, cagnolini, ragni, pesci, tartarughe, maggiolini, criceti e topolini. Un micetto non poteva meravigliarla davvero, neanche se era vestito da bambino.
Stefano Bordiglioni, Omero e l’Acchiappastorie, Einaudi Ragazzi
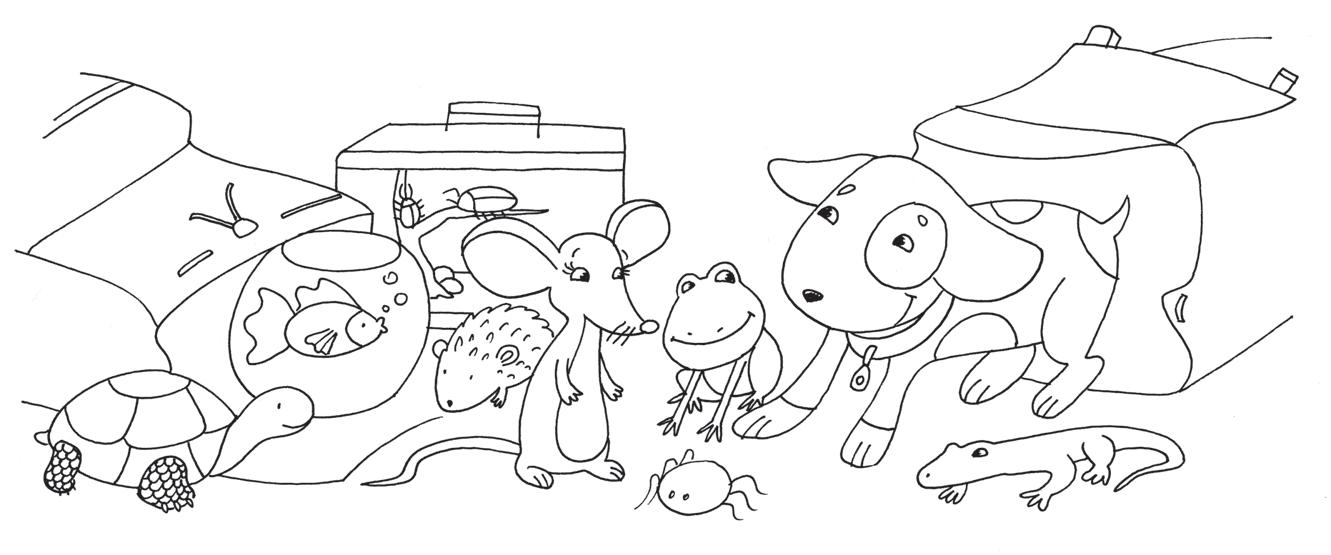
Completa.
Situazione iniziale
Il primo fatto nuovo che avviene rispetto alla situazione iniziale è che il gatto
Il primo cambio di luogo avviene quando Micio
Il primo nuovo personaggio a intervenire è
Il fatto successivo all’ingresso del secondo personaggio è
I personaggi che dialogano sono
La storia si conclude con
Colora con colori diversi i cerchiolini dell’esercizio precedente. Poi colora nello stesso modo le parentesi cui si riferiscono.
Completa segnando con una X .
La frase chiave della sequenza dialogica è:
la maestra e Alessandro si accorgono della presenza del gatto.
Alessandro riconosce il suo gatto. la maestra si accorge della presenza del gatto.
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
Si raccontava un tempo e si racconta ancora oggi… di quando Genesio, cuore semplice, raccontò una frottola proprio clamorosa.
Genesio abitava in un piccolo paese lontano qualche chilometro da Marsiglia e in quella grande città della Provenza si recava tutti i giorni per il mercato.
Genesio era sempre ben felice di rispondere alle domande dei suoi concittadini e ogni sera, al ritorno dal mercato, questi gli chiedevano: – Dicci, Genesio, che cosa è successo oggi a Marsiglia?
Genesio rispondeva gentile, raccontando per filo e per segno tutta la giornata al mercato: raccontava delle stradine del quartiere vecchio, dei grandi viali e del porto, ma tutte le volte, prima ancora di finire il racconto, qualcuno lo interrompeva: – No Genesio, non le solite cose… vogliamo sapere se è successo qualcosa di interessante.
E allora Genesio ci pensava un po’ e poi rispondeva: – Veramente, di interessante interessante non è successo nulla – e così tutti riprendevano le loro faccende.
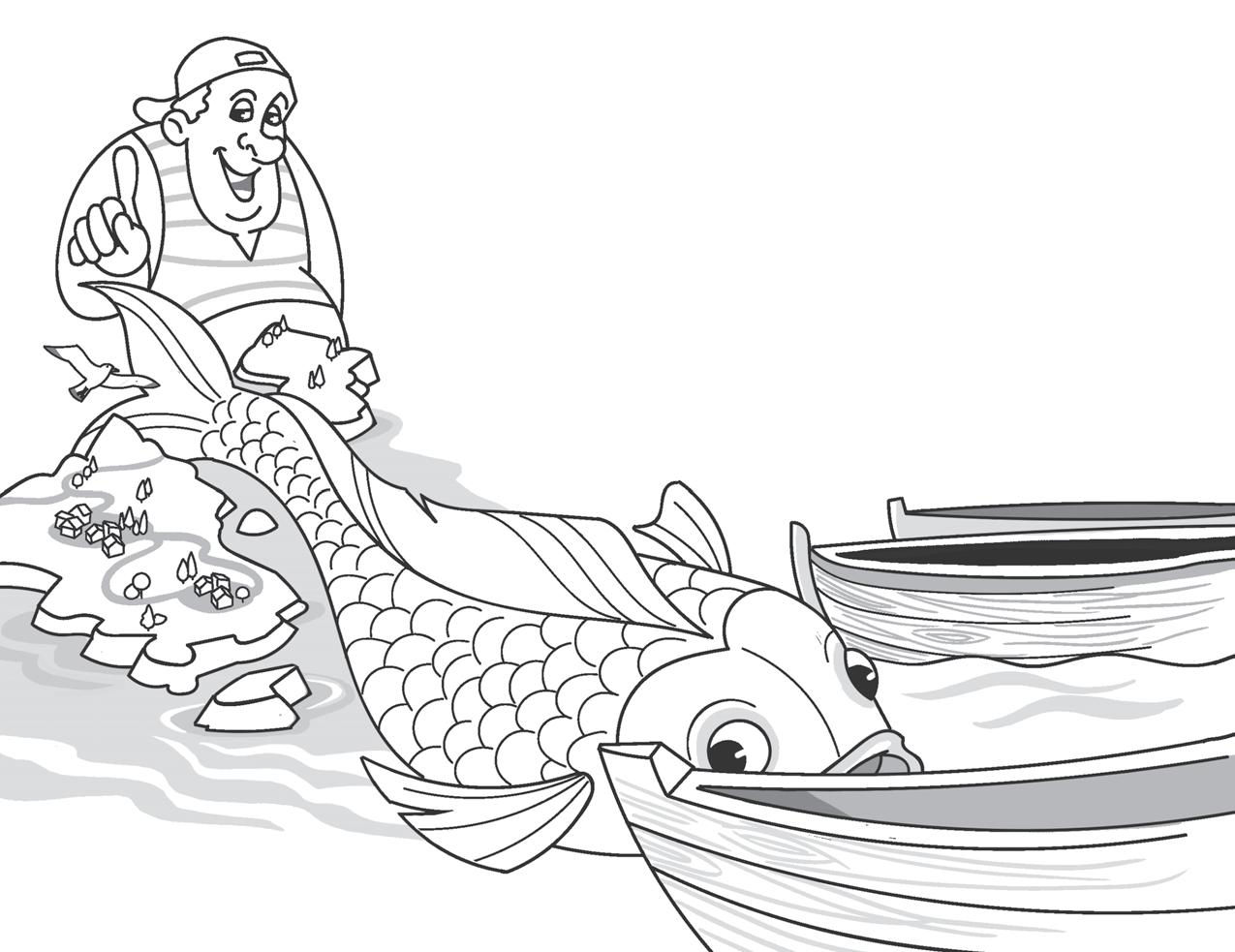
Ma, una sera, Genesio era di buon umore e decise di fare uno scherzo ai suoi concittadini: decise che avrebbe raccontato una frottola così grande da far ridere tutto il paese. Così, quella sera, al ritorno dal mercato, quando gli altri chiesero: – Dicci Genesio, che cosa è successo oggi a Marsiglia? – Genesio rispose allegro: – Eh, sì, oggi è capitato qualcosa di incredibile. Stamattina è entrato in porto un pesce grande come tutta la città, ed è ancora lì: la testa bloccata tra i moli, la coda impigliata nelle isole di fronte a Marsiglia. Tutta la città è salita sulla collina di Nostra Signora della Guardia a godersi lo spettacolo. E tutti i pescatori di Marsiglia, oh poverini! oh disgraziati!,
sono al porto a cercare di liberare il pesce che blocca la città.
I concittadini di Genesio dissero in coro: – Oooh! Cose da non credere: un pesce grande come tutta Marsiglia! Bisogna andare a vedere!
E così, tutti gli abitanti del piccolo paese si diressero verso la grande città della Provenza.
Genesio guardò la gente partire sorridendo in cuor suo, ma quando vide che tutti, ma proprio tutti, perfino i malati, erano partiti per Marsiglia si disse: – Oh! Accidentaccio! Se tutti gli abitanti del mio paese vanno a Marsiglia vorrà dire che la storia del pesce così grande da bloccare la città è vera!
Così Genesio strinse bene i lacci delle scarpe e si mise a correre forte per raggiungere i suoi concittadini che andavano a vedere il pesce talmente grande da bloccare Marsiglia.
A. Roveda - C. Dattola, Il cammello che sapeva leggere, Terre di Mezzo
Rispondi per trovare le frasi chiave
Che cosa fece Genesio?
Dove andava Genesio tutti i giorni?
Che cosa succedeva tutti i giorni?
Che cosa raccontò Genesio una sera per fare uno scherzo?
Che cosa fecero gli abitanti del paese?
Infine che cosa decise di fare Genesio?

Ora, nel testo, segna con colorate le sei sequenze identificate nell’esercizio precedente.
Ricopia in ordine le frasi chiave per fare lo smontaggio.
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
Nel giardino dello zio della compagna di banco del cugino del vicino della nipote del… insomma, in un giardino, da qualche parte della città, se ne stava lì un bell’albicocco che non faceva più albicocche.
Be’, tanto bello non lo era più, quell’albicocco: da un po’ aveva smesso di sbocciare con mille fiori in primavera e, di conseguenza, niente più albicocche d’estate e, cosa ben più grave, niente più marmellata di albicocche tutto l’anno.
Solamente qualche foglia sui rami e nulla più.
A cosa serve un albicocco che non fa albicocche?
“Serve a me, per stare appollaiata sui rami”, pensava una gallina che, in effetti, aveva preso la bella abitudine di starsene un giorno su questo e un giorno su quel ramo, senza paura di cadere.
Lo zio, però, non la pensava per nulla così e dopo essersi consultato con la zia, prese un’accetta e una grossa sega e uscì nel giardino.
La pollastra, accovacciata lassù, appena vide lo zio intuì subito il grave pericolo che il suo albicocco stava correndo e, con quanta più voce aveva nel becco, cominciò a strillare come una matta per chiamare le altre galline.
– Coooo – co – co – co – co – cosa vuoi fare?
Cheeee – che – che – che – che – che intenzioni hai?
Coooo – co – co – co – co – come faccio adesso?
Caaaa – ca – ca – ca – caaaaalma e sangue freddo!
Coooo – co – co – co – correte!
Cuuuu – cu – cu – cu – cu – cugine!
Coooo – co – co – co – co – compagne!
Caaaa – ca – ca – ca – caspiterina!
In men che non si dica il pollaio si svuotò e, svolazzando un po’ goffe, tutte le galline accorsero in aiuto della sorella e del vecchio albicocco.
Lo zio alzò il naso e, ohibò, non c’era un ramo di quell’albero che non ospitasse una delle sue galline con lo sguardo minaccioso.
E non appena fu sotto l’albicocco, proprio accanto al tronco, con l’accetta in una mano e la sega nell’altra, le polle, dopo un rapido cenno d’intesa, sfornarono un bell’uovo, anche più grande del solito. Tutte, nessuna esclusa.
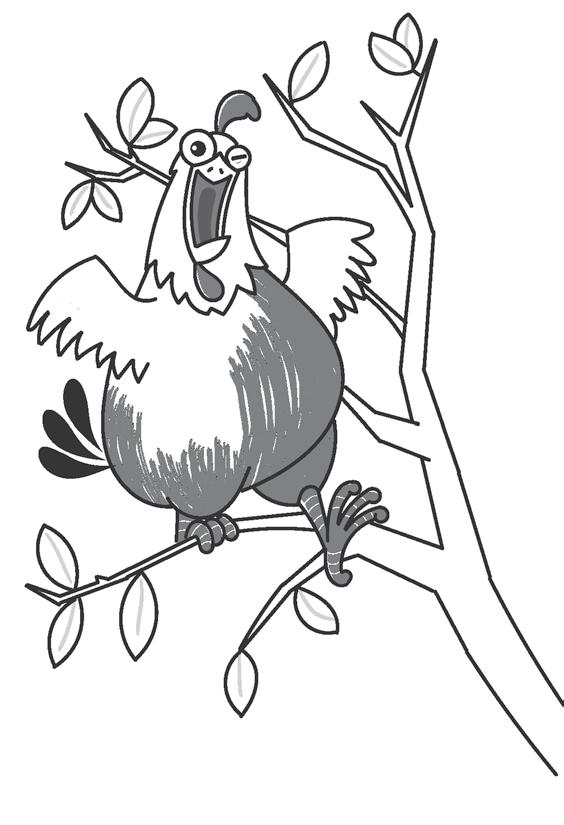
Mamma mia che pioggia di uova… Meglio che a Pasqua! Tre finirono sulla testa dello zio, una sul ginocchio sinistro e una sulla scarpa destra, che era nuova e adesso nuova non lo era più.
Lo zio, spaventato e sbigottito, lasciò cadere i suoi arnesi e, tutto gocciolante di tuorlo e albume, tornò in fretta e furia dentro casa, dalla zia. Non sapendo come spiegarsi, disse solo: – Ho fatto una frittata!

E la cosa bella è che anche dopo molti anni, con sempre meno foglie, ma con sempre più galline, l’albicocco è ancora lì.
Andrea
Valente, Chissà perché, Gallucci
Il testo è stato diviso in sequenze.
Colora le parentesi delle tre che NON sono fondamentali.
Segna con delle X il tipo di sequenze che hai eliminato.
Sequenza descrittiva.
Sequenza dialogica.
Sequenza riflessiva.
Per ogni sequenza importante, scrivi la frase chiave per fare lo smontaggio .
Nome e cognome Data
Una volta un bambino conobbe uno gnomo che gli insegnò a volare a dorso degli uccelli, facendosi piccolo come uno gnomo.
Questo era ciò che il bambino aveva desiderato da sempre. Per questo si recò nel Bosco degli Gnomi, dove conobbe lo Gnomo Amico dei Grandi Uccelli Volanti.
Lo gnomo riunì tutti gli uccelli: l’aquila reale e il condor, l’albatros e l’airone cenerino. Ma nonostante le loro grandi dimensioni, questi uccelli non riuscivano a volare con il peso del bambino.
Allora l’Amico dei Grandi Uccelli Volanti decise che era necessario ridurre le dimensioni del bambino. Gli insegnò il Segreto per Farsi Piccolo, un segreto che il bambino non poteva rivelare a nessuno. Lui stesso doveva dimenticarselo, dopo ogni volo, fino al suo prossimo giro nell’aria.
Perché nessuno scoprisse il segreto, lo gnomo e il bambino si nascondevano a parlare sotto i rami di un albero frondoso, al riparo da orecchie indiscrete.
E così il fanciullo poté volare. Ogni volta che sorvolava il Bosco degli Gnomi, guardava in giù e sorrideva.
AA.VV., Il libro segreto degli gnomi (n. 10), De Agostini AMZ
Dividi il testo in sequenze .
Per ogni sequenza, sottolinea l’ informazione principale
Fai lo smontaggio scrivendo la frase chiave che puoi ricavare dall’informazione principale di ogni sequenza.
Collega le frasi chiave per fare il riassunto .
Nome e cognome
Una notte un saggio stava leggendo nella sua casa quando entrò un ladro, armato di una sciabola affilata.
Con fare minaccioso ordinò al saggio di non muoversi e cominciò ad aprire i cassetti alla ricerca di denaro.
Allora il saggio gli disse: – Ti prego di non buttare tutto all’aria. Il denaro è lì in quel cassetto. Prendilo.
Lo sconosciuto prese il denaro e un vaso di giada. – Vedo che quel vaso ti piace – disse il saggio, – te lo regalo!
Il ladro, non vedendo altre cose da rubare, stava per andarsene, quando il saggio lo chiamò. – Dimentichi qualcosa – gli disse sorridendo, – non mi hai detto grazie. L’uomo, sorpreso, ringraziò il saggio e fuggì nella notte.
Qualche giorno dopo le guardie dell’imperatore bussarono alla porta del saggio. Con loro c’era il ladro. – Quest’uomo deve avervi rubato questo vaso. Se è vero, lo metteremo in prigione – dissero.
– Riconosco questo vaso, ma non l’ha rubato – disse il saggio. – Gliel’ho donato io. Mi ha anche ringraziato.
Le guardie liberarono immediatamente il ladro. Costui, pieno di gratitudine, ringraziò il saggio.
Promise di non dimenticare mai la semplice parola che lo aveva salvato: grazie.
M.C. Coles - M.L. Ross, L’alfabeto della saggezza, Einaudi Ragazzi
Dividi il testo in sequenze
Per ogni sequenza sottolinea l’ informazione principale .
Fai lo smontaggio scrivendo la frase chiave che puoi ricavare dall’informazione principale di ogni sequenza.
Collega le frasi chiave per fare il riassunto .
Funzione didattica
I testi si diversificano tra loro per lo scopo comunicativo per cui sono stati scritti (suscitare emozioni, dare insegnamenti, creare suspense e aspettative, descrivere, informare…). Per realizzare questo scopo gli autori/le autrici hanno creato strutture narrative diverse, le quali sono alla base delle diverse tipologie testuali
Leggendo testi di tipologia diversa i bambini e le bambine, da soli/e, ne colgono inconsciamente le differenze, le caratteristiche, le peculiarità e gli scopi comunicativi.
Un percorso sull’analisi delle differenti tipologie testuali ha come obiettivo quello di offrire al bambino e alla bambina la possibilità di affrontare un argomento seguendo stili espositivi differenti e quindi comprendere quale sia il fine per cui i testi sono stati scritti. Il riconoscimento delle caratteristiche strutturali di ciascuna tipologia ha bisogno di un lavoro di analisi che il bambino e la bambina non sono in grado di fare da soli. Per questo vanno aiutati attraverso un percorso che li induca a individuare gli aspetti specifici di ogni tipologia.
Discutere delle caratteristiche strutturali di ogni tipologia testuale li aiuterà a diventare consapevoli della necessità di adeguare il proprio registro linguistico (orale o scritto) alla situazione.
Il lavoro sarà scandito attraverso queste tappe:
Pensiero computazionale
Scopri : il bambino/la bambina legge un testo e, attraverso domande a scelta multipla, ne individua lo scopo, il contenuto, gli elementi, la struttura della tipologia testuale.
Riconosci : il bambino/la bambina lavora in modo autonomo sulle caratteristiche della tipologia.
Verifica : una modalità per verificare le conoscenze apprese dal bambino/dalla bambina.
Il testo: realistico e fantastico
Domande stimolo per introdurre il genere con la classe
Secondo voi, che cosa vuol dire narrare?
I libri di Harry Potter raccontano fatti reali o fantastici? Perché? Che cosa c’è di reale? Che cosa c’è di fantastico?
Se un amico o un’amica vi racconta che cosa ha fatto durante le vacanze, il suo racconto è fantastico o reale?
È sempre facile, leggendo un libro, distinguere se in esso vi sono solo situazioni fantastiche o se contiene anche parti realistiche?
È facile distinguere la realtà dalla fantasia?
Il testo narrativo racconta sempre una storia, cioè una serie di avvenimenti vissuti da uno o più personaggi, che si svolgono in un certo tempo e in un certo luogo.
Possiamo dividere i testi in due grandi categorie: realistici e fantastici.
I testi narrativi, a seconda del loro contenuto, della struttura, dell’intenzione comunicativa dell’autore/dell’autrice, sono divisi in generi letterari.
Nome e cognome Data
Leggi i testi. Poi, per ognuno, scrivi se è realistico o fantastico.
MORGANA
La fata Morgana viveva nel folto di una foresta molto buia ed era molto sola, perché la sua magia era diventata oscura. Come succede che una magia diventi oscura? Come succede che una fata diventi simile a una strega?
A Morgana era successo così, perché provava un sacco di invidia (e l’invidia è proprio nera) per suo fratello, che si chiamava Artù ed era diventato un re famoso, oltre che il capo dei Cavalieri della Tavola Rotonda. E lei era gelosa, e stava lì nel folto della foresta buia come i suoi pensieri, tramando cose terribili e vendicandosi su tutti i cavalieri che riusciva ad attirare fin lì.
B. Masini, Che fata che sei, Einaudi Ragazzi
Alice viveva in una bella casa insieme ai suoi genitori, quando c’erano, perché i genitori di Alice non c’erano quasi mai. Entrambi volavano, e non per qualche strana capacità o magia, ma perché la mamma di Alice era un pilota di una compagnia aerea russa e suo padre uno steward di una compagnia aerea giapponese.
Si erano conosciuti in uno dei tanti aeroporti in giro per il mondo… in un altro aeroporto si erano innamorati… in un altro aeroporto si erano sposati e in un altro aeroporto ancora era nata Alice.
A. Russo, La bambina Babilonia, Salani

C’era una volta un violino che fra le mani del famoso violinista Melodio Von Diesis suonava melodie meravigliose.
Un giorno Melodio andò a suonare insieme alla celebre violinista Biscroma Bemolle.
Capitò una cosa strana: appena i due violinisti cominciarono, dai violini uscivano solo lamenti, cigolii.
I due violinisti, preoccupati, portarono gli strumenti da Liutus, un bravo aggiustatore di violini, che prese i violini, li osservò, li toccò e disse: – È chiaro, signori! Questi violini si sono innamorati.
D’ora in poi non suoneranno più come prima. Dovrete prendere altri violini, e lasciare questi due insieme in una custodia grande, almeno saranno vicini.
– E non ci sarebbe un modo per poterli far suonare insieme? – chiese Melodio.
– Non da due suonatori diversi.
Fu così che Liutus costruì un violino un po’ più grande del normale: prese le corde dei due violini e le mise insieme come corde del nuovo violino. Era nata la Viola d’amore.
R. Piumini, Le mille e una note, Fabbri Editori
Girava sempre con una copertina.
E che cosa ne faceva?
Le copertine servono per scaldare chi ha freddo, no? Ma lei girava con berretto e sciarpa e guanti, quindi di freddo non ne aveva.
Allora per chi erano le copertine?
Per i battitori di denti.
Appena vedeva o sentiva qualche animaletto che batteva i denti, si avvicinava e gli chiedeva: – La vuoi questa morbida copertina?
Si acciambellavano sotto, felici. Felici come bucaneve sotto la neve, come dolcetti sotto la panna, come gattini sotto la mamma, come voi bambini nei vostri caldi lettini.
V. Lamarque, I bambini li salveranno, Einaudi Ragazzi
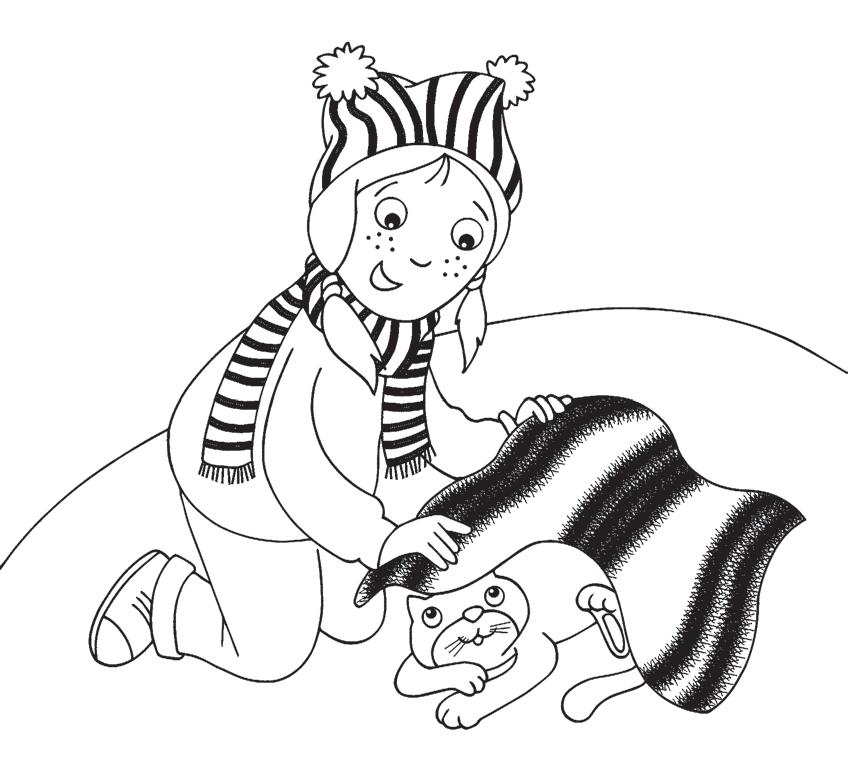
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
Da tre giorni la maestra è assente e per Geremia è già troppo, perché sinceramente, per dirla con gentilezza, il supplente non è davvero il massimo!
Non si può dire che sia cattivo, ma quanto a sorrisi è un po’ avaro e poi non spiega bene come Silenzia.
Silenzia è il soprannome che Geremia e i suoi compagni hanno dato alla maestra, per via della mania che ha di ripetere sempre per tre volte: – Silenzio, silenzio, silenzio!
Sembra una formula magica inventata dalla fatina della classe per far tacere gli alunni che disturbano.
Silenzia è un soprannome affettuoso. Geremia, infatti, adora la sua maestra. Altro che il supplente!
Ogni volta che vuole interrogare qualcuno, punta sulla vittima un lungo dito minaccioso e Geremia trema di paura.
Cosa non darebbe per far tornare la sua maestra… subito… e per sempre!
Più il tempo passa e più Geremia si fa delle domande. Un’insegnante che sparisce così per giorni non è una cosa normale. Più ci pensa più gli vengono in mente cose terribili: forse è accaduto qualcosa al marito, oppure il figlio è stato investito da un’automobile, o addirittura Silenzia è stata rapita… Sì! Dev’essere sicuramente così!
Geremia comincia a riflettere. Ecco perché il Direttore, l’altro giorno, è entrato in classe a chiamare la maestra!
Aveva appena ricevuto una telefonata anonima…
Si trattava della trappola diabolica di qualcuno che voleva attirare Silenzia in un parcheggio deserto. E, una volta lì, in un attimo, una botta in testa, come nei film alla TV… Nessuno ha visto né sentito nulla ed ecco la povera maestra chiusa in una sordida cantina.
Geremia si rigira sulla sedia. Come si fa a concentrarsi sulla lezione di geografia sapendo che la maestra è in pericolo di vita?
In quel momento il Direttore entra in classe e dice: – Ragazzi, mi ha appena chiamato la vostra maestra. Suo figlio è praticamente guarito. Una leggera bronchite… Domani tornerà a scuola – aggiunge con un gran sorriso.
L. Jaffé - L. Saint-Marc, Vivere insieme a scuola, Il Capitello
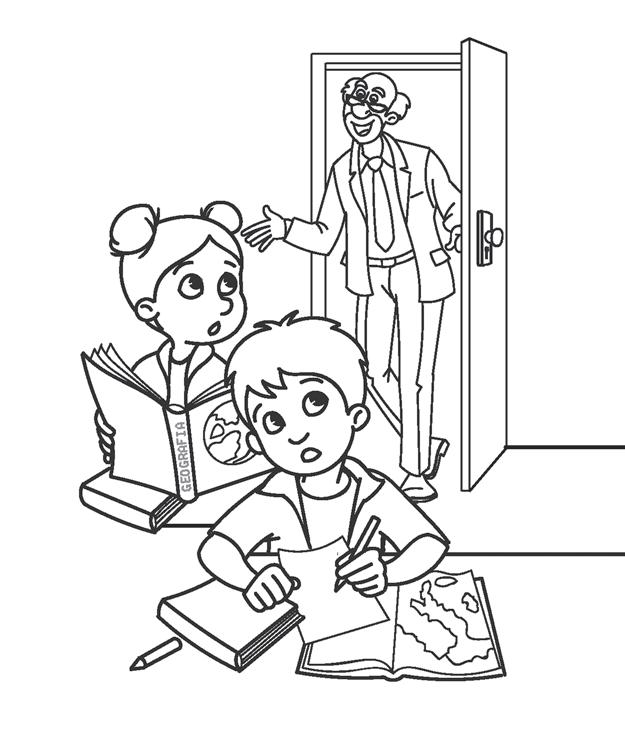
Nel testo, segna con una rossa l’ introduzione , con una blu lo svolgimento , con una verde la conclusione .
Cancella le parole sbagliate.
L’ordine della narrazione è/non è cronologico.
La narrazione contiene/non contiene flashback.
Per ogni affermazione riferita al testo, completa la tabella segnando con una X quale è vera e quale è invece immaginata dal protagonista.
Il figlio della maestra è stato investito da un’automobile.
La maestra Silenzia è stata rapita.
Il direttore ha parlato in disparte con la maestra.
Geremia farebbe qualsiasi cosa per far tornare la maestra.
Qualcuno ha attirato Silenzia in un parcheggio deserto.
Completa la tabella.
Protagonista
Luogo
Tempo
Personaggio principale
Personaggi secondari
Completa segnando con una X .
Il narratore parla: in prima persona. in terza persona.
Cerca nel testo e scrivi: il nome degli autori:
Gli elementi del testo
il titolo del libro da cui è stato tratto il brano:
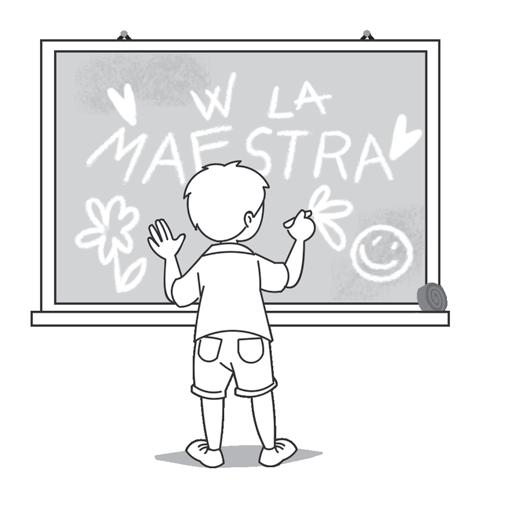
Nome e cognome
Data
Di Barry avevano tutti paura. Non si sapeva bene perché. Bastava sentirlo nominare per provare una specie di pugno gelato alla bocca dello stomaco.
A volte Peter pensava che il suo compagno fosse come un robot programmato per fare tutto quel che voleva. Che strano che non gli importasse di essere senza amici, o di essere odiato ed evitato da tutti.
Un giorno, a scuola, durante la ricreazione, Peter era sul punto di addentare la sua mela quando sollevò lo sguardo e si ritrovò gli occhi puntati sulla faccia di Barry. Sorrideva, ma non aveva l’aria contenta: voleva qualcosa. Tese molto semplicemente la mano e disse: – Voglio quella mela.
Poi tornò a sorridere.
Peter non era un vigliacco ed era abbastanza robusto per la sua età, ma odiava le risse.
– Avanti – disse Barry – passami quella mela, se non vuoi che ti disfi la faccia.
Peter sentì il gelo salirgli dai piedi e diffondersi in tutto il corpo.
Pensò alla sua mela: la buccia era un po’ vizza perché se l’era portata a scuola una settimana prima ed era rimasta nel banco tutto quel tempo. Valeva la pena di farsi disfare la faccia per così poco? Certamente no! E, d’altra parte, era giusto cederla, solo perché un prepotente la voleva?
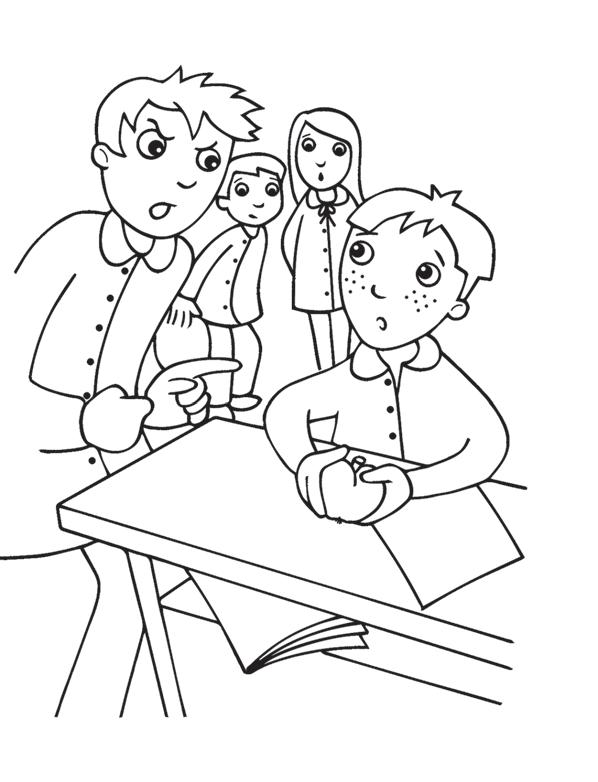
Rivolse lo sguardo su Barry. Si era fatto un po’ più vicino. La sua faccia rotonda da rosa era diventata rossa.
A Barry non piaceva essere contrastato. Si stava preparando a menare le mani. Teneva le ginocchia leggermente piegate e ondeggiava di qua e di là.
Altri bambini si radunavano in cerchio.
Arrivava gente da tutte le direzioni.
Peter sentiva il cuore battere forte dentro le orecchie. Cercando di prendere tempo, si passò la mela da una mano all’altra e disse:
– La vuoi davvero questa mela?
– Hai sentito benissimo – replicò Barry con voce piatta.
Peter osservò il bambino che si stava preparando a colpirlo e gli venne in mente la festa di compleanno di tre settimane prima, quando Barry era stato così affettuoso e cordiale.
E adesso, eccolo lì a fare tutte le smorfie possibili per sembrare cattivo.
Che cosa gli faceva credere che quando era a scuola aveva il diritto di fare e di prendersi tutto ciò che voleva?
Peter vide il cerchio di facce spaventate che gli si accalcavano intorno. Barry il terribile stava per mettere a terra un bambino e nessuno poteva farci granché. Che cosa rendeva tanto potente il roseo, il paffuto Barry? E all’improvviso, dal nulla, Peter trovò la risposta. Ma è ovvio, pensò. Siamo noi. Siamo noi che lo abbiamo sognato come il prepotente della scuola. Non è più forte di nessuno di noi. Tutta la sua forza e il potere ce li siamo sognati noi. Noi abbiamo fatto di lui quel che è. Quando va a casa e nessuno gli crede se fa il prepotente, allora torna se stesso.
I. McEwan, L’inventore di sogni, Einaudi
Cancella la scelta sbagliata e completa. Il contenuto del racconto è realistico/fantastico perché narra fatti
I protagonisti sono
Completa segnando con una X .
Il luogo:
è indicato in modo preciso. si può dedurre dal contesto. non si può dedurre dal contesto. Il tempo:
è indicato in modo preciso. si può dedurre dal contesto. non si può dedurre dal contesto.
Se tu dovessi indicare il tempo e il luogo, che cosa scriveresti?
Tempo: Luogo:
Completa segnando con una X
Il racconto è scritto dal punto di vista di: Barry. Peter.
Barry è: un bullo. un bambino pauroso. un bambino coraggioso. Peter è: un bullo. un bambino pauroso. un bambino riflessivo.
Cerca nel testo e scrivi: il nome dell’autore: il titolo del libro da cui è stato tratto il brano:
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
Può darsi che sia vero, può darsi che non lo sia, ma c’era una volta una donna vecchia vecchia.
Eppure era piena di vita e non si sognava affatto di morire.
Ma, un giorno, la Morte si ricordò della vecchia e venne a bussare alla porta di casa sua. La vecchia stava facendo il bucato e disse che proprio in quel momento non poteva andarsene via.
Doveva ancora sciacquare, strizzare, far asciugare e stirare la sua roba. A fare in fretta, pensava che sarebbe stata pronta la mattina dopo; quindi la Morte avrebbe fatto bene a ritornare da lei il giorno appresso.
– Aspettatemi, allora, domani alla stessa ora – fece la Morte e scrisse col gesso sulla porta: Domani.
Il giorno dopo la Morte tornò a prendere la vecchia.
– Ma, signora Morte, vi siete certamente sbagliata. Guardate sulla porta e vedrete quando è fissato che veniate a prendermi –osservò la vecchia.
La Morte guardò sulla porta e lesse: Domani.
– Vedete, dunque – aggiunse la vecchia, – venite domani e non oggi.
La Morte se ne andò e ritornò il giorno dopo.
E così la storia andò avanti per un mese intero.

Ma la Morte finì per stancarsi. L’ultimo giorno del mese disse: – Mi state ingannando, vecchia mia! Domani verrò da voi per l’ultima volta, ricordatevelo bene!
Cancellò dalla porta quel che lei stessa aveva scritto e se ne andò.
La vecchia, a questo punto, smise di sorridere.
Pensa e ripensa, voleva escogitare un’altra maniera per ingannare la Morte.
“Mi nasconderò nel bariletto del miele” diceva tra sé e sé la vecchia. “La Morte non mi troverà certo lì dentro!”.
E si nascose nel bariletto del miele, lasciando scoperto soltanto il naso. Ma subito pensò: “Per l’amor del cielo, la Morte è furba! Mi troverà anche nel bariletto del miele e mi porterà via!”.
Saltò fuori dal bariletto e andò a nascondersi in una cesta piena di piume d’oca.
Ma subito pensò: “Per l’amor del cielo, la Morte è furba! Mi troverà anche nella cesta!”. Mentre saltava fuori dalla cesta, la Morte entrò nella stanza.
Guardò intorno e non riuscì a vedere la vecchia da nessuna parte. Al suo posto vide una spaventosa, terribile figura, tutta coperta di piume bianche e con qualcosa di denso che le gocciolava di dosso.

Non poteva essere un uccello e neppure una persona: era, comunque, una cosa terribile a vedersi. La Morte ne rimase così spaventata che alzò i tacchi e fuggì, e non tornò più a cercare la vecchia.
G. Rodari, Favole per bambini che non hanno paura di streghe, orsi e lupi cattivi, Editori Internazionali Riuniti
Nel testo, segna con una rossa l’ introduzione , con una blu lo svolgimento , con una verde la conclusione .
Completa segnando con una X .
I fatti narrati: sono realmente accaduti. potrebbero accadere. sono frutto della fantasia dell’autore.
Completa.
Il contenuto del racconto è perché narra fatti Il personaggio fantastico è
Il personaggio verosimile è
Completa segnando con una X
Il luogo in cui è ambientato il racconto è: Il tempo è: assolutamente reale. certo. verosimile. indefinito. assolutamente fantastico.
Per ogni affermazione riferita al testo, completa la tabella segnando con una X quale è verosimile e quale è assolutamente fantastica.
Verosimile Assolutamente fantastica
La vecchia faceva il bucato.
La vecchia parla con la morte.
La morte è spaventata.
La vecchia era piena di vita.
Cerca nel testo e scrivi: il nome dell’autore: il titolo del libro da cui è stato tratto il brano:
Nome e cognome Data
Pioveva a dirotto. Goccioloni che cadevano al suolo.
Le gocce del temporale di quella sera colpivano il minuscolo corpicino di una capretta bianca.
La capretta, senza pensarci, si rifugiò in una capanna abbandonata sul pendio della collina.
Si mise a riposare nell’oscurità aspettando tranquillamente che il temporale finisse.
Ansimando e facendo “Ah, ah, ah” qualcuno entrò nella capanna.
Chissà chi era.
La capretta si nascose e drizzò le orecchie.
Tic, toc, tic, toc. Passi. Qualcosa di duro batteva sul pavimento. Era rumore di zoccoli.
Doveva essere sicuramente una capra.

La capretta, sollevata, si rivolse al nuovo arrivato: – Bel temporale, vero?
– Come? Chi ha parlato? Ah, ah. Con questo buio, ah, ah, non si vede un accidente.
La capretta, un po’ stupita, rispose bruscamente: – Sono appena arrivata anch’io, ma non è così terribile.
– Ma sì, è vero… per fortuna ho trovato questo rifugio dopo essermi trascinato sotto il temporale.
Tirò un sospiro di sollievo e appoggiò il bastone sul pavimento. Già: quell’ombra indistinta, con il bastone, non era una capra, ma un lupo. Per di più era un lupo con una bocca grossa così, che andava ghiotto di carne di capra.
– Che sollievo che ci sia anche tu!
La capra non aveva ancora capito che il suo compagno era un lupo.
– Anch’io, se fossi capitato in questa capanna da solo, in una notte di temporale, mi sarei sentito perduto.
Anche il lupo non aveva capito che il suo compagno era un capra.
– Eeetcciuuù! – starnutì il lupo.
– Tutto bene? Mmmm… devi esserti beccato un raffreddore!
– Penso anch’io. Non sento per niente gli odori.
Improvvisamente il boato di un tuono fece tremare la capanna. – Aiuto!
I due si strinsero.
– Ah, scusami, è che mi sono spaventato.
– Sì, non importa, anch’io ho avuto paura.
– Però ci somigliamo molto, vero?
– Abbiamo avuto la stessa reazione!
– La prossima volta, perché non ci troviamo a mangiare con il bel tempo?
– Va bene. Pensavo che sarebbe stata una pessima serata, per via di questo brutto temporale, ma siccome ho incontrato un buon amico, si è rivelata piacevole.
– Guarda, il temporale è passato, allora incontriamoci domani davanti a questa capanna, ti va bene?
– Ok. Ma se non ti riconosco dalla faccia?
– Già, per sicurezza diremo: “Sono chi ti è diventato amico in una notte di temporale”.
Nell’oscurità, prima dell’alba, le due ombre si salutarono agitando le mani.
Che cosa sarebbe successo il giorno dopo, ai piedi di quella collina?
Questo neanche il sole, che aveva appena mostrato la faccia per far brillare le gocce sulle foglie, poteva saperlo.
A tutti i lettori
In una notte di temporale, da soli, in un luogo sconosciuto, se incontrate qualcuno, che sollievo, non è vero? Ma se questo qualcuno fosse pericoloso, lettori miei, cosa fareste?
Y. Kimura, In una notte di temporale, Salani
Completa segnando con una X .
Ciò che rende il racconto fantastico è: la presenza di animali.
il comportamento degli animali.
I personaggi sono: realistici. fantastici.
Il luogo è: realistico. fantastico.
Il tempo è: realistico. fantastico.
Il racconto è: realistico. fantastico.
La struttura del racconto è: una fabula. un intreccio.
Nel testo, segna con una rossa l’introduzione, con una blu lo svolgimento, con una verde la conclusione, con una viola la riflessione dell’autore.
Cerca nel testo e scrivi: il nome dell’autore: il titolo del libro da cui è stato tratto il brano:
Conoscere le parole
L’onomatopea è un’espressione che riproduce il suono di una cosa o di un essere vivente. Accanto a ogni onomatopea scrivi chi la produce, nel testo, e il suo significato.
Tic, toc, tic, toc Ah, ah, ah
Eeetcciuuù Mmmm
Il racconto d’avventura
Domande stimolo per introdurre il genere con la classe
Che cos’è per voi un’avventura? Avete mai visto un film d’avventura? Chi era il/la protagonista? Che cosa accadeva? Che sensazioni vi ha trasmesso?
Quali tra questi “ingredienti”, secondo voi, sono indispensabili per scrivere un testo dove si parli di avventura: pericolo, colpo di scena, risata, principi e principesse, suspense?
Nei racconti d’avventura si narrano in modo realistico imprese che non fanno parte dell’esperienza quotidiana. Infatti, sono imprese straordinarie, imprevedibili, pericolose.
Nei racconti d’avventura emerge il desiderio dei protagonisti/delle protagoniste di esplorare terre lontane, di mettersi alla prova, di superare i propri limiti, addirittura andando verso l’ignoto.
Il/La protagonista in genere deve trovare un tesoro nascosto, salvare qualcuno in pericolo, dimostrare di essere innocente di fronte a false accuse.
Spesso lotta contro i malvagi per il trionfo della giustizia.
Sovente deve affrontare un viaggio per portare a termine la sua missione.
Durante questo viaggio incontrerà difficoltà, ostacoli, nemici di ogni genere che metteranno alla prova il suo coraggio, la sua ingegnosità, la sua astuzia, il suo amore per la giustizia.
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
IL NAUFRAGIO
Non facemmo in tempo a precipitarci fuori dalle cabine che la nave si incagliò in un banco di sabbia: le onde presero a infrangersi contro di essa con tale violenza che tememmo di morire da un momento all’altro.
È impossibile descrivere i pensieri e le sensazioni che provai mentre venivo risucchiato dal mare. Non riuscivo a sottrarmi al vortice dell’onda per riprendere fiato, finché essa mi trascinò verso riva, lasciandomi mezzo morto per l’acqua che avevo inghiottito.
Ebbi la presenza di spirito di rimettermi in piedi prima che un’altra onda mi risucchiasse. Presto mi resi conto che era impossibile evitarla: il mare saliva alto come una collina; non mi restava che trattenere il respiro e cercare di mantenere la testa fuori dall’acqua, nuotando verso la riva senza sprecare fiato.
Quando già stavo correndo per raggiungere la terraferma e mi credevo in salvo, il mare mi scaraventò contro una roccia con un tale impeto da lasciarmi privo di sensi.
Fortunatamente mi ripresi un attimo prima che l’onda ritornasse e mi travolgesse, e mi aggrappai con forza a uno spuntone di roccia.
Mantenni la presa finché l’onda rifluì, poi con una corsa raggiunsi la riva, mi arrampicai oltre le rocce e mi lasciai cadere sull’erba, finalmente salvo.
D. Defoe, Robinson Crusoe, Einaudi Ragazzi
Per evidenziare la struttura di questo racconto d’avventura, completa segnando con una X .
L’autore ha scritto questo racconto d’avventura con lo scopo di: divertire chi legge. appassionare chi legge.
Per creare la suspense, cioè tenere chi legge con il fiato sospeso, l’autore usa sequenze: descrittive. dialogiche.
Il protagonista supera la difficoltà grazie: al suo sangue freddo e alla fortuna. all’astuzia e alla prudenza.
Nel testo, segna con una colorata i tre colpi di scena che l’autore utilizza per creare la suspense.
Nel testo, sottolinea le parti in cui sono descritti gli stati d’animo del protagonista.
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
Per tutta la mattina Henry e Bill aiutarono i cani a trainare le slitte, che faticavano a scivolare sulla neve. Stremati, verso mezzogiorno decisero di fare una sosta per riposare e per far riprendere forze ai cani. Dopo aver bevuto un po’ d’acqua e mangiato qualche rimasuglio, si misero di nuovo in marcia.
– Henry, tu continua sul sentiero, io mi addentro nel bosco. Voglio vedere da vicino le bestiacce che ci danno la caccia.
– Sei sicuro?
– Sì, sono stufo di scappare. Voglio vedere quante sono e che aspetto hanno.
– Ma ci sono rimaste solo tre pallottole, non sarà pericoloso? – domandò Henry.
– Tranquilla, “mammina”, me la saprò cavare. Non ti preoccupare, ci tengo alla mia pellaccia… – rispose Bill strizzando l’occhio al compagno mentre prendeva la strada per il bosco. Era un intrico fitto di alberi. Nemmeno un raggio di sole riusciva a penetrare attraverso le folte chiome. Sembrava regnare l’oscurità. I rumori che si sentivano facevano immaginare la presenza di animali feroci.
Dopo qualche ora si ritrovarono sul sentiero e Henry tirò un sospiro di sollievo nel vedere l’amico sano e salvo.
– Non crederai mai a quello che sto per raccontarti! – disse agitato Bill, una volta raggiunto il compagno.
– Non tenermi sulle spine. Dimmi tutto. Che cosa è successo? Che cosa hai visto?
– Nel bosco, mi sono ritrovato su un sentiero coperto dagli alberi. Alla mia sinistra c’era una collinetta e a destra un dirupo. A un certo punto, con la coda dell’occhio, ho visto qualcosa che si muoveva. Mi sono voltato e a pochi metri da me c’erano loro… i lupi. Mi sono imposto di stare tranquillo anche se dentro di me non lo ero. Non avevo bisogno di ripetermi che un branco di lupi… è un branco di lupi. Quindi sapevo benissimo che potevo trovarmi a un passo dalla fine.
– E che cosa hai fatto? Sei scappato? – sbottò Henry con gli occhi fuori dalle orbite.
– No, ho dato ai cani l’ordine di fermarsi.
– Ma sei completamente impazzito?
– Volevo vedere chi ci dava la caccia – replicò Bill in tono deciso. – È un branco di lupi magrissimi. Si vede che non mangiano da mesi. Hanno il ventre schiacciato e le costole gli spuntano dalle pellicce. Per questo motivo continuano a seguirci. Siamo la loro unica speranza di sopravvivere.
Solo a sentire quelle parole a Henry si gelò il sangue nelle vene e un lungo brivido gli corse lungo la schiena.
G. Agnello, Zanna Bianca, La Spiga Edizioni
Completa segnando con una X .
Questo testo è un racconto d’avventura perché i fatti narrati riguardano: difficoltà e pericoli da superare con il coraggio. difficoltà e pericoli da superare con l’intervento di un aiutante magico.
Bill supera le difficoltà grazie: al suo sangue freddo. all’astuzia e alla prudenza.
Rispondi.
Chi è il più coraggioso tra i due personaggi?
Qual è l’ambiente in cui si svolge la vicenda?
Sottolinea nel testo: in verde le parti che descrivono l’ambiente tipico del racconto d’avventura. in rosso le parti che descrivono lo stato d’animo dei personaggi.
Tra le seguenti parti del racconto, segna con X le tre in cui si narrano momenti di suspense.
Voglio vedere da vicino le bestiacce che ci danno la caccia.
– E che cosa hai fatto? Sei scappato? – sbottò Henry con gli occhi fuori dalle orbite. – No, ho dato ai cani l’ordine di fermarsi. – Ma sei completamente impazzito?
Dopo qualche ora si ritrovarono sul sentiero e Henry tirò un sospiro di sollievo nel vedere l’amico sano e salvo.
Mi sono voltato e a pochi metri da me c’erano loro… i lupi.
Solo al sentire quelle parole ad Henry si gelò il sangue nelle vene e un lungo brivido gli corse lungo la schiena.
Nel testo, segna con una rossa l ’introduzione , con una blu lo svolgimento , con una verde la conclusione .
Rispondi.
Quali caratteristiche tipiche dei luoghi dei racconti d’avventura puoi trovare in questo brano?
Cerca nel testo e scrivi: il nome dell’autore: il titolo del libro da cui è stato tratto il brano:
Nome e cognome Data
Guglielmo Tell era un cacciatore che viveva tanto tempo fa nelle Alpi svizzere.
Purtroppo la Svizzera era governata dall’imperatore austriaco e i suoi soldati se ne andavano in giro a terrorizzare il popolo.
Guglielmo Tell era stato a caccia sulle montagne e, quando era tornato al villaggio, aveva sentito parlare di Gessler.
– Chi è questo Gessler? – chiese un giorno Guglielmo a un vicino.
– È il nuovo governatore appena arrivato dall’Austria – sussurrò il vicino. – È amico dell’imperatore ed è molto crudele.
Qualche giorno dopo decise di recarsi al villaggio per fare provviste. Guglielmo si mise la balestra a tracolla e, assieme a Walter, il figlio più piccolo, partì di buon’ora.
Padre e figlio raggiunsero la piazza del mercato. In mezzo allo spiazzo sorgeva un alto palo su cui era infilzato un grande cappello.
Guglielmo trovò strana la cosa, ma tirò dritto per la sua strada. Tutt’a un tratto i soldati si misero a urlare e gli corsero dietro.
– Non conosci la nuova legge? – ringhiò uno di loro. – Chiunque attraversi la piazza deve inchinarsi davanti al cappello del governatore. Facci vedere come ti inchini!
– No… non lo farò – disse Guglielmo tranquillo, con voce ferma.
– Benissimo – disse il soldato, – staremo a vedere cos’ha da dire il governatore su questa storia; ti sistemerà per le feste. Non fatevelo sfuggire, uomini!
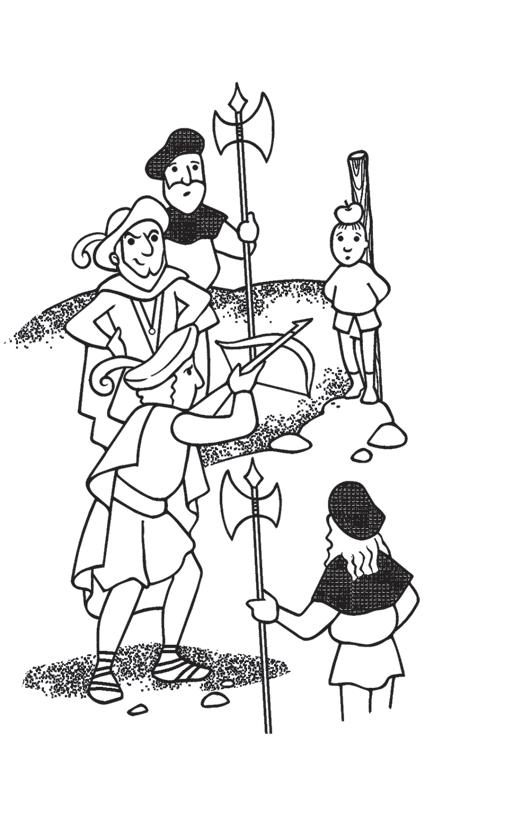
Dopo qualche istante il soldato ritornò, seguito da un altro uomo. Guglielmo capì all’istante che si trattava di Gessler.
– Come mai non vuoi inchinarti davanti al mio cappello? –chiese il governatore. – Arrestatelo!
Proprio in quell’istante Walter saltò fuori: – Mio padre è Guglielmo Tell, il miglior tiratore di balestra di tutta la Svizzera!
– Ma davvero? – ribatté Gessler. Lanciò a Guglielmo la mela che aveva in mano e disse: – Saresti capace di centrarla da cento passi di distanza? Se ci riuscirai, sarai libero.
– Sì, ne sono capace – rispose Guglielmo.
Allora Gessler, sorridendo, disse: – Mi è venuta un’idea: appoggiamo la mela sulla testa di tuo figlio.
Guglielmo allungò il braccio e si tirò Walter accanto: – No, è troppo piccolo – rispose. – Mi rifiuto di mettere mio figlio in pericolo.
– La tua scelta è semplice – ribatté Gessler. – Lancia quella freccia, oppure farò mettere a morte tuo figlio.
Guglielmo si chiese se aveva modo di svignarsela assieme a Walter, ma i soldati erano troppi. Si infuriò con se stesso per non essersi inchinato davanti al cappello, ma poi Walter cominciò a parlare: – Padre, puoi farcela. Ne sono sicuro.
Guglielmo fissò il figlio negli occhi, ci vide una fiducia infinita e capì che non poteva deluderlo. Due soldati condussero il bambino alla porta della taverna e Gessler appoggiò la mela sulla sua testa.
Guglielmo estrasse una freccia dalla faretra e la mise nella balestra.
La corda della balestra vibrò, risuonando con un’eco forte in quel silenzio di tomba.
La freccia si conficcò nella porta della taverna, mentre la mela esplodeva in uno zampillo di pezzi verdi e bianchi e Walter sollevava le braccia trionfante.
T. Bradman, Spade, maghi, supereroi, Einaudi Ragazzi
Nel testo, segna con una rossa l’introduzione, con una blu lo svolgimento, con una verde la conclusione.
Completa per analizzare le diverse parti del testo.
INTRODUZIONE
L’a utore presenta l’ a mbiente in cui si svolge la vicenda, il protagonista e il tempo .
L ’ambiente è
Il protagonista è Il tempo è
SVILUPPO
Nello sviluppo l’a utore narra l’i nizio della vicenda. Per creare suspense, cioè tenere chi legge con il fiato sospeso, vi è un colpo di scena .
I soldati austriaci
Interviene un altro colpo di scena
Gessler obbliga Guglielmo
Il protagonista reagisce con coraggio .
Guglielmo estrae
CONCLUSIONE
Il racconto ha un lieto fine
Rispondi.
Quale impresa pericolosa deve superare il protagonista?
Il protagonista per superare la difficoltà può contare solo su se stesso o riceve aiuto da qualcuno?
Il racconto fantasy
Domande stimolo per introdurre il genere con la classe
Quali parole vi fa venire in mente il termine “fantasy”?
Avete mai visto un film fantasy? Avete letto un libro fantasy?
Se avete letto un libro o visto un film di questo particolare genere, vi siete immedesimati con il/la protagonista oppure no? In che cosa vi somigliava? In che cosa era completamente diverso/a da voi?
Il fantasy è un genere letterario che ha cominciato ad avere successo nella seconda metà dell’800.
I libri fantasy possono essere divisi in questo modo: il fantasy per ragazzi/e. Racconta le avventure e le vicende di adolescenti che apprendono le arti magiche. Sono in genere ragazzi/e apparentemente normali, disposti/e a combattere contro le forze del Male. L’ambiente in cui agiscono, generalmente, non è quello in cui vivono di solito. Il più celebre ciclo di fantasy per ragazzi/e è quello di Harry Potter. Il fantasy contemporaneo. Agli ingredienti del fantasy classico aggiunge quelli del mondo informatico e della tecnologia. Il fantasy urbano. Le avventure dei protagonisti/delle protagoniste sono ambientate non in strani mondi lontani, ma in città che hanno aspetti molto simili a quelli delle città reali.
Il fantasy oggi appartiene anche al mondo dei videogiochi, dei fumetti e dei giochi di ruolo.
Nome e cognome
Leggi con attenzione.
La furia del Signore Oscuro esplose con la forza di una bom ba. Voldemort alzò la bacchetta e la puntò contro Molly Weasley.
– Protego – urlò Harry e il Sortilegio Scudo si allargò al centro della sala. Voldemort si guardò intorno cercandone l’origine e finalmente Harry si tolse il Mantello dell’invisibilità.
La folla ebbe paura e il silenzio cadde improvviso e tota le, quando Voldemort e Harry si guardarono e cominciarono a muoversi in cerchio uno di fronte all’altro.
Data

– Non voglio aiuto – disse Harry e nel silenzio assoluto la sua voce risuonò come uno squillo di tromba. – Deve andare così. Devo essere io.
Voldemort sibilò, ogni suo muscolo era teso e suoi occhi rossi erano immobili: un serpente pronto a colpire. – Pensi che sarai tu a sopravvivere, vero, il Ragazzo che è Sopravvissuto?
– Non ucciderai nessuno questa notte – ribatté Harry puntando la sua bacchetta magica. Ancora si muovevano in cerchio e si fissavano, occhi verdi dentro occhi rossi. – Non potrai uccidere nessuno di loro, mai più. Non capisci? Ero pronto a morire per impedirti di fare del male a queste persone…
– Ma non l’hai fatto!
– Era mia intenzione ed è questo che conta. Non hai notato che nessuno dei tuoi incantesimi funziona su di loro? Non puoi torturarli. Non puoi toccarli. Io so cose che tu non sai. Io so molte cose importanti che tu non sai.
Voldemort non parlò, ma continuò a muoversi in cerchio e Harry seppe di averlo ipnotizzato; per il momento pendeva dalle sue labbra, trattenuto dalla vaghissima possibilità che Harry conoscesse davvero un ultimo segreto.
J.K. Rowling, Harry Potter e i doni della morte, Salani
Rispondi.
Chi è il protagonista, colui che è l’unico in grado di compiere la difficile missione?
Chi è il personaggio che rappresenta il Male?
Quali sono gli oggetti magici di cui è dotato il protagonista?
Nel testo, sottolinea le parole che fanno capire a Voldemort che il Bene lo annienterà.
Nome e cognome
Leggi con attenzione.
LO SCHIANTESIMO
Hagrid guidò Madame Maxime oltre una macchia di alberi e si arrestò. Harry si affrettò ad affiancarli – per un istante credette di vedere dei falò e degli uomini che correvano tutto intorno – e poi rimase a bocca spalancata.
Draghi!
Data
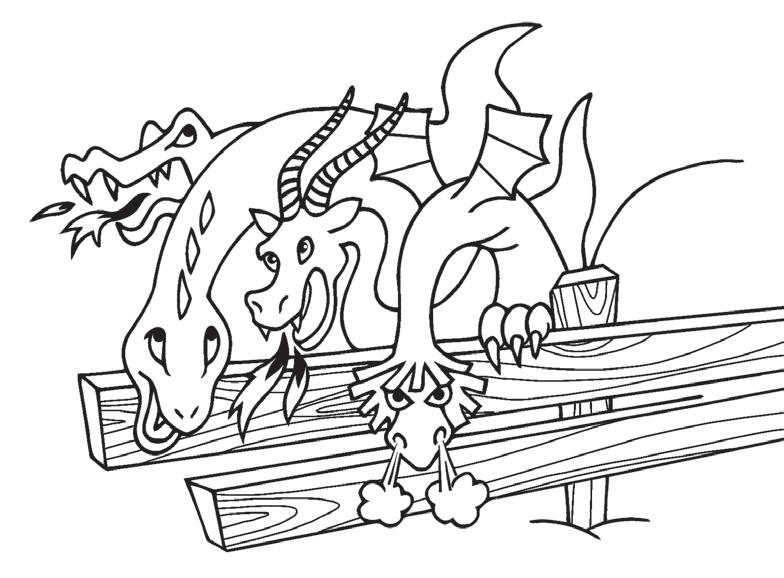
Quattro enormi draghi dall’aria malvagia si impennavano in uno spazio recintato da spesse assi di legno, ruggendo e sbuffando: torrenti di fuoco sprizzavano nel cielo buio dalle loro bocche spalancate e zannute, sorrette dai colli tesi a quindici metri di altezza. Ce n’era uno di un blu argenteo con lunghe corna appuntite, che ringhiava e tentava di mordere i maghi a terra; uno verde ricoperto di scaglie lisce, che si contorceva e pestava i piedi con tutte le sue forze; uno rosso con una strana frangia d’oro lucente attorno al muso, che sparava nuvole di fuoco a forma di fungo nell’aria; e uno nero, gigantesco, più simile degli altri a un lucertolone, il più vicino a loro.
Almeno trenta maghi, sette o otto per ciascun drago, cercavano di tenerli sotto controllo, tirando le catene agganciate a pesanti collari di cuoio fissati attorno al collo e alle zampe dei bestioni. Ipnotizzato, Harry guardò in su, molto in alto, e vide gli occhi del drago nero, dalle pupille verticali come quelle di un gatto, sporgere per la paura o la furia, non sapeva dire perché … emetteva un suono terribile, un urlo stridente, quasi un ululato …
– Stai indietro, Hagrid! – gridò un mago vicino alla staccionata, tirando la catena che aveva in mano. – Sputano fuoco nel raggio di sei metri, sai! Questo Spinato è arrivato anche a dodici, l’ho visto io!
– Non è bello? – disse Hagrid dolcemente.
– Non serve! – urlò un altro mago. – Schiantesimo, al mio tre!
Harry vide tutti i Guardadraghi estrarre le bacchette magiche.
– Stupeficium! – urlarono in coro e gli Schiantesimi sfrecciarono nell’oscurità come razzi infiammati, esplodendo in una pioggia di stelle sulla pelle squamosa dei draghi… Harry vide il drago più vicino barcollare pericolosamente sulle zampe dietro; la mascella si aprì in un gemito improvvisamente muto; le narici d’un tratto furono prive di fiamme, pur conti -
nuando a fumare; poi, molto lentamente, cadde: parecchie tonnellate di nerboruto drago nero squamato si schiantarono a terra con un tonfo che, Harry lo avrebbe giurato, fece tremare gli alberi dietro di lui.
J.K. Rowling, Harry Potter e il calice di fuoco, Salani
Completa segnando con una X
Il luogo è: reale. immaginario. verosimile.
I personaggi sono: reali e fantastici. solo fantastici. solo reali.
Il tempo è: storico. indeterminato. futuro.
I fatti narrati sono: fantastici. verosimili. reali.
Nel racconto agiscono diversi personaggi. Completa la tabella.
Il protagonista
Accompagnano il protagonista
Aiutano il protagonista
Minacciano il protagonista
In ogni frase, cancella l’espressione sbagliata.
In questo racconto:
è presente/non è presente un’introduzione in cui si presentano i personaggi, il luogo, l’ambiente;
è presente/non è presente una conclusione che porta a termine tutta la storia; è presente/non è presente una conclusione che porta a termine solo l’episodio raccontato.
Dal contesto:
si capisce/non si capisce che è un racconto fantasy; si capisce/non si capisce che l’episodio narrato è parte di un libro.
Nome e cognome
Data
Adesso i Nani dalla Barba Blu che accompagnavano l’hobbit Bilbo e per i quali doveva affrontare la difficile impresa di recuperare il tesoro, erano tutti in un bell’imbroglio. Tutti ben legati nei sacchi, con gli Uomini Neri (i tre troll Maso, Berto, Guglielmo) arrabbiati, seduti accanto a loro, che discutevano se dovessero arrostirli lentamente, o tritarli finemente e bollirli, o semplicemente sedersi su di loro e schiacciarli uno per uno, riducendoli in gelatina: e Bilbo su di un cespuglio, dove si era rifugiato dopo essere riuscito a sfuggire ai troll, con la pelle e gli abiti lacerati, aspettava il momento giusto per intervenire.
Fu proprio allora che il mago Gandalf ritornò. Ma nessuno lo vide. Gli Uomini Neri avevano deciso di arrostire subito i nani e di mangiarli più tardi. L’idea era di Berto ed era stata approvata dagli altri dopo un bel po’ di discussioni.
– È stupido arrostirli subito, andremo avanti tutta la notte – disse una voce. Berto pensò che fosse quella di Guglielmo.
– Non ricominciare tutta la discussione da capo, Guglielmo – disse, – o andrà davvero avanti tutta la notte.
– Ma chi discute? – disse Guglielmo, che pensava fosse stato Berto a parlare.
– Tu – disse Berto.
– Sei un bugiardo – disse Guglielmo; e così la discussione ricominciò da capo.
– Voglio sedermi su quello coi calzini grigi – disse una voce simile a quella di Guglielmo. – Adesso piantala! – dissero insieme Maso e Berto. – La notte sta finendo e l’alba arriva presto. Finiamola una buona volta e sbrighiamoci.
– L’alba vi prenda tutti e sia di pietra per voi! –disse una voce che sembrava quella di Guglielmo. Ma non lo era. Infatti proprio in quel momento la luce apparve sopra la collina e si sentì un forte cinguettio tra i rami. Guglielmo non parlò più perché rimase fermo, mutato in pietra mentre si chinava; Berto e Maso si immobilizzarono come rocce mentre lo guardavano. Infatti gli Uomini Neri debbono trovarsi sottoterra prima dell’alba o ritornano alla sostanza petrosa di cui sono fatti e non si muoveranno mai più. Questo è quanto era accaduto a Berto, Maso e Guglielmo.
– Ottimo – disse Gandalf, mentre avanzava da dietro un albero e aiutava Bilbo a scendere dal cespuglio spinoso. Allora Bilbo capì. Era stata la voce dello stregone che aveva indotto gli Uomini Neri a litigare finché non era arrivata la luce a porre fine a tutto.
J.R.R. Tolkien, Lo Hobbit, Adelphi
Nel testo, segna con una rossa l’ introduzione , con una blu lo svolgimento , con una verde la conclusione .
Sottolinea nell’introduzione la presentazione del protagonista e la situazione che deve affrontare per salvare i suoi amici dalle forze del Male.
Scrivi nei riquadri, al posto giusto, le caratteristiche della struttura del racconto fantasy.
Il Bene trionfa sul Male.
La magia agisce sui cattivi.
Interviene l’aiutante dotato di poteri magici.
Per evidenziare la struttura di questo racconto fantasy, completa segnando con una X.
Il racconto che hai letto è un fantasy perché narra un episodio: in cui personaggi fantastici compiono imprese eroiche. in cui personaggi fantastici lottano tra loro in una sfida tra Bene e Male.
I personaggi sono: fantastici. reali.
L’avventura ha un lieto fine grazie: alla forza e al coraggio del protagonista. all’intervento di un aiutante.
L’aiutante per permettere al protagonista di sopraffare le forze del Male: compie la magia di far bisticciare tra loro gli Uomini Neri in attesa che sopraggiunga la luce. gli fornisce poteri magici.
La struttura narrativa del racconto fantasy è simile a quella: della favola, perché ha la morale. della fiaba, perché intervengono un aiutante e un oggetto magico. del mito, perché spiega l’origine del mondo. della leggenda, perché spiega un cambiamento.
Completa.
Il protagonista è
I malvagi sono
I buoni sono
L’aiutante è
Il racconto biografico
Domande stimolo per introdurre il genere con la classe
Se pensate a un personaggio importante, quale nome vi viene in mente?
Secondo voi, è importante leggere le biografie dei personaggi dello spettacolo o dello sport?
Avete mai sentito una persona adulta o anziana raccontarvi episodi realmente accaduti nella sua vita?
Vi ha mai mostrato le foto che la rappresentano in diverse età, in diverse situazioni, con altre persone?
È necessario essere persone “importanti” per raccontare episodi della propria vita?
Il racconto biografico in genere narra la vita di una persona che è stata importante per la società: scienziati/e, persone di cultura, personaggi storici, uomini/donne di pace.
Accanto a queste figure carismatiche, vi sono anche biografie che narrano la vita di personaggi famosi nel mondo dello spettacolo e dello sport (attori/attrici, cantanti, sportivi/e…).
Nel racconto biografico i fatti raccontati sono reali e il luogo e i riferimenti temporali sono facilmente individuabili.
Il racconto biografico di un personaggio è raccontato da un narratore esterno. Esistono biografie che presentano il personaggio in modo rigoroso, raccontando solo i fatti avvenuti; ce ne sono altre, invece, in cui il narratore inserisce anche riflessioni e considerazioni personali.
Le fonti a cui ricorre l’autore/l’autrice di un racconto biografico possono essere memorie, racconti, lettere, scritti offerti direttamente dal/dalla protagonista oppure il frutto di una ricerca storica.
Il racconto autobiografico
INel racconto autobiografico, l’autore/l’autrice racconta episodi della propria vita. Gli elementi narrativi, cioè il racconto dei fatti, sono spesso accompagnati dalla descrizione dei luoghi, degli oggetti, delle persone con cui ha condiviso momenti importanti.
Un altro elemento significativo del racconto autobiografico è la riflessione che l’autore/ l’autrice fa su quanto gli/le è accaduto, riportando i pensieri e le sensazioni che ha vissuto in quel momento.
Il racconto autobiografico è importante per conoscere la personalità dell’autore/dell’autrice e anche per avere un quadro storico e sociale del tempo in cui è vissuto/a.
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
Walter Elias (Walt) Disney è nato a Chicago nel 1901.
Quando Walt ha 9 anni, suo padre si ammala gravemente, deve vendere la fattoria e, meno di un anno dopo, è costretto a trasferirsi di nuovo in città, a Kansas City. Qui distribuisce i giornali facendosi aiutare da due dei figli: Roy e Walt.
A 10 anni Walt inizia a frequentare la scuola media con la sorellina. È un pessimo alunno, ma passa tutto il tempo a disegnare.
A scuola scopre che ama mascherarsi, recitare dei ruoli, inscenare spettacoli.
A 16 anni Walt entra al liceo. In estate lavora con i fratelli, vendendo caramelle e bibite sui treni. In classe passa il tempo a disegnare. Sempre di più.

E poi scoppia la Prima Guerra Mondiale. Walt vuole arruolarsi, ma è troppo giovane. Mente sulla sua età falsificando i documenti e a 17 anni si unisce alla Croce Rossa.
A 18 anni Walt torna negli Stati Uniti. Ora ne è certo: vuole diventare un artista e cerca di trovare lavoro come disegnatore per i giornali.
Nel 1937 realizza il primo lungometraggio di animazione a colori: Biancaneve e i sette nani. Per la realizzazione del film 750 artisti disegnano un milione di schizzi di personaggi e ambienti, con costi faraonici. Alla fine questa scommessa azzardata si trasforma in una fiaba. Centinaia di milioni di spettatori fanno della piccola impresa artigianale Disney la prima industria cinematografica nel mondo.
Oggi questo impero propone le sue trasmissioni e i suoi parchi di divertimenti e vende le sue creature ai bambini di tutto il mondo sotto ogni forma immaginabile.
J.B. Pouy - S. Bloch - A. Blanchard, L’enciclopedia degli asini, Rizzoli
Completa segnando con una X .
Questo testo è: una biografia. una biografia romanzata.
Il biografo/La biografa è: chi scrive la biografia di una persona. chi scrive la propria biografia.
La biografia racconta le fasi più importanti della vita di Walt Disney.
Segna con colorate i momenti narrati: infanzia, studi, attività.
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
CAIO GIULIO CESARE
Caio Giulio Cesare era davvero un grande generale, uno dei più grandi che siano mai esistiti. Pensa che una volta partì per una guerra e dopo pochi giorni mandò a Roma una lettera, su cui stavano scritte solo tre parole in latino: “Veni, vidi, vici”, che in italiano significano: venni, vidi, vinsi. Era un uomo svelto lui!
Conquistò anche la Francia, che allora si chiamava Gallia, e la fece diventare una provincia romana. Non era cosa da poco, considerato che lì vivevano popolazioni straordinariamente coraggiose e bellicose che non si lasciavano intimidire tanto facilmente. Cesare combatté in quei luoghi per sette anni, tra il 58 e il 51 avanti Cristo, contro gli Svizzeri, che allora si chiamavano Elvezi, contro i Galli e contro i Germani.
Passò due volte il Reno nel territorio che oggi appartiene alla Germania, e due volte attraversò il mare sbarcando in Inghilterra, che i Romani chiamavano Britannia. E tutto questo lo fece per incutere alle popolazioni vicine una timorosa soggezione dei Romani. Nonostante i Galli cercassero disperatamente per anni di difendersi, lui continuò a combatterli, lasciando ogni volta dietro di sé le sue truppe a presidiare il territorio. Da allora la Gallia divenne provincia romana, e la popolazione si abituò in fretta a parlare latino, così come avvenne in Spagna.
Dopo la conquista della Gallia, Cesare tornò con il suo esercito in Italia, e a questo punto era l’uomo più potente del mondo.
Quanto agli altri generali con cui un tempo era stato alleato, li combatté e li sconfisse tutti.
E.H. Gombrich, Breve storia del mondo, Salani
Completa segnando con una X . Questo testo è: una biografia. una biografia romanzata.
Lo scopo di questo racconto biografico è: far conoscere la vita di Giulio Cesare. mettere in evidenza le doti di condottiero di Giulio Cesare. relazionare su tutte le imprese di Giulio Cesare.

Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
CARLO GOLDONI
Sono nato il 25 febbraio del 1707, in una bella casa di Calle Zentani nel quartiere di S. Tomà, Venezia.
La famiglia di mio padre, originaria di Modena, era piuttosto agiata ai tempi del nonno Carlo Alessandro, notaio.
Mio padre, Giulio, era un uomo di carattere amabile, ma irrequieto. Abbracciò tardi la professione di medico e, per permetterci di mantenere un certo tenore di vita, dovette svolgere il suo lavoro spesso lontano da casa. Mia madre, Margherita Salvioni, era una bella brunetta arguta, che zoppicava un tantino.
Mentre mia madre si incaricò di educarmi, a mio padre toccò il compito più allegro… quello di divertirmi!
Ero il quinto di sei fratelli. Quelli prima di me morirono tutti in tenera età.
L’ultimogenito, Giovanni Paolo, nacque il 10 gennaio del 1712. Non posso nascondere che i nostri rapporti furono spesso burrascosi.
Mi piaceva molto assistere agli spettacoli di marionette che mio padre allestiva in casa e a quattro anni cominciai a crearne anch’io. Sin da piccolo, insomma, ho avvertito dentro di me il “genio comico”; non so definire diversamente la mia passione precoce per il teatro. Un precettore mi seguì nei primi studi.
Leggevo tantissimo, soprattutto andavo pazzo per gli autori comici della biblioteca di papà. Fra gli otto e i nove anni, non ricordo bene, abbozzai la mia prima commedia. E, orgoglioso più che mai, ne inviai una copia a mio padre, che allora stava esercitando la sua professione di medico a Perugia.
R. Agostini - P. Rossi, Goldoni racconta, Nuove Edizioni Romane
Completa segnando con una X .
Questo è un testo autobiografico perché l’autore: narra un episodio della sua vita.
fa conoscere in breve la storia sua e della sua famiglia.
Segna con una : rossa i dati anagrafici; blu ciò che si riferisce alla famiglia di Goldoni; verde la descrizione del carattere; viola un episodio della sua vita.
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
Un giorno la mia maestra annunciò alla classe: – So che è l’ora di lettura, ma oggi credo proprio di non farcela. Ho la voce troppo stanca. E proprio oggi avremmo dovuto leggere “Alexandra Po temkin e il suo viaggio sullo Space Shuttle verso il pianeta Zeta”. È un vero peccato – aggiunse. – Forse potremmo avere un lettore ospite. Che ne dite?
Be’, era difficile immaginare qualcuno che non fosse la maestra a leggere, ma nessuno voleva saltare l’ora di lettura e allora tutti dissero di sì con entusiasmo.
– Ida, so che hai letto il libro – mi disse la maestra debolmente.
– Ti spiacerebbe leggere il primo capitolo, oggi?

Ero così imbarazzata che quasi non mi accorsi che gli altri bambini mi stavano guardando a bocca aperta. Raccontare una storia dove le parole diventassero musica come faceva la maestra era forse la cosa che più desideravo al mondo. Ma farlo davanti alla mia classe era praticamente l’ultima cosa che desideravo. Ero confusa e spaventata. La maestra si alzò, si avvicinò al mio banco e mi sussurrò: – Ida, ho bisogno del tuo aiuto.
Allora decisi che l’avrei fatto.
– So che leggerai benissimo – gracchiò lei. Avvicinò la sedia e si sedette accanto a me. La maestra mi aveva già dato da leggere diversi libri. “Alexandra Potemkin e il suo viaggio sullo Space Shuttle verso il pianeta Zeta” era il mio preferito, fino a quel momento. Mi sentii formicolare le dita al pensiero di leggere a voce alta, alzando e abbassando il tono, rendendolo via via duro e levigato a seconda delle situazioni, come facevo nella mia stanza.
Alla fine ce la feci: aprii il libro e mi preparai a leggere il titolo.
Mi mancava l’aria. Gli unici suoni che mi uscirono dalla gola furono dei piccoli trilli.
– Dovresti leggere a voce più forte, così sentiranno tutti – mi sussurrò la maestra. Allora feci un respiro profondo, mi riempii lo stomaco di aria e poi la buttai fuori con una contrazione dei muscoli in modo da dare forza alla voce.
– Capitolo uno – gridai. La voce mi era uscita così forte che mi sorprese e feci un piccolo salto indietro sulla sedia. Ma nessuno rise. Stavano ascoltando. All’inizio ero molto preoccupata, ma dopo qualche minuto entrai nella storia. Ero nel laboratorio di Alexandra, invece che a scuola, e spiegavo a voce alta ogni cosa che le vedevo fare o sentire. Arrivò la fine del capitolo e fu come se qualcuno mi avesse svegliato di soprassalto da un bel sogno e io non riuscissi bene a capire dove mi trovavo.
Mi guardai intorno e vidi che ero seduta dietro un banco e che davanti a me c’era un libro e dei bambini che mi guardavano.
La maestra sussurrò: – Grazie mille, Ida, è stato bellissimo. Le porsi il libro e tornammo alla nostra lezione. K. Hannigan, Ida B, Fabbri Editori
Completa segnando con delle X .
Questo testo è autobiografico perché: racconta l’esperienza di una persona. il narratore e il protagonista sono la stessa persona.
Il racconto autobiografico è un testo: regolativo. informativo. narrativo.
L’autore/L’autrice narra: in prima persona. in terza persona.
Nel racconto autobiografico l’autore/l’autrice: non esprime mai sentimenti ed emozioni. esprime anche i propri sentimenti e le proprie emozioni.
Il contenuto di questo testo è: un ricordo del passato dell’autrice. un’esperienza che lei sta vivendo. un progetto dell’autrice per il futuro.

Nella struttura di questo testo sono presenti seq uenze: narrative. descrittive. dialogiche. riflessive.
Segna V (vero) o F (falso).
Nel racconto autobiografico l’unico personaggio è l’autore/l’autrice. V F
I personaggi di un racconto autobiografico, i protagonisti, sono solo l’autore/l’autrice e i componenti della sua famiglia.
I personaggi di un racconto autobiografico possono essere l’autore/l’autrice e altre persone che hanno condiviso episodi della sua vita.
Nome e cognome Data
Marie Sklodowska nacque a Varsavia nel 1867, in una famiglia dove la cultura era di casa.
Fin dall’infanzia si interessò alla scienza.
Dimostrò subito le sue doti, ma non poté frequentare l’università, poiché a quei tempi era proibita alle donne. Si trasferì a Parigi: lì incontrò un giovane professore di chimica e fisica, Pierre Curie, che sposò. Da lui ebbe due figlie, Irène ed Ève.
Con Pierre si dedicò allo studio della radioattività e scoprì due nuovi elementi, il radio e il polonio. Così le fu conferito, all’età di trentasette anni, il premio Nobel per la fisica, che condivise con il marito e con Henri Becquerel.
Dopo la scomparsa di Pierre, morto in un tragico incidente stradale nel 1906, Marie divenne titolare della cattedra di fisica alla Sorbona, che già era stata del marito.
Proseguì le ricerche e nel 1910 pubblicò il Trattato sulla radioattività. Continuò con successo le ricerche, tanto che nel 1911 le fu conferito (e questa volta a lei sola) il premio Nobel per la chimica.
Morì nel 1934, a seguito delle radiazioni assorbite durante gli esperimenti scientifici sulle sostanze radioattive, dopo aver terminato un secondo Trattato sulla radioattività.

Marie fu la prima donna a insegnare all’università e il primo scienziato a ricevere due volte il Nobel. Sua figlia Irène, per le sue scoperte sulla radioattività, vinse il Nobel nel 1935.
Albert Einstein disse di lei: – Di tutti i personaggi famosi che conosco, Marie è l’unica che non si sia lasciata corrompere dalla notorietà.
C. Coppini, Vita avventurosa delle donne famose, Dami Editore

Completa segnando con una X .
Lo scopo di questo testo è: far conoscere un personaggio famoso e gli avvenimenti più impor tanti della sua vita. scrivere un racconto in cui il protagonista è un famoso personaggio.
Il contenuto di questo testo è: la narrazione di alcuni fatti importanti della vita di un personaggio famoso. un racconto realistico ambientato nell’epoca in cui è vissuto il personaggio famoso.
Nel testo, sottolinea: in rosso gli avvenimenti più importanti della vita di Marie Curie; in verde il commento su di lei riportato dall’autrice.
Rispondi.
Come viene definito chi scrive la vita di un personaggio famoso o di una persona?
Quale periodo della vita di Marie Curie non è raccontato, in questa biografia, in modo dettagliato?
In questa biografia vengono messe in risalto le scoperte scientifiche fatte da Marie Curie o gli avvenimenti salienti della sua vita?
Questa biografia contiene commenti personali dell’autrice?
Questa biografia è scritta in forma romanzata?

La lettera
Domande stimolo per introdurre il genere con la classe
Qual è la differenza tra il diario che usate a scuola e il diario scritto da un ragazzino o da una ragazzina?
Voi avete mai scritto un diario? Raccontereste i vostri segreti a un diario?
Nella cassetta della posta di casa vostra trovate frequentemente delle lettere?
Di che tipo di lettere si tratta?
Qualcuno ha mai spedito a voi una lettera per raccontarvi qualcosa?
Oggi qual è il tipo di posta che si usa di più per comunicare con parenti e amici/amiche?
Il diario è il testo più soggettivo che possa scrivere una persona. Chi scrive un diario lo fa per raccontare ciò che gli/le è accaduto. Nel diario riporta anche i suoi pensieri e le sue emozioni che non riguardano solo lui/lei stesso/a, ma anche amici/amiche, momenti vissuti, periodi della vita.
Ci sono anche altri tipi di diario:
l’agenda, in cui si segnano i propri impegni, note per ricordare qualcosa, nomi di persone da incontrare; il diario di viaggio, in cui chi scrive descrive ciò che ha visto e le emozioni che ha provato durante un viaggio; il diario di bordo, che è nato come quaderno che usavano gli esploratori e soprattutto i navigatori per annotare le varie fasi delle proprie imprese e in particolare ciò che accadeva a bordo della nave stessa; il diario di fantasia, che è frutto dell’invenzione dello scrittore/della scrittrice, che usa la struttura del diario per raccontare fatti accaduti a personaggi inventati.
Nella lettera, chi scrive ha come scopo quello di comunicare qualcosa a qualcuno che è fisicamente distante. Con il progredire della tecnologia le lettere oggi vengono inviate prevalentemente per mezzo di e-mail. Con la connessione Internet si possono recapitare i messaggi in qualunque parte del mondo, in ogni momento, e saranno ricevuti in tempo reale.
Nome e cognome
Data
Leggi con attenzione.
Venerdì 5 febbraio
Caro diario,
ieri il pomeriggio non finiva più. In piscina Paola ci ha fatto fare almeno dieci vasche senza quasi farci fermare. Poi, a lezione d’inglese dalla signora Judith, è successa una cosa che prima o poi lo sapevo sarebbe accaduta. Sono arrivata alle cinque, come ogni giovedì; la signora Judith mi ha fatto accomodare sul solito divano. Poi ha sparato tre, quattro delle solite domande e io, come faccio sempre, ho risposto due volte yes e due volte no. A quel punto la fortuna mi ha girato le spalle e la signora Judith deve aver realizzato in un colpo solo che io delle sue conversazioni non avevo mai capito un’acca.
Il sorriso le si è come congelato sulla faccia e le sono diventate pallide persino le lentiggini. Si è seduta, si è presa la testa tra le mani e ha mormorato: – Oh, my God! Io la guardavo quasi preoccupata e non sapevo che pesci pigliare: mi faceva pena. Dopo un paio di minuti molto imbarazzanti, la signora Judith mi ha detto: – Ma cara, potevi dirmelo prima che non capivi le mie parole.
Io sono quasi arrossita come quando penso a Roberto e ho provato a dirle che non ne avevo avuto il coraggio.
E così abbiamo iniziato con l’alfabeto e con i vocaboli più semplici. Mentre leggevo a voce alta apple, mela, car, automobile, dog, cane, pensavo che questo inglese sarà anche la lingua del futuro ma io, intanto, mi perdo il presente. Infatti non ho mai un pomeriggio intero tutto per me.
S. Bordiglioni - M. Badocco, Dal diario di una bambina troppo occupata, Einaudi Ragazzi
Completa segnando con una X .
In questa pagina di diario la bambina: racconta solo gli avvenimenti che le sono accaduti. racconta i fatti che le sono accaduti e li commenta.
In questa pagina di diario la bambina scrive: tutto ciò che ha fatto durante la giornata. i fatti che le hanno suscitato particolari emozioni.
Il diario è stato scritto: nel giorno stesso in cui sono avvenuti i fatti. il giorno seguente.
Nel testo, sottolinea le espressioni gergali.
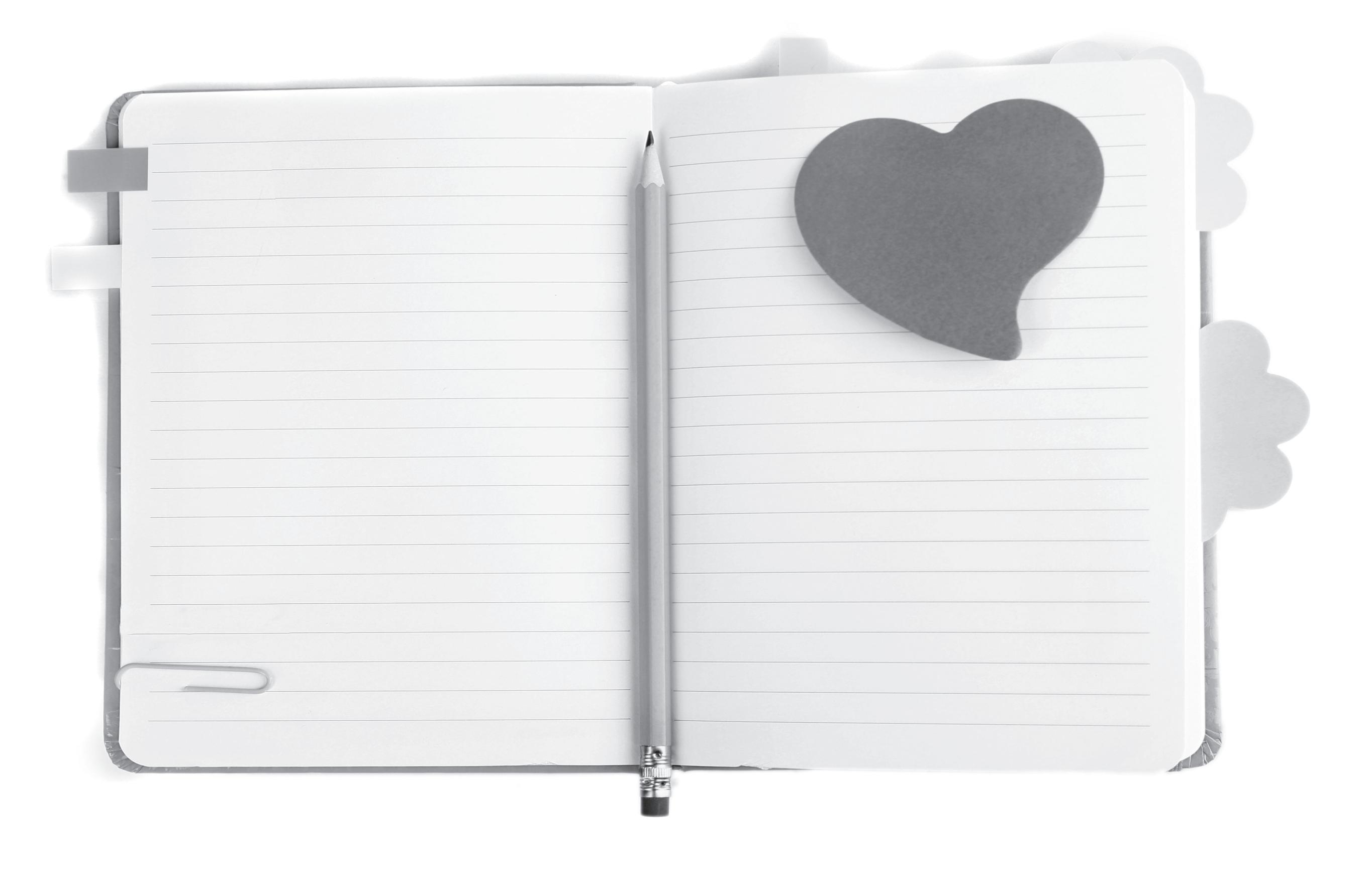
30 novembre
Caro diario, sono pentita di non averti scritto molto di Margot negli ultimi mesi. Dall’inizio della quarta è strana, nervosa, scorbutica ecc. Dirai tu: ma che cosa c’entra scrivere di lei col fatto che adesso sta male?
Stupisco, allibisco, e persino straluno (il verbo stralunare mi piace moltissimo. Io straluno, tu straluni… io stralunavo… io stralunai… tu straluneresti… se lui stralunasse, noi straluneremmo… Non piace anche a te?).
Io straluno: proprio tu, il mio diario intelligente e sensibile, fai questa domanda?
Non sai che scrivere di qualcuno o dei suoi problemi è come occuparsi di lui?
Voglio dire, se avessi parlato di Margot e dei suoi problemi, di come stava eccetera, sono sicura che avrei capito meglio quello che succedeva.
Capisco sempre meglio le cose, quando le scrivo.
Magari avrei trovato qualcosa da dirle, o qualcosa di buono da fare per lei, insomma: come aiutarla.
Ohi ohi ohi, vecchio mio, che discorso serio mi sta venendo!
Insomma, adesso sono così, un po’ triste e preoccupata. Non solo per Margot, veramente.
Te l’ho detto? Non te l’ho ancora detto?
Ora te lo dico.
Qualche volta, da qualche tempo, mi capita di sentirmi tristissima. All’improvviso, senza nessuna, ma proprio nessuna ragione.
Mi succede e basta.
E allora, adesso, uffa, smetto di scrivere.
Prometto che la prossima volta, amico mio, dolce e paziente, sarò più allegra.
R. Piumini, Molte lettere per Sei, Einaudi Ragazzi
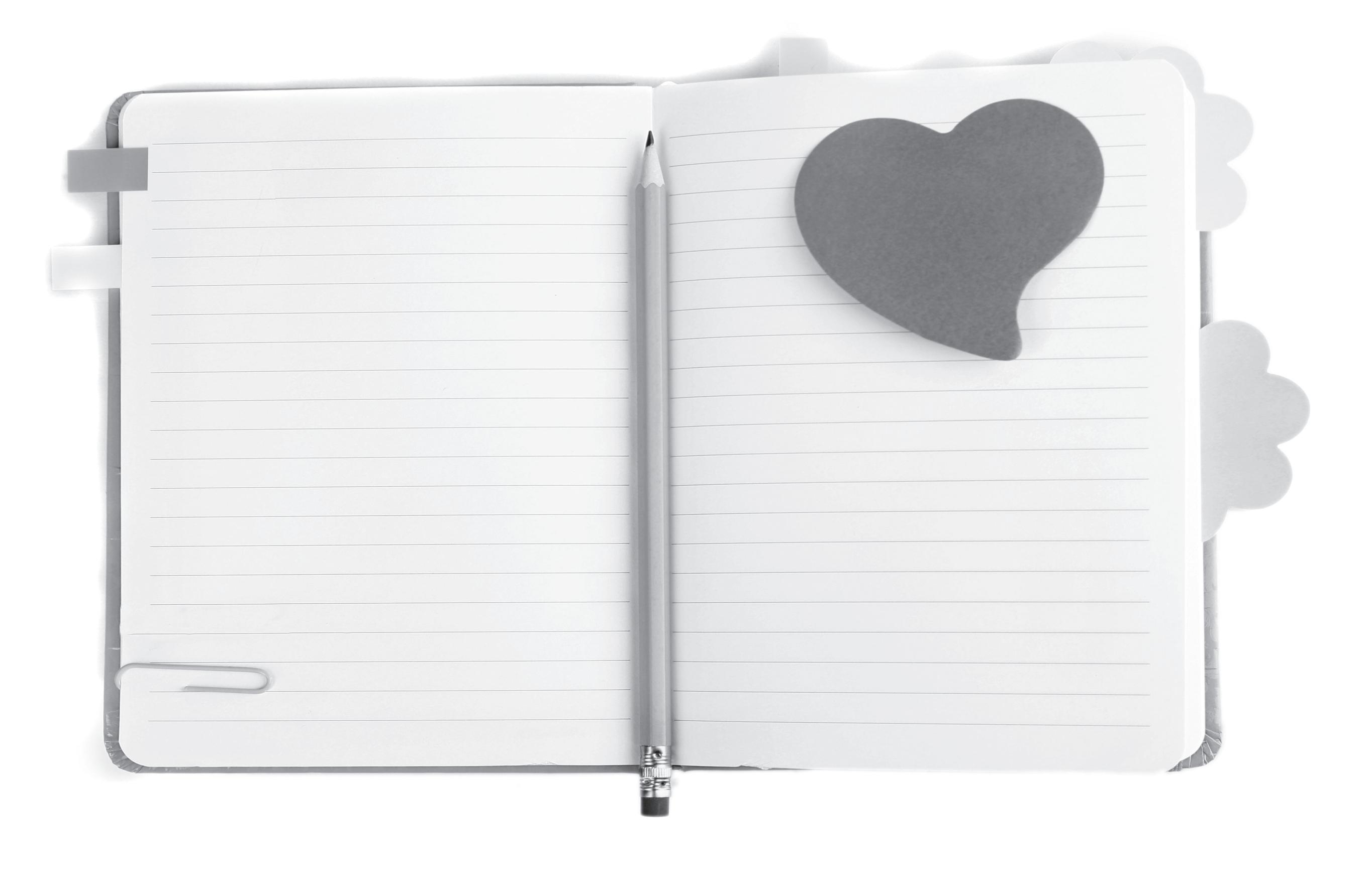
Completa segnando con una X .
In questa pagina di diario la bambina: racconta al diario alcuni avvenimenti che le sono accaduti. confessa i suoi stati d’animo e i suoi sentimenti.
Segna SÌ oppure NO.
Da questa pagina di diario puoi: ricostruire tutto ciò che la bambina ha fatto durante la giornata. SÌ NO dedurre che la bambina ha un’amica a cui tiene molto. SÌ NO
Quali elementi tipici del diario puoi rilevare da queste frasi?
Per ognuna scrivi se si tratta: del racconto di un episodio; dell’utilizzo di un linguaggio spontaneo; dell’utilizzo di un linguaggio colloquiale; dell’espressione di sentimenti; di riflessioni personali.
Stupisco, allibisco, e persino straluno:
Qualche volta, da qualche tempo, mi capita di sentirmi tristissima:
Te l’ho detto? Non te l’ho ancora detto? Ora te lo dico:
Margot… è strana, nervosa, scorbutica:
Capisco sempre meglio le cose, quando le scrivo:
Insomma, adesso sono così, un po’ triste e preoccupata:
Riporta le parti che, nel testo che hai letto, evidenziano la struttura del diario.
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
INVITO ALLA LETTURA
Gentilissimo professore, mi scusi tanto se la disturbo, ma ho un grande problema. A scuola me la cavo, però non mi piace leggere. Leggere mi dà tristezza, mi annoia, perché le pagine sono tutte uguali.
Invece mi piace guardare la televisione. Secondo me uno che guarda la televisione impara sempre e non si annoia mai.
Insomma, perché devo vergognarmi se dico che non mi piace leggere? Mi può rispondere? La saluto.
Annamaria De Bono
Cara Annamaria, non devi proprio vergognarti della franchezza con cui confessi la tua scarsa simpatia per la lettura.
Però sono convinto che leggere sia più importante che ascoltare o seguire le immagini.
E sai perché? Perché quando ascolti o guardi la televisione sei un soggetto passivo, mentre quando leggi sei un soggetto attivo.
Cosa significa? Significa che quando guardi un film assorbi una storia già completa di particolari, dalla faccia dei protagonisti alla loro voce, dall’orologio che hanno al polso all’ambiente in cui si muovono.
Se tu invece provassi a leggere una bella storia in un libro, senza accorgertene, cominceresti a lavorare con il cervello per dare un volto ai protagonisti, per dare un tono di voce alle frasi, per figurarti il viale alberato lungo il quale stanno camminando.
Ti accorgeresti allora che una storia di immagini è uguale per tutti, mentre una storia di pagine è diversa per ognuno.
L. Goldoni, Faccio un esempio, Bompiani
PRENDI IN ESAME LA PRIMA LETTERA
Nel testo, sottolinea: in rosso la formula di apertura; in verde la formula di chiusura.
Rispondi.
Chi scrive questa lettera?
Chi è il destinatario?
Rispondi segnando con delle X .
In questa lettera mancano alcuni elementi caratteristici della struttura di questa tipologia testuale. Quali?
La data.
La formula di apertura.
La località da cui viene spedita la lettera.
La formula di saluto.
La firma del mittente.
PRENDI IN ESAME LA SECONDA LETTERA
Rispondi.
Chi scrive questa lettera?
Chi è il destinatario?
Rispondi segnando con delle X
In questa lettera mancano alcuni elementi caratteristici della struttura di questa tipologia testuale. Quali?
La firma del mittente.
La formula di saluto.
La data.
La località da cui viene spedita la lettera.
La formula di apertura.
Confronta le due lettere e completa.
Il mittente della prima lettera è il della seconda.
Il della seconda lettera è il della prima.
Nome e cognome Data
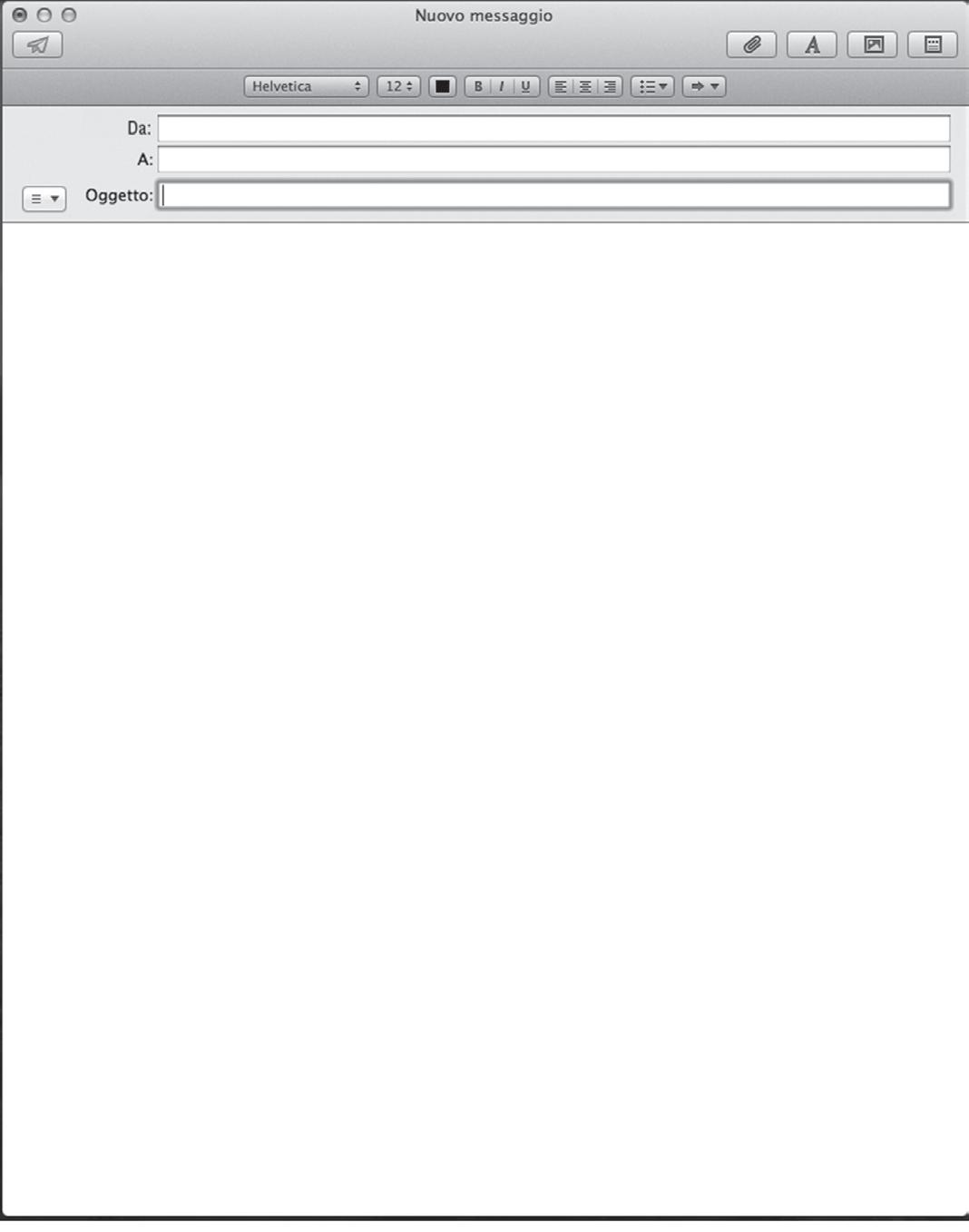
Carla Lombi carlom@merkurio.it
Daiana Tosetti daianatos@epis.it
Per un pelo ce l’ho fatta
Da: Carla Lombi carlom@merkurio.it
A: Daiana Tosetti daianatos@epis.it
Inviato lunedì 20 maggio
Cara Daiana, ho rischiato proprio di non venirci alla settimana verde in vacanza con te.
A raccontarla è una specie di telenovela… vediamo se ci riesco. La giornata è cominciata male fin dall’inizio perché sono arrivata a scuola in ritardo e la preside mi ha fatto la ramanzina nel corridoio. Va beh, pace. Poi mi ero dimenticata il quaderno di Inglese e Miss the Witch (la prof) mi ha messo la nota sul diario. Ha scritto: “Carla non ha svolto i compiti”. Falso, perché io i compiti li avevo fatti, a casa.
A cena pensavo: “Figurati se adesso mi lasciano andare”. Insomma ero in tensione e dovevo chiedere il permesso… così apro la mia boccaccia e parlo tutto d’un fiato, e mentre parlavo mi si ingarbugliavano i pensieri. Insomma ho detto qualcosa del tipo: – Dunque ecco la mia amica del mare Daiana che dopo sono anche andata a casa sua a Torino lei va alla settimana verde in Lombardia che i soldi ce li abbiamo già tutte e due e non c’è problema e la sua mamma è contenta che ci vado anch’io e io ci voglio andare mi lasci mamma ti prego che per me è la cosa più importante del mondo e giuro che non ti chiederò più niente per dieci anni…
I miei sono rimasti senza fiato, pensavano che mi fosse venuto un attacco epilettico o qualcosa del genere.
A quel punto ho pensato di essermi fregata con le mie mani. E dopo è successo un miracolo. Mia sorella Stefania è intervenuta in mia difesa dicendo che le persone diventano responsabili quando gli si comincia a dare le responsabilità, che quella della settimana verde poteva essere la mia prima occasione e che alla disperata la Lombardia comincia dall’altra parte del Ticino, per cui se ne combinavo qualcuna era un attimo venirmi a prendere con l’au to.
CE L’ABBIAMO FATTA!!!
Io la valigia comincio già da domani a prepararla, altroché.
Ciao
Tua super :-))) amica, felice come non mai.
P.S. Poi la nota me l’ha firmata il papà che si arrabbia di men o.
A. Lavatelli, Cara C@rla tua Daian@, Piemme Junior
Completa segnando con una X .
Il testo è: una lettera. una e-mail. una pagina di diario.
Rispondi segnando con delle X .
Il linguaggio utilizzato in questa e-mail è: formale. familiare.
In questo testo sono presenti alcuni elementi caratteristici della struttura di questa tipologia testuale. Quali?
Mittente.
Destinatario.
Formula di saluto.
Firma del mittente. Località. Data. P. S.
Scrivi:
l’indirizzo del destinatario.
la firma del mittente.
le parole con cui il mittente sintetizza il messaggio.
Scrivi l’autrice e il titolo del testo da cui il brano è tratto. Poi rispondi.
Da quale particolare capisci che il libro è una raccolta di e-mail?
Nel testo, circonda il gruppo di segni di punteggiatura utilizzati in modo particolare. Poi rispondi segnando con una X .
Qual è il loro significato?
Contentezza. Tristezza. Arrabbiatura. Delusione.
Per esprimere questi stati d’animo si usano anche gli emoji. Accanto a ogni stato d’animo nominato nell’esercizio precedente, disegna l’emoji che useresti tu.
Il testo descrittivo
Domande stimolo per introdurre la tipologia testuale con la classe
Se voi doveste far capire in modo preciso a un extraterrestre com’è il vostro cane, quale sarebbe il modo più efficace?
Ma se non poteste utilizzare l’immagine, che cosa sarebbe più utile fare?
Vi è mai capitato di leggere un libro o un brano e di avere davanti agli occhi il/la protagonista, l’ambiente, di avere la sensazione di essere proprio lì accanto a lui?
Secondo voi, a produrre questa sensazione sono state le avventure che questo/a protagonista ha vissuto o tutto quello che l’autore/l’autrice vi ha detto per fare in modo che voi poteste “vedere” quella situazione?
È difficile trovare un intero testo che sia totalmente e solamente ”descrittivo”.
Però è altrettanto difficile trovare un testo, di qualsiasi genere, che non utilizzi la descrizione per stimolare la fantasia visiva di chi legge.
All’interno di tutti i testi ci sono, infatti, parti descrittive, più o meno estese e più o meno particolareggiate.
La descrizione è molto importante perché permette all’autore/all’autrice di esprimere anche le proprie impressioni.
Imparare a descrivere vuol dire imparare ad arricchire il proprio lessico, non fermandosi solo all’utilizzo del pensiero e della fantasia, ma coinvolgendo anche le informazioni che i cinque sensi danno e quindi acquisire uno strumento di esplorazione delle realtà più vasto.
Nome e cognome
Leggi con attenzione.
Il popolo Hobbit è discreto e modesto, amante della pace, della calma e della terra ben coltivata. Essi non capiscono e non amano macchinari più complessi del soffietto del fabbro, del mulino ad acqua o del telaio a mano, quantunque abilissimi nel maneggiare attrezzi di ogni tipo. Hanno una vista e un udito particolarmente acuti e, benché tendano ad essere grassocci e piuttosto pigri, sono agili e svelti nei movimenti. Sin da principio possedevano l’arte di sparire veloci e silenziosi al so praggiungere di genti che non desideravano incontrare. Essi sono mi nuscoli: la loro statura è variabile e oscilla da un braccio a un braccio e mezzo.
Gli Hobbit sono un popolo allegro e spensierato; portano vestiti di colori vivaci, preferendo il giallo e il verde, ma calzano raramente scarpe, essendo i loro piedi ricoperti di un pelo riccio, folto e castano come i loro capelli, e le piante dure e callose come suole. I loro visi sono gioviali, illuminati da occhi vivacissimi e guance colorite, con una bocca fatta per ridere, bere e mangiare. Ed è proprio ciò che fanno: mangiano, bevono e ridono con tutto il cuore, amano fare a tutte le ore scherzi. Pranzano sei volte al giorno, quando ne hanno la possibilità. Sono ospitali: feste e regali, che offrono con grande generosità e accettano con entusiasmo, costituiscono il loro massimo divertimento.
J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli, RCS libri

Sottolinea: in rosso le parti che descrivono il carattere degli Hobbit; in blu le parti che descrivono l’aspetto fisico degli Hobbit; in arancione le parti che descrivono l’abbigliamento degli Hobbit; in verde le parti che descrivono le abitudini degli Hobbit.
Copia solo le parti che descrivono l’aspetto fisico degli Hobbit.
Nome e cognome
Data
Leggi con attenzione.
Lulu era un’antilope piccola come una gatta. Aveva occhi viola, sereni, zampe così fragili che, nel piegarsi e nel distendersi, pareva si dovessero spezzare.
Le orecchie, lisce come la seta, erano straordinariamente espressive, il naso nero era come un tartufo.
Gli zoccoli minuscoli le davano l’aria di una damigella cinese vecchio stile, con i piedi stretti nei lacci.
Tenere in braccio una cosa così perfetta era un’esperienza rara.
K. Blixen, La mia Africa, Feltrinelli

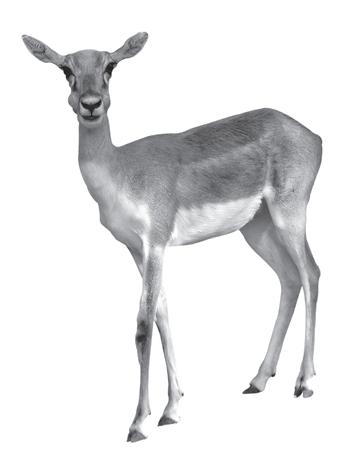
La gazzella è un mammifero ruminante, appartenente alla famiglia dei bovidi, diffusa nelle savane erbose del continente africano. È alta circa settanta centimetri, ha il pelo corto e fulvo, con il ventre bianco e una fascia bruna a ogni lato del capo.
Snella e veloce nella corsa, ha corna affilate, zampe sottili e grandi occhi.
Le gazzelle si addomesticano abbastanza facilmente.
Enciclopedia, Utet
Colora in rosso il quadratino della descrizione oggettiva, in blu quello della descrizione soggettiva.
Scrivi quali sono le similitudini che, nel primo testo, vengono utilizzate dall’autrice.
Prova a disegnare su un foglio i due animali, seguendo le indicazioni delle descrizioni.
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
Entrare nell’orto. Camminando piano piano, trattenendo il respiro.
Per ascoltare la voce dell’orto: il lieve fruscio del vento tra le foglie, il cinguettio degli uccelli che si chiamano da un albero all’altro, il mormorio lontano dell’acqua.
Per guardare la fisionomia dell’orto: le aiuole punteggiate di erbe, di cespugli, di fiori, di morbido prato, il recinto che lo chiude.
Per sentire le fragranze dell’orto: l’odore della terra umida, l’olezzo dolce dell’erba, dei fiori, l’afrore del frutto marcio che in terra si fa terra.
Camminando piano piano con gli occhi al cielo per guardare la trama del cielo tra le foglie degli alberi, le nuvole che passano e che ombreggiano ora la foglia, ora il fiore; con gli occhi al suolo per guardare bolli di luce e ombre nette sul prato, sulla terra.

Nome e cognome Data
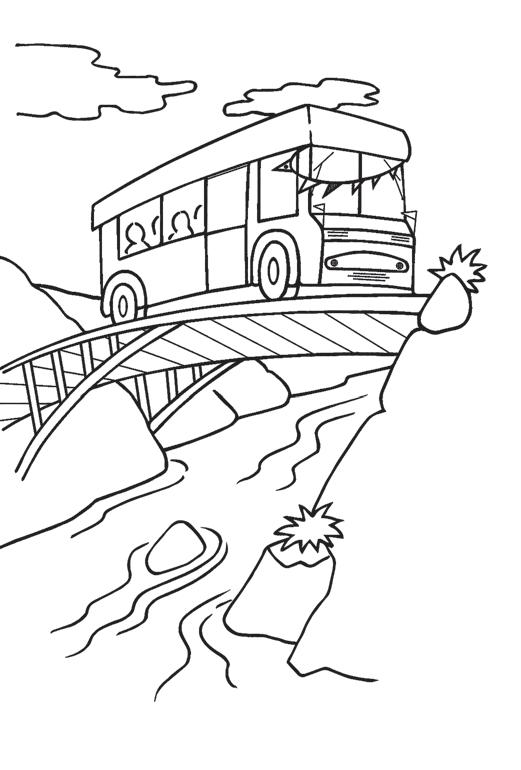
Bahìa Blanca è l’ultimo posto importante prima del deserto della Patagonia. Bill mi lasciò all’albergo prima della stazione degli autobus. La sala del bar era verde, illuminata e gremita di uomini che giocavano a carte. Si sentivano il chiacchiericcio dei giocatori e talvolta le grida di gioia di chi vinceva. Un giovane contadino stava in piedi, al banco: malfermo sulle gambe, ma a testa alta.
La moglie del proprietario mi mostrò una stanza a due letti, calda, senz’aria, con le pareti rosso porpora. La stanza non aveva finestre e la porta dava su un cortile coperto da un lucernaio, il prezzo era basso.
Il giorno dopo, mentre l’autobus attraversava il deserto, guardavo assonnato i brandelli di nuvole d’argento che si spostavano in cielo e la polvere bianca che il vento sollevava dalle saline e, all’orizzonte, la terra e il cielo che si fondevano, mescolando e annullando i loro colori.
La Patagonia inizia sul Rio Negro.
A mezzogiorno l’autobus attraversò un ponte di ferro sul fiume e si fermò davanti a un bar. Una donna india scese col figlio. Con la sua roba aveva occupato due posti. Masticava aglio spandendone intorno l’odore intenso e portava dei tintinnanti orecchini di oro vero e un cappello bianco e rigido, appuntato con spilloni alle trecce.
Le case del villaggio erano di mattoni, con tubi di stufa neri e, sopra, un intrico di fili elettrici. Dove finivano le case di mattoni, cominciavano le catapecchie degli indios, fatte con casse da imballaggio, fogli di plastica e teli di sacco. Un uomo risaliva la strada, con un cappello di feltro marrone tirato giù sulla faccia. Portava un sacco di tela e camminava in mezzo a nuvole di polvere bianca, diretto verso la campagna.
Lungo la riva del fiume i salici erano tutti germogliati e mostravano l’argento che brilla sotto le loro foglie. Gli indios avevano tagliato delle sottili bacchette lasciando sui tronchi delle bianche ferite e nell’aria l’odore della linfa. Il fiume, gonfio per lo scioglimento delle nevi sulle Ande, scorreva veloce, facendo frusciare le canne. Rondini rossastre davano la caccia agli insetti. Quando volavano sopra la scogliera, il vento le afferrava e ne invertiva di colpo il volo, finché calavano di nuovo basse sul fiume.

La scogliera si elevava a picco sull’approdo di un traghetto; mi arrampicai su per un sentiero e dall’alto guardai controcorrente verso il Cile. Vedevo il fiume scorrere lucente fra le scogliere bianche come ossa, con strisce di terra coltivata da ogni lato.
Lontano dalle scogliere c’era il deserto. Nessun suono tranne quello del vento, che sibilava tra i cespugli spinosi e l’erba morta, nessun altro segno di vita all’infuori di un falco e di uno scarafaggio immobile su una pietra bianca.
B. Chatwin, In Patagonia, Adelphi
Sottolinea in verde le descrizioni degli ambienti e in rosso quelle delle persone.
Completa segnando V (vero) oppure F (falso).
In questo brano ci sono:
dati uditivi. V F
dati gustativi. V F
dati visivi. V F
dati olfattivi. V F
dati tattili. V F
Nella seguente frase sottolinea: in rosso i dati uditivi; in verde i dati visivi; in blu i dati olfattivi.
Masticava aglio spandendone intorno l’odore intenso e portava dei tintinnanti orecchini di oro vero e un cappello bianco e rigido, appuntato con spilloni alle trecce.
Completa segnando con una X .
Questo testo esprime un punto di vista: oggettivo. soggettivo.
L’autore descrive: l’ambiente in generale. i vari elementi che compongono l’ambiente.
Inserisci il termine adatto scegliendo tra metafora e similitudine . Scogliere bianche come ossa è una
L’argento che brilla sotto le foglie è una
Il testo poetico
Domande stimolo per introdurre la tipologia testuale con la classe
Vi piacciono le poesie? Perché?
Secondo voi, le poesie hanno qualcosa di simile alla musica?
Leggere poesie vi rende tristi o allegri/e?
Avete mai scritto una poesia?
Gli esseri umani hanno iniziato a scrivere poesie nella notte dei tempi e continuano a farlo ancora oggi in un mondo ricco di tecnologia e multimedialità.
Questo significa che la poesia è un bisogno profondo perché permette di mettere in forma scritta i sentimenti e, comunicandoli, suscitarne anche in chi legge.
Con l’utilizzo di figure retoriche, la poesia suscita immediatamente immagini evocative. Anche le poesie più semplici, come le filastrocche, hanno questa capacità e per questo sono molto amate dai bambini e dalle bambine. Infatti, oltre alla musicalità tipica di tutti i testi poetici, esse, in poche parole, riescono a rappresentare immagini, pensieri e sentimenti facilmente comprensibili.
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
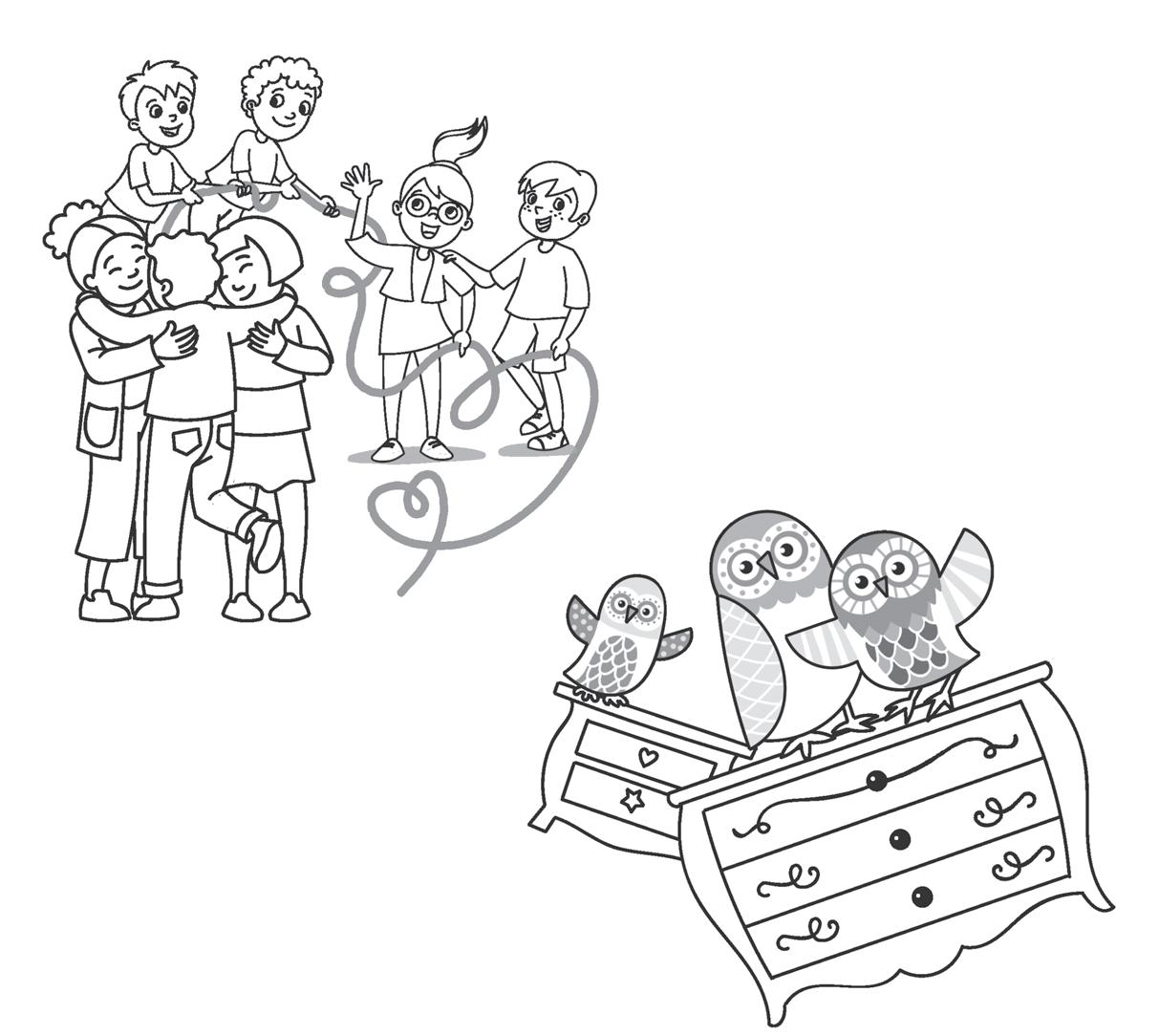
Coi miei migliori amici mi posso anche arrabbiare, tenergli a lungo il muso, farmi desiderare.
Sul filo dell’amicizia si formano dei nodi: ma noi sappiamo scioglierli, troviamo sempre i modi.
A. Sarfatti, Se vuoi la pace, Giunti Junior
Mentre dormite ci sono tre civette
Che se ne stanno nelle vostre camerette
Appollaiate sui comò e sui comodini
Per osservare il vostro sonno da bambini
Sanno quando state fermi e vi girate
Come parlate, sognate, respirate
Fanno la guardia sentinella al vostro sonno
E tutto ciò che fate voi, loro lo sanno!
B. Tognolini, Ufficio Poetico Tuttestorie, Gallucci
Rispondi.
In quale poesia il contenuto è l’espressione e la riflessione su un sentimento?
In quale poesia il contenuto è la rappresentazione di una situazione?
Quale dei due testi poetici è una filastrocca?
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
Siamo diversi siamo bambini usiamo una lingua senza confini.
Io ti parlo tu non ti confondi perché se sorrido tu mi rispondi.
Non ti conosco ma ti faccio un dono non ti comprendo ma ti perdono.
Se ho paura ti prendo la mano non importa se non ci capiamo.
Abbiamo parole di suono e di luce che nessuno di noi traduce.
Se le frasi ci pesano un poco avranno ali nel nostro gioco.
Ascolto il vento.
Mi sussurra: sono forte come un masso che rotola dalla montagna.
Mi sussurra: ti spingo indietro come un palloncino alto e libero nel cielo.
Mi sussurra: volo alto e potente come un’aquila in cielo.
M. Lodi, La natura nelle poesie di adulti e bambini, Piccoli
R. Lipparini, C’è un posto accanto a me, Mondadori

Completa segnando con una X .
La poesia è un testo scritto in: versi. paragrafi.
Segna V (vero) o F (falso).
Un testo poetico è sempre scritto in versi. V F
Un testo poetico può anche non essere scritto in versi. V F
Un testo poetico può essere diviso in strofe. V F
Un testo poetico deve sempre essere scritto in rima. V F
Un testo poetico può essere scritto in rima. V F
Tutti i versi del testo poetico devono avere la stessa rima. V F
Analizza le due poesie rispondendo alle domande.
Quanti sono i versi?
La poesia è divisa in strofe?
Se è divisa in strofe, quante sono?
I versi sono in rima?
Se i versi sono in rima, qual è lo schema della rima?

Senza confini Il vento
Nome e cognome Data
Scrivi di che tipo di testo poetico si tratta.
MARCETTA
Notte sull’aia, il cane abbaia la luna è sola, non c’è parola bella così.
Ed il pompiere con la sirena trova nel mare, sapete chi? Il palombaro solo che cena.
A. Gatto

Completa il limerick e il nonsense.
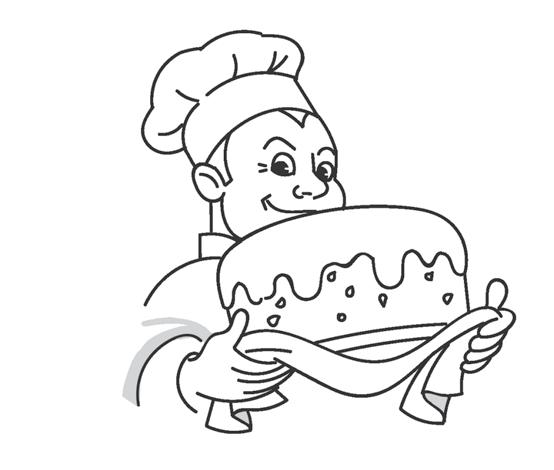
Ora scrivi tu una poesia che abbia come argomento l’amicizia.
Un abile pasticciere di nome Gaetano andava a comprare i canditi a , così invece di tondi ciambelloni faceva morbidi quel furbo
G. Rodari
Il falco di Aosta vola vola senza
Il falco di Trento vola anche contro
Il fringuello di Bratislava dopo un giorno che

Nome e cognome Data
Le cime degli alberi
s’inchinano, i pioppi sussurrano, i prati fremono, i ruscelli rabbrividiscono.
Da lontano
l’eco di una campana argentina.
È la brezza
Che soffia questa mattina.
C. Broutin, Filastrocche del tempo che fa, Motta Junior


Il cielo è azzurro come l’oceano, è rosso come la lava del vulcano.
Il cielo è grigio come un uomo triste che va velocissimo e piange.
Il cielo all’alba è come un incendio oppure come la nascita di un bambino. Il cielo è nero come un uomo cattivo pieno di rabbia, però in certi momenti della sua vita si illumina come un cielo stellato di sera.
C. Broutin, Filastrocche del tempo che fa, Motta Junior
Analizza le due poesie rispondendo alle domande.
La brezza Il cielo è…
La poesia è divisa in strofe?
I versi sono in rima?
La poesia contiene personificazioni?
La poesia contiene similitudini?
La poesia è un limerick?
È una filastrocca?
È un nonsense? la poesia
Il testo informativoespositivo
Domande stimolo per introdurre la tipologia testuale con la classe
Che cosa vuol dire “informare”?
Che cosa vuol dire “esporre”?
Potete esporre un argomento se non avete informazioni su di esso?
Se pensate ai libri che utilizzate, quale testo è “il più espositivo”?
Il testo informativo-espositivo presenta un argomento con lo scopo di dare informazioni e trasmettere conoscenze a chi legge.
I testi informativi-espositivi sono forse quelli che incontriamo più frequentemente: pensiamo ai libri di testo, ai giornali, alle riviste, ai cartelloni pubblicitari, alle guide museali…
I testi informativi-espositivi usano linguaggi molto vari: accompagnano la parte scritta con foto, diagrammi, titoli, disegni, tutti funzionali a una migliore spiegazione dell’argomento. Oggi i testi informativi-espositivi sono sempre di più “misti” perché mescolano ai segni della lingua, cioè le parole, segni di tipo diverso, cioè gesto, immagine, suono, spie luminose…
Domande stimolo per introdurre la tipologia testuale con la classe
Vi è mai capitato di fare un gioco e leggere le regole?
Se voi doveste far capire in modo preciso a un vostro amico/a uno sport, è importante conoscerne le regole?
Secondo voi, è utile avere regole anche a scuola?
Il testo regolativo
Il testo regolativo è un testo che presenta regolamenti e norme di comportamento, istruzioni per costruire o montare oggetti, svolgere giochi, preparare ricette, fare esperimenti scientifici…, consigli e suggerimenti.
I testi regolativi utilizzano un linguaggio chiaro, con frasi brevi e usano un lessico specifico e i verbi utilizzati sono all’indicativo presente, all’infinito o all’imperativo.
I testi regolativi sono spesso accompagnati da disegni o fotografie che mostrano il materiale necessario e il procedimento da seguire.
Gli autori o le autrici dei testi regolativi sono autorità pubbliche, sportive o scolastiche, se si tratta di regolamenti e norme, mentre sono esperti ed esperte dell’argomento di cui si parla, se si tratta di istruzioni.
Nome e cognome
Data
Leggi con attenzione.
I giochi sacri, cioè le gare sportive organizzate in onore degli dèi, avevano una straordinaria importanza presso i Greci.
Questi giochi si svolgevano in varie città, ma i più importanti erano quelli di Olimpia.
Le Olimpiadi, così chiamate dal nome della città, si disputavano ogni quattro anni; in questo periodo si sospendevano tutte le ostilità.
Il vincitore di ciascuna gara era premiato con una corona di olivo, acquistava gloria e prestigio. E i cittadini della sua polis gli offrivano gratuitamente il cibo.
Durante le prime Olimpiadi la gara era una sola, la corsa; poi, a mano a mano, si aggiunsero la lotta, il pugilato, la corsa con i carri trainati da cavalli e il pentatlon, una disciplina composta da cinque specialità sportive: il lancio del disco, il lancio del giavellotto, la corsa, il salto in lungo e la lotta.
Le donne non potevano né partecipare né assistere alle gare, ma alle ragazze erano riservati giochi dedicati a Era, la moglie di Zeus.
La prima Olimpiade si svolse nel 776 a.C. e l’ultima Olimpiade dell’antica Grecia nel 393 d.C.: nell’antichità si tennero in tutto 292 edizioni dei giochi olimpici.
Gli antichi Greci cominciarono a contare gli anni del loro calendario dalla data della prima Olimpiade.
Alle Olimpiadi partecipavano anche gli atleti delle colonie della Magna Grecia.
Completa per riferire brevemente le principali informazioni.
I Greci davano grande importanza
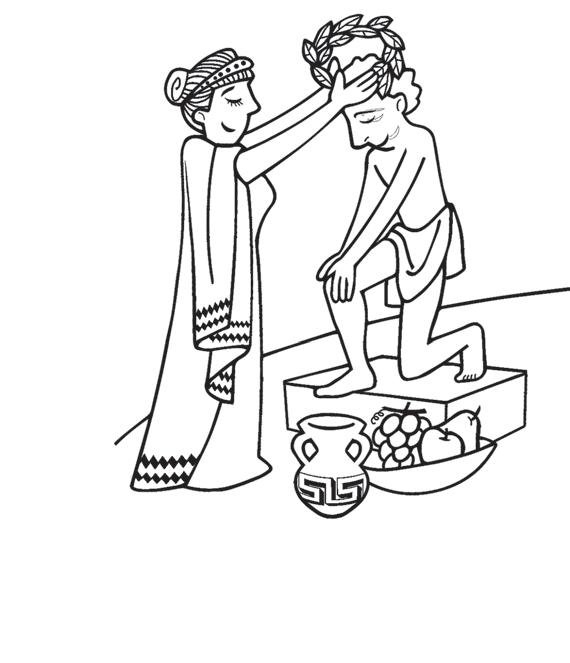
I più importanti giochi sacri erano ai quali partecipavano anche
Durante il periodo in cui
Il premio per Le gare disputate erano
Alle donne erano riservati
Le Olimpiadi iniziarono e terminarono
Dalla prima Olimpiade i Greci
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
L 'ALIMENTAZIONE OGGI
Costi per la terra
Oggi il cibo che acquistiamo è per lo più prodotto, lavorato, impacchettato e conservato in parti diverse del mondo. Il prezzo che l’ambiente paga per queste scelte è assai alto. Per lavorare e trasportare il cibo si consuma molta energia, aumentando l’inquinamento e l’accumulo di rifiuti. Ambienti fragili inoltre sono stati distrutti da piccoli agricoltori che cercavano di guadagnarsi da vivere producendo alimenti da esportare.
Costi invisibili
Il panino con hamburger è diventato uno dei cibi più diffusi: ogni giorno se ne consumano milioni in tutto il mondo. Per prepararne uno occorrono più di 20 ingredienti prodotti in vari Paesi. Il cibo è economico per i consumatori che dovrebbero, però, anche riflettere su come viene preparato.
Distruzione dell’ambiente

La maggior parte del manzo per gli hamburger americani proviene dal Brasile. Per far spazio alle mandrie sono state abbattute vaste aree di foresta pluviale. L’erba sottile cresce per qualche anno, poi la terra viene abbandonata, perché incolta e sterile.
Immagazzinamento e trasporto
I supermercati consumano molta elettricità perché conservano i prodotti in frigoriferi e surgelatori. Una grande quantità di carburante viene bruciata inoltre da navi, aerei e camion che trasportano i prodotti. L’inquinamento prodotto dai gas di scarico dei mezzi di trasporto è una delle principali cause del cambiamento del clima mondiale.
Lavorazione del cibo
Prima di raggiungere i supermercati, molti prodotti freschi vengono lavorati e inscatolati. La preparazione di piatti pronti e di alimenti che si conservano a lungo permette a molta gente di lavorare, ma rende il cibo assai più costoso.
Montagne di rifiuti
Ogni settimana si buttano via tonnellate di scarti di cibo e di rifiuti casalinghi. La spazzatura in molti casi viene accumulata, compressa e sotterrata in discariche. Questo sistema non è ideale perché i rifiuti possono disperdere gas maleodoranti e sostanze chimiche inquinanti per l’acqua delle falde.

Riciclare i rifiuti
I rifiuti in genere vengono sotterrati, ma si possono riciclare.
In molte città sono attivi servizi di riciclaggio dei rifiuti prodotti dai cittadini. Se si riciclano i materiali, si possono tagliare meno alberi e estrarre meno minerali dalla terra, dunque si danneggia meno l’ambiente.
M. Bramwell, Emergenza cibo, Mondadori
Segna con una X quale frase evidenzieresti in ogni paragrafo per indicare l’informazione principale.
Primo paragrafo
Si consuma molta energia.

Il cibo è prodotto in parti diverse del mondo.
Secondo paragrafo
Occorrono più di venti ingredienti.
Riflettere su come viene preparato il cibo.
Terzo paragrafo
Sono state abbattute vaste aree di foresta.
La terra viene abbandonata.
Quarto paragrafo
I supermercati conservano i prodotti in frigoriferi e surgelatori.
L’inquinamento è prodotto anche dai gas di scarico dei mezzi di trasporto.
Quinto paragrafo
I prodotti freschi vengono inscatolati.
La preparazione di piatti pronti rende il cibo assai più costoso.
Sesto paragrafo
Si buttano via tonnellate di scarti di cibo.
Questo sistema non è ideale.
Settimo paragrafo
I rifiuti vengono sotterrati.
Se si riciclano i materiali si danneggia meno l’ambiente.
Nome e cognome Data
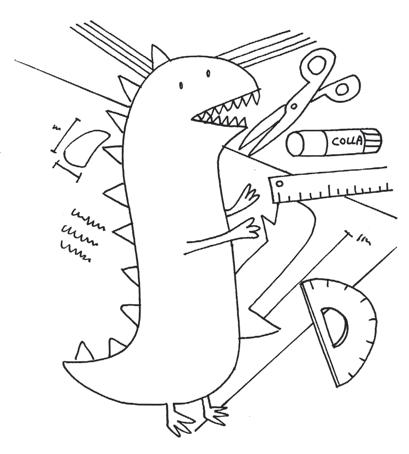
Inventare e ricercare
Per inventare un giocattolo, la fantasia e l’esperienza non bastano: si devono anche studiare i gusti del pubblico e i temi che vanno di moda. – Tutto comincia con una riunione dove proponiamo idee su temi che secondo le ricerche di mercato, le analisi e la nostra esperienza piacciono ai ragazzi, per esempio i dinosauri – spiega Giuliano Meneghini, alla guida del gruppo di inventori dei giochi scientifici di una grande azienda.
Così si realizza un prototipo, cioè il primo esemplare del gioco che si vuole produrre: all’inizio viene disegnato su carta da un designer e poi costruito in cartone, cartapesta o resina. Una volta che il prototipo è completato, lo si presenta all’ufficio tecnico, che ordina la realizzazione degli stampi per creare tutti i pezzi. Quando tutti gli elementi sono pronti, può iniziare la produzione del giocattolo in serie.
Sicurezza e torture
Quando si studia un prototipo, bisogna pensare anche alla sicurezza dei bambini: bordi non taglienti, punte arrotondate, niente pezzi minuscoli. Tutti i giocattoli devono rispondere alle norme di sicurezza stabilite dalla Comunità Europea. Prima di arrivare in negozio, quindi, i giochi devono passare sotto le “grinfie” degli Enti di certificazione che, attraverso macchinari specifici, li “torturano” per controllarne le caratteristiche fisiche e meccaniche, tipo resistenza agli urti, infiammabilità e robustezza. Bambole e peluche, per esempio, vengono messi a contatto con una piccola fiamma per 3 secondi, in modo da misurare la velocità con cui prendono fuoco. Inoltre, vengono lanciati ad alta velocità, tirati e torti: in particolare gli occhi e i nasi devono resistere a uno strappo fortissimo praticato da una tenaglia, che simula il morso di un bambino. Per assicurarsi, invece, che gli elementi piccoli non siano pericolosi, non potendo rivolgersi a bambini reali, si utilizzano strumenti che simulano le parti del corpo di un piccolo giocatore.

Quello che riproduce il naso verifica che non ci siano pezzi talmente piccoli da poter essere aspirati; un altro, a forma di cilindro e grande quanto la gola di un bambino sotto i tre anni, controlla che non siano ingeribili; quello che simula il dito accerta che le parti da non toccare, come le viti, non siano raggiungibili.
Una volta superati tutti i test, i giocattoli possono essere venduti con il marchio della Comunità Europea (CE), che ne attesta l’affidabilità.
I. Infante, Focus Junior n. 101
Per ogni frase, scrivi se si tratta dell’ informazione principale o di una informazione secondaria . Il modo in cui si progettano i giocattoli. Studiare i gusti del pubblico.
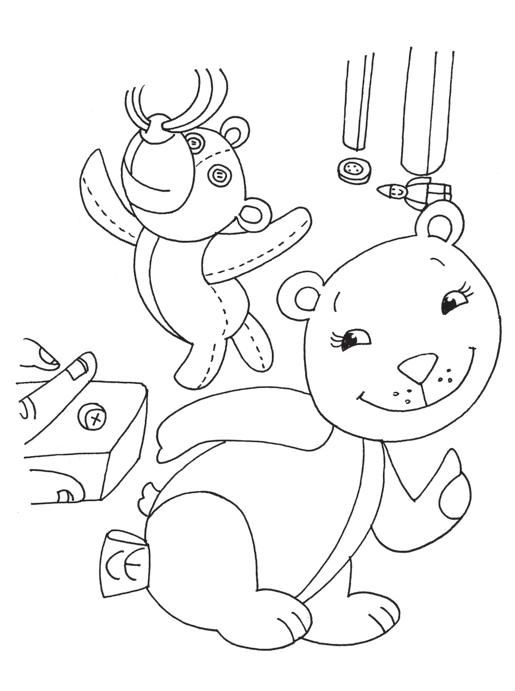
Il tema della sicurezza nei giocattoli. Il modo in cui si verifica la sicurezza dei giocattoli.
Scrivi alcuni termini specifici di quest’argomento contenuti nel testo. Se di alcuni di essi non conosci il significato, cercalo sul vocabolario o su Internet.
Rispondi. Qual è l’ordine in cui l’argomento è trattato nel testo?
Nome e cognome Data
Leggi con attenzione.
Questo è un gioco da fare all’aperto. È molto divertente ed è un gioco cinese! Prima di tutto si sorteggia il bambino/la bambina che sarà il folletto; gli altri/le altre si dividono in due squadre e si dispongono in due righe, una di fronte all’altra. In mezzo resta uno spazio largo che rappresenta il fiume.
Il folletto sta nel mezzo; fa un cenno a un/una bambino/a di una squadra e questo/a fa un cenno a un giocatore/una giocatrice del gruppo avversario.
Il/Le due bambini/e devono cercare di scambiarsi i posti correndo veloci attraverso il fiume. Il folletto cercherà di prenderli e di farli prigionieri. Si continua così con tutti i bambini e le bambine delle due squadre finché il folletto li ha presi prigionieri tutti. L’ultimo/a rimasto/a diventerà folletto.
Lauretta Dalla Rosa - Liliana Roggia, Orizzonti della scuola primaria, Ardea Editrice
Dopo aver letto con attenzione, riscrivi le regole del gioco con l’aiuto delle immagini.
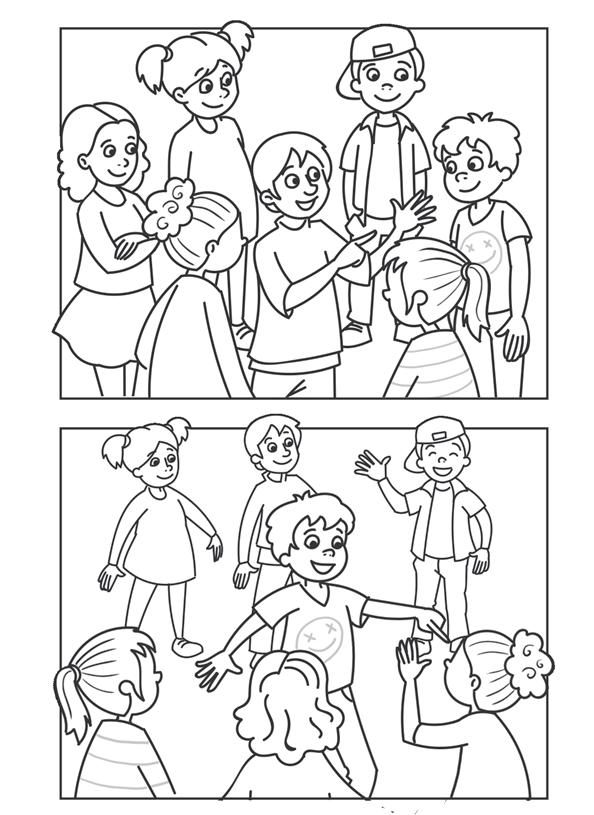
Si sorteggia
Gli altri bambini/Le altre bambine
In mezzo

Completa con una X
Questo testo: insegna le regole di un gioco. spiega come trascorrere l’intervallo.
Riscrivi in breve il testo e numera le fasi di gioco.
Si sorteggia
Gli altri bambini/Le altre bambine
Poi i bambini/le bambine si
In mezzo
Nome e cognome
Data
È un gioco per ragazzi e ragazze dai 10 ai 15 anni. I giocatori devono essere almeno sei. Il gioco è molto semplice: occorrono sei sedie, sei fazzoletti di cotone, una benda scura e un orologio con il cronometro.
Bisogna avere uno spazio abbastanza grande in una stanza e mettere le sedie senza un ordine preciso. Tra una sedia e l’altra bisogna riuscire però a muoversi facilmente. Sopra ogni sedia si deve mettere un fazzoletto. Poi si mette la benda scura sugli occhi di un giocatore. La persona che gioca non deve vedere e ha due minuti di tempo per raccogliere tutti i fazzoletti che sono sulle sedie.
Non deve inoltre mettere le mani su una sedia da dove abbia già preso il fazzoletto e che quindi è vuota. Se mette le mani per caso su una sedia vuota, deve lasciare lì uno dei fazzoletti che ha già raccolto e allontanarsi.
Il capogioco, cioè chi guida il gioco, deve dare il via e lo stop al giocatore e deve contare i fazzoletti raccolti nei due minuti.
Si gioca uno alla volta. Gli altri, mentre uno gioca, devono controllare che le regole vengano rispettate. Alla fine di ogni prova bisogna mettere le sedie in un nuovo ordine, per non facilitare e aiutare quelli che giocano dopo.
Vince chi riesce a raccogliere il maggior numero di fazzoletti.
Il gioco ha regole semplici, ma è abbastanza difficile e mette alla prova il senso di orientamento di chi gioca, la sua capacità di capire dove si trova nello spazio. da Giochi in casa e all’aperto, De Vecchi
Completa con una X .
Questo testo: regolativo. descrittivo. informativo.
Leggi le seguenti affermazioni e indica con una X se sono vere (V) o false (F).
V F
Questo gioco si chiama sedie e bende.
I giocatori devono essere almeno sei.
Bisogna mettere le sedie in fila, una vicina all’altra.
Sopra ogni sedia c’è un fazzoletto.
Ogni giocatore deve raccogliere i fazzoletti in due minuti.
Chi trova meno fazzoletti vince.
Il capogioco dà il via e lo stop e conta i fazzoletti.
Completa e rispondi alle domande.
Questo è un gioco per ragazzi e ragazze di età
Per giocare servono
Dove si può giocare?
Ti piace questo gioco?
Perché?
Completa la tabella inserendo le informazioni necessarie per eseguire un gioco che vuoi spiegare ai tuoi amici e alle tue amiche.
Nome del gioco
Età adatta al gioco
Numero di giocatori
Che cosa occorre per giocare
Come si gioca
Regole del gioco
Chi vince
TESTUALI
Nome e cognome Data
Completa la mappa.
TESTI NARRATIVI
Il TESTO NARRATIVO racconta una storia per appassionare chi legge. Il testo narrativo può essere o
Nel RACCONTO l’autore/l’autrice narra imprese straordinarie affrontate da personaggi coraggiosi.
Nel RACCONTO l’autore/l’autrice narra vicende fantastiche in cui si scontrano il Bene e il Male.
Nel RACCONTO l’autore/l’autrice narra episodi della sua vita.
Nella chi scrive comunica con una persona lontana.
Nel l’autore/l’autrice scrive per se stesso/a, periodicamente, ciò che gli/le succede e le sue emozioni.
TESTI NON NARRATIVI
Nel TESTO l’autore/l’autrice rappresenta con parole le immagini di persone, animali, oggetti e ambienti.
Nel TESTO l’autore/l’autrice fornisce informazioni su un argomento specifico.
Nel TESTO l’autore/l’autrice presenta regolamenti, norme di comportamento, istruzioni o ricette.
Nel TESTO l’autore/l’autrice usa le parole per comunicare emozioni e sensazioni, o divertire.
Funzione didattica
In questa sezione sono inserite parti significative di alcuni libri di narrativa per ragazzi e ragazze.
Nel Libro di Lettura si trovano solo brevi brani tratti da altri libri.
I brani inseriti sono significativi, interessanti e piacevoli per gli alunni e le alunne sia dal punto di vista del linguaggio sia dal punto di vista del contenuto trattato ma, inevitabilmente, sono brevi.
In questo modo i ragazzi e le ragazze non hanno modo di essere affascinati da una narrazione che ha ritmi e contenuti più ampi ed esaurienti.
La scelta di offrire brani più lunghi con argomenti interessanti e relativi alle tipologie testuali trattate durante l’anno scolastico è stata fatta per suscitare negli allievi e nelle allieve il desiderio di “vedere come va a finire”.
Suggerimenti
L’insegnante potrà utilizzare questi estratti nel modo che riterrà più opportuno: lettura collettiva in classe; lettura individuale a casa; lettura critica in cui i ragazzi e le ragazze, “verbalmente”, durante una discussione collettiva o a piccoli gruppi, esprimeranno le emozioni che ha loro suscitato la lettura di questi brani. Si può anche cominciare a chiedere loro un giudizio sullo stile adottato da chi scrive.
Si sconsiglia di utilizzare questi testi per esercizi di comprensione, riassunto, produzione. Sarà molto utile, invece, l’utilizzo finalizzato al piacere della lettura , al piacere della conoscenza e all’acquisizione della consapevolezza che la lettura favorisce lo sviluppo della fantasia e l’apertura verso il mondo.
Questo può essere un punto di partenza per far nascere il desiderio della lettura del “libro intero”. Sarebbe bene abituare i ragazzi e le ragazze a leggere il nome dell’autore/dell’autrice ed eventualmente ricercare notizie su di lui/lei e sulle sue opere.
Testi
I testi sono tratti dai seguenti volumi, editi da La Spiga Edizioni:
Annalisa Casali, Re Artù, il cuore e la spada
Gianluca Agnello, I viaggi di Ulisse
Mauro Martini Raccasi, TomTom e i predoni vichinghi
Re Artù non aveva più una spada perché aveva rotto la sua durante un combattimento.
Merlino e Artù arrivarono sulle rive di un lago lungo e stretto, chiuso tra due alte montagne. L’acqua del lago era così scura che non rifletteva neppure la vegetazione intorno. Il lago era tranquillo ma, a intervalli, un leggero soffio di vento increspava la superficie dell’acqua. Il cielo era nuvoloso e, solo ogni tanto, il sole faceva capolino da dietro le nuvole. Al centro del lago si vedeva un oggetto che brillava quando era colpito dal sole.
– Che cosa c’è laggiù? – chiese Artù.
– Guarda bene.
Il giovane scese da cavallo e si avvicinò alla riva. Fissando quella cosa misteriosa riuscì a distinguere un braccio che usciva dall’acqua. Era un braccio di donna ricoperto da una manica di seta bianca e teneva alta nella mano una spada: era quella che scintillava ogni tanto alla luce del sole.
– Ma è incredibile! Un braccio senza testa e un corpo nel centro del lago!
– Le meraviglie non sono finite – disse Merlino. – Guarda! Lontano, proveniente dall’altra sponda, si avvicinava una fanciulla che camminava direttamente sulla superficie dell’acqua. Era vestita con una tunica azzurra, fermata alla vita da una cintura ricoperta di pietre preziose che brillavano alla luce come la spada. Camminava leggera e sicura verso di loro.
– Questo è un prodigio! Chi è quella ragazza? – chiese Artù. – È la Dama del Lago, ma ci sono anche molti altri prodigi e misteri qui. Sotto una grande roccia, nel profondo del lago, esiste un castello meraviglioso con così tante ricchezze che neppure puoi immaginare. È lì che la dama abita. Ora sta venendo da noi. Se glielo chiederai con gentilezza, forse ti regalerà la spada.
La fanciulla arrivò proprio davanti a loro e,
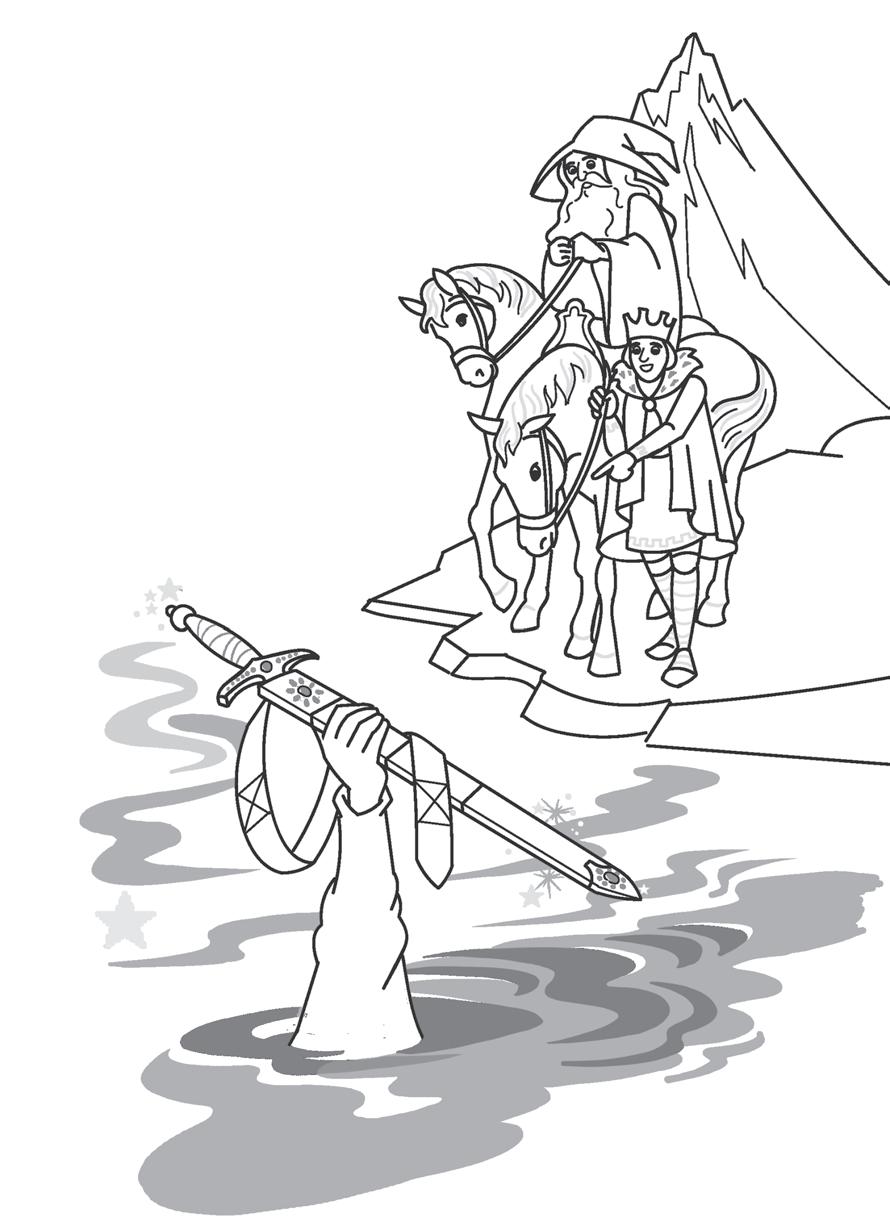
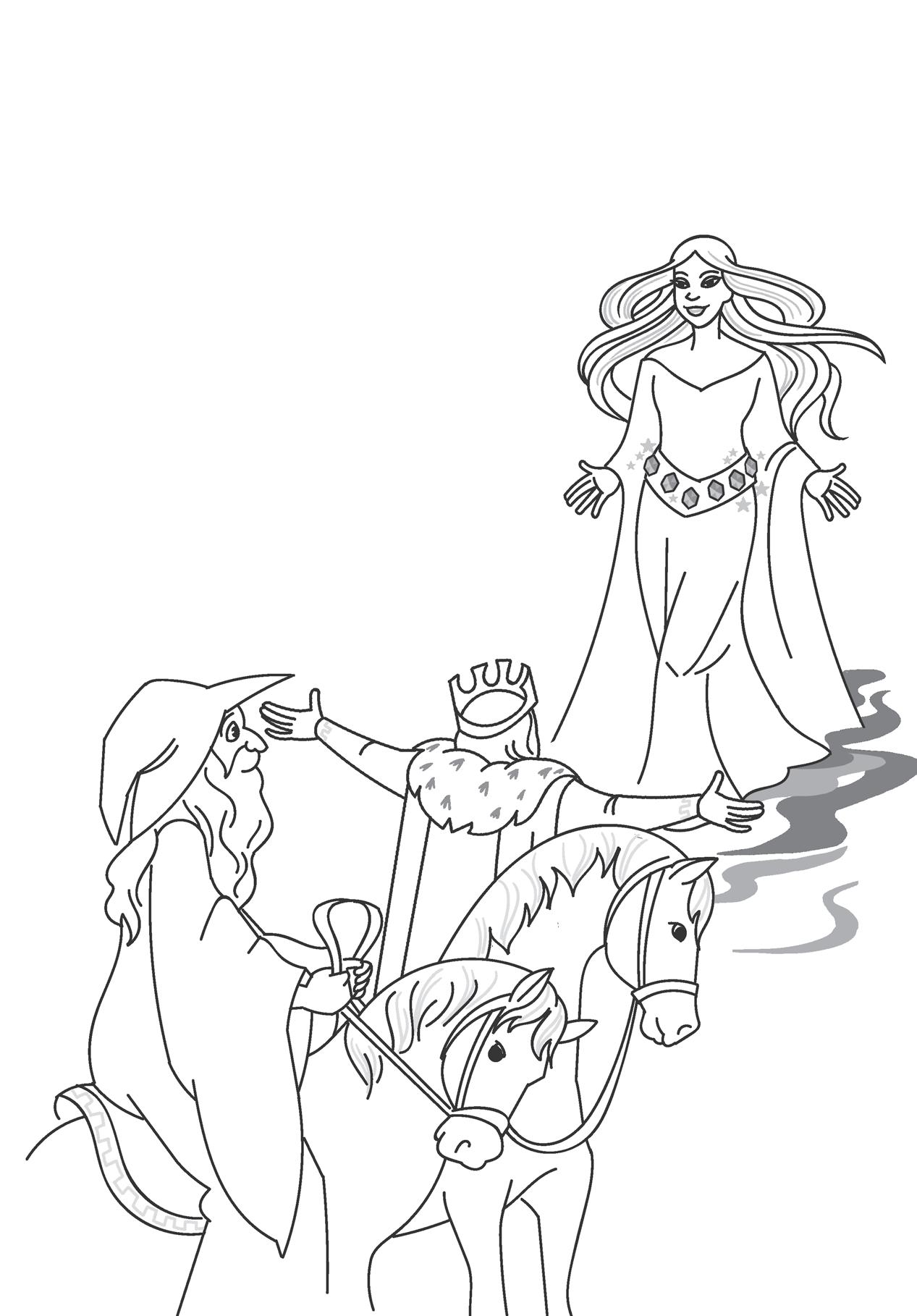
sempre restando sospesa sull’acqua, li salutò: – Buongiorno, Merlino. Buongiorno, mio signore. Tu sei Artù, il figlio di Uter Pendragon, vero?
Artù non si sorprese che la dama conoscesse il suo nome: in quel mondo magico tutto era possibile. Rispose: – Buongiorno, signora. Che spada meravigliosa là in mezzo al lago. Di chi è? È molto bella.
Come vorrei poterla avere, perché, vedi, io non ne ho nessuna.
Così dicendo, spalancò le braccia come a mostrare che in effetti era completamente disarmato.
– Quella è Excalibur. Significa acciaio tagliato ed è la mia spada. Se tu mi farai un dono quando te lo chiederò, potrai averla.
Artù si affrettò a rispondere: – Sul mio onore, mia signora. Ti darò tutto quello che mi chiederai.
– Allora la spada è tua. Sali su quella barca e rema fino al centro del lago. Non temere, quando arriverai, prendi pure la spada, la mano te la consegnerà. Prendi sia la spada che il fodero. Per quanto riguarda il dono, te lo chiederò quando sarà venuto il momento. Detto questo, la dama si dissolse in una cascata di goccioline finissime.
Artù seguì scrupolosamente le istruzioni. Prese la barca legata a un ramo di salice e remò fino al centro del lago. Ogni tanto guardava nell’acqua per scorgervi le meraviglie di cui aveva parlato Merlino, ma il lago era troppo profondo e scuro. Arrivò al misterioso braccio, prese con delicatezza la spada con il suo fodero e la mano, dopo aver fatto la consegna, sparì sott’acqua senza lasciare la minima increspatura sulla superficie.
Artù era turbato, non si sentiva molto sicuro su quell’acqua troppo silenziosa e nera e si affrettò a remare verso la riva. Con i suoi vigorosi colpi di remi, il ritorno fu molto più veloce dell’andata. Quando raggiunse la riva, mostrò raggiante la spada a Merlino, poi la estrasse dal fodero. Sulla lama lucida e tagliente si leggeva scritto in eleganti caratteri: Excalibur. – È meravigliosa! – esclamò.
– Ti piace più la spada o il fodero? – gli chiese Merlino. Il fodero, che aveva deposto sull’erba, era di cuoio, con incastonate pietre preziose che creavano colorate decorazioni, e aveva una fascetta d’argento alla quale era fissata la cintura con cui si legava alla vita.
– La spada – rispose senza esitazione Artù. – Il fodero è molto più prezioso. Finché lo porterai non potrai essere ferito. È un fodero magico, tienilo sempre con te. Forza, andiamo ora, torniamo a Camelot. Sulla strada del ritorno passarono davanti a una tenda elegante e Artù chiese a Merlino, che aveva sempre la risposta a tutto: – Di chi è questa tenda lussuosa?
– Ma come? Non la riconosci? È del tuo avversario, Pellinore.
– L’ultima volta che l’ho vista ero leggermente indaffarato a duellare – rispose un po’ risentito Artù. – Non ho potuto osservarla con attenzione! E lui dov’è?
– Si è battuto contro uno dei tuoi cavalieri, Ser Egglame, che però alla fine si è spaventato, ha voltato il cavallo ed è scappato via. Pellinore l’ha inseguito fino a Camelot. Lo incontreremo presto sulla strada del ritorno.
– Bene, ora che ho una spada potrò battermi di nuovo con lui! – esclamò tutto soddisfatto Artù.
– Ragazzo, ragazzo – sospirò Merlino, – queste non sono parole sagge. Ser Pellinore sarà sicuramente stanco per aver duellato e inseguito Ser Egglame fino a Camelot. Che onore ci sarebbe a duellare con un avversario che non è al meglio della forma? Lo batteresti facilmente e non ne otterresti nessuna soddisfazione. Dai retta a me, lascialo passare. In futuro ti renderà grandi servigi e anche i suoi figli ti faranno onore. Non essere così cocciuto.

Tutto ebbe inizio per… una mela!
Ma facciamo un passo indietro.
Secondo il mito, tutti gli dèi dell’Olimpo vennero invitati al banchetto di nozze tra Peleo, re di Ftia, e la ninfa Teti. Tutti gli dèi furono invitati, tranne Eris, la dea della discordia.
Infuriata, la dea decise di vendicarsi e fece cadere sulla tavola nuziale una mela d’oro su cui era scritto: ALLA PIÙ BELLA.
Afrodite, Era e Atena incominciarono a contendersi la preziosa mela e la lite terminò solo quando intervenne Zeus e decise che sarebbe stato un uomo, Paride, figlio di Priamo re di Troia, a stabilire chi fosse degna del pomo.
Era, per essere scelta, promise a Paride che in cambio gli avrebbe dato il dominio sull’Asia.
Atena gli promise la saggezza e l’invincibilità.
Afrodite, invece, gli promise che, se l’avesse fatta vincere, gli avrebbe fatto sposare la donna più bella del mondo: Elena, già moglie di Menelao, re di Sparta.

Paride scelse proprio Afrodite e la dea mantenne la sua promessa: con un incantesimo, fece in modo che la regina di Sparta si innamorasse a prima vista di Paride.
Così fu. Elena, incontrato il principe durante una missione diplomatica, fuggì con lui a Troia, in Turchia.
Non appena Menelao lo scoprì, andò su tutte le furie e, deciso a riprendersi Elena, chiese aiuto a tutti i re greci: creò un potentissimo esercito e dichiarò guerra a Troia. Ulisse, re di Itaca e protagonista di mirabolanti avventure, a dire il vero non aveva nessuna intenzione di partecipare a quella guerra.
Un oracolo gli aveva predetto che, se fosse andato a Troia, non sarebbe riuscito a tornare nella sua isola per venti anni. Egli, credendo a quel presagio, si finse pazzo.
Quando Palamede, messaggero del re Menelao, andò a Itaca, trovò Ulisse intento a seminare sale. Palamede, che ben conosceva l’astuzia del valoroso condottiero, non si fece trarre in inganno e lo mise alla prova: prese il piccolo Telemaco, figlio di Ulisse, e lo posò sul terreno davanti all’aratro.
– Se sei davvero pazzo, passa con l’aratro sul corpo di tuo figlio – disse con aria di sfida. Il re di Itaca non rispose. Armò i suoi uomini e partì per Troia. La guerra iniziò e fu lunga e sanguinosa.
Nonostante la forza dell’esercito greco, i guerrieri troiani furono così valorosi da riuscire a respingere tutti gli attacchi nemici per uno, tre, cinque, dieci anni!
Terminata la guerra, Ulisse cerca di ritornare in patria, ma mille avventure lo attendono.
Le navi di Ulisse avevano da poco superato il luogo delle Sirene, quando si trovarono di fronte a uno scenario raccapricciante. L’acqua era stretta tra due alte rupi e da un lato c’era una nebbia fittissima sopra un vortice immenso e pauroso: Cariddi.
Sul lato opposto c’era Scilla: un mostro enorme con sembianze di drago. Aveva sei lunghissimi colli che sembravano serpenti e terminavano con feroci e terrorizzanti musi di cane: pareva fatto apposta per attaccare dall’alto gli equipaggi delle navi.
– Svelti, remate verso il vortice! – ordinò Ulisse.
In un batter d’occhio la nave fu inghiottita dalla nebbia e ben presto Ulisse intuì di aver sottovalutato la forza di Cariddi. Il mostro, un pesce enorme simile a una lampreda, aveva un’immensa bocca con la quale cercava di risucchiare la nave.
Attraverso le sue branchie creava onde altissime, che sballottavano la nave e la spingevano verso il centro del vortice per inghiottirla. Non c’era tempo da perdere: se non cambiavano rotta al più presto, il gorgo li avrebbe risucchiati e fatti affondare. – Il mare è troppo forte – gridò Ulisse.
– Remate verso destra, se Scilla ci attacca lo ucciderò con le mie mani e… Non fece in tempo a finire la frase. Quando quella specie di mostruoso drago intuì che la nave si stava avvicinando, iniziò ad agitare i suoi lunghissimi colli.
Con una velocità impressionante scagliò le sei teste verso l’imbarcazione e con i suoi denti appuntiti afferrò sei compagni.
– Nooooo! – urlò impotente il re di Itaca, ma ormai era troppo tardi: le sei bocche del crudele Scilla avevano divorato i suoi compagni. In qualche modo la nave riuscì a scivolare via dallo stretto e, per un pelo, il mostro non riuscì ad afferrare altri uomini. Poi, come per magia, tornò il silenzio. Anche se triste per la perdita dei sei compagni, l’equipaggio tirò un sospiro di sollievo. Nessuno disse una parola, ma tutti in cuor loro pensarono: “Anche questa volta ce l’abbiamo fatta!”.

Nel suo lungo peregrinare per mare, Ulisse era approdato su diverse isole. La sua ultima tappa era stata la terra dei Feaci, guidata dal re Alcinoo.
All’alba del giorno seguente, Alcinoo fece preparare la nave che avrebbe condotto Ulisse in patria.
– Alcinoo, io ti ringrazio con tutto il cuore – disse commosso Ulisse.
– Amico caro, il tuo coraggio e la tua storia mi hanno colpito e sono fiero di poterti offrire il mio aiuto.
E proprio mentre si scambiavano queste parole, Ulisse vide arrivare una folla di persone sorridenti.
Le sue gesta avevano fatto il giro del regno, commuovendo i Feaci, che erano venuti per omaggiarlo con cibo e doni di ogni tipo.
Tra di loro c’era anche la regina, che gli portò in regalo una tunica rossa.
Incredulo, Ulisse salì sulla nave e con un grande sorriso li salutò: – Amici, vi ringrazio per la vostra generosità e racconterò al mio popolo della grandezza di Alcinoo e dei Feaci.
I marinai lo fecero accomodare sul letto nella stiva e partirono alla volta di Itaca. Quando arrivarono a destinazione pensarono che fosse meglio non svegliarlo. Così, lo adagiarono sulla spiaggia circondato dai suoi doni.
Ulisse si svegliò dubbioso. Non riusciva a capire dove si trovasse: il porto, la spiaggia, le mura non erano quelle di Itaca o almeno quelle che ricordava. Disperato, si mise a battere i pugni sulla sabbia.
“Povero me… sono condannato a non tornare mai più a casa…” pensò.
In quel momento, arrivò un giovane pastore che gli chiese: – Straniero, perché ti disperi?
– Da tempo sto cercando di tornare in patria, ma ogni volta finisco su una terra diversa. Mi puoi dire dove siamo?
– Siamo a Itaca!
Non appena sentì quel nome, il cuore di Ulisse iniziò a battere più forte, ma sen za darlo a vedere commentò: – Ne ho sentito parlare – e trattenendo la fortissima emozione, finse indifferen za. – Sai, io sto scappando da Creta. Sorridendo, il pastore replicò: – Ulis se, la tua astuzia non ti abbandona mai.
– Conosci il mio nome? Sei per caso un dio?


– Sì, sono la dea Atena e sono qui per proteggerti.
– Divina Atena, perdonami, ma con quell’aspetto non ti avevo riconosciuta.
– È un travestimento per non dare nell’occhio. Ulisse, sei in pericolo: i Proci hanno occupato la tua reggia e si stanno contendendo la tua amata sposa Penelope.
Un’ira incontrollabile lo assalì e, rosso in volto, iniziò a imprecare: – Maledetti, li ucciderò tutti.
– Stai tranquillo, tua moglie sa difendersi benissimo da sola. Siete fatti l’uno per l’altra: da anni li inganna con la propria astuzia.
– Davvero? In che modo?
– Ha promesso ai Proci che avrebbe scelto il suo sposo tra uno di loro soltanto nel momento in cui il lenzuolo funebre per tuo padre Laerte sarebbe stato finito. Ma quello che tesseva di giorno, lo disfava di notte. Così il lavoro non andava mai avanti.
– Senti senti la mia Penelope… sono fiero di lei.
– Tuttavia, alla fine hanno scoperto il suo inganno e ora è costretta a portare a termine il suo lavoro – replicò la dea.
– Quindi sono arrivato in tempo.
– Sì. Per prima cosa dovrai andare dal tuo vecchio servitore Eumeo, il pastore. Ti ricordi di lui?
– Certamente, è stato il mio più fedele servitore e da sempre custodisce le mie terre e il mio bestiame.
– Bene, recati alla sua stalla e aspetta lì. Io nel frattempo andrò a Sparta a chiamare tuo figlio.
– Telemaco è a Sparta? Perché?
– Da tempo sta andando in visita dai tuoi più fedeli compagni per avere tue notizie. Non si è mai rassegnato all’idea che tu potessi essere morto.
– Atena, non sai quanto mi fa piacere sentire queste parole. Non vedo l’ora di riabbracciarlo!
– Un’ultima cosa Ulisse: con il tuo aspetto sei in pericolo, dobbiamo porvi rimedio – e subito lo toccò con una bacchetta magica trasformandolo in un vecchio mendicante. – Oooh, molto meglio! – concluse soddisfatta. – Ora non ti riconoscerà più nessuno!
Sporco e zoppicante, Ulisse si incamminò verso la dimora di Eumeo. Quando arrivò, rimase stupito dall’ordine e dalla cura con cui erano coltivati i campi e dalla pulizia delle stalle che ospitavano decine di mucche, tori e maiali. Si fermò per un attimo ad ammirare tutto questo. “Anche in mia assenza Eumeo ha fatto davvero un ottimo lavoro, curando con costanza i miei terreni” pensò.
All’improvviso, però, alcuni cani uscirono dal recinto e gli si fecero incontro minacciosi.
Erano i suoi cani ma, vestito di quegli stracci, non lo avevano riconosciuto e gli ringhiavano contro inferociti. Subito Eumeo uscì dalla stalla e fischiò per richiamarli.
Poi si avvicinò al mendicante e disse: – Perdonali, straniero, ma fanno il loro lavoro.
– Certo, non ci sono problemi.
– Ti prego entra nella mia capanna, voglio offrirti del cibo. Ulisse lo seguì.
Eumeo gli offrì un bicchiere di vino, pane e frutta, poi gli chiese: – Straniero, hai l’aria stanca, da dove vieni? Da quanto tempo sei lontano da casa?

– Sono scappato da Creta e purtroppo da moltissimo tempo non riesco a tornare a casa. Queste terre sono tue?
– No, sono del mio buon padrone Ulisse.
– Dov’è ora?
– È dovuto andare in guerra e non sai quanto mi manchi. Quando lui era qui, tutti erano felici, ma adesso…
– Chi c’è ora al suo posto?
– I Proci, i giovani e arroganti nobili che da tempo mangiano le bestie del mio padrone e cercano di prendere in sposa sua moglie.
– Qualcuno dovrebbe fargliela pagare, non credi?
– Hai perfettamente ragione, ma qui nessuno è in grado di combatterli.
In quell’istante i cani cominciarono a guaire senza ostilità. Stavano facendo le feste a un ragazzo. Non appena lo riconobbe, Eumeo gli corse incontro e, abbracciandolo come se fosse suo figlio, gli diede il benvenuto: – Bentornato Telemaco!
Ulisse riuscì a stento a trattenere la sua gioia e a non rivelare la sua vera identità. Non poteva credere ai suoi occhi: quell’uomo era il bambino che aveva salutato tanto tempo prima, quando era dovuto partire per Troia.

Vacanze estive: in un sito scandinavo di scavi archeologici, a causa di un bizzarro esperimento scientifico, Anna e i suoi amici, TomTom e Kid, subiscono un salto spazio - temporale e si ritrovano al cospetto dei leggendari guerrieri vichinghi.
Mentre fuggivano per mettersi in salvo, Anna, TomTom e Kid non si accorsero di due occhi chiari come acqua di fonte che li osservavano da un po’. Due occhi di ragazza che sembravano divertiti di fronte all’imbranataggine di TomTom. Occhi bellissimi che non avevano paura delle frecce e del fuoco, perché le ragazze vichinghe erano abituate a competere con i maschi della loro età. E le frecce le usava pure lei per cacciare: legate alla cintola aveva un paio di prede per la cena. Sapeva di dover essere prudente: il bosco pullulava di nemici decisi a farla pagare a quelli del suo villaggio per un episodio che li aveva portati a farsi la guerra. Ma, quando vide TomTom sfuggire per un pelo a Snorre, il grande cane di proprietà di suo

zio Leif-il-peloso, la ragazza si portò una mano alla bocca per il gran ridere. Era esperta della vita, aveva pressappoco la stessa età di quei tre tonti che stava osservando, con la differenza che lei era dovuta crescere molto più in fretta di loro, tra mille avversità.
E, all’improvviso, il suo viso si fece serio. Era abituata a non sottovalutare il pericolo: un errore nella Scandinavia del X secolo si pagava caro. Una gamba rotta, una brutta frattura, una ferita infetta, spesso volevano dire un viaggio nell’Aldilà, nel loro paradiso chiamato Valhalla, tra le braccia delle Valchirie e del dio supremo, Odino.
Quei tre ragazzi sconosciuti stavano correndo proprio verso di lei e, quel che era peggio, si stavano tirando dietro un branco di inseguitori arrabbiatissimi.
Lo stesso gruppo di attaccanti che aveva scagliato le frecce incendiarie. Li riconosceva dai tatuaggi e dalle incisioni con le Rune su elmi e scudi: erano degli Gjoll (che significava Gli Urlanti), il clan del villaggio vicino, da pochi giorni in lotta contro di loro.
Lo stesso Wulfric-grande-assai, il capo del villaggio della ragazza, aveva guidato, appena il giorno prima, un’incursione di guerrieri Hlokk (il clan in cui viveva la ragazza e che significava I Risonanti) contro le navi dei Gjoll, incendiandole.
Ora la ragazza si stava irritando. Quei tre starnazzavano come oche e si erano tirati dietro un bel po’ di Gjoll molto arrabbiati. Si arrampicò su un ramo alto e attese.
Non ci volle molto. Sotto di lei passò di corsa Kid, urlando, che teneva per mano Anna, che teneva per mano TomTom. Il guerriero che li inseguiva passò ghignando proprio sotto l’albero dove stava seduta la ragazza: l’uomo sentiva di avere in pugno le prede.
Lei alzò i piedi che tenevano piegato all’indietro un ramo basso e lo lasciò andare proprio sulla faccia del guerriero grasso, barbuto e puzzolente che stava per raggiungere i ragazzi. Si udì il cozzare del legno contro il naso dell’uomo, che rimbalzò all’indietro per il contraccolpo, a cui seguì un gemito di dolore; poi, la ragazza si lasciò cadere direttamente sulla cassa toracica del guerriero steso a terra.
Tutto il fiato gli uscì in un sibilo da teiera e lei lo tramortì dandogli un colpo in fronte con un pezzo di legno. Risultato: naso rotto e bernoccolo da primato.
La ragazza si rialzò, snella e agile come chi è abituato a fare certe cose fin da bambino; osservò per un attimo la sua vittima priva di sensi, sorrise soddisfatta e partì alla rincorsa dei tre impacciati fuggiaschi. Troppo tardi. Giunse alle loro spalle quando erano già accerchiati dai Gjoll.
– Ma sono tre nanerottoli con il moccio al naso! – Olaf-cinque-pance era il loro re e quindi aveva il diritto di parlare per primo. – Tutta questa fatica per così poco! – ruggì minaccioso reggendo il manico della lunga scure. – Che ne dite amici… Mi rovino la buona reputazione con le mie ammiratrici se affetto tre mocciosi? – e alzò l’arma.
– Tu non hai nessuna buona reputazione da difendere, Olaf… – gracchiò il suo capitano. – Ne hai una pessima!
Gli altri Gjoll sputacchiarono e risero in modo sgangherato.
Di colpo si fece silenzio. Olaf-cinque-pance non aveva gradito la battuta.
– Questo qui è arrabbiato seriamente! – TomTom schivò il colpo d’ascia riservato proprio a lui. Avevano armi tanto possenti quanto pesanti. Evitare i colpi era fattibile, sperando che le braccia dell’attaccante si stancassero presto, ma sarebbe stato impossibile sopravvivere se solo uno andava a segno.
Ma la ragazza non si era persa d’animo, aveva continuato a correre. Di slancio fece una capriola e colpì dietro le gambe un primo guerriero, che cadde a terra, poi si lasciò rotolare e finì la sua corsa dietro le ginocchia di un altro nemico, che rovinò al suolo impacciato dalle pesanti armi. I Gjoll si stavano ancora chiedendo chi fosse quel furetto rotolante, mentre lei si era già rialzata e, sempre correndo, aveva esortato i tre amici a fuggire, passando nello spazio che, proprio grazie a lei, si era creato in quell’accerchiamento.
Teneva per mano TomTom e correvano tutti a perdifiato verso una gola rocciosa. Correndo come un forsennato, con il cuore in gola, il ragazzo poteva scorgere solo l’ondeggiare dei lunghi capelli biondi, legati a treccia, che oscillavano sull’arco da caccia messo a tracolla.
Inciampava con le sue scarpe da ginnastica tutte sbrindellate ed era preoccupato per Anna, così continuava a voltarsi scorgendola correre, insieme a Kid, tra un ostacolo e l’altro della foresta.
Le voci accanite degli inseguitori erano pericolosamente ancora troppo vicine.
Piano piano un rombo, prima ovattato, poi sempre più possente, divenne un frastuono immane. “Una cascata!” pensò TomTom. “E che cascata! Deve essere larga almeno trenta passi e alta il doppio”.
Non aveva più fiato, ma la ragazza non accennò a fermarsi, proseguendo verso quella barriera liquida. “Non vorrà tuffarsi, spero!”. Nemmeno il tempo di pensarlo e lei continuò su un cammino di roccia, che in apparenza finiva contro il fianco della cascata. Lei li guidò attraverso quella barriera, raggiungendo un luogo asciutto e, al momento, sicuro.
La sconosciuta perlustrò lo spazio dentro a quel nascondiglio e, quando fu sicura che fosse sgombro da pericoli, si avvicinò ai tre bislacchi stranieri in visita a quelle terre. Non aveva ancora pronunciato una parola. Fu allora che, con le spalle rivolte alla cascata, andò loro vicino. E, in quel momento, tutti videro in faccia Karin-l’orgogliosa: era una bellezza mozzafiato!

Intanto nel campo di scavi archeologici la scienziata Rethel continuava nei suoi tentativi di far funzionare il “wormhole” (buco del verme), meccanismo che avrebbe dovuto riportare indietro nel tempo i ragazzi.
I tre amici manifestarono di nuovo quel fenomeno luminescente, questa volta forte e deciso. – Forza! Siamo in tempo per il pranzo alla mensa da campo! – Kid esultò, mentre si smaterializzava davanti ai vichinghi. – Stiamo per partireeeeeeeeeeeee… – la voce scemò, mentre venivano risucchiati in un’altra dimensione attraverso il wormhole che Rethel era riuscita a ricreare. Anna e Kid urlavano come su un ottovolante. TomTom tenne fin che poté gli occhi fissi su Karin, che piangeva. Poi, nella radura del X secolo, più niente.
– Ancora fango! – TomTom cominciava ad averne abbastanza perché dopo un salto dimensionale attraverso il famoso buco del verme, non erano riemersi su un bel giaciglio pulito e comodo, ma in mezzo al fango di una porcilaia. Tutt’intorno le tipiche case vichinghe, ma di un villaggio sconosciuto. All’interno alcune donne tessevano a mano un arazzo, mentre altre pulivano la lana, prendendola pazientemente da grossi tini di legno grezzo. A mezz’aria l’immancabile puzzo di cavoli bolliti e lo starnazzare di grosse oche grigie. Al centro del villaggio un’enorme tavolata: anche loro si preparavano al banchetto della Festa di Mezza Estate.
– Oooooh nooooooooooo! Questo è un altro villaggio vichingo. Ci siamo solo spostati nello spazio e non nel tempo. Siamo rimasti intrappolati nel passato. Rethel deve avere sbagliato i calcoli un’altra volta! – E adesso chi lo spiega a mio padre? –chiese Anna, con la voce incrinata dal pianto.

– Rischiamo di passare il resto della nostra vita in un’altra epoca e tu ti preoccupi della ramanzina di tuo padre?
Seduti in mezzo ai porci, non osavano rialzarsi. Kid notò un ragazzino biondo che passò davanti a loro correndo. Rise vedendoli in mezzo ai maiali, ma tirò dritto, nascondendosi dietro una quercia. Poi Kid si fece più attento e il cicalino elettronico che udì gli fece accapponare la pelle per la contentezza. Si alzò in un lampo-secondo e prese a correre verso il bambino che, vedendo arrivare il ragazzo a passo di carica, se la stava dando a gambe in mezzo al mar giallo di uno sterminato campo di fiori di colza.
– Aspetta! Accidenti a te! Aspettami! – gridava Kid.
Anna non si mosse e non disse niente. TomTom fece lo stesso. Ma, mentre Kid tornava sui suoi passi portandosi dietro a forza il bambino biondo, TomTom alzò gli occhi al cielo e vide ciò che mai si sarebbe aspettato: un aereo con una striscia bianca nell’azzurro sconfinato.
Stava per urlare quando Kid spinse avanti il bambino: – Forza, campione! Fai vedere ai miei amici che cos’hai in tasca!
Riluttante, temendo di essere punito perché in quella comunità non si potevano introdurre oggetti simili, mostrò un videogame nel palmo della mano. – È un villaggio ricostruito, capite? Kid allargò le braccia.
– Ne sei sicuro?
– Te lo dimostro – e strattonò il bambino. – Ehi tu, piccoletto, prova a parlare!
L’altro si lamentò nella sua lingua, senza che i tre capissero nulla.
– Visto? – Kid era su di giri. – Non li capiamo, quindi questa lingua non è scandinavo antico, ma moderno! Ce l’abbiamo fatta. Siamo nel presente!
– Ehi, voi! – li raggiunse la voce arrabbiata di un adulto che si avvicinava parlando in inglese. – È vietato l’uso di materiale elettronico qui! Abbiamo faticato tanto per ricostruirlo com’era nel X secolo a beneficio dei turisti… Cercate di non rovinarci l’opera. Siete con il dottor Scott, agli scavi?
Anna annuì, senza la forza di parlare.
– Bene, allora vi accompagno in macchina: non voglio intrusi qui senza autorizzazione!
TomTom si rilassò: – Mai sentito frase più bella negli ultimi undici secoli!


Tutti e tutte noi, nella vita di ogni giorno, mettiamo in atto le competenze che abbiamo acquisito, tessendo le abilità e le conoscenze delle differenti discipline.
I compiti di realtà ci permettono di “metterci alla prova” in situazioni divertenti, coinvolgenti e adatte a tutti e a tutte.
Radio School sarà la palestra in cui mostreremo il “tessuto” di conoscenze, di abilità e… perché no?… di creatività.
A tutti e a tutte... buona programmazione e buon ascolto!
Che cos’è un compito di realtà
Il compito di realtà è uno strumento utile per consolidare le competenze in situazioni reali e informali.
Con il compito di realtà gli alunni e le alunne sono invitati a risolvere una problematica nuova, decontestualizzata dalle richieste più o meno formalizzate delle esercitazioni di routine. Devono utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite trasferendo le procedure in ambiti diversi.
Per realizzare il compito di realtà gli alunni e le alunne devono partire dalle competenze che afferiscono anche a discipline diverse.
Il compito di realtà incrementa la motivazione ad apprendere perché attraverso la partecipazione attiva gli alunni e le alunne “vedono” che i loro sforzi si possono tradurre in un “prodotto”.
La proposta di Direzione Letture
L’occorrente per questi compiti di realtà
Il compito di realtà che proponiamo in questa Guida è RADIO SCHOOL : la radio di classe. I bambini e le bambine si succederanno come speaker e come esperti/e per le trasmissioni che possono anche avere una scadenza durante il corso dell’anno: una volta al mese, una a trimestre…
Per svolgere al meglio il percorso proposto è necessario dotarsi di: un microfono, anche non funzionante, da posizionare sulla consolle di trasmissione (per rendere più realistica la situazione); un leggio, per posizionare i fogli del copione; una bacheca (per comunicare le attività della “radio”).
Nome e cognome
Data
La bacheca è il pannello sul quale vengono esposti gli avvisi. Sicuramente ce ne sono anche nella vostra scuola.
Preparate la bacheca della vostra radio da appendere dentro l’aula o fuori, se volete dimostrare… quanto siete creativi!
Procuratevi tappi di sughero in quantità sufficiente per fare un bel pannello. Incollate i tappi su un supporto di cartone spesso o su del legno compensato. Sul bordo superiore applicate, con spilli con la capocchia colorata, la “testata” della vostra radio.
(mettete il nome che avete scelto per la vostra radio).
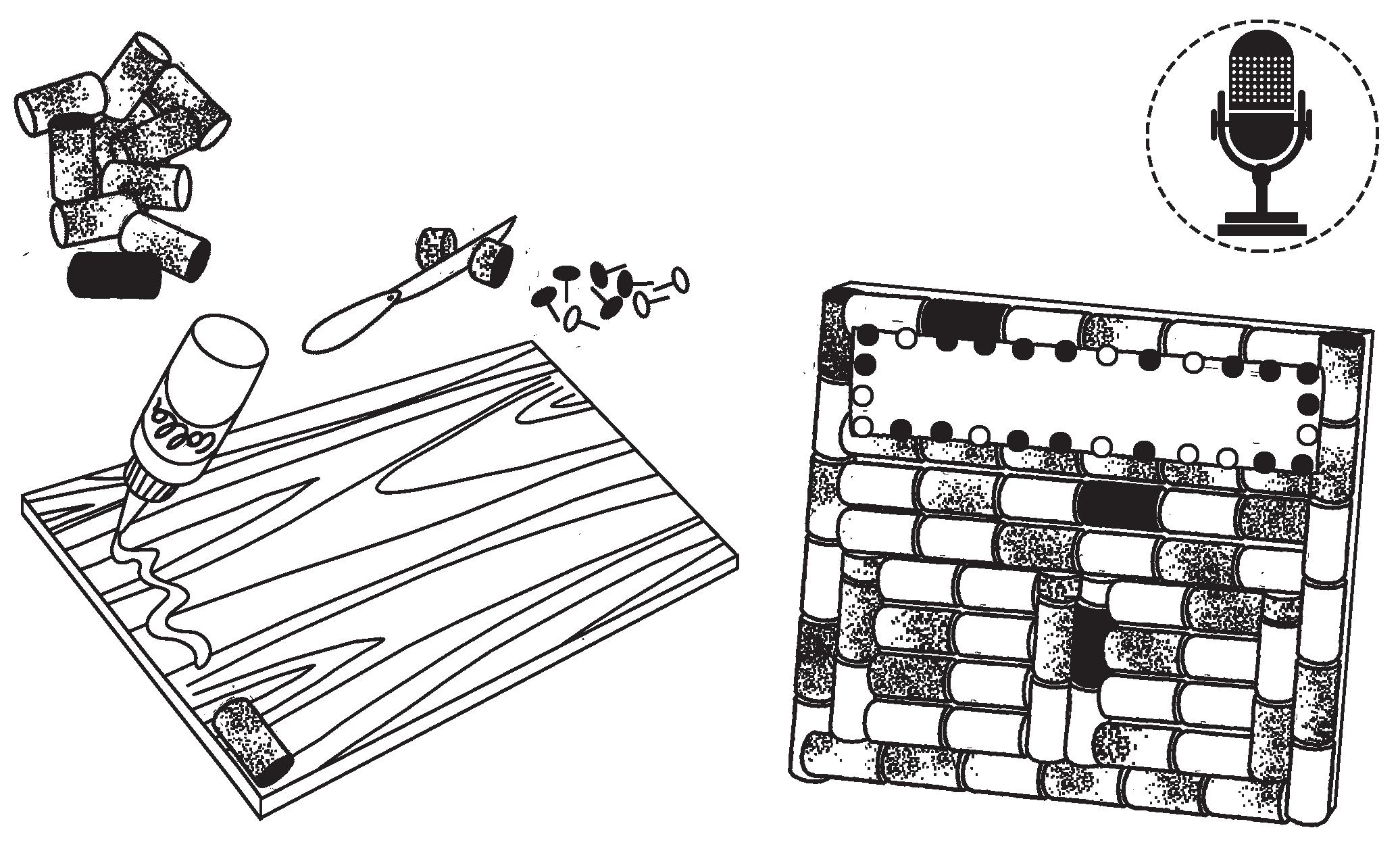
Ogni volta che farete una trasmissione, appuntate alla bacheca un avviso con scritto: titolo della trasmissione; giorno e ora; argomento trattato; autori; speaker.
Nome e cognome Data
Un bravo speaker o una brava speaker deve avere una pronuncia quasi perfetta e allora… organizzate un quiz di dizione!
Nella locandina troverete alcune frasi da far leggere ai/alle concorrenti che parteciperanno al vostro quiz.
Preparate il volantino da affiggere sulla bacheca.
Ritagliate la parte illustrata.
Colorate i disegni.
Completate il volantino.
Preparate un foglio per le iscrizioni al quiz.
Scegliete chi presenta, che dovrà imparare le seguenti battute di presentazione del quiz:
– Benvenuti e benvenute al quiz che metterà alla prova la vostra dizione.
– Dovrete leggere a voce alta le frasi.
– Avete a disposizione un solo tentativo.
– Per ogni frase letta in modo corretto, verrà assegnato un punto.
Nel riquadro troverete le frasi che i concorrenti o le concorrenti dovranno leggere a voce alta.
Oggi capitàno / càpitano tutte a me!
Il capitàno / càpitano della nave diede ordine di levare l’ àncora / ancòra per salpare.
Ma non è àncora / ancòra ora di fare ricreazione?
Sei ancora a letto? Vèstiti / Vestìti siamo in ritardo!
Alla festa nel castello arrivarono tutti i princìpi/ prìncipi del regno.
Nella vetrina della gioielleria c’era un anello con un grande rubìno/rùbino rosso.
Vieni qui subìto/sùbito.
Ho subìto/sùbito un’ingiustizia: la Befana mi ha portato il carbone… sì, ma dolce!

GIORNO .................... ORE .............
Spettacolare quiz “IL GIUSTO ACCENTO”
Partecipanti:
Nome e cognome
Data
Quanti sono gli audiolibri in circolazione? Beh, perché non trasmettere dalla vostra radio la lettura di un brano tratto da un libro? Potrebbe diventare una consuetudine e potreste leggere tutto il libro o brani di tipologia differente.
Ma occorre pubblicizzare l’iniziativa!
Preparate il volantino da affiggere sulla bacheca.
Ritagliate la parte illustrata.
Colorate i disegni.
Completate il volantino scegliendo il brano che intendete leggere.

GIORNO .............................................. ORE ......................
Lettura di un brano tratto dal libro
Autore /Autrice
La lettura del brano è stata proposta da Speaker
Chi vuole può mettere i like!

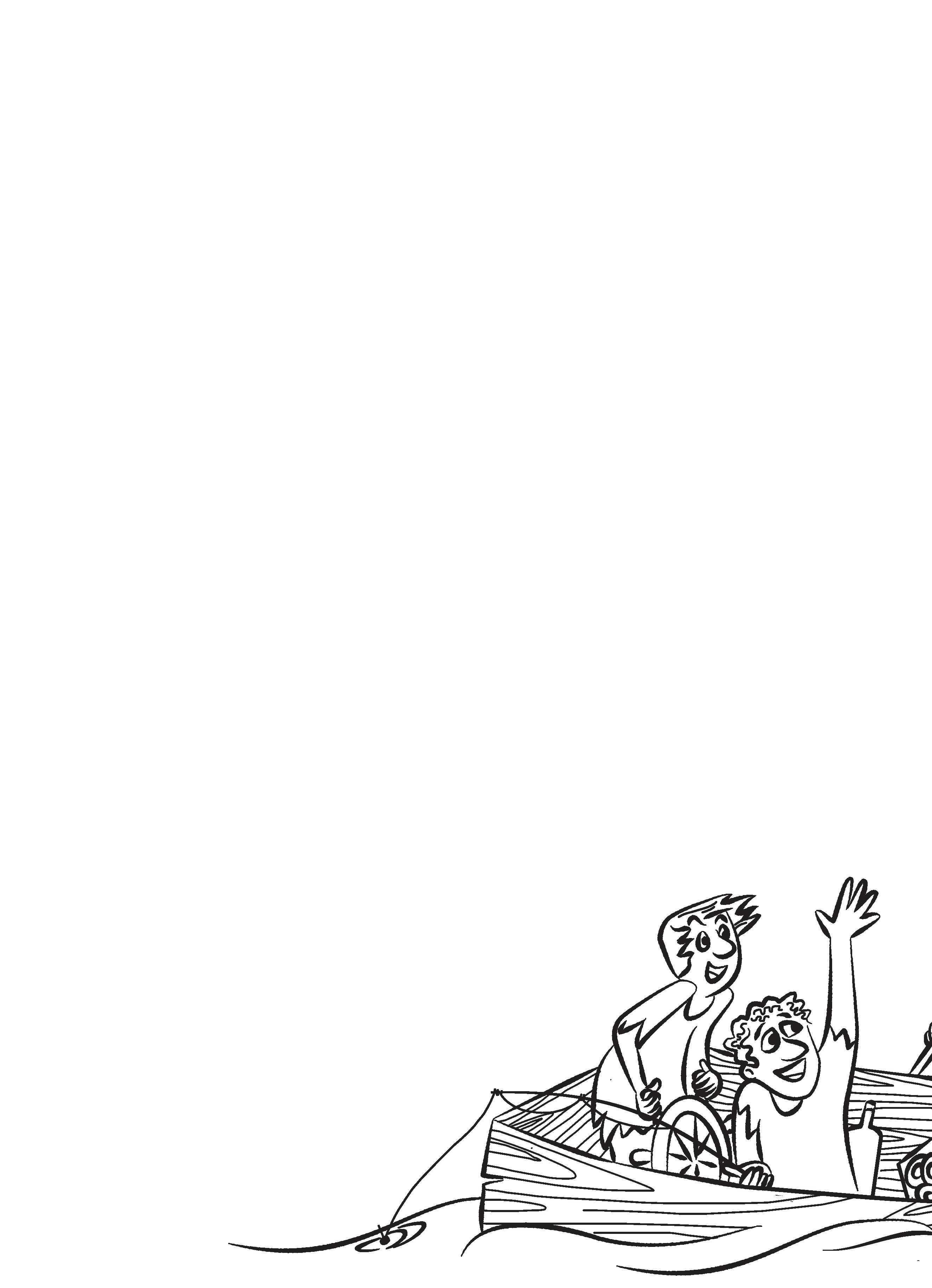
Nome e cognome Data
C’erano una volta… le rappresentazioni teatrali trasmesse per radio! Per radio? Sì, la TV non c’era, dunque la scena si poteva solo immaginare!
Riproponete quell’atmosfera!
Ecco la pièce (come dicono i Francesi!), cioè il “pezzo”, che dovrete rappresentare.
Ma il lavoro non finisce qui.
Sono due le compagnie teatrali che portano in tournée la pièce.
Quindi il cast, cioè l’insieme degli attori e delle attrici, sarà doppio, uno per ogni compagnia, e le trasmissioni saranno in due momenti differenti.
Ecco il testo che dovrete imparare a r ecitare. Leggetelo insieme più volte, così da coglierne bene tutti gli aspetti.
Narratore
Una zattera male in arnese, fornita di albero e di una vela di fortuna, naviga da tempo. Su questa zattera ci sono sei naufraghi con le vesti a brandelli. Sono quattro uomini e due donne: uno sta al timone, altri due ai remi e il quarto cerca di pescare; le donne badano alla vela e ogni tanto scrutano l’orizzonte. La situazione è preoccupante! Per quanto potranno resistere ancora?
Sottofondo con rumore del mare, vento ecc.
Naufrago al remo destro (smettendo di remare)
Non ce la faremo mai, questo ammasso di tavole non potrà resistere per tanto tempo.
Naufrago al timone
La zattera è solida e il mare si mantiene calmo.
Rumore del mare
Naufrago al remo sinistro
Non è la zattera il nostro problema, ma il cibo e l’acqua.
Naufrago al timone
Le provviste dureranno ancora una settimana e in una settimana possono accadere tante cose.
Naufrago al remo destro (ironico)
Che cos’altro può succedere? Ci spieghi meglio… capitano!
Rumore del vento
Naufrago al timone
Innanzitutto, potremmo incrociare una nave.
Naufrago al remo sinistro
Prima moriremo di fame e di sete.

Naufrago al timone
Oppure sbarcare. La costa non dovrebbe essere lontana.
Rumore del mare e del vento insieme
Naufrago al remo destro
Ci sono rimaste solo due scatole di biscotti e tre bottiglie di acqua.
Prima donna
Lei pensa sempre a mangiare, signor rematore?
Naufrago al remo sinistro
Sì, signora, specialmente quando sono in mezzo all’oceano con due pacchi di biscotti da dividere.
Seconda donna
Perché, non li vorrebbe dividere? Sarebbe capace di tenerseli tutti per sé?
Naufrago al remo sinistro
Non ho detto questo, ma trenta biscottini non sono una grande provvista.
Rumore del mare
Naufrago pescatore
Terra! Terra!
Naufrago al remo destro
(allarmato) Sta entrando acqua, guardate qui, sta entrando acqua!
Naufrago al remo sinistro
Le provviste, mettiamo al riparo le provviste! (si alza e appende i biscotti all’albero)
Naufrago al timone
Non c’è nessun pericolo, si è rotta una bottiglia, è solo l’acqua di una bottiglia.
Naufrago al remo sinistro
Allora ne sono rimaste solo due! Oh, poveri noi! E lei dice che non c’è nessun pericolo.
Rumore del mare e del vento insieme
Naufrago pescatore
Terra! Terra!
Naufrago al timone
Terra! Laggiù!
Prima donna
È vero, si vedono le palme (sul telo bianco appare lontanissima
l’ombra di un’isola tropicale che gradualmente ingrandisce).
Tutti
Evviva! Siamo salvi! Terra! Terra! Terra!
C. Leoni - D. Barbonetti, Le uova del re, Edizioni Era Nuova
Preparate la rappresentazione.
Scegliete:
sei “attori”/“attrici” che interpretino i personaggi; un narratore/una narratrice che legga la parte per far immaginare la scena; due rumoristi/e: uno/a farà il rumore del mare, l’altro/a il soffio del vento; un/una regista: deve avere in mano il copione per suggerire ai diversi personaggi quando devono intervenire.
Ogni compagnia (cioè l’insieme di attori/attrici) deve scegliere il suo nome.
E ora… preparate le locandine inserendo le informazioni.
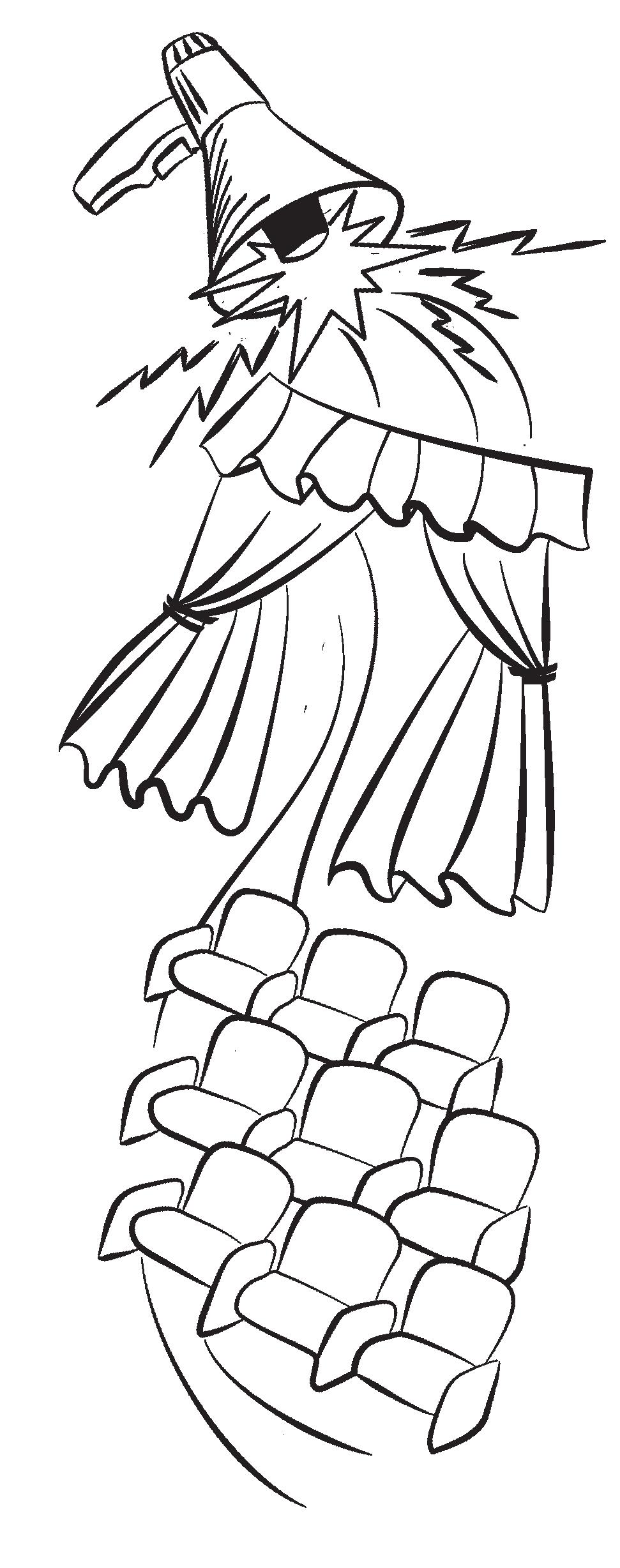
giorno …………………………….. Alle ore …………………………….. La compagnia teatrale presenta
Di Claudio Leoni, Domenico Barbonetti

Personaggi e interpreti
Primo naufrago: .......................................................................................
Secondo naufrago: Terzo naufrago: Prima donna:
Seconda donna: ....................................................................................... Naufrago pescatore: .............................................................................
Rumoristi
Mare: Vento: Regia : ..............................................................................................................
Nome e cognome
Data
Ora è la volta della trasmissione radio sulla salute. Leggete prima i testi che dovranno essere pronunciati dagli/dalle speaker e iniziate a capire come svolgere gli esercizi.
Speaker
Per stare in forma, niente di meglio di un po’ di esercizio fisico. Farà bene anche al buonumore, perché vi divertirete certamente!
Seguite i nostri consigli e, come al solito…
Mens sana in corpore sano (se il corpo è sano, la mente sarà… sanissima)!

Secondo/a personal trainer
Stretching della farfalla
Sedetevi per terra, con le gambe piegate.
Unite i piedi il più possibile vicino al corpo.
Primo/a personal trainer
Camminare come un ragno
Tenete le gambe bene aperte e le ginocchia un po’ piegate.
Piegate il busto in avanti fino a quando riuscirete a toccare il pavimento con le mani.
E ora, cominciate a camminare. Fate 10 passi. Poi fermatevi. Tutti i vostri muscoli lavorano: soprattutto quelli delle gambe, delle braccia e della schiena.
Alzatevi in piedi e stiratevi ben bene: tendete le braccia in alto sulla vostra testa, più che potete. Poi, se non siete stanchi, si ricomincia!
Le gambe rimarranno divaricate verso l’esterno.
Piano piano, senza sforzare troppo, cercate di avvicinare le ginocchia al pavimento.
Rimanete in questa posizione per 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… Alt!
Alzatevi, fate tre saltelli e poi, ricominciate!

Terzo/a personal trainer
Come una tartaruga
Mettetevi in ginocchio. Chiudete gli occhi e immaginate di essere su una spiaggia o in un prato.
Piegatevi dolcemente fino ad appoggiare la pancia e il petto sulle gambe rannicchiate.
Nascondete bene la testa tra le braccia strette
Appoggiate la fronte a terra.
Ora allungate le braccia.
Cercate di spingere in avanti le dita delle mani per stirare un po’ la schiena, come farebbe una tartaruga che prova a camminare.
Rilassatevi e ascoltate i rumori intorno a voi: fate un bel respiro profondo, trattenete l’aria e soffiatela fuori piano, ancora una volta.
Restate un po’ nella posizione della tartaruga prima di rimettervi in piedi lentamente.
Preparate la vostra lezione di fitness.
Come al solito, scegliete: uno/una speaker per la presentazione; tre personal trainer che fanno eseguire gli esercizi. Attenzione al ritmo: dovete pensare che i vostri compagni e le vostre compagne eseguono realmente gli esercizi; una musica rilassante da mettere come sottofondo: il rumore del mare calmo, lo scorrere dell’acqua di un ruscello, il vento leggero…

Quando?
A che ora ?
Camminare come un ragno
Personal
Stretching della farfalla
Personal trainer
Come una tartaruga
Personal trainer

Il vero banco di prova per verificare se siamo stati/e in grado di “tessere bene” conoscenze e abilità.
Un percorso per sviluppare capacità logiche esportabili in tutte le discipline. Le attività proposte in ogni unità sono collegate da un filo conduttore presentato in forma di narrazione.
Coding della didattica
Primo e secondo step:
• osservare e dedurre;
• giocare con le parole;
• giocare con i testi.
Coding
La crescita intellettiva attraversa fasi che procedono di pari passo con la crescita fisica. Come per un equilibrato e costante sviluppo fisico sono indispensabili stimoli che si possono identificare in una corretta alimentazione, in un’adeguata attività fisica e in un ambiente salubre, così, per una crescita intellettiva che diventi un efficace strumento per capire la realtà e permetta di agire su di essa, sono altrettanto indispensabili stimoli diversificati e costanti.
Nel suo percorso di sviluppo il bambino/la bambina compie progressi intellettivi che gli/le consentono di acquisire conoscenze e abilità nuove.
Ma la conoscenza non è la semplice registrazione degli eventi che capitano, delle situazioni in cui si vive; essa è soprattutto un processo continuo che scaturisce dall’interazione del bambino e della bambina con l’ambiente che li circonda. Per questo, più l’ambiente sarà ricco di stimoli diversificati, più la conoscenza sarà attiva, cioè capace di diventare competenza che favorisca una strategia di apprendimento.
L’ interazione con la realtà circostante, che è la base dell’attività intellettiva e dello sviluppo, si concretizza nella tendenza all’adattamento e all’organizzazione.
L’ adattamento si realizza attraverso due processi complementari tra loro: l’assimilazione , che consente al bambino e alla bambina di strutturare ciò che gli/le proviene dall’esterno attribuendogli un significato, e l’ accomodamento , che è la capacità di modificare i dati esterni per renderli funzionali agli schemi conoscitivi che via via si costruiscono.
In un secondo momento interviene l’ organizzazione , che permette di coordinare tutti gli schemi gradualmente acquisiti.
È proprio nei bambini e nelle bambine della Scuola Primaria che si potenziano e sviluppano questi processi mentali che andranno a formare le basi delle strategie di apprendimento.
È questa strutturazione del pensiero che va favorita nella Scuola Primaria attraverso giochi logici di vario tipo, che abituino il bambino e la bamina ad avere attitudini progettuali per la costruzione di nuove conoscenze e a sviluppare la capacità di modificare la realtà dopo aver imparato a osservarla e ad agire su di essa in modo consapevole.
Secondo Max Wertheimer, uno dei maggiori psicologi contemporanei, il pensiero produttivo non procede per prove ed errori, ma escogita altre soluzioni: prende in considerazione i dati a disposizione, li esamina, li confronta, li mette in relazione e con essi scopre le soluzioni al problema.
Questa modalità di procedere del pensiero è la logica che, dunque, fonda la conoscenza
Habitus mentale
Le abilità mentali che vanno conseguite sono quelle di saper osservare, descrivere, rappresentare, interpretare, simulare, modellizzare, fare collegamenti.
Le persone adulte hanno il compito di stimolare il bambino e la bambina all’osservazione per cogliere le analogie e le differenze e per porre in relazione oggetti. Fondamentale è anche la manipolazione concettuale della realtà perché essa permette di generalizzare, di costruire collegamenti, di imparare ad astrarre.
Da tutto ciò si evince che un apprendimento che sia solo registrazione di eventi o di nozioni non è adatto a formare un percorso intellettivo personale, cioè che si modella sulla propria struttura mentale e che consente di avere strumenti per conoscere, manipolare e modificare la realtà in modo proficuo.
Logica linguistica
La logica permette non solo di apprendere, ma anche di manifestare e applicare le proprie conoscenze esportandole in ambiti diversi, perciò è fondamentale per ogni disciplina. Attraverso la logica, le conoscenze si trasformano in competenze e le abilità si consolidano. Un bambino o una bambina capace di osservare sarà in grado di rilevare analogie e differenze in ciò che osserva e riuscirà a comprendere la regola generale che sottende a un fenomeno. Per questo la logica non può rappresentare un fine da raggiungere, ma un mezzo per sviluppare capacità esportabili in tutte le discipline . Ma se alcuni processi di conoscenza sono, per così dire, naturali, la possibilità di svilupparli deve essere indotta attraverso proposte che facciano acquisire strategie per costruire un apprendimento significativo. Da qui la necessità di trovare stimoli nuovi che consentano di tracciare un percorso atto a formare nel bambino e nella bambina il pensiero divergente che, oltre ad essere creativo, risulterà anche idoneo ad affinare le capacità logiche.
La capacità di trovare convergenze e divergenze per affrontare in modo diverso uno stesso apprendimento è analoga in tutti gli ambiti della conoscenza, ma, poiché i contenuti delle discipline sono differenti, divergono le modalità di applicazione. Il ragionamento deduttivo segue un procedimento preciso; si applica nello stesso modo sia in italiano sia in matematica, ma differisce il contenuto, per cui, apparentemente, può apparire diverso.
Da qui la necessità di offrire uno strumento didattico specifico che favorisca l’applicazione delle capacità logiche in campo strettamente linguistico, ma con modalità che consentano di formare un habitus mentale.
Per riuscire a mettere ordine nelle conoscenze occorre essere padroni del codice che sottende alla disciplina stessa. Perciò i giochi linguistici e logici proposti in questo testo portano, gradatamente, il bambino a riflettere sullo strumento “lingua”, per coglierne gli usi e i significati.
Codice linguistico
Il possesso sicuro del codice linguistico porta il bambino e la bambina a organizzare meglio il proprio pensiero e li mette in grado di capire la struttura della parola, della frase, della narrazione. In questo percorso, attraverso “giochi” di osservazione, di manipolazione di parole, si vuole offrire una modalità di approccio alla lingua che sia soprattutto riflessione sulla parola inserita in un contesto, sia esso iconico o scritto.
Nello stesso modo la capacità di comprendere un testo non è considerata solo nella capacità di capire ciò che è palesemente raccontato, ma è un invito ad andare oltre la frase per arrivare a fare inferenze che consentano una comprensione più profonda e più adatta a formare schemi mentali esportabili.
Tutte le situazioni proposte scaturiscono da storie graduate per complessità e difficoltà che inducono il bambino e la bambina ad analizzare la situazione, cercando di comprendere i nessi e, se necessario, trovare una soluzione o, comunque, il modo più coerente per intervenire nella situazione e rappresentare ciò che in essa è contenuto al di là di quanto si può evincere dalla semplice lettura.
La finalità delle attività è quella di conseguire una capacità di elaborazione del pensiero che consenta di acquisire una metodologia di apprendimento spendibile in ambiti diversi.
L’acquisizione di un pensiero logico riguarda trasversalmente tutte le discipline poiché l’educazione logica non può essere oggetto di un insegnamento a se stante, bensì deve, al contrario, permeare tutto l’insegnamento.
Questo percorso è costituito da due serie di unità dedicate alla logica linguistica, strutturate su due livelli di difficoltà.
All’inizio di ogni serie di unità l’insegnante troverà alcune indicazioni metodologiche per realizzare meglio il lavoro proposto.
In tutti i casi i concetti logici sono introdotti gradualmente attraverso giochi che tengono conto sia delle conoscenze pregresse dei bambini e delle bambine sia della realtà in cui vivono, ma che stimolano anche il mondo della fantasia, che è parte integrante della loro realtà in età scolare.
Gli esercizi sono sempre inseriti in un contesto narrativo per indurre il bambino e la bambina a viverlo come “situazione”. Le proposte didattiche non sono accompagnate da una consegna precisa, perché il bambino e la bambina deveono imparare ad attivare capacità interpretative più che di semplice comprensione: deveono essere invitati a osservare il contesto in cui si muove il protagonista e a svolgere le sue stesse azioni, a entrare, quindi, nella situazione rappresentata.
La mancanza di una consegna di lavoro precisa invita il bambino e la bambina ad attivare maggiormente le loro capacità di decodificazione della realtà, comprensione del problema e scelta della risposta.
Nel proporre il lavoro, l’insegnante terrà ben presente che alcuni esercizi non sono facili e potrebbe succedere che alcuni alunni e alcune alunne, se non sono abituati a risolvere quesiti logici, non riescano a comprendere il lavoro richiesto o non siano in grado di rispondere alle richieste, sviluppando atteggiamenti di delusione e di sfiducia in se stessi/e. Nel caso in cui qualche bambino/a dovesse presentare difficoltà nell’individuare il compito da svolgere, l’insegnante lo/la inviterà a osservare e a leggere con maggiore attenzione, poi porrà delle domande stimolo atte a far comprendere la consegna. È bene che l’insegnante abbia un ruolo “discreto” di aiuto e di stimolo. Difficoltà e disagio possono essere evitati facilmente sottoponendo esercizi graduati. È bene spiegare alla classe che è importante anche solo provare a misurarsi con proposte differenti. Il fine non è solo trovare la soluzione ai quesiti del libro, ma, soprattutto, imparare a mettere in atto processi interpretativi e risolutivi diversificati e adatti alla situazione.
OBIETTIVI GENERALI
• Saper osservare e dedurre.
• Distinguere, riconoscere, classificare le caratteristiche di un oggetto, di un evento, di una storia.
• Ordinare secondo criteri (quantitativi e qualitativi).
• Stabilire e riconoscere relazioni e rapporti tra parole e tra situazioni.
• Sviluppare le abilità linguistiche.
• Sviluppare le abilità logiche.
• Favorire la crescita del senso critico.
• Saper rappresentare situazioni e procedimenti mentali.
OBIETTIVI SPECIFICI
Osservare
Riflettere sulla lingua
• Cogliere gli elementi incongrui in un testo iconografico.
• Osservare con attenzione per cogliere i particolari e i cambiamenti.
• Osservare con attenzione per cogliere le relazioni tra oggetti e personaggi.
• Riconoscere un elemento da alcune particolarità.
• Riconoscere gli elementi descritti in un testo.
• Riconoscere analogie e somiglianze.
• Saper fare deduzioni da immagini e testi.
• Riconoscere analogie e differenze.
• Riconoscere oggetti in contesti differenti.
• Osservare con attenzione per cogliere le differenze, le incongruenze, gli anacronismi.
• Riconoscere le informazioni date dagli enunciati.
• Riconoscere gli enunciati adatti alla situazione.
• Riconoscere elementi descritti attraverso connettivi logici.
• Fare inferenze.
• Cogliere le relazioni tra frasi e immagini.
• Risolvere indovinelli.
• Riflettere sulla struttura delle parole.
• Utilizzare le lettere per formare più parole.
• Riconoscere le lettere comuni a più parole.
• Comprendere le connessioni logiche tra parole.
• Collegare logicamente tra loro le parole.
• Utilizzare lettere e sillabe per formare nuove parole.
• Utilizzare lettere e sillabe per risolvere anagrammi, sciarade, rebus, giochi linguistici.
• Saper fare anagrammi.
• Riconoscere parole che contengono la stessa sillaba.
• Ricostruire parole suddivise in sillabe.
• Riconoscere criteri per la formazione di parole.
• Collegare i grafemi per ricostruire una frase di senso compiuto.
• Riconoscere campi semantici.
• Saper riconoscere parole in rima.
• Formare nuove parole togliendo o aggiungendo lettere e sillabe.
• Riflettere sul significato semantico di alcune espressioni di uso comune.
• Saper fare logogrifi.
Riflettere sul testo
• Riconoscere la giusta successione cronologica.
• Comprendere i rapporti causali.
• Inserire una sequenza nel posto logicamente adatto di un racconto.
• Riconoscere la sequenza mancante.
• Riconoscere e inserire in un racconto una frase mancante.
• Riconoscere elementi discordanti con la trama di un testo.
• Riconoscere l’idea essenziale di un testo.
• Leggere con attenzione per ricavare informazioni.
• Leggere con attenzione e collegare le informazioni.
• Leggere con attenzione e fare inferenze.
• Dedurre dal testo informazioni nascoste.
• Riconoscere le informazioni appropriate al tipo di testo.
• Discriminare le informazioni essenziali in una storia.
• Comprendere dal contesto il significato di un termine.
• Comprendere in quale contesto può essere inserito un termine.
• Inserire logicamente una parte mancante di un testo.
• Dedurre dal contesto il significato di parole o espressioni.
Approccio intuitivo
Le prime tre unità hanno come protagonisti rispettivamente una fata, un mago, una strega. Sono personaggi del mondo della fantasia che consentono un approccio intuitivo. Il bambino o la bambina non è, apparentemente, legato/a alla rigidità delle regole e, per questo, sarà più facile per lui/lei mettere in atto personali modalità di esecuzione delle attività proposte. Questo stratagemma consentirà di elaborare un percorso personale per arrivare alla soluzione.
L’attività più strettamente didattica è inserita in un contesto narrativo che serve a contestualizzarla e a formulare le consegne in modo indiretto. Il bambino e la bambina dovranno decodificare la parte regolativa del testo, che è una consegna implicita.
In questo modo si presentano livelli diversi di comprensione di un testo: la narrazione e la focalizzazione di ciò che deve essere fatto per la soluzione del quesito.
Talvolta non viene data la spiegazione di come si fa un esercizio perché è meglio che il bambino/la bambina tenti di capire da solo/a che cosa deve fare. Se dovesse incontrare difficoltà, l’insegnante dovrà intervenire con indicazioni più specifiche o suggerimenti. Sarà utile procedere a una correzione collettiva per confrontare i procedimenti seguiti e le soluzioni trovate.
Gli O.A. sono indicativi perché in ogni pagina gli obiettivi sono molteplici, soprattutto man mano che il livello diventa più alto.
La finalità della prima unità , che ha per protagonista fata Gigliola , è quella di stimolare a osservare e a dedurre. Il saper osservare con attenzione è infatti alla base di qualsiasi apprendimento e consente di effettuare deduzioni che portano all’elaborazione dell’apprendimento stesso.
Sono presentate attività che coniugano la capacità di cogliere i particolari con quella di dedurre da un’immagine o da un testo la chiave per eseguire il lavoro.
Le abilità che si vogliono stimolare sono: la capacità di osservazione, la classificazione, il riconoscimento di caratteristiche comuni, l’istituzione di relazioni; tutte capacità fondamentali e trasversali a qualsiasi apprendimento.
La finalità della seconda unità , con protagonista il mago Barnabà , è la manipolazione delle parole, destrutturate in fonemi o suoni per giungere alla composizione di nuove parole utilizzando gli stessi suoni oppure aggiungendone altri.
Sono proposte attività che richiedono capacità di osservazione e di analisi. Favoriscono l’arricchimento lessicale, la sincresi per la formazione di parole, la riflessione sulla struttura della parola.
La capacità di destrutturare una situazione per arrivare alla soluzione di un problema è generalmente considerata caratteristica della matematica, ma è applicabile anche alla lingua italiana e, in modo particolare, alla struttura delle parole.
La finalità della terza unità , che vede protagonista la streghetta Fliggy , è quella di guidare a una lettura e a una comprensione dei testi non funzionale solo alla ripetizione del contenuto o al riassunto o alla sintesi.
Cogliere la peculiarità di ogni testo è fondamentale per avviare a costruire un metodo per comprendere, enucleare le informazioni principali e dunque fare proprie le informazioni che sono contenute nel testo.
Gigliola ama vivere in mezzo al verde e svegliarsi al canto degli uccellini; per questo abita in una casa in mezzo a un grande parco. Ogni giorno lucida con molta cura le sue bacchette; Gigliola, infatti, è una fata! Ci sono molte altre cose che fa ogni giorno; ad esempio, le piace cucinare e, soprattutto, mangiare! Si diverte a chiacchierare con le sue amiche, a riposarsi sull’amaca e a fare giochi di logica. La settimana scorsa è andata a Fata City per comperare un cappello a punta e ha scattato alcune foto alla città. Ora ne sta osservando una e si accorge che in alcune insegne di negozi sono nascosti i nomi dei suoi amici e anche il suo.
La cosa la diverte: così chiederà alla sua amica Nerina di trovare le insegne con i nomi e di colorare i particolari evidenziati sotto.
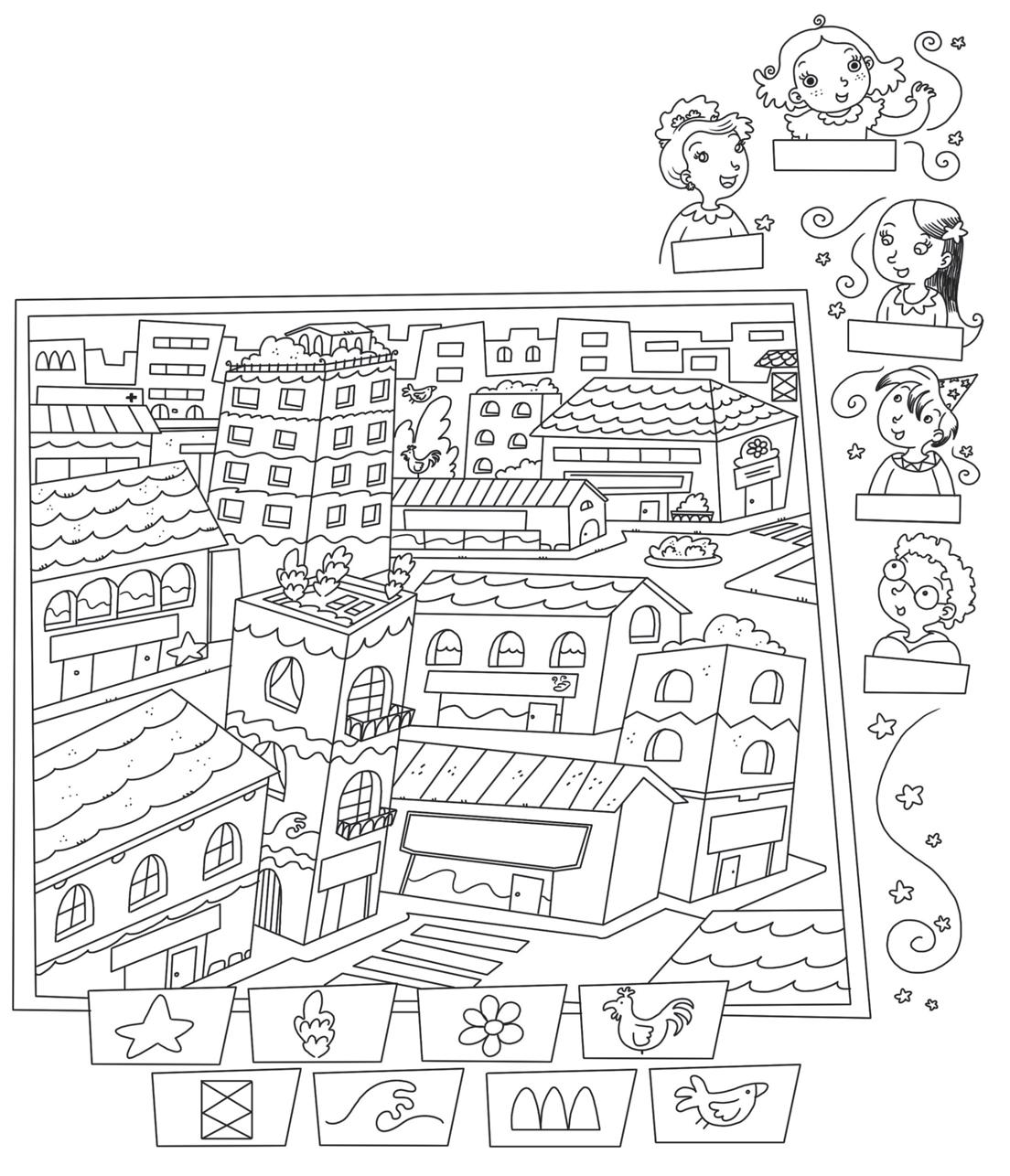
O.A.: osservare con attenzione per cogliere i particolari e i cambiamenti.
E ‘ UN OGGETTO DELLA CUCINA?
Andare a Fata City è sempre un’esperienza emozionante per Gigliola; tutto quel via vai di gente, le auto volanti che sfrecciano da ogni parte e poi… le vetrine dei negozi stracolme di oggetti interessantissimi!

HA UN MANICO?
E ‘ UNA VALIGIA?
E ‘ UNA BORSETTA?
HO CAPITO!
NO, SI PORTA
CON SE ’ QUANDO SI ESCE.
NO, NE HA DUE.
NO, E ‘ UN CONTENITORE PIU ‘ PICCOLO.
Ma, ahimè, Gigliola era così distratta da tutte quelle novità che ha perso un oggetto molto importante.
Per questo va all’Ufficio Oggetti Magici Smarriti a cercare ciò che ha perso.
Per capire bene ciò che Gigliola cerca, l’impiegato le fa alcune domande a cui lei risponde.
NON PROPRIO…
– Ciao Gigliola, guarda che cosa ho trovato! Possiamo fare un bellissimo gioco, dai sbrigati!
Quando Nerina ha in mente qualcosa non la ferma nessuno. È arrivata a casa di Gigliola come un uragano e adesso è impaziente di cominciare a giocare. – Arrivo subito, metto in forno l’arrosto e la torta e sono da te – dice Gigliola. Nerina ha portato due mazzi di figurine; ne tiene uno per sé e dà l’altro all’amica.
Ognuna delle due stende sul tavolone le proprie figurine. Il gioco consiste nell’accoppiarle logicamente e scrivere il numero corrispondente vicino a ogni lettera.
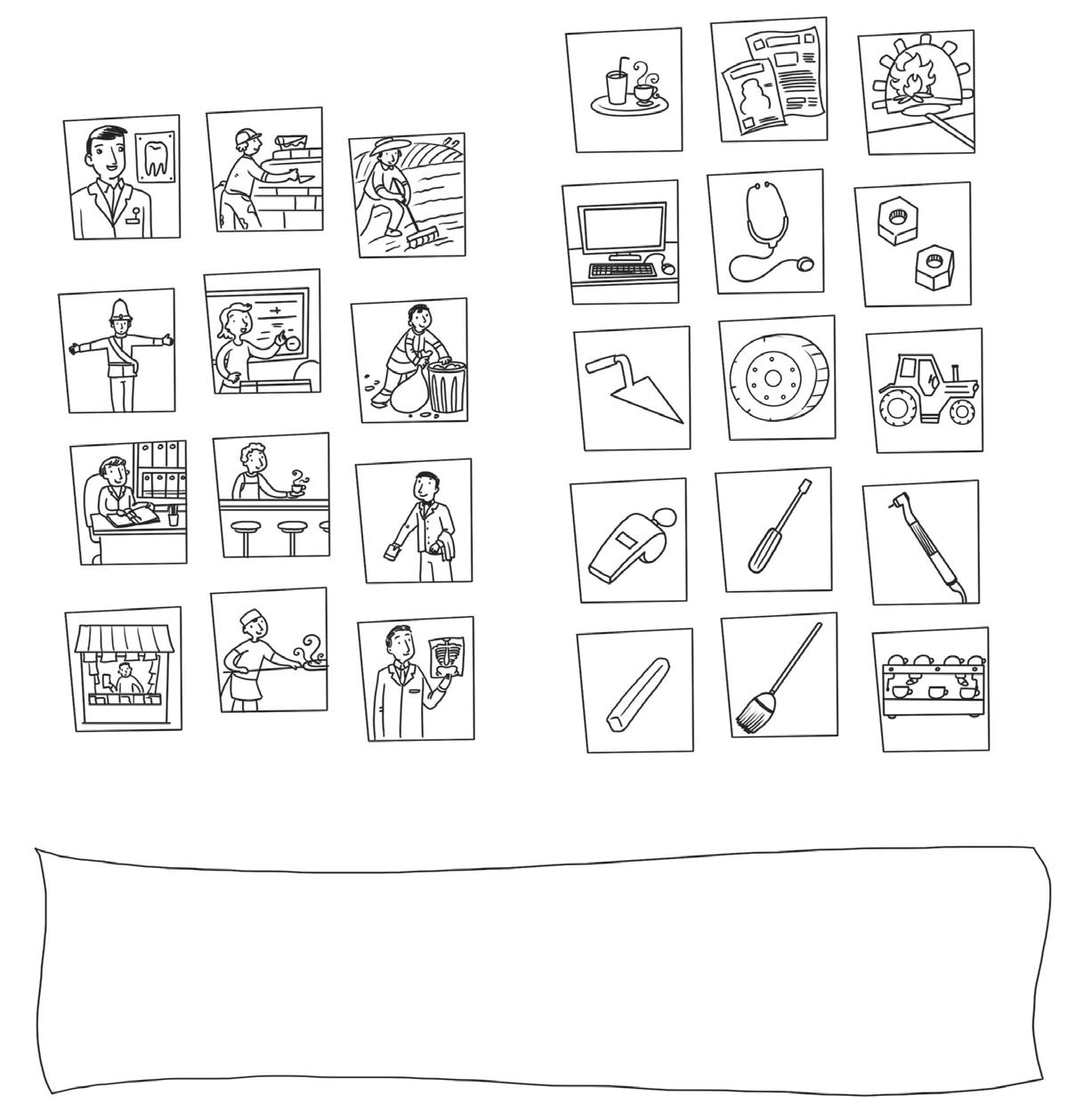
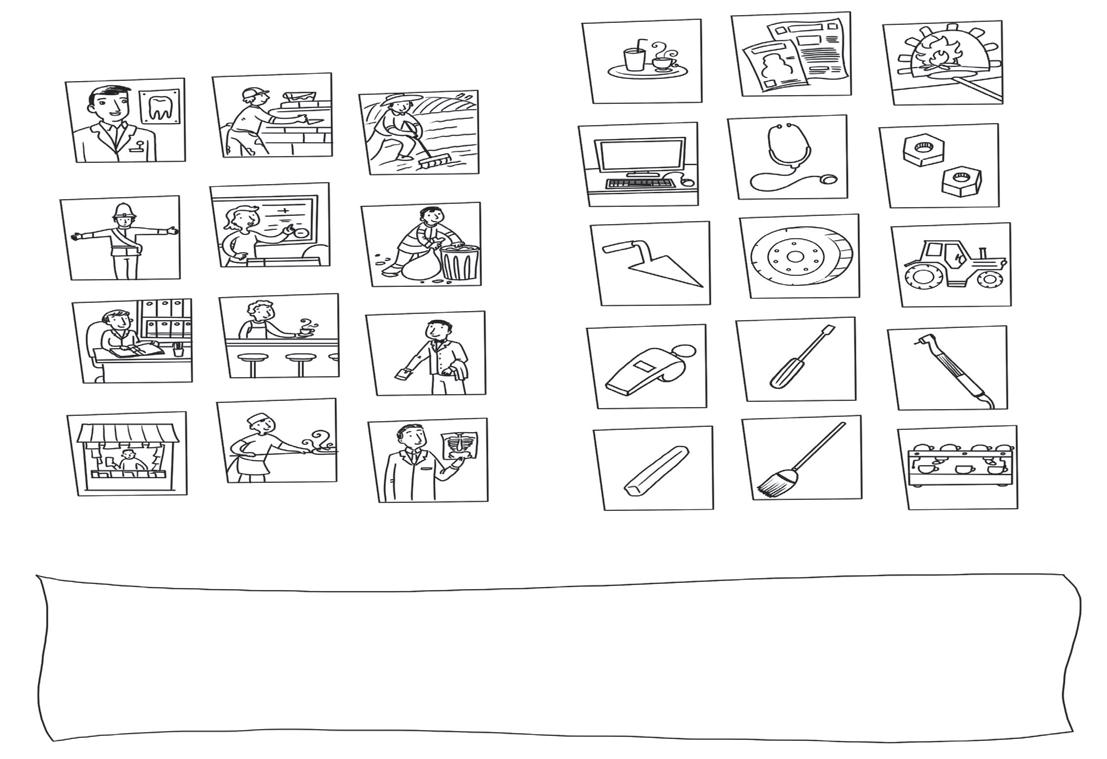
Alla fine del gioco avanzano tre figurine. Gigliola chiede a fata Nerina: – Se hai capito a che cosa servono tutti questi oggetti e chi, di solito, li usa, scrivilo su questo foglietto.
Nel parco di Gigliola è in corso l’evento della stagione: la festa all’aperto più rinomata del circondario. Essere invitate significa essere considerate fate importanti, dunque ognuna aspetta con trepidazione l’invito. Gli ospiti sono tanti, c’è anche la banda che suona; i tavoli sono stracolmi di ogni prelibatezza e le fate indossano abiti molto eleganti e fanno sfoggio di bacchette all’ultima moda. C’è persino una fata giornalista inviata del Magic Journal che sta prendendo appunti per l’articolo che uscirà domani.
I pettegolezzi da fare sono molti e, per non perdere tempo, la giornalista scrive sul suo taccuino delle frasi incomplete, che finirà poi con calma nella sede del giornale.

• Tre fate hanno lo stesso cappello. Sono
• Ci sono due fate che hanno lo stesso ricamo sulla gonna. Sono .
• Oh, oh! Ci sono due fate che sono vestite allo stesso modo, tranne per un particolare ( ).
• Guarda, quella fata ha una giacca nuova, è .
• Quelle bacchette vanno decisamente di moda, ce ne sono addirittura sei uguali! Le hanno .
Ogni tanto fata Gigliola va, in incognito, a curiosare nel mondo degli umani. Ha saputo che di domenica le scuole sono chiuse e i bambini con i loro genitori vanno spesso ai giardini dove, grandi e piccini, possono giocare insieme. Gigliola sta telefonando a Mirtilla e le racconta che domenica scorsa ai giardini della città degli umani ha visto un gruppo di padri e di figli che si assomigliavano in maniera straordinaria. – Ho un’idea! – continua Gigliola – Ti faccio il disegno di ciò che ho visto e tu colori nello stesso modo ogni padre e il rispettivo figlio.
Qualche giorno dopo, Mirtilla va da fata Gigliola con il disegno colorato e le dice: – Ci sono tre bambini di cui non si vede il padre. Io, però, ho scoperto che hanno qualcosa in comune. Guarda e dimmi che cosa pensi.

tre bambini di cui non si vede il padre sono:
riconoscere analogie e somiglianze.
Anche per le fate non sempre la vita è facile! Devono vedersela con spiritelli malvagi, orchi, gnometti crudeli… Nel laboratorio, sulla torre della sua casa, Gigliola tiene, ben custodito, il suo oggetto più prezioso: il librone di nonno Aristide. È un librone magico nel quale la fata trova la soluzione a tutti i problemi. Purtroppo si è accorta che nella pagina dedicata ai folletti, tra tanti buoni, se ne è nascosto uno maligno. Bisogna individuarlo subito e cacciarlo, altrimenti potrebbe causare un sacco di danni: modificare le formule, mangiarsi le parole o, addirittura, le pagine!
Gigliola sa come riconoscerlo: sarà la sua ombra a tradirlo. I folletti maligni, infatti, hanno l’ombra leggermente diversa da sé.
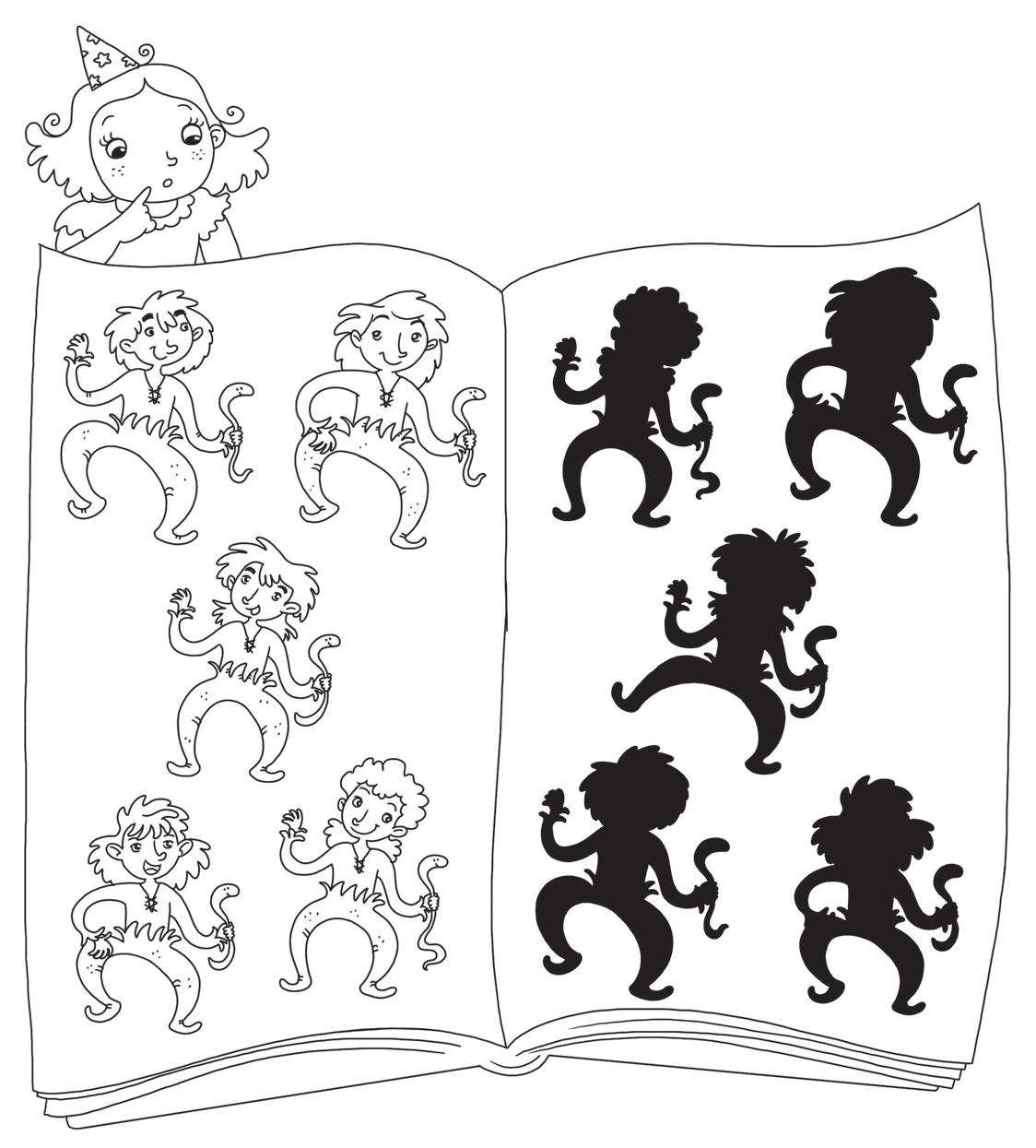
1 2 3 4 5
Il folletto maligno è . La sua ombra è la numero .
Da quando Gigliola si è trasferita a Fata City non ha più avuto occasione di vedere le sue amiche di un tempo. Che nostalgia! Ma lei non si perde d’animo e così ha invitato le sue cinque amiche a un happy hour in un elegante locale del centro. Le fate hanno accettato l’invito con entusiasmo. – Sarà una fantastica occasione per chiacchierare e ricordare il tempo passato insieme – le hanno detto. Fata Gigliola ha prenotato una saletta riservata e ha chiesto al barista, suo amico, di preparare dei simpatici cartellini su cui segnare il nome di ciascuna amica. Che emozione questo incontro! I cartellini, però, non sono ancora pronti; il barista ascolta attentamente ciò che le fate dicono e, in questo modo, riesce a scrivere il nome giusto su ogni cartellino.
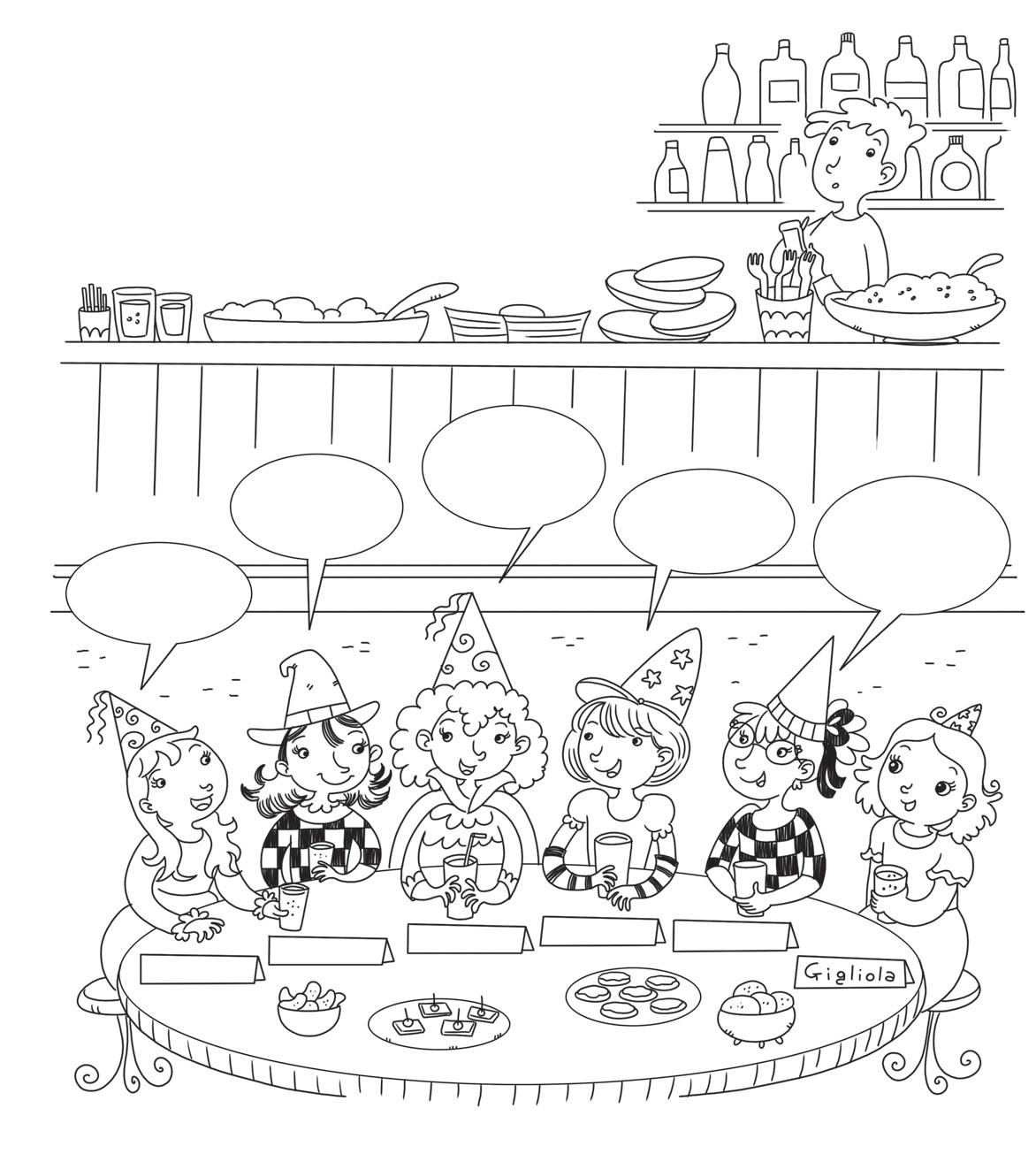
SOAVE HA
IL CAPPELLO COME IL MIO.
GLADIS HA IL MANTELLO.
IRMA HA IL VESTITO A QUADRI.
VERA HA GLI OCCHIALI.
IO NON SONO IRMA E LEDA HA I GUANTI.
O.A.: riconoscere elementi descritti attraverso connettivi logici.
Nerina è la solita pasticciona: anche ieri ne ha combinata una delle sue. Gigliola non avrebbe mai pensato che una semplice passeggiata nel parco potesse risolversi in un disastro; e invece sì. Le due amiche avevano deciso di fare un po’ di jogging per mantenersi in forma; ciascuna di loro aveva una borsetta in cui sistemare tutto l’indispensabile, ma la bacchetta proprio non ci stava e, mentre Gigliola aveva rinunciato a portarla, Nerina se la teneva ben stretta in mano. A un tratto… una radice che sporge, un piede che inciampa, la bacchetta che cade nel modo sbagliato e… quando Nerina si guarda intorno, si accorge che la sua bacchetta ha combinato dieci guai.
Gigliola li individua e, come al solito, rimette tutto a posto.
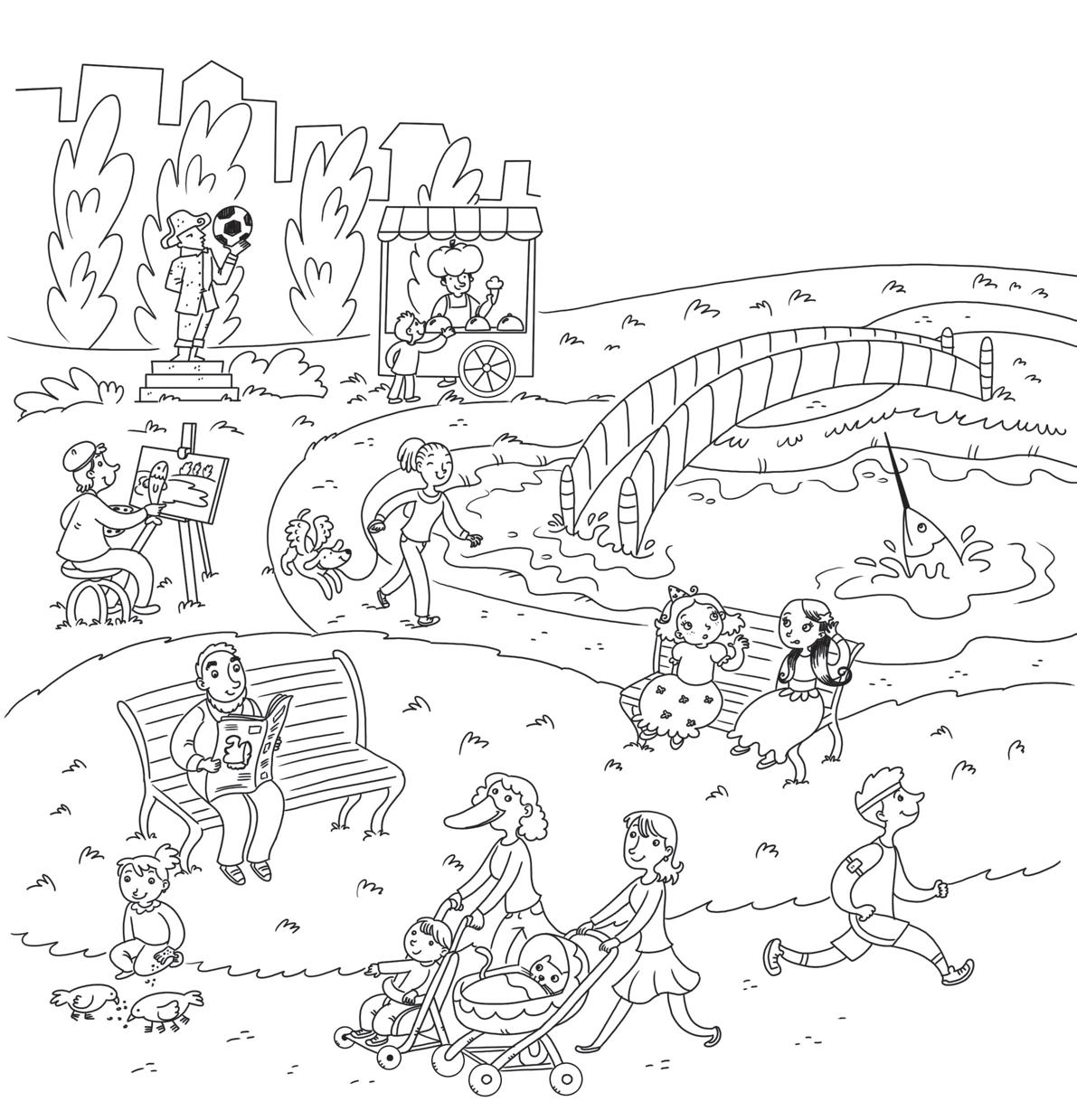
In un moderno palazzo vicino al parco cittadino si è da poco trasferito un simpatico giovanotto. Il suo appartamento è al pian terreno e, nell’angolo accanto al camino, vi è una scala che scende nel sotterraneo in cui Barnabà ha il suo laboratorio. Per la verità, è un laboratorio un po’ particolare: Barnabà, infatti, è un mago! Sulla porta vuole mettere un cartello su cui scriverà una frase misteriosa.
Ma per trovare la frase è necessario fare un gioco.
Ci sono 10 schemi, ognuno formato da 5 gruppi di lettere. Il gruppo centrale manca; lo deve scrivere il mago usando le lettere necessarie per formare due parole.
Infine Barnabà dovrà riportare nel suo cartello i gruppi di lettere che ha scritto sistemandoli in modo da formare una frase.

Barnabà ha ricevuto una comunicazione dall’associazione Grandi Maghi: poiché ha superato brillantemente le prove previste, ha acquisito il diritto ad avere un’assistente. Barnabà è ansioso di riceverla e ha già preparato la sua scrivania; il nome dell’assistente, però, non gli è stato comunicato e il cartellino è rimasto vuoto. Una forte scampanellata lo distoglie dai suoi pensieri; apre la porta e entra… una specie di tornado carico di bagagli!
– Come ti chiami? – chiede Barnabà.
L’assistente risponde: – Non è così semplice scoprire il mio nome! Dovrai prima risolvere questo quiz. Io ti do degli insiemi di parole e in ciascuno dovrai trovare l’intruso. Mettendo in ordine le lettere iniziali dei nomi degli intrusi, potrai completare il mio nome sul cartellino.
aeroplano aria volare ali
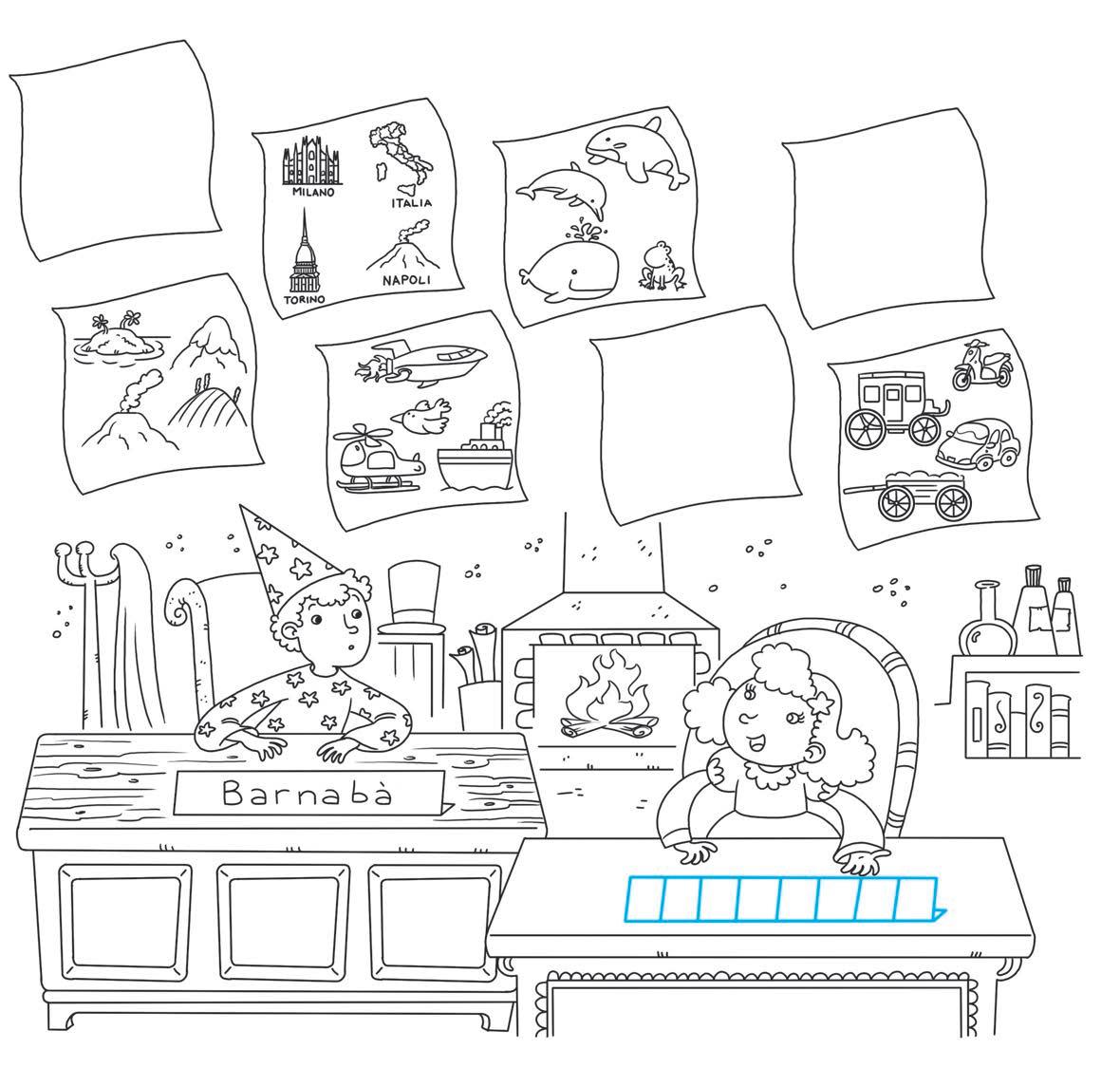
Tutti sanno che Barnabà è un ottimo mago e anche un bravo insegnante per la sua assistente Virginia. Quest’ultima, però, non ha pazienza: vorrebbe fare tre magie alla volta e così combina spesso dei grossi pasticci. Barnabà le spiega che è necessario rimediare a tutti i danni provocati e che, per fare ciò, serve la parola magica. Trovarla non sarà semplice!
Virginia dovrà osservare attentamente i disegni della scheda ed eliminare le 12 coppie il cui nome finisce o inizia con le stesse tre lettere.

Ad esempio: BACHI CHIAVI

Le iniziali dei nomi delle sei figure rimaste, combinate nel modo giusto, daranno la formula magica che serve per riparare i danni.
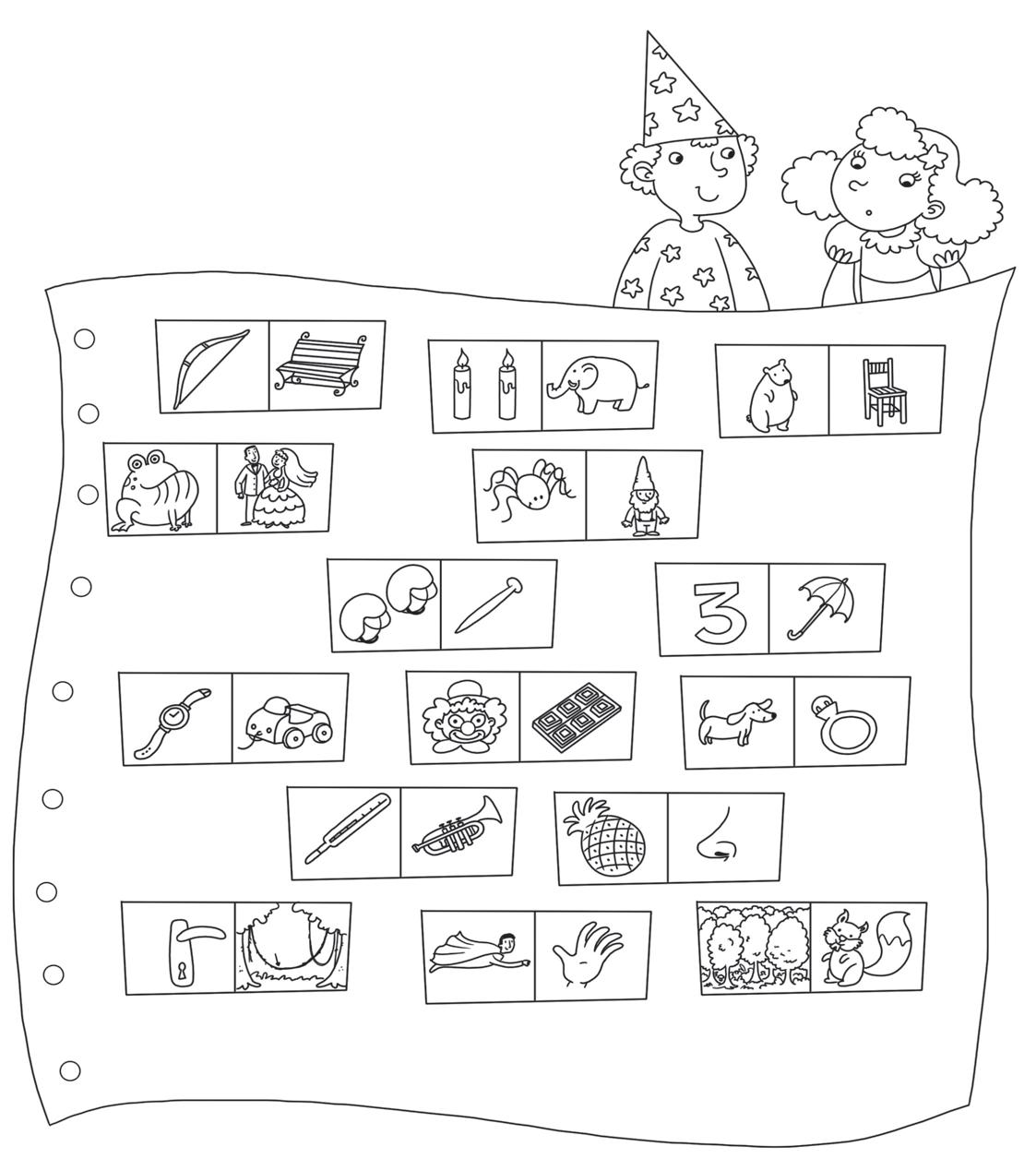

Nel salotto di casa, Virginia racconta a Barnabà che un giorno, alla Scuola Primaria di magia, aveva dovuto svolgere un compito un po’ difficile per lei e ora lo sottopone al mago. Prima, però, gli spiega le regole.
Ci sono 12 parole: la prima e l’ultima sono scritte in un riquadro con la cornice e si deve partire dalla prima per arrivare all’ultima seguendo queste indicazioni:
• la parola successiva può essere un anagramma della precedente oppure un sinonimo o un contrario;
• una sola lettera può essere stata cambiata, aggiunta o tolta;
• la parola precedente può avere un collegamento logico con la successiva.

CAPPELLO • PESCE • QUADRO • SOLIDO • MURO • MARTELLO • EURO • CILINDRO • PARETE • SOLDO • CHIODO • MONETA
1. CAPPELLO 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PESCE
Barnabà, dopo aver risolto la catena di parole, dice a Virginia: – Adesso tocca a te!
Usa le parole n. 8, 9 e 11 per formare una frase e scrivila su questo quaderno.
O.A.: collegare logicamente tra loro le parole.
Sul grande tavolone del laboratorio ci sono dieci grossi nodi. – A che cosa servono tutti questi nodi? – chiede Virginia incuriosita. – Hai deciso di fare il marinaio?
Barnabà la guarda con aria severa e le risponde: – Invece di fare la spiritosa, osserva bene e ti accorgerai che solamente quattro di questi pezzi di corda formano altrettanti nodi; gli altri sei, invece, non sono nodi.
Quando avrai scoperto i nodi, scrivi nei riquadri la lettera che li contraddistingue.

Virginia si chiede a che cosa serviranno quelle lettere, ma ecco che Barnabà con sole quattro lettere forma ben cinque parole!
Davvero una magia…
Un sentimento:
Una città:
Un nome di persona:
Un frutto:
Una parte dell’albero:
Virginia ha una richiesta da fare al mago, ma non osa; allora ricorre a uno stratagemma: gli sottopone un rebus. Barnabà è un mago, lo risolverà sicuramente!
(5 – 7)
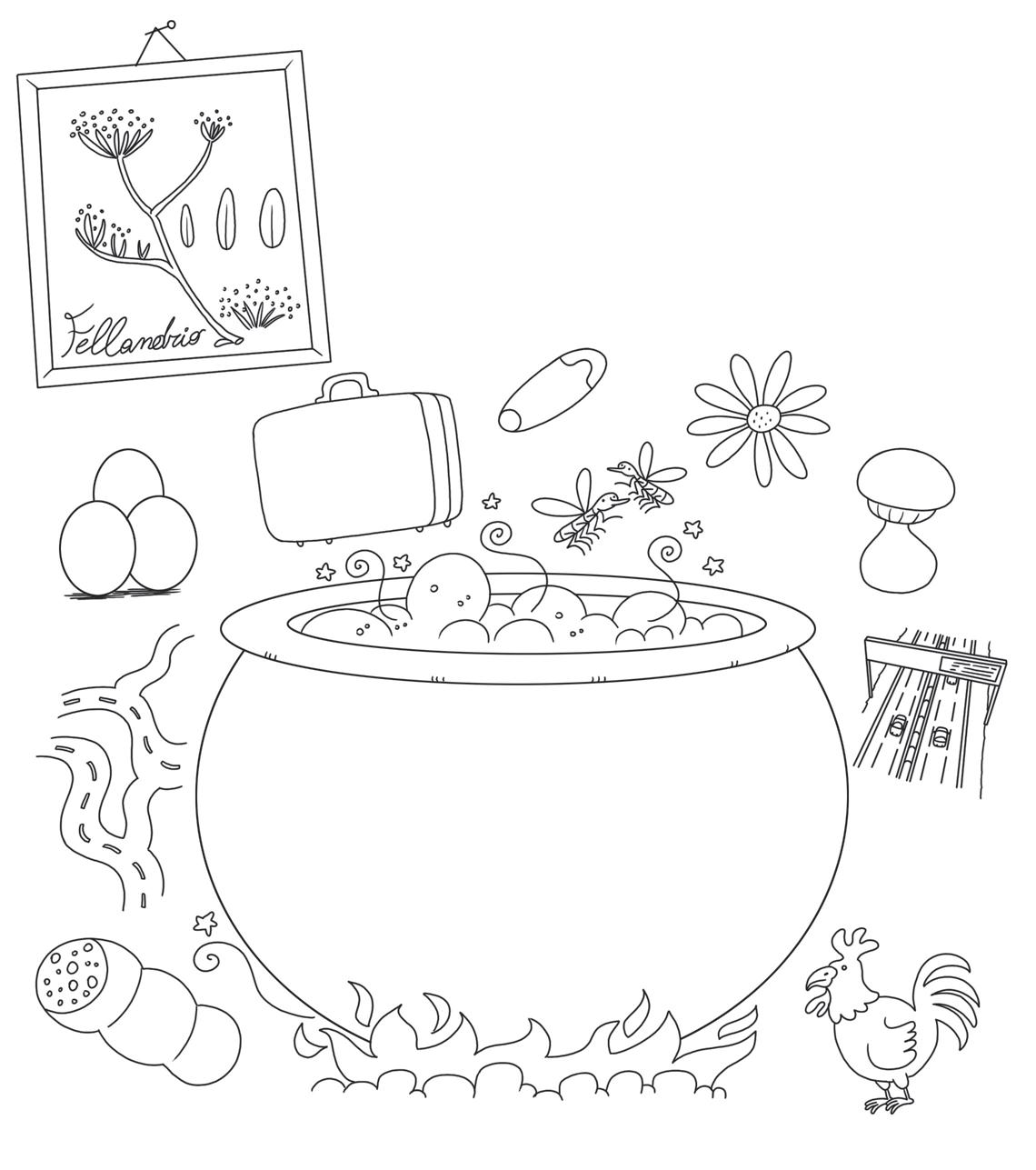
Da almeno sei ore c’è qualcosa che bolle dentro un pentolone. Barnabà dà una mescolata, poi apre i cassetti dell’armadio e toglie qualcosa che butta nel pentolone. A un tratto si batte la mano sulla fronte ed esclama: – Mi mancano i semi di fellandrio!
Senza semi di fellandrio… addio pozione!
Virginia, però, sa da chi andare per averli, ma Barnabà avrà questa informazione solo se sarà in grado di risolvere questo gioco. Deve scrivere nello schema i nomi dei disegni intorno al pentolone. L’informazione apparirà nelle caselle colorate.
L’informazione è: . Appena ricevuta l’informazione necessaria, Barnabà si precipita fuori di casa. Virginia prende il suo quaderno e scrive che cosa pensa possa succedere. 6 4 1 2 7 3
O.A.: utilizzare lettere e sillabe per risolvere giochi linguistici.
Finalmente i semi di fellandrio sono stati trovati, ma per completare la pozione servono altri due ingredienti. – Virginia, gli ingredienti mancanti sono ali di… e code di… Non mi ricordo di chi, e tu?
– Io sì, caro il mio mago, ma per saperlo dovrai risolvere questi enigmi! Questo è il primo: a simbolo uguale corrisponde lettera uguale. Completato lo schema, nella prima colonna scoprirai di chi sono le ali. – Ecco il secondo enigma per scoprire di chi sono le code. Cancella nello schema le seguenti parole e lo leggerai nelle caselle rimaste.
Le ali sono di . alce • cilindro • civetta • dolce • imbuto • magia • ombra • ricordo • tana • tavolo • vanga
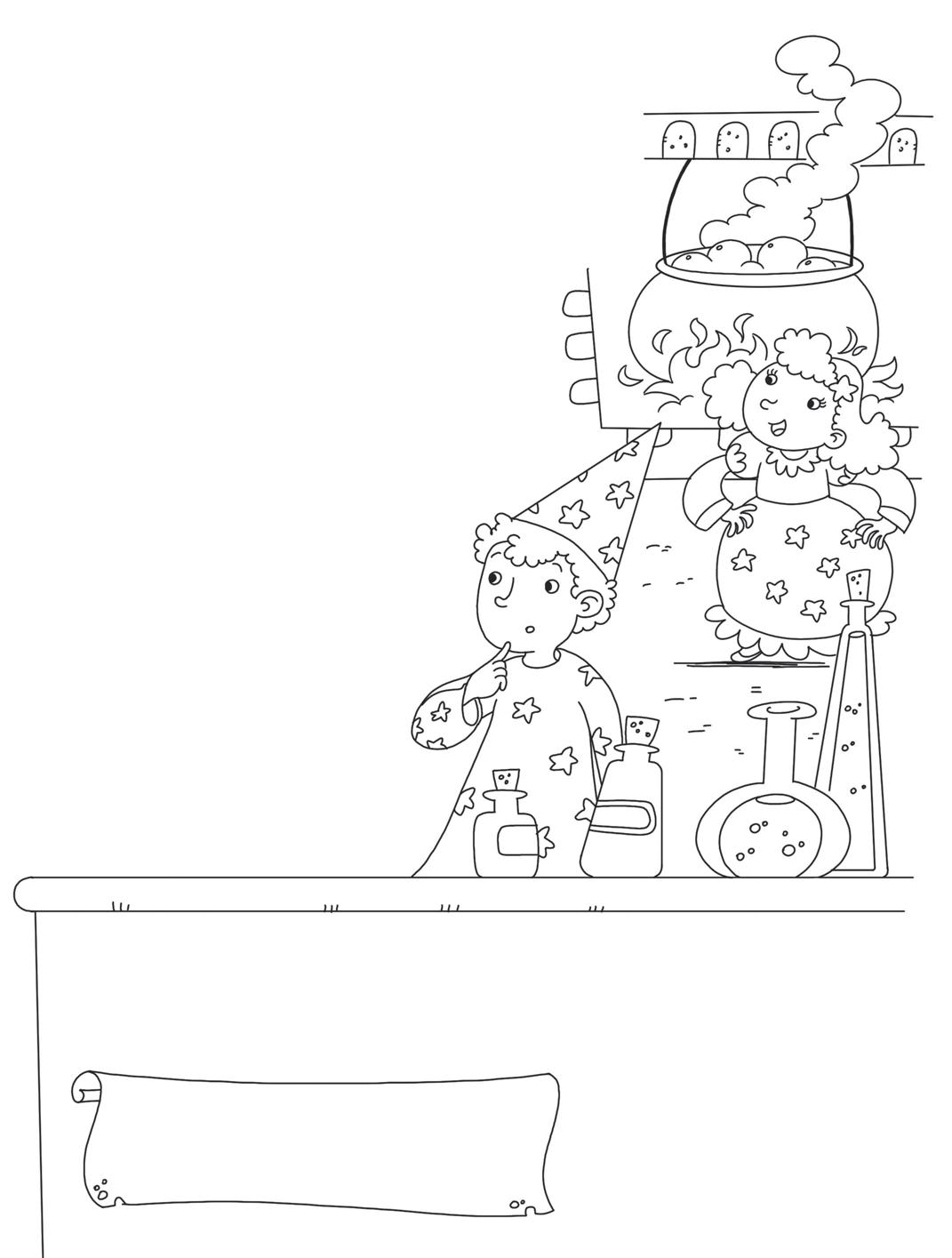
Le code sono di
O.A.: utilizzare lettere e sillabe per risolvere giochi linguistici.
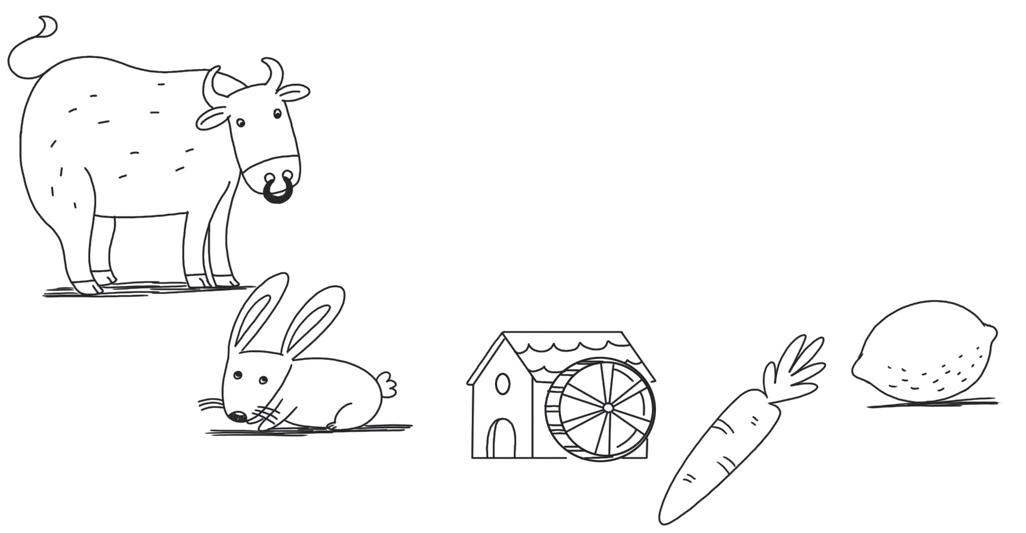
Il grande pentolone è sul fuoco ormai da ore, ma dovrà bollire ancora per tanto tempo. – Sei davvero un grande mago! – dice Virginia. – Questa pozione per non bagnarsi quando piove è un portento! Non avremo più bisogno né di ombrelli né di impermeabili. Mentre la pozione bolle, il mago e Virginia giocano: si stanno proprio divertendo!
Vincerà questo gioco chi saprà collegare ogni figura all’anagramma del suo nome.
– Brava Virginia, questa volta mi hai battuto! – dice Barnabà. – Ma ora ti propongo un’altra sfida. In questo gioco si deve scrivere il nome del soggetto disegnato; poi bisogna togliere le lettere indicate; le lettere rimanenti vanno scritte sotto al disegno e, infine, vanno inserite nello schema per formare una frase.
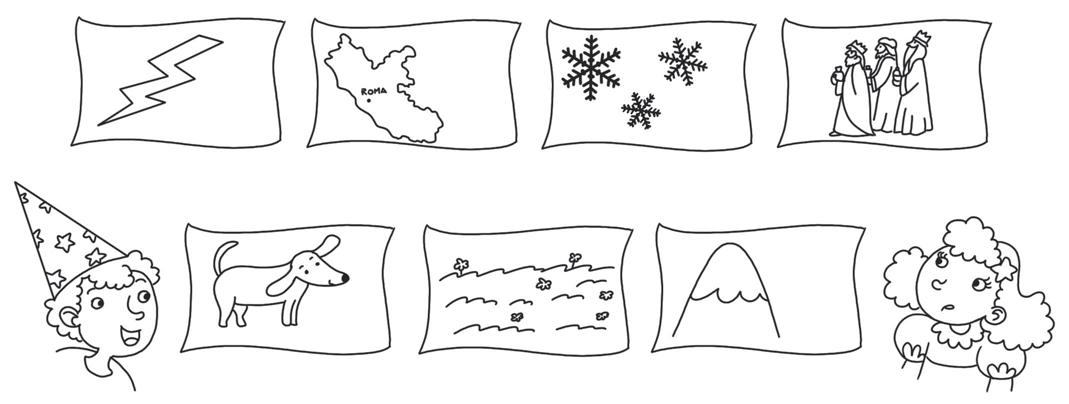
Barnabà esclama: – Ho vinto io! La frase è:
O.A.: saper fare anagrammi.
A vederla camminare per strada nessuno penserebbe che quella ragazza vestita con i jeans e con in testa un cappello a cilindro con un nastro viola sia una strega. Ma Fliggy, questo è il nome della ragazza, è proprio una strega; solo che, anziché la bacchetta magica, usa il telecomando, e non cavalca una scopa di saggina, ma una moderna scopa a motore. Questa notte ha invitato nella nuova casa in cui abita da cinque mesi le sue amiche, per la festa di inaugurazione. Fliggy ha detto a Berto, il portinaio, di fermare le invitate nell’atrio e di farle salire tutte insieme.
Ora sono arrivate tutte e, sentendole parlare, Berto capisce che alcune mentono e non sono amiche di Fliggy. Scrive il nome di ognuna su un taccuino e accanto scrive V se dice la verità, B se dice una bugia. Poi citofona alla streghetta per sapere se può farle salire.

ABITA QUI
SOLO DA UN LUSTRO E GIA ‘ HA FATTO CAMBIAMENTI IN CASA.
NON HO INDOSSATO
IL MIO VESTITO DA STREGA, MA SO CHE PER FLIGGY NON CONTA L’ABBIGLIAMENTO TIPICO DA STREGA.
SONO CURIOSA DI SALIRE. FLIGGY AMA IL VIOLA, SCOMMETTO CHE LE PARETI SARANNO DI QUESTO COLORE!
L’HO VISTA PASSARE IERI SUL COMIGNOLO DI CASA MIA. HA ANCORA LA VECCHIA SCOPA; INVECE DI CAMBIARE CASA, AVREBBE DOVUTO CAMBIARE SCOPA!
HO SCORDATO LA MIA BACCHETTA MAGICA! BEH, INSERIRO ‘ IL MIO CODICE NEL TELECOMANDO DI FLIGGY!
AH! QUEL SIMPATICO
SIGNORE E ‘ IL PORTIERE DI CUI MI HA PARLATO FLIGGY.
Berto ha citofonato a Fliggy dicendole che tra le streghe arrivate ci sono alcune intruse, ma lei ha deciso di accoglierle ugualmente. Se erano curiose di vedere la sua casa e di conoscerla… eccole accontentate! Se si dimostreranno simpatiche, avrà qualche nuova amica; diversamente non varcheranno più quella porta.
Fliggy le fa accomodare nel grande salotto con la vetrata, che ha una splendida vista sulla città: – Carissime, sono proprio felice che siate venute tutte. Vorrei per prima cosa conoscere il nome delle nuove amiche, spero vi troviate bene qui da me.
Vi voglio dire quali sono le abitudini delle nostre feste.
• Chi ha fame troverà i tramezzini nel frigorifero.
• Volendo, alcune di voi potranno esibirsi con le loro magie.
• Attente, non c’è magia che Milù non possa fare.
• La festa non finirà prima dell’alba.
Buon divertimento!
Priscilla, una strega perfida e invidiosa, si chiede quale sia la frase che ha il significato corretto.
A tutte verranno dati i tramezzini che sono nel frigorifero.
Se qualche strega ha fame, può prendere da sola i tramezzini nel frigorifero.
Se qualche strega ha fame, può chiedere di avere i tramezzini che sono nel frigorifero.
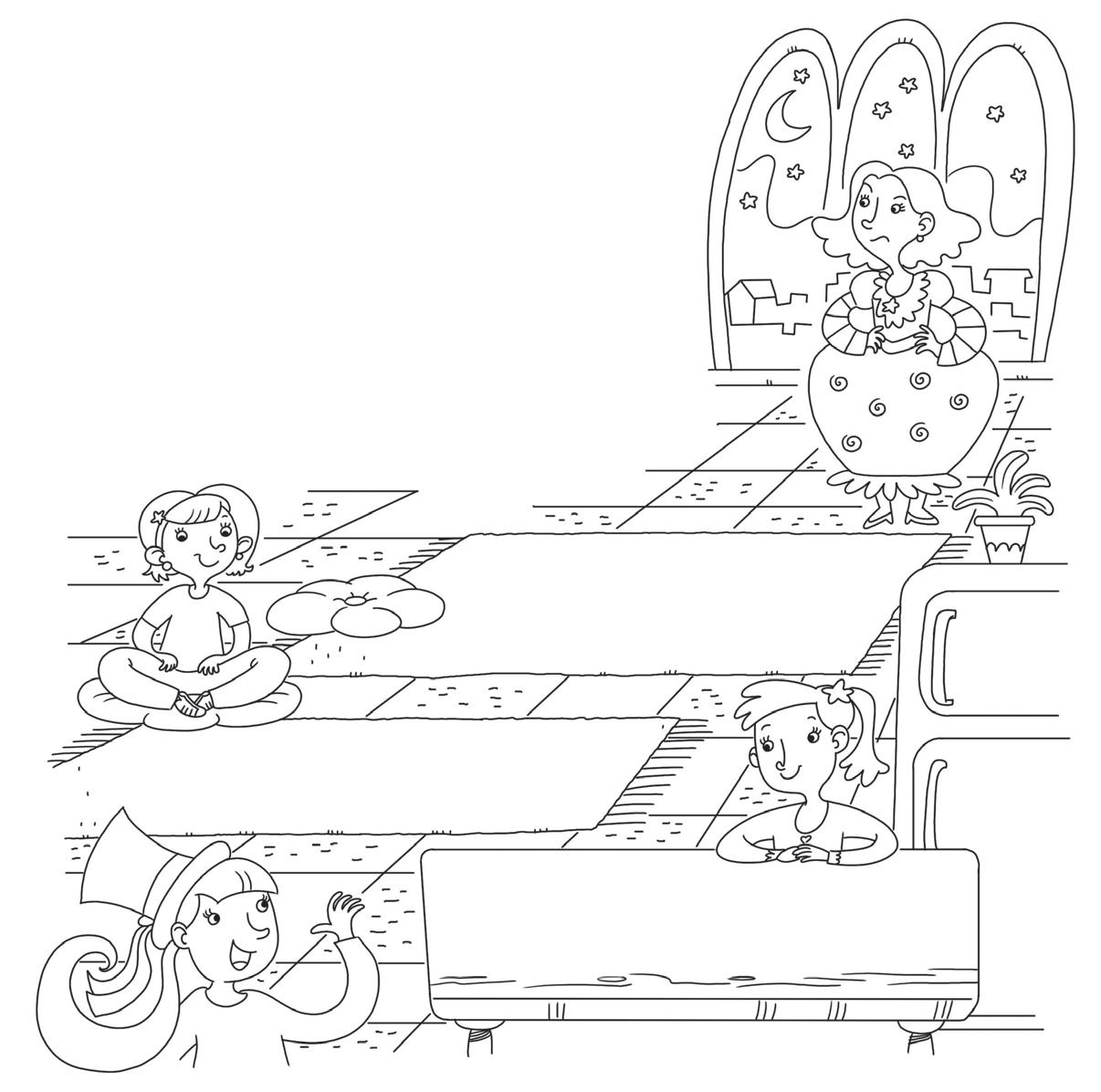
Alcune streghe dovranno fare magie.
Qualche strega non dovrà fare magie.
Le streghe che lo desiderano avranno la possibilità di fare magie.
Alcune magie per Milù sono impossibili.
Ogni tipo di magia non è difficile per Milù.
Milù non sa fare tutte le magie.
La festa finirà prima che spunti il sole.
La festa finirà dopo che è spuntato il sole.
La festa non finirà prima che faccia buio.
Fliggy ritira dalla casella della posta una lettera. All’interno c’è un invito per partecipare a un convegno di maghi e streghe. – Ciao, Berto, leggi questo originale invito.
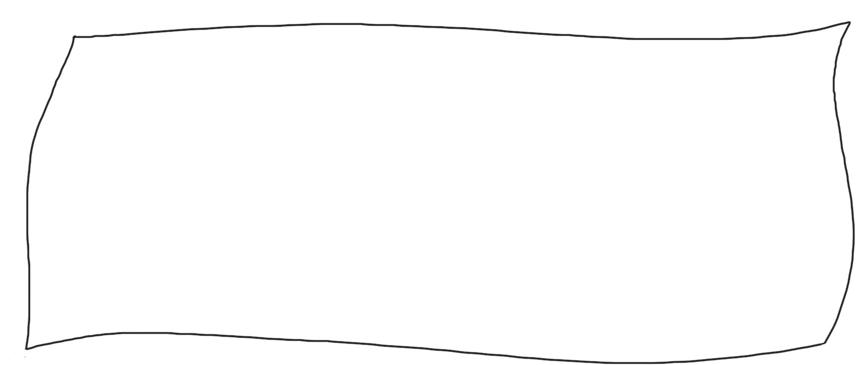

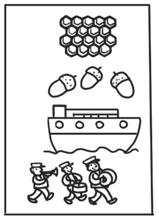
La signoria vostra è invitata al Convegno di Fate, Maghi e Streghe che si terrà a Magicland il 7 ottobre.
Potrà accedere al salone d’onore solo se avrà scoperto di quale dei due racconti è protagonista il personaggio il cui nome è celato in questo gioco. Unisca ciascuna delle figure di sinistra a una di quelle di destra che abbia attinenza con essa. Le terze lettere delle figure di destra formeranno il nome del personaggio. Il giusto ordine è dato dalla posizione nei riquadri a sinistra. Il nome del personaggio è ________ . Il racconto è il numero .

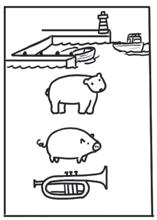
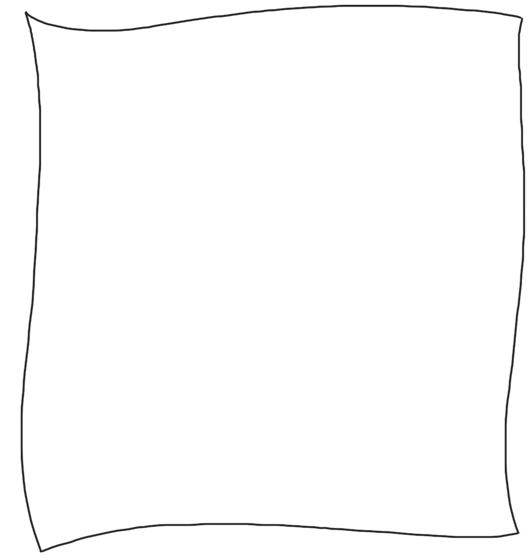
Un gruppo di streghe si recò una notte sotto la grande quercia. Dovevano fare un rito propiziatorio per far scaturire dalla montagna una sorgente d’acqua con magici effetti per ringiovanire chiunque ne avesse bevuto un bicchiere. A un tratto si sentì un boato, si levò da terra una nuvola di fumo dalla quale proveniva una voce: – Un mio nemico, nel passato, tra le rocce, mi ha intrappolato. Voi mi avete liberato e per questo vi sono grato. Per voi una magia farò e quell’acqua vi darò. Sparì la nuvola, l’acqua cominciò a sgorgare e, accanto alle streghe, apparve un cesto di rose.
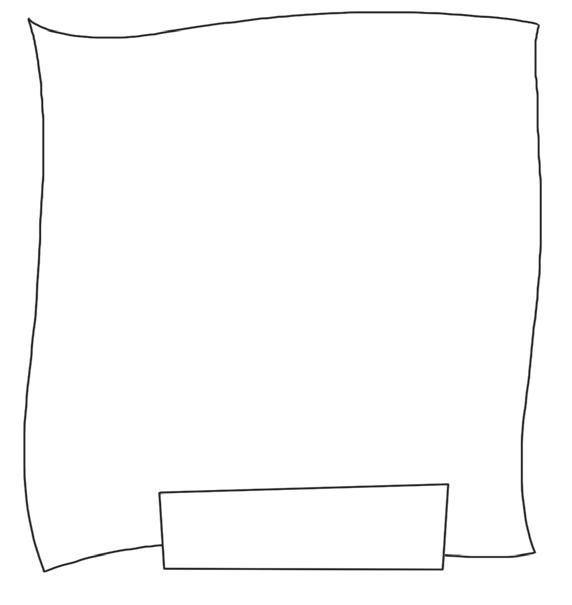
Un gruppo di streghe si recò una notte sotto la grande quercia. Dovevano fare un rito propiziatorio per far scaturire dalla montagna una sorgente d’acqua con magici effetti per ringiovanire chiunque ne avesse bevuto un bicchiere. A un tratto si sentì un boato, si levò da terra una nuvola di fumo dalla quale proveniva una voce: – Se quell’acqua voi volete, un caro prezzo pagherete. Basta che qualcuno paghi, sono più bravo di dieci maghi, ma non sono un mago. Sparì la nuvola, l’acqua cominciò a sgorgare e, accanto alle streghe, apparve un cesto vuoto con un biglietto:
Versare 1000 denari.
Fliggy ha parcheggiato la sua scopa nel parcheggio accanto al salone dei congressi. Orgogliosa, mostra l’invito con la soluzione. Il gran cerimoniere batte tre volte il bastone a terra per annunciarla ai presenti e poi le consegna un altro cartoncino:

La frase è: 3 6 4 5
Fliggy, hai superato il primo test.
Tu non hai mai partecipato ai nostri convegni e dobbiamo metterti alla prova prima di accoglierti come membro onorario dell’Associazione
Internazionale di Fate, Maghi e Streghe. Se risolverai il nuovo gioco sarai dei nostri!
Dai un nome a ciascuna figura e prendi, nell’ordine, tutte le lettere indicate dai numeri.
Otterrai una frase.
Scrivila e segna con una X in quale punto del racconto può essere inserita.
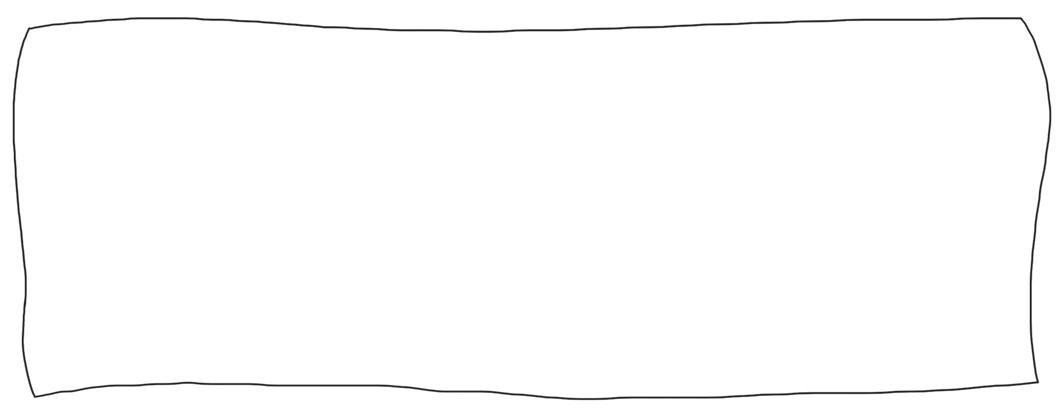
Nelle cupe e fredde foreste del nord vive Gelinda, una strega che deve il suo nome al fatto che riesce a ottenere filtri che resistono a bassissime temperature e non gelano mai. Ieri sera si è presentato alla sua porta Mago Gelo. – Ciao Gelinda! – Ciao Mago Gelo, che ci fai qui? Non ho bisogno di un frigorifero ambulante per trasportare le mie pozioni.
– Ti ci metti anche tu! Non mi va proprio di scherzare! Sono stufo di essere allontanato dalle feste e dai ristoranti perché emano un gran freddo.
Anche la mia fidanzata mi ha lasciato perché non vuole più mettersi quattro maglioni per abbracciarmi!
Preparami una delle tue pozioni. Se ne berrò in quantità sarò meno gelato!
Fliggy ha risolto il quesito ed è entrata a far parte dell’Associazione. Il gran cerimoniere l’accompagna nel salone dove si sono radunati i maghi e le streghe in attesa che inizi il convegno. Tutti stanno chiacchierando e all’orecchio della streghetta arrivano alcune parole che i presenti si scambiano.
Fliggy osserva le persone e riesce ad attribuire a ciascuna le parole che pronuncia.
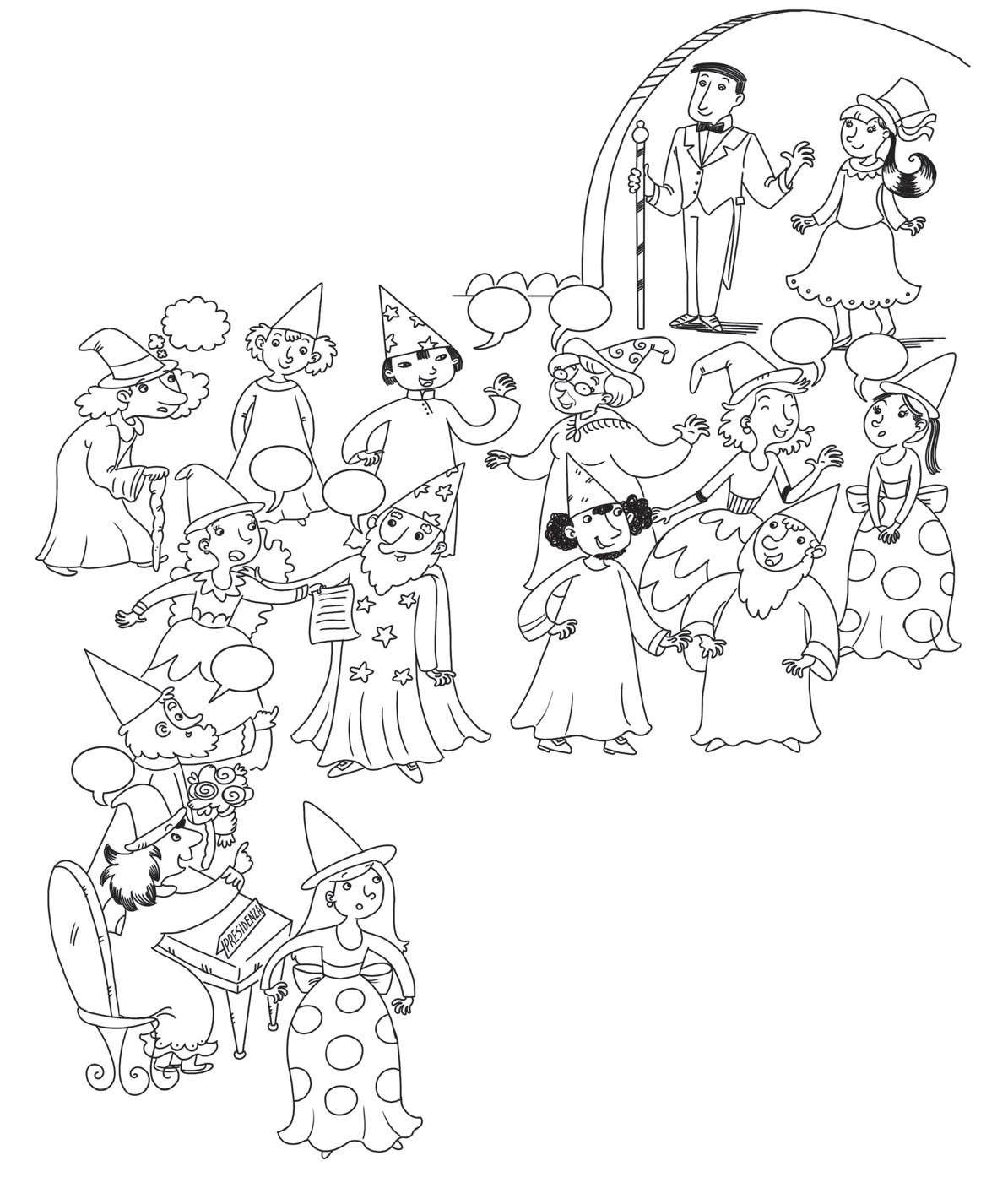
A. In qualità di presidentessa delle streghe, ti seguo.
B. Ma lo sai quasi a memoria! Rilassati!
C. Ti invito a Pechino per il 14 gennaio.
D. Chissà dove posso trovare una sedia libera… Mi fa male la gamba.
E. Devo ripassare il mio discorso di benvenuto.
F. Hai deciso dove sederti durante il convegno?
G. In qualità di presidente dei maghi, vado ad accogliere la nuova arrivata!
H. Mi spiace, ma proprio quel giorno compie gli anni il mio nipotino.
I. Non voglio stare vicino a Priscilla, crederanno che siamo gemelle!
Fliggy ha invitato le sue amiche Rebecca, Malica e Ludmilla. Offre loro un tè e poi inizia a raccontare un episodio al quale ha assistito.
La perfida strega Priscilla aveva chiesto alla sua civetta Diavolonero di aiutarla a catturare il grande Topogrigio.
Topogrigio, infatti, era ricercato da tutte le streghe maligne, che volevano utilizzarlo nella preparazione di una superpozione magica.
La civetta si era accorta che Topogrigio, prima di assalire qualsiasi animale, si accertava che dormisse o fosse morto, mordicchiandolo o dando colpetti con il muso, pronto, in ogni caso, a fuggire.
“Ecco il momento buono; adesso ci provo!”pensò la civetta. Piano piano, senza fare rumore, si mise distesa a terra restando immobile con il capo reclinato da una parte; sembrava morta.
Il grande topo era in perlustrazione, la vide, si avvicinò e cominciò a mordicchiarla piano piano. Diavolonero voltò di scatto la testa e con il suo becco lo ferì su un fianco. Poi lo prese con gli artigli e lo portò a Priscilla.
Le streghe commentano l’episodio; Fliggy sa che solo una ha ragione.
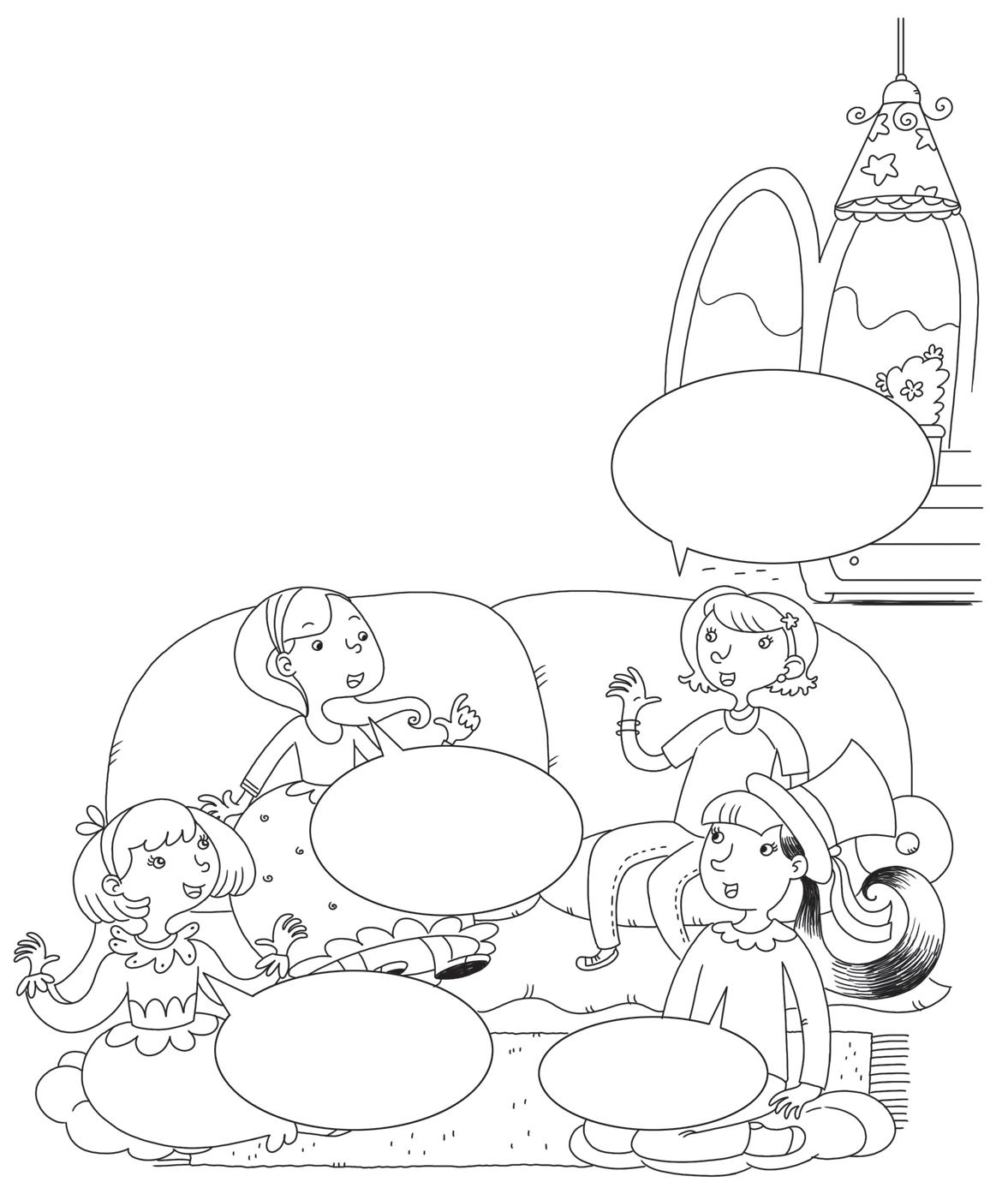
SECONDO ME, SI E ‘ FINTA MORTA, HA VOLTATO LA TESTA PER SEMBRARE PIU ‘ INDIFESA E SORPRENDERE TOPOGRIGIO.
LA CIVETTA HA PENSATO DI FINGERSI MORTA E HA VOLTATO IL CAPO PER NON VEDERE IL TOPO.
IO CREDO CHE SI SIA FINTA MORTA PER INGANNARE TOPOGRIGIO E POI SCAPPARE. HAI RAGIONE TU!
Fliggy telefona alla sua amica Ludmilla: – Ciao Ludmilla, sto catalogando a computer le mie formule magiche e non vorrei interrompermi. Visto che stai venendo da me, puoi passare per favore in cartoleria e comperarmi
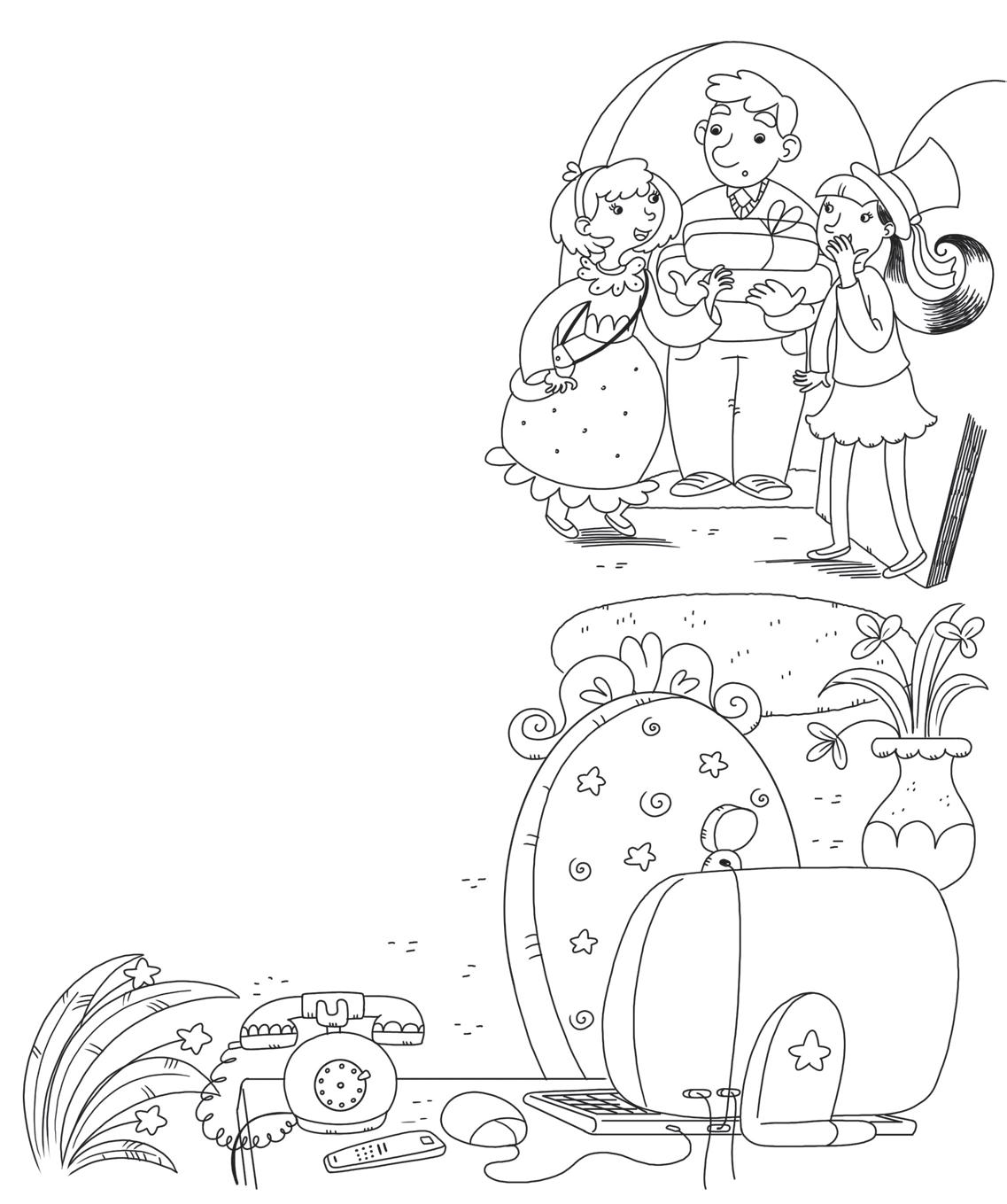
40 etichette adesive per le mie ampolline?
– Certamente! Le vuoi bianche o colorate?
– Colorate, grazie. Ah! Già che ci sei, compera alcuni filapperi per la merenda.
– Ok! Tra un’oretta sono da te.
Ludmilla, andando da Fliggy, è passata a fare un saluto a Malica, poi è andata in cartoleria e ha comperato quattro etichette: una rossa, una viola, una verde e una gialla.
Quando è entrata in pasticceria, ha comperato quaranta filapperi: due pacchi che ha caricato nel cestino della scopa.
Berto la aiuta a portare i pacchi e, quando Fliggy apre la porta, la guarda, si mette a ridere ed esclama: – Non avrò etichette per le ampolle, ma potremo mangiare filapperi per un mese. Vado subito a preparare una cioccolata calda per gustarli meglio!
Berto chiede: – Che cosa sono i filapperi?
Pensa: “Potrebbero essere pizzette, cioccolatini, biscotti, torte, panini, caramelle, cicche, patatine”. Fliggy si accorge della perplessità di Berto e gli dà un aiuto.
– Si comperano al bar, in pasticceria e al supermercato; si possono comperare in confezioni piccole o grandi; sono ottimi con la cioccolata; quaranta filapperi stanno in due pacchi.
– Ho capito! I filapperi sono .
Squilla il cellulare di Fliggy. È la solita Ludmilla che, non sapendo che cosa fare, vuole chiacchierare un po’. – Senti Ludmilla, sono molto impegnata. Ti mando una e-mail con un quesito, così potrai aiutarmi e saprai che cosa fare! Fliggy scrive.
Sto facendo una ricerca sui ragni. Ho digitato sul motore di ricerca del computer la parola “ragno” e la prima voce è: RAGNI.
Autore: Stella Parini, docente di Aracnologia, Università di Bologna.
Che tipo di articolo sarà quello della prima voce? Sarà un testo che:
propone una ricetta per una pozione favolosa dà informazioni utili per la cattura dei ragni dà informazioni sui ragni racconta un’esperienza racconta una leggenda sui ragni
Dove pensi di trovare questo testo? In:
Ragni scarafaggi, manuale fornito da una ditta produttrice di insetticidi
Le mie vacanze a casa dei nonni, diario di una bambina di 9 anni
Artropodi, celenterati e echinodermi, rivista scientifica
Pozioni e intrugli, rivista per apprendiste streghe
I personaggi dei miti e delle leggende, fascicolo dell’enciclopedia dei miti
La seconda voce trovata su Internet è: RAGNI
Autore: Aurora Foscoli, docente di mitologia, Università di Bologna.
Che tipo di articolo sarà quello della seconda voce trovata su Internet?
Sarà un testo che: propone una ricetta per una pozione favolosa dà informazioni utili per la cattura dei ragni dà informazioni sui ragni racconta un’esperienza racconta una leggenda sui ragni
Dove pensi di trovare questo testo? In:
Ragni scarafaggi, manuale fornito da una ditta produttrice di insetticidi
Le mie vacanze a casa dei nonni, diario di una bambina di 9 anni
Artropodi, celenterati e echinodermi, rivista scientifica
Pozioni e intrugli, rivista per apprendiste streghe
I personaggi dei miti e delle leggende, fascicolo dell’enciclopedia dei miti
Segna con X le tue risposte. Io ho già risolto. Poi confrontiamo. Ciao.
Fliggy
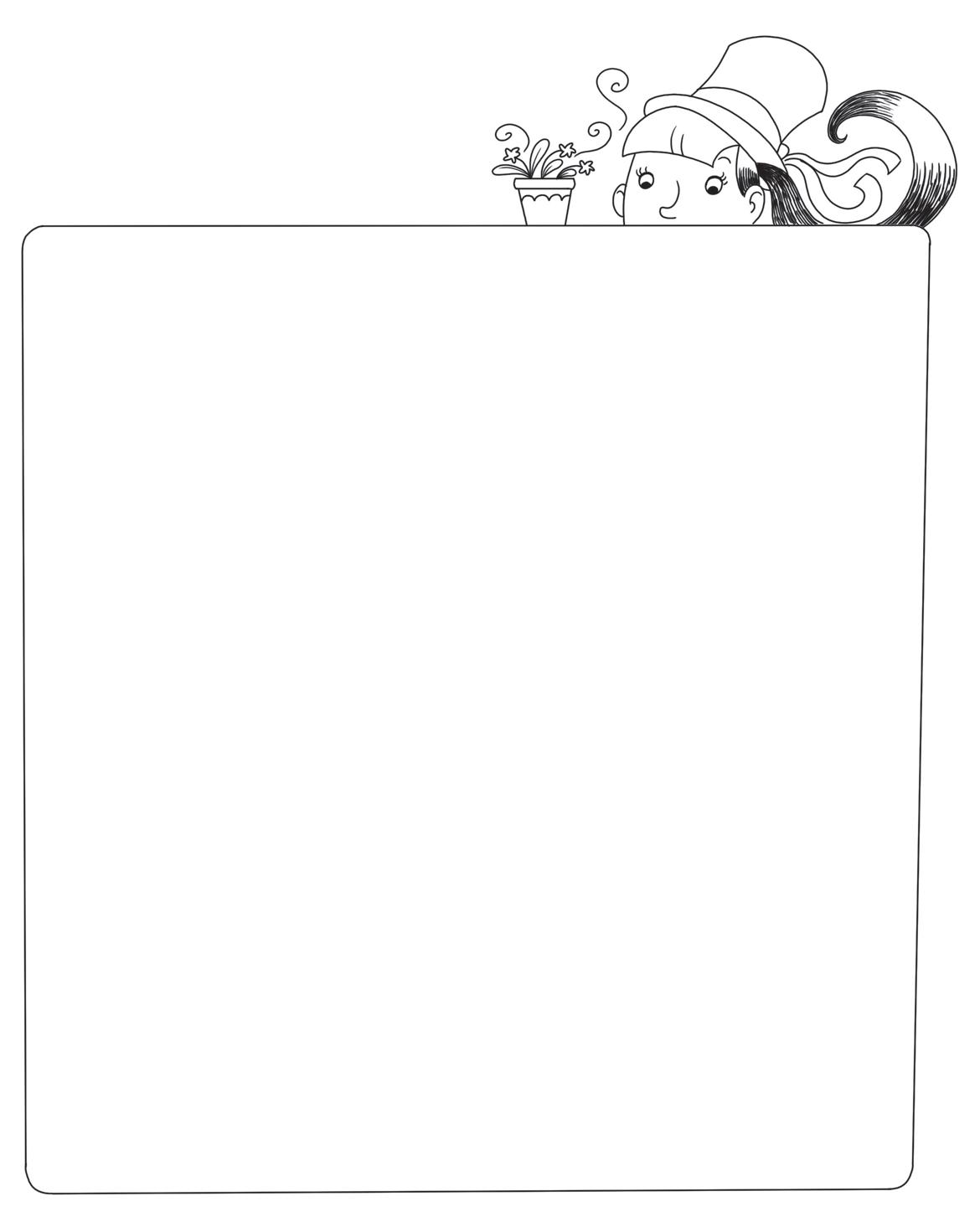
Attenzione, osservazione e strategie
Le tre Unità di Apprendimento del secondo step hanno come protagonisti rispettivamente uno sceriffo, un indiano e un pirata.
Sono personaggi ancora appartenenti al mondo della fantasia, maggiormente legati, però, a una realtà concreta. L’approccio intuitivo ha ancora un’importanza rilevante, ma le situazioni sono più complicate e richiedono da parte dell’alunno/a un maggior livello di attenzione e di osservazione.
Il contesto narrativo fa sempre da sfondo all’attività strettamente didattica e le consegne formulate in modo indiretto derivano dalla decodificazione del testo.
In questo modo si presentano livelli diversi di comprensione di un testo: la narrazione e la focalizzazione di ciò che deve essere fatto per la soluzione del quesito.
È sempre valido il suggerimento di lasciare al bambino/alla bambina la libertà di trovare strategie di esecuzione personali, in modo che possa adottare il percorso risolutivo a lui/lei più consono. Solo in caso di difficoltà l’insegnante interverrà discretamente con suggerimenti.
La correzione collettiva sarà occasione per un confronto in classe. All’interno di questo confronto sarà opportuno valorizzare ogni percorso e ogni soluzione.
Gli O.A. sono indicativi perché in ogni pagina gli obiettivi sono molteplici, soprattutto man mano che il livello diventa più alto.
Prima unità
La prima unità vede protagonista lo sceriffo Lucky Jo e ha come finalità quella di guidare il bambino e la bambina ad affinare le capacità di osservazione e di deduzione.
Queste abilità dovranno essere utilizzate anche per la ricostruzione di storie attraverso sequenze in cui la successione è data dal cambiamento di piccoli particolari nei vari disegni oppure nella comprensione di barzellette.
In questo caso sarà utile che l’insegnante inviti il bambino/ la bambina a spiegare perché quelle barzellette fanno ridere e su che cosa fanno leva per suscitare l’ilarità.
Le abilità che si vogliono stimolare sono: la capacità di osservazione, la classificazione, il riconoscimento di caratteristiche comuni o di differenze a volte poco evidenti, l’istituzione di relazioni.
Seconda unità
Terza unità
La finalità della seconda unità , che ha per protagonista l’indiano Grande Bisonte , è quella di favorire la capacità di manipolare le parole utilizzando suoni per giungere alla composizione di nuove parole. Rispetto al livello precedente, la difficoltà è rappresentata dall’aumento del numero di suoni che possono concorrere alla formazione di nuove parole.
Sono richieste capacità di osservazione e di analisi. Con questa tipologia di attività si favorisce la riflessione sulla struttura della parola.
La lettura e la comprensione di testi sono le finalità della terza unità , con protagonista il pirata Thomas
Essere in grado di fare inferenze vuol dire saper andare oltre il significato palese di una frase o di un testo.
Per abituare a questo tipo di riflessione si propongono brani ad hoc, in cui il contesto avventuroso stimola a capire oltre le parole espresse . Il bambino e la bambina cominciano ad elaborare un personale metodo di studio quando sono in grado di comprendere le informazioni principali di un testo, ma anche di andare oltre facendo collegamenti e inferenze.
In un piccolo villaggio sperso nelle vaste praterie dell’Arizona, lo sceriffo Lucky Jo e il suo vice, Little Boy, cercano di mantenere l’ordine e la calma. Il saloon è il luogo dove molti uomini si ritrovano alla sera dopo il lavoro, ma, qualche volta, gli animi si surriscaldano troppo e scoppiano dei litigi. È a questo punto che Lucky Jo interviene a riportare la calma. Sul giornale locale ci sono le immagini dell’ultima rissa; nella fretta le foto sono state impaginate in modo errato tranne la prima e l’ultima.
Però c’è un modo per ricostruire il giusto ordine: in ogni vignetta, a partire da quella contrassegnata dalla lettera A, c’è un particolare che si trova identico nella successiva; in questa ce n’è un altro identico a quello della terza vignetta e così via fino all’ultima, cioè quella contrassegnata dalla lettera G.
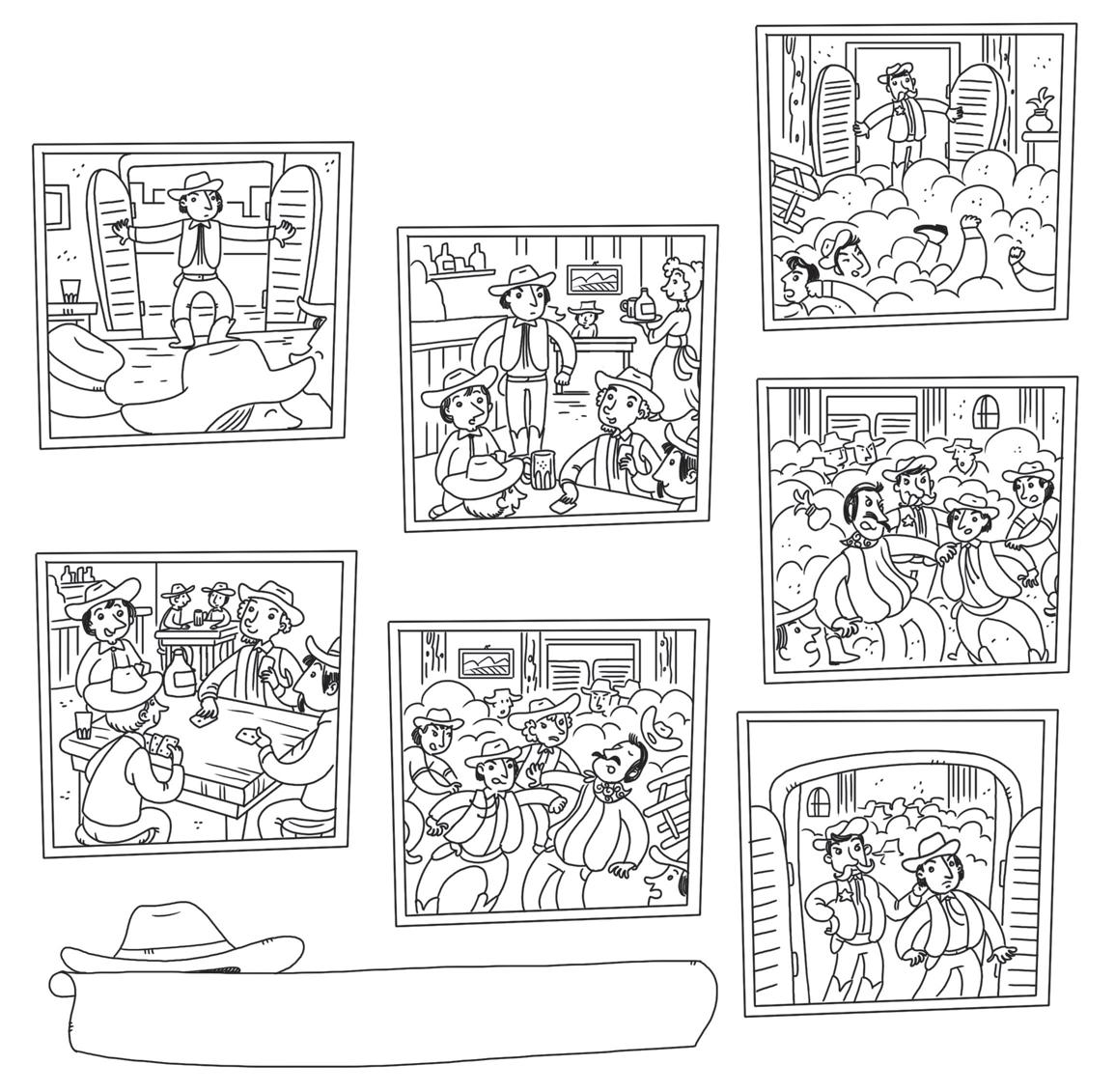
O.A.: osservare con attenzione per cogliere i particolari e i cambiamenti.
Una delle famigerate bande del lontano West, quella di Black Jack, è entrata in azione e ha assalito la diligenza. Lo sceriffo si precipita sul luogo in cui è avvenuto il crimine; per fortuna non ci sono state vittime, ma la diligenza è distrutta, i bagagli dei viaggiatori e il loro contenuto sono sparsi ovunque. L’attacco è stato improvviso e nessuno di coloro che si trovavano a bordo ha visto i malviventi; però, tra i curiosi che assistono alle operazioni di recupero, Lucky Jo scopre che cinque sono dei testimoni perché erano presenti al momento dell’assalto.
– Ehi, capo, ma come hai fatto a capirlo? – chiede meravigliato Little Boy.
– Osserva attentamente la scena e queste persone, vedrai che lo capirai anche tu!
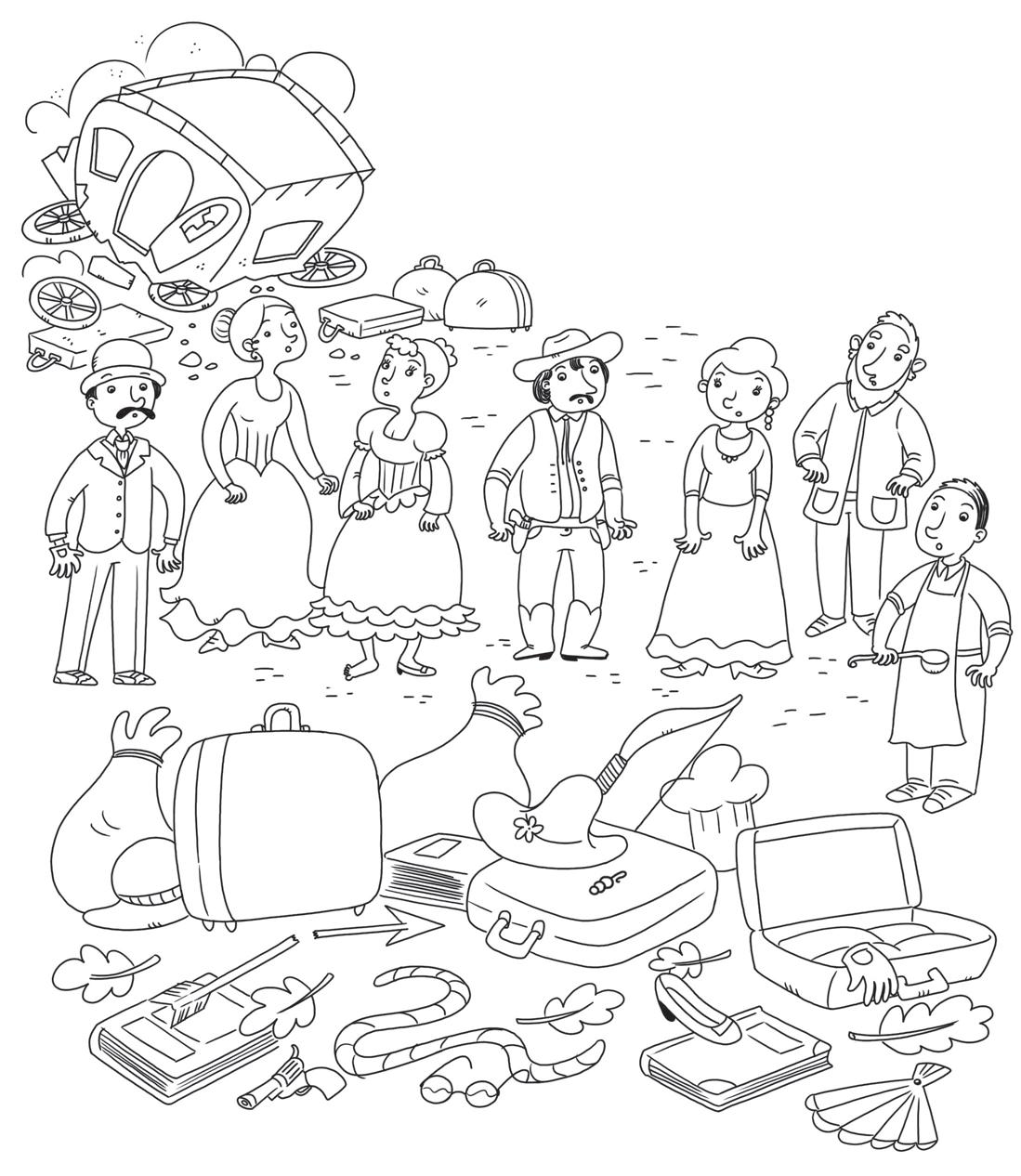
O.A.: osservare con attenzione per cogliere le relazioni.
Nome e cognome
Lucky Jo è sulle tracce di Black Jack, infatti tre giorni fa la banda del fuorilegge ha rapinato la banca di Silver City. Nessuno sa con precisione quale sia l’aspetto del bandito; si sa soltanto che non si toglie mai il cappello, neppure per dormire, ha la barba, i capelli lunghi e tiene sempre gli occhi aperti per non farsi cogliere di sorpresa. Lo sceriffo ha avuto un’idea furba: ha tagliato a metà gli identikit di alcuni ricercati e adesso prova a ricomporre i volti nella speranza di individuare Black Jack. Le metà di sinistra sono contrassegnate da una lettera, quelle di destra da un numero. Basta unire la lettera e il numero giusti e… ecco i ricercati e Black Jack!
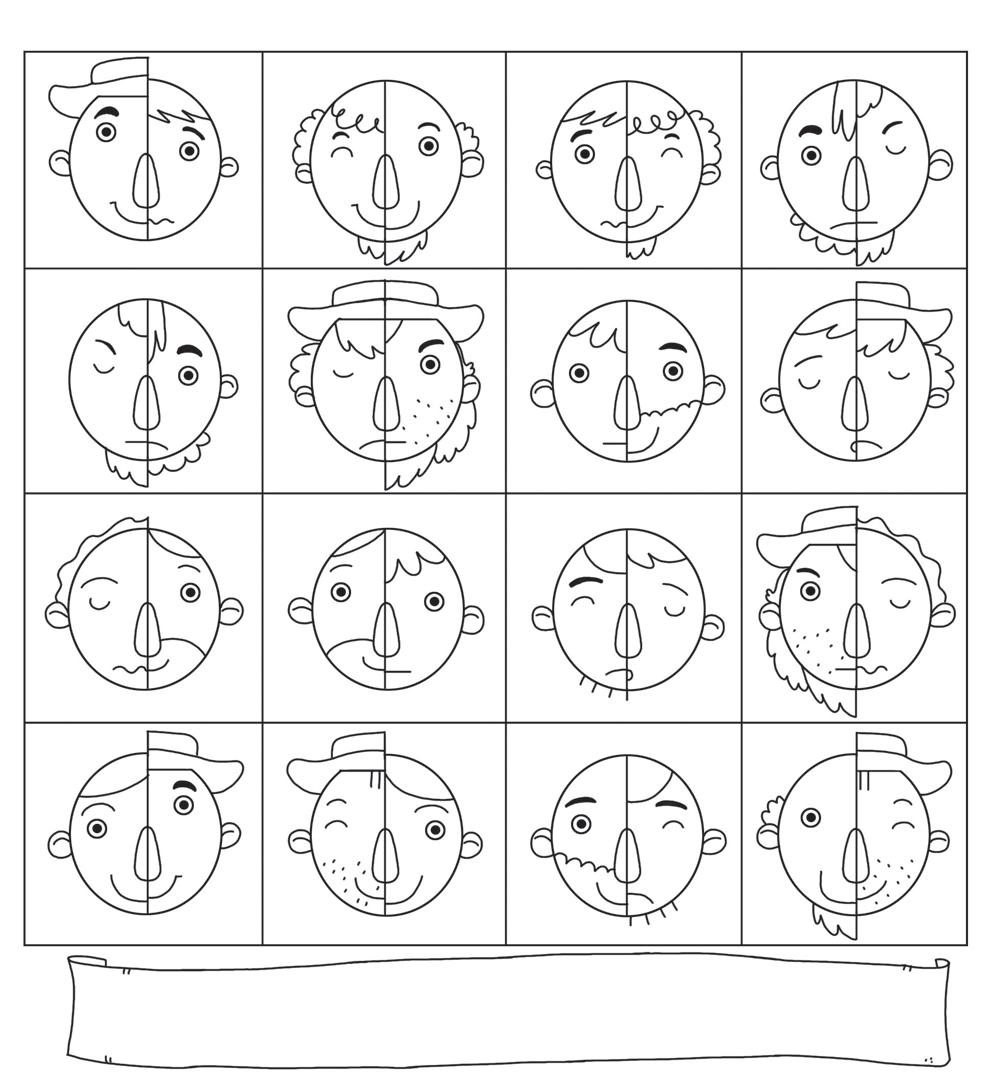
Black Jack è il numero
O.A.: osservare con attenzione per cogliere le differenze e le somiglianze.
Non c’è pace per lo sceriffo Lucky Jo: James Jesse con i suoi fuorilegge ha rubato una mandria di cavalli e ora si nasconde tra la folla. Ma lo sceriffo e il suo vice questa volta non avranno grosse difficoltà a scovarlo, infatti hanno diverse informazioni su di lui, sanno che:
• non fuma e non porta gli occhiali;
• ha sempre il fazzoletto intorno al collo;
• non è parente del derubato;
• non sopporta gli speroni.
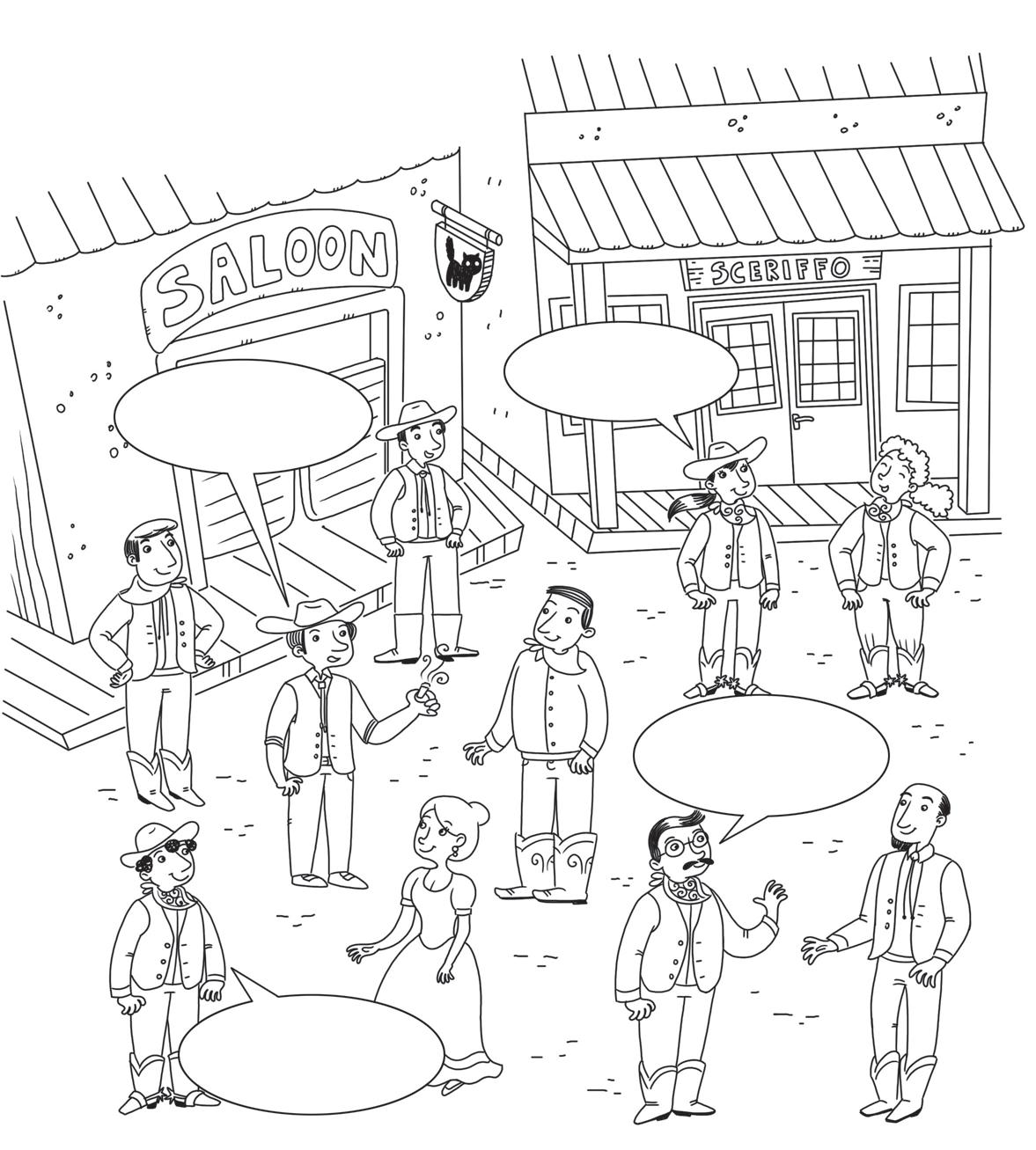
QUANTI CAVALLI HANNO RUBATO A TUO CUGINO?
HO TERMINATO I SIGARI!
MIO ZIO E ‘ MOLTO ARRABBIATO PER IL FURTO SUBITO.
IERI AL SALOON HO PERSO GLI OCCHIALI.
O.A.: riconoscere le informazioni date dagli enunciati.
La banda di James Jesse è stata finalmente sgominata; dopo il capo, a uno a uno, sono finiti in galera tutti i sei malviventi che ne facevano parte. Lo sceriffo li ha radunati nel suo ufficio perché vuole individuare chi, tra loro, ha nascosto i cavalli e chi è il tesoriere della banda. È difficile ottenere informazioni da quei brutti ceffi. Però, nei giorni precedenti, lo sceriffo aveva ascoltato i discorsi che gli uomini chiusi in cella facevano tra di loro e così ha scoperto che:
• Bill, Fred e Tom parlavano spesso con il tesoriere.
• Dave e Fred non erano d’accordo con la spartizione del bottino proposta dal tesoriere; Ringo, invece, la sosteneva.
• John, Dave e Ringo volevano nascondere i cavalli, ma non hanno potuto farlo.
• Fred e il tesoriere avrebbero preferito nascondere i cavalli in un altro posto.
• Tom era arrivato da poco nella banda e non aveva nessun incarico.
• Bill è uno che sbaglia sempre a fare i conti.

Dave Ringo
Il tesoriere è . I cavalli sono stati nascosti da .
Nome e cognome Data
Una volta al mese lo sceriffo fa l’inventario di ciò che gli serve e si reca all’emporio di Silver City, per rifornirsi di tutto ciò che gli manca.
Sul lungo tavolo dell’emporio, Lucky Jo osserva gli oggetti comperati dagli avventori presenti in quel momento e, mentre attende il suo turno, si diverte ad abbinare ogni oggetto al suo acquirente e scrive le combinazioni sul suo taccuino. 1
OGGI MI FARO ‘ UNA NUOVA ACCONCIATURA.

DEVO RACCOGLIERE LE PATATE.
VOGLIO CAMBIARE LE TENDE DELLA CUCINA.
DOMANI PARTECIPERO ‘ AL RODEO.
IO INVECE SEMINERO ‘ IL MAIS.
MI E ‘ RIMASTO SOLO IL TABACCO.
Lettera Numero
Lettera Numero
O.A.: osservare con attenzione per cogliere le relazioni tra oggetti e personaggi.
La Gazzetta di Silver City riporta alcuni episodi di vita locale, ma, per divertire i suoi lettori, ha lasciato vuoti i fumetti scrivendo a fondo pagina le parole dette da ciascun protagonista.
I lettori dovranno inserire le lettere nei fumetti e ci sarà un premio per il primo che farà giungere al giornale la pagina completata correttamente.

A Arrivi da lontano, vero?
B Sembri un pappagallo!
C Avrai la mia deposizione domani mattina!
D Quando ti ho chiesto di indagare sui risvolti della faccenda, intendevo un’altra cosa.
E Non fare domande, tienilo fermo e taci!
F La foto non è disponibile.
G Da dove escono i segnali di fumo, da questo coso?
Dopo aver “sistemato” James Jesse, lo sceriffo Lucky Jo sta portando al tribunale della contea anche Black Jack e tutta la sua banda. Li ha ammanettati e caricati sul carro, mentre il suo vice Little Boy e alcuni aiutanti controllano che a nessuno salti in mente di scappare. Lungo la strada potrebbero esserci altri complici e bisogna stare con gli occhi aperti. L’avvenimento è importante e anche la Gazzetta di Silver City manda un reporter a fotografare la situazione. Alla sede del giornale il direttore decide di inserire sulla foto i fumetti con le frasi pronunciate dalle diverse persone, ma il redattore a cui aveva affidato l’incarico ha scambiato le frasi. Ora bisogna sistemarle in fretta scrivendo i numeri accanto alle persone!
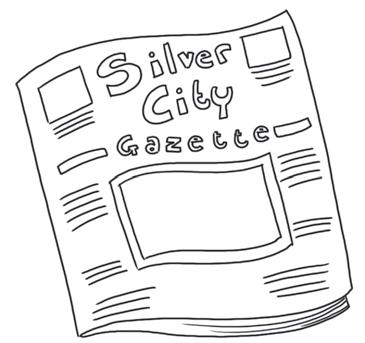

ADESSO SIEDITI, MANGERAI QUANDO E ‘ IL MOMENTO!
SARA ‘ MEGLIO RIFORNIRSI ALLA PROSSIMA SORGENTE. 1 2 5 6 3 4
CHE COSA HANNO COMBINATO QUESTI BANDITI? QUANDO SI MANGIA? LITTLE BOY, ABBIAMO ANCORA BORRACCE DI ACQUA?
E ‘ ORA CHE LO PORTI DAL MANISCALCO.
Nome e cognome
Gli indiani della tribù dei Piedi Scalzi hanno smontato le tende e si stanno spostando: alcuni sono a cavallo, altri a piedi. Le merci e i bambini vengono trainati da slitte. Stanno andando verso le grandi praterie, dove è stato avvistato un grande branco di bisonti. Li guida il capo Grande Bisonte che parlotta con lo sciamano. Qualcosa li turba: è scomparso un oggetto molto prezioso per tutta la tribù. Per sapere qual è l’oggetto mancante bisogna cancellare le sillabe che formano il nome degli oggetti disegnati. Le sillabe rimanenti, nell’ordine, daranno il nome dell’oggetto mancante.
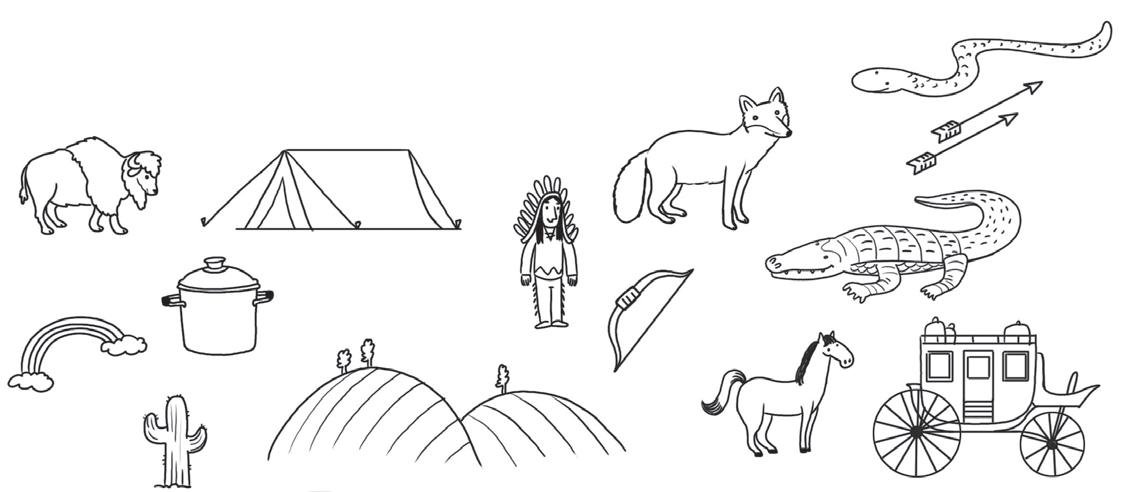
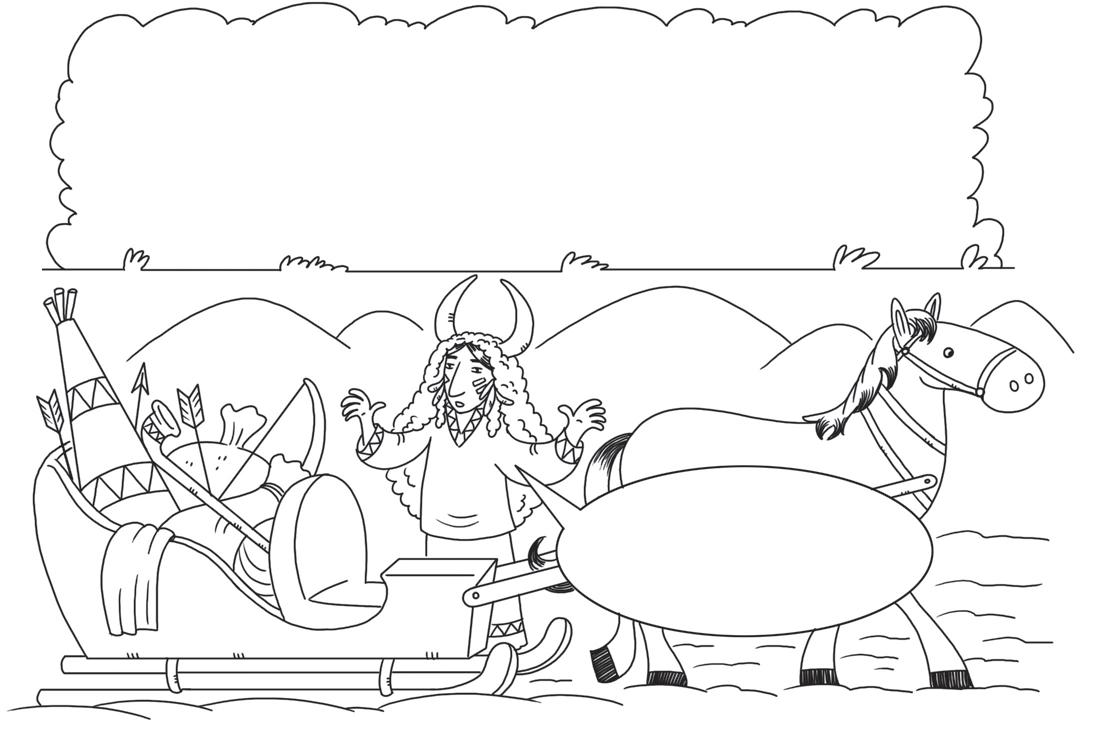
DOVE E ‘ ANDATO A FINIRE L’OGGETTO?
Nome e cognome Data
Grande Bisonte, che, dall’alto delle colline, ha visto un’altra tribù in movimento, incarica Lupo Strano di mandare segnali di fumo per comunicare amicizia e buona fortuna. Lupo Strano, però, non è molto abile con i segnali di fumo e trasmette “strane parole”.
Dalla tribù lontana rispondono con altre parole che, unite a quelle di Lupo Strano, ne formano altre ancora.
Così nel cielo ci sono tante nuvolette e tutti gli indiani si divertono ad accoppiare le parole.
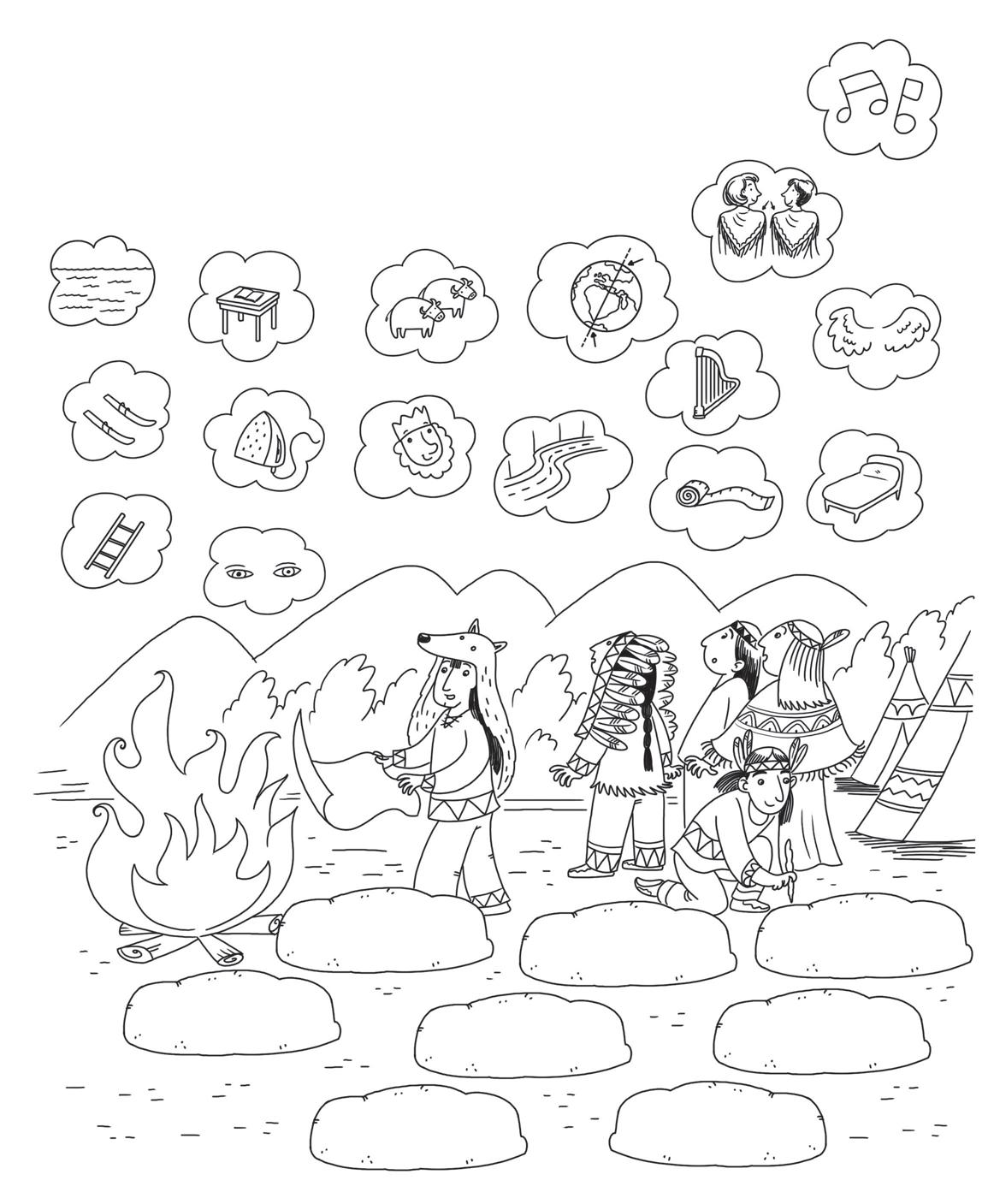
O.A.: riconoscere criteri per la formazione di parole.
1. dine
2. serto
3. lancia
4. nambulo
5. lefono
6. tomarino
7. remoto
8. gazzo
9. boratorio
10. nanas
11. bola
12. nosauro
13. riero
14. vanello
A un tratto, dopo che un forte vento aveva allontanato i segnali di fumo inviati dalla Tribù dei Piedi Scalzi per comunicare la propria presenza nella zona, un gran polverone annuncia l’arrivo di molti cavalieri al galoppo. Grande Bisonte teme che siano nemici; raduna tutti i guerrieri e prende l’ascia di guerra.
Quando i cavalieri sono vicini, Grande Bisonte va a parlare con lo sciamano.
Lo sciamano scrive una frase sulla sabbia e per fare questo utilizza tutte le sillabe iniziali che mancano nelle parole.
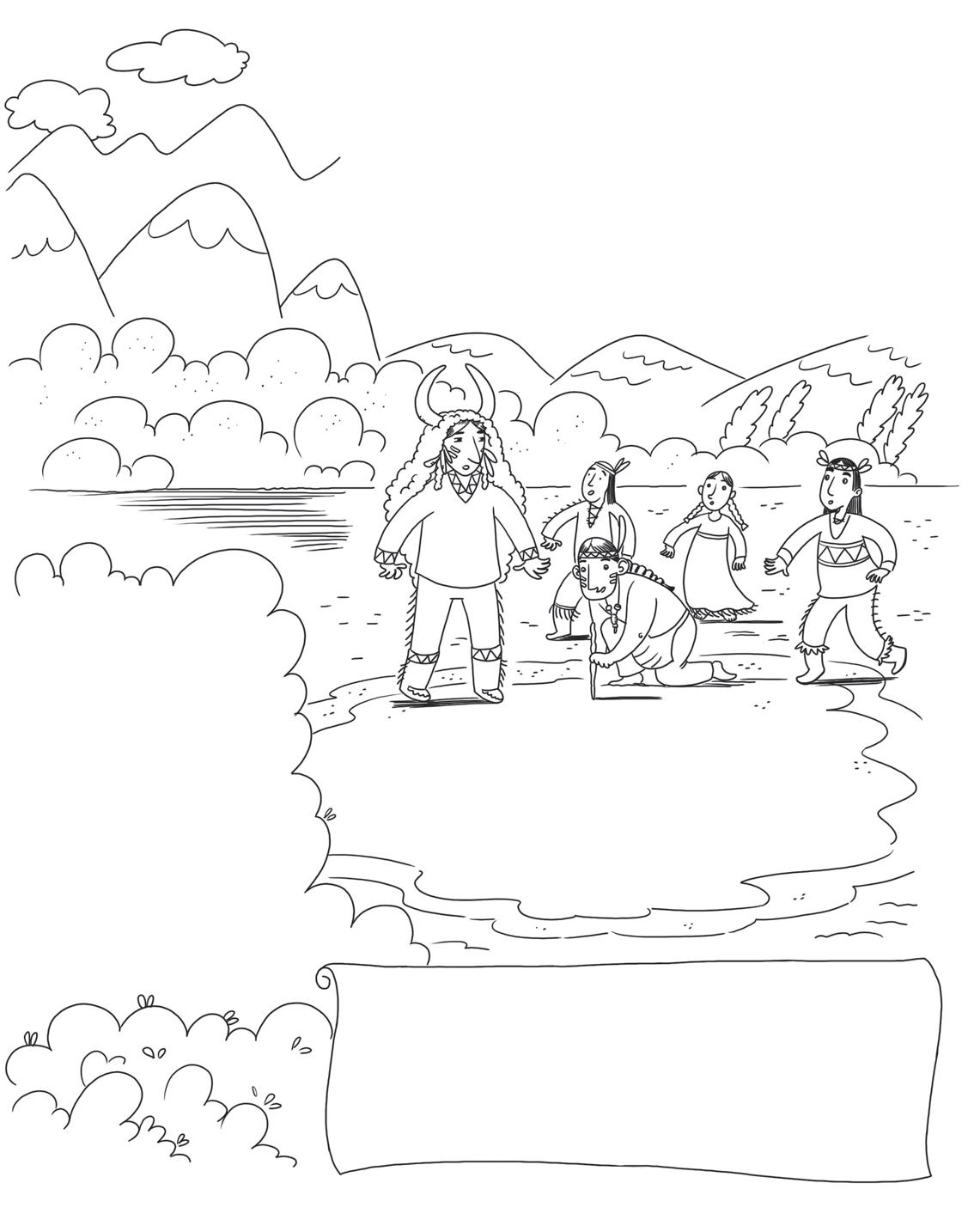
Lupo Stanco legge la frase scritta dallo sciamano e si domanda che cosa possa essere successo.
Finalmente Grande Bisonte ha individuato un luogo adatto per stabilire il nuovo accampamento. È protetto dalle colline, una fresca sorgente è vicina e il percorso dei bisonti non è lontano. Tutto è tranquillo e, proprio quando anche lo sciamano decide di rilassarsi e di farsi una fumatina insieme a Grande Bisonte, arriva un carro trainato da un vecchio cavallo su cui avanza un uomo, un bianco, con un cilindro in testa. È il vecchio Sam, un tipo originale, che passa quasi tutto il suo tempo viaggiando attraverso il territorio indiano e che sa far divertire i bambini.
– Bambini, venite qua – dice Sam, – guardate questi disegni e unite i nomi che fanno rima tra loro colorando i cerchiolini con lo stesso colore.


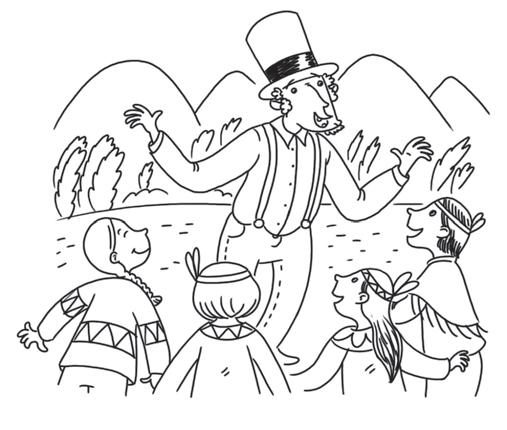
– Bravissimi! Non pensavo che ci sareste riusciti in così poco tempo! Adesso scegliete due coppie di parole e inventate una poesia!
Tanto tempo fa, quando era un bambino, Sam ha vissuto per molti anni con gli indiani della tribù dei Piedi Scalzi ed è per questo che, spesso, torna a trovarli. Ma non fa giocare solo i bambini, ama intrattenersi anche con gli adulti; per loro ha preparato giochi di parole. Grande Bisonte è felice, si siede accanto a Sam e chiama a gran voce i saggi del villaggio, che accorrono tutti, tranne Alce Testa di Legno. Alce Testa di Legno è un bravissimo cacciatore, ma non sa proprio fare i giochi di Sam; così si nasconde nella sua tenda e fa finta di non sentire il capo che lo chiama.
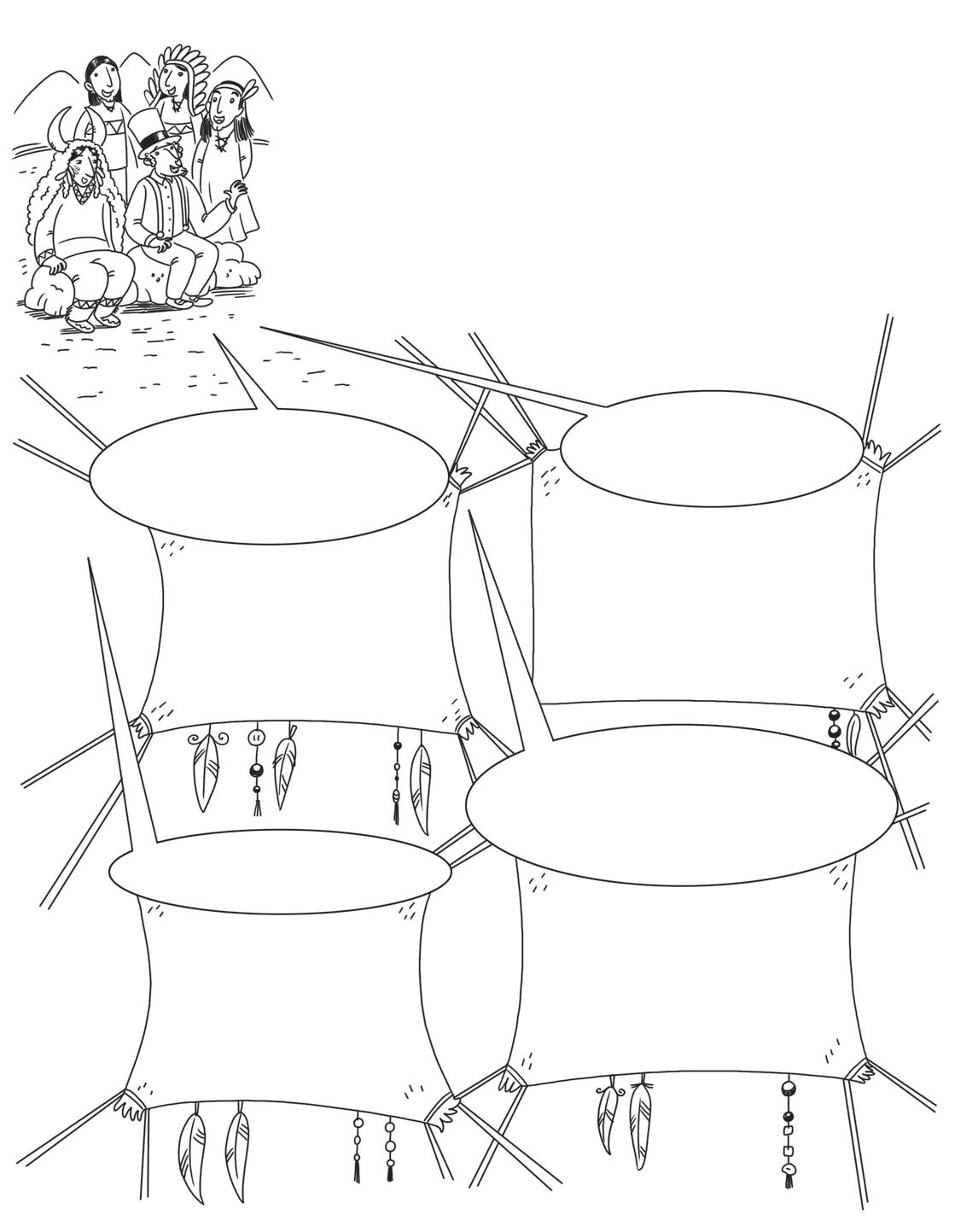
TOGLIETE LA LETTERA INIZIALE PER FARE
UNA PAROLA DI SENSO COMPIUTO.
INFINE AGGIUNGETE UNA SILLABA INIZIALE E FARETE SEMPRE UNA PAROLA DI SENSO COMPIUTO. 1 2 3 4
ADESSO AGGIUNGETE UNA LETTERA INIZIALE.
sasso clima spiedino scarpa spendere podio decotto bisogno tracollo cerotto altre collana
TOGLIETE LA SILLABA INIZIALE.
osso passo uscio oro assaggiatore esche morso letto giada rotondo saggio pari
Nella tribù dei Piedi Scalzi non ci sono libri e così i grandi avvenimenti vengono dipinti sulle pareti delle grotte, ma Grande Bisonte ha avuto un’idea geniale. – Per poter portare con noi il ricordo dei momenti importanti della nostra vita, possiamo scriverli sulle pietre!
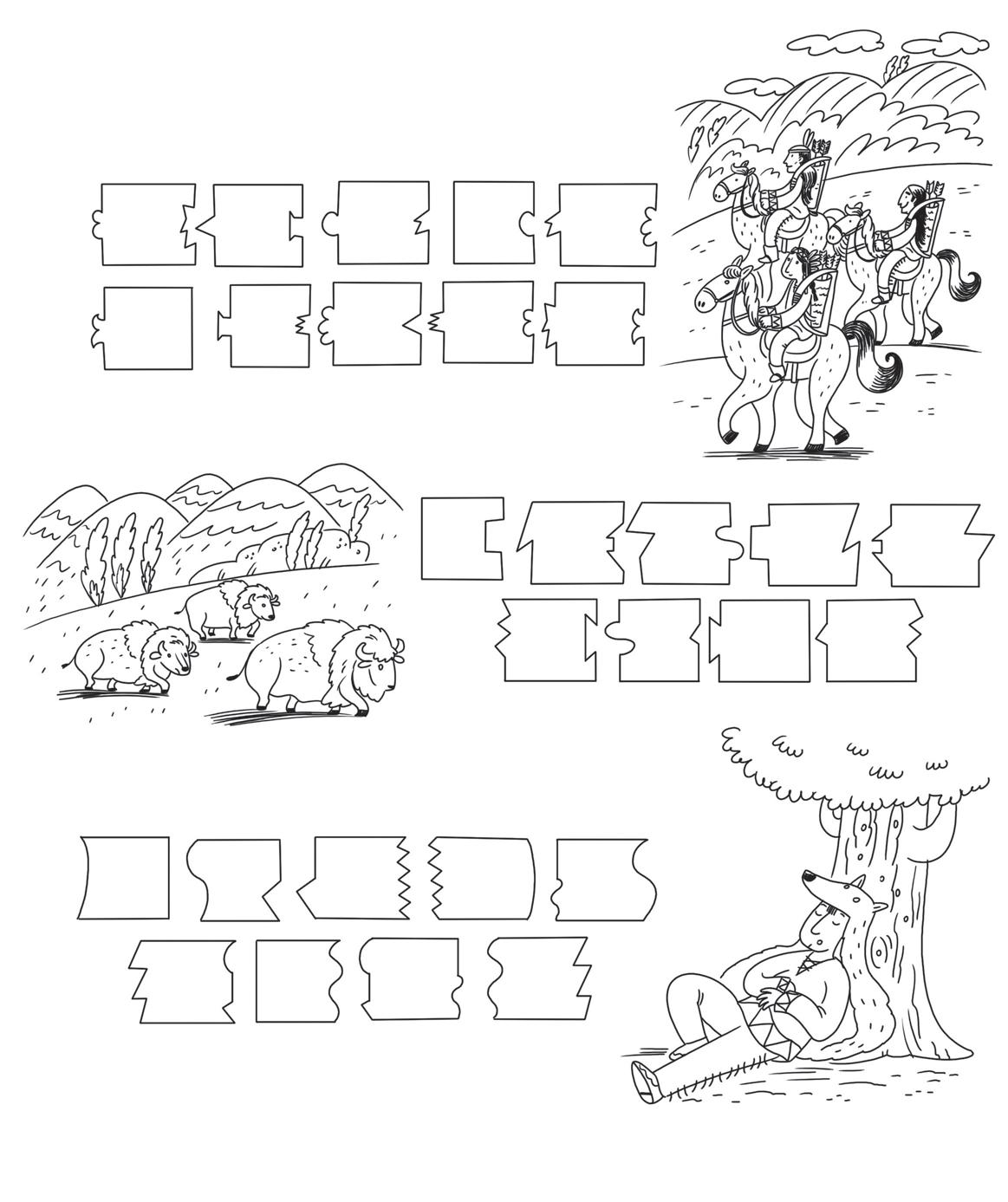
Infatti, su tre lunghe lastre Aquila Pensante scrive altrettante frasi; purtroppo, nello spostarle, le lastre si rompono e adesso, per poter leggere le frasi, bisogna risistemare i pezzi.
I cacciatori stanno tornando all’accampamento e, dalle loro grida, tutto il villaggio capisce che la caccia è stata fortunata. Tutti sono allegri e si preparano ad accoglierli.
I bambini saltano e corrono, le squaw sanno che adesso per loro inizierà un grande lavoro: la carne del bisonte va trattata in modo da essere conservata per molto tempo. Lo sciamano fa dei disegni per terra.
Aquila Pensante li osserva e, su una grande lastra di granito suddivisa in 12 righe, scrive delle lettere. In ogni riga lo sciamano dovrà togliere tutte le lettere che formano il nome di ciascun disegno. Con le lettere che rimarranno, prese nell’ordine, potrà leggere una frase che qualcuno nell’accampamento ha pronunciato.
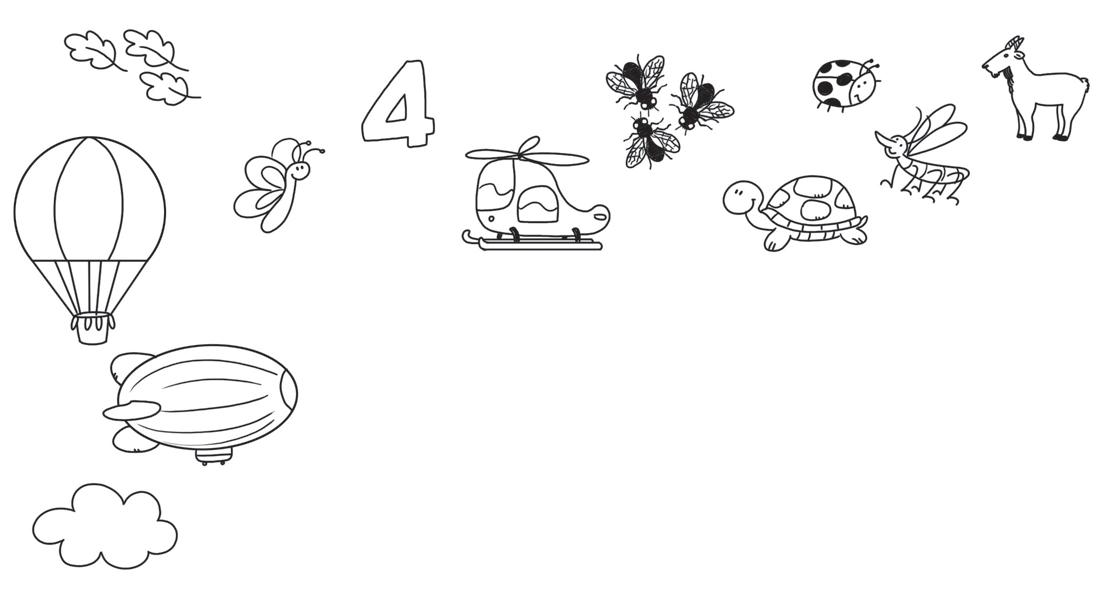

Nome e cognome Data
L’inverno è una stagione che crea molti problemi agli indiani della tribù di Grande Bisonte: scende molta neve e il freddo intenso non consente ai cacciatori di trovare animali da catturare. Dai tepee esce il fumo del focolare e tutti trascorrono la maggior parte del tempo al chiuso, ben coperti dalle pelli di bisonte. Quando le giornate si allungano e il cielo si fa più sereno, lo sciamano annusa l’aria tiepida che arriva da sud e si prepara per un rito magico. Scrive alcune parole e chiede a Grande Bisonte di anagrammarle e di inserirle nello schema. Le lettere contenute nelle caselle colorate formeranno una frase che tutti gli indiani sono ansiosi di sentire.
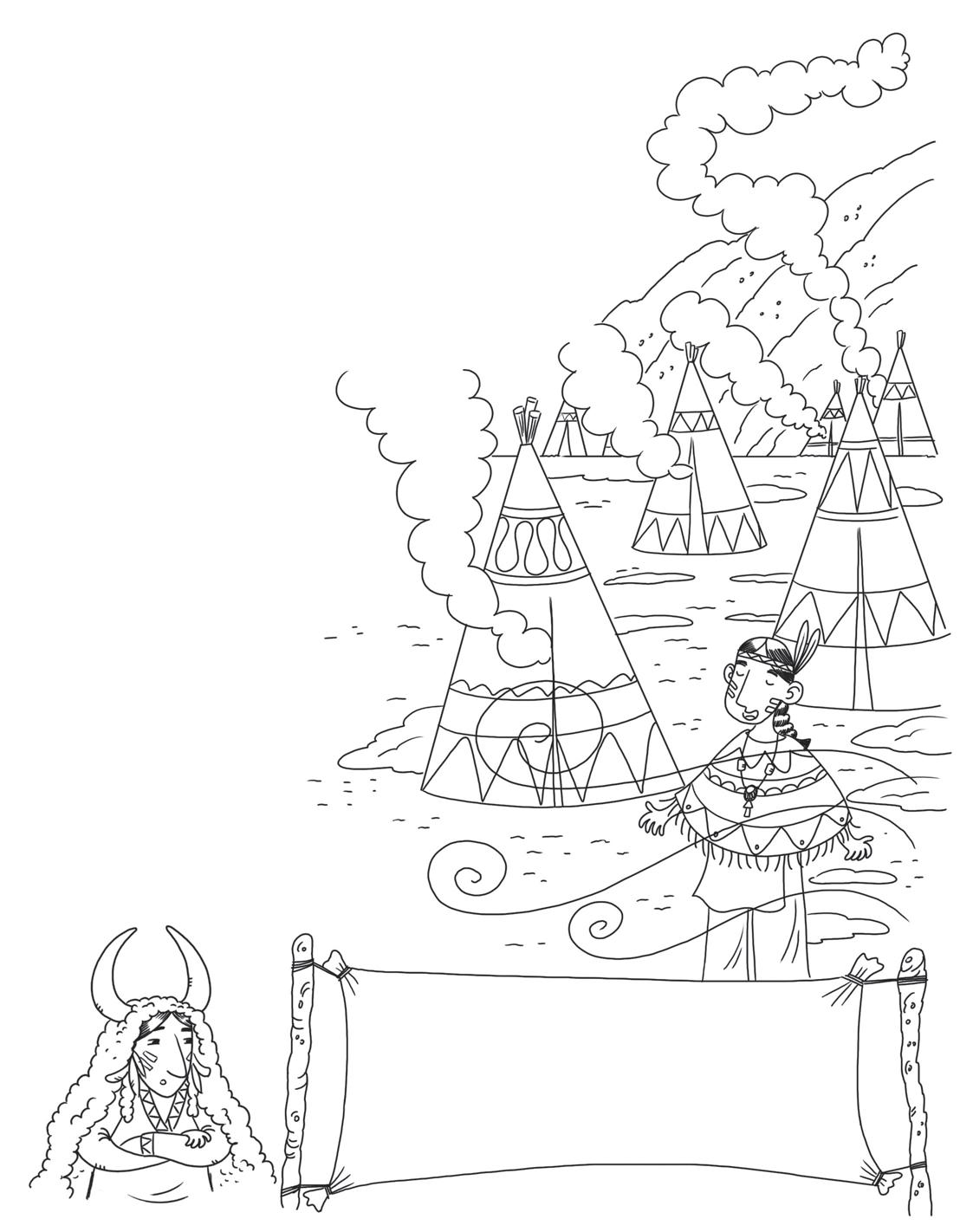
stormi
valente gola
rapiti
ramo
vene
ignare l e
orca a Gli indiani vogliono sentire che .
Il veliero Terrore dei Sette Mari è nella baia dell’isola Dalak, rifugio segreto del pirata Thomas e della sua ciurma di terribili bucanieri. Thomas ha scelto con cura i componenti del suo equipaggio: è il pirata più temuto e non vuole perdere la faccia. È andato nel porto della Tortuga per ingaggiarli, si è seduto con aria indifferente nella taverna Gatto Nero e ha osservato i bucanieri che stavano facendo baldoria. Come si usa da quelle parti, ciascuno ha un posto assegnato con il nome bene in evidenza. Il capo ciurma che li vuole assumere scrive su un foglietto il nome del vascello e del pirata, poi lo deposita, in gran segreto, nella botte accanto alla porta di uscita. In questo modo nessuno saprà su quale vascello si sono imbarcati i pirati. Thomas ha preso appunti.
Poi ha chiesto al suo amico Bonnet di scrivere i nomi per verificare che li avesse identificati.

Uncino Spuntato
• sa simulare il suo handicap. È veramente furbo, nessuno si aspetta che abbia sempre con sé un’arma così micidiale.
• ______________ è irascibile, è armato di pistola, ma tiene allegra la compagnia.
• ______________ ha fama di essere coraggioso e intrepido. Mi preoccupa il fatto che sia taciturno, solitario e schivo. Saprà legare con gli altri?
• ______________ non ha molta esperienza, ma il suo entusiasmo sarà contagioso.
• sovrasta tutti, può scrutare l’orizzonte. Mi toccherà però trovare un letto adatto a lui!
• : anche per lui ci vuole un letto speciale e una chiave per la cambusa così da mettere al sicuro le derrate!
Thomas si è concesso una pausa sulla sua isola. Le ultime scorribande lo hanno veramente soddisfatto. I suoi bucanieri non si sono risparmiati e hanno dato l’assalto a un vascello spagnolo che trasportava sete preziose dalla Cina verso l’America settentrionale (1), a una nave inglese che portava un carico di tè verso le coste atlantiche delle colonie inglesi (2) e a due navi portoghesi, una che portava in patria un carico di piante medicinali ed esotiche della foresta (3) e un’altra che era partita dall’Africa per portare in Brasile un carico di schiavi (4).
Ora invia un messaggio al suo amico Bonnet, che è andato sull’isola della Tortuga a cercare di capire se ci sono altri velieri che solcano i mari con carichi interessanti. Thomas ha scritto il messaggio in modo un po’ enigmatico perché, se dovesse capitare nelle mani del suo acerrimo nemico Rackam, questi verrebbe a sapere delle sue imprese e potrebbe riferire agli Stati interessati chi è l’autore degli assalti che le loro navi hanno subito.
A) Senza lo sciamano che prepara gli infusi, a loro non sarebbe servito quel carico. Venderò il resto del carico alle ricche famiglie di Boston. Potranno abbellire le loro dimore. Per completare l’operazione cercherò una nave che trasporti tucani e pappagalli.
B) È stata l’ultima impresa, ma la prima in ordine di importanza. Non ho ricavato denaro, ma la soddisfazione di una buona azione in nome della libertà.
C) Venderò il carico a Boston perché, come sai, alla taverna Gatto Nero, si mesce ben altro.
D) I nobili di Boston non potranno far confezionare capi per le feste danzanti.
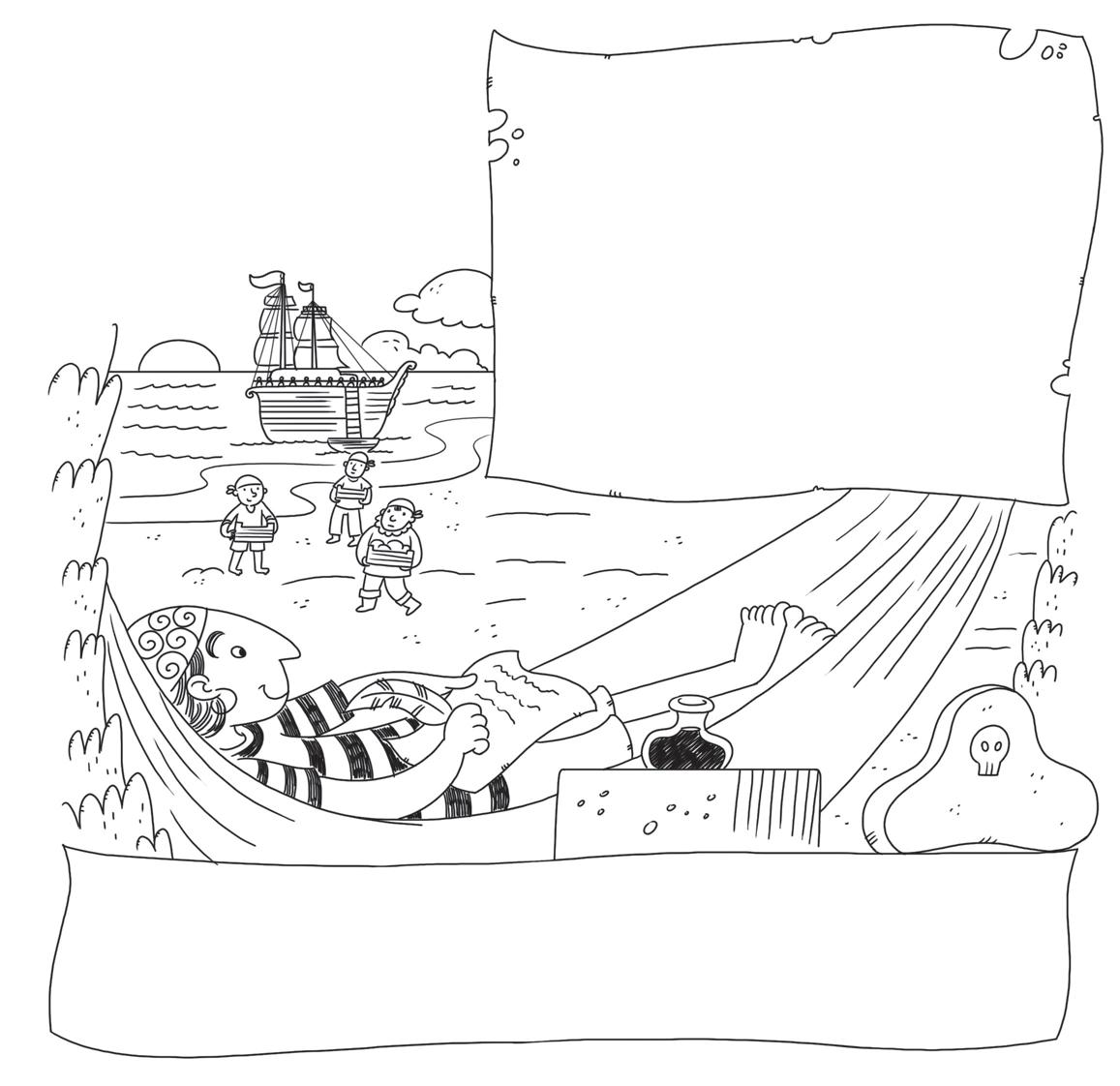
Bonnet ha compreso tutto.
Il messaggio A si riferisce alla nave ____, che trasportava .
Il messaggio B si riferisce alla nave ____, che trasportava
Il messaggio C si riferisce alla nave , che trasportava .
Il messaggio D si riferisce alla nave , che trasportava .
Bonnet è sull’isola della Tortuga per scoprire che cosa si muove sui mari e per informare il suo capo. Seduto al tavolo della taverna, come se fosse un signore qualunque, scrive una lettera a Thomas. Per rendere più difficile la comprensione del testo, inserisce un gioco linguistico e un rebus. Thomas li risolve, poi, sulla lettera, segna con una crocetta il punto dove devono essere inserite le frasi.
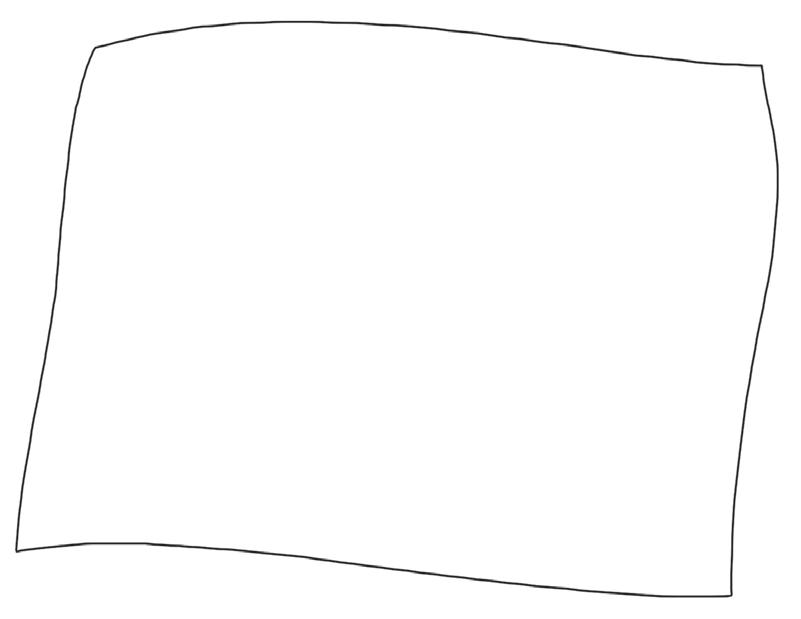
Sull’isola della Tortuga ci sono navi che attraccano e navi che salpano. Certo non tutti i giorni c’è lo stesso movimento, perché le condizioni atmosferiche a volte costringono a soste forzate.
Sulle banchine del porto si incontrano pirati, bucanieri, filibustieri, nomi diversi per persone che svolgono la stessa attività: assalire le navi per rubarne il carico. Nelle taverne si racconta di arrembaggi strepitosi, di tesori nascosti… Quando si vedono due pirati che parlano guardandosi intorno con sospetto, si può essere certi che si stanno comunicando di essere venuti a conoscenza di navi con un carico prezioso. Basta allungare l’orecchio e si scoprono cose interessanti.
A me è capitato.
A presto, Bonnet
Per decifrare la prima frase, Thomas scrive il nome dell’oggetto indicato dal numero: una lettera per ogni cerchiolino, partendo dal numero. I cerchiolini di ogni nome sono legati tra loro. In quelli azzurri comparirà la frase.
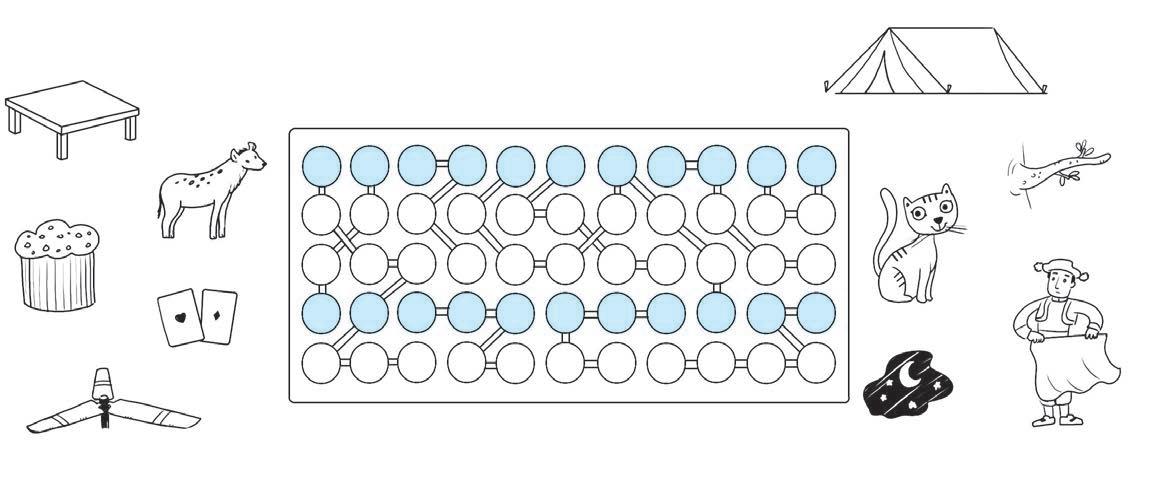
La frase A nascosta è:
Rebus (5, 4, 9, 1, 5, 3, 2, 7) P L IO + TU = … (senza) A + I






Thomas è seduto a un tavolo della taverna Gatto Nero, quando arriva il suo nemico Rackam e gli si rivolge con tono sprezzante: – Ehi! Non hai nulla da fare? So che da circa un mese te ne stai qui in panciolle. Stai invecchiando, non hai più la forza di dare la caccia alle navi! Io invece… sono reduce da un grande successo! – Ah sì? E quale? – controbatte Thomas senza mostrare troppo interesse. – Da informazioni segrete ero riuscito a sapere che un veliero della flotta di proprietà del re di Spagna era partito dal Messico con un carico d’oro. Il re della Francia, padrone di quella nave e delle altre della flotta, sapeva che i suoi soldati l’avrebbero difesa e sarebbero giunti fino alla sua reggia con casse del prezioso metallo. Ho riunito i miei uomini, ho spiegato il piano e ho promesso loro che il bottino da spartire sarebbe stato ben sostanzioso; metà a me e il resto a loro, diviso in parti uguali. Siamo partiti dalla Tortuga con una scorta di acqua e viveri per quattro settimane. Questo era il tempo massimo cui potevamo resistere perché non avremmo potuto fare altri rifornimenti, dal momento che su quella rotta non c’erano approdi sicuri. Se avessimo superato quel limite di tempo saremmo morti di fame e di sete.
Dopo venticinque giorni di navigazione abbiamo intercettato la nave, siamo andati all’attacco, ci siamo impossessati dell’oro e dopo abbiamo appiccato il fuoco perché non restasse traccia. Abbiamo impiegato poi un mese per tornare a Tortuga, perché siamo stati sorpresi da tempeste e mareggiate. C’è voluto coraggio e temerarietà, doti che solo io e i miei uomini abbiamo.
Già si racconta che la nostra impresa passerà alla storia.
Thomas non vuole litigare, beve e, scuotendo la testa, pensa: “Che faccia tosta! Si è inventato tutto.
Due particolari mi fanno capire che sta raccontando frottole: 1.

Un galeone inglese sta veleggiando verso l’Europa. Thomas manda a Bonnet, che ormai si è stabilito a Tortuga, un messaggio perché si imbarchi segretamente sul galeone.
– Per sapere il nome del galeone devi:
1. ricomporre i proverbi unendo le parti; 2. leggere i brevi brani; 3. scrivere per ciascuno il proverbio adatto; 4. con la lettera iniziale del proverbio formerai il nome del galeone sul quale devi imbarcarti per facilitarci l’arrembaggio.
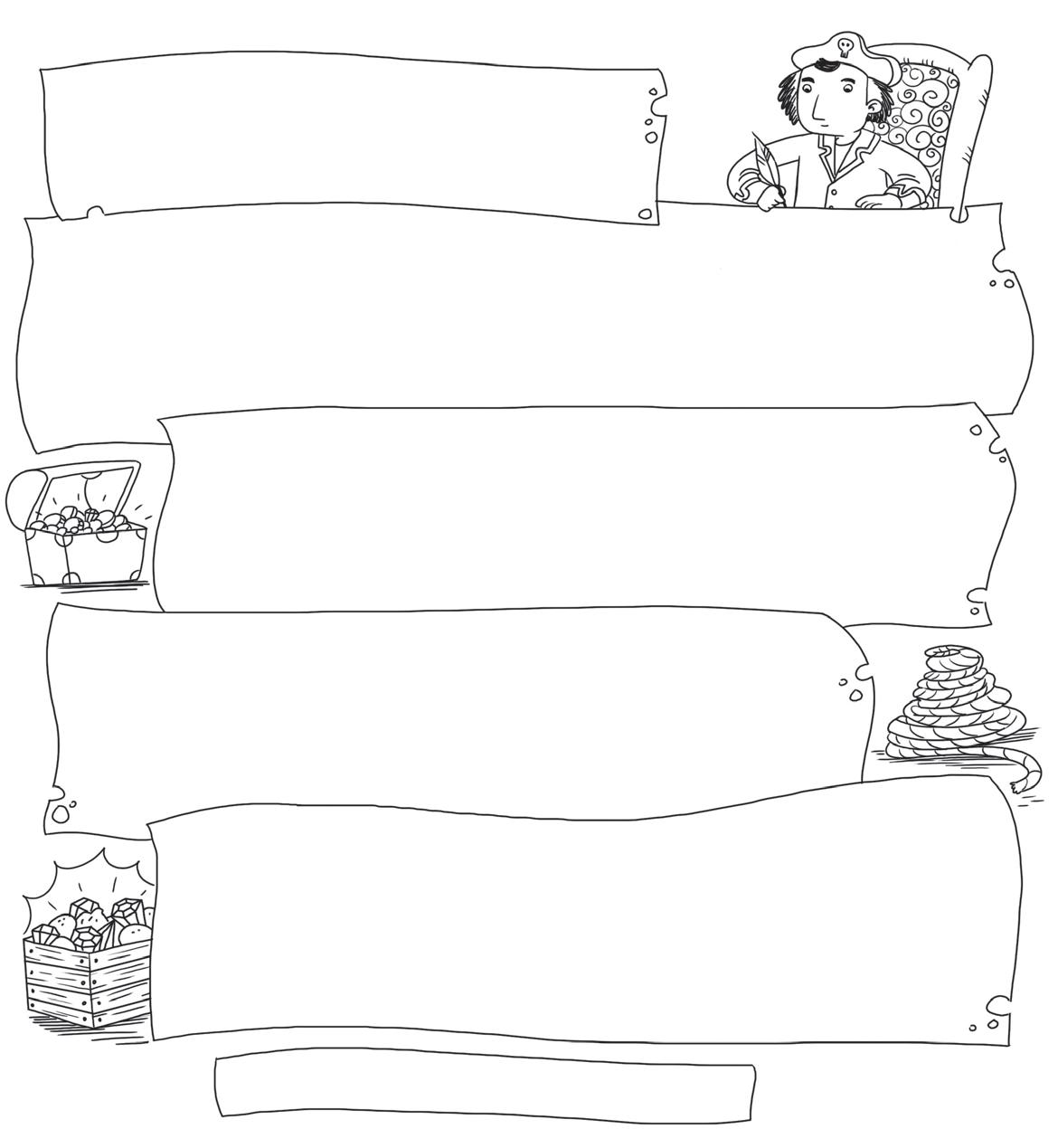
A buon intenditor…
Dal frutto…
Ogni promessa…
Non dire gatto… è debito. se non l’hai nel sacco. si conosce l’albero. poche parole bastano.
Morgan non sopportava di vedere il ponte del suo veliero in condizioni pietose.
Convocò i suoi uomini: – Ciurma, è il momento delle pulizie! – Uffa, siamo pirati, non uomini delle pulizie!
Morgan esclamò: – Se in un’ora brilla, prometto a ciascuno una pinta di rum! Quaranta minuti dopo occorrevano gli occhiali da sole per guardare il ponte della nave! E tutti bevevano rum!
Morgan, guardando una mappa, dice tra sé: “La vecchia mappa del bisnonno! È segnato il luogo in cui è nascosto il tesoro. Certamente si tratterà di un baule enorme, ci saranno tonnellate di oro. Ho già ordinato un nuovo veliero, lo armerò con potenti cannoni. Farò invidia a tutti”. È trascorso un mese e Morgan ha ancora il suo vecchio veliero!
Morgan deve imbarcare altri quattro uomini. Si è sdraiato su un mucchio di cime sulla banchina del porto. Finge di dormire ma, a occhi socchiusi, osserva i pirati che stanno caricando e scaricando le navi e pensa: “È il modo migliore per sapere chi lavora bene e per fare una scelta!”.
Il vascello di Morgan è alla rada nella baia lontana dal villaggio. A bordo c’è un carico di pietre preziose che deve essere sorvegliato giorno e notte. Morgan convoca i suoi uomini: – Ciurma, i pirati sono sempre pirati! Anche se siamo colleghi non siamo sicuri che non ci assaliranno durante la notte. Se scopro qualcuno che non fa il suo turno di guardia… Ora ciascuno al suo posto. Domani all’alba si salpa.
Il nome del galeone è ________________
Thomas sta scrivendo sul suo taccuino.
I pirati di Thomas non sanno il punto esatto in cui getteranno l’ancora, ma lo possono scoprire da ciò che ha scritto Thomas. Ecco il modo:
1. dovranno inserire le parole dell’elenco nelle frasi per completarle;
2. dovranno prendere le iniziali delle parole nell’ordine dato dai numeri e riportarle nello schema: avranno così il nome della località.
uragani • provviste • soffia • euforia • nubifragio • laguna • levante • ozio • timori • alito • diario
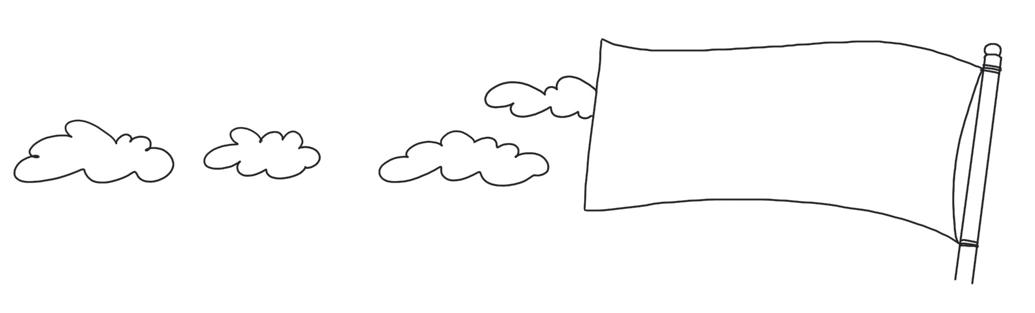
“ _______ (6) di bordo del 5 agosto.
Dall’alba non _______ (9) un _______ (5) di vento e il veliero sembra stare immobile nello stesso punto.
Non sembra neppure che la notte scorsa ci sia stato un terribile ________ (3) con lampi e tuoni che hanno illuminato a giorno il cielo.
All’orizzonte si scorgeva una tromba d’acqua: gli _______ (2) sono frequenti in questo tratto di mare e i pirati scrutavano l’orizzonte temendo per le loro vite. Per fortuna i (4) sono svaniti quando tutti abbiamo visto la colonna d’acqua allontanarsi.
Nonostante il pericolo fosse scongiurato, ho deciso di deviare dalla rotta stabilita, che puntava a ponente, per dirigermi verso _______ (8). Raggiungeremo l’Isola delle Perle e attraccheremo in una _______ (11) sicura. Quando ho comunicato alla ciurma la mia decisione, tutti sono stati presi da gioia e _______ (7)
Sull’isola faremo ___________ (1) di acqua e cibo e trascorreremo qualche giorno nell’_______ (10), a riposarci e a prepararci per una nuova avventura.”
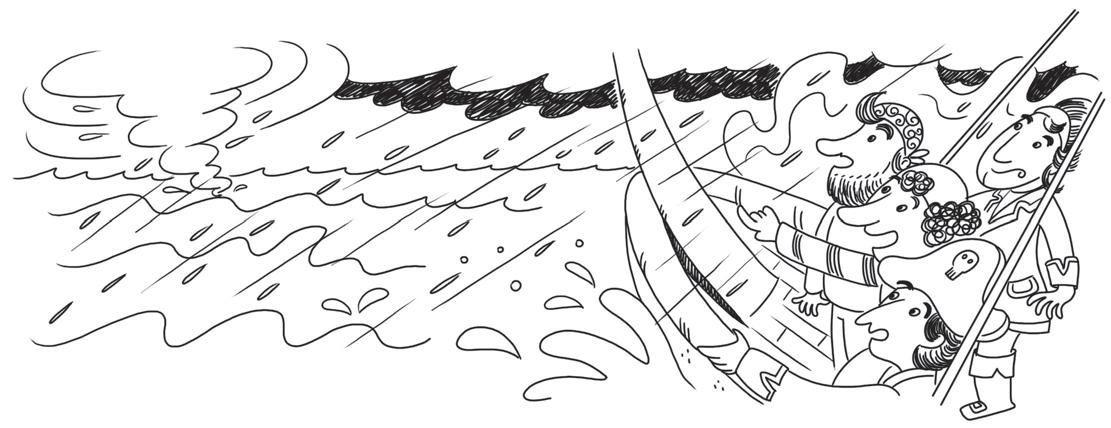
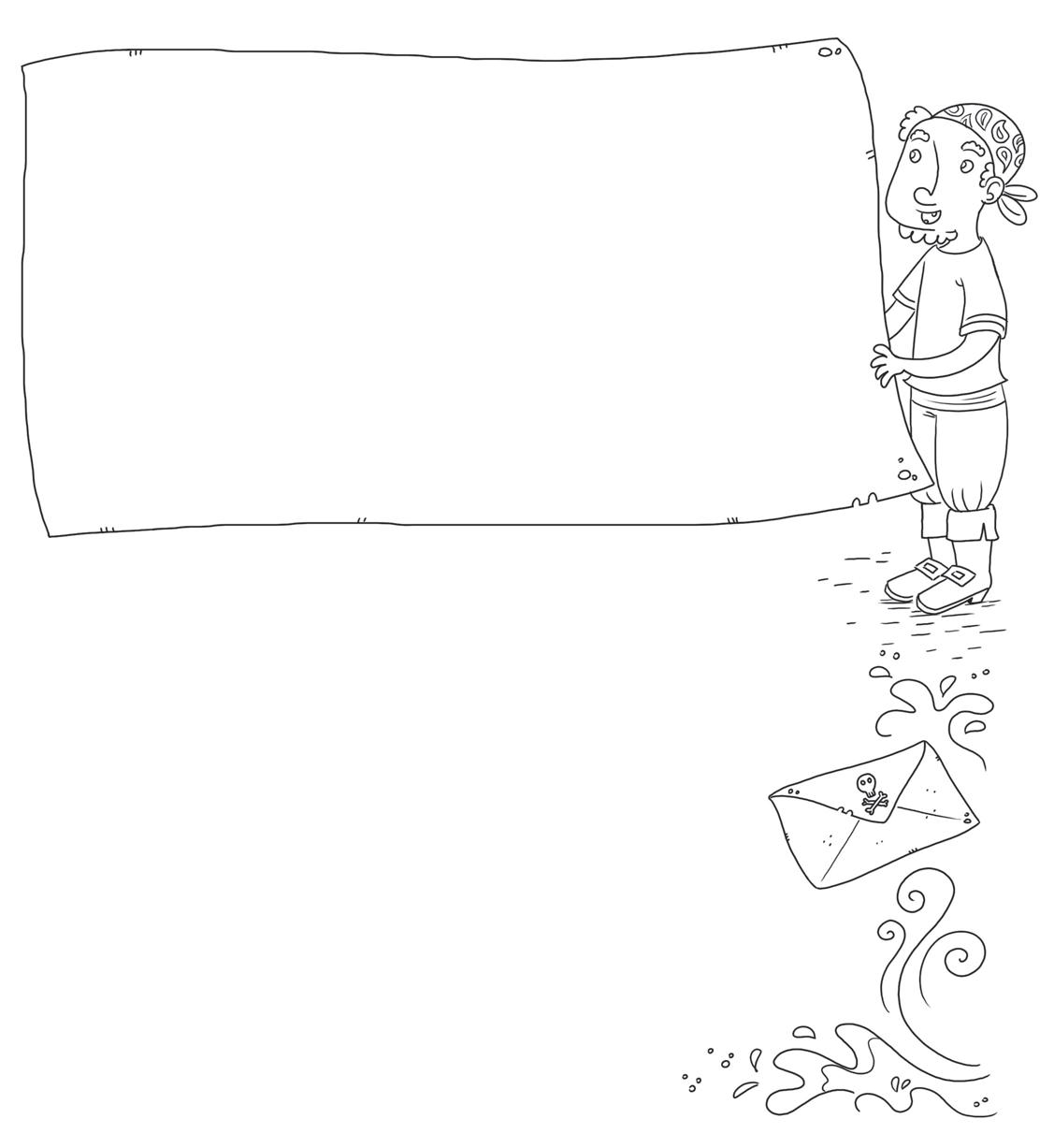
Caro Bonnet, ti invio questa lettera per mezzo di uno dei mozzi del nostro veliero. Ho scelto questo ragazzo per non dare nell’occhio. Ho dovuto omettere alcuni particolari perché, nel malaugurato caso che il messaggio non finisca nelle tue mani, nessuno deve essere in grado di comprendere quello che intendo comunicarti.
Vai nella vecchia casa dove abitavamo quando eravamo bambini. Nel pertugio che c’è nel muro sopra la porta d’ingresso troverai un involucro di pelle nel quale è contenuto un lasciapassare.
Metti il tuo nome dove c’è uno spazio vuoto e così tu diventerai a tutti gli effetti il titolare del documento che userai per presentarti al governatore di Spagna.
Quando sarai alla sua presenza mostragli il documento e riceverai da lui una lettera per me.
Fammela recapitare nel modo che tu sai e poi raggiungi Punta del Sol, dove ci ritroveremo per partire per una missione come corsari al servizio del re di Spagna.
Buona fortuna e a presto,
Thomas
Bonnet legge, ma non è sicuro di aver capito il significato di alcune parole, infatti alcune non sono chiare e si chiede che cosa vogliano dire.
Omettere
mettere in disordine tralasciare, non dire mettere in particolare rilievo
Pertugio piccola scatola di legno gancio buco, fessura
Involucro astuccio, rivestimento documento baule

Lasciapassare documento che dura un giorno permesso scritto che autorizza a passare dove è vietato lettera per un re
Titolare persona che ha il titolo di re la persona il cui nome è scritto su un documento la persona che appare nel titolo di un libro
Corsari pirati autorizzati da un re ad attaccare navi nemiche pirati che correvano per portare messaggi pirati che correvano molti rischi
Il Governatore di Spagna ha ricevuto una lettera da un suo agente segreto che gli descrive i due pirati di cui si parla dall’America all’Europa: Thomas e Rackam.
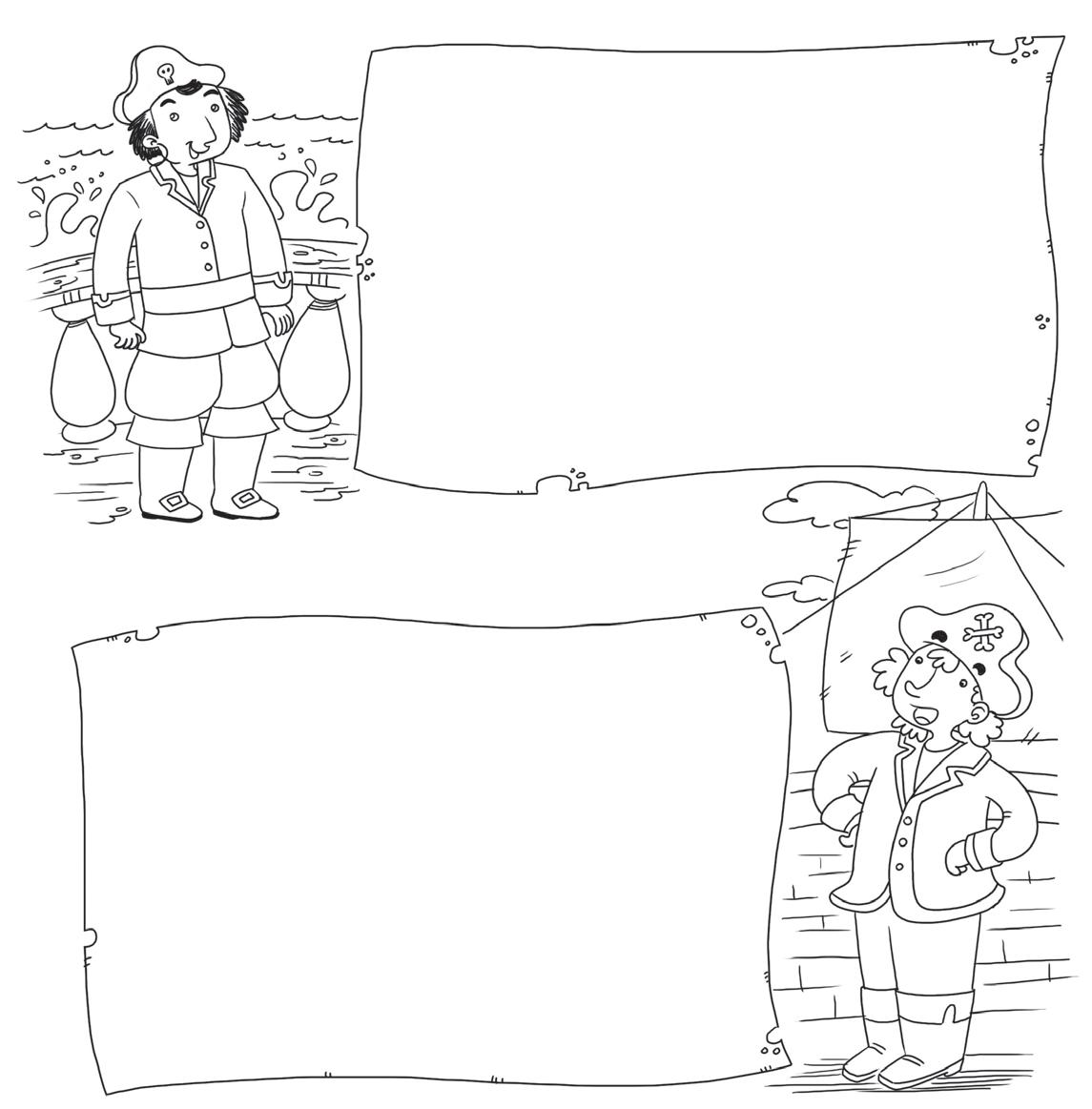
Thomas, pur essendo temuto dai capitani dei vascelli che solcano i mari con carichi preziosi, è rispettato perché non è crudele e spietato. Non ha mai issato il Jolly Roger rosso, la bandiera che, nel linguaggio dei pirati, significa morte certa; ha sempre rispettato il coraggio degli avversari, mentre ha punito chiunque si fosse macchiato di crudeltà, avesse imbrogliato o rubato qualcosa agli amici o ai più deboli. Sulla sua nave il cibo è diviso in parti uguali e non riserva per sé porzioni speciali. Non evita mai i turni di guardia e, durante l’arrembaggio, è sempre in testa ai suoi uomini per incoraggiarli e spesso mette a repentaglio la sua vita per non rischiare quella degli altri. Si batte per i deboli, che difende dalla spavalderia e dall’arroganza dei potenti.
Il Governatore, leggendo la lettera, ha detto al suo agente segreto: – Sarà un pirata, ma è un galantuomo!
Rackam si presenta a tutti in modo gentile e educato, ma basta uno sguardo ai suoi uomini, che lo seguono sempre a distanza, per capire come lo temono.
Quando va all’attacco non issa mai il Jolly Roger rosso per ingannare i vascelli che si trovano sulla sua rotta e che, non avvertendo il pericolo, non stanno all’erta.
Quando recluta i suoi uomini si accerta che sappiano tirare di spada, usare il pugnale e, soprattutto, che non si facciano intenerire. Sulla sua nave non dà regole; ognuno può fare quello che vuole, ma deve guardarsi bene alle spalle. Quando approda in una città, per prima cosa si informa su chi sia il personaggio più potente, si fa ricevere e con lui contratta affari anche a danno degli abitanti della città. Non si è mai visto una volta sul ponte della nave durante un arrembaggio.
Il Governatore sottolinea nel testo della lettera tutte le parti che dimostrano come i due pirati siano diversi, poi esclama: – Questo Rackam non è un pirata: è un delinquente! Gli darò la caccia per tutti i mari.
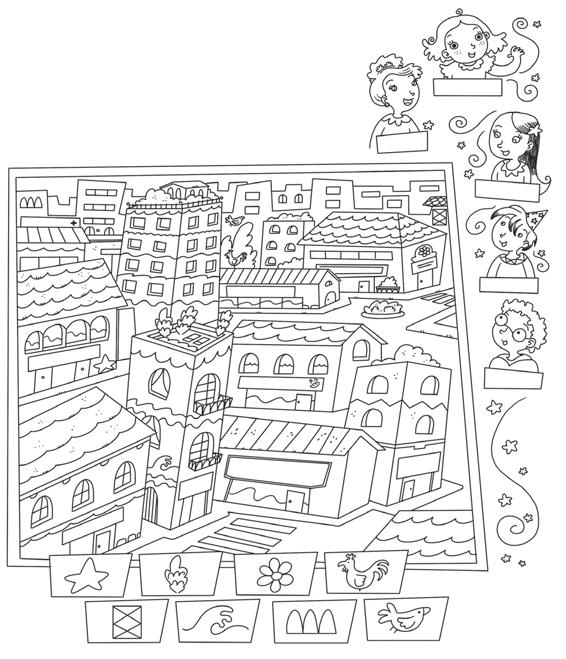
Pagina 160
I nomi si ritrovano in queste insegne:
Giglio Lavanda Gigliola
Pane Rina’s Nerina
Somari Omar
Tavola Calda Alda
Casalinghi Ling
L’oggetto perso è lo zainetto che si trova tra gli sci e l’orsacchiotto.
Pagina 161
A 12 • B 7 • C 9 • D 10 • E 13 • F 14 • G 4 • H 15 • I 1 • J 2 • K 3 • L 5
Gli oggetti che rimangono sono il n. 6, il n. 8 e il n. 11 e vengono utilizzati dal meccanico.
Pagina 162
• Tre fate hanno lo stesso cappello. Sono E, H, L.
• Ci sono due fate che hanno lo stesso ricamo sulla gonna. Sono A e D.
• Ci sono due fate che sono vestite allo stesso modo, tranne per un particolare. Sono E e H.
• La fata con una giacca nuova è G.
• Hanno le bacchette uguali B, C, D, E, G, L.
Pagina 163
Gli accoppiamenti padre-figlio sono: A 11 • B 8 • C 7 • D 9 • E 10 • F 6 • G 1 • H 2. I tre bambini di cui non si vede il padre sono i numeri 3, 4, 5. Tutti e tre hanno un animale domestico: il primo ha un trasportino per gatti, il secondo una gabbia per uccelli, il terzo un guinzaglio.
Pagina 164
Il folletto maligno è C. La sua ombra è la numero 3.
Pagina 165
I nomi delle fate, partendo da sinistra, sono: Soave, Irma, Gladis, Leda, Vera.
Pagina 166
I dieci guai combinati dalla bacchetta di Nerina sono: il pallone in mano alla statua • la zucca in testa al gelataio • il ponticello nel laghetto • il pesce spada nel laghetto • il pesce in mano al pittore • le ali al cane • il giornale con un buco • un uccello con 4 zampe • il becco d’anatra di una signora • un gatto nella carrozzina.
Pagina 167
Le parole sono: tribunale-lunedì (UN) • armadio-remare (MA) • pisolo-risotto (SO) • cannone-dinosauro (NO) • imitare-amico (MI) • angolo-fagotto (GO) • informazione-traforo (FOR) • telefono-balena (LE) • medaglia-pedale (DA) • grembiule-cabina (BI).
SONO UN MAGO FORMIDABILE
Pagina 168
Gli intrusi sono: 1. volare (non è un sostantivo) • 2. Italia (non è una città) • 3. rana (non è un mammifero) • 4. ghiacciolo (non è un aggettivo) • 5. isola (non è un rilievo) • 6. nave (non vola) • 7. imbuto (non è un verbo).
L’assistente si chiama VIRGINIA.
Pagina 169
I disegni da eliminare sono: candele-elefante • rospo-sposi • ragno-gnomo • caschi-chiodo • orologio-giocattolo • pagliaccio-cioccolato • cane-anello • termometro-tromba • ananas-naso • maniglia-liana • superman-mano • boscoscoiattolo.
Le parole che rimangono sono: arco-panchina • orso-sedia • tre-ombrello. Ne risulta la formula magica: A POSTO
Pagina 170
1. cappello • 2. cilindro • 3. solido • 4. soldo • 5. moneta • 6. euro • 7. muro • 8. parete • 9. quadro • 10. chiodo • 11. martello • 12. pesce
La frase potrebbe essere, ad esempio:
Sulla parete c’è un quadro che rappresenta un grande pesce.
Pagina 171
A • R • O • M
Un sentimento: AMOR • Una città: ROMA • Un nome di persona: OMAR • Un frutto: MORA • Una parte dell’albero: RAMO.
Rebus: P + OSSO GI + OCA + RE = POSSO GIOCARE?
Pagina 172
S P
1 I L 2 A 3 G 4
L A M R G H
E R I T A F U N O V
A A 5
L I G I A U T O S
T R 6 O V A 7
A D E U Z A
R E 8 L A
N Z A S A M E
9 T R E 10
S A D G A L L O
Pagina 173
P A T A T A
I P P O P O T A M O
P I L O T A
I S T R I C I
S E D I A
T R E N O
R O S P O
E S T A T E
L A M P O
L A M P O N E
Pagina 265
O R S O
Pagina 174
L’informazione è: IL MAGO VA A TROVARE LA STREGA
Le ali sono di pipistrello.
Le code sono di serpente.
toro orto • lepre perle • mulino lumino • limone monile • carota torace lampo – M: lapo • Lazio – LA: zio • neve – VE: ne • magi • cane – N: cae • prato – ATO: pr • montagna – M GNA: onta
La frase è: LA POZIONE MAGICA È PRONTA
Pagina 175
Le fate che mentono sono: Priscilla (Fliggy abita lì da 5 mesi, non da 5 anni) e Berenice (Fliggy non usa una vecchia scopa).
Pagina 176
Frasi che hanno il significato corretto:
• Se qualche strega ha fame, può prendere da sola i tramezzini nel frigorifero.
• Le streghe che lo desiderano avranno la possibilità di fare magie.
• Ogni tipo di magia non è difficile per Milù.
• La festa finirà dopo che è spuntato il sole.
Pagina 177
Gli accoppiamenti giusti sono: albero-ramo • mano-guanto • barca-lago • carro-ruota.
Le lettere da utilizzare sono: M 1 • A 2 • G 3 • O 4, che formano la parola MAGO.
Gli altri accoppiamenti giusti sono: favo-orso • ghiande-maiale • nave-porto • banda-tromba.
Le altre lettere da utilizzare sono: S 1 • I 2 • R 3 • O 4, che formano la parola SIRO.
Il nome del personaggio è MAGO SIRO. Il racconto è il numero 1 (perché il protagonista del n. 2 non è un mago).
Pagina 178
1. FLAUTI (AIUT) • 2. MARINAIO (AM) • 3. CESTINI (ITI) • 4. SCARPE (PRE) • 5. CONCHIGLIE (GOGELIN) • 6. PANDA (DA)
La frase è: AIUTAMI TI PREGO GELINDA
Va inserita tra queste frasi:
Anche la mia fidanzata mi ha lasciato perché non vuole più mettersi quattro maglioni per abbracciarmi!
Aiutami, ti prego, Gelinda!
Preparami una delle tue pozioni. Se ne berrò in quantità sarò meno gelato!

Pagina 180
Ha ragione Malica.
Pagina 181
I filapperi sono biscotti.
Pagina 182
• Quello della prima voce sarà un testo che dà informazioni sui ragni e può trovarsi in “Artropodi, celenterati e echinodermi”, rivista scientifica.
• Quello della seconda voce sarà un testo che racconta una leggenda sui ragni e può trovarsi in “I personaggi dei miti e delle leggende”, fascicolo dell’enciclopedia dei miti.
Pagina 184
L’ordine giusto è: A D E F B C G.
A D (si ripete il bicchiere) E (si ripete la bottiglia) F (si ripete il quadro) B (si ripete la sedia) C (si ripete il vaso) G (si ripete il particolare della finestra)
Pagina 185
Da sinistra: il primo personaggio ha perso un guanto, il terzo ha perso una scarpa, il quarto la pistola, il quinto un orecchino, l’ultimo il cappello da cuoco.
Pagina 186
I giusti accoppiamenti sono: A 13
Q 7 • R 2.
Black Jack è il numero 6.
Pagina 187
Il ricercato è quello contrassegnato con la lettera A.
Pagina 188
Il tesoriere è John, perché Bill, Fred e Tom parlavano con lui; Dave aveva la stessa opinione del tesoriere e Ringo un’opinione diversa e quindi non potevano essere lui.
I cavalli sono stati nascosti da Bill, perché Fred e il tesoriere (John) non volevano nascondere i cavalli in quel luogo; John, Dave e Ringo non hanno potuto nascondere i cavalli e a Tom non venivano affidati incarichi.
Pagina 189
I giusti accoppiamenti sono: A 1 • B 5 • C 8 • D 2 • E 7 • F 3 • G 4 • H 6 (per esclusione).
Pagina 190 C
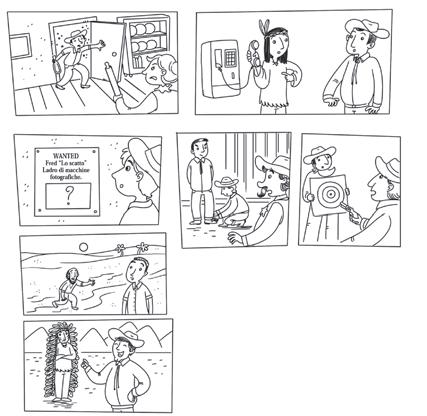
Pagina 191
I cambi sono:
Numero 1: Quando si mangia?
Numero 2: È ora che lo porti dal maniscalco.
Numero 3: Che cosa hanno combinato questi banditi?
Numero 4: Adesso siediti! Mangerai quando è il momento!
Numero 5: Little Boy, abbiamo ancora borracce di acqua?
Numero 6: Sarà meglio rifornirsi alla prossima sorgente.
Pagina 192
• La frase che risulta è: HO PERSO IL MIO CALUMET DELLA PACE
• Il calumet è sulla slitta, tra il sedile e la tenda.
Pagina 193
Le parole che si formano sono: marescialli • banconote • scalatori • metropoli • sciarpa • lettore • ferrovia • occhiali.
Pagina 194
Le parole che si formano sono: 1. grandine • 2. deserto • 3. bilancia • 4. sonnambulo • 5. telefono • 6. sot tomarino • 7. terremoto • 8. ragazzo • 9. laboratorio • 10. ananas • 11. sciabola • 12. dinosauro • 13. guerriero • 14. ravanello.
La frase che risulta è: GRANDE BISONTE SOTTERRA LA ASCIA DI GUERRA.
Una risposta possibile è la seguente: Lupo Stanco ha trovato un accordo con i nemici.
Pagina 195
I nomi che fanno rima sono: secchi-specchi • limone-bastone • stagno-cigno • faccia-braccia • montagne-castagne • ombrello-cancello • finestra-maestra • sirena-balena • canotto-biscotto • stelle-caramelle • occhio-ginocchio • conigliocespuglio.
Pagina 196
1. asso • lima • piedino • carpa • pendere • odio
2. rosso (posso) • spasso • guscio • poro • massaggiatore • pesche
3. cotto • sogno • collo • rotto • tre • lana
4. rimorso • colletto • rugiada • girotondo • paesaggio (assaggio) • dispari (impari).
Il bambino potrebbe trovare anche altre soluzioni per le parole dei gruppi 2 e 4.
Pagina 197
È iniziata la stagione della caccia.
I cacciatori cercano il bisonte.
Lupo Stanco dorme sotto l’albero.
Pagina 198
Le parole da cancellare sono: nuvola • dirigibile • mongolfiera • foglie • farfalla • quattro • elicottero • mosche • tartaruga • coccinella • zanzara • capra
La frase che ne risulta è: METTIAMO LA CARNE SOTTO SALE E LA CONSERVIAMO PER L’INVERNO
L’ha detta una delle donne.
Pagina 199
Parole anagrammate: arco • mostri • levante • lago • pirati • mora • neve • regina.
Gli indiani vogliono sentire che ARRIVA LA PRIMAVERA
Pagina 200
• Uncino spuntato sa simulare il suo handicap…
• Testa di legno è irascibile, è armato di pistola, ma tiene allegra la compagnia…
• Salomon ha fama di essere coraggioso e intrepido. Mi preoccupa il fatto che sia taciturno…
• Scricciolo non ha molta esperienza, ma il suo entusiasmo sarà contagioso…
• Barbagialla sovrasta tutti, può scrutare l’orizzonte…
• Barbariccia: anche per lui ci vuole un letto speciale…
Pagina 201
Il messaggio A si riferisce alla nave 3, che trasportava piante medicinali ed esotiche.
Il messaggio B si riferisce alla nave 4, che trasportava schiavi.
Il messaggio C si riferisce alla nave 2, che trasportava tè.
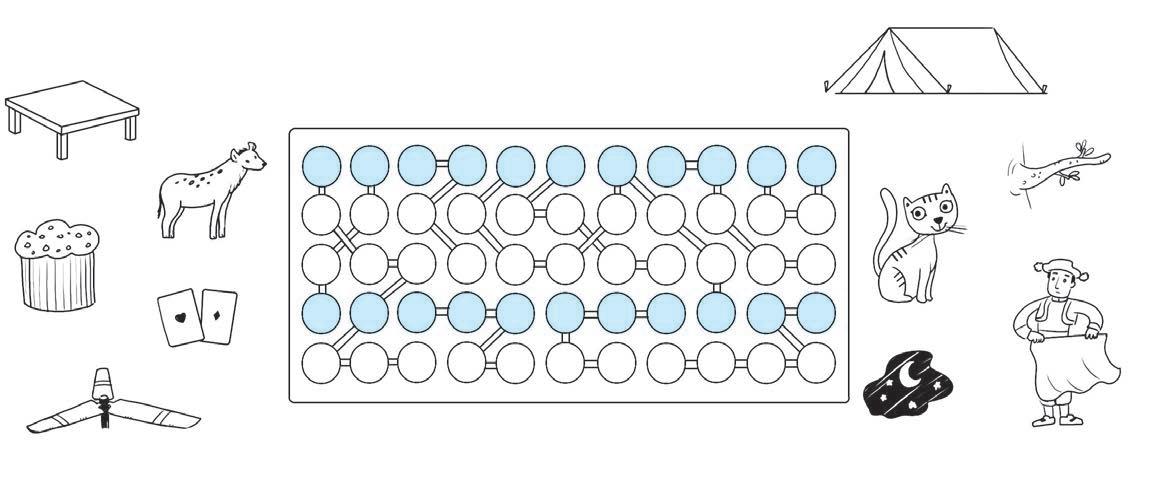
ramo • gatto • notte • torero.
T I A S P E T T E R Ò
A E S A L I T O N A M
N V O I N E C A N D A
G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
La frase A nascosta è: TI ASPETTERÒ AL GATTO NERO
Rebus:
P + oche navi L + ASCIA noi porti perla pioggia
La frase B nascosta è:
POCHE NAVI LASCIANO I PORTI PER LA PIOGGIA.
La frase B va inserita dopo ”costringono a soste forzate”.
La frase A va inserita dopo “A me è capitato”.
Pagina 203
1. Rackam dice che la nave era del re di Francia, ma poi dice che erano del re di Spagna.
2. Se la nave di Rackam ha viaggiato per 25 giorni prima di dare l’assalto alla nave e poi ha impiegato un mese per tornare, ha superato le 4 settimane di navigazione che i viveri e l’acqua gli consentivano.
Pagina 204
I proverbi sono:
A buon intenditor poche parole bastano.
Dal frutto si conosce l’albero.
Ogni promessa è debito.
Non dire gatto se non l’hai nel sacco.
A. Ogni promessa è debito.
B. Non dire gatto se non l’hai nel sacco.
C. Dal frutto si conosce l’albero.
D. A buon intenditor poche parole bastano.
Il nome del galeone è ONDA
Pagina 205
Le parole da inserire sono, nell’ordine: diario • soffia • alito • nubifragio • uragani • timori • levante • laguna • euforia • provviste • ozio.
Il nome della località è: PUNTA DEL SOL
Pagina 206
Omettere: tralasciare, non dire
Pertugio: buco, fessura
Involucro: astuccio, rivestimento
Lasciapassare: permesso scritto che autorizza a passare dove è vietato
Titolare: la persona il cui nome è scritto su un documento
Corsari: pirati autorizzati da un re ad attaccare navi nemiche
Pagina 207
Thomas, pur essendo temuto dai capitani dei vascelli che solcano i mari con carichi preziosi, è rispettato perché non è crudele e spietato. Non ha mai issato il Jolly Roger rosso, la bandiera che, nel linguaggio dei pirati, significa morte certa; ha sempre rispettato il coraggio degli avversari, mentre ha punito chiunque si fosse macchiato di crudeltà, avesse imbrogliato o rubato qualcosa agli amici o ai più deboli. Sulla sua nave il cibo è diviso in parti uguali e non riserva per sé porzioni speciali Non evita mai i turni di guardia e, durante l’arrembaggio, è sempre in testa ai suoi uomini per incoraggiarli e spesso mette a repentaglio la sua vita per non rischiare quella degli altri Si batte per i deboli, che difende dalla spavalderia e dall’arroganza dei potenti.
Rackam si presenta a tutti in modo gentile e educato, ma basta uno sguardo ai suoi uomini che lo seguono sempre a distanza per capire come lo temono.
Quando va all’attacco non issa mai il Jolly Roger rosso per ingannare i vascelli che si trovano sulla sua rotta e che, non avvertendo il pericolo, non stanno all’erta.
Quando recluta i suoi uomini si accerta che sappiano tirare di spada, usare il pugnale e, soprattutto, che non si facciano intenerire. Sulla sua nave NON dà regole; ognuno può fare quello che vuole, ma deve guardarsi bene alle spalle. Quando approda in una città, per prima cosa si informa su chi sia il personaggio più potente, si fa ricevere e con lui contratta affari anche a danno degli abitanti della città. Non si è mai visto una volta sul ponte della nave durante un arrembaggio

L’alunno e l’alunna sono davvero al centro dell’azione educativa: la classe si trasforma in un vero e proprio laboratorio nel quale, come si faceva nelle antiche botteghe artigiane, è possibile imparare il mestiere di lettore/lettrice e scrittore/scrittrice acquisendo le competenze che saranno utili nel corso della vita.
Non resta quindi altro da fare se non… cominciare a scrivere!
a cura di Emanuela Capossela e Michela Zermian
Il percorso del Laboratorio di scrittura proposto in questa queste pagine si basa sulle caratteristiche del metodo noto con il nome di Writing and Reading Workshop (Laboratorio di Scrittura e di Lettura), solo recentemente entrato a far parte del panorama italiano delle metodologie attive.
Conosciuto soprattutto come approccio all’insegnamento della scrittura e della lettura per le Scuole Secondarie di primo e secondo grado, esso si presta benissimo a essere applicato e sperimentato anche nella Scuola Primaria, fin dalle prime classi.
Il breve percorso che proponiamo si ispira ai principi che sono alla base del Writing and Reading Workshop ed è stato progettato pensando alle nostre classi e alla nostra realtà scolastica.
Esistono varie versioni di questa metodologia laboratoriale; noi abbiamo selezionato e rielaborato alcuni elementi e materiali affinché risultassero pronti e di facile utilizzo.
Alla fine degli anni ‘70, in America, Donald Gaves, educatore specializzato nel campo della scrittura, studiò in che modo bambini e bambine imparavano a scrivere focalizzando l’attenzione sul processo di scrittura
Secondo Gaves, infatti, “i bambini e le bambine ci sorprendono continuamente se glielo permettiamo. Questo è ciò che accade quando rallentiamo, ascoltiamo e lasciamo che sperimentino. Questa è la gioia sia della ricerca sia dell’insegnamento” 1 .
Sulla base di tale convinzione, l’autore suggeriva agli/alle insegnanti di: incoraggiare alunni e alunne a scegliere i propri argomenti di scrittura; dare loro l’opportunità di scrivere regolarmente (quasi ogni giorno); fare in modo che i propri alunni e le proprie alunne utilizzassero la riflessione e la revisione come strumenti naturali di scrittura; insegnare loro i meccanismi di scrittura nel contesto della lettura e della scrittura, ovvero leggendo e scrivendo.
Lo stesso modello è stato poi reso popolare negli anni ‘90 da Lucy Calkins, fondatrice del Teachers College Reading and Writing Project presso la Columbia University, e adattato anche alle classi della Scuola Primaria. Nello stesso periodo il metodo si è diffuso anche nel contesto scolastico australiano che prevedeva, nell’organizzazione dell’orario scolastico, specifici momenti dedicati all’alfabetizzazione. Ciò si prestava all’applicazione del WRW, come sosteneva la stessa Calkins: “si raccomanda un orario regolare e prevedibile del laboratorio di scrittura in modo che gli studenti e le studentesse possano anticipare, preparare e pianificare la loro scrittura” 2 .
1. D.H. Graves, Writing: teachers and children at work, Libri educativi Heinemann, 1983
2. L.M. Calkins, The Art of Teaching Writing, Libri educativi Heinemann, 1994
Molte ricerche hanno contribuito allo sviluppo del WRW come lo conosciamo noi oggi. Lucy Calkins e la sua collega Ehrenwort hanno delineato i principi-chiave che sono alla base di questo laboratorio.
Qui li sintetizziamo con l’obiettivo che essi diventino i punti di riferimento per i colleghi e le colleghe che si apprestano a proporre alle proprie classi un laboratorio di scrittura basato sul WRW.
In sintesi è necessario: stabilire un tempo per la scrittura; offrire la possibilità di scelta; fornire un feedback formativo; dare istruzioni esplicite; comunicare chiaramente gli obiettivi su cui lavorare. Per attuarlo nel modo corretto, risulta fondamentale conoscere il processo di scrittura in quanto su di esso si realizzano le mini-lezioni e si organizza l’intero percorso laboratoriale.
In generale, il processo di scrittura è costituito dalle seguenti fasi ben distinte tra loro, ma allo stesso tempo saldamente interconnesse. Vediamo quali sono:
1. la scelta dell’argomento generale, ovvero un brainstorming iniziale per raccogliere le idee;
2. la pianificazione del lavoro , ovvero la redazione di una scaletta e/o di uno schema-guida da seguire per la stesura del testo;
3. la stesura della prima bozza del testo;
4. la revisione del testo prodotto con l’introduzione di nuovi elementi come per esempio descrizioni più dettagliate o alcuni particolari, o con l’eliminazione di alcune parti inutili, o ancora con il cambio di alcune parti;
5. l’ editing del testo, ovvero l’ultima minuziosa revisione con il controllo attento dell’ortografia e della sintassi;
6. la pubblicazione , ovvero il testo definitivo pronto per essere condiviso e letto da altri.
Per ogni fase del processo di scrittura, l’insegnante può creare delle mini-lezioni volte a insegnare molte strategie utili a sostenere e sviluppare tale abilità.
I principi chiave del WRW si intrecciano tra di loro durante i tre momenti della sessione di un laboratorio di scrittura. Essi sono:
primo momento: il tempo delle mini-lezioni; secondo momento: il tempo dedicato alla scrittura individuale; terzo momento: il tempo dedicato alla condivisione con il gruppo.
Va precisato che non esiste un tempo rigido prescrittivo per ogni fase; esso è flessibile e stabilito dall’insegnante sulla base delle esigenze degli alunni e delle alunne in un dato momento. Sicuramente la mini-lezione, in quanto tale, deve avere una durata limitata e non occupare l’intera sessione di laboratorio. Ecco un’ipotesi di scansione del tempo nei tre momenti.
mini-lezione
condivisione
PRIMO MOMENTO: LA MINI-LEZIONE
È la parte del laboratorio di scrittura diretta e gestita dall’insegnante . Si tratta di istruzioni esplicite , brevi e focalizzate su un singolo argomento che tutti gli alunni e le alunne possono ampliare e di cui conoscono già alcuni elementi. È fondamentale, infatti, ricordare che si riesce a scrivere solo se si conosce già l’argomento o/e si ha un’idea su di esso, in modo che ognuno/a possa implementarlo. Lucy Calkins suggerisce di utilizzare le mini-lezioni come primo momento del laboratorio di scrittura e di riunire l’intera classe per sollevare un problema, esplorarlo, presentare una tecnica e/o rafforzare una strategia 3 Gli argomenti per le mini-lezioni possono essere i più svariati. Le/gli insegnanti possono basarsi sul curricolo della propria scuola o sulle Indicazioni Nazionali per scegliere che cosa proporre alla classe. Sarebbe bene, però, che la scelta dei testi scaturisse sempre dalle osservazioni che i/le insegnanti traggono parlando con i propri alunni e le proprie alunne, in modo da rispondere ai loro bisogni.
3. L.M. Calkins, The Art of Teaching Writing, Libri educativi Heinemann, 1994
La connessione
Una mini-lezione è breve ( 5-15 minuti ) ed è formata da tre passaggi :
1. la connessione (detta anche ancoraggio );
2. la presentazione e spiegazione dell’abilità e/o dell’argomento da affrontare o sviluppare;
3. il link o ricapitolazione di quanto presentato.
Il primo passaggio , la connessione , invita la classe all’apprendimento attivando le conoscenze pregresse. L’insegnante spiegherà l’importanza di ciò che si sta affrontando, in modo che capiscano il senso della lezione. Si può collegare la mini-lezione del giorno a quella del giorno precedente, a una ricorrenza, al tema dell’Unità Didattica di Apprendimento, a qualcosa capitato nella vita reale… È importante che l’insegnante offra delle indicazioni chiare e concise, fornendo anche un supporto grafico di ancoraggio visivo. Ai comuni poster sono da preferire grafici di ancoraggio creati con gli studenti e le studentesse durante il laboratorio, perché più attuali e significativi. Le schede-ancoraggio ( anchor chart) sono modelli da compilare/completare e tenere nel taccuino per essere rivisitate.
Presentazione e spiegazione
Ricapitolazione
Il secondo passaggio della mini-lezione è costituito dalla presentazione e dalla spiegazione dell’abilità e/o dell’argomento da affrontare o da sviluppare , ovvero dall’insegnamento vero e proprio da parte dell’insegnante.
Si tratta del cuore della mini-lezione perché è il tempo che l’insegnante impiega per spiegare in modo dettagliato e per mostrare come si fa quello che si sta spiegando. È il momento in cui l’insegnante si mette in gioco nel vero senso del termine, proponendo le sue soluzioni o quelle di un alunno o un’alunna, oppure un testo di un autore o un’autrice tratto da un libro. Prendere il testo di un autore “facilita” l’azione del/della docente, ma in base alla nostra esperienza quando l’insegnante presenta un proprio testo gli alunni e le alunne sono maggiormente motivati a cimentarsi nella stessa abilità e a seguire i consigli del proprio o della propria insegnante, che diventa così un mentore concreto, visibile.
Nel farlo (che sia con materiale proprio o di altri autori e autrici) è importante rilanciare sempre l’insegnamento con espressioni del tipo: “Avete/Hai notato come io/l’autore…? Quando scrivo… Hai notato che…? Quando gli autori/le autrici scrivono… Studiamo insieme questo testo...”.
Nel terzo passaggio, quanto appreso viene condiviso e collegato (link) all’attività svolta e a quelle eseguite nelle lezioni precedenti. Ciò permette al/alla docente di rafforzare tutto ciò che ha insegnato. Il momento dei collegamenti è un’opportunità per assicurarsi che la classe comprenda che la strategia che si è insegnata loro va aggiunta al suo repertorio di strategie di scrittura.
Nel momento conclusivo della mini-lezione, prima di passare la palla agli alunni e alle alunne che dovranno mettersi in gioco e cimentarsi nei panni di scrittori/scrittrici, sarà utile un riepilogo collettivo di quanto presentato, per accertarsi che tutti/e abbiano chiaro il da farsi.
Finita la mini-lezione, si passa alla fase del coinvolgimento attivo : è arrivato il momento di consegnare il testimone agli alunni e alle alunne offrendo loro la possibilità di provare la strategia presentata.
Si tratta del secondo step in cui organizzare il laboratorio di scrittura, quello dedicato alla scrittura individuale
La sua durata sarà maggiore rispetto alle fasi precedenti. È fondamentale che ora alunni e alunne sperimentino ciò che si è appena insegnato: potrebbero anche consultarsi con il loro compagno o la loro compagna di scrittura o di banco su come utilizzare la strategia nella loro scrittura.
L’insegnante osserva i propri studenti e le proprie studentesse per constatare e valutare la comprensione di quanto presentato.
L’ultimo momento è la condivisione. Dopo il tempo stabilito, l’insegnante convoca tutta la classe e riferisce che cosa ha notato mentre gli alunni e le alunne erano al lavoro. Inoltre chiede chi ha piacere di leggere il proprio testo (non si deve mai obbligare: è bene che siano gli alunni e le alunne a offrirsi).
L’insegnante potrebbe usare espressioni come: “Senza timori, chi vuol condividere con tutti noi il proprio componimento? Ho notato il vostro impegno/interesse e voglia di fare… Grazie per la condivisione/riflessione...”.
Recenti ricerche sulla capacità di attenzione mostrano che gli studenti e le studentesse sono più distratti e meno capaci di prestare attenzione quando la lunghezza delle spiegazioni supera i 10 minuti.
Infatti Kerry Goldwyn, professoressa alla Kent State University e uno dei principali autori dello studio (Hechingen Report 2017) di Eric Jensen Teaching with the brain in mind (2005), sostiene che gli studenti e le studentesse hanno un calo di attenzione quando l’attività didattica va oltre i 10 minuti.
I ricercatori hanno scoperto che il 25% delle attività didattiche durava più di 17 minuti, cioè durava più della tipica capacità di attenzione degli adulti, che è di 15 minuti. Jensen parla pertanto di brevità delle lezioni proprio perché il cervello umano fatica a mantenere per lungo tempo un’attenzione continua, come confermano le recenti ricerche neuroscientifiche 4
4. Per un approfondimento della tematica si suggerisce la lettura del testo P.C. Rivoltella, Neurodidattica. Insegnare al cervello che apprende, Raffaello Cortina Editore, 2012
Nel momento in cui ci siamo addentrate nella scoperta e nell’applicazione del metodo WRW, ci è apparsa subito l’immagine di una bottega rinascimentale del XV e XVI secolo in Europa.
Molte sono, infatti, le analogie tra le azioni compiute da chi lavorava nelle botteghe nel periodo rinascimentale e le azioni da compiersi in un laboratorio di scrittura basato sull’approccio del WRW.
Ecco gli elementi della Bottega di scrittura che ricordano le botteghe in cui nell’antichità si formavano gli apprendisti e le apprendiste: un/a maestro/a : ha il compito di guidare e supervisionare i lavori degli apprendisti e delle apprendiste che, per noi, sono i nostri alunni e le nostre alunne. L’insegnante è proprio come l’antico artigiano esperto che trasmette ai suoi giovani allievi e alle sue giovani allieve la propria arte, la propria specifica tecnica. Allo stesso modo, alunni e alunne sono degli apprendisti e delle apprendiste che imparano il mestiere attraverso l’osservazione e la pratica; la specializzazione : in passato esistevano varie botteghe specializzate in diverse discipline come la pittura, la scrittura, la lavorazione del legno… Proprio come nell’antichità, ogni mini-lezione del laboratorio di scrittura è estremamente specifica, per così dire specializzata, in una particolare abilità;
la pratica : gli apprendisti e le apprendiste imparavano principalmente attraverso l’esperienza pratica, assistendo i maestri e le maestre che spiegavano e mostravano le loro conoscenze, trasmettendo così direttamente il loro sapere.
È la stessa azione che compie l’insegnante nel WRW, ovvero mostrare alla classe scritti propri o testi di autori/autrici tratti da libri, per poi farla esercitare sulle singole abilità/strategie di scrittura; le collaborazioni : spesso all’interno di una bottega artisti/e diversi collaboravano per combinare le loro competenze in progetti più ampi e/o per realizzare progetti unici. Anche nel WRW l’insegnante chiede alla classe di collaborare in coppie o in piccoli gruppi per la stesura di testi e poi di condividere le proprie produzioni; la sperimentazione e l’innovazione : il periodo rinascimentale fu caratterizzato da grandi scoperte e innovazioni in campo artistico e molte botteghe diedero vita e diffusero nuove tecniche e nuovi stili. Vale lo stesso nel WRW, dove alunni e alunne possono liberamente cimentarsi e sperimentare vari stili di scrittura e provarne di nuovi; la trasmissione del sapere : le botteghe rinascimentali sono sempre state viste come luoghi in cui le tradizioni artistiche venivano trasmesse di generazione in generazione, contribuendo così allo sviluppo delle arti. Lo stesso vale per il WRW, dove il sapere e l’abilità dell’insegnante sono trasmessi ai propri alunni e alle proprie alunne tramite le esercitazioni e i momenti di “consulenza”.
Suggeriamo innanzitutto di riflettere sull’idea di laboratorio intesa come “bottega” o “officina”, ovvero come luogo in cui si crea qualcosa di originale , di proprio , costruito dalle proprie idee e con le proprie mani. È da qui che l’insegnante deve procedere per progettare l’ambiente di apprendimento adatto ad accogliere tale proposta didattica. L’ideale sarebbe predisporre un angolo dell’aula o comunque uno spazio in grado di contenere il materiale adatto a questo nuovo laboratorio.
Se si pensa a una zona specifica dell’aula, il setting5 dell’arredo dev’essere flessibile e adattabile alle esigenze di ogni alunno/a, come pure del gruppo classe.
I banchi disposti a gruppi permetteranno a tutti/e di avere un supporto anche dai pari e il nome di “Bottega di scrittura” assegnato alla parete attrezzata sottolineerà, enfatizzandolo, il carattere attivo e creativo, di fatica e sforzo per generare nuove forme di scrittura.
La parete attrezzata potrà essere costituita da un pannello adatto per scrivere, esporre e condividere appunti, organizzandolo per aree. Si potrebbe utilizzare un cartellone, anche in formato A3, con una struttura da replicare ogni volta che si lavora nella Bottega di scrittura. Nella pagina accanto vi proponiamo un esempio di organizzazione di un cartellone.
Qui sotto trovate un esempio di come potrebbe essere organizzata un’aula nel momento in cui si attiva il laboratorio di WRW.

5. Linee guida per l’implementazione dell’idea Aule laboratorio disciplinare, Indire, 2015
OBIETTIVO
STIMOLO/SUGGERIMENTO
DEL GIORNO
DATA CONDIVISIONE
IDEE
VALUTAZIONE
Come si evince osservando l’immagine, la parete attrezzata, oltre al nome “Bottega di scrittura”, deve avere degli elementi specifici e ben organizzati:
1. è fondamentale rendere visibile ed esplicito l’ obiettivo della sessione di laboratorio : scriverlo può essere d’aiuto per gli alunni e le alunne;
2. scrivere la data e documentare i vari planning di lavoro permette di ricostruire l’intero percorso, utile sia per l’insegnante in un’ottica valutativa e progettuale sia per alunni e le alunne in senso metacognitivo, ovvero di riflessione su quanto prodotto;
3. lo stimolo/suggerimento dato dall’insegnante con il testo scelto (proprio o altrui) è un aiuto e un supporto fondamentale nel processo di esercitazione per la classe. Poterlo consultare al bisogno, senza doverlo chiedere e/o fotocopiare ogni volta, rappresenta un vantaggio sia in termini di tempo sia in termini di spreco della carta;
4. lo spazio delle idee rappresenta il contenitore per fissare i suggerimenti proposti dagli alunni e dalle alunne;
5. l’ area della condivisione è lo spazio lasciato libero per permettere agli alunni e alle alunne di appuntare i loro lavori in caso volessero condividerli con la classe. In alternativa, l’insegnante prepara e attacca i grafici di ancoraggio 6 , utili a tutti/e per concentrarsi su un’abilità specifica durante una mini-lezione. Questi sono un valido strumento per supportare l’istruzione: delle vere e proprie “ancore” di memoria da consultare in caso di necessità.
I grafici possono essere disegnati e prodotti al momento dall’insegnante o/e possono essere preparati precedentemente e consegnati in un secondo momento. Alunni e alunne pos sono incollarli nel proprio quaderno/ taccuino di scrittura o inserirli in un apposito raccoglitore di facile consultazione;
6. abbiamo pensato di aggiungere la valutazione per ogni sessione: qui sarà l’insegnante a scegliere la modalità più adatta per chiedere un feedback su quanto svolto, invitando semplicemente a spuntare l’icona scelta o a farla disegnare a turno.

Oltre alla parete attrezzata, l’aula dovrebbe essere dotata di arredi dove poter riporre i materiali come i quaderni o i taccuini. Ciò faciliterà la creazione di routine utili anche alla gestione della classe, così come la compilazione/aggiornamento del pannello. Accanto al pannello potrebbe essere collocata l’ area della condivisione (detta anche area meeting e/o reading zone ): uno spazio dedicato al confronto degli alunni e delle alunne con sedute comode, dove tutti/e possano sentirsi liberi/e di esprimere le proprie idee o perplessità e leggere quanto prodotto. In uno spazio ben riconoscibile va inoltre collocata la zona consulenza , che offre all’insegnante il tempo necessario per poter parlare e confrontarsi maggiormente con i singoli alunni e le singole alunne, diventando così un luogo di fondamentale importanza per il processo di apprendimento-insegnamento. Le consulenze sono un momento fondamentale nel laboratorio di scrittura in quanto in esse: l’insegnante e gli alunni e le alunne possono dialogare e interagire più facilmente in un rapporto singolo; gli alunni e le alunne possono proporre liberamente all’insegnante un argomento particolare; gli alunni e le alunne possono chiedere informazioni sui progressi compiuti; l’insegnante prende appunti affinché gli alunni e le alunne possano ricevere suggerimenti.
Le consulenze rappresentano un’opportunità per fornire supporto e creare fiducia offrendo al contempo feedback specifici e mirati e in questo modo realizzando appieno una valutazione formativa per l’apprendimento.
6. D.H. Graves, Writing: teachers and children at work, Libri educativi Heinemann, 1983
1. Schedeancoraggio
2. Idee
3. Obiettivi
Durante ogni sessione di lavoro, l’ organizzazione del materiale diventa un elemento fondamentale per una buona riuscita. Ecco il motivo per cui è richiesto l’ uso del taccuino . Si tratta di uno strumento importante per alunni e alunne in quanto è il luogo in cui conservare idee e informazioni e scrivere liberamente, fungendo da mini-libro di riferimento durante il proprio processo di scrittura. Il taccuino deve essere maneggevole : per tale motivo sarebbe opportuno utilizzare un formato A5. Si possono usare dei mini-quaderni con una copertina rigida, in modo da rendere il taccuino accattivante per alunni e alunne e prezioso ai loro occhi. Il taccuino o mini-quaderno può essere suddiviso in varie parti per organizzare meglio il materiale. Avere una sezione dedicata a ciascuna fase di scrittura permette ad alunni e alunne di avere tutto ciò di cui hanno bisogno a portata di mano e soprattutto dà loro la possibilità di consultare e scrivere in modo ordinato e organizzato.
L’insegnante può proporre di dividerlo in quattro sezioni : 1. schede-ancoraggio; 2. idee; 3. obiettivi; 4. scrittura libera.
La sezione “schede-ancoraggio” dovrebbe essere ordinata, precisa, curata e la più cospicua delle quattro in quanto in essa si raccolgono tutte le informazioni delle mini-lezioni affrontate durante l’anno scolastico.
Nella sezione idee alunni e alunne annoteranno tutte quelle che verranno loro in mente. Appuntare su tale sezione tutte le idee permette di acquisire un’ottima abitudine per diventare abili scrittori e scrittrici.
Nella sezione obiettivi, ogni bambino/a annoterà quelli che si prefigge di raggiungere mentre scrive. Potrebbero essere legati alla lunghezza del componimento, alla correttezza ortografica, all’originalità, all’accuratezza lessicale. Si tratta anche di un’azione metacognitiva e autovalutativa: scrivendo i propri obiettivi e con il supporto e la guida dell’insegnante nei momenti di confronto nella zona consulenza, alunni e alunne hanno l’occasione di poter riflettere sulle proprie capacità per continuare a migliorare.
4. Scrittura libera
Nella sezione di scrittura libera , infine, gli alunni e le alunne si eserciteranno nella scrittura di testi, seguendo le indicazioni fornite dall’insegnante.
Lo scopo della valutazione nella sezione di WRW della Bottega di scrittura è quello di fornire istruzioni che aiutino gli alunni e le alunne a diventare abili scrittori e scrittrici, offrendo loro il giusto incoraggiamento e supporto.
La valutazione è integrata nell’approccio all’insegnamento della scrittura in ogni sua fase: essa inizia ancor prima che cominci il processo di scrittura con la definizione degli obiettivi misurabili da parte dell’insegnante ed esplicitati al gruppo classe. Così facendo l’insegnante coinvolge fin da subito, in modo attivo, alunni e alunne rendendoli consapevoli delle azioni da compiersi per raggiungere l’obiettivo prefissato.
L’iter valutativo segue l’intero percorso d’insegnamento: durante la fase del coinvolgimento, quando alunni e alunne sperimentano la strategia insegnata, l’insegnante si muove, camminando tra i banchi, per osservarli quando parlano tra di loro e/o quando applicano i suggerimenti forniti. Si tratta di un’occasione per valutare in modo informale se hanno compreso la strategia e se riescono ad applicarla alla propria scrittura. Mentre l’insegnante si muove, può tener d’occhio gli alunni e le alunne che sembrano essere confusi o che hanno difficoltà ad applicare quanto proposto. È bene annotare i loro nomi in modo da poterli riunire in un nuovo piccolo gruppo subito dopo la mini-lezione e fornire loro l’occasione di un’ulteriore spiegazione.
Un trucco per rendere tale azione meno visibile agli occhi di tutta la classe è quello di assegnare una card con un orologio o un altro simbolo che dia il via libera a un ulteriore chiarimento, nell’area della condivisione, su quanto appena presentato.
A pag. 268 di questa Guida troverete due possibili modelli di card da replicare.
L’insegnante può dotarsi di una griglia d’osservazione per prendere nota di tutti gli interventi e dei comportamenti di ogni componente della classe durante lo svolgimento della sessione di scrittura.
Ecco il modello di una possibile griglia osservativa.
osservativa
Indicatori Registrazione della frequenza dell’evidenza da osservare Alunno/a Alunno/a Alunno/a Alunno/a Alunno/a Alunno/a Alunno/a Alunno/a Data
Si attiva in modo autonomo. Pianifica.
Recupera le informazioni.
Rispetta i tempi.
Chiede aiuto se in difficoltà.
Si confronta con i pari.
Rispetta le regole del Laboratorio di scrittura.
I criteri osservativi utilizzati potrebbero essere i seguenti: Sì/No/In parte. Nella tabella, le osservazioni possono essere registrate usando la sintesi dei criteri: S, N, IP.
Oltre alla valutazione basata sia sull’osservazione sia sui testi prodotti dagli alunni e dalle alunne, l’insegnante può avvalersi dello strumento dell’ autovalutazione per raccogliere ulteriori “appunti” su come ha lavorato ciascuno/a.
Un ottimo strumento è l’introdurre una routine autovalutativa che noi abbiamo chiamato “ Pensieri allo specchio ”. Si tratta di fornire a ogni alunno/a un biglietto a forma di specchio, proprio come quello della strega di Biancaneve.
A pag. 268 di questa Guida ne trovate un modello. Come la matrigna cattiva della storia, ogni alunno/a si interrogherà chiedendosi come ha lavorato in base alle domande che l’insegnante porrà di volta in volta.
Questa routine autovalutativa può essere proposta al termine di ogni sessione o alla fine di più sessioni del laboratorio, in base agli obiettivi che l’insegnante si è prefissato/a. Si tratta di un’attività metacognitiva basata sulla riflessione: quest’ultima gioca un ruolo fondamentale nel processo di scrittura in quanto aiuta alunni e alunne a riflettere su quanto svolto durante il lavoro.
Per questa routine autovalutativa sono necessari: un taccuino o un quaderno; un timer; una serie di domande 7 .
Il timer serve all’insegnante per calcolare il tempo da dare agli alunni e alle alunne. È importante infatti saper attribuire il giusto tempo, né eccessivo né limitato. Alunni e alunne devono riuscire a concentrarsi, nel tempo stabilito, per riflettere con efficacia su quanto svolto.
Vi proponiamo qui alcune possibili domande e indicazioni da sottoporre alla classe: ogni insegnante può decidere di utilizzarle e/o di proporne di nuove.
In che modo il testo scelto dall’insegnante ti ha aiutato?
Come ti senti quando scrivi?
Ti senti pronto/a quando l’insegnante ti dice l’argomento su cui scrivere?
Come ti senti quando affronti un argomento nuovo?
Ti piace scrivere insieme a un tuo compagno o una tua compagna?
Ti piace condividere con la classe il tuo testo?
Quale momento del laboratorio di scrittura ti piace di più?
Quale parte del processo di scrittura ti piace di più?
Quando hai bisogno di aiuto nel laboratorio di scrittura?
Qual è il momento che ti piace di meno quando scrivi?
In che cosa ti senti meno abile quando inizi a scrivere?
Scrivi un elemento positivo e uno negativo del laboratorio di scrittura.
Scrivi tre parole per esprimere quello che provi quando scrivi.
Fai un disegno che esprima la tua idea di scrittura.
Vorresti partecipare a più momenti di condivisione collettiva?
Vorresti che la condivisione avvenisse solo con l’insegnante?
Ti sei mai sentito/a scoraggiato/a di fronte a un argomento da sviluppare?
Qual è il momento più importante per te quando scrivi?
7. Le domande suggerite sono state tradotte e riadattate dal libro di B. Kissel, When Writers Drive the workshop: Honoring young voices and bold choices, Ed. Stenhouse, 2017
La migliore strategia per l’insegnante in un laboratorio di scrittura è una valida organizzazione.
Fissate dei giorni e degli orari precisi, stabili e prevedibili per il lavoro sul laboratorio, per permettere ad alunni e alunne di anticipare, preparare e pianificare la loro scrittura.
Proponete il laboratorio fin dai primi giorni di scuola. Create delle routine e delle procedure stabili: ciò vi permetterà di avere un maggior controllo del gruppo classe e degli spazi.
Cercate di usare il vostro esempio per insegnare le strategie di scrittura almeno tre volte durante la mini-lezione (alla fine dell’ancoraggio, durante l’insegnamento e nel collegamento finale).
Controllate il tempo: è importante mantenere le mini-lezioni concise in modo da non invadere il tempo di scrittura indipendente degli studenti e delle studentesse. Usate un timer per tenere d’occhio l’ora e, se vi accorgete che le mini-lezioni durano troppo, scoprite quale parte sta impegnando più tempo e riprogettatela. Dedicate molto tempo ad abituare gli alunni e le alunne alla revisione.
Vi proponiamo una visualizzazione schematica dell’architettura di base di una sessione del laboratorio di scrittura, vista dalla parte dell’insegnante con le azioni da compiersi.






OBIETTIVO (focus) → riferire alla classe esattamente che cosa impareranno oggi, in modo preciso e diretto.
COLLEGA (connessione) → ricordare al gruppo qualcosa di familiare e/o alcune conoscenze pregresse e/o un aneddoto legato a un episodio reale, che si collega all’insegnamento di oggi.
CONCENTRATI (spiegazione) → esplicitare l’argomento/la strategia del giorno, anche con l’aiuto della scheda di ancoraggio.
ESERCITATI (dimostrazione) → usare un esempio molto chiaro per dimostrare l’obiettivo della mini-lezione. Può essere un esempio creato dall’insegnante oppure un testo scritto da un alunno o un’alunna o ancora un testo d’autore (mentore).
CREA E SCRIVI (impegno attivo) → invitare ogni alunno/a a sperimentare la strategia appena presentata producendo qualcosa di veloce e breve. Basta un campione!
CONDIVIDI (condivisione) → è il momento di condividere quanto eseguito con i compagni e le compagne e/o di leggere altri esempi di scrittura.
La condivisione non va mai forzata: nel caso in cui qualcuno/a non se la sentisse, sarà l’insegnante a proporre nuovi esempi.
Una precisazione: ogni sessione di lavoro deve essere svolta in classe, sotto la guida e il monitoraggio costante dell’insegnante e non può essere assegnata come lavoro per casa. Ciò non rispecchierebbe l’idea di laboratorio e verrebbero meno tutti i principi su cui si basa il WRW.
Prima di iniziare il laboratorio vero e proprio, è bene proporre alla classe alcune lezioni introduttive con lo scopo di avvicinare gradualmente alunni e alunne al momento di scrittura autonoma e creativa
Si propongono tre sessioni di laboratorio così organizzate:
1. la prima si focalizza sul far comprendere al gruppo classe che cosa sia una bottega di scrittura al fine di rendere tutti/e consapevoli di quanto è loro richiesto;
2. la seconda si pone come obiettivo quello di costruire e predisporre l’ambiente di apprendimento con alunni e alunne per renderli partecipi nel processo di insegnamento-apprendimento;
3. la terza mira a far riflettere alunni e alunne sul comportamento da attuare nel momento in cui si apprestano a dedicarsi alla scrittura.
È necessario far comprendere agli alunni e alle alunne che cosa si intenda per “Bottega di scrittura” . La bottega è un luogo dove si lavora per creare, costruire oggetti.
Obiettivo : spiegare alla classe come è organizzata la Bottega di scrittura e che cosa ci si aspetta.
Valutazione dell’apprendimento : l’insegnante osserva l’impegno e la partecipazione di ogni alunno/a all’attività proposta.






OBIETTIVO Oggi gli alunni e le alunne impareranno che cosa si intende per laboratorio/bottega di scrittura.
COLLEGA (connessione/ancoraggio) In questa prima mini-lezione introduttiva l’insegnante lancia l’argomento chiedendo: “Che cosa succede in una bottega in cui qualcuno costruisce un tavolo?”.
CONCENTRATI L’insegnante mostra l’immagine di una bottega e invita gli alunni e le alunne a raccogliere le idee.
ESERCITATI L’insegnante invita gli alunni e le alunne a fare una ricerca e delle ipotesi di risposta. Come stimolo, può proporre come esempio il processo di costruzione di un oggetto partendo dall’idea, poi passando a uno schizzo, alla scelta dei materiali…
Suddivide la classe in piccoli gruppi da quattro componenti.
CREA E SCRIVI (impegno attivo) Gli alunni e le alunne propongono una lista delle fasi necessarie per costruire l’oggetto scelto in una bottega.
CONDIVIDI (riflessione finale) L’insegnante fa notare che sembrano gli stessi passaggi necessari per scrivere qualcosa. Propone quindi una mini scheda “àncora” utile per fissare gli argomenti/le abilità da ricordare, che deve essere incollata sul taccuino in modo che gli alunni e le alunne possano facilmente consultarla anche in seguito.
SECONDA SESSIONE: COME ORGANIZZARE LO SPAZIO DEL LABORATORIO
Risulta importante allestire e organizzare lo spazio dell’aula coinvolgendo alunni e alunne . Così facendo, si sentiranno veri protagonisti del processo di apprendimento.
Obiettivo : coinvolgere direttamente alunni e alunne per predisporre arredi e strumenti/ materiali per organizzare l’aula nel momento della scrittura.
Valutazione dell’apprendimento : l’insegnante osserva l’impegno e la partecipazione di ogni alunno/a all’attività proposta.



OBIETTIVO Oggi gli alunni e le alunne predisporranno lo spazio individuato per allestire la Bottega della scrittura, scegliendo la disposizione dei banchi e allestendo la parete tematica.
COLLEGA (connessione/ancoraggio) In questa seconda mini-lezione introduttiva l’insegnante lancia la sollecitazione al gruppo: “Come potremmo organizzare lo spazio dell’aula per poter scrivere?”.
CONCENTRATI L’insegnante fa alzare alunni e alunne e dice loro di posizionarsi accanto alla porta dell’aula o in una zona in cui possano avere una visione completa dello spazio che hanno a disposizione. Dopo l’osservazione, consegna a ciascuno/a una piantina dell’aula. Individualmente, per pochi minuti, rifletteranno su come allestire lo spazio, elaborando delle proposte da sottoporre al resto del gruppo.



ESERCITATI L’insegnante invita gli alunni e le alunne a dividersi in gruppi al massimo di quattro componenti per elaborare la propria proposta. Ogni componente del gruppo espone le proprie idee e successivamente il gruppo ne elabora una inserendo almeno un suggerimento di ogni singolo membro. Si tratta di un vincolo che deve essere rispettato in quanto permette a tutti/e di apportare il proprio contributo. L’insegnante può mostrare come modello alcune immagini tratte dal web che mostrano delle aule predisposte e quella della parete attrezzata.
CREA E SCRIVI (impegno attivo) Ogni gruppo propone il proprio allestimento. Un membro di ciascun gruppo esporrà agli altri quanto proposto.
CONDIVIDI La classe, con voto segreto come in una vera elezione politica, sceglierà l’allestimento e la disposizione più funzionale all’attività di scrittura. Ciò permetterà di fare un collegamento con l’Educazione Civica, introducendo il concetto di democrazia. La proposta che riceverà più voti sarà quella da realizzare.
A pag. 249 di questa Guida trovate la scheda-ancoraggio relativa a queste due prime sessioni.
TERZA SESSIONE: COME COMPORTARSI?
Quest’ultima sessione introduttiva ha lo scopo di decidere insieme al gruppo classe le regole di comportamento/atteggiamento da rispettare quando ci si dedica alla scrittura. Ciò dovrebbe facilitare il coinvolgimento di tutti e tutte ed avere come conseguenza la capacità di ognuno/a di mantenere un atteggiamento il più consono possibile all’attività proposta.
Obiettivo : coinvolgere direttamente alunni e alunne nella decisione delle regole da rispettare durante la sessione dedicata alla scrittura. Valutazione dell’apprendimento : l’insegnante osserva l’impegno e la partecipazione di ogni alunno/a all’attività proposta.




OBIETTIVO Oggi gli alunni e le alunne decideranno le regole e il corretto atteggiamento da adottare per facilitare e sostenere il processo di scrittura.
COLLEGA (connessione/ancoraggio) In questa terza mini-lezione introduttiva l’insegnante lancia la sollecitazione al gruppo: “Quali regole stabilire per stare bene durante il tempo di scrittura?”.
CONCENTRATI L’insegnante invita a riflettere individualmente su quali regole/azioni gli alunni e le alunne pensano di dover rispettare per riuscire a sfruttare al meglio il tempo dedicato all’attività.
ESERCITATI Si formano gruppi al massimo di quattro componenti e si propone loro la mappa (vedi pag. 267 di questa Guida). L’insegnante spiega alla classe come compilarla: ogni membro del gruppo scriverà la propria proposta in un riquadro laterale e solo successivamente si sceglieranno le regole/azioni che il gruppo proporrà alla classe, scrivendole nel riquadro al centro.


CREA E SCRIVI (impegno attivo) Ogni gruppo propone le proprie regole: sarà un solo membro per ciascun gruppo a esporre agli altri quanto proposto.
CONDIVIDI La classe sceglierà le regole/azioni migliori mediante votazione per alzata di mano. L’insegnante scriverà alla lavagna le regole proposte da ciascun gruppo. Alunni e alunne voteranno ogni singola regola. Le più votate saranno quelle che andranno appese alla parete/angolo di scrittura e riportate da ciascuno/a nel taccuino.
A pag. 267 di questa Guida trovate la mappa da compilare.
Il percorso che proponiamo per la classe quarta mira a fornire agli alunni e alle alunne la conoscenza di base delle principali caratteristiche per poter scrivere un testo narrativo completo nelle sue parti.
In questa Guida, troverete 12 sessioni, ognuna delle quali è formata da una mini-lezione a cui segue il momento di scrittura autonoma e la successiva condivisione.
Sessione con mini-lezione Argomento Scheda di ancoraggio
1. La struttura del testo narrativo: la situazione iniziale L’inizio del testo Lo sviluppo La conclusione
2. La struttura del testo narrativo: lo sviluppo
3. La struttura del testo narrativo: la conclusione
4. Gli elementi del testo narrativo: i personaggi I personaggi con la spiegazione dei vari ruoli
5. Gli elementi del testo narrativo: il narratore/la narratrice Il narratore/La narratrice
6. Gli elementi del testo narrativo: le sequenze Le sequenze
7. Gli elementi del testo narrativo: le diverse tipologie di sequenze
8. Gli elementi del testo narrativo: la fabula La fabula, l’intreccio e il flashback
9. Gli elementi del testo narrativo: l’intreccio
10. Gli elementi del testo narrativo: il flashback
11. Gli elementi del testo narrativo: il discorso diretto e indiretto Il discorso diretto e indiretto
12. Gli elementi del testo narrativo: il tempo Il tempo
Come già detto, per le mini-lezioni si consiglia di non superare i 15 minuti di spiegazione, mentre per la parte da dedicare alla scrittura con la revisione è bene non dare troppe limitazioni di tempo alla classe. Si sa che il processo di scrittura, essendo un atto personale e creativo, può determinare tempi diversi. Per tale motivo, anche la fase di revisione deve essere molto curata e si dovrà calibrare il giusto tempo da dedicarvi.
In particolare nelle prime tre mini-lezioni (pagg. 237-238-239 di questa Guida) si affronta la struttura del testo narrativo con l’obiettivo di esercitare la capacità degli alunni e delle alunne di costruire un testo ben articolato nelle sue tre parti.
Per tale motivo la classe lavorerà su un unico testo che scriverà pezzo per pezzo fino a quando sarà pronto per la “pubblicazione” e/o la lettura di altri/e.
Seguono poi le mini-lezioni che approfondiscono singoli element i del testo narrativo.



INDICAZIONI METODOLOGICHE
Si propongono qui di seguito alcune indicazioni metodologiche utili per l’insegnante per gestire le varie sessioni di lavoro.
Suggerimenti metodologici
• Esplicitare sempre in modo semplice che cosa alunni e alunne impareranno nella sessione.
• Lanciare l’argomento e/o la suggestione in modo che siano spinti/e a riflettere e a concentrarsi su ciò che affronteranno.
• Fissare la conoscenza e/o la strategia che si vuole insegnare leggendo la spiegazione e riportandola, integrandola o riassumendola, nella schedaancoraggio. Quest’ultima deve essere compilata in modo ordinato e colorata in modo da colpire e facilitare il ricordo.
La stessa scheda-ancoraggio può essere replicata in un cartellone o in una presentazione web ed essere mostrata durante la mini-lezione.
• Proporre un proprio testo come incipit di un racconto. Ci si può limitare a leggere il testo presente nel quaderno operativo dell’alunno/a o proporne un altro simile, come quello qui accanto. Ciò potrebbe aiutare quegli alunni e quelle alunne che sono in difficoltà nell’iniziare la scrittura.
• Avviare la fase di scrittura creativa individuale. In questo momento, se si nota che alcuni alunni o alcune alunne hanno necessità di un’ulteriore spiegazione, si fornisce loro la card per poter accedere all’area della condivisione.
• Condividere con il gruppo quanto si è svolto. La sessione risulterà terminata quando tutta la classe si sarà cimentata nel processo di scrittura proposto. La condivisione può essere eseguita in varie modalità. Vale sempre la regola: mai forzare nessuno a leggere un proprio scritto ad altri/e o a farlo leggere da altri/e se non se la sente.
Eventuale testo da proporre
Nel prato del giardino di Pietro viveva un topolino di nome Rocky, piccolo ma coraggioso. I suoi lunghi denti lo facevano sembrare un combattente battagliero, sempre pronto a difendersi dagli intrusi. Rocky aveva un grande desiderio: esplorare il mondo al di là della rete del giardino. Così un giorno, mentre il sole splendeva alto nel cielo, decise che era arrivato il momento di vivere la sua grande avventura.
Inoltre, per stimolare il processo di scrittura, si consiglia di: suggerire ulteriori strategie per la ricerca delle idee e delle parole: word-list, storyboard…; incentivare l’uso del taccuino per annotare osservazioni, parole, riflessioni; valorizzare gli sbagli, gli errori come opportunità per sviluppare altre idee; permettere agli alunni e alle alunne di “pasticciare” con la scrittura, perché nella bottega “ci si sporca”; apprezzare soluzioni originali e inconsuete; invitare gli alunni e le alunne a raccontare, a voce o per iscritto, il percorso che li ha portati al prodotto finale: sarà un modo per riflettere e prendere coscienza del proprio modo di agire.
A ogni mini-lezione è collegata una scheda-ancoraggio , che trovate nelle pagine 249266 di questa Guida. Le schede-ancoraggio sono strumenti utili per fissare alcune strategie e poterle consultare all’occorrenza. Di ognuna proponiamo due versioni : una compilata , che resterà all’insegnante, e una da completare , che potrà essere fotocopiata e data agli alunni e alle alunne per permettere loro di riflettere e approfondire ulteriormente gli elementi presentati nella mini-lezione.
SITOGRAFIA
www.teachstarter.com
www.weareteachers.com
www.education.vic.gov.au
www.italianwritingteachers.it
• B.A. Bucknen, Competenze sui taccuini: strategie per il taccuino dello scrittore, Portland ME: Stenhouse, 2005
• L. Calkins, L’arte di insegnare a scrivere, Portsmouth NH: Heinemann, 1994
• L. Calkins, Un piano curricolare per il laboratorio di scrittura, Grade k, Portsmouth NH: Heinemann, 2011
• L. Calkins - M. Ehrenwort, Scrittori straordinari in crescita: decisioni della leadership per aumentare il livello della scrittura in una scuola e in un distretto. L’insegnante di lettura 70 (1), 2016
• E. Golinelli - S. Minuto, Lettori e scrittori crescono, Pearson Academy, Torino, 2021
• H. Graves, Writing: teachers and children at work, Libri educativi Heinemann, 1983
• B. Kissel, When Writers Drive the workshop: Honoring young voices and bold choices, Ed. Stenhouse, 2017
Writing and Reading Workshop
Mini-lezioni
237 Situazione iniziale
238 Sviluppo
239 Conclusione
240 Personaggi
241 Narratore/Narratrice
242 Sequenze
243 Diverse tipologie di sequenze
244 Fabula
245 Intreccio
246 Flashback
247 Discorso diretto e discorso indiretto
248 Tempo
249 Laboratorio introduttivo scheda-ancoraggio per l’insegnante
250 Laboratorio introduttivo scheda-ancoraggio per l’alunno/a
251 La struttura del testo narrativo scheda-ancoraggio per l’insegnante
252 La struttura del testo narrativo scheda-ancoraggio per l’alunno/a
253 Personaggi scheda-ancoraggio per l’insegnante
254 Personaggi scheda-ancoraggio per l’alunno/a
255 Narratore/Narratrice scheda-ancoraggio per l’insegnante
256 Narratore/Narratrice scheda-ancoraggio per l’alunno/a
257 Sequenze scheda-ancoraggio per l’insegnante
258 Sequenze scheda-ancoraggio per l’alunno/a
259 Fabula, intreccio e flashback scheda-ancoraggio per l’insegnante
260 Fabula, intreccio e flashback scheda-ancoraggio per l’alunno/a
261 Discorso diretto e discorso indiretto scheda-ancoraggio per l’insegnante
262 Discorso diretto e discorso indiretto scheda-ancoraggio per l’alunno/a
263 Tempo scheda-ancoraggio per l’insegnante
264 Tempo scheda-ancoraggio per l’alunno/a
265 Gli elementi di una storia scheda-ancoraggio per l’insegnante
266 Gli elementi di una storia scheda-ancoraggio per l’alunno/a
267 Mappa per il laboratorio introduttivo
268 Modelli di card
Lettura dell insegnante




OBIETTIVO Oggi imparerai a riconoscere e a scrivere la prima parte di un testo narrativo, chiamata situazione iniziale.
COLLEGA Rifletti sull’espressione “situazione iniziale”. Che cosa significa per te? Scrivi la tua definizione.
CONCENTRATI La situazione iniziale di un testo narrativo è la parte che rappresenta l’inizio di una storia. Generalmente si presenta la vicenda principale da cui nasce poi l’intera vicenda.
ESERCITATI Leggi il testo e sottolinea la situazione iniziale
Nel prato del giardino di Pietro viveva un riccio di nome Rizzy, piccolo ma coraggioso. I suoi aculei folti e affilati lo facevano sembrare un piccolo cavaliere sempre pronto a difendersi dagli intrusi. Rizzy aveva un grande desiderio: esplorare il mondo al di là della rete del giardino. Così un giorno, mentre il sole splendeva alto nel cielo, decise che era arrivato il momento di vivere la sua grande avventura.


CREA E SCRIVI Scrivi la situazione iniziale di una storia. Scegli tra i seguenti personaggi:
• cagnolino • chiocciola
• gattone
• tartaruga
• ragno
• formica
CONDIVIDI Se vuoi, leggi il tuo testo alla classe.
Scheda-ancoraggio per gli alunni e le alunne a pag. 252 di questa Guida.




OBIETTIVO Oggi imparerai a riconoscere e a scrivere la parte centrale di un testo narrativo, chiamata sviluppo o svolgimento.
COLLEGA Rifletti sulla parola “sviluppo”. Che cosa significa per te?
Scrivi la tua definizione.
CONCENTRATI Lo sviluppo di un testo narrativo è la parte centrale e racconta la vicenda. Qui si narra la quasi totalità della storia presentando situazioni che coinvolgono emotivamente e incuriosiscono chi legge.
ESERCITATI Leggi il testo e sottolinea lo sviluppo della vicenda, cioè la parte in cui è raccontata la storia.
Toto viveva in un prato verde e fiorito, dove poteva saltare e correre liberamente. Era un coniglietto allegro e curioso, ma si sentiva solo.
Un giorno Toto incontrò un uccellino che era caduto dal nido. Il coniglietto capì subito che il piccolo uccellino aveva bisogno di aiuto e decise di portarlo nella sua tana. Lì lo curò finché l’uccellino non fu abbastanza forte da volare di nuovo. L’uccellino e Toto diventarono grandi amici e giocavano insieme ogni giorno.
Toto era felice di avere un nuovo amico con cui condividere le sue avventure. Così, il coniglietto imparò che l’amicizia si può trovare ovunque, anche in un prato verde e fiorito.


CREA E SCRIVI Continua la tua storia (quella che hai iniziato a scrivere a pagina 237), aggiungendo la parte in cui si sviluppa la vicenda.
CONDIVIDI Se vuoi, leggi il tuo testo alla classe.
Scheda-ancoraggio per gli alunni e le alunne a pag. 252 di questa Guida.
3
Lettura dell insegnante




OBIETTIVO Oggi imparerai a riconoscere e a scrivere la parte finale di un testo narrativo, chiamata conclusione.
COLLEGA Rifletti sulla parola “conclusione”. Che cosa significa per te?
Scrivi la tua definizione.
CONCENTRATI La conclusione di un testo narrativo è la parte di testo che racconta il finale della storia. Ogni elemento narrato in precedenza deve trovare qui il suo compimento.
ESERCITATI Leggi il testo e sottolinea la parte finale.
Un giorno, mentre si trovava in cucina, Billi scoprì un passaggio segreto che portava a una stanza nascosta.
Deciso a esplorarla, Billi attraversò la porticina ed entrò in una stanza piena di tesori. Iniziò a giocare con gli oggetti che aveva trovato, ma presto si sentì solo. Così decise di portare tutto alla luce e di condividere la sua scoperta con il mondo intero.
Da quel momento in poi, Billi divenne un eroe per molti e il suo nome rimase nella storia dei cani per sempre.


CREA E SCRIVI Scrivi la conclusione della tua storia (quella che hai iniziato a scrivere a pagina 237). Ricorda che deve essere coerente con il resto del racconto.
CONDIVIDI Se vuoi, leggi il tuo testo alla classe.
Scheda-ancoraggio per gli alunni e le alunne a pag. 252 di questa Guida.




OBIETTIVO Oggi imparerai a caratterizzare i personaggi del testo narrativo, nei ruoli primari e secondari.
COLLEGA Pensa alle storie che hai letto ed elenca alcuni personaggi dividendoli in due colonne: primari e secondari.
CONCENTRATI I personaggi primari possono essere i protagonisti o gli antagonisti. Tra i secondari ci sono le comparse, gli aiutanti, gli oppositori e gli oggetti del desiderio.
ESERCITATI Leggi il testo e sottolinea con colori diversi i nomi e le relative caratteristiche del protagonista e del suo aiutante
L’Orco Buono è un gigante dall’aspetto imponente, ma dal cuore grande e gentile. La sua forza fisica lo rende un alleato formidabile, ma sono la sua generosità e la sua lealtà che lo rendono un vero amico. Il Folletto Dispettoso, invece, è piccolo, agilissimo e vivace. È sempre pronto a combinare qualche scherzo ai suoi amici. Il suo cuore è però puro e sincero, e spesso aiuta l’Orco quando si dà da fare per gli altri.
Nonostante le loro differenze, l’Orco Buono e il Folletto Dispettoso sono grandi amici, e insieme vivono avventure straordinarie.
La loro amicizia ci insegna che le persone possono essere amiche nonostante le loro diversità.


CREA E SCRIVI Scrivi la presentazione del/della protagonista di un racconto e del/della suo/a antagonista. Scegli tra persone, animali o creature fantastiche.
CONDIVIDI Se vuoi, leggi il tuo lavoro alla classe e/o scrivi su un post-it quale protagonista e quale antagonista hai scelto.
Scheda-ancoraggio per gli alunni e le alunne a pag. 254 di questa Guida.
GLI elementi DEL testo narrativo
Lettura dell insegnante




5
OBIETTIVO Oggi imparerai a riconoscere chi è il narratore o la narratrice della storia, distinguendolo/a tra interno/a ed esterno/a.
COLLEGA Conosci la storia di Biancaneve? Sapresti individuare il narratore? Scrivilo qui:
CONCENTRATI Il narratore o la narratrice è la voce che racconta gli eventi che si susseguono in una storia. Può essere interno/a o esterno/a
ESERCITATI Leggi i due mini-testi e per ognuno scrivi chi è il narratore/ la narratrice e se è interno/a o esterno/a.
TESTO 1 Il sole splendeva alto nel cielo azzurro mentre camminavo verso l’ingresso della scuola con il mio zaino nuovo sulle spalle. Sentivo una strana agitazione nell’aria: oggi avrei scoperto la destinazione della gita di classe.
Narratore / Narratrice:
TESTO 1 Il maestro aveva organizzato una sorpresa per la sua classe.
– Oggi faremo una caccia al tesoro! – annunciò.
Gli occhi di tutti e tutte brillavano di gioia mentre ascoltavano le istruzioni e si preparavano a cercare il tesoro!
Narratore / Narratrice:

CREA E SCRIVI Scrivi due mini-testi, uno con un narratore interno o una narratrice interna e l’altro con un narratore esterno o una narratrice esterna. Scegli tra i seguenti argomenti:
• gita scolastica
• visita al museo
• vacanza al mare
• giornata piovosa a casa

CONDIVIDI Scegli un piccolo estratto di ogni testo in grado di far capire il tipo di narratore/narratrice usato/a e leggilo alla classe.
Scheda-ancoraggio per gli alunni e le alunne a pag. 256 di questa Guida.




OBIETTIVO Oggi imparerai a suddividere un testo in sequenze e a dare loro un titolo per riconoscerle.
COLLEGA Quando si passa da una sequenza a un’altra? Scrivilo immaginando di spiegarlo a un compagno o a una compagna.
CONCENTRATI Un testo narrativo è formato da varie sequenze. Le sequenze hanno diverse funzioni. Sapresti dire quali?
Narrative
Dialogiche Emozionanti Riflessive
Rosa Paurose Gialle Descrittive
ESERCITATI Leggi il testo e separa le sequenze con una barretta. Per ognuna scrivi una parola chiave per identificarla. È iniziata una nuova giornata nella verde Foresta Incantata. Emma, insieme alla sua banda di amici, è pronta per l’esplorazione. Qui tutto è diverso dal mondo reale e servono occhi nuovi per poter ammirare ogni dettaglio magico. L’allegra compagnia fa subito amicizia con due uccellini canterini e quattro coniglietti saltellanti. Insieme a loro oltrepassano un ponte arcobaleno. Il ponte li conduce all’entrata di una grotta che nasconde la cascata degli gnomi. La sua acqua è pura e cristallina e in essa nuotano fate e gnomi.
1a sequenza
2a sequenza
3a sequenza


CREA E SCRIVI Riprendi la storia che hai scritto (quella che hai iniziato a pagina 94) e dividila in sequenze, dando loro un breve titolo. Così otterrai un riassunto o una sintesi del tuo racconto.
CONDIVIDI Scrivi su un post-it la sequenza della tua storia che ti è piaciuta di più e leggila alla classe.
Scheda-ancoraggio per gli alunni e le alunne a pag. 258 di questa Guida.
Lettura dell insegnante



OBIETTIVO Oggi imparerai a capire il tipo di sequenza in cui è diviso un testo, riuscendo a identificare quelle narrative, dialogiche, riflessive e descrittive.
COLLEGA Lavora in gruppo. Ogni gruppo cerca di scrivere le caratteristiche che deve avere ciascun tipo di sequenza (narrativa, dialogica, riflessiva e descrittiva) per essere identificata nel suo nome.
CONCENTRATI Scrivi a quale tipologia di sequenza si riferiscono le seguenti caratteristiche: narrativa (N), dialogica (Di), riflessiva (R), descrittiva (De).
• È descritto un ambiente. ■
• Il protagonista parla con il suo aiutante. ■
• È raccontato l’evento principale della storia. ■
• Il narratore condivide i propri sentimenti con un personaggio. ■
• Si racconta il lieto fine. ■

ESERCITATI Leggi il testo e individua il tipo di sequenze presenti in esso. Sui puntini scrivi la loro successione usando le seguenti abbreviazioni: narrativa (N), dialogica (Di), riflessiva (R) e descrittiva (De).
Luca era un bambino di dieci anni, appassionato di avventure.
Un giorno scoprì una mappa misteriosa sotto una vecchia pietra. La mappa raffigurava un’isola lontana, circondata da palme maestose. Luca decise di partire per cercarla. Preparò uno zaino con tutto il necessario: una bussola, una borraccia, una lente d’ingrandimento e una piccola scorta di biscotti. Con il suo fedele cane Mimì, iniziò il viaggio verso l’isola sconosciuta.
Dopo giorni di navigazione, finalmente arrivarono. L’isola era ancora più incantevole di quanto avesse immaginato. La bellezza di quei luoghi gli fece accelerare il battito del cuore e provare un senso di tranquillità profonda.


CREA E SCRIVI Scegli due tipologie di sequenze e scrivi un breve testo che abbia come protagonisti un alieno e una scimmietta.
CONDIVIDI Leggi le sequenze che hai scritto ai componenti del tuo gruppo. Confrontati con loro per ottenere consigli e suggerimenti.
Scheda-ancoraggio per gli alunni e le alunne a pag. 258 di questa Guida.




OBIETTIVO Oggi imparerai a seguire e riconoscere la fabula, cioè una storia raccontata seguendo l’ordine cronologico dei fatti.
COLLEGA Pensa alla parola “fabula”. Che cosa potrebbe voler dire? Ricerca sul vocabolario la corretta definizione, scrivila e confrontala con quella che trovi nel riquadro sottostante.
CONCENTRATI La fabula indica la sequenza degli eventi esposti nel loro ordine cronologico, ovvero come sono capitati nella realtà.
ESERCITATI Le parole del tempo (prima, poi, infine…) ti aiutano a individuare la fabula del racconto. Leggi il testo e sottolinea le parole del tempo.
Una sera Tommy, mentre stava guardando le stelle, vide qualcosa di straordinario nel cielo: una luce brillante che si avvicinava sempre di più. Era una navicella spaziale!
Ben presto la navicella atterrò dolcemente nel campo accanto alla casa di Tommy. Da un piccolo oblò uscirono quattro esserini strani, ma simpatici. Avevano occhi enormi e lucidi e la pelle di colore argento.
Non parlavano la lingua di Tommy; il loro capitano, però, aveva un apparecchio che traduceva ogni loro verso e così tutti poterono capirsi.
Circa un’ora dopo il loro atterraggio, questi esseri extraterrestri entrarono a casa di Tommy per nascondersi da occhi indiscreti. Avrebbero trascorso una giornata sulla Terra e sarebbero partiti il giorno dopo…


CREA E SCRIVI Continua tu la storia di Tommy e del suo incontro con gli extraterrestri. Ricordati di rispettare la durata della loro visita sulla Terra.
CONDIVIDI Leggi alla classe solo le parole e/o le espressioni che hai usato per far emergere l’ordine cronologico dei fatti.
Scheda-ancoraggio per gli alunni e le alunne a pag. 260 di questa Guida.
testo narrativo
Lettura dell insegnante




OBIETTIVO Oggi imparerai a distinguere l’intreccio, cioè quando in una storia i fatti non sono raccontati in ordine cronologico.
COLLEGA Ricordi un film in cui gli eventi sono raccontati in un ordine diverso da quello in cui si sono svolti? Scrivi il suo titolo:
CONCENTRATI Si ha l’intreccio quando chi scrive racconta gli eventi con un ordine che non segue quello cronologico.
ESERCITATI Numera le sequenze dell’intreccio, indicando il loro ordine cronologico, cioè quale è avvenuta prima nel tempo.
Il negozio del pane era un luogo di incontro, dove si potevano trovare una buona compagnia e un ottimo pane. Il fornaio era un uomo cordiale, che amava il suo lavoro.
Fin da ragazzo, aveva sempre avuto una passione per il profumo del pane appena sfornato. Dopo aver frequentato la scuola di panificazione, aveva aperto questo negozio.
Nonostante le difficoltà iniziali, grazie alla qualità dei suoi prodotti, il suo negozio era diventato presto un punto di riferimento per il paese.
Anche se il tempo passava, il fornaio non perdeva la sua passione e la sua dedizione per il lavoro.


CREA E SCRIVI Racconta una tua giornata scolastica esponendo i fatti non in ordine di tempo, ma in base a una tua precisa scelta. Potresti cominciare così: È appena suonata l’ultima campanella…
CONDIVIDI A turno, chi vuole, può leggere la propria storia per condividerla con la classe.
Scheda-ancoraggio per gli alunni e le alunne a pag. 260 di questa Guida.


OBIETTIVO Oggi imparerai a riconoscere e a scrivere un flashback all’interno di un testo narrativo.
COLLEGA Avrai sicuramente già sentito utilizzare la parola flashback Che cosa potrebbe significare? Come potrebbe collegarsi alla scrittura di un racconto? Confrontati con un compagno o una compagna e scrivi la tua definizione.


CONCENTRATI In un testo il flashback è una sequenza che interrompe la narrazione cronologica dei fatti per inserire il racconto di un episodio accaduto nel passato
ESERCITATI Leggi il testo e sottolinea il punto in cui è stato inserito il flashback.
Jeffrey sa da quando è nato che la cosa peggiore che può farmi è toccare la mia batteria.
Un fatidico pomeriggio dell’anno scorso, però, sono tornato a casa e mi sono avviato verso il seminterrato per esercitarmi un po’. Ma le mie bacchette speciali non erano più al loro posto! Sono corso di sopra come una furia, sono entrato in cucina e ho visto Jeffrey che “cucinava” sul pavimento. Era tutto preso a mescolare il suo intruglio nella pentola più profonda. Con le mie bacchette speciali!
– Jeffrey! Dammi quelle bacchette!
– Ma sto cucinando! E la torta pazza non è ancora pronta.
– Non mi importa di quella schifezza che stai facendo finta di cucinare.
– Guarda che è vera!
E lo era. La “torta pazza” di Jeffrey era un miscuglio di caffè, uova crude e pezzi di guscio, bacon crudo e tre macchinine da corsa. Le mie bacchette speciali tuttora hanno uno strano odore.
J. Sonnenblick, I 10 mesi che mi hanno cambiato la vita, Giunti


CREA E SCRIVI Rivedi il testo che hai scritto sulla tua giornata scolastica (vedi pagina 245 di questa Guida) e inserisci un flashback nel punto che preferisci.
CONDIVIDI Riscrivi solo il flashback su un post-it e condividilo sulla parete della Bottega di scrittura.
Scheda-ancoraggio per gli alunni e le alunne a pag. 260 di questa Guida.
Lettura dell insegnante




OBIETTIVO Oggi imparerai a inserire il discorso diretto all’interno di un testo e/o a trasformarlo in discorso indiretto.
COLLEGA Ricorda le regole per scrivere un discorso diretto e per trasformarlo in discorso indiretto. Scrivile immaginando di spiegarle a un compagno o a una compagna.
CONCENTRATI Far parlare direttamente i personaggi di una storia può renderla più appassionante per chi legge. A volte, però, il racconto indiretto facilita la comprensione. Pertanto il discorso diretto e quello indiretto sono entrambi fondamentali all’interno di un testo.
ESERCITATI Trasforma il dialogo in un discorso indiretto e viceversa.
1 A: – Vorrei una torta per il compleanno di mia figlia.
B: – Che tipo di torta? La preferisce alla crema o al cioccolato?
A: – La vorrei alla crema con frutta fresca.
2 Stavo correndo come ogni mattina lungo il viale alberato della mia via quando Norma mi fermò per chiedermi l’ora e per informarmi del suo stato di salute. Io l’ascoltai e le risposi con espressioni meravigliate e parole di conforto.


CREA E SCRIVI Inserisci un mini-dialogo nel testo della tua giornata scolastica (quella che hai scritto a pagina 101).
CONDIVIDI Dividetevi in due gruppi. Un gruppo scrive su un post-it le regole per trasformare il discorso diretto in indiretto; l’altro gruppo quelle per trasformare il discorso indiretto in diretto.
Scheda-ancoraggio per gli alunni e le alunne a pag. 262 di questa Guida.




OBIETTIVO Oggi imparerai a riconoscere il tempo in cui è ambientata una storia o un racconto narrativo.
COLLEGA Pensa alla parola “tempo”. Essa racchiude in sé molti significati diversi. Che cos’è il tempo per te? Conosci qualche modo di dire sul tempo? Se sì, scrivilo qui e poi condividilo con il gruppo classe.
CONCENTRATI Il tempo di un testo narrativo si riferisce alla sequenza temporale degli eventi raccontati nella storia. Esso può riferirsi al tempo dell’azione a quello della narrazione e a quello cronologico.
ESERCITATI Individua in quanto tempo si svolge la storia.
Sono le 8.00 e io e Lilli entriamo di nascosto nel laboratorio del professor Perkins. Notiamo subito qualcosa di strano: su tutte le pareti della stanza sono accatastate delle gabbie con all’interno delle creature mai viste prima.
Lo stupore è enorme. Ma io e Lilli iniziamo subito le ricerche e alle 11.45 abbiamo i primi risultati. Siamo però ancora lontani dal comprendere che cosa sta architettando lo strano professore.
Alle 13.00 troviamo finalmente il registro delle attività del signor Perkins e rimaniamo sbigottiti: lo scienziato sta studiando forme aliene provenienti da galassie diverse dalla nostra.
Alle 23.00 il mistero è stato svelato: gli esseri nelle gabbie provengono da un pianeta di nome Luxis e sembrano essere i fratelli alieni dei nostri animali…


CREA E SCRIVI Continua tu la storia, completandola nelle sue parti ed usando i diversi tempi. Nella narrazione inserisci anche un flashback.
CONDIVIDI Scrivi su un post-it il titolo della tua storia. Poi leggi quelli proposti dai tuoi compagni e dalle tue compagne. Quali ti attirano di più? Perché? Chiedi di leggere la storia o le storie il cui titolo ti ha colpito maggiormente.
Scheda-ancoraggio per gli alunni e le alunne a pag. 264 di questa Guida.
Scheda-ancoraggio relativa alle mini-lezioni del laboratorio introduttivo , alle pagine 229-230 di questa Guida.
Scheda-ancoraggio completa per l’insegnante.

• SCELTA DEI MATERIALI
• SCHIZZO
• MONTAGGIO DELLE PARTI DELL’OGGETTO
• LIMATURA DELLE IMPERFEZIONI
• RIFINITURA
• SCELTA DEGLI ELEMENTI NARRATIVI
• BOZZA: PRIMA STESURA DEL TESTO
• REVISIONE: RILETTURA E PERFEZIONAMENTO
• EDITING: CORREZIONI DEGLI ERRORI
• PUBBLICAZIONE: RISCRITTURA FINALE
Scheda-ancoraggio relativa alle mini-lezioni del laboratorio introduttivo , alle pagine 229-230 di questa Guida.
Scheda-ancoraggio da completare per l’alunno/a.

Scheda-ancoraggio relativa alle mini-lezioni delle pagine 237, 238 e 239 di questa Guida: situazione iniziale • sviluppo • conclusione
Scheda-ancoraggio completa. L’insegnante potrebbe fotocopiarla e appenderla in classe una volta terminata la presentazione delle prime tre mini-lezioni.

• CHI?
• DOVE?
• QUANDO?
• CHE COSA SUCCEDE?
• QUAL È L’OSTACOLO?
• QUALE SOLUZIONE
SI TROVA?
• CHI ARRIVA IN AIUTO?
• RACCONTA LE EMOZIONI
PROVATE.
• CHE COSA È CAMBIATO?
• COME SI CONCLUDE LA VICENDA?
Scheda-ancoraggio relativa alle mini-lezioni delle pagine 237, 238 e 239 di questa Guida: situazione iniziale • sviluppo • conclusione

Scheda-ancoraggio da completare per l’alunno/a.
Scheda-ancoraggio relativa alla mini-lezione della pagina 240 di questa Guida: personaggi .
Scheda-ancoraggio completa per l’insegnante.
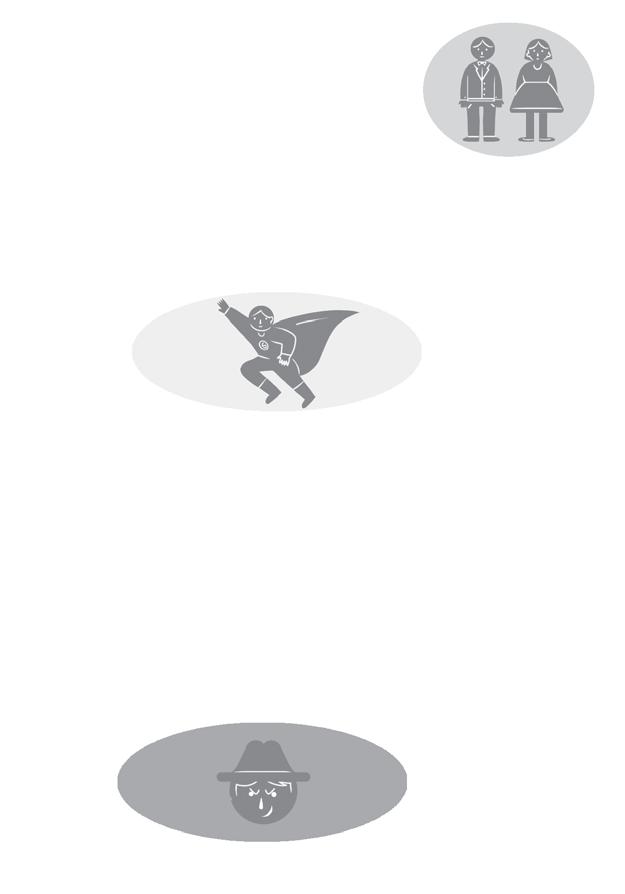
È IL PERSONAGGIO CHE OSTACOLA
IL/LA PROTAGONISTA E DI SOLITO
È UNA FIGURA NEGATIVA.
HA UN RUOLO MARGINALE
E DI CONTORNO ALLA STORIA.
AIUTA, DÀ SOSTEGNO
AL/ALLA PROTAGONISTA.
CIÒ CHE IL/LA PROTAGONISTA VUOLE
RAGGIUNGERE, IL SUO OBIETTIVO.
È UN PERSONAGGIO NEGATIVO CHE AIUTA
L’ANTAGONISTA A OSTACOLARE IL/LA PROTAGONISTA.
Scheda-ancoraggio relativa alla mini-lezione della pagina 240 di questa Guida: personaggi
Scheda-ancoraggio da completare per l’alunno/a.
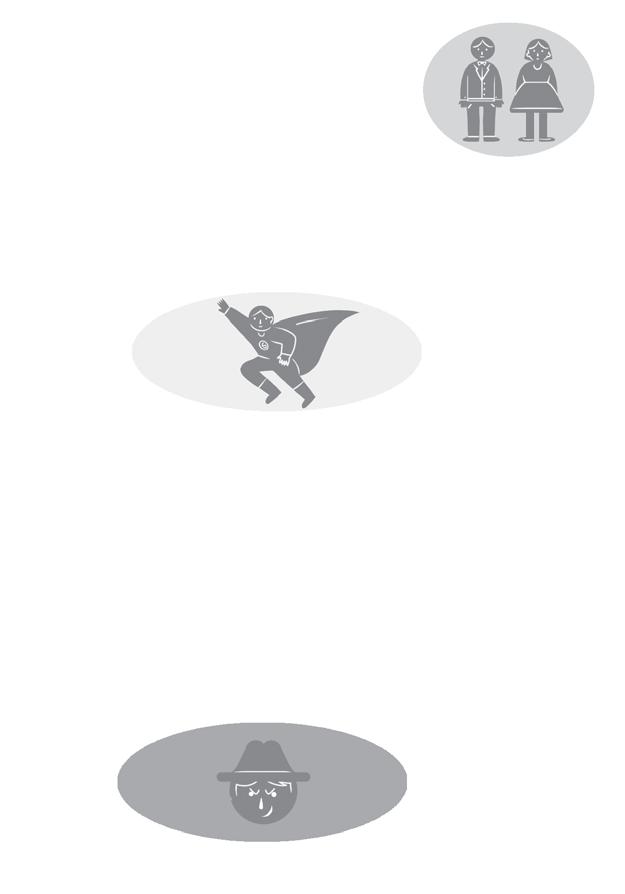
SCHEDA-ANCORAGGIO
Scheda-ancoraggio relativa alla mini-lezione della pagina 241 di questa Guida: narratore/narratrice
Scheda-ancoraggio completa per l’insegnante.

LA VOCE CHE RACCONTA GLI EVENTI CHE SI SUSSEGUONO IN UNA STORIA
PUÒ ESSERE:
• È UN PERSONAGGIO
CHE È PRESENTE E AGISCE NELLA STORIA.
• RACCONTA LA STORIA SECONDO LA SUA PROSPETTIVA PERSONALE.
• ESPRIME I PROPRI SENTIMENTI
E LE PROPRIE EMOZIONI.
• NON È UN PERSONAGGIO PRESENTE E CHE
AGISCE DIRETTAMENTE NELLA TRAMA DELLA STORIA.
• HA UNA VISIONE PIÙ AMPIA E COMPLETA DELLA STORIA.
• RACCONTA LA STORIA SECONDO UNA PROSPETTIVA OGGETTIVA.
Scheda-ancoraggio relativa alla mini-lezione della pagina 241 di questa Guida: narratore/narratrice
Scheda-ancoraggio da completare per l’alunno/a.

laboratorio
SCHEDA-ANCORAGGIO
Scheda-ancoraggio relativa a due mini-lezioni: quella della pagina 242 ( sequenze ) e quella della pagina 243 di questa Guida ( diverse tipologie di sequenze ).
Scheda-ancoraggio completa per l’insegnante.
SEQUENZA
PARTE DI UN TESTO SCRITTO
CON UNO SCOPO SPECIFICO.
SEQUENZE
NARRATIVA
SI CONCENTRA SULLA PRESENTAZIONE DI
EVENTI E AZIONI CHE
SI SUSSEGUONO IN UNA STORIA.
SI CONCENTRA SUL RACCONTARE DETTAGLI E IMMAGINI DI PERSONE, LUOGHI OPPURE
OGGETTI ALL’INTERNO DELLA STORIA.
DESCRITTIVA
RIFLESSIVA
SI CONCENTRA SUI PENSIERI,
SULLE EMOZIONI E SULLE RIFLESSIONI
INTERIORI DEI PERSONAGGI.
SI CONCENTRA SULLE CONVERSAZIONI TRA
I PERSONAGGI ALL’INTERNO
DELLA STORIA.
DIALOGICA
Scheda-ancoraggio relativa a due mini-lezioni: quella della pagina 242 ( sequenze ) e quella della pagina 243 di questa Guida ( diverse tipologie di sequenze ).
Scheda-ancoraggio da completare per l’alunno/a.
SEQUENZA
DESCRITTIVA
RIFLESSIVA
SI CONCENTRA SUI PENSIERI, SULLE EMOZIONI E SULLE RIFLESSIONI
INTERIORI DEI PERSONAGGI.
DIALOGICA
SCHEDA-ANCORAGGIO
Scheda-ancoraggio relativa a tre mini-lezioni: quelle delle pagine 244 e 245 ( fabula e intreccio ) e quella della pagina 246 di questa Guida ( flashback ).
Scheda-ancoraggio completa per l’insegnante.
I FATTI O EVENTI
SONO RACCONTATI
NELL’ORDINE
IN CUI SI SVOLGONO. (ORDINE CRONOLOGICO)
I FATTI O EVENTI
SONO RACCONTATI
SECONDO L’ORDINE
DECISO
DALL’AUTORE/AUTRICE
CON SALTI IN AVANTI
(FATTI CHE DEVONO ANCORA AVVENIRE)
E INDIETRO
(FATTI PASSATI).
LA NARRAZIONE
DEI FATTI
(O DEGLI EVENTI)
È INTERROTTA PER RACCONTARE UN RICORDO DI UN AVVENIMENTO DEL PASSATO.
Scheda-ancoraggio relativa a tre mini-lezioni: quelle delle pagine 244 e 245 ( fabula e intreccio ) e quella della pagina 246 di questa Guida ( flashback ).
Scheda-ancoraggio da completare per l’alunno/a.
Scheda-ancoraggio relativa alla mini-lezione di pagina 247 di questa Guida: discorso diretto e discorso indiretto
Scheda-ancoraggio completa per l’insegnante.
DISCORSO DIRETTO
• SI RIPORTANO LE PAROLE ESATTE
DI UN DIALOGO TRA DUE PERSONE.
• IL TESTO È RIPORTATO TRA « »
OPPURE “ ”.
SI POSSONO USARE
ANCHE I TRATTINI.
ESEMPIO:
MARCO DICE:
«VADO A FARE UNA PASSEGGIATA». OPPURE
MARCO DICE:
– VADO A FARE UNA PASSEGGIATA.
DISCORSO INDIRETTO
• LE PAROLE SONO INTEGRATE
NELLA STRUTTURA DEL TESTO
E NON SONO CITATE DIRETTAMENTE.
• SI USA IL “CHE” PER TRASFORMARE LE PAROLE DIRETTE IN UNA FRASE INDIRETTA.
ESEMPIO:
MARCO DICE CHE VA A FARE
UNA PASSEGGIATA.
Scheda-ancoraggio relativa alla mini-lezione di pagina 247 di questa Guida: discorso diretto e discorso indiretto
Scheda-ancoraggio da completare per l’alunno/a.
DISCORSO DIRETTO
DISCORSO INDIRETTO
Scheda-ancoraggio relativa alla mini-lezione di pagina 248 di questa Guida: tempo
Scheda-ancoraggio completa per l’insegnante.
I FATTI SONO
I FATTI SI SVOLGONO
IN UN PERIODO DI TEMPO PRECISO ALL’INTERNO DELLA STORIA.
PRESENTATI NELL’ORDINE
IN CUI SI VERIFICANO NEL TEMPO.
I FATTI SONO PRESENTATI IN BASE ALLA VOLONTÀ DEL NARRATORE/ DELLA NARRATRICE.
Scheda-ancoraggio relativa alla mini-lezione di pagina 248 di questa Guida: tempo .
Scheda-ancoraggio da completare per l’alunno/a.
ELEMENTI
Questa scheda di ancoraggio va consegnata agli alunni e alle alunne alla fine delle 12 sessioni di laboratorio e inserita nel taccuino. La versione per l’insegnate può essere fotocopiata e appesa sulla bacheca.
Scheda-ancoraggio completa per l’insegnante.
PERSONAGGI
OGNI PEZZO È IMPORTANTE PER COMPLETARE UNA STORIA. LA LOTTA O/E IL CONFLITTO CHE I PERSONAGGI PRINCIPALI DEVONO AFFRONTARE. PERSONE E/O ANIMALI CHE AGISCONO NELLA STORIA. GLI EVENTI E/O LE AZIONI PRINCIPALI CHE ACCADONO DURANTE LA VICENDA. IL TEMPO E IL LUOGO IN CUI UNA STORIA PRENDE VITA. IL MODO IN CUI I PERSONAGGI RISOLVONO I PROBLEMI E LA STORIA SI CONCLUDE.
Questa scheda di ancoraggio va consegnata agli alunni e alle alunne alla fine delle 12 sessioni di laboratorio e inserita nel taccuino. La versione per l’insegnate può essere fotocopiata e appesa sulla bacheca.
Scheda-ancoraggio da completare per l’alunno/a.
Mappa per la terza sessione del laboratorio introduttivo (vedi pagina 231 di questa Guida). La mappa va fotocopiata e consegnata agli allievi e alle allieve, divisi in gruppi: una mappa per ogni gruppo.
Ecco due possibili modelli di card da usare ai fini della valutazione, per invitare l’alunno/a a un incontro per un ulteriore chiarimento, nell’area della condivisione, sugli aspetti su cui ha lavorato (vedi pagina 224 di questa Guida).
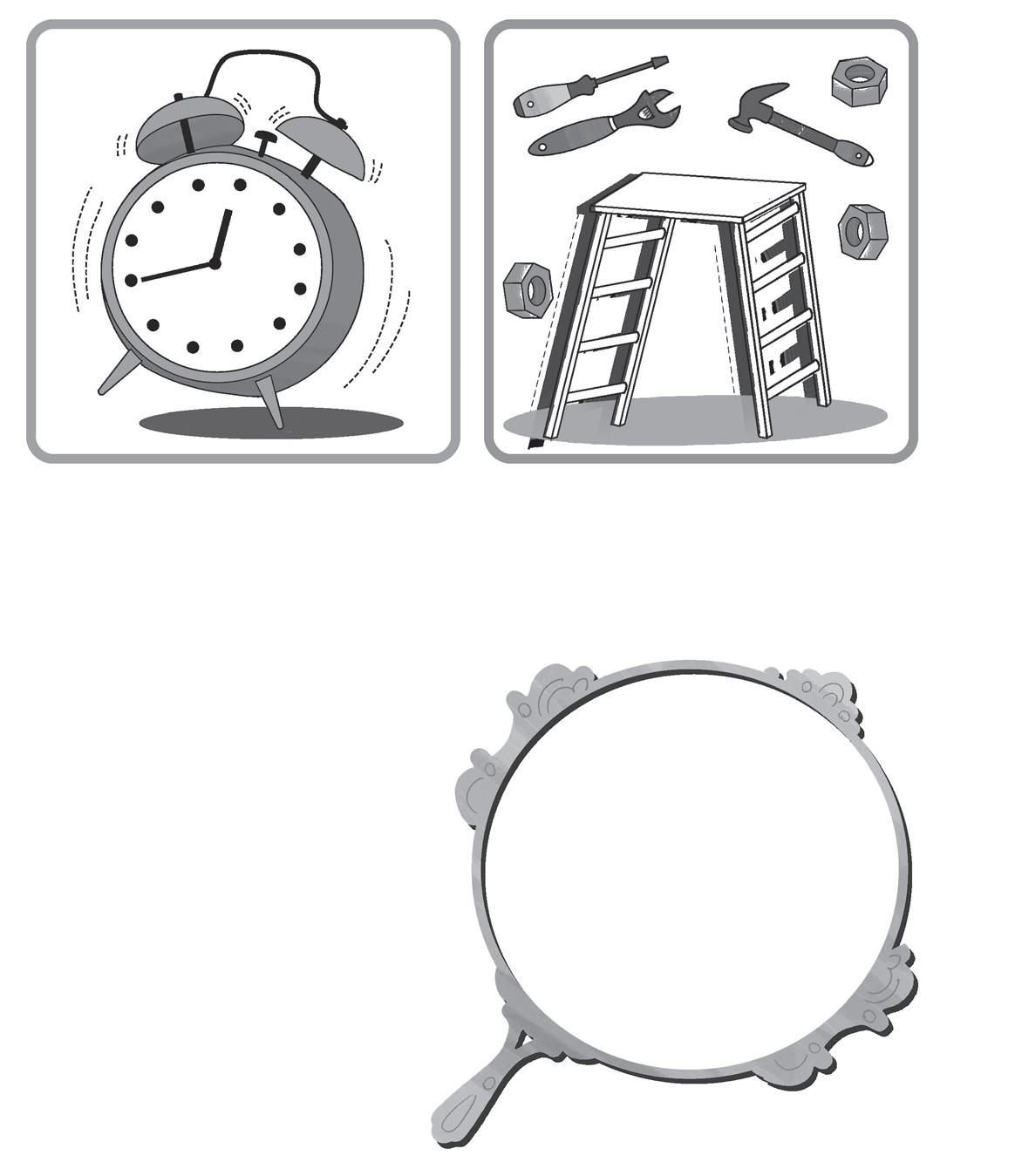
Ecco un possibile modello per la routine autovalutativa “Pensieri allo specchio” (vedi pagina 226 di questa Guida).
SCRIVI LA DOMANDA POSTA DALL’INSEGNANTE.
NELLO SPECCHIO SCRIVI LA TUA RIFLESSIONE.