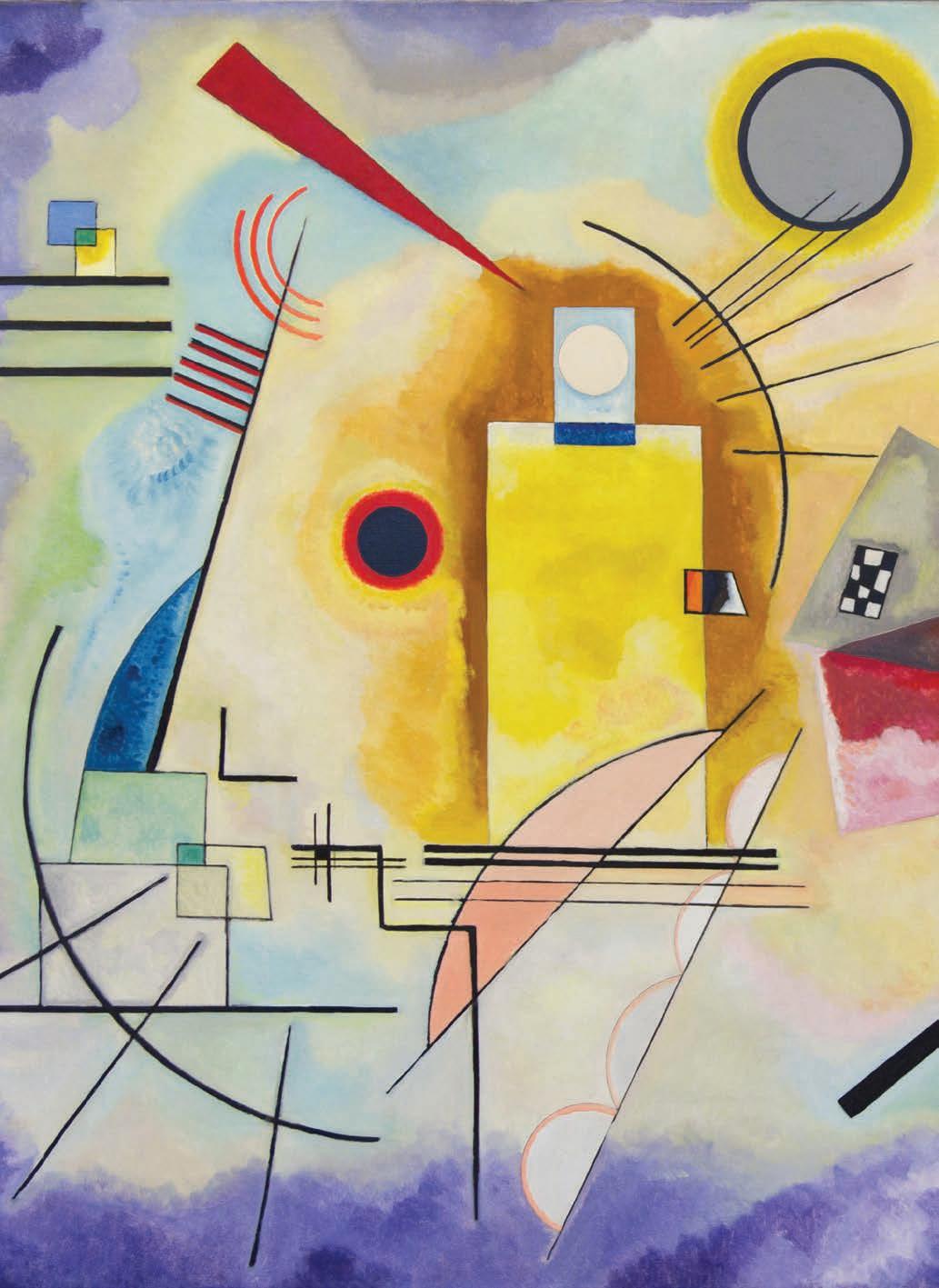6 minute read
Insegnanti vicini e insegnanti lontani Maurizio Parodi
INSEGNANTI VICINI E INSEGNANTI LONTANI
di Maurizio Parodi
PAROLE CHIAVE: OTTUSITÀ, ESTERNALIZZAZIONE, OPPORTUNITÀ, RIPENSAMENTO, REGIA
La prolungata sospensione delle lezioni offre una straordinaria occasione di ripensamento profondo dell’essere e fare scuola della quale, però, profitteranno solo i docenti (e i loro studenti) che già si impegnano, con sensibilità e intelligenza, per qualificare gli “ambienti di apprendimento” nei quali operano.
La tristissima congiuntura che stiamo vivendo potrebbe rappresentare una buona occasione per ripensare i paradigmi, il senso, la filosofia del nostro sistema scolastico, profondamente malato, come dimostrano i dati relativi all’analfabetismo funzionale, alla mortalità scolastica, all’incapacità di compensare le diseguaglianze di partenza. Sintomi gravissimi ma irresponsabilmente trascurati, a tutti i livelli, per il carattere autoreferenziale di un apparato immune agli interventi di innovazione sostanziale, e più incline a restyling meramente cosmetici (vedasi l’uso cattedratico delle LIM). Ma lo sarà solo per quei docenti (e ve ne sono) che, tra mille difficoltà di ogni sorta (carenze di risorse, organici, strumenti...), incomprensioni, ostilità (anche da parte dei colleghi o dei dirigenti più retrivi), già si impegnano con sensibilità e intelligenza, per qualificare gli “ambienti di apprendimento” nei quali operano. Insegnanti che riescono, anche in questa gravosa situazione, a confortare gli studenti, attraverso inedite forme di contatto e coinvolgimento, sollecitandone la riflessione personale e la crescita non solo culturale, creando nuovi spazi di scambio e ricomposizione del gruppo classe, perché alla costruzione del gruppo -ben altro rispetto alla som
matoria di singoli soggetti indistinti e separati- hanno dedicato tempo ed energie: una piccola comunità alla quale ciascuno si sente di appartenere e di cui soffrirebbe l’incuria. Per costoro, la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 338/2020, che reca “Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, rappresenta la conferma di una visione consolidata e di pratiche ordinarie che semmai trovano ulteriore legittimazione ma che del tutto spontaneamente si sviluppano ben oltre i vincoli burocratici di natura corporativistica ai quali si vorrebbero sigillare. Per tutti gli altri, si tratterà della ulteriore declinazione di un malcostume pedagogico sempre più diffuso
e nefasto, tant’è che lo si è dovuto stigmatizzare nella Nota medesima: Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. Considerazioni di semplice buonsenso pedagogico contraddette dalle intemperanze magistrali testimoniate da moltissimi genitori, già esacerbati da una condizione di straordinario disagio, che confermano la propensione ad appaltare lo svolgimento di parti sempre più cospicue del curricolo scolastico alle famiglie, ovviamente impreparate ad affrontare il “compito” improprio. Un richiamo che dovrebbe suscitare vergogna e disdoro ma che, al contrario, in omaggio a una logica corporativistica, di miserrima tutela del “particulare”, viene esecrato e bandito come indebita ingerenza, lesa maestà didattica. Si è costretti a richiamare norme di elementare igiene mentale: occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Un
monito che dovrebbe indignare, per l’ovvietà deontologica della circostanza evocata, che risulterebbe superfluo se rivolto a persone dotate (lo si ribadisce) di semplice buonsenso, ma che invece denuncia la condotta abituale della stragrande maggioranza dei docenti di ogni ordine e grado (purtroppo abbiamo “secondarizzato” anche la scuola primaria). È normale che i nostri studenti siano sovraccaricati di compiti (da cui il richiamo della Nota); si assegnano persino nelle classi a tempo pieno: tutti i giorni, nei week end e per le vacanze Dopo 8 ore di forzata immobilità, bambini di 6-10 anni, che avrebbero tanto più bisogno di giocare, ricrearsi, riposare, coltivare interessi e passioni, sono costretti a un impegno estenuante e dissennato il cui solo effetto è quello di rendere odioso lo studio e repellente la scuola (un accanimento morboso che rasenta la crudeltà mentale). È normale che i docenti operino nella reciproca ignoranza (da cui il richiamo della Nota MIUR): non si curano di verificare il carico complessivo del lavoro assegnato, non si accordano preventivamente, ognuno procede come se i “propri” compiti fossero i soli da svolgere, ulteriore manifestazione di grave insensibilità umana prima che professionale. Tutto ciò avviene, per l’appunto, in circostanze normali, figurarsi in epoca di prolungata sospensione delle attività scolasti
che. L’eccezionalità delle circostanze esalta una filosofia (e relativa pratica) pressoché generalizzata: a scuola si insegna e si impara a casa. Assurda e consueta invasione di campo che espropria gli studenti degli indispensabili spazi di rigenerazione cognitiva e affettiva, dopo le tante ore trascorse inchiavardati negli angusti (non solo fisicamente) stalli di strutture inadeguate anche rispetto a logiche puramente concentrazionarie. In questi giorni sembra diffondersi la tendenza alla completa esternalizzazione del “processo”, interamente demandato allo studente e ai genitori, laddove gli stessi siano in condizioni di potersi sostituire ai docenti (ulteriore aggravamento del carattere censitario della scuola italiana). Si riversano caterve di compiti, che già abitualmente opprimono fino all’esaurimento del tempo e delle energie, su bambini e ragazzi isolati perciò in condizioni ottimali (nessun compagno che disturbi) per ascoltare la lezione e svolgere gli esercizi. Delle due, l’una: o l’insegna
mento può essere delegato allo studente e alla famiglia, e allora non si capisce a cosa servano la scuola e i docenti, oppure gli insegnanti svolgono un ruolo insostituibile, come delineato dalle “Indicazioni nazionali” (del tutto ignorate o contraddette dalla didattica “reale”) e allora non può essere rimesso a chi ne dovrebbe trarre profitto. Non si può continuare a pretendere che i soggetti più bisognosi di maieutiche attenzioni si elevino (non solo culturalmente) “prendendosi per i capelli”, come faceva il Barone di Munchausen. Maria Montessori sosteneva che i bambini (ma il discorso vale per tutti gli studenti) devono essere liberati dal tutorato dell’adulto, e l’insegnante, pur restando l’organizzatore e il moltiplicatore dell’esperienza formativa, deve operare “indirettamente”, secondo il famoso slogan in cui il bambino dice: aiutami a fare da solo. L’alternativa non è tra l’invadenza e l’abbandono. Il docente può, deve essere il riferimento didatticamente più autorevole dei propri studenti, il mediatore di processi non solo cognitivi, il sostenitore della crescita individuale e collettiva, colui che aiuta quando è necessario, per quanto è necessario e non di più, interrogandosi costantemente sulla misura di tale necessità. Il principio vale sempre e ovunque, nello spazio fisico dell’aula come nello spazio virtuale della rete.
MAURIZIO PARODI

Dirigente scolastico, vive a Genova e si occupa di ricerca e formazione in campo socio-pedagogico, non ancora rassegnato all’impermeabilità degli apparati educativi. Ha pubblicato un centinaio di articoli sulle più importanti riviste italiane di pedagogia e didattica, e alcuni saggi, tra i quali: Basta compiti! Non è così che si impara, Sonda, 2012; Gli adulti sono bambini andati a male, Sonda, 2013; Non ho parole. Analfabetismo funzionale e analfabetismo pedagogico, Armando, 2018; «Così impari. Per una scuola senza compiti», Castelvecchi, 2018. Ha creato i gruppi Facebook: «Docenti e Dirigenti a Compiti Zero» e «Basta compiti!» (oltre 13 mila iscritti) che sostiene l’omonima petizione su change.org (più di 33 mila firme)