E l’indipendenza dal dato?

IMMOBILIARE
Anche il mattone a volte va in vacanza
SANITÀ
La sostenibilità dei conti sta nei compromessi
OROLOGI
La tradizione guarda oltre: social sì, ma d’incontri
FINANZA
L’industria assicurativa si riscopre in famiglia
PHARMA
Tra scienza e tecnologia: un matrimonio d’intelligenze
CULTURA
Echi di colonialismo, Svizzera davanti allo specchio



Società Editrice
Eidos Swiss Media Sagl
Via Lavizzari 4 - 6900 Lugano Tel. 091 735 70 00 info@eidosmedia.ch www.eidosmedia.ch
Sede della Redazione
Via Lavizzari 4 6900 Lugano Tel. 091 735 70 00 redazione@eidosmedia.ch
Responsabile editoriale
Federico Introzzi · fintrozzi@eidosmedia.ch
Redazione
Susanna Cattaneo · scattaneo@eidosmedia.ch
Giulio De Biase · gdebiase@eidosmedia.ch
Mirta Francesconi · mfrancesconi@eidosmedia.ch
Simona Manzione · smanzione@eidosmedia.ch
Andrea Petrucci apetrucci@eidosmedia.ch
Emanuele Pizzatti epizzatti@eidosmedia.ch
Maria Antonietta Potsios - mapotsios@eidosmedia.ch
Eleonora Valli evalli@eidosmedia.ch
Hanno collaborato a questo numero
Ettore Accenti, Florian Anderhub, Achille Barni, Alessandro Beggio, Ignazio Bonoli, Sergio Galanti, Simona Galli, Thomas Harnischberg, Frank Pagano, Stelio Pesciallo, Rocco Rigozzi, Claudio Saputelli, Luca Trisconi, Andrea Ziswiler, Sejla Zulic Progetto e coordinamento grafico
Veronica Farruggio grafica@eidosmedia.ch
Coordinamento Produzione
Roberto Musitano · rmusitano@eidosmedia.ch
Pubblicità
Coordinamento interno pubblicita@eidosmedia.ch Tel. 091 735 70 00
Agenzia esterna
Claus Winterhalter · winterhalter@ticino com
Abbonamenti abbonamenti@eidosmedia.ch
Annuo franchi 100.- (9 numeri, 3 bimestrali)
Estero: supplemento postale
Tel. 0041 (0)91 735 70 00
Logistica e amministrazione amministrazione@eidosmedia.ch
Chiusura redazionale: 4 ottobre 2024

Editoriale

Montblanc
Prime, ma per quanto?
il Vecchio Continente da intendersi quale espressione geografica, e per sostenibile o meno che sia, rimane la patria del manifatturiero, come Svizzera, Italia e Germania confermano tutti i giorni. Le materie prime sono dunque un tema di capitale importanza, spesso snobbato, se non per questioni destinate a rimanere irrisolte. Eppure sempre in Europa nel corso degli anni si sono insediati i giganti del trading mondiale, e proprio in Svizzera hanno trovato la loro casa, a mancare continuano a essere queste risorse. Ma del resto a geologia non si comanda...
Al centro del dibattito politico e geopolitico è da ormai un decennio che si tratta e contratta di ‘indipendenza strategica’, ossia l’affrancarsi dell’Europa da altri Paesi esportatori di materie prime considerati o considerabili ostili, provvedendo da sé ai propri bisogni. Al di là che questo sia o meno possibile, la vera domanda è sino a che punto convenga davvero destinare decine di trilioni di euro e franchi per conquistare questa indipendenza, laddove forse non sono queste le vere materie prime di domani, ma solo di oggi. Le tecnologie cambiano, e gli elementi necessari a farle funzionare anche.
L’Europa non dispone di campioni digitali, ma se il petrolio di domani saranno i dati, non dovrebbe forse ragionare su quello, e sul come prevenire questo nuovo genere di cartelli?
Risorse ‘di primaria importanza’ a loro volta, anche la sanità, l’immobiliare e il tempo nelle differenti interpretazioni, mentre il futuro già incalza, sono materia di un dibattito che si spera non produca solo parole.
Federico Introzzi
Homage to Victoria & Albert Un omaggio al mecenatismo reale. Quello della regina Vittoria e del principe Alberto appassionati e convinti sostenitori del mondo delle arti.
La tradizione che si rinnova. Caro lettore, nel solco dell’inzio di questo delicato e rispettoso cambiamento prosegue il percorso che nell’arco di pochi mesi, e quattro edizioni porterà a un piccolo e grande rinnovamento di cui comunque se ne percepiva la necessità per guardare rinnovati a un futuro, già presente. Ogni quarto di secolo è tempo di prendersi un po’ cura anche di se stessi, con una piccola manutenzione.

Dipendenza... da cosa?


Le materie prime sono i fondamenti delle economie anche avanzate, ancora nel XXI secolo, eppure alla geologia non si comanda. Come ci si può affrancare dalla dipendenza dagli Emergenti? E soprattutto, sono davvero i minerali il punto?
Opinioni
12 Ettore Accenti. I virtuosi obiettivi della transizione energetica sono verosimili? La parola ai dati.
14 Luca Trisconi . Cosa comporta per le imprese svizzere l’obbligo di annuncio rapido della nuova Ldp?

16 Oliver Buomberger (in foto). Meglio Trump o Harris per i mercati finanziari? A confronto, quattro possibili scenari.
18 Stelio Pesciallo. Anche in Svizzera si corre il rischio di rispondere alla disinformazione con la censura.
20 Ignazio Bonoli. Il calo del costo dell’energia e la forza del franco fanno scendere l’indice dei prezzi al consumo e prospettano nuovi tagli del tasso guida della Bns.
22 Frank Pagano. L’Ia ucciderà la creatività o, al contrario, potenzierà quella che è oggi una merce rara?
Economia
34 Convegni. Guidare la formazione dei leader di oggi e domani interpretando il continuo cambiamento.
40 Sanità. Ex fiore all’occhiello della nazione, il sistema sanitario dà sempre più problemi. Da risolvere uniti.
45 Sanità. I costi in esplosione in Ticino richiedono una risposta da Berna.
46 Aziende. Tensol Rail di Giornico.


Da sinistra, Andrew Keiller, Partner di Baillie Gifford, Manuel Maleki, Responsabile Ricerca economica di Edmond de Rothschild, Marc Elliott, Investment specialist di Ubp, Alessandro Valentino, Product Manager di VanEck.
Osservatorio
81 Sfama. I fondi svizzeri.
82 Alternativi. Solidi rendimenti e obiettivi ecologici: la finanza privata guarda alle tecnologie ambientali.
84 Commento. Dopo i colpi di scena del pre, cosa potrebbe seguire alle presidenziali Usa di novembre?

86 Mercati. Niente panico, la storia insegna che il mercato prima o poi si riprenderà, se si guarda a lungo termine
88 Analisi tecnica (in foto, Yves Schläpfer). Identificare parallelismi storici per prevedere gli sviluppi dei mercati, affidandosi alla matematica per superare i bias.
90 Tematici. L’Ia nelle sue molte forme delinea interessanti opportunità a patto di sapersi posizionare, per tempo.
91 Mercati Avvicendamenti al timone, guai giudiziari, politiche fiscali discutibili: le difficoltà della Thailandia.
Eureka
48 Life sciences. Affidabilità e innovatività delle Biotech svizzere.
51 Life sciences. Velocizzare la catena di fornitura del Pharma.
52 Digitale L’abito non farà il monaco, ma la presenza digitale sì.
54 Universitari. Appianare le diseguaglianze di genere a vantaggio di un’economia moderna e dinamica.
Immobiliare
58 Hospitality. L’alberghiero come alternativa per investire nel real estate commerciale Quali i trend?
64 Tassi. Il taglio della Bns ridà slancio a proprietà e investimenti.
66 Studio legale. Lafe e Italia, attenzione all’impatto della reciprocità.
72 Territorio. Cosa rivela il ranking dei comuni più belli della Svizzera?
Cloud computing p. 36
I dati si preparano a vivere felici, sicuri e performanti nel regno delle nuvole.
A fronte di soluzioni in costante evoluzione, fondamentale la consulenza di un cloud service provider. A lato, Marco Tramacere, Ceo di Tinext Cloud.

Life sciences p. 48

Il Tech corteggia il Pharma, recando in dote le opportunità dell’Ai. Un matrimonio di cui il settore ha più che mai bisogno accelerare Ricerca & Sviluppo.
A lato, Luciano Monga, partner di Deloitte Svizzera a Lugano.
Crescere in famiglia
Il mondo assicurativo evolve, e mantiene la rotta in una direzione ormai presa nei primi Duemila. La storia di una realtà locale, affermata. A lato, Vittorio Finardi, Ceo di Finardi & Partners.
Finanza
Sistema sanitario p. 42
Obiettivo comune: mantenere l’eccellenza di cure e prestazioni, ma a condizioni sostenibili. Fra pragmatismo e arte del compromesso, un percorso lungo e complesso per trovare soluzioni efficaci.
A lato, Anne Lévy, direttrice dell’Ufsp.

Branded real estate p. 68

Forte delle sue competenze uniche nell’automotive, Pininfarina è in pole position per portare innovazione e stile anche nell’immobiliare.
A lato, Giovanni de Niederhäusern, Senior Vice President di Pininfarina Architecture & Product Design.
p. 76

74 Analisi. Le Pmi svizzere tornano ottimiste sul futuro. E l’Ia?
85 Tematici. La formula che spinge il successo del settore degli ascensori.
Cultura&Lifestyle
92 Mostre. Anche la Svizzera si confronta con la sua eredità coloniale.
Haute Horlogerie p. 106
Oltre i confini della tecnica e dell’estetica, per esplorare con approccio indipendente nuove frontiere dell’orologeria. Quando il gioco si complica, le stelle non stanno (solo) a guardare. A lato, Denis Flageollet, cofondatore di De Bethune.

96 Mostre . I percorsi simmetrici e complementari di Yves Klein e Arman, alla Collezione Olgiati.
100 Architettura. Una progettualità in simbiosi con la natura e la cultura locale, che reinterpreta il passato guardando al futuro.
104 Orologi. Il successo degli eventi fisici dedicati all’haute horlogerie conferma l’importanza di un’interazione reale per il settore.
108 Orologi . Dalla montagna all’avazione alle immersioni, l’anima sportiva di un 140enne.
110 Motori. In pista e... al museo: il mito di Ferrari seduce e appassiona.
Rubriche
10 Appuntamenti
112 Motori
Cover story
Quali sono le materie prime di questo secolo? Quali le risorse più rare e preziose?
Eureka
La sezione dedicata all’innovazione, alla tecnologia e
Opinionisti
Le voci degli esperti che accompagnano i lettori con costanza.
Finanza
Riflettori accesi su indipendenti, banche e asset management.
Economia
Tutti gli articoli dedicati all’analisi di temi economici dalle aziende alla consulenza.
Osservatorio
La rubrica di approfondimento finanziario si amplia.
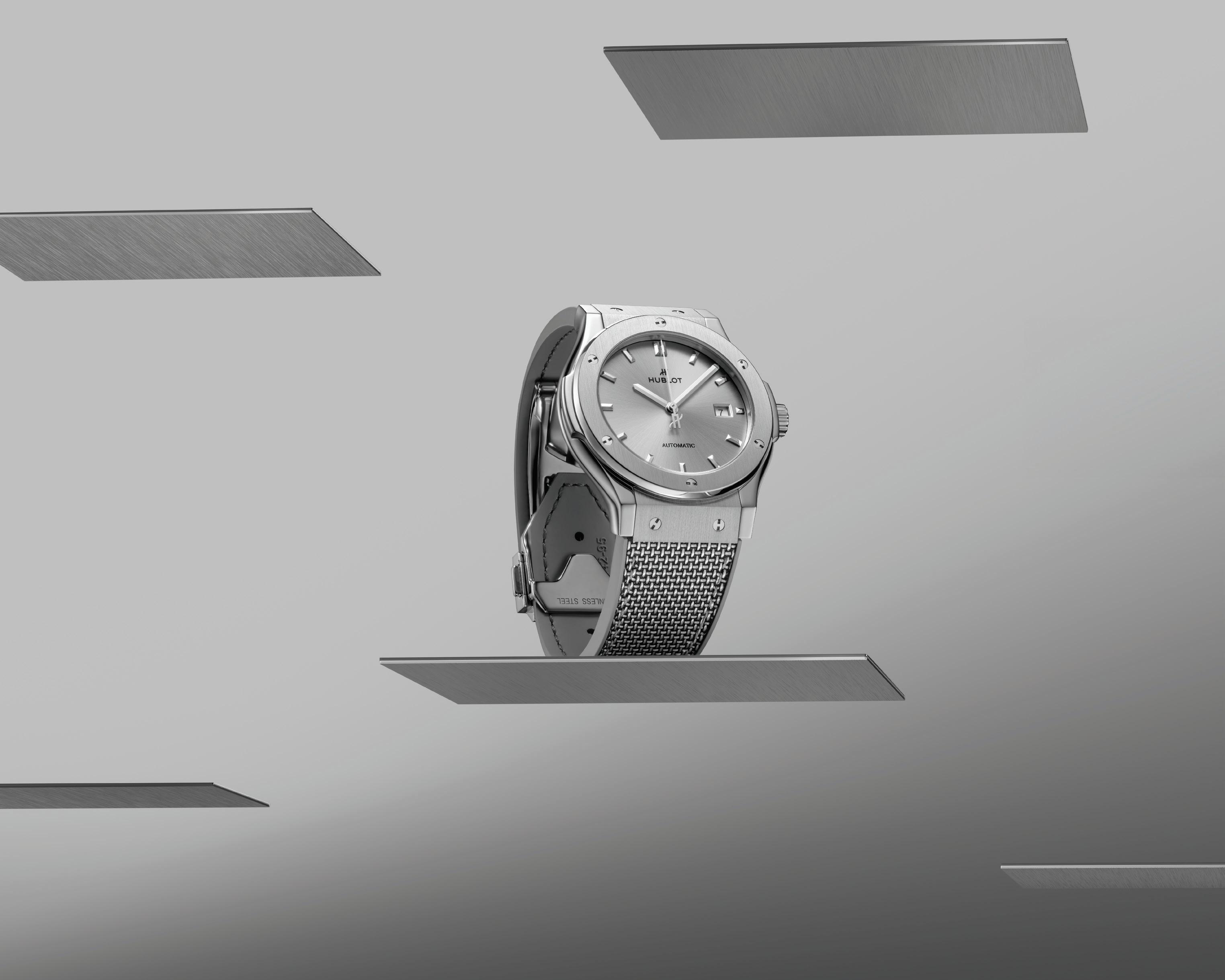
Hublot scrive il terzo capitolo della storia del suo Essential Grey. La release 2024 comprende due modelli Classic Fusion in un grigio radioso, disponibili esclusivamente online.
Using EIDOS colors
E IDOS G R AY # 8a8 d8 e
C: 0 M: 0 Y: 0 K : 57
R :137 G:14 0 B:142 PANTONE 87 7
E IDOS R E D
#e4 0 02b
C: 0 M:10 0 Y: 8 0 K : 0 R :2 28 G: 0 B:4 3
18 5

Vienna Rembrandt. Hoogstraten
Colore e illusione
La luce protagonista assoluta della pittura olandese del XVII secolo trova la sua massima espressione nell’uso del colore e nell’illusionismo ottico delle opere di Rembrandt (1606-1669). Il Kunsthistorisches Museum Vienna ne mette in dialogo alcuni dei capolavori con le opere del suo altrettanto ambizioso discepolo Samuel van Hoogstraten (1627-1678) che, entrato nella sua bottega a 15 anni, seppe gareggiare con il maestro in virtuosismo, facendone teatro di sfide artistiche e continue innovazioni. Esemplari i quadri che raffigurano persone che vanno letteralmente oltre la cornice dipinta, come la Ragazza nella cornice di Rembrandt e il Vecchio alla finestra di Van Hoogstraten.


Due pionieri, sempre alla ricerca di nuovi modi per rappresentare la natura e la realtà, ingannando l’occhio dello spettatore con tridimensionalità e movimento. Sessanta opere, fra dipinti, disegni e stampe, con molti capolavori provenienti dalle collezioni del museo e da importanti prestiti internazionali, sono state selezionate per offrire esempi paradigmatici delle due produzioni, focalizzando l’attenzione su due aspetti cruciali, colore e illusione, mostrandone il carattere sperimentale e l’arsenale di artifici.
L’iniziativa viennese è frutto di una collaborazione con la Rembrandthuis di Amsterdam, che dal 1 febbraio al 4 maggio 2025 dedicherà una mostra interamente a Van Hoogstraten (L’illusionista). Kunsthistorisches Museum Fino al 12 gennaio 2024

Allievo e maestro fanno a gara di illusioni ottiche, esemplarmente illustrate dai trompe l’oeil raffiguranti persone che si proiettano oltre la cornice dipinta: a sinistra, Rembrandt, Ragazza nella cornice, 1641, tavola, 105,5 × 76,3 cm; a destra, Van Hoogstraten, Vecchio alla finestra, 1653, tela, 114,9 × 91,3 cm, in un’eccezionale mostra al Kunsthistorisches Museum Vienna.
Parigi Rodin / Bourdelle Corpo a corpo
Per quindici anni Antoine Bourdelle (1861-1929) scolpì marmi per Rodin (1840-1917), che assediato dalle commissioni si appoggiava a una dozzina di praticanti. Nipote di uno scalpellino e figlio di un ebanista, il giovane dimostrava un talento che, malgrado l’indisciplinatezza del carattere, fece vedere in lui al maestro un “apripista per il futuro”. I loro percorsi, paralleli e spesso sovrapposti, si ritrovano uniti nella grande mostra al Musée Bourdelle di Parigi, un luogo già di per sé affascinante, che ingloba edifici costruiti tra il 1878 e il 1992, collegati da tre giardini pieni di sculture in bronzo, fra i quali proprio l’ex atelier dove Bourdelle scolpì per oltre quattro decenni. Attraverso più di 160 opere, tra cui 96 sculture, 38 disegni, 3 dipinti e 26 fotografie, il dialogo proposto rivela affinità e reciprocità, ma anche divergenze e antagonismi di questi due creatori di due universi plastici portatori dei grandi temi della modernità. Musée Bourdelle Fino al 2 febbraio 2025
Da sinistra, Auguste Rodin, La Lussuria, testa, modello in grande scala, 1907, gesso, Parigi, Musée Rodin, e Antoine Bourdelle, Apollo, maschera, 1900, gesso, Parigi, Musée Rodin.
I due scultori sono protagonisti di un ‘corpo a corpo’ al Musée Bourdelle.
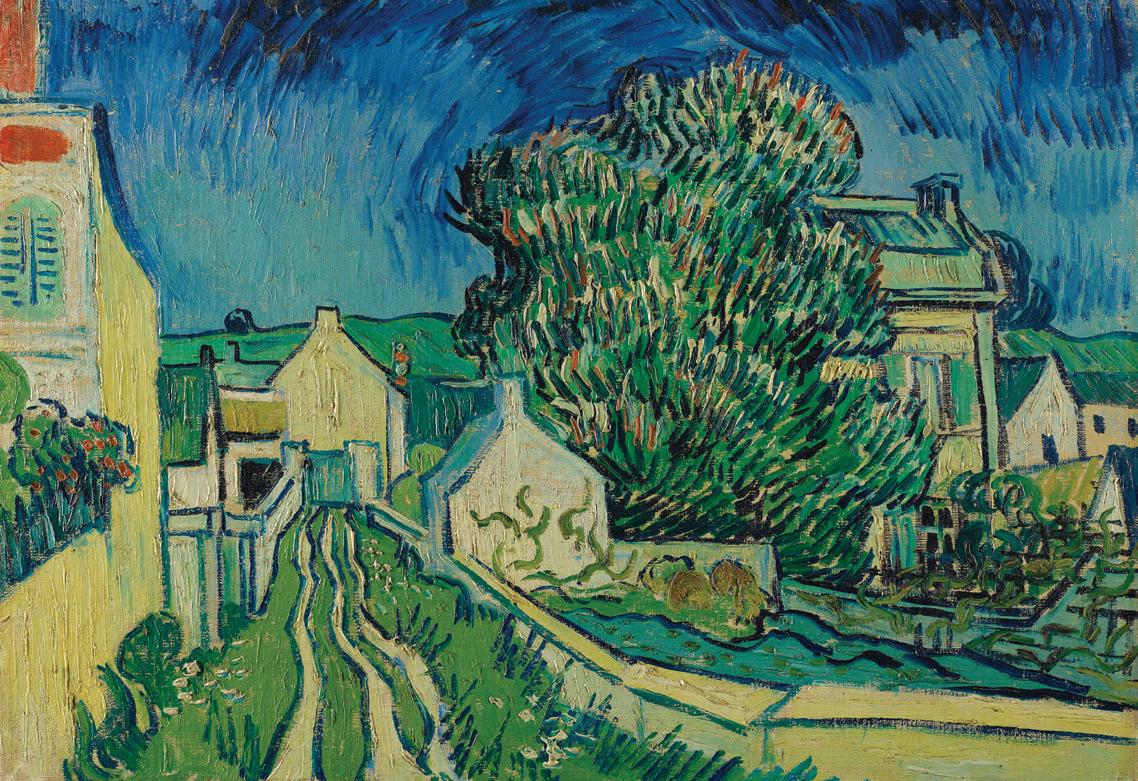
Zurigo
Wong - Van Gogh
Pittura,ultima salvezza
“Mi vedo in lui. L’impossibilità di appartenere a questo mondo”, dichiarava il pittore canadese, di origini cinesi, Matthew Wong (1984-2019), evocando il suo grande modello Vincent van Gogh (18531890). Come lui avvicinatosi alla pittura da autodidatta, realizzando il suo primo disegno relativamente tardi, all’età di 27 anni, con sorprendente rapidità negli otto anni successivi ha creato un corpus di opere tanto vasto quanto vario, caratterizzato da una pittura dinamica e colorata, con una predilezione per i paesaggi lirici di grande forza evocativa che non può che richiamare il maestro olandese. Ma i parallelismi sono purtroppo evidenti anche nel tragico epilogo delle loro vite: Wong, che soffriva di depressione, sindrome di Tourette e autismo fin da giovane, si è tolto la vita a 35 anni, come pure van Gogh, tormentato da ansia e allucinazioni, pose fine ai suoi giorni mentre era ricoverato ad Auvers-sur-Oise
Il Kunsthaus Zurich presenta la prima grande retrospettiva dedicata in Europa questo artista, proprio mettendone circa 40 interni e paesaggi immaginari in dialogo con una dozzina di capolavori di Vincent van Gogh.
Kunsthaus Zürich Fino al 26 gennaio 2025
Accanto, il ‘gioco di specchi’ fra Ruth Moro, H2801 Verde Acqua, 2023, brattee di hydrangea quercifolia su carta a mano su Mdf 50 x 50 cm (a sinistra), e Giancarlo Moro, 4403 senza titolo, 2024, olio su tela, 98 x 98 cm (a destra). © Ruth
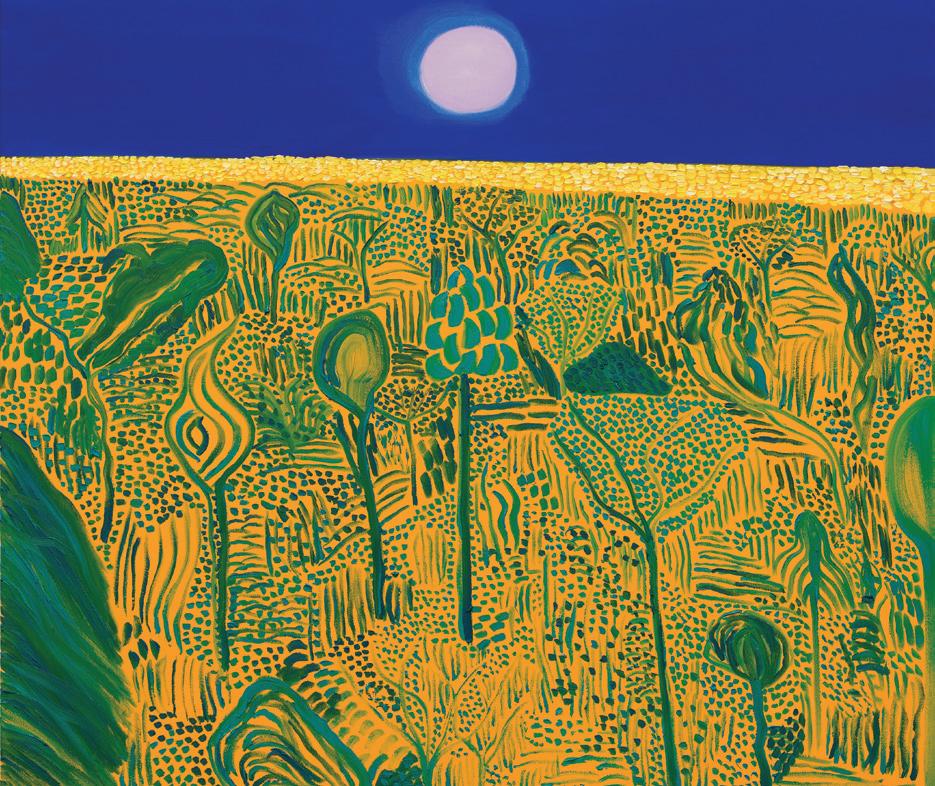
Ruth e Giancarlo Moro
Gioco di specchi
Uniti nella vita e nell’arte: Ruth (Svitto 1944) e Giancarlo Moro (Ginevra 1944), due fra i più significativi artisti del territorio ticinese, sono protagonisti al Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona, che presenta una serie di opere nate da più di cinquant’anni di vita comune e quotidiano confronto creativo nell’abitazione a Cavigliano, in cui dal 1971 abitano e lavorano nei loro atelier.
Ruth, al piano inferiore, facendo della natura la materia prima del suo operare, ne distilla forme strutturalmente essenziali e pure, che a volte immerge nel colore, per poi comporle, assemblarle, trasformarle in reticoli; a volte le lascia libere nello spazio, altre le integra in supporti di carta realizzati a mano. Giancarlo, nel suo studio al piano superiore, si dedica totalmente alla pittura in senso astratto. Applicando un rigore scientifico, attento ai meccanismi della percezione, vaglia e sperimenta le intrinseche potenzialità e interferenze del colore puro espanden-
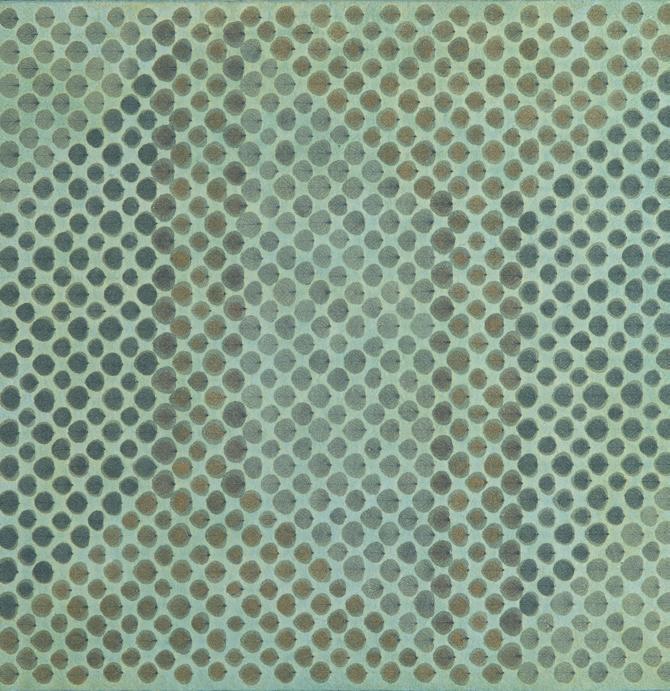
Da sinistra, van Gogh, La Casa di Père Pilon,1890, olio su tela, 49 x 70 cm, Collezione privata, e Matthew Wong, Coming of Age Landscape, 2018, olio su tela, 152,4 x 177,8 cm, Collezione privata. In dialogo, al Kunsthaus Zürich.
dolo e combinandolo in infinite gamme e gradazioni di toni, di tinte e di sfumature e studiandone lo strutturarsi in modo autonomo e processuale in griglia e in superficie spaziale assoluta.
Pur lavorando con stili e modalità diversi, i lavori dell’una sembrano riflettersi in quelli dell’altro per una forte assonanza nella scelta dei colori, per la stessa analisi rigorosa nella realizzazione compositiva e, soprattutto, per il comune interesse per l’universo formale orientale, essenziale, cosmico e olistico, che ha portato verso un sintetismo ancor più minimalista il bagaglio della loro formazione nell’àmbito delle avanguardie degli anni Sessanta. Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona Fino al 5 gennaio 2025
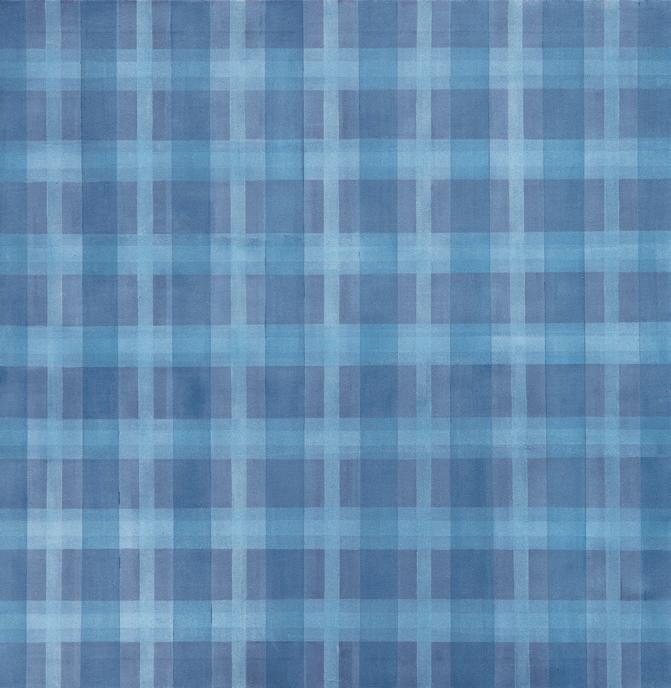
opinioni / l’esperto di tecnologia
Un bagno di realtà fra i dati
Richiamarsi ai numeri è un esercizio indispensabile per non perdere di vista la realtà. Quelli su economia, consumi energetici e inquinamento mostrano un quadro ben lontano dalle attese.
Con l’industrializzazione iniziata nel XIX secolo, l’avanzata della tecnologia si è trovata spesso a doversi confrontare con gli effetti sull’ambiente e sulla vita. Da qualche decennio la situazione si è enormemente complicata per l’impetuoso sviluppo delle attività umane basato su un largo impiego di energie fossili. L’argomento, come sempre, è diventato appannaggio di opinioni tra le più disparate
e della politica che, spesso, si preoccupa più delle questioni elettorali che non di analizzare la realtà dei numeri. Questo è dovuto alla complessità che per la prima volta l’umanità intera si trova di fronte: consumare meno il pianeta riducendo il Pil globale distribuendolo meglio e farlo in poco tempo mettendo d’accordo tutti i Paesi. Ci si sta provando da ormai decenni senza alcun risultato, come i numeri indicano chiaramente.

Ettore Accenti, esperto di tecnologia. Blog: http://bit.ly/1qZ9SeK.
Nella ferma convinzione che solo i numeri possano catturare la realtà in cui siamo immersi, con un lavoro da certosino, ho creato una tabella che consente a chiunque, con un minimo di capacità tecnica, di trarre considerazioni oggettive. La tabella comprende dati su energia
Quadro globale energia, economia e inquinamento Energia ed economia dati 2019 (sopra) e 2023 (sotto); inquinamento dati 2013 (sopra) e 2023 (sotto)

ed economia per gli anni 2019 e 2023 e sull’inquinamento per gli anni 2013 e 2023, permettendo anche confronti temporali e lasciando ogni giudizio al lettore. I dati sono ricavati dai documenti disponibili e precisamente: Energy Institute, Enerdata, Iea, World Energy, Irena, Eia, NewClimate e Climate Observatory.
Legenda della tabella
Colonne 1-7: energia primaria (totale) consumata per singola fonte, in TWh (2019 e 2023).
Colonna 8: consumo energia primaria pro capite (Ppp) in kWh (2019 e 2023). Colonna 9: energia importata ed esportata come % dell’energia primaria consumata nel 2023.
Colonna 10: Pil Ppa (a parità di costi) 2023 in miliardi di Usd (Pil B$) e Pil pro-capite Ppa in Usd (Ppp $).
Colonna 11. Emissioni annuali CO2 in milioni di tonnellate, 2013 e 2023 Colonna 12 : emissioni annuali procapite CO2 in tonnellate, 2013 e 2023.
Esempi di alcune osservazioni ricavabili dalla tabella. Dal 2019 al 2023 il consumo di energia nel mondo è aumentato di 9.933 TWh e nello stesso periodo le rinnovabili (solare + eolico + geotermica + biomassa + rifiuti) sono aumentate di 5.005 TWh. L’incremento delle rinnovabili non ha coperto il solo aumento dei consumi. Nel 2023 la produzione mondiale di solare ed eolico è stata di 1.641 TWh (0,95%) e 2.325 TWh (1,35%) rispettivamente dell’energia primaria. La Federazione Russa, con un consumo a parità di costi pro capite nel 2023 dell’ordine dei consumi di Usa ed Europa, dispone di un Pil molto inferiore; questo può essere spiegato dagli elevati consumi dell’industria pesante russa.
La distanza tra consumi pro capite tra Paesi ricchi e poveri rimane spaventosa: nel 2023 quelli dell’Africa sono ancora un decimo degli europei. In Europa il consumo di energia primaria dipende in gran parte dalle nazioni esportatrici. Il Net Zero, leggi zero emissioni di Co2, che l’Unione europea ha previsto per il 2050, appare una chimera. Ad esempio, per l’Italia, anche supponendo un Pil fer-
Fare impresa è la responsabilità verso il personale
mo al 2023, occorrerebbe che l’elettrico passasse dagli attuali 220 TWh/anno a 1.654 TWh/anno, impossibile senza il nucleare e anche con questo ben difficile. L’emissione antropica di Co2 dal 2013 al 2023 è aumentata di 3.850 milioni di tonnellate portandosi ad un totale di circa 40 miliardi di tonnellate. Questo fa ritenere che l’attuale riscaldamento medio dell’atmosfera di 0,12 C° ogni 10 anni tenderà ad aumentare. Dal 2013 al 2023 l’Europa ha ridotto le proprie emissioni di Co2 di 889 milioni di ton/anno, mentre nel mondo sono aumentate di 2.428, aumento dovuto ai 2.922 aggiunti nello stesso periodo da Cina e India. Le disparità dell’inquinamento pro-capite da Co2 sono incredibilmente diverse: le nazioni meno inquinanti pro capite nel 2023 risultano essere Africa (0,95), India (1,97), Indonesia (2,52), Svizzera (3,63), Francia (3,86), Spagna (5,15), mentre le più inquinanti risultano essere Usa (14,31), Arabia Saudita (14,05), Australia (13,98), Russia (11,2), Sud Corea (10,98), Giappone (8,10). Le nazioni con il maggior utilizzo di rinnovabili in TWh sono: Cina (4.481), Usa (2.440), Germania (723), India (661).

Uno sguardo vigile sui dati
Fra i principali cambiamenti per le imprese della nuova Legge sulla protezione dei dati, l’obbligo di segnalare un accesso non consentito a informazioni riservate in proprio possesso.
Nella primavera 2018 avevo già scritto su queste pagine in merito al nuovo Regolamento generale sulla protezione dati dell’Unione europea, noto con l’acronimo inglese Gdpr - General Data Protection Regulation, - entrato in vigore il 25 maggio di quell’anno. Avevo ricordato come quelle disposizioni legali fossero direttamente applicabili a tutte le aziende attive sul territorio dell’Unione europea, senza la necessità di essere recepite nelle varie legislazioni degli Stati membri. Anche ad aziende non stabilite all’interno dell’Unione, nel limite in cui venissero trattati dati personali di persone residenti all’interno dei suoi confini.
La Svizzera, quale Stato terzo, si è adeguata a suddette nuove normative aggiornando la propria Legge federale sulla protezione dei dati (Lpd), in essere dallo scorso 1 settembre 2023.
La prima legge federale sulla protezione dei dati risaliva al 1992. Nel frattempo la popolazione svizzera ha introdotto l’uso di internet e degli smartphone nel suo quotidiano e ricorre sempre più frequentemente a reti sociali, cloud o IoT. Oggi anche all’intelligenza artificiale. Un rimaneggiamento completo della Legge sulla protezione dei dati era quindi indispensabile per assicurare alla popolazione una protezione adeguata e adattata alle evoluzioni tecnologiche e sociali. Cosa cambia? La nuova Lpd introduce i seguenti otto cambiamenti principali per le imprese: i) solo i dati delle persone fisiche saranno da ora in poi protetti, e non più quelli delle persone giuridiche; ii) i dati genetici e biometrici entrano nella definizione dei dati sensibili; iii) vengono introdotti i principi di “Pri-
vacy by Design” e di “Privacy by Default”. Come indicato dal nome, il primo principio (protezione dei dati sin dalla concezione) implica che gli sviluppatori integrino la protezione e il rispetto della vita privata degli utenti nella struttura stessa del prodotto o del servizio chiamato a raccogliere i dati personali. Il secondo principio (protezione dei dati per impostazione predefinita) assicura invece il livello di sicurezza più elevato dalla messa in circolazione del prodotto o del servizio, attivando automaticamente, ovvero senza intervento da parte degli utenti, tutte le misure necessarie alla protezione dei dati e alla limitazione del loro utilizzo. In altre parole, tutti i software, il materiale e i servizi devono essere configurati in modo da proteggere i dati e da rispettare la vita privata degli utenti; iv) devono essere condotte delle analisi d’impatto, in caso di rischio elevato per la personalità o per i diritti fondamentali delle persone interessate;
v) viene esteso il diritto di informare: la raccolta di tutti i dati personali - e non più unicamente di quelli detti sensibili - deve portare all’informazione preventiva della persona interessata;
vi) diventa obbligatorio allestire un registro delle attività di trattamento;
vii) è richiesto l’annuncio rapido in caso di violazione della sicurezza dei dati, da inoltrare all’Incaricato federale per la protezione dei dati e per la trasparenza; viii) la nozione di profilazione (cioè il trattamento automatizzato dei dati personali) entra a far parte della legge.
Mi soffermo qui sul nuovo obbligo di annuncio rapido. Lo stesso deve aver luogo soltanto in caso di violazione della sicurezza dei dati che comporti verosimil-

Luca Trisconi, avvocato e notaio, partner studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.
mente un rischio elevato per la personalità o per i diritti fondamentali della persona interessata. La valutazione del rischio presuppone un’analisi della situazione sulla base della natura, le dimensioni e il contenuto dei dati violati, le modalità e le circostanze dell’avvenuta violazione, il numero delle persone toccate e la facilità con cui le stesse potrebbero essere identificate. La notifica di un’avvenuta violazione della propria banca dati segue una procedura semplice. Addirittura, il preposto Ufficio federale ha messo a disposizione un formulario prestampato, scaricabile da internet. Dal 1 settembre a fine luglio 2024 sono già stati registrati ben 353 annunci di cui 37 pratiche si riferiscono a casi in cui sono stati violati i dati di oltre 2000 persone contemporaneamente. Ma cosa succede se il responsabile per la protezione dei dati di un’azienda non procede all’immediato annuncio indicato dalla legge? Nulla. L’avamprogetto legislativo prevedeva la possibilità di comminare una multa fino a 500mila franchi. Ma a seguito delle molteplici critiche espresse durante la procedura di conciliazione, il Consiglio federale ha poi rielaborato il progetto di legge limitando le sanzioni a carattere penale alle violazioni di norme essenziali e gravi. Non è considerata tale la semplice omissione dell’annuncio all’Incaricato federale per la protezione dei dati e per la trasparenza o la mancata informazione alle persone toccate dalla violazione della sicurezza dei dati. Chi non procede alla notifica non può pertanto essere punito.
Segnatempo che soddisfano la sete di adrenalina
Il brivido della pista e l’eleganza dell’artigianato: con gli orologi TAG Heuer Carrera Extreme Sport, la Maison continua a spingersi oltre i confini dell’orologeria.
Per 164 anni, TAG Heuer ha dimostrato un puro spirito orologiero d’avanguardia. Oggi, la collezione principale del marchio è composta da tre famiglie iconiche disegnate da Jack Heuer - Carrera, Monaco e Autavia - ed è completata dalle linee contemporanee Link, Aquaracer, Formula 1 e Connected.
La ‘Carrera’ deve il suo nome alla leggendaria corsa su strada ‘Carrera Panamericana’, famosa per le sue sfide estreme in Messico. Gli ultimi nati della collezione, il TAG Heuer Carrera Chronograph Extreme Sport e il TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport, fondono l’iconica eredità del marchio nel mondo delle corse con materiali all’avanguardia e un design innovativo.
I modelli del 2024 con un approccio audace alle gare motoristiche e alle prestazioni, comprendono quattro cronografi e due cronografi tourbillon.
Al centro dei nuovi segnatempo c’è il caratteristico quadrante scheletrato, ingegnosamente ripensato per migliorare la leggibilità, mentre uno scudo ancorato al centro richiama il celebre logo del marchio. Il TAG Heuer Carrera Chronograph e il Tourbillon Extreme Sport sono ora disponibili anche come quadrante connesso, estendendo lo spirito estremo di questi segnatempo al ricercato TAG Heuer Connected one.

Per informazioni:
Le collezioni TAG Heuer sono disponibili presso le boutique
CHARLY ZENGER
Lugano, Via Pessina 8
Ascona, Via Borgo 49 charlyzenger.ch
TAG Heuer Carrera Chronograph Extreme Sport Ref.CBU2082.FT6275
Meglio Trump o Harris?
Molti si domandano la vittoria di chi sarebbe meglio accolta dai mercati finanziari. È una domanda importante, la cui risposta dipende dai dettagli in cui questa dovesse verificarsi.
Democratici e Repubblicani
Performance degli indici nell’anno successivo le elezioni sotto le diverse presidenze

Oliver Buomberger, Coo & Deputy Ceo di Saxo Bank Switzerland. A lato, il delicato rapporto tra politica e mercati finanziari. Ci sono vere differenze?
Quattro, sono i possibili scenari: Trump o Harris vincono, ciascuno con o senza una maggioranza congressuale. Harris è leggermente in vantaggio, soprattutto negli swing states. Tuttavia, senza una chiara maggioranza al Congresso, potrebbe esserci un rischioso stallo.
Harris si propone di combattere la crescente disuguaglianza negli Stati Uniti. Il 10% più benestante possiede il 67% della ricchezza, mentre il 50% più povero ne possiede solo il 2%. Da qui l’idea di ridurre le tasse agli uni e aumentarle agli altri, in particolare quelli con un patrimonio superiore a 100 milioni di dollari. Si potrebbe dunque avere un gettito fiscale aggiuntivo, ma anche molte resistenze. Trump, invece, punta su nuovi e ulteriori tagli fiscali per i ricchi.
Nel complesso, si prevede che entrambi i Governi aumenteranno ulteriormente il deficit. Il principale motore dei mercati, la politica monetaria, è controllata dall’ancora indipendente Fed. Poiché le prospettive economiche sono piuttosto modeste, la politica monetaria rimarrà allentata e
i tassi di interesse bassi. È dunque più interessante guardare ai singoli settori.
Con un governo democratico, è probabile che l’espansione delle rinnovabili venga fortemente promossa. Le aziende che operano nel solare, eolico e delle tecnologie sostenibili potrebbero trarne vantaggio. Il passaggio alle energie rinnovabili è un megatrend, anche se i mercati lo stanno già in parte anticipando.
Anche il settore sanitario potrebbe beneficiare della politica di Harris. Questo settore è meno ciclico e offre stabilità. Aziende come United Health Group ed Elevance Group, che offrono soluzioni mediche innovative, potrebbero crescere anche in tempi incerti.
Con Trump, le aziende energetiche tradizionali come Exxon e le banche come Jp Morgan Chase sarebbero probabilmente avvantaggiate. Mentre in Europa si potrebbe assistere a un aumento della spesa in difesa, a vantaggio di Rheinmetall...
Nel 2023, il prezzo dell’oro è cresciuto di oltre il 20% e ha sovraperformato tutti i principali listini. Questa tendenza potrebbe continuare indipendentemente
dal risultato elettorale. I motivi sono l’aumento dei deficit nei Paesi industrializzati e le tensioni geopolitiche. È tradizionalmente considerato un bene rifugio in tempi di incertezza e di inflazione. Inoltre, le Banche centrali hanno iniziato ad aumentare le proprie riserve auree, riducendo i dollari. Se Trump dovesse porre rapidamente fine alla guerra in Ucraina, il prezzo dell’oro potrebbe scendere, ma ciò sembra improbabile.
Indipendentemente dall’esito delle elezioni, gli investitori dovrebbero attenersi a strategie consolidate. Investire in società di alta qualità e solide è fondamentale per sopravvivere alle flessioni dei mercati e garantirsi rendimenti a lungo termine. I settori difensivi come le Utility, i beni di consumo e l’assistenza sanitaria offrono stabilità in quanto meno sensibili alle fluttuazioni economiche. Occorre inoltre aumentare la quota di investimenti sicuri, come l’oro e i titoli di Stato a breve termine. Anche la diversificazione globale, in particolare Emergenti e tecnologia, può aiutare a minimizzare i rischi e a cogliere le opportunità dei mercati sottovalutati.
Gli investitori possono utilizzare diverse strategie di copertura per proteggersi da eventuali turbolenze di mercato a breve termine durante e dopo le elezioni. Un metodo popolare è la copertura con opzioni put, al pari degli ordini stop-loss. Gli investitori dovrebbero anche diversificare all’interno delle asset class per non limitarsi a detenere diversi titoli, ma investire in diversi settori e regioni.


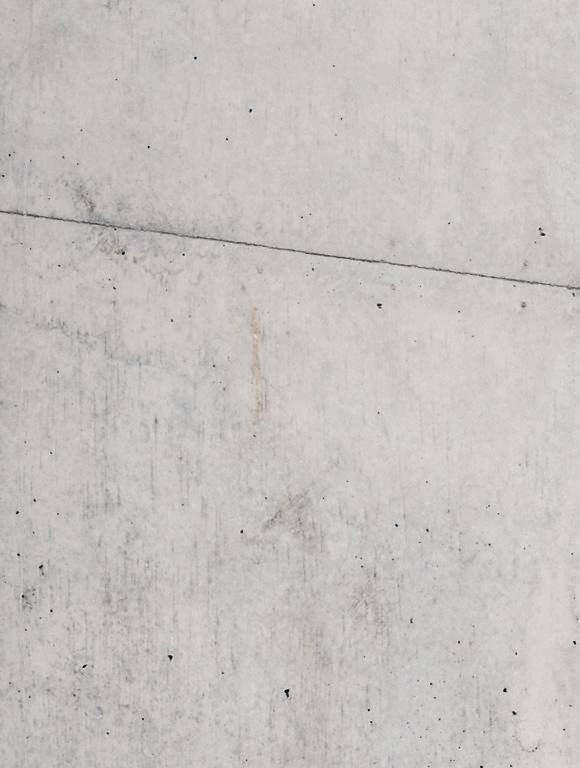



È piccola. È potente. È qui.
La nuova Volvo EX30 100% elettrica.

Il nostro SUV più piccolo di sempre che si distingue per le sue prestazioni potenti, il suo design innovativo e l’impronta di CO₂ più bassa di tutti i veicoli Volvo.


Spesso la vera grandezza è nelle piccole cose.


Prenota subito un giro di prova.










Soffiano venti di censura
Il Consiglio federale adotta un rapporto che, per contrastare la cosiddetta ‘disinformazione’, prevede misure che metterebbero a tacere tutte le idee ritenute non politicamente corrette.
Nell’edizione dello scorso numero di marzo avevo commentato il Digital Services Act emanato dalla Commissione Europea il mese precedente con il quale viene imposto alle società di messaggistica online come Facebook, TikTok o X l’obbligo di escludere dalla rete la pubblicazione di messaggi o notizie ritenuti ‘illeciti’ o ‘contrari ai valori europei’ o ‘dannosi’, pena la comminatoria di penalità pari al 6% del loro fatturato. Nel contempo mettevo in rilievo il pericolo che simili misure costituivano per l’esercizio della libertà di espressione.
Ora questa tendenza degli Stati e delle organizzazioni internazionali che li rappresentano sembra prender piede anche in Svizzera con la pubblicazione, nel mese di giugno, di un rapporto del Consiglio federale intitolato Attività di influenza e disinformazione, cui è seguito ad agosto un rapporto commissionato dal Dipartimento della difesa con cento “raccomandazioni” in materia di sicurezza, su temi centrali come la neutralità (che si vuole indebolita), la cooperazione con alleanze esterne (leggasi Nato) e l’apertura nella politica degli armamenti (leggasi esportazione anche verso paesi in guerra, vietata dalla vigente legislazione).
In ambedue i rapporti, ma in modo più puntuale nel primo, vengono espressi argomenti che, con il pretesto di supposte influenze esterne e della disinformazione, sottolineano la necessità di intervenire di imperio, limitando la libera espressione e la libera fruizione di tutti i canali di informazione.
Se riprendiamo qui questa tematica è perché, molto sorprendentemente, gli organi di informazione pubblici e di più ampia diffusione hanno stranamente sot-
taciuto il citato rapporto del nostro governo che, se attuato nei suoi intendimenti, porterebbe a mettere il bavaglio a idee ritenute non ‘politically correct’.
Il punto di questo rapporto è che determinate attività di influenza sarebbero volte a sabotare i processi politici, così come sarebbero atte a minare la fiducia della popolazione nelle istituzioni.
In particolare, il Consiglio federale ritiene che, a seguito della crescente insicurezza che si sarebbe instaurata in Europa e con le tensioni che si manifestano a livello globale, si sarebbe rinforzata la minaccia delle attività di influenza quali, appunto, la ‘disinformazione’. Queste attività sarebbero divenute più importanti con l’impiego dei mezzi tecnologici messi a disposizione della popolazione, segnatamente con l’impiego dei social, a dimostrazione che questa forma di democratizzazione dell’informazione costituirebbe una spina nel fianco di chi ci governa. L’impiego di questi mezzi porterebbe a un indebolimento della Svizzera a seguito di una modificata fruizione dei media, segnatamente a un’indebolita fiducia nei media tradizionali.
Chi si aspetta, a fronte di questa denuncia della ‘disinformazione’, che il nostro governo faccia autocritica per la tendenza alla ‘disinformazione’ proveniente da fonti della politica federale o della pubblica amministrazione rimarrà deluso.
In effetti per il nostro governo l’unica fonte di ‘disinformazione’ è esterna e proviene da ben identificabili forme statuali e sistemi politici. Secondo i guru della nostra politica di sicurezza, che stanno dietro a questo rapporto e che pedissequamente riprendono i mantra espressi dalle mosche cocchiere dell’Occidente, rilevanti a livello della nostra sicurezza

Stelio Pesciallo, avvocato e notaio presso lo Studio 1896, Lugano.
sarebbero attori di Stati esercitanti attività di influenza che propaganderebbero in maniera attiva altri ‘valori’, norme o sistemi politici e che tenderebbero ad affossare le nostre istituzioni democratiche. L’identificazione di questi ‘pericoli’ diventa chiara quando in un altro passo del rapporto viene detto che “con l’aggressione russa dell’Ucraina la guerra è ritornata in Europa e l’ordine di sicurezza europeo risulta scosso” aggiungendo che “il settore dell’informazione gioca un ruolo determinante in conflitti come la guerra in Ucraina o in quella tra Israele e Hamas”, laddove non si è più precisi se in questo caso la ‘disinformazione’ provenga da Israele o da Hamas.
Più esplicito ancora è il rapporto quando dice che “le attività russe, ma anche quelle cinesi, costituiscono a medio/lungo termine i maggiori elementi di instabilità per la sicurezza della Svizzera” e, ulteriormente, quando sottolinea che “i canali di informazione russi tramite soprattutto i mezzi online offrono a un pubblico globale un’interpretazione alternativa, disinformazione e una falsificazione della realtà in Ucraina”.
E così argomentando, ritendendo evidentemente i cittadini svizzeri privi di maturità e incapaci di farsi un’opinione, il nostro governo celebra la lotta alla disinformazione lanciata dalle alleanze politiche e militari occidentali e perora l’adozione di misure di censura puntuali analoghe a quelle adottate nell’Unione europea con il divieto di determinate fonti di informazione e con l’instaurazione del Digital Services Act.

SPARKS
Shine out and express your style.


Giù i tassi e l’inflazione
I prezzi dell’energia e il franco forte fanno scendere l’indice dei prezzi al consumo in settembre in Svizzera e lasciano ipotizzare nuove riduzioni del tasso guida da parte della Bns.
Afine settembre la Banca Nazionale Svizzera ha annunciato la riduzione del tasso guida dello 0,25%, sceso così all’1%, anticipando, in contemporanea, possibili altre correzioni entro fine anno. Per ora si è trattato della terza riduzione consecutiva, dopo quella - un po’ a sorpresa e prima di altre Banche Centrali - dello scorso mese di marzo.
L’annuncio preventivo di possibili altre riduzioni è piuttosto insolito per la Banca nazionale, ma è anche una sorta di risposta a coloro che si aspettavano un passo più consistente. In passato un intervento simile era già stato fatto, ma erano momenti di particolari difficoltà dell’economia, che aveva quindi bisogno di stimoli più significativi. Non è il caso oggi, dato che le previsioni di crescita economica, pur contenute, non indicano ancora un allentamento importante. Gli ultimi mesi dell’anno potrebbero però riservare qualche sorpresa, vista la situazione difficile della Germania, con le inevitabili ripercussioni in Europa.
La tendenza alla contrazione dei tassi di interesse è comunque evidente e ottiene ogni volta chiare conferme dall’evoluzione dei tassi di inflazione. Infatti, pochi giorni dopo l’annuncio, l’Ufficio federale di statistica pubblicava i dati del mese di settembre sull’andamento dei prezzi in Svizzera. L’indice del costo della vita ha subito un ribasso - piuttosto sorprendente - dello 0,3%. Sorprendente perché, anche se la tendenza è abbastanza chiara, pochi mesi prima, e cioè in gennaio e febbraio, si registravano ancora aumenti rispettivamente dello 0,6% e dello 0,2%. Si è quindi avuta la più forte diminuzione mensile da aprile 2020. Lungo tutto l’anno si è invece costatata una stabilizzazione dei prezzi nei
mesi estivi, ma già a partire da luglio una leggera tendenza alla contrazione. Comunque, a fine settembre, il livello dei prezzi era ancora dello 0,8% superiore a quello dello stesso mese dell’anno precedente. Da qui la probabilità che il rincaro scenderà ancora entro la fine dell’anno, creando le premesse per un’ulteriore riduzione dei tassi di riferimento.
Due sono i fattori principali che stanno provocando un calo del tasso di inflazione in Svizzera. In primo luogo i costi dell’energia, compresi quelli degli oli combu-
«L’annuncio preventivo di possibili altre riduzioni è piuttosto insolito per la Banca Nazionale Svizzera, ma è anche una sorta di risposta a coloro che si aspettavano un passo più consistente»
stibili, in calo del 3,4% dallo scorso mese di aprile. In secondo luogo le quotazioni del franco che, dopo un periodo di relativa debolezza in primavera, sono tornate a salire. Così, se a fine maggio l’euro era quotato a 98,2 centesimi, a fine settembre è sceso a 94,5 centesimi, favorendo i prezzi in Svizzera dei beni importati (-2,5%). Nel solo mese di settembre i prezzi dell’energia e dei combustibili sono diminuiti dell’1,6% e quelli dei beni importati dello 0,5% rispetto al mese precedente. Questo ha favorito anche i prezzi delle importazioni di semilavorati e simili (-0,2%). L’inflazione di base, cioè senza l’energia, è pure diminuita dello 0,3%.
Osservando più da vicino l’effetto sui prezzi di singoli prodotti si può costatare che il rincaro del franco premia le

Ignazio Bonoli, economista.
vacanze all’estero (non meno del 7,7% secondo l’Ufs), ma anche in patria (meno 11,2% nel para-alberghiero). I prezzi della locazione di automobili sono scesi del 7,2%, quelli della frutta esotica del 5,6%. Questo non ha impedito che i prezzi di alcuni prodotti (vestiti, scarpe e carne di manzo per esempio) siano aumentati. Da notare però che i prezzi di alcuni servizi privati sono scesi dello 0,4%, più delle merci (0,1%). Da tempo, invece, il rincaro era trascinato da servizi con forte intensità di lavoro. Probabilmente la costante mancanza di personale specializzato in Svizzera si è ridotta e la pressione sui salari è leggermente diminuita.
Questa panoramica ha in sostanza permesso alla direzione della Banca Nazionale di annunciare probabili nuove diminuzioni del tasso guida. Non va però dimenticato che le variazioni mensili dei prezzi sono a volte soggette a fattori particolari, che non modificano sensibilmente la tendenza di fondo. In realtà il tasso di inflazione in Svizzera resta ancora al 2,7%, cioè a un livello superiore a quello di fine 2022. Tuttavia un rincaro netto dello 0,8% in dodici mesi rientra negli obiettivi della Bns, cioè quelli di un tasso di inflazione compreso fra 0 e 2%.
La Banca Centrale è comunque confrontata con una sensibile rivalutazione del franco, per cui dovrà procedere nelle due direzioni, da un lato di acquisti di divise estere, dall’altro della riduzione delle rimunerazioni sul franco. Restano però altri fattori da considerare: che cosa faranno le altre banche centrali, in particolare la Bce, e quale sarà l’influsso della crisi medio-orientale sui prezzi dell’energia?








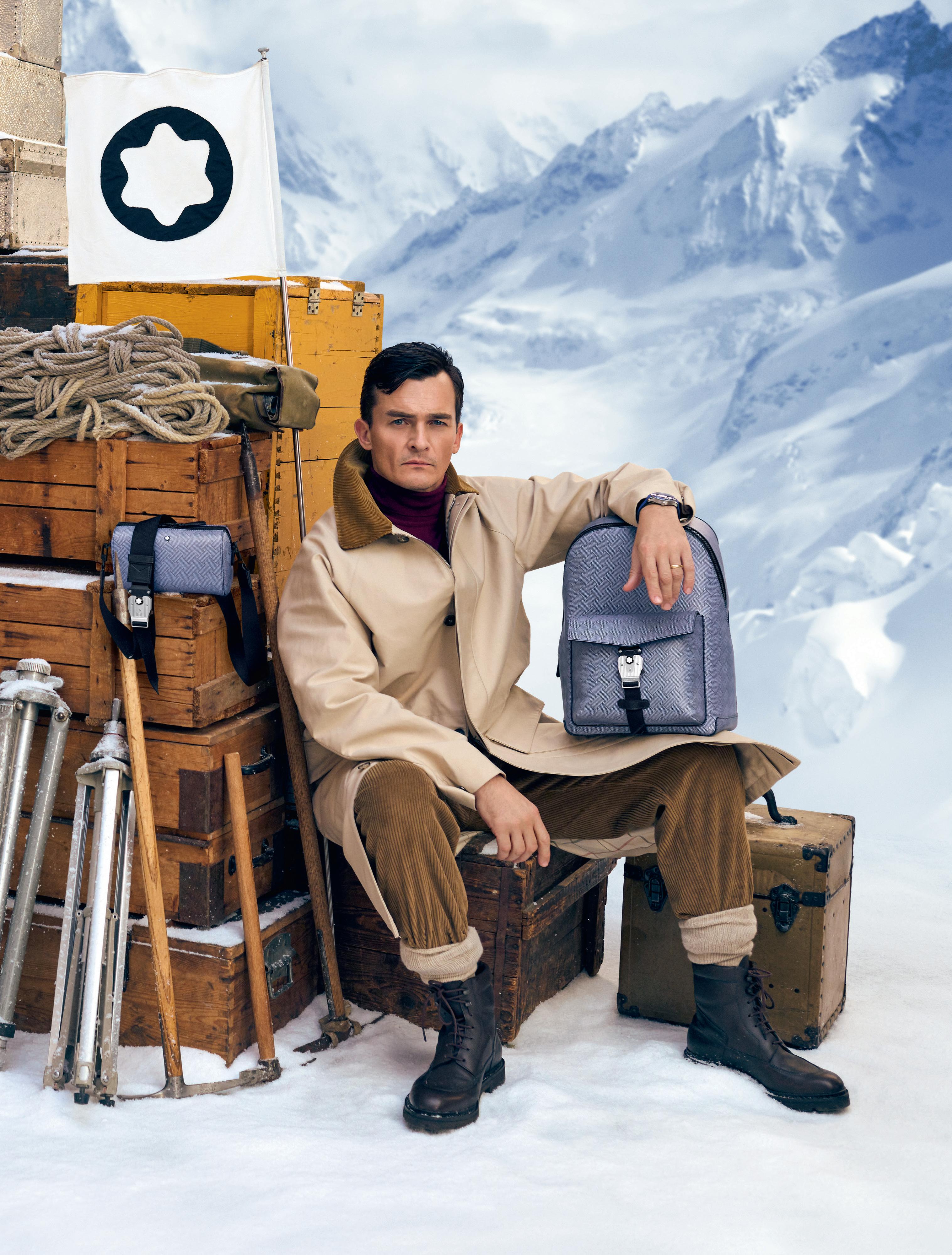
Rivoluzione creativa
I creativi di talento oggi sono pochi, e mal pagati. Ma se tra i loro strumenti imparano a metter l’Ia, possono trovare un prezioso alleato per aumentare la propria efficacia.

Èuna mattina qualsiasi, anno 2030. L’avatar dello stilista, alimentato dall’ultimo modello di Llm, ha passato al setaccio tutte le collezioni di moda globali e locali, di qualsiasi marchio, oltre a tutte le idee, gli schizzi, i post sui social media, le conversazioni private, video ed e-mail di ogni persona. Tutto ciò, a partire dall’Impero Romano, grazie al famoso Google Odyssey, il database più grande al mondo, per cercare quella nuova idea di una camicia estiva, per la comunità Alpha di Berlino, e in particolare per la tribù del Cap 10115, vicino al vecchio Muro. Il nuovo design viene creato istantaneamente dall’intelligenza artificiale e im-
mediatamente distribuito ai primi mille, i fortunati a vincere la lotteria tra coloro che si sono iscritti al workshop del marchio, con un semplice ‘tap’ delle dita dei loro avatar. Ricevono anche una frazione di bitcoin per il loro ruolo di ambasciatori. Se generano abbastanza interazioni, o buzz, su Roblox, verranno prodotti solo dieci capi e spediti a domicilio, a quelli con le migliori prestazioni. La designer del marchio non ha ancora abbozzato alcuno schizzo a mano, il suo compito è piuttosto quello di interagire digitalmente con i suoi fan. Una volta che ‘un’ design viene battezzato per la produzione e distribuito in formato fisico, in edizione limitata, oltre che a venire prodotto in

Frank Pagano, azionista di Tokenance, Senior Partner di Jakala, Contributor de Il Sole 24 Ore.
massa ma solo digitalmente, i diritti di proprietà intellettuale e i ricavi vengono distribuiti subito ai fan e agli azionisti, tramite blockchain, con calcoli elaborati da quantum computer che funzionano su occhiali, dispositivi indossabili o chip installati sul collo delle persone. Benvenuti nel futuro della moda.
Il mito della creatività. L’intelligenza artificiale ucciderà la creatività e i diritti di proprietà. Questo è l’adagio più comune, che sento ripetutamente. Indovina? Non siamo creativi, da adulti, e la maggior parte delle cose che scriviamo online non dovrebbero essere protette, compreso questo articolo. Nel suo ultimo lavoro, The Cost of Dull, Adam Morgan mostra come un video in cui una vernice si asciuga abbia un rendimento molto migliore dell’85% di tutte le pubblicità del momento. Lo stesso vale per un video di mucche che mangiano erba. Morgan ha testato le sue ipotesi e presentato le sue intuizioni al famoso Festival della Pubblicità di Cannes, dove le persone più creative del pianeta si riuniscono per una settimana per parlare di creatività e, naturalmente, bere rosé. Il problema è che i creativi di talento sono pochi, e non vengono pagati. La maggior parte delle interazioni sui social media sono passive (like) e i contenuti tendono a non essere originali (repost o retweet). Coloro che ‘creano’ qualcosa di nuovo non ricevono abbastanza soldi. Secondo il Wall Street Journal, lo scorso anno il 48% dei veri creatori ha guadagnato 15mila dollari o meno, mentre solo il 13% arriva a 100mila o più.

La capacità dell’intelligenza artificiale di moltiplicare la sperimentazione creativa ci fornirà gli strumenti per aumentare le nostre possibilità di coinvolgere il pubblico, se abbiamo qualcosa da dire (prompt). Ciò di cui abbiamo veramente bisogno è un sistema che ci permetta di monitorare il processo e i risultati dell’intelligenza artificiale, distribuendo al contempo gli incentivi lungo la catena ‘alimentare’.
Ora abbiamo lo stack tecnologico: blockchain e Ai. L’intelligenza artificiale sconvolgerà alcune professioni? Certo. L’intelligenza artificiale cambierà il modo in cui creiamo? Yes. L’intelligenza artificiale cambierà il modo in cui interagiamo digitalmente? Affermativo. Quindi, se gestisco una casa di moda, cosa faccio? O meglio: chi sarò come manager, creatore o leader d’impresa?
Chi sei? La creatività è un modo di operare, e necessita di un obiettivo e di una visione. L’obiettivo per qualsiasi azienda, e per la società in generale, quando i suoi poteri vengono aumentati dall’intelligenza artificiale e da altre tecnologie esponenziali come la blockchain, è triplice:
a) Cercare conoscenza, come abbiamo fatto fin dall’Illuminismo, per risolvere problemi concreti delle persone, sempre in modo semplice ed efficace, e talvolta con un’aggiunta di ispirazione e un senso di sorpresa, se pensiamo a come dovremmo trattare i nostri Vip e super-fan.
«La capacità dell’Ia di moltiplicare la sperimentazione creativa ci fornirà gli strumenti per aumentare le nostre possibilità di coinvolgere il pubblico, se abbiamo qualcosa da dire. Ciò di cui abbiamo veramente bisogno è un sistema che ci permetta di monitorarne il processo e i risultati, distribuendo al contempo gli incentivi lungo la catena ‘alimentare’»
b) Creare capitale sociale, ovvero assicurarsi che la nuova conoscenza e i suoi benefici siano condivisi il più ampia-
mente possibile, premiando azioni, contributi, ambasciatori, in linea con il tempo e la volontà delle persone di ‘ballare’ con un marchio, un’azienda e la loro rete di familiari, amici e contatti (giusto per essere chiari, pagandoli).
c) Sfidare lo status quo, almeno digitalmente (simulare più versioni di futuro), poiché i progressi tecnologici renderanno fragile qualsiasi attività e professione; e la tecnologia può aiutare a costruire un Piano B.
Continua a macinare dati. La tecnologia ci renderà più creativi, più adatti a identificare e premiare equamente amici e sostenitori, e più capaci di far evolvere ciò che facciamo. E allora, come sarà il futuro? Chiedi all’intelligenza artificiale, ma poni le domande giuste e controlla le risposte, se hai una visione di ciò che il mondo potrebbe conoscere, condividere e sognare. Se sei a corto di idee, continua a chiedere. Non troveremo una ‘teoria del tutto’ nell’Ai, almeno fino al 2030. È sufficiente inseguire nuove conoscenze, un ampio accesso per tutti a esse, e l’urgenza di cambiare, ripetutamente, o comunque essere pronti al nuovo.

PORTIAMO IL TUO BUSINESS PIÙ LONTANO O
Accedi a soluzioni innovative e a una vasta gamma di prodotti con il leader svizzero dell'online banking.
Indipendenza sì, ma da che cosa?

Il presente e il prossimo futuro sono legati a doppio nodo alla disponibilità di modeste quantità di minerali sempre più rari e difficili da raffinare, di cui ovviamente l’Occidente è sprovvisto. Sono concentrati in pochi Emergenti, il che aumenta il rischio del formarsi di nuovi cartelli, su modello dell’Opec. Se dunque garantirsi una ‘autonomia strategica’ è complesso, la vera domanda è se siano davvero questi i materiali da cui affrancarsi, o forse altri, più ‘impalpabili’.
Tanto, laddove non tutto, storicamente può essere reso spiegabile, o quanto meno giustificabile, se portato su un piano semplicemente economico. Delineata la giusta cornice, il contesto all’interno del quale la decisione era stata presa, le più balzane delle iniziative degli ultimi 5mila anni di storia diventano molto più razionali, fermo restando che continuino a esistere eccezioni, e che molto spesso la variabile ‘ideologica’, e qui la religione gioca la parte del leone, si conferma essere la più volatile in termini assoluti, e dai risultati meno economicamente confortanti. Se l’economia è sempre stata materia solida e concreta, non fosse che negli ultimi 15 secoli sopravvivesse l’idea non troppo arguta di scambiarsi merci a fronte di carriole d’oro o d’argento, a dipendenza del periodo, a occuparsene
erano persone altrettanto pragmatiche, chiamate a misurarsi con i mille vincoli del momento, geografici, politici, militari, religiosi… ecco dunque che accaparrarsi risorse altrettanto concrete e produttive, in primis miniere, pur al costo di qualche guerra non è insolito, se non addirittura normale amministrazione.
Parimenti in una data fase storica al termine dello sviluppo di un nuovo e incredibile ritrovato della tecnologia del tempo, frutto di quella che a tutti gli effetti poteva essere considerata una rivoluzione, laddove anche non ancora industriale, una determinata risorsa o lega risulterà essere sempre ‘quella definitiva’. Un suo ulteriore sviluppo improbabile, e troppo remoto anche solo per essere immaginato, o ipotizzato. Ecco dunque che al netto dei metalli preziosi, sui quali c’è una singolare unanimità, assoluta nel
tempo e nello spazio, le epoche storiche possono essere scandite sulla base di una semplice materia prima: dalla pietra al silicio è poi un attimo.
Se in origine era la pietra, ad essere seguita è l’argilla, ma questo in una fase ancora primigenia. La vita delle poleis greche era scandita dalla domanda e dall’offerta di bronzo, erano di questo metallo sia le statue che le armi, e infatti delle prime ne sono sopravvissute ben poche. Sino ai romani quando lo scettro è passato invece al ferro e all’acciaio, il che ad esempio spiega l’interesse per la conquista di alcune regioni tutt’altro che strategicamente interessanti o difendibili.
In questa chiave mettere in relazione le conquiste territoriali romane, con tutte le derivanti incombenze amministrative e regolatorie legate alla formazione di una nuova provincia in capo ai generali,
con la necessità di sostenere e alimentare l’apparato militare e civile della prima Repubblica, e poi Impero, spiega molto di quanto effettivamente successo. Al pari di tutti gli investimenti infrastrutturali che una nuova provincia imponeva ai magistrati incaricati, dunque edifici pubblici e ludici, strade e forti, in parte per presidiare i giacimenti delle nuove risorse, in genere minerali, così come per esportare in Italia quanto ricavato. Situazione tipicamente spagnola, con l’Hispania strappata a Cartagine che era lì per analoghe motivazioni, così come la Gallia, la Britannia, la Dacia, l’Africa, l’Egitto, l’Asia…
Guardando a tempi più recenti, e dunque gli anni ruggenti del carbone, seguito poi dal petrolio, dall’uranio, dal silicio, come spesso accade sono una semplice variazione del tema, seppur con qualche moderna ambiguità. La risorsa emblematica di questi anni qual è? E dei prossimi? Hic, et nunc. Al di là di una prospettiva storica, comunque apprezzabile e importante, a contare a livello di economia reale è sempre l’andamento del mercato, dunque il brevissimo periodo laddove non l’istante, ieri e domani, con uno scarto quadratico medio dell’ordine di qualche ora. Del resto, senza produzione, che nel secondario è vincolata alla disponibilità delle materie prime, non esiste nulla. «Sono il carburante che muove il mondo, un’imprescindibile fonte di ricchezza per i Paesi che ne dispongono, e la base di qualunque prodotto. La loro domanda è su base tendenziale in costante crescita, al pari di tenore di vita e numerosità della popolazione mondiale, per quanto la loro estrazione resti problematica in più d’un senso, pur con qualche palliativo offerto da innovazione e sviluppo tecnologico. Sono però anche un affidabile termometro delle tensioni geopolitiche, e della congiuntura mondiale, una finestra sulle prospettive di breve periodo di famiglie e imprese», esordisce così Elena Guglielmin, Cio di Ubs Wealth Management. Qualche conferma? Guardando semplicemente indietro di poche settimane, al cuore dell’estate. Un caso isolato, certo, ma ricco di riflessi. «I primi sei mesi dell’anno erano stati particolarmente positivi per l’asset class nel suo insieme, registrando risultati migliori di obbligazionario e immobiliare, e tenendo il passo dell’azionario globale. Qualcosa si è poi rotto, luglio è stato un mese molto negativo, e la volatilità di agosto ha reset-
«Nel 2023 il consumo mondiale di elettricità è aumentato del 2,5% rispetto all’anno precedente, e più del consumo energetico complessivo. Questo sollecita ulteriormente le linee elettriche esistenti, che necessitano di adeguamenti, oltre a richiederne di nuove, tutte opere ad alta intensità di metalli»
Elena Guglielmin, Cio di Ubs Wealth Management

Le materie prime nei cicli d’industrializzazione Domanda per materiale in % della domanda globale di quel periodo
tato l’intero 2024, innescata il 2 agosto dalla pubblicazione di deludenti dati sul mercato del lavoro americano. A distanza di pochi giorni il capitombolo del Topix, con la peggiore performance giornaliera dal 1987 ha fatto il resto. Il Vix intraday si è portato sui livelli del Covid, del 2011 e del 2008, sfondando quota 60, con al traino l’Ovx e il Move, indicatori analoghi su petrolio e obbligazionario. Nonostante il successivo generale recupero le
La necessità di materie prime può essere una chiave di lettura di molte delle decisioni di Roma nell’attenta selezione delle nuove regioni da attenzionare, e dunque da conquistare, in epoca repubblicana e imperiale. Del resto, sono le materie prime alla base di un qualunque miracolo economico per un certo tipo di economie, antiche e non. Solo oggi qualcosa è forse cambiato.

«La metà della domanda mondiale di platino, palladio e rodio è sì la tutela dell’ambiente, ma applicata ai motori a combustione interna, e nello specifico la marmitta catalitica che da decenni svolge un ruolo chiave nell’abbattere le emissioni più inquinanti nei veicoli tradizionali»
Andrew Keiller, Investment Specialist Director e Partner di Baillie Gifford
Fonte: Bp 2023
Fonte: Bp 2024 Energia
energetico pro capite in diversi Paesi (in ToE)
La prosperità delle economie avanzate è riconducibile a un uso molto intenso di energia e materiali, tra cui i metalli più rari, alla base di moltissime applicazioni tra le più avanzate, dalla tecnologia al medicale, dalle più semplici a quelle più complesse. Evidentemente l’energia dev’essere prodotta, e i materiali estratti e importati. Sin tanto che non succede nulla...
commodity languono», analizza Nitesh Shah, Head of Commodities and Macroeconomic Research di WisdomTree. Nell’arco di poche settimane cosa potrà mai essere cambiato, sembra essere una domanda legittima. Come sempre in economia, anche ex post, le risposte possono essere molte. «È ormai evidente che il 2024 si stia rivelando un anno particolarmente complesso per l’asset class, influenzata pesantemente dagli sviluppi
geopolitici, oltre che da fattori economici e ambientali, che stanno piegando l’andamento di rame, oro e petrolio, per fare solo qualche esempio. A una fisiologica volatilità congiunturale, determinata dall’equilibrio di domanda e offerta, si sommano l’ulteriore debolezza cinese, l’incertezza dell’appuntamento elettorale dell’anno, e l’ambiguità delle non decisioni dei grandi produttori, Opec+ in testa», sintetizza Roberta Caselli, Research Analyst presso Global X Etf. Allargando il raggio . Nonostante dunque un’estate particolarmente calda e intensa, in termini finanziari certamente non una grande novità se si guarda agli ultimi decenni, non si può certo concludere, analizzando qualche decina di mesi, che la situazione sia così cambiata. «Guardando oggi al prossimo decennio appare evidente il ruolo sempre più critico che le materie prime assumeranno, come nel caso di litio e cobalto, in chiave di transizione energetica, ed elettrificazione dei veicoli, tuttavia questi cambiamenti sono già percepibili e percepiti. Il litio è abbastanza esemplificativo dell’ambiente in cui le imprese sono chiamate a confrontarsi, nel 2023 il suo prezzo è arrivato a 70mila dollari la tonnellata, nel 2024 si è stabilizzato sui 1.120, per causa di un eccesso di offerta cinese. Domanda, offerta e geopolitica sono sempre più intrecciate, e la loro combo getta più d’un’ombra, come il conflitto in Ucraina aveva già ampiamente dimostrato nel 2022, rispetto al gas naturale e dunque il prezzo dell’elettricità in Europa», rileva Alberto Conca, Chief Investment Officer di Lfg+Zest. Risalendo a un passato ancora più passato, e scavallando gli anni dell’emergenza pandemica, non si riscontrano grandi differenze. Dunque, cos’è cambiato al netto dei modi? «È la velocità sempre più elevata con cui tutto succede che rende sempre più evidente e problematico gestire situazioni e contingenze che ci sono sempre state. La pandemia ha sicuramente giocato un ruolo, riaccendendo la luce su tematiche appartenenti a epoche passate, ma soprattutto ha riportato d’attualità un semplice fatto: al netto delle fluttuazioni di prezzo, non bisogna dare per scontata la disponibilità delle risorse. Dunque tutto il tema delle catene di fornitura e della diversificazione dei fornitori e dei Paesi di produzione. Ulteriore elemento critico in un quadro geopolitico sempre più teso e ostile», riflette Alessandro Valentino,
Product Manager di VanEck.
Al netto delle fluttuazioni, soprattutto nel caso delle materie prime si è soliti trattare di medio o lungo periodo, approccio sicuramente dettato anche dalla quotidianità dell’ultimo ventennio. «I fondamentali che traineranno l’asset class nei prossimi anni rimangono intoccati, nello specifico crescita economica e aumento della popolazione, all’occorrenza rinsaldati da politiche di reshoring. Non bisogna però dimenticare che la volatilità di oggi è dettata principalmente dal chiudersi di un ‘super ciclo’, segnato dal rapido industrializzarsi della Cina, e dei suoi 1,5 miliardi di abitanti. Un fatto inedito nella storia, per dimensioni e portata. Ha toccato il suo picco nel 2012, e ha visto il progressivo delocalizzarsi dell’industria pesante europea in Cina, sostenuto da investimenti per centinaia di miliardi di dollari in infrastrutture iniziati nel post 2008. E solo di recente il trend si è invertito», nota Marc Elliott, Investment specialist di Union Bancaire Privée (Ubp). Il prossimo futuro. Se dunque il passato è abbastanza acclarato, al netto di un inevitabile dibattito su cause e conseguenze tipicamente da economisti, i prossimi mesi, o poco oltre, appaiono abbastanza definiti pur nella loro democristiana incertezza. «Al netto di fattori strutturali, a rimanere determinanti già nel breve periodo sono gli indici Pmi manifatturieri, sempre più fiacchi, il recepimento da parte del mercato del policy mix che Pechino vorrà mettere in campo per uscire dalle sabbie mobili, al momento non troppo entusiasmante, e il sentiment delle famiglie, anche questo in calo. Guardando ai Pmi di Europa, Stati Uniti e Cina i segnali di debolezza non mancano, a eccezione del comparto tecnologico che ad esempio differenzia Corea del Sud e Taiwan. In Cina la situazione rimane difficile, le mosse del Governo non vengono ritenute essere decisive, e questa è la principale zavorra per l’asset class. Si somma poi l’indebolimento globale della domanda dei privati, e soprattutto della spesa in conto capitale delle imprese, che non si aspettano mesi troppo positivi», riflette il Cio di Ubs.
Il passato ha però quasi sempre pesanti conseguenze sul presente, e sull’immediato futuro. «Negli anni precedenti la pandemia si era registrata una lunga e generalizzata fase di sottoinvestimenti in capacità estrattiva da parte delle
«Non va trascurato il contributo che potrebbe portare lo sviluppo tecnologico, spostando ad esempio l’attenzione su materiali diversi, o la scoperta di giacimenti che potrebbero rendere gli attuali ‘metalli rari’, più facilmente reperibili il che annacquerebbe molti problemi»
Manuel Maleki, Deputy Head of Economic Research di Edmond de Rothschild
Concentrazione delle forniture

Quota di Paesi (in %) che dipendono da n. fornitori per il loro fabbisogno
Un fornitore
Due fornitori
Tre fornitori
Fonte: Imf 2023
Impatti macroeconomici Su crescita del Pil (sotto la linea dello 0) e inflazione per regione (sopra) (in %)
Fonte: Imf 2023
aziende, in larga parte per i bassi prezzi, i cui bilanci restano però in salute e non destano preoccupazioni. La salda disciplina finanziaria che i produttori avevano sino ad allora applicato non è cambiata, con la differenza che con i prezzi di oggi sono tornati in utile, ma non abbastanza da giustificare nuovi investimenti. La capacità estrattiva in più di un ambito rimane la stessa, e tale resterà, dunque specialmente per i metalli i prossimi anni
Spesso gli stati fanno affidamento su un unico fornitore di materie prime, e quando succede qualcosa sorgono i problemi, com’è stato il caso dell’Unione Europea nel 2022, in seguito alle sanzioni alla Russia. Uno dei principali produttori mondiali di gas naturale è uscito dal mercato, pur tornandoci dalla finestra, ma questo ha avuto un pesante impatto su Pil e inflazione di molte economie.

Le
dipendenze
«È ormai evidente che il 2024 si stia rivelando un anno particolarmente complesso per l’asset class, influenzata pesantemente dagli sviluppi geopolitici, oltre che da fattori economici e ambientali.
A una fisiologica volatilità congiunturale, si sommano l’ulteriore debolezza cinese, l’incertezza politica»
Roberta Caselli, Research Analyst presso Global X Etf
del vecchio continente
Livello di import (in % tot) di alcuni minerali critici degli stati europei
Produzione globale Fornitori dell’Europa
100% Niobo Brasile 92% Canada 7%
100% Metalli del gruppo platino Russia 4% S. Africa 94%
100% Titanio Cina 25% S. Africa 13% Australia 12% Kazakistan 39% Russia 34% Cina 9%
100% Antimonio Cina 56% Tajikistan 20% Russia 12% Turchia 63% Bolivia 26% Cina 6%
100% Boro Turchia 48% Usa 35% Cile 11% Turchia 99%
100% Litio Cina 83% Cile 12% Argentina11% Cile 79% Svizzera 7% Argentina6%
100% Terre rare pesanti Cina 100%
100% Terre rare leggere Cina 85% Malesia 11%
81% Cobalto Congo 63% Russia 7% Canada 4% Congo 63%
Fonte: Eurostat 2023
La ricerca dell’indipendenza da parte degli Stati europei rispetto all’import di molti minerali critici resta critica.
Platino & friends
saranno contraddistinti da possibili e frequenti fiammate di prezzo. È il caso del rame», nota l’esperto di Ubp.
Sono probabilmente i minerali con i più ampi e variegati ambiti d’applicazione, democratici sino all’estremo, e forse proprio per questo anche rari, e concentrati. «I metalli del Gruppo del platino trovano applicazione in ambito tecnologico, sanitario ed energetico, oltre che nella gioielleria. Combattono il cancro, riducono le emissioni, raffinano il petrolio, fanno funzionare i computer, sono presenti negli impianti dentali e nelle turbine dei caccia… sono presenti nella vita di tutti i giorni», rileva lo specialista di Baillie Gifford. Ma chi sono, e da dove vengono? «Stiamo parlando del platino e del palladio, principalmente, ma anche del rodio, del rutenio, dell’iridio e dell’osmio. Alcuni dei minerali più rari e ricercati, e che in larga misura arrivano dal Sud Africa. Nel solo complesso del Bushveld Igneous si estrae il 70% del platino mondiale, l’80% del rodio, il 90% di rutenio e iridio, e il 40% del palladio», prosegue Keiller. In prospettiva però il loro utilizzo, a partire da quello del platino, potrebbe evolvere significativamente. «Secondo l’Hydrogen Council, dunque una fonte non disinteressata,
Eppure sempre più spesso a prevalere non sono questioni tecniche o strutturali, quanto delicati equilibri politici e geopolitici, un nuovo terreno di confronto. «Le superpotenze sono sempre più spesso chine sullo scacchiere mondiale nel tentativo di garantirsi l’accesso a questa o quella risorsa, o di privarne del tutto un diretto avversario. La transizione energetica sta accelerando un trend in atto sin da prima del Covid, che vede l’approvvigionamento di minerali critici quale pilastro portante anche della sicurezza energetica, il che per inciso sta facilitando il riaprirsi del dibattito su idrogeno e nucleare. Specie in questo ambito a pur legittime preoccupazioni si oppone il ‘caso’, o la geologia, con ad esempio la Cina che detiene riserve significative di elementi di terre rare, fondamentali per Difesa e high-tech, oltre che per le rinnovabili. Si stima che questo piccolo segmento crescerà dai 7,5 miliardi di dollari del 2023 ai 16,9 del 2030», illustra l’esperto di VanEck. Verdi, ma quanto? Nonostante del doman non vi sia mai certezza, e sicuramente non in economia, alcuni dei temi dominanti del prossimo futuro sono già oggi abbastanza chiari, tra questi la fascinazione green. «Ogni Paese è stato chiamato a riflettere sulle proprie vulnerabilità in termini di approvvigionamento di materie prime critiche, e i numeri parlano da soli. L’Unione Europea ha individuato 34 elementi considerati molto importanti
entro il 2050 l’idrogeno potrebbe arrivare a coprire il 18% del consumo mondiale di energia, e il platino sarebbe al centro di una particolare applicazione che consentirebbe la produzione di idrogeno verde, il più pulito di tutti, andando a separare ossigeno e idrogeno presenti nell’acqua attraverso l’elettrolisi. Questa tecnologia, la Proton Exchange Membrane, vale oggi il 24% del mercato globale degli elettrolizzatori, ma già nel 2030 sarà al 70%, assorbendo ben 22 tonnellate di platino all’anno, il cui consumo relativamente all’idrogeno è già raddoppiato nel 2024 rispetto al 2023», snocciola l’esperto. Ma l’interessante deve ancora arrivare. «Ci si attende dunque che la domanda di platino sarà significativamente maggiore rispetto a quanto previsto in precedenza, ma non si può dire lo stesso dell’offerta. Sono molti i problemi che negli ultimi anni in Sud Africa si stanno verificando, da problemi elettrici, a scioperi del personale, a chiusure programmate a blocchi di emergenza della produzione. I prezzi sul mercato del materiale sono traballanti, il che ne rende ulteriormente problematica la gestione», conclude Keiller.
in termini di esigenze industriali e produttive, 17 di questi considerati strategici; gli Stati Uniti ne hanno invece individuati ben 50. La transizione verde e digitale è sicuramente una sfida determinante, che richiede un’infinità di materiali anche molto rari, prodotti in pochi Paesi, spesso infrastrutturalmente problematici, o soggetti a preoccupazioni di carattere ambientale. L’eccessiva dipendenza dal loro import espone il fianco a ulteriori problemi, il che non aiuta», rileva Monica Zurfluh, Segretario generale Lcta.
Soprattutto in ambito industriale e produttivo le regole del gioco sono dettate da fattori terzi, e dunque in assoluto la rarità di un materiale non è poi così determinante. «È l’uso che si fa delle risorse naturali, e i problemi di approvvigionamento, raffinazione e stoccaggio a determinarne l’utilità intrinseca. Attualmente al centro delle preoccupazioni c’è la questione energetica, un ambito molto ampio che spazia dalle materie prime energetiche, dunque petrolio e gas naturale, agli elementi invece necessari a produrre rinnovabili, ancor più variegati. Se si prende il caso di una turbina eolica sono dalle 4 alle 8 le tonnellate di rame necessarie per un Mwh di elettricità, cui aggiungere metalli rari, come il litio, per immagazzinare tale energia. E viviamo in un mondo che necessita di sempre più energia, nel 2000 il consumo mondiale era di 570 Twh, nel 2023 di oltre 2.430», sottolinea Manuel Maleki, Deputy Head of Economic Research di Edmond de Rothschild.
Fermo restando che energia ed elettricità sono cose comunque diverse, e che in quanto tali richiedono investimenti in parallelo. «Per decarbonizzare l’economia globale è indispensabile che le rinnovabili continuino a correre, e che vengano introdotte nuove tecnologie più facilmente scalabili. L’elettrificazione è un buon esempio, per quanto qualche problema lo sollevi. Nel 2023 il consumo mondiale di elettricità è aumentato del 2,5% rispetto all’anno precedente, e più del consumo energetico complessivo, in progresso del 2%, ma questo sollecita ulteriormente le linee elettriche esistenti, che necessitano dunque di adeguamenti, oltre che richiedere nuove linee, tutte opere ad alta intensità di metalli. Senza scordare i macrotrend in atto, come il diffondersi dell’Intelligenza Artificiale, altamente energivora, che se possibile aggrava il problema», chiosa Guglielmin.
«Sebbene ci si dovrebbe mettere in sicurezza sia per produzione, che approvvigionamento soprattutto di quei materiali considerati critici, nei fatti è complesso farlo. Dovrebbe essere dunque privilegiata una più modesta autonomia strategica attraverso il friendshoring, l’urban mining»
Monica Zurfluh, Segretario generale Lcta

di emissioni (kiloton Co2 Twh)
Altro ■ Cadmio, gallio, tellurio
Terre rare ■ Alluminio
Rame, nickel, zinco
Gas Eolico Fotovol.
Fonte: McKinsey 2024
Quota dei Top3 nell’estrazione
Congo Concentrazione
Quota
Un’agenda, quella energetica, soggetta a molte pressioni negli ultimi anni, con evoluzioni sotto molti aspetti impensate, seppur pensabili. Ucraina in primis. «Se l’abbandono delle energie fossili, e dunque la decarbonizzazione, era un tema già politicamente sensibile, ha sicuramente guadagnato in importanza con una nuova accezione: essere meno dipendenti da altri stati, fronteggiando al tempo stesso una corsa dei consumi. Il reshoring e l’Ia trai-
Generare energia equivale a consumare molti minerali rari, e meno rari, oltre che a emettere notevoli gas nocivi. La più semplice delle soluzioni sarebbe smettere di consumare, e tornare nelle caverne, ma non tutti potrebbero accoglierla bene, nemmeno tra gli ecologisti. Dunque è indispensabile affidarsi al solito circolo dei soliti noti Paesi fornitori sperando in bene.

Terre rare
«Il litio è abbastanza esemplificativo dell’ambiente in cui le imprese sono chiamate a confrontarsi, nel 2023 il suo prezzo è arrivato a 70mila dollari la tonnellata, nel 2024 si è stabilizzato sui 1.120. Domanda, offerta e geopolitica sono sempre più intrecciate, e la loro combo getta più d’un’ombra»
Alberto Conca, Chief Investment Officer di Lfg+Zest
Riserve stimate di terre rare per Paese per anno di esplorazione (mln T)
Mdpi 2024
Questione di prezzo
Volatilità dei prezzi delle materie prime per periodo (st. deviation log)
Le terre rare sono una delle materie più delicate, sia in termini di fornitura, che di raffinazione. Evidentemente la Cina si conferma Paese chiave nell’intera architettura mondiale del settore, in termini di riserve accertate, che di produzione e raffinazione. Negli ultimi anni ad aver fatto la differenza non è stato solo il prezzo delle materie prime, ma anche la loro disponibilità.
neranno ulteriormente la crescita del consumo di elettricità, con gli eventi climatici estremi che sicuramente non stanno aiutando, imponendo un adeguamento delle infrastrutture più e meno datate, una riprogettazione di quelle nuove, e un aumento della potenza da installare, per fronteggiare eventi puntuali e circoscritti nel tempo, ma potenzialmente distruttivi per il sistema, come ondate di caldo o freddo», prosegue Elliott.
Una relazione, quella tra metalli rari e inquinamento, di lunga data e con ancora importanti conseguenze operative. «Si tende a pensare che l’utilizzo dei metalli del gruppo del platino sia confinato ad ambiti particolarmente elitari, gioielli o high-tech, dunque aerospazio, Difesa, salute, rinnovabili… applicazioni insomma molto complesse. La metà della domanda mondiale di platino, palladio e rodio è sì la tutela dell’ambiente, ma applicata ai motori a combustione interna, e nello specifico la marmitta catalitica che da decenni svolge un ruolo fondamentale nell’abbattere le emissioni più inquinanti nei veicoli tradizionali. Un’auto venduta nel 1960 senza, inquinava al pari di 100 autovetture vendute oggi dotate di tale dispositivo. Tali metalli rivestiranno un ruolo chiave nella transizione verde dei prossimi anni, ma i siti estrattivi sono quasi del tutto concentrati nei Paesi emergenti, basti pensare al rame in Cile, al nickel in Indonesia, al platino in Sud Africa e Zimbabwe», evidenzia Andrew Keiller, Investment Specialist Director e Partner di Baillie Gifford.
Evidentemente attribuendo a tutto e tutti i giusti pesi, date le circostanze. «Dovrebbe essere sempre privilegiato un approccio dinamico alla materia. La transizione energetica pone queste serie di problemi che gli stati devono risolvere nell’interesse della collettività, e sappiamo di cosa dovremmo avere bisogno per i prossimi anni, dunque sia questi metalli, comuni e rari, sia risorse energetiche tradizionali che continueranno a essere utilizzate per l’intera durata della transizione, ma le necessità possono cambiare, e lo fanno spesso, sia in termini di scoperta di nuovi giacimenti, sia di sviluppo di tecnologie che potrebbero richiederne altri», riflette l’esperto di Rothschild. Oro cileno. Per quanto non possa certo essere considerato un metallo raro, e nemmeno innovativo, in termini di ricerca o utilizzo, passano gli anni ma rimane sulla cresta dell’onda, anzi. «Se da un lato l’Europa ha rinunciato a buona parte della sua industria pesante, a crescere è la domanda di altri materiali, in testa rame e nickel per il ruolo che ricoprono in termini di elettrificazione e accumulo di energia, il che si riflette sui prezzi. Il rame negli ultimi mesi ha oscillato tra i 7 e i 10mila dollari per tonnellata a fronte di un altalenante equilibrio tra domanda e offerta, un problema comune a molti altri materiali,
tra tensioni geopolitiche e rischi di interruzione delle forniture. È il caso di litio e cobalto, che porrebbero sotto scacco l’intero comparto tecnologico, e l’automotive europeo, ma la cui sostituzione richiederebbe anni di sviluppo e grandi investimenti», nota l’esperto di Lfg. Il 2024 potrebbe essere ricordato come l’anno del rame, che non sembra trovare requie. Ma qual è il nodo da sciogliere? «I fattori che stanno giocando un ruolo sono molti, e variegati. La debolezza dell’economia cinese spinge al ribasso il suo prezzo, e dunque ogni qual volta torni l’ottimismo sui risultati di Pechino si verifica un rialzo, al tempo stesso la risoluzione delle vertenze sindacali in Cile, a cui è attribuibile un quarto della produzione globale, diminuisce fortemente i potenziali problemi di fornitura, distenendo le pressioni sul prezzo. Ma se l’immobiliare cinese è anemico, la domanda di rame da parte dell’automotive rimane forte, al pari delle prospettive dei prossimi anni», precisa l’esperta di Global X.
Cina che rimane epicentro del mercato, anche in vista di potenziali prossimi sviluppi, e dell’eventualità che presto o tardi il Dragone possa tornare a volare. «Le fonderie cinesi negli ultimi mesi stanno affrontando una mancanza di concentrato di rame, anche a fronte della chiusura della miniera di Cobre a Panama, il che potrebbe portare entro fine anno a tagli della produzione. Se si analizza il mercato a livello globale, nel 2023 la produzione mineraria si è attestata a 22 milioni di tonnellate, dunque inferiore ai 25 milioni di domanda, gap che dovrebbe allargarsi. Anche ammettendo che l’offerta continui a crescere del 2,5-2,7% annuo, in linea con l’ultimo decennio, entro il 2035 l’offerta dovrebbe toccare i 32 milioni di tonnellate, a fronte di una domanda che probabilmente sfiorerà i 50 milioni, il che rende ottimisti sull’andamento futuro dei prezzi», sintetizza il Cio di Ubs.
Bisogna del resto sempre tenere in gran considerazione i tempi con cui viaggiano i mercati delle materie prime. «Se anche la domanda può muoversi molto in fretta, l’offerta viaggia spesso con il freno a meno tirato. Dalla scoperta del sito all’effettiva produzione dei primi barili un pozzo petrolifero richiede dai 5 ai 7 anni di lavoro, ed è uno dei casi più semplici. Una miniera di rame che debba essere realizzata da zero richiede 15-20 anni di lavoro, mentre l’allargamento di una
«La volatilità di oggi è dettata dal chiudersi di un ‘super ciclo’, segnato dal rapido industrializzarsi della Cina. Un fatto inedito nella storia. Ha toccato il suo picco nel 2012, e ha visto il progressivo delocalizzarsi dell’industria pesante europea in Cina, a suon di centinaia di miliardi di dollari di investimenti»
Marc Elliott, Investment specialist di Ubp

Il sogno d’indipendenza degli Avanzati
Investiment crossborder in greenfield per area (usd mld)
Fonte: Mc Kiseny 2024
Il mondo del trading
Ebit dei giganti del trading (usd mld)
già esistente circa un lustro. Le decisioni degli operatori del settore sono dunque molto spesso ben ponderate, e seguono logiche di lungo periodo, ciononostante errori o un timing sbagliato sono sempre possibili», rileva l’esperto di Ubp.
La politica. Ciononostante anche la geologia può riservare sorprese, il che allarga la natura del problema. «Nel breve periodo domanda e offerta possono essere piegate da logiche più politiche, ad esem-
Conquistare l’indipendenza strategica è forse risibilmente fattibile a patto di impegnare centinaia di miliardi di dollari in investimenti spesso discutibili, se non a fini nazionalistici e politici. Nell’ultimo biennio ad aver contribuito al ritorno di questi temi è stata anche la fiammata nei prezzi, a beneficio di una manciata di enormi attori del settore, solitamente con sede in Svizzera, ma non solo.

Chi vuole quanto gas naturale?
«Se i bites sono il nuovo petrolio, si è anche formato un nuovo Opec, al momento definito come Faang, società la cui capitalizzazione è pari a trilioni di dollari, e che oltre a detenere tali dati, sono anche le uniche con il know-how per leggerli, in una fase storica in cui la ‘data dependency’ è il nuovo mantra»
Alessandro Valentino, Product Manager di VanEck
Variazione tra domanda e offerta per regione (in mld m3)
L’Opec è probabilmente il più emblematico dei consorzi nati nel secolo scorso, e che negli anni ha man mano perso buona parte della sua forza in più d’un senso. Soprattutto da quando il primo produttore mondiale di petrolio non ne fa più parte, e si chiama: Stati Uniti. La domanda di materie prime varia però nel tempo, che sia petrolio, che siano altre fossili.
pio le mosse dell’Opec+ nel caso del petrolio, ma nel lungo periodo tutto cambia. Nel 2023 è stato scoperto il più grande giacimento di litio al mondo, dell’ordine di 12 volte le riserve mondiali accertate l’anno precedente. Il sito si trova negli Stati Uniti, il che insidia l’ancora indiscusso primato della Cina, che a oggi copre i due terzi della produzione mondiale. Non va nemmeno trascurato il contributo che potrebbe portare lo sviluppo tecnolo-
gico, spostando ad esempio l’attenzione su materiali completamente diversi, o la scoperta di giacimenti che potrebbero rendere gli attuali ‘metalli rari’, molto più facilmente reperibili il che annacquerebbe molti problemi», sottolinea Maleki.
Se i cartelli possono imporre, o almeno provare, determinati prezzi, la domanda può esse soggetta a molto altro. «I prezzi delle materie prime sono agganciati alla dinamica domanda/offerta. Un calo delle esportazioni, a prescindere dalla ragione, porta a un calo del prezzo dei materiali a esse connesse. Se si aggiunge l’effetto che potrebbero avere dazi doganali particolarmente scoraggianti per il mercato locale, ecco che anche i singoli Governi potrebbero giocare un ruolo in questa partita. Il fatto che il 2024 sia un anno elettorale, e che il grande appuntamento non si sia ancora consumato, lascia aperta la porta a moltissime alternative. Non è chiaro cosa faranno di preciso Trump ed Harris, se non che i dazi certamente torneranno a far parlare di sé», eccepisce il responsabile di WisdomTree.
A dipendenza dei Governi l’impatto su domanda e offerta potrebbe essere molto maggiore, o trascurabile. «Sino al gennaio 2022 la Russia rappresentava il 17% del mercato globale del gas naturale, prevalentemente a beneficio dell’Europa. Il fatto che ne sia stata estromessa ha creato non pochi disequilibri, come è ovvio che accada ogni qual volta uno dei principali produttori esca dal mercato. La Cina domina invece il mercato delle terre rare, controllandone l’85% della produzione globale, il che riduce di molto possibili alternative e aumenta il rischio di nuovi cartelli, stile Opec», riflette Conca.
E la Svizzera? La distorsione del mercato a fronte di interventi esogeni ha però delle conseguenze. Alcune meno evidenti. «La Piazza elvetica ha sempre ricoperto un ruolo chiave nel regolare il mercato mondiale delle materie prime. Negli ultimi anni questo è cambiato, in larga misura proprio per le politiche sanzionatorie decise dai Governi occidentali, che avendo ostracizzato Russia e Iran, hanno portato alla nascita di nuovi operatori, piccoli intermediari domiciliati in Paesi meno politicamente esposti, come Dubai. Tali operatori sono particolarmente abili ad esempio nell’aggirare le sanzioni internazionali», sottolinea Elliott. Lo scettro è stato però in mano alla Svizzera per diversi decenni. «Pur non
disponendo di grandi borse come il Chicago Mercantile Exchange o il London Metal Exchange, rimaniamo un hub molto importante. Ospitiamo le maggiori compagnie del settore a livello mondiale ed esercitiamo un certo ruolo nel finanziamento del commercio di tali materie, nel trasporto marittimo e più in generale nella loro logistica, avendo sviluppato una buona diversificazione delle fonti di approvvigionamento sia per le materie prime verdi, sia per i metalli essenziali per le rinnovabili, rispettando tutti i principi Esg», rileva l’esperta della Lcta.
A quali condizioni la Svizzera potrebbe dunque riprendersi il suo ruolo? «Laddove il regime sanzionatorio dovesse venir meno, gli atout della Piazza tornerebbero a contare, in primis la disponibilità di capitali a un costo contenuto. Un elemento, questo, determinante per gli equilibri del settore, ma che al momento non conta. Al pari dei trader, anche sul lato dell’offerta non mancano i problemi; il mercato si sta consolidando, il numero dei produttori si riduce, il che rischia di ingessare ulteriormente un’offerta da sempre piuttosto rigida», nota l’esperto di Ubp. L’indipendenza. Se però sono dunque tantissime le ragioni per cui si dovrebbe raggiungere un minimo di indipendenza, le difficoltà nel conquistarla sono delle più notevoli. «Sebbene ci si dovrebbe mettere in condizioni di sicurezza sia in termini di produzione, che di fornitura soprattutto di quei materiali considerati critici, nei fatti è estremamente complesso farlo, ed improbabile il riuscirci. Dovrebbe essere dunque privilegiata una più modesta autonomia strategica attraverso politiche di friendshoring, appoggiandosi a Paesi amici, aprendo laddove possibile siti di produzione nazionali, e riciclando di più, il cosiddetto ‘urban mining’. Aldilà dei costi, miliardari, anche i tempi saranno però lunghissimi. Per Stati Uniti ed Europa si parla di 10-20 anni», prosegue Zurfluh. Del resto la questione non è soltanto in termini di produzione, ma un po’ più ampia. «L’Europa si sta muovendo, e a maggio è entrato in vigore un nuovo regolamento che mette sotto la lente l’intera filiera, dunque l’estrazione, la lavorazione, lo stoccaggio delle risorse per cercare di mitigarne i rischi. A essere infatti molto concentrata non è solo la produzione di certi materiali, ma anche la loro raffinazione, con la Cina saldamente in testa alla classifica sulla maggior parte dei materiali
«Un calo delle esportazioni, a prescindere dalla ragione, porta a un calo del prezzo dei materiali a esse connesse. Se si aggiunge l’effetto che potrebbero avere dazi doganali particolarmente scoraggianti per il mercato locale, ecco che anche i singoli Governi potrebbero giocare un ruolo in questa partita»
Nitesh Shah, Head of Commodities Research di WisdomTree

sensibili, dal rame al cobalto, al litio alla grafite, e tutte le terre rare, per normative ambientali molto accomodanti. Le priorità degli Stati europei sono molte, è dunque fondamentale ci sia una buona cooperazione, ad esempio investendo in tecnologie, e alleggerendo le normative», riflette l’esperto di VanEck.
Eppure, quali sono le materie prime davvero essenziali? I materiali sono strumentali a fare qualcosa, dunque produrre strumentazione, per supportare le attività produttive, che però si basano su tutt’altro. «La metamorfosi digitale del mondo analogico sta di fatto ‘commoditizzando’ moltissimi servizi, una volta ritenuti esclusivi, ma oggi di pubblico utilizzo a. Se i bites sono il nuovo petrolio, si è anche formato un nuovo Opec, al momento definito come Faang, società la cui capitalizzazione è pari a trilioni di dollari, e che oltre a detenere tali dati, sono anche le uniche con il know-how per leggerli, in una fase storica in cui la ‘data dependency’ è il nuovo mantra», conclude Valentino. Nel caso dell’Europa quale che sia il fronte su cui affrancarsi dal resto del
Se certo i metalli rari sono un capitolo estremamente importante dei piani strategici di tutte le potenze nei prossimi anni, non va persa di vista la visione d’insieme di tutto, dunque anche la sensibilità sui metalli di base, quelli più comuni.
mondo la situazione non cambia, minerali critici non ne ha, al pari di campioni digitali che possano fare la differenza in un altro ambito ancor più delicato. Se dunque il tema è certo essere più minerariamente indipendenti, considerando sia un continente ancora manifatturiero, anche il fronte più digitale non deve essere trascurato, ed è dove con ogni probabilità i nuovi cartelli sono già serviti. Dunque, sembrerebbe che la domanda sia semplicemente: dipendere dai cinesi o dagli americani? La risposta si limita a due sole alternative, o forse sarebbe anche tempo che l’Europa decidesse. Ha i campioni delle materie prime, ma non le stesse, ha i dati, ma... non può farvi nulla. Qual è il senso di tutto questo? ❏
Formare è passione
Il mondo del lavoro negli ultimi decenni è evoluto rapidamente sulle ali di sviluppo tecnologico e globalizzazione, con un’incredibile accelerazione nel post pandemia. Cosa è lecito attendersi nel prossimo futuro, e cosa può garantire il successo alle imprese?

Guidare il futuro
Business thinker del panorama globale, esperti di management, del mondo accademico e culturale, in un evento unico per ispirare il cambiamento, trasformare le imprese e ripensare insieme il futuro del business. Da oltre 13 anni, il Leadership Forum attrae migliaia di decision maker, imprenditori e top manager, qualificandosi come business event di riferimento dedicato ai temi della leadership e del management.
Un appuntamento mondano, a Milano, una due giorni che attira migliaia di persone del mondo delle imprese e dell’economia reale.
Le vie del Signore sono infinite, e spesso imperscrutabili, l’esito di determinate azioni e i riflessi di molte decisioni apparentemente trascurabili possono rivelarsi sorprendenti. Alternativamente a fare la voce grossa potrebbe essere la Sorte o il Caso; a non cambiare paradossalmente, pur facendolo, è il risultato ultimo. Almeno quello apprezzabile, al netto di molti ‘se’ e molti ‘ma’, calati nella moderna arena del periodo ipotetico, o nella molto più antica degli ‘an + ottativo’. «La mia è una storia un po’ insolita, studiavo pianoforte
e sognavo di fare l’artista, avevo già iniziato un percorso musicale come Dj negli anni Novanta, che mi piaceva molto, e mai avrei pensato che un giorno avrei potuto fare impresa. A cavallo degli anni Duemila ricevo per caso un invito a partecipare a un corso di formazione a Londra dedicato a crescita personale e leadership, qualcosa a cui altrimenti non avrei mai pensato. È a tutti gli effetti un nuovo inizio», esordisce così Marcello Mancini, fondatore e Ceo di Roi Group.
Il dado è però presto tratto, e dunque da ‘formando’ a formatore, da formatore
a responsabile dei formatori di un’azienda di certe dimensioni, a Ceo della stessa, il percorso è apparentemente molto breve, sino alla lettera di dimissioni. «Al termine di una travagliata fase di riflessione, e dopo un memorabile spettacolo del Cirque du Soleil negli Stati Uniti, tornato in Italia decido di fondare Performance Strategies, un’azienda di grandi eventi B2B all’epoca concentrata sulle esigenze delle più grandi imprese italiane, sui temi che più mi interessavano, dunque formazione, management, leadership… Nel 2016 le abbiamo affiancato una seconda business unit, Life Strategies, concentrata sulla crescita personale, e più marcatamente B2C, supportata da una Casa editrice interna al nostro Gruppo, Roi Edizioni. A fine 2023 si è aggiunta InSpeaker», prosegue il Ceo.
A distanza di pochi anni, nel 2011 era in seria discussione la sopravvivenza dell’Eurozona, il mondo è sicuramente cambiato in più d’un modo, con dunque molte conseguenze. «Ad aver fatto la differenza
nell’ultimo decennio è lo sviluppo tecnologico, l’esponenziale diffondersi della tecnologia, che ha messo in discussione molti assunti del passato. Oggi nessuno si scandalizza nel sentir parlare di ‘reskilling’, l’esperienza ha un valore maggiore, sempre più spesso sono le aziende a dover ‘conquistare’ i candidati, e non il contrario, è sempre più nota la differenza tra soft e hard skills, dove a prevalere sono le prime… Si tratta di cambiamenti sostanziali del mercato del lavoro, e dunque dell’arena in cui competono le aziende, non solo in Italia», riflette Mancini. È in tale contesto che si innesta il classico vecchio dibattito: si nasce con determinate doti o si possono acquisire nel tempo? «Dal mio punto di vista la dedizione e l’impegno possono molto se non tutto, ma è evidente che esistano caratteristiche personali e tratti caratteriali che a dipendenza dei casi possono semplificare il lavoro, o renderlo quasi impossibile. Anche in questo caso l’emergenza pandemica ha fatto da spartiacque; nei primi mesi del Covid c’è stata un’accelerazione digitale impensabile, che ha spinto tutto in avanti di almeno sette anni. A determinate condizioni, il che non è mai ovvio, l’online è perfetto per imparare e accrescere alcune competenze, ma molto meno in altri ambiti, ad esempio nel costruire relazioni forti e durature», nota il Ceo.
A fare la differenza sono però anche le persone direttamente coinvolte nello sforzo, da un lato e dall’altro. «Esistono due tipologie di persone e aziende: quelle consapevoli, e quelle che non lo sono. Paradossalmente sono quelle che meno ne hanno bisogno le più sensibili a certe tematiche, il che accresce la probabilità che continuino a essere di successo, diversamente dalle altre, che più ne avrebbero bisogno. Al tempo stesso a essere determinanti sono anche gli speaker, è dunque necessario coinvolgere i migliori del loro ambito per capire come ‘ce l’hanno fatta’. Il messaggio è influenzato dal messaggero, se a dirlo è Obama ha un valore, se è un altro anche lo stesso messaggio fa più fatica a passare. Quello che noi vogliamo fare è Inspiring leaders, transforming companies, e cerchiamo di farlo nei nostri eventi, in primis il Leadership Forum», prosegue Mancini.
Altrettanto determinante è l’interazione tra pubblico e palco, questione delicata specie in occasione di grandi eventi, per definizione molto più disper-
«Esistono due tipologie di persone e aziende: quelle consapevoli, e quelle che non lo sono. Paradossalmente sono quelle che meno ne hanno bisogno le più sensibili a certe tematiche, il che accresce la probabilità che continuino a essere di successo, diversamente dalle altre, che più ne avrebbero bisogno»
Marcello Mancini, Ceo e fondatore di Roi Group

Anni di forte crescita
Evoluzione dei dati del Gruppo tra il 2019 e il 2024
*Perfomance, Life, Roi Edizioni ** Sicily Business Forum e Festival ***Speaker Bureau, Eventi aziendali e scolastici
sivi di piccoli consessi dal clima familiare. «Il Leadership Forum è il nostro evento più importante dell’anno, con ospiti di fama internazionale e oltre 2mila partecipanti, una due giorni al Teatro degli Arcimboldi a Milano, che penso dica molto anche senza aggiungere troppi dettagli. Noi forniamo spunti, vogliamo ispirare, stimoliamo i partecipanti a vedere le cose da un punto di vista differente, poi sta a loro coglierne gli aspetti più utili, e interiorizzarli. Guardiamo agli imprenditori, la cui principale dote è spesso immaginare le cose non per come sono oggi, ma per come potranno essere domani, e dunque agire di conseguenza, preparandosi e preparando per tempo», rileva il Ceo. Il mondo di oggi vive alla giornata, laddove non anche meno, con una velocità ancora dieci anni fa impensabile. È dunque così che molte strategie 2040-2050 fanno quasi tenerezza, e lasciano il tempo che trovano, per quanto anche a livello di imprese molto sia cambiato. «L’Italia del miracolo economico ragionava secondo piani programmatici e strategici decennali, era questo il mindset di qua-
Il Gruppo si è fatto grande di pari passo con il complicarsi delle dinamiche economiche globali, di cui l’Italia è solo un inizio.
lunque imprenditore. Nonostante oggi l’arco temporale si sia di molto ridotto, assestandosi sui 3-5 anni, è ancora più importante saper leggere correttamente il presente. Ad accomunare tutti i più grandi protagonisti dell’era contemporanea sono la curiosità e l’umiltà, il restare con i piedi per terra senza lasciarsi ubriacare dal successo che hanno avuto. Sono molti gli insegnamenti che questi personaggi possono trasmettere, nel mio caso ricordo sempre con grande piacere il generale Franco Angioni, protagonista della seconda Repubblica, e il suo monito sul ruolo fondamentale che può arrivare a giocare il nostro atteggiamento sul morale, sulla motivazione dei propri collaboratori», conclude Marcello Mancini, fondatore di Roi Group.
Federico Introzzi

Migrare sulle nuvole
Con un universo in esponenziale crescita di dati da archiviare, condividere ed elaborare, il cloud computing sembra destinato a un lungo e felice regno. Per massimizzarne le opportunità per il proprio business, ma anche per affrontare insidie e complessità di gestione, è essenziale l’esperienza di un cloud service provider che sappia individuare la conformazione più idonea.
Se una lingua, nelle sue evoluzioni, segue le trasformazioni economiche, tecnologiche e culturali che definiscono una società, ci si può a breve attendere che un’espressione idiomatica come “avere la testa fra le nuvole”, almeno in italiano e in inglese - in altre lingue non trova un corrispettivo perfetto, i germanofoni ad esempio “vivono fra i cucù” - verrà risemantizzata: non più a indicare la sbadataggine del sognatore perdigiorno ma, al contrario, espressione di piena concentrazione e operatività. Immersi nei dati. E se nell’atmosfera, sotto forma di nubi, gravitano 15 miliardi di tonnellate d’acqua, la massa dei dati archiviati in cloud cresce esponenzialmente, puntando ai 100 zettabyte (un trilione di gigabyte) entro il 2025. A detenere il 65% del mercato globale del cloud computing è oggi il terzetto Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud Platform.
La maggior parte delle aziende opta ormai per una strategia ibrida, multicloud, che permette di combinare il server locale (on premises) o un cloud privato, con uno o più cloud pubblici, alla scalabilità pressoché infinita degli hyperscaler. «Anche a livello svizzero e ticinese rileviamo come
la tendenza delle aziende più lungimiranti sia di muoversi in questa direzione», conferma Massimo Baioni, Head of Sales di Tinext Cloud. Insieme alle consorelle Tinext Experience, Swisscolocation e Valuelead, l’azienda svizzera Tinext Cloud capitalizza il know-how quasi trentennale di Tinext Group, che ha visto la luce nel 1995 con la nascita di Tinet, il primo internet service provider in Ticino. Nei primi anni del nuovo millenio Tinext Group si è ristrutturata cedendo le attività di telecomunicazione e rafforzando le divisioni Digital Experience e Cloud.
Oggi ha sedi a Ginevra, Lugano, Milano e Dubai per la clientela aziendale e internazionale che supporta nei processi di trasformazione digitale con competenze che spaziano dalla consulenza digitale alla realizzazione di progetti, fino all’operatività e alla continua ottimizzazione e manutenzione delle soluzioni realizzate. La divisione Cloud si è sviluppata soprattutto dal 2014, con il trasferimento della sede originaria a Morbio Inferiore, dove Tinext ha acquisito un edificio da 2mila mq con un datacenter completamente ristrutturato e modernizzato, pre-
In quali progetti digitali investono le aziende svizzere? Progetti effettuati nel 2022 e previsti per il 2023 (su 104 aziende svizzere)
cedentemente proprietà di un istituto bancario, cominciando così a offrire servizi di hosting non soltanto ai propri clienti, ma anche a esterni. Successivamente, in collaborazione con VMware (fra i leader del cloud computing, di recente oggetto della mega-acquisizione da 61 miliardi di dollari da parte del colosso statunitense dei semiconduttori Broadcom), si è iniziata a sviluppare un’architettura multi-tenant. «Dal server del cliente fisicamente installato presso il datacenter, si è così passati a offrire la possibilità, connettendosi via internet, di accedere ai propri servizi cloud erogati da una piattaforma molto più ampia, con un’infrastruttura stabile, ridondata, sempre disponibile, monitorata h24 e costantemente aggiornata», spiega Massimo Baioni, entrato in azienda nel 2018 proprio per supportare questa fase di crescita. Tinext ha quindi iniziato a proporsi come cloud service provider anche ad altre aziende del territorio che fornivano a propria volta servizi IT, permettendo di raggiungere una qualità superiore a quella consentita dalle loro capacità interne. «Investendo di pari passo in tecnologie, risorse umane e formazione siamo cresciuti in termini di prestazioni, diversificazione delle soluzioni proposte, disponibilità e sicurezza», sottolinea Marco Tramacere, Ceo di Tinext Cloud.
Con una clientela che, a differenza di quella del Gruppo, si compone prevalentemente di aziende del territorio e svizzere - il che però, tenuto conto della loro vocazione internazionale, implica spesso la presenza di sedi estere - l’orientamento verso un approccio hybrid-multicloud perseguito da Tinext Cloud ha il vantaggio di adattarsi alle esigenze molto variegate di realtà attive in settori che spaziano da quelli altamente regolamentati come il fintech, al manufacturing, fino alle associazioni no profit e all’healthcare.
«Proprio la nostra libertà di scegliere le soluzioni più adatte alle specificità del singolo cliente, valutando con attenzione e senza pregiudizi di sorta l’intero portafoglio di servizi offerto dall’universo del cloud, ci consente di aiutare ogni realtà a massimizzare i propri investimenti e raggiungere i propri obiettivi, divenendone di fatto un business partner», commenta Massimo Baioni. «Il fatto che disponiamo dei nostri datacenter non preclude la valorizzazione delle infrastrutture informatiche locali in cui il cliente potrebbe precedentemente aver investito, così come
«La libertà di scegliere le soluzioni più adatte alle specificità del singolo cliente, valutando con attenzione e senza pregiudizi di sorta l’intero portafoglio di servizi offerto dall’universo cloud, ci consente di aiutare ogni realtà a massimizzare i propri investimenti e a raggiungere i propri obiettivi, divenendone di fatto un business partner»
Massimo Baioni, Head of Sales di Tinext Cloud

Principali sfide nell’adozione di strategie Multicloud
Problemi di sicurezza/ elevato rischio di minacce
Costi elevati nella gestione
Difficoltà a individuare dove risiedono i workload critici
Difficoltà a implementare un modello di data governance
Necessaria una maggiore collaborazione tra IT e Business
Mancanza di interoperabilità tra i diversi ambienti (orchestration)
Cultura aziendale
Testing/scaling e gestione dei dati nei diversi ambienti
Classificare i dati (cloud, on prem, edge, ecc..)
È necessario un nuovo modello organizzativo in azienda
Mancanza di skill adeguati
Fonte: “Percorsi di trasformazione digitale presso le aziende svizzere”, 2023, Tinext, VMware
Dove posizionate dati e applicazioni?
Hub
Uno scenario sempre più ibrido Utilizzo del Cloud, oggi e fra tre anni
/ sistemi di produzione Dati personali / dati sensibili dei clienti
Fonte: “Percorsi di...”, Tinext, VMware, The Innovation Hub
non esitiamo a orientarlo su un hyperscaler qualora il servizio sia più adatto allo scopo. Un approccio che premia: da 6 anni cresciamo costantemente a un ritmo annuale quasi del 20%. E la maggior soddisfazione è che con noi crescono i nostri partner e le aziende nostre clienti, a vantaggio dell’intero ecosistema», afferma l’Head of Sales di Tinext Cloud. Il fatto che i dati, oltre ad aumentare
■ Oggi ■ Tra tre anni
Quasi tutte le aziende svizzere hanno intrapreso piani di trasformazione digitale, ma la maggior parte è ancora in fase implementativa. Il cloud, come infrastruttura abilitante, è fra le principali tendenze, anche se prevale un uso selettivo. La preferenza per le soluzioni ibride comporta però sfide di sicurezza, costi e difficoltà legati alla gestione di ambienti eterogenei.
Il datacenter di Tinext Cloud, a Morbio Inferiore, insieme a quello di Zurigo, fa parte dell’ampio portafoglio di soluzioni proposte dall’azienda come cloud service provider.

Svizzera fra le nuvole?
Considerato come le statistiche che monitorano lo sviluppo del cloud computing facciano riferimento soprattutto allo scenario internazionale o all’Ue, Tinext Cloud ha voluto promuovere un’indagine fra le aziende di casa per meglio analizzare le dinamiche del suo mercato di riferimento. Un’iniziativa che, grazie alla collaborazione con VMware e The Innovation Group, si è tradotta nel primo studio quantitativo nazionale sui percorsi di trasformazione digitale aziendali e in un focus qualitativo regionale sulla Svizzera italiana. Come emerge dalla survey condotta su un campione di 104 aziende svizzere, solo una minoranza (16%) ha già integrato il digitale in modo completo nel proprio business, in particolare organizzazioni di grandi dimensioni. Nel 2022, più di un’azienda su due ha però investito in cloud. Solo un 3% ha già un approccio cloud first, mentre la maggior parte lo utilizza selettivamente in singoli ambiti specifici, ma in media la spesa It per infrastrutture e applicazioni in cloud ha superato quella per gli ambienti tradizionali on premises, ed è in crescita costante anno su anno a tassi a due cifre (sia la spesa infrastrutturale cloud, IaaS/PaaS,sia quella per il SaaS). Il cloud provider locale è preferito rispetto a quello globale, ma l’alternativa SaaS è sempre più presente, soprattutto per il software di produttività/collaborazione, poco per Erp/gestionale. Ancora presente per tutti gli ambienti applicativi/dati, il data center on-prem non sarà abbandonato nel breve termine e la situazione sarà quindi sempre più ibrida e multicloud, con le sfide che ne conseguono. «Le architetture di tipo ibrido costituiscono la realtà più comune anche per le aziende della Svizzera italiana analizzate. Le resistenze culturali del management a esternalizzare dati ritenuti più strategici, non solo mantenendoli sul territorio svizzero, ma non facendoli uscire dall’azienda in alcun modo, insieme ai vincoli normativi, ai timori sul fronte della sicurezza e alle perplessità sui costi, hanno finora visto portare sul cloud pubblico soprattutto applicazioni tipicamente commoditizzate (come posta elettronica e di produttività individuale) o workload non legati ai processi core delle aziende. Diverso il discorso per chi opera in una logica già cloud native», nota Massimo Baioni. Per monitorare l’evoluzione, Tinext Cloud punta a ripetere a cadenza biennale lo studio e sta dunque già mettendo in pista la prossima edizione, focalizzata proprio sulla Svizzera italiana.
esponenzialmente in volume, siano anche sempre più distribuiti combinando sistemi eterogenei amplia però la complessità della gestione e la superficie d’attacco. Inoltre, con la diffusione dello smart working, i dipendenti si connettono
da ovunque: casa, ufficio, trasporti, ... Tinext Cloud si sta impegnando anche per sensibilizzare su questo aspetto critico, con eventi divulgativi come quello dello scorso settembre Sicurezza e Governance nell’ambiente di lavoro ibrido: strategie per
il futuro del lavoro , in collaborazione con Fidigit. «Cerchiamo di stimolare le aziende a riflettere sulla loro vulnerabilità e a comprendere le ripercussioni tanto sull’interruzione dell’operatività quanto in termini di sanzioni penali cui una compromissione dei servizi informatici o un cyberattacco le esporrebbero. Fortunatamente ci aiutano i paletti posti dalle nuove normative, come la Legge sulla Protezione dei Dati svizzera (Lpd) e la direttiva Ue Nis2, che introducendo severi requisiti di gestione dei fornitori, tocca anche le imprese svizzere, non di rado parte della supply chain di aziende europee», osserva Massimo Baioni.
Tinext Cloud ha acquisito un’importante esperienza in materia ‘esercitandosi’ in uno degli ambiti più ristrettivi, quello dei servizi finanziari, chiamato a recepire le severe normative della Finma e del regolamento europeo Dora. «Nel corso degli anni abbiamo maturato un importante know-how non solo dal punto di vista normativo e tecnico, ma anche contrattuale, il che ha il pregio di facilitare poi i nostri clienti nel superamento degli audit. Cerchiamo inoltre di trasporre questa expertise anche ad altri settori di per sé meno regolamentati, sempre valutandone la proporzionalità rispetto alla sensibilità dei dati da proteggere», specifica Massimo Baioni.
Se la consapevolezza che la trasformazione digitale non sia solo un costo, ma un driver strategico di sviluppo, sembra ormai condivisa anche a livello regionale, quantificare il ritorno sull’investimento dell’adozione di una strategia cloud risulta più complesso di quanto non sia, ad esempio, stimare l’impatto dell’introduzione di un nuovo macchinario nella linea di produzione. «La leva più efficace sono di solito i casi di studio, che permettono di portare l’esempio dei vantaggi ottenuti da un pari. Poi è vero che ogni azienda è un caso a sé, per cui si parte sempre da un assessment dello status quo, aiutando il cliente a capire che il passaggio al cloud non si può limitare al lift and shift di quanto si ha fisicamente in casa. Si procede dunque a un’ottimizzazione dell’installato su carta, individuando eventuali sprechi e possibilità di consolidamento, per poi paragonare il canone dei servizi in cloud al costo dell’infrastruttura locale, mostrando come quest’ultimo nasconda non poche spese legate alla gestione: la manutenzione e gli aggiornamenti per
mantenere il server locale efficiente, la corrente elettrica per alimentarlo e le norme di sicurezza, compreso sistema rilevamento fumi e antincendio, oltre a sistemi ridondanti o gruppi di continuità per garantire l’operatività in caso di panne o guasto. Una volta messi sul piatto tutti questi elementi, ovviamente rapportati al livello di rischio che l’attività può tollerare, ecco che di solito i conti tornano a favore del cloud», dichiara Massimo Baioni.
Per citare una fra le più recenti analisi, proposta da Goldman Sachs Research, entro il 2030 il giro d’affari globale del cloud computing dovrebbe salire a 2.000 miliardi di dollari, beneficiando soprattutto della spinta della GenAi verso il Platform e Software as-a-Service (PaaS e SaaS), che arriveranno rispettivamente a pesare il 30% e il 41% del totale.
«Il nostro obiettivo è continuare a crescere a un Cagr attorno al 20%. Per farlo puntiamo su tecnologie e competenze. Ad esempio, nei nostri due datacenter, in Ticino e a Zurigo, stiamo implementando in queste settimane sistemi di archiviazione object storage per potenziare la conservazione georidondata a lungo termine di dati, affidandoci a questi sistemi di archiviazione in grado di interfacciarsi con tantissime diverse applicazioni, con un occhio particolare all’immutabilità del dato su cui insiste la regolamentazione. Inoltre stiamo reclutando specialisti verticalizzati negli ambiti Security e Public Cloud, con tutte le difficoltà che comporta accaparrarsi questi talenti alle nostre latitudini. Ma il ritorno giustifica l’investimento», osserva il Ceo di Tinext Cloud.
Al contempo sono stati selezionati anche profili specializzati in DevOps, la metodologia - ma si può addirittura parlare di filosofia - che, come suggerisce il suo nome, integra due dimensioni solitamente estranee come ‘development’ e ‘operations’ per creare una cultura condivisa e un ambiente di lavoro agile consentendo di accelerare sviluppo, validazione e implementazione di prodotti e servizi software di qualità, che mettano al centro le reali esigenze del cliente. «Supportiamo così le software house nostre partner nella loro evoluzione verso logiche di modern applications, destinate a diventare il nuovo standard, per offrire in particolare servizi SaaS sempre più flessibili e scalabili. Stiamo dunque facendo investimenti in piattaforme per queste
«L’obiettivo è continuare a crescere a un Cagr attorno al 20%. Per farlo puntiamo su tecnologie e competenze. Ad esempio, nei nostri due datacenter, in Ticino e a Zurigo, stiamo implementando sistemi di archiviazione object storage per potenziare la conservazione georidondata a lungo termine di dati. Inoltre stiamo reclutando specialisti verticalizzati in ambito Security e Public Cloud»
Marco Tramacere, Ceo di Tinext Cloud


Accanto, una selezione delle molte iniziative di cloud transformation a cui, con i loro potenziali benefici, le aziende svizzere sono interessate.
applicazioni containerizzate, per contribuire a facilitarne l’adozione», conclude Massimo Baioni.
Si torna dunque all’idea di un ecosistema virtuoso in cui mettere a fattore comune i propri progressi per avanzare insieme. Inoltre, Tinext Cloud può andare al di là del proprio perimetro grazie alle sinergie con il Gruppo, al contempo mettendo la propria expertise al servizio di altre sue aree.
La concorrenza non manca ma nemmeno lo spazio per coesistere, con un universo dei dati in esponenziale espansione e tante aziende che ancora devono migrare, almeno in buona parte, verso il cloud. Una sana competizione che, a pari livello di prestazioni e garanzie, ha il pregio di ac-
Iniziative di Cloud Transformation ritenute prioritarie
Top 5 attività previste nel 2022 per il 2023
Ottimizzare l’uso attuale del cloud per ottenere risparmi
applicativo (spostare le app in cloud)
“Percorsi di...”, Tinext, VMware, The Innovation Hub
crescere la qualità complessiva dell’offerta dei cloud service provider. L’importante è non limitarsi a farsi portare dalle correnti ma, con i piedi ben piantati a terra, volgere lo sguardo all’orizzonte per intercettare in anticipo nuvole e nubi all’orizzonte.
Susanna Cattaneo
Decisioni da condividere
Il sistema sanitario è sotto pressione. Tuttavia, concentrarsi esclusivamente sui costi non è sufficiente: anche la qualità e l’assistenza sono fondamentali. Da qui occorre ripartire, insieme.
L’evoluzione delle prestazioni rimborsate dall’Aoms
Crescita cumulativa per gruppo di costo, in %, 2007-2022

Sopra, Thomas Harnischberg, Ceo di KPT, autore di questo contributo. Nel 2023, l’Aoms ha rimborsato 39,9 mld di Chf di prestazioni mediche. Ad aver conosciuto il maggior incremento negli ultimi 15 anni, le cure ospedaliere ambulatoriali, al centro della riforma Efas su cui si voterà il 24 novembre, seguite dai medicamenti.
ICure ospedaliere stazionarie (con medicamenti) Case di cura Cure mediche ambulatoriali
Fonte: Ufsp
Cure ospadaliere ambulatoriali (con medicamenti) Medicamenti (medici + farmacia) Altro (Spitex, fisioterapia, laboratori, ...)
l sistema sanitario svizzero è una grande conquista. Ma l’ex fiore all’occhiello della nazione dà sempre più pensieri. I costi sanitari sono tristemente in cima al barometro delle preoccupazioni e i premi hanno ormai raggiunto la soglia del dolore. Più di un terzo della popolazione beneficia di riduzioni: la chiara dimostrazione che qualcosa non funziona.
Il dibattito in corso sui costi non può ignorare due fattori. In primo luogo, dobbiamo renderci conto che questo problema è presente in tutti i sistemi sanitari moderni. Il progresso medico non è gratuito: i trattamenti innovativi - e costosi - sono molto richiesti. In secondo luogo, la salute in quanto bene supremo non può non avere un prezzo. Ce ne rendiamo conto solo quando siamo malati. Perché non chiedete a 50 persone sane se i loro premi sono troppo alti? E poi fate la stessa domanda a persone che si sono sottoposte a un trattamento contro il cancro. Otterrete risposte del tutto diverse.
Oltre ai costi, dovremmo considerare con maggiore attenzione anche la qualità e la disponibilità dei servizi medici. A cosa
serve avere i soldi se mancano gli infermieri e i pediatri? La situazione è simile per i medicamenti: la strozzatura nella fornitura di farmaci essenziali si è aggravata. Quindi non è solo un problema di costi, ma dalle radici molto più profonde. Le ricette abbondano. È necessario avviare una discussione sul tipo di offerta che vogliamo. L’assistenza ospedaliera frammentata e su piccola scala è un chiaro fattore di costo. Invece di 300 ospedali, la Svizzera ha bisogno di una buona assistenza di base con strutture decentrate per la riabilitazione e l’assistenza infermieristica e di una maggiore concentrazione di ospedali acuti. A tal fine è essenziale un coordinamento significativamente migliore tra il governo federale e i cantoni. Dovremmo anche smetterla di fare della microgestione attraverso il sistema legislativo. In Parlamento sono stati presentati innumerevoli pacchetti di contenimento dei costi che gonfiano il sistema soprattutto dal punto di vista amministrativo senza offrire alcun valore aggiunto, certamente non per le persone interessate.
Se vogliamo aiutarle, dobbiamo tornare ai valori tradizionali svizzeri e ritrovare la
strada della comunità. La solidarietà è un prerequisito fondamentale per un sistema sanitario sostenibile. Questi valori vengono trascurati nelle discussioni attuali. Ora abbiamo la possibilità di scegliere come riformare il nostro sistema sanitario: o lasciamo che siano i politici cambiarlo o lo fanno i suoi stessi attori. Come società, sarebbe bene scegliere la seconda opzione. Ritengo che tutti siano responsabili - comprese noi, compagnie di assicurazione sanitaria. Abbiamo una responsabilità sociale. Le casse malati collegano tutte le parti interessate e fungono da snodo. Inoltre, sono vicine ai loro clienti e ne conoscono le esigenze. Purtroppo, in passato ci siamo ripetutamente indeboliti non intervenendo con una voce unitaria nel dibattito politico. Era giunto il momento di lanciare una nuova associazione di settore standardizzata. Sono lieto che il progetto sia stato accolto con grande favore e che finalmente possiamo aggregare la nostra categoria.
Il settore sanitario comporta un difficile gioco di equilibri tra le istanze sociali e la prassi politica. Tutti vogliamo qualità e buone cure, preferibilmente a prezzi accessibili. Al centro non sono i singoli attori, ma le persone, non solo come contribuenti, ma anche come pazienti ed elettori. Non dobbiamo dimenticarlo.
GESTIONE PATRIMONIALE ONLINE
Scegliete il Mandato di Investimento Online di BancaStato. Facile, veloce, professionale
Trovare salutari compromessi
Per continuare a garantire la sostenibilità di un sistema sanitario di qualità, basato sul principio della solidarietà, sono necessarie proposte concrete e concessioni da parte di tutti gli attori in gioco. Ma le lunghe negoziazioni per varare nuove riforme e la difficoltà nello shift verso l’e-Health mostrano un percorso complesso. La parola alla Direttrice dell’Ufsp, Anne Lévy.
Sanità in sofferenza, un nuovo aumento medio dei premi del 6% Premi mensili medi per Cantone nel 2025, in Chf e variazione in % rispetto al 2024
Che in Svizzera sia necessaria una maggiore cultura del consenso in materia di politica sanitaria è indubbio.
Gli aumenti dei premi annunciati ormai regolarmente ogni anno non sono che la manifestazione più evidente delle contraddizioni di un sistema che, pur di altissima qualità - e in parte proprio perché, generosamente, tale - è chiamato a evolversi per cogliere le sfide, ma anche le opportunità con cui gli squilibri demografici, il progresso scientifico e la trasformazione digitale lo confrontano. Trovare un accordo fra i tanti interessati è talmente complesso da non poter che parlare di compromesso. Confederazione, Cantoni, l’ampia gamma dei fornitori di prestazioni, le casse malati, i cittadini sono chiamati a trovare un’intersezione fra le loro rivendicazioni. Quella che circoscrive il comune obiettivo: mantenere l’eccellenza dell’offerta, ma a condizioni sostenibili. Ne abbiamo discusso con la direttrice dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), Anne Lévy.
Direttrice Anne Lévy, come intervenire sui costi in lievitazione della sanità?
Il nostro è un sistema sanitario che offre alla popolazione la possibilità di ricevere cure tempestive e di alto livello, vicino a dove si vive. Un sistema che non abbandona nessuno e che garantisce un’elevata aspettativa di vita. Inevitabile che abbia un costo, destinato ad aumentare ulteriormente in futuro, complici il progresso medico, la crescita demografica e l’invecchiamento della popolazione. Quello che possiamo fare, e che stiamo già facendo, è frenare questa tendenza lavorando a stretto contatto con i vari attori in causa. È un sistema è enormemente complesso e sappiamo che ci sono aree in cui possiamo intervenire per migliorare il coordinamento delle cure, evitare doppioni, trattamenti non necessari e un’eccessiva medicalizzazione o per moderare l’aumento di alcuni oneri. Due epocali riforme, sul tavolo dei negoziati da circa quindici anni, Tardoc ed Efas (quest’ultima in attesa del voto del 24 novembre) sono finalmente sul
Se la sostenibilità è il nuovo mantra generale, garantire quella del sistema sanitario è missione non da poco. Fra i fattori a spingere al rialzo i costi, nuove terapie e medicamenti, invecchiamento della popolazione e squilibri strutturali. Nel 2025, il premio medio mensile sarà di 378,7 Chf (+6 %).
punto di concretizzarsi. Perché è stato così difficile trovare un accordo tra le parti?
Nel nostro sistema sanitario, i Cantoni sono in gran parte responsabili dell’assistenza sanitaria. Inoltre, sono coinvolti molti altri attori: più di 200 ospedali acuti e di 40 assicurazioni sanitarie, migliaia di studi medici, servizi infermieristici, farmacie, numerose associazioni, l’industria farmaceutica e le tecnologie mediche. Che si tratti del nuovo tariffario medico Tardoc e dei forfait ambulatoriali o del finanziamento uniforme delle prestazioni Efas, dobbiamo considerare i diversi interessi di ciascuna parte per procedere insieme e non pregiudicare le riforme, comprese le stesse opinioni divergenti che attraversano il Parlamento.
Ma il risultato c’è: i partner tariffari stanno attualmente lavorando insieme per mettere a punto i due sistemi di fatturazione Tardoc/forfait ambulatoriali, che dovranno essere implementati in parallelo. Anche la riforma del finanziamento uniforme ha finalmente ottenuto una chiara maggioranza in Parlamento, oltre che tra gli operatori sanitari e i Cantoni. In che misura porteranno benefici al nostro sistema sanitario?
Sottolineo che non si tratta tanto di risparmiare quanto di controllare i costi. Su questi ultimi possiamo agire lavorando sul
prezzo dei farmaci, su un migliore coordinamento delle cure per evitare doppioni, abbassando alcune tariffe e rafforzando la prevenzione. Ma le due riforme hanno altri obiettivi. Il Tardoc consentirà di fatturare in modo più accurato i tempi di consultazione e terrà maggiormente conto di caratteristiche ed esigenze specifiche della medicina di famiglia. La fatturazione forfettaria semplificherà la fatturazione e limiterà gli incentivi ad aumentare il numero di prestazioni fatturate. D’altra parte, poiché l’Efas prevede che i Cantoni e le assicurazioni sanitarie finanzino congiuntamente tutti i servizi, entrambi saranno incentivati a promuovere le cure più appropriate e meno costose. Ciò dovrebbe accelerare il trasferimento dei servizi ospedalieri verso l’assistenza ambulatoriale, che spesso è più rilevante dal punto di vista medico per i pazienti e meno costosa in generale. All’estero, dove è molto più comune, risulta spesso un grande sollievo per molti pazienti. Benché l’Efas possa dare un impulso decisivo alle cure ambulatoriali, il numero molto elevato di ospedali rimane un punto dolente. Come si può strutturare meglio la pianificazione ospedaliera?
In Parlamento sono in corso diverse discussioni, in particolare per invitare i Cantoni ad analizzare la situazione e trovare soluzioni a livello sovraregionale. È infatti a loro che spetta la ripartizione delle aree di competenza tra gli ospedali per coprire le esigenze del proprio territorio, e così rimarrà in futuro. Molti istituti si trovano attualmente in difficoltà finanziarie, come sanno bene i Cantoni, dovendone pagare i debiti. Per cui nessuno se ne sta con le mani in mano.
Ciò detto, ritengo che ci sia bisogno di più centri ambulatoriali con servizi di emergenza che di ospedali acuti. E che dobbiamo mettere in rete i processi digitali in modo che basti inserire i dati sanitari una sola volta. Da un lato, per migliorare la qualità e la sicurezza dei pazienti e, dall’altro, per combattere la carenza di personale qualificato.
Se la digitalizzazione può esser parte della soluzione, dove risiedono le principali criticità che ne stanno rallentando l’adozione? Penso, per esempio, ai ritardi nella diffusione della Cartella informatizzata del paziente (Cip)...
La Cartella informatizzata del paziente è già disponibile in tutta la Svizzera. La sua utilità è indiscutibile. Riunendo tutte le
«La pianificazione ospedaliera rimarrà di pertinenza cantonale. Ritengo però che ci sia bisogno di più centri ambulatoriali con servizi di emergenza che di ospedali acuti. E che dobbiamo mettere in rete i processi digitali per poter inserire i dati sanitari una sola volta. Sia per migliorare qualità e sicurezza dei pazienti, sia per combattere la carenza di personale qualificato»
Anne Lévy, Direttrice dell’UFSP
Premi più che raddoppiati dal 1997

In crescita più dei salari
cumulativa dei premi Aoms e indicatori macroeconomici 2007-2022
Ufsp
(0-18 anni) Giovani (19-25 anni) Adulti (dai 26 anni)
cosa si paga
finanzia il sistema?
informazioni rilevanti sulla salute di un paziente, contribuisce a migliorare la qualità dell’assistenza medica, ad esempio per le persone affette da malattie croniche. Inoltre, ottimizza l’efficienza del sistema sanitario, evitando di perdere informazioni e di ripetere inutilmente procedure mediche. Non è però ancora perfetta nella sua attuazione. Le istituzioni collegate
Ust
I premi pesano sempre più sugli assicurati, crescendo a un ritmo ben superiore all’evoluzione dei salari. Nel 2023, l’assicurazione di base ha rimborsato 39,9 miliardi Chf di prestazioni (373.- mese/persona).
La partecipazione degli assicurati (franchigia, aliquota e contributo spese degenze ospedaliere) è stata di 5,3 mld.
Spesa sanitaria, un mal comune
Costi della salute / Pil
Austria Francia Germania Italia Svizzera Regno unito Stati Uniti
Cambiano i modelli, ma la sfida della sostenibilità accomuna tutti i sistemi sanitari moderni. Una parte della soluzione potrebbe venire dal digitale, che ha il potenziale per snellire molti costi. Fra i suoi presupposti, la Cartella informatizzata del paziente (Cip) richiede però ancora sforzi organizzativi e di comunicazione per diffondersi.
sono ancora troppo poche. E troppo poche persone la usano. Ma ci stiamo lavorando. Ecco perché, oltre alla revisione a breve termine che fornirà un sostegno finanziario per ogni dossier aperto, abbiamo bisogno di una revisione globale che faciliti lo sviluppo della Cip. Più in generale, per agevolare la comunicazione e la condivisione di dati fra gli attori in gioco, l’obiettivo è quello di standardizzare e collegare meglio i sistemi informatici di cui già dispone la maggior parte degli studi medici, come avviene attualmente con Digisanté.
Accennava alla carenza di personale che affligge il settore: come contrastarla?
La promozione della medicina di famiglia ha già rappresentato un importante passo avanti. Abbiamo creato più posti di formazione e reso la medicina di base una materia di studio più interessante. La Consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha chiarito che, nella prossima fase, questo aspetto dovrà essere considerato in modo più ampio, includendo nelle discussioni medici di famiglia, infermieri, farmacie e, ad esempio, pediatri e pronto soccorso.
Rafforzare l’assistenza infermieristica resta senza dubbio il principale obiettivo. Allo stesso tempo, dobbiamo chiederci: quali compiti possono assumere gli infer-
mieri? E cosa dovrebbe fare un medico? Ad esempio, le farmacie possono fornire più vaccinazioni. Un secondo aspetto importante è che il ricovero in ospedale consuma molte risorse. Oggi, molte cure potrebbero essere fornite a livello ambulatoriale.
A scarseggiare sono anche i medicamenti: a fine agosto l’Ufsp ha proposto una nuova serie di misure per affrontarne la carenza. Come è potuto accadere in un Paese leader dell’industria farmaceutica? Il problema è in aumento in tutto il mondo e non facciamo eccezione. La delocalizzazione delle principali fasi di produzione in Asia e la concentrazione su un numero ridotto di fornitori si ripercuote in particolare sui farmaci il cui brevetto è scaduto. Anche se la Svizzera è un leader del pharma, è un Paese piccolo, con un mercato che non è il più attraente per l’industria. E la produzione raramente è localizzata qui, o addirittura in Europa. La Confederazione ha lanciato un piano di approvvigionamento e intende, tra l’altro, aumentare le riserve obbligatorie, rinunciare alle riduzioni di prezzo per alcuni farmaci essenziali e autorizzare più facilmente alcune importazioni in caso di necessità. Inoltre, il Consiglio federale vuole creare incentivi per incoraggiare la produzione di farmaci importanti. Ha anche discusso le modalità per migliorare l’approvvigionamento di beni medici essenziali in caso di pandemia. La possibilità, pure citata, di produrre alcuni medicamenti tramite la Farmacia dell’esercito sarebbe solo una soluzione temporanea di emergenza, ma non può risolvere la fragilità della produzione e delle catene di approvvigionamento.
La principale missione dell’Ufsp è garantire la qualità delle cure e la sicurezza
dei pazienti. Ma non sempre tutto ciò che è fattibile dal punto di vista medico è appropriato e sostenibile. Di recente avete anche lanciato un’iniziativa in tal senso. Di cosa si tratta?
Non è solo l’assenza di cure a poter comportare dei rischi. Il trattamento giusto deve essere somministrato al momento giusto. Né troppo né troppo poco.
A tal fine, ad esempio, abbiamo già sostenuto l’aggiornamento dell’Atlante dei servizi sanitari svizzeri da parte dell’Osservatorio svizzero della salute (Obsan), che fornisce un quadro chiaro della misura in cui l’assistenza varia da cantone a cantone.
L’obiettivo del progetto lanciato in primavera su questo tema, che si concluderà nell’autunno dell’anno prossimo, è quello di fare il punto della situazione con le numerose organizzazioni mediche specializzate, ospedali e associazioni che si stanno già occupando della questione, per chiarire insieme gli ambiti in cui è necessario intervenire.
Si ha sempre la tendenza a vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma negli ultimi anni quanto si è già risparmiato?
Da anni lavoriamo per contenere l’aumento dei costi sanitari. Dal 2012, l’Ufsp ha ridotto il prezzo dei farmaci di circa 1,5 miliardi di franchi. Il programma di Health Technology Assessment (Hta) ha già permesso alla Confederazione di decidere venti volte sul rimborso delle prestazioni da parte dell’assicurazione di base, con un risparmio diretto di oltre 90 milioni di franchi all’anno.
Il Consiglio federale ha inoltre creato incentivi mirati per l’utilizzo di generici e biosimilari meno costosi. Si stima che il risparmio potenziale ammonterà fino a 250 milioni di franchi all’anno. Inoltre, per il 2019 e il 2022, il governo ha presentato al Parlamento due serie di misure di contenimento dei costi. La prima è entrata in vigore nel 2023 e nel 2024. Il Parlamento sta attualmente discutendo il secondo pacchetto, che comprende misure importanti come gli sconti sulla quantità dei farmaci più venduti e il rafforzamento dell’assistenza coordinata. I potenziali risparmi potrebbero ammontare a mezzo miliardo di franchi all’anno. Ciò detto, il controllo dei costi rimane un esercizio costante, che richiede l’impegno congiunto di tutti gli attori.
Susanna Cattaneo
Occorrono misure federali
Al di là dell’impegno profuso dal Ticino per affrontare i costi della salute in esplosione, che rischiano di farne collassare il sistema, una risposta efficace e duratura deve venire da Berna.
Il 2025 segnerà il terzo anno consecutivo di aumenti significativi dei premi di cassa malati in Ticino, con un rincaro del 10,5%, dopo quelli nel 2024 (+10,5%) e nel 2023 (+9,2%). Un colpo durissimo per i cittadini del nostro cantone, tra i Cantoni più penalizzati. Come già evidenziato negli anni passati, il nostro sistema è vicino al collasso. Senza interventi strutturali urgenti, la situazione non farà che peggiorare. Saremo l’unica regione con un rincaro a due cifre, mentre la media nazionale si attesta al 6%, con una riduzione significativa rispetto all’anno precedente.
Puntualmente la Confederazione invita a cambiare assicuratore per risparmiare, ma gli assicuratori che perdono clienti aumentano i premi l’anno dopo, caricando il peso nuovamente sugli assicurati. Il problema viene dunque semplicemente rinviato, creando oltretutto un’enorme burocrazia! Il considerevole divario tra i premi proposti dai vari assicuratori, che può arrivare a 1.380 franchi l’anno, dimostra che esistono margini di risparmio, ma solo a scapito di un sistema che non affronta le cause strutturali del problema. Un sistema ben oltre il capolinea.
Lo scarto tra il Ticino e il resto della Svizzera è riconducibile a vari fattori. La diversa struttura demografica e la maggior densità di fornitori di prestazioni (cioè di offerte di cura) si traduce in un consumo superiore di trattamenti, soprattutto in età avanzata. Abbiamo quindi un sistema con diversi attori in gioco, senza alcun incentivo alla riduzione della spesa. Peggio: il sistema genera un ricorso continuo alle prestazioni, considerato che una volta raggiunta la franchigia non vi è più nessuna ‘diga’ che contiene l’accesso alle cure. È quindi necessaria la responsabilizzazio-
ne di tutti, pazienti, medici e operatori sanitari inclusi, per contribuire a frenare la spirale di costi. La crescita dei premi non è sostenibile e richiede un impegno condiviso da tutte le parti in causa.
A livello cantonale, abbiamo fatto la nostra parte: limitando le nuove autorizzazioni in 11 specialità mediche, introducendo la moratoria per gli infermieri indipendenti e le organizzazioni di cure a domicilio, e riducendo il valore del punto Tarmed per i medici (decisione impugnata dalla categoria e ancora sospesa in attesa del Tribunale amministrativo federale). Abbiamo inoltre investito nel rafforzamento del ruolo del medico di famiglia: da alcuni anni contribuiamo finanziariamente al progetto di formazione dei medici assistenti negli ambulatori privati, e più di recente abbiamo sostenuto la realizzazione dell’Istituto di medicina di famiglia all’Usi e del Servizio di medicina di famiglia all’Ospedale Italiano, voluto per servire meglio la popolazione.
In ambito stazionario, i costi sono sotto controllo, merito della negoziazione dei volumi di attività e del relativo finanziamento tramite ‘budget globale’. Lo strumento della pianificazione ospedaliera, in fase di aggiornamento, può fare il resto. Il problema, però, non è da cercare qui: la spesa in questo settore cresce in media del 2% l’anno, un trend del tutto giustificato, sostenibile e sotto controllo.
Fra i costi che invece esplodono, quello dei medicamenti, di esclusiva competenza federale. Il settore si distingue per la marcata disparità di costo rispetto all’estero, farmaci innovativi estremamente costosi e una preoccupante mancanza di trasparenza nella formazione dei prezzi. È fondamentale che l’intervento e la vigilanza in questo ambito vengano rafforzati, anche

Raffaele De Rosa, Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità.
in termini di lotta agli sprechi. Gli assicuratori malattia devono assumere un ruolo più attivo nel monitorare e prevenire utilizzi inefficaci o eccessivi. Un esempio è il progetto pilota promosso dal Canton Ticino per la dispensazione su misura degli antibiotici che, visto il successo, è stato esteso a livello nazionale. Iniziative come questa dimostrano che un approccio più mirato e razionale può contribuire a contenere i costi senza compromettere qualità e disponibilità delle cure. In questo senso, occorre contrastare la medicina inutile, quella ‘di troppo’: nella sanità l’offerta genera la domanda, ma spesso fare di più non significa fare meglio!
In conclusione, se non verranno attuate riforme strutturali, il sistema sanitario svizzero rischia seriamente di collassare. È urgente che Berna assuma un ruolo più attivo e responsabile per affrontare la crisi dei costi della salute: prioritario è rendere il sistema più trasparente, intervenire sui prezzi dei medicamenti, arginare il ricorso troppo frequente alle prestazioni, rivedere il meccanismo di remunerazione (oggi retto da falsi incentivi) e correggere il sistema ‘tarandolo’ anche sui fattori sociodemografici.
Il Cantone continuerà a fare la sua parte, ma non possiamo ignorare che una risposta efficace e duratura deve venire dal livello federale. Senza un cambiamento reale, gli aumenti annuali dei premi diventeranno insostenibili, danneggiando irreversibilmente la qualità della vita dei nostri cittadini e la sostenibilità del sistema sanitario nel suo complesso.
Un’impresa sempre in corsa
Che cosa hanno in comune le 54 società private della Svizzera, proprietarie di ben seimila chilometri di linea ferroviaria?
Lo stesso fornitore, presente in Ticino da centoventi anni.
Con il fermento innescato dalla realizzazione della ferrovia del Gottardo, alla fine dell’Ottocento, in Leventina si erano sviluppate numerose attività edili e industriali. Tra queste, fondata nel 1904, Tensol Rail di Giornico si occupa di concezione e fabbricazione di materiale viario ferroviario. Gli archivi dell’azienda raccontano la storia, non solo sua, ma indirettamente dell’evoluzione del Cantone che, grazie alle opere di quegli anni, si collocava nell’importante asse nord-sud. Come è evoluto il settore e quali sono oggi le opportunità e le sfide per un’azienda che vi opera? Ne parla Roberto Ballina, Ceo di Tensol Rail.
Da Piotta dove l’azienda è nata, nel 2005 ci siamo trasferiti a Giornico, nello stabilimento della ex Monteforno: un sito industriale dotato delle caratteristiche strutturali necessarie a farle fare l’ambìto salto di qualità. Con 80 collaboratori, oggi Tensoil Rail trasforma 30mila tonnellate di acciaio all’anno, produce 130-140 scambi ferroviari e registra un fatturato annuo di 25-30 milioni. Lo stabilimento, che è di nostra proprietà, occupa una superficie di 70mila mq, 24mila dei quali sono al chiuso. L’80% del nostro fatturato è realizzato grazie al mercato interno. Lavoriamo infatti per tutte e 54 le società ferroviarie private della Svizzera, proprietarie di ben 6mila chilometri di linea ferroviaria. Il restante 20%, lo realizziamo all’estero, grazie alla produzione e alla fornitura di ferrovie a cremagliera. Tensol Rail vanta dunque due primati: è leader nazionale nella produzione di materiale ferroviario e leader mondiale nella produzione di ferrovie a cremagliera. Quali i motivi di tale posizionamento?
Come per tutte le aziende che riescono ad attraversare epoche diverse, occorrono vicinanza e proattività nei confronti dei clienti, con risposte puntuali a qualsiasi richiesta o problematica. Negli anni, siamo diventati un punto di riferimento per tutto quanto attiene all’infrastruttura ferroviaria in Svizzera. Per le cremagliere

e le traverse ferroviarie, i nostri mercati di riferimento sono la Francia, la Spagna e la Grecia. Ultimamente abbiamo realizzato anche un grosso appalto in Colorado, negli Stati Uniti, fornendo tutto il materiale infrastrutturale ferroviario a cremagliera. Attualmente, stiamo investendo nella messa a punto di una macchina di ultima generazione per la forgiatura degli aghi destinati all’infrastruttura ferroviaria, nella fattispecie alla parte mobile degli scambi: si tratta di un prototipo, e siamo gli unici ad averlo, che ci permetterà di essere totalmente indipendenti e di competere sui mercati europei con prezzi decisamente più concorrenziali.

Roberto Ballina, Ceo di Tensol Rail, dal 2001. Sotto, uno scatto realizzato nel reparto produttivo dell’azienda.
La formazione di nuove leve è una costante …
Purtroppo, in Ticino, gli apprendistati tecnici non vengono presi sufficientemente in considerazione dai ragazzi e dalle loro famiglie. Oltre Gottardo la sensibilità nei confronti della formazione duale - vero fiore all’occhiello del sistema formativo svizzero - è ben più marcata. Tensol Rail, insieme ad altre aziende della regione Tre Valli - l’Azienda Elettrica Ticinese, Imerys Graphite & Carbon e Tenconi - ha fondato congiuntamente, con il sostegno del Cantone, il Campus Formativo di Bodio (Cfb): un centro di formazione interaziendale industriale per apprendisti polimeccanici e operatori in automazione. Con l’intento di offrire, alle nostre aziende, l’opportunità di attingere a un bacino di risorse adeguatamente formate, e sul territorio, per poi inserirle nei rispettivi contesti aziendali e perfezionare la formazione. In otto anni abbiamo formato più di 40 apprendisti, dei quali però nemmeno uno è rimasto a lavorare nelle aziende del comparto. Per il futuro e la continuità delle nostre imprese, questa tendenza costituisce un elemento di preoccupazione.
Nonostante sia passato più di un secolo, Tensol Rail è rimasta fedele a sé stessa… Ci caratterizzano oggi come allora l’attaccamento al territorio e, soprattutto, un’attenta e rispettosa gestione delle risorse umane. Questo modus operandi continua tuttora a portare i suoi frutti, tant’è vero che da noi il turnover è pari a 0. Simona Galli
Eureka!
Il 13esimo capitolo di un’epica avventura...

La 13esima edizione di Eureka ha al suo centro le Life sciences, declinate in più d’un modo, spaziando dunque dal Pharma e dalla salute, al BioTech più puro, e con i suoi più recenti cambi di equilibri. Se certo l’Intelligenza Artificiale ci sta mettendo il suo zampino, è pur vero che le altre industrie non sono immuni al cambiamento, leggasi anche l’industria finanziaria.
Federico Introzzi
Se il Tech si prende cura del Pharma
Ai&Co hanno il potenziale per rimodellare il settore delle Life sciences, a partire dalla possibilità di accelerare notevolmente lo sviluppo di nuovi farmaci e dispositivi medici, sotto pressione per i costi e le regolamentazioni crescenti. Tutta salute, per il Tech.

Apalesare l’affinità elettiva, bastavano le BigTech in grande spolvero alla J.P. Morgan Healthcare Conference di inizio anno, principale appuntamento a livello globale per imprese e investitori del settore delle Life Sciences. Non a caso, momento clou dell’affollatissima quattro giorni è stato l’intervento di Jensen Huang. Nella storica cornice della vecchia Zecca di San Francisco, il fondatore di Nvidia ha sottolineato con la sua concreta visionarietà come la stessa metodologia applicata alla progettazione computerizzata di chip possa rivoluzionare il ‘conio’ di nuovi farmaci. Da in vivo e in vitro a in silico: anche per la medicina si inaugura l’era delle simulazioni che sostituiscono
Le aziende di pharma e medtech sono sempre più globali. La regione Asia-Pacifico dovrebbe registrare una crescita tra le più elevate nei prossimi anni, grazie all’ampia base di consumatori, all’aumento dell’incidenza delle malattie e al supporto normativo.
algoritmi e modelli computerizzati a esseri viventi e provette, con tanto di vantaggi etici, finanziari e compressione delle tempistiche di sviluppo.
Più in generale, l’intelligenza artificiale, ancor meglio se generativa, dovrebbe rappresentare la chiave di volta per un settore che ha accumulato dati per decenni e in cui continuano a crescere esponenzialmente, secondo le statistiche addirittura a un Cagr persino più elevato che nell’industria finanziaria, manifatturiera e dell’entertainment. Un boost di cui la ricerca
ha tremendamente bisogno, confrontata alle sfide che rischiano di rallentarne la crescita. Nvidia non è ovviamente la sola ad averlo capito e alla sua piattaforma BioNeMo rispondono servizi e suite offerti dalle altre ‘Magnifiche’ del Tech, che si affrontano anche a suon di round di investimento e partnership per arricchire le proprie scuderie con i nomi più promettenti del biopharma. Corteggiamenti ben accolti per portarsi in casa nuove capacità tecnologiche e talenti assicurandosi un vantaggio competitivo.
«Se l’industria farmaceutica è innovativa nella R&D, è altrettanto vero che essa è spesso lenta nell’abbracciare le rivoluzioni tecnologiche. Tuttavia, la GenAi ha portato un’attenzione più diffusa sulle potenzialità di applicazione dell’intelligenza artificiale, che rappresenta attualmente circa il 16% nelle attività di scoperta dei farmaci. Ci si attende, inoltre, che l’uso di Ai nella R&D aumenti del 106% nei prossimi tre-cinque anni», esordisce Luciano Monga, partner di Deloitte Svizzera a Lugano.
Fra i principali trend identificati dal 2024 Global Life Sciences Sector Outlook di Deloitte, emerge proprio l’interesse per l’adozione della GenAi. A stimolarlo, un
Life sciences, un mercato sempre più globale
Vendite in mld Usd, 2019, 2023 e previsioni 2028
Device
Fonte: Deloitte
contesto sfidante, che richiede risposte: da una parte, insieme alle tensioni geopolitiche, la pressione sui prezzi, i cambiamenti normativi e i brevetti in scadenza, questi ultimi che potrebbero costare alle aziende del settore oltre 200 miliardi di dollari di fatturato, mettendone in discussione i modelli operativi. Dall’altra parte, l’invecchiamento della popolazione, la (in) sostenibilità dei sistemi sanitari (ne sa qualcosa anche la Svizzera) e la garanzia di un accesso equo alle cure a livello globale. Nel prossimo anno, oltre 9 su 10 degli intervistati da Deloitte attivi nel settore del biopharma e del medtech prevedono che la GenAi avrà un impatto sulle loro aziende. «Secondo le nostre stime, un’azienda biofarmaceutica della top ten, con un fatturato medio di 65-75 miliardi di dollari, scalando l’uso dell’Ia potrebbe generare 5-7 miliardi di dollari nell’arco di 5 anni. L’R&D rappresenta la principale opportunità di creazione di valore, seguita da commercializzazione, produzione &supply chain e aree abilitanti (It, Hr, finanza, ...). Impatti che possono trasformarsi in vantaggi competitivi: una maggiore velocità ed efficienza può consentire la riallocazione del capitale ad altre aree e la maggior efficacia può aiutare le aziende a far progredire la loro innovazione e a coinvolgere i loro clienti, ottenendo in ultima analisi risultati migliori per i pazienti», sottolinea Luciano Monga.
Da quando Deloitte ha iniziato ad analizzare l’innovazione farmaceutica nel 2010, ancora oggi solo un nuovo farmaco su dieci che entra in sperimentazione ottiene l’approvazione: fallimenti che rappresentano circa il 60% di tutti i costi di sviluppo. Nonostante i numerosi progressi scientifici e tecnologici, questa rimane una delle principali sfide per l’industria. Nel 2023, le grandi case farmaceutiche, che rappresentano quasi i due terzi degli investimenti totali in R&D del settore, hanno speso un record di 161 miliardi di dollari, con un aumento quasi del 50% rispetto al 2018, toccando il massimo storico del 23,4% in percentuale del fatturato netto. Il costo medio per far progredire un’attività dalla scoperta al lancio ammonta a 2,284 miliardi di dollari per asset.
A oggi, l’uso più comune della GenAi è la trasformazione del modo in cui le aziende farmaceutiche decidono in quali aree patologiche investire. Modelli linguistici avanzati e algoritmi di machine
«L’Ai accelererà l’identificazione di farmaci più precisi e mirati, altamente specifici, con minor rischio di effetti collaterali, consentendo di testare scenari ed esiti in modo controllato ed efficiente, identificando potenziali problemi di sicurezza e ottimizzando le strategie di dosaggio e trattamento prima di condurre onerosi studi clinici»
Luciano Monga, Partner di Deloitte Svizzera a Lugano
Creare valore grazie all’Ai

Incremento di valore generato scalando l’uso dell’Ai su cinque anni per una biopharma con un fatturato fra 65-75 mld
Preoccupazioni executives R&D
“Su una scala da 1 a 5, quanto vi preoccupano i seguenti fattori?”
M&A nel biopharma
Principali 20 operazioni per fase e area terapeutica 2023
learning consentono di analizzare grandi quantità di dati clinici per identificare nuovi target terapeutici. «Dati interoperabili, piattaforme aperte e sicure, cure incentrate sul paziente hanno il potenziale per offrire uno sviluppo di farmaci meno costoso e più produttivo. L’intelligenza artificiale accelererà l’identificazione di farmaci più precisi e mirati, altamente specifici, con un minor rischio di effetti
Inasprimento delle normative e aumento di costi e cicli di sviluppo: le preoccupazioni che assillano l’innovazione del pharma possono trovare un prezioso alleato nell’Ai. Attività R&D in fase avanzata e le aree terapeutiche dell’oncologia, immunologia e sistema nervoso centrale hanno dominato nel 2023 le operazioni di M&A nel settore.
Costi dalla scoperta al lancio
Il ritorno sull’investimento
collaterali, in particolare grazie alle sperimentazioni in silico, consentendo di testare diversi scenari ed esiti in modo controllato ed efficiente, identificando potenziali problemi di sicurezza e ottimizzando le strategie di dosaggio e trattamento prima di condurre onerosi studi clinici», sottolinea il partner di Deloitte Svizzera. Inoltre, l’Ai generativa può facilitare una migliore comunicazione e condivisione delle conoscenze tra i gruppi di ricerca, rompendo i
silos di dati e aprendo nuove opportunità di collaborazione.
Al netto di dotarsi di infrastrutture e piattaforme per introdurre e scalare queste nuove applicazioni in azienda, il fattore di differenziazione sarà probabilmente la qualità e la completezza dei dati proprietari su cui addestrare e far lavorare gli algoritmi. «La creazione di motori analitici che consentano di gestire facilmente i dati degli studi clinici interni,
Meglio accompagnati che soli
Uno dei principali fattori di forza del settore delle Life sciences lo scorso anno sono state le aziende farmaceutiche a grande/megacapitalizzazione con capitale di risparmio. Le 10 principali acquisizioni chiuse nel 2023 avevano ciascuna un valore superiore a 4 miliardi di dollari, guidate dalle operazioni multimiliardarie di Pfizer/Seagen (43 miliardi Usd). I dealmaker stanno pagando premi molto elevati per asset ad alto potenziale commerciale, oncologia in testa, seguita da immunologia e sistema nervoso centrale. L’approvazione del farmaco antiobesità di Novo Nordisks ha poi scatenato una vera e propria corsa nel segmento. «Le piccole e medie biotech, confrontate invece con un raffreddamento dei mercati dei capitali, si sono dovute orientare verso metodi alternativi di finanziamento, guardando sempre più a partnership e altre collaborazioni, come alternativa o precursore di fusioni e acquisizioni. Il tempo necessario per ottenere le autorizzazioni normative può essere particolarmente impegnativo e molte biotech hanno a disposizione una liquidità inferiore al passato. Inoltre, alleanze e joint venture possono essere utilizzate per dimostrare la fattibilità della proposta commerciale, tranquillizzando le autorità di regolamentazione sull’accordo», osserva il partner di Deloitte Svizzera. Dopo che la pandemia le ha sdoganate, anche le sinergie pubblico-privato possono diventare parte dell’equazione per sostenere l’ecosistema dell’innovazione biomedica, soprattutto offrendo incentivi finanziari, fiscali e tecnici anche laddove siano meno evidenti le prospettive di mercato. «Più incertezza, invece, per le valutazioni del medtech, che scontano un anno in cui le aziende si sono concentrate principalmente sulla razionalizzazione del portafoglio, sulle cessioni e la trasformazione dei costi. Tuttavia, i fondamentali sono solidi e i leader del settore erano ottimisti sulla crescita di quest’anno, visto il miglioramento della situazione della supply chain e anche le buone prospettive per la diagnostica, con la diffusione della biometrica, delle terapie digitali e a domicilio, insieme alla velocità di commercializzazione», conclude Luciano Monga.
La spesa in R&D continua a crescere: sull’arco di un decennio costa quasi il doppio sviluppare un nuovo asset. Oltre che dall’efficienza (tempi e costi del ciclo), il Tir dipende dalla creazione di valore (ricavi previsti corretti per il rischio): la tecnologia può agire su molteplici parametri di entrambi.
i set di dati multi-omici disponibili pubblicamente e quelli generati dai pazienti (ad esempio dai dispositivi indossabili) è destinata a trasformare il modo in cui le aziende utilizzano i dati per la generazione di informazioni», precisa Monga.
L’accelerazione diventa oggi ancor più vitale, per riuscire a dribblare i paletti sempre più stretti che la regolamentazione sta ponendo alla ricerca farmaceutica. In particolare, preoccupano i contraccolpi dell’Inflation Reduction Act (Ira) varata dal Governo Biden che in dote reca anche l’autorizzazione per il programma sanitario federale Medicare a negoziare prezzi equi per alcuni farmaci ad alto costo, onde renderli accessibili (il programma assicurativo si rivolge a over 65, disabili e altri pazienti critici).
Soprattutto rischiano di essere penalizzati, malgrado il loro successo, i farmaci a base di piccole molecole, i cui prezzi potranno essere rinegoziati a 9 anni dall’approvazione, quando - secondo le stime di Deloitte - ne sono necessari 8 per il ritorno sull’investimento. «Considerando che gli Stati Uniti detengono quasi il 43% del mercato farmaceutico mondiale, si prevede che l’Ira avrà implicazioni a scala globale sul modo in cui l’industria prende le decisioni e alloca le risorse sia nell’R&D che in sforzi commerciali», avverte Luciano Monga.
Da non sottovalutare, però, per un’adozione di successo dell’Ai, la diffusione di una cultura che vinca lo scetticismo e la resistenza di scienziati e ricercatori a integrarla in flussi di lavoro consolidati e che risponda alle perplessità di clienti e pazienti, oltre ad affrontare l’incertezza sul piano normativo e legale. Ad esempio, la Fda statunitense ha già istituito un gruppo di lavoro di oltre 200 scienziati dedicato all’analisi dei possibili campi di applicazione del modelling&simulation. Incognite, dunque, ma soprattutto opportunità. L’equazione di ogni ricerca.
Andrea Petrucci
Il cluster del bioteCH
La Svizzera conferma l’importanza della sua industria biotech, dimostrando in particolare un’invidiabile agilità, nelle attività di commercializzazione e finanziamento. Fondamentali, la forza innovativa, la diversificazione del portafoglio di prodotti e le collaborazioni internazionali.
Negli ultimi 25 anni, il settore delle scienze della vita ha quadruplicato il proprio valore in Svizzera. La leadership dell’export conquistata dal 2013 si è confermata l’anno scorso, contribuendo al commercio estero per 105,5 miliardi di franchi, il 38,5% del totale. «In prima linea nello sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni efficaci alle esigenze globali, si trovano le aziende biotech, elemento essenziale dell’equazione che colloca da ormai 13 anni consecutivi il nostro Paese al primo posto del Global Innovation Index dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (Wipo)», sottolinea Michael Altorfer, Ceo della Swiss Biotech Association, che monitora l’andamento del settore con il suo report annuale. Anche nel 2023 le biotech rossocrociate focalizzate sull’R&D - 361 aziende - hanno generato un fatturato in crescita, 7,3 miliardi Chf (6,8 nel 2022). «Un risultato determinato da importanti accordi di collaborazione e licenza con grandi case farmaceutiche e dalle vendite di prodotti incrementate dal record di approvazioni da parte di Swissmedic, Ema, Fda e altre autorità di regolamentazione globali, tra cui la prima terapia di editing genico Crispr al mondo», osserva Michael Altorfer. Nonostante un contesto sfidante, sono stati raccolti oltre 2 miliardi di investimenti di capitale, in crescita del 50% rispetto al 2022. L’unica a essersi quotata in borsa è stata Oculis che, con una transazione Spac sul Nasdaq e un successivo finanziamento, ha raccolto 144 milioni di dollari. Mentre il sentiment del mercato pubblico è rimasto negativo dalla fine della pandemia, l’ambiente dei finanziamenti privati ha resistito bene, raccogliendo 600 milioni di franchi. Noema Pharma, con 103 milioni Chf, e Alentis Therapeutics, 94 milioni Chf, hanno fatto da apripista. Tuttavia a beneficiarne è stato solo un numero ristretto di realtà. Con i mer-

Michael Altorfer, Ceo della Swiss Biotech Association, fondata nel 1998, rappresenta gli interessi del settore.
Il Biotech svizzero
Investimenti, ricavi e spese R&D (sx), mld, e n. addetti Fte (dx). tot. 361 R&D biotech
spesso nuove opportunità presso altre realtà del settore», chiarisce il Ceo della Swiss Biotech Association.
A dimostrare la maturità dell’industria, anche le operazioni di M&A. In particolare, sono da segnalare l’acquisizione di Vertical Bio (sviluppo terapie oncologiche) da parte della francese Pierre Fabre Laboratories, quella di VectivBio (trattamenti trasformativi per gravi patologie gastrointestinali rare) da parte di Ironwood Pharma per 1 miliardo di dollari, e l’acquisizione di T3 Pharma (specializzata in terapie batteriche contro il cancro) da parte di Boehringer Ingelheim per 450 milioni di franchi. Tutte e tre basilesi.
cati azionari e del debito più difficili da raggiungere, si è continuato a guardare a modalità alternative di finanziamento (licenze, collaborazioni, ma anche transazioni di monetizzazione degli asset).
«Malgrado diverse aziende siano state costrette ad avviare misure di ristrutturazione o riorganizzazione, pressoché invariato il numero di impieghi, con 19mila Fte, il che sembra indicare che i dipendenti altamente qualificati trovano
Quasi 2,5 i miliardi investiti dalle Biotech svizzere in R&D, per circa i due terzi in collaborazioni esterne. «Approcci protezionistici come quelli esacerbati dalla pandemia possono funzionare per paesi e alleanze molto grandi, ma data la sua piccola taglia e l’interdipendenza dai mercati globali, la Svizzera è portata a condividere il proprio know-how. Insieme alle principali università svizzere, agli ospedali, ai Cdmo globali e alle multinazionali farmaceutiche, le aziende biotech hanno creato negli anni una vasta rete di partner per la collaborazione internazionale, affermandosi come partner affidabile nelle alleanze bi- e multilaterali. Inoltre la Confederazione sta promuovendo alleanze normative per semplificare, facilitare e accelerare l’accesso al mercato dei prodotti innovativi. In pochi anni, Swissmedic e i suoi partner regolatori nell’Access Consortium (Uk, Canada, Australia e Singapore) sono riusciti a unire le loro conoscenze, risorse e competenze per accelerare l’approvazione di nuovi farmaci e snellire il quadro normativo per i loro mercati combinati come nessuno avrebbe potuto fare in autonomia», conclude il Ceo della Swiss Biotech Association.
Andrea Petrucci
Una logistica da curare
Fondamentale per velocizzare l’R&D del Pharma, garantire la conformità della catena di fornitura agli standard che tutelano la qualità, ma rischiano di rallentare lo sviluppo di nuovi prodotti.
Per sviluppare prodotti farmaceutici è necessario seguire precise linee guida e, per la sicurezza di tutti, è giusto che sia così. Ma c’è anche il rovescio della medaglia: le regole e le procedure spesso creano un appesantimento burocratico che rallenta le attività e aumenta i costi.
Riuscire a velocizzare i processi senza compromettere la sicurezza, soprattutto nella catena di fornitura, è una sfida importantissima. E in Germania c’è una start up che mira a risolvere proprio questo nodo: Qualifyze. Per farlo, la società ha bisogno di capitali da investire nell’innovazione e, recentemente, ha concluso un round da 54 milioni di dollari che utilizzerà per crescere, in particolare negli Stati Uniti, ed espandere i suoi prodotti con più analisi e Ai.
Qualifyze si è specializzata soprattutto sulle Gmp, ovvero delle misure di produzione e fabbricazione per garantire gli standard dei prodotti farmaceutici. «Ufficialmente, Gmp sta per ‘Good Manufacturing Practices’», ha spiegato David Schneider, fondatore e Ceo della società, a TechCrunch. Sottolineando che «La gente scherza dicendo che in realtà sta per ‘Give Me Paper’, perché nell’industria farmaceutica tutto è basato sulla carta».
di sigle, tra cui GxP e Iso. Guardando ai numeri, la società lavora con una rete di 250 revisori che effettuano controlli periodici su un database di circa 3mila fornitori di 1.200 clienti.
Tornando al round, questo è stato guidato da Insight Partners con la partecipazione degli investitori esistenti Hv Capital, HarbourVest Partners, H14 e Cherry Ventures. La start up non ha rivelato la sua valutazione, ma Schneider ha dichiarato di aver raccolto complessivamente 84 milioni di dollari ad oggi e che la sua

Alessandro Beggio, Ceo e fondatore di Vector Wealth Management.
particolarmente costosi a causa del prezzo di produzione, spesso influenzato da una dinamica precisa: un rapporto ha stimato che gli errori nelle catene di approvvigionamento possono comportare costi fino al 20% dell’importo finale del prodotto. L’idea originale di Schneider era quella di creare un marketplace B2B, per aiutare le aziende a procurarsi ingredienti e altri prodotti o servizi per lo sviluppo dei farmaci. Dopo un po’ di tempo, però, la start up si è orientata verso ciò su cui si concentra oggi, capendo che è una modalità più strategica: «La sfida non era tanto trovare i fornitori, quanto capire se questi soddisfano i requisiti normativi e di qualità. Questa è la parte più difficile. Ottenere il prezzo giusto è solo una questione di e-mail», ha detto l’imprenditore.

valutazione è “significativamente più alta” rispetto ai 100 milioni della precedente valutazione post-money.
La start up, in particolare, ha creato un team di esperti di garanzia della qualità e un ampio database (con annesse tecnologie per l’analisi dei dati) di fornitori e acquirenti, con la finalità di aiutare le aziende a monitorare la catena di fornitura e la sua conformità agli standard del settore. Questi sono molto frammentati e vengono rappresentati da una giungla
Gli investitori sono stati sicuramente attratti dal portafoglio clienti, che comprende nomi del calibro di Merck, Moehs, Siegfried, CordenPharma, Cipla, Sun Pharmaceuticals e Sandoz, solo per fare alcuni esempi.
Qualifyze punta a diventare un partner imprescindibile per le aziende del settore, aiutandole sempre più a ottimizzare la propria attività. Schneider, inoltre, ha ricordato che i farmaci possono essere
Il mercato globale della logistica farmaceutica è stato valutato, da Grand View Research, a 92,18 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che crescerà a un Cagr del 9,3% dal 2024 al 2030. La pandemia ha impattato fortemente sul settore. Le catene di fornitura dei biocomponenti e dei prodotti farmaceutici sono particolarmente soggette ai rischi associati all’adulterazione dei prodotti durante il trasporto e alla non conformità con le normative. Di conseguenza, gli operatori stanno investendo molte risorse per potenziare questo segmento fondamentale del loro ciclo operativo. E Qualifyze si sta adoperando per sfruttare questo trend.







Un’immagine di successo
Finanza e Wealth Management investono molto in un’immagine impeccabile ma spesso trascurano quella online, che però è l’essenziale e strategica estensione dell’identità aziendale.

Recita il noto proverbio, “L’abito non fa il monaco”, ma nell’era digitale, possiamo davvero permetterci di crederci ancora? Pensiamo ai dettagli maniacali, volutamente stereotipati, di alcuni cult cinematografici: dalla carta dei biglietti da visita con filigrana di Patrick Bateman alle sedute sartoriali di Gordon Gekko. Ogni elemento dell’immagine è studiato per trasmettere un messaggio chiaro: “Gestisco grandi quantità di denaro, e la mia immagine deve riflettere questa responsabilità per ispirare fiducia”.
Ahimè, oggi non basta più limitarsi all’immagine offline. Una comunicazione omnicanale ben curata è il vero biglietto da visita.
Non si tratta di mera estetica. Ogni dettaglio influisce direttamente sull’esperienza del cliente. Diversamente da un bell’abito, infatti, il digitale offre strumenti per migliorare processi, misurare risultati e raggiungere i clienti in modo mirato.
Spesso, l’attenzione si concentra sull’offerta di servizi di alto livello, sulla cura
dei processi interni e sulla professionalità. Tuttavia, se la comunicazione digitale non è all’altezza, questa dissonanza può creare una percezione negativa.
Molti operatori si sentono al sicuro con una clientela consolidata, composta da persone che hanno accumulato capitali nel tempo. Ma non bisogna dimenticare i clienti di domani, individui che oggi potrebbero non rientrare nei parametri del wealth management, ma che in futuro ne saranno i protagonisti. Queste generazioni parlano digitale, ed è lì che vanno intercettate.
Inoltre, se ben sfruttata, un’immagine digitale curata ha implicazioni estremamente funzionali. Un sito web non è solo una vetrina elegante, ma anche uno strumento che, se progettato con intelligenza, può semplificare i processi interni, ottimizzare la comunicazione con i clienti e rendere accessibili i servizi in modo più efficace.
Trascurare questi aspetti significa inviare un chiaro segnale di disinteresse verso le nuove generazioni di clienti, che invece andrebbero coltivate fin da ora. La cura

Florian Anderhub, fondatore e Chief Vision Officer di Ander Group. Uffici in centro con vista panoramica, abiti sartoriali, cura del dettaglio non bastano più per trasmettere un’immagine di professionalità e successo: una strategia omnicanale è il nuovo biglietto da visita e un potente strumento di sviluppo.
dei processi, il rigore con cui vengono seguiti e la qualità del servizio offerto devono trovare una naturale estensione all’esterno, attraverso una comunicazione efficace e funzionale.
È tempo per le aziende del settore finanziario di rivedere cosa significano davvero “qualità” e “immagine”. La dimensione analogica, per quanto raffinata, non può più essere l’unico parametro. Oggi, la comunicazione digitale è la vera estensione dell’identità e l’opportunità perfetta per mettere in luce i propri valori. Gordon Gekko non avrebbe mai sottovalutato il modo in cui si presentava, perché ogni dettaglio conta. Allo stesso modo, trascurare la comunicazione digitale è come presentarsi a un incontro con una giacca stropicciata. Un chiaro segnale di disattenzione.
È il momento di interrogarsi. La propria presenza digitale riflette davvero la qualità dei servizi offerti? Ogni dettaglio del tuo sito, dei tuoi social e dei tuoi canali online non solo trasmette l’immagine che desideri, ma rende anche più semplice e immediato l’accesso ai tuoi servizi?
In fondo, mentre un bell’abito resta legato all’estetica, il digitale può diventare lo strumento più potente. Pensaci bene, la prossima volta che il sarto ti prenderà le misure.
Wealth Solutions. Simply Beautiful.
Siamo la banca svizzera privata ed indipendente con un unico obiettivo: permettere ai nostri clienti di crescere, realizzarsi e prosperare.


Una parità che moltiplica
Appianare le disuguaglianze di genere sussistenti nel mondo del lavoro è essenziale anche per liberare un potenziale inespresso e affrontare le sfide di un’economia moderna e dinamica.
Pur essendo un principio cardine della nostra società contemporanea, l’uguaglianza di genere ha radici in un lungo e complesso percorso di lotta e cambiamento. Dalla seconda metà del XX secolo si sono ottenuti progressi significativi nella riduzione delle disuguaglianze tra uomini e donne. Tuttavia persistono numerose sfide, soprattutto nel mondo del lavoro. In molti settori le professioni continuano a essere influenzate da stereotipi di genere che tendono a valorizzare ruoli tradizionalmente maschili, lasciando in secondo piano quelli femminili. Malgrado le donne costituiscano una parte fondamentale della forza lavoro globale, esse continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e nei ruoli che offrono maggior prestigio sociale e retributivo.
I movimenti sociali degli ultimi decenni hanno contribuito a portare alla luce le disparità presenti nel mondo lavorativo, ponendo pressione su governi e aziende affinché adottassero misure concrete per correggere queste ingiustizie. Le statistiche mostrano però una rappresentanza femminile in crescita, ma a un ritmo ancora insoddisfacente.
Molte donne, soprattutto dopo la nascita dei figli, scelgono di interrompere temporaneamente la propria carriera, mentre la maggior parte degli uomini continua senza pause. Questa disparità riflette la diffusa percezione che la cura dei figli e le responsabilità familiari siano principalmente compito delle madri, piuttosto che un impegno condiviso da entrambi i genitori. Di conseguenza, le donne affrontano maggiori difficoltà nel conciliare gli impegni lavorativi e familiari, con un impatto negativo sulle loro opportunità di crescita professionale e retributiva.
La struttura gerarchica di genere si manifesta anche nel diritto del lavoro, con importanti ripercussioni economiche. Nel 2020, il divario salariale era del 18%, di cui il 47,8% non giustificato da fattori oggettivi come il ruolo professionale o il livello di istruzione. Inoltre, le donne che rientrano nel mercato del lavoro dopo una pausa, in particolare le madri, vedono ridotte le opportunità di avanzamento e subiscono un calo del salario del 3,2% per ogni anno di assenza.
Per risolvere queste disuguaglianze, sono state adottate diverse misure legali. L’articolo 8 della Costituzione federale ha stabilito il principio di uguaglianza, ma
«L’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro non è solo una questione di giustizia sociale, ma anche di progresso collettivo»
da solo non è riuscito a eliminare completamente il divario salariale tra uomini e donne. Per questo motivo, nel 1995 è stata introdotta la Legge federale sulla parità dei sessi, ulteriormente rafforzata nel 2020 con l’obbligo per le aziende con più di cento dipendenti di condurre analisi periodiche sulla parità salariale. Nonostante ciò, i risultati iniziali delle analisi si sono rivelati limitati, poiché solo l’1% dei datori di lavoro soggetti a questo obbligo rappresenta circa il 45% della forza lavoro svizzera. Nelle piccole aziende, non soggette a tali obblighi, il divario salariale inspiegato è spesso più elevato.
Le quote di genere rappresentano un’altra misura volta a garantire una rap-

presentanza equa delle donne in diversi settori, tra cui istruzione, lavoro e politica. Sebbene siano state oggetto di critiche per il loro potenziale di favorire la selezione basata sul genere, è fondamentale chiarire che le quote vengono applicate solo in caso di pari qualifiche tra uomini e donne. Non si tratta di discriminare gli uomini, ma di correggere squilibri storici e garantire pari opportunità.
L’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro non è solo una questione di giustizia sociale, ma anche di progresso collettivo. Garantire pari opportunità a tutti, indipendentemente dal genere, non significa solo abbattere barriere, ma anche liberare un potenziale umano inespresso, essenziale per affrontare le sfide di un’economia moderna e dinamica. Ogni passo verso la parità non è solo una vittoria per le donne, ma per l’intera società, che si arricchisce di talenti, idee e prospettive diverse. Sebbene il percorso verso una vera uguaglianza sia ancora costellato di ostacoli, è innegabile che il cambiamento è in atto. Le leggi, i movimenti sociali e le nuove generazioni stanno plasmando un futuro in cui la diversità non sarà più vista come un’eccezione, ma come un valore centrale. Tuttavia, è imperativo che il dibattito resti vivo e che la sensibilizzazione prosegua. Solo attraverso un impegno collettivo e continuo potremo davvero superare gli ultimi ostacoli rimasti e costruire una società più equa per tutti. Guardando al domani, possiamo immaginare un mondo del lavoro in cui il talento, la passione e la competenza conteranno più del genere.
Rancate (Mendrisio), Cantone Ticino, Svizzera

(1815-1884)
Carlo Bossoli
Pittore giramondo tra le corti reali e il magico Oriente
20 ottobre 2024 - 23 febbraio 2025
Investire nell’alberghiero

Dopo stagioni di risultati brillanti, la forza del franco poteva lasciar presagire una contrazione per il turismo in Svizzera, sia domestico - complice anche la voglia di cambiare orizzonte dopo gli anni in cui le restrizioni pandemiche hanno imposto di scegliere destinazioni in casa - sia estero. Ma la ben maggior pressione inflazionistica fuori confine ha sostenuto la domanda, frenando al contempo le partenze degli svizzeri verso lidi più lontani. Così, dopo il record del 2023 con 41,8 milioni di pernottamenti registrati - circa 3,5 milioni in più del 2022 e quasi 2,2 milioni del 2019 - l’industria alberghiera ha buone ragioni di puntare a superarsi nuovamente quest’anno, mirando a sfondare la soglia dei 43 milioni. Se la statistica parla di notti, letti o camere, gli alberghi - dal 5 stelle superior al BnB, dalla grande catena internazionale all’hotel de charme - sono prima di tutto immobili. Per una volta può dunque essere interessante leggere i dati del settore valutandone l’impatto sul real estate. «Proprio come il mercato immobiliare svizzero nel suo complesso nel 2023 è stato caratterizzato da prezzi relativamente stabili, ma allo stesso tempo da un numero significativamente inferiore di transazioni, anche nel segmento al-
Investimenti come quello di Six Senses a Crans-Montana (sopra) o il Mandarin Oriental Savoy di Zurigo, inaugurati nel 2023 - nuovo anno da record per il turismo svizzero - confermano l’attrattività del mercato per i grandi gruppi alberghieri internazionali.
Evoluzione dei pernottamenti
Evoluzione dei pernottamenti, 2014-2023, Ticino e Svizzera (indice 2014=100)
Dal 5 stelle superior al city hotel, gli alberghi sono prima di tutto immobili.
Un’alternativa per investire nel real estate commerciale, che in Svizzera incontra l’evoluzione favorevole del turismo, in particolare premiato dalla clientela internazionale. Fondamentale un’offerta che sappia rispondere le nuove esigenze.
giunta al terzo taglio, favorendo insieme al rallentamento dell’inflazione risultati operativi migliori», osserva Andrea Boschetti, manager di Wüest Partner, che con il suo Hospitality Report monitora l’andamento di questo specifico segmento. Complessivamente il valore di mercato di tutte le proprietà alberghiere svizzere si attesta a 33,1 miliardi di franchi. I prezzi più alti si registrano nella regione di Zurigo (288mila franchi; +2,8%), seguita da Ginevra (277mila; +0,4%), Canton Vaud (262mila; +0,4%) e la regione di Berna (227mila; +3,2%), mentre in Ticino ci si colloca su 207mila (+0,5%).
berghiero si è osservato un forte calo del volume di operazioni. Il contesto di mercato suggerisce però che presto tornerà a crescere. Oltre all’elevato numero di pernottamenti e all’aumento delle tariffe delle camere, dovrebbe concorrere anche la riduzione dei tassi di interesse operata dalla Bns sin da marzo e ora
Con una crescita del 2%, l’andamento dei pernottamenti del primo semestre di quest’anno conferma il momento positivo per il turismo in Svizzera, in particolare con un incremento dei visitatori stranieri del 4,7%, che controbilancia la lieve contrazione degli ospiti indigeni (-0,6%). «Malgrado l’anno scorso i valori delle proprietà alberghiere svizzere non abbiano ancora beneficiato dello slancio turistico, a differenza del mercato delle seconde case (condomini: +6,6%, case unifamiliari: +10,0%), proprio in questi mesi dovrebbe tornare a registrarsi un leggero aumento, indicativo del rinnovato interesse per gli hotel come proprietà d’investimento», precisa Andrea Boschetti.
Il convegno annuale che Wüest Partner organizza a settembre a Lugano, è stata l’occasione per proporre un focus sulle prospettive del segmento Hospitality, con un affondo anche sul mercato ticinese per cui il settore turistico riveste particolare peso. In controtendenza rispetto alla norma che lo vede recepire con un certo ritardo i trend nazionali, il Ticino sta questa volta precedendo la fase di normalizzazione dopo l’eccezionale 2021 e il buonissimo 2022, complice anche la penalizzazione della chiusura del tunnel ferroviario del Gottardo cui, nella prima parte di quest’anno si è aggiunta una meteorologia inclemente. «Nonostante questa flessione, nel 2023 le cifre sono rimaste al di sopra dei livelli prepandemici. Anche l’offerta alberghiera ticinese è leggermente cresciuta rispetto al 2019, dello 0,4%(Svizzera: +2,8%), dimostrando resilienza, ed è stabile a livello strutturale, costituita soprattutto da strutture relativamente piccole, con dimensioni costanti dal 2014», illustra Delia Dabaghi, Senior Consultant di Wüest Partner specializzata nel settore Hospitality.
Se su scala nazionale la media di camere per struttura, attualmente a 33, sta aumentando, complice lo sbarco anche di catene internazionali, in Ticino si scende a 23/24. Ciò non esclude un buon dinamismo, in particolare nella regione Lago Maggiore e valli, dove questo hanno già aperto le loro porte il nuovo Seven Town House Boutique Hotel del Gruppo Seven in centro a Locarno, che abbina ospitalità e gastronomia haute de gamme; un progetto della catena Hampton by Hilton all’ex Agie a Losone, che offre un’oasi del relax con un centinaio di camere; il Resort&Spa del gruppo tedesco Dorint sul sedime dell’ex Polivideo a Riazzino; in attesa della rinascita, nel 2026, di un’icona della storia alberghiera ticinese, il Grand Hotel Locarno di Muralto, al centro del grande progetto di ristrutturazione e sviluppo affidato ad Artisa Group. Mentre nel Mendrisiotto si sperimentano formati alternativi come l’hotel diffuso del Monte Generoso, cui si è aggiunta di recente l’apertura della capanna Alpe di Caviano, per ora rimane più statico il Luganese - che per servire i suoi convegni avrebbe però bisogno di nuove strutture e concetti - dominato dal prestigio dei suoi storici Grand Hotel, che non escludono però qualche nuova iniziativa, come il B5 Boutique Hotel Lugano, che introduce un
«Malgrado, a differenza delle seconde case, lo scorso anno i valori delle proprietà alberghiere svizzere non abbiano ancora beneficiato dello slancio turistico, dovrebbe ora tornare a registrarsi un leggero aumento, indicativo del rinnovato interesse per gli hotel come proprietà d’investimento»
Andrea Boschetti, Manager di Wüest Partner

Performance delle regioni turistiche nel 2023 vs 2022
Variazione % numero pernottamenti 23 vs 22 e % occupazione camere 2023, area cerchio proporzionale alle notti 2023
Variazione n. pernottamenti 23 vs. 22 Aumento Calo
Regione Berna Vallese
Regione Zurigo CH Orientale
Regione Basilea Argovia e Regione Soletta
Giura e Tre Laghi Regione Froborgo
Fonte: UST
Valore di mercato per camera in migliaia Chf, per regione turistica a giugno 2024
Provenienza degli ospiti in %, Svizzera (anello esterno) e Ticino (anello interno),2023
Fonte: Wüest Partner
innovativo concetto di soggiorno sostenibile, abbinato allo stile cosmopolita degli interni in collaborazione con Nordisk Lugano e opere d’arte di talenti locali e internazionali, curate da Galleria Doppia V. Intercettare i trend futuri. Per capire dove sia più interessante investire in strutture ricettive e quali siano i concetti più redditizi da sviluppare, sia attraverso ammodernamenti e ristrutturazioni dell’esistente, sia con progetti ex novo,
Nell’insieme il valore di mercato delle proprietà alberghiere svizzere si attesta a 33,1 miliardi di franchi. A beneficiare nel 2023 del nuovo record di pernottamenti, soprattutto i centri urbani di Zurigo e Ginevra, dove si registrano anche i valori più elevati per camera. Crescono in particolare gli ospiti stranieri provenienti da mercati lontani, Usa e Asia in testa. Essenziale investire per incontrarne le preferenze.

è fondamentale prevedere quali saranno le destinazioni più richieste, la tipologia di clientela e l’evoluzione di abitudini e preferenze.
«Su scala nazionale, nel 2023 ad aver registrato la più forte crescita media dei pernottamenti, pari al 12-17%, sono state le regioni turistiche dell’area metropolitana, cui ha corrisposto anche un marcato incremento dei prezzi delle camere, circa dell’8%. Centri urbani come Zurigo e Ginevra continuano a registrare i tassi di occupazione più elevati, ma si può prevedere che la tendenza, dovuta anche alla ripresa ritardata nel postpandemia, sia destinata a stabilizzarsi nel prossimo anno», commenta Andrea Boschetti.
«Il turismo del benessere è in crescita esponenziale e numerosi attori del settore stanno rispondendo rapidamente alla domanda. Non solo incontra la sensibilità dei turisti, ma a livello strategico ha il potenziale di allungare la stagione»
Delia Dabaghi, Senior Consultant di Wüest Partner
Se i pernottamenti domestici sono rimasti pressoché invariati rispetto all’anno precedente (-1,1%), oltre il 20% in più è stato registrato da ospiti provenienti dall’estero. Stati Uniti (3,1 milioni, +33%) e Regno Unito (1,7 milioni di pernottamenti, +24%) hanno segnato la crescita relativa più elevata. Significativo anche l’incremento di arrivi dall’Asia: Cina (0,5 milioni, +314%), Corea del Sud (0,4 milioni, +151%), India (0,6 milioni, +59%), Giappone (0,2 milioni, +130%).
«In Ticino, dove prevalgono come sempre gli ospiti locali (63% nel 2023), i turisti stranieri sono comunque tornati ai livelli prepandemici, Germania in testa, includendo un numero crescente di
arrivi da mercati lontani, con un peso crescente dei turisti statunitensi che con le loro caratteristiche presentano un potenziale particolarmente interessante per l’industria: altospendenti, prenotano con largo anticipo e optano per soggiorni più lunghi», sottolinea Delia Dabaghi.
Accanto alle sfide cui il settore è chiamato a rispondere, tra cui la carenza di personale qualificato e le insicurezze globali e politiche, non mancano le opportunità da cogliere, con un forte potenziale di ottimizzazione su diversi livelli: se la sostenibilità spadroneggia anche qui, imponendo di allineare l’offerta ai valori della clientela che si orienta sempre più su strutture alberghiere che rispondano a criteri Esg, gli altri due pilastri sono la digitalizzazione - una sfida non solo per le realtà più piccole, ma anche per quelle storiche che devono aggiornare la loro infrastruttura e i sistemi gestionali - e il wellness. «Il turismo del benessere è in esponenziale crescita e numerosi attori del settore stanno rispondendo rapidamente alla domanda. Non solo incontra la sensibilità dei turisti, che dalla pandemia in poi hanno sviluppato una maggior attenzione sui temi della salute e della cura di sé, ma a livello strategico ha il potenziale di allungare la stagione. Lo vediamo nelle località alpine, con Grand Hotel storici e nuovi nomi che sempre più svi-
Il sostegno della Società svizzera di credito alberghiero

Con sede a Zurigo, la Società svizzera di credito alberghiero (Sca) si occupa dell’attuazione della promozione dell’industria alberghiera per conto della Confederazione, con lo scopo di preservarne e migliorarne la competitività e la sostenibilità economica. Come società cooperativa conta 640 membri: Confederazione, banche, cantoni, comuni e i vari rappresentanti del settore turistico e alberghiero. «Ci focalizziamo su alberghi di piccole e medie dimensioni, in regioni turistiche sottoposte alle maggiori fluttuazioni stagionali. I destinatari dei nostri prestiti sono aziende del settore competitive, con una sana situazione di reddito, alle quali prestiti subordinati con tassi convenienti permettono di colmare le lacune tra fondi propri, finanziamenti bancari e altre fonti di finanziamento. Valutando le prospettive di reddito, possiamo concedere prestiti
superiori ai limiti applicati dalle banche, a tasso agevolato, con ammortamento a 15-20 anni», spiega Peter Gloor (in foto), direttore della Sca. Dopo il calo di domande di cofinanziamento nel 2023, con 18,4 milioni di franchi di prestiti concessi, la richiesta è tornata ad aumentare nel primo trimestre del 2024. «Nel 2023 i buoni risultati operativi degli ultimi anni hanno permesso a molte aziende di finanziare autonomamente i propri investimenti. In secondo luogo, c’è ancora molta liquidità dagli anni precedenti e le banche commerciali hanno una visione positiva dei finanziamenti nel settore. Quest’anno riteniamo che i tassi di interesse nuovamente favorevoli avranno un impatto positivo sulle decisioni di investimento. Continueremo a monitorare da vicino gli sviluppi della situazione di rischio, per indirizzare il nostro sostegno verso aziende e progetti commercialmente validi e non incoraggiare il mantenimento delle strutture», anticipa Peter Gloor. Nell’ambito dei servizi di consulenza, oltre ai mandati tradizionali, l’attenzione della Sca continuerà a concentrarsi sulle questioni più complesse relative alla legislazione sulle seconde case e alle valutazioni aziendali.
luppano l’offerta Spa e trattamenti, si può prendere l’esempio del gruppo Six Senses che l’anno scorso ha aperto a Crans-Montana un nuovo hotel allo stato dell’arte», conclude Delia Dabaghi.
Riposizionamenti strategici. Il settore alberghiero ha dunque diverse opportunità per gestire al meglio le attuali sfide e garantire un’offerta mirata approfittando delle emergenti tendenze, rendendolo un settore molto interessante anche dal punto di vista degli investimenti immobiliari. Lo conferma l’esperienza di un attore di primissimo piano dell’immobiliare svizzero, leader del segmento commerciale, Psp Swiss Property. Nel suo prestigioso portafoglio da 9,7 miliardi di franchi, tutte proprietà collocate nel cuore dei centri economici svizzeri, Zurigo e Ginevra in prima linea (75% del valore del portafoglio), seguite da Berna, Losanna e Basilea, trovano spazio anche alcuni progetti a destinazione alberghiera. «I nostri 157 immobili sono principalmente a uso ufficio e commerciale, in zone centralissime caratterizzate da un mercato del lavoro molto forte, con la presenza di importanti sedi di società di diversi settori. Accanto a retail e ristorazione di alta gamma, vediamo nei city hotel un’ulteriore alternativa per portare valore aggiunto alle nostre microlocation, offrendo un servizio in più ai nostri ‘inquilini’ e alla clientela che li raggiunge in visita. Al di fuori di questo contesto molto specifico, non siamo però attivi nel segmento hospitality e, anche a livello contrattuale, non entriamo nell’operatività dei gruppi che gestiscono le strutture, stipulando contratti di lunga durata molto simili a quelli dell’immobile per uffici», spiega Giacomo Balzarini, Ceo di Psp Swiss Property. Così, ad esempio, il recentissimo acquisto, quest’estate, per 58 milioni di franchi, dell’immobile storico, nel cuore del Quartier des Banques ginevrino, di proprietà di Edmond de Rothschild è stato accompagnato già in sede di transazione dall’elaborazione di un’opzione di sviluppo insieme a un operatore alberghiero per poterlo attuare dopo la partenza della banca, che rimarrà come affittuaria fino al giugno 2026. Un riposizionamento destinato a rendere ancor più interessante
«Accanto a retail e ristorazione di alta gamma, vediamo nei city hotel un’ulteriore alternativa per portare valore aggiunto ai nostri prestigiosi immobili di uffici nei principali centri economici svizzeri, offrendo un servizio complementare ai nostri “inquilini” e alla clientela che li raggiunge in visita»
Giacomo Balzarini, Ceo PSP Swiss Property



questo quartiere per Psp Swiss Property, che qui possiede già altri cinque immobili. Ovviamente la ridestinazione d’uso richiede un alto investimento iniziale per convertire gli spazi di quelli che in origine sono per lo più stabili di uffici nella sintassi di camere e servizi tipica di un hotel - ma anche aree comuni, sempre più importanti - e per aggiornarne la dotazione tecnologica. Gli immobili che entrano nel
Dal prestigioso portafoglio di Psp in location centralissime, due esempi innovativi di conversione di immobili commerciali in alberghi che sono andati ad arricchire e diversificare la sua offerta. Sopra, il gruppo olandese CitizenM a Ginevra ha reinterpretato un tipico edificio da uffici con il suo concetto di “affordable luxury”. Accanto, il gruppo tedesco Ruby Hotels & Resorts ha portato la sua esclusività all’avanguardia e contemporanea nel meraviglioso edificio Belle Époque a Zurigo che ospitava un cinema.
portafoglio di Psp Swiss Property sono infatti molto spesso edifici d’epoca, il che offre sì un valore aggiunto e grande charme alla location, ma impone anche un lavoro di concerto con la Protezione dei Beni culturali e il rispetto di precisi parametri sugli interventi. Ma con quale prospettiva di ritorno? «La reddittività può essere superiore a quella già ottima del nostro prime office; in certi casi e a
seconda della location fra il 5 e il 10% superiore ai precedenti affitti, risultati che riusciamo ad assicurare grazie ai nostri interventi di ristrutturazione. Più difficile da quantificare, ma innegabile, l’impatto positivo sulle nostre altre proprietà vicine. Inoltre un significativo vantaggio è la lunga durata di questa tipologia di contratti, tipicamente di 20-25 anni, a condizioni fisse, cui si aggiunge un extra in base al fatturato. Solitamente, rispetto alle stime iniziali, constatiamo un netto incremento dei prezzi delle camere. Gli operatori dei city hotel, che si sono molto sviluppati negli ultimi anni, sono in grado di ottenere una maggiore marginalità rispetto all’hôtellerie tradizionale, sia perché utilizzano strutture modulari e flessibili, sia riuscendo a limitare la necessità di personale grazie all’automazione, ad esempio con le procedure di self check-in/ out. L’importante, per affrontare le oscillazioni cui il segmento hospitality può essere soggetto, come ha ricordato la pandemia colpendo in particolare il turismo dei centri urbani e business, è orientarsi verso partner solidi, in grado di compensare le fluttuazioni, e che puntino su un concetto forte», precisa il Ceo di Psp.
Dunque nuove formule, contemporanee, di hospitality, improntate a un lusso accessibile, molto apprezzato dalla clientela business internazionale e dalle nuove generazioni, esigenti ma attente ai costi: posizione privilegiata con ottimi collegamenti con i trasporti pubblici, design moderno, alta tecnologia, ...

Sopra, uno dei primi incontri di Psp con l’hospitality, sul suo sito Hürlimann a Zurigo, che oltre alla più grande sede R&D di Google fuori dagli Usa, sfrutta la sorgente sotterranea una volta impiegata per la produzione di birra per un’originale Resort&Spa.

Sopra, la prestigiosa sede di Edmond de Rothschild nel Quartier des Banques ginevrino, appena acquista da Psp, potrebbe diventare un hotel. Sotto, la fotovoltaica Grosspeter Tower, sempre di Psp, presso la stazione di Basilea ospita anche un Ibis hotel.

per la produzione della birra, un unicum nel centro di Zurigo, per farne una Spa. Congiuntamente Turicum Lifestyle Hospitality Management ha sviluppato il concetto “B2 - boutique e bookmark hotel” (il fulcro è una biblioteca di 33mila volumi sulla storia della birra): 60 camere arredate in modo elegante e funzionale, integrando pezzi di design ed elementi industrial chic originali per offrire una “urban sleeping experience”.
«Non tutti gli edifici sono però idonei. Un caso esemplare è il nostro immobile in Rue du Marché 40, a Ginevra: posizione centralissima, ottimamente collegato, con una struttura che si prestava alla perfezione a ospitare delle camere di hotel, basta guardare dall’esterno la facciata scandita da tante finestre ravvicinate: un candidato ideale per la filosofia di ‘affordable luxury’ del gruppo olandese CitizenM, che nel 2020 ha aperto qui un concept hotel con 144 camere», esemplifica Giacomo Balzarini.
Ci sono progetti ancor più originali, come una fra i primi incontri di Psp con l’hospitality, l’Hotel B2 sul suo sito Hürlimann a Zurigo. Un tempo ospitava il più grande birrificio in Svizzera, oggi la più grande sede R&D di Google fuori dagli Stati Uniti. Si è deciso di sfruttare la sorgente termale una volta impiegata
«Guardiamo con interesse anche a un’altra declinazione dell’hospitality, i serviced apartments, che costituiscono sempre una forma di utilizzo commerciale dell’immobile ma proponendo una versione di ‘extend hotel’, ideale per le esigenze della clientela business metropolitana. In particolare, stiamo approfondendo la parnership con City Pop di Artisa Group, che con il suo concetto abitativo innovativo propone appartamenti completamente arredati, funzionali e confortevoli, spazi comuni appositamente progettati e una vasta gamma di servizi aggiuntivi, nelle zone più strategiche della città, proprio come quelle che noi possiamo offrire. Ad esempio, a Basilea, nella zona della stazione dove già siamo presenti con la Grosspeter Tower e un Ibis Hotel, metà di un nuovo palazzo che stiamo ristrutturando diventerà un City pop e seguirà poi Berna», anticipa il Ceo. Fondamentale l’attenzione alla sostenibilità, già implicita nell’ubicazione centrale degli immobili di Psp Swiss Property, che permettono di rinunciare all’auto. Per il suo intero portafoglio, si impegna inoltre nella preservazione delle risorse e nella riduzione al minimo delle emissioni di CO2 durante l’intero ciclo di vita degli edifici, puntando sulle fonti rinnovabili per i sistemi energetici e gli impianti di condizionamento e riscaldamento, sulla flessibilità d’uso, così come su un inserimento nel tessuto urbano che possa generare valore economico e sociale. Una vocazione, quest’ultima, che l’industria dell’ospitalità porta nel suo Dna.
Susanna
Cattaneo
Approach life’s adventures with peace of mind
Keep your pension on track as you transition to new life chapters. Whether you are between jobs, going on a sabbatical or becoming self-employed, our wealth expertise is here to guide you.
Our vested benefits solutions protect you against coverage gaps and let you choose your investment strategy.

Let’s talk about your pension
Un taglio che rinvigorisce
Non c’è il due senza il tre. Con la terza riduzione dell’anno del tasso guida della Bns, proprietari di immobili, investitori, acquirenti e il settore delle costruzioni potrebbero ritrovare lo slancio.
Un’ulteriore riduzione del tasso ipotecario di riferimento all’orizzonte? in %; previsione Ubs da settembre 2024
Tasso ipotecario di riferimento Previsione evoluzione tasso ipotecario di riferimento Tasso guida Previsione evoluzione tasso guida
Fonte: Ufab, UBS
Come ampiamente previsto, il 26 settembre la Bns ha nuovamente abbassato il tasso guida di 25 punti base, portandolo all’1,0%, in seguito al forte calo dell’inflazione e alla necessità di contrastare la forza del franco. E se scendono i tassi, torna a salire l’attrattiva del mattone.
Poiché di solito seguono nella stessa misura l’andamento del tasso di base, le ipoteche Saron dovrebbero a loro volta alleggerirsi di 25 punti base. Il taglio è invece già stato prezzato dai mutui a tasso fisso, per cui non si aspettano dunque ulteriori correzioni. Le ipoteche decennali sono attualmente tornate così basse da rappresentare l’opzione di finanziamento più vantaggiosa e così dovrebbe restare nel corso del prossimo anno.
Se in primavera l’acquisto era ancora meno conveniente dell’affitto, la situazione sembra destinata a ribaltarsi e tornare a premiare la proprietà. Entro la fine dell’anno, prevediamo uno sconto sugli immobili di oltre il 10%, dovuto sia al calo dei costi di finanziamento, sia al fatto che gli affitti stiano aumentando più rapidamente dei prezzi degli immobili residen-
12.2023: 1,75
03.2025: 1,50 06/2026
ziali. Ciononostante, nel 2025 i prezzi delle case dovrebbero salire leggermente più di quest’anno, del 3,5%. Probabilmente saranno le unifamiliari a beneficiare del calo dei tassi in misura maggiore. Diverso il trend per gli appartamenti di vacanza e il segmento di lusso, che reagiscono meno fortemente alle variazioni dei tassi, poiché il rapporto ipoteca/valore è solitamente più basso. Sulla scia di una domanda generalmente più vivace per le case occupate dai proprietari, l’anno prossimo gli aumenti dei prezzi di questi due segmenti saranno probabilmente un po’ più bassi rispetto al mercato generale. Gli investimenti buy-to-let rimangono per contro costosi rispetto agli standard storici, a fronte di rendimenti iniziali bassi. Tuttavia, l’aumento dei redditi da locazione e la riduzione dei costi di finanziamento stanno aumentando i rendimenti del capitale proprio. Inoltre, le aspettative di guadagno in conto capitale stanno crescendo grazie al calo dei tassi d’interesse, il che dovrebbe essere di stimolo.
Tenuto conto anche della prospettiva di ulteriori riduzioni per garantire la stabilità dei prezzi nel medio-lungo termine,

Claudio Saputelli, Cio Global Real Estate Ubs Global Wealth Management. Il tasso ipotecario di riferimento dovrebbe riscendere entro marzo 2025, ma rallenterà solo leggermente l’aumento degli affitti. Intanto, la proprietà sta tornando più interessante della locazione.
è probabile che anche il tasso ipotecario di riferimento scenda nuovamente, al più tardi entro marzo 2025, all’1,5%, per poi stabilizzarsi almeno fino alla fine del 2026. Indipendentemente dall’andamento dei tassi d’interesse, nel 2025 gli affitti richiesti dovrebbero però aumentare ancora in modo significativo, del 3%, mantenendo elevati anche i canoni degli immobili residenziali esistenti (poco meno del 2%, rispetto al 3% di quest’anno).
Per quanto riguarda il mercato delle transazioni per gli immobili d’investimento, è probabile che nei prossimi trimestri i prezzi dei condomini incrementino di una percentuale a una cifra. L’andamento sarà infatti guidato dall’aumento degli affitti e non dai tassi. Tuttavia, ci aspettiamo una netta ripresa delle transazioni e una maggiore domanda da parte degli istituzionali. Riducendo i costi di gestione delle società immobiliari, i mutui più favorevoli avranno anche un effetto positivo sulle distribuzioni degli investimenti immobiliari quotati. Anche i tassi d’interesse più bassi sostengono le valutazioni immobiliari. Ciò dovrebbe favorire la domanda di titoli immobiliari in borsa. Ciononostante, visti i numerosi aumenti di capitale, soprattutto nei titoli di fondi immobiliari, è probabile che i prezzi dei titoli salgano solo leggermente entro la fine dell’anno.

TECHNOGYM RUN
L‘esperienza di allenamento che apre la strada a un futuro più sano.
Lafe e Italia, reciprocità
Gli svizzeri che acquistano un immobile in Italia devono essere consapevoli che la condizione di reciprocità dell’ordinamento giuridico italiano comporta un’applicazione speculare della Lafe.
Il mercato immobiliare italiano - in particolare nelle regioni balneariha recentemente attirato un numero crescente di investitori stranieri, inclusi cittadini svizzeri. Tuttavia, molti di questi ultimi - anche gli stessi notai italiani - spesso ignorano come oltre alle leggi italiane applicabili sia altresì indispensabile rispettare una specifica normativa svizzera: la Lafe. In vigore dall’inizio degli anni ’60 per evitare l’eccessivo dominio straniero del suolo indigeno, questa normativa, nota anche come Lex Koller, limita l’acquisto di fondi in Svizzera da parte di persone all’estero, imponendo un obbligo di autorizzazione per l’acquisto (diretto o indiretto) di determinati beni immobili, in primis di carattere residenziale.
Oltre al territorio elvetico, la Lafe trova un’applicazione indiretta - ovvero ‘speculare’ - nell’ordinamento giuridico italiano che, segnatamente all’art. 16 delle “Disposizioni sulla legge in generale” (Preleggi) del Codice civile italiano, sancisce il cosiddetto principio di reciprocità.
La valutazione in merito alle restrizioni Lafe applicabili indirettamente a un cittadino svizzero non residente in Italia nell’acquisto di un bene immobile in Italia incombe in primis al notaio italiano incaricato della formalizzazione dell’atto di compravendita immobiliare. La prassi, tuttavia, insegna come ai notai italiani - perlomeno quelli non attivi nelle regioni confinanti con la Svizzera - non sia sempre nota la suddetta applicazione per reciprocità della Lafe.
Ai sensi di un’interpretazione puramente svizzera della Lafe, le violazioni a tale normativa comportano conseguenze di carattere amministrativo, civilistico e - in caso di atto intenzionale o negligenzapenale. Da evidenziare l’art. 26 Lafe, se-
condo cui i negozi giuridici (segnatamente contratti) concernenti un acquisto immobiliare in Svizzera soggetto ad autorizzazione sono nulli se perfezionati in assenza di tale autorizzazione. Di conseguenza, un atto notarile italiano riguardante l’acquisto di un bene immobile nella Penisola da parte di un cittadino svizzero non residente in Italia risulta nullo (o quanto meno inefficace), qualora avvenga in violazione ‘speculare’ della Lafe. Il notaio italiano che ha allestito un simile atto è inoltre passibile di responsabilità professionale.
Esemplificativa, a riguardo, è una sentenza del Tribunale di Vicenza del 18 maggio 2022, nella quale la corte, oltre a dichiarare nullo l’acquisto immobiliare effettuato da una cittadina svizzera in Italia in violazione delle disposizioni della Lafe, ha perfino condannato il notaio alla restituzione degli onorari ricevuti. La richiesta delle parti di condannare il notaio al risarcimento di ulteriori danni non è invece stata accolta dalla corte.
La sentenza mostra, una volta di più, l’importanza per tutte le parti coinvolte di conoscere la portata della Lafe, le sue restrizioni nonché l’applicazione giurisprudenziale della stessa. A tal fine, il Ministero degli Affari Esteri italiano ha pubblicato sul proprio portale una lista di fattispecie di acquisti immobiliaricon specifico riferimento alla Svizzera e all’applicazione della Lafe - per i quali la condizione di reciprocità è data.
Da evidenziare come tale lista sia in parte vaga e poco esplicita. Ad esempio, si limita a elencare alcune fattispecie in cui l’acquisto in Svizzera da parte di un cittadino italiano sarebbe in linea di principio permesso (ad esempio, l’acquisto di abitazioni di vacanza nella misura in cui la superfice non superi una determinata

Rocco Rigozzi, avvocato, LL.M. e notaio, partner dello Studio Bär & Karrer (a Zurigo e Lugano), specializzato in transazioni immobiliari e corporate/ M&A, autore del presente contributo insieme all’Avv. Andrea Ziswiler, LL.M, partner Studio Bär & Karrer (Lugano), specializzato in operazioni di finanziamento, mercato dei capitali e transazioni corporate/M&A.
metratura), mancando tuttavia di esplicitare tutta una serie di condizioni e oneri a cui un siffatto acquisto in Svizzera sarebbe nondimeno sottoposto. In caso di acquisto di abitazioni di vacanza, l’autorità svizzera impone infatti, tra i possibili oneri, il divieto di cedere in locazione durevole tale abitazione e il divieto di rivendere l’abitazione nei cinque anni successivi. Inoltre, sebbene la Lafe sia una normativa federale, la sua applicazione spetta alle autorità cantonali, le cui prassi divergono di volta in volta anche in modo piuttosto rilevante. A titolo esemplificativo, alcuni cantoni (in particolar modo il Ticino, i Grigioni e il Vallese) hanno sviluppato particolari sensibilità in determinate fattispecie soggette a possibili abusi di legge. Rimane quindi in parte difficile capire se, e in quale misura, le specifiche problematiche della Lafe trovino applicazione in Italia. In particolar modo, non è (ancora) stato chiarito se il principio di reciprocità richieda un’applicazione letterale e integrale della Lafe, così come della relativa giurisprudenza svizzera. Risulta quindi opportuno che il potenziale acquirente e il notaio italiano coinvolti in una transazione approfondiscano la problematica presso un legale attivo in Svizzera specializzato in materia di diritto immobiliare.
Trading Investments
Il futuro si costruisce sulle Materie Prime.
Scegli il Partner giusto per gli investimenti, scegli Kommodities Partners.









Higold Headquarters: primo progetto architettonico di Pininfarina in Cina, che lo ha interamente curato, landscape incluso, esprimendo l’identità dell’azienda di arredo con un complesso elegante e iconico - 2017

Creare una bellezza senza tempo, ma consapevole delle sfide del presente. Forte delle straordinarie competenze in tecnica e design maturate nel settore automobilistico, Pininfarina si è ritrovata in pole position per trasporle anche in architettura. Portando visione, dinamismo e iconicità nel settore immobiliare.

All’interno degli HQ di Higold, elementi architettonici e prodotti in esposizione si integrano in modo unitario.
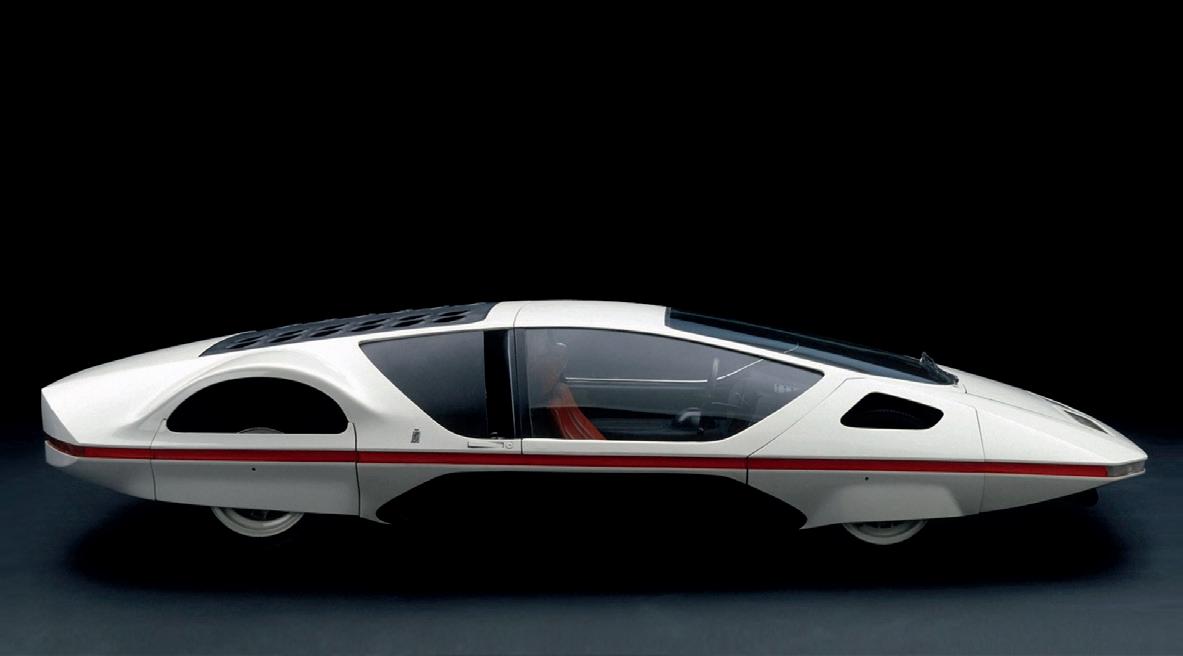
Le audaci forme dell’insuperabile e premiatissima Ferrari 512 S Pininfarina Modulo, 1970: un capolavoro avveniristico per due brand uniti dall’iconicità.
La lezione iconica dell’automotive
Le automobili che ha progettato hanno dato forme fra le più belle alla velocità, facendone uno dei nomi internazionalmente più apprezzati di un ‘made in Italy’ in grado di coniugare estetica e tecnica ai massimi livelli. Dopo l’iniziale specializzazione nella concezione e costruzione artigianale di carrozzerie di lusso per una facoltosa clientela di famiglie regnanti europee e personalità internazionali, cruciale per la sintesi fra bellezza e prestazioni è stato l’incontro fra le sue competenze in design e la potenza dei motori di Ferrari. Pininfarina è così diventato un brand tanto iconico da ricevere, nel 1961, l’autorizzazione del
Presidente della Repubblica a farne anche il cognome della famiglia, integrando all’originario ‘Farina’ il soprannome del fondatore Giambattista, ‘Pinin’. E se proprio a lui, sin dalle origini nel 1930 a Torino, va il merito di aver intuito come l’automobile sarebbe diventata il vettore irrinunciabile della mobilità quotidiana, due generazioni dopo, a inizio anni Duemila, è stato il nipote Andrea, poi seguito dal fratello Paolo, a capire come fosse giunto il momento di trasporre in altri settori il know-how e il prestigio acquisiti nell’automotive. «Un passaggio compiuto anche da tante altre case automobilistiche, ma noi, ragionando da sempre in una logica di co-branding, lo abbiamo fatto
con un approccio molto più libero di chi è solitamente focalizzato sulla propria produzione interna», sottolinea Giovanni de Niederhäusern, Senior Vice President di Pininfarina Architecture & Product Design. In una ventina di anni il settore Architettura ha conosciuto un rapido sviluppo e oggi vale il 20% del fatturato da 90,4 milioni di euro del Gruppo, con un team dedicato di circa 120 tra architetti, designer e ingegneri, sede principale a Torino, cui si affiancano Milano, Miami, New York e Shanghai. Una presenza su tre continenti che negli ultimi 5 anni ha permesso di crescere a un Cagr fra il 25% e il 40%, gestendo anche i contraccolpi della pandemia.
«Provenendo da uno studio di architettura legato a nome e cognome del suo fondatore, al mio ingresso in Pininfarina, nel 2019, mi chiedevo se il branded real estate potesse funzionare altrettanto bene, come poi è stato. Credo infatti che oggi il mercato sia più attento al valore dell’edificio, al di là del fatto che porti la firma di un’archistar. Inoltre, è un approccio che funziona molto bene anche dal punto di vista organizzativo: la libertà lasciata dai nostri nove direttori creativi ai loro team, adottando la logica orizzontale tipica dell’automotive, incontra la visione delle nuove generazioni di talenti che vogliono avere un impatto concreto nel e con il loro lavoro, senza essere vincolati a idee calate dall’alto», sottolinea Giovanni de Niederhäusern.
Nato circa una decina di anni fa negli Stati Uniti, il mondo del branded real estate è poi approdato sui mercati emergenti di Sud America e Cina, e oggi è molto presente anche nel Middle East e in mercati maturi come l’Europa, dove ad esempio Pininfarina sta lavorando al suo primo progetto brandizzato nel mondo non-hôtellier in Italia. «La value proposition che ci pone fra i leader dei branded buildings residenziali - primo marchio italiano e secondo al mondo - è che, a differenza dei nostri competitor che sono principalmente gruppi del fashion o nomi dell’industria del lusso che supervisionano il progetto ma ne danno il design in licenza a uno studio di architettura o design esterno, noi avendo in casa queste competenze, cuore stesso della nostra progettualità, siamo in grado di garantire la piena coerenza dei risultati con i valori identitari della nostra visione», osserva il Senior Vice President di Pininfarina Architecture & Product Design.
Tipicamente si tratta di edifici residenziali alti - per elevazione, high-rise, e per posizionamento high-end - particolarmente richiesti dal mercato sudamericano e mediorientale, dove Pininfarina è sinonimo di eccellenza dell’italianità, della qualità, del design. «Lì gli sviluppatori immobiliari vedono in una partnership con Pininfarina non solo la possibilità di costruire edifici dal design e dall’architettura veramente particolari ma, al contempo, di costruirsi una nuova immagine, proprio perchée questo connubio è un unicum che ci contraddistingue - oltre a essere noi un marchio iconico, grazie alle nostre com-
«La value proposition che ci pone fra i leader dei branded buildings residenziali - primo marchio italiano e secondo al mondo - è che avendo in casa le competenze di design e tecnica, da sempre al cuore della nostra progettualità nell’automotive, siamo in grado di garantire la piena coerenza dei risultati con la nostra visione»
Giovanni de Niederhäusern Senior Vice President di Pininfarina Architecture & Product Design
petenze cross settoriali siamo in grado di aiutare i clienti nella definizione della loro identità, dei loro prodotti e della customer experience, supportandoli anche a livello di marketing nella fase di go-tomarket, tanto che non di rado già durante la costruzione vengono venduti tutti gli appartamenti», evidenzia Giovanni de Niederhäusern.
Nei mercati più maturi, dove si esce dalle rigide logiche di zonizzazione dei quartieri residenziali prediligendo invece una pianificazione mixed use, i progetti di Pininfarina includono spesso anche una componente di retail e aree pubbliche. Al contempo, in Europa come negli Stati Uniti dove il marchio è comunemente associato all’automotive, il brand viene interpellato anche per disegnare infrastrutture, ad esempio la Torre di controllo dell’aeroporto di Istanbul o, prossimo all’inaugurazione, un circuito per auto sportive, clubhouse inclusa, negli Usa. «Inoltre, capita ormai con crescente frequenza che gli architetti

siano chiamati a progettare stabilimenti industriali o strutture ospedaliere. Ci si è resi infatti conto di quanto la qualità dello spazio influisca sulla motivazione e sulla salute di chi vi lavora. Inoltre, si vuole comunicare un messaggio all’esterno, considerato come sia sempre più importante soddisfare gli obiettivi del framework Esg, tanto che questa sensibilità sta facendo breccia persino tra i grandi player della logistica che hanno sempre lesinato sui costi di costruzione, ridotti a poche centinaia di euro a metro quadro. Ma ora che stanno entrando anche nelle aree periurbane e urbane, diventa imperativo impegnarsi nella beautification delle strutture», rileva Giovanni de Niederhäusern. Una sensibilità che Pininfarina respira sin dalle sue origini, radicata nella cultura di un territorio dove Olivetti, oltre all’innovazione tecnica e sociale della sua visione, ha trovato negli stabilimenti di Zanuso un sistema proprio pensato secondo questa logica, e sempre a Torino Pier Luigi Nervi ha

L’innovativo design creato da Pininfarina per la torre di controllo dell’Istanbul Grand Airport, coniuga influenze dall’aviazione e dall’automotive con un forte segno architettonico - 2015

Il rivoluzionario Urban Lounge, a Milano, uno spazio pubblico responsivo per sconfiggere il cambiamento climatico.
La struttura è in fibra di plastica riciclata e riciclabile, stampata in 3D per modellarne le linee fluide, integrandole con l’ambiente naturale - 2021

lavorato sul principio della prefabbricazione strutturale portando l’attenzione all’estetica anche nel contesto industriale.
In particolare, in architettura Pininfarina ha trasposto la metodologia del Design for manufacturing and assembly (Dfma) tipica dell’automotive, dove per controllare tempi, costi e assicurare la continuità della qualità, si punta sulla semplicità di fabbricazione delle componenti e sull’efficienza dell’assemblaggio, individuando tutte le possibili ottimizzazioni di processo ancor prima di far partire la catena di produzione. «Analogamente, oggi quando si realizza un edificio si cerca di minimizzare le attività di cantiere, che sono quella più complesse, più rischiose, meno controllabili, massimizzando la produzione dei componenti da remoto e la costruzione a secco», spiega Giovanni de Niederhäusern. L’edificio viene sempre più visto come un prodotto, il che aiuta a progettare in un’ottica di Life Cycle Assessment, prevedendone
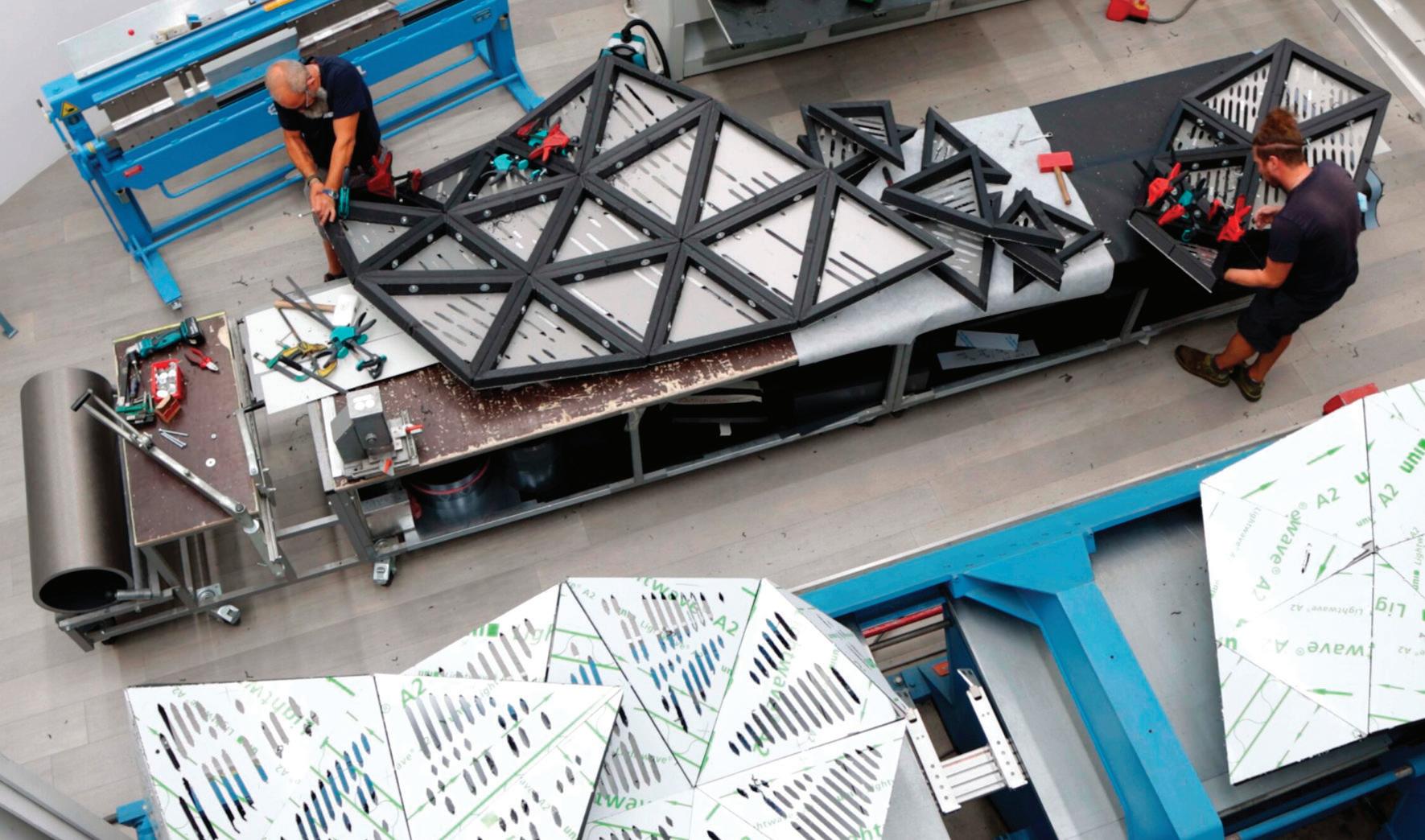
ogni trasformazione, fino allo smantellamento. «E se fino a qualche anno fa si puntava a una vita utile di cento anni - spesso persino superata dal parco immobiliare - oggi, soprattutto in regioni come il Middle East, soggette a cambiamenti sociali ed economici molto rapidi, ci viene chiesto di pensare agli edifici con una vita utile di 40 anni», aggiunge il Senior Vice President di Pininfarina Architecture & Design Product.
Prodotto sì, ma organico, vivo. Che, nel residenziale, significa responsivo alle esigenze dei suoi utenti, in particolare grazie alla sensoristica. Qui si esplica un’altra analogia essenziale fra edificio e auto, entrambi sempre più tecnologici: tanto che, se una quindicina di anni fa, l’impiantistica rappresentava il 15-20% del costo finale di un immobile, oggi arriva a pesare anche la metà. Fondamentale, dunque, l’apporto degli ingegneri di un brand abituato a lavorare alla frontiera dell’innovazione, basti pensare che già nel 1978 Pininfarina si cimentava con la sua prima vettura elettrica.
‘Vivo’ lo è anche lo stabile industriale, al quale è richiesto di seguire i mutamenti dei processi di produzione che ormai, già nell’arco di 5-10 anni, possono determinare una riconfigurazione degli spazi.
Pininfarina ha curato la direzione artistica del masterplan di sviluppo dei 20 ettari della comunità di Aldea Uh May (Messico), unendo maestria del design e uso innovativo della tecnologia per un modello di vita consapevole - 2022

Specularmente, anche il mondo dell’architettura ha iniziato a ispirarsi all’automotive, ad esempio per riuscire a realizzare forme fluide, ambiziose e complesse, proprio come quelle delle curvature delle auto di Pininfa -
rina. Prodezze che i processi tipici del car design possono aiutare a realizzare senza gravare ulteriormente sui costi già in esplosione delle costruzioni in Europa e Usa.
«Uno dei trend più interessanti è quello dell’additive manufacturing, che riusciamo ad applicare anche a materiali come cemento e acciaio, per componenti da integrare nell’involucro dell’edificio incrementandone la sostenibilità e ottenendo effetti nuovi, più vibranti, impensabili solo fino a qualche anno fa per costi, energia necessaria e ostacoli tecnici. In particolare, stiamo sviluppando questo filone insieme al Politecnico di Milano con cui abbiamo avviato un dottorato industriale, una formula di collaborazione fra università e imprese che, sul modello anglosassone, permette una reale integrazione fra produzione, progettazione e ricerca, ma ancora è poco praticata in Italia», specifica Giovanni de Niederhäusern.
In un’ottica invece di trasferimento culturale, Pininfarina non poteva che aderire all’iniziativa Cofactory Designtech, di recente inaugurata a Milano, promossa da Rimas per favorire la trasformazione di una filiera ancora tradizionalista come quella delle costruzioni, creando un ecosistema di aziende, scale- e start up che possano confrontarsi e sperimentare tecnologie di prototipazione rapida e produzione digitale in un laboratorio urbano.
Se la progettazione dell’edificio è il core del settore Architettura, i servizi spaziano dal design di prodotto - prevalentemente arredo - all’interior design, dalle infrastrutture alla pianificazione urbana. Se quest’ultima ormai non ha più nell’auto il link imprescindibile fra gli edifici, grazie all’esperienza maturata

Fluide, evolute ed eleganti, le inconfondibili linee e i dinamici volumi di Pininfarina a servizio del car design e dell’architettura di alta gamma.

in quasi un secolo di attività confrontandosi praticamente con qualsiasi mezzo di trasporto - dai monopattini elettrici agli aerei - e forte delle competenze multidisciplinari derivanti dai numerosi ambiti di applicazione del suo design, Pininfarina ha l’ampiezza di visione necessaria per progettare masterplan innovativi, che rispondano al cambiamento di paradigma di mobilità e sostenibilità.
Anche in futuro, l’intenzione è di mantenere la diversificazione di mercati che ha permesso di affrontare con flessibilità i cambiamenti improvvisi degli ultimi anni, con la chiusura di mercati come Russia o Cina, quest’ultima ostica anche dopo la riapertura, sia per il crollo di diversi importanti sviluppatori immobiliari, sia più in generale per il minor interesse ad acquistare design dall’estero. «Abbiamo ancora qualche importante progetto in ambito retail, che in Cina resta il più dinamico, ma da una parte le ormai ottime competenze di progettazione che si è portata in casa, dall’altra il trend emergente del luxury shame, stanno chiudendo le porte ai brand occidentali. Nel Middle East invece stiamo lavorando molto bene, con grandi complessi residenziali a Dubai, Abu Dhabi e Ras Al Qaim. Il Sud America, in

particolare Messico e Brasile, rimane il mercato più costante e che dà le maggiori soddisfazioni, ma abbiamo anche progetti interessanti in Europa, soprattutto in Costa del Sol, la Miami europea che sta attraendo molti investitori e residenti, e delle chicche come la riqualificazione di due ex vetrerie a Murano con destinazione principalmente residenziale. L’intenzione è di guardare anche più a Nord, a partire dalla Germania siamo già presenti a Monaco e Stoccarda per l’automotive, ma anche verso Francia e Svizzera», anticipa Senior Vice President di Pininfarina Architecture & Product Design. Non può mancare una presenza in India, uno sbocco naturale considerato

Adottando la logica orizzontale tipica dell’automotive, i direttori creativi del settore Architettura lasciano grande libertà di apporto personale ai talenti dei loro team.
Heritage by Pininfarina, secondo progetto a San Paolo insieme al costruttore Cyrela, che si posiziona così come riferimento del residenziale di fascia alta - 2019
come dal 2016 Mahindra Group sia l’azionista di maggioranza di Pininfarina, che mantiene però un management ampiamente italiano ed europeo.
A sintetizzare la formula vincente del settore Architettura di Pininfarina, un’eloquente equazione: “bellezza + tecnologia = impatto”, che esplicita come per il brand la cura di aspetti intangibili come quelli estetici non perda mai di vista la fattibilità e il benessere dell’utente, proprio come insegna la lezione dell’automotive. Allo stesso modo, la tecnologia diventa una risorsa sia in fase di progettazione, sia integrata all’edificio per creare un’esperienza unica e multisensoriale di interazione fra spazio e persone, determinante per la qualità del prodotto finale. «Insieme, bellezza e tecnologia devono generare un impatto positivo, con la consapevolezza che l’edificio zero energy, sostenibile a livello ambientale, non basta più: altrettanto fondamentale è l’impatto sociale, la possibilità di migliorare la vita non solo di chi in questi edifici di alto standing vivrà, ma anche dei contesti in cui si inseriscono, restituendo qualcosa alle comunità locali, ad esempio creando aree aperte al pubblico, zone verdi o servizi accessibili a esterni, così come valorizzandone le eccellenze creative con il coinvolgimento di maestranze, artigiani e artisti locali», conclude il Senior Vice President di Pininfarina Architecture & Design. Un branded real estate che unisce capacità concrete e valori intangibili, portando al settore immobiliare quel dinamismo progettuale di cui ha grande necessità per ripensarsi e svilupparsi, in nuove forme e dimensioni.
Susanna Cattaneo
Comuni che si distinguono
Fra i criteri determinanti per l’attrattività di un comune, cruciale il suo mercato immobiliare, oltre a tassazione, sicurezza, trasporti e sostenibilità. Un mix ben interpretato dalla Svizzera centrale.
Paesaggio da cartolina - spazi verdi idilliaci, affascinanti case padronali e ville imponenti - ma anche tassazione favorevole: sembra essere la combinazione vincente che ha portato per la seconda volta dal 2018 il comune di Meggen, sulla Goldküste della Svizzera centrale, in vetta al ranking stilato dalla Handelszeitung analizzando un migliaio di comuni svizzeri da oltre 2 mila abitanti insieme alla società zurighese di consulenza immobiliare Iazi. La top ten è presidiata dalla Svizzera tedesca: il Canton Lucerna con Meggen e Oberkirch si porta a casa oro e bronzo, l’argento va al nidvaldese Hergiswil. Se il comune di Zugo è quarto, Zurigo scivola dal 45mo al 54mo gradino e precipitano addirittura Basilea, dal 93mo al 486mo, e Berna dal 199mo al 491mo. Una magra consolazione per un Ticino che fa capolino solo alla 145ma posizione con la Collina d’Oro, mentre Riviera e Biasca si piazzano nella coda delle dieci peggiori. Ma quali parametri vengono utilizzati per costruire il palmarès? Risponde Matteo Molteni, esperto immobiliare di Iazi. Quali criteri prendete in considerazione per valutare l’attrattività dei comuni nel modo più oggettivo possibile?
Utilizziamo 51 indicatori individuali raggruppati in 8 categorie: abitazioni e immobili, mercato del lavoro, struttura della popolazione, pressione fiscale, mobilità e trasporti, offerta di servizi, sicurezza, ed ecologia. Questi indicatori hanno ponderazioni diverse e includono dati come i prezzi degli immobili, il tasso di disoccupazione, la crescita della popolazione e l’accessibilità ai trasporti pubblici. I dati provengono da varie fonti ufficiali come l’Ust el ’Afs, ma anche dai modelli di prezzo degli immobili di Iazi.
Negli anni sono emersi nuovi fattori?
In questi ultimi anni la sostenibilità è diventata un tema centrale, portando all’introduzione di nuovi parametri come l’efficienza energetica del parco immobiliare e la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Molti criteri fondamentali sono tuttavia rimasti costanti, come la sicurezza, disponibilità di posti di lavoro e mercato immobiliare. È proprio quest’ultimo uno degli indicatori più importanti per la classifica - l’attrattività di un comune o di una particolare località è indirettamente riflessa nei prezzi degli immobili.

I primi qualificati sono comuni di ville riservati a una popolazione facoltosa e a stranieri altospendenti?
Non sempre. Sebbene comuni come Zugo o Küsnacht siano noti per il loro alto tenore di vita e bassa imposizione fiscale, non attraggono solo facoltosi e stranieri ma anche famiglie del ceto medio grazie all’offerta e qualità dei servizi.
La Svizzera centrale dà lezione; quali sono i suoi punti di forza?
Cantoni come Lucerna, Svitto, Zugo e Zurigo offrono una combinazione vincente di bassa imposizione fiscale, accessibilità e un mercato immobiliare dinamico, con nuove costruzioni e un basso tasso di sfitto, sinonimo di domanda elevata. In

Sopra, Matteo Molteni, esperto immobiliare della società di consulenza Iazi. Nel 2024, in vetta al ranking dei comuni svizzeri più attrattivi stilato con la Handelszeitung si è piazzato Meggen (LU). Sotto, il suo castello.
confronto, il Ticino ha una disoccupazione leggermente più elevata e una crescita economica più lenta, come dimostra l’evoluzione demografica sostanzialmente piatta negli ultimi anni.
Quali criticità dovrebbero risolvere i comuni ticinesi per qualificarsi meglio? Negli ultimi anni i comuni ticinesi hanno registrato un leggero peggioramento nel ranking. Tra le principali criticità ci sono la difficoltà di attrarre nuove imprese, la crescita economica lenta e un leggero eccesso di offerta di abitazioni rispetto ad altre regioni. Dovrebbero concentrarsi sull’ampliamento della mobilità, creare un ambiente più favorevole per le imprese e attirare nuovi residenti, in particolare giovani in cerca di una prima occupazione. In sintesi, dal comune di Meggen alla Val-de-Travers che Svizzera fotografa il vostro ranking?
Il ranking del 2024 descrive una Svizzera con forti differenze regionali. Comuni come Meggen eccellono per qualità della vita grazie a bassa pressione fiscale, servizi di alto livello e un mercato immobiliare dinamico. In altri comuni, anche in Ticino, l’offerta è più limitata in termini di servizi e di trasporti. Tuttavia, se si è felici dove si vive e l’unico ristorante del paese è anche quello dove ci si trova meglio, questo ranking basato su dati statistici non rispecchierà la percezione dei residenti.
Achille Barni

regionale
Ben attrezzate e ottimiste sul futuro finanza /analisi
Dopo aver dimostrato un’invidiabile resilienza di fronte alle sfide degli ultimi anni, le Pmi svizzere guardano con crescente fiducia al loro sviluppo economico. Un futuro di cui farà sempre più parte l’Ia e in cui fondamentali restano le relazioni con un partner commerciale come l’Ue.
Dopo anni turbolenti segnati dalla pandemia, da tendenze inflazionistiche, impennate dei prezzi di materie prime ed energia e dal rapido progresso tecnologico, quest’anno le Pmi svizzere tornano a essere più ottimiste. Il 69% delle aziende intervistate nell’edizione 2024 della Ricerca sulle Pmi di Raiffeisen valuta infatti da buona a molto buona la propria situazione economica e solo il 3% la definisce negativa o molto negativa.
L’umore positivo si riflette anche nelle aspettative finanziarie per l’anno in corso. Come il precedente, un po’ più dell’80% delle Pmi prevede un fatturato in crescita o almeno invariato.
Secondo la ricerca, le questioni finanziarie e valutarie sono diventate meno rilevanti e non sono considerate un rischio dalla maggior parte delle aziende. «In particolare le Pmi più piccole operano principalmente in Svizzera e spesso hanno una bassa percentuale di finanziamenti bancari, e quindi un elevato grado di autofinanziamento», spiega Goran Juric, Responsabile Clientela aziendale Ticino di Raiffeisen Svizzera.
Il focus del sondaggio di quest’anno si concentra sull’intelligenza artificiale. Le
Evoluzione dei prezzi, sicurezza informatica e dei dati, sviluppi geopolitici e trend tecnologici sono i fattori che più pesano sull’andamento economico delle Pmi svizzere. Alla politica si richiede in prima battuta, come ormai da sei anni, di porre su una solida base i rapporti con l’Unione europea.
Quale importanza hanno i seguenti fattori sullo
sviluppo economico della sua azienda?
Valori percentuali, più risposte possibili Elevata Ridotta Var. annuale
Andamento dei prezzi / Inflazione
Sicurezza informatica e dei dati
Fonte: Ricerca PMI Svizzera – Come stanno le PMI svizzere?
20 -6,7%
Quali tre temi principali dovrebbe affrontare la politica nei prossimi dodici mesi?
Valori percentuali, più risposte possibili
Fonte: Ricerca PMI Svizzera – Come stanno le PMI svizzere?
Tenere il polso delle Pmi
La Ricerca sulle Pmi viene condotta dal 2018 ogni anno e misura il polso delle piccole e medie imprese svizzere. Nella primavera del 2024, l’associazione swiss export e la società di consulenza Kearney hanno condotto per la settima volta un sondaggio tra le Pmi svizzere. Raiffeisen partecipa come partner per la quinta volta, mentre il Gruppo Kistler si è aggiunto quest’anno quale partner industriale temporaneo. Al sondaggio online hanno partecipato oltre 600 aziende presenti in Svizzera.
potenzialità prospettate, trasformando metodi di lavoro e processi, di aumentare produttività ed efficienza impongono anche alle Pmi svizzere di entrare in materia tempestivamente per capire quali siano le opportunità e i rischi per la propria azienda, dove effettuare investimenti mirati e come creare valore aggiunto.
Le risposte raccolte mostrano che l’uso è ancora limitato. Sebbene circa la metà delle aziende intervistate ne riconosca le opportunità, solo il 9% circa la impiega attualmente in modo sistematico. La riluttanza è giustificata soprattutto dall’insufficienza o dalla mancanza di know-how nell’individuazione e nell’implementazione, nonché dalla scarsa conoscenza delle possibili applicazioni.
Spesso ci si concentra dunque ancora su applicazioni semplici, evitando le più complesse. L’uso più diffuso è infatti risultato essere quello per la creazione e la modifica di immagini (23%), seguito dalla conversione di audio in testi (20%), dall’utilizzo nelle banche dati delle conoscenze interne (19%) e dal marketing personalizzato (18%). Queste applicazioni sono spesso integrate in strumenti digitali molto diffusi, come i prodotti Microsoft per l’elaborazione di testi o i prodotti Adobe per il design. Nel campo del marketing personalizzato esistono anche numerosi programmi di Crm con funzionalità di Ia integrate. Poco diffuse invece le applicazioni a compiti più complessi, come l’analisi dei dati finanziari o la produzione.
«Nonostante le sfide, però, molte Pmi stanno esaminando attivamente il tema e prevedono una maggiore adozione di Ia in futuro, come integrazione e non come sostituzione dell’intelligenza o della manodopera umana. Sebbene l’Ia sia destinata infatti a cambiare significativamente il loro modo di lavorare e interagire con la clientela, solo il 23% ipotizza quale conseguenza una riduzione dei posti di lavoro», rileva Juric.
Le aziende più grandi tendono a fare da apripista, anche perché possono fronteggiare più facilmente gli investimenti necessari. Fra i benefici che più interessano, soprattutto il notevole potenziale di aumento della produttività e dell’efficienza attraverso l’automazione dei processi, mentre non si confida nel fatto che la tecnologia possa davvero fornire un maggiore supporto nel processo decisionale o che migliori la qualità del lavoro.
«Nonostante le sfide, molte Pmi svizzere stanno esaminando attivamente il tema dell’intelligenza artificiale e ne prevedono una maggiore adozione in futuro, come integrazione e non come sostituzione dell’intelligenza o della manodopera umana»
Goran Juric, Responsabile Clientela aziendale Ticino di Raiffeisen Svizzera

La sua azienda utilizza già l’intelligenza artificiale?
Valori percentuali
Edilizia
Industria chimica/farmaceutica
Servizi e consulenza
Elettronica, tecnologia e telecommunicazioni
Energia e infrastrutture
Settore della ristorazione/alberghiero
Commercio e distribuzione
Produzione e lavorazione
Ricerca Pmi Svizzera – Come stanno le Pmi svizzere?
Il ritmo di adozione dell’intelligenza artificiale varia notevolmente a seconda di settore e dimensioni dell’azienda, con le più grandi e più affini alla tecnologia a fare da apripista. I maggiori vantaggi potenziali sono visti nell’automazione dei processi e nel conseguente aumento di efficienza e produttività.
Guardando a un futuro più immediato, il perdurare di diverse crisi e il nuovo conflitto in Medio Oriente gettano qualche ombra. Anche gli sviluppi di politica interna e le decisioni in diversi importanti mercati di sbocco della Svizzera sono fonte di preoccupazione, ad esempio la generale spaccatura politica in diversi Paesi europei. Gli sviluppi della politica estera sono più importanti per le aziende più grandi, con un fatturato superiore ai 10 milioni di franchi (49%) che per le più piccole (38%). «Ciò non sorprende in quanto queste ultime in genere hanno una minore attività di esportazione», ag-
Per niente Con singoli progetti pilota
In modo sistematico in tutta l’azienda
60 36 3
7 71 21
39 49 12
15 62 23
52 39 9
73 27 0
41 57 1
28 66 6
Quali vantaggi offre l’Ia?
Valori %, selezione top 3
Automazione di attività e processi 47
efficienza e produttività 37
semplificata 33
velocità 32 Riduzione del margine di errore 26 Nuove competenze e modelli business 18
Miglioramento qualità lavoro 17
Miglioramento qualità servizi 17 Maggiore forza innovativa 14
Miglioramento del controlling 13
Fonte: Ricerca Pmi Svizzera – Come stanno le Pmi svizzere?
giunge Goran Juric. Per la sesta volta consecutiva, la priorità assoluta è assegnata al chiarimento dei rapporti con l’Ue, il più importante partner commerciale della Svizzera. Anche la preoccupazione di ridurre la burocrazia è forte, condivisa dal 41% (38% l’anno precedente) delle aziende intervistate.
Achille Barni
Crescere, alla nostra maniera
Il mondo assicurativo sta vivendo da anni una delicata fase di trasformazione. La ricerca dell’efficienza non è priva di sacrifici, le compagnie l’hanno scoperto, a prosperare sono gli indipendenti, specie quelli della prima ora. Ecco una consolidata realtà del territorio.
Inizio attività di Carla Bernasconi (back office)
Inserimento di diversi collab. esterni
Fondazione della società
Firma accordi con tutte le assicurazioni in Svizzera
IInizio attività per Marco Petito
Trasloco nella attuale sede di Lugano
‘family business’, altrimenti detti aziende di famiglia, si confermano nei dati essere la spina dorsale dell’economia svizzera, europea e mondiale. Tutte le aziende nascono in famiglia, e non di rado vi rimangono. Eppure, cosa voglia dire ‘famiglia’ spesso non è così scontato, ed è qui che iniziano i dibattiti, senza che vi sia un’unanime concordanza nel seppellire l’ascia di guerra da parte dei più oltranzisti. Tali aziende, e su questo è facile trovare consenso, sono note per essere innovative, resilienti, in molti casi particolarmente prospere, ma soprattutto orientate a un successo che vuole essere duraturo nel tempo, in primis per una questione di buona reputazione nei confronti del resto della comunità locale, da parte della ‘famiglia’, e dei suoi membri, che di frequente sono omonimi dell’azienda. I casi sono infiniti, di ogni ordine e grado, ma soprattutto uniformi in tutti i settori nel cui sottobosco si trovano operatori piccoli e ancora agili, anche nelle industrie più mature, finanziaria e assicurativa incluse. In Svizzera, ma anche in Ticino. «Ho iniziato in qualità di apprendista a conoscere il mondo delle assicurazioni, negli anni Novanta, quando ancora esisteva la Ginevrina. Ho ricoperto molti ruoli, da quelli meno qualificati a quelli di maggiore responsabilità, in Ticino ma anche a Ginevra, e in diverse grandi compagnie, posso quindi affermare di avere assistito in prima persona a molti
Apertura nuova succursale a Mendrisio
Sottoscrizione accordi con compagnie internazionali
Digitalizzazione sistemi operativi e archivio
Potenziamento del back office con nuovi elementi
cambiamenti del settore nell’arco di oltre trent’anni, ma soprattutto ho trascorso gli ultimi 25 da dipendente, nell’azienda che ho fondato insieme a mio padre», esordisce così Vittorio Finardi, Ceo e co-fondatore di Finardi & Partners, boutique luganese specializzata nel brokeraggio assicurativo.
Non tutti i percorsi sono però altrettanto lineari, e spesso a non mancare sono proprio le sorprese. «Diversamente da Vittorio, ho iniziato nella logistica del mondo luxury, per un brand molto noto qui in Ticino. Sono però 25 anni che ormai mastico di assicurazioni ogni giorno e, dopo le prime esperienze presso i giganti del settore, tra cui Allianz, sono già da 20 in questa società, che nel corso del tempo è cresciuta, precorrendo molti dei cambiamenti che hanno poi segnato profondamente il settore. In questo il padre di Vittorio, Flavio Finardi, aveva certamente visto lungo», sottolinea Marco Petito, Socio, Direttore commerciale e responsabile acquisizioni di Finardi & Partners. Tendenze comuni ormai a moltissimi ambiti, e settori, ma che rischiano di passare sottotraccia sino al deflagrare di questo o quel problema, o sino a che un qualche evento, spesso non positivo, non inneschi una reazione. «Nei primi Duemila il mondo assicurativo veleggiava ancora in ottime acque, erano spesso anni eccezionali, con risultati economici molto importanti che spingevano a sottostimare l’impatto che avrebbero avuto alcune
Marco Petito diventa socio della società
Acquisizione di nuovi collaboratori esterni
Dipartita del Fondatore Flavio Finardi
Potenziamento back office nel ramo casse malati
‘innovazioni’ che stavano comunque avvenendo. Mio padre Flavio, per primo, aveva intuito che l’equilibrio si sarebbe sempre più spostato a favore dei broker, consulenti assicurativi terzi alle compagnie, che così facendo ne esternalizzavano i costi crescenti. Così, se all’interno delle compagnie, vent’anni fa, il rapporto tra broker e consulenti era, senza esagerare, di 10 a 90, oggi siamo passati a 65-35, e in alcuni casi si è già superato il 70-30. Le ragioni sono diverse, ma la rotta risulta ormai tracciata», riflette il Ceo.
In più d’un ambito lo si definisce ‘effetto palla di neve’. Una volta imboccata la strada è difficile tornare indietro, e sotto altri aspetti incredibilmente complicato. Sarà per questo che mai succede? «Vittorio ha impiegato più di un anno a convincermi, e dopo aver iniziato mi ci sono voluti diversi mesi per entrare in questa, all’epoca nuova, logica. È evidente che i consulenti esisteranno sempre, ma si è chiusa un’epoca, e ci troviamo in una completamente diversa. In termini di volumi i broker sono diventati fondamentali per le compagnie, il che è interessante anche per l’aspetto economico, in quanto sono agenti esterni, non dei dipendenti, che all’assicurazione non costano nulla se non una parte del fatturato che generano e i bonus contrattualizzati. Siamo del resto strutture molto più dinamiche e snelle, recettive nei confronti dei cambiamenti del mercato, e delle esigenze della clientela. L’opposto delle compagnie, molto più
ingessate e statistiche», rileva il direttore.
A essere cambiato è del resto anche il rapporto tra compagnie e clientela, con una forte accelerazione negli ultimi anni dettata dalle circostanze. «L’emergenza pandemica ha intaccato molti equilibri, e il mondo assicurativo è stato probabilmente tra i più influenzati nel lungo periodo. In termini finanziari sono stati anni costosissimi per le compagnie, che hanno reagito rivedendo e inasprendo l’intera contrattualistica, perdendo la poca flessibilità che ancora c’era. Quello che però il cliente vuole è proprio flessibilità, un servizio di qualità, sartoriale e quasi in tempo reale, ovviamente senza costi aggiuntivi e concorrenziale. E cerca una persona, un confidente che gli stringa la mano quando serve, non un anonimo servizio clienti che magari, al giorno d’oggi, viene gestito dall’intelligenza artificiale. Proprio quello che una piccola azienda familiare può offrire», nota Finardi.
Evidentemente al crescere delle dimensioni la flessibilità diventa una merce estremamente rara e costosa, come i grandi istituti bancari hanno scoperto negli ultimi anni. Dunque decisioni drastiche e draconiane, e qualche sacrificio sull’altare dell’efficienza. «I clienti sono sempre più informati, la domanda continua a crescere e l’offerta è sempre più complessa e variegata, ma soprattutto personalizzabile. Ed è noto che i sarti piacciano a tutti. Un broker è libero di fare cherry picking, discriminando per qualunque variabile sia necessario, dunque sì in termini di costo, ma anche di servizio, modularità, copertura… quello di cui necessita il cliente. C’è ovviamente un ‘ma’. La vera ricchezza di una Casa di brokeraggio è il numero di relazioni che ha con le compagnie, il numero delle controparti a cui può rivolgersi. Noi avendone ben 42 siamo a tutti gli effetti un broker, possiamo soddisfare le esigenze del nostro cliente dialogando con tutti i principali (e non) istituti, altri hanno 4-5 relazioni… è tutto diverso», sintetizza Marco Petito.
Se dunque le controparti sono la ricchezza, perché non le hanno tutti? «Nel ’99, anticipando i tempi e in controtendenza, mio padre insistette per avere relazioni con tutti i principali istituti. Oggi le compagnie non si concedono più facilmente, è oneroso per loro gestire tali relazioni, e vincolano questi contratti a molti paletti, non solo finanziari, il che limita molto i nuovi operatori. Nel corso

Il Re cliente
Evoluzione della clientela privata e aziendale dal 1999 (in unità)
Finardi & Partners
Evoluzione del fatturato
Andamento dal 2000 al 2023 (2008: 100)
di questo quarto di secolo la nostra società è stata però brava nel costruirsi una solida reputazione presso le compagnie, che hanno piacere e interesse a collaborare con noi, oltre che nei confronti della clientela. Siamo una società che cresce, e continua a farlo, ma senza scendere a compromessi su quelli che sono e rimangono i nostri valori: il cliente è il nostro re, agiamo sempre nel suo interesse; tutti i nostri clienti sono uguali, senza eccezioni
Sopra da sinistra, Vittorio Finardi, Ceo di Finardi & Partners, e Marco Petito, Socio, Direttore commerciale e responsabile acquisizioni. Sotto, i dati della crescita del broker assicurativo luganese, una piccola realtà familiare che in molti casi ha precorso le evoluzioni del settore, riuscendo a posizionarsi nel delicato comparto degli indipendenti. Una scommessa, che è stata vinta.
di alcun tipo», precisa il Ceo.
Si tratta dunque anche in questo caso di un sottile gioco di equilibri, avendo sempre in mente l’obiettivo finale: cucire un buon abito, che soddisfi tutti. «Un buon broker deve essere sufficientemente aggiornato e preparato da chiedere le offerte da presentare al cliente basate sulle compagnie più concorrenziali indirizzate alla sua specifica esigenza, pur soddisfacendola al meglio possibile. Per le compagnie preparare queste offerte è oneroso, bisogna dunque interpretare l’esigenza e raccogliere i dati necessari per andare mirati, evitando di far perdere a tutti tempo e denaro. Al cliente del resto non interessano 20 offerte, ma le migliori cinque. Da qui la nostra necessità di avere collaboratori specializzati e operosi, a livello di back office, che sono il segreto del nostro successo», enfatizza il direttore.
L’esperienza è spesso la migliore delle insegnanti, soprattutto laddove è il contatto con le persone a fare la vera differenza. Ed è noto che il punto siano sempre e solo le persone. «In tutti questi anni ho imparato ad ascoltare, senza giudicare, specie sulla base delle semplici apparenze. Per noi ogni cliente merita il massimo delle nostre capacità, che sia l’anziana signora che ha rotto lo specchietto dell’auto, che sia l’affermato imprenditore con al seguito qualche centinaio di collaboratori in temi previdenziali. È vero, la clientela istituzionale in termini finanziari è prevalente, ma vogliamo offrire a ogni singolo cliente quello che ci aspetteremmo venisse dato a noi, dunque massima disponibilità, comprensione, empatia e vicinanza, professionale ma soprattutto umana quando evidentemente le circostanze lo richiedono. Il nostro miglior alleato? Il passaparola dei nostri
clienti», mette in evidenza Finardi. Un quarto di secolo è comunque lungo da cavalcare, ma anche estremamente breve; le tappe del viaggio numerose, in positivo ma anche in negativo. «Nel 2020, durante l’emergenza pandemica, è scomparso il fondatore, Flavio Finardi. È stato un evento traumatico, come è spesso il caso in realtà piccole e familiari, ma con la forza e l’attaccamento di tutto il team siamo riusciti a superare anche questa dura prova, confermando il lavoro fatto nei vent’anni precedenti. Due anni fa abbiamo potenziato notevolmente il servizio Cassa malati, acquisendo una risorsa dedicata e con vent’anni di esperienza, che ci sta dando un’importante spinta. Siamo un team piccolo ma affiatato, appassionato del proprio lavoro e che non si risparmia pur di arrivare al risultato, ossia che il cliente risulti soddisfatto. Non possiamo sicuramente permetterci di formare giovani apprendisti, puntiamo dunque ad acquisire professionisti esperti del settore, di buona volontà e disposti a rimettersi in gioco, accettando una filosofia del lavoro un po’ particolare, estranea a molti», rileva Petito.
Indipendentemente dal settore, trascorrono gli anni, ma lo fanno per tutti e nella stessa misura, il che ha inevitabilmente una serie di conseguenze abbastanza scontate. «Certo, siamo alla ricerca attiva di nuove risorse per potenziare il back office, ma anche per ‘allevare’ una seconda generazione di consulenti, parallelamente al rallentamento fisiologico di alcune figure Senior. Abbiamo la struttura, che è la nostra forza, possiamo metterla a disposizione di delusi o scoraggiati che vogliano continuare a soddisfare i propri clienti, ma senza trascorrere le giornate a compilare scartoffie, al pari dell’inca-
Crescere in un ambito time-intensive presuppone anche acquisire nuovi collaboratori che facciano il loro.
ricarci della gestione di portafogli di un certo peso, garantendo al proprietario una parte importante dei ricavi derivanti. Non si tratta dunque di ‘acquisire’ o comprare, ma di gestire quanto ci viene consegnato, al meglio delle nostre possibilità, anche grazie alla reputazione che ci siamo conquistati», sottolinea il Ceo.
Al netto di altisonanti definizioni, qual è il ruolo di un broker? Come trascorre la giornata? «Come dicevo spesso a mio figlio, in tenera età, mi prendo cura delle persone, le supporto e gli semplifico la vita, in cambio queste mi sono riconoscenti, e lo percepisco non solo nelle parole. È la più grande delle soddisfazioni, ma anche la più grave delle responsabilità, ti puoi organizzare e gestire la giornata in piena autonomia, ma sai di non poterti mai fermare, che è il nostro più grande limite», evidenzia il direttore.
Qualcosa nel corso degli ultimi anni è però cambiato, e si riflette inevitabilmente anche sulla figura stessa dell’addetto di questa industria. «Nell’immaginario collettivo l’assicuratore non gode certamente della migliore delle reputazioni, ed è per questo che noi siamo particolarmente orgogliosi di quella che ci siamo costruiti. Non è più ormai da tempo un lavoro da cui si inizia, ma dove si approda, a patto di accettare l’idea di ‘mettersi a disposizione’ del cliente, dell’azienda, della formazione, delle autorità… la soddisfazione viene dal riuscire a risolvere problemi complessi, dal rapporto quotidiano con il cliente, dall’immedesimarsi; è gioire per quello che si è riusciti a fare, è ottenere la fiducia del cliente nel gestirlo e affiancarlo in tutte le sue pratiche assicurative quotidiane. Siamo un team di persone che vive con una passione incrollabile il proprio lavoro, come dimostrano questi 25 anni di attività», conclude Vittorio Finardi. Le somiglianze tra industria finanziaria e mondo assicurativo sono dunque più che sostanziali, al pari dell’evoluzione che stanno vivendo. In una Piazza in cerca d’autore, come quella luganese, che parte della soluzione non stia anche nel riuscire a creare sinergie sino a ieri improbabili? Del resto, il cliente è sempre lo stesso. Federico Introzzi
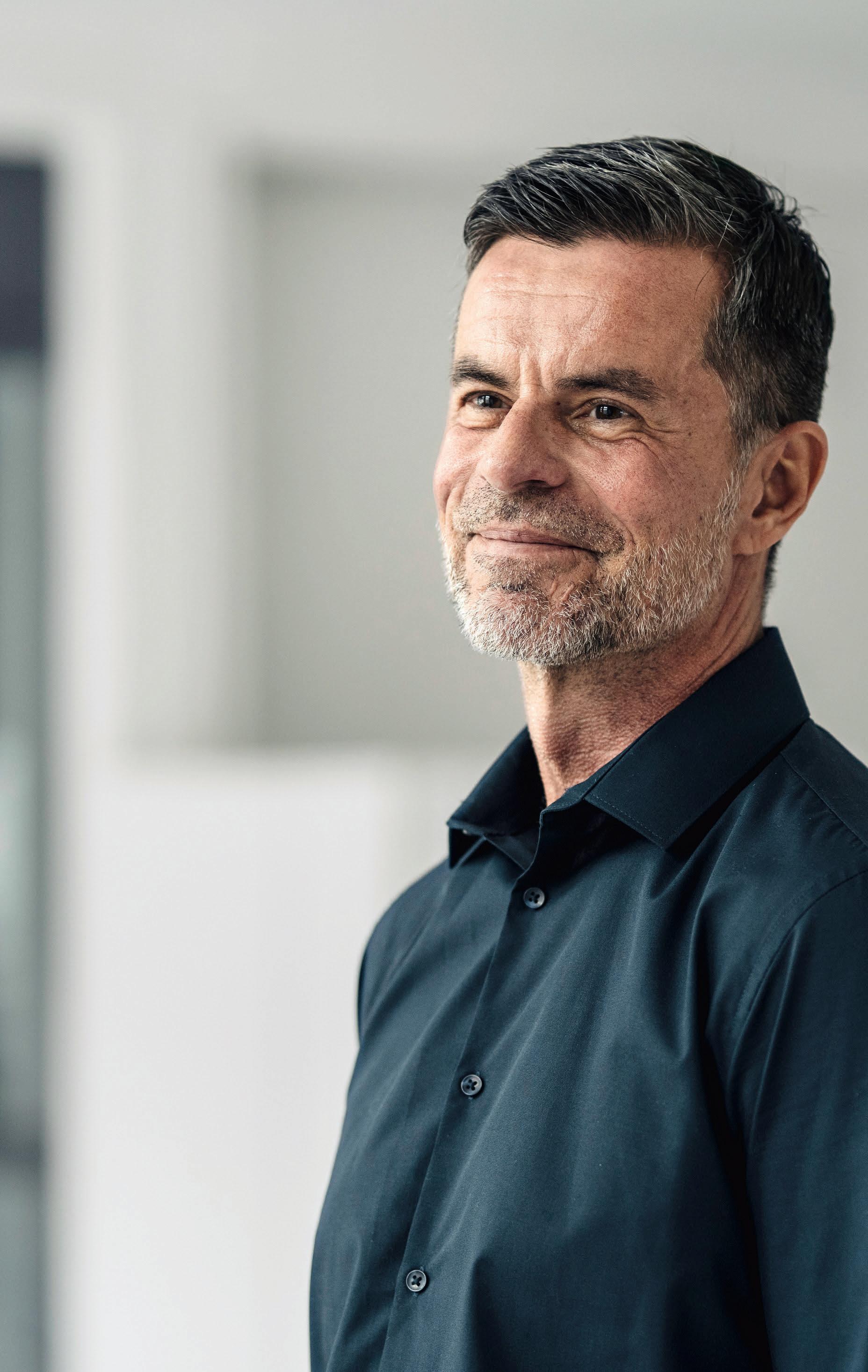
Fiduciaria statica
Sostituto d’imposta Cross Border
Adempimenti fiscali italiani per rendite AVS, 2 e 3 Pilastro, Libero Passaggio
Adempimenti fiscali italiani per investimenti esteri
rivarenofiduciaria.it
Gruppo Ferraretti Milano – Bologna
Osservatorio
Aspettando... e poi?
Il buon andamento registrato dai fondi svizzeri nel cuore dell’estate, non sconta ancora le tensioni delle settimane successive, tra politica e geopolitica sulla fiamma.
Il mercato svizzero dei fondi nel corso del mese di luglio ha visto una discreta crescita delle masse, trainata in una certa misura dal buon andamento dei mercati finanziari, intercettata dai fondi azionari e obbligazionari, e sostenuta da una buona raccolta.
Il net new money del mese di luglio si attesta infatti a 5.48 miliardi di franchi, in leggera calo rispetto alla precedenza, ma comunque indicativo della stabilità dell’industria dei fondi, e della fiducia degli investitori nella corazzata elvetica.
Se si guarda infatti in chiave più retrospettiva all’andamento del mercato dei fondi svizzero, quello che emerge è una crescita stabile e lineare delle masse gestite, nonostante le forti oscillazioni degli indici, e l’alta volatilità dell’ultimo biennio, in uscita dagli anni del ‘pilota automatico’ segnati dall’emergenza pandemica. Ecco quindi che cinque anni fa le masse si attestavano di poco sopra gli 1,204 trilioni di franchi, che tre anni, in piena pandemia avevano già raggiunto gli 1,519 trilioni, correggendo l’anno successivo a 1,408 ma tornando nel mese di luglio a 1,531 trilioni in linea dunque con i massimi toccati in precedenza.
Evidentemente questi dati non scontano la volatilità e gli attacchi di panico vissuti invece ad agosto, nello specifico l’azionario americano, e giapponese, nel timore sussurrato che il favorevole ciclo congiunturale statunitense potesse stare giungendo al termine, nonostante l’aiuto ciclopico messo in campo dal bilancio federale, ormai nell’ordine del 7% del Pil.
Quella che va aprendosi è dunque una ripartenza potenzialmente scivolosa, all’avvicinarsi del grande appuntamento di novembre, che certamente rimarcherà almeno in apparenza molto equilibri, per quanto poi nella sostanza il bilancio politico dell’amministrazione Biden è incredibilmente allineato con le decisioni prese in precedenza dal vituperato Trump.
Il mercato svizzero dei fondi (Dati Morningstar in mln di franchi)
Categoria fondi Asset
Raccolta
per Asset class (in milioni di franchi)
Osservatorio 4.0
Caro lettore,
L’Osservatorio sta infine sfondando la famosa terza dimensione, l’online, per essere sempre più completo e aderente all’evoluzione vorticosa dei mercati finanziari, tenendo il passo. Una parte dei contributi dei numerosi Partner che da anni contribuiscono alla sua ricchezza, e che molti apprezzano, inizieranno a essere web-only, specie per quelle tematiche molto più ‘liquide’. Buona meta-lettura FI
L’Angolo dell’investitore: (Technology, Automove, Luxury; Isin):
▲ Apple (US0378331005)
▲ Microsoft (US5949181045)
▲ Nvidia (US67066G1040)
▲ Porsche (DE000PAG9113)
▲ Ferrari (NL0011585146)
▲ Mercedes Benz (DE0007100000)
▲ Hermès (FR0000052292)
▲ Lvmh (FR0000121014)
Moncler (IT0004965149)
Sviluppi alternativi
Il ruolo dei mercati privati nello sviluppo di tecnologie ambientali decisive non dovrebbe essere dimenticato, è lì che si giocherà il futuro del pianeta. Oggi, e domani.
Soluzioni private
Evoluzione delle masse nei mercati privati per segmento (in mld usd)

Lorenzo Fusco, Principal Thematics
Private Equity di Pictet Am. A lato, l’impatto che il Private Equity potrebbe avere nella transizione energetica è significativo.
12,1 trilioni entro il 2030. Tuttavia, per raggiungere il loro pieno potenziale, queste tecnologie hanno ancora bisogno di investimenti significativi. Climate Policy Initiative calcola che per raggiungere gli obiettivi climatici mondiali dichiarati entro il 2030, il finanziamento deve aumentare almeno del 590%.
Tecnologie di domani
Sviluppo di alcuni mercati secondo le attuali previsioni
Dimensioni del mercato dello sviluppo di nuove tecnologie sostenibili
La lotta contro il cambiamento climatico sta prendendo slancio sia tra i Governi che tra i consumatori: gli obiettivi di azzeramento delle emissioni interessano ora il 92% del Pil globale. Tuttavia, questi impegni non possono essere soddisfatti solo modificando i propri atteggiamenti. Molto dipenderà anche dallo sviluppo di nuove tecnologie e dall’implementazione delle esistenti, la cui adozione, però,
è problematica. La penetrazione delle tecnologie pulite è infatti troppo bassa. Non mancano però i motivi di ottimismo. L’Agenzia Internazionale dell’Energia stima che la maggior parte delle tecnologie pulite necessarie per raggiungere gli impegni Net Zero globali entro il 2030 sia già pronta a essere commercializzata. Inoltre, si prevede che la dimensione del mercato delle tecnologie ambientali passerà da 4,9 trilioni di dollari nel 2020 a
Si tratta di un obiettivo impegnativo, ma rappresenta un’opportunità potenzialmente gratificante per gli investitori. Investire nella transizione. Le aree chiave in cui questo investimento può avere l’effetto maggiore sono cinque:
- Riduzione dei gas serra: batterie e stoccaggio, efficienza energetica, tecnologie a basso/zero contenuto di carbonio e di rimozione del carbonio, tecnologie e servizi per le energie rinnovabili;
- Consumo sostenibile: tecnologie agricole, sicurezza alimentare, ottimizzazione della catena di approvvigionamento, tecnologia alimentare;
- Controllo dell’inquinamento: qualità dell’acqua, qualità dell’aria, conservazione del suolo, trattamento dei rifiuti;
- Economia circolare: sharing economy, riciclo, efficienza delle risorse, materiali bio-based;
- Tecnologie abilitanti: sensori e acquisizione dei dati, catena del valore dei semiconduttori, software per la progettazione e il controllo, chimica green. Queste soluzioni stanno già attirando l’interesse degli investitori ed è probabile che l’opportunità sia particolarmente in-
teressante nell’ambito dei mercati privati, anche perché le aziende non quotate sono all’avanguardia in queste tecnologie. A livello globale, il numero totale di aziende private in ambito ambientale con una valutazione superiore a 1 miliardo di dollari (gli ‘unicorni’) è aumentato di 14 volte dal 2017. A paragone, il numero totale di ‘unicorni’ è aumentato solo di quattro volte nello stesso periodo.
Un tale boom delle valutazioni non sorprende, dato che le aziende non quotate stanno diventando leader in molte aree della tecnologia ambientale. A maggio, ad esempio, un’azienda privata europea ha stabilito il record di efficienza nella conversione dei raggi solari in elettricità attraverso pannelli di dimensioni commerciali. Tra le aziende non quotate si collocano anche alcuni dei maggiori attori della catena del valore dei veicoli elettrici, nonché i leader nel riciclo delle batterie agli ioni di litio. Chi ha investito in aziende operanti in questi settori ha potuto godere di rendimenti solidi. Il coinvestimento. Naturalmente, investire in società non quotate non è esente da rischi, in particolare nel settore delle tecnologie ambientali, dove Governi e autorità di regolamentazione svolgono un ruolo enorme nel plasmare lo scenario.
Tuttavia, esiste un’area all’interno del Private Equity che offre agli investitori un certo grado di protezione da tali rischi: i coinvestimenti. Attraverso questa struttura, i gestori (noti come general partner, Gp) offrono a investitori selezionati (limited partner, Lp) l’opportunità di investire direttamente in una specifica transazione insieme a loro.
Negli ultimi due decenni, i fondi di coinvestimento hanno raccolto oltre 175 miliardi di dollari. Ed è molto probabile che i coinvestimenti aumentino di pari passo con l’espansione del settore.
Per i Gp, il vantaggio principale del coinvestimento è la possibilità di investire maggiormente nelle aziende che ritengono interessanti, sono infatti spesso soggetti a ‘restrizioni della concentrazione’, vale a dire che esiste un limite alla quantità di capitale investibile in un’unica azienda. Per gli Lp, invece, uno dei principali vantaggi del coinvestimento è l’accesso diretto ad aziende private di alta qualità. Piuttosto che investire in centinaia di aziende tramite un fondo di fondi, una strategia di coinvestimento è molto più mirata (solitamente in 25-30 società),
Contano le prospettive
Contributo atteso nel taglio delle emissioni verso net-zero (rispetto al 2020)
mantenendo al contempo una diversificazione adeguata tra Gp, Paesi e settori.
Un altro vantaggio è il fatto che i coinvestimenti vengono implementati molto più rapidamente (di solito in due o tre anni) rispetto ai tradizionali fondi di fondi Private Equity, che possono richiedere da sei a sette anni per arrivare a essere investiti completamente. L’implementazione precoce può contribuire a mitigare il problema dall’andamento della “J-curve”, la curva che rappresenta la tendenza degli investimenti del segmento a riportare perdite di capitale nei primi anni di vita prima di generare utili. Ciò è confermato dalla nostra esperienza.
Per finire, il rendimento netto è potenziato dal fatto che i Gp offrono solitamente coinvestimenti senza le consuete commissioni di gestione (1,5-2,0%) e di performance (20%). Un dato significativo per un’asset class che di solito impone commissioni considerevolmente più elevate rispetto alle attività quotate.
Il coinvestimento può dunque essere una strada interessante per investire nei mercati privati in generale e nei pionieri
Molto spesso ci si sofferma sul ruolo che le tecnologie esistenti possono assumere nel decarbonizzare l’economia, non si considera però quello che avranno quelle non ancora sviluppate.
ambientali in particolare. Finanziando l’innovazione nel privato, gli investitori giocheranno un ruolo importante nel porre l’economia mondiale su basi sostenibili. La storia lo testimonia. Quarant’anni fa, una delle principali preoccupazioni ambientali era l’allargamento del buco dell’ozono. L’attivismo su questo tema portò al Protocollo di Montreal del 1989 sull’eliminazione graduale delle sostanze che danneggiavano l’ozono, e al più ampio Protocollo di Kyoto, nel 1997. Dei nove limiti planetari, i livelli di ozono nella stratosfera sono oggi uno dei pochi che l’umanità non ha violato. L’innovazione tecnologica, sostenuta dalla finanza privata, può sicuramente contribuire a ripristinare il pianeta e al contempo fornire solidi rendimenti.
Manifesti e promesse
La corsa verso le elezioni di novembre entra sempre più nel vivo, con clamorosi colpi di scena registrati negli ultimi mesi. Ma cosa cambierebbe a dipendenza degli scenari?
La campagna elettorale è stata caratterizzata da clamorosi colpi di scena, dall’attentato a Trump in Pennsylvania al cambio in corsa del candidato democratico, con Kamala Harris che nelle ultime settimane ha riportato il partito in vantaggio.
Democratici e repubblicani hanno visioni molto diverse su come gestire l’economia, a partire dalla materia fiscale.
Le indicazioni programmatiche di Harris, coerenti con l’amministrazione Biden, mirano a ridurre le disuguaglianze e favorire la transizione energetica, confermando i piani di spesa e gli incentivi dell’Inflation Reduction Act (Ira) e gli investimenti per l’assistenza sanitaria. Parallelamente, la regolamentazione di alcuni settori, in particolare l’antitrust, verrebbe rafforzata.
Gli sgravi fiscali per le aziende approvati da Trump nel 2017 verrebbero lasciati scadere, incrementando così le aliquote delle imposte sulle società. Anche la tassazione marginale sulle persone fisiche e la tassazione di plusvalenze e immobili aumenterebbe.
Queste politiche potrebbero ridurre leggermente la crescita economica, mentre l’effetto disinflazionistico potrebbe portare a tagli dei tassi d’interesse più rapidi e, quindi, a un dollaro più debole.
Il manifesto di Trump punta in direzione opposta confermando le aliquote fiscali per le società che potrebbero essere addirittura ridotte in seguito. Alcuni incentivi dell’Ira potrebbero essere cancellati e la supervisione regolamentare ridotta, a vantaggio soprattutto del settore petrolifero e di quello finanziario.
Tuttavia, deficit più alti e tensioni commerciali potrebbero indebolire il dollaro, come auspicato dallo stesso Trump per favorire la manifattura statunitense. La
conferma degli sconti fiscali per le aziende avrebbe un impatto positivo iniziale per la borsa, così come la promessa di una minor regolamentazione per alcuni settori.
La borsa americana potrebbe inizialmente risentire della vittoria di Harris per via della maggior tassazione sulle imprese, tuttavia i titoli legati alla transizione energetica probabilmente sarebbero avvantaggiati. La deregulation proposta da Trump potrebbe beneficiare in particolar modo le banche e l’energia. In ogni caso, in questa
«Entrambi i partiti condividono il protezionismo, ma con modalità diverse.
Trump favorisce i negoziati bilaterali e ha proposto dazi universali del 10% su tutte le importazioni
negli Stati Uniti e del 60% su quelle provenienti dalla Cina»
fase è bene evitare di prendere decisioni drastiche sui portafogli sulla base delle aspettative sulle elezioni.
Entrambi i partiti condividono il protezionismo, ma con modalità diverse. Trump favorisce i negoziati bilaterali e ha proposto dazi universali del 10% su tutte le importazioni negli Stati Uniti e del 60% su quelle provenienti dalla Cina. I democratici desiderano preservare l’alleanza transatlantica, concentrandosi sugli scambi con la Cina.
Dazi più elevati sarebbero negativi per le aziende con export verso gli Stati Uniti, come i produttori automobilistici europei, e a medio termine ciò potrebbe

Matteo Ramenghi, Cio di Ubs Wealth Management Italia.
accelerare la tendenza a riportare alcune produzioni vicino ai mercati di sbocco. Tuttavia, occorre ricordare che la metà del commercio internazionale avviene all’interno delle multinazionali, tra le quali le aziende statunitensi, che potrebbero fare pressione sulla nuova amministrazione.
Qualsiasi amministrazione dovrà confrontarsi con un debito federale di oltre 34 trilioni di dollari e un deficit di quasi il 6% che pare difficile da comprimere. Anche in considerazione di un rallentamento economico sempre più evidente, ci si attende che il dollaro si possa indebolire con entrambi i candidati.
Le elezioni avranno ramificazioni per il resto del mondo: le relazioni con l’Europa, la Cina, il Messico, la Russia e il Medio Oriente potrebbero cambiare sensibilmente dopo le elezioni.
Gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale dell’Unione europea e il loro ruolo come fornitore, per esempio di energia, è cresciuto notevolmente dall’inizio della guerra in Ucraina. Una presidenza Harris rappresenterebbe continuità rispetto a Biden, mentre una presidenza Trump potrebbe creare più incertezza, con implicazioni (per esempio riguardo all’Ucraina o ai dazi) sia positive che negative.
Con tutta probabilità, le relazioni sino-americane rimarranno difficili, con maggiori restrizioni sullo scambio di tecnologia indipendentemente dal presidente. Con gli Stati Uniti che cercano di ridurre la dipendenza dalla Cina, la relazione economica con il Messico invece dovrebbe crescere in importanza.
Superman... non esiste!
Il settore degli ascensori è fortemente legato all’attività edilizia di un Paese, ma soprattutto alla manutenzione di tutti gli impianti già installati, che fanno la vera differenza.
Il mercato globale degli ascensori è fortemente consolidato: le quattro maggiori aziende - Otis, Schindler, Kone e Tk Elevator - controllano circa il 60% del mercato. Il modello di business di Schindler copre l’intero ciclo di vita di un ascensore: dall’installazione alla manutenzione fino alla modernizzazione. Costruzione e manutenzione. La domanda di nuovi impianti dipende dall’attività edilizia. Sebbene gli ascensori rappresentino solo una piccola parte dei costi di costruzione (meno del 5%), hanno una durata di vita di 25 anni o più. I ricavi una tantum derivanti dai nuovi impianti rappresentano circa il 40% delle entrate di Schindler. Schindler ha installato circa 2 milioni di ascensori e scale mobili in tutto il mondo e possiede contratti di manutenzione in numero simile.
Le attività di manutenzione rappresentano invece il 45% delle entrate e generano la maggior parte dei profitti. Una volta completato e occupato un edificio, il funzionamento affidabile degli ascensori diventa essenziale. Per questo la manutenzione regolare è obbligatoria. La maggior parte dei contratti di manutenzione rappresenta una piccola parte dei costi operativi complessivi di un edificio, ma i margini di profitto sui contratti di manutenzione superano il 20%. Ancora meglio: i contratti vengono pagati in anticipo. Attualmente, circa un terzo degli ascensori Schindler è connesso in rete. I sensori rilevano vibrazioni indesiderate e consentono una manutenzione predittiva. Ciò ottimizza la disponibilità degli impianti. Gli impianti connessi giustificano anche prezzi di manutenzione più elevati. Ottime prospettive quindi per l’azienda. Modernizzazione. Questo segmento rappresenta circa il 15% del fatturato
complessivo e ha un margine di profitto leggermente superiore a quello dei nuovi impianti. La vendita una tantum di nuove installazioni rafforza la base del portafoglio impiantistico, garantendo decenni di entrate ricorrenti dalla manutenzione, con un’elevata trasparenza dei ricavi. Il settore degli ascensori è un mercato oligopolistico, in cui i principali attori agiscono in modo razionale. Le differenze tra i fornitori sono spesso sottili, l’offerta di prodotti è comparabile e le innovazioni tecnologiche rapidamente copiate.
«Il settore degli ascensori è un’attività solida, in cui i costi una tantum giocano un ruolo minore e si beneficia a lungo termine di entrate ricorrenti dalla manutenzione. Finché non si svilupperanno superpoteri, c’è solo un rischio minimo che gli ascensori diventino obsoleti»
Schindler si concentra maggiormente sull’Europa, Kone sulla Cina e Otis e Tk Elevator sul continente americano. Per ampliare la base dei loro impianti installati, le aziende si concentrano spesso sui Paesi con un’elevata attività edilizia. L’ultima ‘conquista’ in tal senso è stato il mercato cinese, e resta da vedere come evolverà. Lezioni dal passato. La gestione e la cultura aziendale sono altri fattori distintivi fondamentali che hanno un impatto significativo sulla redditività e sulla crescita. In passato, i margini per i nuovi impianti di Schindler erano inferiori a quelli del leader del settore Otis, situandosi nell’intervallo di una singola cifra

Beat Keiser, Head of Equities, Rothschild & Co Bank, Wealth Management.
percentuale. Per colmare questa lacuna, Schindler ha sviluppato un piano per la modularizzazione dell’offerta di prodotti. Sebbene il piano fosse promettente in teoria, la sua attuazione è fallita. I clienti sono stati confrontati con troppe opzioni, il che ha portato a scorte eccessive e a una complessità produttiva non necessaria. Il risultato è stato che il sistema di gestione delle scorte non è più riuscito a gestire in modo efficiente le innumerevoli parti. Questi problemi si sono manifestati contemporaneamente ai problemi della catena di approvvigionamento causati dal Covid e all’aumento dei prezzi delle materie prime, peggiorando ulteriormente i margini per i nuovi impianti. Inoltre, nel reparto vendite venivano spesso concessi sconti sui prezzi di listino, sacrificando gli aumenti di prezzo giustificati per raggiungere obiettivi personali.
Turnaround. A fine 2021, il CdA di Schindler ha lanciato l’allarme e Silvio Napoli è stato richiamato alla carica di Ceo. Nel 2022, il margine operativo del gruppo Schindler è sceso per la prima volta dal 2007 sotto la soglia del 10%. Napoli ha subito adottato misure per migliorare la situazione. È atteso un miglioramento a lungo termine della redditività, passando dall’attuale livello al 10%.
Il settore degli ascensori è un’attività solida, in cui i costi una tantum giocano un ruolo minore e si beneficia a lungo termine di entrate ricorrenti dalla manutenzione. Finché non si svilupperanno superpoteri, c’è solo un rischio minimo che gli ascensori diventino obsoleti.
Tra scale e ascensori
Nei decenni i mercati finanziari hanno regolarmente vissuto momenti negativi, alcuni più importanti di altri. La storia insegna però che, di norma, i mercati tendono a riprendersi.
Street
Andamento dell’indice Standard&Poors
Fonte: Bloomberg
Piazza Affari
Andamento dell’indice Ftse Mib
Fonte: Bloomberg
Èimportante capire che i mercati, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a ciclicità, ovvero salgono e scendono. Il fatto che il mercato sia in ribasso non significa che bisogna farsi prendere dal panico. I mercati sono ciclici. Nel corso del XX secolo, e anche ora, si è assistito a numerosi crolli del mercato. Alcuni peggiori di altri. Il 1929, la crisi petrolifera, la crisi finanziaria asiatica, le Dotcom, il 2008,
il 2011... sono stati tutti periodi in cui i mercati sono precipitati ai minimi. Tuttavia si sono ripresi, nella maggior parte dei Paesi. Sono molti gli esempi del passato. Quando gli indici salgono, tendono a ‘fare le scale’, ovvero ad aumentare di pochissimo al giorno, in percentuale, ma nel lungo periodo tendono a produrre una traiettoria ascendente. Quando crollano, invece, ‘prendono l’ascensore’, arrivando a cali molto più sostanziosi in un solo

Jacques Sale, responsabile business developement di Alpian. A lato, l’andamento di Wall Street e Piazza Affari, nelle stesse fasi di mercato.
giorno di contrattazioni. Da qui il panico. Il recupero non avviene da un giorno all’altro. A partire dal 2009, si è osservato un trend rialzista. Da allora, gli indici internazionali sono cresciuti in media del 13% annuo in 11 anni. Tuttavia, negli ultimi anni, si sono affrontati due scenari difficili: la pandemia nel 2020, e la guerra in Ucraina nel 2022, che ha segnato l’ingresso in quello che viene definito un mercato ribassista. Si parla di mercato ribassista quando i prezzi azionari seguono un trend al ribasso sul lungo periodo e scendono del 20% o più.
Da allora le cose sono migliorate, e gli indici hanno prodotto risultati interessanti. A fine luglio sembrava che si fosse entrati in un altro momento critico, ma dopo poco tempo i mercati si sono stabilizzati e hanno recuperato. Ma cosa si può fare per proteggere i propri investimenti? Molte conferme, poche eccezioni… Esaminando gli indici mondiali, si nota questa tendenza. Ad esempio, lo S&P 500 per il periodo 1990-2022. I mercati di norma si riprendono dopo un calo, nel lungo periodo. Seppur con eccezioni: ad oggi, l’indice italiano non si è ancora ripreso del tutto negli ultimi 20 anni.
Se si considerano gli indici complessivamente, a livello globale, questi seguono il trend, ma non è sempre garantito che tutti gli indici recuperino. Per questo è importante prendere alcune precauzioni. L’emotività. L’aspetto emotivo di un investitore è fondamentale in queste situazioni. Si è scritto molto sulla psicologia
degli investimenti nel corso degli anni. La finanza comportamentale evidenzia due concetti chiave: mentalità di gregge e avversione alla perdita.
La mentalità di gregge descrive la tendenza degli investitori a seguire le azioni della maggioranza. Quando i mercati crollano, il panico può diffondersi rapidamente e molti si precipitano a vendere i propri asset perché altri stanno facendo lo stesso. Questa vendita collettiva dettata dal panico può amplificare il crollo.
L’avversione alla perdita si riferisce al fatto che, psicologicamente, le perdite fanno più male di quanto i guadagni diano soddisfazione. Gli investitori spesso reagiscono emotivamente alle perdite a breve termine, anche se sono minori e recuperabili nel lungo periodo. Questa reazione emotiva può portare a vendite irrazionali durante i ribassi.
La chiave per evitare queste trappole emotive è mantenere la disciplina e aderire a un piano finanziario, rispettando alcuni accorgimenti. Come disse Warren Buffett: “Siate timorosi quando gli altri sono avidi, e avidi quando gli altri sono timorosi.” In altre parole, i ribassi possono spesso rappresentare opportunità di acquisto per l’investitore razionale.
La durata dei cicli finanziari. È di particolare interesse notare quanto i cicli di mercato durino nel tempo. Di norma, le situazioni in cui il mercato è rialzista tendono ad avere un periodo di durata maggiore. In media, negli ultimi 100 anni, i rialzisti sono durati tra 5 e 6 anni. Come esempio, il periodo iniziato nel 2009 è durato oltre un decennio, registrando uno dei periodi ‘positive’ più lunghi. Al contrario, i cicli ribassisti sono generalmente più brevi, tra 18 e 24 mesi. La crisi del 2008 ha visto i mercati perdere terreno in maniera drastica e repentina. Il suo recupero, al contrario, è stato molto più lento. Alcuni cicli hanno vita breve, spinti da eventi temporanei come ad esempio nel 2020; altri, come il 1929 si sono estesi su un periodo di tempo maggiore, richiedendo uno sforzo temporale importante per recuperare. Comprendere queste tendenze ed essere consapevoli può aiutare a non farsi prendere dal panico. Mantenere la rotta. Ecco alcune misure che si possono adottare per proteggersi:
- Mantenere una prospettiva a lungo termine. Avere una strategia d’investimento a lungo può proteggere l’investimento e far sì che il portafoglio sopravviva
La volatilità
Andamento dell’indice della paura, il Vix
alle oscillazioni del mercato;
- Diversificare il portafoglio può aiutare a sopravvivere a un crollo di un settore, specie nel caso di bolle (Dotcom);
- Comprendere l’importanza dell’interesse composto e del value investing:
- Ascoltare il proprio consulente;
- Dominare le emozioni.
Ma soprattutto, ricordare che la maggior parte dei cicli di mercato prima o poi giunge al termine (l’ultimo risale al 2011). Gli indici premonitori. A titolo informativo, si possono usare due indici che misurano il sentiment del mercato: il Fear&Greed e il Vix. Il primo, molto semplicista, è stato creato da Cnn Money e prova a misurare le emozioni che spingono l’azionario. Attualmente registra un solido ottimismo, con 66.
Il Vix invece è molto più utilizzato, anche come prodotto da inserire nelle strategie per proteggere il portafoglio. Creato dal Chicago Board Options Exchange, misura le attese di volatilità per i prossimi 30 giorni. Si basa sul prezzo delle opzioni dell’S&P 500, e quando presenta degli aumenti previsti nella volatilità,
La costanza della borsa svizzera, e la volatilità catturata dal Vix nel corso degli ultimi decenni. Un raffronto tra i due, e gli ultimi mesi dovrebbe quanto meno far riflettere.
vuol indicare un aumento dei rischi con un probabile ribasso. È un indice aperto, con livelli che spaziano tra 15 e 35. Con l’attuale 15,76 registra una relativa quiete. Un crollo dei mercati può essere allarmante, ma non è la fine del mondo. Può allarmare vedere il valore dei propri investimenti diminuire, ma è importante ricordare che un crollo del mercato è naturale. Si verifica periodicamente e potrebbe essere visto come un’opportunità.
La storia insegna che il mercato prima o poi si riprenderà, purché si abbia un piano di investimento a lungo termine. E soprattutto, non bisogna farsi prendere dal panico durante un calo.
Ma come si è comportata la borsa svizzera in questi scenari? Guardando agli ultimi vent’anni si può notare lo Smi abbia seguito la tendenza globale.
Parallelismi storici
Identificare somiglianze tra andamento dei mercati oggi e il passato può aiutare a identificare i trend futuri, a patto però di essere oggettivi. Qual è il metodo per essere imparziali?
A caccia di parallelismi (F.1) Il quadro di riferimento del presente e gli eventi accorsi negli ultimi

Yves Schläpfer, Co-Cio e responsabile ricerca quantitativa di Copernicus Wealth Management. A lato, la costruzione di un framework di dati e serie temporali utile a fare confronti tra andamento dei mercati nel passato, e nel presente.
Le quattro serie temporali (F.2) Andamento dei diversi indicatori di riferimento
L’identificazione di parallelismi storici è fondamentale per prevedere gli sviluppi dei mercati. Ciò diventa ancora più importante nei periodi di forte incertezza. Il crollo dell’azionario a inizio agosto è una di queste situazioni. Poiché l’insieme dei possibili indicatori da esaminare è vasto, il bias di conferma può portare a dare maggior peso alle informazioni che si allineano alle convinzioni esistenti, ri-
schio amplificato dalla vastità del set informativo. La sfida risiede nel modo in cui aggregare tutte le informazioni per formare il quadro più accurato possibile.
L’interpretazione dello stato attuale e della direzione di economia e mercati dovrebbe essere condotta nel modo più imparziale possibile. Le regole matematiche possono aiutare a superare i pregiudizi, aggregando le informazioni disponibili, il cui risultato è la Figura 1.
Supponendo che oggi sia il 19 agosto, dove ci si trova? Guardando alla Figura 1, si nota che copre dal 4 settembre 1990 al 14 agosto 2024, con dati disponibili fino alla chiusura del 16 agosto scorso. La linea grigio scuro rappresenta la somiglianza di ogni giorno passato con ‘oggi’, con valori più alti che indicano un maggior significato. Nella costruzione dei pesi di ‘importanza’, la somma dei pesi del passato deve essere di 1. Per migliorarne la leggibilità, si includono eventi di mercato degni di nota e recessioni Nber statunitensi.
Al 19 agosto 2024, si trovano analogie con periodi come la recessione dei primi Novanta, la bolla Dotcom e la crisi dei Subprime nel 2007 e all’inizio del 2008. Pertanto, il grafico e i dati suggeriscono di considerare questi parallelismi storici. Ma come si è arrivati a questo risultato? Le premesse e il metodo. Si inizia definendo una serie di variabili accademicamente solide per determinare lo stato dell’economia. È preferibile utilizzare dati ‘negoziati’, come prezzi e spread creditizi in quanto riflettono le reali aspettative degli operatori, diversamente dai sondaggi.
Si definiscono quattro serie temporali (Figura 2) utili a determinare i parallelismi storici con il presente. Dunque, il ‘term spread globale’, definito dal rendimento a 10 anni meno il rendimento a 1 anno, che riflette le aspettative del ciclo economico; il ‘dividend yield globale’ rap-
Nel cercare parallelismi temporali con il passato è bene prima di tutto individuare con certezza le somiglianze dei dati nelle diverse serie storiche, dunque quanto i dati analizzati siano significativi, e quanto siano simili tra loro, per poi confrontarli con... altro.
presenta la valutazione del mercato azionario; la ‘variazione a un anno del tasso di deposito globale a 1 mese’, misura le azioni delle Banche Centrali; e il Vix, che riflette l’avversione al rischio istantanea dei partecipanti al mercato. Le quattro serie temporali coprono il ciclo economico, le valutazioni, le banche centrali e l’avversione al rischio. La linea rossa tratteggiata evidenzia il valore più recente di ciascuna serie, ovvero il valore di chiusura del giorno lavorativo precedente.
Con i dati più recenti - indicati con una linea rossa tratteggiata - si ottiene un’impronta digitale dell’attuale stato dell’economia. Per ogni variabile informativa, la distanza tra i valori passati (in nero) e il valore attuale (in rosso) indica la somiglianza con ‘oggi’. Esaminando queste serie temporali singolarmente si ottiene una visione monodimensionale. Il passaggio non banale è ottenere una visione aggregata, che sintetizzi tutte e quattro le dimensioni in un unico indicatore di somiglianza. Integrare le diverse variabili in modo euristico, senza un solido modello, è un processo complesso già con quattro variabili, che diventa impraticabile al crescere del numero di dimensioni. La ponderazione dell’importanza nella Figura 1 viene aggiornata quotidianamente.
La Figura 3 mostra la ponderazione dell’importanza per due date, il 31 dicembre 2023 e il 19 agosto 2024. Dalla fine dello scorso anno, ci si è allontanati dai cicli di rialzo dei tassi 2004-2006 e si è dunque attribuito un peso maggiore agli anni ’90 e al forte mercato rialzista prima e dopo la crisi da Covid-19.
La Figura 1 e la Figura 3 sono uno strumento prezioso in qualsiasi processo d’investimento, in quanto rappresentano un punto di partenza imparziale per una discussione. Ma le ulteriori applicazioni della ponderazione per similarità sono molteplici, in quanto possono utilizzarla per calcolare misure prospettiche di rendimenti attesi, volatilità o correlazioni.
Le Figure 4 e 5 illustrano questo concetto visualizzando la ponderazione d’im-
L’importanza (F.3)
Ponderazione dell’importanza in due date chiave
Il ritorno (F.4)
Confronto degli indicatori con ritorno a un anno
La volatilità (F.5)
Confronto degli indicatori con volatilità a un mese
portanza insieme ai rendimenti futuri a 1 anno e alle volatilità future a 1 mese dell’S&P 500 e dei titoli di Stato americani a 7-10 anni. La Figura 4 mostra la ponderazione d’importanza insieme agli extra-rendimenti a un anno e la Figura 5 le volatilità realizzate a un mese. Le aspettative per gli extra-rendimenti o le volatilità possono essere ricavate ponderando i rendimenti o le volatilità storiche.
In sintesi, l’obiettivo è comprendere i
mercati di oggi identificando oggettivi parallelismi storici. Si può farlo creando un’impronta dell’economia attuale e confrontandola con i dati storici: si ottiene così una misura di somiglianza tra oggi e qualsiasi giorno o istante nel passato. Tale misura può servire come base per le decisioni di asset allocation, nel calcolo delle aspettative di rendimento e volatilità di strumenti o portafogli... e perché non anche molto altro!
Un potente potenziale
Il diffondersi dell’Intelligenza Artificiale nelle sue molte forme schiude opportunità interessanti nel breve e nel lungo periodo, sempre a patto di sapersi posizionare, per tempo.
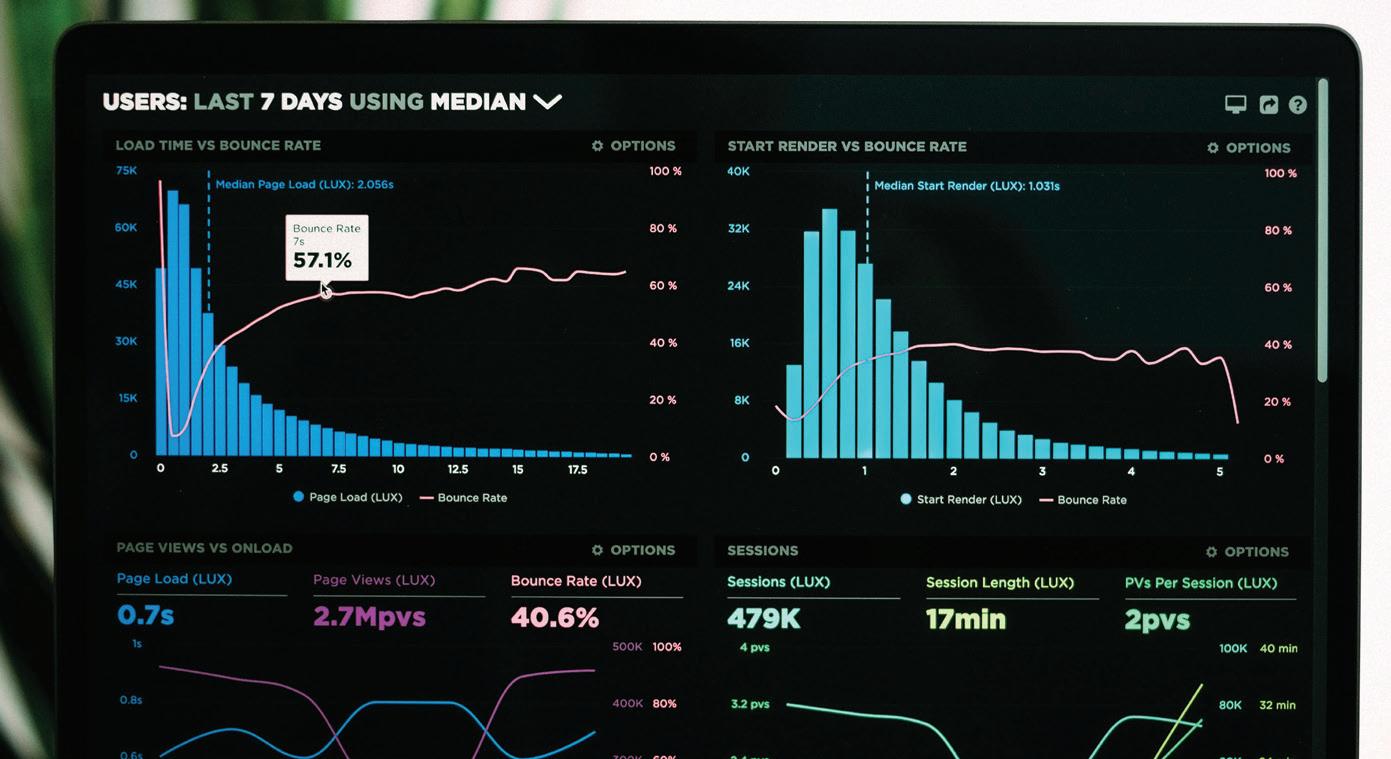
L’intera economia è pervasa da nuove ondate di Intelligenza artificiale, tra cui l’Edge Ai, che stanno schiudendo nuovi orizzonti. Il mercato dell’Ia, in forte accelerazione, potrebbe raggiungere gli 1,81 trilioni di dollari entro il 2030. Due sono i motori di questa crescita: la ripresa della trasformazione digitale dell’economia e lo sviluppo dell’Ia generativa.
L’avvento della Generativa. Sulla scia di ChatGpt, i cui ricavi dovrebbero ammontare a diversi miliardi di dollari nel 2024, lo sviluppo dell’Ia generativa innescherà un’ondata di crescita per l’economia, con applicazioni che daranno alle imprese nuove opportunità di guadagno e di ottimizzazione dei costi grazie alla potenza di calcolo e all’abbondanza di dati.
Grazie ai data center, le tecnologie cloud dal potenziale crescente si sono diffuse. Con il proliferare dei server Gpu, essenziali per l’elaborazione parallela a bassa latenza, le reti neurali artificiali si sono ampliate. Queste rivoluzioni permettono l’avvento dell’Ia generativa mentre le applicazioni per la cybersicurezza,
progettazione di prodotti e chatbot ne stanno democratizzando l’uso.
L’Ia generativa avrà innumerevoli impatti. Si stima che entro il 2035 aumenterà del 40% la produttività nei Paesi sviluppati. Ne sono un esempio, tra i tanti, i moduli Copilot di Microsoft, in grado di automatizzare numerose attività, sintetizzare i dati aziendali e fornire suggerimenti agli utenti, favorendo così un processo decisionale più rapido.
Le prossime ondate. L’Ia sta diventando un nuovo indice di competitività. I campioni di questi sistemi intelligenti stanno già crescendo del 50% in più rispetto ai loro pari. Aziende come Nvidia sono le più veloci a impadronirsene, insieme alle piattaforme tecnologiche - i fornitori di cloud hosting - pagate in base al consumo e all’utilizzo dei dati.
Oltre ai semiconduttori e ai provider di cloud hosting, la base oggi dell’infrastruttura dell’Ia, la sua monetizzazione dovrebbe favorire la crescita del resto del settore del software. C’è molto interessati per le aziende che promuovono la migrazione dei dati nel cloud, come Sap e

Christophe Pouchoy, Gestore di Echiquier Artificial Intelligence, di La Financière de l’Echiquier (Lfde).
l’automazione dei processi, nonché agli specialisti della gestione e dell’analisi dei dati, come Datadog e MongoDB, o della sicurezza informatica.
Anche l’integrazione nella tecnologia mobile è promettente: l’Edge Ai, che porta l’Ia nella vita reale, genera risultati di calcolo senza trasferire dati ai data center, un aspetto fondamentale per applicazioni come le auto autonome e la realtà aumentata. L’Edge Ai migliora anche la riservatezza, evitando la trasmissione di dati sensibili al cloud. Apple ha presentato la sua strategia Apple Intelligence volta a integrare le funzionalità di AI generativa nel suo assistente Siri, che potrebbe accelerare l’adozione dell’Ia su scala globale. La sua adozione diffusa porterà a rinnovare tutti i dispositivi, telefoni e computer. Successivamente, l’Edge Ai sarà integrata nella robotica umanoide, industriale o medica, e nella meccatronica. Accelerazione. La monetizzazione dell’Ia cresce velocemente. Si è identificato quattro temi chiave per la nostra strategia dedicata: la trasformazione digitale, i big data e l’analisi predittiva con operatori come Datadog, la cybersicurezza con il leader mondiale Palo Alto Networks e l’adozione dell’Ia da parte di nuovi settori. L’uso diffuso dell’Ia, con un tasso annualizzato di crescita del 38% entro il 2030, sarà una sfida strategica, finanziaria, scientifica ed etica. Questa rivoluzione favorirà le aziende ben posizionate per cavalcarla, nonché tutti gli investitori alla ricerca di innovazione e crescita sostenibile.
Thailandia: che succede?
La terza economia della regione sta vivendo una fase delicata e molto contrastata, con avvicendamenti al timone, guai giudiziari, e politiche fiscali alquanto discutibili.
Corre la crescita
Andamento del Pil reale annuale di alcuni Paesi asiatici (in %)

Luca Castoldi, Senior Portfolio Manager, Reyl Intesa Sanpaolo, Singapore. A lato, l’evoluzione del Pil reale nel sud est asiatico.
All’inizio di agosto è stato sciolto il Move Forward Party, un partito di opposizione orientato ai giovani che ha vinto le elezioni nazionali del 2023. Lo scioglimento del partito perché ritenuto colpevoli di minacciare la monarchia costituzionale, così come la sicurezza nazionale.
Il partito aveva precedentemente condotto una vigorosa campagna contro il Governo militare e sostenuto modifiche audaci alle leggi che proibivano la critica della monarchia. La vittoria del Move Forward Party con 151 seggi sui 500 disponibili alla Camera dei Rappresentanti ha segnato un momento storico. È stata la prima volta in oltre due decenni che il Pheu Thai, strettamente legato all’ex primo ministro Thaksin Shinawatra, ha subito una sconfitta elettorale.
Tuttavia, Pita Limjaroenrat, leader del partito Move Forward, aveva ancora bisogno dell’approvazione parlamentare per suggellare la sua vittoria. Il destino ha voluto che alla fine gli venisse impedito di prendere il potere dai senatori conservatori. Di conseguenza, Srettha Thavisin,
un alleato di Thaksin, è stato scelto per diventare il nuovo primo ministro poco dopo il ritorno di Thaksin in Thailandia alla fine di un esilio autoimposto durato 15 anni per evitare le accuse di corruzione di cui era stato inizialmente accusato.
La rapida ascesa di Thavisin è stata veloce quanto la sua caduta dopo solo 1 anno in carica. Il suo breve mandato è stato notoriamente oscurato da una postura fiscale irresponsabile attraverso la politica del “portafoglio digitale” da 500 miliardi di baht, che ha portato un supporto praticamente nullo alla lenta economia thailandese. Il 14 agosto, la Corte costituzionale lo ha ufficialmente destituito, spingendo il Pheu Tai alla elezione non popolare di Paetongtarn Shinawatra, la figlia trentottenne di Thaksin, che è diventata la più giovane primo ministro.
L’ascesa di Paetongtarn alla premiership porta sia opportunità che sfide per la Thailandia. La sua mancanza di esperienza amministrativa ha sollevato preoccupazioni rispetto le complesse sfide che l’economia thailandese, 500 miliardi di dollari, si trova ad affrontare. Molti si
aspettano che farà affidamento su suo padre, Thaksin, e la sua ‘Thaksinomics’. Paetongtarn si è impegnata a rivitalizzare l’economia, ma le sue strategie rimangono poco chiare. Ereditando la premiership da un alleato di partito, non sono previsti grandi cambiamenti politici e il suo Governo probabilmente si concentrerà sul rilancio della crescita, affrontando l’alto costo della vita e i livelli di debito quasi record delle famiglie. Sebbene l’impatto delle varie politiche di stimolo rimanga poco chiaro, ciò non dovrebbe modificare i disavanzi previsti e l’offerta di bond, poiché il finanziamento iniziale è già stato stanziato nel bilancio suppletivo 2024 e nel disegno 2025.
I mercati finanziari si sono anche concentrati sulla continuazione del programma di Thavisin di sussidi basato su portafoglio digitale da 500 miliardi di baht, che aveva grandi speranze di spingere l’economia thailandese a crescere annualmente del 5% come molti Paesi vicini. Con l’attuale situazione politica rischiosa unita alle riconsiderazioni della Commissione nazionale anticorruzione e della Banca di Thailandia, sullo schema del portafoglio digitale si profila una grande incertezza. Con una crescita media inferiore al 2% nel decennio, la Thailandia è evidentemente in ritardo rispetto a Malesia e Indonesia (4 e 5%). Date le negative prospettive di crescita e l’attuale contesto fiscale e politico incerto, per gli investitori fiduciosi del mercato azionario thailandese si prospetta una battaglia tutta in salita.
Confrontarsi con l’eredità coloniale

Il Museo nazionale svizzero di Zurigo presenta, per la prima volta e attraverso una pluralità di sguardi, una panoramica completa della storia coloniale della Svizzera. Un passato ambivalente, con cui anche un paese che non ha avuto domini d’oltreoceano deve fare i conti.
Anche per lo sviluppo economico e industriale di un paese che, come la Svizzera, non ha mai posseduto colonie, i mercati d’oltremare hanno indubbiamente molto contato. In questi ultimi anni viene finalmente dedicata crescente attenzione alla questione, sull’onda di una presa di coscienza che ha portato l’Occidente a fare i conti con quest’eredità carica di contraddizioni. Da poche settimane si è inaugurata la grande mostra con cui il Museo nazionale svizzero di Zurigo si confronta con il tema. «Nella scelta delle tematiche per le nostre esposizioni ci chiediamo continuamente, in quanto museo storico-culturale, come essere rilevanti per la società. Lo sguardo al pas-
sato può orientare, può aiutarci a capire il presente. Negli ultimi anni, ricercatori e ricercatrici di diverse discipline hanno dedicato importanti pubblicazioni agli intrecci intrattenuti dalla Svizzera con il colonialismo. Anche qui, il movimento Black Lives Matter ha acceso dibattiti. Partendo da questi presupposti, malgrado il nostro museo non possegga una collezione etnografica, abbiamo deciso di presentare, per la prima volta e attraverso una pluralità di sguardi, una panoramica completa della storia coloniale della Svizzera», spiega Denise Tonella, direttrice del Museo nazionale svizzero.
La preparazione dell’esposizione ha richiesto un impegno di oltre due anni, con un dialogo a più livelli che ha coinvolto esperti ed esperte di diverse discipline, raccogliendo gli spunti dal consiglio scientifico della mostra, composto da personalità con profonde conoscenze accademiche e museologiche. «La ricerca più recente ha portato alla luce nuovi aspetti. Ad esem-

pio, l’impatto ecologico delle piantagioni e, più in generale, del sistema coloniale. Nella mostra affrontiamo questo tema in una sezione dedicata allo “sfruttamento della natura”. Oppure il ruolo dei mercenari e degli esperti svizzeri al servizio delle potenze coloniali o ancora l’impatto che ancora oggi ha il colonialismo, ad esempio sul razzismo strutturale. La scelta è stata quella di mostrare l’ampio ventaglio degli intrecci coloniali della Svizzera ed evidenziarne anche le ambivalenze. Il colonialismo è stato un fenomeno complesso e
Sotto, due esempi di presenza elvetica nei domini coloniali: da sinistra, la casa padronale della piantagione di Karl Krüsi, a Sumatra (1885), e il geologo Arnold Heim (Uganda, 1954) che, spesso ingaggiato da compagnie petrolifere, divenne sostenitore della decolonizzazione. Sopra, il tipico casco coloniale (Congo, fine XIX).

spesso contradditorio, caratterizzato da molteplici relazioni e interessi. Abbiamo inoltre creato uno spazio nella mostra che permette al pubblico di riflettere sulla tematica e di esprimere la sua opinione che sarà poi analizzata dieci giorni prima della chiusura, il 9 gennaio 2025, in un incontro», anticipa Denise Tonella. Il percorso si articola in due parti. Sulla scorta di numerosi esempi concreti e grazie a oggetti, opere d’arte, fotografie e documenti, la prima passa in rassegna undici ambiti, in cui privati, aziende o collettività svizzeri svolsero attività associate al colonialismo a partire dal XVI secolo, spaziando dal Nord e dal Sud America all’Africa e all’Asia. «Si pensi che le ricerche attuali presumono il coinvolgimento di oltre 250 aziende svizzere nel commercio triangolare e nella deportazione di circa 172mila persone. In particolare, a partire dalla metà del XIX secolo, l’industrializzazione e l’integrazione dei mercati globali hanno subìto un’accelerazione. Anche le aziende svizzere iniziarono a espandere le loro attività all’estero o a fondarne di nuove. Tra queste, ad esempio, la società di commercio di lana di Basilea Simonius, Vischer & Co, la Basler Handelsgesellschaft (fondata nel 1859 come Missions-Handlungs-Gesellschaft) e i fratelli
Sotto, una sala dell’esposizione in corso al Museo nazionale di Zurigo. Gli angolari rossi evidenziano documenti, fotografie e artefatti ricontestualizzati. Accanto, l’artista ginevrino Mathias C. Pfund ribalta la scultura celebrativa del mercante neocastallano di David de Pury, coinvolto nel commercio triangolare (2021).
«Nella scelta dei temi per le nostre esposizioni ci chiediamo continuamente, in quanto museo storico-culturale, come essere rilevanti per la società. Lo sguardo al passato può aiutare a capire il presente. In questo caso, mostriamo l’ampio ventaglio degli intrecci coloniali della Svizzera evidenziandone anche le ambivalenze»
Denise Tonella, Direttrice del Museo nazionale svizzero
Volkart di Winterthur (1851). Queste ultime due vengono presentate in mostra. Spieghiamo come si siano specializzate nel commercio di transito, ad esempio in India o nel Ghana, e nel commercio di materie prime quali il cotone, il grano o il cacao, costruendo inoltre una propria rete di filiali, agenzie di acquisto e di vendita nei Paesi in cui vendevano i loro prodotti», spiega Marina Amstad, storica del Museo nazionale svizzero, alla direzione del progetto.
Non furono però unicamente imprenditori, commercianti e banchieri a guardare con interesse ai traffici oltremare, ma anche missionari e ricercatori svizzeri. In particolare per chi era ridotto in povertà, partire per le colonie rappresentava la speranza di una vita migliore. Non solo: periti delle più diverse professioni vi trovavano impiego; funzionari riscossero le tasse; ingegneri costruirono ponti e ferrovie. I missionari svizzeri partivano con la volontà di portare la fede cristiana anche alle popolazioni locali di altri continenti. «Un caso interessante sono le cosiddette


“spose missionarie”: per molto tempo alle donne non è stato permesso di lavorare come missionarie. L’unica possibilità era un matrimonio combinato con un missionario. In molte erano disposte, senza conoscerlo, a trasferirsi dal loro futuro sposo in un Paese straniero, perché questo permetteva loro di condurre una vita assai indipendente», racconta Marina Amstad. L’intenzione del Museo nazionale di Zurigo non è assolutamente quella di fare un processo alla storia giudicando atti commessi in un contesto valoriale e sociale molto distante da quello odierno. L’opinione prevalente all’epoca tollerava la proprietà e il commercio di persone ridotte in schiavitù. Lo dimostra ad esempio il caso di Pauline Buisson, giunta in Svizzera nel 1776 come proprietà di David-Philippe de Treytorrens di Yverdon. Nel corso del XIX cresce però la consapevolezza che la schiavitù violasse i diritti umani. «In Svizzera sono inizialmente singoli circoli intellettuali - il gruppo di umanisti attorno a Germaine de Staël ad esempio, attivo a Coppet tra il 1786


e il 1817 - a sostenere la lotta contro la schiavitù con i loro scritti e il loro impegno politico. A partire dal 1858, vennero fondate associazioni e comitati contro la schiavitù, per lo più provenienti da ambienti religiosi. L’attenzione era rivolta alla lotta contro la tratta degli schiavi in Africa organizzata dai commercianti arabi. Ciononostante, il Consiglio federale difendeva la schiavitù ancora nel 1864 in un rapporto al Consiglio nazionale ri-
«Le ricerche attuali presumono il coinvolgimento di oltre 250 aziende svizzere nel commercio triangolare e nella deportazione di circa 172mila persone, in particolare a partire dalla metà del XIX secolo, quando l’industrializzazione e l’integrazione dei mercati globali hanno subìto un’accelerazione»
Marina Amstad, storica del Museo nazionale svizzero
guardante possibili disposizioni penali contro i proprietari svizzeri di schiavi in Brasile, affermando che si trattava di “un atto che non comporta un crimine”», ricorda la Direttrice del progetto.
La domanda che interpella a più riprese i visitatori lungo l’itinerario della mostra“Che ne è oggi?” - trova un fondamentale quadro di riferimento nella videoinstallazione interattiva sulle continuità coloniali in Svizzera, a cui è dedicata l’ultima parte
Le tracce del colonialismo in Svizzera

Diverse sono le associazioni che propongono visite guidate, mappe digitali e audioguide svelando le tracce del passato coloniale nelle città svizzere. Ong Cooperaxion è attiva a Berna, Thun, Neuchâtel e Friburgo; lo storico, cabarettista e attivista politico Hans Fässler offre diversi itinerari alla scoperta delle tracce (post)coloniali a San Gallo e dintorni; l’associazione Zürich Kolonial, fondata nell’ambiente accademico delle scienze storiche, propone un tour in 12 tappe a zurigo; a Winterthur studiosi di storia raccontano episodi dimenticati; mentre a Ginevra ci pensa il collettivo Afro-Swiss, e nuove iniziative continuano a nascere. Inoltre, sono in corso diverse mostre. Le principali, a partire da Zurigo:
• Museum Rietberg, In dialogo con il Benin. Arte, colonialismo e restituzione, fino al 16 febbraio 2025
• Museo etnografico dell’Università di Zurigo, I diritti del Benin. Gestione dei tesori reali saccheggiati, fino al 14 maggio 2025
• Collezione del Politecnico federale di Zurigo Tracce coloniali - collezioni nel contesto, fino al 13 luglio 2025
• Musée d’ethnographie de Genève, Ginevra, nel mondo coloniale, fino a 5 gennaio 2025
• Museo di Storia di Berna, Resistenze. Come affrontare il razzismo a Berna, fino al 1 giugno 2025
• Museo dei trasporti di Lucerna, Cacao, arte e colonialismo. La collezione di spedizioni di Philipp Keller, fino al 7 giugno 2026
della mostra, riflettendo anche sul ruolo del nostro Paese nell’elaborazione di questo passato sensibile. Un processo che richiede tempo, ma che ha visto compiere grandi passi. Ne fa parte a pieno titolo la discussione sulla restituzione di reperti e opere d’arte trafugate dalle ex colonie dei Paesi occidentali. «A differenza di molti altri musei di storia culturale, il Museo nazionale svizzero non possiede collezioni provenienti da regioni colonizzate. Tuttavia, numerosi oggetti come manifesti, album fotografici o manufatti con rappresentazioni stereotipate e razziste fanno riferimento al passato coloniale della Svizzera ed è importante contestualizzarli. La mostra presenta le storie di questi oggetti, finora poco conosciute», precisa Heidi Amrein, conservatrice capo del Museo nazionale svizzero. «Al contempo, vediamo come molti musei svizzeri che possiedono manufatti provenienti da culture non occidentali, entrati nelle loro collezioni attraverso collezionisti privati e istituzioni, stiano oggi esaminando criticamente questi oggetti, spesso in collaborazione con le parti interessate dei Paesi di origine. Progetti congiunti come l’Iniziativa Benin Svizzera possono portare a restituzioni, a nuove narrazioni nei musei o a ulteriori progetti congiunti», conclude Heidi Amrein.
Proprio l’iniziativa Benin Svizzera (Bis), lanciata con il sostegno dell’Ufficio federale della cultura nel 2021 da otto musei svizzeri a vocazione culturale-etnografica per identificare oggetti trafugati dall’Impero del Benin, sta dando vita in questi mesi a diverse esposizioni, come quella del vicino Museum Rietberg, ideata in collaborazione con partner nigeriani e della diaspora, avvalendosi dell’allestimento dall’architetta svizzera-nigeriana Solange Mbanefo, che si è ispirata a forme, geometrie e simbologie della sua cultura di origine per restituirne la sensibilità.
A chi volesse ulteriormente approfondire gli intrecci coloniali della Svizzera, si consiglia anche l’ultimo numero di Tangram, la pubblicazione annuale della Commissione federale contro il razzismo, che nella sua 47esima edizione (accessibile sul sito dell’Amministrazione federale, sezione Pubblicazioni) traccia un quadro il più possibile esaustivo sul tema, incrociando prospettive complementari che riflettono le ultime ricerche.
Susanna
Cattaneo
Guida al licenziamento - Cosa
devo sapere in caso di disdetta del rapporto di lavoro?
Isa Mariotta
Consulenza legale di Swiss Leaders, Esperta di diritto del lavoro

Lun 18.11.2024
18.00 - 19.15
Online, registrazione obbligatoria
Opposti, complici e complementari
La simmetria assiale di due percorsi che, nella loro complementarità, sono unitaria espressione di totalità: nel vuoto di Yves Klein e nel pieno di Arman si fronteggiano la smaterializzazione spirituale dell’essere e l’accumulazione seriale dell’avere. Ponendoli vis-à-vis grazie all’ispirato allestimento di Mario Botta, la mostra della Collezione Olgiati ne evoca la vertigine concettuale.


Fra i dualismi che attraversano la storia dell’arte - e con essa l’umano intuire di cui è espressione e l’equilibrio cosmico in cui si inscrive - quello fra pieno e vuoto si pone alle origini stesse dell’atto creativo con pari forza della dicotomia fra luce e oscurità. Se, come tale, è insito nella tensione generativa di ogni opera, unica rimane l’interpretazione congiunta che ne hanno dato due protagonisti del Nouveau Réalisme come Yves Klein (1928-1962) e Arman (1928-2005): il ‘guardiano del
vuoto’ e il ‘magnificatore del quantitativismo’, secondo la calzante definizione proposta dallo stesso Arman. Si erano conosciuti a scuola di judo, disciplina che per Klein rappresentò la prima esperienza della dimensione spirituale che avrebbe cercato di comunicare con la sua opera. Di lì a breve, su una spiaggia della loro Nizza, insieme al poeta Claude Pascal, i due coetanei e conterranei si sarebbero spartiti simbolicamente il mondo: ad Arman la terra e le sue ricchezze, a Yves il cielo e il suo infinito. Non una boutade: i loro per-
L’antitesi fra la smateralizzazione di Klein e il quantitativismo di Arman. A sinistra, l’iconica Sculpture Éponge bleue sans titre, (SE 263),1960 ca, 50 x 34 x 12 cm, nel blu identitario della ricerca dell’assoluto di Klein. A destra, Les ailes jaunes - Accumulation Renault n. 105, 1967, 164 x 120 x 115 cm. Con la casa automobilistica francese Arman ebbe una collaborazione di due anni che lo portò a realizzare 106 opere. In mostra, alla Collezione Olgiati, fino al 12 gennaio 2025.
corsi sono sempre proceduti paralleli e complementari, anzi si potrebbe dire che così sia stato anche dopo la prematura scomparsa di Klein, nel 1962, che con sua irreversibile assenza ha avverato in misura ancor più radicale il concetto di vuoto eletto a suo principio poetico.
Una corrispondenza esplicitata dalla nuova mostra della Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, Yves Klein e Arman. Le Vide et Le Plein, in programma fino al prossimo 12 gennaio. Impostazione concettuale e allestimento espositivo procedono all’unisono: Mario Botta ha magistralmente reinterpretato lo Spazio -1 rievocando una dimensione sacrale entro cui consentire il puntuale confronto fra linguaggi e poetiche dei due artisti proposto dal curatore Bruno Corà. Cinque absidi poligonali simmetriche - a sinistra Klein, a destra Arman - racchiudono nuclei fondanti della loro produzione, rivelando sottili rimandi, reciproche influenze, personali inclinazioni e progressivi avanzamenti. Un vis-àvis serrato, quasi fossero stanze di un comune poema, se come voleva Lao-Tze - punto di riferimento della visione di Klein - “è solo dal non-essere che si realizza l’essere”.
Una mostra che concretizza un progetto realizzato in vita solo in maniera imperfetta, differita, dai due artisti: immediatamente a seguire l’esposizione presso la Galerie Iris Clert di Parigi con cui il 28 aprile 1958 Klein, che compiva quel giorno trent’anni, portava all’apoteosi la sua interpretazione dell’immaterialità introducendo gli invitati in uno spazio vuoto, le pareti intonacate di bianco - intitolata Le Vide -, Arman avrebbe voluto proporre, a mo’ di dittico, la sua Le Plein, che dovette però attendere altri due anni per vincere le perplessità della galleria, che questa volta, era il 25 ottobre del 1960, saturata da oggetti, mobili e rifiuti accatastati, impediva l’accesso ai visitatori, costringendoli a sbirciare dall’esterno.
La sintesi, oggi finalmente attuata, presenta sessanta opere fra le più emblematiche dei rispettivi percorsi: sul versante sinistro, dedicato a Klein, si succedono nove splendidi
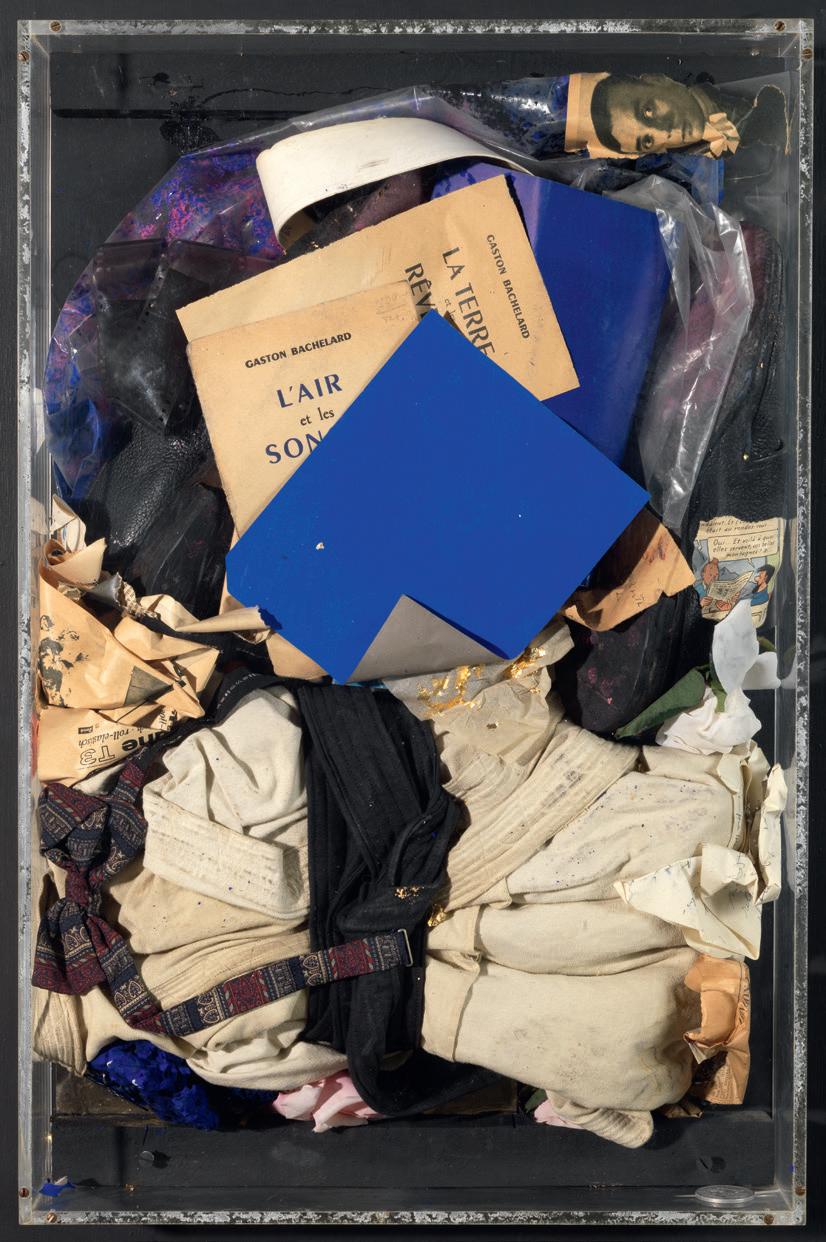
In questa pagina, i ritratti rivelatori che i due amici si sono dedicati a vicenda. Sopra, Arman, Premier portrait-robot d’Yves Klein, le Monochrome, 1960, 76 x 50 x 12
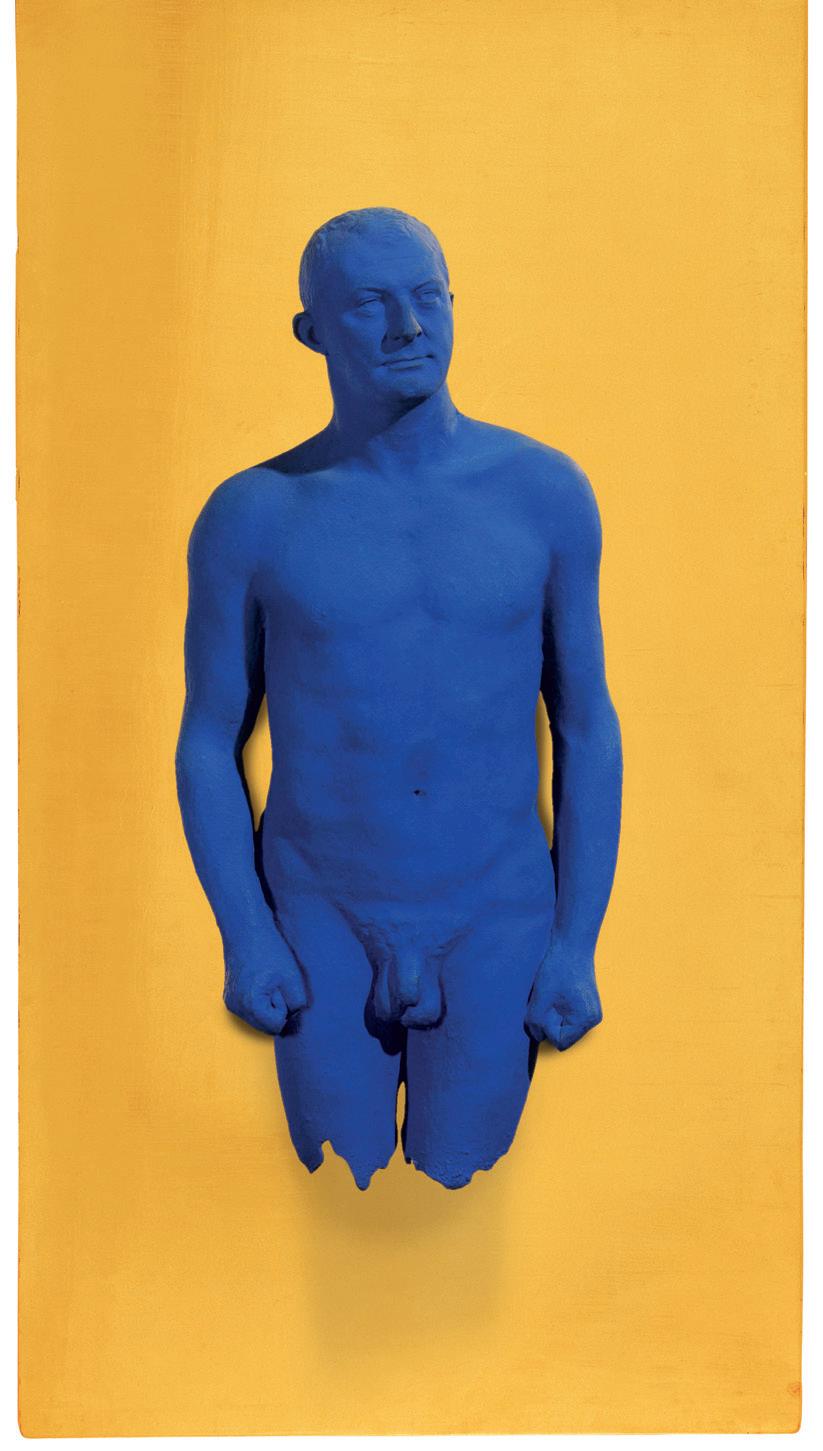
Monochromes, le impronte di cinque Anthropométries, una selezione di iconiche Éponges e di Reliefs, ma anche un particolare lavoro a quattro mani con Jean Tinguely come l’Excavatrice de l’espace, (S19), che introducendo la variabile del moto porta alla smaterializzazione ottica del disco blu di Klein; le Cosmogonies con i loro echi rosacrociani - dottrina che segna la formazione del giovane Klein come più tardi la filosofia zen - fino alle Peintures de Feu, elemento primigenio in cui trova “l’essenza dell’immediato”. In questa sala finale, si incontrano simbolicamente i due itinerari paralleli, laddove Arman del fuoco si serve come strumento del suo istinto distruttore, generatore al contempo di nuove forme, come il violino bruciato e poi conservato sotto resina del 1969. Conclusione preceduta da un excursus che, dai Cachets e le Allures d’objets in apertura, con cui Arman cominciava a catturare le impronte degli oggetti, passa alle Poubelles e alle Accumulations, con cui da fine anni ’50 la società dei consumi diventa protagonista delle sue opere: rifiuti, rasoi elettrici, tubetti di pittura, mani di bambole, ingranaggi di orologi, … compressi all’interno di plexiglass e teche di legno, diventano l’iperbolico memento della produzione seriale. Sezionando anatomicamente l’oggetto, Colères et Coupes ne svelano invece i meccanismi e le strutture interne. Infine giunge il confronto con l’oggetto della produzione industriale per eccellenza, l’automobile, con Arman a cogliere l’invito di Renault a utilizzare parti costruttive dei suoi modelli. Ne nascono 106 opere in due anni: accumulazioni iconiche e ironiche come Les ailes jaunes (1967) e Spaghetti-Sauce Renault (1968), entrambi presenti nell’ultima abside. Non bisogna cadere nell’errore di pensare che la prosaicità dell’arte per addizione di Arman esca sconfitta dal lirismo per sottrazione di Klein. Il percorso dialogico ne dimostra semmai la pari dignità. Perché se immenso è il salto gnoseologico che Klein ha fatto compiere all’arte introducendo la dimensione dell’immaterialità, Arman ha dal canto suo avuto il coraggio di assumere su di sé la quantità come aspetto poetico, in-
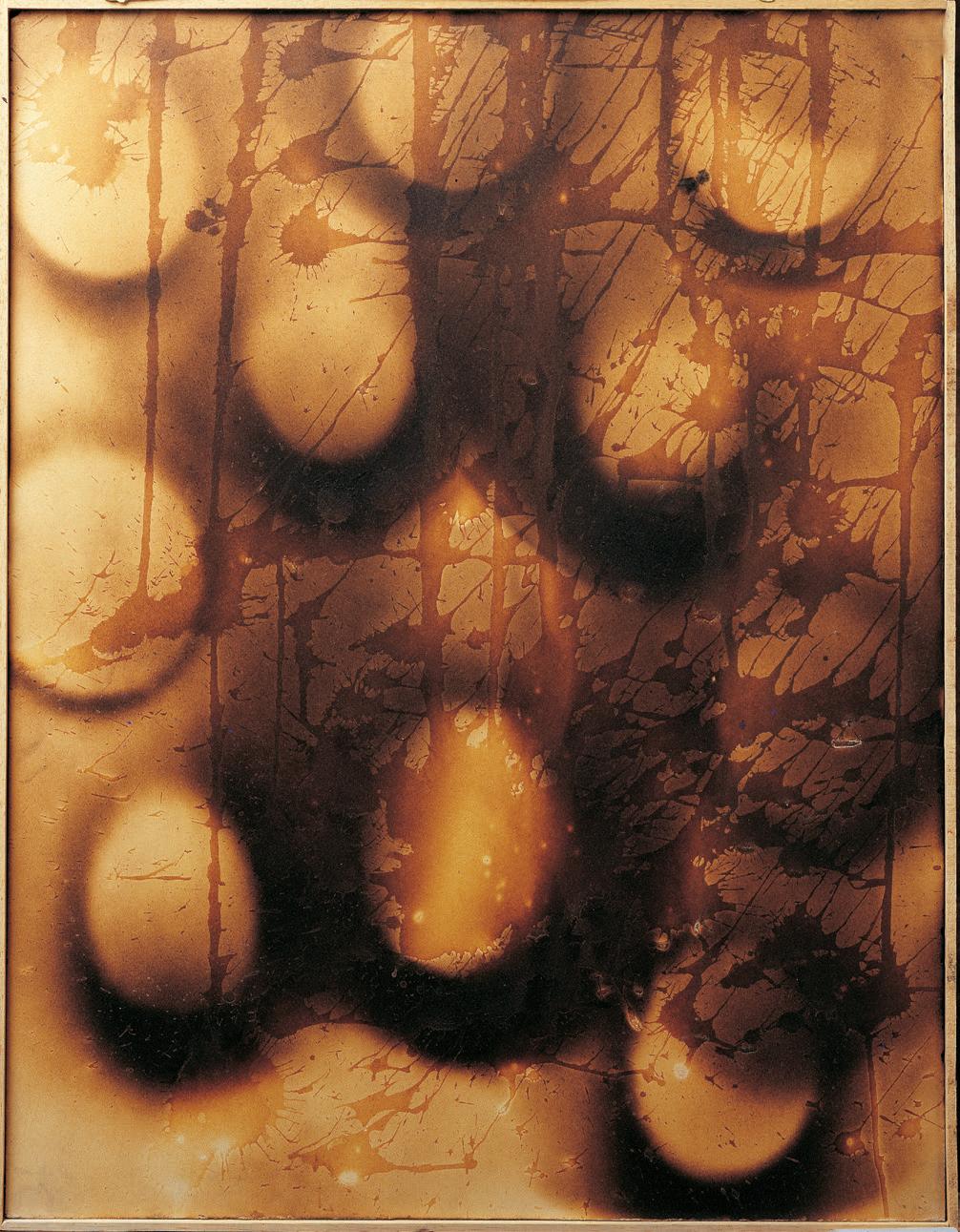
Il fuoco, strumento di distruzione e creazione per entrambi gli artisti: da sinistra, Klein, Peinture de Feu sans titre, (F13),1961, 65 x 50 cm; Arman, Antonio e Cleopatra (Colère), 1966, 200,5 x 160,5 x 21 cm.
tuendo come fosse lo Zeitgeist del contemporaneo. Stabilendo un rapporto viscerale con l’oggetto - e difatti non solo accatasta, ma seziona, maltratta, rompe, brucia i materiali raccolti, ... - un approccio molto diverso, malgrado una comune matrice, da quello dissacrante ma eminentemente concettuale di un Duchamp, che con i suoi ready-made elevava la merce ad arte ‘semplicemente’ ricontestualizzandola. La rarefazione in cui l’allestimento di Botta distilla anche gli accumuli di Arman - ulteriormente sottolineata dal gioco di estroflessioni e nicchie che scandisce ogni singola abside - ne rivela tutta la potenza e l’attualità. Due artisti sodali ma molto diversi fra loro, entrambi decisivi nella formazione della sensibilità artistica e dell’identità di collezionista di Giancarlo Olgiati. Fresco di laurea in
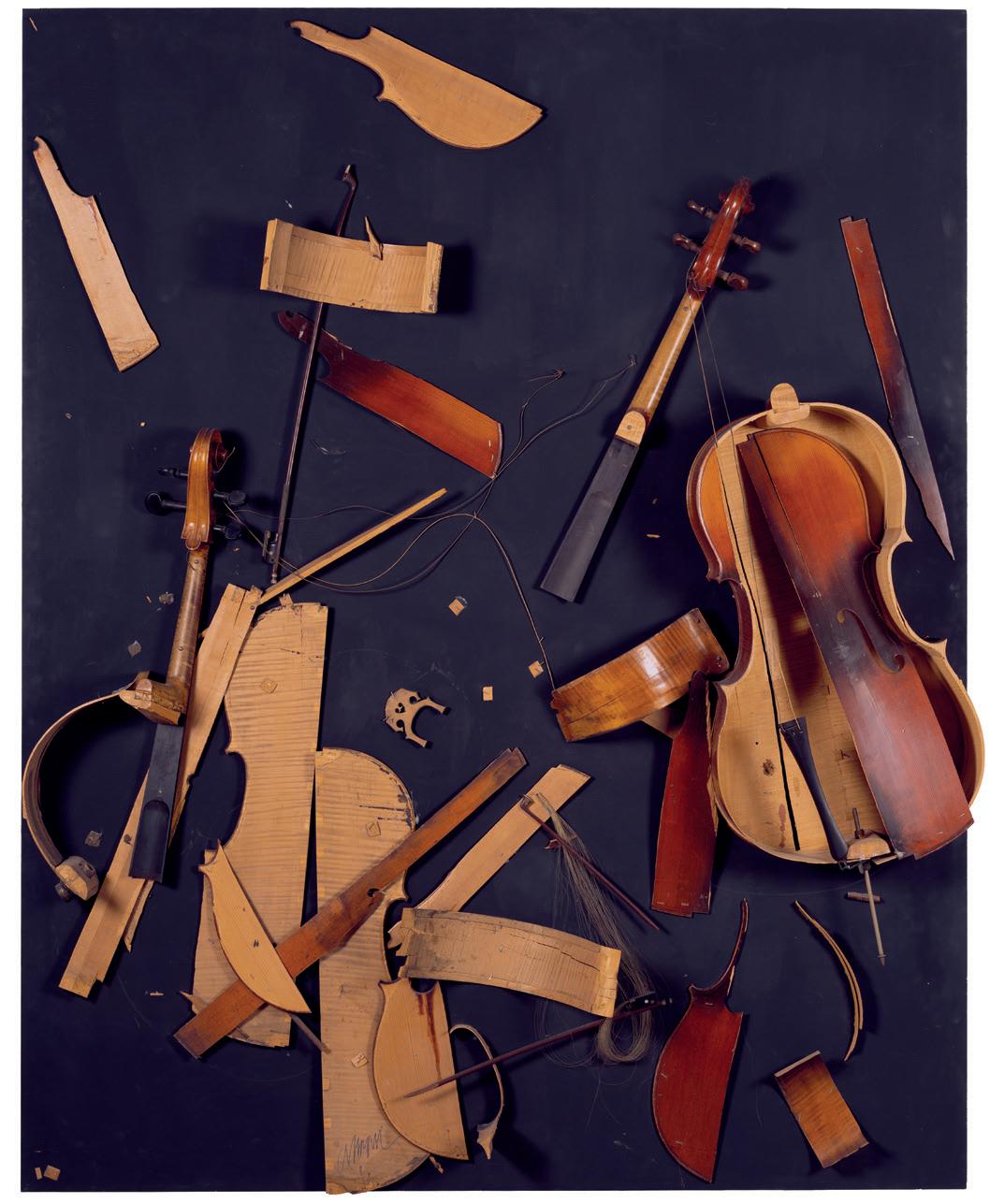
Economia e Diritto, inviato a Düsseldorf per un praticantato alla Commerzbank, è entrando per pura curiosità nella Galerie Schmela che ‘incontra’ i Nouveaux Réalistes e, soprattutto, Yves Klein. In quella piccola prestigiosa galleria d’Avanguardia che, insieme a Richter, Polke e opere del Gruppo Zero, esponeva una selezione di lavori del nizzardo, rimane folgorato dalla potenza rivoluzionaria di quella visione concettuale e spirituale. Non farà in tempo a conoscerlo di persona - Klein scompare due mesi dopo - mentre con Arman, che anche scopre in quell’occasione, stringerà una profonda amicizia e complicità arti-
stica, e sarà proprio Arman, suggerendogli di visitare la galleria Fonte d’Abisso Arte a Milano di Danna nel 1985, l’artefice del felice incontro (come nel 1957 lo era stato di quello fra Klein e Rotraut Uecker, ragazza alla pari presso la sua famiglia, con cui l’amico visse un’intensa relazione nei restanti anni, come ha ricordato la stessa vedova presente all’inaugurazione di questa mostra).

Maquette delle absidi pentagonali ideate da Mario Botta per sottolineare consonanze e antinomie dei linguaggi espressivi dei due artisti.
Nella nostra epoca in cui l’horror vacui trova un ‘economico’ antidoto in una produzione di massa che moltiplica non più soltanto le distrazioni materiali, ma altrettanto, se non più generosamente, quelle digitali - di fatto sancendo con il virtuale la scissione fra immaterialità e spiritualità - ogni margine per la ricerca dell’assoluto sembra essere occluso, soffocato. Perché spazio e tempo rimangono le due condizioni ineludibili dell’esistere e di ogni atto creativo. Con l’universale linguaggio dell’arte, questa mostra e le opere dei suoi due grandi protagonisti, grazie alla sensibilità di chi l’ha voluta e curata, sanno ricordarlo.
Susanna Cattaneo
Il caveau dei vini nel cuore dell'Europa
Temperatura, umidità controllata e massima sicurezza. Il place to be per il deposito e la conservazione delle bottiglie più pregiate, dell’arte e dei beni di valore.

Progettare secondo natura

Una stretta familiarità con la cultura locale e il rispetto per il contesto sono al centro di una architettura di ispirazione ‘vernacolare’. Una progettualità che sceglie di contenere l’impatto dell’antropizzazione sul territorio e si focalizza invece sulla triade uomo-natura-architettura. Di fatto, reinterpretando il passato in chiave contemporanea, per anticipare il futuro.
Idealmente, la progettazione architettonica dovrebbe realizzare un’armonia tra l’uomo e la natura, creare un nuovo sistema in equilibrio tra ambiente costruito e ambiente naturale attraverso l’integrazione dei vari elementi artificiali (edifici, arredi) nel contesto in cui essi si collocano. Sotto il profilo progettuale, l’indagine sulla relazione tra individuo e spazio architettonico e tra questo e la natura, è stata condotta e presa in considerazione con modalità e risultati diversi nel corso del tempo. Questa spinta aveva portato Frank Lloyd Wright a parlare di architettura ‘organica’, di cui il celebre architetto è ancora oggi considerato il ‘padre’, in quanto fautore di una progettualità incentrata su edifici in armonia con il contesto circostante, come testimonia la sua famosa casa sulla cascata.
Un’armonia derivante dalla fusione di elementi differenti, a partire da forme e volumi, che dovrebbero adattarsi e tenere conto delle necessità e delle opportunità della natura ospitante: luce, suoni, territorio, temperature, innanzitutto.
Un’ispirazione analoga ha dato vita all’architettura ‘vernacolare’ promossa da Bernard Rudofsky, venuta alla ribalta, nel 1964, con la celebre mostra Architettura senza architetti, al MoMa di New York.
I prodotti dell’architettura vernacolare sono costruiti secondo le condizioni climatiche del luogo, con materiali disponibili sul posto, le tecniche tradizionali e in totale equilibrio con l’habitat. Se ne parla con riferimento ad un’ampia gamma di strutture insediative, fabbricate per soddisfare esigenze specifiche, valori, economie e modi di vivere tipici delle culture che le
realizzano. Strutture che testimoniano la vita sociale e culturale passata e presente di un determinato luogo.
In sostanza, un’architettura in cui convergono antropologia, storia e geografia.
In apertura e nella pagina accanto, un’immagine dell’esterno e uno scorcio del living dello Chalet Kochau: un progetto dello Studio Peter Pichler Architecture. La facciata dello Chalet è caratterizzata da curve morbide e armoniose che passano con eleganza dalle travi alle colonne, creando un’estensione visiva verso le montagne. Realizzato in Austria, a Kitzbühel, questo progetto offre un’audace reinterpretazione dell’architettura vernacolare locale.
«L’architettura ha un legame forte con la natura, la cultura e la storia di uno specifico luogo», esordisce Peter Pichler, fondatore dell’omonimo studio di architettura. «La ricerca è la premessa di ogni nuovo lavoro al quale, come studio, ci dedichiamo. Con un interesse particolare per l’architettura vernacolare, spesso punto di partenza per una progettualità basata su materiali ed elementi che, combinati con la tecnologia, possono esprimere un’interpretazione contemporanea, anche radicale, del passato», prosegue l’architetto che, dopo gli studi a Vienna e negli Usa, ha collaborato con rinomati studi come Zaha Hadid Architects a Londra, Delugan Meissl a Vienna e Oma / Rem Koolhaas a Rotterdam. «Proprio l’architettura vernacolare offre spunti per affrontare tematiche oggi di grande attualità, dal risparmio energetico al mantenimento degli ecosistemi e degli equilibri del paesaggio», nota il progettista, per il quale «Comprendere la tradizione è la chiave per un’evoluzione sostanziale. Per questo in ogni nostro progetto incorporiamo una stretta familiarità con la cultura locale e il rispetto per l’ambiente naturale», aggiunge Peter Pichler, che di questi temi parlerà a Lugano, il 12 ottobre, come relatore, nell’ambito dell’evento LuganoLifestyle.
L’architettura ‘naturale’ si basa sull’idea che esseri umani e natura non siano entità separate, ma piuttosto un sistema interconnesso. Al suo nucleo, questo approccio si preoccupa della sostenibilità e dell’uso di materiali ecologici, privilegiando l’utilizzo di quelli di origine locale e rinnovabili, e incorporando sistemi energetici efficienti e strategie di design passivo per ridurre il consumo energetico dell’edificio e la sua impronta di carbonio.
«Non solo le modalità di progettazione e di costruzione affondano le proprie radici in tecniche del passato, reinterpretandole in chiave contemporanea, ma i nostri progetti includono anche l’uso di materiali del passato a cui viene data una nuova espressione. In tal modo si può rispondere alle esigenze specifiche di ogni committente, esplorando di volta in volta la versatilità espressiva di tali materiali. Tutto è sempre diverso: ogni progetto del resto, come ogni storia, è unico», aggiunge l’architetto che ha fondato lo studio Peter Pichler Architecture, a Milano nel 2015, con la moglie Silvana Ordinas.
La relazione tra architettura e natura non è certo una novità: «Fin dalle esperienze primordiali, si costruiscono strutture utilizzando materiali locali e adattando i progetti al clima e al terreno

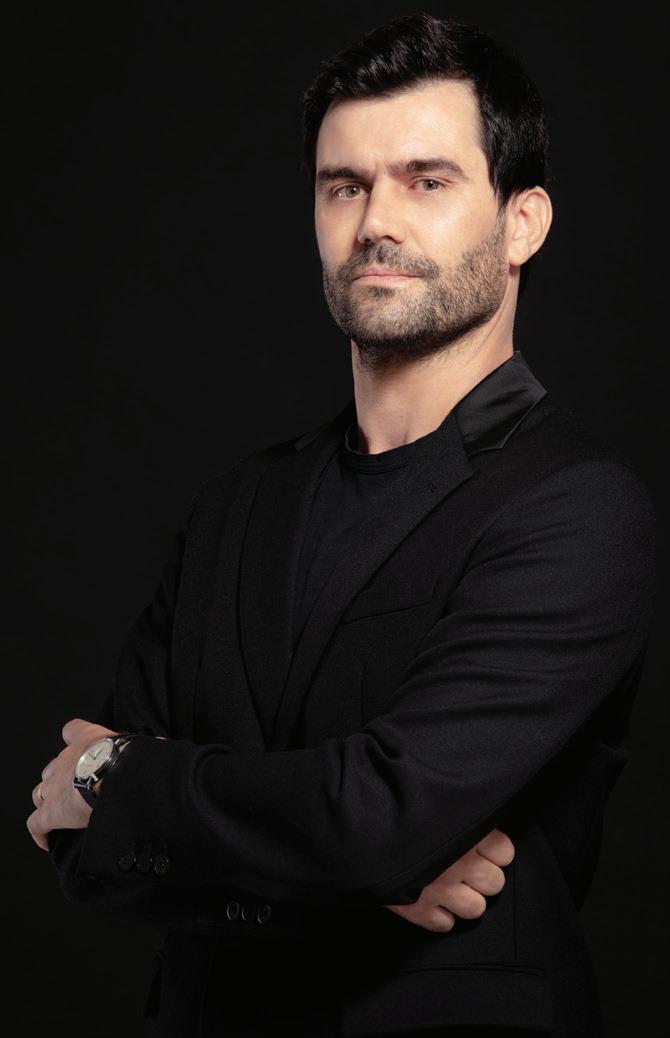
architetto. Fondatore, con Silvana Ordinas, dell’omonimo studio d’architettura. L’esperto sarà a Lugano, il 12 ottobre 2024 quando, nell’ambito di ‘LuganoLifestyle’, terrà una conferenza dal titolo “L’approccio contemporaneo verso architettura, urbanistica e design”.
circostante. In regioni calde e aride, con materiali che aiutano a regolare la temperatura interna assorbendo e rilasciando calore. Oppure, nelle regioni soggette a terremoti, con materiali flessibili in grado di resistere alle scosse. C’è un sapere che arriva da un tempo remoto». Ai nostri giorni, l’architettura naturale ha guadagnato nuova attenzione con lo sviluppo del movimento ambientalista e la crescente preoccupazione per il cambiamento climatico. Architetti e designer hanno iniziato a sperimentare nuovi materiali e tecnologie per rendere gli edifici più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico, non solo funzionali ed esteticamente piacevoli. Uno dei princìpi chiave di questo modo di fare architettura è la biomimetica, che comporta l’ispirazione dal mondo naturale e l’applicazione dei suoi principi al design. La struttura di una foglia per esempio può suggerire la forma di un edificio.
Tra gli altri aspetti salienti dell’architettura naturale, c’è lo sfruttamento della luminosità come pure della ventilazione naturali, per ottenere luce e raffrescamento senza uso di tecnologie. Incor-


porare grandi finestre, lucernari e altre formule e caratteristiche che consentono alla luce naturale di entrare nell’edificio e all’aria fresca di circolare non solo riduce il consumo di energia, ma crea anche un ambiente interno più sano e confortevole. Questa architettura in sintonia con la natura, che punta a creare edifici in armonia con il paesaggio, si basa pertanto sulla sostenibilità, sull’uso di materiali rinnova-
bili e sull’incorporazione di sistemi di efficientamento energetico. Mentre il mondo affronta sfide ambientali, non è dunque difficile immaginare che l’architettura naturale diventi ancora più importante nella definizione non solo dei singoli edifici ma in generale delle città del futuro.
«Gli stessi concetti utilizzabili nella progettazione di una singola struttura, valgono su una scala ben più ampia, fino
Sopra e a sinistra, due immagini che si riferiscono all’Oberholz, progettato da Peter Pichler Architecture. A 2000 metri, nel cuore delle Dolomiti, stazione sciistica in inverno e sentiero escursionistico in estate, presenta una struttura a sbalzo che cresce dalla collina come un albero caduto, con tre rami principali che creano una simbiosi con il paesaggio. Ognuno di essi è rivolto verso le tre più importanti montagne circostanti.
a interessare il disegno urbano nel suo complesso», nota l’architetto. L’antropizzazione del territorio, ovvero il nostro modo di edificare e trasformare i contesti naturali, i modi in cui produciamo e usiamo beni o servizi così come i nostri stili di vita - e per ‘nostri’ si intendono soprattutto quelli delle società occidentali e orientali fortemente sviluppate e di quanto queste hanno esportato nei paesi del Terzo Mondo - è divenuta impattante sugli ecosistemi locali e planetari, rappresentando un problema per il pianeta, le persone e molte specie animali e vegetali. Una situazione che sollecita gli urbanisti ad affrontare una nuova sfida: ridurre l’impronta ecologica delle attività umane sul pianeta rimodellando lo spazio insediativo, e utilizzare attivamente le capacità e la sensibilità collettiva nei confronti dell’ambiente, re-immaginando

le funzioni urbane, le forme degli insediamenti e le loro relazioni con i contesti paesaggistici e naturali.
Ma, quali forme di urbanità devono o possono assumere i contesti edificati per affrontare e rispondere efficacemente
agli effetti della crisi ambientale? Non si tratta tanto del progetto di nuove e più potenti strutture volte a contrastare o ad arginare gli effetti dei cambiamenti climatici - come tante del resto ne sono state realizzate durante il secolo scorso
A sinistra, la nuova sede di Bonfiglioli, a Bologna: non è solo un luogo di lavoro, ma testimonia al contempo il potenziale del design sostenibile nel settore industriale. Il progetto sfida la sostenibilità attraverso una geometria che consente una celebrazione della luce indiretta del nord in un edificio per uffici. In risposta alle condizioni di soleggiamento dei locali, il tetto dell’edificio è stato inclinato, ampliando la facciata nord per massimizzare lo spazio di lavoro con luce naturale indiretta, assicurando il massimo comfort a coloro che usano quotidianamente questi spazi.
la società, gli edifici) e Natura», conclude Peter Pichler.
Con un approccio contemporaneo, l’architetto parte dalla tradizione per rivisitarla e, in tal modo, anticipare il futuro. Pluripremiato, Peter Pichler è vincitore

il
Alto
La geometria della villa si evolve in base alle condizioni locali del sito, creando una transizione fluida e armoniosa con il paesaggio. La struttura a nastro crea un cortile interno che offre protezione dal forte vento proveniente dal Lago di Garda.
per proteggere le coste marine e fluviali e per rafforzare gli argini di fiumi e torrenti. Piuttosto, si tratta di prediligere strategie e tecniche che sappiano accogliere l’imprevisto climatico, prevedendone nel modo più naturale possibile la soluzione o almeno la gestione. «Che, al contempo vadano nella direzione di ricostruire relazioni più equilibrate tra Uomo (il singolo,
anche del premio “40 under 40” tra i migliori giovani architetti e designer emergenti in Europa, selezionato dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture e dal Centro Europeo per l’Architettura, l’Arte, il Design e gli Studi Urbani. Una visione, la sua, che non passa inosservata!
Simona Manzione
Il tempo è ‘social’
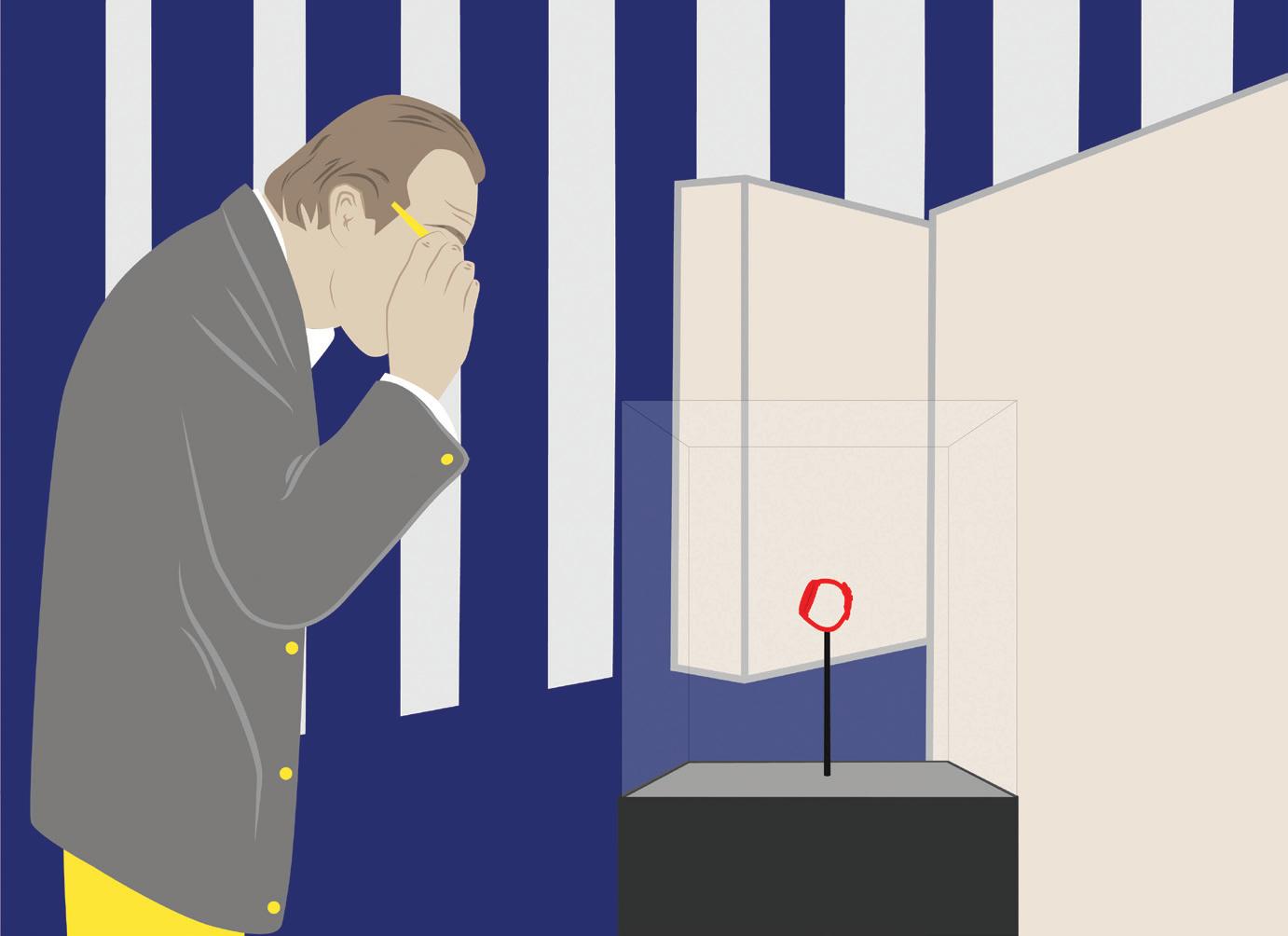
Grandi o piccoli, storici o giovani, la maggior parte dei marchi orologieri cede alle lusinghe delle piattaforme social. Il successo degli eventi fisici dedicati ai segnatempo conferma, tuttavia, l’importanza di un’interazione reale. Per i collezionisti, gli appassionati, i neofiti e gli stessi Brand. Lo conferma Jean-Christophe Babin, Ceo di Bvlgari Group e neo-presidente dei Geneva Watch Days.
Neppure un settore tradizionale come l’orologeria di alta gamma è rimasto semplicemente a guardare. Al contrario, si è messo in gioco e in vista ben oltre i confini delle vetrine delle sue lussuose boutique. I social media hanno cambiato il modo in cui i brand si presentano al pubblico, con un impatto che abbraccia tutte le fasce di mercato, dai modelli più esclusivi alle proposte entry level. Anche sul fronte delle vendite, l’online non è più un tabù per i marchi, sia i grandi sia i piccoli, ma un’occasione per andare incontro ai mutati comportamenti dei consumatori, all’interesse verso l’orologeria da parte di nuovi segmenti di pubblico - in primis, i giovani, sempre più attenti alle novità del settore - e per esplorare le potenzialità di mercati diversi.
Insomma (anche) l’industria dell’orologeria, storicamente legata alla tradizione e all’eleganza affascinante e rassicurante dei negozi fisici, sta vivendo una rivoluzione epocale.
Nonostante ciò, quando si parla di orologi la ‘fisicità’ per i più resta irrinunciabile. Sicuramente per l’esperienza d’acquisto nelle boutique, ma in parallelo anche per quanto concerne i momenti di aggregazione di una moltitudine che per gli orologi si prende il tempo!
Lo ha dimostrato, la scorsa primavera, l’evento ginevrino Watches&Wonders, e lo hanno confermato a fine agosto i Geneva Watch Days, alla quinta edizione. Di eventi e di orologi abbiamo parlato con Jean-Christophe Babin, Ceo di Bvlgari Group e, da qualche giorno, presidente dei Geneva Watch Days.
Signor Babin, congratulazioni per la sua recente nomina. Nuovo presidente dei Geneva Watch Days. Alla cui nascita aveva dato un personale impulso. Perché questo evento e come si inserisce nel panorama degli eventi orologieri in Svizzera?
La prima edizione dei Geneva Watch Days si è tenuta nel 2020, nel bel mezzo della pandemia, quando le tradizionali fiere orologiere di primavera erano state tutte cancellate. Pur evitando di riunirci fisicamente, non volevamo abbandonare, per ventiquattro mesi, la promozione della nostra creatività orologiera. Al contrario, dovevamo lanciare un segnale forte: il Covid non ci avrebbe fermato! Da qui l’idea un po’ azzardata di un evento decentralizzato e ‘phygital’ durante il quale ogni marchio avrebbe potuto lanciare i suoi nuovi prodotti nel proprio showroom, ma condividere una sede comune e servizi per eventi e prenotazioni di hotel e appuntamenti, nel rispetto delle norme sanitarie. Ho quindi chiamato alcuni amici per testare l’idea: Georges Kern (Ceo di Breitling) e Patrick Pruniaux (Ceo di Girard-Perregaux & Ulysse Nardin) sono subito ‘saliti a bordo’. Così è nato l’unico raduno multimarca dell’anno. All’epoca i marchi erano dieci, ne sono seguiti altri, e un po’ alla volta l’evento si è istituzionalizzato...
... Tanto che all’edizione 2024 hanno partecipato oltre cinquanta nomi. Qual è il valore per i marchi di un evento ‘fisico’ oggi e di questo evento in particolare? In effetti, il numero degli espositori è arrivato a cinquantadue. Questo dimostra la rilevanza del format: decentrato, autogestito, aperto al pubblico e ai collezionisti, un’organizzazione leggera che evita la complessità e ha livelli di contribuzione accessibili, anche per i piccoli marchi. Tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, si svolge puntualmente in un clima festoso e informale, con il Jet d’eau a far da sfondo. Ognuno può esprimere il proprio Dna in uno spazio personalizzato - hotel o boutique - approfittando del Padiglione per presentare i propri prodotti al pubblico durante il giorno e incontrarsi con gli altri
la sera. Quest’anno è stato aggiunto un nuovo spazio dedicato alle conferenze e ai forum di discussione, sempre nel cuore di Ginevra, alla Rotonde du Mont-Blanc. I Geneva Watch Days collaborano con la Fondation de la Haute Horlogerie e il Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Qual è il valore dei Geneva Watch Days nella diffusione della tradizione e della cultura orologiera in patria e all’estero?
In Svizzera, quest’anno abbiamo accolto 13.800 visitatori al Padiglione, dagli appassionati di orologi ai neofiti. Con un accesso sempre gratuito per tutta la durata dell’evento. Sono stati esposti più di cento orologi e sono state organizzate visite guidate. Altre attività hanno contribuito a far conoscere l’orologeria, tra cui dimostrazioni di abilità e mestieri. All’estero, a fare da cassa di risonanza al Salone hanno provveduto i seicentocinquanta professionisti dei media presenti, garantendo ai marchi partecipanti un’esposizione internazionale.
raneo a una prodezza tecnica che lo rende un orologio elegante e contemporaneo. Sa anche essere discreto, perché solo l’occhio esperto può distinguere un orologio a 3 lancette da 16.500 franchi da una ripetizione minuti da 150mila franchi. L’eleganza è sempre stata l’ossessione di Bvlgari nella gioielleria, e volevamo offrirla anche agli uomini attraverso una collezione di orologi ultramoderni ed extrapiatti, il che significava reinventare il movimento per ottenere una tale finezza. Ho lanciato la collezione poco dopo il mio ingresso in Bvlgari, per combinare il meglio dei due mondi: essere al passo con i tempi ma rompere i codici, sempre nel massimo rispetto dell’arte orologiera. In occasione dei Geneva Watch Days di quest’anno, abbiamo lanciato diversi nuovi modelli di questa collezione, tra cui l’Octo Roma Grande Sonnerie e il Carillon Tourbillon. La combinazione di design d’avanguardia e complicazioni orologiere tradizionali è il futuro dell’o-

Che progetti ha per il futuro dell’evento?
Negli ultimi due anni siamo stati molto attivi con i collezionisti, offrendo loro programmi speciali. Quest’anno abbiamo accolto oltre quattrocento collezionisti. Mi piacerebbe continuare su questa strada, perché è vantaggiosa sia per i marchi partecipanti sia per la diffusione della cultura orologiera. Quale tipo di orologio esprime la sua personalità?
Senza dubbio l’Octo Finissimo di Bvlgari, perché unisce un design ultracontempo-

Jean-Christophe Babin, Ceo di Bvlgari Group e neo-Presidente dei Geneva Watch Days, l’evento annuale dedicato all’orologeria.

rologeria. Ecco perché i Geneva Watch Days sono più importanti che mai. Non è una fiera, è un incontro informale, dinamico ma unificante, dedicato a perpetuare l’alta orologeria in modalità cool. Come sta andando l’industria orologiera? Quali sono le prospettive? Quest’anno stiamo assistendo a un rallentamento della crescita. Ma si tratta di un calo delle esportazioni di orologi svizzeri dell’1,4% rispetto al 2023, che è stato un anno record, caratterizzato da un’impennata anomala dei consumi post-Covid. Il
settore ha dato prova di resilienza in passato e dimostrerà di averne ancora molta in futuro. È tuttavia chiaro che il futuro non è lastricato di buone intenzioni, ma di iniziative coraggiose, innovative e creative.
I Geneva Watch Days sono l’incarnazione di un lusso agile, che rimette i clienti al centro dell’evento, ed è anche collegiale e rilassato, quindi il Gwd è un riflesso dei nostri tempi.
Simona Manzione
Visioni del tempo

Design ergonomici e temi celesti, per spingersi oltre i confini della maestria tecnica e dell’estetica. Le innovazioni dell’orologeria indipendente che anche i grandi gruppi apprezzano.

Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, l’orologeria svizzera di lusso è stata attraversata da una precisa tendenza modernista. A caratterizzarla, l’introduzione da parte di alcuni gruppi orologieri di metodi orientati all’efficienza; metodi spesso influenzati da pratiche di altri settori, tra cui ad esempio quello automobilistico. «Questo cambiamento ha portato a una frammentazione dei metodi artigianali tradizionali; la formazione è diventata più specializzata e segmentata, e l’artigianato olistico e pratico che aveva fino a quel momento
definito l’orologeria passava in secondo piano», nota Denis Flageollet, co-fondatore, con David Zanetta, del marchio orologiero De Bethune. «Da anni, tuttavia, gli stessi grandi gruppi, riconoscendo il valore dell’artigianato, hanno ripreso ad investire nella formazione e a ripristinare i metodi di produzione tradizionali, consapevoli che tali metodi sono essenziali per la sopravvivenza dell’industria orologiera di lusso», aggiunge Denis Flageollet. In questo scenario, De Bethune è nata nel 2002 con l’idea di fondere le tecniche orologiere del XVIII secolo con i progressi moderni. Flageollet, orologiaio di quarta generazione, e Zanetta appassionato di segnatempo storici, hanno puntato a creare orologi che fondessero l’eredità con l’innovazione tecnica. Da un approccio improntato a qualità e creatività è derivato lo sviluppo di oltre 30 calibri propri e di innovazioni come le anse flottanti brevettate nella collezione DB28. I poco meno di 200 orologi all’anno sono realizzati meticolosamente. «Ogni pezzo riflette l’artigianalità della sua creazione,
Sopra, DB Kind of Grand Complication. Un segnatempo particolare anche per la sua ‘reversibilità’: è infatti possibile alternare due quadranti, uno con un’indicazione contemporanea traforata e l’altro con un cielo stellato celeste in titanio azzurrato ornato di stelle in oro bianco.
dai componenti lucidati a mano alle intricate incisioni», aggiunge Flageollet. De Bethune ha siglato importanti progressi nell’architettura del bilanciere e della spirale, che ottimizzano la precisione dei suoi orologi. Per esempio il bilanciere in titanio e platino del marchio che, con un design leggero ma stabile, migliora le prestazioni cronometriche. Anche la curva terminale piatta brevettata per le sue spirali migliora la precisione riducendo al minimo gli errori gravitazionali. Infine, l’introduzione del sistema triplo pare-chute garantisce un maggiore assorbimento degli urti, assicurando prestazioni superiori in tutte le condizioni.
Dalla meccanica ai materiali, l’uso del titanio brunito a caldo è un segno distintivo del linguaggio di design del marchio, una sintesi di funzione e forma, come nel DB28 Kind of Blue. «Le nostre innovazioni nel corso degli anni sono state adottate da altri marchi, più grandi: dall’uso di viti in acciaio inossidabile alla colorazione del titanio», osserva Flageollet, «e l’innovazione resta la nostra linea guida». Con il DB28, che ha debuttato nel 2010 ed è identitario di De Bethune, l’uso innovativo di anse flottanti e di un bilanciere in titanio ha stabilito un nuovo standard sia per il design che per la meccanica. Il DB25 Starry Varius porta al polso un cielo stellato personalizzato sul quadrante, aggiungendo un tocco poetico a un orologio tecnicamente sofisticato. Entrambi i modelli hanno influenzato altri marchi indipendenti, ispirandoli a esplorare design ergonomici e temi celesti. Il 2024 ha arricchito la galassia De Bethune con segnatempo che incarnano il senso dell’innovazione e dell’eccellenza propri del marchio. Il DB Kind of Grand Complication, capolavoro tecnico dotato di otto complicazioni, tra cui fasi lunari sferiche, tourbillon ultraleggero di 30 secondi, secondi saltanti e calendario perpetuo. Il DB28XS Purple Rain, un’edizione limitata a 25 esemplari, che unisce design d’avanguardia e maestria tecnica, con un’esclusiva tonalità viola ottenuta grazie all’ossidazione termica del titanio. È compatto e leggero, con un diametro di 38,7 mm e uno spessore di 7,4 mm, ma conserva le caratteristiche anse flottanti per una vestibilità confortevole. «La Grand Complication, in fase di sviluppo concettuale da oltre un decennio, consisteva nel combinare numerose complicazioni che si erano evolute sin dagli inizi del marchio», spiega Flageollet, «Il DB28 XS, invece,
Sopra a sinistra, DB28XS Purple Rain: il motivo guilloché casuale del quadrante ricorda il riflesso del cielo notturno sull’acqua, con i perni in oro bianco che rappresentano le stelle, creando un dinamico gioco di luci.
Sopra a destra, DB28XS Aérolite: con cassa in zirconio nero di 39 mm e quadrante con un motivo guilloché casuale, armoniosamente contrastato dalle perfette linee geometriche del meteorite Muonionalusta.
mirava a racchiudere l’essenza della linea DB28 in un orologio più piccolo e piatto. Il processo ha comportato un lavoro intricato sui quadranti, comprese le finiture blu e guilloché, puntando sulla casualità per ottenere l’estetica desiderata. E c’è un’interazione tra i due progetti».
Il tema cosmico connota anche il DB28XS Aérolite, che trae ispirazione direttamente dalle stelle. Il quadrante è realizzato in meteorite Muonionalusta, con un motivo guilloché che ne esalta il fascino ultraterreno. Questo orologio, rivestito in titanio e dotato di anse fluttuanti, bilancia l’impatto visivo con il comfort. La collezione 2024 è completata dal DB28XS Steel Wheels, un modello che enfatizza la trasparenza e la luce. Il suo design traforato rivela l’intricato movimento sotto i ponti di zaffiro, con un movimento scheletrato e un bilanciere in titanio azzurrato.

A meno di dieci anni dalla fondazione, De Bethune ha vinto nel 2011, con il DB28, il prestigioso Grand Prix d’Horlogerie de Genève (Gphg), aggiudicandosi il premio “Aiguille d’Or”. «L’evoluzione dell’identità del marchio De Bethune è incentrata sul piacere di creare qualcosa di universale, che rifletta sia la storia dell’uomo che il momento attuale», osserva Flageollet, «I codici di design e la narrazione del marchio si evolvono attraverso una miscela di influenze culturali, artigianato e contesto globale». Una stessa logica e una continuità di fondo col-

Denis Flageollet, fondatore, con David Zanetta, del marchio orologiero indipendente De Bethune.

legano le varie referenze, sia attraverso elementi tecnici, che estetici o culturali. L’approccio del marchio non è quello di aderire strettamente alla tradizione, ma piuttosto di innovare e superare i limiti, proprio come facevano gli orologiai del passato. Questa filosofia di continua evoluzione ed esplorazione definisce De Bethune come produttore contemporaneo, ancorato alla tradizione ma con lo sguardo sempre teso al futuro, tanto da anticiparlo. Anche guardando le stelle.
Sergio Galanti
Fedele, dalle vette alle profondità
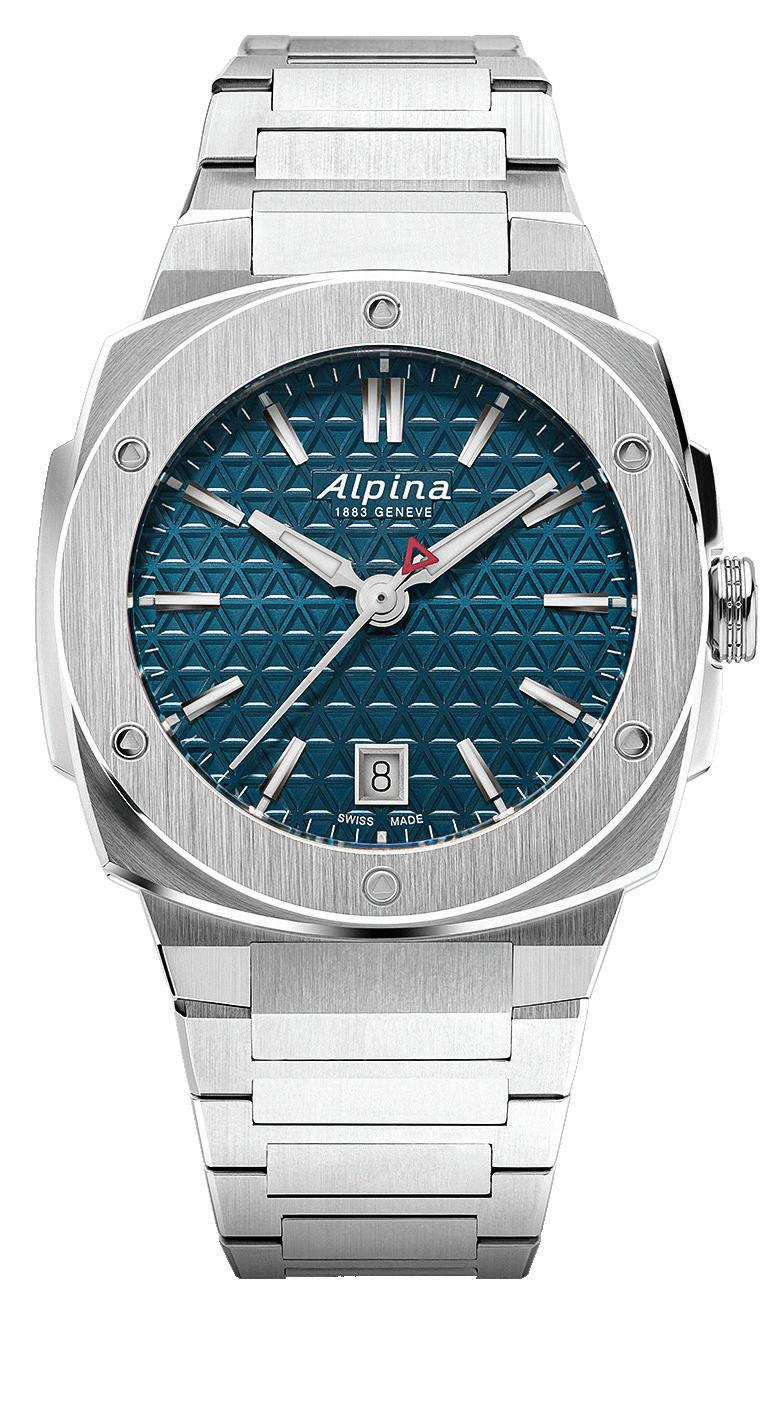
Èlizzato il proprio patrimonio nell’orologeria, conquistando sempre nuove generazioni di appassionati. Non solo in forza di un’eredità storica, ma anche per l’impegno nell’innovare costantemente. Fin dalla sua fondazione, nel 1883, ad opera di Gottlieb Hauser. L’iniziale attività di assemblaggio di componenti fu presto sostituita da un’attività di manifattura, che produceva anche i movimenti in casa. Alpina ha legato il proprio nome a vari settori: dalla montagna all’aviazione, fino agli orologi per immersioni. Un numero straordinario per l’epoca: negli anni Venti aveva già ben 2000 punti vendita. Con Oliver Van Lanschot Hubrecht, brand manager di Alpina, abbiamo ripercorso le tappe fondamentali del marchio.
Quando nel 1883 Gottlieb Hauser ha fondato l’azienda, la sua visione si basava essenzialmente sui ‘princìpi dell’alpinista’. Essere perseveranti, pensare in modo indipendente, fidarsi del proprio istinto, non dimenticare le proprie radici, sono stati fin dall’inizio i capisaldi di una azienda legata allo sport. Sempre originale, per prima, nel 1926, ha introdotto la garanzia internazionale per i propri orologi.
Segnatempo particolari, in cosa?
Alpina ha definito l’orologio sportivo nel 1938 con l’Alpina-4, introducendo quattro principi fondamentali: resistenza agli urti, proprietà antimagnetiche, impermeabilità e costruzione in acciaio inossidabile. Oggi, questi valori restano centrali nel nostro Dna. Continuiamo a combinare sportività, robustezza ed eleganza, con modelli versatili per ogni occasione e accessibili a molti.
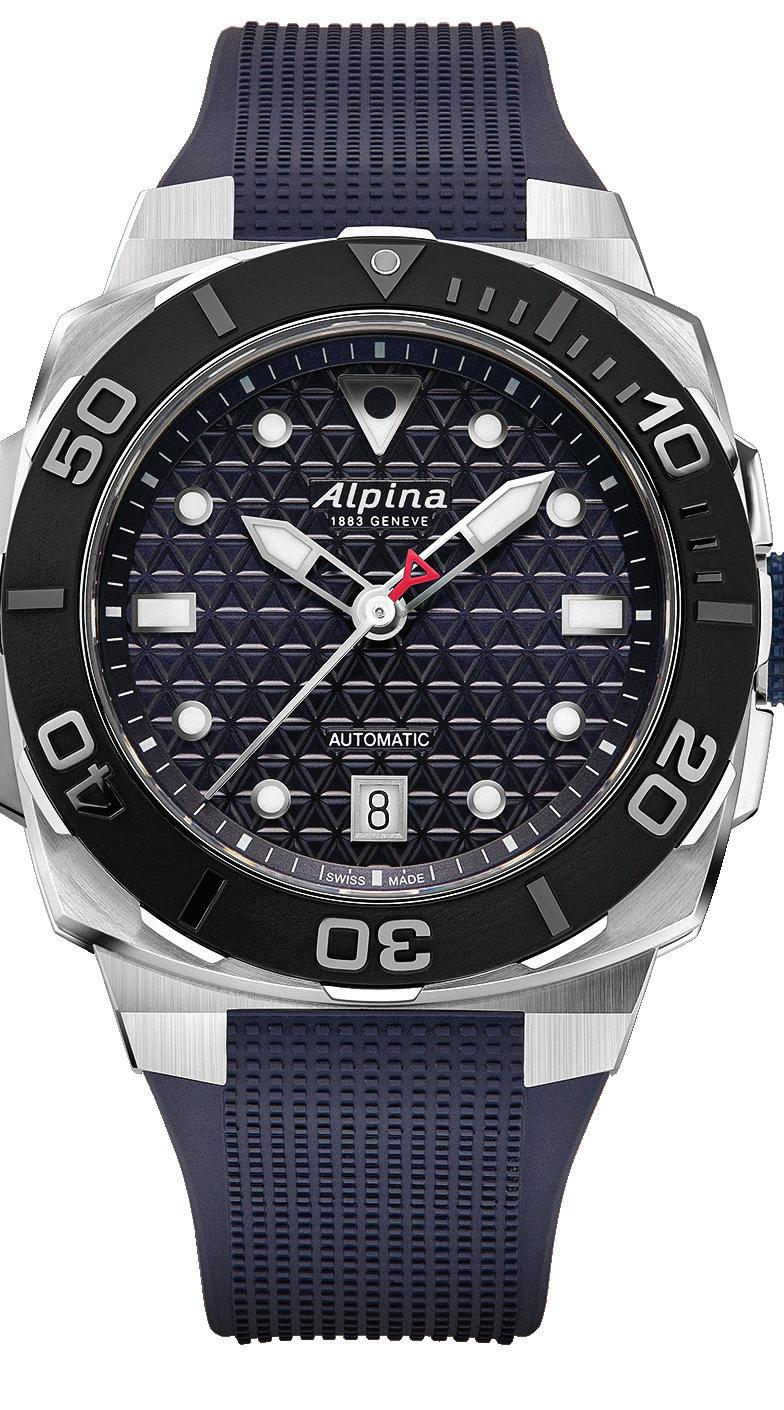
Qual è il modello più popolare di Alpina?
Le collezioni più vendute includono la cassa Extreme, ora parte della linea Seastrong, dedicata agli orologi da immersione con lunetta in ceramica. Abbiamo rilanciato la cassa nel 2022, con un design a cuscino in quattro parti che offre finiture esclusive. Offriamo varianti da 42 mm, 39 mm e 34 mm, per soddisfare diverse esigenze. Quest’anno, abbiamo introdotto un nuovo modello da 39 mm con quadrante scheletrato, mostrando la maestria artigianale del marchio. Quali sono stati i momenti salienti dell’ultimo anno?
Abbiamo celebrato, nel 2023, il 140° anniversario di Alpina, un traguardo importante. Tra gli eventi di rilievo, c’è stata una celebrazione ai piedi del Cervino e il lancio dell’Heritage Carrée 140 Years, che ha riscosso un enorme successo. Cosa ci riserva il futuro?
Per il futuro, ci concentriamo sul consolidamento del nostro posizionamento di mercato, mantenendo una gamma di prodotti chiara nella fascia di prezzo attuale.
In alto, Alpiner Extreme Automatic, con bracciale in acciaio. A sinistra, Seastrong Diver Extreme Automatic, con cinturino in caucciù.
Nella pagina accanto, da sinistra verso destra, due declinazioni della collezione ‘Heritage’: Heritage Carrée Automatic 140 Years e Heritage Automatic.
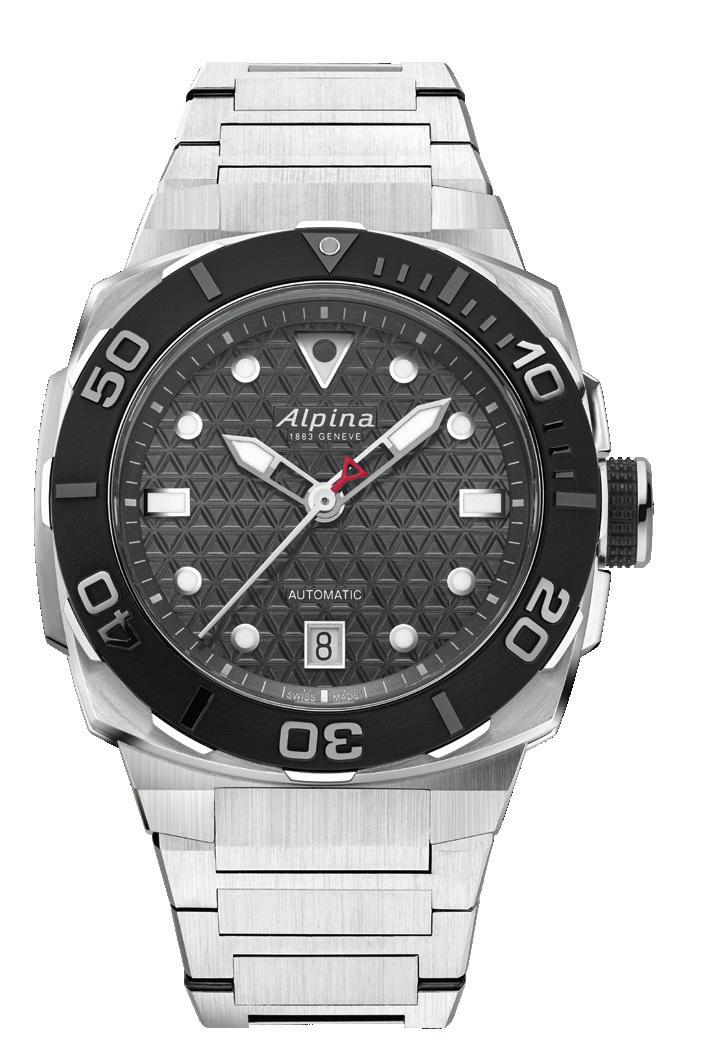
Continueremo a sviluppare la collezione
Extreme e ad espandere la nostra distribuzione in nuovi mercati.
Come è cambiato il marchio dopo l’acquisizione da parte del Gruppo Citizen?
L’acquisizione da parte di Citizen nel 2016 ci ha offerto maggiore stabilità finanziaria e nuove collaborazioni, pur mantenendo la nostra autonomia nelle decisioni strategiche. Questa sinergia ci ha permesso di crescere, rafforzando i nostri legami con mercati globali e marchi del gruppo, come La Joux-Perret.


Quali sono i mercati più forti per Alpina?
I nostri principali mercati sono gli Stati Uniti e l’Europa occidentale, in particolare Francia, Germania e Svizzera. Abbiamo grandi ambizioni per il futuro, inclusa l’espansione in Italia con 150 punti vendita entro il 2026. Vediamo anche grandi opportunità in Medio Oriente e India.
Chi è il cliente tipico di Alpina?
Il nostro cliente-tipo ha un’età compresa tra i 30 e i 50 anni, ama le attività all’aperto, ma spesso vive e lavora in contesti

Sopra, Oliver van Lanschot Hubrecht, Brand Director, Alpina Watches. In alto a sinistra, Seastrong Diver Extreme Automatic.
urbani. Stiamo anche attirando un pubblico più giovane, grazie a collaborazioni come il Freeride World Tour e l’Xtreme de Verbier, che ci permettono di connetterci con una nuova generazione. Quanto è importante l’e-commerce nel vostro caso?
L’e-commerce rappresenta una grande opportunità per noi, ma non può sostituire la nostra rete di vendita al dettaglio tradizionale, che resta fondamentale per affermare il marchio. Continuiamo ad espandere entrambe le reti per rafforzare la consapevolezza del marchio.
Qual è la produzione annuale di Alpina?
Non condividiamo cifre precise, ma prevediamo una crescita del 30% per quest’anno, con piani di raddoppio dell’attività nei prossimi 3-5 anni.
La sostenibilità non è semplicemente un proclama ma un impegno serio...
Sì, stiamo sviluppando una strategia di sostenibilità a lungo termine. Esploriamo l’uso di materiali riciclati o upcycled per collegare i nostri prodotti ai valori di natura e outdoor, contribuendo agli obiettivi del gruppo in tema di sostenibilità.
Maria Antonietta Potsios
In pista e oltre...



La mostra One of a Kind al Museo Enzo Ferrari di Modena è dedicata all’unicità, elemento che rappresenta una prerogativa della produzione Ferrari sin dagli esordi. Fin dalle prime granturismo troviamo esempi di creazioni speciali fatte su singole richieste quanto a forma, allestimenti, materiali e finiture per la creazione di pezzi modellati in base alle esigenze. Il particolare allestimento espositivo da
un lato valorizza al massimo le extra-ordinarie auto esposte, spesso mai viste prima dal grande pubblico, dall’altro mostra in maniera immersiva i programmi di personalizzazione a cui hanno accesso i clienti Ferrari: affascinante, una parete interattiva consente ai visitatori di fare un’esperienza fisica dei materiali, i tessuti, i colori e la vasta quantità di opzioni offerte dal Centro Stile Ferrari. La mostra è visitabile fino al 17 febbraio 2025.
Il Museo Enzo Ferrari di Modena e il Museo Ferrari di Maranello svelano agli appassionati del Cavallino Rampante quell’universo spettacolare, fatto di potenza, creatività, storia e passione che contribuisce ad alimentare il mito.
In apertura, Ferrari 812 Competizione Tailor Made: primo esemplare di una serie limitata di 999 pezzi. Al centro, Ferrari 166 MM, classe 1948, carrozzeria Touring, plasmata in ogni dettaglio secondo il gusto di Gianni Agnelli, come il particolare del bicolore blu e verde che riprende quelli della Famiglia di provenienza Savoia. In alto a sinistra, Ferrari Monza SP1 - 2018, prima della serie Icona, qui in color oro.
Rampante sempre
‘La piccola Indianapolis’. Fu soprannominato così il circuito cittadino attivo nella città di Modena fino al 1976. Noto a livello internazionale, grazie anche alle assidue frequentazioni di piloti, personaggi e dei marchi più popolari del tempo.
Una mostra in corso al Museo Ferrari di Maranello ne racconta l’epopea.
La mostra Roaring '50s in corso al Museo Ferrari di Maranello trasporta il visitatore nelle atmosfere di quegli anni, tra i primi Cinquanta e la metà dei Settanta, in cui la passione verso il motorsport era fervente e Modena ne rappresentava il cuore pulsante. Raccoglieva l’interesse di piloti, artisti, attori e aristocratici affascinati dall’esclusività delle vetture e dall’adrenalina generata dai capolavori prodotti nella Motor Valley ante litteram.
L’Aerautodromo di Modena nasce il 7 maggio 1950 dall’esigenza espressa dalle case automobilistiche del territorio che in quel periodo cercavano un luogo per le proprie attività sportive e di collaudo.
Nel suo periodo di attività, il circuito ha ospitato una grande quantità di eventi sportivi e di club, alla messa a punto delle macchine in preparazione delle competizioni più impegnative come Gran Premi, Mille Miglia e Targa Florio, coinvolgendo specialisti e appassionati accumunati dal piacere del motorsport e della guida veloce in moto e in auto, integrata a una attività aviatoria anch’essa attiva nella struttura.
Attraverso una raccolta di straordinarie immagini e inediti contenuti video d’archivio, la mostra racconta la storia del mitico circuito. Per gli appassionati e i nostalgici.
Simona Manzione

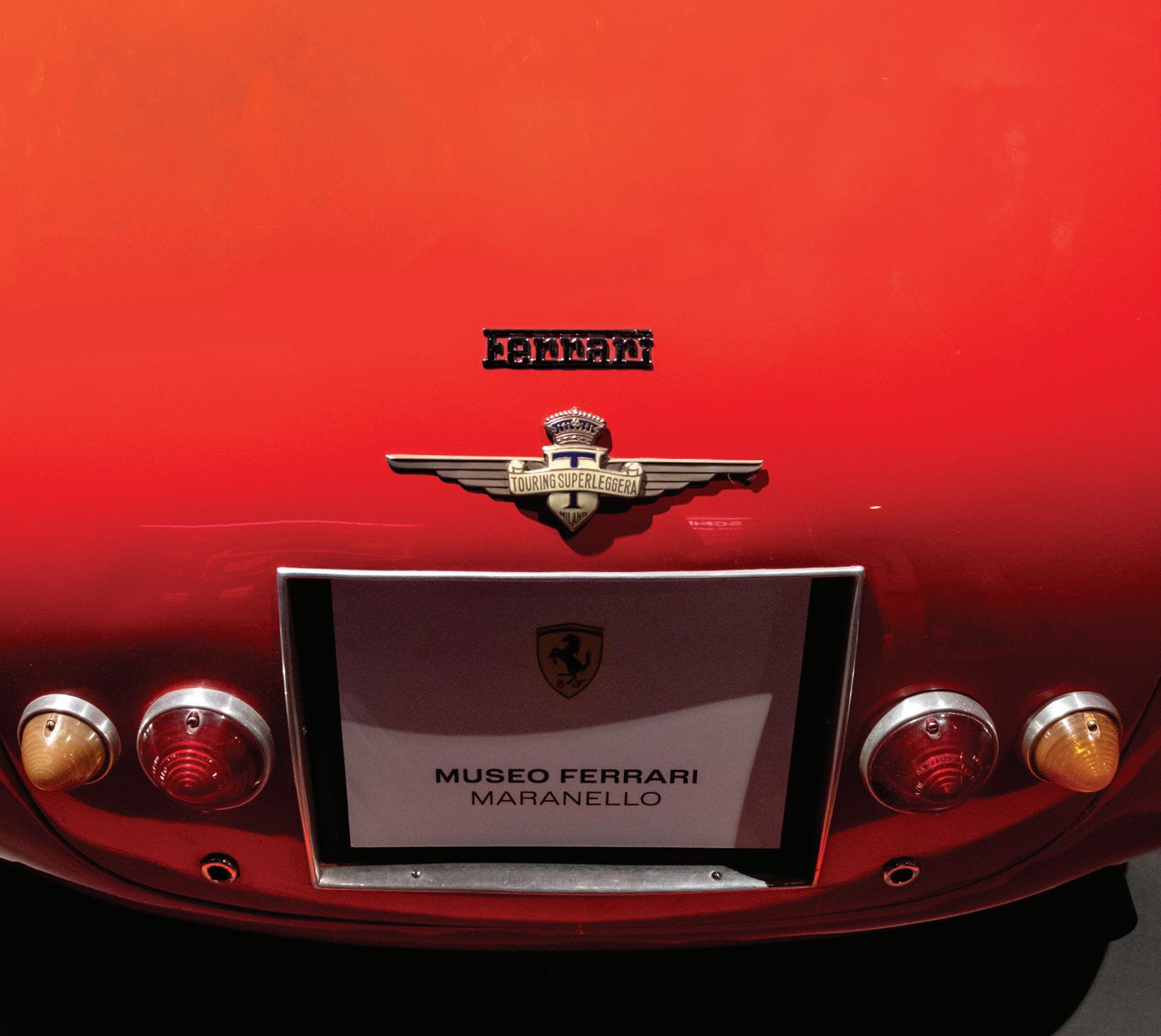
I visitatori del Museo Ferrari possono ammirare l’esposizione di due iconiche Ferrari: la 166 MM del 1948 che, nelle varie versioni a partire dagli anni ’50, veniva collaudata prima delle competizioni proprio sul circuito modenese, e la 315 S del 1957 (foto in alto) che ha visto i suoi primi test su questa pista prima di conquistare l’ultima Mille Miglia con Piero Taruffi.
Largo ai cavalli
Una volta potenza e capienza facevano soltanto rima sulla carta senza incontrarsi a bordo. Oggi alcune case automobilistiche uniscono prestazioni sportive e generosità di spazi in un solo modello, alcune addirittura in versione ibrida plug-in.

Land Rover Defender
110 P525 V8
Con il leggendario motore V8 Supercharged da ben 525 cavalli, la Land Rover Defender è uno dei fuoristrada più pazzi al mondo e non potevamo perdercelo poiché, con questa motorizzazione, lo specialista dell’offroad per eccellenza schizza da 80 a 120 km/h (come l’Audi RS5 provata l’autunno scorso) senza perdere il minimo delle sue capacità anche nelle situazioni estreme. Presentato 75 anni fa come modello destinato al trasporto militare e civile con trazione integrale e un design essenziale con dotazione spartana, decenni dopo lo spirito di quella vettura, nel frattempo evoluta in Defender, divenuta iconica e sinonimo di inarrestabilità, rivive nel nuovo modello per nulla essenziale bensì di lusso, in grado di trasportare comodamente i passeggeri su strada e, soprattutto, fuoristrada. Lusso e praticità sono stati dunque il paradigma nella progettazione degli interni della Defen-
Land Rover Defender 110 P525 V8

Sopra, la Serie Speciale Octa, in sole 50 unità, la Defender più potente mai costruita da oltre 600 Cv per correre fino a 250 km/h su ogni terreno.
avviene in 5,2 secondi fino a una velocità massima di 240 km/h con un consumo medio di 14,2 litri. A partire da 160.000.franchi.
der con plancia moderna e minimale, che richiama le Land Rover del passato. Offre ampi vani portaoggetti, numerose prese di ricarica e una combinazione di materiali ricercati, come il magnesio pressofuso, legno e pelle. Dettagli come i tappetini in gomma, più facili da lavare, o i pannelli porta con i bulloni a vista sono esempi delle soluzioni pratiche e stilistiche che caratterizzano la Defender e che ancorano questo modello al mondo del fuoristrada duro e puro, nonostante a bordo si respiri la qualità che si addice a un Suv di lusso. Non mancano vano portaoggetti refrigerato, pulsanti per abbassare la soglia di carico oppure lo specchio retrovisore digitale e, infine, l’immancabile sistema di infotainment, con connessione veloce e aggiornabile over-the-air. L’interfaccia è doppia e comprende uno schermo da 11,4 pollici che domina la plancia ed è abbinata al quadro strumenti digitale.
Il motore V8 da 5.0 litri offre 525 cavalli e 625 Nm, lo scatto da ferma a 100 km/h
Mercedes AMG C 63 S E Performance
La quinta generazione della Mercedes Classe C Amg è un’ibrida plug-in da 680 cavalli e oltre: velocissima, e con sterzo e sospensioni di ottimo livello. Quest’auto ha fatto discutere gli appassionati fin da quando le prime indiscrezioni hanno dato per certo il ‘trapianto’ di motore poiché non monta più un V8 4.0, ma il quattro cilindri di serie più potente di sempre, ovvero il 2.0 che equipaggia la Classe A 45 S, ma qui disposto longitudinalmente e, grazie a un turbo della Garrett ancora più grande, eroga 476 cavalli (55 in più). Ma non finisce qui: il 2.0 fa parte di un sofisticato sistema ibrido con un’unità elettrica posteriore da 204 cavalli, alimentata da una batteria da 6,1 kWh, ricaricabile anche via cavo - secondo le informazioni rilasciate dalla casa, l’auto può percorrere in media solo 12 km in modalità solo elettrica - ma è studiato per garantire le massime prestazioni piuttosto che per ridurre

consumi ed emissioni. Lo si nota subito alla guida: la batteria viene tenuta sempre piuttosto carica dal generatore che crea corrente ‘gratis’ in rilascio, ma viene azionato anche dal quattro cilindri, tanto che da questa prima presa di contatto ci è sembrato quasi superfluo pensare di attaccare l’auto alla rete elettrica.
La potenza è scaricata a terra dalla trazione integrale attraverso un cambio automatico a nove rapporti per il 2.0 e uno a due marce per il motore a corrente. Il sistema ibrido lavora con una notevole fluidità, senza incertezze o ritardi nella risposta. Fin dai primi chilometri si apprezza come la coppia motrice istantanea del motore elettrico si combini all’allungo del 2.0 turbo, che arriva molto in fretta alla zona rossa del contagiri, fissata a 7200 giri. Le prestazioni dichiarate sono di alto livello, con appena 3,4 secondi per lo scatto da 0 a 100 km/h e 280 km/h di velocità massima, e non dubitiamo di quanto dice la casa: la spinta è mozzafiato. Resta solo un po’ di nostalgia per il rombo ritmato del precedente V8: una vera e propria sinfonia per gli appassionati, ora sostituta dalla ‘voce’ un po’ piatta del quattro cilindri. A partire da 145.000.franchi.
Audi Q5 Sportback TFSI e quattro

Audi Q5 Sportback TFSI e quattro
L’Audi Q5 Sportback Tfsi e quattro è il Suv perfetto per chi cerca qualcosa in più rispetto ai classici motori termici, ma non è ancora pronto per passare all’elettrico puro. Grazie al motore ibrido plug-in, percorre oltre 50 km in modalità elettrica con il motore a scoppio spento, se la batteria è completamente carica (occorrono due ore e mezza per fare il pieno). Quando invece gli accumulatori sono vuoti, subentra il 2.0 turbobenzina a trazione integrale da 299 cavalli e infatti l’Audi Q5 Sportback 55 Tfsi passa da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi - grazie anche al cambio doppia frizione a 7 rapporti.
Il Suv medio di Ingolstadt, che è anche l’Audi più venduta nel mondo, è un’auto molto equilibrata. Due le carrozzerie disponibili, che differiscono soltanto di 8 millimetri in lunghezza. Ma è lo stile che fa la differenza tra le classiche forme da Suv o quelle della Sportback, con tetto degradante, montanti posteriori fortemente

inclinati e lo spoiler appena accennato. Sulla capacità di carico incide minimamente, con solo 40 litri di differenza: 550 per la Q5 Suv e 510 per la Q5 Sportback. A ogni modo, la strategia di avere due varianti di carrozzeria sullo stesso modello deriva dal fatto in Europa un’Audi nuova su due è un Suv e che anche le sfumature possono fare la differenza.
La Q5 Sportback ha anche un carattere più dinamico grazie a sterzo a servoassistenza con demoltiplicazione variabili e l’assetto sportive di serie. In questo modo il Suv tedesco è anche divertente da guidare, mentre all’interno c’è tanto spazio grazie al passo di 2,82 metri. Al centro della plancia domina l’ampio display da 10,1 pollici del sistema di infotainment Mmi Touch di terza generazione che è fluido, veloce e connesso.
Tornando all’utilizzo quotidiano della Q5 plug-in, è il conducente a decidere come sfruttare il plus di energia elettrica, se per consumare poco in modalità ibrida o per spegnere il motore termico entrando in una zona ad accesso limitato. A partire da 76.200.- franchi.
Claus Winterhalter


Un anno con noi
Edizione dopo edizione, in dialogo con i protagonisti, per approfondire l’attualità economica e finanziaria, e per raccontare tradizione e tendenze, dall’arte al lifestyle


Abbonamento annuale
Ticino Management (9 edizioni)
100.- Chf
Abbonamento annuale
Ticino Management Donna (4 edizioni)
35.- Chf
In combinazione
Ticino Management + Ticino Management Donna
125.- Chf
PER ABBONARSI
abbonamenti@eidosmedia.ch
Editore
Eidos Swiss Media Sagl • Via Lavizzari 4 - 6900 Lugano • info@eidosmedia.ch
Redazione
Via Lavizzari 4 - 6900 Lugano • Tel. 091 735 70 00 • redazione@eidosmedia.ch
Pubblicità
Tel. 091 735 70 00 · pubblicita@eidosmedia.ch
Abbonamenti
Annuo franchi 100.- (9 numeri) • Estero: supplemento postale • Tel. 0041 91 735 70 00 • abbonamenti@eidosmedia.ch www.eidosmedia.ch


