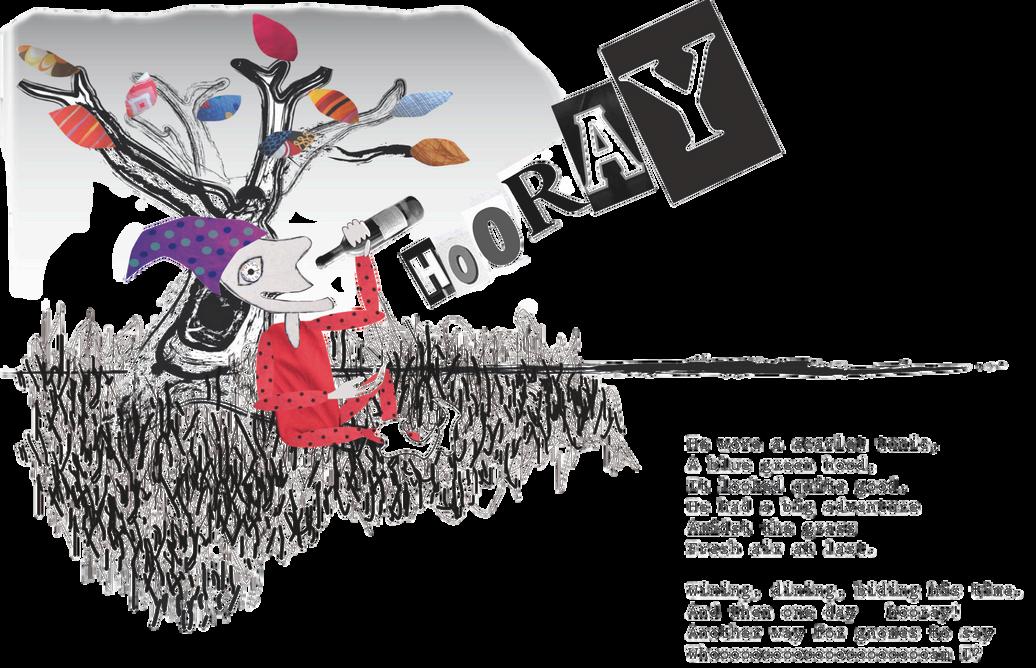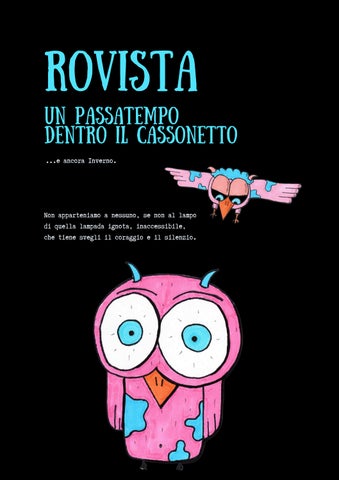un passatempo dentro il cassonetto
...e ancora Inverno.
Non apparteniamo a nessuno, se non al lampo di quella lampada ignota, inaccessibile, che tiene svegli il coraggio e il silenzio.


Il giorno che sono stata arrestata, dopo ore di attesa e tensioni in questura, mi sono sentita male e sono stata portata al pronto soccorso. Avevo forti dolori addominali e dopo un ’ecografia, piantonata da due guardie, il dottore mi ha detto freddamente di essere incinta. Così ho saputo della mia gravidanza.
Una telefonata fatta dalle guardie decretò che andavo comunque in galera e che poi " se la sarebbe vista un giudice", testuali parole. Sono stata trasferita al carcere di Rebibbia in infermeria 1 per minacce d' aborto. Non dimenticherò mai la prima volta che ho sentito il rumore della chiusura del blindo della cella; quella sera, come tutte le altre sere a venire, ho avvertito una morsa sullo stomaco feroce e un senso d' impotenza così reale da provocarmi il vomito.
L'infermeria 1 era abitata da donne con problemi di tossicodipendenza o con forti terapie di psicofarmaci. Col tempo ho capito che era un po ' lo "scarto problematico" del carcere, infatti vi era anche una infermeria 2 dove vi erano donne più mature con problemi cardiaci o con malattie croniche.
Io non credo che un uomo abbia mai vissuto l'onta di giudizio e umiliazione che vive una donna in carcere in attesa di un figlio, non credo che un uomo perché padre lo vivrà mai. Per mesi ho convissuto con le battutine, i giudizi ed i “consigli" sempre più insistenti di lasciare mia figlia in adozione, soprattutto dopo che i miei si rifiutarono di accogliermi ai domiciliari.
Ero sola, perché anche le persone più vicine a me preferivano il giudizio e l'indignazione all' empatia. Tuttavia io per questa bambina ho lottato così tanto e con tutte le mie forze contro tutto lì dentro.
Sotto l’infermeria 1 c ' era il giardinetto del nido, passavo i miei pomeriggi a sentire le voci dei bambini che giocavano, dalle sbarre riuscivo a scorgerne solo un pezzetto e immaginavo che anche mia figlia un giorno avrebbe giocato lì.
Ho pianto tutte le lacrime che avevo in quei primi mesi, poi ho reagito.
Le concelline conoscendomi hanno iniziato a volermi bene ed è stato l'unico affetto che io abbia ricevuto lì dentro, donne disastrate da un sistema che non ci perdona nulla, emarginate, recluse… eppure, capaci di amare più di ogni altro.
Ho fatto tutta la gravidanza in carcere, ricordo che con il blindato mi portavano alle visite all' ospedale Pertini, la mia pancia cresceva e con lei i giudizi della gente.
L’ultimo mese sono stata trasferita all'infermeria 2, da lì non sentivo più le voci dei bambini al piano terra. Mi avevano comunicato la data del parto programmato, passai lì il Natale, la fine di un anno e l'inizio di un altro senza che niente succedesse, senza nessuna rassicurazione sul futuro, senza sapere cosa sarebbe stato di noi, senza affetti, senza amore mi accingevo a far nascere questa bambina in carcere.
La mattina del parto, all'alba, sono stata portata col blindato all'ospedale Pertini, al protetto. Ho atteso lì, su una sedia a rotelle e ammanettata che mi chiamassero per partorire C'era tanto silenzio, un silenzio irreale e ascoltavo il mio cuore battere forte nell'indifferenza generale.
Portata al reparto, tra donne in attesa di felicità transitavo verso la sala operatoria. Mi hanno fatto un cesareo ed ho sentito la mia bambina piangere e mi sono sentita piangere… l'ho guardata per pochi secondi e poi via, ci hanno divise. Dopo non so quante ore hanno deciso di portarmi al reparto "normale" e mi hanno fatto vedere la bambina.
C'erano le guardie che facevano avanti e indietro e le persone passavano davanti alla mia stanza per vedere la faccia di questa donna orribile.
Ricordo che un'infermiera mi abbracciò forte e mi disse che ce l’avrei fatta, prima di andare via le regalai il libro che mi ero portata “I giorni dell'amore e della guerra" di Tahmima Anam, a cui mi ero aggrappata per non pensare.
Dopo forse tre giorni con tutti i punti del cesareo sono stata trasferita al nido di Rebibbia. Il nido è il carcere. Il carcere, capite, con le celle, le sbarre, il blindo che si chiude la sera a doppia mandata, con le guardie, con le regole e con i bambini.
Faceva tanto freddo, rispetto all'infermeria da dove venivo c ’ era molta distanza tra tutte noi, poca empatia ed è paradossale vista la situazione delicata in cui vivevamo. Ma poi ho capito, si sentiva così forte l'istinto di sopravvivenza che pensare a sé e al/alla propri* figli* per non soccombere, era la priorità. Mia figlia era l’unica neonata e dopo qualche giorno si ammalò di bronchiolite, mi dissero che se non migliorava con la cura che le facevano loro l'avrebbero ricoverata in ospedale, ma senza di me.
Ero terrorizzata dal fatto di non vederla più, ho chiesto a chiunque di aiutarmi, ero stanca dal parto, non avevo latte, non dormivo più e rompevo il cazzo a chiunque È stato un momento così difficile che ancora oggi non riesco a raccontarlo. Dopo qualche mese andai in una comunità donne con bambini con una pena sospesa da scontare e lasciai alle mie spalle il carcere.
Oggi dopo tanti anni racconto questa storia perché sono ai domiciliari per quel reato, un reato che appartiene ad una donna che non c'è più, una donna che ho perdonato e con cui il destino mi mette ancora a confronto riportando alla luce solo ed esclusivamente antichi dolori e infiniti veleni.
Sono ai domiciliari con i miei figli, ormai adolescenti, obbligati a vivere questa situazione di restrizioni. Sono tante le sensazioni che mi attraversano scrivendo queste righe, tuttavia il mio pensiero va ' a tutte quelle donne che vivono lì dentro, che hanno vissuto lì dentro e che purtroppo ci vivranno ancora… e che, oltre alla tortura del carcere, sentono l'onta continua di giudizio e umiliazione perché donne e madri.
Tutta la mia solidarietà e la mia rabbia è con voi e così sarà sempre. Vi abbraccio forte, non mollate.





in ordine:
grafite su carta 55,5x27
tecnica mista su carta 20,6x28,9 acrilico su cartone telato 24x18
Tristezza e gioia nella vita delle giraffe
SCENA 14
JUDY GARLAND. - Hai paura. E’ chiaro che hai paura, cazzo. Sei nell’ignoto. Sei immersa nell’ignoto e hai paura Cazzo Maledizione E qual è il problema? Corriamo, cazzo. Corriamo e non sappiamo verso dove. Non è forse così?
Se non sai dove ti trovi e ti metti a correre non puoi sapere verso dove corri. Che fai? Ti orienti col dannato sole, non è così? Corri - e questo è quanto?
Fanculo, cazzo. Prima di noi, tutti si sono messi a correre. Cappuccetto Rosso. Hansel e Gretel Alice Appena hanno capito di essersi persi hanno iniziato a correre. Sapevano verso dove correvano? No cazzo. E pensi interessi a qualcuno? Chi sa davvero dove va? Tutte le persone che incrociamo mentre corriamo pensi che sappiano dove vanno? Se glielo domandi ti risponderanno di si. Vanno a lavoro, vanno a casa. Ma poi? Poi vanno a casa e a lavoro, cazzo. E questo si chiama sapere dove si va? No, porca merda Questo si chiama girare in tondo, fanculo porca merda. Anche se sai dove sei, non sai mai dove vai.
Possiamo tutti morire da un momento all’altro. Cade un meteorite e ce ne andiamo tutti come dei coglioni Chi sa davvero dove va? Nessuno, cazzo Se ti dicono di si è una bugia, fanculo. Ci siamo persi, tutti.
Siamo tutti naufraghi, cazzo Hai paura? E quindi? Anche io ho paura, cazzo
E non è bello? La paura che fa ribollire il sangue, che fa sudare, che fa male ai muscoli Cazzo se è bello! Corri, maledizione Corri perché ci siamo persi Fanculo, non mi ero mai perso ragazzina Sempre chiuso a casa, sempre davanti alla televisione ad aspettare che rientri da scuola, sempre a giocare in cameretta o in bagno Sempre a girare in tondo, a sapere dove mi trovo Pensavo che sarei morto senza essermi perso neanche una sola volta. E adesso, corriamo, cazzo E tutto grazie a te Fanculo Grazie ragazzina E’ bello Ci siamo persi. Veramente persi. Realmente persi. Non sappiamo più dove siamo né dove andiamo. E’ bello, cazzo. Sono un orso, sono un peluche, e mi sono perso
traduzione di Mandarino della traduzione di Thomas Quillardet del testo teatrale di Tiago Rodrigues






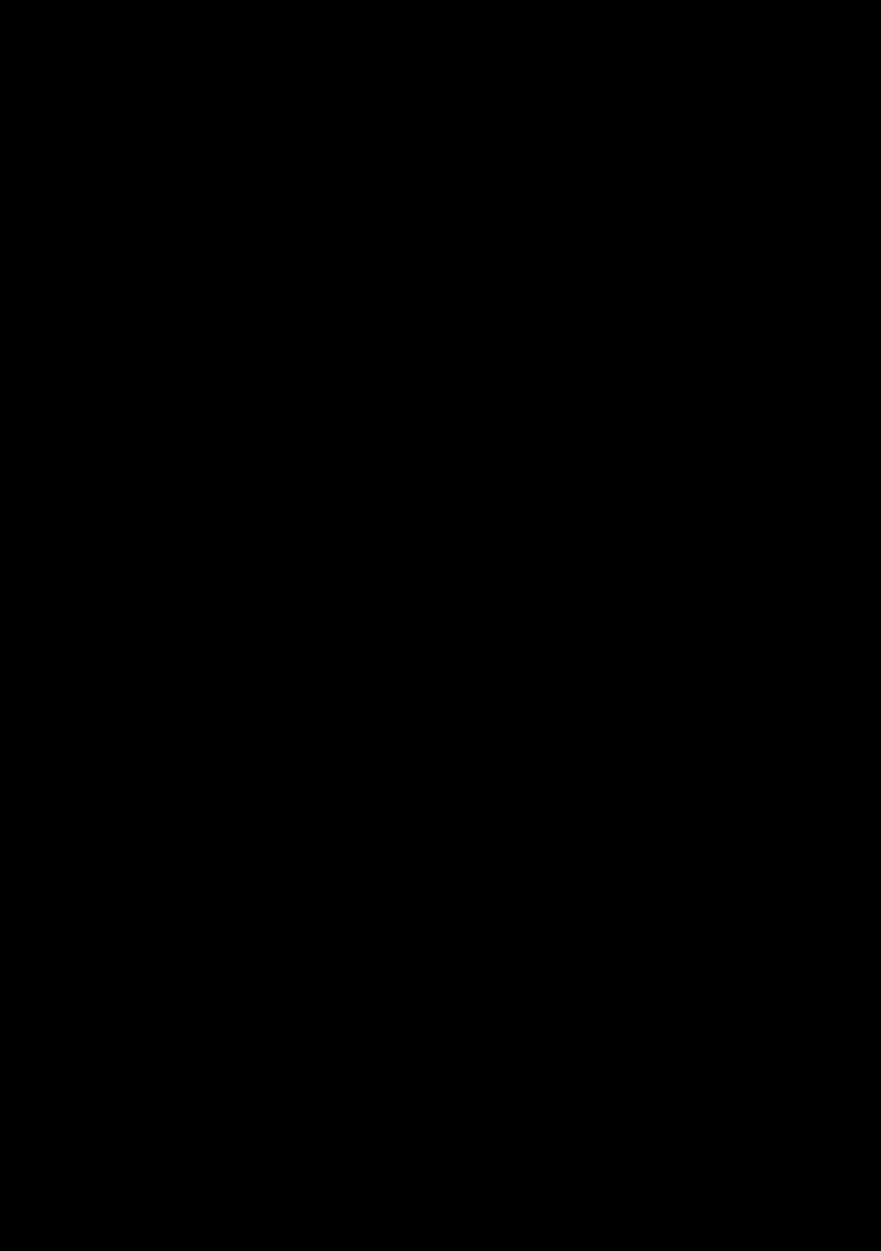
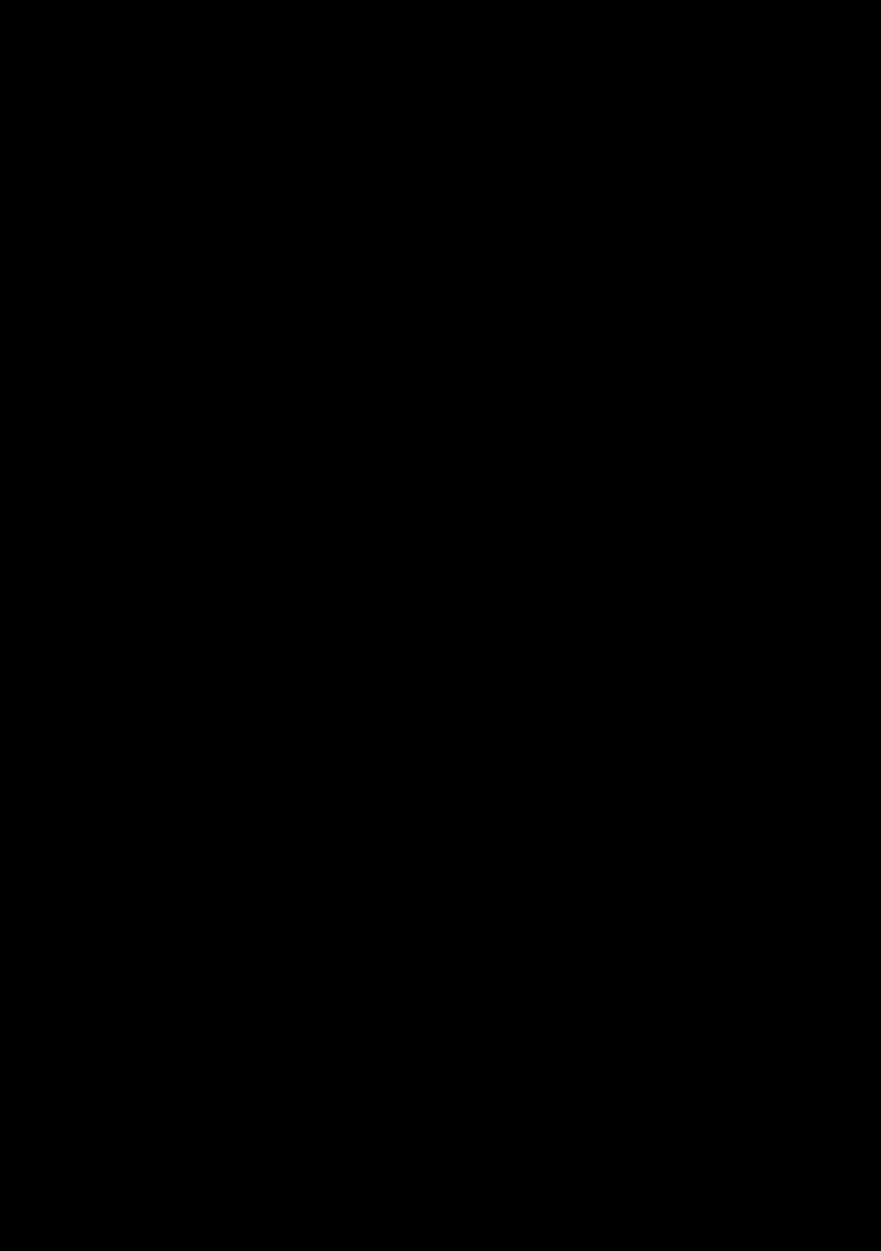

Celebrazione di un dolore per un amore finito
OVVERO QUELLA VOLTA
CHE MI SONO CONCESSA
IL SENTIRE TUTTO
Mi adorno di ghirlande e luci, mi vesto di brillanti e sofferenza, la indosso come la migliore camicia che ho nell’armadio, la prendo dalla sua stampella di plastica inutile e come una seconda pelle mi ci infilo dentro, è stretta, pizzica, non è molto comoda ma è sfarzosa, tutti e tutte intorno si accorgono che la indosso, sono tentata di togliermela quella camicia, mi guardano e se ne parla, sento il vociare altrui e quello della mia anima che a tratti si vergogna, come se soffrire fosse un crimine, delinquente della non gioia, la mia faccia mente, i miei occhi guardano il vuoto, ma quella camicia parla per me, per i miei occhi e pure per la mia bocca che ridicolizza me stessa, l’ironia esce da essa con un futile blabla, un'arma tagliente con la lama al posto dell’impugnatura, mi sanguina la pancia, lo stomaco, il ventre ogni volta che faccio ironia sul lutto di un amore vero, finito perché incapace di parlare seriamente, non mi sono concessa la serietà e il dolore e ora lo indosso con eleganza a giorni, altri sembra un brutto cappotto sgualcito, lurido come un bradipo pieno di muschi che neanche riesce a lavarsi, così io e quel cappotto di sentire tutto, il puzzo di vecchio di quel cappotto è nauseante, vomito a terra e mi ripulisco la bocca con la manica della camicia sfarzosa
Come quella volta che ho fatto ironia sulla morte di mia nonna, dentro andava tutto male, eppure l’unica cosa che sono riuscita a fare è prendere in giro la morte di fronte a tutte le persone presenti, anche fuori dalla chiesa: il dolore non è concesso, dobbiamo ridere, dobbiamo essere positive, che altrimenti le energie negative ci portano altro male; allora decido di rimettermi la camicia sgargiante del dolore, la sento così scomoda ma ne ho bisogno, mi guardo allo specchio e non mi rappresenta, ma per qualche astruso motivo non voglio e non posso più toglierla, in fondo mi è sempre piaciuto danzare nel fango e nell’argilla sporca. La camicia rimane sulla pila di panni che ho sulla sedia, si mescola e si nasconde tra il pantalone della nostalgia e la canottiera della rabbia, a volte ho imparato a indossare tutto insieme, i pattern non stanno bene tra loro, l’assenza di stile mi appaga, i tessuti sono ruvidi e infeltriti, sono ridicola, brutta, ancora più ridicola se sorridente. Perché non riesco a togliermi dalla faccia quel cazzo di sorriso? Che maledizione grottesca è quella di non saper soffrire pubblicamente o forse di non saper soffrire affatto?
Allora prendo gli stivali del lutto, hanno un tacco non molto comodo, ma sono bellissimi, emanano una luce propria, sono dello stesso colore del glicine, quando li metto ai piedi mi sento una falena meravigliosa che è pronta per la notte, che vaga preziosa ma rimbambita, sbattendo tra una parete e un’altra, alla ricerca di una luce che sa già la porterà a friggersi, gli occhi altri vedono solo una grigia creatura, eppure mi sento finalmente splendente, mi fanno male i piedi ma come sono seducente nell’esistere davvero, nel momento che indosso quegli stivali del lutto, insieme a tutti gli altri abiti, posso finalmente piangere Risplendo di dolore mio, mi riempio della mia essenza e sono incredibile, la musa di me stessa, che finalmente si è concessa di esistere in tutta la sua sostanza, disperata, insonne e puzzolente, ma con l’unico abito che può realmente indossare: la disperazione
Mi tolgo dal viso quel patetico e stupido sorriso, i miei occhi blu non risplendono la luce del sole, il mio naso cresce e crolla su se stesso, lungo e bozzoluto, le mie orecchie pendono come carne molla, ma i miei occhi finalmente si spengono, non ho più voglia di ridere, lasciatemi piangere, non voglio conforto, datemi la possibilità di sentire tutto, di vomitare l’assenza, di rimpiangere la presenza, di ripetere in testa quanto era prezioso il passato e infruttuoso il presente Fatemi sognare una morte alla Virginia Woolf, fatemela programmare, lasciatemi immaginare mentre mi immergo nel fiume della depressione, con il mio bastone da passeggio sull’argine del Tevere, lasciate il mio corpo andare in mezzo alle buste di plastica e a residui organici umani, donate alla mia anima la libertà. Nella disperazione assoluta mi appago, non voglio essere felice, non ora, gli stivali del lutto mi rendono pregiata, il mio corpo è mostruosamente avvenente, storta e raggrinzita, più deforme mi vedo più mi piaccio, trovo la luce in cui friggermi e mi lascio andare. Ho camminato nella notte senza meta, nella puzza di Roma est, ero la principessa del nulla, eppure gli stivali glicine li ha notati anche dio.
Ascoltate “Oh Coal, Black Smith” dei Current 93
Litania per la sopravvivenza
Per quelle di noi che vivono sul margine ritte sull’orlo costante della decisione cruciali e sole
per quelle di noi che non possono lasciarsi andare ai sogni passeggeri della scelta che amano sulle soglie mentre vanno e vengono nelle ore fra un’alba e l’altra guardando dentro e fuori e prima e poi allo stesso tempo cercando un adesso che dia vita a futuri
come pane nelle bocche dei nostri figli perché i loro sogni non riflettano la fine dei nostri
Per quelle di noi che sono state marchiate dalla paura come una ruga leggera al centro delle nostre fronti imparando ad aver paura con il latte di nostra madre perché con questa arma questa illusione di poter essere al sicuro quelli dai piedi pesanti speravano di zittirci
Per tutte noi questo istante e questo trionfo Non era previsto che noi sopravvivessimo
E quando il sole sorge abbiamo paura che forse non resterà quando il sole tramonta abbiamo paura che forse non sorgerà domattina quando abbiamo la pancia piena abbiamo paura dell’indigestione quando abbiamo la pancia vuota abbiamo paura di non poter mai più mangiare quando siamo amate abbiamo paura che l’amore svanirà quando siamo sole abbiamo paura che l’amore non tornerà e quando parliamo abbiamo paura che le nostre parole non verranno udite o ben accolte ma quando stiamo zitte anche allora abbiamo paura
Perciò è meglio parlare ricordando non era previsto che sopravvivessimo.
Audre Lorde


-Io non capisco, ma proprio bianche le dovevate mettere le mattonelle?
-Erano in sconto.
-Ok, ma così non finiremo mai di pulire! Guarda!, sta schizzando ovunque!
-Ma tu lo sai che hanno inventato i coperchi, Anita bella?
Prendili, lì, nel pensile in alto Anita si arrampica sul piano della cucina. Ha dodici anni e non ha mal di schiena, può
tranquillamente ignorare lo sgabello che sua zia le sta offrendo per raggiungere i coperchi
Ne afferra tre belli grandi, uno per ogni pentola, e li passa a zia Regina.
-Comunque preferivo restare fuori.
-Ormai sei grande. Devi aiutare.
-Ma non mi pare giusto.
Perché dobbiamo fare il sugo per tutti?!
- Avresti preferito il lavoro fuori?
Non che fuori non ci fosse da faticare, in effetti era molto più pesante del lavoro che le avevano assegnato. Però amava stare all’aperto. Anche d’inverno, quando faceva talmente freddo che potevi perderci una mano. E soprattutto non era sempre uguale. In cucina era sempre uguale: c ’ era sempre caldo. A pensarci bene l’unica cosa (proprio l’unica) che non le mancava erano le macchie, almeno quelle che si faceva sul grembiule ai fornelli erano molto più facili da togliere. I grembiuli in cucina erano immacolati, come la neve, che adesso dalla finestra appariva bruttamente interrotta dai grembiuli delle donne che lavoravano fuori, e che a forza di lavaggi erano diventati di uno sciapo rosa pallido.
-Ragazze, avete fatto? Roberto sta aspettando
-Liliana sì, è quasi pronto. Aiuti per favore Anita a scendere giù? Ho paura che si faccia male.
-Certo tesoro,- Liliana apre le braccia verso la piccola- vieni, salta qui!
-Nooo! Mi sono sporcata col tuo grembiule! Liliana che cavolo!
-Dai, non frignare. Aiuta Lili con Roberto, che tanto ormai sei sporca.
-Uffa!
Le due percorrono il lungo corridoio a passi svelti. Fuori la neve si posa silenziosa.
Se solo i colpi pesanti delle asce si fermassero per qualche secondo, magari si riuscirebbe persino a sentirla mentre copre tutto di bianco
-Il sugo è quasi pronto e come al solito zia Regina ha trovato una scusa per non venire a prendere la carne. Un giorno è il mal di schiena e quello dopo lo sa Dio. Non sia mai si sporchi il grembiule.
Te prendi da sotto che fai meno fatica -uno, due e issa!
Il corridoio lo ripercorrono al contrario, con passetti ancora più svelti ma più brevi, per non perdere l’equilibrio sotto il peso morto.
In cucina posano con un tonfo la carne sul tavolo.
-Lo sapevo! - urla Regina- Mai una volta che non devo fare tutto io. Ok lasciare la cotenna, ma i tatuaggi per Dio toglieteli!
-Regina, mi dispiace dai! Dirò alle ragazze di fare più attenzione!
-Va bene va bene. Ani, piccola, per favore aiutami a togliere tutta la pelle da buttare. Comincia dal petto.
La ragazzina obbedisce Il sangue incrostato è talmente denso che non riesce a capire dove siano tutti i tatuaggi. Prende uno straccio e inizia a pulire nel punto più rosso di tutti, sul torace.
-Zia?
-Dimmi cara.
-Che vuol dire “Resilienza”?




Fotosottocasa è un progetto di street photography che esplora la città di Latina con uno sguardo attento agli elementi insoliti e fuori contesto della vita quotidiana.
IG: @fotosottocasa










Ci sono città che non hanno bisogno di presentazioni, dove tutto sembra sempre in ordine, e altre, più ambigue, dove gli oggetti si posano in modo irregolare, come in una storia raccontata a metà.
Qui, nei dettagli quotidiani e casuali, si svelano angoli che nessuno guarda, accessibili solo a chi nota il "fuori posto": un dinosauro di plastica sul cemento, una porta socchiusa, un'ombra troppo grande per il suo oggetto.
Sono indizi che sfuggono a chi ha fretta, ma per chi si sofferma, ogni cosa sembra raccontare una storia appena accennata, lasciando intuire realtà parallele dietro ogni finestra e muro
C'è ironia in questi oggetti, nel loro essere seriamente lì, come nei dettagli infiniti di Wallace, che si chiudono in un circolo di significati
ambigui È un equilibrio precario tra senso e non senso, tra luce e ombra, dove il confine tra reale e immaginato si dissolve
La luce è tagliente, mai indulgente, e la malinconia si insinua dolcemente, come una sera d'autunno.
Nella familiarità di ogni scena si cela estraneità: oggetti che sembrano di epoche diverse, dettagli che non si integrano con l'ambiente, come frammenti di un mondo da ricostruire.
Nulla è esplicito, tutto rimane in sospeso, affidato a un senso di attesa mai risolta, a una malinconia che sa di polvere, di luce artificiale, di passaggi incompiuti
In questa sospensione, la città diventa più di uno sfondo: un luogo dove i pensieri si aggirano, come ombre in cerca di forma

Una stanza tutta per noi
L’inquietudine quotidiana e la ricerca di un posto nel mondo, che sia fisico o mentale, sono un sentire comune Dove restare, in quali luoghi passare il nostro tempo, cosa fare del tempo (poco) che abbiamo e con chi passarlo?
Le risposte non penso siano semplici e non penso siano uguali per tuttə, ma vi riporto qui un piccolo racconto che parla di persone che cercano di sopravvivere ogni giorno, e di non venire sopraffatte da un mondo che si sgretola sempre di più.
Sono passati due anni abbondanti dalla prima volta che le ho viste. Il posto era un circolo Arci di una cittadina toscana di quasi novantamila abitanti di nome Ho Chi Minh. Quello che mi spinse ad andare lì quella sera di una settimana annoiata in una città sconosciuta, furono le parole “laboratorio” e “femminismo”.
Non conoscevo nessunə a Pistoia e l’occasione sembrava essere fatta apposta per me Quello che è successo dopo va ancora avanti oggi ed è una storia che parla di donne che si sono riconosciute in un racconto comune, nella volontà di sopravvivere e di farlo creando qualcosa.
Il laboratorio di letture di scritti sul femminismo “Stanza Femminista” che oggi portiamo avanti insieme, è nato dalla scommessa di alcune mie amiche e folli compagne. Il laboratorio si svolge il mercoledì, due volte al mese.
Questa ritualità va oltre la possibilità di avere un semplice momento per noi stesse: è un momento che scegliamo di prenderci per stare insieme, per dirci qualcosa su quello che vorremmo che fosse veramente il mondo.
Le mie compagne lo descrivono in vari modi: come un'occasione di confronto e riflessione, un luogo dell’ascolto accogliente e senza giudizio, un posto in cui si scambiano idee sul femminismo e la società.
Un momento tanto intimo quanto potente, è una pratica di lotta, ma dalla nostra camera Uno spazio che fa concretamente capire il valore politico dell’arte, la quale deve alimentare discussioni, confronti e riflessioni collettive, altrimenti che senso ha?
Per altre rappresenta la trasposizione in parole non nostre di esperienze che in realtà appartengono anche a noi, che viviamo quotidianamente. Se crediamo che il femminismo é sia teoria che pratica, le letture fatte insieme possono essere una pratica fatta con la teoria. Con questo partire dai testi entriamo nel nostro sé.

*https://www minimaetmoralia it/wp /approfondimenti/gli-oggettiseppelliti-negli-archivi-delle-donne/
Quello che cerchiamo di fare è ispirato dalle parole di Lea Melandri* - "Il femminismo non è un sapere organizzato, ma innanzitutto una “presa di coscienza”, un salto, una rottura rispetto ai saperi e alle metodologie date [ ] è una consapevolezza che non si dà come processo di acculturazione, ma avviene nella discontinuità rispetto a convinzioni abituali. È un sapere che si dà nella rivelazione con altre donne, in un racconto di sé che comporta il rivivere, il riattualizzarsi del passato; un pensare che si avvale dello sguardo di altre donne, capaci di vedere quello che noi non vediamo di noi stesse”. Il laboratorio di letture è lo spazio nel quale le parole di una rinomata scrittrice femminista possono essere pronunciate tali e quali dalla socia del circolo che si ferma a partecipare quasi per caso, e stimolata da qualche testo, racconta la sua esperienza di vita. A volte siamo poche, delle volte siamo state tante e tanti che si faceva fatica a trovare posto. Spesso il laboratorio è frequentato anche da uomini ma non sono sempre costanti, tranne uno che trova sempre il modo di ascoltarci e contribuisce al bagaglio di testi che abbiamo affrontato. Ci sono dei tempi che scandiscono gli incontri, ci diamo dei turni, si prende la parola per alzata di mano. Può sembrare qualcosa di rigido e delle volte lo è, ma con quelle piccole regole che ci siamo date riusciamo ad esprimerci tutte.
Questi incontri hanno contribuito a creare un legame ed un modo di pensare insieme, che non vuol dire avere le stesse idee ma vuole dire avere una sorta di sentire di base comune, una sensibilità che affina lo sguardo con il quale guardi il mondo. In qualche modo alcune di noi si sono cercate e si sono trovate.

Il posto in cui facciamo il laboratorio è forse come vi potete immaginare sia un circolo Arci, ma magari anche no. Questo posto è particolare, forse ostile, pieno di maschi ubriachi e arrabbiati con un mondo ingiusto, e con sempre tanta possibilità che accada qualcosa di strano e la serata finisca male
Noi però ci siamo lo stesso. Restiamo. Scegliere di attraversare uno spazio piuttosto che un altro non è una scelta banale. In ogni città ci
sono luoghi che ci piacerebbe frequentare ma li sentiamo ostili, soprattutto dopo l’aver preso consapevolezze politiche che prima non avevamo Proprio per questo è ancora più importante portare le nostre esigenze di donne, di persone queer, e cercare di risignificarli e riabitarli, creando una convivenza migliore. Ci sono luoghi di cui abbiamo bisogno, dei luoghi protetti, ma esistono anche dei luoghi difficili, di confine, e questi forse sono gli unici in cui si può imparare qualcosa.
Oggi, per me, forse per noi, si sopravvive così, anzi, si vive così.
Trovare compagne di viaggio e fare qualcosa che ci piace. Si può partire da una stanza tutta per noi per poi cercare di far nascere piccole comunità. Guardare ai bisogni, prenderci cura di quello che ci fa soffrire e di quello che amiamo Il femminismo per noi è la lente che guida questa cura, il valore aggiunto che porta speranza di cambiamento. Quello che andrebbe fatto è cambiare il mondo, una stanza alla volta.


A tuttə quellə che guardano dentro di sé e non sanno più contenere quello che trovano:
Un legame che senti crearsi a pelle. Qualcosa di più profondo che viene da lontano, che una volta che lo vedi davvero per quello che è squarcia il sipario, la scena finisce, un’altra cosa inizia. Quei primi incontri si ripeteranno negli anni, nuovi modi di affidarsi, di rendere altri corpi prossimi al tuo. Li senti vicini, come una massa informe che tutto fagocita. Quella fame è quasi inarrestabile. Il lembo di pelle che le unisce tutte si tira ma si crea altro spazio, sotto le ali ci stiamo tutte La strada da fare si intravede appena ma si va finché le gambe reggono, e quando tremano, è la mente che le alimenta. Sembriamo, tutte insieme, degli animali, quegli esseri che sentono, fino in fondo La paura ci accompagna costantemente ed è là che nasce un nuovo nodo da sbrogliare… e poi arriva la sofferenza… e si ricomincia. Sale dallo stomaco passa per tutti i nervi e arriva alla testa. Ci si confida, ci si riorganizza, e si affronta il prossimo groviglio. Ancora e ancora e ancora. Sono pochi i posti dove riposare, dove staccare la spina e sentirsi al sicuro e capite, quando non siamo quella cosa unita Unita, che poi non vuol dire mica essere la stessa cosa. Unite e uniche. Unicamente insieme perché sole non si può. Un sentimento così grande che nel corpo non ci sta, che ci porta camminando a zig zag fino al limite pensato, il cielo notturno e la sua luna piena. Da là lo vediamo che è tutto sbagliato, e la luce lunare è nuova linfa e vita nel fermar la necessità di fermarsi.
Morg e più vocHi