





I nostri reometri e viscosimetri hanno la tecnologia DRIVE, per:
• Pieno controllo dello strumento
• Intuitivo display touch screen
• Gestione integrale dei dati
• Massima affidabilità

Strumenti da laboratorio per il controllo di gomma e plastica
RheoCheck MD - Drive
Reometro a camera
oscillante con tecnologia Drive



TECNOLOGIA CHE PROTEGGE, INNOVAZIONE CHE RISPET TA
TECNOLOGIA CHE PROTEGGE, INNOVAZIONE CHE RISPET TA



La transizione ecologica ha fatto intraprendere all’industria della gomma un nuovo percorso, che si sta rivelando un’opportunità concreta per ripensare materiali, processi e prodotti in chiave circolare. L’intera filiera è chiamata a diventare più sostenibile riducendo l’impatto ambientale, a partire dalle materie prime. Sostituire le cariche tradizionali, come il nero di carbonio e le cariche minerali ad esempio, con alternative naturali e/o rinnovabili, è una delle sfide più promettenti.
Le biocariche offrono oggi caratteristiche tecniche che permettono di coniugare prestazioni, efficienza economica e sostenibilità, aprendo la strada a manufatti sempre più “green”. Parallelamente, la ricerca esplora frontiere ambiziose. Tra queste, la possibilità di trasformare la CO₂ in risorsa, grazie a processi di catalisi al plasma che convertono l’anidride carbonica in metanolo o etilene. È una rivoluzione che potrebbe rendere la chimica di base e la gomma sintetica più sostenibili, integrando materie prime circolari e riducendo la dipendenza da fonti fossili.
Sul fronte dei manufatti giunti a fine vita, la pirolisi degli pneumatici si sta affermando come tecnologia strategica: un processo capace di recuperare materiali preziosi – olio, gas e nero di carbonio riciclato – e restituirli al ciclo produttivo. Una risposta concreta all’enorme quantità di pneumatici che ogni anno diventano rifiuto e che, invece, possono trasformarsi in nuova risorsa.
Resta aperta, infine, la questione delle particelle di usura di pneumatici e strade, un tema cruciale per la salute e per l’ambiente. Ridurre le microplastiche e sviluppare soluzioni più pulite è l’ultima tappa – e forse la più impegnativa – di un cammino verso una filiera della gomma pienamente sostenibile.
L’edizione 2025 del Green Rubber testimonia, ancora una volta, che l’innovazione, oggi, non è più solo una scelta tecnologica, ma un atto di responsabilità: dare alla gomma una nuova vita significa contribuire al futuro del pianeta. u
The ecological transition has led the rubber industry to embark on a new path, which is proving to be a concrete opportunity to rethink materials, processes, and products in a circular way.
T he entire supply chain is called upon to become more sustainable by red ucing its environmental impact, starting from raw materials. Replacing traditional fillers - such as carbon black and mineral fillers - with natural and/or renewable alternatives is one of the most promising challenges. Today, bio-based fillers offer technical properties that make it possible to combine performance, economic efficiency, and sustainability, paving the way for increasingly “green” products.
A t the same time, research is exploring ambitious frontiers. Among these is the possibility of transforming CO₂ into a resource through plasma catalysis processes that convert carbon dioxide into methanol or ethylene. It is a revolution that could make basic chemistry and synthetic rubber more sustainable, integrating circular raw materials and reducing dependence on fossil sources.
O n the front of end-of-life products, tire pyrolysis is emerging as a strategic technology: a process capable of recovering valuable materials - oil, gas, and recycled carbon black - and returning them to the production cycle. It is a concrete response to the enormous quantity of tires that become waste each year and that, instead, can be transformed into a new resource.
Finally, the issue of tire and road wear particles remains open - a crucial topic for both health and the environment. Reducing microplastics and developing cleaner solutions is the final - and perhaps most challenging - step on the path toward a fully sustainable rubber supply chain.
T he 2025 edition of Green Rubber once again demonstrates that innovation today is no longer just a technological choice but an act of responsibility: giving rubber a new life means contributing to the future of the planet. u
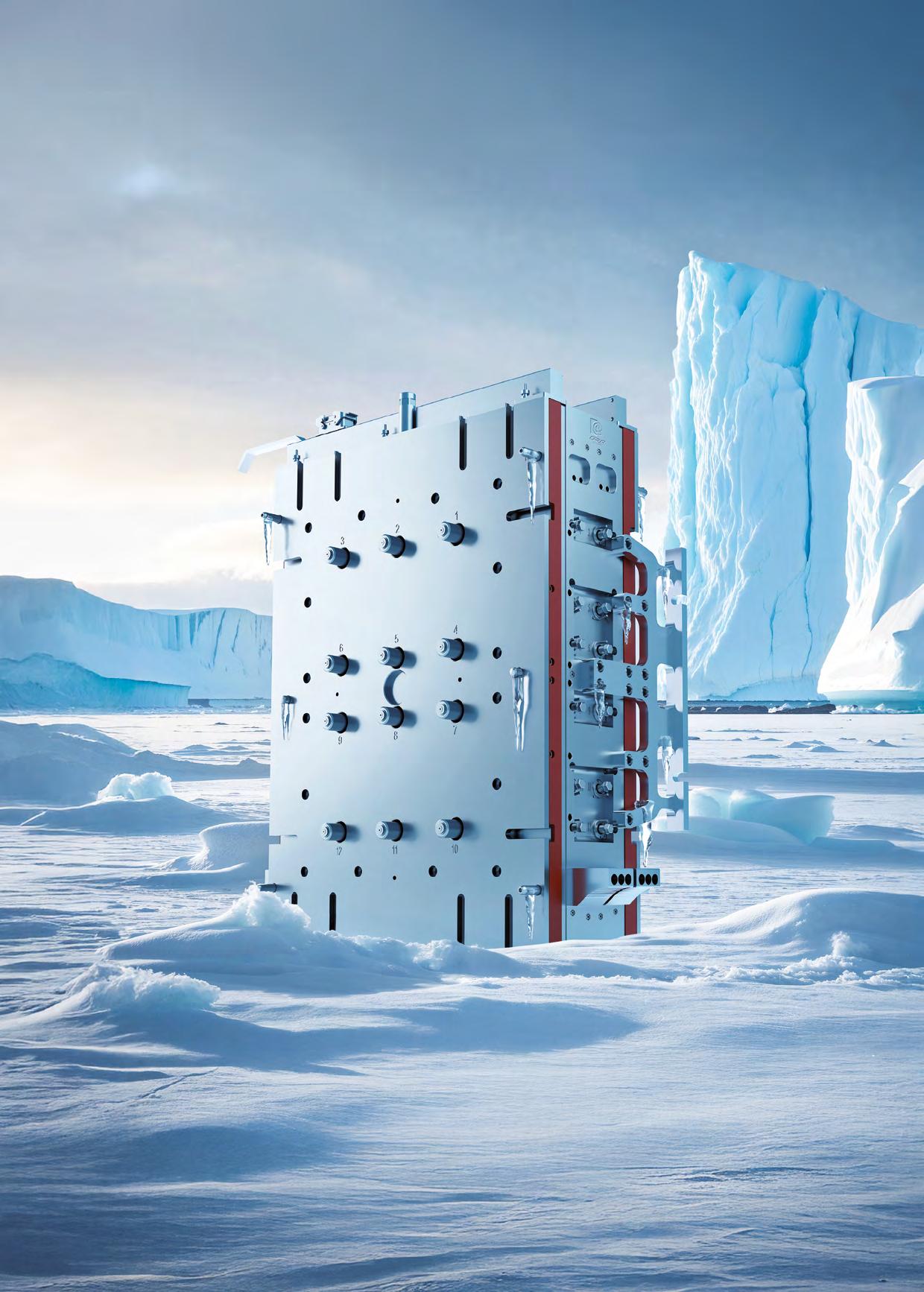
Over 1000 Cold Runner Blocks running worldwide
SUPPLEMENTO AL NUMERO DI NOVEMBRE 2025
DE L’INDUSTRIA DELLA GOMMA 733
MENSILE DEGLI ELASTOMERI
E DEGLI ALTRI POLIMERI RESILIENTI
Direttore responsabile
Andrea Aiello in reDazione
Daniela Garbillo - daniela.garbillo@edifis.it
Collaborano alla rivista
Gianpaolo Brembati, Giuseppe Cantalupo, A.L. Spelta
GrafiCa e impaGinazione
Barbara Aprigliano - barbara.aprigliano@edifis.it pubbliCità dircom@edifis.it
traffiCo pubbliCitario
Francesca Gerbino - francesca.gerbino@edifis.it stampa
Grafiche Arrara
Grafiche Arrara s.r.l. – Abbiategrasso (MI) amministrazione amministrazione@edifis.it


Registrazione Tribunale di Milano n. 4275 del 1.4.1957 Iscrizione Registro Operatori della Comunicazione n. 06090
Tutti i diritti di riproduzione degli articoli e/o foto sono riservati. Manoscritti, disegni, fotografie, supporti audio e video anche se non pubblicati non saranno restituiti. Per le fotografie e le immagini per cui, nonostante le ricerche eseguite, non sia stato possibile rintracciare gli aventi diritto, l’Editore si dichiara disponibile ad adempire ai propri doveri. Ai sensi del Reg.EU 679/2016 l'Editore garantisce la massima riservatezza nell'utilizzo della propria banca dati con finalità redazionali e/o di invio del presente periodico. Ai sensi dell'art. 15 il ricevente ha facoltà di esercitare i suoi diritti fra cui la cancellazione mediante comunicazione scritta a EDIFIS Srl - Viale Coni Zugna 71 - 20144 Milano (o ai riferimenti sotto trascritti), luogo della custodia della banca dati medesima.
L’Industria della Gomma una rivista edita da:
Edifis S.r.l.
Viale Coni Zugna 71 20144 - Milano - Italy
Tel. +39 023451230
Fax +39 023451231 www.edifis.it
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA DI SETTORE
EDITORIALE/EDITORIAL
2 NUOVA VITA PER LA GOMMA NEW LIFE FOR RUBBER
SOSTENIBILITÀ/SUSTAINABILITY
10 CARICHE ECOLOGICHE PER LA SOSTENIBILITÀ
DEI MANUFATTI IN GOMMA
ECO-FRIENDLY FILLERS FOR SUSTAINABLE RUBBER PRODUCTS
Per lo sviluppo di manufatti di gomma sostenibili occorre sostituire le cariche convenzionali (carbon black e cariche minerali) con alternative ecologiche e sostenibili. Le biocariche offrono caratteristiche che le rendono promettenti sostituti delle cariche tradizionali, con vantaggi di efficienza economica e sostenibilità ambientale.
The development of sustainable rubber products requires replacement of conventional fillers (carbon black and mineral fillers) with eco-friendly and sustainable alternatives. The bio-based fillers offer characteristics that make them promising substitutes for conventional fillers, with advantages of economic efficiency and environmental sustainability.
24 CONVERSIONE DELLA CO₂ IN PRODOTTI CHIMICI
DI BASE SOSTENIBILI
CONVERSION OF CO₂ INTO SUSTAINABLE COMMODITY CHEMICALS
Un nuovo processo messo a punto dal Fraunhofer IMWS permette di convertire la CO₂ in prodotti chimici di base sostenibili, come metanolo ed etilene, impiegando una tecnologia avanzata di catalisi al plasma a bassa temperatura e biogas come materia prima. Il progetto potrebbe rendere la filiera della gomma sintetica più verde e competitiva grazie a materie prime circolari e processi energeticamente efficienti.
A new process developed by Fraunhofer IMWS enables the conversion of CO₂ into sustainable base chemicals such as methanol and ethylene, using advanced lowtemperature plasma catalysis technology and biogas as a feedstock. The project could make synthetic rubber supply chains greener and more competitive thanks to circular raw materials and energy-efficient processes.


MESGO, today among the most important compounders, has always been committed to the continuous pursuit of customer satisfaction and has made customer service its true passion, ensuring exceptional flexibility and promptness in meeting every request. With a product range unique in Europe, it serves as a single point of reference for all needs in the fields of rubber compounds, thermoplastic compounds, and masterbatches.
MESGO is part of the HEXPOL Group, a global leader in the industry.

PFU/ELT
34 LA PIROLISI DEGLI PNEUMATICI A FINE USO:
UN AGGIORNAMENTO
END-OF-LIFE TIRE PYROLYSIS: AN UPDATE
Con oltre 2,5 miliardi di pneumatici prodotti ogni anno e circa 1,6 miliardi arrivati a fine vita solo nel 2023, la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) è una sfida ambientale ed economica centrale per il settore gomma. La pirolisi si afferma oggi come tecnologia innovativa e strategica: decomponendo gli pneumatici in olio, gas e nero di carbonio riciclato, consente di recuperare materiali preziosi e ridurre l’impatto ambientale.
With over 2.5 billion tires produced each year and about 1.6 billion reaching end-of-life in 2023 alone, the management of end-of-life tires (ELTs) is a central environmental and economic challenge for the rubber sector. Pyrolysis is now emerging as an innovative and strategic technology: by decomposing tires into oil, gas, and recycled carbon black, it enables the recovery of valuable materials and reduces environmental impact.
46 PARTICELLE DI USURA PNEUMATICI E STRADE:
IMPATTO AMBIENTALE E RISCHI
TYRE AND ROAD WEAR PARTICLES: ENVIRONMENTAL IMPACT AND RISKS
Le particelle di usura degli pneumatici e delle strade hanno un forte impatto sull’ambiente: contribuiscono, infatti, all’inquinamento da microplastiche e questo comporta dei rischi per la salute umana. The tyre and road particles (TRWP) have a strong impact on the environment, contribute to the microplastic pollution and present risks for human health.


AZIENDE/COMPANIES
61 u C.S.I. CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI
u COATING TECHNOLOGY
u COMERIO ERCOLE
u ELASTOMERS UNION
u ENGEL
u EURORUBBER
u EVERCOMPOUNDS
u G3 MIXING TECHNOLOGIES
u GIBITRE INSTRUMENTS
u ISOPREN
u JP-TECH
u MESGO
u OR.P. STAMPI
u PEZZATO
u REP ITALIANA
u TECNISTAMP
u VALLI GESTIONI AMBIENTALI



Leader globale nella produzione di presse a iniezione per materie plastiche, ENGEL offre soluzioni integrate per ogni esigenza: macchine, automazione, processi, formazione e assistenza, tutto da un’unica fonte. Ogni componente è perfettamente armonizzato per garantire efficienza e competitività. Innoviamo oggi per costruire il domani: le tecnologie più avanzate offrono ai nostri clienti un vantaggio decisivo. Get connected – con le nostre macchine.
engelglobal.com/stockmachines












di Gianpaolo Brembati
Per lo sviluppo di manufatti di gomma sostenibili occorre sostituire le cariche convenzionali (carbon black e cariche minerali) con alternative ecologiche e sostenibili. Le biocariche offrono caratteristiche che le rendono promettenti sostituti delle cariche tradizionali, con vantaggi di efficienza economica e sostenibilità ambientale.
Le formulazioni della gomma richiedono l’utilizzo di diversi tipi di cariche, per migliorare le proprietà di lavorazione e meccaniche dei vulcanizzati e per conferire loro le caratteristiche richieste per l’applicazione prevista. Le proprietà delle cariche (dimensione e forma delle particelle, area superficiale, struttura eccetera) e la loro interazione con la matrice polimerica contribuiscono sensibilmente a determinare le prestazioni dei vulcanizzati. La disposizio -
ne spaziale della carica, all’interno della matrice polimerica, è influenzata da vari fattori, come il livello di caricamento e la sua attività e interazione con gli agenti di vulcanizzazione, mentre il suo tipo, la sua struttura e la sua quantità hanno un ruolo importante nell’intensità delle interazioni interfacciali e nella morfologia complessiva del composito. La funzione delle cariche rinforzanti è quella di migliorare rinforzo, modulo, carico di rottura e resistenza ad abrasione e lacerazione, e si crede che il loro tipo in-
fluenzi il meccanismo dell’effetto Mullins (sollecitazione-deformazione della gomma), essenziale per comprendere comportamenti come accumulo di calore, cedimento del manufatto e perdita delle caratteristiche meccaniche durante deformazioni cicliche.
La scelta della carica dipende dalle proprietà richieste dall’applicazione del prodotto finale e, in base al loro effetto di rinforzo, le cariche sono classificate in tre gruppi (Figura 1): - cariche rinforzanti, con particelle di di-


mensioni fra 10 e 100 nm, come carbon black, silice, grafite e nanotubi di carbonio (CNT), che migliorano le proprietà meccaniche dei compositi;
- cariche semirinforzanti, con particelle di dimensioni fra 100 e 1.000 nm, come caolino e carbonato di calcio pre -
by Gianpaolo Brembati
cipitato, cha hanno limitata capacità di migliorare caratteristiche meccaniche e robustezza;
- cariche non rinforzanti, con particelle di dimensioni fra 1.000 e 100.000 nm, come carbonato di calcio macinato, talco, ossido di metallo e solfato di bario,
che possono influire negativamente sulle proprietà meccaniche, ma vengono utilizzate per ridurre i costi di produzione.
L’aspetto negativo delle cariche polari (silice e biocariche idrofile) è la incompatibilità con elastomeri non polari, che
The development of sustainable rubber products requires replacement of conventional fillers (carbon black and mineral fillers) with eco-friendly and sustainable alternatives. The bio-based fillers offer characteristics that make them promising substitutes for conventional fillers, with advantages of economic efficiency and environmental sustainability.
Rubber formulations require the use of different types of fillers to improve the processing and mechanical properties of vulcanized products and to give them the characteristics required for their intended application. The properties of the fillers (particle size and shape, surface area, structure, etc.) and their interaction with the polymer matrix contribute significantly to determine the performance of vulcanized products. The spatial
arrangement of the filler within the polymer matrix is influenced by various factors, such as the loading level and its activity and interaction with the vulcanizing agents, while its type, structure and quantity play an important role in the intensity of the interfacial interactions and the overall morphology of the composite. The function of reinforcing fillers is to improve reinforcement, modulus, tensile strength, resistance to abrasion and tear strength, and their type is believed to influence the mechanism
of the Mullins effect (stress-strain behaviour of rubber), which is essential for understanding behaviours such as heat build-up, product failure and loss of mechanical characteristics during cyclic deformation.
T he choice of filler depends on the properties required by the application of the final product and, based on their reinforcing effect, fillers are classified into three groups (Figure 1): - r einforcing fillers, with particle sizes between 10 and 100 nm, such as carbon black, silica, graphite and carbon

richiede modifiche superficiali per mezzo, in particolare, di silani per migliorare l’adesione interfacciale e la compatibilità. Nelle applicazioni, che coinvolgono gomma naturale, SBR, NBR e BR, è quindi necessario valutare l’impatto delle cariche sulla struttura e sulle caratteristiche dei compositi di gomma (Schema 1).
I materiali di rinforzo carboniosi influenzano decisamente robustezza e prestazioni dei compositi. Tra di loro il carbon
nanotubes (CNTs), which improve the mechanical properties of composites;
- s emi-reinforcing fillers, with particle sizes between 100 and 1000 nm, such as kaolin and precipitated calcium carbonate, which have limited ability to improve mechanical characteristics and strength;
- n on-reinforcing fillers, with particle sizes between 1000 and 100000 nm, such as ground calcium carbonate, talc, metal oxide and barium sulphate, which can negatively affect mechanical properties but are used to reduce production costs.
T he downside of polar fillers (silica and hydrophilic biofillers) is their incompatibility with non- polar elastomers, which requires surface modifications, in particular using silanes, to improve interfacial adhesion and compatibility. In applications involving natural rubber, SBR, NBR and BR, it is therefore necessary to assess the impact of fillers on the structure and characteristics of rubber composites (Scheme 1).
black, con più del 90% di carbonio elementare puro, è il più vecchio e il più comunemente usato nella gomma come carica di rinforzo sostenibile, soprattutto per la produzione degli pneumatici. Il carbon black migliora le proprietà dei compositi, quali resistenza a lacerazione, carico di rottura, resistenza all’abrasione, resistenza allo slittamento, fatica a flessione e modulo. Le caratteristiche dei compositi finali possono essere influenzate dalle proprietà del carbon black, come la dimensione delle particelle primarie, l’attività superficiale, la struttura, il livello di carica e il grado di
C arbonaceous reinforcing materials critically affect the strength and performance of composites. Among them, carbon black, with more than 90% pure elemental carbon, is the oldest and most commonly used in rubber as a sustainable reinforcing filler, especially for tyre production. Carbon black improves the properties of composites, such as tear resistance, tensile strength, abrasion resistance, skid resistance, flexing fatigue and modulus. The characteristics of the final composites can be influenced by the properties of carbon black, such as primary particle size, surface activity, structure, content and dispersion degree in the rubber matrix.
O ther carbonaceous materials such as graphite, graphene, carbon nanotubes and multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) have received considerable attention due to their extraordinary characteristics, including excellent mechanical, thermal, elec -
dispersione nella matrice gomma. A ltri materiali carboniosi come grafite, grafene, nanotubi di carbonio e nanotubi di carbonio a pareti multiple (MWCNT) hanno ricevuto notevole attenzione grazie alle loro straordinarie caratteristiche, tra cui eccellenti proprietà meccaniche, termiche, elettriche e ottiche. Tuttavia l’utilizzo di questi materiali è soprattutto in fase sperimentale e di sviluppo e le loro applicazioni sono attualmente limitate. Uno dei loro principali vantaggi è la capacità di fornire un notevole rinforzo anche a bassi livelli di carico nei compositi, ti-
trical and optical properties. However, the use of these materials is mainly in the experimental and development phase and their applications are currently limited.
O ne of their main advantages is the ability to provide significant reinforcement even at low load levels in composites, typically in the range of 1-5% by weight. This contrasts with mineral fillers and fibres, which require much higher loads (up to 50%) to achieve comparable performance, so that the incorporation of these carbonaceous materials allows the filler content to be reduced and lighter products to be obtained.
C NTs, in particular, are an excellent reinforcing filler in rubber composites, thanks to their superior mechanical and physical characteristics (high Young's modulus, thermal conductivity, specific surface area and intrinsic mobility), but the homogeneous dispersion of graphene in the rubber matrix remains a problem, which can be solved by using its modified forms
picamente nell’intervallo dell’1-5% in peso. Ciò contrasta con le cariche minerali e con le fibre, che richiedono carichi molto più elevati (fino al 50%) per ottenere prestazioni comparabili, così che l’incorporazione di questi materiali carboniosi consente di ridurre il contenuto della carica e di ottenere manufatti più leggeri.
I CNT, in particolare, sono un’eccellente carica rinforzante nei compositi di gomma, grazie alle loro superiori caratteristiche meccaniche e fisiche (elevato modulo di Young, conduttività termica, area superficiale specifica e mobilità intrinseca), ma rimane un problema la dispersione omogenea del grafene nella matrice di gomma, che può essere risolto usando sue forme modificate come ossido e ossido ridotto.
R imanendo nell’ambito dei materiali carboniosi, è stato fatto uno studio che prevede la sostituzione del carbon black con il 10% di grafite esfoliata termicamente, con un conseguente aumento delle prestazioni di carico di rottura, di resistenza a lacerazione e abrasione, grazie probabilmente all’elevata area superficiale della grafite, che ha offerto una buona interazione
such as oxide and reduced oxide. R emaining in th e field of carbonaceous materials, a study has been carried out that involves replacing carbon black with 10% thermally exfoliated graphite, resulting in an increase in breaking load, tear and abrasion resistance, probably thanks to the high surface area of graphite, which offered good interaction between the filler and the rubber matrix and a consequent reduction in rolling resistance and heat build-up.
S tudies were also conducted on the partial replacement of carbon black with modified graphene (from 1 to 5 phr) in the natural rubber/BR matrix, obtaining, with a content of 2.5 phr, an increase in elongation at break and bound rubber content, attributable to effective interaction between rubber and modified graphene. In addition, rolling resistance was reduced and this replacement proved favourable for the development of sustainable compounds fo r eco-friendly tyres.
P recipitated silica is the type of silica chosen for use in the tyre industry, while crystalline and pyrogenic silica have not proven suitable, due to the lack of reinforcing properties in the former and high processing costs in the latter. Proposed by Michelin in 1992 to develop more environmentally friendly tyres, silica has improved fuel efficiency by 3-15% and reduced tyre rolling resistance by 20-30%, resulting in lower CO2 emissions into the environment compared to the use of carbon black.
I t should be borne in mind that the tyre industry focuses on certain performance factors, such as rolling resistance, wear resistance or abrasion and wet grip: these are the three parameters of the so-called magic triangle (Figure 2), which are difficult to reconcile because improving one factor leads to the deterioration of the others.
T he initial problems of poor rein
forcement of silica compared to car

fra carica e matrice gomma e una conseguente riduzione della resistenza al rotolamento e dell’accumulo di calore. Sono stati condotti anche studi sulla sostituzione parziale del carbon black con grafene modificato (da 1 a 5 phr) nella matrice gomma naturale/BR ottenendo, con il contenuto di 2.5 phr, un aumento dell’allungamento a rottura e del contenuto di gomma legata, attribuibile a un’efficace interazione fra gomma e grafene modificato. Inoltre, la resistenza al rotolamento si è ridotta e questa sostituzione si è rivelata favorevole allo sviluppo di mescole sostenibili per pneumatici ecologici.
La silice precipitata è il tipo di silice scelto per l’utilizzo nel settore degli pneumatici, mentre quella cristallina e pirogenica non si sono dimostrate idonee, a causa della mancanza di caratteristiche rinforzanti per la prima e di lavorazione e costi elevati per la seconda. Proposta da Michelin nel 1992 per sviluppare pneumatici più ecologici, la silice ha permesso di migliorare l’efficienza del
bon black, due to its weaker interaction with the polymer and relative dispersion, heat build-up, temperature sensitivity and tendency to form gels, have been solved by the use of silanes, in particular bis(triethoxypropyl)tetrasulphide, commonly known as Si69.
TOWARDS SUSTAINABLE AND E NVIRONMENTALLY FRIENDLY F ILLERS
Together with natural rubber, SBR and BR polymers are the main components in tyre production and are derived from fossil raw materials, as is carbon black, commonly used as a reinforcing filler in most rubber composites, whose production involves the combustion of hydrocarbons, which can release greenhouse gases and other pollutants into the atmosphere.
W ith growing global environmental awareness and the aim of reducing

carburante del 3-15% e di ridurre la resistenza al rotolamento degli pneumatici del 20-30%, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambiente rispetto all’utilizzo del carbon black. Occorre tener presente che l’industria dello pneumatico si concentra su alcuni
environmental pollution and global warming, extensive research has been conducted to replace petroleum-based fillers with biomaterials as environmentally friendly and sustainable alternatives. The biodegradable fillers identified so far are from renewable sources and include: animal sources (chitosan and chitin); cereals (starch and polysaccharides); vegetables/wood (lignin, cellulose and natural fibres); agricultural waste; industrial by-products.
Table 2 shows the main characteristics of conventional and biological fillers. I n addition to being biodegradable and renewable, these materials have lower densities and costs than carbon black and silica and offer high specific strength and stiffnes, all characteristics that would reduce the rubber industry's dependence on fossil resources and contribute to global environmental conservation (see Figure 3 for the difference in performance between
fattori di prestazione, quali la resistenza al rotolamento, la resistenza all’usura o abrasione e l’aderenza sul bagnato: questi sono i tre parametri del cosiddetto triangolo magico (Figura 2), difficili da conciliare perché il miglioramento di un fattore comporta il de -
tyre compounds with carbon black and carbon black plus bio-filler).
N owadays countless efforts have been made to use plant materials to produce green silica as an environmentally friendly technique, with the advantages of abundant and low-cost raw materials, elimination of chemicals and reduced energy consumption. Various agricultural wastes are used to synthesize green silica, such as bamboo stems, sugar cane bagasse ash, rice husk ash, palm oil ash, wheat straw, corn stalks, cassava periderm and corn cob ash. Of all these wastes, rice husks (RHA), cassava bagasse and bamboo leaves offer a high silica content of up to 85-95%, 92.5% and 61% respectively.
G reen silica shows reinforcement potential in rubber composites and offers many benefits in terms of high
CompaCt devulCanizing plant
Comerio Ercole & Rubber Conversion Partnership


modulus, tear resistance, heat and abrasion resistance, hardness, reduced heat build-up and fracture resistance. In practice, it is the presence of the silanol functional group on its surface that improves all the characteristics mentioned above while reducing the vulcanization start time. I n addition to green silica, two types of silica recovered from tyre pyrolysis (r-silica) and geothermal water sources (geosilica) were also studied (Figure 4), the former of which was used as a reinforcing filler in epoxidized natural rubber (ENR) composites in comparison with Zeosil 1165. Good physical characteristics (tensile strength, hardness, abrasion resistance and good workability) were obtained with r-silica, which, together with silane X50S, further improved them, indicating that it is still capable of reacting with silane. Geosilica comes in the form of a thin thread, without small spherical particles that can affect the mixing process and the reinforcement of the composite. R ice generates about 22% by weight of husks during husking, which are
largely used as fuel for boilers for energy production, creating a large amount of ash. Among agricultural waste materials, rice husk ash (RHA) offers the highest silica content, approximately 90% in amorphous form, thus becoming an available source and an economical alternative for silica production.
S ince rice husk ash is difficult to dispose of and represents a significant environmental problem, extensive research has been conducted into using it as a reinforcement in rubber composites. One study in particular investigated the effect of replacing carbon black with RHA and two silicas (Zeosil 200MP and Ultrasil VN3) in a typical tyre tread formulation: it was found that composites with RHA have better M300 and M100 modules, better tensile strength and elongation at break, together with greater dispersibility in the SBR/BR rubber matrix, with a potential reduction in rolling resistance compared to both commercial grades used.
A nother recent study investigated the physical and dynamic-mechanical
terioramento degli altri. Gli iniziali problemi di scarso rinforzo della silice rispetto al carbon black, dovuti alla sua interazione più debole con il polimero e relativa dispersione, accumulo di calore, sensibilità alle temperature e tendenza a formare gel, sono stati risolti con l’utilizzo di silani, in particolare il bis(trietossipropil)tetrasolfuro, conosciuto comunemente come Si69.
VERSO CARICHE SOSTENIBILI
ED ECOCOMPATIBILI
Insieme alla gomma naturale, i polimeri SBR e BR sono i componenti principali nella produzione degli pneumatici e derivano da materie prime fossili, così come il carbon black, impiegato comunemente come carica rinforzante nella maggior parte dei compositi di gomma, che per la sua produzione comporta la combustione di idrocarburi, che possono rilasciare gas serra e altri inquinanti nell’atmosfera.
Con la crescente consapevolezza ambientale a livello globale e con l’obiettivo di ridurre inquinamento ambientale e riscaldamento globale, sono state condotte approfondite ricerche per sostitu-

2 - Confronto delle prestazioni tra gomma rinforzata con silice e carbon black (triangolo magico), riprodotto da https://doi.org/10.1186/s42252-022-00035-7 / Figure 2 - The performance comparison between silica and CB reinforced rubber (Magic triangle), Reprinted from https://doi.org/10.1186/s42252-022-00035-7.

ire le cariche a base petrolio mediante l’utilizzo di biomateriali come alternative ecologiche e sostenibili. Le cariche biodegradabili identificate finora sono da fonti rinnovabili e comprendono: fonti animali (chitosano e chitina); cereali (amido e polissaccaridi); vegetali/legno (lignina, cellulosa e fibre naturali); scarti agricoli; sottoprodotti industriali.
La Tabella 1 mostra le principali caratteristiche delle cariche convenzionali e di quelle biologiche.
Oltre ad esser biodegradabili e rinnovabili, questi materiali hanno densità e costi inferiori a carbon black e silice e offrono elevata robustezza specifica e rigidità, tutte caratteristiche che ridurrebbero la dipendenza dell’industria della gomma da risorse fossili e contribuirebbero al-
properties of SSBR/BR composites with partial and complete replacement of carbon black with precipitated rice husk silica (RHS) obtaining, with the 50% carbon black-50% RHS composite, an increase in rebound resistance at 100°C and abrasion resistance and a decrease in heat build-up, dynamic modulus and tan delta. Further improvements in dynamic modulus, heat build-up, rolling resistance and abrasion loss were obtained by increasing the RHS content, while no comparable physical and dynamic characteristics were found with complete replacement of carbon black.
C ellulose is the most sustainable and abundant polysaccharide in nature and is derived from various natural
la conservazione dell’ambiente globale (vedi Figura 3 per la differenza di prestazioni fra mescola pneumatico con carbon black e carbon black più biocarica).
O ggigiorno sono stati compiuti innumerevoli sforzi per utilizzare materiali vegetali per produrre silice green come tecnica ecocompatibile, con vantaggi di abbondanza e basso costo della materia prima, eliminazione di sostanze chimiche e ridotto consumo energetico. Per sintetizzare la silice green vengono utilizzati vari scarti agricoli come steli di bambù, cenere di bagassa di canna da zucchero, di lolla di riso e di olio di palma, paglia di frumento, gambi di grano-
sources, such as plants, algae, fungi and bacteria. It is non-toxic, renewable, environmentally friendly and biodegradable, with excellent thermomechanical qualities, low density and low cost. Together with its derivatives, such as microcrystalline, nanocrystalline, nanofibrillated variants and its esters, cellulose has attracted great interest in research. When mixed with rubber, it tends to agglomerate within the matrix due to the presence of surface hydroxyl groups, so it must undergo surface modification treatments beforehand to be effectively dispersed in the rubber matrix and ensure better integration and improved properties of the resulting composite. N anocrystalline cellulose, in particular, is increasingly being studied for its desirable characteristics, such as high specific surface area, high aspect
turco, periderma di manioca e cenere di pannocchia di granoturco. Fra tutti questi scarti, la lolla di riso (RHA), la bagassa di manioca e la foglia di bambù offrono un alto contenuto di silice fino a 85-95%, 92,5% e 61% rispettivamente. La silice green mostra un potenziale di rinforzo nei compositi di gomma e offre molti benefici in termini di alto modulo, resistenza a lacerazione, calore e abrasione, durezza, riduzione dell’accumulo di calore e resistenza alla rottura. In pratica è la presenza del gruppo funzionale silanolo sulla sua superficie che migliora tutte le caratteristiche citate riducendo, al contrario, il tempo di inizio della vulcanizzazione.
Oltre alla silice green sono stati studiati (Figura 4) anche due tipi di silice recu-
ratio, high crystallinity and strength, high modulus, low density, mechanical flexibility, biodegradability and biocompatibility. The use of Si69 silane allows for better interaction between the nanocrystals (CNC) and the rubber matrix, so that the composite offers better thermal ageing and better mechanical characteristics. A study has verified that CNC from softwood pulp, modified with ethyltrimethylammonium bromide (CTMAB) and used as a partial replacement for carbon black at a level of 5 or 10 phr in natural rubber-based composites for tyres, improves their mechanical characteristics as well as their wet-skid and ageing resistance. I n another study, CNCs were used as reinforcing agents in NBR-based composites to increase their heat resistance and thermal stability, thanks
perata da pirolisi di pneumatici (r-silice) e da fonti di acqua geotermica (geosilice), tra cui la prima è stata utilizzata come carica di rinforzo in compositi di gomma naturale epossidata (ENR) in confronto a Zeosil 1165. Si sono ottenute buone caratteristiche fisiche (carico di rottura, durezza, resistenza all’abrasione e buona lavorabilità) con la r-silice che, insieme al silano X50S, le ha ulteriormente migliorate, indicando di essere ancora in grado di reagire con il silano. Per quanto riguarda la geosilice, essa si presenta sotto forma di filo sottile, senza piccole particelle sferiche che possono influenzare il processo di mescolazione e il rinforzo del composito.
I l riso genera circa il 22% in peso di lolla, durante la sbramatura, che viene in gran parte utilizzata come combustibile per caldaie per la produzione di energia, creando una grande quantità di cenere. Fra i materiali di scarto agricolo la cenere di lolla di riso (RHA) offre il più alto contenuto di silice, circa il 90% in forma amorfa, diventando così una fonte disponibile e un’alternativa economica per la produzione di silice. Poiché lo smaltimento della lolla di riso è difficile e rappresenta un importante problema ambientale, sono state con-
SOSTENIBILITÀ/SUSTAINABILITY
dotte estese ricerche per utilizzare le sue ceneri come rinforzo in compositi di gomma. Una ricerca, in particolare, ha studiato l’effetto della sostituzione del carbon black con RHA e con due silici (Zeosil 200MP e Ultrasil VN3) in una tipica formulazione per battistrada pneumatico: è stato riscontrato che i compositi con RHA presentano migliori moduli M300 ed M100, migliore carico di rottura e allungamento a rottura, insieme a una maggiore disperdibilità nella matrice gomma SBR/BR, con potenziale riduzione della resistenza al rotolamento rispetto a entrambi i gradi commerciali utilizzati.
Un’altra recente ricerca ha studiato le proprietà fisico e dinamico-meccaniche di compositi SSBR/BR con parziale e completa sostituzione del carbon black con silice di lolla di riso precipitata (RHS), ottenendo con il composito 50% carbon black-50% RHS un aumento della resistenza al rimbalzo a 100 °C e della resistenza all’abrasione e una diminuzione dell’accumulo di calore, di modulo dinamico e di tan delta. Un ulteriore miglioramento di modulo dinamico, accumulo di calore, resistenza al rotolamento e perdita per abrasione sono stati ottenuti aumentando il contenuto di RHS mentre, con la sostitu -

Figura 3 - Il confronto delle prestazioni tra i compositi di gomma rinforzata con (CB + bio-filler) e quelli rinforzati solo con CB sul magic triangle del pneumatico, riprodotto da https://doi.org/10.1039/D1GC01115D /
Figure 3 - The comparison of the performance between (CB + bio-filler) and CB reinforced rubber composites on the tire magic triangle, Reprinted from https://doi.org/10.1039/D1GC01115D.
zione completa del carbon black, non si sono riscontrate caratteristiche fisiche e dinamiche comparabili.
La cellulosa è il polisaccaride più sostenibile e abbondante in natura e deriva da varie fonti naturali, quali piante, alghe, funghi e batteri, non è tossica, è rinnovabile, ecologica e biodegradabile, con eccellenti qualità termomeccaniche, bassa densità e basso costo. Insieme ai suoi derivati, come le varianti microcristallina, nanocristallina, nanofibrillata e suoi esteri, la cellulosa ha suscitato grande interesse nella ricerca. Durante la sua miscelazione con la gomma, essa tende ad agglomerarsi all’interno della matrice per la presenza di gruppi idrossilici superficiali, per cui deve subire preventivamente trattamenti di modifica superficiale per essere efficacemente dispersa nella matrice di gomma e garantire una migliore integrazione e migliori proprietà del composito risultante.
La cellulosa nanocristallina, in particolare, viene sempre più studiata per le sue desiderabili caratteristiche, quali elevata superficie specifica, elevato rapporto di aspetto, elevata cristallinità e robustezza, elevato modulo, bassa densità, flessibilità meccanica, biodegradabilità e biocompatibilità. L’utilizzo di silano Si69 consente una migliore interazione fra i nanocristalli (CNC) e la matrice gomma, così che il composito offre un migliore invecchiamento termico e migliori caratteristiche meccaniche.
U no studio ha verificato che CNC da polpa di legno tenero, modificati con bromuro di etiltrimetilammonio (CTMAB) e utilizzati come parziale sostituzione del carbon black a livello di 5 o 10 phr in compositi a base gomma naturale per pneumatici, ne migliorano le caratteristiche meccaniche nonché la resistenza allo scivolamento e all’invecchiamento.
I n un altro studio i CNC sono stati utilizzati come agenti di rinforzo in compositi a base NBR, per aumentarne la resistenza al calore e la stabilità termica, grazie ai buoni legami interfacciali con la gomma.
Are you looking for more than just a product for your Rubber business?
The services of Brenntag’s Rubber team go far beyond distribution. Together with our lead suppliers and our Service and Solution Centre in Orbassano, Italy, our team offers dedicated services and blends for rubber compounders. It is specialized in the production of tailor made dry liquids and special and innovative repacking additives.
The Brenntag Rubber team is constantly researching new sustainable solutions, also considering the use of green raw materials aiming to provide safe and sustainable solutions to its partners.
Are you interested to learn more about the capabilities of Brenntag’s Rubber Business Unit?

La lignina (LGN) è un polimero naturale altamente aromatico con una struttura amorfa tridimensionale, è il secondo polimero rinnovabile più disponibile dopo la cellulosa e si trova in tutti i materiali lignocellulosici, in particolare nel legno, di cui costituisce circa il 1525% in peso. Sono varie le sue proprietà vantaggiose, tra cui buona stabilità, bassa densità, effetto di rinforzo, proprietà antiossidanti, adesività, elevata disponibilità, basso costo, rinnovabilità e biodegradabilità: tutte queste caratteristiche possono essere influenzate dalla sua origine e dalle tecniche di estrazione applicate.
Sebbene la lignina sia principalmente ottenuta come sottoprodotto di scarto delle industrie cartarie e della cellulosa, solo il 2% è stato finora utilizzato con successo per scopi industriali. Esistono tre diversi metodi di miscelazione per preparare i compositi di gomma, ossia meccanica, con lattice e con lavorazione morbida, e la funzione dei compositi rinforzati con lignina è influenzata dalle caratteristiche della lignina come contenuto di ceneri, peso molecolare medio e distribuzione, concentrazione nella matrice, purezza, metodo di lavorazione e compatibilità con la matrice.
L a lignina è stata usata per la prima volta all’inizio degli anni 2000 come carica rinforzante in c omposti a base NBR, ma solo nell’ultimo decennio sono state condotte ricerche sulla sua applicazione come agente di rinforzo per sviluppare composi biologici e sostenibili, soprattutto in gomma naturale, SBR, ANBR (gomma acrilonitrile butadiene) ed EVA. È cresciuta così la considerazione della lignina come alternativa al carbon black nell’industria dello pneumatico e degli articoli per l’automobile.
Sono stati fatti molti studi sull’aggiunta di lignina a compositi con carica carbon black e silice, con risultati incoraggianti di volta in volta per processabilità, stabilità termica e resistenza all’invecchiamento, per proprietà meccaniche e dinamiche oppure per riduzione dell’effetto Payne, con interessi legati soprattutto all’industria dello pneumatico.
to their good interfacial bonds with rubber.
L ignin (LGN) is a highly aromatic natural polymer with a three-dimensional amorphous structure. It is the second most available renewable polymer after cellulose and is found in all lignocellulosic materials, particularly wood, of which it constitutes approximately 15-25% by weight. It has various advantageous properties, including good stability, low density, reinforcing effect, antioxidant properties, adhesiveness, high availability, low cost, renewability and biodegradability: all these characteristics can be influenced by its origin and the extraction techniques applied.
A lthough lignin is mainly obtained as a waste by-product of the paper and cellulose industries, only 2% has been successfully used for industrial purposes todate. There a re three different mixing methods for preparing rubber composites, namely mechanical, latex and soft mixing, and the function of lignin-reinforced composites is influenced by lignin characteristics such as ash content, average molecular weight and distribution, concentration in the matrix, purity, processing method and compatibility with the matrix. Lignin was first used in the early 2000s as a reinforcing filler in NBR-based composites, but it is only in the last decade that research has been conducted on its application as a reinforcing agent to develop biological and sustainable composites, especially in natural rubber, SBR, ANBR (acrylonitrile butadiene rubber) and EVA. This has led to increased consideration of lignin as an alternative to carbon black in the tyre and automotive industries.
M any studies have been conducted on the addition of lignin to composites with carbon black and silica fillers, with encouraging results in terms of processability, thermal stability and ageing resistance, mechanical and dynamic properties, and reduction of the
Payne effect, with particular interest in the tyre industry.
S tarch is a polysaccharide with a rigid structure and crystalline content, which can be obtained from various sources, such as cereals (wheat, corn and rice), roots or tubers (potatoes and cassava), sugar, fruit and vegetables. Its beneficial properties are low density, environmental compatibility, abundance, renewability and low cost, making it a promising reinforcing biofiller for rubber composites. Once incorporated into rubber using techniques such as mechanical mixing, masterbatch, coagulation, chemical modification, irradiation and grafting, starch improves its biological content and mechanical properties, acting as a reinforcing and coupling agent. In tyre applications, starch improves wet grip, decreases rolling resistance and reduces tyre weight.
H owever, starch and rubber are incompatible due to their polarity and non-polarity respectively, which can damage the properties of the composites. Three approaches have therefore been proposed to improve their compatibility: modification of the polymer matrix or starch before mixing and the use of a compatibilizer.
N umerous studies conducted on the inclusion of starch in tyre formulations have led to positive results in terms of tensile strength, elongation at break and tear resistance, while also improving rolling resistance and reducing hysteresis.
B iochar is a carbonaceous material obtained through the pyrolysis of biomass. It represents an economical, sustainable and practical alternative to traditional carbon black, although it is less pure than the latter as it is produced from any carbon-containing biomass and therefore consists of various other chemical com -
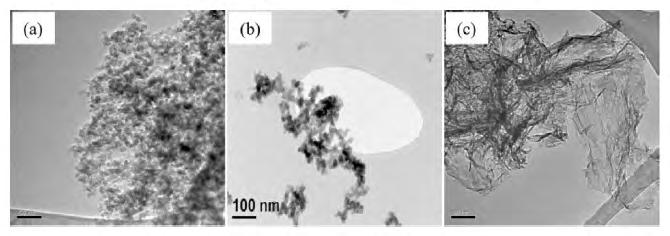
https://doi.org/10.1007/ s42464-023-00196-5 /
https://doi.org/10.1007/s42464023-00196-5.
L’amido è un polisaccaride con una struttura rigida e un contenuto cristallino, che può essere ricavato da varie fonti, quali cereali (frumento, granoturco e riso), radici o tuberi (patate e manioca), zucchero, frutta e verdura. Le sue proprietà vantaggiose sono la bassa densità, la compatibilità ambientale,
pounds. However, the pyrolysis conditions (temperature, residence time and heating rate) can be controlled and optimized to produce biochar that can be adjusted in terms of turnable size, surface morphology, porosity, surface area, functional groups, intrinsic modulus, high carbon content (> 90%) and less ash content (< 8%). The variable surface chemistry of biochar can also be modified to achieve better compatibility with rubber.
S ince biochar is a renewable material, it has become interesting as an alternative filler to carbon black in rubber, with studies considering various types from different plant biomasses, evaluating their effects in natural rubber and NBR, always as a filler combined with carbon black, and obtaining promising results in terms of tensile strength, modulus and rolling resistance reduction.
l’abbondanza, la rinnovabilità e il basso costo, che lo rendono una promettente biocarica rinforzante per i compositi di gomma. Una volta incorporato nella gomma, con tecniche quali miscelazione meccanica, mediante masterbatch, per coagulazione, modifica chimica, irradiazione e aggraffaggio, l’amido ne migliora il contenuto biologico e le proprietà meccaniche, com-
H owever, it is important to note that replacing carbon black with biochar usually degrades the reinforcing properties of rubber composites, due to the much larger particle size of biochar and the resulting introduction of localized stresses in the composite. For this reason, top-down methods, such as milling, are used to reduce the particle size of biochar: in this way, by replacing 50% of the carbon black in the SBR/natural rubber formulation with ground silica/biochar, equal or superior elongation at break and toughness were obtained with a small loss of tensile strength (<6%).
CARBON BLACK RECYCLED F ROM WASTE TYRES
With an approximate estimate of global rubber production at 30 million tonnes (55% synthetic rubber and 45%
portandosi come agente di rinforzo e di accoppiamento. Nelle applicazioni per pneumatico, l’amido migliora l’aderenza sul bagnato, diminuisce la resistenza al rotolamento e riduce il peso dello pneumatico.
Tuttavia amido e gomma sono incompatibili per la loro polarità e non polarità rispettivamente, che possono danneggiare le proprietà dei compositi,
natural rubber), and the tyre industry accounting for almost 70% of consumption, it is clear how enormous the amount of rubber waste is (Figure 5), the disposal of which causes numerous and critical environmental problems. C urrent techniques for disposing of waste tyres include reclaiming, combustion, retreading, grinding and pyrolysis: in recent years, research has focused on pyrolysis for the production of value-added recycled materials, such as gaseous and liquid fractions, steel and carbon black, the latter consisting of carbon black used in tyre production together with impurities derived from the inorganic ingredients of the compound. Recovered carbon black (rCB) is an alternative to virgin carbon black, which it partially replaces, providing good performance, sometimes even superior to that of the control formulation.

Figura 5 - a) Percentuali di consumo della gomma nei vari settori industriali; (b) Produzione globale di rifiuti di gomma / Figure 5 - (a) The percentages of rubber consumption in various industries; (b) the global production of waste rubber.
per cui sono stati proposti tre approcci per migliorare la loro compatibilità: la modifica della matrice polimerica o dell’amido prima della miscelazione e l’utilizzo di un compatibilizzante.
I numerosi studi, condotti sull’inserimento dell’amido nelle formulazioni per pneumatici, hanno portato a risultati positivi in termini di carico di rottura, allungamento a rottura e resistenza a lacerazione, migliorando anche la resistenza al rotolamento e riducendo l’isteresi.
I l biochar è un mat eriale carbonioso, ottenuto mediante pirolisi di biomasse, che rappresenta un’alternativa economica, sostenibile e pratica al carbon black tradizionale, rispetto al quale è meno puro poiché è prodotto da qualsiasi biomassa contenente carbonio ed è quindi costituito da diversi altri composti chimici.
Tuttavia le condizioni di pirolisi (temperatura, tempo di permanenza e velocità di riscaldamento) possono essere controllate e ottimizzate per produrre biochar, regolabile per quanto riguarda dimensione, morfologia superficiale, porosità, area superficiale, gruppi funzionali, modulo intrinseco, alto contenuto di carbonio (> 90%) e minore contenuto di ceneri (< 8%).
L a chimica superficiale variabile del biochar può inoltre essere modificata per ottenere una sua migliore compatibilità con la gomma.
Poiché il biochar è un materiale rinnovabile, è diventato interessante come carica alternativa al carbon black nella gomma, con studi che ne hanno preso in considerazione vari tipi da diverse biomasse vegetali, valutandone gli effetti in gomma naturale ed NBR, sempre come carica combinata con carbon black, e ottenendo risultati promettenti in termini di carico di rottura, moduli e riduzione della resistenza al rotolamento.
Tut tavia è importante notare che la sostituzione del carbon black con biochar di solito degrada le proprietà di rinforzo dei compositi di gomma, a causa della molto maggiore dimensione delle particelle del biochar e della conseguente introduzione di sollecitazioni localizzate nel composito.
P er questo motivo vengono utilizzati metodi top-down, come la macinazione, per ridurre la dimensione delle particelle del biochar: in questo modo, sostituendo il 50% del carbon black della formulazione a base SBR/gomma naturale con silice/bi ochar macinato si sono ottenuti allungamento a rottura e tenacità uguali o superiori con una piccola perdita di carico di rottura (< 6%).
C on una stima approssimativa della produzione globale di gomma di 30 milioni di tonnellate (55% gomma sintetica e 45% gomma naturale), con l’industria dello pneumatico che costituisce quasi il 70% dei consumi, si capisce quanto sia enorme la quantità di scarto della gomma (Figura 5), il cui smaltimento causa numerosi e critici problemi ambientali. Le attuali tecniche di smaltimento degli pneumatici di scarto sono il recupero, la combustione, la ricostruzione, la macinazione e la pirolisi: l’attenzione della ricerca si è focalizzata negli ultimi anni sulla pirolisi, per la produzione di materiali di recupero a valore aggiunto, quali frazioni gassose e liquide, acciaio e carbon black, costituito quest’ultimo dal carbon black utilizzato nella produzione degli pneumatici insieme a impurità derivate dagli

ingredienti inorganici della mescola. Il carbon bvlack di recupero (rCB) rappresenta un’alternativa al carbon black vergine, di cui viene utilizzato in sostituzione parziale, così da essere in grado di fornire buone prestazioni, a volte addirittura superiori a quelle della formulazione di controllo.
Le cariche tradizionali della gomma, come carbon black e silice, forniscono eccellenti proprietà di inforzo, ma i loro processi di produzione hanno spesso un impatto negativo sull’ambiente per quanto riguarda consumo di energia, emissioni di gas serra ed esaurimento di risorse non rinnovabili. Gli studi condotti per affrontare questi problemi hanno valutato cariche alternative più economiche e rispettose dell’ambiente. I risultati ottenuti con le cariche biologiche rinnovabili e sostenibili sono promettenti e la loro incorporazione migliora la sostenibilità dei manufatti, mantenendone o migliorandone le prestazioni e riducendo la dipendenza dai materiali da fonti fossili. L’utilizzo di biocariche nei compositi di gomma è in linea con i principi dell’economia circolare, riducendo la produzione di rifiuti, promuovendo la conservazione delle risorse e allineandosi con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio e di mitigazione dell’impatto ambientale verso un futuro più green. Inoltre biodegradabilità e riciclabilità dei compositi di gomma possono essere migliorate, riducendo ulteriormente il loro impatto sull’ambiente e consentendo lo sviluppo di soluzioni sostenibili per il loro fine vita. Tuttavia sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare e ottimizzare le tecniche di lavorazione, la compatibilità e le prestazioni delle biocariche in diverse formulazioni di gomma.
Questo articolo è una rielaborazione del testo originale, pubblicato in inglese da Elsevier Materials Today Sustainability 2024.100886 col titolo “A comprehensive overview of conventional and bio-based fillers for rubber formulations sustainability” e firmato da Mehran Dadkhah, Department of Applied Science and Technology (DISAT), Politecnico di Torino, Torino, Italia. u
Traditional rubber fillers, such as carbon black and silica, provide excellent reinforcing properties, but their production processes often have a negative impact on the environment in terms of energy consumption, greenhouse gas emissions and depletion of non-renewable resources. S tudies conducted to address these issues have evaluated alternative fillers that are more cost-effective and environmentally friendly.
Th e results obtained with renewable and sustainable biological fillers are promising, and their incorporation improves the sustainability of manufactured products, maintaining or improving their performance while reducing dependence on materials from fossil sources.
T he use of biofillers in rubber composites is in line with the principles of the circular economy, reducing waste
production, promoting resource conservation and aligning with the objectives of red ucing carbon emissions and mitigating environmental impact towards a greener future. In addition, the biodegradability and recyclability of rubber composites can be improved, further reducing their impact on the environment and enabling the development of sustainable end-of-life solutions. Nevertheless, further research is needed to explore and optimize the processing techniques, compatibility and performance of biofillers in different rubber formulations.
This article is a reworking of the original text, published in English by Elsevier Materials Today Sustainability 2024.100886 with the title “A comprehensive overview of conventional and bio-based fillers for rubber formulations sustainability” and signed by Mehran Dadkhah, Department of Applied Science and Technology (DISAT), Politecnico di Torino, Torino, Italia. u

Un nuovo processo messo a punto dal Fraunhofer IMWS permette di convertire la CO₂ in prodotti chimici di base sostenibili, come metanolo ed etilene, impiegando una tecnologia avanzata di catalisi al plasma a bassa temperatura e biogas come materia prima. Il progetto potrebbe rendere la filiera della gomma sintetica più verde e competitiva grazie a materie prime circolari e processi energeticamente efficienti.
Il nostro settore fa largo uso di gomma sintetica, i cui componenti, in primis i monomeri, sono tipicamente derivati dal petrolio e sono quindi di origine fossile.
La riduzione del fabbisogno di materie prime di origine fossile è un trend in corso da anni, con l’obiettivo di rendere anche la nostra industria sempre più sostenibile e questo numero monografico dedicato alla Green Rubber è un’occasione di aggiornamento periodico.
La motivazione che sta alla base della necessità di ridurre l’impiego dei materiali fossili è perché sono ritenuti responsabili del cambiamento climatico, causato dal riscaldamento globale, in quanto, quando utilizzati in particolare per produrre energia, portano a un incremento netto di CO2, il gas serra più importante in termini quantitativi.
Le attività umane sono la principale causa dell'aumento delle emissioni di gas serra nell'atmosfera e il parametro più importante è la differenza tra la CO2 emessa e quella assorbita.
L’assorbimento naturale (oceani e vegetazione) è la frazione preponderante, mentre l’assorbimento artificiale (cattura e stoccaggio, anche geologico, del carbonio) è ancora minimo. In questo campo di particolare interesse c’è non solo il sequestro, ma anche l’utilizzo della CO₂ per produrre materie prime.
Questo articolo, dopo una parte introduttiva che chiarisce alcuni concetti

entrati nel vocabolario quotidiano, ma qualche volta non ben padroneggiati, illustra un progetto di ricerca in corso presso il Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems IMWS, che ha l’obiettivo di utilizzare la CO 2 per produrre prodotti chimici di base (CCU) quali metanolo (CH3OH) o etilene (C2H4), che possono diventare materie prime sostenibili per la produzione dei monomeri impiegati nella sintesi della gomma sintetica.
CAMBIAMENTO
Come noto, il cambiamento climatico è una minaccia globale e una delle priorità che dovrebbe coinvolgere l’inte -

by A.L. Spelta
A new process developed by Fraunhofer IMWS enables the conversion of CO₂ into sustainable base chemicals such as methanol and ethylene, using advanced low-temperature plasma catalysis technology and biogas as a feedstock. The project could make synthetic rubber supply chains greener and more competitive thanks to circular raw materials and energy-efficient processes.
Our industrial sector makes extensive use of synthetic rubber, whose components, particularly monomers, are typically derived from oil and are therefore of fossil origin. Reducing the demand for fossil raw materials is an ongoing trend, aiming to make the sector increasingly sustainable and this special issue dedicated to Green Rubber provides regular updates. The reason behind the need to reduce the use of fossil fuels is that they are considered responsible for climate change,
caused by global warming, since, when used in particular to produce energy, they lead to a net increase in CO2, the most important greenhouse gas. Human activities are the main cause of the increase in greenhouse gas emissions into the atmosphere, and the most important parameter is the difference between CO2 emitted and CO2 absorbed. Natural absorption (by oceans and vegetation) dominates, while artificial absorption (carbon capture and geological storage) is still minimal. In this context, not only CO₂ sequestration is of interest, but
also its utilization to produce raw materials.
This article first clarifies concepts that have entered our daily vocabulary but are sometimes misunderstood, then presents an ongoing research project at the Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems IMWS, which aims to use CO₂ to produce commodity chemicals (CCU) such as methanol (CH₃OH) and ethylene (C₂H₄), which can become sustainable feedstocks for production of monomers used in the synthesis of synthetic rubber.

ro pianeta. Il cambiamento climatico è causato dal riscaldamento globale e ha conseguenze profonde e diversificate sul pianeta, in quanto coinvolgono gli ecosistemi, le economie e le società.
Ne elenchiamo alcuni.
Aumento delle temperature globali, che si ritiene possano portare a ondate di ca-
A s is well known, climate change is a global threat and one of the priorities that should concern the entire planet.
C limate change is caused by global warming, which has profound and diverse impacts on ecosystems, economies, and societies. Here are some of them.
Rising global temperatures, which can lead to more frequent and intense heatwaves, increased human health risks, and greater water evaporation resulting in drought in some regions.
Melting glaciers and rising sea levels i.e. the reduction of mountain glaciers and polar ice caps (Arctic and Antarctic), sea level rise (up to 1 meter by 2100 in some scenarios), with risks for coastal cities and small islands, and loss of habitat for species such as polar bears and penguins.
M ore frequent extreme weather events : more intense hurricanes, cyclones, typhoons due to higher ocean
lore più frequenti ed intense, con rischi per la salute umana e maggiore evaporazione dell’acqua, con conseguente aridità in alcune regioni.
Scioglimento dei ghiacci e innalzamento del livello del mare, vale a dire la riduzione dei ghiacciai montani e delle calotte polari (Artide e Antartide), l’innalzamen-
temperatures, more severe floods in some regions and prolonged droughts in others; more destructive wildfires (e.g., in Australia, California, the Mediterranean).
Ecosystem alteration and loss of biodiversity, extinction of plant and animal species unable to adapt, coral bleaching due to ocean acidification, forced animal migrations toward cooler latitudes.
Impacts on agriculture and food security: reduced crop yields in some regions (e.g., sub-Saharan Africa, South Asia), increased food prices and risk of famine, changes in fish and marine resource distribution, with effects on fishing.
Socioeconomic consequences and climate migration: greater conflicts over water and farmland, mass migration from regions affected by desertification sea level rise or extreme events; high economic costs of reconstruction after natural disasters.
O cean acidification: CO₂ absorbed by oceans turns into carbonic acid, harming shellfish, plankton, and entire marine food chains.
to del livello del mare (fino a 1 metro entro il 2100 in alcuni scenari), con rischi per le città costiere e le piccole isole, e perdita di habitat per specie come e gli orsi polari e i pinguini.
Eventi meteorologici estremi più frequenti, uragani, cicloni e tifoni più intensi a causa delle temperature oceaniche più
Altered oceanic and atmospheric currents : possible weakening of the Gulf Stream with unpredictable effects on the European climate, changes in monsoons with repercussions on agriculture and water availability in Asia and Africa. Climate change caused by global warming is mainly driven by increased greenhouse gas emissions from human activity:
- burning fossil fuels (coal, oil, natural gas) for energy, heating, and transport, releasing CO₂ and other greenhouse gases;
- d eforestation: trees absorb CO₂, but their destruction (e.g. in the Amazon) reduces this capacity;
- intensive agriculture and livestock: livestock produce methane (CH₄), a greenhouse gas more potent than CO₂; fertilizers release nitrous oxide (N₂O), another impactful greenhouse gas;
- industry and waste: industrial processes and landfills emit greenhouse gases and pollutants;
- n atural causes (less significant than human impact): volcanic eruptions, so-
elevate, alluvioni più gravi in alcune aree, mentre altre soffriranno di siccità prolungate, incendi boschivi più frequenti e distruttivi (es. in Australia, California, Mediterraneo).
Alterazione degli ecosistemi e perdita di biodiversità , con estinzione di specie animali e vegetali che non riescono ad adattarsi, sbiancamento e morte delle barriere coralline a causa dell’acidificazione degli oceani, migrazioni forzate di specie animali verso latitudini più fredde.
Impatto sull’agricoltura e sicurezza alimentare, con riduzione delle rese agricole in alcune regioni (es. Africa subsahariana, Asia meridionale), aumento dei prezzi dei generi alimentari e rischio di carestie, cambiamenti nella distribuzione di pesci e risorse marine, con effetti sulla pesca.
Conseguenze socioeconomiche e migrazioni climatiche, con aumento dei conflitti per le risorse idriche e le terre coltivabili, migrazioni di massa da aree colpite da desertificazione, innalzamento del mare o eventi estremi, costi economici elevati per la ricostruzione dopo disastri naturali.
Acidificazione degli oceani, assorbimen-
lar variation, ocean cycles influence climate, but recent warming is too rapid to be explained by natural factors alone.
Greenhouse gases are:
- Carbon dioxide (CO₂), which, as mentioned, mainly comes from burning fossil fuels (oil, coal, natural gas), deforestation (failure to capture CO₂), and industrial activities. It is the most widespread greenhouse gas and is believed to contribute to approximately 76% of total greenhouse gas emissions (over a 100-year period).
- Methane (CH₄), from livestock, rice paddies, landfills, gas and oil extraction; it accounts for about 16% of emissions, but has a climate-changing power 28-36 times greater than CO₂;
- Nitrous oxide (N₂O) from agriculture (nitrogen fertilisers), combustion (including biomass), industrial processes; about 6% of emissions, 265–298 times more warming impact than CO₂;
- Fluorinated gases (HFCs, PFCs, SF₆, NF₃), from refrigerants, air conditioners, industrial processes, semiconductors; about 2% of emissions, up to 23,500 times the warming power of CO₂ (for SF6);
- O ther minor gases like ozone (O₃) formed by pollution and water vapor (H₂O).
Sunlight passes through the atmosphere and illuminates and warms the Earth’s surface. Part of this heat is re-emitted as infrared radiation, which greenhouse gases absorb and radiate in all directions, warming the atmosphere. Basically, greenhouse gases act as a kind of blanket trapping heat.
Without this effect, Earth would be too cold for life (-18 °C versus the current average +15 °C).
Human activities have increased greenhouse gas concentrations and continue to do so, enhancing the natural greenhouse effect.
The result is global warming, which international agreements (Kyoto, Paris) aim to keep within 2°C-and preferably 1.5°C-through a series of actions that should involve all nations on the planet.

to di CO₂ da parte degli oceani, che si trasforma in acido carbonico, danneggiando molluschi, plancton e intere catene alimentari marine.
Alterazione delle correnti oceaniche e atmosferiche, con possibile indebolimento della corrente del Golfo, con effetti imprevedibili sul clima europeo, cambiamenti nei monsoni, con ripercussioni su agricoltura e disponibilità d’acqua in Asia e Africa.
Il cambiamento climatico causato dal riscaldamento globale è provocato principalmente dall'aumento delle emissioni di gas serra nell'atmosfera, derivanti dalle attività umane:
- combustione di fonti energetiche fossili (carbone, petrolio e gas naturale) per produrre energia, riscaldamento e consentire i trasporti, con rilascio di anidride carbonica (CO₂) e altri gas serra; - deforestazione, gli alberi assorbono la CO₂, ma la distruzione delle foreste (es. in Amazzonia) riduce questa capacità; - agricoltura e allevamento intensivo, gli allevamenti producono metano (CH₄), un gas serra più potente della CO2, i fertilizzanti rilasciano protossido di azoto (N₂O), un altro gas climalterante;
A s mentioned above, carbon dioxide is by far the most abundant greenhouse gas in the atmosphere, but reducing methane, which has a greater climate-changing power and remains in the atmosphere for only 10-12 years, would also bring rapid benefits. Many experts agree that reducing methane in the coming decades, while working on CO₂, could be the most effective strategy for limiting global warming by 2050. That said, we will focus mainly on CO2, whose global emissions were In 2023, about 37.5 billion tons (Gt). The top five emitting countries: China (over 12 Gt, 33%), USA (5.3 Gt, 14%), India (3.5 Gt, 9%), Russia (1.8 Gt, 5%).
China + USA + India account for about 56% of global emissions; the EU about 7.5%, and Italy 0.9%. So even if the EU eliminated all its CO₂ emissions, over 90% would still come from elsewhere.
I n addition to emissions, we must al -

- industria e rifiuti, i processi industriali e le discariche emettono gas serra e sostanze inquinanti; - cause naturali (minori rispetto all'impatto umano), eruzioni vulcaniche, variazioni solari e cicli oceanici influenzano il clima, ma il recente riscaldamento è troppo rapido per essere spiegato solo da fattori naturali.
so consider CO₂ absorption. In fact, approximately 55–65% (2023 data) was absorbed by natural processes, much less by artificial ones; the remainder accumulated in the atmosphere, increasing CO₂ concentration to about 420 ppm (2023) from around 280 ppm before the industrial era (~1750). Compared to 2022, atmospheric CO₂ rose another 2.5 ppm.
Natural absorption accounts for approximately 20–25 Gt CO₂/year, the main share.
Absorption is carried out by:
- vegetation and soils (11–12 Gt CO₂/year): forests, grasslands, and plants absorb via photosynthesis, but deforestation reduces this capacity;
- oceans (9–10 Gt CO₂/year): dissolve CO₂ forming carbonic acid (H₂CO₃), contributing to ocean acidification;
- chemical reactions with rocks (~0.1 Gt CO₂/year): slow processes like silicate weathering.
Artificial absorption, on the other hand, is still minimal, amounting to less than 0.01
QUALI SONO I GAS SERRA E PERCHÉ CONTRIBUISCONO AL RISCALDAMENTO GLOBALE
I gas serra sono: - Anidride carbonica (CO₂), che, come detto, deriva principalmente dalla combustione dei combustibili fossili (petrolio, carbone, gas naturale), dalla defore -
Gt CO₂/year.
There are several technologies and approaches for reducing atmospheric CO₂ - categorized as carbon capture, storage, and utilization (CCUS).
Direct air capture (DAC): technologies that filter CO₂ directly from the air (e.g. Climeworks or Carbon Engineering plants). Post-combustion capture: removes CO₂ from industrial or energy fumes before atmospheric release.
Bioenergy with CCS (BECCS): burning biomass (which absorbed CO₂ during growth i.e. now and not millions of years ago), with carbon captured and stored.
Geological storage of CO₂
Injection into underground rock formations (spent oil/gas fields or saline aquifers).
Mineralization: conversion of CO₂ into solid minerals (e.g., basalt) via natural chemical reactions.

Carbon Capture and Utilization (CCU)
P roduction of synthetic fuels: CO₂ + green hydrogen → e-fuels.
Construction materials: CO₂ used to produce carbonated concrete (e.g., CarbonCure technology).
Chemicals and plastics: conversion to methanol, polymers, or other useful compounds.
The aim is to reduce emissions and increase CO₂ absorption. Europe’s green transition has set a goal of becoming “carbon neutral” by 2050.
The following section describes an ongoing research project at Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems IMWS to use CO₂ for basic chemical production (CCU).
The project uses “Power-to-X” technology: using electricit y from renewable sources, an effective approach for sustainable production of base organic chemicals like ethylene, methanol, or styrene. Hydrogen needed for these chemicals can also be produced emission-free by electrolysis. The project, called “PKat4Chem”, focuses on the conversion and subsequent use of CO₂ for for the production of basic chemicals. The consortium is concentrating on low-temperature plasma catalysis (LTP). With this technology, feed-
stock gases from biomass-such as methane (CH₄) - in combination with CO₂ are activated very efficiently using plasma and converted, with appropriate catalysts in a single-stage process, into basic chemicals such as methanol (CH₃OH) or ethylene (C₂H₄).
LTP catalyst reactors can offer very high efficiencies (up to 95%), as well as easy scalability and lower investment and operating costs. This enables a potential turnkey process that can be flexibly activated or deactivated as needed.
The project (running until the end of 2027) aims to develop a new chain process with a modular unit composed of an LTP catalyst reactor for methanol or ethylene synthesis, validated through pilot testing at an existing biogas plant.
Fraunhofer IMWS is responsible for microstructural characterization of the patented electrode material and catalysts, using scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDXS) for elemental distribution analysis. Surface material changes due to LTP catalysis are analyzed using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and time-offlight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS).
To understand electrode processes, fundamental properties are also studied using thermal analysis and electron energy

stazione (mancata cattura della CO2) e da attività industriali. È il gas serra più diffuso e si ritiene che contribuisca a circa il 76% delle emissioni totali di gas serra (su scala 100 anni);
- Metano (CH₄), che deriva dall’allevamento del bestiame, da risaie, discariche, estrazione di gas e petrolio. Contribuisce a circa il 16% delle emissioni, ma ha un potere climalterante 28-36 volte superiore alla CO₂;
- P rotossido di azoto (N₂O). Deriva dall’agricoltura (fertilizzanti azotati), combustione, anche di biomassa, processi industriali. Contribuisce a circa il 6% delle emissioni, con un potere climalterante 265-298 volte superiore alla CO₂;
- Gas fluorurati (HFC, PFC, SF₆, NF₃), Fonti: refrigeranti, condizionatori, processi industriali, semiconduttori. Contributo: ~2% delle emissioni, ma con un altissimo potere serra (fino a 23.500 volte la CO₂ per l'SF₆),
- altri gas minori come Ozono (O₃) che si forma a seguito dell'inquinamento e vapore acqueo (H₂O).
La luce solare passa attraverso l'atmosfera e illumina e riscalda la superficie terrestre.
Parte di questo calore viene riemesso come radiazione infrarossa, che i gas serra assorbono e riemettono in tutte le direzioni, riscaldando l'atmosfera. In sostanza i gas serra agiscono come una sorta di coperta che trattiene il calore. Senza questo effetto, la Terra sarebbe troppo fredda per sostenere la vita (circa -18 °C invece degli attuali circa +15 °C medi), tuttavia le attività umane hanno aumentato la concentrazione di gas serra, e continuano a farlo, potenziando l’effetto serra naturale.
Il risultato è un riscaldamento globale, che secondo accordi a livello internazionale (Kyoto, Parigi) si vuole contenere in 2 °C e preferibilmente in 1,5 °C, attraverso una serie di azioni che dovrebbero coinvolgere tutte le nazioni del pianeta.
Come sopra detto, l’anidride carbonica è il gas serra di gran lunga più presente in atmosfera, ma ridurre anche il metano, che ha un potere climalterante
superiore e permane nell'atmosfera solo 10-12 anni, darebbe benefici rapidi. Molti esperti concordano che ridurre il metano nelle prossime decadi, mentre si lavora sulla CO₂, potrebbe essere la strategia più efficace per limitare il riscaldamento globale entro il 2050. Ciò chiarito, ci concentreremo principalmente sulla CO2 e le cui emissioni globali sono (anno 2023) circa 37,5 miliardi di tonnellate (Gt). Le 5 nazioni che ne hanno rilasciata di più sono state Cina (oltre 12 Gt, circa 33% del totale), USA (5,3 Gt, circa 14%), I ndia (3,5 Gt, circa 9%), Russia (1,8 Gt, circa 5%).
Cina più USA più India rappresentano circa il 56% delle emissioni globali, l’Unione Europea circa il 7,5% e l’Italia lo 0,9%.
Quindi se l’Unione Europea azzerasse le proprie emissioni di CO 2, il mondo continuerebbe ad emetterne ben più del 90%.
Oltre all’emissione, dobbiamo prendere in considerazione anche l’assorbimento della CO₂, infatti circa il 55-65% (dati 2023) di queste emissioni è stato assorbito da processi naturali e, molto meno, artificiali, mentre il resto si è accumulato in atmosfera, contribuendo all'aumento della concentrazione di CO₂: a circa 420 ppm nel 2023, rispetto a circa 280 ppm prima dell'era industriale, diciamo intor-
loss spectroscopy (EELS) to clarify redox processes at the various material interfaces. According to project leaders, this approach offers numerous advantages: high flexibility, decentralized application, and the possibility to use all biogas, completely eliminating CO₂ emissions from the process.
All of this contributes to meeting the enormous demand for sustainable basic chemicals, both for the chemical industry and, in the long term, for the transport sector. The PKat4Chem project also involves EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Arcanum Energy Systems GmbH & Co KG, HTWK Leipzig, TU Bergakademie Freiberg, Leipzig University, Ruhr University Bochum, and Fraunhofer IMWS. It is funded by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK). u
no al 1750. Rispetto al 2022 la Concentrazione atmosferica di CO₂ è aumentata di altre circa 2,5 ppm.
L’assorbimento naturale vale circa 20-25 Gt CO₂/anno ed è la frazione preponderante. L’assorbimento è attuato da:
- vegetazione e suoli (circa 11-12 Gt CO₂/anno): grazie alla fotosintesi, foreste, praterie e piante assorbono CO₂, ma la deforestazione riduce questa capacità;
- oceani (circa 9-10 Gt CO₂/anno): dissolvono CO₂ formando acido carbonico (H₂CO₃), contribuendo all'acidificazione degli oceani;
- reazioni chimiche con le rocce (~0,1 Gt CO₂/anno): processi lenti come l'alterazione dei silicati.
L’assorbimento artificiale, invece, è ancora minimo, valendo solo meno di 0,01 Gt CO₂/anno.
Esistono diverse tecnologie e approcci per ridurre la CO₂ accumulata nell'atmosfera, suddivisi in cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio (CCUS - Carbon Capture, Utilization, and Storage).
Cattura e stoccaggio del carbonio (CCSCarbon Capture and Storage) Cattura diretta dall'aria (DAC - Direct Air Capture): tecnologie che filtrano la CO₂ direttamente dall'aria (es. impianti di Climeworks o Carbon Engineering).
Cattura post-combustione: rimozione della CO₂ dai fumi industriali o energetici prima che venga rilasciata in atmosfera.
B ioenergia con CCS (BECCS): combustione di biomassa (che ha assorbito la CO₂ durante la crescita, cioè ora e non milioni di anni fa) con successiva cattura e stoccaggio del carbonio.
Stoccaggio geologico della CO₂
Iniezione in formazioni rocciose sotterranee (es. giacimenti esauriti di petrolio/gas o acquiferi salini).
Mineralizzazione: conversione della CO₂ in minerali solidi (es. basalto) tramite reazioni chimiche naturali.
Utilizzo della CO₂ (CCU - Carbon Capture and Utilization)
Produzione di combustibili sintetici: CO₂ + idrogeno verde → carburanti (efuel).
M ateriali da costruzione: CO₂ utilizzata per produrre calcestruzzo carbonato (es. tecnologia di CarbonCure).
Prodotti chimici e plastiche: conversione in metanolo, polimeri o altri composti utili.
L’obiettivo è quello di ridurre le emissioni e di aumentare l’assorbimento di CO2 e l’Europa con la transizione green ha dichiarato di voler diventare “carbon neutral” entro il 2050.
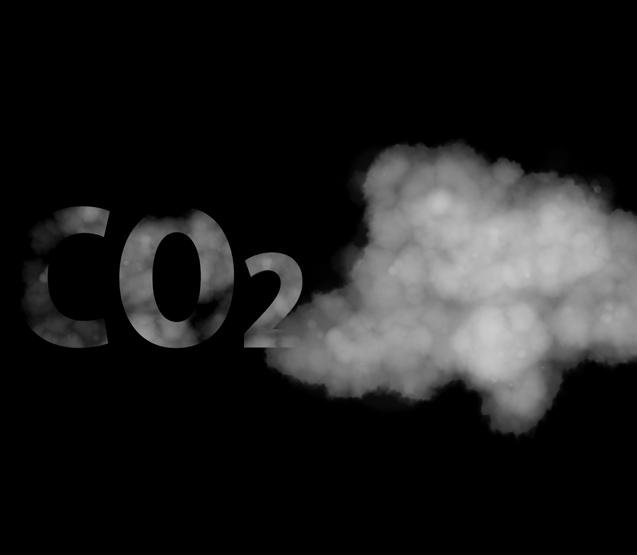
UN NUOVO INTERESSANTE
PROCESSO DI CCU
La parte che segue vuole illustrare un progetto di ricerca in corso presso il Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems IMWS, che ha l’obiettivo di utilizzare la CO2 per produrre prodotti chimici di base (CCU).
Il progetto utilizza una tecnologia “Powerto-X”, vale a dire l’impiego di elettricità proveniente da energie rinnovabili, che è un approccio molto efficace per la produzione sostenibile di sostanze chimiche organiche di base come etilene, metanolo o stirene. L'idrogeno necessario per i composti chimici può anch’esso essere prodotto senza emissioni utilizzando l'elettrolisi. Il progetto denominato “PKat4Chem” si concentra sulla conversione e quindi sull'utilizzo della CO2 per la produzione di materiali chimici di base. Il consorzio si sta concentrando sulla catalisi al plasma a bassa temperatura (catalisi LTP = Low Temperature Plasma catalysis). Con questa tecnologia, i materiali di partenza, che sono i gas prodotti dalla biomassa come il metano (CH4) in combinazione con la CO2 devono essere attivati in modo altamente efficiente utilizzando il plasma e infine convertiti, utilizzando appropriati catalizzatori in un processo a fase singola, in materiali chimici di base come il metanolo (CH3OH) o l'etilene (C2H4).
Il progetto si concentra sui reattori di catalisi LTP perché possono raggiungere efficienze molto elevate, fino al 95%. Offrono inoltre il vantaggio di una semplice scalabilità e di minori costi di investimento e operativi. Ciò consente un potenziale proces-
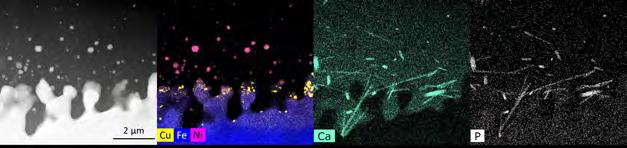
Mappe di distribuzione degli elementi all’interfaccia di un elettrodo rivestito / Elemental distribution maps at the interface of a coated electrode. © Fraunhofer IMWS.
so chiavi in mano che può essere attivato e disattivato in modo flessibile e in linea con la domanda.
L'obiettivo del progetto, che durerà fino alla fine del 2027, è quello di sviluppare un nuovo tipo di processo a catena. Lo scopo è quello di sviluppare un'unità modulare costituita da un reattore di catalisi LTP per la sintesi di metanolo o etilene. Ciò deve essere validato con prove in campo su un impianto pilota associato a un impianto di biogas esistente.
Nel progetto, il Fraunhofer IMWS è responsabile della caratterizzazione microstrutturale del materiale dell'elettrodo (brevettato) e dei relativi catalizzatori. La microstruttura dei materiali viene analizzata utilizzando la microscopia elettronica a scansione (SEM) e la microscopia elettronica a trasmissione (TEM), e le distribuzioni degli elementi vengono esaminate utilizzando la spettroscopia a raggi X a dispersione di energia (EDXS).
Inoltre, lo studio dei cambiamenti del materiale vicino alla superficie dovuti all'effetto della catalisi LTP, viene condotto utilizzando la spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS) e la spettrometria di massa di ioni secondari time-of-flight (ToF-SIMS).
Al fine di comprendere i processi sull'elettrodo, vengono anche studiate le proprietà fondamentali utilizzando l'analisi termica e la spettroscopia di perdita di energia elettronica (EELS) per chiarire i processi redox alle varie interfacce dei materiali coinvolti.
Secondo i responsabili del progetto questo tipo di approccio offre numerosi vantaggi, dall'elevata flessibilità, all'applicazione decentralizzata fino alla possibilità di utilizzare tutto il biogas, eliminando completamente le emissioni di CO2 legate al processo.
Tutto questo va nella direzione di contribuire a soddisfare l'enorme domanda di prodotti chimici di base sostenibili, sia per l'industria chimica che, a lungo termine, per il settore dei trasporti.
Nel progetto PKat4Chem sono anche coinvolti EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Arcanum Energy Systems GmbH & Co KG, HTWK Leipzig, TU Bergakademie Freiberg, Leipzig University, Ruhr University Bochum e Fraunhofer IMWS.
Il progetto è finanziato nell'ambito del programma di ricerca energetica del Ministero Federale dell'Economia e della Protezione del Clima (BMWK). u
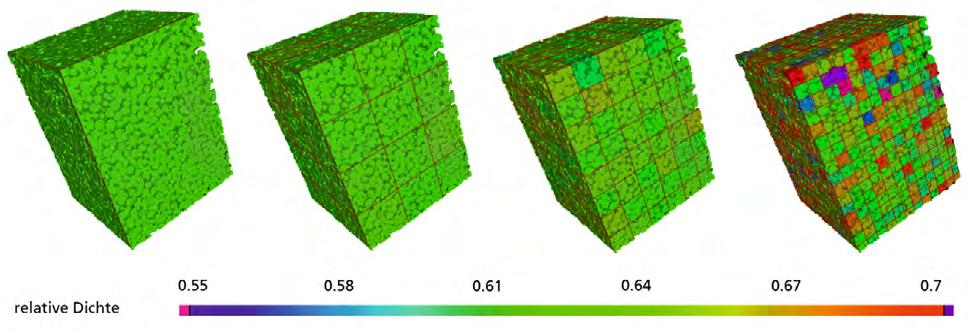
Valutazione tridimensionale del comportamento di sinterizzazione di un rivestimento per elettrodi mediante tomografia a raggi X / Three-dimensional evaluation of the sintering behavior of a coating for electrodes using X-ray tomography. © Fraunhofer IMWS.










di A.L. Spelta
Con oltre 2,5 miliardi di pneumatici prodotti ogni anno e circa 1,6 miliardi arrivati a fine vita solo nel 2023, la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) è una sfida ambientale ed economica centrale per il settore gomma. La pirolisi si afferma oggi come tecnologia innovativa e strategica: decomponendo gli pneumatici in olio, gas e nero di carbonio riciclato, consente di recuperare materiali preziosi e ridurre l’impatto ambientale.
Gli pneumatici sono i manufatti in gomma vulcanizzata di gran lunga più prodotti nel mondo (oltre 2,5 miliardi di unità all'anno) ed impiegano circa il 65% della gomma vulcanizzata (naturale e sintetica) prodotta. Nel 2023 si stima che circa 1,6 miliardi di pneumatici abbiano raggiunto la fine della propria vita utile, diventando
PFU (Pneumatici a Fine Uso), equivalenti a circa 25-27 milioni di tonnellate. Per avere un’idea del contributo europeo (+UK) nello stesso anno possiamo pensare a circa 320-340 milioni di PFU (3,7-3,9 milioni di tonnellate), mentre quello italiano ammonta a circa 35-38 milioni (0,38-0,40 milioni di tonnellate). L a stima del diverso peso medio del PFU mondiale e italiano/europeo deriva dalla diversa percentuale di penu-
matici vettura, truck&bus, moto, agricoltura, industriali, nelle diverse aree geografiche.
COSA FARE DEI PFU
P reso atto che la UE con Direttiva 1999/31/CE (sulle discariche) ha vietato lo smaltimento in discarica di pneumatici interi e successivamente (2003 e 2006) anche di quelli triturati, per affrontare al meglio la gestione di que -

sta grande quantità di manufatti arrivati a fine uso, dobbiamo partire dalla gerarchia dei rifiuti (L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, 2015) dove viene stabilito il seguente ordine di priorità:
Prevenzione
L’aumento della durabilità dei manufatti, nel caso specifico dello pneumatico, a pari altre prestazioni, ha un impatto positivo sull’ambiente.
Preparazione per il riutilizzo
N on si hanno molti esempi di manufatti in gomma che possono essere riutilizzati. Quello più importante è proprio quello degli pneumatici ricostruiti. I vantaggi ambientali sono molto elevati.
R iciclaggio
I l riciclo dei manufatti in gomma è sostanzialmente concentrato sui PFU e valuteremo in questa nota la parte relativa alla pirolisi, che è una tecnica in grande sviluppo per le potenzialità nel recupero valore da manufatti e residui di manufatti non altrimenti valorizzabili.
Recupero di energia
Bruciare rifiuti con alto potere calorifico è preferibile che buttarli in discarica. Non si consuma terreno, si riduce l’impatto ambientale e si recupera energia, bene sempre prezioso, il tutto deve essere fatto nel rispetto delle normative vigenti in ambito di imbatto ambientale.
Smaltimento
A lla fine di questa catena inevitabilmente rimarrà qualcosa da cui non si potrà più estrarre valore. Quello che sarà importante è che la quantità destinata alla discarica sia una frazione sempre più piccola del rifiuto di partenza e che sia stata opportunamente inertizzata.
IL RECUPERO DI MATERIA DAI PFU
U n PFU è grosso modo costituito da mescole vulcanizzate (85%) intimamente accoppiate alle strutture di rinforzo della carcassa (15%).
Le mescole (85%) sono costituite da:
by A.L. Spelta
With over 2.5 billion tires produced each year and about 1.6 billion reaching end-of-life in 2023 alone, the management of end-of-life tires (ELTs) is a central environmental and economic challenge for the rubber sector. Pyrolysis is now emerging as an innovative and strategic technology: by decomposing tires into oil, gas, and recycled carbon black, it enables the recovery of valuable materials and reduces environmental impact.
Tires are by far the most widely produced vulcanized rub ber products in the world (over 2.5 billion units per year) and consume about 65% of all vulcanized rubber (natural and synthetic) produced.
I n 2023, it is estimated that about 1.6 billion tires reached the end of their useful life, becoming ELTs, equivalent to about 25–27 million tons.
To get an idea of the European (+UK) contribution in the same year, we can consider about 320–340 million ELTs (3.7–3.9 million tons), while the Italian contribution amounts to about 35–38 million (0.38–0.40 million tons).
T he difference in the estimated average weight of ELTs worldwide versus Italian/European ELTs derives from the different percentages of passenger car, truck & bus, motorcycle, agricultural, and industrial tires in various geographical areas.
G iven that the EU, with Directive 1999/31/EC (on landfills), has banned the disposal of whole tires in landfills and later (2003 and 2006) also of shredded ones, in order to best address the management of this large
volume of end-of-life products, we must start from the waste hierarchy (Closing the loop – EU Action Plan for the Circular Economy, 2015), where the following order of priority is established:
Prevention
I ncreasing product durability, in the specific case of tires, with equivalent performance, has a positive environmental impact.
T here are not many examples of rubber products that can be reused. The most important one is retreaded tires. The environmental benefits are very high.
R ecycling
R ecycling of rubber products is essentially focused on ELTs, and in this paper we will assess pyrolysis, a technique that is rapidly developing for its potential in recovering value from products and residues otherwise not recoverable.
E nergy recovery
B urning high-calorific waste is preferable to landfilling. It saves land, re -

40% gomma (naturale e sintetica), 30% fillers (nero di carbonio, silice, cariche inerti), 6% plastificanti (oli e resine), 6% agenti vulcanizzanti (zolfo, zinco ossido, acceleranti), 2% protettivi e altri chemicals.
Le strutture di rinforzo della carcassa (15%) sono costituite da acciaio e/o fibre (poliestere, rayon, nylon).
La separazione delle strutture di rinforzo (acciaio/fibre) dalle mescole vulcanizzate
I PFU raccolti prima del trattamento sono controllati per la rimozione di corpi estranei. Quindi sottoposti a triturazione primaria (ad esempio con trituratore a martelli) e ridotti in chip di 50-300 mm. La separazione dell’acciaio avviene grazie a un estrattore magnetico. L’acciaio pulito viene venduto alle fonderie. Dopo la prima avviene una seconda triturazione (tipicamente con mulini a lame) e questa granulazione consente di ottenere granuli di 10-50 mm, una separazione magnetica secondaria permette di recuperare i residui di acciaio. La separazione delle fibre tessili avviene invece meccanicamente attraverso vibrovaglio/setacciatura. Correnti d’aria in aspirazione permettono di estrarre le fibre leggere (nylon/poliestere) per differenza di densità. Le fibre tessili sono utilizzate in isolamento o materiali compositi.
I granuli/polverino delle mescole vulcanizzate vengono usati come filler “elastico” in una matrice di gomma o plastica per ottenere prodotti quali ruote per carrelli vari, pattumiere, carriole, tosaerba, arredo urbano, segnaletica stradale, pavimentazioni per parchi giochi, piste di atletica, tappetini ammortizzanti per scuole e stalle, blocchi o piastrelle per pavimentazione e materiali per coperture (vedi https:// www.etrma.org/key-topics/circulareconomy/). La quantità di questo filler dipende dalle prestazioni richieste dal manufatto finale, più le richieste sono alte minore è la quantità di granuli/polverino utilizzabile.
M odi per incrementare la quantità di questo filler in applicazioni più sofisticate e di maggior volume
L'applicazione più importante è ovviamente lo pneumatico e i modi s ono la de-vulcanizzazione e l’impiego di compatibilizzanti/attivanti, che esulano dallo scopo di questo articolo e sono già stati trattati nei fascicoli Green Rubber 2023 (https://issuu.com/edifis/docs/greenrubber_sfoglio) e 2024 (https://issuu.com/edifis/docs/green_ rubber_sfoglio_0b6f830e8507b1).
Un’altra applicazione è nelle strade. Il legante bituminoso, meglio se modificato polimero, ingloba oltre al solo pietrisco, anche i granuli di mescola
duces environmental impact, and recovers energy—always a valuable resource.
However, everything must be carried out in compliance with existing environmental impact regulations.
D isposal
A t the end of this chain, inevitably something will remain from which no value can be extracted. What will be important is that the fraction destined for landfill is as small as possible compared to the original waste and that it has been properly inertized.
M ATERIAL RECOVERY FROM ELTs
A n ELT consists roughly of vulcanized compounds (85%) intimately bonded to the reinforcement structures of the carcass (15%).
T he compounds (85%) consist of: 40% rubber (natural and synthetic), 30% fillers (carbon black, silica, inert fillers), 6% plasticizers (oils and resins), 6% vulcanizing agents (sulfur, zinc oxide, accelerators), 2% protectants and other chemicals.
T he reinforcement structures of the carcass (15%) are made of steel and/or fibers (polyester, rayon, nylon).
Emmett L. “Doc” Brown (Chris Lloyd) Ritorno al Futuro, 1985

Realizziamo MACCHINE NUOVE per la mescolazione della gomma, conformi ai più recenti standard tecnologici e di sicurezza.
Attraverso il nostro know-how e le nostre procedure innovative siamo in grado di proiettare nel futuro ogni VECCHIO MACCHINARIO
Disponiamo di uno STOCK di macchine usate pronte per una nuova vita.
Tutte le nostre attività sono contraddistinte da un SERVICE efficiente e di qualità.
vulcanizzata da PFU. In questo modo si sfrutta l'elasticità e le caratteristiche fonoassorbenti della gomma, aumentando la durata della superficie stradale, riducendo l'inquinamento acustico e migliorando la sicurezza in condizioni di bagnato. Nonostante l’utilizzo attuale sia limitato a poche centinaia di chilometri di strade, si ritiene che la nuova direttiva CAM (Criteri Ambientali Minimi, vedi L’Industria della Gomma n. 727 (https:// issuu.com/edifis/docs/l_industria_ della_gomma_4_2025) per le strade possa dare da subito un impulso all’utilizzo di questo materiale.
Q ueste applicazioni, più il riciclo dei PFU in applicazioni di ingegneria civile, non sembrano in grado di assorbire tutti i PFU che vengono prodotti annualmente.
Gli pneumatici interi sono utilizzati in progetti come la protezione costiera, barriere antierosione, barriere artificiali, frangiflutti, ripari antivalanga, stabilizzazione di pendii, rilevati stradali, costruzione di discariche, barriere antirumore e isolamento.
I granuli/polverino sono utilizzati come fondamenta per strade e ferrovie, materiale di drenaggio, costruzione di discariche, riempimento di sottofondi e argini, riempimento di muri e ponti e isolamento di sottofondi stradali. U na tecnologia complementare che sta generando sempre più interesse è la pirolisi perché scompone i PFU in gas, olio e nero di carbonio di recupero (rCB, recycled Carbon Black).
L’ETRMA (European Tyre and Rubber Manufacturers Association) stessa promuove il riconoscimento della pirolisi come processo di riciclo degli pneumatici e meritevole di investimenti, essendo considerata una tecnologia innovativa.
La pirolisi è un processo di decomposizione termica (a 300-800 °C) in un ambiente anaerobico (senza ossigeno), che evita la combustione e permette di convertire la gomma in frazioni più leggere (gas, liquidi) e solidi.
Dalla pirolisi si ottengono in media: - 35-50% o lio di pirolisi (TPO: Tyre Pyrolytic Oil), liquido denso simile al petrolio grezzo, ricco di idrocarburi. Può essere raffinato in carburante
S eparation of reinforcement structures (steel/fibers) from vulcanized compounds
C ollected ELTs are inspected for foreign bodies. They are then subjected to primary shredding (e.g., with a hammer shredder) and reduced into 50–300 mm chips. Steel separation takes place thanks to a magnetic extractor. Cleaned steel is sold to foundries. After the first step, a second shredding follows (typically with blade mills), producing granules of 10–50 mm. Secondary magnetic separation recovers residual steel. Textile fiber separation is done mechanically through vibrating screens/sieves. Air suction currents allow the extraction of light fibers (nylon/polyester) by density difference. Textile fibers are used in insulation or composite materials. Granules/powders of vulcanized compounds are used as “elastic” filler in a rubber or plastic matrix to produce products such as wheels for caddies, dustbins, wheelbarrows, lawnmowers, urban furniture, signposts, playground flooring, athletic tracks, shock-absorbing mats for schools and stables, paving blocks or tiles, and roofing materials (see https://www.etrma.org/ key-topics/circular-economy/). The amount of filler depends on the performance required of the final product: the higher the requirements, the lower the amount of granules/powder that can be used.
Ways to increase the use of this filler in more advanced and larger-volume applications
The prime example is tires themselves, via devulcanization and the use of compatibilizers/activators. These topics are beyond the scope of this article and have already been discussed in Green Rubber 2023 (https://issuu. com/edifis/docs/greenrubber_sfoglio) and 2024 (https://issuu.com/edifis/docs/green_rubber_sfoglio_0b6f830e8507b1).
A nother application is in road construction. The bituminous binder, preferably polymer-modified, incorporates not only aggregates but also
ELT-derived vulcanized granules. This exploits the elasticity and sound-absorbing properties of rubber, extending road surface life, reducing noise pollution, and improving safety in wet conditions. Despite current use being limited to a few hundred kilometers of roads, it is believed that the new CAM directive (Minimum Environmental Criteria, see L’Industria della Gomma n. 727 https://issuu.com/edifis/docs/l_ industria_della_gomma_4_2025) could immediately boost the use of this material.
T hese applications, along with ELT recycling in civil engineering applications, do not seem capable of absorbing all ELTs generated annually.
W hole tires are used in projects such as coastal protection, erosion barriers, a rtificial reefs, breakwaters, avalanche shelters, slope stabilization, road embankments, landfill construction, sound barriers, and insulation.
Granules/powders are used as road and railway foundations, drainage material, landfill construction, subgrade and embankment fill, wall and bridge backfill, and roadbed insulation.
A complementary technology that is generating growing interest is pyrolysis, as it breaks down ELTs into gas, oil, and recovered carbon black (rCB).
T he ETRMA (European Tyre and Rubber Manufacturers Association) itself promotes the recognition of pyrolysis as a tire recycling process worthy of investment, considering it an innovative technology.
P yrolysis is a thermal decomposition process (at 300–800 °C) in an anaerobic environment (i.e. without oxygen), which avoids combustion and converts rubber into lighter fractions (gases, liquids) and solids.
From pyrolysis one obtains, on average:
- 35–50% p yrolytic oil (TPO: Tyre Pyrolytic Oil), a dense liquid similar to crude oil, rich in hydrocarbons. It can be refined into fuel (diesel, gasoline, SAF = Sustainable Aviation Fuel) or used as a feedstock for crackers or the chemical industry in general;
- 10–20% pyrolytic gas (syngas), a mix-
ture of light hydrocarbons, hydrogen (H₂), methane (CH₄), carbon monoxide (CO). Used as a fuel to power the plant itself or to produce electricity;
- 30–40% carbon black (char), a carbonaceous powder usable as rCB for new tires, asphalt filler or composites, or as solid fuel (if sufficiently pure);
- 5–10% l osses/ashes;
- 10–15% s teel, which may have been removed beforehand or recovered afterward, depending on whether the process uses whole or shredded ELTs.
T hese figures vary depending on plant efficiency and pyrolysis temperature.
E ssentially, three (or four if syngas is not self-consumed) products of commercial interest are obtained.
I n particular, there is strong attention from tire manufacturers regarding rCB. See Green Rubber 2024 for Bridgestone and Michelin’s interest in rCB qualification (https://issuu. com/edifis/docs/green_rubber_sfoglio_0b6f830e8507b1) and Continental’s multi-year purchase of Pyrum A.G.’s entire production (https://www. pyrum.net/en/corporate-news/pyruminnovations-ag-concludes-framework-
agreement-with-continental-for-longterm-acceptance-of-its-recovered-carbon-black/).
S imilarly, TPO is of interest as it represents a more sustainable alternative to petroleum and naphtha used in petrochemical crackers.
I n the rubber sector, interest has also been noted in using TPO (in this case produced by Contec, https://contec. tech/) by a carbon black producer (Orion: https://investor.orioncarbons.com/ financial-press-releases/press-releases-details/2025/Orion-S.A.-signs-supply-agreement-for-tire-pyrolysis-oilwith-Contec-S.A/default.aspx).
I t is also clear that even if all ELTs collected annually in Italy were pyrolyzed, the resulting TPO (about 0.15 MT) would be a drop compared to Italian petroleum demand (>50 MT) or naphtha (4.5–5 MT, 2023 data). A drop, but one in the right direction.
E nergy
First, let us assess whether the pyrolysis process is energy sustainable. We will
give general indications because the energy balance of a modern ELT pyrolysis plant depends on process efficiency, the technology used, and the final destination of the products obtained. As an example, let us consider a process that separates steel and fibers before feeding shredded ELTs into the pyrolysis reactor, with reference data from 2023-2024, per ton of ELTs.
To heat the pyrolysis reactor, we can estimate a demand of 500-800 kWh/ ton, depending on temperature (300800 °C) and heating method (gas, electric, microwave), plus 50-100 kWh/ton for pretreatment (ELT shredding), 100200 kWh/ton for product separation/ refining (oil, carbon black, gas), and another 50-100 kWh/ton for “other” uses (ventilation, controls, etc.).
Total energy demand: 700-1,200 kWh/ ton.
E nergy yield:
- 4,000-5,500 kWh/ton from oil (40-55% by weight), calorific value about 35-40 MJ/kg (9.7-11.1 kWh/kg)
- 1,000-1,800 k Wh/ton from gas (1015% by weight), calorific value about 15–20 MJ/Nm³ (4.2-5.6 kWh/Nm³)


Linea di pneumatici a fine vita pronta per la valorizzazione (Fonte: Enviro) / End-of-life tire line ready for valorization (Source: Enviro).
(diesel, benzina, SAF= Substainable Aviation Fuel) o usato come materia prima per i cracker o per l’industria chimica in generale;
- 10-20% gas pirolitico (syngas), che è costituito da una miscela di idrocarburi leggeri, idrogeno (H₂), metano (CH₄), monossido di carbonio (CO). Usato come combustibile per autoalimentare l'impianto o per produrre energia elettrica;
- 30-40% nero di carbonio (Chair), polvere carboniosa utilizzabile come rCB per nuovi pneumatici, filler per asfalti o materiali compositi, combustibile solido (se sufficientemente puro);
- 5-10% perdite/ceneri;
- 10-15% a cciaio, che potrebbe essere stato rimosso prima, vedi sopra, o recuperato dopo in funzione di come è alimentato il processo, se PFU intero o granulato.
Questi dati variano in base all'efficienza dell'impianto e alla temperatura di pirolisi.
I n sostanza si ottengono 3 (o 4 se non si autoconsuma il syngas) prodotti che hanno interesse o grande interesse di mercato.
I n particolare c’è molta attenzione da parte dei produttori di pneumatici per il rCB, vedi Green Rubber 2024 per l’interesse di Bridgestone e Michelin per la qualifica produttiva e qualitativa del rCB (https://issuu.com/edifis/docs/green_rubber_ sfoglio_0b6f830e8507b1) e l’interesse
di Continental per acquisto pluriennale di tutta la produzione di Pyrum A.G. (https://www.pyrum.net/en/corporate-news/pyrum-innovations-ag-concludes-framework-agreement-withcontinental-for-long-term-acceptance-of-its-recovered-carbon-black/).
Analogamente anche il TPO è di interesse perché rappresenta una alternativa più sostenibile sia del petrolio, che della nafta, utilizzata per i cracker petrolchimici. Sempre nel mondo della gomma è da segnalare l’interesse a utilizzare il TPO (in questo caso di produzione Contec, https://contec. tech/) da parte di un produttore di Nero di Carbonio (in questo caso Orion: https://investor.orioncarbons.com/financial-press-releases/press-releasesdetails/2025/Orion-S.A.-signs-supplyagreement-for-tire-pyrolysis-oil-withContec-S.A/default.aspx).
È altresì chiaro che se anche si pirolizzasero tutti i PFU raccolti ogni anno in Italia, il TPO che si otterrebbe (circa 0,15 ML T) sarebbe una goccia nel fabbisogno italiano di petrolio (>50 ML T) o di nafta (4,5-5 ML, dati 2023). Una goccia che comunque andrebbe nella giusta direzione.
Energetica
Per prima cosa vediamo se il processo di pirolisi è sostenibile da un punto di vista energetico.
- 2,000-3,000 kWh/ton from carbon black (30-35% by weight), calorific value about 25-30 MJ/kg (7-8.3 kWh/kg). Total energy output (if all c onverted to energy): 7,000-9,000 kWh/ton of ELTs. Net energy efficiency: 80-90%, so the process is energy sustainable. O bviously, it makes little sense to burn everything produced by the process, since oil and rCB can have greater value when used to produce other materials.
A pyrolysis plant is not zero-impact, but if well managed it is less polluting than other disposal methods. It is considered less polluting than incineration (lower CO₂, NOx, dioxin emissions) and landfill (no longer permitted in Europe), which releases microplastics and leachate.
T he least polluting pyrolysis processes are those with high efficiency, true oxygen-free conditions, advanced abatement systems (bag filters, scrubbers, catalysts), and where products (carbon black, oil) are properly treated/reused.
G enerally, pollution risk increases with outdated technologies or poor monitoring/controls.
Economic
A pyrolysis plant is considered economically sustainable, even if the return on investment is expected in 5–10 years. As always, it is advisable that the plants are not too small (>10,000 tonnes/year), that public subsidies can be obtained, given the contribution of this technology to sustainability, that industrial partnerships are established (e.g. with tyre manufacturers for carbon black) and/or that the end products (pyrolysis oil) are sold in premium markets (e.g. green chemistry rather than as fuels).
R eactor
T he heart of a pyrolysis plant is the reactor, which may be a Rota -







I silos di un impianto di Pyrum / The silos of a Pyrum plant.
D aremo delle indicazioni di massima perché Il bilancio energetico di un moderno impianto di pirolisi degli pneumatici fuori uso (PFU) dipende dall'efficienza del processo, dalla tecnologia utilizzata e dalla destinazione finale dei prodotti ottenuti.
A titolo di esempio prendiamo come riferimento un processo che preveda la separazione di acciaio e fibre prima dell’immissione del PFU frantumato nel reattore di pirolisi e terremo come riferimento le informazioni disponibili al 2023-2024 e la tonnellata di PFU. Per riscaldare il reattore di pirolisi, possiamo stimare un fabbisogno di 500–800 kWh/ ton, in funzione della temperatura (300800 °C) e del tipo di riscaldamento (gas, elettrico, microonde), cui aggiungere 50-100 kWh/ton per il pretrattamento (triturazione dei PFU), 100-200 kWh/ton per la separazione/raffinazione prodotti ottenuti (olio, nero di carbonio, gas) e altri 50-100 kWh/ton per “altri” consumi (ventilazione, controlli, ecc.). Complessivamente il fabbisogno energetico ammonta a 700-1.200 kWh/ton.
La resa in termini energetici è: - 4.000-5.500 k Wh/ton per l’olio (40–55% in peso) con potere calorifico: circa 35-40 MJ/kg (9.7-11.1 kWh/kg)
- 1.000-1.800 k Wh/ton per il gas (1015% in peso) con potere calorifico: circa 15-20 MJ/Nm³ (4.2-5.6 kWh/Nm³)
- 2.000-3.000 kWh/ton per il nero di carbonio (30-35% in peso) con potere calorifico: circa 25-30 MJ/kg (7-8.3 kWh/kg). Totale output energetico (se tutto convertito in energia): 7.000-9.000 kWh/ ton di PFU, l’efficienza energetica netta è pertanto tra 80-90%, quindi il processo è energeticamente sostenibile. Ovviamente non ha senso bruciare tutto quello che si ottiene dal processo, in quanto i prodotti (olio e rCB) possono avere maggior valore quando impiegati per produrre altri materiali.
Ambientale
Un impianto di pirolisi non è a zero impatto, ma se ben gestito è meno inquinante di altre forme di smaltimento. Si ritiene che sia meno inquinante dell’incenerimento, emettendo meno CO₂, NOx e diossine, e della discarica, che tra l’altro in Europa non è più consentita, in quanto evita il rilascio di “microplastiche” e percolato.
I processi di Pirolisi meno inquinanti sono quelli ad alta efficienza e che lavorano in vera assenza di ossigeno; quelli che prevedono la presenza di sistemi di
ry Kiln (a horizontal heat-resistant steel cylinder, up to 700°C, rotating slowly at 2–10 RPM), a Fluidized Bed chamber, or a Batch reactor (vertical refractory steel tank, fed discontinuously).
Key reactor components: pyrolysis chamber, thermally insulated zone where thermal decomposition occurs; heating system, electric or gas (with burners fueled by syngas produced); sealing system, airtight joints to prevent oxygen ingress; screw conveyor for feeding material into continuous reactors; heat exchangers, to cool vapors and recover oil.
A complete ELT pyrolysis plant is not particularly complex but includes several integrated units to ensure efficiency, safety, and product quality.
Feeding system
S crew or conveyor belt to introduce material into the reactor in a controlled way, preventing oxygen ingress.
H eating system
G as or electric furnaces to provide initial heat (300-800°C). If heating is by gas, syngas produced by pyrolysis itself fuels the heating (self-sustaining). Heat exchangers for recovering heat from exhaust gases, which can be used to preheat the feedstock.
Condensation and oil collection
s ystem
Multi-stage condensers (first stage, rapid cooling at 150-200 °C for heavy oils; second stage, tower cooling at 50-80 °C for light oils). Storage tanks for TPO for refining or sale.
G as cleaning system
B ag filters/cyclones (to remove dust/particles); water or solvent washing (to remove sulfur, chlorine, other contaminants); adsorption tower (activated carbon) for further gas purification.
abbattimento avanzati (filtri a maniche, scrubber, catalizzatori); dove i prodotti (nero di carbonio, olio) vengono trattati e/o riutilizzati correttamente. In generale il rischio di inquinamento aumenta con tecnologie obsolete o controlli/ monitoraggi insufficienti.
Economica
Si ritiene che un impianto di pirolisi sia economicamente sostenibile anche se il ritorno sull’investimento è atteso in 5-10 anni. Come sempre è opportuno che gli impianti non siano troppo piccoli (>10.000 ton/anno), che si possano ottenere sovvenzioni pubbliche, visto il contributo alla sostenibilità di questa tecnologia, si mettano in campo partnership industriali (es. con i produttori di pneumatici per il nero di carbonio) e/o i prodotti finali (olio di pirolisi) siano venduti in mercati premium (es. chimica verde invece che come combustibili).
Reattore
Il cuore dell’impianto di pirolisi è il reattore, che può essere a Tamburo Rotante, che consiste in cilindro orizzontale in acciaio resistente al calore (fino a 700°C), ruota lentamente (2-10 RPM), a Letto Fluido, costituito da una camera verticale o reattore Batch, ovvero serbatoio verticale in acciaio refrattario, alimentato in modo discontinuo.
I componenti chiave del Reattore sono: camera di pirolisi, zona isolata termicamente dove avviene la decomposizione termica; il sistema di riscaldamento, che può essere elettrico o a gas (con bruciatori alimentati dal syngas prodotto); il sistema di tenuta, giunti stagni per evitare ingressi di ossigeno; coclea di trasporto per alimentare il materiale nei reattori continui; scambiatori di calore, per raffreddare i vapori e nel recupero dell’olio.
U n impianto completo di pirolisi di PFU, pur non essendo particolarmente complesso, non è costituito solo dal reattore, ma comprende diverse apparecchiature integrate per garantire efficienza, sicurezza e qualità dei prodotti.
Sistema di alimentazione
Coclea o nastro trasportatore per introdurre il materiale nel reattore in modo controllato, evitando ingressi di ossigeno.
S istema di riscaldamento
Forni a gas o elettrici per fornire il calore iniziale (300-800°C). Se il riscaldamento è a gas syngas prodotto dalla pirolisi stessa alimenta il riscaldamento (autosostentamento).
S cambiatori di calore per il recupero di calore dai gas di scarico e che può essere impiegato per preriscaldare il materiale in ingresso.
S istema di condensazione e raccolta olio
Condensatori multi-stadio (primo stadio, raffreddamento rapido, per condensare gli oli pesanti a ca. 150-200 °C e secondo stadio, raffreddamento a torre, per la separazione degli oli leggeri a circa 50-80 °C); serbatoi di stoccaggio olio: per la raccolta del TPO per eventuale successiva raffinazione o vendita.
Trattamento del gas (Gas Cleaning System)
Filtri a maniche o cicloni (per rimuovere polveri e particolato dal syngas); Lavaggio con acqua o solventi (per eliminare zolfo, cloro e altri contaminanti; Torre di adsorbimento (a carboni attivi) per purificare ulteriormente il gas per riutilizzo energetico.
Trattamento del nero di carbonio (Char)
Eventuale raffinazione del char: macinazione: Polverizzazione del char per aumentare la superficie specifica; disoleazione: cioè rimozione di residui oleosi con solventi o trattamento termico. Separazione magnetica per eliminare eventuali tracce di metalli residui.
S istemi di controllo e riduzione delle emissioni
D epolveratori, Catalizzatori (SCR/SNCR): per ridurre NOx e CO. Monitoraggio continuo con Sensori per rilevare SO₂, CO, particolato.
A pparecchiature ausiliarie
Torre di raffreddamento: per il ricircolo dell’acqua di processo. Gruppo elettrogeno di Backup per l’alimentazione elettrica, sistemi automatici di controllo di temperature, portate e pressioni.
S toccaggio prodotti finali
S erbatoi riscaldato per l’olio, Silos per il rCB.
Q UALE TECNOLOGIA?
L a miglior tecnologia di pirolisi industriale per PFU attualmente disponibile è quella che combina alta efficienza, basso impatto ambientale e sostenibilità economica.
Di seguito riportiamo le principali tecnologie leader nel mercato.
P irolisi a letto fluido (Fluidized Bed Pyrolysis)
S i caratterizza per alta efficienza termica (minori consumi energetici), buon controllo della temperatura (400-700 °C), che riduce la formazione di IPA e diossine e che consente di ottenere un olio pirolitico di maggior purezza (meno zolfo e contam inanti).
Carbon black treatment (char)
O ptional refining-grinding (to increase specific surface area), deoiling (removing oily residues with solvents or heat treatment), magnetic separation (to eliminate residual metals).
E mission control systems
D ust collectors, catalysts (SCR/SNCR) to reduce NOx and CO. Continuous monitoring with sensors (SO₂, CO, particulates).
Auxiliary equipment
Cooling tower (for process water recycling), backup generator (electric supply), automatic control systems (temperature, flow, pressure).
Final product storage
H eated tanks for oil, silos for rCB.
Pirolisi a tamburo rotante (Rotary Kiln Pyrolysis)
Una tecnologia collaudata e robusta, adatta a grandi volumi e permette una buona separazione tra acciaio, carbonio e olio. Se non ben controllata si ha un maggiore rischio di emissioni.
Pirolisi catalitica (Catalytic Pyrolysis)
L’uso di catalizzatori migliora la qualità dell’olio (meno zolfo, più adatto a carburanti), permette di operare a temperature più basse, con risparmio di energia. Per contro occorre tenere in considerazione il costo dei catalizzatori e necessità di rigenerazione. È una tecnologia ancora in sviluppo.
Microonde (microwave)
Un’altra tecnologia in sviluppo è quella che fa ricorso a microonde. Applicazioni industriali sono al momento concentrate sulle plastiche, in particolare polistirene (PS), con depolimerizzazione praticamente completa, ma a livello universitario (es. Università di Birmingham) l’uso delle microonde ha fornito risultati incoraggianti anche su altri impianti di pirolisi, in termini di maggiore velocità di riscaldamento, minore consumo energetico e migliore controllo del processo, con minore formazione di sottoprodotti indesiderati.
In conclusione attualmente la pirolisi a letto fluido è considerata lo stato dell’arte per applicazioni industriali, per le basse emissioni (grazie al controllo preciso del processo), la qualità dell’olio (utilizzabile come carburante o materia prima chimica) e la sua scalabilità (adatta sia a piccoli che grandi impianti). Alternative come la pirolisi a microonde o catalitica sono promettenti ma meno mature industrialmente.
Per chi ritiene di non essere arrivato alla fine di questo percorso conoscitivo e vuole conoscere un po’ meglio alcune realtà industriali nel campo della pirolisi, segnaliamo i seguenti siti: http://en.niutech.com/ https://kleanindustries.com/ https://envirosystems.se/ https://infiniteria.com/ https://contec.tech/ https://www.pyrum.net/en/ https://www.eco-infinic.com/ https://www.bolderindustries.com/ https://www.repitaliasrl.com/ u
WHICH TECHNOLOGY?
T he best available industrial pyrolysis technology for ELTs today is the one that combines high efficiency, low environmental impact, and economic sustainability. Below are the main leading technologies on the market.
Fluidized Bed Pyrolysis
C haracterized by high thermal efficiency (lower energy consumption), good temperature control (400–700°C), which reduces PAH and dioxin formation, and produces higher-purity pyrolytic oil (less sulfur and contaminants).
R otary Kiln Pyrolysis
Proven, robust technology, suitable for large volumes, enabling good separation of steel, carbon, and oil. If poorly controlled, higher emission risks arise.
Catalytic Pyrolysis
T he use of catalysts improves oil quality (lower sulfur, more suitable for fuels), allows operation at lower temperatures (saving energy).
H owever, catalyst costs and regeneration must be considered. Still under development.
M icrowave Pyrolysis
Another developing technology, mainly applied to plastics (especially poly-
styrene) with nearly complete depolymerization.
A t a university level (e.g., University of Birmingham), microwaves have shown encouraging results in pyrolysis, with faster heating, lower energy consumption, and better process control, reducing unwanted byproducts.
I n conclusion, fluidized bed pyrolysis is currently considered state of the art for industrial applications, due to low emissions (thanks to precise process control), oil quality (usable as fuel or chemical feedstock), and scalability (suitable for both small and large plants).
A lternatives such as microwave or catalytic pyrolysis are promising but less mature industrially.
F or those who feel they have not yet reached the end of this journey of discovery and would like to learn more about some industrial realities in the field of pyrolysis, we suggest the following websites: h ttp://en.niutech.com/ h ttps://kleanindustries.com/ h ttps://envirosystems.se/ h ttps://infiniteria.com/ h ttps://contec.tech/ h ttps://www.pyrum.net/en/ h ttps://www.eco-infinic.com/ h ttps://www.bolderindustries.com/ h ttps://www.repitaliasrl.com/ u


di G. Brembati
Le particelle di usura degli pneumatici e delle strade hanno un forte impatto sull’ambiente: contribuiscono, infatti, all’inquinamento da microplastiche e questo comporta dei rischi per la salute umana.
Le particelle di usura degli pneumatici e delle strade (TRWP), generate durante la guida, contribuiscono alle emissioni atmosferiche non di scarico e costituiscono un elemento importante dell’inquinamento da microplastiche.
O ltre agli altri componenti della mescola (cariche, acceleranti etc.), l’usura degli pneumatici contiene circa il 50% di polimeri naturali e sintetici ed è probabilmente la fonte più importante di materiale a base di polimeri sintetici nell’ambiente. Si stima che ogni anno vengano generate, sulle strade d’Europa, circa 1,3 milioni di tonnellate di usura di pneumatico e questo dato spiega perché il tema “emissioni dovute all’usura di pneumatici” merita particolare attenzione.
L’usura degli pneumatici è generalmente definita microplastica (MP) per la sua struttura polimerica (semi)sintetica, lo stato solido, l’insolubilità e le dimensioni delle particelle, comprese nell’intervallo definito per le microplastiche (1-1.000 μm). Le proprietà e il comportamento ambientale delle particelle di elastomeri provenienti dagli pneumatici, che si formano direttamente alla fonte di emissione, ossia il traffico stradale, differiscono da quelle da plastiche, che mostrano una struttura parzialmente
cristallina e diverse composizione chimica, forma e superficie. Le particelle pure di usura degli pneumatici si trovano raramente nell’ambiente, poiché si mischiano con altre particelle legate alla strada, formando così particelle con composizione mista.
Oltre alle particelle grossolane di usura dello pneumatico e della strada (TRWP),
che si depositano sulla strada e vengono trasportate sui terreni vicini al bordo stradale o nelle acque di superficie, durante la guida si genera una frazione di particelle più piccole, compatibili con il trasporto nell’aria, che costituiscono fino al 10% in massa delle emissioni totali dovute all’usura degli pneumatici e che sono state per lungo tempo l’argo -

mento principale relativo all’usura degli pneumatici, in merito ai rischi per la salute umana. Le cosiddette emissioni non di scarico legate al traffico, che comprendono l’usura degli pneumatici, delle strade e dei freni, nonché la risospensione della polvere della strada, sono ampiamente discusse come contributo al particolato (PM) in ambiente aria. Le emissioni del traffico sono in genere la principale fonte di superamento del valore limite annuale di 40 μg/m3, stabilito dall’Unione Europea per il PM10 (particelle responsabili del particolato di diametro <10 μm). Le emissioni di scarico sono in calo, grazie a varie misure di riduzione, mentre sono in aumento quelle non di scarico che, a fronte di un’ulteriore riduzione di quelle di scarico per la transizione alla mobilità elettrica, aumenteranno a causa del previsto aumento del volume di traffico. Per ora, comunque, il contributo dell’usura degli pneumatici alle emissioni riferite al PM10 è relativamente basso (11%).
Per quanto riguarda gli ambienti acquatici, sia di acque dolci che marine, il problema delle TRWP viene affrontato in relazione all’inquinamento da MP, anche se è possibile che, a causa della loro densità relativamente elevata, esse abbiano un ruolo minore nell’ambiente marino rispetto a polimeri di peso specifico più leggero, con l’eccezione delle acque dolci, che potrebbero essere più colpite. Dal momento che le particelle MP vengono ingerite da varie specie acquatiche, tra cui bivalvi e pesci, sono oggetto di discussione i rischi ecologici e i rischi per la salute umana attraverso le catene alimentari, con il coinvolgimento anche delle TRWP.
I NGREDIENTI DEL BATTISTRADA PNEUMATICO
I componenti più comuni del battistrada, che determinano la durata e le caratteristiche di guida sono (in parentesi la percentuale in massa):
- materiali di base (40-50%) - gomma naturale e gomme sintetiche (SBR e BR);
- cariche (30-35%) - carbon black, silice e carbonato di calcio;
- plastificanti (15%) - (olio e resine);
- agenti di vulcanizzazione (2-5%) - zol-
by G. Brembati
The tyre and road particles (TRWP) have a strong impact on the environment, contribute to the microplastic pollution and present risks for human health.
The tyre and road particles (TRWP), generated on roads during driving, contri bute to airborne non-exhaust emissions and play an important role in the microplastic pollution.
Besides other components of the compound (fillers, accelerators, etc.), tyre wear contains about 50% natural and synthetic polymers and is probably the most important source of synthetic polymer-based material in the environment. It is estimated that approximately 1.3 million tonnes of tyre wear are generated on European roads each year, which explains why the issue of “emissions from tyre wear” deserves particular attention.
Tyre wear is generally defined as microplastic (MP) due to its (semi)synthetic polymer structure, solid state, insolubility and particle size, which falls within the range defined for microplastics (1-1000 μm). The properties and environmental behaviour of elastomer particles from tyres, which are formed directly at the source of emission, i.e. road traffic, differ from those of plastics, which have a partially crystalline structure and different chemical composition, shape and surface. Pure tyre
wear particles are rarely found in the environment, as they mix with other road-related particles, thus forming particles with a mixed composition. I n addition to coarse tyre and road wear particles (TRWPs), which are deposited on the road and transported to land near the roadside or into surface water, a fraction of smaller particles compatible with air transport is generated during driving. These particles constitute up to 10% by mass of total emissions from tyre wear and have long been the main topic of discussion regarding tyre wear in terms of risks to human health. So-called non-exhaust traffic-related emissions, which include tyre, road and brake wear, as well as the resuspension of road dust, are widely discussed as a contributor to particulate matter (PM) in the air environment. Traffic emissions are generally the main source of exceedances of the annual limit value of 40 μg/m3 set by the European Union for PM10 (particles responsible for particulate matter with a diameter <10 μm). Exhaust emissions are declining, thanks to various reduction measures, while non-exhaust emissions are increasing. Despite a further reduction in exhaust emissions due to the transition to electric

fo e ossido di zinco; - additivi (5-10%) - antiossidanti e antiozonanti (TMQ, ammine e cere).
Va considerato che il contenuto medio di SBR è circa l’11%, con l’eccezione degli pneumatici di veicoli pesanti, che di solito ne contengono poca o non la contengono.
Le TRWP vengono generate dal contatto fra lo pneumatico e la superficie stradale durante la guida, dall’accelerazione e dalla frenata e sono le forze di taglio e di attrito sul battistrada, che causano l’abrasione delle particelle prevalentemente più grossolane, mentre il calore con l’attrito altera la composizione chimica delle particelle generate. Il materiale proveniente dal manto stradale, inoltre, viene incorporato nelle particelle, dando origine alle TRWP che, raccolte sulla strada, consistono di una composizione eterogenea e inseparabile di gomma, minerali e polveri fini da usura dei freni e da risospensione delle particelle di usura.
Le TRWP hanno forme allungate e cilindriche, simili a quelle di usura raccolte in un percorso simulato di laboratorio, e una volta depositate sulla superficie stradale raccolgono la sua polvere fine, il che porta a un incrostamento con par-
ticelle più piccole, perlopiù inorganiche, arrivando a una composizione finale del 53% di minerali, del 23% di oli plastificanti e dell’11% di carbon black. I processi di abrasione comportano anche un sensibile aumento della densità delle TRWP, da 1,5 a 2,2 g/cm3, che insieme alla variazione della composizione chimica influenzano sensibilmente il loro comportamento ambientale. La variazione di densità le fa tendere a depositarsi in sedimenti più di altri tipi di microplastiche, ostacolando così il loro ulteriore trasporto, mentre la variazione di composizione chimica impatta sulla degradazione e sulla ecotossicità. Secondo alcuni studi di laboratorio, anche l’usura degli pneumatici può contribuire alle emissioni di nanoparticelle, per la cui formazione può essere plausibile l’evaporazione e la condensazione di composti volatili del materiale dello pneumatico.
EFFETTI TOSSICOLOGICI
La presenza di particelle sintetiche, come le MP, nel tratto gastrointestinale degli organismi, può causare effetti fisici e chimici. A causa del volume occupato dalle particelle può verificarsi una riduzione dell’assunzione di cibo e, di conseguenza, una perdita di energia e vitalità. Gli additivi polimerici, inoltre, posso -
mobility, non- exhaust emissions will increase due to the expected increase in traffic volume. For now, however, the contribution of tyre wear to PM10 emissions is relatively low (11%). W ith regard to aquatic environments, both freshwater and marine, the issue of TRWPs is addressed in relation to PM pollution, although it is possible that, due to their relatively high density, they play a lesser role in the marine environment than polymers with a lower specific gravity, with the exception of freshwater, which may be more affected. Since MP particles are ingested by various aquatic species, including bivalves and fish, ecological risks and risks to human health through food chains are under discussion, with also TRWPs involved.
T he most common tread components, which determine durability and driving characteristics, are (percentage by mass in brackets): - b ase materials (40-50%) - natural rubber and synthetic rubbers (SBR and BR); - fillers (30-35%) - carbon black, silica and calcium carbonate; - plasticizers (15%) - oil and resins;









no essere rilasciati nel tratto digestivo, causando effetti tossici.
Nella maggior parte degli studi, effettuati dal 2000, sono stati esaminati in vivo gli effetti dei percolati, derivati dall’usura degli pneumatici, su varie specie acquatiche quali dafnie, pesci, alghe, insetti e batteri. I relativi effetti tossici sono stati collegati allo zinco, ad altri metalli e a composti organici come benzotiazoli, ftalati e acidi resinici. L’usura è stata prodotta artificialmente mediante simulatori della strada, macinazione del materiale da pneumatici e pneumatici usurati, ottenendo però particelle di TRWP di composizione diversa da quelle reali generate sulle strade, per cui sarebbe utile usare TRWP raccolte nell’ambiente.
Il rischio per la salute umana è correlato soprattutto all’inalazione delle TRWP emesse nell’atmosfera, con gli effetti negativi che possono verificarsi a causa delle caratteristiche fisiche delle particelle, in dipendenza da dimensione e forma, da chimica della superficie e da componenti tossici (metalli pesanti e composti organici). Attualmente non sono disponibili informazioni sui rischi per la salute umana, legati alla potenziale assimilazione di TRWP attraverso la catena alimentare, mentre è stata ampiamente discussa la possibile minaccia rappresentata dalle particelle di MP negli alimenti destinati al consumo umano, come pesci e frutti di mare.
DEGRADAZIONE DELL’USURA DEGLI PNEUMATICI NELL’AMBIENTE
Per quanto riguarda il comportamento ambientale delle TRWP, un aspetto importante è la velocità con cui vengono degradate, verosimilmente con processi di fotodegradazione e biodegradazione, senza che tuttavia ci siano riferimenti che forniscano informazioni quantitative. È stato ipotizzato che la biodegradazione dell’usura degli pneumatici sia ostacolata dai suoi additivi tossici e da stabilizzanti, ma rimane il fatto che i dati sulla degradazione da studi sul campo sono stati raccolti in misura molto limitata, mentre è risaputa la persistenza della gomma solida dello pneumatico in ambiente acquatico, dal momento che pneumatici di
- v ulcanizing agents (2-5%) - sulphur and zinc oxide;
- additives (5-10%) - antioxidants and anti-ozonants (TMQ, amines and waxes)It should be noted that the average SBR content is approximately 11%, with the exception of heavy vehicle tyres, which usually contain little or no SBR.
T RWPs are generated by contact between the tyre and the road surface during driving, acceleration and braking. It is the shear and friction forces on the tread that cause the abrasion of the coarser particles, while the heat generated by friction alters the chemical composition of the particles produced. Material from the road surface is also incorporated into the particles, giving rise to TRWPs which, when collected from the road, consist of a heterogeneous and inseparable composition of rubber, minerals and fine dust from brake wear and resuspension of wear particles.
T RWPs have elongated, cylindrical shapes, similar to those collected from a simulated laboratory route, and once deposited on the road surface, they collect its fine dust, which leads to encrustation with smaller, mostly inorganic particles, resulting in a final composition of 53% minerals, 23% plasticizing oils and 11% carbon black.
Abrasion processes also lead to a significant increase in the density of TRWPs, from 1.5 to 2.2 g/cm3 , which, together with the change in chemical composition, significantly affects their environmental behaviour.
T he change in density causes them to settle in sediments more than other types of microplastics, thus hindering their further transport, while the change in chemical composition impacts degradation and ecotoxicity. According to some laboratory studies, tyre wear can also contribute to nanoparticle emissions, the formation of which may be plausible due to the evaporation and condensation of volatile compounds in the tyre material.
T he presence of synthetic particles, such as MP, in the gastrointestinal tract of organisms can cause physical and chemical effects. Due to the volume occupied by the particles, there may be a reduction in food intake and, consequently, a loss of energy and vitality. Polymer additives can also be released into the digestive tract, causing toxic effects.
M ost studies conducted since 2000 have examined the effects of leachates derived from tyre wear on various aquatic species such as daphnia, fish, algae, insects and bacteria in vivo. The associated toxic effects have been linked to zinc, other metals and organic compounds such as benzothiazoles, phthalates and resin acids.
Wear was produced artificially using road simulators, grinding tyre material and worn tyres, but this resulted in TRWP particles with a different composition from those actually generated on roads, so it would be useful to use TRWP collected from the environment.
The risk to human health is mainly related to the inhalation of TRWPs emitted into the atmosphere, with adverse effects that may occur due to the physical characteristics of the particles, depending on their size and shape, surface chemistry and toxic components (heavy metals and organic compounds).
Currently, no information is available on the risks to human health associated with the potential assimilation of TRWPs through the food chain, while the possible threat posed by PM particles in food intended for human consumption, such as fish and seafood, has been widely discussed.
A n important aspect of the environmental behaviour of TRWPs is the rate at which they degrade, presumably through photodegradation and biodegradation processes, although there
are no references providing quantitative information. It has been hypothesised that the biodegradation of tyre wear is hindered by its toxic additives and stabilisers, but the fact remains that data on degradation from field studies has been collected to a very limited extent, while the persistence of solid tyre rubber in the aquatic environment is well known, since waste tyres are used to build breakwaters and artificial barriers on the coast.
To date, studies have been conducted on the effects on various aquatic species, in particular those due to tyre wear leachates or TRWPs, and the ecotoxicity of added sediments, finding acute and chronic aquatic toxicity values. However, there is a lack of studies on the effects of TRWP concentrations and the presence of actual TRWPs in environmental conditions.
T he estimation of annual emissions from tyre and road wear, on a regional or national scale, is carried out using
emission factors EF (mass of wear generated by tyres or TRWPs per kilometre travelled by the vehicle and total annual mileage) or by taking into account the total consumption of tyres and their weight loss due to abrasion per year, but without assessing the contribution of road wear, as is the case with many EFs. EFs, which should reflect tyre and road wear as realistically as possible, depend on a number of factors, including tyre characteristics (type, age, size and chemical composition), road surface properties (material, porosity, surface coating, humidity and temperature), vehicle characteristics (weight and braking system) and vehicle usage patterns (speed, acceleration, braking and steering intensity and frequency). The EFs reported in the literature are derived from studies on test benches, with test vehicles and in road tunnels, or are calculated on the basis of tyre weight loss or annual tyre change and mileage. Table 1 shows the results obtained by various authors, who in some cases do not indicate the original source, so the approach or test procedure applied is not always clear and, as a result, all the val-
ues reported are purely indicative. W hen assessing tyre wear emissions released into water or soil, it should be borne in mind that a significantly smaller fraction of fine particles is also generated and emitted into the atmosphere. A nnual TRWP emissions have been estimated for a number of European and non-European countries (Table 2), using the EF criterion and the annual mileage of the vehicle on a national or regional scale, differentiating by vehicle type, urban roads, rural roads or motorways, taking into account population growth since the first year of the original assessments and extrapolating the total amount of tyre wear to approximately 3.4 million tonnes/year. Taking into account the variety of data entered, it can be seen that the highest emissions are in the USA, where transport is mainly by road, while the lowest value is recorded for India, where the standard of living is lower than in other industrialised countries. The result for the Netherlands is interesting, where motorways are built with open (porous) asphalt, so that it is assumed that 95% of emissions are captured by the pores of the road sur-

Microplastiche / Microplastics - Oregon State University - https://www.flickr.com/photos/oregonstateuniversity/21282786668/, CC BY-SA 2.0, https://commons. wikimedia.org/w/index.php?curid=97656199.
Table1
Emissionfactorsoftyrewearfordifferentvehicletypes(mg/vehiclekm).
Vehicletype Urban roads Rural roads HighwaysReference
Lightdutyvehiclesa 5
Heavydutyvehiclea 7.5
Motorcyclea 1.72
Passengercara 3.45
Lightdutyvehiclea 4.5
Heavydutyvehiclea 18.56
Passengercar53
Van 107
Bus 344
Lorry 539
Truck 1092
Passengercara 6.1
Lorrya ≤32
EPA(1995)
Referenceyear1995 CEPMEIP(2020)
B.Baensch-Baltruschatetal./ScienceoftheTotalEnvironment733(2020)137823 scarto vengono usati per costruire frangiflutti e barriere artificiali sulle coste. Fino ad oggi sono stati studiati gli effetti su varie specie acquatiche, in particolare quelli dovuti ai percolati da usura pneumatici o TRWP, e l’ecotossicità di sedimenti addizionati, riscontrando valori di tossicità acquatica acuta e cronica. Mancano tuttavia, per quanto riguarda le concentrazioni delle TRWP e la presenza di TRWP reali, studi sugli effetti in condizioni ambientali.
GebbeandHartung(1997)
totheatmospherewhereasthecoarsefractionisreleasedtowater andsoil.TheyrecommendtopresumethatthefractionofPM10 amountsto5%ofthetotaltyreweargeneratedbypassengercars andtousethisvaluetocalculatetheatmosphericfractioncaused byothervehicletypes,forwhichthepercentvaluesofPM10areunknownorscarce.
5.2.Estimationsoftyreandroadwearemissionsfordifferentcountries
EMISSIONI DERIVATE DALL’USURA DI PNEUMATICI E STRADE
Rauterberg-Wulff(1998)
PassengercarMean:100;range:40–360c 74d Luhanaetal.(2004)
PassengercarMean:90;range:53–200 Hillenbrandetal.(2005)
Van/Lorry Mean:700;range: 107–1500
Bus 700(likevanandlorry)
Truck Mean:1200;range: 1000–1500
Notspecifieda 9
Kupiainenetal.(2005)
Car 50 Gustafssonetal.(2008)
Bus 700
Motorized2-wheeler7
Aatmeeyataetal.(2009)
Notspecifieda 2.2 Sjödinetal.(2010)
Passengercar33 Anonymous(2012)
Lightcommercial51
Heavycommercial178
Notspecifieda 2.4–7
La stima delle emissioni annuali di usura di pneumatici e strade, su scala regionale o nazionale, viene effettuata mediante fattori di emissione EF (massa di usura generata dagli pneumatici o TRWP per chilometro percorso dal veicolo e chilometraggio annuale totale) o tenendo conto del consumo totale di pneumatici e delle loro perdite di peso dovute all’abrasione per anno, ma non valutando il contributo dell’usura delle strade, come del resto succede in parecchi casi di EF.
Pankoetal.(2013a)
Passengercara 8.86.85.8 NAEI(2017)
Motorcyclea 3.82.92.5
Mopeda 3.8
Lightdutyvehiclea 14119.1
Heavydutyvehiclea 472731
Bus/coacha 211714
Passengercarb 13285104 DELTARESandTNO(2016)
Motorcycleb 603947
Mopedb 13910
Vanb 159102125
Lorryb 850546668
Truckb 658423517
Busb 415267326
Lightspecialvehicleb 159102125
Heavyspecialvehicleb 850546668
Unit:mg/vehiclekmincludesthevehicle-specificnumberoftyres.
a Emissionfactorsexclusivelyfor fineairborneparticulates(PM10).
b Emissionfactorsexclusivelyforcoarseparticulates.
c Compiledby Luhanaetal.(2004) fromliterature.
d Measuredby Luhanaetal.(2004)
(Germany). BaumannandIsmeier(1997) provideEFforpassengercars, lorries,trucksandbusseswithoutexplicitlydescribinghowtheEFwere derived. Boller(2000) reportedEFforcarswithoutanyinformationof theoriginaldatasourceandthemethodused.Thequestionrises whetherallthesedataarestillvalidandreflectthecurrentdrivingconditionsinGermanyorother(European)countries.
Tabella 1 - Fattori di emissione dell'usura degli pneumatici per diversi tipi di veicoli (mg/veicolo km) / Table 1 - Emission factors of tyre wear for different vehicle types (mg/vehicle km).
5.1.3.Airbornefraction
Gli EF, che dovrebbero riflettere il più realisticamente possibile l’usura degli pneumatici e delle strade, dipendono da una serie di fattori, che comprendono le caratteristiche dello pneumatico (tipo, età, dimensione e composizione chimica), le proprietà del manto stradale (materiale, porosità, rivestimento superficiale, umidità e temperatura), le caratteristiche del veicolo (peso e sistema frenante) e le modalità di utilizzo del veicolo (velocità, accelerazione, entità e frequenza di frenate e sterzate). Gli EF riportati in letteratura derivano da studi su banchi di prova, con veicoli di prova e in tunnel stradali, oppure sono calcolati sulla base di perdita di peso degli pneumatici o del cambio annuale degli pneumatici e del chilometraggio. La Tabella 1 riporta i risultati ottenuti da diversi autori, che in alcuni casi non indicano la fonte originale, per cui l’approccio o la procedura delle prove applicate non è sempre comprensibile e, di conseguenza, tutti i valori riportati sono puramente indicativi.
Annualemissionsoftyre(androad)wearhavebeenestimatedfor numerousEuropeanandnon-Europeancountries(see authorscalculatedtheemissionsbasedonEFandtotalannualvehicle kmatnationalorregionalscalewhereasdifferentdatasetsfortyre wearrateswereapplied.Inmoststudiesadifferencewasmadebetweenvariousvehicletypes.MostuseddataonEFwerethosegiven by Hillenbrandetal.(2005), Luhanaetal.(2004) (2012) andthedifferentversionselaboratedbyDELTARESandTNO (originalwork: TenBroekeetal.(2008),lastupdatedversionavailable: DELTARESandTNO(2016) ).Insomecases,differentdatasetswere combined.EFprovidedbyTNOandDELTARESallowadifferentiation betweentyrewearemissionsgeneratedonurbanandruralroadsand onhighwaysprovidedthatmileagedatafordifferentvehicleandroad typesisavailable. Verschooretal.(2016) elaboratedsuchanestimation oftheannualtyrewearemissionsintheNetherlands. alsoestimatedtyrewearemissionsbasedonthesedatasetsforthe Netherlands.Additionally,theauthorsrecalculatedtheemissionsestimatedby Lassenetal.(2015) (Denmark)and Yamanaka(2013) (Japan)andupdatedtheresultsof (UnitedKingdom)and Councelletal.(2004) theytookintoaccountthepopulationgrowthsincethereportyearof theoriginalestimations.Basedontheemissiondataforseven EuropeancountriesandsixcountriesoutsideEurope,inwhich57%of theworld'svehiclesareregistered,theyextrapolatedtheworld'styre wearemissionsamountingto3,369,698t/a. Toenablethecomparisonbetweendifferentcountries, displaystheannualemissionspercapita.Thedatacompriseslessthan twoordersofmagnituderangingfrom0.2to5.5kg/(cap*a)withanaverageglobalvalueof0.8kg/(cap*a).Forsomecountriesdifferentresults havebeenpublished(e.g.,forGermanyortheNetherlands)whichshow thattheestimatedemissionsdependondiverseinputdata.AnownestimationoftheannualtotaltyrewearemissionsforGermanywasperformedbasedonEFandtotalvehiclekm(see Baensch-Baltruschatetal., 2020).Totalannualemissionsofcoarseparticleswereestimatedtobe 0.9kg/(cap*a)(EFderivedby GebbeandHartung(1997) (cap*a)(EFcompiledby DELTARESandTNO(2016) These figuresareconsistentwiththeresultsof (2005) and Esseletal.(2014) andsomewhatlowerthantheemissions estimatedby Wagneretal.(2018) Takingintoaccountthevariationofinputdatasomestatementscan bemade.ThehighestemissionspercapitaoccurintheUSAwhere transportismainlyfocusedonroads.ThelowestvaluehasbeenestimatedforIndiawheremanyinhabitants'economicstatusisrelatively lowcomparedtothestandardoflivinginindustrialcountries. etal.(2017) estimatedrelativelylowemissionsfortheNetherlandstakingintoaccountthat95%oftheDutchhighwaysarepavedwithopen
8 B.Baensch-Baltruschatetal./ScienceoftheTotalEnvironment733(2020)137823
Table2 Annualemissionsoftyrewearfordifferentcountriesandregions. Country/RegionTyrewearemissionsintotal
Remarks
Reference
TotalvehiclekmderivedfromdataforGermany Wagneretal.(2018)
DerivationofEFisnotexplained BaumannandIsmeier (1997)
Hillenbrandetal.(2005)
Esseletal.(2014)
Wagneretal.(2018)
Owncalculation (Baensch-Baltruschat etal.,2020)
Recalculationofdataestimatedby Lassenetal. (2015) Koleetal.(2017)
Lassenetal.(2015)
Koleetal.(2017)
Uniceetal.(2019)
Milanietal.(2004)
Sherringtonetal.(2016)
Koleetal.(2017)
Verschooretal.(2016) NLD 15,030 8768(correctedforamounts trappedinopenporeroad surface)
Sundtetal.(2014)
Magnussonetal.(2016)
EAUK(1999)
Updateofdatagivenby EAUK(1999) Koleetal.(2017)
CountriesoutsideEurope
Milanietal.(2004)
Koleetal.(2017)
Koleetal.(2017)
Koleetal.(2017)
Recalculationofdataestimatedby Yamashitaand Yamanaka(2013) Koleetal.(2017)
Councelletal.(2004)
Updateofdatagivenby Councelletal.(2004)Koleetal.(2017)
Koleetal.(2017)
Wagneretal.(2018)
ExtrapolationfromemissionsofDEU,DNK,GBR,ITA, NDL,NOR,SWE,AUS,BRA,CHN,JPN,IND,andUSA Koleetal.(2017)
a Owncalculation,datasourcefornumberofinhabitants:totalEurope(EUROSTAT,2018),others(CIA,2018).
b Estimationbasedonemissionfactorsandtotalvehiclekm.
c Databasedon Gebbeetal.(1997)andWDK(AssociationofGermanRubberManufacturingIndustry,reportingyear2005)
d Estimationbasedonconsumptionoftyresandabrasiveloss(weightlossduringuse).
e DerivedfromdataforentireFrancebasedonpopulationdensityandlengthsofurbanandruralroadsintheSeineriverbasin.
f Estimationbasedonthenumberoftyrescollectedforretreadingandweightlossduringuse.
g Estimationbasedonthenumberofregisteredvehicles,lifeexpectancyoftyresandlossduringlifetime.
h ExtrapolatedfromtheemissiondataforDEU,DNK,GBR,ITA,NLD,NOR,SWE,AUS,BRA,CHN,IND,JPN,andUSA,andtheworld'snumberofvehicles.
i Emissionsfactorscompiledby Hillenbrandetal.(2005)
j Emissionsfactorscompiledby GebbeandHartung(1997)
k Emissionfactorsby DELTARESandTNO(2016)
l Luhanaetal.(2004)
m Anonymous(2012)
n DELTARESandTNO(2014)
o Kleinetal.(2015) (DutchPollutantReleaseandTransferRegister).
p VanDuijnhoveetal.(2014).
q Gustafssonetal.(2008)
r Aatmeeyataetal.(2009)
s UnifiedEF:50mg/km.
Themajorfractionisemittedtowaterandsoils.Annualemissions werecalculatedfornumerouscountries.Theannualtyrewearemissionsareestimatedtobe1.3milliont/ainEuropeand1.1–1.8million
Tabella 2 - Emissioni annuali dovute all’usura degli pneumatici per diversi paesi e regioni / Table 2 - Annual emissions of tyre wear for different countries and regions.
t/aintheUSAwhileworld'sannualemissionsareapprox.3.4million t/a.ThehighestemissionspercapitaisreportedfortheUSA( ≥5.5kg/ cap*a),thelowestforIndia(0.25kg/cap*a).

Quando si valutano le emissioni di usura degli pneumatici, rilasciate nell’acqua o nel suolo, occorre tener conto del fatto che è generata anche una frazione di particelle fini, di entità sensibilmente inferiore, che viene emessa nell’atmosfera.
Le emissioni annuali di TRWP sono state stimate per numerosi paesi europei ed extraeuropei (Tabella 2), con il criterio degli EF e del chilometraggio annuale del veicolo su scala nazionale o regionale, differenziando per tipo di veicolo, per strade urbane, rurali o autostrade, tenendo conto della crescita della popolazione dal primo anno delle valutazioni originali ed estrapolando la quantità globale di usura degli pneumatici in circa 3.4 milioni di tonnellate/anno. Tenendo conto della varietà dei dati immessi, si vede come le più alte emissioni siano negli USA, dove il trasporto è essenzialmente su strada, mentre il valore più basso si registra per l’India, dove il tenore di vita è inferiore rispetto ad altri paesi industriali. Interessante il risultato dell’Olanda, dove le autostrade sono costruite con asfaltatura aperta (porosa), così che si presume che il 95% delle emissioni sia catturato dai pori della superficie stradale e le autostrade vengano pulite regolarmente.
La frazione grossolana delle TRWP, generata dal movimento dei veicoli, si deposita inizialmente sulla superfice stradale, per essere successivamente lavata via e trasportata ai bordi della strada. La pioggia, anche intensa, non è sufficiente per dilavare completamente la strada, se non in maggior parte in caso di forti intensità e deflusso, per cui il dilavamento avviene a impulsi e dipende fortemente dai periodi di siccità e pioggia. Sulle strade prive di drenaggio artificiale, il deflusso si infiltra in una piccola zona adiacente alla strada, per una larghezza stimata in 0,75-1,50 metri. A causa della turbolenza dell’aria, causata dai veicoli ad alta velocità, dal vento e dagli spruzzi di acqua, le particelle possono essere anche trasportate sul bordo della strada. Il materiale di usura degli pneumatici e della strada, accumulato nel suolo, non contribuisce al trasporto delle particelle con il deflusso dell’acqua piovana nell’ambiente acquatico, poiché esse vengono integrate nel suolo insieme ai contaminanti che contengono. Un corridoio di alcuni metri, vicino ad una strada, è inquinato da sostanze non disciolte e
face and motorways are cleaned regularly.
The coarse fraction of TRWPs, generated by vehicle movement, initially settles on the road surface, before being washed away and transported to the roadside. Even heavy rain is not sufficient to completely wash the road, except partially in case of high intensity and runoff, so the runoff occurs in pulses and is highly dependent on periods of drought and rain. On roads without artificial drainage, runoff infiltrates a small area adjacent to the road, with an estimated width of 0.75-1.50 metres. Due to air turbulence caused by high-speed vehicles, wind and water spray, particles can also be transported to the roadside. Tyre and road wear material accumulated in the soil does not contribute to the transport of particles with rainwater runoff into the aquatic environment, as they are integrated into the soil along with the contaminants they contain. A corridor of several metres near a road is polluted by undissolved substances and heavy metals, and this probably also applies to TRWPs, with the roadside affected depending on traffic density: using zinc as an indicator, the width can vary from about 6 metres on motorways to 1-3 metres on other roads.
Field studies show that one third of the solids emitted on roads are removed by displacement and two thirds by runoff. Runoff can be distinguished for urban areas, rural roads and motorways, with estimated values of 50-60%, 20-30% and 10% respectively. It should also be noted that 60% of TRWPs is subsequently released into sewers, while outside urban areas 10% is transported into surface water and 90% remains in the soil.
metalli pesanti e questo vale probabilmente anche per le TRWP, con il bordo stradale interessato a seconda della densità del traffico: usando lo zinco come indicatore, la larghezza può variare da cica 6 metri sull’autostrada a 1-3 metri sulle altre strade. Dai risultati di studi sul campo, un terzo dei solidi emessi sulle strade viene rimosso dallo spostamento e due terzi dal deflusso. Il deflusso può essere distinto per aree urbane, strade rurali e autostrade, stimando che i valori siano rispettivamente 50-60%, 20-30% e 10%. Occorre poi considerare che il 60% delle TRWP viene successivamente rilasciato nelle fognature, mentre al di fuori delle aree urbane, il 10% viene trasportato nelle acque di superficie e il 90% rimane nel suolo.
Poiché le autostrade generalmente non sono collegate a sistemi fognari, le TRWP si depositano principalmente nel suolo adiacente, con infiltrazione e ritenzione di particelle e contaminanti. Solo in alcuni paesi, in tratti di attraversamento di ponti e viadotti e in tunnel, vengono costruiti sistemi di drenaggio e, in questo caso, è possibile installare impianti di trattamento, tra cui bacini di sedimentazione, schiumatoi e canali di scolo. In altri casi l’acqua di deflusso non trattata viene rilasciata nelle acque di superficie. Le acque di deflusso stradale inquinate dovrebbero essere depurate prima di essere scaricate nelle acque di superficie (programma CEDR 2016) e, in Europa, lo standard tecnico di trattamento è più sviluppato in Austria, Germania e Svizzera. N ella maggior parte dei paesi europei le strade urbane sono completamente asfaltate, per cui una parte delle TRWP viene rimossa con altri rifiuti stradali, mentre una parte viene trasportata verso zone non asfaltate vicino alla strada, come bordi piantumati o aiuole, dove si accumulerà nel tempo, e la parte restante sarà lavata via dalla pioggia e trasportata ai margini della strada. Nei paesi dell’Europa occidentale, le strade urbane sono perlopiù collegate a un sistema fognario,
che ne raccoglie il deflusso, così che le TRWP più grossolane vengono già trattenute negli scarichi fognari, nei pozzetti e nei canali, e quelle più fini sono trasportate attraverso l’intero sistema fognario fino all’impianto di trattamento, se esistente, oppure scaricate direttamente nelle acque di superficie. I sistemi fognari delle aree urbane possono essere di tipo separato o combinato: nel primo caso il deflusso dalle strade e le acque reflue da abitazioni e industrie vengono raccolti in canali diversi, nel secondo caso nello stesso canale, fino all’impianto di trattamento che, nel caso non sia in grado di ricevere e trattare il volume d’acqua eccessivo per forti piogge e in assenza di bacini di raccolta delle acque piovane e/o di fognature di stoccaggio, lo lascerà scaricare direttamente nelle acque di superficie con un trattamento solo parziale.
Attualmente non sono disponibili informazioni specifiche sul destino delle TRWP negli impianti di trattamento ma, basandosi sul fatto che le MP a densità più elevata si depositano nei fanghi di depurazione o sono trattenute in piccola percentuale dai filtri a sabbia, è verosimile che anch’esse seguano questo percorso e, come componente dei fanghi, siano poi incenerite, smaltite in discarica o sparse sui terreni agricoli. In quest’ultimo caso, una volta sparse sul terreno, le MP, le TRWP e altri inquinanti possono rimanere nel suolo, rimosse e disperse dal vento oppure trasportate, con il deflusso superficiale, nell'ambiente acquatico. È prevedibile che le TRWP vengano rilasciate in diversi comparti ambientali, con una piccola parte che viene emessa nell'atmosfera e con la maggior parte che raggiunge i suoli vicini alle strade e i comparti acquatici. Grazie ai sistemi di drenaggio e agli impianti di trattamento in loco o destinati alle acque di deflusso, le TRWP vengono trattenute in misura maggiore o minore e non raggiungono le acque di superficie se non in misura limitata. Partendo da deflussi, stimati del 15 e del 50% in studi diversi, e valutando l'efficienza del trattamento al 50%, si può ipotizzare che il 6 e il 23% rispettivamente
dell'usura degli pneumatici generati sulle autostrade venga rilasciata nelle acque di superficie, mentre il 77 e il 45% rimangano sul ciglio della strada. Per fare un esempio, sulla base di studi condotti sull'intero sistema stradale tedesco i risultati confermano che il 66-76% delle TRWP grossolane, generate sulle strade, si depositano nel suolo vicino alle strade, il 12-20% viene rilasciato nelle acque di superficie e solo una piccola quantità del 2,3% si diffonde nelle aree agricole. Poiché i dati sulla degradazione del suolo sono scarsi, al momento non è chiaro se e come le particelle si accumuleranno nel lungo periodo. Inoltre, poco si sa sul comportamento delle TRWP nei fiumi per quanto riguarda la sedimentazione, l'ulteriore frammentazione, la degradazione e il trasporto, e sembra che solo il 2% possa raggiungere il mare. È infine discutibile se i risultati relativi alle MP siano trasferibili al comportamento delle TRWP nei fiumi, a causa delle diverse densità, forme e altre proprietà delle particelle, con la considerazione che i risultati relativi a singoli bacini fluviali non sono generalmente applicabili ad altre ac -
As motorways are not generally connected to sewerage systems, TRWPs are mainly deposited in the adjacent soil, with infiltration and retention of particles and contaminants. Only in some countries there are drainage systems built on bridge and viaduct crossings and in tunnels, and in this case treatment plants can be installed, including sedimentation basins, skimmers and drainage channels. In other cases, untreated runoff water is released into surface waters. Polluted road runoff water should be treated before being discharged into surface waters (CEDR 2016 programme) and, in Europe, the technical standard for treatment is most developed in Austria, Germany and Switzerland.
I n most European countries, urban
que di superficie con condizioni idrologiche diverse.
MONITORAGGIO RELATIVO ALLE PARTICELLE DI USURA
DI PNEUMATICI E STRADE
I primi studi di monitoraggio sulle TRWP nell'ambiente sono stati condotti negli anni '70, con riscontri della loro presenza nell'aria, nella polvere stradale, nel suolo, nella neve, nel deflusso stradale, nei sistemi di trattamento delle acque reflue, nell'acqua e nei sedimenti dei fiumi. Questo monitoraggio ambientale è ostacolato da problemi analitici, perché le particelle non possono essere analizzate con la spettroscopia FTIR o Raman, dal momento che il battistrada degli pneumatici e le TRWP hanno una composizione chimica complessa e le TRWP sono difficili da separare dalle matrici ambientali: si rendono così necessari dei marcatori, ossia dei composti chimici contenuti come additivi nei materiali del battistrada in concentrazioni sufficientemente elevate. Per questo scopo un marcatore affidabile deve essere specifico per il polimero dello pneumatico, essere presente in concentrazioni comparabili, preferibilmente indipendenti dalle marche degli pneumatici, non essere facilmente dilavato o trasformato in condizioni ambientali e, infine, essere rilevabile con facilità e precisione. Molto spesso è stato scelto lo zinco come marcatore, anche se non è considerato molto specifico per l'usura degli pneumatici in generale, poiché viene emesso anche da altre fonti legate al traffico, come i sali antigelo, le barriere stradali, il metallo zincato delle automobili, l'usura dei freni e la segnaletica orizzontale. Tuttavia, sulla scorta di analisi della sua concentrazione nel battistrada di vari e diversi pneumatici e di raffronto con lo zinco presente nei terreni naturali, esso è considerato almeno un indicatore significativo delle TRWP nei campioni di suolo o sedimenti, prelevati in prossimità delle emissioni stradali e in assenza di altre fonti rilevanti.
Altri marcatori spesso utilizzati sono i benzotiazoli, come 24MoBT ed NCBA, entrambi componenti degli acceleran-
roads are completely paved, so a part of the TRWPs is removed with other road wastes, while a part is transported to unpaved areas near the road, such as planted verges or flower beds, where it will accumulate over time, and the rest will be washed away by rain and transported to the roadside. In Western European countries, urban roads are mostly connected to a sewerage system, which collects runoff, so that the coarser TRWPs are already retained in drains, manholes and channels, and the finer particles are transported through the entire sewerage system to the treatment plant, if one exists, or discharged directly into surface waters.
S ewerage systems in urban areas can be separate or combined: in the former case, runoff from roads and wastewater from houses and industries are collected in different channels, in the second case in the same channel, to the treatment plant which, if it is unable to receive and treat the excessive volume of water due to heavy rainfall and in the absence of rainwater collection basins and/or storage sewers, will allow it to discharge directly into surface waters with only partial treatment.
C urrently, no specific information is available on the fate of TRWPs in treatment plants, but based on the fact that
higher-density MPs are deposited in sewage sludge or retained in small percentages by sand filters, it is likely that they also follow this path and, as a component of sludge, are then incinerated, disposed of in landfills or spread on agricultural land. In the latter case, once spread on the ground, PM, TRWP and other pollutants may remain in the soil, be removed and dispersed by the wind, or be transported by surface runoff into the aquatic environment. I t is foreseeable that TRWPs will be released into various environmental compartments, with a small proportion being emitted into the atmosphere and most reaching soils near roads and aquatic compartments. Thanks to drainage systems and onsite or off-site treatment plants for runoff water, TRWPs are retained to a greater or lesser extent and do not reach surface waters except to a limited extent. Based on runoff estimates of 15% and 50% in different studies, and assuming 50% treatment efficiency, it can be assumed that 6% and 23% of tyre wear generated on motorways is released into surface waters, while 77% and 45% remains on the roadside. For example, based on studies conducted on the entire German road system, the results confirm that 66-76% of coarse

a) Campo da calcio in erba artificiale con gomma triturata di pneumatici (GTR) utilizzata per l’imbottitura. b) Microplastiche provenienti dallo stesso campo, trascinate via dalla pioggia, trovate in natura vicino a un ruscello / a) Artificial turf football field with ground tyre rubber (GTR) used for cushioning. b) Microplastics from the same field, washed away by rain, found in nature close to a stream - Soleincitta, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, Wikimedia Commons.
ti usati nelle formulazioni degli pneumatici, che però possono separarsi per dilavamento. Se la presenza dei marcatori zinco e benzotiazoli non costituisce una prova certa della presenza di particelle di gomma degli pneumatici, tuttavia la loro assenza è un forte indizio dell'assenza di TRWP nel compartimento ambientale in questione. Pertanto fino a oggi nessun composto sembra soddisfare tutti i requisiti per essere considerato un indicatore affidabile. Un'alternativa ai marcatori descritti sono i metodi termoanalitici, che consentono di rilevare i prodotti di degradazione della gomma mediante pirolisi o desorbimento per estrazione termica.
Le analisi che usano additivi della gomma o prodotti di decomposizione termica come marcatori, forniscono risultati relativi alle concentrazioni di massa dell'usura degli pneumatici, per cui sembra sensato riportare i risultati degli studi di monitoraggio in termini di usura degli pneumatici.
AMBIENTI ACQUATICI, NELL'ARIA
E NEL SUOLO
Finora sono stati condotti alcuni studi per analizzare la quantificazione delle concentrazioni dell'usura degli pneumatici in compartimenti acquatici: sono state fatte, per esempio, analisi di 24MoBT e altri benzotiazoli nel delta del fiume Pearl in Cina, mentre in Germania si è applicato il metodo TED di estrazione termica con desorbimento, combinato con GC-MS, su campioni provenienti da un sistema di trattamento delle acque di deflusso stradale in un'autostrada, compreso il campionamento nel canale di afflusso e dei fanghi dal bacino di sedimentazione, per analizzare l'usura degli pneumatici e le MP termoplastiche. Per quanto riguarda invece i compartimenti marini, sono disponibili studi su sedimenti costieri della baia di San Francisco e in una laguna incontaminata.
Più numerosi gli studi relativi all'aria ambiente in prossimità delle strade, sia in grandi città che nelle vicinanze di autostrade, a volte con marcatori (zinco, NCBA e acidi resinici idrogenati) e,
nel caso di maggior copertura geografica, esaminando 17 siti a Los Angeles, Londra e Tokio. In alcuni casi sono stati usati modelli statistici per determinare il contributo al PM da diverse fonti, tra cui l'usura degli pneumatici, mentre una terza opzione per indagare l'usura degli pneumatici nel PM consiste nell'analizzare singole particelle sospese nell'aria mediante microscopia elettronica o ottica combinata con spettroscopia a raggi X a dispersione di energia o spettroscopia di massa. Studi in tal senso sono stati condotti nelle strade di Londra e Barcellona, in Germania occidentale lungo il bordo di una strada trafficata e in una stazione cittadina, oltre che in prossimità di due autostrade. Gli studi di monitoraggio nell'aria ambiente forniscono dati sul contributo dell'usura degli pneumatici relativi al particolato, soprattutto al PM10, che fornisce informazioni sulla sua rilevanza come fonte di inquinamento legata al traffico.
Gli studi sulla presenza delle TRWP nel suolo sono piuttosto scarsi e la maggior parte delle pubblicazioni si focalizzano sulle concentrazioni di composti organici, metalli e altri elementi nel suolo e nell'acqua di percolazione in correlazione alle emissioni non di scarico.
I n definitiva, le TRWP sono state rilevate nei compartimenti acquatici, nell'aria ambiente, nella polvere stradale e nel suolo, con l'osservazione che gli studi condotti con marcatori chimici (zinco, NCBA ed 24MoBT) sono meno affidabili rispetto a quelli che applicano metodi termoanalitici. Considerando tutti gli studi fatti, il contributo dell'usura degli pneumatici al PM10 è risultato essere all'incirca l'11% in massa, la concentrazione assoluta più elevata nell'aria ambiente è stata 3,4 µm/ m3 (senza il contributo in massa dell'usura della strada) e per i suoli in prossimità delle strade la stima è stata fra 0,4 e 158 µg/g dw.
SITUAZIONE ATTUALE
E PROSPETTIVE FUTURE
Le emissioni annuali, generate dall’usura degli pneumatici sulle strade, sono state stimate per molti paesi, ma
TRWP generated on roads is deposited in the soil near roads, 12-20% is released into surface water and only a small amount (2.3%) spreads into agricultural areas.
A s data on soil degradation are scarce, it is currently unclear whether and how the particles will accumulate in the long term. Furthermore, little is known about the behaviour of TRWPs in rivers with regard to sedimentation, further fragmentation, degradation and transport, and it appears that only 2% may reach the sea. Finally, it is debatable whether the results for MPs are transferable to the behaviour of TRWPs in rivers, due to the different densities, shapes and other properties of the particles, bearing in mind that results for individual river basins are not generally applicable to other surface waters with different hydrological conditions.
M
A
T he first monitoring studies on TRWPs in the environment were conducted in the 1970s, with findings of their presence in the air, road dust, soil, snow, road runoff, wastewater treatment systems, river water and sediments. This environmental monitoring is hampered by analytical problems, because the particles cannot be analysed using FTIR or Raman spectroscopy, as tyre treads and TRWPs have a complex chemical composition and TRWPs are difficult to separate from environmental matrices: this makes it necessary to use markers, i.e. chemical compounds contained as additives in tread materials in sufficiently high concentrations. For this purpose, a reliable marker must be specific to the tyre polymer, be present in comparable concentrations, preferably independent of tyre brands, not be easily washed away or transformed under environmental conditions and, finally, be easily and accurately detectable. Z inc has very often been

spesso non è chiaro se i fattori di emissione applicati riflettono la situazione reale per quanto riguarda i materiali del battistrada degli pneumatici e le condizioni del manto stradale.
N ella realtà le concentrazioni di usura degli pneumatici, raccolte da diversi studi di monitoraggio, mostrano concentrazioni altamente variabili nel deflusso e nella polvere stradali, nei terreni lungo le strade, nei sedimenti fluviali e nell’acqua dei fiumi. Le concentrazioni più elevate sono state riscontrate nella polvere dei tunnel (max 204 mg/g) e nei sedimenti di un bacino di trattamento per il deflusso stradale (max 150 mg/g), con le concentrazioni di usura degli pneumatici nel deflusso stradale che variano da 5 a 92 mg/g e nel suolo da 0,2 a circa 160 mg/g. Purtroppo si riscontra la mancanza di dati specifici per tutte le situazioni affrontate, soprattutto riguardo al monitoraggio ambientale, che comporta la necessità di una raccolta di campioni ripetu-
ta per periodi più lunghi per studiare le concentrazioni ambientali. Nonostante la certezza che ogni anno vengono emesse nell’ambiente enormi quantità di TRWP, fino a ora non è stata chiara la portata degli effetti ecotossicologici, probabilmente perché la maggior parte degli studi sono stati condotti con particelle di usura degli pneumatici prodotte artificialmente, che differiscono dalle particelle reali. Inoltre, non sono attualmente chiariti nemmeno i rischi per la salute, dovuti all’esposizione attraverso la catena alimentare.
O ccorre quindi colmare le lacune esistenti in materia di conoscenze con ulteriori ricerche, in merito ai fattori di emissione, ai metodi analitici, al monitoraggio sul campo, soprattutto con l’uso di modelli per la stima di trasporto, degradazione e ritenzione delle TRWP in fiumi e suoli, e all’esecuzione di studi ecotossicologici con campioni ambientali.
I n contemporanea si possono attuare misure di mitigazione dei fenomeni esposti nello studio, provvedendo a migliorare i sistemi di trattamento delle acque di deflusso, a incenerire i fanghi di depurazione, a migliorare la manutenzione delle strade e ottimizzare il manto stradale, a promuovere veicoli più leggeri e ottimizzare i materiali degli pneumatici per una loro maggiore durata e resistenza all’usura.
Questo articolo è una rielaborazione del testo originale, pubblicato in inglese da Elsevier Science of the Total Environment 2020.137823 col titolo “Tyre and road wear particles (TRWP) - A review of generation, properties, emissions, human health risk, ecotoxicity and fate in the environment” e firmato da Beate Baensch-Baltruschat, Federal Institute of Hydrology, Koblenz, Germany / This article is a reworking of the original text, published in English by Elsevier Materials Today with the title “Tyre and road wear particles (TRWP) - A review of generation, properties, emissions, human health risk, ecotoxicity and fate in the environment” and signed by Beate Baensch-Baltruschat, Federal Institute of Hydrology, Koblenz, Germany. u
chosen as a marker, even though it is not considered very specific to tyre wear in general, as it is also emitted from other traffic-related sources, such as de-icing salts, road barriers, galvanised metal in cars, brake wear and road markings. However, based on analyses of its concentration in the treads of various different tyres and comparisons with zinc present in natural soils, it is considered at least a significant indicator of TRWPs in soil or sediment samples taken near road emissions and in the absence of other relevant sources.
O ther markers often used are benzothiazoles, such as 24MoBT and NCBA, both components of accelerators used in tyre formulations, which, however, can separate due to leaching. While the presence of zinc and benzothiazole markers does not constitute definitive proof of the presence of tyre rubber particles, their absence is a strong indication of the absence of TRWPs in the environmental compartment in question. Therefore, to date, no compound appears to meet all the requirements to be considered a reliable indicator. An alternative to the markers described are thermoanalytical methods, which allow the detection of rubber degradation products by pyrolysis or thermal extraction desorption.
A nalyses using rubber additives or thermal decomposition products as markers provide results relating to the mass concentrations of tyre wear, so it seems sensible to report the results of monitoring studies in terms of tyre wear.
To date, some studies have been conducted to analyse the quantification of tyre wear concentrations in aquatic compartments: for example, analyses of 24MoBT and other benzothiazoles have been carried out in the Pearl River Delta in China, while in
Germany, the TED method of thermal extraction with desorption, combined with GC-MS, has been applied on samples from a road runoff water treatment system on a motorway, including sampling in the inflow channel and sludge from the sedimentation basin, to analyse tyre wear and thermoplastic MPs. As for marine compartments, studies are available on coastal sediments in San Francisco Bay and in an uncontaminated lagoon. There are more studies on ambient air near roads, both in large cities and near motorways, sometimes using markers (zinc, NCBA and hydrogenated resin acids) and, in the case of greater geographical coverage, examining 17 sites in Los Angeles, London and Tokyo.
In some cases, statistical models have been used to determine the contribution to PM from different sources, including tyre wear, while a third option for investigating tyre wear in PM is to analyse individual airborne particles using electron or optical microscopy combined with energy dispersive X-ray spectroscopy or mass spectroscopy. Studies to this effect have been conducted on the streets of London and Barcelona, in western Germany along the edge of a busy road and at a city station, as well as near two motorways. Ambient air monitoring studies provide data on the contribution of tyre wear to particulate matter, especially PM10, which provides information on its relevance as a source of traffic-related pollution. S tudies on the presence of TRWPs in soil are rather scarce, and most publications focus on the concentrations of organic compounds, metals, and other elements in soil and leachate in relation to non-exhaust emissions.
U ltimately, TRWPs have been detected in aquatic compartments, ambient air, road dust and soil, with the observation that studies conducted with chemical markers (zinc, NCBA and 24MoBT) are less reliable than those applying thermoanalytical methods. Considering all the studies conduct -
ed, the contribution of tyre wear to PM10 was found to be approximately 11% by mass, the highest absolute concentration in ambient air was 3,4 µm/m3 (without the mass contribution of road wear) and for soils near roads the estimate was between 0.4 and 158 µg/g dw.
A nnual emissions from tyre wear on roads have been estimated for many countries, but it is often unclear whether the emission factors applied reflect the actual situation with regard to tyre tread materials and road surface conditions.
In reality, tyre wear concentrations, collected from various monitoring studies, show highly variable concentrations in road runoff and dust, in soils along roads, in river sediments and in river water. The highest concentrations were found in tunnel dust (max 204 mg/g) and in sediments from a road runoff treatment basin (max 150 mg/g), with tyre wear concentrations in road runoff ranging from 5 to 92 mg/g and in soil from 0.2 to approximately 160 mg/g. Unfortunately, there is a lack of specific data for all the situations addressed,
especially with regard to environmental monitoring, which requires repeated sampling over longer periods to study environmental concentrations.
D espite the certainty that enormous quantities of TRWP are emitted into the environment every year, the extent of the ecotoxicological effects has not been clear until now, probably because most studies have been conducted with artificially produced tyre wear particles, which differ from real particles. Furthermore, the health risks due to exposure through the food chain are also currently unclear.
I t is therefore necessary to fill the existing knowledge gaps with further research on emission factors, analytical methods, field monitoring, especially using models to estimate the transport, degradation and retention of TRWPs in rivers and soils, and the performance of ecotoxicological studies with environmental samples.
At the same time, measures can be implemented to mitigate the phenomena described in the study, by improving runoff water treatment systems, incinerating sewage sludge, improving road maintenance and optimising road surfaces, promoting lighter vehicles and optimising tyre materials for greater durability and wear resistance. u

per l’uomo attraverso la catena alimentare / Potential risk of microplastics for human through food chain - Immagine tratta da: / Source: “Microplastics Pollution: A Silent Killer that Leads to the Next Global Environmental Disaster”, di/by Koongolla, Bimali - https://www.researchgate. net/publication/372787652_VIDUE_38_4_6_19.









Oggi il mercato è fiorente con prodotti sostenibili, ognuno dei quali promette di essere migliore rispetto alla concorrenza. Eppure, le informazioni sul loro impatto ambientale non sono disponibili al pubblico. Se tutti sono bravi come dicono, come si può distinguere una soluzione affidabile da una trovata di marketing?
La valutazione dell’impatto ambientale fornisce la conoscenza sulla sostenibilità di un’attività, dalle emissioni di gas serra all’impatto sugli ecosistemi. Ma la conoscenza non è la stessa cosa che l’intelligenza; l'intelligenza non è solo informazione ma anche il modo in cui questa viene coordinata e utilizzata. Conoscendo l’impatto, possiamo prendere decisioni che ci consentono di creare soluzioni meno inquinanti.
Il trattamento a spruzzo CSI NP18 riduce il coefficiente di attrito dei componenti in gomma senza utilizzo di PFAS nella sua composizione. Le sbavatrici meccaniche di C.S.I. operano alla pari di quelle criogeniche, evitando l’impatto ambientale dell’azoto liquido, oltre a ridurre i costi operativi. Internalizzando lo sviluppo delle formulazioni, il R&D e la produzione in loco vicino al lago d'Iseo contribuisce a ridurre l'inquinamento derivante dalla logistica. C on l’entrata in vigore di CSRD e CSDDD, il settore deve affrontare nuove sfide alla luce delle nuove direttive. Ecco perché C.S.I. ha deciso di accompagnare ogni ordine con informazione su totale di kgCO2eq generati nell'elaborazione. La trasparenza evita al cliente il grattacapo della rendicontazione delle emissioni Scope 3 e facilita la conformità con le normative imminenti u

C.S.I. CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI


The market is thriving with various sustainable products, each one promising to be better for the environment than competitors. And yet information about their environmental impact is not publicly available. If everyone is as good as they say they are, how can one distinguish a reliable solution from the marketing gimmick?
E valuating the environmental impact provides knowledge on the sustainability of a product, from greenhouse gas emissions to impact on ecosystems. But knowing is not the same as being
smart; intelligence is not information alone but also the manner in which i t is coordinated and used. Knowing the impact of our operations, we take decisions that allow us to develop better, less polluting solutions.
C SI NP18 liquid spray coating reduces friction coefficient of rubber components without any PFAS in its composition.
C .S.I.’s mechanical deflashing machines operate on par with cryogenic ones, while evading the environmental impact connected to the production and logistics of liquid nitrogen, as well as reducing operational costs. Internal -
ized coating development, R&D laboratory, and production on-site near Lake Iseo in Italy helps to reduce pollution from logistics.
W ith CSRD and CSDDD entering into force, rubber sector has to face new challenges in the light of new directives. That’s why C.S.I. has decided to accompany every order with information on how much kgCO2eq has been generated during the elaboration. A more transparent value chain saves the client a headache of evaluation and reporting of Scope 3 emissions and eases the due diligence and compliance with the upcoming legislations. u
Coating Technology ritiene che l’innovazione debba andare di pari passo con la sostenibilità. Da anni si dedica allo sviluppo di trattamenti superficiali pensati per migliorare le prestazioni delle guarnizioni in gomma, riducendo l’attrito (low-friction) e garantendo al tempo stesso elevati standard di cleanliness. La certificazione ISO 14001 conferma l’impegno verso un’industria sempre più sostenibile.
I trattamenti al plasma con deposito di HMDSO rappresentano una tecnologia pulita e a basso impatto ambientale, capace di migliorare l’adesione e la scorrevolezza senza l’utilizzo di sostanze critiche.
Coating Technology ha inoltre sviluppato e brevettato il Revol-Sil, un trattamento innovativo che non prevede alcun tipo di coating ma modifica direttamente la superficie del silicone, rendendola antistatica e a bassissimo coefficiente d’attrito. È una soluzione ideale per applicazioni dove la scorrevolezza e la pulizia superficiale sono fondamentali.
Negli ultimi anni ha ampliato la gamma di trattamenti completamente PFAS free, fino a introdurre anche un coating colorato PFAS free, che unisce estetica, performance e sostenibilità.
I n vista del trasferimento nella nuova sede, previsto per l’inizio del 2026, Coating Technology ha potenziato il parco macchine con impianti di nuova generazione a basso consumo energetico, confermando l’impegno verso una produzione sempre più responsabile e orientata al futuro. u


At Coating Technology, it is believed that innovation must go hand in hand with sustainability. For years, the company has been developing surface treatments designed to enhance the performance of rubber seals by reducing friction (low-friction) while ensuring high levels of cleanliness.
I ts ISO 14001 certification confirms the commitment to an increasingly sustainable industry.
I ts plasma treatments with HMDSO deposition are clean, low-impact technologies that improve adhesion and surface smoothness without the use of environmentally critical substances. T he company has also developed and patented Revol-Sil, an innovative process that requires no coating at all. It modifies the silicone surface itself, making it antistatic and extremely low-friction - the ideal solution for applications where surface cleanliness and smooth movement are essential.
I n recent years, it has expanded its range of completely PFAS-free treatments, including the introduction of a colored PFAS-free coating that combines performance, sustainability, and design.
A head of its relocation to the new headquarters, planned for early 2026, Coating Technology has upgraded its machinery with next-generation, energy-efficient equipment, reaffirming its commitment to a more responsible and sustainable production model. u
Con 140 anni di storia e una reputazione internazionale nella progettazione e costruzione di impianti per la lavorazione della gomma e delle materie plastiche, Comerio Ercole si conferma protagonista della nuova frontiera dell’economia circolare.
L’azienda di Busto Arsizio, in partnership con Rubber Conversion, ha infatti sviluppato LOGOS®, il primo impianto compatto di de-vulcanizzazione industriale capace di trasformare gli scarti vulcanizzati in mescole di gomma nuovamente utilizzabili.
L a tecnologia LOGOS®, frutto della combinazione tra il know-how impiantistico di Comerio Ercole e il processo chimico brevettato di Rubber Conversion, rappresenta una soluzione scalabile, sostenibile e pienamente integrabile nei siti produttivi di pneumatici o articoli tecnici in gomma (es. suole, pavimenti, etc).
Attraverso un processo meccano-chimico a bassa temperatura, privo di sostanze tossiche e a ridotto impatto energetico, gli scarti di produzione vengono rigenerati in mescole di alta qualità, idonee a essere reintrodotte nei cicli industriali fino al 100%.
I n qualità di partner industriale globale, Comerio Ercole cura la progettazione, la realizzazione e la distribuzione degli impianti LOGOS®, offrendo al mercato la solidità di un gruppo che da
sempre coniuga precisione meccanica e innovazione. Il processo, completamente automatizzato e tracciabile, si distingue per efficienza, ripetibilità e flessibilità operativa, rispondendo alle esigenze di un’industria della gomma sempre più attenta alla sostenibilità e alla sicurezza.
LOGOS® è disponibile in versioni modulari (400, 700 e 1.000 kg/h) ed è pensato per essere installato direttamente presso i produttori di pneumatici e articoli in gomma, permettendo la valorizzazione in situ degli scarti e riducendo
drasticamente i costi logistici e la carbon footprint. Questa collaborazione tra Comerio Ercole e Rubber Conversion segna un punto di svolta: unisce l’esperienza meccanica di un costruttore storico con la visione innovativa di una PMI, aprendo la strada a un nuovo paradigma industriale dove la gomma non è più un rifiuto, ma una risorsa rigenerabile. LOGOS® non è soltanto una tecnologia, ma il simbolo tangibile di una transizione concreta verso una produzione circolare, competitiva e sostenibile. u

COMERIO ERCOLE

With 140 years of history and an international reputation in the design and manufacturing of machinery for rubber and plastics processing, Comerio Ercole stands as a key player in the new frontier of the circular economy. The Busto Arsizio-based company, in partnership with Rubber Conversion, has developed LOGOS®, the first compact industrial devulcanization plant capable of transforming vulcanized waste into reusable rubber compounds.
T he LOGOS® technology - the result of Comerio Ercole’s engineering expertise combined with Rubber Conversion’s patented chemical processrepresents a scalable, sustainable, and fully integrable solution for tire and
rubber product manufacturing sites (e.g., soles, flooring, and other technical items).
T hrough a low-temperature mechano-chemical process, free from toxic substances and with minimal energy impact, production waste is regenerated into high-quality compounds that can be reintroduced into industrial cycles up to 100%.
A s a global industrial partner, Comerio Ercole oversees the design, construction, and worldwide distribution of LOGOS® plants, offering the market the reliability of a company that has always combined mechanical precision with technological innovation. The process, fully automated and traceable, stands out for its efficiency, consistency, and operational flexibility, addressing the growing demand for safety and sus -
tainability within the rubber industry.
A vailable in modular versions (400, 700, and 1,000 kg/h), LOGOS® is designed to be installed directly within tire or rubber manufacturing facilities, enabling on-site recovery of production scraps and significantly reducing logistics costs and carbon footprint.
T his partnership between Comerio Ercole and Rubber Conversion marks a true turning point: it unites the mechanical mastery of a historic manufacturer with the innovative vision of a modern tech SME, paving the way for a new industrial paradigm where rubber is no longer waste but a renewable resource.
LOGOS® is not just a technology - it is the tangible symbol of a concrete transition toward a circular, competitive, and sustainable production model. u


Elastomers Union produce mescole in FKM dal 2009. Grazie al suo network, l’azienda può soddisfare le richieste della clientela offrendo mescole con le caratteristiche tecniche più idonee alle applicazioni finali, partendo sin dalla polimerizzazione e con il minimo impatto ambientale possibile.
L a collaborazione costante e diretta con il produttore di materie prime per-
mette a Elastomers Union di rispondere anche alle esigenze più specifiche, che richiedono polimeri tailor-made. U n continuo investimento sia in macchinari sempre più interconnessi, sia in risorse umane giovani, qualificate e motivate, rappresenta la strategia vincente che consente all’azienda di restare al passo con i tempi. Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla ricerca e sviluppo, per garantire la massima qualità. O ggi Elastomers
ELASTOMERS UNION
Union, oltre alle mescole in FKM (bisfenoliche e perossidiche), produce: mescole in FFKM, che grazie alla loro eccezionale resistenza chimica e termica sono impiegate in contesti altamente critici, dove materiali standard non garantirebbero affidabilità; mescole in FMQ, ideali per applicazioni che richiedono elasticità a basse temperature e resistenza a carburanti e oli. Tutte le mescole prodotte rispondono ai principali capitolati di riferimento. u


Elastomers Union has been producing FKM compounds since 2009. Thanks to its network, the company can meet customer demands by offering compounds with the most suitable technical characteristics for final applications, starting from polymerization and with minimal environmental impact. C ontinuous and direct collaboration with the raw material producer en -
ables Elastomers Union to meet even the most specific requirements, which demand tailor-made polymers. A constant investment in increasingly interconnected machinery, as well as in young, qualified and motivated human resources, represents the winning strategy that allows the company to keep pace with the times. Particular attention is also dedicated to research and development in order to ensure maximum quality. Today, in addition
to FKM compounds (bisphenolic and peroxide cured), Elastomers Union produces: FFKM compounds, which thanks to their exceptional chemical and thermal resistance are used in highly critical environments where standard materials would not be reliable; FMQ compounds, ideal for applications requiring elasticity at low temperatures and resistance to fuels and oils. A ll produced compounds meet the main reference specifications. u
Quando pressa a iniezione, stampo, automazione e ausiliari dialogano in modo perfetto all’interno di un unico sistema, l’efficienza non è più un obiettivo da raggiungere, ma una caratteristica intrinseca del processo produttivo. È su questa visione che Engel costruisce le proprie soluzioni, integrando ogni componente nell’unità di controllo CC300 delle proprie macchine. L’impianto completamente automatizzato per lo stampaggio di guarnizioni in LSR su strati di diffusione del gas (GDL) per fuel cell – recentemente presentato al K 2025 – ne è un caso esemplare.
Cuore della soluzione, compatta e affidabile, è una pressa a iniezione verticale Engel insert 150, con forza di chiusura di 1.500 kN e tavola rotante integrata. Questa configurazione consente di effettuare simultaneamente l’iniezione e l’estrazione dei pezzi stampati, raddoppiando di fatto la produttività con un tempo ciclo di 50 secondi. La produzione è affidata a un innovativo stampo a 2 cavità sviluppato da ACH Solution, mentre la movimentazione dei componenti è gestita da un robot antropomorfo Engel easix, che coordina con precisione i movimenti della macchina e dell’automazione.
Nella prima fase, il robot preleva i film GDL e li posiziona nella prima stazione dello stampo a tavola rotante. Dopo

la rotazione, nella seconda stazione ha luogo il processo di iniezione, durante il quale i film vengono parzialmente sovrastampati con una guarnizione in LSR, sottile e ad alta precisione, posizionata con estrema accuratezza. In parallelo, nella prima stazione, vengono rimossi i pezzi stampati e quindi inseriti i nuovi film. Un sistema di supervisione integrato verifica l’uniformità dello spessore della guarnizione in LSR garantendo così la massima qualità del componente.
La precisione del processo è assicurata anche dall’assistente digitale iQ weight control, che ottimizza il volume di iniezione in modo da mantenere costante
il peso delle parti stampate. In questo modo la guarnizione viene applicata in modo uniforme, evitando sovrastampaggio o vuoti che potrebbero compromettere la capacità di diffusione del gas.
Oltre all’elevata precisione, le presse a iniezione verticali della serie Engel insert offrono il vantaggio di un design estremamente compatto. Il quadro elettrico è integrato direttamente nella macchina, riducendo in modo significativo l’ingombro complessivo della cella: un vantaggio determinante quando la produzione automatizzata deve essere implementata in spazi ristretti. u

When the injection moulding machine, mould, automation, and ancillary equipment communicate seamlessly within a single integrated system, efficiency is no longer a goal to be achieved: it becomes an inherent feature of the production process. This is the leading principle behind Engel’s approach to system design, where every component is integrated into the machine’s CC300 control unit. A fully automated production cell for moulding LSR gaskets onto gas diffusion layers (GDL) for fuel cellsrecently unveiled ahead of K 2025 - perfectly embodies this philosophy. The core element of this compact and process-reliable complete solution is a vertical Engel insert 150 injection moulding machine with 1,500 kN clamping force
and an integrated rotary table. This setup enables simultaneous injection and demoulding, nearly doubling the output with a cycle time of 50 seconds. Moulding is carried out by the innovative 2-cavity mould concept from ACH Solution, while a fully integrated Engel easix articulated robot handles part manipulation, coordinating machine and automation movements with precision. In the first step, it removes the delicate GDL films from the feeding system and positions them precisely in the front station of the rotary table mould. After rotation, the injection process takes place in the rear station, where the films are partially overmoulded with a precisely positioned, thin and highly accurate LSR seal. At the same time, finished parts are removed from the front station and new films are inserted. An integrated camera inspection system then
verifies the even wall thickness distribution of the LSR seal, ensuring the highest part quality.
Thanks to volume regulation using Engel’s digital assistance system iQ weight control, the accuracy of the injection moulding process is further enhanced, and the part weight remains reliably constant. This guarantees the uniform application of the gasket, preventing overmoulding or voids that could impair gas diffusion performance.
In addition to its high precision, the vertical machine concept of the Engel insert series offers the advantage of a very compact design. The control cabinet is integrated directly into the machine, significantly reducing the footprint of the entire cell: a key benefit when automated production must be implemented in confined spaces. u
Alex Bonacini, R&D laboratory specialist
In linea con la trasformazione globale verso un’industria più moderna e sostenibile, in Eurorubber è stato intrapreso un percorso di transizione “green” che ha inizio dal calcolo della carbon footprint di prodotto. Il calcolo della CO2 generata dai processi produttivi, condotto secondo la norma ISO 14067, consente di monitorare direttamente le principali criticità e di progettare strategie di sviluppo orientate alla riduzione dell’impronta ambientale delle mescole. L’azienda crede fortemente nel principio dell’economia circolare “from cradle to cradle” e, per metterlo in pratica, promuove l’utilizzo di polverini e gomma rigenerata, ormai ampiamente utilizzati nelle sue formulazioni. Inoltre, sono stati avviati nuovi progetti volti a incrementare l’impiego di materiali devulcanizzati, contribuendo così a chiudere il


ciclo produttivo in modo sempre più sostenibile. Con l’obiettivo di raggiungere la neutralità energetica, Eurorubber si è dotata di un impianto fotovoltaico da 1 MWp, che copre attualmente tra il 15 e il 20% del fabbisogno energetico aziendale, mentre gran parte del restante consumo proviene da energia elettrica certificata con Garanzia di Origine da fonti rinnovabili. Parallelamente, l’azienda si impegna a ridurre i consumi energetici complessivi ottimizzando i processi e prediligendo quando possibile la lavorazione delle mescole in unica fase. È previsto che questi sforzi verranno riconosciuti entro fine 2025 con l’ottenimento della certificazione ISO 50001. u

In line with the global shift towards a more modern and sustainable industry, Eurorubber has embarked on a “green” transition journey that begins with calculating the carbon footprint of its products. Calculating the CO2 generated by its production processes, conducted in accordance with ISO 14067, allows the company to directly monitor the main critical issues and design development strategies aimed at reducing the environmental footprint of
its compounds. T he company strongly believes in the principle of the “cradle to cradle” circular economy and, to put it into practice, promotes the use of rubber powder and regenerated rubber, which are now widely used in its formulations. In addition, new projects have been launched to increase the use of devulcanised materials, thus helping to close the production cycle in an increasingly sustainable way.
With the aim of achieving energy neutrality, Eurorubber has installed a 1
MWp photovoltaic system, which currently covers between 15 and 20% of its energy needs, while most of the remaining consumption comes from electricity certified with a Guarantee of Origin from renewable sources. At the same time, the company is committed to reducing its overall energy requirements by optimising processes and, where possible, favouring single-stage compound processing. Its efforts are expected to be recognised by the end of 2025 with the achievement of ISO 50001 certification. u

CM Manzoni, che quest’anno celebra i suoi 60 anni di storia, è ancora oggi un’azienda a conduzione familiare, ma con una visione ormai globale. Con 8 stabilimenti nel mondo, continua a investire e a guardare al futuro. Dai siti storici di Fusignano e Ravenna, l’azienda ha esteso la propria presenza internazionale grazie alla partnership con LTE per la produzione di silicone e FKM, con stabilimenti in India, Messico e Italia, e dal 2022 con Eflaya, specializzata nella produzione di compound termoplastici, in particolare TPE-S e TPE-V.
Completano il quadro gli stabilimenti di Evercompounds, presenti sia in Italia che negli Stati Uniti. Proprio Evercompounds, nel corso degli anni, ha sviluppato una solida esperienza nella produzione di compound ignifughi destinati ai settori dei cavi, ferroviario e dell’edilizia. Le soluzioni più recenti puntano a migliorare la processabilità dei compound ritardanti di fiamma, eliminando l’uso di additivi tradizionali come alogeni e antimonio, a favore di polimeri halogen-free come EVA ed EPDM.
La gamma di prodotti recentemente sviluppata, adatta al settore ferroviario, è stata studiata per garantire un basso sviluppo di fumi ‘’non corrosivi’’, senza compromettere le prestazioni meccaniche. Nel restyling formulativo l’azienda si è focalizzata principalmente sulla processabilità, consentendo di ottenere guarnizioni estruse, vulcanizzate in aria calda, UHF e sali fusi con un'ottima stabilità di forma, in conformità alla norma ferroviaria europea

UNI EN 45545 - HL3 R22-R23. Per quanto riguarda il settore dei cavi, le richieste di mercato hanno spinto verso la sostituzione dei composti alogenati e dell’antimonio, o più in generale dei metalli pesanti, per approdare verso l’utilizzo di cariche minerali.
Questo ha generato lo studio e lo sviluppo di una gamma di materiali per la creazione di cavi, con diversi gradi di resistenza alla fiamma, secondo standard di riferimento che variano in base al campo di applicazione del cavo stesso.
Si parte dai materiali per guaina più comuni, impiegati in cavi per servizio ordinario secondo standard CEI 50363 dove viene richiesta semplicemente una non propagazione alla fiamma, passando attraverso la formulazione di compounds
per la costruzioni di cavi utilizzati nella creazione di impianti elettrici navali o per installazioni offshore secondo standard di riferimento IEC 60092-359 e NEK TS 606, dove a parte il maggiore potere autoestinguente, viene richiesta la completa assenza di alogeni e un basso sviluppo di fumi e relativa tossicità.
La gamma di prodotti recentemente sviluppata culmina poi in compounds sia di isolamento che di guaina secondo standard CEI 20-11 impiegati nella produzione di cavi che rispettino il regolamento per prodotti da costruzione (CPR), dove, a seconda della classe di appartenenza del cavo in oggetto, vengono richiesti valori sempre più elevati di resistenza al fuoco, mancanza di fumi acidi, e gocciolamento. u

Celebrating it s 60th anniversary this year, CM Manzoni still remains a family-owned company, but now with a global vision. With 8 production sites worldwide, the company continues to invest and look towards the future. Starting from its historic sites in Fusignano and Ravenna (Italy), CM Manzoni has expanded internationally through partnerships such as the one with LTE - for silicone and FKM production, with plants in India, Mexico, and Italy, and, since 2022, with the company EFLAYA - specialized in the production of thermoplastic compounds, particularly TPE-S and TPE-V. The group is further strengthened by Evercompounds, with manufacturing sites located in both Italy and the United States.
Over the years, Evercompounds has indeed gained strong expertise in the development of flame-retardant compounds for the cable, railway, and construction industries.
The latest solutions focus on improving the processability of flame-retardant compounds, by eliminating traditional flame retardants additives, such as halogens and antimony, and instead using halogen-free polymers like EVA and EPDM.
The newly developed product range, designed for the railway sector, was engineered to ensure low emissions of non-corrosive fumes without compromising mechanical performance. In the reformulation process, the main focus was on processability, enabling the

production of extruded gaskets cured with hot air, UHF, or salt bath, while maintaining excellent shape stability, in compliance with the European railway standard UNI EN 45545 - HL3 R22-R23. A s for the cable industry, market demands have pushed towards the replacement of halogenated compounds and antimony, or more generally heavy metals, in favour of mineral fillers. This led to the research and development of a range of materials for cable production, with varying levels of flame resistance depending on the specific cable application and relevant standards. The product range starts with common sheathing materials used in general-purpose cables, compliant with CEI 50363, where only flame non-propagation is required. It then includes compounds formulated for cables used in nautical electrical systems or offshore installations, according to the IEC 60092-359 and NEK TS 606 standards, where - besides improved self-extinguishing propertiescomplete halogen-free composition and low smoke and toxicity are essential. The most recently developed products also proudly include both insulation and sheathing compounds in accordance with CEI 20-11 standards, suitable for cables that must comply with the Construction Products Regulation (CPR). According to this Regulation, depending on the required classification of the specific cable, increasingly stringent requirements must be met in terms of fire resistance, low emission or absence of corrosive gases, and reduced dripping. u
G3 Mixing Technologies a oggi è riconosciuto tra i leader di mercato per la vendita di macchinari (nuovi e ricostruiti) per la lavorazione della gomma, quali mescolatori interni tangenziali e compenetranti e mescolatori a cilindri (in entrambi i casi sia da laboratorio che da produzione). In circa 20 anni di attività l’azienda ha ricostruito più di 300 macchinari per l’industria della gomma, processando più di 100 tipologie di differenti macchine ed è in grado di effettuare interventi di manutenzione/ispezione e fornire ricambi/ausiliari delle proprie macchine e di quelle di altri produttori.
Tra le soluzioni più all’avanguardia di G3, un focus va fatto sul nuovo gruppo tramoggia con pressatore idraulico tipo HHR-PF (Powder Free). Il gruppo tramoggia con pressatore idraulico G3 tipo HHR-PF ha la caratteristica principale di avere dimensioni compatte in modo da agevolare il montaggio anche su impianti esistenti e in spazi ridotti. Il gruppo è ingegnerizzato per avere ridotta manutenzione ordinaria e un migliore accesso ai componenti principali sia nella parte inferiore (tramoggia di carico) che in quella superiore (pressatore idraulico).
I l gruppo tramoggia con pressatore idraulico da test effettuati in linea di produzione risulta essere uno dei sistemi più performanti sul mercato e più efficiente in termini di tenuta delle polveri sulla porta di carico e sull’asta del peso. I noltre, tra i vantaggi che si possono riscontrare paragonandolo con un gruppo pressatore pneumatico, c’è sicuramente una maggiore ed efficiente pressione sul compound con relativo miglior controllo della posizione del peso pressatore.
I n termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, in aggiunta, eliminando il sistema di alimentazione ad aria si ottiene un aumento dell’affidabilità in termini di ripetibilità del processo che unito a una significativa riduzione delle spese dell’impianto danno come risultato finale un risparmio energetico complessivo fino al 20%. u


G3 Mixing Technologies today is recognised as one of the market leaders in the sale of (new and rebuilt) rubber processing machinery, such as internal tangential and intermeshing mixers and open mills (both laboratory and production). In about 20 years of ac -
tivity, the company has rebuilt more than 300 machines for the rubber industry, processing more than 100 different types of machines, and they are able to carry out maintenance/ inspection and supply spare parts/ auxiliaries for their machines and those of other manufacturers.
A mong the most cutting-edge solu -
tions, a focus should definitely be on the new hopper unit with hydraulic ram HHR-PF type (Powder Free). The main feature of the G3 HHR-PF hopper unit with hydraulic ram is that it is compact in size, making it easy to install even on existing plants and in small spaces.
T he unit is engineered for low maintenance and improved access to the main components in both the lower part (loading hopper) and the upper part (hydraulic ram).
T he hopper unit with hydraulic ram has been proven by tests carried out on the production line to be one of the best performing systems on the market and the most efficient in terms of dust holding on the loading door and ram rod.
M oreover, among the advantages of comparing it with a pneumatic ram unit, there is a greater and more efficient pressure on the compound with relative better control of the position of the ram.
I n terms of energy efficiency and environmental sustainability, in addition, eliminating the air supply system results in an increase of reliability in terms of process repeatability, which combined with a significant reduction in plant expenditure results in overall energy savings of up to 20%. u
Gibitre Instruments continua il proprio percorso verso un modello di impresa sempre più sostenibile, investendo in tecnologie e processi che riducono l’impatto ambientale e migliorano l’efficienza complessiva delle proprie attività.
La sede aziendale è alimentata da un impianto fotovoltaico da 87 kW e dotata di isolamento termico ad alte prestazioni, che insieme all’illuminazione LED garantiscono un uso razionale dell’energia e un
comfort ottimale per il personale. La sostenibilità è anche parte integrante della produzione: gli strumenti Gibitre sono progettati per assicurare ergonomia, sicurezza e automazione delle operazioni, riducendo l’affaticamento degli operatori e l’inquinamento acustico. L’attenzione all’ambiente si riflette anche nelle apparecchiature per prove di invecchiamento, che richiedono quantità ridotte di prodotti chimici, e nei nuovi modelli di prova che ottimizzano le dimensioni dei provini, minimizzando l’uso di materiali.
Attraverso lo sviluppo di applicazioni dedicate, l’azienda supporta inoltre i clienti impegnati nel riciclo di prodotti in gomma e plastica, contribuendo all’economia circolare del settore.
G ibitre ha già completato una Gap Analysis ESG per definire le proprie priorità ambientali, sociali e di governance e punta entro il 2026 alla misurazione completa della carbon footprint di organizzazione, consolidando il proprio impegno verso una crescita responsabile e duratura. u
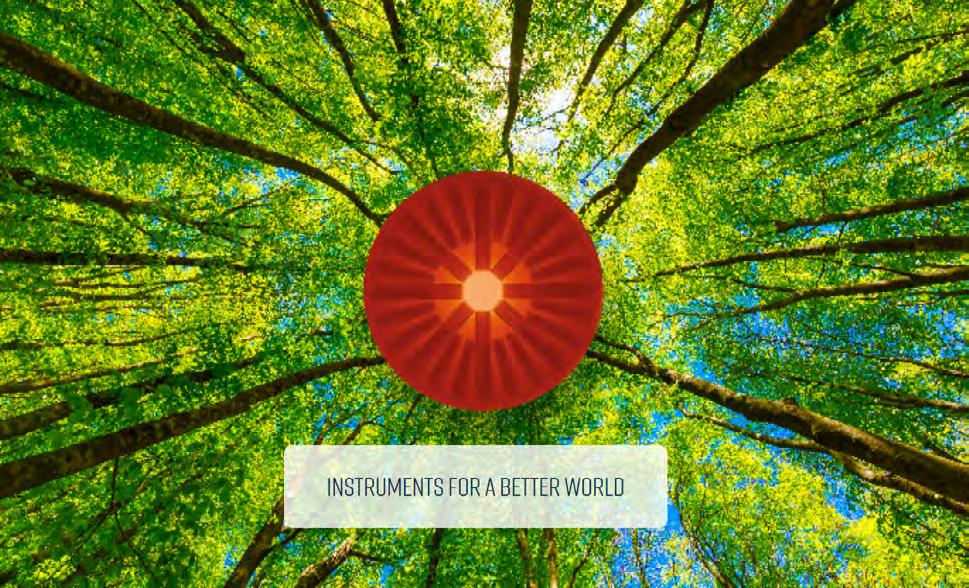

Gibitre Instruments continues its journey towards an increasingly sustainable business model, investing in technologies and processes that reduce environmental impact and improve the overall efficiency of its activities.
T he company headquarters is powered by an 87 kW photovoltaic system and equipped with high-performance thermal insulation, which, together with LED lighting, ensures rational energy
use and optimal comfort for staff.
S ustainability is also an integral part of production: Gibitre instruments are designed to ensure ergonomics, safety and automation of operatio ns, reducing operator fatigue and noise pollution.
T his focus on the environment is also reflected in the ageing test equipment, which requires reduced quantities of chemicals, and in the new test models that optimise the size of the test pieces, minimising the use of materials.
T hrough the development of dedicated applications, the company also supports customers engaged in the recycling of rubber and plastic products, contributing to the circular economy of the sector.
G ibitre has already completed an ESG Gap Anal ysis to define its environmental, social and governance priorities and aims to fully measure its organisational carbon footprint by 2026, consolidating its commitment to responsible and sustainable growth. u

Fon data nel 1953, Isopren è una storica PMI Italiana, oggi un punto di riferimento nella produzione di articoli tecnici in gomma per il B2B, con oltre 1.180 mescole proprietarie e più di 70.000 prodotti realizzati ogni anno. L’azienda unisce la tradizione di tre generazioni imprenditoriali alla spinta innovativa di giovani talenti e manager di esperienza per l’evoluzione verso una Managerial Family Company che si distingue per competenze, soluzioni customizzate e alte prestazioni. Consapevole delle sfide ambientali, Isopren ha ottenuto recentemente la certificazione ISO 14001 per l’ambiente, un traguardo che rappresenta il frutto di un lavoro strutturato di squadra, della dedizione dei suoi collaboratori e del desiderio costante dell’a-


zienda di migliorare. Isopren sta portando avanti iniziative concrete come l’Isopren Recycling Rubber Project - che reintroduce nel ciclo produttivo gomma devulcanizzata ricavata da scarti e prodotti a fine vita - e l’utilizzo di materie prime eco-sostenibili, con l’obiettivo di ridurre in modo significativo le emissioni di CO2 e favorire un modello industriale più circolare e rispettoso del pianeta.
A conferma della propria visione green, Isopren ha previsto, entro la fine del 2025, l’installazione di un impianto fotovoltaico, passo decisivo per ridurre l’impatto energetico e accelerare la transizione verso fonti rinnovabili.
Coniugando innovazione e responsabilità ambientale, Isopren dimostra come il successo imprenditoriale possa andare di pari passo con il rispetto per l’ambiente.u

Founded in 1953, Isopren is a le ading company in the production of technical rubber components for the B2B, with ov er 1.180 proprietary compounds and more than 70.000 items manufactured every yea r. The company combines three generations of entrepreneurs with the innovative drive of young talents and experienced managers, evolving into a Managerial Family Company distinguished by expertise, custom made solutions and high performance.
Aware of environmental challenges, Isopren has recently obtained the ISO 14001 certification for environment, an achievement that reflects the result of structured teamwork, the dedication of its employees and the company’s constant commitment to improvement.
Isopren is carrying out concrete initiatives such us the Isopren Recycling Rubber Project - which reintroduces, into the manufacturing cycles, devulcanized rubber obtained from production waste and end of life products - and the use of eco-sustain-
able raw materials, with the goal of significantly reducing CO₂ emissions and promoting a more circular and environmentally friendly industrial model.
As a confirmation of its green vision, Isopren has planned to install a photovoltaic system by the end of 2025 - a decisive step to reduce energy impact and accelerate the transition to renewable sources.
By combining innovation with environmental responsibility, Isopren demonstrates how business success can go hand in hand with respect for the environment. u
Le tecnologie di controllo e automazione evolvono ogni giorno, elevando le prestazioni e la tracciabilità degli impianti.
Su macchine nuove e revisionate, sensori e software aiutano a governare il processo, garantendo ripetibilità delle ricette, qualità costante e allarmi che riducono i fermi imprevisti, abilitando manutenzione predittiva sulla base dei dati raccolti. Il risultato sono scarti minori e un controllo dei costi più rigoroso, temi chiave per le aziende italiane.
Q uesti benefici, però, poggiano su una condizione irrinunciabile, la cura degli impianti. Anche la migliore tecnologia richiede basi meccaniche solide, per questo JP Tech promuove manutenzioni preventive programmate (MPP) e interventi di revisione che sostituiscono la componentistica obsoleta con soluzioni più efficienti, riducendo consumi e prolungando la vita utile delle linee produttive.
L a revisione è spesso la via più sostenibile rispetto alla costruzione di macchine completamente nuove, quando il “vecchio” può essere recuperato con criterio. Dove gli altri vedono usato, JP Tech vede il futuro. I n quest’ottica l’azienda progetta anche macchine “future-ready”, adattabili nel tempo. Un esempio è il raffreddatore per gomma, realizzato in gran parte con alluminio strutturale, facilmente recuperabile a fine vita. Le scelte per risparmiare e migliorare ogni giorno esistono, vanno affidate a chi investe davvero in affidabilità e circolarità. u


Control and automation technologies evolve daily, elevating plant performance and traceability.
On new and refurbished machines, sensors and software govern the process, ensure recipe repeatability and consistent quality, and trigger smart alerts that cut unplanned stops while enabling data driven predictive maintenance.
The result is lower scrap and tighter cost
control, both priorities for Italian manufacturers. These gains rest on a non-negotiable foundation, asset care. Even the best technology needs robust mechanics. That’s why JP Tech promotes Planned Preventive Maintenance (PPM) and overhaul programs that replace obsolete components with more efficient solutions, reducing energy use and extending the service life of production lines. O verhauling is often the most sustainable route versus building entirely new
machines when existing assets can be responsibly recovered. Where others see used equipment, JP Tech sees the future. With this in mind, the company also engineer future-ready machines, designed for easy adaptation over time. One example is the rubber cooler, built largely from structural aluminum and readily recoverable at end of life. The options to save and improve every day already exist - entrust them to those who truly invest in reliability and circularity. u
Uno dei pilastri dello sviluppo di Hexpol è promuovere la transizione verso mescole in gomma sempre più sostenibili per diventare il partner di fiducia per i clienti che puntano a ridurre le proprie emissioni. Da sempre pioniere nel settore, Hexpol è in grado di fornire i dati di Impronta di Carbonio del Prodotto (PCF) per tutte le mescole prodotte in Europa, utilizzando un metodo di calcolo interno certificato dal TÜV.
I dati disponibili mostrano che oltre l’85% delle emissioni associate alla produzione
di una mescola derivano, mediamente, dalle materie prime, mentre trasporto e mescolazione incidono solo in minima parte.
La strada principale da seguire per ridurre le emissioni è quindi sostituire le materie prime di origine fossile con alternative rinnovabili di origine biologica, circolari o bio-circolari.
Questa è l’idea alla base di Hexgreen®, una gamma di mescole in gomma personalizzate con almeno il 10% di materie prime sostenibili.
Insieme ai clienti, Hexpol seleziona le nuo-
ve alternative per garantire il rispetto dei requisiti prestazionali previsti. Le materie prime circolari e riciclate sono particolarmente efficaci, perché evitano lo smaltimento in discarica e assicurano una qualità affidabile.
Esempi concreti sono la gomma devulcanizzata ottenuta da scarti post-industriali e prodotti di pirolisi di pneumatici a fine vita (PFU). Il personale tecnico di Hexpol può adattare ricette esistenti o sviluppare nuovi compound Hexgreen® da zero, offrendo la consueta qualità con una minore impronta di carbonio. u


Hexpol’s mission is to be the preferred solution provider for sustainable rubber compounds. As one of the first compounders, Hexpol provides Product Carbon Footprint (PCF) data for its compounds produced in Europe, using an in-house TÜV certified calculator.
T he tool shows that more than 85% of emissions come from raw materials rather than transport or mixing. The
solution is clear: replacing fossil-based inputs with bio-based, circular or bio-circular alternatives reduces the footprint significantly.
T his is the idea behind Hexgreen®, a range of tailor-made rubber compounds with at least 10% of alternative raw materials, adjustable to higher shares.
Together with customers, Hexpol selects the right alternatives to ensure strict performance requirements are
met. Circular and recycled feedstocks are particularly valuable, as they prevent landfill and provide stable quality.
C oncrete examples are devulcanized rubber, obtained from post-industrial scraps as well as End of Life Tire (ETR) pyrolysis products.
H expol experts can adapt existing recipes or develop new Hexgreen® compounds from scratch, offering the renowned quality w ith a lower carbon footprint. u

Il 2025 segna per OR.P. Stampi un nuovo passo nel percorso verso una produzione sempre più digitale e sostenibile. Dopo gli importanti traguardi raggiunti nel campo della mobilità green e del silicone LSR, l’azienda amplia oggi il proprio impegno nella digitalizzazione dei processi di stampaggio e nel miglioramento dell’efficienza energetica delle attrezzature.
L’introduzione di sistemi di monitoraggio interconnessi permette ora di raccogliere dati in tempo reale su prestazioni, cicli e consumi degli stampi, fornendo ai clienti strumenti concreti per ottimizzare la produttività e ridurre l’impatto ambientale.
P arallelamente, il reparto R&D con -


OR.P. STAMPI
tinua a sviluppare nuove g enerazioni di Canali Freddi ad alta efficienza, pensate per rispondere alle esigenze di un mercato che richiede tempi di avvio rapidi, precisione costante e risparmio energetico.
L’approccio “green by design” è oggi parte integrante della filosofia aziendale: ogni progetto nasce con l’obiettivo di combinare qualità, affidabilità e sostenibilità, valorizzando il knowhow di un team che da 45 anni mette l’esperienza al servizio dell’innovazione.
Con lo sguardo rivolto alle sfide di Industry 5.0, OR.P. Stampi conferma la propria vocazione: fornire a chi stampa gomma e silicone tool intelligenti, performanti e pronti per il futuro. u

2025 marks a new step for OR.P. Stampi on its journey towards an increasingly digital and sustainable production. After major achievements in the green mobility and LSR silicone sectors, the company is now extending its commitment to digitalized moulding processes and enhanced energy efficiency of its equipment.
The introduction of interconnected mon-
itoring systems now allows real-time data collection on mould performance, cycles, and energy consumption, giving customers tangible tools to optimize productivity while reducing environmental impact.
At the same time, the R&D department continues to develop a new generation of high-efficiency Cold Runner Blocks, designed to meet the needs of a market that demands fast ramp-up, consistent
precision, and low energy use. The company’s “green by design” philosophy ensures that every project combines quality, reliability, and sustainability, leveraging 45 years of experience and technical excellence.
Looking ahead to the challenges of Industry 5.0, OR.P. Stampi reaffirms its mission: to provide rubber and silicone moulders with smart, high-performance tools ready for the future. u
La vera rivoluzione per la sostenibilità nell’industria della gomma inizia molto prima dell’ottimizzazione dei processi o del riciclo dei materiali: nasce dal macchinario, elemento sempre centrale nel processo di trasformazione.
P er Pezzato, sostenibilità significa progettare presse non solo efficienti dal punto di vista energetico, ma capaci di durare nel tempo con un impatto ambientale ridotto.
U n esempio emblematico, tangibile per i clienti ormai da diversi anni, è la realizzazione delle carenature in profili di alluminio strutturale e pannelli compositi, che hanno sostituito le tradizionali lamiere verniciate.
Q uesta scelta ha permesso di eliminare quasi del tutto i processi di verniciatura, riducendo drasticamente emissioni, scarti e consumo di solventi.
L’alluminio, materiale leggero e riciclabile, rende inoltre i moduli facilmente smontabili, aggiornabili e rigenerabili, favorendo un approccio circolare al prodotto.
U n ulteriore passo è rappresentato dall’uso esteso della stampa 3D per componenti non strutturali.
L a produzione additiva riduce gli sprechi, evita lavorazioni sottrattive e consente di realizzare solo ciò che serve.
A nche le parti minori della pressa contribuiscono così a un processo produttivo più agile, efficiente e sostenibile.
L a sostenibilità, tuttavia, è anche du -

Particolare stampato in 3D per una pressa a compressione Pezzato, esempio di componente efficiente e progettato per ridurre l’impatto ambientale. 3D printed component for a Pezzato compression press, an example of an efficient part designed to reduce environmental impact.
rabilità e qualità costruttiva: componenti selezionati, soluzioni robuste e possibilità di retrofit permettono alle presse Pezzato di lavorare per decenni, riducendo davvero l’impatto complessivo sul pianeta.
I n quest’ottica, la pressa non è più solo un mezzo produttivo, ma un elemento attivo dell’economia circolare, costruita per durare, pensata per rigenerarsi e progettata per rispettare l’ambiente in ogni dettaglio. u

The true revolution for sustainability in the rubber industry starts long before process optimization or material recycling: it begins with the machinery, which has always been a central element in the transformation process. For Pezzato, sustainability means designing presses that are not only energy-efficient but also built to last, with a reduced environmental impact.
A tangible example, experienced by customers for several years now, is the use of structural aluminum profiles and composite panels for machine casings,
replacing traditional painted sheet metal. This choice has virtually eliminated painting processes, drastically reducing emissions, waste, and solvent consumption. Aluminum, being lightweight and recyclable, also makes the modules easy to disassemble, upgrade, and refurbish, promoting a circular approach to the product.
Another step forward is the extensive use of 3D printing for non-structural components. Additive manufacturing minimizes waste, avoids subtractive processes, and enables the production of only what is truly needed. Even the smallest parts of
the press thus contribute to a more agile, efficient, and sustainable manufacturing process.
However, sustainability also means durability and construction quality: carefully selected components, robust solutions, and retrofit possibilities allow Pezzato presses to operate for decades, truly reducing the overall environmental impact. From this perspective, the press is no longer just a production tool, it becomes an active element of the circular economy: built to last, designed to regenerate itself, and conceived to respect the environment in every detail. u
Nel campo del riciclo della gomma, i termini rigenerazione e devulcanizzazione vengono spesso usati come sinonimi, ma indicano due approcci distinti per ottenere un materiale riutilizzabile da scarti elastomerici. Entrambi i processi mirano a ripristinare le proprietà elastiche della gomma che, durante l’uso o la produzione, vengono perse. La differenza fondamentale risiede nel metodo impiegato per rompere i legami chimici che mantengono la struttura reticolata del materiale. La devulcanizzazione utilizza agenti chimici in grado di attaccare selettivamente i ponti di zolfo che col-
legano le catene polimeriche. Si tratta quindi di un processo prevalentemente chimico. La rigenerazione, invece, avviene attraverso un’azione termomeccanica: calore e forti sollecitazioni di taglio agiscono per rompere tali legami senza l’uso di sostanze chimiche. Queste definizioni sono riconosciute dagli standard internazionali ISO 2382:2020 e AFNOR UNM PNC-MPEC-511. Per riflettere meglio la propria evoluzione tecnologica, la macchina per la rigenerazione degli scarti in gomma sviluppata da REP per questo processo ha cambiato nome da HSM (High Shear Mixing) a HSR (High Shear Regeneration). In origine, infatti, il sistema era pensato per miscelare
formulazioni di gomma; oggi il suo scopo consiste nel polverizzare i residui di gomma per il reimpiego nella catena di produzione. Questo processo brevettato si applica a qualsiasi tipo di residuo di produzione di gomma non contaminato. I vantaggi economici e ambientali sono significativi. Con una produzione annua di circa 61.000 kg di gomma rigenerata, si possono ottenere risparmi fino a 228.934 € e una riduzione delle emissioni pari a oltre 400.000 kg di CO₂, evitando in media 4,5 kg di CO₂ per ogni chilo di gomma riciclata.
Un passo concreto verso un’economia circolare più sostenibile nel settore della gomma. u


In the field of rubber recycling, the terms regeneration and devulcanization are often used interchangeably, but they refer to two distinct approaches to obtaining a reusable material from elastomeric waste. Both processes aim to restore the elastic properties of rubber that are lost during use or manufacturing.
T he key difference lies in the method used to break the chemical bonds that maintain the crosslinked structure of the material.
D evulcanization employs chemical agents capable of selectively attacking the sulfur bridges that connect
the polymer chains. It is therefore primarily a chemical process.
R egeneration, on the other hand, is achieved through a thermo-mechanical action: heat and high shear forces act to break these bonds without the use of chemical substances.
T hese definitions are consistent with international standards ISO 2382:2020 and AFNOR UNM PNCMPEC-511.
To better reflect its technological evolution, the machine developed by REP for this process has been renamed from HSM (High Shear Mixing) to HSR (High Shear Regeneration).
O riginally designed for mixing rub -
ber compounds, its primary purpose today is material regeneration. T his patented process applies to any type of uncontaminated rubber production waste. T he economic and environmental benefits are substantial. With an annual output of approximately 61,000 kg of regenerated rubber, savings of up to €228,934 can be achieved, along with a reduction of over 400,000 kg of CO₂ emissions-equivalent to an average of 4.5 kg of CO₂ avoided per kilogram of recycled rubber. T his represents a concrete step toward a more sustainable circular economy within the rubber industry. u
Tecnistamp da oltre 40 anni progetta e costruisce stampi per particolari in gomma. Con la capacità di realizzare stampi di dimensioni notevolmente differenti ma con la medesima qualità (da 300*300mm a 1.600*1.600mm) oggi Tecnistamp ha la possibilità di offrire stampi per qualsiasi tipo di articolo in gomma elastomero, oltre che a sistemi termoregolati di iniezione.
L’ultimo investimento ha riguardato l’estensione del sistema fotovoltaico, che oggi a pieno regime arriva a soddisfare il 50% del fabbisogno quotidiano dell’azienda.
La sostenibilità è diventata una linea guida anche all’interno dalle aziende me -
talmeccaniche; la progettazione sostenibile è un aspetto sempre più cruciale. Integrare la sostenibilità nel processo di progettazione di uno stampo è elemento essenziale oggi anche per risultare più competitivi, e fornire al cliente un prodotto che non solo sia protagonista, ma che, nello stesso tempo, sia incline all’ecosostenibilità dell’intera linea di produzione; ciò implica l’utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione del consumo di risorse durante il ciclo vita dello stampo e la progettazione per un eventuale riciclaggio. L’innovazione tecnologica e l’utilizzo della AI stanno offrendo soluzioni sempre più efficaci e a basso impatto ambientale.
La richiesta di uno stampaggio in auto-
matico da parte dei clienti ha portato Tecnistamp a sviluppare parecchie soluzioni di automatismo. L’utilizzo dei blocchi termoregolati di iniezione (di propria costruzione e concezione) è parte fondamentale del processo di automatismo. Un ulteriore servizio che negli ultimi anni ha riscosso un notevole apprezzamento è il Test dello stampo direttamente in Tecnistamp con la produzione di 10/15 pezzi per cavità; la prova stampo è possibile grazie a una pressa a iniezione di 500 Ton di proprietà dell’azienda installata presso la sede di Corte Franca (BS). L’area produttiva di Tecnistamp si è aggiornata ulteriormente negli ultimi anni e conta oggi più di 30 centri di lavoro distribuiti in due aree produttive. u



Founded in 1982, Tecnistamp has been designing and building moulds for rubber items for over 40 years. The company can make moulds of greatly different sizes but the quality does not change (from 300x300 mm to 1,600x1,600 mm), for this reason it can offer moulds for every kind of rubber articles and multi-injection CRB systems.
T hanks to the last investment made by the company, an integration of the photovoltaic system, Tecnistamp is now able to satisfy 50% of its electricity demand.
S ustainability has become a guideline within engineering companies and a sustainable design is now a crucial point. The commitment to inte -
grate sustainability into the construction process of Tecnistamp moulds is essential to be competitive and provide the customers both high-performance and eco-sustainable product. All this implies the use of environmentally friendly materials, the reduction of the consumption of resources during the life cycle of the mould and the planning for a possible recycling.
Technological innovation and AI provide different solutions to be more effective and environmentally friendly.
T he request from customers of the automatic demoulding gave Tecnistamp the opportunity to develop new solutions.
T he use of cold runner blocks (of Tecnistamp own design and construction) is a key part in the process, otherwise the
company can supply distributor inserts – easier concept and production – that can double or even quadruple the injection points, definitely the best solution for medium-large articles. Robot grippers, external frames, demoulding plates, cartesian and industrial robot are some of the elements “beyond the mould” that help to reach a completely automatic cycle.
Tecnistamp also offers the opportunity to test the moulds, producing 10/15 pieces for each cavity using a 500 Ton injection press own by the company and settled in Cortefranca (BS). A really appreciate service by the customers.
T he production area has been further updated in recent years; today it has more than 30 machining centers divided in two production areas. u
La gomma siliconica è un materiale d’eccellenza: resistente, stabile e straordinariamente versatile, è protagonista in numerosi settori industriali, dall’automotive all’elettronica, dal medicale all’edilizia. La sua diffusione, tuttavia, ha posto una sfida cruciale: la gestione responsabile degli scarti di produzione.
I n un’epoca in cui la sostenibilità è una priorità globale, il riciclo degli scarti di gomma siliconica pre-consumo è un impegno che Valli Gestioni Ambientali ha scelto di affrontare con competenza, lungimiranza e una consolidata cultura ambientale maturata in oltre sessant’anni di attività.
P unto di riferimento nella raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti industriali, Valli Gestioni Ambientali è autorizzata alla produzione di End of Waste (EoW) di gomma siliconica, in conformità al D.Lgs. 152/2006 s.m.i. La nozione di End of Waste, introdotta dalla Direttiva 2008/98/CE, si riferisce a un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto a un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto.
G li End of Waste di gomma siliconica ottenuti sono destinati a essere impiegati nella produzione di oli siliconici e derivati del silicone, generando nuove risorse da ciò che, altrimenti, sarebbe destinato allo smaltimento. I benefici sono concreti: riduzione del

consumo di risorse naturali, diminuzione dei rifiuti in discarica e consolidamento di un modello produttivo fondato sulla rigenerazione della materia.
Con Valli Gestioni Ambientali, il riciclo
VALLI GESTIONI AMBIENTALI
dei rifiuti di gomma siliconica diventa un’opportunità concreta di sostenibilità e innovazione industriale. L’azienda offre un servizio completo, garantendo trasparenza, efficienza e piena conformità alle normative vigenti. u


Silicone rubber is a material of excellence: resistant, stable and extraordinarily versatile, it is a protagonist in numerous industrial sectors, from automotive to electronics, from medical to construction. Its diffusion, however, has posed a crucial challenge: the responsible management of production waste.
In an era in which sustainability is a global priority, the recycling of pre-consumer silicone rubber waste is a commitment that Valli Gestioni Ambientali S.r.l. has chosen to face with competence, fore -
sight and a consolidated environmental culture matured in over sixty years of activity. A point of reference in the collection, treatment and recovery of industrial waste, Valli Gestioni Ambientali is authorized to produce End of Waste (EoW) of silicone rubber, in accordance with Legislative Decree 152/2006 as amended. The notion of End of Waste, introduced by Directive 2008/98/EC, refers to a process by which a waste, subjected to a recovery process, loses this qualification to acquire that of a product. The silicone rubber End of Waste obtained is intended to be used in the production of silicone
oils and silicone derivatives, generating new resources from what would otherwise be destined for disposal. The benefits are concrete: reduction in the consumption of natural resources, reduction of waste in landfills and consolidation of a production model based on the regeneration of materials.
With Valli Gestioni Ambientali, the recycling of silicone rubber waste becomes a concrete opportunity for sustainability and industrial innovation. The company offers a complete service, guaranteeing transparency, efficiency and full compliance with current regulations. u



STATORI POMPE




Isopren è una storica PMI, con oltre 70 anni di esperienza, specializzata nella lavorazione della gomma e nella produzione di articoli tecnici per il B2B in diversi settori industriali.
Si distingue per i suoi prodotti personalizzati e ad alte prestazioni tecnologiche come i compensatori di dilatazione, i tubi flessibili, gli anelli in gomma, le ruote per i gatti delle nevi e gli statori idonei al contatto con gli alimenti.
Grazie al Continuous Improvement nella produzione, ricerca e innovazione, Isopren è sinonimo di qualità, flessibilità e capacità di offrire articoli con i più alti standard e in grado di resistere alle condizioni più estreme.
L’azienda di Cusano Milanino può vantare un lungo e storico rapporto di fedeltà con i suoi clienti, con cui vengono instaurate partnership pluriennali dalla progettazione fino all’assistenza post-vendita.





