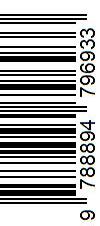





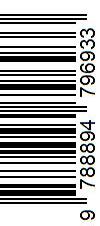






Per Maudie la vita è come l’oceano: immensa e imprevedibile.
Ma adesso sente di poterla affrontare un’onda alla volta.



leggere il mondo

















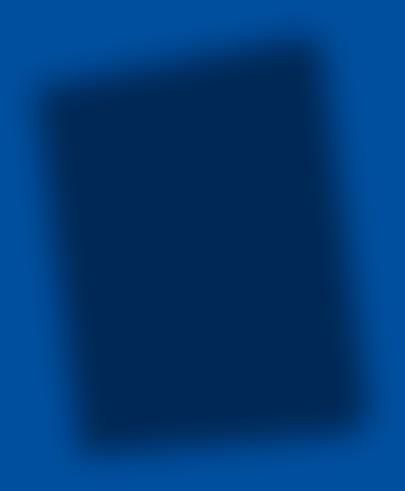




















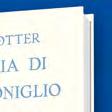



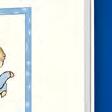




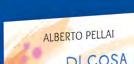






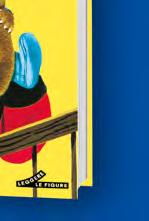




















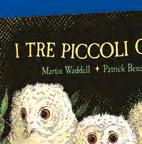




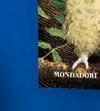


Leggere le figure, la storica collana di Mondadori dedicata ai picture book, compie 35 anni!


















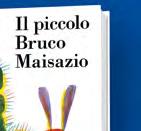






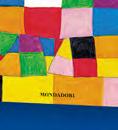









Classici indimenticabili di ieri edi oggi, personaggi, autori e illustratori amati da intere generazioni ti aspettano in libreria per festeggiare insieme!



















REDAZIONE
Direttore responsabile:
Pier Francesco Nesti
Coordinamento editoriale
Ilaria Tagliaferri (itagliaferri@idest.net)
Redazione Federica Mantellassi (fmantellassi@idest.net)
Staff catalogatori documentalisti
Selene Ballerini, Antonella Lamberti, Federica Mantellassi
Progetto grafico
Paolo Bulletti
Grafica
Mirco Bettazzi
Stampa
Arti Grafiche Cardamone srl - Decollatura (CZ)
Amministrazione e pubblicità
Sonia Mini (smini@idest.net)
Abbonamenti
Sabrina Benelli (sbenelli@idest.net)
Evelin Arweck è illustratrice e graphic designer. Laureata in secnografia e comunicazione visiva, ha lavorato per nove anni come graphic designer a Londra. Sta completando il Mimaster Illustrazione.
Editoriale

5 Un mondo di mondi. Sandra Gesualdi e Federica Petti
Identità arricchita
18 Pinocchio e l’identità arricchita. Vinicio Ongini
20 Scomporre per creare. Intervista di Letizia Soriano a Laura Izzi
23 Bambini di vetro. Manuela Trinci
26 Ambivalenza dell’inclusione. Marco Dallari
29 Giocare alle parole intraducibili. Conversazione di Ilaria Tagliaferri con Franco Lorenzoni
31 Ombre, teatro e racconti. Felicita Rubino
33 Una scuola speciale. Tiziana Scemi
36 Biblio con Vista. Monica Caiazzo
37 Una lingua sola non basta. Cristina Manea
39 Cittadinanza italiana, scuola e opportunità. Michele Arena
40 Con-cittadinanze. Diana Cesarin
42 Da Mamma lingua al sevice learnig. Patrizia Sopranzi e Francesca Pepi
43 Crescere e conoscere attarverso le lingue. Maria Rosaria Colagrossi
45 Very Brat. Fiamma De Salvo
47 Nascondersi tra le pagine. MCE di Genova
48 Un iconico personaggio ponte. Rossana Maranto
50 Albi per conoscere il mondo. Antonella Capetti
53 Io come te. Gabriela Zucchini
57 Sciogliere i nodi delle contraddizioni. Conversazione di Fausto Boccati con Sumaya Abdel Qader
LiBeR, trimestrale sull’editoria e letteratura per l’infanzia, è progettato ed editato da Fondazione Accademia dei Perseveranti, ente culturale partecipato del Comune di Campi Bisenzio (FI).
Sede editore, amministrazione e gestione dei servizi
Fondazione Accademia dei Perserveranti
Piazza Dante 23 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 8979403
E-mail: liberweb@idest.net www.liberweb.it
Autorizzazione del Tribunale di Firenze n. 3719 del 2/6/1988
L’editore si dichiara disponibile a riconoscere, a chi ne sia legalmente in possesso, eventuali diritti per le immagini di cui non sia stato possibile reperire la fonte.
Segui LiBeR su

HANNO COLLABORATO AL N. 146
Michele Arena, educatore e scrittore
Sumaya Abdel Qader, scrittrice
Selene Ballerini, bibliotecaria documentalista, Campi Bisenzio
Dina Basso, libraia
Marcella Basso, autrice ed esperta di libri tattili
Matteo Biagi, insegnante e blogger
Alice Bigli, libraia e formatrice
Fausto Boccati, libraio e formatore
Francesca Brunetti, bibliotecaria, INAF Arcetri
Cristina Busani, esperta di letteratura per l’infanzia
Monica Caiazzo, dirigente scolastica
Marnie Campagnaro, docente di Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, Università di Padova
Antonella Capetti, docente e scrittrice
Diana Cesarin, docente e scrittrice, Movimento Cooperazione Educativa
Maria Rosaria Colagrossi, bibliotecaria
Elena Corniglia, responsabile centro documentazione e ricerca sul libro accessibile, Area Onlus, Torino
Marco Dallari, scrittore e saggista
Susi Danesin, attrice


Premio LiBeR
Numero 146 . Aprile/Giugno 2025 . Anno XXXVIII . Fasc. II 72 60

Vichi De Marchi, giornalista e scrittrice
Adolfina De Marco, esperta di promozione della lettura
Fiamma De Salvo, bibliotecaria
Agata Diakoviez, libraia
Sandra Gesualdi, Direttrice Fondazione Accademia dei Perseveranti
Grazia Gotti, esperta di letteratura per l’infanzia
Nicoletta Gramantieri, bibliotecaria, Bologna
Hannah Arnesen, scrittrice e illustratrice
Francesca Romana Grasso, pedagogista
Maria Grosso, esperta di letteratura per l’infanzia
Laura Izzi, illustratrice
Antonella Lamberti, bibliotecaria documentalista, Campi Bisenzio
Franco Lorenzoni, docente e scrittore
Cristina Manea, docente
Rossana Maranto, direttrice artsitica Festival Illustramente
Serena Marradi, bibliotecaria, Firenze
Giusi Marchetta, scrittrice ed esperta di letteratura per ragazzi
Benedetta Masi, bibliotecaria
Claudia Masiero, redattrice
Vinicio Ongini, consulente MIUR, saggista
60 Libri senza retorica. Benedetta Masi
62 Bellezza come resistenza.
Intervista di Marnie Campagnaro a Hannah Arnesen
Speciale Salone internazionale del libro 2025
64 Nati sotto il segno dei libri...e dell’accessibilità
65 Lo scaffale ideale di libri accessibili.
Marcella Basso, Elena Corniglia, Susi Danesin, Francesca Meoli,
Sabrina Egiziano
67 Educare alla lettura: anticipazioni sul programma al Salone.
Giusi Marchetta
Mappamondi
68 Brasile e condivisione. Grazia Gotti Spuntinidiletture
70 Splendide e altre creature. Selene Ballerini
72 Tempo di Fiera: novità dalla Bologna Children’s Book Fair
Rubriche
6 Zoom editoria
74 Rubabandiera. Roberto Farnè
76 La cattedra di Peter. Emma Beseghi
78 La cassetta degli attrezzi. Claudia Masiero
Schede Novità – Inserto redazionale
81 La bibliografia del libro per bambine/i e ragazze/i 120 segnalazioni bibliografiche
Federica Petti, Vicesindaca Campi Bisenzio con delega alla cultura
Francesca Pepi, bibliotecaria
Rosella Picech, esperta di letteratura per l’infanzia
Felicita Rubino, docente
Giulia Romualdi, bibliotecaria, Faenza
Fernando Rotondo, esperto di letteratura per l’infanzia
Patrizia Sopranzi, bibliotecaria
Tiziana Scemi, docente
Letizia Soriano, docente
Francesca Tamberlani, giornalista e blogger
Marcella Terrusi, docente di Storia e Culture d’infanzia, Università degli Studi di Bologna
Manuela Trinci, psicoterapeuta, saggista
Gabriela Zucchini, esperta di letteratura per l’infanzia
IL COMITATO SCIENTIFICO DI LIBER
Domenico Bartolini, studioso di letteratura per l’infanzia
Emma Beseghi, docente di Letteratura per l’infanzia, Università di Bologna
Pino Boero, docente di Letteratura per l’infanzia, Università di Genova
Stefano Calabrese, docente di Semiotica del testo, Università di Modena e Reggio Emilia
Franco Cambi, già docente di Filosofia dell’educazione, Università di Firenze
Roberto Farnè, docente di Pedagogia del gioco e dello sport, Università di Bologna
Mary Hoffman, scrittrice e editor di Armadillo, magazine sui libri per ragazzi, Inghilterra
Mauro Guerrini, docente di Biblioteconomia, Università di Firenze
Federico Maggioni, illustratore e concept designer
Rita Valentino Merletti, studiosa di letteratura per l’infanzia
Luigi Paladin, psicologo, bibliotecario, studioso di letteratura per l’infanzia
Riccardo Pontegobbi, studioso di letteratura per l’infanzia
Michele Rak, docente di Teoria e critica della letteratura, Università di Siena
Dieter Richter, docente di Storia e critica della letteratura, Università di Brema, Germania
Jack Zipes, docente di Lingua e letteratura tedesca, Università del Minnesota, Stati Uniti

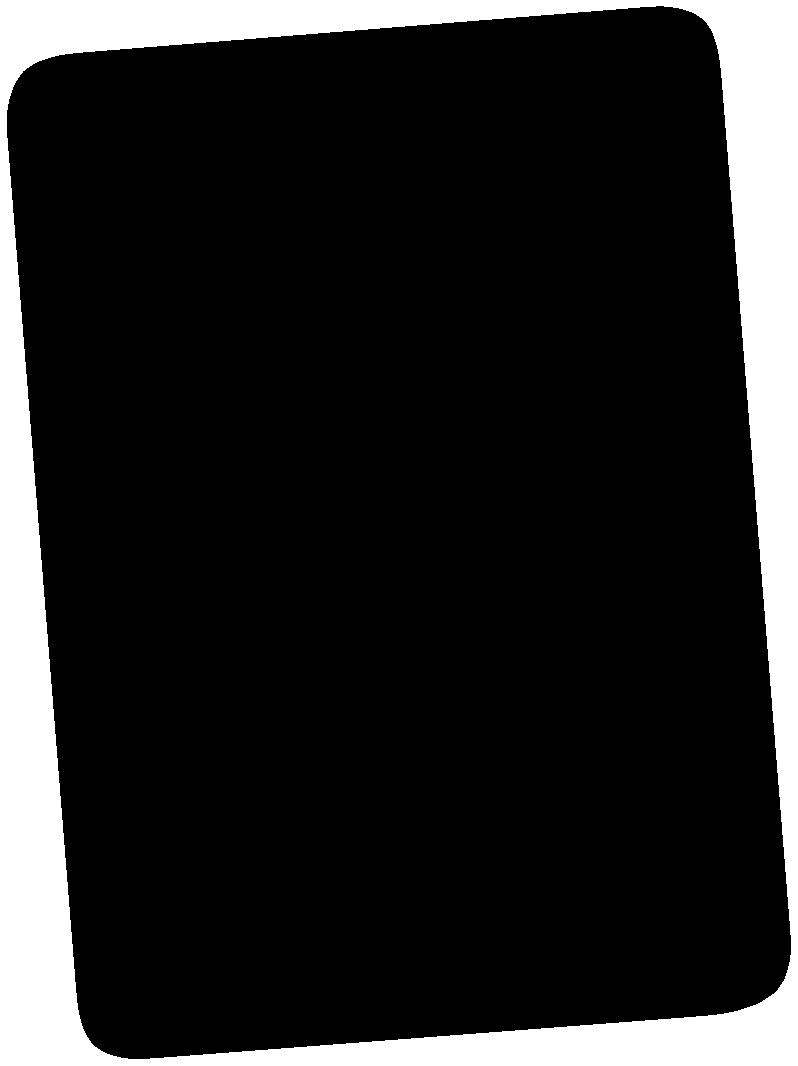
Un albo illustrato dal design ra nato e dal sapore vintage, che invita a ri ettere su come tendiamo a giudicare gli altri
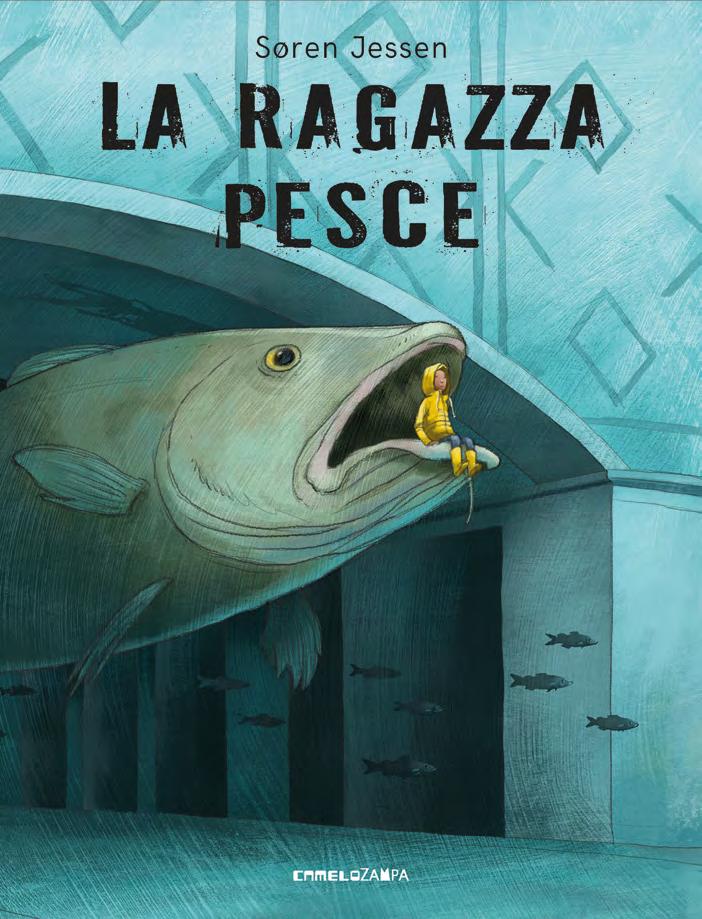
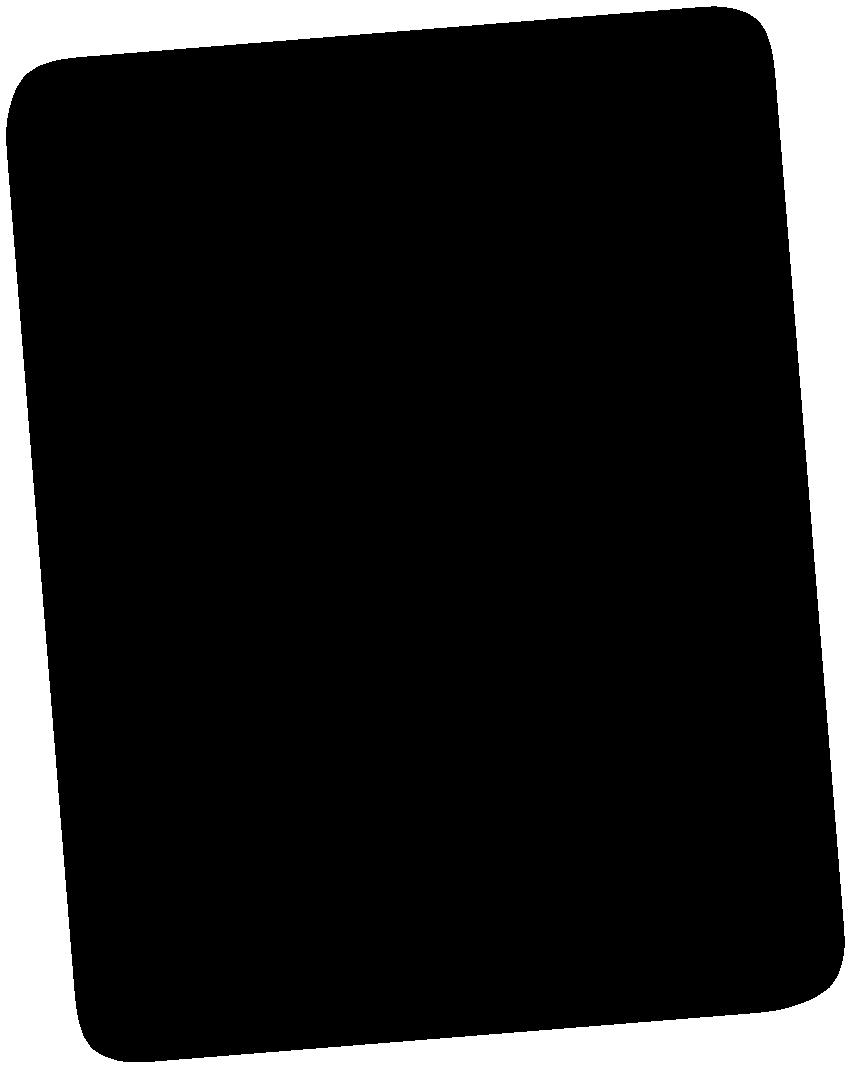
Uno sbalorditivo e toccante graphic novel che ci racconta del cambiamento climatico e della potenza della natura
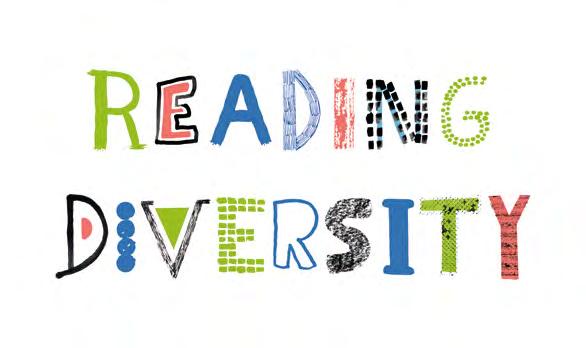




Dall'autore Premio Andersen per Testa di Ferro, un nuovo appassionante Young Adult a sfondo storico, con protagonista una ragazza vichinga


Pieno di umorismo e disarmante sincerità, un romanzo su quel momento in cui un bambino sta diventando un adolescente
In Italia succede ancora oggi che una ragazza o un ragazzo non possano andare in gita scolastica o partecipare a una gara sportiva all’estero perché in attesa di alcuni documenti. Perché? Perché i bambini e le bam bine di altra origine, nonostante frequenti no le scuole delle nostre città e/o sia no nati in Italia non sono considerati cittadini e cittadine italiane, almeno fino ai loro 18 anni: inaccettabile. Per questo sosteniamo convintamente il referendum sulla cittadinanza previsto l’8 e il 9 giugno prossimo. Un primo importante passo per far sì che quella convivenza delle differenze che si respira nelle nostre aule, piazze, biblioteche così piene di vita e brulicanti di umanità, possa finalmente diventa re una pratica, non solo consolidata nella nostra Repubblica, ma anche riconosciuta per legge. Per far sì che i e le nostre concittadine si sentano final mente cittadine e cittadini, riconosciuti nei loro diritti e an che nei loro doveri. È questo che ci chiedono i tanti ragazzi e ragazze: partecipare, votare, vivere, essere protagonisti e portatori di incontro e relazione.

Ed è proprio nelle nostre scuole e nelle nostre biblioteche che dobbiamo continuare a seminare il “sentimento dell’ampiezza” che deriva da una società meticciata, ascoltare storie di famiglie multietniche, parlare di esperienze condivise, promuovere quelle “identità arricchite” e le molte appartenenze di cui il nostro Paese è foriero.
Proprio laddove la cultura di tutte e tutti, e il plurilinguismo, sono i valori aggiunti che promuovono la cittadinanza attiva, evoluta e in evoluzione in cui il conoscersi e il riconoscersi di-
ABBONAMENTI
LA RIVISTA LIBER
Editore Fondazione Accademia dei Perseveranti
Abbonamento annuale a 4 numeri: Italia: € 50,00 - Estero: € 72,00
LiBeR in versione digitale
I singoli fascicoli in pdf nei principali store a € 4,99
LIBER DATABASE
Abbonamenti - accesso singolo: € 115,00 + iva 22%
- accessi multipli:
- da 2 a 5 accessi sconto 10%
- da 6 a 10 accessi sconto 15%
- da 10 a 20 copie sconto 20%
- ulteriori sconti oltre i 20 abbonamenti
ventino una modalità di essere città, Italia, Europa, mondo: come ci indicano gli articoli 3 e 11 della nostra Costituzione, in pace e legati da relazioni di solidarietà e uguaglianza.
Fare cultura e fare scuola in ottica multiculturale è in tal senso un atto politico: senza ergersi a un “noi” distanziato da un loro, sentendosi parte di un mondo senza confini e pregiudizi sociali, dove qualsiasi persona portatrice di una qualsivoglia caratteristica di diversità sia un unicum all’interno di una comunità di pari. Come in ogni comunità educante attiva, che dovrebbe essere alla base di ogni città.
Vogliamo vivere in un mondo di mondi, un mondo di unione e internazionalismo, un mondo in cui le storie e le parole siano di tutte e tutti, in uno scambio continuo e incessante. Per questo l’8 e il 9 voteremo SI. Per questo continueremo a pubblicare numeri di LiBeR liberi e indipendenti che possano contribuire a far pensare, inventare nuove parole, rimuovere gli ostacoli. Come da art. 3.
Federica Petti, Vicesindaca Campi Bisenzio con delega alla cultura
Sandra Gesualdi, Direttrice generale Fondazione Accademia dei Perseveranti
BONUS DOCENTI
Tutti gli insegnanti possono utilizzare il bonus docenti per acquistare LiBeR, LiBeR Database e le pubblicazioni di Idest per l’aggiornamento professionale A www.liberweb.it
PER ABBONARSI
- http://www.liberweb.it - email: sbenelli@idest.net
Pagamento intestato a Fondazione Accademia dei Perseveranti tramite:
- bollettino di c/c postale n. 15192503
- bonifico: IBANIT15P0760102800000015192503
A Attiva l’abbonamento in LiBeRWEB
A Acquista LiBeR in versione digitale nei principali store
Visita il portale di LiBeR e iscriviti a LiBeRWEB News per ricevere gratuitamente la newsletter A www.liberweb.it

Promosso dal Comune di Campi Bisenzio
Socio International Board on Books for Young People Italia

Membro del comitato promotore del Premio Nazionale Nati per leggere
LiBeR è una rivista riconosciuta dalle associazioni pedagogiche per le valutazioni nazionali della ricerca
ESPERTI
Isol;
trad. di L. Vergara
Huilcamán
Logos, 2025, 48 p.
(Gli albi della Ciopi)
€ 16,00 ; Età: da 5 anni

Antonia Murgo Bompiani, 2025, 493 p.
(I grandi e i piccoli)
€ 18,00 ; Età: da 10 anni
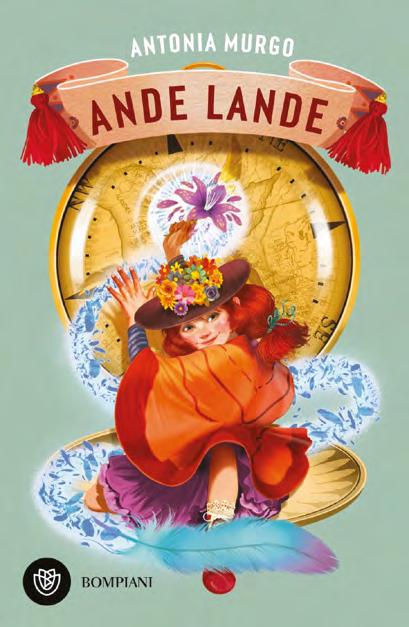
Se già Munari, Delaunay, Pacovská, Luzzati si sono cimentati nella creazione di alfabetieri, ora è la volta di Isol, premio Astrid Lindgren nel 2013.
Con il suo stile unico e il suo sguardo ironico, la poliedrica autrice argentina offre nei suoi libri sempre un’indagine profonda della società contemporanea, ampliando le prospettive dell’albo illustrato.
In Italia grazie a Logos, ecco la sua interpretazione dell’alfabeto che già dal titolo imbocca una strada tutta sua: la parola abbecedario ricorda quel grosso volume venduto dal burattino per poter partecipare allo spettacolo del terribile Mangiafuoco. Ma oltre all’eredità culturale, abbecedario si presenta come una parola ludica, che gioca sommando le prime quattro lettere dell’alfabeto. Se vogliamo dare una definizione sintetica di questo libro potremmo dire che è un gioco sapientemente libero.
Dopo una vera e propria nuotata a dorso in un mare di lettere nella seconda di copertina, una a una le lettere sfilano scritte a mano lasciando che il gesto libero dell’artista ne valorizzi la forma. A fianco l’autrice crea un’illustrazione in perfetto “stile Isol”, utilizzando una tecnica di doppi contorni: grazie al segno su forme geometriche, si
crea un raffinato effetto fuori registro, che rende i soggetti dinamici, sfuggenti, ironici. Ma è l’aggiunta del testo che crea la vera rivoluzione. Ecco un esempio: c’è un grande Elefante con una lunghissima scala appoggiata alla pancia e a fianco una piccolissima bambina, con valigia, che lo guarda; il testo recita “Andiamo in vacanza?” Scardinando la tradizione che vuole lettera, immagine e parola in perfetta sintonia (E come Elefante), Isol si libera totalmente ma segue due regole: crea immagini evocate dalla composizione di forme geometriche e dà vita a un testo che comprende una parola che comincia con la lettera scelta, in questo caso la parola “vacanza” (ma forse anche la sottintesa valigia). Così di pagina in pagina genera uno stupore divergente, apparentemente ironico ma, sotto la superficie, profondamente emotivo e visionario. Un ennesimo inno all’infanzia.
Grazie a un suggerimento dell’editore italiano, l’opera si completa con una pagina di istruzioni per fare dove Isol spiega il suo progetto e invita i bambini e le bambine a creare il loro abbecedario.
Cristina Busani
Il regno di Ande Lande è un mondo immaginario dove il prestigio sociale degli abitanti si misura nei nomi. Trentuno sono i nomi del Re. I cittadini e le cittadine umani ne ricevono in numero variabile secondo la benevolenza degli astri, quattro, cinque, diciassette, qualcuno addirittura più di venti. La dodicenne Chel è l’unica ad averne uno solo. Orfana, cresciuta dalla zia, secondo le regole di Ande Lande Chel è destinata a combinare ben poco: pochi nomi sono considerati infatti causa di poca pazienza, poca memoria, poche capacità, spesso propensione ai guai. Eppure Chel manifesta alcuni poteri dei maghi della terra; tuttavia sa che nessuno le crederebbe. Sa anche che la magia, per potersi sviluppare, ha bisogno di un maestro, e nessun astro la prenderà mai come apprendista. Dove passa, Chel, sembra la-
Nomi, magia e determinazione
sciare una scia di disastri. La sua ostinazione a partecipare a una fiera porta una serie di conseguenze catastrofiche e quando la zia e la cugina, che costituiscono tutta la sua famiglia, vengono miniaturizzate e rapite da un misterioso personaggio, la Reina di Tasche, alla ragazzina non resta
che imbarcarsi in una rocambolesca avventura per cercare di acquisire competenze magiche e così salvarle. Chel attraverserà paesi con regole proprie, dove il tempo e lo spazio non sono mai certi, così come chi siano gli alleati e i nemici, dove ci sono creature fantastiche di ogni tipo, i mezzi di trasporto sono imprevedibili, le bussole non indicano la direzione, i moli si spostano e le profezie vanno interpretate a volte guardando al passato e non solo al futuro.
Dopo Miss Dicembre e il Clan di Luna (2022), Antonia Murgo firma, ancora per per Bompiani, un corposo romanzo di quasi 500 pagine, dall’invenzione fantastica strabordante e originale, dove il mondo prende la forma di un uccello, le piume sono un linguaggio simbolico, i personaggi non sono ciò che sembrano e l’invenzione linguistica continua rivela tutto il piacere di giocare con il suono delle parole.
Alice Bigli
Zo-O
Terre di Mezzo, 2025, 64 p.
(Acchiappastorie)
€ 16,00 ; Età: da 4 anni

C’è un tempo per la cura di sé, che include la costruzione, passo dopo passo, di uno spazio entro il quale sentirsi a “casa”, e un tempo, successivo, in cui è necessario aprirsi all’esterno e accogliere l’altro. L’evoluzione identitaria che si sviluppa nella dialettica dentro/fuori è mirabilmente rappresentata dal protagonista dell’albo L’angolo della giovane e promettente illustratrice coreana Zo-O, stampato ai primi di quest’anno da Terre di Mezzo e già selezionato come “2024 Outstanding International Book” dalla sezione americana di Ibby. Un piccolo corvo elegge a propria dimora un angolo grigio: vi sosta un poco, ne testa la superficie con il corpo, poi avverte il bisogno di renderlo più confortevole. Pagina dopo pagina si procura un letto, una piccola libreria, un tappeto, la luce, una pianta da innaffiare. L’angolo diventa un luogo caldo e sicuro dover poter riposare, leggere, nutrirsi; lo diventa ancor di più quando il corvo decide di tinteggiare di giallo le pareti, realizzando originali forme geometriche che ampliano e illuminano un ambiente che assume un’aria sempre più allegra e personale: “Eppure manca ancora qualcosa…”. La pianta, nel frattempo, è cresciuta, e tra le mura altissime anche il nostro protagonista, che ha
edificato uno spazio tutto per sé ma adesso sente il desiderio di aprire una grande finestra e affacciarsi al mondo. L’autrice sceglie le potenzialità comunicative dell’albo illustrato per raccontare un tratto di vita intimo e comune a ciascuno.
Lo fa attribuendo alla struttura stessa del libro – di formato oblungo in senso
verticale (29x16 cm) – un valore narrativo nel collocare l’angolo al centro, in corrispondenza della rilegatura centrale. È questa una strategia stilistica che conferisce tridimensionalità alla pagina e ricorda le intuizioni dirompenti di Suzy Lee, altra (e più nota) artista coreana, quando ne La trilogia del limite mostrava come le componenti materiali del libro potessero divenire parte della storia. Una strategia stilistica che amplifica il gioco interpretativo dei lettori e muove suggestioni a partire dai segni essenziali e altamente poetici affidati a forma, immagini e (rare) parole.
Chiara
Lepri
Andrew Clements; trad. di B. Masini
Rizzoli, 2025, 240 p.
€ 16,00 ; Età: da 9 anni

Solitamente ci si accosta al seguito di un libro di grandissimo successo con un misto di curiosità, desiderio e la certezza quasi matematica che ci deluderà.
Andrew Clements pubblicò Frindle nel 1996 e immediatamente il mondo ne consacrò il successo. Quando Rizzoli decise di pubblicarlo, serviva una traduzione di questa parola inglese inventata così deliziosa. Beatrice Masini, traduttrice del libro, chiamò Roberto Piumini, e Drilla fu.
Altri libri seguirono, altri successi, altri casi editoriali, ma Frindle/Drilla rimase nel
cuore di tutti i lettori di Clements, ormai cresciuti e diventati a loro volta genitori. Clements morì nel 2019, lasciando al mondo il suo ultimo regalo, The Frindle Files/ Il caso Drilla, ambientato trent’anni dopo Drilla in una scuola media americana. Protagonista è Josh, ragazzino di prima media genio dell’informatica e appassionato di tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia. La sua scuola già da alcuni anni permette agli alunni di usare il computer in classe. Gli insegnanti si sono presto adeguati alle nuove tecnologie, tranne il professore di Inglese, Mr N. che pre-
tende libro, carta e penna. Mr N. è un simpatico insegnante, solo un po’ fissato e, secondo il pensiero di Josh, completamente negato con la tecnologia, tanto che non usa in classe mai né il computer né la lavagna interattiva. Un giorno nel cassetto di casa Josh scopre una penna strana, marchiata Drilla: la madre le è molto affezionata e racconta a Josh che quando era bambina ha lottato con tutti i suoi compagni di scuola perché la parola drilla come sinonimo di penna fosse accettata in tutto il Paese. Josh, a cui la curiosità e lo spirito di intraprendenza non mancano, con un’accurata ricerca su Internet scopre che la parola drilla è stata inventata da Nicholas Allen, ma non trova informazioni recenti. Curiosamente Mr N., l’insegnante di Inglese, si chiama Allen Nicholas e le foto nel web gli assomigliano terribilmente… che sia lui il bambino che ha inventato la parola drilla? E come mai odia tanto la tecnologia? Nasce così una strepitosa storia, che non deluderà chi ha amato Drilla, sul significato di cura e di attenzione, sul rapporto che si può instaurare con gli insegnanti, sul valore della riservatezza e su quanto sia faticoso mantenere i segreti.
Angela Catrani
Coso
Arianna Papini Uovonero, 2025, 40 p.
(I geodi)
€ 16,50 ; Età: da 7 anni

Michelangelo Rossato L’ippocampo, 2025, 64 p.
€ 19,90 ; Età: da 7 anni
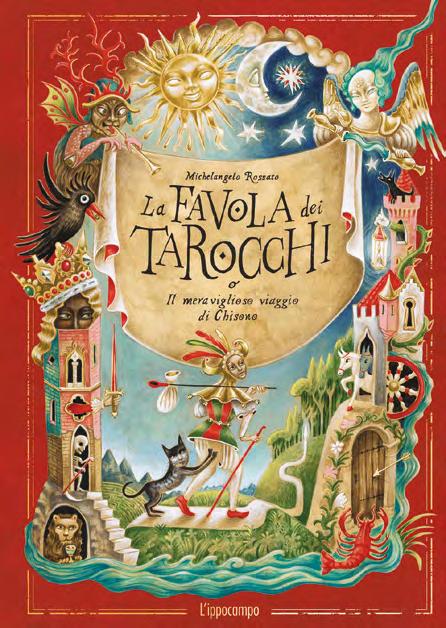
“Mi occupo dei bambini. Quando crescono me ne occupo ancora solo che fingono di non conoscermi come fanno con le maestre delle scuole finite. Io ho pazienza, capisco che si vergognano di un Coso immaginato solo per consolarsi”.
Inizia così, in prima persona, l’ultimo albo illustrato dell’artista fiorentina Arianna Papini: a raccontare non è un essere umano e nemmeno un essere vivente in generale, ma lui, Coso, l’amico immaginario di Lei, una bambina
“larga di corpo e di sorriso” che lo ha inventato appena nata.
Il protagonista, un buffo personaggio rosa con le corna e il faccione sorridente, ci spiega la vita difficile degli amici immaginari: disegnati dai bambini quando ne hanno bisogno, trascorrono la loro esistenza a sostenerli nei momenti difficili e vengono dimenticati una volta diventati adulti perché “a disegnare così liberamente i piccoli disimparano un giorno. Quasi tutti. La chiamano età adulta. Alcuni continuano. Quelli li chiamano matti oppure artisti.”
Ciascuna pagina doppia ha uno sfondo di un colore diverso, così come vario è il
rapporto fra il testo e le figure, queste ultime sempre piatte, stilizzate e coloratissime, in un chiaro richiamo al flusso di pensiero libero e giocoso di chi sta raccontando.
Di Lei non si sa molto perché Coso non ci dice neppure il suo nome, non ci dice se ha dei genitori o dei nonni o degli amici. Eppure si sa tutto. Si sa che per stare bene deve dipingere, si sa che ha bisogno di giocare con ciò che conosce, perché altrimenti si spaventa, si sa che ha capito come restare sé stessa, come distinguere tra ciò che si può lasciare andare e ciò a cui non si deve rinunciare mai. Per conoscerla meglio possiamo leggere anche E gli altri, il secondo racconto illustrato, uscito contemporaneamente sempre per i tipi di Uovonero, rivolto a lettori leggermente più grandi, in cui seguiamo la crescita di Lei dal suo punto di vistaunico, scomodo e divergente - in un progetto editoriale originale e poetico, dove il filo conduttore principale della creazione come elemento salvifico è solo uno dei tanti che vi si possono apprezzare.
Serena Marradi
“C’era una volta, o forse c’è ancora, uno strano personaggio che vagabondava come una testa matta di paese in paese”. Inizia così questa favola illustrata il cui protagonista intraprende un lungo viaggio alla ricerca della propria identità; per alcuni era un matto, per altri era semplicemente Chisono, per via della domanda che faceva a tutti quelli che incontrava. E così, camminando per sentieri perduti e città in rovina, il Matto conosce un Mago, una Sacerdotessa, un’Imperatrice, un Imperatore, un Papa e tante altre figure, che compongono l’intero mazzo degli arcani maggiori dei tarocchi.
All’inizio Chisono incontra le figure del tarocco, una dopo l’altra, poi piano piano diventa le figure stesse. Tutti i personaggi lo attraversano e gli insegnano qualcosa, guidandolo - e guidandoci assieme a lui - da un punto di partenza, la domanda del Matto, la prima carta senza numero, a uno di arrivo, il Mondo, la carta numero XXI. Michelangelo Rossato, autore e illustratore, ha creato una favola dedicata al mondo dei tarocchi, che segue l’ordine del mazzo stesso e reinterpreta gli arcani maggiori, sia a livello visivo che di signifi-
cati, inserendosi in una lunga tradizione di artisti e scrittori che si sono ispirati e lasciati suggestionare da queste carte, per citarne due tra i tanti, Niki de Saint Phalle con il parco di sculture Il Giardino dei Tarocchi e Italo Calvino con il romanzo fantastico Il castello dei destini incrociati
Le figure secolari dei tarocchi vengono così riportate in vita integrando gli elementi della tradizione con originali dettagli d’autore e suggestivi rimandi alla storia dell’arte: oltre ai riferimenti alle miniature di alcune carte storiche, il libro è ricco di richiami alla pittura medievale e rinascimentale, ma anche alle miniature persiane e alle incisioni ermetiche e alchemiche; nascosti tra le pagine ci sono inoltre omaggi al Sacro Bosco di Bomarzo e al Castelletto di Villa Belvedere a Mirano.
Chiudono poi quest’opera complessa e stratificata alcune appendici di approfondimento e un gioco finale: come i tarocchi nascondono segreti, anche questo libro ha i suoi, che possono essere scoperti tra le pagine, andando alla ricerca di campanellini perduti, numeri e lettere per risolvere, forse, l’enigma della favola.
Eléonore Grassi
Kari Stai;
trad. di M. V. D’Avenia
Camelozampa, 2025, 165 p.
(I peli di gatto)
€ 15,90 ; Età: da 11 anni

Juri ha dodici anni e per strada non vuole mai superare una persona anziana per non ricordarle che presto morirà. Ama bere il latte freddo, ma quando la mamma per accontentarlo apre apposta un cartone nuovo prima che quello vecchio sia vuoto e Juri si accorge che è freddissimo, non dice nulla per non darle un dispiacere.
Tanto acuta è la sua capacità di comprendere il mondo, quanto arduo è per lui il confrontarsi con il divorzio dei genitori, con il primo innamoramento per una compagna di scuola, con la morte, con il suo cuore e con l’imma-
le fragilità
gine di sé che con fatica sente formarsi dentro nelle sue interazioni con i compagni e con Evy, l’amica di sempre, nonché con un ottantacinquenne, che sa trasmettergli i trucchi del calcio… È “difficile spiegare perché tutto è così stressante”. “Se solo uno potesse andare dal dottore e farsi amputare i sentimenti”. È tempo di esultare perché con Felice abbastanza, suo primo romanzo in un tracciato di autrice di testi e illustrazioni – vedi i noti albi norvegesi della serie di Jacob e Neikob – Kari Stai ridona attenzione letteraria alla sensibilità. Tanto più acuta
quanto più rivoluzionaria. Una sensibilità che promana sia dalla freschezza geniale della scrittura – che la traduzione di Maria Valeria D’Avino coglie in pieno – sia dal compenetrarsi del romanzo e delle immagini, a disvelare un sottotesto più cupo e visionario: chiaroscuri esasperati e grandi occhi, quali segni di una sofferenza che, soprattutto per chi ha antenne sottili come il protagonista, comporta l’essere relegati nell’infanzia, in balia del mondo e degli adulti.
Così vediamo Juri precipitato dentro un grande cuore, mentre cerca di capire dai film come si bacia, e cosa copiare dal modo di vestire dal ragazzino più “considerato” in classe. Il suo è un affacciarsi con umanità e umorismo sulla vita e sui primi vissuti amorosi, con una compagna o con un compagno che sia.
Prescelto dalla selezione White Ravens, Felice abbastanza sa dunque trasmettere al tempo stesso dolore e gioia (“quanto dev’essere felice uno, secondo te?”), la sensibilità come valore e come capacità di accettare pian piano, tra goffaggine e sbagli, le proprie fragilità. Un antidoto fantastico all’ossessione sociale performativa e competitiva dei nostri tempi.
Maria Grosso
Kathleen Glasgow
trad. di A. Di Meo Rizzoli, 2025, 464 p.
€ 18,00 ; Età: da 14 anni

Ampiamente acclamata dal pubblico e dalla critica, l’autrice statunitense Kathleen Glasgow torna in Italia per la casa editrice Rizzoli con un romanzo tagliente e coraggioso al pari di quelli che lo hanno preceduto. Glass girl, nelle librerie da marzo 2025, entra in punta di piedi – ma senza filtri né addomesticamenti – nell’universo angoscioso della dipendenza, che
qui inghiotte un’adolescente incapace, inizialmente, di assemblare i pezzi dispersi del proprio io in frantumi. Bella, quindici anni, nasconde il proprio viso dietro un trucco pesante, mentre felpe e jeans larghi ospitano il suo corpo bisognoso di spazio per il dolore traboccante che giorno dopo giorno vi cresce. Investita dai genitori di responsabilità che non le competerebbero, la ragazza subisce dapprima il loro divorzio, quindi l’abbandono da parte del fidanzato e, poco dopo, la morte dell’amatissima nonna, suo unico porto sicuro. Per rendere tutto più sopportabile, Bella beve vodka e altre sostanze alcoliche, come e quando può, mentendo a genitori e amici e, ancor prima, a se stessa. Non si riconosce, infatti, come alcolista e si convince, vi-
ceversa, di avere la situazione sotto controllo. Ma i continui hangover e, in particolare, un drammatico episodio di intossicazione da alcol richiedono infine la sua ospedalizzazione, cui seguono due mesi in un centro di riabilitazione per adolescenti. Qui, circondata dalla selvatichezza del deserto dell’Arizona, Bella avvia un percorso di recupero segnato da conquiste e ricadute, in cui non mancano la fatica e il dolore che affrontare la realtà del proprio abisso interiore richiede. Alla sua protagonista che avverte se stessa come un “errore gigantesco” Glasgow offre, così, la possibilità di un viaggio iniziatico alla scoperta di sé, concedendosi il lusso di togliersi i guanti perché lei, con i suoi adolescenti lettori, vuole interagire nel segno del rispetto e dell’onestà: non smussa gli spigoli del reale, non sceglie l’obnubilamento di fronte all’abbandono, alle ferite autoinflitte o alla morte, ma dice la verità, che sola può aggiustare, accanto alle vere amicizie e al supporto di professionisti empatici, tutto quello che si rompe. Persone comprese.
Elena Guerzoni
Nadia Mikail; trad. di M. Bastanzetti
Il Castoro, 2025, 177 p.
(HotSpot)
€ 16,50 ; Età: da 13 anni
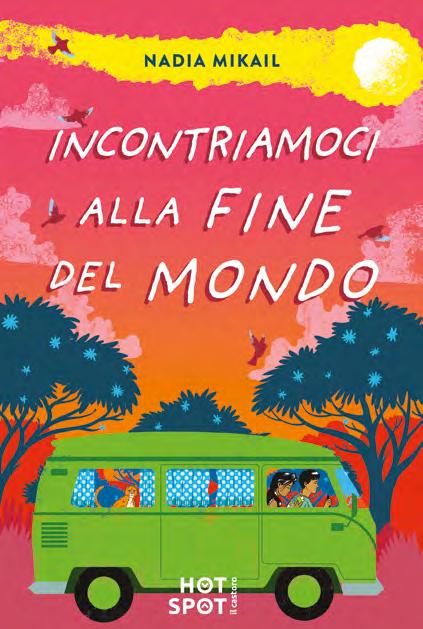
Il romanzo prende avvio da un contesto pre-apocalittico, raccontando come Aisha, adolescente che vive in Malesia, affronta con la sua famiglia le settimane che la separano dalla fine del mondo. Infatti, proprio nel giorno in cui scoprono di aver superato le prove di ammissione all’università, Aisha e il fidanzato Walter apprendono che un asteroide è entrato in rotta di collisione con la Terra e che, nonostante una serie di tentativi segreti, i leader mondiali non sono stati in grado di evitarlo. Nel tempo che resta loro da vivere, Aisha e la madre decidono di partire per cercare June, la sorella che un paio di anni prima le ha abbandonate e ha interrotto i contatti con loro. Con Walter, i suoi genitori e un gatto randagio che non hanno il coraggio di abbandonare, Aisha si mette in viaggio per Malacca, con la speranza di trovare la sorella nella vecchia casa dei nonni. A dispetto dell’ambientazione e della scintilla che muove la trama, il felice esordio di Nadia Mikhail non è affatto un romanzo di genere, ma una storia che esplora le relazioni e che ha il suo centro nel verbo “incontrare”, presente sia nel titolo italiano, sia – con una sfumatura diversa – nel titolo originale (The cats we meet along the way). Durante il viaggio,
che tocca tappe significative per l’universo emotivo dei personaggi, il lettore si interrogherà su quali comportamenti rendono dignitosa la vita degli uomini, cosa significhi essere una famiglia, in quali differenti modalità le persone affrontano il dolore e la perdita. Incontriamoci alla fine del mondo è una riflessione delicata, ma non consolatoria, sulla tran-
Prima dell’Apocalisse
sitorietà dell’esistenza, minacciata non soltanto dalla catastrofe in arrivo, ma anche dal ciclo naturale della vita. La vecchiaia e la malattia, evocate nei ricordi di famiglia, non determinano un abbandono alla disperazione, ma al contrario rafforzano la volontà di celebrare la vita e i legami tra le persone. Il romanzo intesse realtà e sogni, passato e presente, con una fluidità narrativa che non spiazza il lettore, ma gli restituisce pienezza di senso e di orizzonte. In conclusione, si tratta di un libro che scalderà il cuore dei lettori adolescenti, poiché non nasconde il dolore, ma lascia campo alla speranza.
Matteo Biagi
Charly Delwart, ill. di Ronana Badel; trad. di F. Novajara
La Nuova Frontiera Junior, 2025, 144 p.
€ 13,90 ; Età: da 9 anni
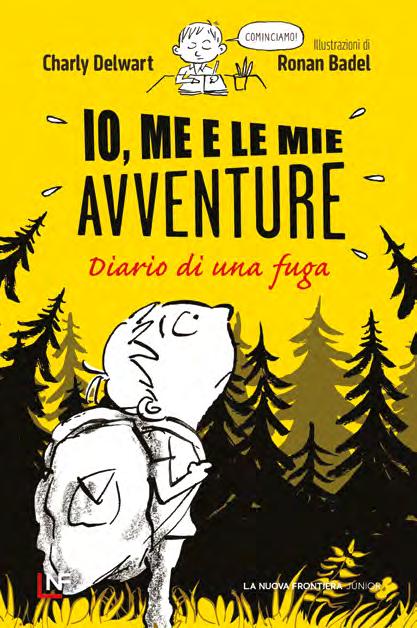
La realtà diventa piatta e grigia senza la fantasia e che cosa c’è di più fantastico che organizzare una fuga da casa? Gaspar è un ragazzino di dieci anni, ma ha già idee ben precise sugli adulti. Per esempio è convinto che i diritti dei bambini non debbano essere messi in discussione. Così decide di scappare da casa. Una storia divertente, piena di humor per chi ama il gioco e lo scherzo, Io, me e le mie avventure racconta come il desiderio di ignoto si trasforma per Gaspar in una magica avventura più inventata che reale, una prospettiva diversa di vedere le cose.
Scappare di casa
I motivi per scappare di casa sono svariati e Gaspar li enumera uno dopo l’altro, ma la ragione fondamentale è che non va d’accordo con i genitori. Si sente rimproverato ingiustamente quando invece spesso la colpa è delle due sorelle più piccole; non viene ascoltato quando espone le sue ragioni; è insomma trattato in maniera non adeguata, si sente incompreso. “So meglio di loro cosa fare per il mio bene.” Il motivo di discussione è la scelta della scuola media. Lui vuole restare vicino a casa con i suoi compagni, loro preferi-
scono una scuola “migliore e più grande”. Il solito discorso dei genitori: sceglierai quello che vuoi quando sarai più grande e non osare contraddire altrimenti chiuditi in camera tua. Considerazioni di Gaspar: “più diventiamo preadolescenti, meno i genitori ci capiscono, ma noi capiamo di più come la pensano loro e quindi andiamo meno d’accordo”. Ma una volta decisa la fuga, il problema è come attuarla. E qui comincia il bello. Giorno per giorno si snoda il suo diario che rivela un carattere molto attento ai particolari e deciso ma anche consapevole delle innumerevoli difficoltà che dovrà affrontare sia che la sua fuga avvenga in un bosco vicino a casa o in un Paese straniero. Quest’ultima scelta è subito esclusa poiché anche i suoi amici sono partecipi del progetto e lo mettono in guardia dai pericoli che potrebbe incontrare. Leggendo le traversie di Gaspar e i suoi interrogativi vengono in mente i nostri ricordi d’infanzia ed è questo il pregio di questo piccolo libro. È come se tutto fosse accaduto in ambienti di sogno, senza dimenticare turbamenti e contraddizioni, ma neppure la svogliatezza di quei giorni felici quando sembrava che nulla potesse avere fine.
Paola Benadusi Marzocca
Nick Abadzis; trad. di O. Martini
Tunué, 2025, 208 p.
(Prospero’s books)
€ 19,90 ; Età: da 14 anni

A quasi venti anni dalla sua uscita giunge in Italia Laika, un graphic novel dedicato al primo essere vivente “lanciato” nello spazio. Il libro nel 2008 è stato insignito dell’Eisner Award, uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel campo dei fumetti, viene proposto da Tunué e porta la firma di Nick Abadzis. Laika racconta molto di più della storia di Kudrjavka, Codariccia, come era stata soprannominata questa cagnetta randagia scelta e addestrata per affrontare la missione spaziale a bordo dello Sputnik 2. Oltre a essere un atto di amore verso l’animale, il libro ha il pregio di ricostruire, tra finzione e realtà, il conte-
sto storico culturale che dette origine all’impresa. Il racconto, in quattro capitoli, alterna e intreccia due piani narrativi: quello dedicato della realizzazione di una delle più note missioni spaziali e quello “biografico” della cagnolina. L’incipit anticonvenzionale e inaspettato mostra un uomo in lotta per la sopravvivenza in un gelido paesaggio nordico. Si tratta di Sergej Pavlovič Korolëv, il principale artefice dei programmi spaziali dell’Unione sovietica, arrestato alla fine degli anni trenta del secolo scorso, durante le purghe
staliniane, e spedito a Kolyma in Siberia.
Il fumetto con un salto temporale ci porta nel 1957, al lancio appena avvenuto dello Sputnik 1, cui Korolëv allora riabilitato dette un contributo immenso, e alla atmosfera di cupa segretezza che caratterizzò la realizzazione della seconda missione nello spazio. Imposta da Chruscëv allo stesso Korolëv per celebrare i quaranta anni della Rivoluzione di Ottobre avvenne a un mese di distanza dalla prima, un periodo troppo breve perché andasse a buon fine e che si rivelò fatale per il destino di Laika. La versione ufficiale dei fatti racconta che la cagnetta sopravvisse quattro giorni in orbita; la realtà, documentata da fonti diverse, elencate al termine libro, fu che a poche ore dal lancio Laika morì a causa del surriscaldamento della capsula. Ecco come andò a finire la storia di questo animale vivace, sveglio, amatissimo da coloro che se ne presero cura, che si affidò fiducioso al proprio destino. Ripercorsa passo dopo passo, la vicenda della cagnetta non può non appassionare chi la segue e soprattutto, alla luce di queste rivelazioni, merita di essere letta.
Francesca Brunetti
Stefan Boonen, ill. di Dieter De Schutter; trad. di L. Pignatti, Mondadori, 2025, 328 p.
(Contemporanea)
€ 17,00 ; Età: da 10 anni

Prolifico autore belga, Stefan Boonen ci propone una storia apparentemente fuori dal nostro tempo veloce, segnato dal battito frenetico dell’informazione in cui si disincarnano i fatti e la realtà delle persone. Il suo racconto si estende tra boschi e borghi remoti, e mette in scena personaggi che rimandano ai protagonisti (da Rasmus della Lindgren ai piccoli vagabondi di Rodari) di una grande stagione letteraria d’altri tempi, personaggi sulle strade del mondo in cerca di fortuna. Il suo è un universo finzionale che ha le movenze e il fascino dell’inattuale, ma che a ben vedere ha molto a che fare con il nostro qui e ora. Luisa Robin, 11 anni, è una domestica al servizio di una coppia di incattiviti benestanti che per capriccio l’hanno rinominata Luvi.
La sua vita è segnata dal duro lavoro e dalla quotidiana ingratitudine dei coniugi, che la trattano come una “specie di… servetta”, e la fanno sentire come un “passerotto domestico”. Quando la misura sarà colma, Luvi non potrà fare altro che fuggire, prendere la via del bosco, eclissarsi senza una meta, per liberarsi dalla gabbia in cui è stata rinchiusa.
Luvi incarna quello che, parafrasando il titolo di un noto libro di Peter Hoeg, potremmo definire “il senso dei
ragazzi per la fuga”, una prerogativa tutta infantile segnata dal coraggio estremo di mollare e di aprire a prospettive nuove. Con lei, sulla via del bosco e dei campi, incontriamo altri tre ragazzi fuggiti dal riformatorio con l’idea, confusa quanto mai, di rifarsi una vita altrove. Non mancano di incrociare Luvi e i suoi nuovi amici, rinnovate e aggiornate, figure classiche della fabulazione,
come il rappresentante della legge, naturalmente nemico del vagabondo e di chi fugge. Il Commissario darà filo da torcere ai ragazzi e a chi li aiuta, a chi crede che “da soli non siamo nessuno” e che anche per quei poveri ragazzi possa esistere un posto accogliente in cui vivere. Il romanzo è tutto al presente indicativo, procede per periodi brevi, rifuggendo le subordinate; la frammentazione del discorso e il minimalismo delle descrizioni riescono perfettamente a dar corpo e sostanza a quei piccoli brani di vita che costituiscono la bellezza di questa storia di fuga, approdo e accoglienza che, all’attualità, finisce per pagare un forte tributo.
Riccardo Pontegobbi
Chiara Carminati, Massimiliano Tappari Lapis, 2025, 56 p.
€ 15,00 ; Età: da 6 anni

Nella produzione, ormai piuttosto ampia, di Chiara Carminati e Massimilano Tappari per Lapis si può individuare un ideale percorso, passando da Occhio ladro (2020) attraverso Quattro passi (2021) a Ogni volta che parti
Le fotografie di Massimiliano Tappari e i testi in versi di Chiara Carminati si confrontano nei primi due albi accostando a ogni immagine una breve storia in versi che accoglie una suggestione e invita il lettore a fare inedite associazioni. Passeggiare in contesti quotidiani e consueti, attraverso percorsi noti, fra lampioni e segnali stradali, può diventare un’esperienza nuova, se si alzano gli occhi al cielo per osservare una scia bianca o se ci si lascia catturare dal lampo rosso di un papavero. Così se l’occhio ladro di un’osservatore che legge “il libro del mondo” è pronto a cogliere nel dettaglio decorativo di una parete una sagoma felina, può benissimo trattarsi di un gatto mimetizzato e per questo imbattibile cacciatori di topi. E basta fare – con animo bambino – quattro passi per rendersi conto che “ogni oggetto del mondo non è mai solo se stesso, ma ne richiama altri con cui compone famiglie, squadre, collezioni” che offrono spunti narrativi inattesi.
Ogni volta che parti propone ancora la riuscita combinazione di immagine fotografica e poesia, ma qui i due livelli figurativo e testuale sviluppano una narrazione più ampia: di immagine in immagine, frascorci di azzurro e giochi di ombre, una solitaria passeggiata attraverso la città e gli spazi quotidiani guida lo sguardo su angoli nascosti e dettagli, mentre il testo racconta, in forma di
un’unica poesia, lo struggimento e il desiderio che non bastano a riempire l’attesa di una persona cara e la necessità di dare senso a quel tempo sospeso oltre la distanza. Come negli albi precedenti, dove l’invito a scoprire il mondo con occhi nuovi era esplicitato, Ogni volta che parti suggerisce di tornare a osservare l’ambiente che ci circonda - naturale o urbano - come spazio dell’anima. “Il paesaggio sa tutto” – come scriveva il poeta premio Nobel Harry Martinson – e forse anche per questo in esso è è possibile per ciascuno trovare la propria storia e la propria consolazione.
Federica Mantellassi
Olivier Dupin, ill. di Barroux; trad. di S. Bandirali
Uovonero, 2025, 40 p.
(I geodi)
€ 18,50 ; Età: da 6 anni

Anche la letteratura per ragazzi ha più volte ricordato storie vere di uomini e donne che si impegnarono per salvare ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti, da Schindler e Perlasca a Gino Bartali, il campione di ciclismo che durante gli allenamenti portava nascosti nella canna della bicicletta messaggi della Resistenza. Un albero li ricorda nel Giardino dei Giusti dedicato in Israele ai gentili (non ebrei) che salvarono anche un solo ebreo. Ma molti prestarono aiuto, anche con un piccolo gesto, eppure rimasero sconosciuti, per umiltà o inconsapevolezza.
Dupin, con le illustrazioni di Barroux soffuse di luci e penombre che alludono ed esplicitano, narra una favola che condensa in forma poeticamente esemplare al confine tra fantasia e realtà la grandezza di questi eroi ignoti. Sara e la sorellina hanno paura del portiere, l’orco del piano di sotto, del suo sguardo truce, della barba lunga fino alle ginocchia dove – dicono i bambini del quartiere - nasconde mostri e che detesta la “gente come noi”, che ora non può più entrare nei negozi, deve portare una stella gialla sul vestito, è
guardata male in strada. Un giorno il papà non torna a casa e le bambine vedono dalla finestra che la mamma viene portata via. Mentre i poliziotti salgono le scale, l’orco entra in casa e nasconde le bambine timorose dentro la barba che allarga come una tenda. Porta loro anche da mangiare, ma quando il vecchio vicino di casa le vede e le denuncia alla polizia lui le fa entrare ancora nel barbone e le trasporta in treno, autobus e taxi – sempre nascoste nella barba – in una casa di campagna nel verde sotto un sole brillante, dove le accoglie sorridente la sorella dell’orco. Il quale nei giorni seguenti porta tre bambini e poi altri quattro. Le sorelline imparano qualcosa di più della morale spiccia che non bisogna mai giudicare dalle apparenze: “L’orco del piano di sotto nascondeva qualcosa che in realtà non aveva niente di spaventoso. Al contrario. Nascondeva un cuore enorme, un cuore giusto!” Quell’uomo dalla barba smisurata che incuteva paura avrebbe certamente meritato un posto nel Giardino del Giusti. Ma ne resta il ricordo nel cuore di chi da lui fu soccorso.
Fernando Rotondo
Katsumi Komagata Topipittori, 2025, 20 p.
(I grandi e i piccoli)
€ 12,00 ; Età: da 4 anni

Alessandro Vanoli, ill. di Kaja Kajfez Giunti, 2025, 94 p.
(Punti di vista)
€ 19,90 ; Età: da 8 anni

Finalmente arrivano in Italia gli oggetti-libro di Katsumi Komagata, progettati per appagare le persone fin dai primi anni e per tutta la vita, con la loro spiccata capacità di coinvolgimento che si disvela attraverso segni, materiali, pieni, vuoti, suoni.
Ping Pong si pone in continuità con il progetto Little Eyes che Komagata sviluppò appena divenuto padre: procede per sintesi rendendo evidenti le relazioni tra soggetti e oggetti, unità e molteplicità, differenze e uguaglianze, somma, sottrazione e moltiplicazione. Aggiunge in questo caso la variante sonora attraverso
Non solo per i più piccoli
un testo minimale.
La lettura inizia dalla copertina, dove vengono presentate le protagoniste della storia, le palline appunto, in numero di tre, scelta non casuale ma probabilmente dettata dal fatto che le persone nascono dotate di un’intelligenza numerica pari a tre.
Tre sono anche i colori che incontriamo: pagine bianche, scritte nere, palline arancioni. Troviamo poi in sequenza un pallino centrale, due in verticale, tre in diagonale, quattro disposti a quadrato, cinque in diagonale ma orientata diversamente
rispetto alla precedente, poi nuovamente cinque sommando le precedenti figure di uno e quattro. A Komagata premeva favorire precocemente un incontro giocoso ed estetico con concetti logico-spaziali, matematici ed etici rendendo sensorialmente esperibile la varietà di posizioni, relazioni e cambiamenti. Successivamente troviamo tredici palline di cui quattro, ordinate secondo i punti cardinali, sono più grandi rispetto alle altre: complessivamente viene sollecitata l’identificazione di relazioni e proporzioni. Pure il nove è rappresentato in due diverse modalità, rinforzando il concetto di unità e gruppo, ma anche della molteplicità di rapporti possibili in base al contesto. L’ultima pagina è popolata da un gruppo di venticinque soggetti. In Komagata la sintesi diviene attenzione a come si trasformano le relazioni e i rapporti tra soggetti (senzienti e non ) ma anche in ambito speculativo. Questo libro si legge a svariati livelli, sarebbe un peccato proporlo solo nei primi anni!
Francesca Romana Grasso
Film, romanzi, manga ne hanno modellato l’iconografia: orecchino, occhio bendato, un fazzoletto allacciato al capo e la bandiera nera con il teschio che sventola minacciosa sull’imbarcazione pronta all’attacco. È l’immagine romanzata dei pirati. Chi, invece, vuole davvero conoscerli deve leggere il documentatissimo Pirati dello storico e scrittore Alessandro Vanoli, illustrato da Kaja Kajfez, un’opera di divulgazione che è un affascinante viaggio lungo i secoli. L’autore ha seguito numerose traiettorie incrociando le lotte di potere delle grandi potenze, le esplorazioni geografiche con la scoperta di nuovi mondi (le Americhe), l’evolversi delle dottrine militari, le convenienze economiche, le innovazioni tecnologiche che hanno spesso offerto nuova linfa alle imprese piratesche.
In Pirati si trova anche una descrizione dettagliata, sorretta dalle illustrazioni, di come erano fatte le navi vichinghe o le galee ottomane e del ruolo delle torri di guardia erette per difendere le località costiere dagli attacchi di pirati e corsari, questi ultimi spesso al soldo di grandi potenze.
La storia della pirateria, dal mar Mediterraneo, all’Atlantico, all’Oceano Indiano, è fatta anche di luoghi simbo-
lici. Chi non conosce l’isola di Tortuga, resa celebre anche da Emilio Salgari in Il corsaro nero? E poi ci sono i personaggi storici famosi come Francis Drake e Henry Morgan che depredavano le navi spagnole e attaccano gli insediamenti costieri. Di Barbarossa, Vanoli narra lo stile di combattimento e le tattiche intimidatorie, mentre di William Kidd si ricorda un misterioso tesoro nascosto e mai trovato. Infine, merito di questo testo di divulgazione è il racconto delle donne pirata, certamente una minoranza, eppure “né pochissime né di importanza secondaria”. Tra queste, cita Anne Bonny e Mary Read, attive nel Mar dei Caraibi nel XVIII secolo, e la mitica Zheng Yi Sao, “regina” di una temibilissima confederazione pirata. Le sue gesta, per chi vuole transitare dalla divulgazione alla letteratura, sono raccontate da Davide Morosinotto in La più grande. O, per uno sguardo avventuroso sulla pirateria, ci si può tuffare nell’ottocentesco romanzo di Robert Louis Stevenson L’isola del tesoro
Vichi De Marchi
Michael Rosen, ill. di Benjamin Phillips; trad. di L. Pelaschiar Emme, 2025, 32 p.
€ 15,90 ; Età: da 6 anni

Sulla copertina dell’albo Quel giorno. Una storia vera di coraggio nei giorni bui dell’olocausto di Michael Rosen, ci sono dei volti, tanti, che Benjamin Phillips ha disegnato per questa storia in cui viene raccontata la vita di alcune di quelle persone. Mute, ma non silenziose. Dietro ogni persona ci sono sempre una storia, un nome, dei legami, un giorno che resta a fare da ponte tra il prima e il dopo. Di storie sulla tragedia del secolo breve ce ne sono tante. I testimoni che hanno avuto la forza e il coraggio di raccontarle sono una minima parte della folla che compare sulla copertina del libro.
Michael Rosen, scrittore e poeta britannico conosciuto per i lavori dedicati all’infanzia, è anche giornalista e ha presentato per la BBC un programma televisivo dedicato all’educazione. Nella nota che chiude il testo racconta come è venuto a conoscenza di questa vicenda che coinvolge anche membri della sua famiglia. Ogni volta che qualcuno racconta i fatti che sconvolsero e distrussero la vita delle persone nel decennio più buio del ‘900, scopriamo di trovarci dinanzi a pezzetti di vita che devono essere raccontate per non finire a “Pitchipoi”. “Pitchipoi” è il luogo più irreale e reale che sia esistito.
È una parola che indicava un luogo che in molti si rifiutavano di credere reale, serviva per non spaventare i più piccoli, o anche i grandi. Lo sterminio di milioni di ebrei è stato un’azione determinata e realizzata meticolosamente: “Pitchipoi” era il mantello con cui si voleva rendere invisibile quello che era sussurrato. Michael Rosen è anche un poeta e sa dare alla narra-
zione il ritmo e l’essenzialità delle composizioni poetiche. Quel giorno - un giorno che cambiò le nostre vite, le vite di chi c’era e di chi oggi legge queste storie - è il giorno in cui può succedere qualsiasi cosa. Anche di incontrare qualcuno che si oppone, che nella storia entra aprendo altre porte. In questo tempo sovraccarico di luoghi che ci sembrano irreali, ma che sono terribilmente reali, bisogna sperare e fare ogni cosa, anche piccola, perché come ha dichiarato David Grossman in un’intervista rilasciata poco tempo fa: “Questo è il tempo delle cose imprevedibili, non del realismo”. Quel giorno grazie alle “cose imprevedibili” fu possibile ricevere un gesto di umanità.
Agata Diakoviez
Kristien In-’t-Ven, ill. di Martha Verschaffel; trad. di V. Freschi Orecchio acerbo, 2025, 80 p.
€ 18,00 ; Età: da 8 anni
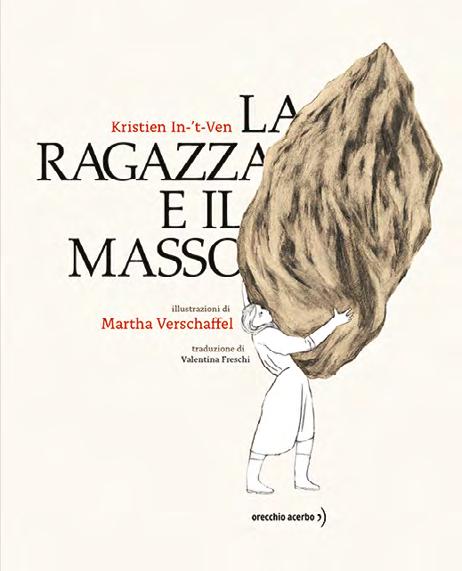
C’è un non protagonista cruciale in questa splendida storia: l’impasto del pane. Compare all’inizio, torna alla fine per prendersi anche la quarta di copertina. Pane come simbolo di vita che per essere vissuta pienamente deve scendere a patti con la gestione della sofferenza: il più delle volte né capita, né accettata. Le autrici, belghe, snodano sul filo di una pungente metafora un’iniziazione all’inquietudine esistenziale necessaria per realizzare il proprio destino. Si entra subito, nelle pagine dell’incipit, nel mondo visionario di Martha Verschaffel, con i suoi chiaroscuri
di grafite, un ritmo alternato tra campi lunghi e doppie inquadrature in sequenza, col gioco di un’accelerazione multiframe quando nella stessa tavola il soggetto è ripreso più volte in successione.
Lontano da ogni tentazione digitale, con un tratto che riprende il gusto per l’arcaico e il folk della francese Céline Hudreaux, Verschaffel costruisce una narrazione per immagini in cui il contrappunto tra il segno e la scrittura affilata di In-’t-Ven ci guida attraverso il peso del dolore emotivo, senza mai
appesantirlo.
Partito il fattorino che ha portato il masso, pesante come “tre macchine e sette elefanti”, la protagonista tenta di liberarsi dell’ingombro buttandolo in un burrone. “Non è che esageri un pochino?” – le domanda la gente. Stretta al macigno, si lascia cadere e qui avviene il miracolo del surrender: anziché precipitare, la ragazza fluttua dolcemente verso il fondo. Sarà lo sguardo incantato dell’infanzia a salvarla: dei bambini, con una corda, l’aiuteranno a risalire. Si renderà così conto che non solo la pietra è diventata più leggera, ma che tutti, persino i cani, ne hanno una. Illustrazioni, testo – attentissima la traduzione – in una cornice grafica raffinata, ci aprono a uno stato di nuova consapevolezza, dove il disagio può essere accolto e in cui la nostra paura si dissolve scoprendo le pietre degli altri. Solo allora la vita potrà ripresentarsi col suo pane, col suo impasto di magia e imprevedibilità.
Elena Baroncini

L’attenzione per la cultu ra materiale, in questo caso per un alimento specifico come il riso, guida, attraverso l’interesse per un singolo elemento, alla scoperta dell’interdipendenza fra uomo e natura, fra cultura e tecnica, fra scienza e letteratura. Questo albo, curato nel dettaglio e concepito all’interno di una collana di divulgazione, propone un ricco e accessibile percorso di approfondimento e conoscenza di un alimento diffusissimo a livello planetario eppure di rado illustrato e raccontato ai bambini.
Non solo fornisce spiegazioni di tipo scientifico, storico
Consumo consapevole
e nutrizionale sull’agricoltura, la produzione e il consumo del riso, ma ospita, ben intervallate in una struttura mossa e godibile anche per il pregio delle illustrazioni e le scelte cromatiche, alcune narrazioni mitologiche provenienti da diversi paesi del mondo, dedicate naturalmente al riso. L’operazione è in sé interessante, perché fondata sull’idea che la cultura per l’infanzia abbia anche il compito di offrire e incoraggiare una consapevolezza di cittadinanza e di appartenenza sostenibile al pianeta, che prende avvio dalla cono-
scenza degli elementi mate riali e simbolici che abitano il quotidiano, e incoraggia la possibilità di iscrivere la propria esperienza in quella comunitaria e cosmica. I regni sono molti: fra loro quello vegetale, animale, minerale, e non solo comunicano fra loro, ma sono strettamente dipendenti nella relazione ecologica. Un chicco di riso, un libro ben illustrato, il cibo che portiamo alla bocca, l’attenzione per i materiali e gli elementi che frequentiamo ogni giorno possono essere la scintilla per rendere visibili queste relazioni, scoprirle e discuterle con i bambini, in una chiave che sarà inevitabilmente interculturale. Un libro di divulgazione può ospitare racconti fantastici, visioni e informazioni scientifiche e utilizzare, come qui accade, registri stilistici diversi per interpretare la responsabilità pedagogica di fornire ai bambini quante più chiavi possibili di lettura del mondo e dunque possibilità di azione.
Marcella Terrusi
Bruno Maida
EDT Giralangolo, 2025, 240 p.
(Dinamo)
€ 13,00 ; Età: da 13 anni

Storico, docente universitario, studioso dell’infanzia, autore del recente saggio Sciuscià. Bambini e ragazzi di strada nell’Italia del dopoguerra. 1943-1948 (Einaudi, 2024), Bruno Maida si cimenta ora con la narrativa giovanile, dando vita a un romanzo intenso nel quale riversa una forte sensibilità per il mondo interiore infantile. E col quale riesce a vincere la sfida di dar vita a una narrazione filtrata attraverso una coscienza giovanile, che sempre rappresenta lo spartiacque, secondo il pensiero di Aidan Chambers, tra Youth Fiction e letteratura tout court È un periodo difficile quello raccontato attraverso lo sguardo pieno di domande di Alberto, dieci anni, ebreo, che vede il mondo attorno a sé perdere tutte le certezze. Ma quello che il giovane e ingenuo protagonista proprio non riesce a comprendere è perché nessuno reagisca alle ingiustizie che colpiscono gli ebrei. Cresciuto in un ambiente intriso di valori fascisti, fino a quel momento ha creduto ciecamente in Mussolini. Perciò quando sui giornali, il 1° dicembre 1943, appare l’ordine di arrestare tutti gli ebrei e di mandarli nei campi di concentramento, Alberto pensa che debba esserci una qualche ragione per tutto questo. È l’inizio di
La fine delle certezze
una fuga pericolosa e avventurosa assieme a un padre che da mesi sente lontano, chiuso in una dolorosa malinconia, mentre i nonni, a cui è legato da profondo affetto, decidono di rimanere. Ma Alberto sente anche emergere dentro di sé un coraggio sconosciuto quando si accorge che a vivere con lui quell’avventura c’è un padre che riesce gradualmente a “riprendere per mano” quel figlio spesso dimenticato. E lo fa soprattutto nei momenti di maggior pericolo, attraverso il filo delle storie. Un romanzo denso, che richiede in certe parti pazienza ai giovani lettori. Ma è una pazienza necessaria, per sondare i sentimenti più profondi del giovane protagonista e la sua graduale acquisizione di consapevolezza, e per comprendere la complessità di quei mesi tragici segnati dalla persecuzione di tanti italiani (e non), costretti a seguire “rotte illegali” per mettersi in salvo. Quelle “rotte illegali” che risuonano nella nostra mente – perché la Storia “fa le rime”, come dice Mark Twain – inducendoci a interrogarci non solo sul passato ma anche sul presente.
Gabriela Zucchini
Claudia Mencaroni, ill. di Maria Rico
Verbavolant, 2025, 1 v.
€ 18,00 ; Età: da 4 anni
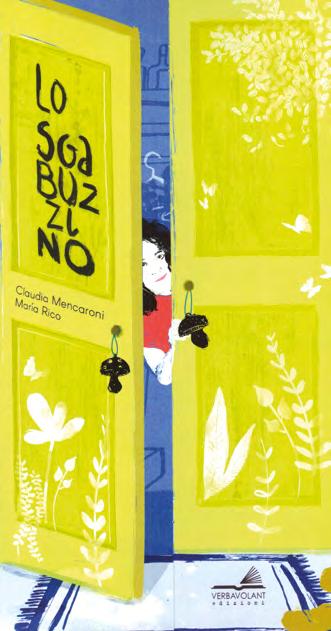
Per entrare nello sgabuzzino di Claudia Mencaroni e Maria Rico non occorre sollevare la copertina e voltare pagina, basta far scivolare la “porta” scorrevole e addentrarsi nel luogo incantato in cui ci conduce la piccola protagonista. Non è infatti un “semplice” libro ad ospitare questa storia intima e un po’ misteriosa, ma un elegante albo leporello dal formato alto e stretto, racchiuso in una custodia di cartoncino. Così il gioco di scoperta a cui ci invitano le autrici ha inizio da subito, grazie a una confezione editoriale curatissima e funzionale alla narrazione.
La voce narrante è quella di una bambina che non ha voglia di mangiare broccoli ed è turbata soprattutto dall’atmosfera nervosa che si respira tra i suoi genitori. Quando ci sono troppo rumore, troppa confusione e troppa tensione, lei si dilegua dentro il suo posto segreto, in compagnia di un orso rosa, dei suoi attrezzi, di una pelliccia calda. Qui si sente al sicuro, in silenzio e al buio può lasciar riposare la mente e far viaggiare l’immaginazione. È un rifugio dove non c’è spazio per le preoccupazioni. Quando poi la quiete viene interrotta, perché mamma e papà
Giuditta Campello, ill. di Mauro Garofalo
Feltrinelli Kids, 2025, 32 p. (I bruchi)
€ 7,50 ; Età: da 6 anni

la chiamano e le ricordano le verdure da finire, lei continua a vivere la sua avventura immaginaria a cavallo tra i due mondi, interpretando il ruolo di una guerriera che lotta contro gli odiati broccoli che la perseguitano.
Se dentro il ripostiglio magico è il buiopesto - il blu della notte - a fare da sfondo al racconto, una volta fuori dello sgabuzzino ritornano prepotentemente i colori e la luce a inondare le pagine, insieme a oggetti e luoghi familiari della casa. I due orizzonti, quello dell’immaginazione e quello della realtà, sono perfettamente rappresentati dalle due facciate del libro a fisarmonica, che dà voce sia al fertile mondo interiore della protagonista sia alla sua carica vitale. I testi di Claudia Mencaroni, di una notevole capacità introspettiva, sono essenziali, profondi, poetici e, come lei stessa ha dichiarato, fortemente autobiografici. Le illustrazioni di Maria Rico, talento spagnolo dal tratto pittorico e materico, aprono allo spazio sconfinato della fantasia e all’esuberanza incontenibile della protagonista. Un connubio che convince ed è in grado di emozionare lettori e lettrici di diverse età.
Francesca Tamberlani
Una favola inattesa
(Quando il gatto non c’è) i topi ballano. E il gatto, per esempio, può essere la mamma, la maestra, può essere anche la ragazza grande che ti fa da baby sitter – intendiamoci, se sei un bambino come quelli che leggono I bruchi”, libri per bambini piccoli, questo compreso. Altrimenti, per tutti gli altri, quelli che sono già grandi, il gatto è solo quello che sta sopra di loro, perché è più forte, più potente, magari un capo, per intenderci. Perché il celebratissimo detto conia una metafora ricordandosi della favola antica che prevede gli animali al posto degli uomini, che si comportano come in genere si comportano gli uomini, soprattutto nelle malefatte e nei vizi. Dopo questa puntualizzazione, i topi possono irrompere sulla scena. Il segnale di via è inequivocabile: “Clic clac”. È la serratura della porta della casa del gatto, che poi clandestinamente è anche la loro, che si apre e poi si chiude (e allora si capisce che il gatto è uscito!). Quindi, disciplinati dalle indicazioni del Capotopo ballerino – eccolo, spavaldo, ciuffo nero accuratamente esibito – i topi escono dagli anditi più segreti e si accingono ad aprire le danze.
Ci sono ballerine e ballerini che, in costumi che si addicono alle coreografie di balli diversificati, uno per ogni giorno di uscita del gatto, si fanno ammirare dai piccolissimi lettori.
Ma il sabato di quella settimana, quella che cade nelle pagine del libro dei bambini, succede qualcosa che non ci aspetteremmo. Insomma, il gatto che quel giorno non ha incombenze precise (in fondo è sabato), dopo aver bighellonato per un po’, fa dietrofront e avvicinandosi a casa scorge dalla finestra uno spettacolo inaspettato. I topi che ballano. E invece di lisciarsi I baffi in attesa di... si sente offeso, si indigna, (perché non mi hanno invitato?).
E I topi? I topi a loro volta hanno in serbo un’altra sorpresa. Quasi più strabiliante di quella del gatto. Andare a vedere per credere.
Una favola con la sua morale, che si fa beffe in pagine figuratissime e colorate di luoghi comuni, moralismi, e perché no? anche di pregiudizi.
Rosella
Picech
Guia Risari,
ill. di Federico Delicado Kalandraka, 2025, 36 p.
€ 16,00 ; Età: da 5 anni
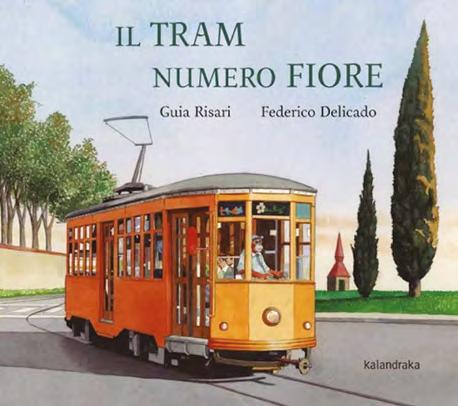
Serena Ballista, ill. di Letizia Iannacone Settenove, 2025, 56 p. (Flush)
€ 21,00 ; Età: da 8 anni

“Disegnare è un’altra forma di linguaggio. È come respirare, come parlare con le dita, come pensare con gli occhi”. Questo afferma Delicado, illustratore dell’albo, realizzato con Guia Risari. E sarebbe bello non dire altro per parlarne, soprattutto se, confermandone l’affermazione, potessimo disegnare una recensione e lasciare che solo alcune volute leggere e colorate restituissero e stimolassero le sensazioni esperite da chi legge il libro, senza ridurlo in parole. Proprio come gli autori riescono magistralmente a fare, intrecciando in modo leggero le parole con “l’altra lingua”, le immagini. Ma noi non abbiamo nelle dita la stessa maestria e allora ne parliamo, sperando di non tradirne lo spirito immaginifico e cercando di trasmettere almeno in parte la sensazione di ricchezza e leggerezza da cui è animato. Laura, una bambina, insegna all’amico Omar, che viene da lontano e soffre di nostalgia per il suo paese di origine, l’esistenza di un tram speciale, che non è segnato con un numero ma con un fiore. Basta salire a bordo – ed è quello che i due fanno – e si inizia un viaggio tra parchi cittadini e radure, innalzandosi in cielo e poi scendendo fino alla superficie del mare. Intanto i paesaggi cambiano, ricchi di particolari sorprenden -
ti da osservare e, mentre si scopre che neanche l’autista, che sembra un po’ un orango, conosce la meta finale, a ogni fermata qualcuno scende, e non è mai un tipo banale: vecchine che sembrano piante rampicanti, mantidi e
scarabei vestiti da umani, ragazze sogliole e cavallucci di mare dallo sguardo intenso. In ogni caso non è la destinazione quello che conta, ci fa capire Laura quando Omar la ringrazia per l’esperienza: prendere il tram numero fiore è alla portata di tutti e, ora che lo sa, può evadere quando vuole da nostalgia e tristezza e tornare ai luoghi che ama. Il testo preciso e colloquiale, dove ogni parola è essenziale e puntuale, dialoga perfettamente con le immagini, nitide, ricche di particolari e colori, di grande impatto e qualità, insieme accompagnandoci, con i due giovani viaggiatori, tra tappe e passeggeri bizzarri di un viaggio che, al voltare pagina, sembra farci arrivare ogni volta una brezza leggera, un respiro che allarga il petto e accarezza l’animo.
Antonella Lamberti
È un’incursione immaginaria nella vita di Virginia quella che presentano Serena Ballista e Letizia Iannacone per i tipi Settenove con il libro Woolf! Woolf!. Un ritratto diverso della sua vita, ma non inedito, che lo stile di Serena riesce a svelare, facendo emergere la voce fluente, empatica e lieve della somma autrice, qui in veste di protagonista. Chi l’ha incontrata nelle sue memorabili pagine, non può non avere percorso il flusso di coscienza che ha fatto camminare i lettori a braccetto con i protagonisti. Anche nelle pagine di Woolf! Woolf! si percepisce questo flusso fatto di routine quotidiane, di microazioni, di legami speciali tra persona e animale. Ecco la scrittrice Woolf, metodica e puntuale, che si ritira nel suo capanno per iniziare una nuova giornata lavorativa, pronta a trovare l’intimità dei suoi pensieri inseguendo un ordine dettato da rituali, quando si accorge di non avere i fiammiferi per assaporare un sigaro prima di dare inizio all’attività. La raggiunge la cagnolina Grizzly, piena di brio e con il pacchetto di fiammiferi stretto in bocca, pronta a giocare e a scombinare i piani della padrona che si mette carponi ad abbaiare anche lei. Quella mattina, come tante, Virginia viene colta improvvisamente dall’ango-
scia per la sua scrittura che sembra essere inceppata, ma l’ondata contagiosa di brio che le porta Grizzly le restituisce la fiducia al punto che Virginia si trasforma in compagna d’avventure della cagnolina e si fa spuntare la coda e le orecchie, pronta per abbandonarsi ai colori e ai profumi che offre una passeggiata all’aria aperta. Alla fine, Virginia ha ritrovato il suo ordine e pensa già che nel suo racconto trasformerà Grizzly in un personaggio. La scrittura rinasce, prende respiro nutrita dall’amore profondo e autentico tra persona e animale: un nuovo ordine viene ristabilito per Virginia. La penna fluente della Ballista, profonda conoscitrice della Woolf non va in contrasto con le tavole della Iannacone che propongono una mescolanza di caldi e freddi, di linee morbide e di segni decisi per mettere in evidenza l’ambiente privato nel quale la scrittrice si muoveva, accompagnata dai suoi fedeli cani, quel legame intimo e indissolubile che Letizia ha già dato prova di conoscere in altre storie.
Adolfina De Marco
inocchio è toscano, italiano, europeo e del mondo, e per la sua storia può anche rappresentare le aspirazioni, i sogni, le avventure e le inquietudini di molti giovani immigrati di oggi.

“Pinocchio è il libro per antono masia dell’identità italiana”, lo scrive Loredana Perla, docente di pedagogia all’Università di Bari, nel libro di cui è coautrice, con lo storico Ernesto Galli della Loggia, Insegnare l’Italia: una proposta per la scuola dell’obbligo.1 L’autrice coordina la commissione del Ministero dell’istruzione incaricata di rivedere le Indica zioni nazionali, ovvero i program mi scolastici. Le tesi del libro, e le successive dichiarazioni del ministro dell’istruzione, hanno suscitato un acceso dibattito perché hanno preso una esplicita posizione a favore dell’ insegnamento della storia d’Italia (“dei popoli italici”), dell’Europa, dell’Occidente, contrapponendoli e criticando le aperture al mondo e l’universalismo cosmopolita delle indicazioni e degli indirizzi culturali precedenti. Le linee pre-
genza e la capacità di comprendere il mondo aumentano con l’apertura e diminuiscono con chiusure come queste. I problemi dell’umanità sono globali, i nostri figli avranno un futuro dove saranno in contatto continuo e sempre più stretto con uomini e donne di altri continenti (… ) Il pianeta affronta una fase delicata, sta crescendo una pericolosa e distruttiva conflittualità (…) l’umanità ha due strade davanti a sé: la prima è rinchiudersi in identità locali, caparbiamente in difesa di sè stesse, incapaci di comprendersi ed accettarsi, e in crescente conflitto, armate l’una contro l’altra. L’altra strada è imparare a riconoscerci, intorno al pianeta, come una comunità unica, ricca di differenze, ma unita dal comune destino. Insegnare ai nostri figli l’identitarismo della storia locale, anziché aprirli alla splendida storia
Anche agli immigrati capita di perdere o di modificare qualcosa della cultura d’origine e di acquistare o di aggiungere elementi della cultura e della lingua dei Paesi attraversati o del Paese di approdo. Si chiama identità arricchita
cedenti, uscite nel 2012, si ispiravano anche ad alcune idee del filosofo francese Edgar Morin. Insomma, schematizzo: più Italia e meno mondo; più patria e meno multicultura. In un intervento sul Corriere della sera del 23 gennaio 2025 intitolato “Andiamo a scuola. Di futuro” il fisico Carlo Rovelli è critico verso questa linea ministeriale e scrive: “L’intelli-
dell’umanità intera, è spingere per la prima strada”. Sulla prima strada gli autori del libro citato, Insegnare l’Italia, hanno convocato due classici della letteratura per ragazzi, Cuore di Edmondo De Amicis e Pinocchio di Carlo Collodi, da proporre e far leggere alle scuole per insegnare l’identità italiana. Mi soffermo sul secondo libro: Pinocchio

Giovanni Capra
è certamente un libro nazionale e locale, italiano e toscano, anzi toscanissimo. Lo rivelano le battute, i modi di dire, i cibi, il paesaggio. Ma è anche conosciuto e letto in tanti Paesi e in tante lingue, è nelle antologie scolastiche di mezzo mondo, è già conosciuto anche da alcuni dei bambini e ragazzi figli di immigrati nelle nostre classi multiculturali ed è il libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia. Pinocchio cammina, corre, è imprendibile, ha le gambe lunghe, non solo il naso.
E dove è stato tradotto ha perso qualcosa della sua cultura di provenienza (l’Italia, la Toscana), e ha acquistato elementi, o caratteristiche nuove, del Paese di arrivo. Anche agli immigrati capita di perdere o di modificare qualcosa della cultura d’origine e di acquistare o di aggiungere elementi della cul-
Le illustrazioni alle p. 18- 58 sono frutto della collaborazione con Mimaster Illustrazione di Milano, che ringraziamo per il prezioso contributo.
Pinocchio dalla testa ai piedi è un albo illustrato che parla di ricerca di identità, ma anche di cambiamento e diversità. Pubblicato da EdizioniPiagge in formato A3, rappresenta una nuova interpretazione del personaggio di Collodi. Ce ne parla l’autrice Laura Izzi, in questa intervista raccolta da Letizia Soriano.
Innanzitutto perché ha scelto proprio Pinocchio? È buffo ammettere che questo libro è nato per un esame all’Accademia di Belle Arti, al corso di Illustrazione. Il professore ci aveva commissionato una personale elaborazione della storia di Pinocchio. Questa storia è iniziata così e mi ha permesso di fare delle scoperte sensazionali: Pinocchio, secondo una ricerca pubblicata dal sito Maremagnum.com (piattaforma on-line italiana per il commercio elettronico di libri), è il libro italiano più tradotto al mondo. Successivamente ho scoperto che ci sono persone così appassionate che lo collezionano in tutte le lingue e in tutti i formati. È stato illuminante capire che tutti, ma proprio tutti, conoscono Pinocchio, per questo mi sono detta “se tutti sanno leggere i significati dei personaggi io posso giocare a destrutturare la storia!”. Una storia conosciuta aiuta ad avere una base di partenza comune, scomporne i significati per ricreare nuovi personaggi ci permette di giocare sulla rottura degli schemi collettivi. Il suo è un libro scomposto, nel senso che si scompone, si muove, e grazie a questo movimento i personaggi acquistano nuove identità.
Come è arrivata questa idea?
Sulla scomposizione ho fatto lunghe ricerche, e ad essa ho dedicato un capitolo della mia tesi intitolata Lo scopo ludico dell’arte. La tesi lega il mondo dell’infanzia a quello del gioco e dell’arte che, secondo me, non devono mai es-
tura e della lingua dei Paesi attraversati o del Paese di approdo. Si chiama identità arricchita. La docente di linguistica della Scuola per Stranieri dell’Università di Palermo, Mari D’Agostino, ha coniato la definizione di “analfabeti plurilingui”, per definire la complessa condizione linguistica di alcuni giovani migranti, analfabeti nella lingua scritta del Paese in cui sono nati e da cui vengono, ma plurilingui nell’oralità per le conoscenze acquistate, anche se in modo disordinato, durante i viaggi nei diversi Paesi attraversati.2 Scrive il filosofo Gianfranco Pellegrino, in Il patriottismo degli immigrati: la lezione di Mattarella: “Identità fisse non esistono, men che meno in un paese ibrido come l’Italia: uno stato giovane con molti dialetti che sono lingue, con una storia secolare di divisioni, con una varietà geografica e culturale enorme. E in generale, in tutti i tempi e luoghi le identità, personali, culturali, politiche, sono porose, sono costruzioni della mente, comunità immaginate”.3
Pinocchio e Giufà, personaggi ponte
Difficile dunque chiudere Pinocchio in una piccola
sere separate se vogliamo avventurarci nell’esplorazione del mondo infantile e se, a questo, vogliamo apportare qualcosa di significativo. Lavorare con i bambini mi ha fatto comprendere che la scomposizione è uno stimolo importante nella creazione: si scompone non per distruggere, ma per definire qualcosa. Quando il bambino fa crollare di proposito una torre creata con le costruzioni, di solito ride. E ride perché vuole ricomporla, vuole sentire il rumore che fa quando cade, ne sta studiando il peso, ne sta studiando il suono e lo spazio che occupa.
Mi ha incuriosita questa incessante ricerca, mi è venuto in mente che molte delle avanguardie artistiche attuano lo stesso processo: il dadaismo, per esempio, ma anche il cubismo. Allora ho unito in un laboratorio giochi di avanguardie artistiche che avevano come base la scomposizione e mi sono messa nella situazione di osservatrice. Adesso ho bisogno di chiederle qualcosa anche sulla scelta del formato.
In effetti è molto grande, un A3! Sono proprio grandi tavole, in un libro così grande ho pensato che un bambino ci potesse entrare, tuffandosi totalmente nell’immagine. In questa opera come ha intrecciato l’aspetto artistico a quello inclusivo e aggregante?
Vorrei che questo albo fosse un ponte, mi immagino due bambini che lo strappano ma poi ci costruiscono personaggi nuovi, una maestra che insegna ai suoi alunni a leg-

patria, eleggerlo e ingaggiarlo addirittura a campione di identità nazionale. E soprattutto perché contrapporlo alla dimensione plurilingue e multiculturale del nostro tempo?. Pinocchio ha diverse identità e molte appartenenze: è toscano, italiano, europeo, e del mondo. E per la sua storia può anche rappresentare le aspirazioni, i sogni, le avventure, le inquietudini di molti giovani immigrati del nostro tempo. Pinocchio sembra assomigliare ai minori stranieri non accompagnati, arrivati senza niente, in cerca di un posto dove vivere. Lo dice il computer, che a un’analisi testuale rivela: la parola più diffusa nel testo di Collodi è “povero” (139 volte), seguita da “casa” (98), e “strada” (69). Quando Mangiafoco chiede a Pinocchio: “che mestiere fa tuo padre?”, lui risponde: “Il povero!”. E com’era la casa di Geppetto?: “Era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. Una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parte di fondo si vedeva un caminetto col
gere usando le poche lettere del libro, un’insegnante di italiano per stranieri che, attraverso una storia conosciuta a livello mondiale, insegna poche parole per volta, oppure un professore alle scuole secondarie che vuole parlare di genere. Mi piace l’idea di aver messo un’opera a disposizione di tutti, e che tutti ne facciano assolutamente quello che vogliono, che continuino a usarla esprimendo interessi, passioni e stimoli. Alle presentazioni succede che qualcuno si avvicini e mi dica come lo userà: sono sempre modi interessanti perché riadattati al proprio mondo. Durante le presentazioni propongo sempre un laboratorio che ricrea un libro sul meccanismo del “cadavre exquis”, basato sulla successione casuale degli elementi. È molto bello sfogliare, rivedere insieme i personaggi che abbiamo creato. In questo piccolo laboratorio passano messaggi di collettività e uguaglianza: il bambino crea un personaggio che viene tagliato in tre parti e che sarà poi inserito in un libro in cui sono presenti anche i personaggi degli altri. A volte i bambini faticano a staccarsi dalla loro creazione ma, alla fine, quando vedono il libro completo ne sono sorpresi e contenti. Questo è quello che intendo per aggregazione. Quanto i bambini con cui lavora ispirano o modificano le idee per i suoi progetti? E quanto hancondizionato l’idea per questo Pinocchio dalla testa ai piedi?

cadavre exquis, un gioco surrealista. Nel laboratorio è venuta fuori l’idea di un libro diviso in tre parti e vedendo quanto i bambini amassero giocarci ho pensato di creare Pinocchio così. Il mio metodo di lavoro è esattamente questo: un’idea che viene messa sul tavolo, pensata con una conoscenza artistica e che poi, insieme alle persone che ho davanti, cambia e si trasforma diventando un’opera unica che può continuare a cambiare. Non mi interessa che ci sia il giudizio estetico o che i bambini siano chiamati a una prestazione o come lo chiamano a scuola al “lavoretto”. Vorrei che passasse un’idea di bellezza fuori dagli schemi: lo scarabocchio, l’incepparsi, l’errore sono oggetti preziosi per tutta l’arte contemporanea oltre a essere così teneramente umani.
Mi piacerebbe sapere se la sua inclinazione al sociale unita, in senso più ampio, all’ attività artistica, si era già affacciata durante l’infanzia e se c’è un episodio in particolare, che ricorda, legato a questo tema.
Il processo creativo di questo libro è partito proprio dal laboratorio con i bambini: dovevo parlare con loro del
fuoco acceso ma il fuoco era dipinto e accanto c’era dipinta una pentola”. I servizi sociali forse avrebbero da ridire sull’ idoneità di questa abitazione di Geppetto, in quanto tutore responsabile che deve accogliere un minore! Pinocchio è un personaggio glocale, capace di contenere in sé la dimensione locale e quella globale. Far dialogare queste due dimensioni è il problema del nostro tempo, e Pinocchio può aiutarci a risolverlo, o almeno a capirlo. È un personaggio ponte, come per certi aspetti è considerato Giufà, il furbo, sciocco, saggio, conosciuto in tanti Paesi e lingue diverse del Mediterraneo e oltre. In Sicilia, e nel sud d’Italia soprattutto, pur essendo Giufà nato nel mondo arabo. Pinocchio è un possibile mediatore culturale, capace di calarsi in contesti linguistici diversi.
Quando Pinocchio sbarcò in Albania
Pinocchio sbarcò per la prima volta in Albania nel 1935. “Il verbo sbarcare è proprio il termine giusto da usare, scrive Mirela Papa, dell’Università di Tirana, nel volume Atlante Pinocchio: la diffusione del romanzo di Carlo Collodi nel mondo. 4 Si racconta che un diplomatico e scrittore albanese, Cuk Simoni, curiosando tra i negozi di Bari, in attesa di imbarcarsi per l’Albania, si imbattè in una edizione di Pinocchio. Lo acquistò, lo tradusse e lo fece pubblicare. Diventò Pi-
Quando ero molto piccola mia mamma lavorava come fumettista, avere una matita in mano per me è stato un passaggio naturale, non ho ricordo di un episodio particolare, il linguaggio dell’arte non mi è sconosciuto, ho sempre avuto grande affinità, e poi lo studio mi ha dato gli strumenti per non subire l’immagine ma vederne sempre la parte latente. Il mondo dell’arte insegna a essere dei ricercatori di fantasia.
noku. e cominciò a circolare con successo, passando indenne anche negli anni della dittatura che invece censurò molti altri libri, anche per l’infanzia. La fortuna del Pinocchio albanese è anche un evidenziatore della vicinanza e delle relazioni tra i due Paesi, della diffusa conoscenza della lingua italiana in Albania, dei clamorosi e sorprendenti sbarchi in Italia che avvengono proprio a Bari nell’estate del 1991 (Gianni Amelio diresse il film L’America, cioè l’Italia vista dagli albanesi), e degli strani sbarchi e andirivieni di migranti oggi nei cosiddetti Cpr (Centri di Permanenza per il Rimpatrio), fatti costruire in Albania dall’attuale governo italiano. Un dettaglio è rivelatore delle mediazioni linguistiche in cui è impegnato Pinocchio: il sopran -
Scoprilo in LiBeRWEB
Orientamenti culturali: idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori, a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale https://shorturl.at/EHGSt

nome di Geppetto, “polendina”, per via della sua parrucca gialla, come la polenta, è stato tradotto in diversi modi a seconda delle diversità linguistiche regionali albanesi: ma cosa è successo in un Paese che non conosce la polenta? In Iran il soprannome è diventato “pappa gialla”, che però sarebbe un dolce, e in Eritrea è stato tradotto in lingua tigrina
tradotta dal francese, e quella egiziana ridotta tradotta dall’inglese, e poi quella tunisina: ogni volta che un traduttore trova nel testo di partenza una parola che non ha un corrispettivo nella lingua di arrivo ha davanti delle scelte. Per la città di Acchiappacitrulli, per esempio, una versione araba attinge al versetto numero quattro della sura delle donne del Corano, e la traduzione, per definire quella città inventata da Collodi, diventa: “un luogo di beatitudine e gusto”. In un’altra traduzione araba, in Egitto, il grillo parlante è stato sostituito dallo scarafaggio parlante. In India Pinocchio, tradotto in diverse lingue sudasiatiche, si chiama Pinto e il cappellino di molliche di pane

che gli ha fatto Geppetto, si chiama Gandhitupi, più simile al copricapo che portava Gandhi, e con il suo nome incorporato!
Come un tortellino di Bologna
In Cina ci sono diverse traduzioni di Pinocchio, e almeno due scuole linguistiche. In una versione, quando Geppetto
Pinocchio è un personaggio glocale, capace di contenere in sé la dimensione locale e quella globale. Far dialogare queste due dimensioni è il problema del nostro tempo, e Pinocchio può aiutarci a risolverlo, o almeno a capirlo
con la parola e l’immagine che indica la chioma gialla di un albero locale. In Ucraina la popolarità del racconto di Collodi è dovuta invece ad un vero e proprio rifacimento, ad opera dello scrittore Aleksej Nikolaevič Tolsto, amico personale di Stalin. Pubblicato nel 1936, con il titolo La piccola chiave d’oro o Le avventure di Buratino. Questo rifacimento toglie, aggiunge, modifica personaggi e situazioni ma soprattutto elimina il carattere pedagogico dell’originale: nel finale il protagonista non si trasforma in un bambino ma resta burattino. È un eroe, rappresentante e guida di una collettività buona contro i nemici, secondo i dettami del realismo socialista.
Pinocchio mediatore culturale in lingua araba
La prima edizione integrale di Pinocchio in lingua araba apparve in Egitto nel 1949, poi seguì la versione libanese ridotta,
racconta che è stato inghiottito da un pescecane (lungo un chilometro!) pronuncia questa frase: “come un tortellino di Bologna”. La traduzione cinese diventa: “come un piccolo raviolo al vapore”. Ma un’altra versione, sempre cinese, traduce con:“come un piccolo raviolo al vapore, di Bologna!...”.
1. E. Galli Della Loggia; L.Perla. Insegnare l’Italia: una proposta per la scuola dell’obbligo, Brescia, Morcelliana, 2024.
2. Mari D’Agostino. Noi che siamo passati dalla Libia: giovani in viaggio tra alfabeti e multilinguismo, Bologna, Il Mulino 2021; G. Favaro. Parole al centro: plurilinguismo e italiano L2, Firenze, Giunti Scuola, 2024.
3. G. Pellegrino.“ Il patriottismo degli immigrati. La lezione scomoda di Mattarella”, in Il Domani, 4 gennaio 2025.
4. M. Papa. Atlante Pinocchio: la diffusione del romanzo di Carlo Collodi nel mondo, Roma, Treccani, 2024.
nche in esperienze complesse quali
l’ospedalizzazione il confronto e il dialogo tra bambini possono aiutare a superare i pregiudizi culturali, le barriere della paura e della disinformazione.
L’esperienza della Piccola Babele all’interno dell’ospedale Meyer nel racconto di Manuela Trinci
Piccola Babele nasce all’interno degli spazi della dell’ospedale pediatrico AOU Meyer IRCSS, nel dicembre del 2021.1 Nasce così, semplicemente con due scaffali tinteggiati di rosa, dal sapore domestico, e soprattutto nasce dopo attente riflessioni a fronte del fatto che fra i tanti bambini ricoverati in ospedale c’erano − e ci sono − anche loro, i bambini che vengono da “altrove”. Bambini scampati a guerre, soprusi, ca restie, miseria e che, al Meyer, da sempre hanno trova to e trovano cure e accoglienza; come pure bambini che magari, pur vivendo in Italia, non hanno reperito nelle loro regioni le cure adeguate alla malattia che li affligge.
Ecco allora che Piccola Babele − uno “scaffale multiculturale”, una raccolta multietnica di libri per bambini, ragazzi e famiglie – si presenta a oggi come una iniziativa origi nale, affatto frequente in un ospedale pediatri co, quasi una sfida e soprattutto un tentativo per rispondere a misura di bambino a un immaginario pervasivo forgiato da confini marcati da fili spinati, aspre rotte di mare e aspre rotte di terra; bambini
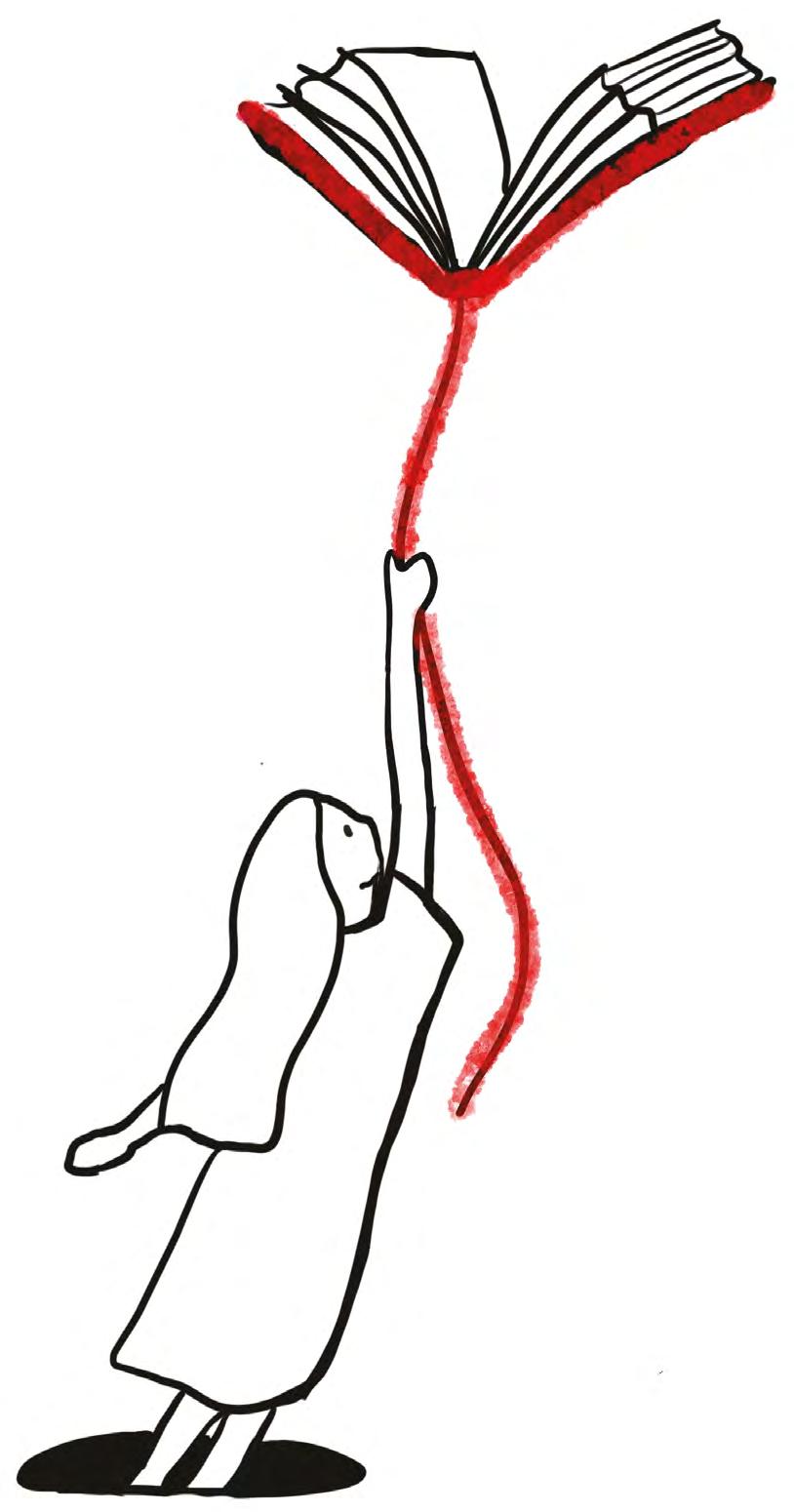
che dormono nelle tempeste con il pollice in bocca come cena fra il puzzo della paura, gli affetti dispersi e gli orrori subiti. Rumori e immagini rubati a video, riviste, telegiornali e ormai penetrati sin nei libri per bambini costruendo una intensa e commovente narrazione di piccoli, quotidiani, eroismi: c’è Akim che corre, fugge, si perde tra i sibili delle bombe; Gago che con altri “invisibili” vive nelle baracche; Amali che arriva con il barcone tra lacrime salate e amare come le gocce del mare; Nadeem, piccolo nativo del villaggio Naomez, che per due soldi di lavoro si sposterà di terra in terra, c’è Iqbal venduto, a 4 anni, per 12 dollari a un fabbricante di tappeti, c’è il coraggio di Malala traversata testa-collo da una pallottola assassina e ci sono Fuad e Jamila, il naufragio, la paura della morte e il vagito, il primo, della loro bambina nata, lì, sulla “carretta” scricchiolante, fra un cumulo di corpi aggrappati fra loro come formiche prima di annegare. Uno dei massimi esperti in materia di intercultura, Vinicio Ongini, ha guidato per noi la suddivisione tipologica dove sono allineati: libri in lingua originale,

foto e documentari; libri bilingui e plurilingui; storie di immigrazione, storie di emigrazione. Libri dunque che vengono da lontano. Libri reportage che trattano il duro viaggiare con la narrazione dei sentimenti a questo correlati; libri che attingono al patrimonio fiabesco e sentimentale appartenente a differenti paesi del mondo. Libri tutti che contengono pensiero e lo mostrano sorprendendo, sovvertendo, senza moralismi né buonismi. Libri che descrivono il mondo secondo prospettive diverse, con linguaggi, stili, alfabeti che dipingono e offrono narrazioni plurime, attivando quindi nei bambini la capacità di decentrarsi dal proprio punto di vista, imparando a considerare il proprio modo di pensare non come l’unico possibile o legittimo, ma uno fra i tanti.
Con Piccola Babele si è mirato, vale a dire, a favorire la riflessione sulla complessità e parzialità dei punti di vista; una necessità resa ancora più urgente per chiunque, in condizione di malattia e ospedalizzato, stia vivendo uno stato di bisogno e di dipendenza, dove più che mai nella comunicazione con l’altro sono necessari rispetto, risonanza emotiva, empatia, apertura alla speranza. Tutto questo è stato costruito senza trascurare la migliore intenzione di trasformare questa straordinaria opportunità di intrecci e di transiti multiculturali in una occasione di crescita, di avvicinamento democratico e costruttivo alla diversità per tutti i piccoli ricoverati e per gli adulti a loro vicini. In Ludobiblio hanno quindi preso il via alcuni atelier di narrazione e d’arte, dove gli educatori, utilizzando il “metodo narrativo” − forse il metodo più caldo e accogliente per proposte interculturali − sollecitano e intersecano racconti di giochi, avventure, cartoon, leggende, musiche, cibi, fiabe, di terre e paesi ora lontani, ora reali, ora solo immaginati e sognati. Centrali rimangono i presupposti dell’ “educazione al presente”, che per gli educatori ospedalieri significa soprattutto avere
un doppio sguardo, uno sguardo attento e sollecito rivolto alla delicatezza della situazione di vita presente dei ricoverati, e uno sguardo, altrettanto attento e sollecito, rivolto a quel che accade nel nostro pianeta così che non si interrompa nei bambini ricoverati il loro essere cittadini-del-mondo, isolandoli e racchiudendoli, di contro, nei luoghi della malattia, con un conseguente, penoso, impoverimento delle loro peculiarità immaginative.
Spontaneo sorge però l’interrogativo del perché leggere, perché raccontare, perché scegliere un buon libro in mezzo a sofferenze, calamità, malattie? Una risposta possibile sta forse nel fatto che la letteratura è ancora quella metafora della vita che continua a riunire in uno spazio comune chi narra e chi ascolta per far nascere una storia che almeno per un momento curi con la parola, raccolga e metta insieme e oltrepassi le zone più inospitali di sé. Per avere la possibilità di aprire la mente, di comprendere, di immaginare soluzioni, di avere gli strumenti, nella ragione e nei sentimenti, per essere dentro alla vita: per avere desiderio di cambiarla quando è necessario, per disubbidire quando non si tratta di un capriccio ma di un sovvertimento di qualcosa di ingiusto. Per ritrovarsi. E questo, per dirla con Calvino, solo la letteratura può farlo. Perché la letteratura è la grande alleata della conoscenza. Inoltre, alle molteplici pratiche educative negli spazi rivolti all’infanzia (nidi, scuole, biblioteche, ludoteche) Marie Rose Moro – neuropsichiatra infantile, etnopsichiatra, docente Paris 13 – affida il ruolo salvifico della “rinascita”, della mediazione necessaria, dell’integrazione, tra il mondo interiore dei piccoli “stranieri” − il mondo legato all’affettività e all’universo culturale dei genitori − e il mondo esterno del contesto sociale; quello, vale a dire, retto dalle regole del paese ospitante, e nel nostro caso, in particolare, legato alle rappresentazioni del benessere come della malattia. La malattia, l’ospedalizzazione, ha poi annotato Marie Rose Moro, rende i bambini venuti da “altrove” doppiamente esposti, più vulnerabili; “bambini di vetro”. Riallacciare, elaborare, condividere, rinarrare la loro storia familiare e la loro appartenenza – preciserà poi la etnopsichiatra parigina – è una necessità: “la storia familiare è una riva dalla quale parte il loro viaggio e l’approdo al quale tornare di volta in volta per ritrovare memoria e narrazioni”. Spesso il bambino “straniero”, il bambino “estraneo” è diviso fra due mondi e due culture diverse che, osserva ancora Moro, si influenzano in modo circolare, in una condizione esistenziale da lei definita “cultura in movimento”. In questo senso, anche in esperienze complesse quali l’ospedalizzazione − usufruendo degli arricchimenti che si possono trarre dalla reciprocità degli scambi − saranno proprio il confronto e il dialogo tra bambini ad aiutare a superare i pregiudizi culturali, le barriere della paura e della disinformazione, perché, come recita un proverbio indiano, “con i nostri occhi vediamo il mondo intero eccetto i nostri stessi occhi”.
1. Il progetto Piccola Babele è sostenuto nella sua progettualità e realizzazione dalla Fondazione Anna Meyer. Si ringrazia Vinicio Ongini per i suoi attenti, generosi, consigli. Si ringraziano le colleghe della Direzione Scientifica: Maria Baiada e Daniela Elettra Papini e gli educatori della cooperativa Arca in servizio presso la LudoBiblio (C. Micheli, C. Barbieri, C. Gori, T. Lanza, E. Nuzzi, L. Segantini, E. Vezzosi, I. Vitali).
eggere, discutere e commentare con ragazze e ragazzi il racconto Nel paese dei ciechi di Wells consente di affrontare un tema delicato e complesso come l’integrazione senza formulare giudizi e prescrivere schieramenti.
Ciascuna epoca, e ciascuna cultura, generano e utilizzano “parole chiave” che indicano e orientano pensieri e azioni. Un termine oggi molto presente, se non abusato, in ambito educativo e nel linguaggio della politica è inclusione, e così dicasi dell’aggettivo inclusivo.
Concetti inflazionati come questo costituiscono al tempo stesso una risorsa e un pericolo. Una risorsa perché indicano, orientano, aggregano, ma anche un pericolo perché, trasformandosi spesso in slogan, si auto-banalizzano e perdono la problematicità e la capacità di “sospendere il giudizio” che dovrebbero
caso spesso assumono, anche arbitrariamente, il rilievo univoco del logos, mentre nel secondo possono conservare l’opportuno tono problematico e aperto alla negoziazione.
Cerchiamo allora di condurre un’esplorazione sul campo semantico dell’inclusività mediante l’associazione a termini analoghi o antinomici che ci aiutino a metterlo a fuoco.
Accoglienza, segregazione, esclusione, integrazione, inclusione Le cinque parole indicano comportamenti differenti e, a due
L’integrazione mantiene una visione “speciale” del soggetto, e presuppone la necessità di intervenire con strategie particolari mentre l’inclusione prevede che le regole e le routines del contesto debbano essere riformulate avendo presenti tutti i componenti, ciascuno con la propria specificità
sempre accompagnarli. Ed è poi vero che queste parole possono assumere prospettive di senso differenti se scritte o se utilizzate nella dimensione dell’oralità e del dialogo: nel primo
a due, antitetici. Accoglienza occupa uno spazio semantico molto largo. Essere accoglienti o meno è una caratteristica individuale che riguarda i normali rapporti interpersonali,
gli stili relazionali, e non solo le scelte politiche: può essere o no accogliente chi gestisce lo sportello di un pubblico servizio, un medico, il gestore di un bar, un insegnante. Le tre parole esclusione, segregazione e integrazione, sono esplicite e per

così dire plastiche, tutte e tre prevedono un margine netto che segna un dentro o un fuori, ma, nel caso della segregazione, gli esclusi sono anche inclusi in un insieme a sé stante. Perché includere deriva dal latino in, ‘dentro’ e claudêre ‘chiudere’. A ben vedere dunque letteralmente, e paradossalmente, Rebibbia è un perfetto luogo di inclusione, anche se accoglie soggetti segregati.
Nell’integrazione ci sono soggetti che entrano in un insieme di cui prima non facevano parte, ma ne rimangono comunque separati, raggruppati all’interno di un sottoinsieme ben distinto. Antropologicamente è il modello definito multiculturale, il melting pot in cui culture (o subculture) diverse convivono nello stesso territorio, ma il singolo quartiere (cinese, afro-americano…) rimane separato e distinto. Nell’inclusione, in teoria,
limite, a essere il risultato di un’interazione negativa con il contesto. In contesti diversi, infatti, una persona può essere disabile o abilissima. In una società belligerante e violenta, o semplicemente fondata sulla prestanza fisica, come una comunità agricola, di allevatori, di “frontiera”, risulta “handicappata”, come si diceva una volta, la persona fisicamente meno dotata, e già l’anzianità è condizione di disabilità; in un contesto di elevato sviluppo intellettuale e simbolico il disabile è chi ha difficoltà cognitive o il poco acculturato, anche se forzuto e coraggioso, e spesso l’anziano è oggetto di stima e riguardo. Inclusione e integrazione sono parole spesso utilizzate come sinonimi, ma, pur avendo in comune il presupposto dell’accoglienza, l’integrazione mantiene una visione “speciale” del soggetto, e presuppone la necessità di intervenire con strategie particolari (a scuola corrisponde al modello della classe speciale nella comunità scolastica), mentre l’inclusione prevede che le regole e le routines del contesto debbano essere riformulate avendo presenti tutti i componenti, ciascuno con la propria specificità. Nel secondo caso si afferma cioè “il valore della differenza” ed è il soggetto, con il portato di unicità che gli è proprio, ad accedere comunque alla condizione di “normalità”. Quest’ultima, peraltro, è la scelta che, almeno nelle intenzioni e nelle formulazioni programmatiche, ha compiuto la scuola italiana, dove qualsiasi persona portatrice di qualsiasi attributo di diversità entra nella comunità alla pari degli altri. E, dalla scuola, questo principio dovrebbe, secondo le intenzioni del legislatore, passare a tutto il contesto sociale, dove l’inclusione è dichiarata un diritto fondamentale ed è collegata al concetto di appartenenza, condizione necessaria per “star bene” in un luogo, in una comunità.
Nel paese dei ciechi, un racconto sull’ambivalenza “Trecento miglia e più dal Chimborazo, un centinaio dalle nevi del Cotopaxi, tra le più selvagge solitudini delle Ande ecuadoriane, giace, separata dal mondo degli uomini, quella misteriosa vallata montana, il paese dei ciechi”. 1 Così comincia il racconto di fantascienza Il paese dei ciechi, tradotto anche col
L’ambivalenza caratterizza l’autenticità, perché un sentimento univoco, senza contraddizioni e oscillazioni, è lo stereotipo di sé stesso. Sentimenti considerati positivi, come l’amore, la cura, portano con sé l’ombra ambivalente del possesso e del controllo
tutti si trovano liberi, con le stesse opportunità, all’interno dello stesso spazio, senza che le caratteristiche culturali o personali determinino la posizione sociale all’interno del gruppo. È, quest’ultimo, il modello definito interculturale. Da qui il successo del termine da parte di chi tifa per l’accoglienza. Cosa accade, a questo proposito, nella labirintica complessità delle interazioni tra gli esseri umani? Tralasciamo per un attimo il fenomeno dell’immigrazione e riferiamo la categoria dell’inclusione al problema della cosiddetta disabilità: quale criterio ci permette di effettuare la distinzione fra persone “normali” e disabili? Il concetto stesso di normalità è molto debole. Franco Basaglia era solito sostenere che, visto da vicino, nessuno è normale. Lo stesso concetto di disabilità, d’altra parte, è passato dall’essere collegato a una mancanza, un difetto, un
titolo Nel paese dei ciechi, pubblicato nel 1904 da Herbert George Wells nella rivista The Strand Magazine e nel 1911 nella raccolta di storie di Wells dal titolo The Country of the Blind and Other Stories. A seguito di una rovinosa caduta lungo una montagna della cordigliera andina, il protagonista Nuñez si risveglia in una bella e rigogliosa vallata che ospita il Paese dei Ciechi, isolato dal mondo da trecento anni a seguito di un’eruzione vulcanica e di un terremoto.
“Si rizzò a sedere e vide che era su una piccola alpe ai piedi di un vasto precipizio, solcato dal canalone lungo il quale era ruzzolato lui e la sua neve. Dirimpetto un’altra parete di roccia si ergeva contro il cielo. Sotto di lui sembrava esserci un precipizio altrettanto ripido, ma dietro la neve del canalone egli trovò una sorta di fenditura a cammino, gocciolante di neve disciolta,

giù per la quale un uomo disperato poteva forse arrischiarsi. Il passaggio riuscì più facile di quanto sembrava, e Nuñez giunse infine in un’altra alpe e poi dopo un’arrampicata non particolarmente difficile a un rapido pendio boschivo. Si orientò e volse il viso giù per la gola, poiché vide che essa si apriva in alto su prati verdeggianti, in mezzo i quali ora distinse chiaramente un gruppo di casupole di pietra di foggia inconsueta”. 2
In quel luogo, ricco di pascoli e coltivazioni, Nuñez è sorpreso dalla bellezza della natura, dalla perizia regolare delle coltivazioni e delle strade che costeggiano case dotate di porte ma senza finestre. L’incontro con i nativi, dopo un’iniziale e comprensibile diffidenza, ha buon esito. Gli abitanti sono accoglienti e ben disposti nei confronti dello straniero. D’altra parte la loro prudenza è comprensibile: sono tutti ciechi. I bambini nascono senza gli occhi, probabilmente a causa di un‘infezione protrattasi nei secoli, ma quello stato non è vissuto da essi come una menomazione e rappresenta, anzi la normalità. Le stesse parole “vista”, “cecità”, “occhi”, sono per loro sconosciute e prive di significato, il mondo è percepito e rappresentato, perfino nel loro mito cosmogonico, attraverso l’olfatto, l’udito e il tatto. Nuñez si rende conto di ciò perché ogni volta che prova a spiegare la differenza che distingueva lui da loro, i ciechi proprio non capiscono, le parole che descrivono la facoltà del vedere vengono vissute come suoni senza alcun senso.
“Il cieco più anziano gli spiegò la vita, la filosofia, la religione: che il mondo (ossia la loro valle) era stato dapprima una vuota cavità nelle rocce, e poi erano venute anzitutto cose inanimate, prive del dono del tatto, e i lama e alcune altre creature di poco senno, e poi gli uomini, e infine gli angeli, che si udivano cantare e frullare per l’aria ma non si potevano toccare; e questo lasciò grandemente perplesso, finché non gli vennero in mente gli uccelli. Il vecchio proseguì spiegando a Nuñez che il tempo era stato diviso in caldo e freddo (gli equivalenti ciechi del giorno della notte), e che era bene dormire durante il caldo e lavo-
rare durante il freddo: sicché adesso, se non fosse arrivato lui, tutta la città dei ciechi sarebbe stata a dormire. Disse che certo Nuñez era stato creato appositamente per apprendere e servire la sapienza da essi acquisita, e che nonostante il vaneggiare della sua mente e le goffaggini del comportamento egli doveva avere coraggio e fare del suo meglio per imparare (la gente attaccata sulla porta diede un mormorio di incoraggiamento”.3 Promuovere il benessere di un individuo significa favorire la sua interazione positiva con l’ambiente che a sua volta possa risultare un contesto inclusivo. L’ambiente naturale, alla pari di qualsiasi altro ambiente, può essere un interlocutore educativo e offrire opportunità, stimoli, guidare alla scoperta, all’esperienza delle proprie possibilità e dei propri limiti. Può divenire un veicolo di inclusione.
Ma se, come in questo caso, i detentori della presunta rappresentazione “normale” hanno un’idea dell’ambiente del tutto differente da quella che il soggetto accolto costruisce attraverso i propri requisiti differenti, che succede? Nuñez vede, ed è convinto che questa facoltà sia un vantaggio, considera “disabili” i suoi ospiti e fantastica di diventare il capo della comunità in nome del principio secondo il quale “in terra di ciechi il monocolo è re”, ma per i nativi il disabile è lui e va incluso e integrato attraverso un processo di rieducazione.
La sapienza narrativa di Wells mostra con evidenza come le migliori intenzioni e i più apprezzabili sentimenti siano sempre carichi di ambivalenze. D’altra parte la psicoanalisi, e in particolare Melanie Klein, considera l’ambivalenza una caratteristica essenziale e positiva della madre nella relazione col figlio.4
L’ambivalenza caratterizza l’autenticità, perché un sentimento univoco, senza contraddizioni e oscillazioni, è lo stereotipo di sé stesso. Sentimenti e comportamenti considerati positivi, come l’amore, la cura, portano sempre con sé l’ombra ambivalente del possesso e del controllo. E l’ambivalenza fra desiderio di integrarsi e pulsione di ribellione occupa la mente di Nuñez, che inscena una fuga, scontrandosi a colpi di vanga con i suoi sorveglianti-educatori.
“Appena in tempo udì passi alle sue spalle, un uomo d’alta sta-
tura avventò un colpo nella sua direzione sonora. Sgomento scagliò la vanga a un metro dall’assalitore, girò su sé stesso e fuggì, urlando nello schivarne un altro. Era sopraffatto dal panico. Corse furiosamente su e giù, schivando dove non c’era bisogno di schivare, e inciampando nell’ansia di guardarsi a un tempo ad ogni lato. Per un momento fu a terra, e udirono la sua caduta. Una piccola apertura nel muro di cinta, lontano lontano, gli parve paradisiaca, e corse verso di essa a perdifiato. (…) Alla fine si trascinò fino al muro del paese dei ciechi nell’inten to di patteggiare. Si trascinò lungo il rivo, gridando, finché due ciechi uscirono dalla porta e gli parlarono. “Sono stato un pazzo” disse. “Ma ero creato da poco“. Quelli dissero che così andava meglio. Disse che ora era più savio, e si pentiva di ciò che aveva fatto, poi pianse, sinceramente, perché era molto debole, stava male; e lo presero come un segno favorevole. Gli domandarono se credeva ancora di poter vedere. “No” disse. “Era una follia. Questa parola non significa niente… Meno di niente!”.5
Nuñez si innamora di una ragazza della vallata, Medina-Saroté, che ricambia il suo senti mento. Il processo di inclusione sta per concludersi, già si parla di matrimonio, anche se non mancano, nella comunità, dubbi e diffidenze. Finché il medico-stregone, diagnostica che la follia di Nuñez dipende dalla presenza, sul suo volto, di quelle strane protuberanze munite di ciglia che si muovono e provocano nel cervello uno stato di irritazione e logoramento.
E sentenzia:
Il bagliore del tramonto si spense, e scese la notte, ed egli giacque contento, pacificato, sotto le fredde stelle”.7
Possiamo, a questo punto, formulare una riflessione più generale. Un mantra assai diffuso negli anni ’70 del Novecento ripeteva che tutto è politica. Ma forse questo principio va ripensato: la politica ha meccanismi propri e nasconde ciò che non le è funzionale. La pratica politica, poi, è sempre più ricerca del nemico da combattere e difesa ossessiva della propria fazione, ma la nostra vita psichica ha bisogno anche di altro.

Per esempio di riconoscere e accogliere il dubbio, l’ambivalenza, la domanda, spesso ben più importante della risposta. A questo serve la letteratura, per questo sono importanti i racconti, le narrazioni e il dialogo e il commento che portano con sé. Leggere, discutere, commentare, a scuola, il racconto di Wells, consente di affrontare un tema delicato e complicato come l’integrazione senza formulare giudizi e prescrivere schieramenti.
Non è in discussione il valore etico e politico dell’accoglienza, ma è giusto chiarire che accogliere necessita di curiosità, prudenza e capacità di decentrarsi, perché l’integrazione è una questione di reciprocità, e chi siano gli accoglienti e chi gli accolti, come ci mostra Wells, non è sempre chiaro.
“E io penso di potere dire con ragionevole certezza che per guarirlo completamente altro non occorre se non una semplice e facile operazione chirurgica: asportare cioè questi corpi irritanti”.6 E Nuñez, dopo essere stato tentato dall’idea di sacrificare la sua vista per amore e per desiderio di inclusione, pur pieno di dubbi e di dolore, scappa, scala la parete lungo la quale era caduto. Lacero, ferito e sfinito, si avvicina al picco che ancora lo separa dal mondo, ma lo allontana definitivamente dal paese dei ciechi, e si ferma per riposarsi.
“Dal punto in cui riposava, la valle pareva situata in fondo un pozzo, quasi un miglio più in basso. Già era velata da ombre e di foschia, sebbene intorno a lui le vette dei monti fossero tutte luce fuoco. Nelle rocce vicine certi particolari erano intrisi di una delicata bellezza: una vena di minerale verde affiorante nel grigio, lampi qua e là di sfaccettature cristalline, un minuscolo lichene di un bel colore arancio a un palmo dal suo viso.
Nella gola c’erano ombre profonde, misteriose, di un blu cangiante in violetto, il violetto in un’unità luminosa, e c’era, sopra, l’illimitata vastità del cielo. Ma a queste cose egli non prestava più attenzione giaceva immobile, sorridendo come fosse semplicemente soddisfatto di essere scampato dalla valle dei ciechi, dove aveva creduto di essere re.
Jonathan Bazzi, giovane romanziere dalla solida formazione filosofica, in un bell’articolo sulla rivista Finzioni, sostiene che frequentare la letteratura significa “tornare al sentimento dell’ampiezza della nostra esperienza e del nostro desiderio, desiderio che spesso è cangiante, opaco. (…)Tornare alla letteratura significa non lasciarsi ridurre a corpi che in eterno urlano solo il loro rancore, i loro bisogni primari, le loro ferite: riprenderci il privilegio di quel libero gioco tra le facoltà, liberatorio, ri-creativo, che per Kant costituiva l’esperienza estetica, quella legata all’arte grazie alla quale riconoscere che in noi, anche in noi, come diceva Jung, convivono il ladro, la prostituta, il folle, l’omicida”.8 Di questo, oggi più che mai, abbiamo molto bisogno.
1. H.G. Wells. Nel paese dei ciechi, trad. Franca Salvatorelli, con una nota di Sandro Modeo, Milano, Adelphi 2008, p.11.
2. H.G. Wells. op. cit., 2008, p. 18.
3. H. G. Wells. op. cit., 2008, p.27.
4. M. Klein. Scritti, Torino, Bollati Boringhieri, 1990.
5. H. G. Wells. op. cit., 2008, p. 36-38.
6. H.G. Wells. op.cit., 2008, p. 43.
7. H.G. Wells. op.cit., 2008, p. 48-49.
8. J. Bazzi. “L’intelligenza della letteratura può salvarci dal brutalismo degli algoritmi”, Finzioni, supplemento del quotidiano Domani, sabato 12 dicembre 2024, p.7
agionare con bambine e bambini sulle diversità linguistiche a scuola è una grande opportunità per giocare sul tema, approfondirlo e fare straordinarie scoperte.
Una conversazione con Franco Lorenzoni, a cura di Ilaria Tagliaferri
I.T. Lavorando da tempo con i bambini quali sono state le esperienze più significative che ha costruito sulla dimensione multiculturale delle classi scolastiche? Ci sono degli strumenti che ritiene particolarmente significativi in questo senso?
F. L. La presenza in classe di figlie e figli di famiglie immigrate da decenni è ormai diffusa in tutto il territorio nazionale. Vanno tuttavia distinte due condizioni: per coloro che sono arrivati recentemente c’è un problema linguistico da affrontare, e lo si può fare in modi diversi. Per le bambine e i bambini – la mia esperienza è soprattutto nella primaria – credo possa essere una grande esperienza l’assumersi la responsabilità di offrire una nuova lingua a chi è appena arrivato e magari non sa bene l’italiano. Questo apprendimento per immersione offre tra l’altro ottime possibilità di ragionare sulla lingua, perché credo che in tanti campi sia bello sperimentare quante possibilità offra l’imparare insegnando. A me è capitato più volte con le mostre matematiche, in cui tutte e tutti i bambini spiegavano le loro scoperte ai compagni di altre classi, ai genitori e alle persone del quartiere della città e, spiegandole, le capivano meglio perché avevano l’occasione di tornarci e ritornarci sopra. Ecco allora che avere un compagno o una compagna in classe che non conosce bene la lingua italiana è uno straordinario stimolo
per ragionare e lavorare sulla lingua italiana, sulla nostra lingua di cui diamo troppe cose per scontate. Sappiamo bene che la lingua, quella che parliamo ogni giorno, la si impara molto di più giocando tra pari nella vita quotidiana che non a scuola. È la vita che insegna a parlar. Poi, naturalmente, c’è una sistematizzazione che avviene a scuola. Un gioco che mi è capitato spesso di proporre è quello di andare alla ricerca delle Scoprire in una lingua quelle parole che sono intraducibili perché fanno parte, in qualche modo, di una specie di una sorta di miniera segreta che solo quella lingua possiede.
Charlotte Parente

I.T. Ci fa un esempio di questo gioco?
F. L. Prendiamo per esempio il verbo ensimismarse, che Gabriel Garcia Marquez utilizza in Cent’anni di solitudine per descrivere il carattere di alcuni uomini della famiglia Buendia. È una parola intraducibile e ci insegna a capire che ogni lingua ha una sua ricchezza, una sua peculiarità: bisogna stare molto attenti a non stabilire una gerarchia rigida tra le lingue, come se ci fossero lingue di serie A e di serie B. Questo è molto importante, perché il bambino o la bambina che ha un’altra lingua materna alle spalle, nella quale forse sogna o certe volte pensa, deve sapere che quella sua lingua ha una sua ricchezza, dignità e profondità, anche se nel nostro paese magari la parlano in pochi. E questa ricchezza è importante che sia riconosciuta nella scuola, che dovrebbe essere il tempio della curiosità reciproca.
Nisrin, una bambina la cui famiglia proveniva dal Marocco, ha detto un giorno una frase molto bella: “La matematica per me è un omino che corre in bicicletta dentro la testa. Se si ferma, cade”. Questa frase ci è molto piaciuta perché ci appariva strana, curiosa. Parlando con il padre della bambina mi ha raccontato che in arabo matematica si dice alraiat, che vuol dire allenamento, esercizio ginnico, anche acrobazia. Questo mi ha fatto pensare che questa metafora bellissima che aveva immaginato Nisrin derivava dalla sua lingua materna. Questo ci dice che l’incontro tra lingue, se gli diamo il valore che merita, può diventare un grande gioco che appassiona i bambini. Il tradurre è un’attività straordinariamente complessa, ricca e anche divertente. Questo per dire che certe volte noi vediamo solo le difficoltà, che pure ci sono, e sottovalutiamo le opportunità, le porte che si aprono. In classe avere vive tra noi memorie di tante lingue, che naturalmente sono anche concezioni del mondo e modi di guardare la realtà, arricchisce il gruppo. Certo ci dobbiamo lavorare e ragionare sopra con attenzione e curiosità, dandoci l’occasione di valorizzare le nostre differenze e renderle nutrimento del gruppo.
Certe volte a noi insegnanti viene da dire ai genitori di origine straniera: “Mi raccomando, a casa parlate italiano, non parlate la vostra lingua!”: è un errore gravissimo perché per imparare a parlare bene l’italiano è molto importante praticare e possedere bene la lingua materna.
I.T. Ci racconta un aneddoto legato a questo uso della lingua materna?
F. L. Ho avuto in classe per cinque anni una bambina, Emilia, che aveva il padre uruguayano e la madre belga. Emilia, in tutte le discussioni, sosteneva che bisogna sempre considerare anche un altro punto
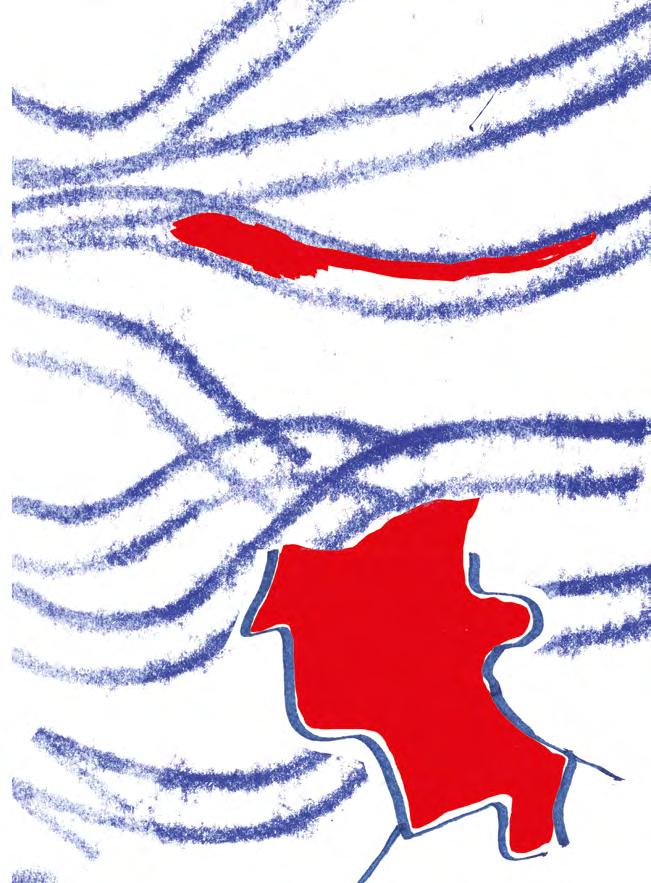
di vista. Questa sua propensione a sottolineare la relatività di ogni affermazione derivava chiaramente dalla sua esperienza. Aveva infatti una particolare sensibilità nel vedere le cose in un modo, ma anche in un altro. Una volta, lavorando sul tema della non-violenza, Emilia propose per un testo collettivo che stavamo scrivendo queste parole: “Gandhi non dava ragione a uno ma a due”. Per me questa frase è una delle più belle definizioni della nonviolenza che io abbia mai ascoltato. Nelle settimane successive ci ha portato a interrogarci su cosa volesse dire dare ragione a due. Le risposte, i ragionamenti che ne sono scaturiti sono stati molto profondi e intriganti. Sono sicuro che la consapevolezza di Emilia, la sua sensibilità, derivavano dal suo parlare correntemente tre lingue, dall’essere nata da un incrocio tra sangui e storie diverse. In quinta primaria stavamo costruendo corrispondenze fantastiche con personaggi del passato e al gruppo di Emilia erano arrivate lettere da Erodoto. Quando i bambini scoprirono che il fondatore della Storia − che ha intitolato il suo grande libro Le Storie, al plurale! − era figlio di madre greca e padre persiano, che era come essere oggi figlio di una palestinese e un israeliano, cioè due popoli in guerra tra di loro, furono entusiasti.
Scoprimmo insieme che una materia straordinaria come la Storia fu inventata da un uomo figlio di due culture diverse, in guerra tra loro. È un aspetto affascinante, che ho raccontato nel libro I bambini ci guardano:un’esperienza educativa controvento (Sellerio, 2019), dedicato all’intercultura.
I. T. Secondo lei la scuola oggi è davvero pronta ad accogliere la multicultura e l’incontro fra lingue ed etnie diverse?
F. L. La scuola è il luogo pubblico che ha lavorato meglio sull’integrazione tra culture diverse. In modi e con risultati molto diversi, naturalmente, perché tutto ciò che riguarda la scuola è a macchia di leopardo. Ci sono istituti dove si sperimentano percorsi interessantissimi e all’avanguardia, e altri dove si fa più fatica per molteplici ragioni. In generale la scuola primaria, la scuola dell’infanzia e anche i nidi, sono i luoghi dove si sta lavorando meglio, anche perché sono scuole che si fondano sulla relazione e l’ascolto e dunque alle maestre e maestri viene naturale l’affrontare con sensibilità e attenzione il tema delle differenze. Nelle scuole superiori di primo e ancor più di secondo grado professoresse e professori sono molto presi dal cosa devono insegnare e da quanto gli studenti debbano apprendere. Il rischio allora è che sottovalutino quanto la cultura sia sempre luogo di relazioni, e che valorizzare i diversi modi di pensare presenti in classe arricchisca la didattica.

eatro delle ombre, dei burattini e kamishibai, attraverso un lavoro quotidiano in classe, diventano strumenti per favorire l’incontro, la creatività e il superamento delle barriere linguistiche.
L’esperienza della scuola primaria Carlo Pisacane di Torpignattara nel racconto di Felicita Rubino
Le classi della mia scuola hanno tutte una caratteristica comune: un melting pot di etnie in pochi metri quadrati. Anche le docenti e i docenti hanno un profilo singolare: sfidano l’impossibile! Quando viene chiesto ai docenti qual è la mission di una scuola in cui si intrecciano culture, religioni e lingue differenti, la risposta che viene data è la presenza di laboratori, progetti, feste, in cui sono coinvolti, genitori, associazioni, artisti. Una comunità educante che collabora in sinergia, affinché tutti abbiano opportunità e vantaggi, dove nessuno si senta escluso dal processo educativo e didattico. A fronte di questa grande organizzazione costruita nel tempo, c’è però an-
mille potenzialità, ma anche dalle mille difficoltà. È così che nascono le sperimentazioni, grazie a una creatività che si sprigiona e si contamina, ed è così che nascono i nostri laboratori teatrali delle ombre, dei burattini e del kamishibai: per dare una chance, soprattutto a chi parte svantaggiato o penalizzato dalla propria condizione personale e/o sociale.
Il teatro delle ombre: la magia dello schermo “Le ombre si muovono, si girano verso di me, vogliono che io presti attenzione al loro destino” diceva Ingmar Bergman. Il teatro delle ombre è la soluzione perfetta per dar vita a rac-
Essere dietro uno schermo permette anche ai più timidi e introversi di potersi esprimere senza essere visti, e anche chi ha difficoltà linguistiche riesce a trovare il proprio canale espressivo perché le figure si muovono e hanno vita propria, dando vita alle scene
che un quotidiano che fa la differenza: docenti che accolgono e che si impegnano nella realizzazione di un presente, dove ogni bambino e ogni bambina è protagonista e valorizzato. Docenti che consapevolmente hanno scelto questa scuola dalle
conti fantastici. Il racconto è l’elemento principale di questo percorso, dove ognuno inventa una storia con dei personaggi, costruisce le proprie sagome con cartoncino, forbici, scotch, stecchini, e infine con un telo bianco e una torcia dà vita alla

propria storia, creando un’atmosfera magica nel buio dell’aula e nel silenzio più totale, dove ognuno è in tento ad ascoltare le storie altrui, dove ognuno si sente libero di esprimere i propri sogni a occhi aperti. Il teatro delle ombre con la sua sugge stione è perfetto per una didattica inclusiva, perché in esso si combinano varie discipline multicanale/multisensoriale, intrecciate con l’attività creativa. Essere dietro uno schermo permette anche ai più timidi e introversi di potersi esprimere senza essere visti, e anche chi ha difficoltà linguistiche riesce a trovare il proprio canale espressivo perché le figure si muo vono e hanno vita propria, dando vita alle scene. Utilizzare i diversi linguaggi come un film, una drammatizzazione o un dipinto può rappresentare la svolta per apprendere in modo motivante e inclusivo. Utilizzare il teatro delle ombre, così come quello dei burattini o del kamishibai, facilita l’apprendimento linguistico per tutta la classe, ma in particolare per gli alunni con BES-ADHD-DSA.
Il teatro dei burattini
Il burattino è quello che si avvicina più all’umanità, grazie all’umorismo, all’ironia e allo spirito di improvvisazione, così vicino alla Commedia dell’Arte. Con l’aiuto dei burattini si possono fare molte attività in classe: attività manuali, come la costruzione di pupazzi ornati anche con materiale riciclato; attività di animazione, con esercizi e giochi di movimento che vedono coinvolti corpo, mani e dita; attività di immaginazione, narrazione e drammatizzazione, partendo da storie già esistenti o completamente inventate, con personaggi e ruoli, dove ci si può concentrare sulle emozioni e sui sentimenti, imparando a gestire la propria voce. Il teatro dei burattini è una forma di espressione che può potenziare le competenze trasversali, perché permette di utilizzare differenti linguaggi e tecniche espressive, favorisce la comunicazione, l’espressione e la socializzazione, attraverso il processo creativo. È straordi nario vedere come bambini che hanno difficoltà lingui stiche e non solo, possano sentirsi coinvolti e impegnati in piccole storie comiche, divertendo i propri compagni che applaudono con spontaneità, scoprendo così doti e abilità a loro sconosciute.
Il teatro del Kamishibai: raccontare per immagini
“Ho scoperto prestissimo che i migliori compagni di viag gio sono i libri: parlano quando si ha bisogno, tacciono quando si vuole silenzio. Fanno compagnia senza essere invadenti. Danno moltissimo, senza chiedere nulla”: sono parole di Tiziano Terzani. Raccontare per immagini è la più antica forma di narrazione, dove la parola perde potenza e centralità e diventa completamen to dell’immagine. L’immagine a volte trasmette più della parola; ha il potere di evocare significati, emo zioni, sentimenti e ricordi e lo fa in modo semplice. Se l’immagine è accompagnata da un testo, dalla mu
sica e da una lettura emozionale, l’efficacia è esponenziale. La tecnica del Kamishibai o teatro di carta si presta bene nel dare importanza alla lettura animata, soprattutto promuove una didattica inclusiva, perché i testi e le immagini sono semplici, le frasi brevi, il numero dei personaggi è ridotto, i disegni grandi per poter essere visti da lontano. Si può raccontare nella penombra e con un sottofondo musicale per favorire la concentrazione e l’attesa. Come per il teatro delle ombre, il potersi collocare dietro al teatrino, permette agli alunni di far emergere il coraggio di relazionarsi e di raccontare una storia di fronte al gruppo classe, senza aver paura. Tutto ciò favorisce la promozione della lettura e aiuta a narrare ad alta voce, ma stimola anche la scrittura e il disegno. Il kamishibai è un valido strumento di storytelling che crea le giuste condizioni per l’apprendimento, ed è un’attività divertente nella quale gli alunni si sentono protagonisti attivi perché inventano, costruiscono e rappresentano. Possiamo dire con certezza, per averlo esperito sul campo, che quando gli alunni diventano protagonisti dell’apprendimento, i risultati sono sorprendenti: si cimentano in storie brevi dalla bellezza e profondità inaspettata e chi ascolta è avvolto da una sensazione di stupore e di grande meraviglia. Ricercando, attraverso i propri genitori, le leggende e le tradizioni appartenenti al proprio Paese di origine, si permette a tutta la classe di conoscere e apprezzare meglio culture differenti e di cogliere affinità e differenze con la propria cultura. Il kamishibai è un mediatore didattico prezioso per rielaborare e produrre racconti e per trasformare le parole in immagini, con una modalità semplice ed efficace, una via di mezzo tra teatro e lettura che stimola l’immaginazione e favorisce la concentrazione. Nel nostro lavoro non ci sono bacchette magiche o scorciatoie, per raggiungere la meta prefissata, ma un lavoro quotidiano, lento e graduale, che a volte affatica, a volte è frustrante, ma il più delle volte è emozionante, ti regala sorprese inaspettate, come quando osservando con attenzione i propri alunni e le proprie alunne, si possono scorgere delle personalità decise e risolute, che desiderano rendersi visibili in questo universo-mondo scolastico e sociale.

È questo il nostro mestiere: accogliere e sostenere, dare dignità e opportunità a ogni bambino e bambina, nella speranza che le loro identità pur differenziandosi, si possano incontrare e contaminare a vicenda.
alle giovani madri che vogliono
imparare l’italiano, agli studenti che vogliono ricominciare a studiare e a completarela loro formazione: i percorsi del Cpia sono vari, articolati, eterogenei.
Notizie dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Campi Bisenzio, a cura di Tiziana Scemi
A Campi Bisenzio c’è una scuola ‘speciale’: si trova in via Verdi 12, molto vicino al centro di Campi, e si chiama Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, più noto come Cpia, un acronimo che risulta oscuro o sconosciuto a molti, talvolta persino agli insegnanti degli altri istituti scolastici. Il Cpia è una scuola statale e gratuita, aperta a tutti gli stu denti dai 16 anni in su. La sede di Campi Bisenzio fa capo al Cpia 1 Firenze che, oltre a Firenze Centro Storico e Novoli, comprende Scandicci, Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino, nonché il carcere di Sollicciano e l’Istituto Penintenziario Minorile (IPM) di Firenze. La sede di Campi, in particolare, copre anche i comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano. Il CPIA svolge un ruolo fondamentale nel garantire l’accesso all’istruzione ad adulti e a ragazzi e ragazze che per varie ragioni hanno lasciato il percorso di studi e desiderano ri prenderlo e concludere la propria formazione. Ma è anche e soprattutto un luogo che favorisce l’inclusione sociale, l’incontro e il confronto tra culture, lingue, storie e vissuti. L’utenza del CPIA, di fatto, è costituita so-
Angela Moro
prattutto da persone straniere (migranti appena arrivati o residenti da molti anni nel nostro paese) che vogliono imparare la lingua italiana o perfezionarne la conoscenza, perché


la lingua è il primo strumento di integrazione e inserimento nel contesto sociale. Il Cpia è una scuola accogliente, dove ciascuno può sentirsi a casa propria, forse anche grazie al fatto che è ubicata nei locali al piano terra di una palaz zina e la disposizione delle aule è simile a quella delle stanze di un appartamento. Le attività del Cpia includo no corsi di alfabetizzazione, corsi di lingua italiana per stranieri, percorsi per il recupero degli anni scolastici, per il conseguimento del diploma di licenza media e per l’adempimento dell’obbligo scolastico (primo biennio di scuola superiore). Il Cpia svolge inoltre varie attività di formazione professionale, organizzando corsi e la boratori di orientamento e ricerca attiva del lavoro e percorsi professionalizzanti e collaborando, a questo scopo, con l’Agenzia Regio nale Toscana per l’Impiego, con i Centri per l’Impiego della Provincia e con altre agenzie formative pro vinciali, con associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore (ad esempio la “Andrea Bocelli Foundation”, che propone laboratori e stage). Il Cpia propone anche corsi di italiano finanziati dal FAMI (Fondo Asilo Migrazione, Integrazione 2020-2027) e rivolti all’utenza straniera, che può così accedere alla formazione in ogni periodo dell’anno, indipen-
a caso, il primo mese di ogni anno scolastico è dedicato alla fase di accoglienza degli studenti e all’individuazione dei loro bisogni formativi e dei loro progetti di vita. Gran parte degli studenti del Cpia 1 Firenze sono giovani tra i 20 e i 25 anni, arrivati da poco in Italia, spesso con una discreta scolarizzazione pregressa, ma che sfortunatamente non viene riconosciuta in Italia. Il primo bisogno dei nostri utenti è lo studio dell’italiano. I corsi che il Cpia organizza riguardano i livelli base di conoscenza della lingua: si va dal livello Pre-Alfa al livello B1 richiesto per l’ottenimento della cittadinanza, passando dai livelli A1 e A2 (individuati in base al Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue). Chi inizia il perdi livello A1 ad ottobre, continua poi con il corso A2 sostenendo a giugno l’esame per il conseguimento della certificazione, utile anche ai fini del permesso di soggiorno. Molto spesso i nostri studenti proseguono il percorso l’anno successivo passando al corso di livello B1. Inoltre il CPIA ha stipulato una convenzione con l’Università per Stranieri di Siena per svolgere presso la propria sede di Scandicci l’esame CILS B1 (ovvero la Certificazione di Italiano come Lingua Straniera). Altri studenti hanno necessità
Il Cpia è una scuola “speciale” perché le sue molteplici attività richiedono una pluralità di competenze. Gli insegnanti mettono al primo posto l’ascolto delle esigenze di studenti
dentemente dai termini dell’anno scolastico strettamente inteso. Nelle diverse sedi del Cpia si svolgono anche le attività della Prefettura previste dall’Accordo di Integrazione, ovvero le sedute di formazione civica, il test di certificazione della lingua italiana di livello A2 per il rilascio del permesso di lungo soggiornanti e il test per la verifica dell’Accordo. Il Cpia è una scuola “speciale” anche perché le sue molteplici attività richiedono una pluralità di competenze. Il corpo docente del Cpia è infatti composto da insegnanti di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado: docenti preparati, motivati e appassionati al proprio lavoro, che mettono al primo posto l’ascolto delle esigenze di studenti e studentesse. Non
studentesse
di conseguire un diploma riconosciuto dallo Stato italiano e, dopo aver studiato la lingua, iniziano il corso di scuola secondaria di I grado. Si tratta di un corso di studio che prevede una frequenza di 400 ore, orientato sulle discipline di base (italiano, matematica, inglese, storia, geografia, scienze). Al termine dell’anno scolastico gli studenti sostengono l’esame di licenza e se lo superano ottengono il diploma di terza media. Ottenuto il diploma, alcuni studenti scelgono di orientarsi verso i corsi di formazione professionale proposti dalle varie agenzie del territorio; altri invece vogliono continuare il percorso scolastico e passano al corso di un solo anno di 800 ore

(il cosiddetto “monoennio”), cor rispondente al biennio di scuola secondaria di II grado. Il passaggio successivo per chi vuole arrivare al diploma di maturità sono i corsi serali dei diversi indirizzi di studio, organizzati dagli istituti tecnici e professionali dell’a rea metropolitana. I bisogni e i percor si degli studenti del Cpia sono molto articolati: ci sono le giovani mamme che vogliono imparare bene l’italiano per poter aiutare i figli che vanno a scuola; ci sono le badanti che voglio no perfezionare la conoscenza dell’i taliano, imparato sommariamente lavorando con gli anziani di cui si prendono cura; ci sono i giovani e giovanissimi ragazzi stranieri, spes so ospiti di case-famiglia e centri di accoglienza, che vogliono costruir si un futuro in Italia; ci sono anche studenti meno giovani che, dopo aver trascorso tanti anni in Italia conoscendo solo poche parole, quelle di uso più comune, aspirano a imparare meglio la lingua italiana; infine ci sono i ragazzi giovani (italiani e stranieri) che hanno abbandonato il percorso scolastico e dopo qualche anno vogliono ricominciare a studiare e completare la loro formazione. Ho iniziato a insegnare al Cpia di Campi nel

Claudia Isoardi
2015 e ho conosciuto tante persone, molte delle quali disorientate e spaventate (come lo siamo noi quando ci troviamo semplicemente per un viaggio di piacere in un paese straniero di cui non conosciamo la lingua); ho ascoltato e raccolto tante storie, spesso drammatiche, di disperazione e spaesamento, ma ho visto anche tante persone sorridere soddisfatte del lavoro svolto assieme, felici di aver trovato un luogo dove poter stringere nuove amicizie, in un contesto accogliente e non giudicante, dove potersi muovere senza ostacoli né dicriminazioni. Forse la dimostrazione che il Cpia è una scuola ‘speciale’ sta nel fatto che molti dei nostri studenti, che ormai conoscono la lingua italiana e che si sono diplomati, ci lasciano a malincuore e tornano a trovarci per fare quattro chiacchiere o per portarci libri o materiali da mettere a disposizione dei nuovi iscritti. Il loro affetto e la loro stima sono la riprova che accogliere, ascoltare e sostenere è la strada giusta per creare una comunità aperta e inclusiva.
COMPRENSIVO MONTALCINI DI CAMPI BISENZIO
Il progetto F.A.M.I. (Fondo Asilo Migrazione Integrazione) è un progetto del Ministero dell’Interno in collaborazione col Ministero dell’Istruzione e del Merito per favorire l’accoglienza e l’integrazione di studenti, studentesse e famiglie con background migratorio. L’istituto Comprensivo Montalcini di Campi ha partecipato per la prima volta al progetto FAMI 20142020, in qualità di capofila regionale e una seconda volta, partecipando al bando FAMI 2021-2027. Anche per questo secondo bando, l’istituto Montalcini è stato individuato quale scuola capofila regionale: il progetto prevede infatti la partecipazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana (USR) che ha creato una rete di scuole del Primo e del Secondo ciclo, assieme anche a tre università toscane. Questo consorzio ha presentato un progetto che è stato finanziato e verrà attuato a partire dall’a.s. 2024-2025, dopo la stipula della convenzione. Il progetto prevede, oltre alla rete di scuole regionale, la creazione di altre reti di scuole su base provinciale, di modo che le iniziative ed i risultati si riverberino a cascata su tutto il territorio toscano. Le azioni previste dal progetto regionale sono molte e possono riassumersi in alcune direttrici principali di lavoro:
. Integrazione sociale e contrasto alla dispersione scolastica di alunni/e, studenti/studentesse stranieri attraverso il potenziamento del plurilinguismo anche in contesto extra-scolastico; . Rafforzamento dell’Italiano come lingua seconda; realizzazione di interventi di mediazione linguistica e culturale, nonché di valorizzazione della lingua madre per mezzo della condivisione di esperienze e conoscenze legate ai paesi di origine; . Formazione del personale scolastico da parte delle università toscane, anche attraverso il conseguimento della certificazione per l’insegnamento dell’Italiano come L2.
Le scuole della rete intendono creare (e hanno già iniziato a lavorare in questo senso) una condivisione di buone pratiche per l’inclusione di alunni e alunne con background migratorio, anche attraverso l’elaborazione di un protocollo regionale per l’integrazione e il raggiungimento del successo formativo da parte di dette alunne, alunni, studentesse e studenti.
a convivenza di esseri umani con diverse storie, memorie e sfumature del proprio essere, accresce il bisogno di co-costruire: è il principio alla base di un progetto scolastico che lega insieme parole, immagini, bellezza e relazioni.
Il progetto della scuola Vittorino da Feltre di Piacenza, dove la percentuale di alunni non italofoni è molto alta, nel racconto di Monica Caiazzo
Ore 10.30. Occhi ben aperti, corpo in movimento, braccia che si incrociano, espressioni di attesa, ricerca, osservazione, scelta, scoperta, sguardi che si incontrano, scambi di parole, gesti simbolici. I bambini della classe 2C sono pronti. Non ci sono schemi, fasi e tempi prestabiliti, c’è piena libertà di vivere con stupore uno spazio, un momento, lungo o corto non importa, senza finalità specifiche, per il puro piacere di compiere quest’azione così spontanea e priva di ostacoli: leggere un libro.
Eccoci a Piacenza, seconda città in Italia per numero di studenti non italofoni; alla scuola primaria Vittorino da Feltre, con il 55% di alunni di 36 differenti nazionalità. Partiamo da una domanda: quale effetto produce sull’organizzazione questo dato? Per rispondere mi soffermerei su tre elementi. A partire da imprescindibili impegno ed energia richiesti a tutta la comunità educante, procederei con l’innesto di strategie eterogenee di azione e la ricerca di un particolare slancio creativo, sulla base di un dato indiscutibile: la convivenza di esseri umani con molteplici e diverse storie, memorie e sfumature del proprio essere, accresce il bisogno di co-costruire.
Co-costruire significa conferire senso, insieme, significa let-

teralmente “comporre con l’unione delle parti convenientemente disposte”. È proprio questo il grande obiettivo che ogni scuola dovrebbe porsi e noi abbiamo cercato di farlo
Nella scuola secondaria Ciscato di Malo, in provincia di Vicenza, l’attenzione al plurilinguismo ha dato vita a uno scaffale che raccoglie libri di tutte le lingue presenti tra gli studenti e le studentesse: ce ne parla la professoressa Cristina Manea.
“Siamo tutti quanti diversi, uno dall’altro, e questo ci rende tutti uguali”: questa splendida frase di . Sammy Basso che abbiamo commentato insieme ai nostri studenti introduce perfettamente una riflessione sulla realizzazione dello Scaffale Multiculturale a scuola. Lo Scaffale Multiculturale è una sezione della Biblioteca della Scuola Secondaria G. Ciscato di Malo (Vicenza) che raccoglie libri in tutte le lingue presenti nella nostra scuola, cioè non solo le lingue straniere europee studiate, ma anche le altre lingue straniere portate a scuola dai compagni che arrivano da altri paesi del mondo. Questo è stato possibile grazie a un progetto di collaborazione nato dalla Commissione Area3 della Scuola Secondaria G. Ciscato, che si occupa attivamente degli alunni di origine straniera, e l’Amministrazione Comunale di Malo. Dopo anni dedicati a cercare di migliorare continuamente l’accoglienza, l’approccio e il supporto ai nostri studenti arrivati da altri paesi, si è fatta strada l’idea di offrire a tutto l’Istituto una visione più ampia e stimolante del multilinguismo e della multiculturalità, elementi imprescindibili della realtà quotidiana. Abbiamo dato vita quindi a un progetto rivolto a docenti e a tutti i nostri alunni. Il progetto è stato ideato e organizzato dalla Prof. Cristina Manea, curato dalla Dott. Francesca Comparin della Biblioteca Civica per la ricerca e la scelta dei libri, accolto e incoraggiato dalla Dirigente Scolastica Manuela Scotaccia, promosso e sostenuto economicamente dall’Amministrazione Comunale. I libri donati dal Comune alla scuola sono stati consegnati il 4 dicembre scorso dall’ Assessore alla Cultura Silvia Berlato e dall’Assessore ai Servizi Educativi Genny Poggetta nella serata di inaugurazione della Biblioteca Scolastica, realizzata grazie ai fondi PNRR. Lo Scaffale al momento conta libri bilingui in inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, arabo, albanese, serbo, curdo, bengalese, senegalese, ucraino, rumeno, filippino. Annovera poi storie di immigrazione, libri di divulgazione, autobiografie. “Lingua Madre” è il titolo del progetto di formazione del personale docente di tutto l’istituto Comprensivo, dall’Infanzia alla Primaria e alla Secondaria, sui temi dell’inclusione linguistica, dell’insegnamento della lingua italiana L2 agli alunni stranieri e sulla multiculturalità, con formatori del calibro di Vinicio Ongini, del Prof. Fabio Caon fondatore di Labcom dell’Università di Ca’ Foscari e della Dott.ssa Silvia Dalli Cani, sua assistente sui temi della normativa e della valutazione . Questi incontri, organizzati lo scorso anno scolastico hanno attirato anche colleghi di altre scuole dell’AltoVicentino, creando una rete di collaborazione e studio su questi temi. In questo tempo di progettazione e lavoro la Prof. Elisa Massignan, motore del laboratorio di alfabetizzazione, insieme ad altri colleghi e ai nostri studenti Arpita e Apurba Dash e Fardia Islam hanno dato vita al libro n. 1 dello Scaffale ovvero un libro in tre lingue, scritto dall’autore originale in inglese, ma tradotto in italiano da Fardia e in bengalese da Arpita e Apurba: un libro unico, frutto di un lavoro prezioso e di menti generose ed inclusive. Ma perché la citazione iniziale di Sammy Basso? La scuola è uno dei pochi luoghi dove le barriere linguistiche
e culturali si trasformano in luoghi da esplorare, in mete da raggiungere, dove si attraversano spazi che mutano l’apparente impossibilità di capire in opportunità di espansione del pensiero. Tradurre significa traghettare, attraversare e trasportare le persone dalla propria origine al proprio divenire, affrontando un presunto ostacolo e facendolo diventare parte dell’avventura formativa, un’occasione di sviluppo e fulcro di nuova vita. Le lingue sono lo specchio del pensiero, sono le tante variegate visioni del mondo e della vita, i tanti modi di spiegarla e sono la moneta che usiamo, la nostra carta d’identità, l’attestazione del nostro essere al mondo, ci permettono di costruire ponti e di avvicinarci agli altri. Sono madri che ci cullano, ci crescono , ci nutrono, ci fanno comunicare. Basti pensare alle ninne nanne che qualcuno ci cantava da piccoli per farci addormentare, ai suoni delle parole che ci calmavano, nella nostra lingua. Sono spazi naturali di sicurezza. Così come le madri vivono per farci vivere, le lingue madri ci rassicurano, sono carezze indispensabili e mani che sostengono. Ecco perché ci deve essere uno Scaffale Multiculturale in una scuola, che sia scrigno e casa di ogni persona presente, perché la scuola accoglie tutti e valorizza ogni persona che la frequenta e ogni persona attraverso la sua lingua arricchisce la scuola di nuovi saperi e nuove carezze. Lo sconfinamento è un’operazione necessaria: per conoscere ci si deve spostare in un luogo nuovo e questo atto dello spostarsi è slancio vitale verso la crescita. Ecco perché le lingue straniere sono strumenti di crescita e non solo passaporti aziendali, ci permettono di uscire da un ambiente rassicurante e affrontare lo straordinario rischio di determinarci come persone, costruire il nostro progetto di vita e diventare cittadini del mondo. Se imparo, se sbaglio, se riprovo, se ho la possibilità di traghettarmi verso il mio futuro, sarò anche una persona capace di costruire pace, perché nel superamento del confine avrò imparato che le barriere sono fatte per essere superate, per incontrare le altre persone che condividono la loro esistenza sullo stesso pianeta e per scoprire che ci sono molti più fili che ci uniscono di quelli che ci dividono.
Le lingue sono fatte di parole, e sono quelle che scegliamo a presentarci al mondo e per questo studiarle, conoscere le parole di tante lingue spalanca finestre nella mente, ci permette di definirci meglio, di definire la nostra storia e la Storia più grande, quella con la S maiuscola: noi siamo fatti di relazioni, che travalicano i confini del nostro luogo di origine e che cosa meglio delle lingue può costruire relazioni? Nella scuola la relazione è la base su cui si fonda l’apprendimento. Apprendiamo tutti quando ci sentiamo accolti, visti, amati, quando sentiamo di esistere per gli altri con tutto il nostro bagaglio di vita. Ora inizia per la Scuola la seconda fase della progettazione: studenti e insegnanti decideranno insieme come utilizzare nei modi più coinvolgenti e creativi questo Scaffale Multiculturale, questo “angolo di casa” di ciascuno così ricco di suoni e significati nuovi perché… una lingua sola non basta a capire il mondo!
partendo da un’approfondita riflessione sul rinnovamento degli ambienti di apprendimento, intesi non solo come riallestimento degli spazi e di risorse materiali, ma anche come ventagli di possibilità di interazioni tra i soggetti che coabitano la comunità, come estrinsecazione di una visione di scuola, come collegamento tra le mura scolastiche e la realtà esterna. Convinti del valore di affermare un curricolo competenziale, capace di superare i limiti indotti da una

didattica puramente trasmissiva, abbiamo colto come cuore del sistema un ambiente speciale, dove si attivano legami più profondi, dove sembra più facile affermare la propria identità e intrecciarla ad altre, dove il confronto e l’incontro tra una pluralità di prospettive si erge a timone del sapere e del fare: lo spazio della lettura. E così abbiamo cominciato a riflettere sul senso e sulla forma della nostra biblioteca, affinché il suo rinnovamento potesse essere volano per il cambiamento dell’intera scuola. Ci siamo interrogati e abbiamo colto immediatamente il bisogno di creare un ambiente contraddistinto da delicati profili, da arredi modulari, da spazi flessibili e confortevoli, in modo che scegliere un libro e sfogliare le sue pagine non rappresentasse un compito, ma il piacere della scoperta, personale e/o condivisa. Insieme all’architetto Mao Fusina, esperto nella progettazione di spazi educativi e convinto della necessità di proiettare gli spazi in direzione di relazioni dinamiche, abbiamo tratteggiato questo nuovo e versatile spazio “soffice”, colorato, accogliente dove bellezza estetica e senso pratico forniscono agio e serenità. In questo ambiente leggere un libro, tuffandosi su una morbida poltrona insieme a un ritrovato amico o a una nuova amica, permette di estraniarsi dall’ordinario e immergersi nello “straordinario”. La possibilità di riconfigurare continuamente setting e arredi non rigidi è vincente perché risponde a eterogenei bisogni dei bambini. Scegliendo un libro e avviandosi a ricercarlo e a scoprirlo, i bambini imparano a sostenere un pensiero, ad ascoltare quello di altri,
a sviluppare inconsciamente ma solidamente le radici del pensiero critico. Così l’efficacia di questo spazio duttile e la risposta positiva ed entusiasta dei bambini ci hanno spinto a estendere il progetto, da indoor ad outdoor. Siamo riusciti a ridare vita e corpo a una vecchia terrazza adiacente alla biblioteca, in disuso da molti anni, abbellendola, un pezzo alla volta, fino a veder nascere la nostra Biblio con Vista, “in” e “out”, in coerenza con la vocazione outdoor della scuola, già membro della rete Scuole all’aperto. L’ambiente esterno incrementa ulteriormente le potenzialità percettive del bambino e rende più autentico l’apprendimento naturale, senza fatica, quell’apprendimento attraverso il quale la conoscenza si trasforma in competenza, vero e proprio connubio di conoscenze, abilità e atteggiamenti/attitudini del bambino. Il libro, in uno spazio esterno, bello e gradevole, diventa veicolo di relazioni interpersonali ed ecosistemiche e rende più autentica l’empatia. E chi non padroneggia l’italiano?
La risposta non è cercare libri nella propria lingua madre, ma piuttosto scoprire diversi modi per interconnettersi e per esprimere ed esprimersi. La biblioteca diventa luogo dove la comunicazione non verbale supera le barriere, dove immagini, cinestesia, semiotica e prossemica, graduano il coinvolgimento e la passione di chi legge e di chi ascolta, entrambi attivi nel cogliere e rielaborare messaggi. Leggere e ascoltarsi sviluppa capacità di comprensione, di mediazione, di interpretazione, ampliando abilità metacognitive. E tutte queste pratiche non possono che nascere ed alimentarsi a partire dall’età infantile 3-6 anni. Ecco perché ci siamo impegnati a creare uno spazio altrettanto bello e stimolante nella nostra grande scuola dell’Infanzia Dante, la scuola più grande della regione Emilia Romagna, dove l’interculturalità costituisce elemento identitario e occasione di sviluppo. Al via la ricerca dei fondi, la progettazione, la compartecipazione delle famiglie e del personale per rinnovare e dipingere lo spazio. Il secondo stepè stato quello di arredi e idee che prendono corpo per dare vita a un vero disegno di rete che fa nascere “Sulle ali di un libro”, spazio aperto a tutto il territorio, in cui bambini di tutto il quartiere si incontrano, dialogano con i loro piccoli corpi, con il kamishibai che abbatte muri e distanze e coinvolge nuovi volti, piccoli e grandi, in un processo dialettico tra culture che appare istintivo e continuo e getta i semi, passo dopo passo, di una sana idea di cittadinanza fondata su una maggior consapevolezza di sé nel mondo. Tra le pagine di un libro sconfinano molteplicità di immagini, parole, visioni, la cui pluralità incentiva il libero pensiero e il dialogo al contempo.
Uno spazio di scuola che sappia diventare spazio di evasione, di divertimento, di armonia, è uno spazio vincente perché agevola lo sviluppo delle potenzialità di ognuno e genera un’atmosfera di “piacere”. È questa la grandiosità di ambienti di apprendimento, divertimento e socialità che sanno essere fonte di innovazione, ricchezza e crescita. Il libro diventa strumento e fine; la biblioteca diventa punto di partenza, mezzo e meta. Tanti viaggi sono stati compiuti, tanti si compiranno, pervasi da quell’euforia che dà quella gioia che conferisce colore, tono e speranza alla scuola delle persone, piccole e grandi, bianche e nere, estroverse e introverse, alla scuola di Tutte e di Tutti.
dati sulla dispersione
scolastica, sulle bocciature e sull’orientamento nella scelta
della scuola superiore rilevano una forte influenza dovuta all’avere o meno la cittadinanza italiana.
Un contributo di Michele Arena

Ogni tanto faccio questa domanda agli studenti e alle studentesse che incontro con il mio lavoro di educatore: secondo voi qual è il gruppo sociale verso cui le persone più istruite indirizzano i propri pregiudizi e stereotipi? Per esempio quali sono le persone che vengono derise o attaccate dalle persone che hanno titoli di studio più alti? Le risposte prevedono di solito categorie come donne, immigrati, poveri, a volte persone con disabilità o persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+. A volte ci sono dei teneri e spiazzanti “noi.” Un “noi” inteso come studenti. Sono dei “noi” che si avvicinano molto alla realtà, perché la ricerca Educationism and the irony of meritocracy1 (2016) prova che il pregiudizio considerato ancora accettabile tra le persone con titoli di studio alti è proprio quello verso la popolazione meno istruita. E tra questa popolazione, in qualche modo, ci sono anche gli studenti che nel loro percorso incontrano delle difficoltà. Andare male a scuola quindi non è solo un problema di carriera e soldi in prospettiva, ma ti fa essere anche qualcosa di condannabile da un punto di vista sociale. La responsabilità individuale attribuita al successo scolastico non è quasi mai messa in discussione ed è trasversale a ogni parte politica. Dal 4 novembre 2022 il Ministero dell’Istruzione si chia- Martina Scarlata
Un convegno dedicato alle prospettive concrete per agire sul tema del riconoscimento della cittadinanza e sull’inclusione: ce ne parla Diana Cesarin, maestra del Movimento di Cooperazione Educativa che si occupa della prospettiva interculturale a scuola e nei servizi socio-educativi attraverso attività di ricerca-azione e formazione.
In una società multiculturale come quella in cui viviamo, essere e fare cittadinanza, condividere diritti e doveri, assume una importanza cruciale per l’inclusione, per il benessere e la qualità della vita di ciascuno/a e per la qualità della vita democratica di tutte e tutti. Infatti, la cittadinanza non implica solo un riconoscimento formale, ma anche la piena partecipazione alla vita sociale e, nell’educare a questo, la scuola ha una funzione insostituibile. È particolarmente grave, perciò, che le dichiarazioni di intenti e i provvedimenti del MIM in questo campo vadano in direzione contraria ai
il dibattito sulla cittadinanza, gli episodi sempre più frequenti di xenofobia, di discriminazione, perfino di violenza e il diffondersi del discorso d’odio nei confronti delle persone con background migratorio chiamano a una riflessione e a un sistematico impegno per promuovere CON/CITTADINANZE. Pensiamo che la preposizione “con” sia fondamentale: ci pare infatti che senza di essa non possa esserci né intercultura né cittadinanza, senza cioè una prospettiva concreta e agita di “fare insieme”, di “fare con”, appunto.
E per muovere in questa direzione, la FLC CGIL, sindacato dei Lavoratori della Conoscenza: Scuola, Università, Ricerca, Afam ha organizzato un Convegno, insieme all’Associazione Proteo Fare Sapere, che si è svolto il 14 novembre 2024. La giornata si è caratterizzata per un susseguirsi molto dinamico di interventi di vario genere: relazioni in presenza o da remoto, dialoghi in presenza, video con interventi verbali e/o musicali. Hanno portato i loro contributi Linda

famiglie qualcuno ha perso il lavoro e il denaro manca. O vivete in un quartiere poco sicuro, o avete amici che cercano di convincervi a fare cose sbagliate. Ma, alla fine dei conti, le circostanze della vostra vita − il vostro aspetto, le vostre origini, la vostra condizione economica e familiare − non sono una scusa per trascurare i compiti o avere un atteggiamento negativo. Non ci sono scuse per rispondere male al proprio insegnante, o saltare le lezioni, o smettere di andare a scuola. Non c’è scusa per chi non ci prova”.2 Non ci sono scuse per andare male a scuo la. Se il Presidente di una delle Nazioni più influenti nel mondo ti dice questo, se il Ministero che ha la responsabilità delle scuole che frequenti te lo dice, se perfino i tuoi insegnanti attraverso voti e bocciature ti fanno capire che è colpa tua, a te quale possibilità resta di pensarla diversamente?

Ma chi è che va male a scuola? Siamo sicuri che sia tutta una questione di impegno individuale? di costanza e disciplina? I dati sembrano dirci che non è esattamente così. Che ci sono dei fattori predittivi, uno tra questi, tra i più influenti, è avere una cultura e una lingua non conforme a quella della scuola italiana. Più in generale non avere la cittadinanza italiana. Nelle nostre scuole ci sono circa l’11% di studenti con cittadinanza non italiana (Dati MIM), e la ricerca La classe plurilingue3 (2022) racconta che di questo 11% la metà in famiglia parla solo la lingua di origine o la lingua di origine più un’altra lingua. Stiamo parlando di oltre quattrocentomila bambini e adolescenti che devono utilizzare due lingue diverse in due contesti diversi: quello familiare e quello scolastico. Appartenere a questo 11% però sembra voler dire avere un percorso scolastico meno favorevole di chi sta nel restante 89%. Per esempio nell’anno scolastico 2022-23 gli studenti con cittadinanza in ritardo nella scuola media erano il 3,7% contro il 26,1% degli studenti senza cittadinanza italiana. Il divario continua anche alle superiori dove le percentuali dei ritardi diventano rispettivamente 16% e 48%. I dati sulla dispersione non sono molto diversi da quelli delle bocciature: tra i giovani con Alice Callegari
Laura Sabbadini, Camilla Velotta della Rete degli Studenti Medi, Federica Corcione dell’Unione degli Studenti e altri studenti e studentesse, Rahma Nur scrittrice e insegnante, Vinicio Ongini esperto ben noto a questa testata, mediatori e mediatrici culturali, insegnanti e dirigenti scolastici sia di scuole “ordinarie” − e già da molto tempo le scuole “ordinarie” vedono al loro interno molti ragazzi e ragazze con background migratorio − che di Cpia: Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti dove molti adulti immigrati possono frequentare corsi italiano come L2. Le conclusioni di Gianna Fracassi, segretaria generale della FLC, hanno preso avvio da un brano tratto dal libro di Chandra Candiani Questo immenso non sapere (Einaudi, 2021)1 e dalla conseguente domanda: possiamo sperare che il nostro Paese sia capace di essere “la terra”, nel senso indicato da Candiani, per chi lo abita? Un banco di prova su questo terreno è rappresentato dall’ormai imminente referendum, che se avesse esito positivo quantomeno potrebbe dimezzare i tempi attualmente necessari per ottenere la cittadinanza italiana per i ragazzi e le ragazze con background migratorio. Il resoconto completo della giornata di lavoro è consultabile al link: www.flcgil.it/ attualita/con-cittadinanze/con-cittadinanze-insieme-e-me-
cittadinanza italiana la quota di abbandono è al 7,9%, tra i ragazzi con cittadinanza diversa è al 26,4%.
Quando la scuola dà un voto, questo sembra in qualche modo legato al fatto di essere o non es sere italiani più che all’impegno nello studio. A conferma del fatto che la cittadinanza influenza il percorso scolastico ci sono anche i dati dell’o rientamento: nei licei italiani c’è un 3,6% di studenti con cittadinanza non italiana, dato che sale al 12,2% negli istituti professionali e al 25% nella formazione professionale.5 là di mille riflessioni che si possono fare sulle tipologie di scuole, resta il fatto che anche nell’orientamento sembra pesare molto la cittadinanza. Oggi, nonostante molte espe rienze di integrazione e plurilinguismo di eccellenza che cercano nei loro contesti di rimuovere quegli ostacoli di ordine econo mico e sociale, il problema resta sistemico e la scuola, in particolare quella secondaria, sembra presentarsi a molti studenti di origine straniera come un paese dove non hanno le stesse opportunità dei co-
glio-anche-a-scuola-resoconto-dei-lavori.flc. Subito dopo il convegno, per garantire continuità e sistematicità al nostro impegno, abbiamo attivato un canale sul sito della FLC: https://www.flcgil.it/attualita/con-cittadinanze/ Il canale è suddiviso in due parti, la prima intitolata Essere e fare cittadinanza si propone di documentare e partecipare al percorso per il riconoscimento della cittadinanza; la seconda Scuola-cittadinanza-interculturalità è suddivisa in tre sezioni: L’inclusione fa bene a tutti; il plurilinguismo come occasione; Ital2 e formazione civica per migranti nei CPIA e intende offrire il fattivo supporto del nostro sindacato a coloro che nella scuola lavorano per produrre inclusione, intercultura e formazione democratica delle giovani generazioni. Per contribuire con segnalazioni, suggerimenti, proposte si può inviare una email a organizzazione@flcgil.it. Saremmo veramente contenti di riceverle.
1. “Ho un amico che vive in un paese straniero con il suo bambino. Ci parliamo al telefono di un po’ di tutto. E lui dice: “Niente di trascendente, adesso, nella mia vita, proprio non ce la faccio, solo cose concrete per mio figlio”. Lo ascolto, non solo le parole, e poi gli dico: ‘Sei la sua terra’. Lui ride” (in C.Candiani. Questo immenso non sapere, Torino, Einaudi, 2021, p. 145).

1. T. Kuppens. “Educationism and the irony of meritocracy: Negative attitudes of higher educated people towards the less educated”, in Journal of Experimental Social Psychology 76, 2018.
2. B. Obama. Discorso agli studenti, 8 settembre 2009, in https:// www.lastampa.it/ opinioni/editoriali/2009/09/08/news/ragazzi-volete-il-successo-dovete-studiare-1.37058144.
3. I. Fiorentini; C. Gianollo; N. Grandi. La classe plurilingue, Bolo-
etanei di origine italiana. E questo aspetto va oltre gli anni passati sul banco e riguarda i progetti di vita: dati e ricerche sostengono ormai da anni che il successo scolastico è strettamente correlato alla qualità della vita, all’accesso a tutte le forme di opportunità, comprese quelle culturali e politiche. Questi dati, se uniti ai risultati della ricerca Educationism and the irony of meritocracy su come la società più istruita considera la parte di popolazione con titoli di studio più bassi, sembrano raccontare una scuola che ha interiorizzato il razzismo e che oggi considera fisiologico che i percorsi degli studenti con background migratorio siano più difficili. O comunque una scuola lontanissima da quella circolare ministeriale numero 73 del 2 marzo 1994. che a proposito di intercultura nelle scuole diceva che: “L’educazione interculturale si basa sulla consapevolezza che i valori che danno senso alla vita non sono tutti nella nostra cultura, ma neppure nelle culture degli altri; non tutti nel passato, ma neppure tutti nel presente o nel futuro.”6
gna University Press, 2022.
4. MIM, Gli alunni con cittadinanza non italiana A.S. 2022/2023, Agosto 2024.
5. MIM, Gli alunni con cittadinanza non italiana A.S. 2022/2023, Agosto 2024.
6. https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm073_94. html - Ultima consultazione 10 aprile 2024 ore 9:25
a presenza dei libri in
nella biblioteca pubblica dà ai bambini degli immigrati un messaggio immediato di valorizzazione del codice materno e trasmette a bambini e genitori autoctoni il valore
Un’esperienza della biblioteca Gronchi di Pontedera nel contributo di Patrizia Sopranzi e Francesca Pepi
La nostra esperienza di Service Learning ha avuto inizio da una domanda e da una necessità, oltre che da un preciso contesto di possibili collaborazioni esistenti o da creare.
Con i suoi 29.695 abitanti (dati ISTAT 2024), Pontedera vede il 16,3% della popolazione residente con background migratorio: per quasi un terzo, il Paese di provenienza è il Senegal (29,5%), seguono l’Albania (14,1%), la Romania (10,8%) e il Marocco (9,2%). Si può però facilmente ritenere dai dati statistici disponibili che lo scenario locale in cui ci collochiamo rifletta una situazione con una tendenza di crescita della presenza di persone con provenienze linguistiche e culturali diverse. Come entrare in relazione con le persone con specificità linguistiche e culturali presenti nella nostro territorio ed essere utili alla loro integrazione, al di là dei canali della scuola dell’obbligo?
Un primo punto su cui investire, secondo noi, è una corretta narrazione della migrazione, da portare avanti in modo trasversale, nelle scuole, nelle biblioteche della rete, in dialoghi pubblici. Il progetto DiMMi: Diari Multimediali Migranti, in collaborazione con Amref FDU Toscana, Archivio diaristico nazionale di Pieve S. Stefano, Archivio Memorie Migranti e con la commissione Valdera per la lettura e la valutazione delle storie, è uno degli assi caratterizzanti della biblioteca Gronchi e
di Bibliolandia, che permette di invitare testimoni diretti della migrazione nelle scuole e in diversi contesti pubblici. Abbiamo poi pensato al progetto Mammalingua, arricchendo le collezioni di libri in lingua per fasce d’età e provando a individuare e a coinvolgere in particolare le madri dei bambini già utenti della biblioteca per leggere, insieme ai bibliotecari, le storie ai piccoli, in italiano e nelle altre lingue parlate nelle loro famiglie. Sono state anche coinvolte le associazioni di Mediatori Linguistici Amic. Con questo scopo abbiamo sviluppato, circa tre anni fa, un rapporto di collaborazione informale con il CenCpia 1 Pisa a cui avevamo proposto la visita della biblioteca comunale di Pontedera per farne conoscere ubicazione, spazi e servizi, ai quali si aggiungono quelli ulteriori di Bibliolandia. La vera svolta innovativa per noi si è sviluppata grazie al progetto di service learning proposto proprio dal Cpia 1 al Comune di Pontedera, ma anche a una serie di enti, associazioni e organizzazioni del territorio comunale e della Valdera. Il service learning è un approccio pedagogico che integra impegno per la comunità e competenze sociali e disciplinari consentendo di ampliare conoscenze e abilità attraverso il servizio alla comunità.1 L’idea alla base è quindi imparare rendendosi utili e propositivi: un diverso modello di cittadinanza attiva.
L’esperienza della Biblioteca Lazzerini di Prato e del Polo Interculturale
Regionale toscano, nel contributo di Maria Rosaria Colagrossi.
L’esperienza della Biblioteca Lazzerini di Prato sulle tematiche dell’intercultura si può riassumere col titolo del presente contributo: crescere e conoscere attraverso le lingue.1 Sì, perché sono sicuramente le lingue a essere portatrici di culture e non viceversa. Valorizzare il plurilinguismo è quindi l’obiettivo principale della Lazzerini, indipendentemente da quegli aspetti dell’intercultura che, se non considerati in maniera equilibrata, rischiano di tradursi in pratiche che portano a raffigurazioni stereotipate, folkloristiche ed eccessivamente semplificate degli altri. L’intercultura è un elemento specifico dell’identità della Lazzerini da circa trent’anni, cioè da quando, nel 1996, fu inaugurata una piccola sezione di libri in albanese, arabo e cinese pensata all’epoca prevalentemente per un pubblico adulto. Questa raccolta è cresciuta nel corso degli anni sia nella quantità sia nella qualità seguendo l’evoluzione di un dibattito generale sul tema e i cambiamenti del mercato editoriale, soprattutto in riferimento ad alcune aree del mondo, come per esempio i paesi di lingua araba, dove la letteratura per l’infanzia ha vissuto importanti cambiamenti negli ultimi anni. Restando nel campo della letteratura araba per l’infanzia, si vuole ricordare un emozionante progetto che nel 2023 ha visto la Biblioteca Lazzerini collaborare con una scuola primaria di Prato nella traduzione e reinterpretazione di una breve storia di Rania Hussein Amin, autrice e illustratrice egiziana non tradotta in Italia. Col supporto di un’esperta di lingua e letteratura araba per l’infanzia, una classe quarta della Scuola primaria Cesare Guasti ha analizzato una delle storie più significative dell’autrice, che vede protagonista una simpatica bambina di nome Farhana, gioiosa (questo è il significato del suo nome), vivace e un po’ anticonformista.
Nell’avventura proposta alla classe, Farhana è stata invitata a un matrimonio insieme ai suoi genitori che, per l’importante occasione, la vestono elegantemente: lei si guarda allo specchio e non si riconosce con indosso gli abiti scelti
Questa sperimentazione si inserisce in un orizzonte che vede il Comune di Pontedera, molto attento alle politiche interculturali, partecipare alla rete delle città del dialogo, un network nazionale di oltre 30 città italiane impegnate a condividere politiche e migliorare il dialogo interculturale e la partecipazione delle varie comunità alla vita della città. La biblioteca è inoltre parte attiva all’interno di un percorso di co-programmazione a livello comunale che coinvolge tutte le realtà territoriali che agiscono sui temi dell’intercultura.2 Nell’ambito di questo percorso ha preso vita il Festival delle Culture,3 in cui la biblioteca ha partecipato sollecitando, a propria volta, attraverso il service learning e il progetto Mammalingua, anche la partecipazione del Cpia 1. Ad oggi ci risulta che i soli progetti di service learning attivati a Pontedera siano quelli presso la biblioteca Gronchi. All’inizio del 2024 è stata stipulata una convenzione triennale che permette di ospitare studenti del Cpia 1, con specifici progetti formativi pensati in accordo con i docenti (un po’ come avviene per i Pcto e i tirocini universita-
dalla mamma, quindi si spoglia lungo il tragitto da casa al luogo della cerimonia (i genitori nemmeno se ne accorgono) e si presenta in mutande lasciando perplessi gli ospiti e anche alcuni esperti egiziani di libri per bambini. Nella letteratura araba per l’infanzia Farhana è la prima eroina ad aver imposto la propria personalità esuberante e tutte le sue caratteristiche sono state perfettamente colte dalla classe senza che nessuna persona adulta intervenisse a indirizzare le riflessioni. L’insegnante ha introdotto la storia senza neanche suggerire il nome della bambina e lasciando che gli alunni e le alunne ne scegliessero uno: loro hanno osservato il personaggio e hanno deciso spontaneamente di attribuirle il nome di Gioia (il significato di Farhana è proprio “gioia”). La classe è stata coinvolta in un lavoro di osservazione delle immagini ma anche di comparazione linguistica grazie al supporto dell’esperta e grazie al metodo didattico dell’insegnante che parte dalle teorie del translanguaging, pratica fondata sull’uso dinamico in classe di tutte le risorse linguistiche presenti e che legittima i parlanti bi/ plurilingui ad attingere al proprio repertorio in una vera prospettiva di inclusione.
Nel saggio Il pulcino non è un cane di Mathilde Chèvre, tradotto in italiano da Enrica Battista e Mariagrazia Decente,2si trova una sezione dedicata proprio al lavoro di Rania Hussein Amin e una delle due traduttrici, Enrica Battista, è stata l’esperta che ha supportato l’insegnante nello svolgimento del lavoro, permettendo anche all’autrice di incontrare “virtualmente” la classe.
1. Il riferimento è a: V. Carbonara; A. Scibetta. Imparare attraverso le lingue: il translanguaging come pratica didattica, Roma, Carocci, 2020. Nel libro i due linguisti affrontano il tema del translanguaging, ampiamente diffuso nel contesto nordamericano, e della valorizzazione del plurilinguismo nell’attività didattica .
2. M. Chèvre. Il pulcino non è un cane: l’editoria araba per l’infanzia come specchio della società, Astarte, 2023.
ri). I progetti sono calibrati sulla base del curricolo scolastico, del livello di competenza linguistica dello studente, ma anche delle sue propensioni, non ultime quelle di carattere relazionale e inoltre sulla base dei servizi e delle opportunità date dalle iniziative programmate in biblioteca e dai progetti in cantiere. Lo scorso anno scolastico per esempio, abbiamo ospitato tre studentesse, due provenienti dal Marocco ed una dal Brasile. I prossimi studenti che cominceranno a breve la loro esperienza in biblioteca provengono uno dalla Nigeria e l’altra dall’Honduras.
“La biblioteca è uno spazio fertile di cittadinanza in cui coltivare legami, idee e azioni partecipate. È un diritto irrinunciabile che ha il valore di un bene comune e collettivo vicino alle persone e da gestire attivamente”.4 L’osservazione espressa dal Manifesto per una nuova visione della biblioteca pubblica in Toscana, riassume pienamente la finalità del progetto di service learning realizzato nella biblioteca di Pontedera con il prezioso contributo di Siham, Naima e Edileide.
Con l’aiuto di Edileide, studentessa del Cpia di origine brasiliana, da pochi anni residente nel territorio ma con un’ottima conoscenza della lingua italiana, abbiamo allestito la nuova sezione Lingua +, dove è stato raccolto e valorizzato il materiale documentario destinato all’apprendimento di nuove lingue e di cui una parte importante è rivolta proprio all’apprendimento della lingua italiana. Grazie alla passione per la grafica, Edileide ci ha aiutato anche nella comunicazione della sezione, realizzando una segnaletica in più lingue. Siham e Naima sono


due studentesse di origine marocchina residenti nel nostro territorio da molti anni. Vivono e lavorano a Pontedera, i loro figli frequentano le scuole e la biblioteca comunale, ma prima dell’esperienza del Service Learning non pensavano che proprio in biblioteca avrebbero potuto svolgere un ruolo attivo, inclusivo, volto alla valorizzazione della propria lingua madre e all’arricchimento culturale della comunità. Il punto di partenza per il loro progetto è stato l’ampliamento del catalogo della biblioteca ragazzi di Pontedera. Negli ultimi due anni sono stati acquistati albi illustrati di qualità nelle lingue delle comunità straniere maggiormente presenti nel nostro territorio: arabo, albanese, cinese, romeno. Come strumento di riferimento è stata utilizzata la bibliografia di Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso, progetto nazionale a cura dell’Associazione Italiana Biblioteche. I libri
sono stati messi a disposizione di tutti, con l’obiettivo di raggiungere soprattutto le famiglie non italofone maggiormente distanti dai libri, dalla lettura e dall’uso delle biblioteche e avvicinarle alla lettura condivisa. Il fatto che nella biblioteca pubblica – luogo valorizzato e riconosciuto – siano presenti libri nella propria lingua madre dà ai bambini figli di immigrati un messaggio immediato di valorizzazione del codice materno, spesso ignorato o svalorizzato, e della propria appartenenza, in generale. Nello stesso tempo, questa presenza trasmette a tutti i bambini e genitori autoctoni il messaggio simbolico e importante che ogni lingua e cultura hanno valore. 5 Naima e Siham hanno sfogliato e studiato con molto entusiasmo i libri dello scaffale in lingua madre della biblioteca ragazzi, aiutandoci nella valorizzazione di quelli in lingua araba. Hanno selezionato alcuni albi illustrati, si sono preparate per alcune letture, in lingua araba e italiana, che la biblioteca di Pontedera ha portato “fuori di sé”, in un contesto del tutto privilegiato, il Festival delle Culture che si è tenuto in alcuni parchi cittadini nel maggio del 2024. Questa è stata sicuramente un’occasione importante per la biblioteca, per conoscere il proprio territorio, stringere nuovi legami, progettare nuove alleanze e avvicinare sempre più famiglie non italofone alla scoperta della biblioteca e dei suoi servizi. Le due studentesse hanno poi collaborato attivamente a un evento di “Poesia diffusa” in biblioteca, volto all’approfondimento delle poetesse africane contemporanee.
Con il nuovo progetto di Service Learning che prenderà il via tra qualche settimana, arriveranno in biblioteca due nuovi studenti del Cpia 1 Pisa, che si dedicheranno all’organizzazione di nuove letture in lingua madre per bambini e alla comunicazione dei servizi multiculturali della biblioteca.
1. L. Orlandini; S. Chipa; C. Giunti (curatrici). Il service learning per l’innovazione scolastica: le proposte del Movimento delle avanguardie educative, Roma, Carocci, 2020.
2. Con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 24/05/2024 è stato approvato un Piano interculturale e un Tavolo istituzionale permanente per il dialogo interculturale, composto da tutti gli attori del territorio che si occupano di questi temi, per favorire i rapporti istituzionali e il dialogo tra società civile e istituzioni, programmare iniziative, organizzare servizi e sviluppare progettualità congiunte sui temi dell’intercultura.
3. Il festival è nato grazie alla collaborazione di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo di co-programmazione e co-progettazione delle iniziative in ambito di intercultura promosso dal Comune, con il coordinamento di ARCI Valdera e Tavola della Pace e della cooperazione internazionale. Le pagine informative sono consultabili sul sito del Comune di Pontedera: https://www.comune.pontedera.pi.it/pontedera-delle-culture (ultima consultazione 26/01/2025).
4. Manifesto per una nuova visione della biblioteca pubblica in Toscana, a cura di Francesca Navarria e Paola Scarpelli. https:// www.regione.toscana.it/documents/10180/25721110/Manifesto. pdf/f67467a1-f027-b76a-be47-8a4c50012ae9 (ultima consultazione 30/01/2025).
5. Manifesto “Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso” di Graziella Favaro. https://www.mammalingua.it/manifesto/ (ultima consultazione 30/01/2025).
ntergenerazionale, affollata e con valigie di libri in lingua che vengono consegnate alle scuole: una realtà bibliotecaria può diventare punto di ritrovo abituale in città, tra lettori madrelingua e gemellaggi con altre biblioteche.
La Biblioteca Ragazzi di Treviso nella promozione della lettura in lingua madre: un contributo di Fiamma De Salvo
La biblioteca Brat (Biblioteca dei Ragazzi di Treviso) è nata nel 1969 da un’idea di Enzo Demattè, alla quale, dopo la sua morte, avvenuta nel 2014, è stata intitolata. Alla fine degli anni ’60 non era affatto scontato che bambini e ragazzi avessero uno spazio dedicato ai loro specifici bisogni culturali, tant’è vero che l’allora regolamento della biblioteca di Treviso ne escludeva l’ingresso fino al compimento del quattordice-
biblioteca ragazzi d’Italia tra quelle ancora attive e funzionanti da allora.1 La precocità è la continuità del servizio per oltre cinquant’anni hanno reso la biblioteca Brat un vero servizio alla comunità e casa dei trevigiani. Una biblioteca ad “alto funzionamento”2 in cui i genitori di oggi conservano ricordi di quando da piccoli venivano in biblioteca. Questa dimensione intergenerazionale rende la Brat tanto cara alla città da atti-
Quando arriva nelle scuole, la valigia Mamma lingua è gestita dalle maestre, che nella maggior parte dei casi decidono di fare dei piccoli festival della lettura invitando i genitori a pescare dalla valigia per preparare delle letture pomeridiane in lingua
simo anno di età. Ma Enzo Demattè, diventato assessore alla cultura del Comune di Treviso, era anche insegnante e preside scolastico, oltre che ricercatore negli ambiti storici, e autore di romanzi per ragazzi, ma soprattutto, era un uomo che guardava lontano e vedeva nell’infanzia e nei giovani il vero motore di cambiamento della società. Ed è così che Treviso, una città di provincia di solo 80.00 abitanti, ebbe la prima
rare doni, offerte e moltissime attività vengono organizzate dalla rete del volontariato locale.
Anti elitaria e popolare nel senso più genuino del termine, la biblioteca è spesso affollata e un punto di ritrovo abituale in città. Anche le famiglie che non hanno un’abitudine al consumo culturale, i genitori con bassa scolarizzazione o che provengono da paesi in cui ci sono pochi servizi, riconoscono
nella Brat un luogo aperto e informale nel quale sentirsi completamente a proprio agio. L’attenzione ad accoglienza e inclusione hanno fatto sì che la Brat si sia subito innamorata del progetto Mamma lingua,3 sviluppato da Associazione Italiana Biblioteche e ormai molto diffuso, tanto da averlo abbracciato molto prima che diventasse una linea di intervento forte e riconosciuta da molte biblioteche per ragazzi.

Nella grande cornice di Mamma lingua abbiamo sviluppato diversi servizi e interventi. Il primo è ovviamente quello di avere una estesa disponibilità di libri in lingua, in sede, recenti, disponibili per il prestito e ovviamente collocati a scaffale aperto. La dotazione della Brat è al momento di quasi 2000 libri ma è in progetto di raddoppiarla nei prossimi due anni. Nel 2024 questa piccola collezione ha infatti contato 3000 prestiti, segno che è ancora insufficiente rispetto ai bisogni della comunità. Lo scaffale multilingue4 è collocato proprio all’ingresso come esplicito benvenuto ai lettori e al momento comprende 33 idiomi: Albanese, Arabo, Armeno, Bambara, Bielorusso, Bulgaro, Catalano, Cinese, Cingalese, Coreano, Croato, Curdo, Francese, Georgiano, Giapponese, Hindi, Inglese, Panjabi, Persiano, Polacco, Portoghese, Russo, Serbo, Somalo, Spagnolo, Svedese, Tagalog, Tamil, Tigrino, Turco, Urdu, Ucraino, Ungherese. Alcuni testi provengono dal primo nucleo donato dal progetto Mamma lingua come partenza di tutti i presidi regionali. Per alcune lingue, parlate in territori che vivono situazioni politiche ed economiche di crisi, è molto difficile l’approvvigionamento di testi in lingua per bambini. Questo è dovuto sia alla mancanza di canali di distribuzione verso l’estero che allo scarso sviluppo di un mercato editoriale interno. Questa è la situazione per alcune lingue del continente africano, per le quali si offre letteratura specializzata nelle “lingue ponte” come il francese e l’inglese. Il secondo servizio è proprio la
valigia Mamma lingua, un trolley robustissimo che contiene 100 libri a coprire la maggior parte delle lingue parlate a casa dai bambini che frequentano le scuole cittadine. I libri contenuti nella valigia sono disponibili per il prestito, e vengono

consegnati direttamente al plesso per gli istituti scolastici del territorio comunale. Quando arriva nelle scuole la valigia Mamma Lingue e il programma di valorizzazione sono gestiti dalle maestre, che nella maggior parte dei casi decidono di fare dei piccoli festival della lettura invitando i genitori a pescare dalla valigia per preparare delle letture pomeridiane in lingua. Si tratta di attività di grande valore, che mettono al centro e rendono protagonisti quei genitori che spesso a causa della barriera linguistica si sentono poco coinvolti o poco rilevanti rispetto al processo di apprendimento dei figli. Al contempo l’organizzazione delle letture crea dei momenti di condivisione tra genitori e insegnanti in cui l’asse della competenza è sbilanciato verso chi padroneggia la lingua straniera.
La valigia Mamma lingua negli ultimi due anni ha viaggiato ventidue volte, spesso con liste di attesa di mesi rispetto alle richieste. Ecco perché la biblioteca è diventata partner dell’Istituto comprensivo Arturo Martini di Treviso, che partecipando con successo a un bando FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) ha deciso di dotare la biblioteca di altre tre valigie per coprire tutto l’anno molte più scuole.
La valigia è in assoluto il progetto che con pochi oneri di gestione offre più occasioni di incontrare le famiglie straniere e generare valore. Un terzo polo di attività è quello di dedicare alcuni pomeriggi al mese alle letture in lingua. Per questo progetto, già al suo quarto anno, è stato fondamentale il coin-
Un laboratorio tenuto alla Biblioteca De Amicis di Genova tra lingue, libri e identità, a cura di Francesca Balbi, Alessandro Berghenti, Andrea Bruzzo, Rosy Fiorillo, Valeria Spanu del Movimento Cooperazione Educativa di Genova.
Il laboratorio che vi raccontiamo ha lo scopo di creare una situazione di ribaltamento: mettere gli adulti nella situazione che vivono sempre più alunne e alunni negli spazi dei nostri servizi e delle nostre scuole.1 Tutto ha inizio da una valigia, come ogni volta che si parte per un viaggio. All’interno della valigia ci sono tre indizi per ciascuno dei personaggi che scopriremo attraverso gli albi illustrati. Insieme agli indizi, un messaggio per dare il via a questa particolare “caccia al tesoro letteraria”: “Ops! Mi sono cascati questi tre oggetti… eppure li avevo conservati con cura! Ero sicuro/a di essermi nascosto così bene dentro al mio libro. Chi sono? Provate ad immaginarmi e costruite la mia carta d’identità”. I partecipanti, divisi in gruppi, si confrontano tra loro per costruire l’identità del loro personaggio. Quale sarà la sua storia? Avrà un nome? Che lingua parla? Che aspetto potrebbe avere? Quale il suo paese di origine? Quale la sua relazione con gli oggetti trovati nella valigia? Una volta compilata una carta d’identità si entra nel mondo dei libri. Lo spazio è allestito con cura, la musica accompagna i partecipanti che si muovono tra fili e libri installati in modo creativo. Decine di albi illustrati scritti in molte lingue diverse: cinese, arabo, olandese, tedesco, giapponese, polacco, russo, portoghese... I libri vengono presi in mano, sfogliati, letti, esplorati. Ciascun gruppo è in cerca del suo personaggio tra le pagine. Le lingue sconosciute degli albi non sembrano un grande ostacolo, perché la forza delle immagini, la mediazione degli oggetti persi in valigia e il confronto collettivo svolgono bene il loro lavoro di facilitazione. Certo, non sempre si riesce ad azzeccare il libro in cui il personaggio sarebbe nascosto. Ma non è questo l’importante. Come leggere un libro, un albo quando ancora non si sa leggere? Si sperimentano le sensazioni di bambine e bambini che per la prima volta si trovano ad avere a che fare con una lingua sconosciuta. E questo vale per l’italiano così come per qualsiasi insegnamento L2. È molto importante che l’approccio sia ludico, motivante, cooperativo, legato a esperienze che siano significative. Si gioca per riflettere insieme su quanto cambia il rapporto con il libro se è preceduto da un’esplorazione, dalla formulazione di ipotesi, da un lavoro di gruppo. Come è diverso poter tenere in mano il libro in un piccolo gruppo, rispetto alla richiesta di stare 1. Il laboratorio si è svolto durante l’incontro “Barba, Baffi, Libertà. Una mattinata dedicata a Francesco Langella. Storie, racconti e laboratori per riflettere sull’uso della voce, sul perché e sul come leggere”, tenutosi il 23 novembre 2024 in ricordo di Francesco Langella, storico direttore della Biblioteca Internazionale per Ragazzi Edmondo De Amicis di Genova.
volgimento del gruppo di volontari amici della Brat.5 Questa squadra di lettori conosce i titoli e le dinamiche giuste per passare un bel pomeriggio tra i libri con un gruppo di bambini, che tuttavia sono principalmente di madrelingua italiana. Il piano è quindi di intercettare altri genitori stranieri presso le scuole, i parchi, i campi sportivi e altri luoghi frequentati da famiglie, convincendoli a leggere in biblioteca. I lettori esperti offrono supporto e tutoraggio nella scelta dei libri e accompagnano i nuovi nelle prime letture. Il processo di reclutamento di madrelingua necessita di uscire dalle istituzioni e di usare le reti informali.
I lettori volontari sono i veri ambasciatori della biblioteca in
seduti a leggere o in silenzio ad ascoltare una lettura. Entrare in un rapporto attivo con il libro vuol dire anche renderlo significativo per tutte e tutti. Lo spaesamento stimola a osservare attentamente non solo il testo ma soprattutto le immagini, fare inferenze, creare reti di significato. Andare a sollecitare il bagaglio di conoscenze pregresso, riconoscendo l’altro come portatore di un sapere. A questo proposito ricordiamo le parole di Lilia Andrea Teruggi: “Se non si promuove l’attivazione di strategie cognitive, come il fare collegamenti con le conoscenze pregresse e il fare inferenza, si rischia di avere dei buoni oralizzatori ma dei pessimi intenditori”. É fondamentale incoraggiare questo processo, non basta l’incontro con diversi tipi di testo ma è doveroso l’intervento attivo capace di incentivare riflessioni. Più lettori che ragionano insieme arricchiscono il processo di lettura. Il passaggio successivo all’esplorazione è quello dell’entrare in contatto con la narrazione. Ciascun gruppo sceglie un luogo per ipotizzare possibili restituzioni al grande gruppo della storia contenuta nel libro scelto. Il libro è scritto in una lingua sconosciuta ai partecipanti, per questo motivo la storia non sempre è chiara, va interpretata. La restituzione può avvenire con performance teatrali, giochi di ruolo, scritture creative con traduzioni improvvisate e improbabili… La tecnica utilizzata è quella che Marina Pascucci, riferendosi alle possibili attività di letto-scrittura all’inizio della scuola primaria, chiama “una seduta di lettura sociale”: lettura completamente gestita da un gruppo che ancora non governa la decodifica del linguaggio scritto. Nuove storie vengono narrate e condivise, poco importa se la trama reale del libro è distante; magari il personaggio misterioso non si trova neppure tra quelle pagine. La valigia può essere riempita lo stesso, questa volta non solo con oggetti curiosi ma anche con nuove parole, nuove immagini negli occhi, nuove compagne e compagni di viaggio.
città e l’attività ha un grande seguito. Infatti ha generato piccole unioni di genitori che si incontrano e organizzano ormai autonomamente, come il gruppo della lingua spagnola, con un unico rammarico: non essere ancora riusciti a leggere in cinese.6
Ultima attività molto soddisfacente e sempre legata al contesto generativo di Mamma lingua è il gemellaggio tra biblioteche. In questo caso sono le istituzioni a tenersi in contatto; ad esempio la Brat ha iniziato una relazione con la biblioteca provinciale di Klagenfurt o con la biblioteca Infanta Elena di Siviglia; ma il carteggio, un’eventuale telefonata, gli accordi e i ringraziamenti vengono gestiti in modo molto più produttivo
Il festival Illustramente ha al centro la singolare figura di Giufà, simbolo di saggezza popolare e unità tra popoli diversi. Ce ne parla Rossana Maranto, direttrice artistica del festival.

In un mondo sempre più interconnesso, la pro mozione della diversità culturale e linguistica assume un’importanza cruciale, soprattutto tra i più giovani. La dodicesima edizione di Illustramente, festival dell’illustra zione e della letteratura per l’in fanzia, incentrato sulla figura di Giufà, personaggio iconico del folklore mediterraneo, ha rap presentato un’opportunità per riscoprire le proprie tradizioni e per favorire l’incontro tra allievi e allieve di ogni età anche provenienti da diversi background culturali, promuovendo la lettura e la valorizzazione del patrimonio mediterraneo. La scelta di Giufà come filo conduttore del festival non è stata casuale. sto personaggio, presente in numerose culture mediterra nee, rappresenta un simbolo di saggezza popolare e di unità tra popoli diversi. Le sue storie, tramandate oralmente per secoli, hanno il potere di superare le barriere linguistiche e culturali, favorendo l’empatia e la comprensione reciproca, fattori oggi sempre più importanti perché mancanti nei rapporti tra coetanei.
La fitta rete di biblioteche che aderisce ad Illustramente, ha

tale nell’organizzazione delle attività. Dalle provincie di Trapani e di Palermo, da quelle di Messina e di Catania, le biblioteche sono diventate luoghi di incontro e di scambio culturale, offrendo a bambini, bambine e ai giovani allievi delle scuole siciliane, l’opportunità di scoprire nuove storie e di entrare in contatto con altre culture dalle uguali matrici, partendo dalla promozione della lettura e del libro, dalle culture e dal desiderio di creare un dialogo interculturale, coinvolgendo migliaia di bambini e ragazzi in tutta la Sicilia. Tra le attività proposte,
ed elastico dai volontari lettori Mamma lingua. Il gemellaggio può limitarsi a scambiarsi una scatola di libri tra l’Italia e l’estero, attingendo ciascuno alla dotazione di doni e doppie copie. Un piccolo nucleo di libri quasi irrilevante per la biblioteca cedente ma preziosissimo per la biblioteca ricevente perché i canali di vendita internazionali7 non sono così economici e facili da praticare. Oppure il gemellaggio può comprendere lo scambio di buone pratiche e la condivisione social dei programmi e contenuti.
La biblioteca Brat ha al momento in campo il gemellaggio con 7 biblioteche europee e intende continuare. Nel futuro della biblioteca ci sarà ancora maggiore attenzione ai bisogni di una società sempre più eterogenea, dal punto di vista linguistico e culturale.
Una comunità costituita da una crescente migrazione e da bambini e ragazzi con vissuti e identità complesse. La Brat spera di compiere i suoi sessant’anni, nel 2029, celebrando una riorganizzazione completa dei suoi servizi nell’ottica di una completa internazionalizzazione.

si sono distinti i laboratori creativi, durante i quali i partecipanti hanno potuto ascoltare e dare vita alle storie di Giufà. Ogni biblioteca ha proposto un programma di letture animate in diverse lingue rivolto alle classi, per fare apprezzare la ricchezza delle diverse narrazioni, stimolando la curiosità e l’immaginazione dei giovani partecipanti. Questa dodicesima edizione di Illustramente, che si sta preparando allo step di maggio 2025, ha dimostrato come la figura di Giufà possa essere un potente strumento per promuovere la lettura e la cultura, soprattutto tra i più giovani. Grazie alle attività svolte, i bambini hanno sviluppato un maggiore interesse per la lettura, hanno ampliato i loro orizzonti culturali e hanno imparato a valorizzare la diversità.
in provincia di Messina le biblioteche di Acquedolci, Capo D’Orlando, Frazzanò, Giardini-Naxos, Mirto, Tortorici e, nella provincia di Trapani, Caltagirone.
Le biblioteche, veri e propri fulcri del progetto, hanno offerto un ambiente accogliente e stimolante dove bambini e ragazzi, grazie alla collaborazione con le scuole, hanno potuto immergersi nelle storie di Giufà. Attraverso laboratori creativi, letture animate e incontri le biblioteche sono diventate luoghi di incontro e di scambio, promuovendo la curiosità e la voglia di scoprire. In particolare, la rete delle biblioteche siciliane ha dimostrato come la collaborazione tra istituzioni possa moltiplicare gli effetti positivi di un progetto, raggiungendo un pubblico sempre più ampio e diversificato. E infine, a novembre 2024 ha preso vita “Giufà che vien dal mare” il concorso di illustrazione rivolto agli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado e agli esordienti. Partendo dalla lettura delle storie della tradizione popolare siciliana nelle raccolte di Laura Gonzenbach e Giuseppe Pitrè, nei racconti Italo Calvino e di Leonardo Sciascia, i giovani allievi che parteciperanno rielaboreranno il proprio pensiero, progetteranno e realizzeranno una illustrazione, in cui i due ambiti, scientifico e letterario, dovranno essere fusi a raccontare radici e ali per volare. I prossimi appuntamenti con Giufà e Illusstramente saranno dal 26 al 29 maggio 2025.
L’obbiettivo è quello di promuovere il multicultu ralismo e il plurilinguismo, partendo dalle biblioteche in rete, e sono sedici i comuni della Sicilia coinvolti, con un sistema in crescita costante, al fine di unire in un’unica tessitura la pluralità delle voci nelle storie di Giufà. Partecipano al progetto: il sistema bibliotecario cittadi no del Comune di Palermo, con 5 biblioteche decentrate e le biblio teche comunali della Provincia di Palermo, Monreale, Cefalù, Corle one, Marineo, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Ventimiglia di Sicilia, Biblioteca Pax di San Martino delle Scale; il sistema bibliotecario di Trapani e la biblio teca della Fondazione Orestiadi di Gibellina (culla di multiculturalità); Filippo Frizza

1. La vera primizia per la nostra nazione è stata l’incredibile esperienza della biblioteca Maria Pezzè Pascolato, attiva a Venezia dal 1926 ma purtroppo chiusa nel 1938. Si conserva tuttavia un nucleo importante del fondo originale, vedi: B. Vanin, “La Biblioteca dei ragazzi Maria Pezzè Pascolato”, in D. Raines (curatore). Biblioteche effimere. Biblioteche circolanti a Venezia (XIX-XX secolo), Venezia, Edizioni Cà Foscari, 2012, p. 105-174.
2. Sebbene abbia una sede di poco più di 500 metri quadri e una collezione intorno ai 40.000 volumi, la biblioteca conta ogni anno più di 50.000 presenze e nel 2024 ha registrato 200 classi in visita e 52000 prestiti.
3. Mamma lingua è accoglienza, integrazione, intercultura, narrazione, diversità linguistica. Il progetto, nato nel 2015, è risultato vincitore del Bando Leggimi 0-6 2019 del Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura. Il progetto “Mamma lingua: storie per tutti, nessuno escluso” si rivolge alle famiglie con bambini 0-6 anni delle più numerose comunità straniere del nostro paese promuovendo la consapevolezza dell’importanza della lettura condivisa in famiglia in lingua madre, della narrazione e della diversità linguisti-
ca, tramite la diffusione dei libri per bambini in età prescolare nelle lingue maggiormente parlate nel nostro Paese. Per informazioni e il manifesto https://www.mammalingua.it/.
4. In un’ulteriore spinta verso l’internazionalizzazione delle collezioni della Brat non è escluso che lo scaffale multilingue “rompa gli argini” e che tutte le lingue siano collocate in tutta la biblioteca seguendo i criteri di genere e fascia d’età ma con segnalazioni visibili molto semplici come colori e bandiere sui dorsi dei libri.
5. ABiBRaT è un’associazione di lettori volontari che ha come primo scopo la promozione della lettura tra bambini ed adolescenti, si tratta di circa 40 adulti impegnati in svariate situazioni per tenere alta l’attenzione alla narrazione a alla lettura. Dopo molti anni come gruppo informale sono diventati associazione dal 2015.
6. La comunità cinese di Treviso esiste anche se non è paragonabile per dimensione e coesione a quelle di altre zone d’Italia.
7. Molte piattaforme di vendita e spedizione dall’estero di libri, richiedono sistemi di pagamento come l’anticipo su carta di credito a cui le pubbliche amministrazioni, di cui fanno parte le biblioteche, sono a volte poco avvezze.
li albi illustrati raccontano
la multicultura in molteplici forme, a partire dalla nostra comune origine fino ad arrivare alla conoscenza di un popolo attraverso viaggi, cibo e ascolto reciproco.
“Ci sono parole che racchiudono ed esprimono la complessità del mondo. Origine è una di queste. Al principio, tutti noi esseri viventi eravamo polvere di stelle. Siamo fatti dei frammenti di astri estinti miliardi di anni fa, ed è la nostra comune origine ciò che ci connette ad altre creature, alla natura e al tessuto multidimensionale che compone l’universo”.1 Origine, l’albo
Conoscerle e in qualche modo frequentarle mi pare l’unico modo per comprendere i molti modi in cui uomini e donne hanno mantenuto e protetto il loro rapporto con la natura e il mondo. Fortunatamente, la scuola è un microcosmo che, proprio grazie alla multiculturalità e al plurilinguismo, può allargarsi a dismisura.
Bilù è “straniera” in un modo e in una forma facilmente chiari e comprensibili anche alle bambine e ai bambini più piccoli, dalla scuola dell’infanzia ai primi anni della primaria: è minuscola, sola, completamente gialla, ha tre occhi e due lunghissime orecchie che arrivano fino a terra
scritto da Nat Cardozo e illustrato da Maria Josè Ferrada per L’ippocampo (2024) colpisce fin dalla copertina per la sua capacità di mostrare, attraverso un solo volto, l’unicità di ogni popolo, e per esteso di ogni essere umano. Allo stesso tempo, fin dall’introduzione richiama un concetto chiave per ogni abitante del pianeta: le molte culture di cui è popolata la Terra e le altrettante lingue che vi si parlano hanno un’unica origine.
“Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola. L’intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno. A centocinquanta anni dall’Unità, l’Italiano è diventata la lingua comune di chi nasce e cresce in Italia al di là della cittadinanza italiana o straniera. La scuola raccoglie con successo una sfida universale, di apertura verso il mondo, di
pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze.”2 Fin dalla scuola dell’infanzia, la convivenza quotidiana con bambine, bambini e famiglie che hanno avuto origine in luoghi e culture lontani e diversi dai nostri ci aiuta ad ampliare lo sguardo e a relativizzare convinzioni, credenze, abitudini. Confrontarsi con lingue, abbigliamento, consuetudini, riti diversi apre alla ricchezza e alla diversità, in un pluralismo che non smette di interrogarci.

Allo stesso modo, è possi-


bile riflettere su lingue, culture, plurilinguismo e multiculturalismo anche attraverso la lettura delle parole e delle immagini degli albi illustrati.
Scrive Silvia Vecchini in LiBeR 144: “Già il fatto di parlare a bambine e bambini molto piccoli o rivolgersi a chi sta iniziando a leggere da solo o a lettori più esperti oppure agli adolescenti… farlo con il testo di un albo, di un fumetto, di una poesia, di un romanzo è già parlare lingue profondamente diverse!”. I libri e la lettura sono fondamentali per la crescita di ciascuno e ciascuna perché permettono di conoscere, ascoltare e leggere parole e immagini relative a mondi fino a quel momento sconosciuti, e che potreb bero, altrimenti, esserlo per sempre. “Bilù non doveva trovarsi lì/ Si era persa/Nes suno sembrava capirla/Alcuni non si fermavano nemmeno ad ascolta re”. Inizia così Bilù, 3 l’albo di Alexis Deacon in cui una strana creatura atterrata per errore sulla Terra ne esplora i territori e e incontra i suoi abitanti, giungendo alla conclusione che “Le creature terre stri erano per la maggior parte grandi e ostili, ma ce n’erano al cune piccole che promettevano bene”. Il problema principale di Bilù, oltre alla lontananza dalla famiglia e all’apparente impossi bilità di ricongiungersi con essa, è l’impossibilità di comunicare con gli strani abitanti del pianeta su cui è arrivata. Bilù ha bisogno di trovare degli amici. Gli unici che rispondono a questa necessità sono i più piccoli −cuccioli e bambini − con cui può riposare e giocare senza bisogno di scambiare troppe parole. Bilù è “straniera” in un modo e in una forma facilmente chiari e comprensibili anche alle bambine e ai bambini più piccoli, dalla scuola dell’infanzia
ai primi anni della primaria: è minuscola, sola, completamente gialla, ha tre occhi e due lunghissime orecchie che arrivano fino a terra. Inoltre, parla una lingua incomprensibile: ce lo mostrano i segni scritti nei fumetti che inutilmente tentiamo di leggere. Ma che cos’è la lingua, per una bambina o un bambino? Ce lo spiega, attraverso un racconto in prima persona, l’albo La cosa più preziosa: 4: “Sono in circolazione da molto, molto tempo / Da più tempo che i giocattoli, i cani/o chiunque tu conosca/Le mie radici


risalgono a molti secoli fa / Alcune vanno anche più indietro / Sono la cosa più preziosa, ma puoi trovarmi dappertutto / In ogni nazione, ogni città, ogni scuola e ogni casa”. Sono spesso stata testimone dell’arrivo in classe di bambine e bambini − talvolta ragazze e ragazzi − in un contesto totalmente nuovo e sconosciuto, senza alcuna conoscenza della lingua italiana e senza alcuno strumento di decodifica che non fosse l’interpretazione della realtà attraverso lo sguardo. Se ripenso al loro silenzio, non posso che trovarlo simile a quello del protagonista di Ascoltami quando sto zitto:5 “Quando ero piccolo, i grandi mi fecero conoscere le parole/perché avessi un posto dove mettere le cose / Le parole mi piacciono / ma dentro non ci sta proprio tutto”.

Non ascoltare è la peggior interruzione di comunicazione possibile: peggiore perché è intenzionale, volontaria. Uno dei maggiori privilegi degli insegnanti è invece mettere le bambine e i bambini nelle condizioni di esprimere liberamente i propri pensieri, di condividere riflessioni e domande, potendo di conseguenza ascoltare, nel loro formarsi e dipanarsi, i processi di pensiero dei più piccoli. Ciò avviene frequentemente proprio sulle suggestioni generate dalla lettura condivisa, che spesso ha il grande merito di suscitare in chi legge e in chi ascolta molteplici domande. Domande mai univoche; domande in cui le possibilità di risposta sono tante quanti i lettori e le lettrici. Domande generatrici di ulteriori domande, in un processo dove davvero la condivisione, tra i pari e con gli adulti, è strumento utilissimo per la costruzione della conoscenza e di competenze, prima
fra tutte lo sviluppo del pensiero cri tico. Le stesse do mande che M., prota gonista dell’albo M come il mare si pone osser vando l’orizzon te: “Il suo sguar do si posò su quell’acqua che / sembrava non avere fine, sulle onde/ Le se guì, lontano lontano, fino all’o rizzonte / C’è qualcuno dall’altra parte? /C’è qualcuno lì dove scompaiono le onde? / Qualcuno come me? E come si sta laggiù?” .
Se il mondo, con le sue tante lingue e culture, non entra a scuola attraverso i suoi abitanti umani, può farlo grazie ai libri e alle storie. Viaggi7 si apre con la possibilità di muoversi “ancor prima di partire” − oppure, al contrario, di non volerne proprio sapere. Ci invita all’esplorazione attraverso il planisfero della prima doppia pagina, o i ravioli cinesi di una tra le successive. La conoscenza di un popolo e della sua cultura passa anche attraverso il cibo. Questo albo, uscito nel 2023, è stato recentemente arricchito da un mazzo di carte-racconto dal titolo Storie di viaggi, che invitano a inventare storie proprio a partire dalla lettura delle immagini, e giocando con esse. Chiudo il cerchio tornando a Origine: ho subito trovato questo albo magnifico per le suggestive illustrazioni e il dichiarato intento di portare lettrici e lettori a riflettere su quanto i 22 popoli protagonisti delle ricerche dell’autrice abbiano mantenuto, nei secoli, il contatto con la natura. Mi sono però chiesta quanto questa mia considerazione potesse essere condivisa anche dalle bambine e dai bambini di seconda primaria in cui insegno. Ho

iniziato l’attività proponendo loro la lettura dell’immagine della quarta di copertina8. La parola Origine, che dà il titolo all’omonimo albo, racchiude ed esprime la complessità del mondo: tutte le creature viventi sono connesse tra loro, alla natura e all’universo. Un’immagine tanto suggestiva per me, adulta, quanto particolarmente interessante per le osservazioni che ne sono scaturite da parte bambine e bambini. Nel corso della lettura di parole e immagini di ciascuna doppia pagina abbiamo incontrato, nelle settimane successive, 22 popoli: sono state occasioni di riflessione su identità, diversità, rapporto con gli altri e con la natura, rispetto, solidarietà, gratitudine. La lettura quotidiana è stata attesa con trepidazione: ogni volta, bambine e bambini hanno letto le immagini, condiviso ipotesi, confrontato i numeri relativi ai popoli (“3000 sono tanti!” “Ma no, 70.000 sono di più!”), cercato di localizzare i popoli sul planisfero; si sono interrogati su riti e credenze, hanno imparato parole nuove e chiesto di vedere le immagini fotografiche relative ai diversi popoli alla digital board. A margine di una lettura sola (per esempio a proposito dei Bijagó) abbiamo parlato di maschere, spiriti, totem, morte, nudità, leggende, religioni, colori naturali, artigianato, Carnevale, nativi americani; e avremmo potuto continuare a lungo.

Scoprilo in LiBeRWEB
Volgere lo sguardo all’origine comune delle cose significa ricordare che tutto è connesso, e capire che tutti gli esseri viventi del mondo compongono un’unità, e che siamo “Una cosa sola” 9
1. N. Cardozo. Introduzione all’albo Origine, Milano, L’ippocampo, 2024.
2. Dalle Indicazioni nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.
3. A. Deacon. Bilù, trad. di Loredana Baldinucci, Milano, Il Castoro, 2020.
4. V.D.O Santos. La cosa più preziosa, trad. e postfazione di Vera Gheno, ill. di Anna Forlati, Milano, Terre di Mezzo, 2024.
Vera Gheno, sociolinguista, ha tradotto l’albo La cosa più preziosa di Victor D.O. Santos e Anna Forlati (Terre di Mezzo, 2024): al centro del libro c’è l’importanza delle lingue madri, ritratte con numerose definizioni.
Ce ne parla in questa intervista raccolta da Sibilla Ponzi: https://shorturl.at/hhSSa Vaiall’intervista
5. Z. Hristova. Ascoltami quando sto zitto, trad. di Neva Micheva, ill. di Kiril Zlatkov, Roma, Orecchio Acerbo, 2024.
6. J. Concejo. M come il mare, Milano, Topipittori, 2020.
7. A. Benotto. Viaggi, Milano, LupoGuido, 2023.
8. La proposta di scrittura “Cosa vedi? Cosa immagini?” è un’idea preziosa di Melania Longo.
9. Dall’introduzione di Origine, op. cit.
ono numerose le storie ispirate in gran parte a esperienze realmente vissute da tanti migranti italiani, che dovrebbero consentire a lettori e lettrici di comprendere meglio le ragioni, i sogni, le paure di chi oggi scorge nell’Italia una possibile meta o una terra di transito.
L’incontro-scontro con l’altro da noi, con l’altro che è in noi:
una rassegna di libri per ragazze e ragazzi a cura di Gabriela Zucchini
La parola ci libera, ci imprigiona, ci definisce. Ci identifica. Scrive Chimamanda Ngozi Adichie, autrice nigeriana cresciuta leggendo storie occidentali, che la scoperta degli scrittori africani l’ha salvata “dall’avere un’unica storia”. 1
Perché il rischio di una visione focalizzata sull’occidente e sulla letteratura occidentale è quello di creare stereotipi, “un’unica storia” appunto, non priva di importanti conseguenze, come quella di mettere l’accento “sulle nostre diversità piuttosto che sulle nostre somiglianze.”2 È allora
verso la complessità, la varietà e la ricchezza di esperienze storiche, linguistiche, culturali. Storie per mettersi in relazione, per riconoscere l’altro in noi stessi, come ci racconta Giuseppe Catozzella in Il grande futuro:3 spinto dal desiderio di conoscere le radici del rapporto e dello scontro millenario tra la civiltà occidentale e quella islamica, l’autore si reca nel Corno d’Africa “per guardare il mio nemico negli occhi”. E si accorge che al fondo degli occhi di Alì, ex combattente fondamentalista salvato dalle parole e dai rac-
È dalle parole che bisogna iniziare, perché “è la parola che ha il potere di trasformare il mondo”, di creare e cambiare destini, di favorire l’incontro con l’altro, di umanizzare
importante che a narrare la propria storia siano i protagonisti di quella storia, per diventare essi stessi soggetti della scrittura, invece di rimanere semplicemente oggetti . Ed essere consapevoli della parzialità del nostro punto di vista, e dei rischi che corriamo tutte le volte che semplifichiamo, perché la nostra umanità può essere compresa solo attra-
conti di Marya, c’è un’umanità che li rende uguali: lui e il nemico erano perfettamente la stessa cosa. In questo scontro-incontro con l’altro da noi, o con l’altro che è in noi, il potere delle parole rappresenta il filo conduttore, lo strumento più potente per creare mondi umani, per costruire e non distruggere, per restituire e non sottrarre dignità, come
scrive Ngozi Adichie. E come ci dice anche Antonio Ferrara nel libro illustrato Come i pini di Ramallah (Fatatrac, 2003), ormai introvabile ma di estrema attualità, in cui i giovani protagonisti − David, israeliano, e Mohammed, palestinese, entrambi segnati dalla violenza dello scontro e dall’amore per la loro terra − guardandosi negli occhi pensano che forse la pace non è qualcosa di irreale, bisogna solo “dirla, raccontarla, finché non sarà


energicamente ai commenti quotidiani sui “macaroni”, si interroga sulla sua identità, arrivando alla fine a comporre tutte le parti della sua storia, familiare e culturale. Così come in Il viaggio di Stefano (Mondadori, 2015) M.Teresa Andruetto, argentina di origini piemontesi, attraverso la storia del giovane protagonista, che nel secondo dopoguerra fugge dalla fame e dalla miseria per approdare in Argentina, sostenuto dal con-



L’incontro con l’altro spesso non è cercato ma subìto, vissuto come costrizione, esemplificato dall’esperienza di tanti costretti a travalicare confini , fisici e ideali
dappertutto, nelle alghe, nella pietra, nella montagna”. Ecco, è dalle parole che bisogna iniziare, perché “è la parola che ha il potere di trasformare il mondo”, 4 di creare e cambiare destini, di favorire l’incontro con l’altro, di umanizzare. Un incontro con l’altro spesso non cercato ma subìto, vissuto come costrizione, esemplificato dall’esperienza di tanti costretti a travalicare confini, fisici e ideali. Un’esperienza la cui universalità può forse essere meglio compresa partendo da quando l’altro eravamo noi. In Bellosguardo (Sinnos, 2006), Manuela Salvi narra della migrazione di tanti italiani da Napoli agli Stati Uniti all’inizio del secolo scorso, fino all’approdo a Ellis Island, dove veniva deciso il destino di tutti coloro che all’arrivo avevano tratto forza e speranza dalla visione della imponente statua che si innalzava con la sua fiaccola sulle acque di Manhattan. Lo stesso tragitto è tracciato dall’autrice nel romanzo breve Mandolin Rock: da Napoli a New York (Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2012)5 nel quale il giovane protagonista Samuel, amante del rock e orgogliosamente americano, scopre la sua discendenza da una tribù di “mangiaspaghetti” e da una trisnonna suonatrice di mandolino, che con la sua musica aveva portato il cuore di Napoli laggiù. E così la musica del passato si fonde con la storia di un ragazzino che sta scoprendo le proprie radici, contaminando la sua identità e la sua formazione musicale. Di razzismo verso gli italiani parla Melina Marchetta nel romanzo Terza generazione (Mondadori, 1999) che attinge alla sua storia familiare: troppo italiana per essere australiana, troppo australiana per essere italiana, Josephine, mentre reagisce
forto della musica, ripercorre la storia del padre e della sua famiglia. E il filo conduttore della musica, che consente di preservare le proprie origini e la propria identità, ritorna anche in Sotto il cielo di Buenos Aires, di Daniela Palumbo (Mondadori, 2013), un intenso romanzo che conduce Ines, la giovane protagonista, dall’Italia centrale fin nel cuore dell’Argentina, per scomparire poi nella spirale dei desaparecidos durante il periodo della dittatura militare. Nei romanzi Io come te, di Paola Capriolo (EL, 2011), e Giù nella miniera, di Igor De Amicis e Paola Luciani (Einaudi Ragazzi, 2016), incontriamo invece la storia di numerosi italiani migrati in Belgio, impiegati in condizioni di lavoro durissime nelle miniere di Marcinelle e costretti a vivere in capanne fatiscenti e malsane, vittime di razzismo da parte della popolazione locale tanto da vedersi negare l’ingresso in tanti negozi del paese con veri e propri divieti affissi alle vetrine, e che in gran numero trovarono la morte nel tragico incendio scoppiato in quelle miniere l’8 agosto 1956, che segnò in modo indelebile la storia dell’emigrazione italiana. Allo stesso episodio rinvia il bellissimo albo illustrato Mio padre il grande pirata di Davide Calì e Maurizio A.C. Quarello (Orecchio acerbo, 2013), che tratteggia in modo commovente il rapporto tra un figlio e il padre minatore, attraverso una rielaborazione poetica e fiabesca di quella storia di emigrazione. Allo stesso contesto riporta anche il primo dei venti racconti di emigranti italiani presentati nella raccolta Sulla porta del mondo, di Luigi Dal Cin (Ill. di Cristiano Lissoni, Terre di Mezzo, 2024), mentre della nostalgia del ritorno ci parla Claire Nivola, figlia del pittore e scultore Costantino Nivola, nell’albo illustrato Orani. Il paese di mio padre (Rizzoli, 2013), accolto con attenzione anche negli Stati Uniti, in cui l’autrice narra le estati passate ad Orani, in un universo quasi fiabesco molto lontano dalle atmosfere newyorchesi di cui era intrisa la famiglia. Leggere queste storie, ispirate in gran parte ad esperienze realmente vissute da tanti migranti italiani, dovrebbe consentire di meglio comprendere le ragioni, i sogni, le paure di chi oggi scorge nell’Italia una possibile meta o una terra di
transito. A partire da quei libri che hanno segnato l’avvio di un vero e proprio filone all’interno della letteratura giovanile, come Viki che voleva andare a scuola di Fabrizio Gatti (Fabbri, 2004); Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda (Baldini&Castoldi, 2010); Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella (Feltrinelli, 2014), trasposto in film nel 2024 con la regia di Yasemin Samdereli. Quello del ‘Viaggio’ come spartiacque tra mon- di diversi è un tema centrale



approdare nella nuova terra, cercando di conciliare le diverse anime della propria identità.
A un coro di voci, provenienti da contesti diversi, dà invece espressione La frontiera: raccontata ai ragazzi che sognano un mondo senza frontiere, raccolte da Alessandro Leogrande e riproposte da Nadia Terranova in una edizione per ragazzi (Feltrinelli, 2021) ; così come Se non muoio domani , di Pablo Trincia (De Agostini, 2024), che narra di tre giovani provenienti da tre continenti diversi, le cui



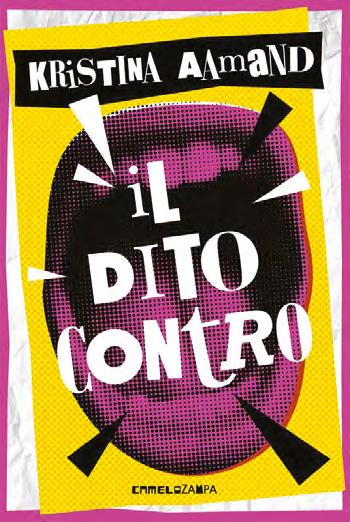
in tanti libri autobiografici, come Butterfly, di Yusra Mardini (Giunti, 2019), coraggiosa nuotatrice siriana, profuga assieme alla sorella in Germania, paese che le consentirà di realizzare il sogno di gareggiare alle Olimpiadi di Rio nel 2016, e a quelle di Tokyo del 2021, sotto la bandiera degli Atleti Olimpici Rifugiati, diventando ambasciatrice dell’UNHCR, la cui storia è stata trasposta nel 2022 nel film Le nuotatrici , per la regia di Sally El Hoseini. Sempre da Damasco arriva in Europa anche Ahmad Joudeh, autore di Danza o muori (De Agostini, 2018), animato fin dall’infanzia da una inscalfibile passione per la danza, che difende sia dalle violenze del padre che dalle minacce dei fondamentalisti, portando sui palchi europei un messaggio universale di pace. E dalla Siria prende le mosse anche Il paese degli addii (Giunti, 2019), il cui titolo è esemplificativo del destino di quella terra, in cui Atia Abawi narra una storia di speranza e di umanità attraverso la voce del Destino, che rende ancora più intensa la narrazione. Non sappiamo nulla invece sulla provenienza di Madina, quindici anni, protagonista di E in mezzo: io di Julya Rabinovich ( Besa Muci, 2022), fuggita dalla guerra e approdata a Vienna, la cui integrazione è ostacolata non solo dal contesto di accoglienza ma anche dalla sua famiglia, che teme un distacco dalle proprie origini. Animata da una grande voglia di riscatto, Madina si trova in mezzo al mondo occidentale e a quello orientale, tra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi, e troverà nella lingua una sorta di ponte attraverso il quale

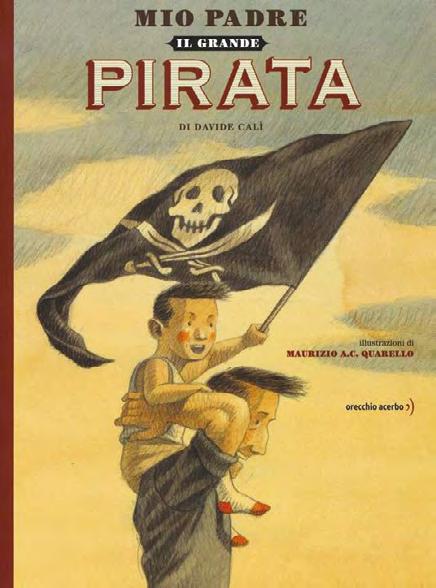

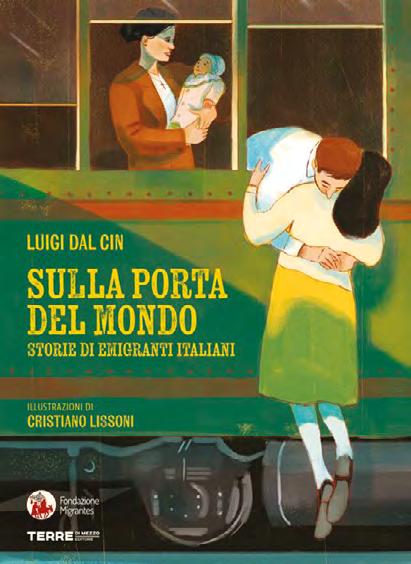
storie di dolore e di speranza, toccate con mano dallo stesso autore, ci interpellano e ci interrogano. Del ‘Viaggio’ come spartiacque tra mondi ma anche come affondo di tutti i sogni, e della percezione dell’altro come nemico troviamo una indimenticabile rappresentazione negli albi illustrati di Armin Greder, tutti pubblicati da Orecchio acerbo, di cui segnaliamo il recente Voi (2024) una impietosa accusa contro il colonialismo occidentale in Africa e le sue responsabilità per tutte le morti in mare, un libro dedicato “Alle vittime della cattiveria europea” dal tono decisamente politico, capace di parlare a tutti attraverso il filtro dell’arte. Come fa anche Shaun Tan in L’approdo (Elliot, 1998), libro ibrido tra fumetto e albo illustrato, silent book che narra con immagini realistiche calate in una dimensione onirica lo spaesamento di chiunque si trovi catapultato in un mondo sconosciuto, alieno, al di fuori di qualsiasi tempo.
Tanti sono anche i testi che narrano di
Scoprilo in LiBeRWEB
Sconfinamenti: letture, narrazioni e letterature in movimento. Un progetto a cura della Biblioteca Passerini-Landi di Piacenza e Equilibri https://shorturl.at/VdEUO
Vai al progetto
salvataggi e di approdi, come Salvezza, di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso (Feltrinelli Comics, 2018), un’opera di graphic journalism nata dall’esperienza diretta degli autori sull’Aquarius, la nave della Ong Sos Méditerranée, impegnata a lungo nei salvataggi nel Mediterraneo. O della sofferenza e reclusione a cui sono sottoposti i sopravvissuti, una sofferenza riconosciuta spesso da occhi infantili piuttosto che adulti, come in Ibra (Anicia, 2024), di Stefano Tofani, una storia che è anche un progetto, ideata al termine di uno dei Camp tenuti nella biblioteca di Ibby sull’isola di Lampedusa. Da profonda pietas è animato l’albo illustrato Azur del mare, di L.M. Kalamian (40GB, 2024) , anch’esso ispirato a eventi reali, tradotto in laboratorio teatrale con il coinvolgimento di giovani di paesi, culture ed esperienze diverse. E di accoglienza ci parla Casa Lampedusa di Antonio Ferrara (Einaudi Ragazzi, 2017), che attraverso un graduale processo di conoscenza porta il giovane protagonista ad elaborare l’insofferenza e la rabbia nei confronti dell’altro. Alla storia di Alan Kurdi, il bimbo di tre anni in fuga dal conflitto siriano ritrovato sulla spiaggia turca di Bodrum nel settembre 2015, la cui foto ha fatto il giro del mondo scuotendo tante coscienze, si ispira infine Khaled Hosseini nella Preghiera del mare (a cura di Roberto Saviano, SEM, 2022), accompagnata dai suggestivi acquerelli dell’artista inglese Dan Williams, per dar spazio a una struggente lette-

Cambiare sguardo, abituarci ad osservare con gli occhi dell’altro: in questo consiste la forza anche di alcuni intensi romanzi usciti recentemente. Tra le storie di ambientazione italiana, scritte da autrici afrodiscendenti, ricordiamo Il corpo nero, di Anna Maria Gehnyei (Fandango, 2023), e Addio, a domani , di Sabrina Efionayi (Einaudi, 2022), entrambe nate e cresciute in Italia. Il primo è la storia di Anna, nata a Roma da genitori liberiani, e costretta costantemente a fare i conti col colore della sua pelle, e a rimanere sospesa tra due culture: quella italiana, che le nega diritto di cittadinanza, e quella africana, a cui sente di non appartenere fino in fondo. Il secondo è la storia, narrata con inconsueta consapevolezza tecnica, di Sabrina Efionayi, di origine nigeriane, che oscilla perennemente tra l’amore di due madri, tra una lingua e una cultura e l’altra, nel tentativo di ricomporre una identità sfumata e complessa. La sua storia è raccontata anche nel podcast “Storia del mio nome”, prodotto da Spotify Studios in collaborazione con Chora Media6. Ambientati in contesti lontani sono il bel romanzo di Elisa Puricelli Guerra #Siamolavostravoce (Einaudi Ragazzi, 2023), che dall’Italia ci porta a Teheran in un momento drammatico, segnato dalla morte di Masha Amini, in mezzo ai tanti manifestanti che protestano al grido di “Donna, vita, libertà”; Senza titolo , di Erna Sassen (Illustrazioni di Martijn Van der Linden, Camelozampa, 2024), ambientato in Olanda e focalizzato sul dolore di un amore giovanile spezzato da una tradizione violenta e iniqua, contro il quale nulla può la rabbia del giovane protagonista, che trova espressione nei bellissimi disegni che accompagnano tutta la narrazione; Il dito contro, di Kristina Aamand (Camelozampa, 2024), la cui protagonista, dal nome emblematico di Sherazade, arrivata in Danimarca per sfuggire dalla guerra, oppressa dalle aspettative di una famiglia tradizionale, lotta con coraggio per rivendicare le sue scelte e la sua libertà, anche in campo affettivo, affidando la sua storia alle fanzine che compone in segreto. Tanti libri per dare vita a quella pluralità di voci necessaria a cogliere la complessità sociale e culturale del presente, tessere importanti di un puzzle difficile ma necessario da comporre che è la costruzione di una società aperta ed accogliente. Perché navigare tra una molteplicità e diversità di storie è irrinunciabile per dare forza alla nostra umanità, per restituire dignità a chi sembra averla smarrita, per contrastare razzismi ed esclusioni. In altre parole, per formare cittadine e cittadini del mondo.
1. C. Ngozi Adichie. Il pericolo di un’unica storia, Torino, Einaudi, 2009, p. 3-5.
2. Ivi, p. 15.
3. G. Catozzella. Il grande futuro, Milano, Feltrinelli, 2016, p. 225-226.
4. A. Ferrara. Come i pini di Ramallah, op. cit.
5. A cura della stessa autrice è A braccia aperte. Storie di bambini migranti, ill. di Cristina Spanò, Mondadori, 2016, dodici storie ispirate a fatti reali che raccontano di bambini migranti, italiani e stranieri.
ono le storie quotidiane che ci rendono simili e più vicini, anche se esperienze, abitudini o tradizioni possono essere molto diverse. Gli “altri” sono anche il nostro specchio, ci costringono a guardarci dentro.
Multicultura, pregiudizi e sfide nella conversazione di Fausto Boccati con Sumaya Abdel Qader
F. B. “Chi sono io?”: Fairùz, la giovane protagonista del suo romanzo In cerca di me (Mondadori, 2023), è in quell’età “sospesa” nella quale si pone domande esistenziali complesse, che il mondo circostante le restituisce nella dimensione monolitica del piano culturale e religioso: “Da quale Paese provieni?”, “Di quale religione sei?”. Come, e in quali contesti educativi si può efficacemente agire per favorire il dialogo e la conoscenza reciproca tra le culture che si interfacciano nel nostro Paese, per ridurre fin da bambini l’entità di questa “con-fusione identitaria”?
S.A.Q. Ogni occasione, ogni luogo e momento può essere una opportunità dove provare a favorire il dialogo e la conoscenza reciproca: da una cena con gli amici, ai luoghi e spazi nelle scuole. Soprattutto a scuola vanno stimolate la curiosità attiva e il rispetto reciproco. Non solo le nozioni sono importanti e necessarie, ma soprattutto l’incontro e confronto tra le persone. È necessario ritrovare la dimensione umana dietro ogni storia. Sono proprio le storie quotidiane che ci rendono simili e più vicini, anche se le esperienze e le abitudini o tradizioni possono essere molto diverse.
“Gli altri” sono anche il nostro specchio. A volte per questo fanno paura, ci costringono a guardarci dentro o da fuori. Sono
la prova del nove dei principi e valori in cui diciamo di credere.
F.B. Fairùz si stupisce quando compagni “non sospetti” svelano la loro origine, albanese o brasiliana: lei stessa deve fare i conti con pregiudizi introiettati, per quanto li riconosca e cerchi di compensarli razionalmente. È in corso qualche evoluzione nel modo in cui la generazione dei giovanissimi percepisce oggi le persone con background migratorio e le questioni legate al razzismo e alla cittadinanza? Hanno strumenti e linguaggi nuovi, per affrontare con sguardo nuovo questi temi?
S.A.Q. I pregiudizi ci sono sempre verso ciò che è nuovo. Non sono da condannare in quanto tali, fanno parte di un “meccanismo di difesa” in parte anche istintivo e non razionale davanti a ciò che è una incognita. Per questo è importante far seguire una azione razionale e riflessiva come conoscere
Le giovani generazioni vivono sempre più spesso in contesti già multiculturali, per cui non è più come per le generazioni precedenti, che vivevano l’immigrato come una novità. I figli di immigrati condi-vivono con i nostri figli fin dall’infanzia. Crescono insieme, imparano a conoscersi presto. Inoltre, i social media permettono di “viaggiare” e conoscere sempre più culture e tradizioni anche attraverso giovani nati e cresciuti in Italia figli di immigrati che si raccontano. Sono sempre più

i tiktoker, per esempio, che vanno in questa direzione e, in qualche modo, “normalizzano” la multi cultura, la pluralità. Questo può aiutare a diminuire il razzismo e aiuta a far solidarizzare su temi come la riforma della legge sull’acquisizione della cittadinanza italiana. Il tempo ci dimostrerà se questo “trend” si consoliderà o meno e se, crescendo, non influiranno altri fattori che cambieranno i percorsi di questi giovani “nativi plurali”.
F.B. La contraddittoria questione del velo, la restrizione delle donne negli spazi domestici e nei ruoli di cura, i privilegi maschili: ricorre nel romanzo il riferimento ad aspetti sessisti e patriarcali, che hanno origine nelle rigide interpretazioni dei fondamenti religiosi e della tradizione. Quanto pesano, sulle nuove generazioni di fede islamica, questi elementi di intersezionalità relativamente alle questioni di genere? Quanto ne sono consapevoli e con quale grado di libertà li elaborano? Cosa vuol dire oggi essere donna musulmana e femminista?
S.A.Q. Non potevo esimermi dal parlare di certi temi, perché sono una realtà. Potevo raccontare una favola dove i problemi non esistono, ma sarebbe stata appunto una favola. Io volevo raccontare storie reali pur sicuramente non rappresentative di tutti, ma storie che potessero aprire una finestra su un pezzo di mondo dove “la contraddittoria questione del velo, la restrizione delle donne negli spazi domestici e nei ruoli di cura, i privilegi maschili” ci sono ancora, ma vengono messe in discussione e stanno avvenendo dei cambiamenti. Di questo si parla poco. Su questi temi, incidono (non sempre ma spesso), le origini, il grado di istruzione dei genitori, gli strumenti che la scuola dà. Le nuove generazioni hanno più consapevolezza
della generazione dei padri e delle madri, fanno e si pongono molte domande, cercano risposte e coerenza. C’è la consapevolezza che molte cose “non tornano”. Soprattutto provano a conciliare tra “i mondi” in cui vivono, operazione faticosa, non di rado lacerante. Se da un lato sono consapevoli che hanno delle battaglie da affrontare con famiglie non sempre dialoganti, non sempre attente ai loro problemi e difficoltà, portatrici di tradizioni più o meno patriarcali, dall’altro lato combattono con una società che li vede con sospetto, li stigmatizza, non di rado discrimina e razzializza. Sono giovani che si impegnano a sciogliere i nodi delle contraddizioni religiose e culturali: per esempio superare le restrizioni della libertà delle donne, restrizioni che hanno un peso culturale e non religioso, dove la cultura si eleva a livello della religione e la assorbe. Lo sanno, hanno imparato a distinguere tra tradizione e religione e cercano di recuperare il senso originario di precetti deculturalizzandoli. Sul secondo fronte c’è la difficoltà di raccontare il cambiamento in atto, le differenze culturali, la pluralità di pensiero, ecc. Un esempio classico che una ragazza musulmana si trova ad affrontare è quello dello spiegare il velo e la condizione della donna musulmana. Alla domanda “perché il velo è imposto e perché molte donne musulmane non hanno libertà”, cosa può rispondere un giovane adolescente che non ha neppure gli strumenti per spiegare tali complessità? Eppure, ci provano, provano a spiegare la differenza tra cultura e religione, provano a dire che “l’Islam” non impone il velo, che le donne dovrebbero essere libere di scegliere e quando questo non accade è un problema che va condannato e superato. Non è questo lo spirito del femminismo? Lottare affinché le donne, appunto, siano libere di scegliere? Tuttavia, quando una donna musulmana dice di essere libera di indossare il velo e lo fa come esercizio di fede, non sempre viene creduta e si sente spesso ribattere “voi non siete consapevoli di essere sottomesse”. Questo infantilizza le donne musulmane e porta molte/i a vederle incapaci di autodeterminarsi. Dovremmo poi domandarci: siamo tutti/e liberi/e dai condizionamenti?
F.B. Con quali parole-chiave potrebbe riassumere la sua idea di inte(g)razione e convivenza in un Paese che non è quello d’origine dei propri genitori: si tratta di adattarsi rinunciando ai propri valori? L’idea di preservare le radici culturali familiari è in conflitto con quella di rielaborarle, in dialogo con le tradizioni del Paese nel quale si è cittadini? Nello specifico dell’identità islamica in Italia, quali resistenze reciproche si oppongono a questo processo di incontro?
S.A.Q. Non credo ci possa essere una parola riassuntiva. Non credo neppure sia opportuno ridurre un percorso articolato, mutevole e complesso con una parola. Ci sono fasi, ci sono alti e bassi, sfide, negoziazioni e rinegoziazioni. L’identità islamica poi non esiste. Esistono persone che provengono da paesi diversi, che vivono la fede e la religione in modo diverso come anche la propria plurale identità.
I musulmani, come gruppo religioso, sono visti ancora come una minoranza, e pur essendo la seconda religione in Italia per numero di fedeli, non hanno ancora un riconoscimento: l’Intesa con lo Stato, come previsto dall’articolo 8 della Costituzione. In passato la “scusa” è sempre stata legata al fatto che le comunità musulmane non avessero una sola rappresentanza che facesse domanda per la procedura di Intesa. Richiesta di
La protagonista del libro In cerca di me (Mondadori, 2023) affronta la questione identitaria osservando il mondo, tra contraddizioni e aperture
“Prima di passare alle scuole superiori, è importante riflettere su chi siamo, da dove veniamo e chi vogliamo essere da grandi”: questo è l’argomento del tema che la prof di lettere consegna all’inizio dell’anno scolastico alla sua terza media, in una zona di Milano a forte concentrazione multietnica. È la classe di Fairùz, nata a Milano in una famiglia “incasinata” ma dove sicuramente non regna la noia: madre di origini palestinesi cresciuta in Kuwait, padre giordano, due sorelle maggiori impegnate a crescere tra outfit e primi impegni nel sociale, un fratellino super viziato, e poi decine di cugini e zìì di origine araba sparsi per il mondo. Ma c’è differenza fra essere stranieri e figli di stranieri? E si può essere contemporaneamente italiani e arabi? Fairùz descrive il mondo dal suo angolo di osservazione e si rende conto che per lei, e per i compagni adolescenti accomunati da una famiglia con background migratorio, “riflettere su chi siamo” ha il peso di una questione identitaria particolarmente complessa. Nello svolgere il tema le basterà il racconto di qualche divertente aneddoto familiare o potrà scrivere − senza imbarazzi e senza passare per una pericolosa estremista islamica − anche del fatto che in

casa si prega cinque volte al giorno, si frequenta la scuola di arabo e Corano della domenica, si considera il velo un esercizio spirituale che una donna può fare in piena consapevolezza? Dovrà tacere di alcune rigide interpretazioni della tradizione islamica che si esprimono in timorose superstizioni o in atteggiamenti sessisti? A tavola si discute e si ragiona di tutto: tradizioni e modernità, patriarcato e femminismo, specificità e integrazione, il significato di cittadinanza: ma quello di Fairùz è il profilo di una famiglia reale e dunque imperfetta, a sua volta non del tutto libera da opinioni preconcette. Nel contrappunto tra scene di quotidianità domestica, relazioni tra pari a scuola e alcuni episodi conflittuali di socializzazione extra-scolastica tra gruppi antagonisti di ragazzi, l’autrice ricostruisce un credibile e attualissimo affresco di contraddizioni, pregiudizi, chiusure, disagi identitari e reciproche diffidenze; l’anima irrisolta di una città (un Paese) che comunque sa ancora esprimere slanci e aperture, e non rinuncia a credere nell’inte(g)razione e nell’ascolto fra le diverse culture come occasione di arricchimento per tutti.
Fausto Boccati
unità che per altre confessioni non è mai stata posta; infatti, altre comunità religiose hanno più intese. Una giustificazione dal sapore “politico” (ovvero di non volontà politica). Ma la mancanza di una intesa non è condizione sufficiente per non garantire i diritti minimi alle comunità religiose (si veda sempre la Costituzione). Per esempio c’è la mancanza di riconoscimento di vari diritti, come la possibilità regolarizzare di luoghi di culto, per problemi sempre legati a motivazioni urbanistiche, non si concedono spazi cimiteriali adeguati al rito islamico (come sarebbe previsto per legge e garantito per tutte le altre confessioni), e si creano norme ad hoc affinché queste due esigenze (avere un luogo per pregare e per riposare per l’eternità) siano sempre più difficili da realizzare. Sono due dei tanti esempi possibili. Faccio notare che di fatto sempre più musulmani chiedono di essere sepolti in Italia: è un “sintomo di “integrazione”. Invece siamo alla quarta generazione di musulmani in Italia che ancora vengono visti come corpo estraneo verso il quale scatta il “sistema immunitario di difesa”. La conseguenza sempre più visibile è che molte/i cominciano a sentirsi delusi del paese che reputano il loro e a guardare fuori, per andarsene. Non è un fallimento? Rispetto al tema delle “radici”: è un tema intrinseco all’essere umano. Senza le radici non esistono l’albero e i suoi frutti. F.B. Il suo romanzo, che ha molti riferimenti alla sua esperienza personale, è ambientato a Milano, dove lei svolge anche gran
parte del suo attivismo sociale e culturale. Immagina che la storia avrebbe avuto lo stesso sviluppo se ambientata in un’altra città? Quali sono le sostanziali differenze e i sostanziali punti in comune da una città all’altra del nostro Paese, sulle questioni legate a razzismo, dialogo interculturale, integrazione?

S.A.Q. Sicuramente una grande città come Milano è diversa da un piccolo paesino. Immagino che le storie avrebbero potuto prendere percorsi differenti, per certi aspetti. Ma molte delle differenze sono le stesse che un italiano “doc” affronterebbe: la dimensione più alienante della grande città, ma che allo stesso tempo offre più opportunità, soprattutto se al nord. Nella grande città, Milano in particolare, c’è una dimensione più aperta e internazionale che molte piccole città di provincia non hanno. Ma non è detto che nelle città di piccole dimensioni, rurali o sperdute nelle montagne ci sia meno apertura e dialogo o che ci sia più razzismo. Nella mia esperienza ho incontrato bellissime realtà, con sindaci/ che molto attenti, cittadini consapevoli e attivi, scuole con dirigenti e insegnanti molto propositivi e illuminati, realtà associative di grande valore impegnate nel sociale con progetti che funzionano. Il punto è che in Italia dipendiamo molto dalla buona volontà delle persone (che sono tante) ma le buone pratiche che si sviluppano non sempre vengono modellizzate e istituzionalizzate o finanziate come si dovrebbe. Un enorme spreco.
sondaggi
Dalla magia dell’universo alle storie di bullismo e alle esplorazioni poetiche del ciclo della vita: i migliori libri 2024 raccontano il mondo senza buonismi, con attenzione ai lettori e alle lettrici
La giuria di LiBeR, composta da librai, bibliotecari e studiosi della letteratura per l’infanzia, ha stilato la classifica dei migliori libri per bambini e ragazzi pubblicati nel 2024, segnalando opere che spaziano dalla poesia alla narrativa illustrata e offrendo ai giovani lettori storie che emozionano e fanno riflettere spingendosi oltre il semplice intrattenimento. Al vertice della graduatoria si è posizionato Stardust: polvere di stelle di Hannah Arnesen, edito da Orecchio Acerbo, seguito da Il lupo di Stanišić per Iperborea. Stardust è una storia che parla di crescita, desideri e del legame invisibile tra passato e futuro. Con una scrittura evocativa e bellissime illustrazioni, tra acquerelli e parole, Arnesen regala un’esperienza che va oltre la semplice narrazione, portando a riflettere sulla magia dell’universo, combinando il linguaggio poetico con un messaggio profondo e universale raccolto in forma epistolare. Com’è iniziata la vita sul nostro pianeta? Possiamo ancora salvarlo? Un vero manifesto ecologico che fonde arte, poesia, scienza e filosofia e che si snoda tra generi e linguaggi, per raccontare la bellezza della Terra, il nostro ruolo e quello di chi verrà dopo di noi. Diverso nello stile e nelle tematiche, Il lupo di Saša Stanišić ha conquistato il secondo posto grazie all’intreccio avvincente di una storia che affronta i temi della paura, del coraggio e dell’identità. Attraverso la voce di Kemi, un ragazzo che partecipa a un campo estivo nel bosco, il romanzo ci parla di bullismo, della paura e del coraggio di essere se stessi con
uno stile che − come sottolineato da Fausto Boccati nella sua recensione su LiBeR 144 – “ci risparmia retoriche e buonismi su cosa sia l’adolescenza vista dagli adulti, su come siano gli adulti visti dagli adolescenti e sul perché gli adolescenti dovrebbero andare tutti d’accordo tra loro”. L’opera ha ricevuto il Deutscher Jugendliteraturpreis 2024, il più importante premio tedesco per la letteratura per l’infanzia, e ha ottenuto una menzione speciale al Premio Rodari 2024 nella categoria Romanzi e Racconti. Al terzo posto troviamo le poesie raccolte in Canti dell’inizio, canti della fine firmate da Bruno Tognolini e Silvia Vecchini, illustrate da Giulia Orecchia e pubblicate da Topipittori. Il libro esplora il ciclo della vita attraverso inizi e conclusioni di momenti quotidiani come l’ultimo morso di un gelato, il primo e l’ultimo giorno della scuola, la fine della pioggia, il momento prima di prendere sonno. Ogni poesia è un invito a considerare la bellezza e la transitorietà di ogni momento. Le illustrazioni di Giulia Orecchia potenziano il messaggio poetico in modo elegante ed evocativo. Il quarto posto è occupato ex aequo da tre opere: Il segreto di Rosie di Maurice Sendak (Adelphi), Killiok di Anne Brouillard (Babalibri) e Misha. Io, i miei tre fratelli e un coniglio di Van de Vendel e Elman (Sinnos).
Sendak ci porta a Brooklyn, nel quartiere dei suoi anni giovanili, da una Rosie che è esistita davvero e che è diventata per l’autore la personificazione dell’idea di Infanzia. Sendak trascorreva le sue giornate alla finestra, disegnando e annotando i


B. Tognolini, S. Vecchini, ill. di G. Orecchia, Canti dell’inizio. Canti della fine, Topipittori, 2024
H. Arnesen, Stardust: polvere di stelle, trad. di L. Cangemi, Orecchio acerbo, 2024

S. Stanišić, ill. di R. Kehn, Il lupo, trad. di C. Valentini, Iperborea, 2024
Scoprilo in LiBeRWEB
Scopri la classifica dei migliori libri 2024, la composizione della giuria e i commenti dei giurati ai primi tre libri classificati: https://shorturl.at/LFJRg
Vai aclassifica, giuria
Arte, scienza e speranza in tempi di crisi ecologica e sociale
Hannah Arnesen racconta a Marnie Campagnaro la nascita e la crescita del suo libro Stardust: polvere di stelle.
Stardust è un libro bellissimo, ma al contempo respingente. 352 pagine, quasi una al giorno per un anno. Potrebbero essere impegnative da affrontare, specialmente se non si ha la passione per la lettura, la poesia e la scienza. Ma Stardust stupisce proprio per questo. Perché attraverso le immagini tiene insieme tutta la tela. Una tessitura visiva che parla del mondo, del nostro mondo. Di quello che era, di quello che è, di quello che sarà. E parla anche di noi, esseri umani, una specie ben difficile da comprendere, nei suoi comportamenti, nelle sue abitudini, nei suoi valori. Per questo Stardust: polvere di stelle è un libro più unico che raro. È un libro-mondo. Perché certamente parla di terra, natura, cambiamento climatico, inquinamento, effetto serra, Antropocene e di distruzione, ma parla anche di sguardi d’infanzia, di memoria bambina, della straordinarietà della vita quotidiana, di bellezza, tanta bellezza. Racconta il mondo in cui viviamo con meraviglia, con stupore, con amore. Oltre che con precisione scientifica. Abbiamo rivolto alla sua autrice, Hannah Arnesen, alcune domande. Tenere tutto questo assieme non deve essere stato facile. Da dove vuole partire, Hannah Arnesen, nel raccontare questo libro-mondo?
Stardust è nato da due punti di partenza. Ho sempre sognato di tracciare nuove strade per l’albo illustrato. Penso che sia troppo limitato da regole rigide, da fasce d’età, temi e strutture narrative. Il mio desidero è di creare albi illustrati per tutte le età perché li percepisco come un fantastico luogo di incontro tra generazioni, un’esperienza artistica che possiamo condividere e che può innescare conversazioni. Eppure, il tema di Stardust era l’ultima cosa sulla quale avrei immaginato di
giochi e le conversazioni divertenti che il gruppo di bambini del quartiere inventava e metteva in scena tra i vicoli, le porte aperte e le finestre semi-chiuse, sotto la guida dell’ingegno inesauribile di Rosie. Apparso per la prima volta nel 1960, grazie ad Adelphi è disponibile anche in Italia. Killiok è il protagonista di un libro che ci cattura con il suo sguardo curioso sulla vita. È un simpatico cagnolino nero, un piccolo esploratore che, con il suo passo tranquillo, ci guida a scoprire le meraviglie nascoste nei dettagli quotidiani. Tra le sue passeggiate e i suoi momenti di riflessione, Killiok ci insegna a rallentare, a fermarci e ad apprezzare le piccole gioie. Con la storia del
scrivere un libro. Tutto è iniziato con il mio compagno, che studiava sostenibilità e tornava a casa parlando della crisi climatica. Ho capito che non volevo ascoltare, era troppo deprimente, non riuscivo ad accettarlo. Mi sono sorpresa a cambiare l’argomento. È stato allora che ho preso una decisione: non volevo essere quel tipo di persona, volevo prendermene cura. Volevo fare un libro sulla crisi climatica per tutti noi che non vogliamo ascoltare Lo sguardo sul mondo è, insieme, scienza e poesia. In Stardust, questi due registri narrativi convivono: da un lato, infografiche, linee del tempo e tabelle restituiscono la precisione del dato scientifico; dall’altro, le illustrazioni e la narrazione poetica evocano emozioni e suggestioni. Nel suo processo creativo, questi due modi di raccontare il mondo seguono percorsi di pensiero diversi? Il suo approccio cambia quando lavora su un dato scientifico rispetto a quando costruisce una narrazione più immaginifica? Per me, Stardust è stata un’esplorazione di come integrare scienza e storia e, attraverso il potere della narrazione, trasformarle in qualcosa che non solo sono in grado di comprendere intellettualmente, ma che posso anche sentire emotivamente. Penso che abbiamo delegato troppe responsabilità agli scienziati. Come se la crisi climatica fosse solo un problema tecnico da risolvere, un grafico da spiegare. Per me è molto di più. È la questione esistenziale del nostro tempo. E sentivo la mancanza di quella conversazione. Nella società in cui sono cresciuta, i fatti misurabili sono considerati di grande valore, ma non credo che la minaccia alla democrazia derivi dalla mancanza
coniglietto Misha invece siamo trascinati nelle vicende di una famiglia rifugiata, toccando tematiche di integrazione, identità culturale e l’importanza inestimabile di famiglia e di amicizia. Infine, al quinto posto, sempre a pari merito, si classificano Cavalca la tigre di Davide Calì e Guridi per Kite, Nella tua pelle di Chiara Carminati per Bompiani, Origine di Nat Cardozo per L’Ippocampo e Ti ricordi? di Sydney Smith per Orecchio Acerbo. L’albo illustrato di Calì e Guridi racconta una storia piena simbolismo, in cui trovano spazio coraggio, crescita e autoaffermazione attraverso il pensiero unico e una visione divergente; nel libro Nella tua pelle
di fatti. Credo, piuttosto, che nasca da una mancanza di empatia, giudizio e capacità di relazione. E sono convinta che l’arte abbia un ruolo importante da giocare in tutto questo. Nel libro si percepisce una fluidità di passaggio tra esseri umani, animali e vegetali, quasi una dimensione liquida in cui le specie convivono in un rapporto di interdipendenza, trasformazione e scambio. La tecnica illustrativa ha cercato, in qualche modo, di essere essa stessa coerente con questa visione? Vi è stata una riflessione sulla possibilità di restituire, attraverso le immagini, l’idea di un flusso vitale condiviso, simile a un brodo primordiale che ci contiene tutti?
È entusiasmante leggere la tua interpretazione, e mi piace. Lavoro spesso con acquerelli e acrilici, e questo non è qualcosa di esclusivo per questo progetto. I miei pensieri sulle immagini erano che volevo essere abbastanza figurativa da coinvolgere l’immaginazione del lettore, ma al tempo stesso lasciare uno spazio astratto sufficiente da non limitarla. Per me è importante che l’immagine non si limiti a illustrare il testo, ma abbia lo stesso valore nella narrazione. Insieme, testo e immagine creano l’esperienza. Uso spesso il testo come trampolino per far sì che il lettore “cada” dentro le immagini. Le immagini possono offrire un silenzio, un vuoto, dove il lettore può collocare i propri pensieri. Ho anche riflettuto molto su come usare la bellezza come filtro per rendere possibile l’assorbimento dell’oscurità. Volevo che il lettore fosse catturato dalle immagini. Ho dedicato molto tempo a ciascuna illustrazione, come una forma di resistenza alla società dell’efficienza in cui viviamo. Per quanto riguarda i soggetti, ho pensato a lungo a come viene spesso rappresentata la crisi climatica. Credo che siamo diventati immuni ai ghiacciai che si sciolgono e agli orsi polari tristi. Un problema che ho sentito sollevare dai ricercatori è che tendiamo a percepire la crisi climatica come qualcosa di distante, sia nel tempo che
nello spazio. In Stardust, ho cercato di avvicinarla, riflettendo sulle immagini che emergono dalla mia vita quotidiana. Ho fotografato il mio guardaroba, i miei acquisti e i miei viaggi in aereo. Ho riflettuto su cosa significhi la crisi climatica per me, e ciò che è emerso è stata una sensazione di folla umana e di consumo.
Nel corso della sua ricerca ha parlato con tanti giovani, raccogliendo emozioni, paure, speranze.
Ora che Stardust è nelle loro mani, che tipo di dialogo si è creato con loro? Ci sono parti del libro che inizialmente non aveva immaginato come centrali, ma che invece attraggono maggiormente ragazze e ragazzi?

Hannah Arnesen
Quando ho creato Stardust, avevo la sensazione che alle persone non importasse davvero della crisi climatica. Forse sono stata influenzata dalla politica mondiale e dai media. Volevo raccontare la crisi climatica e trovare un modo per spingere le persone ad accoglierla. Ma oggi, dopo aver portato il libro in giro, mi rendo conto che mi sbagliavo. Il problema non è che alle persone non importa; ovunque, vada, nelle grandi città o nei piccoli villaggi, con bambini con bambini piccoli o persone anziane – a tutti importa. Il vero problema è che si sentono impotenti. Ho incontrato undicenni che non credono di avere un futuro, donne anziane che non vogliono avere nipoti e scienziati che hanno perso la speranza. Sento un forte desiderio di connessione tra le persone su questo tema. C’è bisogno di parlare della paura per il futuro e del dolore per ciò che stiamo perdendo. Sta crescendo una generazione con un’ansia climatica che non esisteva quando io ero un’adolescente. Rifletto spesso su me stessa, come narratrice, mi dovrei rapportare a tutto ciò. Oggi, sono ancora più interessata alla speranza. Cos’è la speranza? E come possiamo trovarla in tempi come questi? Credo che le storie ci plasmino, sia come individui che come società. E sono curiosa di capire che tipo di storia abbiamo bisogno di raccontare oggi.
la Carminati racconta di Giovanna, Vittorio e Caterina, “figli della guerra” cresciuti in istituto, le cui vite si intrecciano alla Storia; Origine –opera prima di Nat Cardozo, illustratrice che ha viaggiato in lungo e in largo – ci presenta le storie di 22 bambini di diverse popolazioni indigene di tutto il mondo. Tra tradizioni, leggende e credenze, ci offre uno sguardo unico sulla resilienza di culture millenarie ricche di saggezza e da sempre capaci di cura verso il nostro pianeta. Concludiamo questo excursus con l’albo Ti ricordi?, dove Smith affronta con delicatezza temi come la separazione, l’incertezza e l’amore attraverso una storia visiva commovente e il flusso
di ricordi di una madre e il suo bambino. Premio Andersen 2024, Smith con questo suo ultimo lavoro è stato anche selezionato tra i migliori albi illustrati del 2023 dal New York Times.
Benedetta Masi
Scoprilo in LiBeRWEB
Vaiall’intervista
Leggi l’intervista di Marnie Campagnaro ad Hannah Arnesen https://shorturl.at/qrc9I
Il volume di Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin torna in una nuova edizione aggiornata sui temi del libro accessibile e multimodale
Sono trascorsi dieci anni dalla prima edizione di Nati sotto il segno dei libri: sono tanti, in un mondo editoriale così denso di proposte e così esposto ai cambiamenti. Alcuni concetti fondanti, tuttavia, continuano a essere validi e non è trascurabile la necessità di ribadirli. Ecco perché la nuova edizione di Nati sotto il segno dei libri – pubblicata da Accademia dei Perseveranti, casa editrice dell’omonima Fondazione – mantiene salda la parte riferita ai fondamenti che nel corso del tempo hanno confermato la loro efficacia e validità: la lettura ad alta voce ai bambini e alle bambine fin dalla primissima infanzia può essere considerata una “buona pratica” ormai data per acquisita in contesto familiare ed educativo. Col tempo, però, la locuzione lettura ad alta voce, specialmente se riferita alla fascia di età tra zero e sei anni, è risultata insufficiente e generica per indicare una pratica molto complessa, che necessita di sensibilità, conoscenze, strumenti che procedano di pari passo con i risultati delle più recenti ricerche nell’ambito delle neuroscienze. Di qui la necessità di affinare almeno in parte lo sguardo su un argomento che potrebbe apparire usurato, per arricchirne le potenzialità. La lettura multimodale, ad esempio, poggia ormai su un codice ben documentato, che amplia il rapporto tra lettore e libro e offre idonei strumenti per l’accessibilità e l’inclusività di lettori con le più diverse competenze. La nuova edizione del libro tiene conto, dunque, degli apporti della ricerca

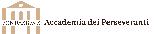
scientifica sull’approccio multimodale e del notevole impegno dell’editoria specializzata, capace oggi di pubblicare e diffondere libri con diversi, specifici codici di comunicazione. I libri in simboli CAA, ad esempio, permettono una migliore inclusività e consentono una maggiore autonomia nella comprensione del testo anche da parte di bambini e bambine che non sanno ancora leggere per i più diversi motivi: età, specifiche difficoltà o provenienza linguistica e culturale. A questo proposito, gli autori, studiosi di Letteratura per l’infanzia, forniscono una rinnovata bibliografia per bambini da 0 a 6 anni, composta, come già nella prima edizione, di Libri che sanno di buono. La selezione comprende libri classici e più recenti, in grado di coinvolgere e di trasmettere il contenuto attraverso l’attivazione di più sensi, in un’ottica multimodale. Libri capaci di agganciare il maggior numero di lettori e di accogliere anche quelli più deboli, demotivati o sprovvisti di adeguati strumenti culturali, linguistici, cognitivi, relazionali. Libri, dunque, che sanno attraversare corpo e mente del lettore, stimolando differenti canali: la vista, l’udito, la percezione tattile e sensomotoria con immagini, suoni, ritmi, musicalità, parole, grafica, formato, materiali e altro ancora. Ogni lettore si orienta sui canali percettivi che preferisce, che sa controllare meglio o che può tenere più aperti. Quando il sistema nervoso centrale è così attivato, si generano serotonina e buon umore, premesse per vivere momenti di felicità.
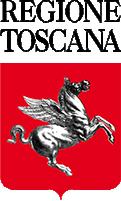
Al Salone Internazionale del libro di Torino, il Centro regionale servizi biblioteche per ragazze e ragazzi toscani, con sede nella Biblioteca Tiziano Terzani di Campi Bisenzio (FI), realizzerà in collaborazione con Regione Toscana e Fondazione Accademia dei Perseveranti una serie di iniziative e incontri legati al tema dell’accessibilità culturale. Abbiamo chiesto alle esperte che interverranno in questa occasione consigli e suggerimenti di lettura specifici.
Marcella Basso
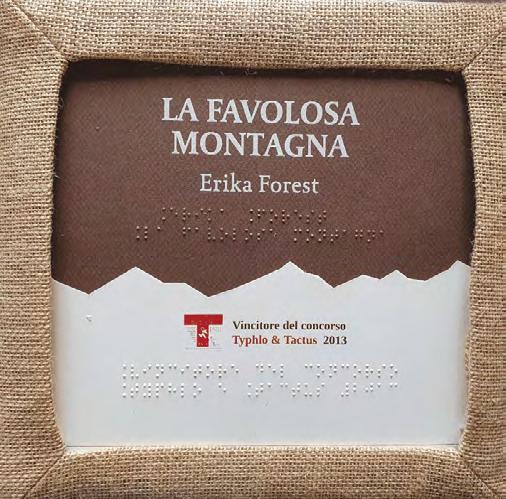
Il libro è quell’oggetto che viene definito come un insieme di fogli. Tuttavia non è solo questo. I libri sono ponti, finestre... ed in entrambe queste accezioni, danno l’idea di aprire ad altro, di condurre in luoghi diversi da quelli in cui ci si trova. Ed è forse questo uno dei loro grandi poteri: quello di farci muovere pur restando fermi. I libri tattili permettono a tutti di svolgere questo viaggio, indipendentemente dalle abilità che si hanno o non si hanno. Sono libri ricchi di stimoli, sensazioni, materiali... e tutta questa ricchezza è in grado di nutrire le nostre mani e la nostra immaginazione. Sono libri generalmente associati alla disabilità visiva ma di fatto, per la loro struttura e composizione, sono adatti a tutti; presentano un doppio testo in nero e braille e nel racconto per immagini sfruttano il canale tattile, di cui tutti siamo provvisti benché non sempre ne facciamo uso o per lo meno un uso consapevole. Purtroppo non così presenti nella scena libraria per i loro tempi e costi di produzione, sarebbe bello se anche loro potessero trovare spazio in un ripiano accessibile, testimoni della possibilità, per tutti, di immaginare attraverso parole ed immagini. Nel mio personale scaffale accessibile metterei senz’altro Nel bosco, di Laura Cattabianchi (Federazione Nazionale Istituto pro Ciechi, 2023). Questo libro è un viaggio, una meravigliosa passeggiata sonora nella natura. Nel libro, accanto al racconto, le indicazioni sui gesti da compiere per risvegliare i suoni del bosco, custoditi da materiali diversi. Un libro poetico, delicatissimo nel suo essere visivamente pulito e discreto ma in grado di raccogliere una potenza evocativa gigante. E poi La favolosa montagna di Erika Forest. Un libro silenziosissimo, senza parole ma depositario di immagini ricche, eloquenti, potenti per la loro capacità di parlare su piani diversi e offrire così livelli di lettura differenti. Anche questo libro potrebbe essere un viaggio, un viaggio alla scoperta di spazi fisici ma anche spazi interiori da esplorare con le mani, per contattare sensazioni, emozioni e aprire spazio al dialogo nel momento in cui la lettura viene condivisa. In ultimo, Io, tu, le mani, un libro che nel mio personale scaffale già c’è e che, a proposito di viaggi, è un libro che ho immaginato come una esplorazione
delle diverse possibilità che le relazioni offrono. La lettura è condivisa, per due persone nello stesso momento, un viaggio in due che permette di trovare e ri-trovare l’altro ma anche noi stessi e il nostro modo di stare assieme. Questi i miei preferiti, quelli che quando li richiudo dopo averli letti, le mie mani fanno un bel sospiro, arricchite da ciò che hanno sfiorato ed esplorato.
Elena Corniglia
In un viaggio tra i più significativi libri accessibili di recente pubblicazione, una tappa Nel bosco di Laura Cattabianchi (Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi) è irrinunciabile. Sorprendente e capace di aprire sentieri narrativi inesplorati, il libro accompagna il lettore in una passeggiata sonora immersiva, facendo leva sul potere evocativo dei suoni della carta. Una magia! Come spesso, però, accade nel settore dei libri tattili illustrati, le poche copie disponibili di Nel bosco sono andate presto esaurite e bisognerà aspettare la fine del 2025 per una ristampa. Della stessa autrice, in collaborazione con Patrizio Anastasi, è uscito però a inizio anno Dalla finestra (Edizioni Start), un altro libro tattile sorprendente, fresco vincitore del premio BRAW nella categoria New Horizons. Qui finestre dalle fatture e dalle collocazioni diverse giocano con forme grafiche essenziali e aprono fessure da cui sbirciare (e origliare) pezzi di mondo.
Per un libro che va e un libro che arriva, c’è anche un libro che torna. Questa primavera segna, infatti, il felice e atteso ritorno di un altro volume tattile di valore. Si tratta de Il girasole di Valentina Lungo ed Enrico Delmastro (Dieciocchi), frutto di un lavoro progettuale certosino che lo rende a tutti gli effetti un libro di design, in cui si combinano accessibilità ed estetica, poesia e scienza, gioco e narrazione. E in cui, non da ultimo, la scelta delle tecniche compositive muove dalla consapevolezza che l’accessibilità, per dirsi piena, dovrebbe riguardare non solo i contenuti ma anche il prezzo dei libri. L’inclusione, infatti, passa anche da lì.
Ma chi dice inclusione, dice diritto alla condivisione di immaginari. In questo senso, almeno due titoli recenti vanno assolutamente segnalati. Il primo è Uno e sette (La leggeria): una versione tattile del celebre racconto di Gianni Rodari, proposta su pagine di stoffa molto raffinate con ingegnose illustrazioni tutte fatte di fili e bottoni. Il secondo è Caccapupù di Stephanie Blake (Officina Babùk). Primo di una serie di volumi molto amati dai bambini, questo libro è caratterizzato da una storia spassosa e irriverente ma anche da un testo che si presta benissimo alla lettura ad alta voce e alla simbolizzazione.
Sempre tra i più recenti libri in simboli pensati per i più piccoli, I vestiti nuovi dell’imperatore (Uovonero) di Enza Crivelli e Nadia Corfini cattura l’attenzione per la freschezza delle illustrazioni che

si muovono snelle tra tradizione e modernità e per un testo che si sviluppa asciutto ed essenziale con il supporto visivo dei PCS. Ai lettori più grandi, spesso trascurati nell’ambito dell’editoria accessibile, guarda, invece, L’argine di Marina Girardi e Rocco Lombardi (Homeless book), che sperimenta in maniera interessante l’uso dei simboli all’interno di una graphic novel.
Su tutt’altro fronte ma parimenti capace di mettere in atto soluzioni peculiari, La zuppa dell’orco di Vincent Cuvellier e Andrea Antinori, nella sua ultima versione ad alta leggibilità e in LIS (Biancoenero, collana Fabulis), moltiplica le possibilità di fruizione del racconto, grazie all’integrazione tra volume cartaceo e contenuti digitali attivabili tramite QRcode. Dello stesso illustratore, infine, vale davvero la pena citare anche
La montagna (Fatatrac): un leporello senza parole non solo esteticamente incantevole e ipnotico, per il pullulare di colori e creature che dispiega, ma anche molto fruibile da bambini con età e abilità diverse.
Susi Danesin

Al Salone del libro di Torino sarò presente con un piccolo laboratorio sui Silent Books, che sono potenti anche nel campo dell’accessibilità: sono libri per tutti e per tutte!. Tra i vari libri che esploreremo proporrò questi titoli. Giocheremo a leggere Il vento e La merenda di Monique Felix (Camelozampa), tra i libri più piccini e forti visivamente. Quando li propongo ai bambini e alle bambine chiedo sempre “Cosa fa un topo chiuso dentro un libro?”: e qui già si apre il loro immaginario. I titoli dell’edizione precedente, di Emme Edizioni, erano C’era una volta un topo chiuso in un libro… e Seconda storia di un topo chiuso in un libro… che già svelavano la presenza del topolino. Con questo libro alterno un dialogo con il pubblico alla sonorità della parola “Rosicchia”, ripetendola con un ritmo, per creare un’atmosfera di curiosità e altri suoni. Pagina dopo pagina gioco con il pubblico scoprendo insieme a loro cosa questo topolino stia combinando tra e con le pagine del libro. Con Pois di Cristina Bazzoni (Carthusia) il primo personaggio che incontriamo è una signora che cuce con la macchina da cucire, felice per il suo vestito a pois. Il ritmo della lettura è scandito dal suono della macchina da cucire e dal linguaggio immaginario, gramelot, della signora. In assenza della padrona, avviene una cosa sorprendente, i pois dell’abito magicamente si staccano dalla stoffa e se ne vanno via in fila indiana, qui gioco con la voce creando un ritmo cadenzato di questo piccolo esercito di pois. Unico testimone il cane che li segue, prima con lo sguardo e poi giocando come un giocoliere. Alla scoperta della sparizione dei pois, la sarta si dispera ma grazie al suo fedele amico scoprirà che i pois si sono trasformati in palline di Natale addobbando così
il suo abete. In C’è posto per tutti di Massimo Caccia (Topipittori) ogni volta che si gira una pagina si scoprono animali diversi che vanno verso la stessa direzione. Insetti, dromedari, uccelli, un panda, un formichiere, un camaleonte, un elefante ecc. Per la lettura ad alta voce ho scelto di giocare con i versi degli animali senza farli tutti ma scegliendone alcuni. Il finale, a sorpresa, fa capire al lettore che tutti gli animali stanno andando sull’arca, il colpo di scena è vedere l’interno dell’arca con tutti gli animali che, anche se un po’ stretti, si sono ricavati il loro posto.C’è posto per tutti!
Francesca Meoli e Sabrina Egiziano
Se pensiamo alle bambine e ai bambini e alle parole che dovrebbero abbracciarli e accompagnarli negli anni della crescita ci vengono in mente i libri che nella storia della letteratura per l’infanzia hanno tracciato una linea netta e marcata: libri che da quando hanno visto la luce sono rimasti nei cuori dei loro lettori e ascoltatori, libri che passandoci fra le mani ci hanno chiesto di essere letti e riletti. È così anche per i libri scritti con la comunicazione aumentativa, libri che hanno un triplice codice di accesso: le immagini, le parole e i simboli. Nella CAA sono proprio i simboli ad avere il compito di sostenere il significato delle parole e di amplificarlo attraverso un disegno che raffigura il loro significato. I simboli di comunicazione aumentativa sono pensati per tutti i bambini, per quelli che ancora non hanno accesso alla letto-scrittura, per quelli che ancora non conoscono la lingua in cui è stata scritta la storia e per chi ha difficoltà cognitive. Anche la scelta di questi libri deve avvenire con i criteri appena raccontati, per dirlo con poche parole, i libri devono contenere storie eterne, senza fine e che non temono il passare degli anni. Nello scegliere i libri in simboli, per noi imperdibili, abbiamo tenuto conto di queste caratteristiche che si sono sommate alla bellezza e alla capacità di comunicazione delle immagini che accompagnano la potenza della storia. Potenza nel raggiungere il cuore degli ascoltatori perché trattano tematiche condivisibili da tutti e che riguardano la crescita di tutti i bambini e le bambine. Questi i nostri quattro temi: amicizia, fiducia in sé stessi, gentilezza e fantasia. L’amicizia, affidata a Piccolo blu e piccolo giallo , edito da Babuk e scritto dal grandissimo Leo Lionni. Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. Ma quando si abbracciano diventano verdi e i loro genitori non li riconoscono più. Come far loro capire che sono sempre gli stessi? Ancora una volta basterà un abbraccio per sciogliere i pregiudizi e comprendere quanto importante sia mescolarsi, imparare, cambiare l’uno a contatto con l’altro per creare una nuova entità più forte e più complessa. La fiducia nelle proprie capacità, raccontata da Silvia Vecchini in Brava chiocciolina!, edita da Edizioni Corsare. Chioccioli-

SUL PROGRAMMA
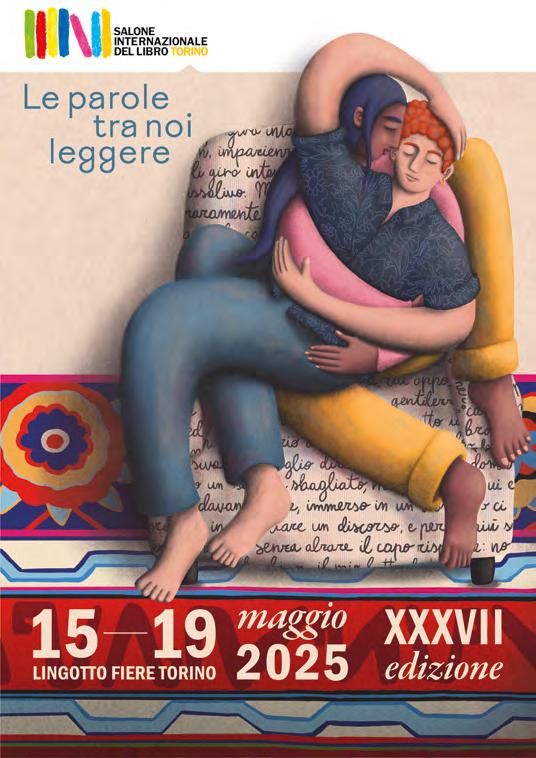
Le parole tra noi leggere, tema della XXXVII edizione del Salone del libro di Torino, invita a una riflessione lieve e al tempo stesso profonda sulla centralità delle parole e sul ruolo della lettura nella vita di tutti e di tutte. Particolarmente ricco è il programma di Educare alla lettura, progetto del Salone del libro in collaborazione con il CEPELL che anche quest’anno mette a disposizione di docenti, educatori e genitori una pluralità di voci e di sguardi che si confrontano su temi chiave dell’educazione. Giovedì 15 maggio si terranno gli incontri con le classi che hanno partecipato al corso di formazione Orientarsi, perdersi ritrovarsi, che ha coinvolto quasi mille docenti. Domenica 18 i docenti interessati alla didattica orientativa potranno incontrare i curatori del corso e trovare un numero speciale de La Ricerca Loescher dedicato ai kit didattici su lettura e cittadinanza attiva nati dall’esperienza già conclusa di Leggere è partecipare. Grande rilevanza avranno in questa edizione gli spazi dedicati all’illustrazione: oltre alle masterclass e ai workshop del progetto The Illustrators Survival Corner, a cura di Mimaster Illustrazione e Bologna Children’s Book Fair, sono previsti eventi come il convegno di Nati per leggere e laboratori per ogni fascia d’età tenuti da illustratori esperti come Sergio Olivotti e Anna Castagnoli che sabato 17 terrà un laboratorio sull’uso delle immagini negli albi illustrati. Sempre nel fine settimana numerosi saranno gli incontri dedicati alla lettura a partire dai più piccoli: tra i tanti previsti, l’incontro di sabato sulla collana Scatoline con la curatrice Vera Gheno e il panel di domenica sulle prime letture che vedrà come ospiti Nicoletta Costa, Ludovica Cima e Giulia Rizzo. Spazio e attenzione saranno dedicati anche al mondo della lettura accessibile con un incontro sugli albi in CAA curato da Area Onlus, LiBeR e Officina Babuk e un laboratorio di scrittura tenuto da Maria Cannata, ideatrice del progetto Babalibri in musica, collana di storie musicate e lette da attori professionisti per offrire un’esperienza condivisa da tutti e da tutte. Inclusione e accessibilità sono anche le parole chiave di una serie di appuntamenti pensati per offrire gli strumenti di un linguaggio libero da concetti e termini abilisti e razzisti. A completare il quadro degli eventi legati all’educazione affettiva non mancheranno laboratori di scrittura incentrati sulla gestione delle emozioni difficili come la paura o la tristezza per un amore finito (a cura dell’Ordine degli psicologi). Tra le novità del programma sul versante scientifico l’introduzione dell’IA e gli spunti di Gianni Ferrarese per portarla in classe in modo efficace. Anche quest’anno quindi lo sguardo del Salone è puntato al futuro a partire dalle nuove generazioni: l’esperienza dei gruppi di lettura di adolescenti infatti non sarà solo al centro di un confronto tra formatori come Alice Bigli, Matteo Biagi e Giuliana Facchini ma riguarderà l’intera manifestazione che vedrà impegnati numerosi gruppi di lettura coordinati dal Salone e pronti a dialogare con autori e autrici con leggerezza e profondità.
Giusi Marchetta
na sta bene nella sua casetta, ma la mamma la invita a uscire per conoscere gli altri abitanti del prato. Incontra il Grillo, la Libellula, la Formica, il Ragno… ciascuno di loro sa fare qualcosa! E lei cosa sa fare?
La gentilezza, con La scatola di Isabella Paglia edita da La Margherita. Nel bosco succede qualcosa di strano. Qualcuno o qualcosa ha lasciato una scatola con due fessure. Da dentro qualcuno o qualcosa guarda attento gli animali. Chi sarà mai? Da dove è venuta? Cosa ci fa nella foresta? Nessuno si sa rispondere. Una cosa è certa: quel qualcuno o qualcosa non vuole uscire da li dentro.
La fantasia, attraverso La sedia blu , scritto da Claude Boujon ed edito da Babuk.
Scoprilo in LiBeRWEB
Vaialla rassegna
Leggi la rassegna sulle collane di libri in alta leggibilità a cura di Federica Mantellassi: https://shorturl.at/1PwVW
Una sedia in mezzo al deserto che per due amici diventi di tutto, un cammello rompiscatole e razionale che pensa che possa servire solo per sedersi. I libri che abbiamo scelto sono stati scritti con simboli di CAA (Comunicazione Aumentativa) con il sistema simbolico WLS (Widgit Literacy Symbols) e due di questi titoli sono inbook, un modello di traduzione in simboli sviluppato dal Centro Studi Inbook e dal Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano e Verdello.
Questo modello cerca di rispettare la narrazione attraverso una traduzione in simboli fedele e precisa, mantenendo il dialogo fra testo e immagine e restituendo gli aspetti specifici della lingua italiana, in particolare la morfologia. Nell’inbook il simbolo è associato all’etichetta alfabetica all’interno della riquadratura, in modo da facilitare la lettura condivisa con modeling; è monocromatico per favorire i processi di automatizzazione della lettura. Particolare cura è posta nell’organizzazione della pagina per quanto riguarda la dimensione e la distanza fra simboli, fra righe e fra paragrafi e nella punteggiatura. Due libri sono pubblicati da Officina Babùk, una nuova casa editrice di libri in simboli, nata da un progetto delle case editrici Uovonero e Babalibri. Questi sono due grandissimi classici imperdibili.
Etica, politica ed estetica come patrimonio comune, sul quale confrontarsi e crescere: notizie dal grande paese sudamericano di Grazia Gotti
L’edizione 2025 della Bologna Children’s Book Fair è certamente segnata da una luce brasiliana molto particolare. L’identità visiva è firmata dal brasiliano Bruno de Almeida, così come la mostra della Fundacion SM, che ogni anno sceglie un giovane fra i selezionati della mostra Illustratori e gli commissiona una libro illustrato che diventerà poi lo scenario per una mostra. È stato scelto Henrique Coser Moreira, autore degli splendidi fumetti senza parole pubblicati dall’e-
professionali, bibliotecari.
Le fiere del libro sud americane sono bellissime, a partire da quella Buenos Aires che ho visitato più volte. A San Paolo non era stata una fiera a invitarmi, ma un’associazione privata che ha un bellissimo nome, Emilia. Perché questo nome?
Semplice! Così come Giannino Stoppani, il nome che scegliemmo per la libreria, era il protagonista di una storia molto letta e molto amata: per i brasiliani Emilia è una bambola, mol-

ditore portoghese Planeta Tangerina. A questa luce brasiliana si aggiungono i tanti libri ricevuti per il BolognaRagazzi Award, tanti da segnare l’ingresso del Brasile fra i primi dieci paesi per numero di titoli inviati.
Dell’editoria brasiliana per ragazzi mi occupo da tempo, precisamente dal 2014, anno del mio primo viaggio a San Paolo. Ero stata invitata, come molti rappresentanti europei, editori, autori, illustratori, a prender parte a momenti di formazione per insegnanti, figure
dren’s Book Fair. A San Paolo, quella prima volta, era con me Maria Teresa Andruetto, argentina, e da lei ho davvero imparato molto, non solo sulla letteratura, ma sulla vita, sugli orrori delle dittature.

to popolare, frutto dell’invenzione dello scrittore Josè Bento Renato Monteiro Lobato. L’ho scoperto studiando e leggendo, e ringrazio tutte le amiche e gli amici sudamericani che mi hanno fatto conoscere la loro letteratura. Emilia è una bambola di pezza che insegna a volare sulle ali dell’immaginazione e l’associazione che prende il suo nome ora è Revista Emilia, un punto di riferimento per tutto il Sud America, per il preziosissimo lavoro di Dolores Prades, oggi consulente della Bologna Chil-
L’editoria per ragazzi italiana non ha mai dimostrato un grande interesse per la letteratura sudamericana, nonostante autrici brasiliane vincitrici di premi internazionali come l’Astrid Lindgren Memorial Award, assegnato nel 2004 a Lygia Bojunga Nunes, pubblicata da Donatella Ziliotto per Salani, e l’Hans Christian Andersen nel 2000 a Ana Maria Machado, pubblicata in Italia da Giunti. La grandissima Clarice Lispector, a mio avviso una delle scrittrici più grandi del Novecento, era entrata, grazie al lavoro di Francesca Lazzarato nel variegato e rimpianto mondo di Mondadori Junior. Scarsa attenzione anche per il mondo delle immagini, nel quale spiccano figure come Fernando Vilela, pluripremiato in contesti internazionali, artista poliedrico che opera con diverse tecniche e linguaggi: xilografia, pittura, fotografia. I suoi lavori sono stati accolti dai più importanti musei e gallerie del mondo. Dal MoMa alle pagine dei libri per ragazzi: un salto che ci fa capire come in paesi che gli eurocentrici hanno sempre considerato molto poco, l’arte e la cultura sono beni di tutti, senza distinzioni di età. Un’altra figura di spicco è Daniel Kondo, grafico e illustratore, inventore di progetti editoriali per le più importanti case editrici brasiliane. Tanti sono i suoi libri usciti nel 2024, tutti sugli scaffali dell’Accademia Drosselmeier, a celebrare il suo percorso artistico. Oggi, cinquantenne, vanta riconoscimenti internazionali a partire dal BolognaRagazzi Award nella categoria New Horizon. Kondo discende da immigrati giapponesi. Il Brasile, infatti, ha accolto quasi due milioni di migranti giapponesi dall’inizio del Novecento. Lo scoprii a San Paolo, in un ristorante giapponese con arredi anni ’60. Men-
tre in Europa nasceva la moda del sushi, là era molto familiare da tempo. Passeggiando sull’ Avenida Paulista pensavo al grande architetto celebrato sulle pareti di un grattacielo. Sapevo che Oscar Niemeyer era stato un architetto importantissimo e che da noi aveva lavorato per la vecchia sede Monda-

dori. Era stato l’artefice della famosa scala, ma aveva poi costruito la sede nuova a Segrate, ma non sapevo che fosse morto a 105 anni. Avevo fatto una gaffe a cena dandolo per morto. Ma i brasiliani avevano sorriso. Un incontro brasiliano per me molto importante è stato quello con le editrici di Pallas, una casa brasiliana condotta da madre e figlia. Ho familiarizzato in fretta, una volta capito che il loro intento era narrare i meticci, i neri, parlare di schiavitù, di culture indigene o africane. Preparammo insieme una mostra nella biblioteca Amilcar Cabral, una biblioteca civica bolognese, centro studi nel qualche si ricerca, si discute, si informa il lettore sui temi sudamericani. Cabral era nato in Guinea Bissau ed era venuto in Europa, a Lisbona a studiare agronomia. Tornato in Guinea, aveva lavorato per costruire un futuro di libertà e di progresso. Venne assassinato nel 1973, sei mesi prima dell’indipendenza della Guinea. Brutta, bruttissima storia. Per noi bolognesi è stato un simbolo di libertà e democrazia. Le editrici di Pallas hanno iniziato questo lavoro sulle radici in completa autono-
mia e solitudine, allacciando nel tempo rapporti con l’Africa. A Maputo, per fare un esempio, lavorano con artisti che tengono workshop con giovani e ragazzi. Fanno circolare i libri e pubblicano autori africani. Queste storie, purtroppo, non occupano le pagine dei giornali, non costituiscono soggetti per film o documentari da presentare ai festival, ma vivono
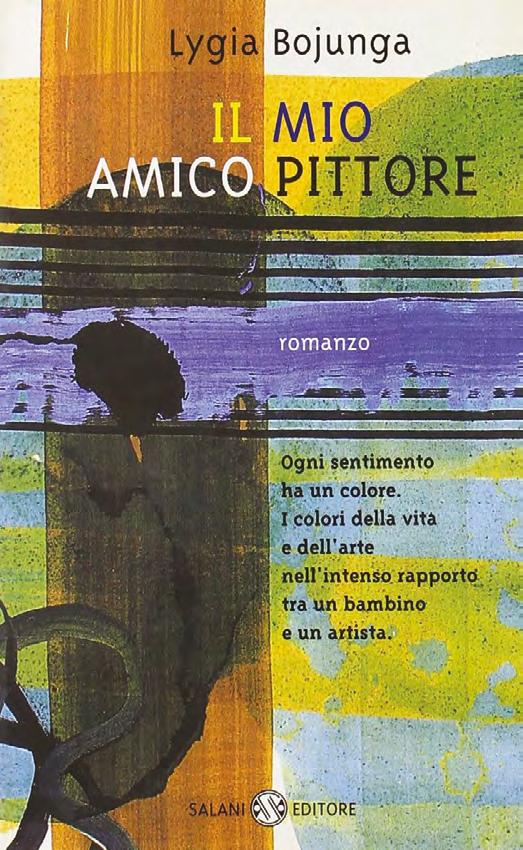
esiste una biblioteca storica che possiede un fondo di libri per ragazzi sudamericani. A leggere le carte scopriamo che l’ente che si occupava della Biblioteca del fanciullo partecipò alle prime edizioni della fiera di Bologna con una mostra di 1300 libri stranieri. Oggi la biblioteca ha nome Biblioteca statale Baldini ed è diretta da Amalia


grazie all’impegno delle persone. Ma torniamo alla contemporaneità e andiamo a scoprire la straordinaria crescita quantitativa e qualitativa dell’industria editoriale per ragazzi in Brasile. I titoli arrivati, come dicevo, sono tanti e fra qualche mese si potranno sfogliare in una biblioteca pubblica italiana. Le coincidenze sono sempre importanti e io le saluto con entusiasmo. A Roma
Amendola. Con lei sto selezionando i nuovi libri brasiliani per ragazzi, in continuità con quanto aveva fatto l’Ambasciatore brasiliano che aveva voluto una biblioteca per ragazzi. Ricostruiremo il fondo storico, aggiungeremo le nuove acquisizioni, entreremo nel merito dei libri con schede critiche. Riallacciarsi a chi ci ha precedute, ma guardare avanti, immaginando un futuro di interesse per libri non solo italiani, libri che ci aprono al mondo, alla sua vastità, alla sua complessità, scoprendo poi che molte sono le cose che ci accomunano come esseri umani, a qualsiasi latitudine, e di qualsiasi provenienza siamo. Scopriremo così che una casa brasiliana, indipendente, sperimentale e nuova sceglie una favola di Antonio Gramsci e la affida per le figure a una giovane illustratrice di talento. Il libro viene notato e selezionato per una mostra in fiera a Bologna. Tutti lo vedono e così il libro compie il suo giro nel mondo, un giro di condivisione di valori etici, politici ed estetici. Questo è quello che ho appreso nel mio girovagare. Certo i libri sono prodotti per un mercato, ma dietro le quinte ci sono ancora umani che pensano e sognano.
Emozioni, sentimenti, mondo naturale, universo mitologico e varietà di esistenze di Selene Ballerini
Un ragazzino è afflitto perché è andato a cercare Saltafossi e trovando non lui ma la sua favolosa bicicletta da cross ha ceduto alla bramosia di sperimentarla, finendo però per romperla malamente! Cosa dirà ora il suo amico?
Nell’emozionante albo magistralmente scritto e illustrato da Alessandro Sanna Saltafossi (Gallucci, 2024, dai 5 anni), dominato da un giallo e un rosso densi che trasmettono con immediatezza il calore della giornata assolata vissuta dal protagonista - io

Proseguendo in ordine di target d’età degli Spuntini che stavolta vi propongo, tratti dal fascicolo di schede-novità allegato a questo numero di LiBeR e mai recensiti sulla rivista, incontriamo adesso un fumetto imperdibile il cui titolo prende spunto da un ben noto proverbio: L’abito non fa il lupo di Sid Sharp (EDT-Giralangolo, 2024, dai 6 anni), illustrato dall’autore con vignette a colori accattivanti ed espressive. Greg, un montone solitario, indossando un travestimento da lupo, da lui stesso cucito, sta

narrante - nella piena libertà delle vacanze estive senza precisi programmi, campagna e collina che fanno da scenario sono punteggiate da luoghi con denominazioni tradizionali attribuite da chi li ha frequentati abitualmente. E nel lento scorrere del tempo naturale la disperazione inconsolabile che può cogliere talora nella primissima gioventù si stempera a contatto con la saggezza esperienziale del nonno, che invece di rimproverare il nipote lo conforta e gli dimostra che quasi tutto - e in questo caso è possibile - si può riparare.
tabilmente le radici di ciascuna e ciascuno di noi, come del resto quelle di qualsiasi entità vivente.
In Splendide creature di Guia Risari (Settenove, 2024, con illustrazioni a colori cariche e deliziosamente naïf di Cinzia Ghigliano, dai 7 anni) l’ambientazione boschiva è abitata da esseri animaleschi e metamorfici che formano coppie di ogni tipo: tutte vanno bene, perché ciò che conta è solo l’amore! In particolare la creatura bambina che narra, di cui non è specificato il sesso, è nata dal connubio tra una rondine-uomo e una lupa-donna, dai quali ha ereditato i linguaggi umano e animale; per adesso si muove da bipede, ma assai presto apprenderà come correre a quattro zampe e volare, perché ciascuna e ciascuno di noi può possedere tante identità, nonché svariate modalità per esprimere ciò che ha da raccontare di sé e della propria vita, proprio come alla fine viene invitato a fare chi leggendo il libro ha avuto la fortuna di avventurarsi in questa magica selva.
La bambina e l’orsa di Cristiana Pezzetta (Topipittori, 2024,

raccogliendo le more nella forestafinalmente in sicurezza - quand’ecco giungere tre suoi apparentemente simili che cercano di coinvolgerlo in una nottata lupesca per ululare insieme alla luna piena. L’intreccio finirà con un colpo di scena imprevedibile che delizierà lettrici e lettori dopo averli tenuti con il fiato sospeso, decretando inoltre l’inizio di un’amicizia di gruppo e l’avvento della serenità. La foresta è anche l’habitat di due stupendi albi illustrati in grado di titillare l’insoffocabile richiamo verso quella Natura Mater in cui affondano inelut-

con affascinanti tavole pulviscolari di Sylvie Bello, dagli 8 anni) è la storia del fervido e fecondo incontro nel bosco - amato da entrambe e consacrato ad Artemide - tra una piccola umana e una gigantesca plantigrada, fatto di reciproca fiducia e amabile desiderio di condivisione. La Dea, alla quale l’orsa è stata donata, osserva però con apprensione quest’insolita amicizia tra due viventi così diverse, certo prevedendone il tragico epilogo, poi rigenerato tuttavia da un susseguirsi di eventi che non voglio svelare. Solo alla fine, in una nota dell’autrice, sco-
priamo che questa leggenda risale al V secolo a.C. e proviene da Braurón, un villaggio dell’Attica, felicemente stupendoci, come Pezzetta rileva, per aver reso protagonista una ragazzina e averci fatto scoprire che pure le femmine - così avveniva nel santuario locale di Artemide - ricevevano un’istruzione. Per coloro che hanno da dieci anni in su ho trovato di notevole interesse Digestario di Aina Bestard (Camelozampa, 2024), un volume elegante che attraverso raffinate illustrazioni a colori ed esplicazioni verbali chiare e puntuali descrive apparato digerente, funzione escretoria e abitudini alimentari di numerosi animali sia vertebrati che inver -
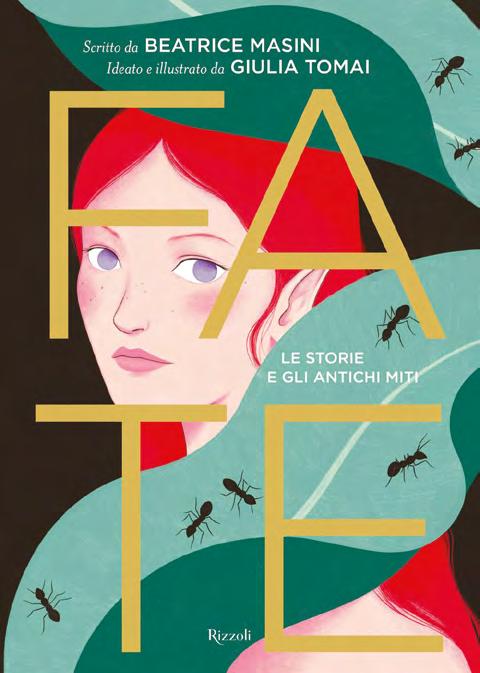
Rassegna critica di buoni e ottimi libri non recensiti su LiBeR e presenti nell’inserto Schede Novità
analoga nella Sibilla Appenninica dei Monti Sibillini)... Ciascun personaggio è contrassegnato da un numero che indica non solo la successione in cui è descritto nel testo, ma anche la sua zona di appartenenza nel disegno geografico del mondo mostrato all’inizio, che fornisce una mappa per questo viaggio incantatorio meritevole di venir letto e riletto e ancora

tebrati, mostrando come nella varietà e complessità del mondo naturale le digestioni - stupefacenti processi alchemici che ci consentono di sopravvivere nutrendoci e depurandoci - si differenzino fortemente l’una dall’altra pur avendo spesso alcuni o molti punti in comune.
Dalle profondità ctonie del corpo transitiamo ora alle sottili manifestazioni del Piccolo Popolo suggestivamente narrate da Beatrice Masini in Fate (Rizzoli, 2024, con le illustrazioni limpide ed efficacissime di Giulia Tomai, che è pure l’ideatrice, dagli 11 anni): un ampio volume in cui si susseguono 34 figure mitiche e leggendarie che han fatto parte, e la fan tuttora, dell’immaginario dell’umanità, dall’irlandese Leanan Sidhe (“bella e selvaggia”) agli Yumboe del Senegal (piccole “persone buone”), dal filippino Nuno Sa Punso (“il vecchio nel termitaio”) alla celeberrima fata-serpentessa francese Mélusine (che peraltro - ma non compare nel libro ed è un peccato - ha una sua
ria pizzica così le variegate corde dello scintillio dei sentimenti, rese ancor più autentiche dalle marcate differenze di personalità che caratterizzano le nostre irresistibili protagoniste. Chiude infine questa mia carrellata “cronologica” un romanzo insolito e a tratti sconvolgente rivolto agli e alle young adults : In nome di Chris di Claudine Desmarteau (Terre di Mezzo, 2025, dai 14 anni), stagionalmente scandito - dal concludersi di un’estate all’inizio di un’altra - e narrato con scrittura potentemente drammatica e introspettiva.
Pesantemente bullizzato, colmo di odio verso

riletto per assimilarne le molteplici risonanze e reciproche corrispondenze. Nel graphic novel È tutto una scintilla di Lily Williams e Karen Schneemann (Il Castoro, 2024, con le espressive e coinvolgenti vignette di Lily Williams, dai 12 anni) continuano le vicende delle inseparabili amiche Brit, Abby, Sasha e Chris iniziate con È tutto un ciclo (Il Castoro, 2020), del quale mi sono occupata negli Spuntini di LiBeR 130. E se in quel caso il tema forte era il menarca stavolta - pur facendovi riferimento e includendo problematiche correlate, come la dolorosa endometriosi di cui soffre Brit - tutto gira intorno all’amore: Sasha ha un fidanzato da cui è così presa che rischia di trascurare del tutto lo studio, Brit ondeggia i suoi brividi amorosi tra due ragazzi (da uno dei quali resterà molto delusa) e Chris trova soltanto alla fine il coraggio di rivelare ad Abby che è innamorata di lei, ricevendone una risposta inaspettata.
Con realismo tenero e ironico la sto-

un padre di cui la madre non gli parla mai e che non crede sia morto e reso irrequieto dal rapporto affettivamente controverso con lei - da cui oltretutto è stato indotto a svolgere sedute psicoterapeutiche - e dal trasloco della sua unica amica, il quattordicenne e sempre insonne Adrien incontra nel bosco un misterioso e ambiguo adulto e a lui, del quale ignora la devastante e fanatizzata ossessione distopica, si affida in toto.
L’uomo, che ha scelto per sé il nome Chris, gli dice che deve imparare a sopravvivere e difendersi (uccidere o morire), cambiare pelle, uscire dalla bambagia protettiva famigliare, rompere il cordone ombelicale con la genitrice, assumere un nome nuovo… e lo invita a trascorrere con lui un weekend di apprendimento nella macchia. Inizia così per il ragazzo una vicissitudine pericolosa e angosciante ma che gli consentirà di ritrovarsi: perché a volte per riuscirci occorre prima perdersi.
Novità, eventi e sorprese dalla 62ª edizione di Bologna Children’s Book Fair, che per quattro giorni rende la città capitale mondiale dell’illustrazione e dell’editoria per infanzia e adolescenza
Il 2025 accoglie la 62ª edizione di Bologna Children’s Book Fair (BCBF), in programma nei padiglioni di BolognaFiere dal 31 marzo al 3 aprile 2025 insieme a BolognaBookPlus (BBPlus), dedicata all’editoria generalista e realizzata in collaborazione con Associazione Italiana Editori (AIE), e a Bologna Licensing Trade Fair/Kids (BLTF/Kids), per i marchi del settore ragazzi. 1500 espositori da 90 paesi e regioni del mondo sono attesi nelle tre fiere (tra i nuovi ingressi: Albania, Azerbaigian, Ecuador, Georgia, Guatemala, Islanda, Madagascar, Malta, Macedonia del Nord, Perù, Arabia Saudita, Sri Lanka, Thailandia), che costituiscono un sistema sempre più interconnesso, con un’offerta che attraversa tutti i settori dell’editoria e oltre. Tra le novità di questo 2025, infatti, spiccano le nuove aree business preposte a intercettare segmenti di mercato in evoluzione, come quello audiovisivo e del gaming, che aprono possibilità più ampie per espositori e visitatori. Sulla scorta del successo riscontrato dagli appuntamenti di formazione professionale messi in campo al The Illustrators Survival Corner per gli illustratori, inoltre, all’interno di BolognaBookPlus troverà spazio quest’anno un calendario di incontri dedicati agli scrittori: il Pronto Soccorso Narrativo, curato da Bottega Finzioni, sarà un punto di consulenza narrativa per gli autori alla ricerca di un aiuto per sviluppare la propria storia, e di consigli su come indirizzarla alla migliore pubblicazione.
Paese Ospite d’Onore del 2025 è l’Esto-
nia, il piccolo stato affacciato sul Mar Baltico che vanta però un mercato editoriale vivace e dinamico, capace di offrire una qualità elevata di contenuti che spaziano tra vari generi, e che nell’op portunità offerta da Bologna Children’s Book Fair vede un’im portante occasione di vi sibilità e apertura ai mercati internazionali.
Anche quest’anno, Bologna si riconferma per quattro giorni capitale mondiale dell’illu strazione e dell’editoria per bambini e ragazzi: nell’edi zione 2025, la fiera torna ad accogliere grandi nomi come Sydney Smith, vincitore dell’H.C. Andersen Award 2024, Beatrice Alemagna, vincitrice nel 2024 della sua seconda Golden Medal della Society of Illustrators di New York, Altan, nell’occasione del 50° anniversario della sua Pimpa, Jeff Kinney, in un inedito incontro con Davide Calì,
Paul Cox, protagonista di una mostra in città, e ancora Rotraut Susan Berner, Marie-Aude Murail, Sara Lundberg, Daniel Pennac, Mariangela Gualtieri, Nikolaus Heidelbach, Joelle Jolivet, Igort, Susie Morgenstern, Serge Bloch, Ole Könnecke, Sergio Ruzzier, Maicol e Mirco e i tributi a Katsumi Komagata e a Leo Lionni, alla presenza della nipote Annie Lionni.

Ma il 2025 è anche un anno di grandi anniversari: BCBF festeggerà con Altan i 50 anni della Pimpa, compagna di infanzia di generazioni di bambini e bambine; al centro della celebrazioni sarà anche Pippi Calzelunghe, personaggio immortale che compie 80 anni. Ma gli anniversari non mancano nemmeno tra i progetti della fiera: toccano quota sessant’anni i BolognaRagazzi Awards, i premi istituiti per mettere in luce i libri illustrati più belli e innovativi a livello internazionale, mentre sono dieci le candeline spente dal premio Strega Ragazze e Ragazzi, estensione del più prestigioso riconoscimento letterario italiano dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi, in tutte le sue forme. Infine, un anno di anniversari anche per gli espositori: i 70 anni di Feltrinelli, i 40 del Libro Game, che torna con nuove collane, i 35 della collana “Leggere le figure” Mondadori, i 25 di Babalibri, di Lapis e del personaggio Geronimo Stilton, tra i massimi successi editoriali italiani di sempre. Va festeggiata nel contempo una nascita: le storiche edizioni Sellerio si aprono al libro per ragazzi con due titoli nuovi di zecca all’interno della collana di debutto, “La
Tra i temi al centro del dibattito, torna

sul palcoscenico della fiera la Sostenibilità, sulla scia della collaborazione con le Nazioni Unite avviata nel 2024 e ora rinnovata, e dell’impegno investito da BCBF nel corso degli ultimi anni nella promozione dei 17 goal di sviluppo sostenibile. Tra le tematiche più urgenti nell’editoria di tutto il mondo, la sostenibilità sarà dunque protagonista di appuntamenti e iniziative tanto dal punto di vista dei contenuti quanto da quello dell’industria. Ma conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile sono anche i temi della rappresentazione di genere e del ruolo della letteratura nell’educazione degli uomini di domani, approfonditi in tavole rotonde con ospiti internazionali che offriranno punti di vista a 360 gradi. Ancora, uno spazio è sempre dedicato alle voci marginalizzate: dopo l’esperimento triennale dello Spotlight on Africa, che ha portato a BCBF 100 editori africani, l’impegno della fiera si è ora rivolto alla formazione degli illustratori di domani, dal punto di vista artistico quanto delle competenze manageriali. The “Make-a-Picturebook” Projec è un’iniziativa di Bologna Children’s Book Fair in collaborazione con la Book Buzz Foundation, curata da Mimaster Illustrazione: un corso online cui hanno preso parte 35 artisti africani selezionati sulla base del loro portfolio. I due

progetti risultati migliori al termine del corso sono presentati in una mostra a BCBF. Infine, all’Intelligenza Artificiale, tra i temi caldi nel settore, sarà dedicato un focus organizzato da BBPlus: si discuterà della tutela del copyright, del lavoro creativo e dello sviluppo di una normativa ad hoc, indagando al contempo le opportunità che questo strumento offre all’industria per migliorare o semplificare i processi, come distribuzione e targetizzazione. Tra le mostre, tornano i tradizionali e attesissimi appuntamenti con: la Mostra Illustratori; la mostra del Paese Ospite d’Onore, l’Estonia, dal titolo Hello!/Tere!, a cui si aggiunge un’esposizione negli spazi di BBPlus dedicata ai migliori libri illustrati estoni degli ultimi quattro 25 Best Designed Estonian Books; la personale dell’autore della cover dell’Illustrators Annual, Sydney Smith, vincitore 2024 dell’H.C. Andersen Award; la personale del vincitore 2024 del Premio Internazionale di Illustrazione Bologna Children’s Book Fair – Fundación SM, il brasiliano Henrique Moreira; la mostra che ricostruisce la nascita della visual identity 2025 di BCBF, realizzata dal brasiliano Bruno de Almeida; Chinese Excellence in Children’s Illustration, che per la seconda edizione porta a BCBF il meglio dell’illu-
strazione cinese contemporanea; la selezione di opere dalla mostra The Original Art, della Society of Illustrators di New York; la mostra curata da Book Arsenal Festival Kiev, quest’anno intitolata Ukrainian Illustration: Yesterday and Today, che mette in scena l’evoluzione dell’illustrazione ucraina; la mostra di illustrazione africana dell’iniziativa The “Make-A-Picturebook” Project; The BRAW Amazing Bookshelf, selezione dei 150 migliori libri candidati ai BolognaRagazzi Awards, cui quest’anno fa da complemento The BRAW Amazing Bookshelf - Sustainability: 17 Goals for a Better Future, che presenta i 150 migliori candidati alla categoria speciale 2025, realizzata in collaborazione con le Nazioni Unite; la mostra dedicata ai finalisti del Silent Book ContestGianni De Conno Award; nell’area di BBPlus è ospitata Jackets Off!, mostra che analizza quest’anno le diverse interpretazioni delle copertine de Il Grande Gatsby; infine, un’anteprima della mostra organizzata dalla prestigiosa Folio Society; una mostra sulla figura di Jella Lepman, fondatrice di IBBY, dal titolo Jella Lepman. Fateci cominciare dai bambini. I libri come ponti e, ancora, una mostra celebrativa dei 60 anni della Biennale di Illustrazioni di Bratislava, i cui vincitori hanno da sempre creato, in alternanza con i vincitori dell’H.C. Andersen Award, le copertine degli Annual Illustratori di BCBF.

Rubabandiera
Roberto Farnè
Il libro di Dario Voltolini racconta la vicenda di un insegnante di educazione fisica che incoraggia allieve e allievi a scoprire la disciplina sportiva più adatta a loro.
Qualche anno fa, parlando con gli studenti e studentesse del mio corso di “Educazione e avviamento allo sport” a Scienze motorie (molti facevano attività come educatori e allenatori sportivi), uno di loro disse che allenava una squadra di calcio di bambini di nove-dieci anni; un bambino in particolare non mostrava alcuna attitudine al calcio, non era il suo sport e anche i compagni se ne accorgevano. Aveva però una caratteristica: sapeva correre e correva forte. Dunque, raccontò lo studente, parlai con suo padre che lo accompagnava agli allenamenti e gli dissi che a mio avviso non era il calcio lo sport in cui suo figlio poteva divertirsi e trovare soddisfazione. “Ho notato che gli piace correre e che è veloce, perché non lo iscrive in una società di atletica dove può esprimere meglio questo suo talento?”. La risposta del padre fu: “Mi scusi, ma lei non vuole che mio figlio giochi a calcio…?!”. La cosa non ebbe seguito. Mi è venuto in mente questo episodio leggendo il libro di Dario Voltolini: Dagli undici metri (Baldin e Castoldi, 2024, p.95) dove si racconta di un insegnante di educazione fisica che, osservando i suoi allievi nelle attività sportive che organizza a scuola, cerca di scoprire i loro talenti, ne parla per incoraggiarli e indirizzarli verso una disciplina o un’altra. Lui per primo ha seguito il suo talento iscrivendosi a Scienze motorie e laureandosi a pieni voti, anziché a Psicologia “come tutti gli consigliavano con ragionamenti che si erano infine persi nel vento”. Prima che un allenatore sul piano tecnico, lui è un educatore, osserva con occhio scoutistico, cerca di vedere nei ragazzi ciò che loro stessi ancora non vedono, in un’età che non è più l’infanzia e non è ancora l’adolescenza: una “miscela di inermi dall’igiene ancora incerta” (p.20).

Si chiama Rosario ma per tutti è “il Mister”, parla con gli allievi, perché vuole sapere che cosa loro pensano e sentono quando giocano a basket o a volley, corrono o nuotano in piscina, avendoli osservati durante le giornate sportive che lui organizza nella scuola, anche per “darle immagine”. C’è
un ragazzino che mostra un formidabile talento nel basket e “in un crescendo di lodi e di analisi e di visioni future” gli dice che ha davanti una carriera promettente in questo sport; lui ringrazia ma gli risponde: “Solo che io vorrei fare l’avvocato…”. Il mister insiste: gli dice che è della stessa pasta di giocatori come Reggie Miller, Stephen Curry…Niente da fare. Poi tocca a Erbia, una ragazzina che corre, corre, corre… Il mister le dice che potrebbe fare i 1500, i 3000, forse i 10000… Persino la maratona? Lei annuisce sempre. “Non mi sembra possibile” dice il mister, ma Erbia risponde che corre “per natura”, che stare ferma per lei è un esercizio. “Io di mio correrei sempre e basta”. Il mister non capisce e Erbia gli spiega che in realtà è sempre stanca, che tutto l’universo è stanco ma si muove continuamente, che quando corre si sente inseguita da un albero… Alla fine il mister deve ammettere che “c’è qualcosa a cui non ero preparato” (p.29). Da bravo educatore, Rosario dialoga e suggerisce, non impone, né si dispiace quando vede che i ragazzi decidono di fare di testa loro: e sono la maggior parte. Come dire: scoprire i talenti dei tuoi allievi significa fare in modo che siano loro stessi a scoprirli, e aiutarli sulla strada che hanno appena intuito. Infine tocca a Cebola: è lui il coprotagonista. Lo incontriamo nell’incipit del racconto, è il portiere prima del calcio di rigore di una partita sullo zero a zero. Silenzio, fischio, attesa, e qui il racconto si ferma. I capitoli che seguono sono il flashback che ci fa entrare nel piccolo mondo di una scuola dove un insegante di ginnastica e i suoi ragazzini alle prese con lo sport animano un vivace, a tratti surreale teatro pedagogico. Sì perché a loro piace fare sport, ma a modo loro. Se c’è un messaggio che emerge nella godibile leggerezza di questo racconto è che le strategie elaborate da adulti che pretendono di “orientare” un ragazzo o una ragazza sul suo futuro in un’età in cui si è più o meno felicemente disorientati su se stessi, queste strategie, ancorché animate da buone intenzioni (come quelle del mister),

dovrebbero dubitare, aspettare, forse astenersi. Con Cebola avviene questo: lui è un formidabile velocista, “schizza come un tappo di spumante”, sui 100, sui 200, dunque…Ebbene, come in una sorta di “legge del contrappasso” dantesca applicata allo sport Cebola vuole fare il portiere, l’unico ruolo dove non si corre. E quando il mister gli chiede perché, lui dice che non lo sa ancora (o forse non lo sa ancora dire). Quando corre porta sempre con sé una figurina che si è fatto lui, una sorta di portafortuna: è Jašin, e per chi non lo sa, il russo Lev Jašin è stato uno dei più grandi portieri della storia del calcio. Cebola spiazza il mister e lui sta al suo gioco.
dettagli sono minuziosi, l’azione ha il ritmo di un rallenty. Quado il pallone verrà calciato arriverà l’intuizione…?
Ma c’è un momento di questa storia su cui voglio soffermarmi, forse quello pedagogicamente più suggestivo: è l’ultima lezione del mister; lascerà la scuola e così decide che i suoi allievi devono conoscere lo sport da un altro punto di vista, quello della sua cultura che ha una storia antica, che nasce dove è nato il teatro e la filosofia, e che diventa spettacolo, rappresentazione, rito: il campo da gioco come “luogo sacro” che dice molto di più di ciò che apparentemente mostra. Il mister crea attesa, accende lo schermo e fa partire il video

C’è una partita dove “la squadra dei Piugrandi” ha bisogno di un portiere, Cebola sarà in campo e, al momento giusto, sarà lui a dare all’allenatore qualche buon suggerimento. Il talento di Cebola, che lui sa di avere ma che gli altri non vedono, è di “essere veloce nella vista e nel pensiero” (p.55); lui intuisce la direzione, la velocità e si fa trovare pronto nel momento giusto e nel punto giusto. Affidato a Leo, un allenatore di portieri su indicazione del mister, Cebola si prepara tecnicamente, ma rimane qualcosa che il suo allenatore gli chiede a proposito della sua abilità di capire dove va la palla nelle situazioni più imprevedibili. Quello che Cebola chiama “culo” e Leo “Intuizione”. Ecco, fra questi due termini si gioca tutto il “sapere”, un sapere che ha sempre, comunque, un punto debole che non bisogna dire. E così, alla fine, si torna al principio: sul campo, dagli 11 metri tutto è pronto per il calcio di rigore, Cebola è in porta. I
di una famosa partita di calcio, famosa non tanto per il suo risultato ma per ciò che è successo dentro e oltre la partita: brutale violenza e imperdonabile cattiveria sportiva. Le immagini scorrono, si fermano, accompagnate dal commento del mister.
Perché questa lezione? Perché “ci sono momenti in cui è necessario incontrare la malattia per sviluppare gli anticorpi” spiega il mister, e perché siano chiare due verità: “La prima è che tutto può capovolgersi nel suo opposto. La seconda è che bisogna combattere testardamente e continuamente perché ciò non accada” (p.75). Dario Voltolini non ci dà i dettagli di quella partita, una finale internazionale del secolo scorso, fra club, in Sudamerica, una delle due squadre è italiana; lascia a noi il gioco di trovarla, gli indizi ci sono. A me piace ricordare che il portiere della squadra italiana si chiamava Fabio Cudicini e che proprio quest’anno ci ha lasciato. Pare sia stato uno dei migliori portieri del calcio italiano, un bell’esempio per Cebola.
La cattedra di Peter Emma Beseghi
La rubrica, realizzata in collaborazione con la cattedra di Letteratura per l’infanzia dell’Università di Bologna, segnala lavori originali presentati come tesi di laurea
La tesi di dottorato di Elena Guerzoni indaga le rappresentazioni di adolescenza nella Youth Fiction contemporanea.
“Ho pensato”, scrive l’adolescente Cordelia Kenn nelle memorie che intende lasciare alla sua primogenita nascitura, “a quanto è strano e bello un fiume. (…) Si espande e diventa più profondo mentre strofina, sbatte, erode, massaggia, mangia e si fa strada attraverso la terra”.1 Raccolte in uno dei romanzi più intensi ed esemplificativi della narrativa contemporanea scritta e pubblicata avendo in mente gli adolescenti e la loro età, le parole di Cordelia appena ricordate vengono riprese, insieme ad altri brani straordinari che costellano la letteratura cosiddetta Young

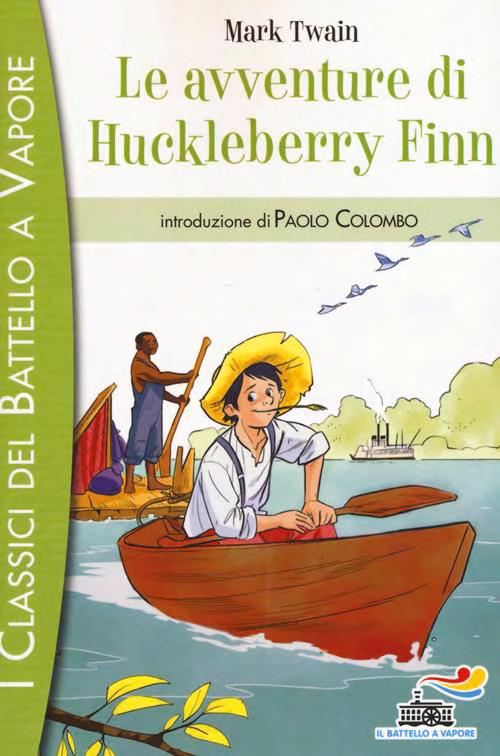
Adult, nella tesi dottorale di Elena Guerzoni, frutto di una ricerca triennale (anche condotta presso la Internationale Jugendbibliothek di Monaco di Baviera e l’Università di Anversa) che indaga le rappresentazioni di adolescenza all’interno dello specifico sottogenere della Youth Fiction (YF). Definita dall’autore britannico Aidan Chambers come una letteratura filtrata da una coscienza giovanile, la YF si rivela, nella ricerca di Guerzoni, quale luogo privilegiato ove recuperare indizi letterari riferiti all’età sud-
detta come stato dell’essere caratterizzato da un sentire e da un percepirsi-nel-mondo differenti rispetto alle altre età della vita umana. Le considerazioni della protagonista sopra menzionata, che proseguono con una serie di riflessioni profonde in grado di rendere testimonianza dell’elevata sensibilità e capacità introspettiva degli adolescenti, sono sintesi perfetta delle caratteristiche di una letteratura (la YF, appunto) che – riconosce Guerzoni – si impegna a esplorare e suggerire l’io profondo dei suoi adolescenti finzionali, restituendo ai lettori scorci di mondi interiori altrove non percepibili – perché non detti, oppure perché non riconosciuti e viceversa occultati da narrazioni stereotipizzanti che dei ragazzi e delle ragazze sottolineano primariamente le gesta sconvenienti e immature e gli atteggiamenti violenti. È precisamente dalla rilevazione di un immaginario popolare patologizzante oramai impostosi quale cifra di senso comune che la ricerca di Guerzoni prende avvio, elaborando anzitutto un’inquadratura storica del concetto di adolescenza, per quindi indagare la possibilità di rintracciare una specificità adolescenziale all’interno della YF. A fornire spessore e fondamento all’analisi del contemporaneo, sul quale la ricerca di Guerzoni si concentra esaminando un corpus di oltre duecento titoli italiani e internazionali, sono altresì uno studio e un’attenta ricostruzione della storia del genere letterario Young Adult, cui segue un lavoro di scavo ermeneutico sulle singole opere di YF sostenuto da una metodologia interpretativa indiziaria. Intrecciando tale postura agli approcci metodologici della linguistica e della narratologia cognitiva, la ricerca di Guerzoni individua, così, elementi narrativi e formali che nel corpus in esame ricorrono in maniera costante, contribuendo a suggerire,

dell’adolescenza, una nuova leggibilità. Tra questi, gli ambienti acquatici (soprattutto i fiumi), i ponti, le isole, la stagione estiva, il doppio o controparte e le figure del mostro e del selvaggio. Spesso inessenziali rispetto al dispiegarsi delle trame di superficie delle singole storie, gli elementi suddetti – ai quali sono frequentemente associate una lingua e una forma sperimentali – vengono interpretati da Guerzoni in termini di illuminanti metafore dell’esperienza di attraversamento dell’età “di mezzo”, nonché di menti adolescenti impegnate nel complesso e insieme esaltante compito di sperimentazione delle proprie possibilità identitarie. Come Huckleberry Finn, il cui viaggio iniziatico è interamente controllato dagli umori del grande fiume Mississippi, i protagonisti adolescenti di tantissima YF contemporanea vengono collocati in un mondo finzionale che ospita fiumi o altri ambienti acquatici, che insieme li attraggono e li respingono, li affascinano e li inquietano. Attingendo, su indicazione echiana, a un sistema di conoscenze enciclopedico che abbraccia la storia, l’antropologia, la filosofia e la psicanalisi delle acque, il lavoro ermeneutico di Guerzoni riconosce negli ambienti acquatici una rappresentazione della costitutiva ambiguità dell’adolescenza, delle sue intime contraddizioni e trasformazioni, che la metafora dell’acqua mai presenta in termini di inconciliabilità. Specchio e luogo di costruzioni identitarie, l’acqua è contemporaneamente fons vitae e imago mortis, ed è solamente immergendosi in essa – ovvero negli abissi del proprio sé – che i protagonisti adolescenti incontrano il proprio umano destino acquisendone per la prima volta una piena consapevolezza, così come acquisiscono consapevolezza di un tempo che scorre e a ogni istante muore, per quindi rinascere e proseguire il suo eterno fluire. Il tuffo degli adolescenti nelle acque di fiumi, laghi e mari è un salto nell’ignoto, prima prova iniziatica sulla via interiore che si rivela motivo di spaesamento e difficoltà, ma anche esperienza affascinante e irrinunciabile, sete di verità e di bellezza alla quale non si può, in adolescenza, non dare appagamento. Per questa ragione, la dodicenne Jess, in Il ragazzo del fiume (1997) di Tim Bowler, risponde al “chiacchiericcio ininterrotto” del maestoso fiume che la notte non la fa dormire, e prima con timore poi con convinzione vi entra lo percorre a nuoto dalla sorgente sino alla foce, mentre il diciassettenne Nik, protagonista di Ora che so (1987) di Aidan Chambers, si immerge completamente nudo nelle acque di un lago svedese, grembo umido e ricettivo dalle profonde ambivalenze materne. Similmente a Jess e Nik, numerosi altri ado-
lescenti della finzione letteraria appagano la propria “sete” mediante immersioni in ambienti acquatici naturali, oppure attraversando ponti, arrampicandosi su montagne, alberi e alti edifici, o ancora scendendo in ambienti terrigni, come miniere sotterranee e fognature cittadine, sempre muovendosi entro una dimensione verticale che garantisce loro una prospettiva alterata capace di innescare la “visione profonda” e generare, così, l’esperienza epifanica rispetto al sé, all’altro da sé, al mondo. Conducendo la propria ricerca con sguardo sempre attento a cogliere aspetti


di complessità, inattualità e marginalità, Guerzoni rileva, dunque, come la metafora acquatica inviti a operare, esattamente come tutti i motivi e le metafore ricorrenti all’interno della YF presa in esame, una torsione di sguardo, ad adottare una prospettiva nuova rispetto ai modi di pensare e rappresentare l’adolescenza che non intende tacere il disagio, ma che viceversa chiede di attraversarlo cogliendone la carica di possibilità. Affinché insegnanti ed educatori non siano portati a relazionarsi con gli adolescenti carichi di aspettative negative che facilmente si traducono in profezie autoavveranti, risulta fondamentale – conclude Guerzoni – che essi si avvicinino anche alle pagine di YF contemporanea, al fine di cogliere in esse nuovi sguardi e interessi sui ragazzi, le ragazze e la loro età. Allo stesso tempo, è auspicabile che essi incoraggino nei propri studenti la lettura di questa letteratura, giacché in essa possono trovare possibilità di rispecchiamento e sperimentare, attraverso le coscienze dei loro coetanei finzionali, lo sforzo necessario di una salita o una discesa, anticipando in tal guisa le prime prove di coraggio sulla via interiore.
1. A. Chambers. Questo è tutto: i racconti del cuscino di Cordelia Kenn, Milano, Rizzoli, 2015, p. 461-463.
Claudia Masiero
Il libro di Matteo Corradini dedicato alla didattica della Shoah propone attività di conoscenza della civiltà ebraica, fondamentale per fare Memoria.
Matteo Corradini, ebraista e scrittore, è in libreria con Noi siamo memoria (Erickson), un libro con cui, attraverso riflessioni, attività da svolgere e una ricchissima bibliografia, guida insegnanti, educatori, genitori e chiunque desideri dare un senso alla memoria in un percorso sul perché, sui modi, sui tempi e sul senso, oggi, di una didattica della memoria. Lei incontra tantissimi ragazzi nelle scuole: che coinvolgimento vede rispetto al tema della Shoah?
Ai ragazzi piacciono le storie delle persone; si affezionano alle storie, più difficilmente alla Storia. Ma questo capita a tutte le età. Sentono soprattutto che le amicizie di ieri, i legami,

le difficoltà, le passioni somigliano a quelle di oggi, magari a quelle che loro stessi vivono e provano. Le vicende dei singoli rimangono attraenti anche se sono passati molti anni, e il tempo sembra annullarsi. Per essere convincenti, però, le storie di ieri devono essere studiate, approfondite, conosciute bene da chi le racconta e le propone. Questa è la responsabilità che ci prendiamo noi adulti, e anche noi scrittori. Fare ricerca prima di raccontare la Shoah non è pignoleria da storici: è una questione di rispetto per chi c’era prima di noi e per chi ascolta da noi qualcosa.
Le capita di ricevere feedback da insegnanti che met-
tono in pratica le attività proposte nel libro? Se sì, qual è la risposta dei ragazzi?
Spesso mi mandano fotografie: “Ecco, abbiamo fatto questo!” Nel volume Noi siamo Memoria, così come nel precedente dedicato alla primaria, propongo venti attività strutturate, ma ogni insegnante ha l’autonomia di adattarle al contesto, alle persone e alla loro identità. Così mi piace molto vedere come gli insegnanti hanno trasformato le mie proposte in attività cucite sulle misure dei loro studenti. Mi piace quando gli insegnanti escono dal seminato, in modo divergente e spiazzante. Mi piace lasciare abbastanza libertà per aprire nuovi percorsi originali.
Nel libro, ricorda che prima che insegnare ai ragazzi, è importante che siano gli insegnanti a formarsi sul tema: quanto pensa che la memoria sia assente negli adulti di oggi?
A giudicare da come va la politica mondiale, la memoria del passato non solo è assente, ma è proprio rinnegata. Per una fetta di adulti, la memoria è commemorazione di una parte del passato e in particolare di quel passato che li fa sentire nella squadra dei buoni: il passato è un ottimo pretesto per dividerci al presente. Per una fetta degli adulti, avere a che fare con la memoria costa troppa fatica ed è meglio occuparsi solo di quanto avviene tra la colazione e l’aperitivo (sono gli stessi che accusano i giovani di pianificare poco il futuro). Ma gli insegnanti non sono mai adulti come gli altri, è quello che spero. La sua scelta di diventare ebraista è in qualche modo legata anche al tema della memoria e della Shoah?
Credo sia nato tutto per una questione di giungla. Non sono ebreo. Non vengo da una famiglia ebraica. Ho conosciuto il primo ebreo in vita mia quando avevo dodici anni: il mio paesello in provincia di Piacenza si era gemellato con una cittadina vicina a Parigi, erano arrivati i francesi e ogni famiglia italiana ne ospitava uno. Quello che ospitavamo noi si chiamava Samuel e (ce lo aveva rivelato lui) era ebreo. Però era come me, era uguale a me, una cosa davvero stupefacente! Ma qualcosa di diverso doveva pur averla, dentro, visto che mi aveva detto di essere ebreo. In quarta superiore ho visto Schindler’s List e ho capito che raccontare bene quel pezzo di storia era l’unico modo per guardare al futuro. A diciannove anni mi sono iscritto a Lingue orientali a Venezia, per studiare

l’ebraico forse inseguendo quel senso di giungla, di novità. Per poi scoprire che non sei tu a entrare nella giungla, è la giungla che è dentro di te: lo dicevano anche Calvin & Hobbes. Dieci anni fa ho lavorato con sir Ben Kingsley, a Terezin: erano i settant’anni dalla liberazione dei lager. Il progetto era coordinato a monte da Steven Spielberg: e con loro due, che erano il cuore di Schindler’s List, per me si è chiuso un cerchio. Qual è l’importanza della memoria, intesa in senso ampio come “ricordare”?
I souvenir sono ciò che ci è avvenuto e che possiamo scambiare con chi preferiamo: li portiamo a casa dalle vacanze, li raccontiamo agli amici a cena. Le madeleine sono ciò che ci è avvenuto e che possiamo mettere nei libri. I ricordi sono ciò che ci è avvenuto e che teniamo per noi: sono gli amabili resti, la cosa più personale che abbiamo. La memoria, invece, non sono i ricordi, la memoria non ci è avvenuta. È un ricordo di altri, una scelta collettiva e mai solitaria, è un passaggio, una condivisione. È soprattutto una scelta civile. Scorriamo insieme le date significative del calendario italiano, dal 27 gennaio al 25 dicembre, passando per il 10 febbraio, il 25 aprile, il 2 giugno, il 2 novembre... Cos’hanno in comune queste date? Segnano il nostro tempo perché i nostri antenati, recenti o lontani, hanno pensato che fosse importante fondare la nostra società su quella storia. Il 27 gennaio 1945, per esempio, è la data nella quale le truppe sovietiche entrano ad Auschwitz, ma non è di fatto la fine della Shoah, che purtroppo continuerà per mesi in molti altri luoghi. Dietro il 27 gennaio c’è una scelta, c’è un momento nel quale quella particolare data diventa il Giorno della Memoria e da lì comincia a segnare il tempo in modo completamente diverso. Dietro ogni data importante del calendario se ne nasconde una seconda, spesso sconosciuta, ossia il momento nel quale la nostra comunità civile decide che quella particolare data diventerà “quella” data. Fare memoria significa avere la consapevolezza di quella data fantasma, di una civiltà che si occupa di qualcosa che non è suo, che non sei tu, che va oltre il tuo orizzonte e il tuo tempo terreno. Significa prendersi la responsabilità dell’altro nel senso più ampio e nobile. Fare memoria è un atto civile di generosità, e proprio per questo è fuori dal tempo e può farci bene. Nel libro, lei afferma che l’idea secondo cui dalla memoria sarebbe discesa una diminuzione del razzismo, dell’antisemitismo e di quanto ne deriva, si è rivelata fallimentare: pensa sia errata l’idea, o che sia necessario un cambio di impostazione?
generazione le gambe cambiano. Questa azione di memoria è sempre stata politica, ma oggi sento che lo diventa anche più di un tempo: una parte della politica italiana e planetaria è mossa da egoismo, discriminazione, violenza. Lavorare sulla memoria, di fronte a queste derive nazionaliste, è un atto di civiltà.
Gli adolescenti di oggi sono la prima generazione a non avere quasi più contatto diretto con la Shoah, i sopravvissuti sono ormai pochi. È possibile sviluppino un’empatia per avvenimenti per loro così distanti? Non sono così certo di desiderare empatia per il passato. Così come non sono così certo che la generazione che viene dopo di noi sia nostra debitrice. Insegnare l’empatia, mostrare la bellezza dell’empatia ai più giovani significa educarli a dimostrare empatia per i loro coetanei e per chi verrà dopo di loro. È giusto che un giovane non si guardi indietro. La Memoria della Shoah in fondo ti dice: senza empatia è accaduto questo, a queste persone, che avevano queste storie, queste vite. Ora tocca a te. Voltati dall’altro lato della strada, ecco il tuo mondo.

Ci sono ancora tante storie “sommerse” legate alla Seconda Guerra Mondiale. Pensa che ci sia spazio per un recupero della memoria o che, con il passare del tempo, si andrà verso una semplificazione sempre maggiore?
Lentamente, sarà così: semplificheremo. Ma non conta la quantità di spazio sui libri di storia. Conta quanto quel pezzo di storia ha inciso nella nostra mentalità, nella nostra sensibilità. Nella nostra comunità.
A dispetto di questa sempre maggiore distanza, la Shoah continua a essere fonte apparentemente inesauribile di ispirazione per libri, film, prodotti culturali in genere: a cosa pensa si debba questo fenomeno?
La Shoah è diventato un genere, coi suoi pochi pro e molti contro. Ce ne accorgiamo ogni anno a gennaio. È l’occasione perfetta per vendere film e libri tra Natale e San Valentino, no? In molti libri, poi, la Shoah è poco più che un’ambientazione perché... non so perché. Da tempo io mi dico: pazienza. Il giorno in cui capirò l’editoria, farò l’editore.
La comunità ebraica in Italia oggi è molto ridotta: pensa che, per avere efficacia attiva nel presente, la memoria della Shoah debba passare anche per una conoscenza più profonda della cultura e religione ebraiche?
Era un’idea ottimista e molto forte alla fine degli anni Novanta del secolo scorso: tutto l’affaccendarsi intorno alla Memoria avrebbe abbassato la violenza razzista non solo nei confronti degli ebrei. Oggi la sensazione di pessimismo sembra vincere, ma non abbiamo la controprova: siamo certi che, senza tutto questo lavoro, il razzismo non sarebbe più forte? Non è errata l’idea, ma le idee hanno bisogno di gambe, e di generazione in
Nel mio saggio-manuale propongo attività di conoscenza della civiltà ebraica. Sono la base per fare Memoria in un modo veramente sensato. Gli ebrei italiani sono pochi, e una conoscenza più profonda della loro identità è necessaria e desiderabile. Ricordate la giungla di prima? Siamo tutti lì, in quella giungla. Conoscerci è solo il punto di partenza, ma da lì bisogna partire.





Contenuto e copertura
Il fascicolo di Schede Novità: la bibliografia del libro per bambini e ragazzi segnala, a cadenza trimestrale, una selezione di pubblicazioni per bambini e ragazzi pubblicate in Italia.
I dati bibliografici sono tratti da LiBeR Database, promosso dal Servizio di documentazione “Biblioteca Gianni Rodari”, attivo presso la Biblioteca Tiziano Terzani di Campi Bisenzio (info su: www.liberweb.it).
Le segnalazioni delle novità librarie per bambini e ragazzi – presentate in versione ridotta nel fascicolo – sono consultabili online in formato completo (con descrizione bibliografica al massimo livello di approfondimento e numerosi accessi per le ricerche) in LiBeR Database, dov’è disponibile l’intero archivio delle pubblicazioni distribuite in Italia dal 1987.
Norme
Le norme applicate nella redazione delle schede sono le Regole italiane di catalogazione REICAT.
Struttura e ordinamento delle schede
Le descrizioni, sempre presentate sotto il titolo e strutturate secondo lo schema dell’International standard bibliographic description, sono distribuite nei fascicoli in una sequenza per generi. Tutte le schede sono completate da abstract, fascia d’età e valutazione, proposta mediante un giudizio sintetico espresso con “stellette”:
HHHHH Da non perdere
HHHH Molto interessante
HHH Meritevole di interesse
HH Di scarso interesse
H Di nessun interesse
83 Albi e Racconti Illustrati
85 Libri Gioco
85 Poesia e Dramma
85 Fiabe, Favole e Leggende
85 Romanzi e Racconti
86 Fantascienza e Fantasy
86 Storie Fantastiche e Avventure
87 Storie Di Animali e Della Natura
87 Storie Dell’Età Evolutiva
87 Temi Sociali e Storici
88 Fumetti
88 Pensiero e Società
88 Scienza e Tecnologia
88 Natura
89 Arte e Spettacolo
89 Giochi, Sport e Hobby
89 Geografia e Storia
Indice
90 Titoli
Redazione e amministrazione: Fondazione Accademia dei Perseveranti
Piazza Dante, 23 50013 Campi Bisenzio (FI) Tel. 055 -8979403
E-mail: liber@idest.net
URL: http://www.liberweb.it
Direttore responsabile: Pier Francesco Nesti Coordinamento editoriale: Ilaria Tagliaferri
Per i dati bibliografici di LiBeR Database: Claudio Anasarchi, Selene Ballerini, Antonella Lamberti, Federica Mantellassi, Elena Tonini
Per la gestione e il trattamento della base dati dell’inserto: Federica Mantellassi
Inserto redazionale nel numero 146 (Aprile-Giugno 2025) di LiBeR
Progetto grafico: Paolo Bulletti Impaginazione: Mirco Bettazzi
1 - A casa
Mark Janssen ; [traduzione e] adattamento di Alessandro Riccioni Lapis, 2025
[32] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9791255190295 : € 16,00
Con grande entusiasmo una bambina che vive nella foresta accoglie un extraterrestre disceso dal cielo, gli mostra la fauna locale e lo ospita nel proprio villaggio; lui ne è felice, ma subito dopo riparte senza quasi salutare... Dove sarà andato?
Età: 4-5 HHHH
2 - A volte arriva il buio
Francesco Morgando, Melinda Berti Il Castoro, 2024
[32] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9791255332381 : € 16,00
Al buio qualcuno ha paura, ma in realtà sono così tante le cose belle da fare quando non c’è la luce che quasi quasi di giorno se ne potrebbe sentire la mancanza!
Età: 4-5 HHHH
3 - Abbassa la cresta
Géraldine Collet, Maurèen Poignonec ; traduzione dal francese di Eleonora Russo Giralangolo, 2024
[28] p. : ill. ; 29 cm (Sottosopra)
ISBN 9788859290599 : € 13,50
Il gallo pensa di poter fare quello che gli pare e comandare sulle galline del pollaio, ma quando si ritrova già mezzo mangiato dalla volpe è Nerina, la gallina che derideva, a liberarlo con grande coraggio.
Età: 4-6 HH
4 - La bambina con la grande mano verde scritto e illustrato da Matthew Gray Gubler Uovonero, 2024 [232] p. : ill. ; 21 cm (I geodi)
ISBN 9791280104564 : € 18,00
Una bambina cresciuta nascondendo la sua enorme mano verde che la fa sentire diversa scopre che quest’ultima è animata e ha provato a lungo verso di lei il medesimo senso di repulsa salvo poi cambiare prospettiva, come le confida in un discorso accorato.
Età: 7-9 HHHHH
5 - Bim bum bam
Maria Girón
Kalandraka, 2024
[36] p. : ill. ; 21x29 cm
(Libri per sognare)
ISBN 9788413433318 : € 16,00
Un’allegra comitiva si dirige verso la spiaggia fermandosi spesso per invitare qualcun altro, tanto che dai tre iniziali i bagnanti diventano sette, tutti con una gran voglia di divertirsi insieme!
Età: 3-4 HHHH
6 - Brava chiocciolina!
Silvia Vecchini, Carla Manea Edizioni corsare, 2024
[28] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788899136963 : € 16,00
Nel prato una chiocciolina incontra altri animali, ammira l’abilità che caratterizza ciascuno di loro e inizia a interrogarsi su quale sia la propria specialità.
Età: 3-5
7 - Il bruco misuratutto
Leo Lionni
Officina Babùk, 2024
[40] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9791281495104 : € 12,50
Un bruco che per la sua capacità di misurare la lunghezza di parti del corpo ha ottenuto dagli uccelli salva la vita è adesso in balia delle richieste dei predatori, ma un giorno si presenta per lui un’occasione di fuga...
Età: 4-5
HHHH
HHHHH
8 - C’era una volta un coniglio gigante
Cristiana Valentini e Gemma Palacio Zoolibri, 2024
[40] p. : ill. ; 29 cm
(Gli illustrati)
ISBN 9788899556730 : € 18,00
Coniglio ha ricevuto in regalo un libro in cui si parla di un coniglio gigantesco che a ogni pagina diventa sempre più alto ed è così preso dalla lettura da dimenticarsi degli amici che lo aspettano per giocare.
Età: 4-5
9 - Cinque topolini
Maria Giron
Kalandraka, 2024
[36] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788413432953 : € 15,00
HHH
Il topolino Felice e cinque amici topi seguono la scia di un profumino invitante, ma uno alla volta si fermano lungo il percorso e ad arrivare in fondo è solo lui, benché nel percorso di ritorno uno alla volta gli altri si aggiungano di nuovo, ricomponendo così l’allegro gruppetto.
Età: 2-4
HHHH
10 - Come crescere un mostro nell’armadio!
Antoine Dole, Bruno Salamone
Emme, 2024
[36] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788829605859 : € 14,50
Un bambino che convive con un mostro nell’armadio, diventato suo amico, lo abitua pian piano alla coabitazione, insegnandogli come stare tranquillo ad ascoltare storie, lavarsi i denti per rimediare al fiato mefitico ed essere consapevole di cosa può o non può toccare.
Età: 3-5
HHHH
11 - Come si fanno le caramelle magiche
Heena Baek ; traduzione di Dalila
Immacolata Bruno
Terre di Mezzo, 2024
[56] p. : ill. ; 21 cm
(Acchiappastorie)
ISBN 9791259962966 : € 13,50
Istruzioni fantasiose per realizzare caramelle magiche, qui intese come fossero parte di una vera ricetta di cucina e protagoniste di un altro albo dell’autrice.
Età: 5-6
HHHH
12 - Cosa fanno i sentimenti di notte?
Tina Oziewicz, Aleksandra Zaj?c ; traduzione di Valentina Parisi
Terre di Mezzo, 2024
[66] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9791259962317 : € 16,00
La felicità dorme profondamente, la curiosità non vuole dormire, la comprensione legge una storia, l’ansia si gira e si rigira: questi e altri comportamenti notturni dei sentimenti durante la notte.
Età: 5-7
13 - Decidi sempre tu!
Jörg Mühle ; traduzione di Giulia
Genovese
Terre di Mezzo, 2024
[32] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9791259962614 : € 14,00
Un orso e una donnola, che hanno un tasso ospite a casa loro, discutono su quali giochi fare, su chi fa cosa in ogni gioco, su chi gioca con il tasso... e così finiscono per sprecare tutto il pomeriggio invece di giocare!
Età: 5-7 HHHH
14 - Dov’è Momo? In giro!
Andrew Knapp
Topipittori, 2024
[24] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788833701585 : € 16,00
Nella camerina il cane Momo si nasconde sul letto a castello, mentre nel fiume sta sguazzando dietro la canoa: queste e altre scene nelle quali il lettore è invitato a cercare l’animale protagonista e altri oggetti più o meno nascosti.
Età: 1-2 HHH
15 - I fiori di Carlo
Mario Onnis
Topipittori, 2024
[36] p. : ill. ; 25 cm (I minitopi)
ISBN 9788833701592 : € 10,00
Il topino Carlo, appassionato di fiori, acquista semi e accessori per il giardinaggio e consulta cataloghi, finché le sue cure e un eccesso di fertilizzante gli consentono di realizzare il sogno di una casa letteralmente traboccante di piante!
Età: 4-5
16 - Il frutto rosso
Lee Gee Eun
Emme, 2024
[30] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788829606122 : € 15,90
HHHH
Cercando di raggiungere un invitante frutto rosso che ha intravisto tra i rami di un albero Orsetto sale in alto, sempre di più, a ogni tappa deluso perché il frutto non c’è, per poi trovarlo in modo inatteso e rassicurante dopo una caduta a precipizio.
Età: 3-4
17 - La giacca rossa
Valentina Zinzula, Yile Gao
MIMebù, 2024
[44] p. : ill. ; 31 cm
(Primi passi)
ISBN 9788831426879 : € 14,50
HHHH
Una giacca rossa scartata a causa di un’imperfezione viene poi scelta e utilizzata da un attore, poi da un direttore di circo e infine da un’artista di strada; lei n’è felice, ma tutti loro non fanno che coprire quel suo difetto e gli altri che nel frattempo ha accumulato... Verrà mai accettata soltanto per sé stessa?
Età: 5-7
HHHH
18 - La grande avventura e altre storie
Jarvis ; traduzione dall’inglese di Alessandra Valtieri
Lapis, 2024
61 p. : ill. ; 24 cm (Orso e Uccellina)
ISBN 9788878749993 : € 12,50
Uccellina è un po’ abbattuta e Orso non riesce proprio a risollevarle l’umore, ma forse quello che occorre è solo stare vicini: è la prima di quattro storie di cui sono protagonisti i due amici.
Età: 5-7 HHHH
19 - Grigio
Laura Dockrill, Lauren Child ; traduzione di Alessandro Zontini
Il Castoro, 2025
[40] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9791255332077 : € 16,00
HHHH
Un bambino che oggi si sente proprio giù - e che esprime il proprio stato d’animo attraverso metafore cromatiche - dialoga con la madre, da cui viene invitato ad accettare tutte le emozioni che esperisce, senza escluderne alcuna.
Età: 4-5 HHHH
20 - Il ladro di neve
Alice Hemming, Nicola Slater
Emme, 2024 [32] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788829605460 : € 14,50
Scoiattolo scopre la neve e il freddo insieme a Uccello: si può giocare a pallate, scivolare sul laghetto ghiacciato, sbattere contro un pupazzo di neve e accogliere poi il disgelo!
Età: 4-5 HHH
21 - La maestra è tornata!
Harry Allard, James Marshall ; traduzione di Sergio Ruzzier
LupoGuido, 2025 [36] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788885810822 : € 15,00
La signorina Dolcini, assente per qualche giorno da scuola, viene sostituita dal preside, un uomo così noioso che gli alunni escogitano un piano ingegnoso per liberarsene! Ma ecco un giorno presentarsi nella loro aula la terribile supplente Acquamarcia...
Età: 5-6 HHHH
22 - La merenda
Monique Felix Camelozampa, 2024 [32] p. : ill. ; 18 cm
(I libri del topolino)
ISBN 9791254641767 : € 12,90
Rosicchiando pian piano il contorno di una pagina un topino scopre un bel paesaggio disegnato in quella sottostante, sul quale inizia a volare a bordo dell’aeroplanino di carta realizzato con la pagina tagliata.
Età: 3-4 HHHHH
23 - Nanà è arrabbiata
Kimiko
Lapis, 2024
[26] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788878749757 : € 11,50
L’orsetta Nanà è furiosa perché non trova più neanche uno dei suoi biscotti lasciati nel piatto e sembra inutile ogni tentativo di Tato di tranquillizzarla e farla godere d’altro.
Età: 2-3 HHH
24 - Nanà ha paura
Kimiko Lapis, 2024 [26] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788878749986 : € 11,50
Al momento di andare a letto Nanà si spaventa per un ragnetto nel lavandino; Tato la rassicura, ma poi quando sono a letto è lui ad aver paura e allora la sorellina lo calma spiegandogli a cosa servono il buio e la notte.
Età: 2-3 HHH
25 - Ora ti prendo
Camilla Pintonato
Terre di Mezzo, 2024 [48] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9791259962416 : € 16,00
Un cucciolo di leone che deve cacciare la sua prima gazzella tutto da solo commette l’errore di ritenere facile l’impresa, finendo per fallire un appostamento dopo un altro!
Età: 2-4 HHHH
26 - L’orco del piano di sotto
testo Olivier Dupin ; illustrazioni Barroux Uovonero, 2025
[40] p. : ill.; 26 cm
(I geodi)
ISBN 9791280104601 : € 18,50
Una bambina ebrea racconta di come quello che credeva un crudele orco, ovvero il portinaio del palazzo, era in realtà buono e coraggioso e salvò lei e sua sorella durante l’occupazione nazista nascondendole nella sua lunga e folta barba.
Età: 6-8 HHHHH
27 - Ovunque
Chris Saunders
Emme, 2025
[32] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788829606399 : € 14,90
A una talpa partita in viaggio per esplorare il mondo si uniscono via via animali di varie specie e tutti sono convinti che sia diretta verso una precisa meta, sulla quale ciascuno inizia per conto proprio a fantasticare.
Età: 3-4
28 - I pantaloni di Luisa
Susanna Isern, Esther Gili NubeOcho, 2024
[36] p. : ill. ; 30 cm
(Egalité)
ISBN 9788410074873 : € 16,90
HHH
Ispirata alla storia vera di Luisa Capetillo, portoricana nata alla fine dell’Ottocento, scrittrice e attivista, il racconto di come da piccola iniziò a indossare i pantaloni, rivendicandoli in seguito come simbolo di pari opportunità per le donne.
Età: 5-7
HHHH
29 - Questo è molto strano...
Matilde Facchini, Mercè Galì Kalandraka, 2025
[38] p. : ill. ; 22 cm
(Libri per sognare)
ISBN 9788413433608 : € 14,00
Per la sua mamma è un piccolo koala, per il papà è un topolino, quando dorme è un ghiro... Ce n’è da farsi venire una crisi d’identità per il bambino protagonista!
Età: 3-4
HHHHH
30 - Il regalo delle fate formiche
Shin Sun-Mi
Topipittori, 2024
[40] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788833701622 : € 20.00
Un bambino ottiene dalle fate formiche, che hanno minime dimensioni, un mantello magico da far indossare sia alla sua mamma che alla sua nonna e che le farà tornare al tempo per cui provano nostalgia, dando loro l’opportunità di rimediare a qualche rimpianto.
Età: 3-5
31 - Saltafossi
Alessandro Sanna
Gallucci, 2024
[48] p. : ill. ; 34 cm
ISBN 9791222106670 : € 18,00
HHHHH
Uscito nella campagna assolata nella speranza di trovare Saltafossi il ragazzino protagonista non riesce a rintracciarlo, però s’imbatte nella sua favolosa bicicletta da cross e non resiste alla tentazione d’inforcarla per continuare a cercare l’amico.
Età: 5-6
HHHHH
32 - Se non ci sei tu Lisa Swerling e Ralph Lazar ; adattamento dall’inglese di Alessandra Valtieri Lapis, 2025
[96] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9791255190325 : € 13,50
Un piede senza calzatura, un remo senza imbarcazione, uno yacht senza equipaggio: questi e numerosissimi altri paragoni con cui una ragazza esprime quanto gli manca il suo lui quando non sono insieme.
Età: 6-8
HHHH
33 - Un sogno per Piccolo Orso
Michael Rosen ; traduzione di Chiara Carminati ; illustrazioni di Daniel Egnéus Mondadori, 2024
[32] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788804781530 : € 16,00
Piccolo Orso, preoccupato che nel lungo inverno, durante il letargo possa restare senza sogni, fa un ultimo giro della foresta prima di addormentarsi e si ricarica di sogni con l’aiuto di altri animali.
Età: 4-5 HHHHH
34 - Splendide creature
Guia Risari e Cinzia Ghigliano Settenove, 2024
[36] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9791281477049 : € 19,00
Una giovanissima creatura umana, nata dall’unione di una rondine maschio e di una lupa femmina, racconta come si vive nel bosco in cui abita con i genitori, dove gli animali si uniscono fra loro nei modi più imprevedibili e in cui regnano armonia, metamorfosi e incanto. Età: 7-9 HHHHH
35 - La storia vera
Sergio Ruzzier
Topipittori, 2024 [32] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788833701615 : € 18,00
Quando il gatto chiede al topo il motivo per cui la scatola dei biscotti è sul pavimento rotta il roditore gli racconta un sacco di storie incredibili, ma così appassionanti che forse in fondo sono meglio della banale storia vera!
Età: 3-4 HHHH
36 - Storie di paura
Edward Marshall, James Marshall ; traduzione di Sergio Ruzzier LupoGuido, 2025
48 p. : ill. ; 22 cm + 1 c.
ISBN 9788885810839 : € 14,00
La storia di paura letta in riva al lago dalla bambina Lolly per spaventare il fratellino di Spider che fa troppa confusione è così insulsa che i suoi due amici decidono di crearne ciascuno una propria, sempre con protagonista il piccolo, che però non si spaventa di nulla, anzi!
Età: 4-5 HHHH
37 - Ti leggerò una storia
Gideon Sterer, Charles Santoso Il Castoro, 2024
[40] p. : ill. ; 23x29 cm
ISBN 9791255332411 : € 15,00
All’ora della nanna quando la mamma gli propone di leggergli una storia un bambino si preoccupa di andare a leggere per i mostri, di cui nessuno mai si occupa, e solo quando anche loro sono tranquilli torna a dormire.
Età: 4-5 HHH
38 - I topi ballano
Giuditta Campello, Mauro Garofalo Feltrinelli, 2025
28 p. : ill. ; 21 cm
(I bruchi : per lettori che metteranno le ali)
ISBN 9788807924644 : € 7,90
Tutte le volte che il gatto esce per una commissione i topi nascosti in casa sua escono dalle loro tane e iniziano a ballare scatenati, finché un giorno lui non rientra prima del tempo e scopre tutto... Cosa accadrà?
Età: 5-7
39 - Troppo tardi
Giovanna Zoboli, Camilla Engman Topipittori, 2024
[28] p. : ill. ; 27 cm
(I minitopi)
ISBN 9788833701608 : € 10,00
HH
Il desiderio del piccolo Riccardo di far tardi, molto tardi, si traduce di notte in un felice viaggio fantastico che - compiuto insieme a un orso con la bicicletta, un gatto e una cerva - lo rende molto felice!
Età: 5-7
40 - Tutino con la terra
Lorenzo Clerici
Minibombo, 2024 [36] p. : ill. ; 17 cm (Bombi di cartone)
ISBN 9791281054127 : € 9,90
HHHH
Tutino vuol realizzare un piccolo orto e procede con le operazioni necessarie in rigoroso ordine, ma poi resta deluso perché sembra che nessuno dei semi piantati dia il risultato sperato...
Età: 2-4
41 - Tutino nella neve
Lorenzo Clerici
Minibombo, 2024 [36] p. : ill. ; 17 cm
HHH
(Bombi di cartone)
ISBN 9791281054134 : € 9,90
Ha nevicato e Tutino raccoglie rametti, pigne e tutto quel che può servire a realizzare un pupazzo di neve, senza prevedere che rotolando giù per il poggio sarà lui stesso a trasformarsi in un bianco pupazzo!
Età: 2-4 HHH
42 - Tutti zitti, per piacere!
Barroux
Lapis, 2024
[40] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9791255190080 : € 13,00
Gru si piazza sul bordo di un laghetto per fare un sonnellino in tranquillità ma scopre che è pieno di rane gracidanti e allora si sposta di nuovo, non immaginando che nell’unico luogo tranquillo sarà lei a dare fastidio a qualcun altro!
Età: 5-7 HHH
43 - Il vento
Monique Felix
Camelozampa, 2024
[32] p. : ill. ; 18 cm
(I libri del topolino)
ISBN 9791254641774 : € 12,90
Un topino comincia a rosicchiare pian piano il contorno di una pagina e poi, una volta tagliata tutta, la trasforma in un’elica con cui plana dolcemente portato dal vento, che scompiglia la scena della pagina successiva.
Età: 3-4 HHHHH
44 - Voglio andare senza rotelle!
Tobias Giacomazzi
Kalandraka, 2025
[32] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788413433455 : € 16,00
Il ranocchietto Ettore vorrebbe andare senza rotelle come vede fare agli altri, più grandi e capaci di grandi imprese sulle due ruote, e il soddisfacimento del suo desiderio arriva in modo inatteso.
Età: 3-4 HHHH
45 - Vola!
Marianne Valentine e Giulio Noccesi
Zoolibri, 2024
[32] p. : ill. ; 28 cm
(Gli illustrati)
ISBN 9788899556709 : € 18,00
Anna cerca di addestrare un gabbiano ferito rifugiatosi a casa sua mentre la nonna malata le dice di consentirgli di essere ciò che lui desidera, frase che la bambina ricorderà e che la guiderà dopo la morte dell’anziana.
Età: 5-7 HHHH
46 - Zucca, Osso e Pelliccia. Straccio è giù di corda
Davide Calì, Stefano Martinuz Nomos, 2024 [36] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9791259581884 : € 16,90
Zucca, Osso e Pelliccia sono preoccupati per l’amico fantasmino Straccio che sembra da un po’ di tempo tristissimo e dopo aver scoperto che soffre di nostalgia per i famigliari lontani decidono di accompagnarlo a trovarli.
Età: 4-6 HHHH
47 - Dove sei, Randolph?
Marianna Coppo Lapis, 2024
[30] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788878749900 : € 12,50
Per non annoiarsi l’orsetto Randolph accetta una sfida a nascondino, ma si rivela poco abile: al riparo della tenda, dietro una pianta in vaso o sotto il paralume un piccolo dettaglio tradisce ogni volta la sua presenza!
Età: 1-3 HHHH
48 - Aiuto, sono finito nello smartphone!
Pier Mario Giovannone, Erika De Pieri Feltrinelli, 2025
29 p. : ill. ; 21 cm
(I bruchi : per lettori che metteranno le ali)
ISBN 9788807924569 : € 7,90
A forza di spippolare sul cellulare un bambino di nome Pigrino si ritrova l’indice della mano prima lunghissimo e poi letteralmente ingoiato dallo schermo! Come fare a tornare nel mondo tridimensionale, che gli piace molto di più? Età: 5-7 HHH
49 - Batti cuore
Chiara Carminati, Massimiliano Tappari Lapis, 2024
[32] p. : foto ; 20 cm
ISBN 9791255190059 : € 12,50
Un cuore sulla fronte di una mucca che farà il latte per un cappuccino decorato da un cuore di schiuma, una nuvola a forma di cuore e numerosi altri cuori individuati in situazioni disparate e raccontati.
Età: 3-5
50 - Caccia alle uova
HHHH
Giuditta Campello ; illustrazioni di Arianna Cicciò EL, 2025
[28] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788847742550 : € 14,50
Coniglia Esterina nasconde nel bosco quattro uova colorate e Cincia, Scoiattolo, Lepre e Riccio si mettono subito alla loro ricerca, accorgendosi però ben presto che individuarle non è così facile! Età: 4-6 HHH
51 - Un cappotto piccolo piccolo
Joy Cowley, Giselle Clarkson Storiedichi, 2024
[36] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791281160170 : € 15,00
Una donna minuscola che ha freddo e desidera un cappotto trova aiuto e regali vari grazie alla natura e agli animali che incontra: una foglia come stoffa, un aculeo dell’istrice come ago, il becco dell’oca come forbici e i semi del tarassaco come bottoni. Età: 3-4
HHHH
52 - Con le mani posso : diciotto filastrocche per giocare con il corpo
scritte da Mia Floridi ; illustrate da Maurèen Poignonec Il Castoro, 2024
[48] p. : ill. ; 18x24 cm
ISBN 9791255332176 : € 14,50
Diciotto filastrocche incentrate su utilizzo delle mani, singhiozzo, nudità, capelli e molti altri aspetti, manifestazioni e movimenti del corpo esperiti da bambine e bambini.
Età: 2-3
53 - Ogni volta che parti
HHHH
Chiara Carminati e Massimiliano Tappari Lapis, 2025
[56] p. : foto ; 24 cm
ISBN 9791255190288 : € 15,00
Ogni volta che la persona cara parte chi resta è preda del vuoto dell’assenza, della nostalgia e del ricordo delle esperienze passate, nonché del desiderio di ritrovarsi, con la fiducia di ricongiungersi e tornare alla gioia.
Età: 6-99
ISBN 9791255190141 : € 14,00
Un cavaliere di piccole dimensioni affronta un drago sbrana-persone, un feroce gattopardo e due enormi soldati pur di far uscire la principessa dalla sua torre; ma chi si nasconde dietro il cavaliere? e chi è la principessa?
Età: 5-7
HHHHH
54 - Salverò la principessa!
Nicola Cinquetti ; illustrazioni di Silvia
Vignale
Lapis, 2024
[36] p. : ill. ; 21 cm
HHHH
55 - La bambina e l’orsa
Cristiana Pezzetta, Sylvie Bello
Topipittori, 2024
61 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788833701462 : € 24,00
In un bosco governato da Artemide una bambina innamorata della natura e un’orsa, che è stata portata lì come dono per la dea Artemide, s’incontrano e si legano affettivamente l’una all’altra: una storia mitologica greca, dall’epilogo drammatico ancorché rigenerante, risalente al V secolo a.C.
Età: 8-10 HHHHH
56 - Fate : le storie e gli antichi miti
scritto da Beatrice Masini ; ideato e illustrato da Giulia Tomai
Rizzoli, 2024
153 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788817188500 : € 26,00
Descrizione di 34 esseri soprannaturali - fate, elfi, gnomi, ninfe... - di ogni parte del mondo, tra cui il coboldo tedesco, la francese Melusina, il giapponese korpokkur e gli africani aziza.
Età: 11-14 HHHHH
57 - Le mini fiabe box 4
Attilio
Lapis, 2024
1 contenitore (4 v.) : ill. ; 15 cm
ISBN 9791255190158 : € 18,50
Sfruttata e maltrattata da matrigna e sorellastre Cenerentola grazie a un incantesimo riesce a partecipare al ballo indetto dal principe per scegliersi una sposa: come finirà? In quattro libretti questa, altre due fiabe e una sintesi di Pinocchio. Età: 2-3 HHH
58 - Ossa che cantano : immagini ispirate alle fiabe dei fratelli Grimm
Shaun Tan ; prefazione di Neil Gaiman ; introduzione di Jack Zipes
Tunuè, 2024
192 p. : foto ; 22 cm
(Mirari)
ISBN 9788867907052 : € 24,00
Brani tratti da 75 fiabe - sia celebri che meno note - dei fratelli Grimm, scelti per la loro pregnanza dal creatore delle sculture che li commentano. Età: 14-99 HHHHH
59 - Un agente troppo segreto
Angelo Mozzillo ; illustrazioni di Davide Panizza Piemme, 2024
155 p. : ill. ; 21 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856694680 : € 16,00
Per diventare agente segreto Ettorino, con cui collabora Linus, deve superare alcune prove, ma
ben presto scopre che chi gliele sta ponendo è un’organizzazione criminale e che il proprio nonno nasconde un’identità del tutto imprevedibile. Età: 10-12 HHH
60 - La famiglia Gattoni
Annie M. G. Schmidt, Fiep Westendorp ; traduzione di Valentina Freschi LupoGuido, 2024
136 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788885810791 : € 19,00
La famiglia Gattoni è composta dal padre, dalla figlia Bice e dalla madre, che essendo stata un tempo una micia sale sugli alberi, ha paura dei cani e soprattutto può parlare con i gatti, traendone grandi vantaggi: una storia in 29 episodi. Età: 9-10 HHHH
61 - Ande Lande
Antonia Murgo Bompiani, 2025
493 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788830119994 : € 18,00
La bambina Chel, che ha solo questo nome in un regno – Ande Lande – in cui chi ha più nomi vale di più (sono gli astri a darli), mette in gioco la propria abilità e il proprio coraggio quando la zia e la cugina vengono rapite, in forma miniaturizzata, dalla Reina di Tasche.
Età: 12-14 HHHHH
62 - I disobbedienti del mondo nuovo
Patrizia Rinaldi
Giunti, 2024
407 p. ; 21 cm
ISBN 9788809967199 : € 14,00
In un futuro dove la condizione di hikikomori è stata imposta dalla tirannia come legge quattro adolescenti, resi obesi dall’inattività forzata, si ribellano a questo modello sociale, in cui fra l’altro vigono la sterilità e il rapimento dei piccoli nati fra i cosiddetti selvaggi che vivono nelle riserve.
Età: 15-17 HHHHH
63 - Petrademone : la saga completa
Manlio Castagna
Mondadori, 2024
1108 p. ; 28 cm
ISBN 9788804797739 : € 25,00
Frida, tredicenne orfana affidata agli zii, raggiunge la sua nuova casa a Petrademone, dove scopre che i cani della zona stanno misteriosamente sparendo e che esiste un pericoloso mondo parallelo con il quale pure lei è coinvolta: questo e gli altri due libri della trilogia in raccolta.
Età: 12-99 HHH
64 - Redwall
Brian Jacques ; traduzione di Laura Cangemi
Mondadori, 2025
425 p. ; 23 cm
ISBN 9788804755951 : € 14,90
La lotta senza quartiere tra il malvagio ratto Cluny che cerca di conquistare l’abbazia di Redwall e Matthias, topo novizio dell’ordine monastico - lì residente - fondato dal leggendario eroe
Martin: è l’inizio della celebre saga ambientata nel medioevo inglese.
Età: 11-14 HHHHH
65 - Villa Zombie
Francesco Bedini ; illustrazioni di Stefano Tambellini
Il Castoro, 2025
183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791255332831 : € 14,00
L’undicenne Tobia, che da quando ha avuto un incidente automobilistico (causato da una pioggia di meteoriti) con il nonno - che ora è ricoverato in un gerontocomio e dorme da quasi sette mesi - è diventato afasico, scopre insieme all’amica del cuore Amelia che è in atto un’invasione aliena: misteriosi lumacoidi spaziali stanno infatti penetrando dentro gli esseri umani!
Età: 11-12
HHH
66 - Ada e lo specchio magico
Lucia Stipari ; illustrazioni di Giusy Gallizia Il Castoro, 2024
121 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791255332404 : € 14,00
Nella vecchia soffitta, dove ama molto leggere in solitudine, la giovanissima Ada s’imbatte con un proprio riflesso, che si rivela non solo animato ma con un carattere opposto al suo!
Età: 8-10
HHH
67 - Dolci magie. Apprendista pasticciera
Aurélie Gerlach ; traduzione di Lorenzo Vetta ; illustrazioni di Maud Begon Mondadori, 2025
61 p. : ill. ; 22 cm
(Dolci magie)
ISBN 9788804790297 : € 14,00
Istruita dalla nonna, maga pasticciera, la seienne Candy scopre di aver ereditato i poteri della famiglia Ladolcezza, ma il primo incantesimo che compie è un vero pasticcio perché trasforma genitori e vicini in animali e la cagnolina della nonna in una bambina!
Età: 7-9
HH
68 - Dolci magie. Nel regno del cioccolato
Aurélie Gerlach ; traduzione di Lorenzo Vetta ; illustrazioni di Maud Begon Mondadori, 2025
61 p. : ill. ; 22 cm
(Dolci magie)
ISBN 9788804790303 : € 14,00
Candy, 6 anni, che erede dei poteri della famiglia Ladolcezza viene istruita dalla nonna maga senza che i genitori lo sappiano, cerca di liberare il padre, che è stato rapito da uno stregone per carpirgli una ricetta, all’uomo invece ignota.
Età: 7-9
69 - Einstein il pinguino
Iona Rangeley ; illustrazioni di David Tazzyman ; traduzione di Maria Laura Capobianco
Il Castoro, 2024
213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791255332374 : € 15,00
HH
fa per annunciare il suo incredibile matrimonio: si sposerà con un’onda del mare...
Età: 9-10 HHHH
71 - Irma la strega
Marco Viale
Feltrinelli, 2024
43 p. : ill. ; 21 cm
(I bruchi : per lettori che metteranno le ali)
ISBN 9788807924583 : € 7,90
La strega Irma, sentendosi poco alla moda, si dà da fare per raggiungere una posizione di successo, salvo poi rimpiangere la vita che faceva e gli amici di sempre, con cui si sentiva a proprio agio. Età: 5-7 HHH
72 - La ragazza che perse il leopardo
Nizrana Farook ; traduzione di Rachele
Salerno
Emons, 2025
211 p. : ill. ; 21 cm
(Emons!raga)
ISBN 9788869863547 : € 14,00
Sull’isola di Serendib la ragazzina cingalese Selvi cerca di proteggere dai bracconieri, anche con l’aiuto di alcuni coetanei, lo splendido esemplare di leopardo Lokka, con il quale ha stretto un legame intimo e speciale.
Età: 9-11 HHH
73 - Lumpi Lumpi. Capricci e pasticci
Silvia Roncaglia, Roberto Luciani Feltrinelli, 2025
44 p. : ill. ; 21 cm
(I bruchi : per lettori che metteranno le ali)
ISBN 9788807924651 : € 7,90
Il bambino Giampi e il suo amico immaginario, il draghetto Lumpi Lumpi, s’intestardiscono a ottenere uno gli stivali delle sette leghe e l’altro il flauto magico, ma una volta ottenuti si rendono conto che sono solo fonte di guai!
Età: 7-8
Con l’aiuto dei genitori la novenne Imogen e il fratello seienne Arthur, londinesi, investigano su dove sia stato portato il pinguino Isaac, dopo aver capito che il pinguino Einstein presentatosi alla loro porta è evaso da uno zoo australiano per venire a cercarlo.
Età: 9-10 HHHH
70 - Era sirena
Alice Rohrwacher, Lida Ziruffo
Mondadori, 2025
84 p. : ill. ; 22×28 cm
ISBN 9788804794370 : € 17,00
In un paesino stretto da monti e mare cresce Peppi’Nata, un ragazzo da sempre un po’ strano e silenzioso ma che un giorno finalmente parla e lo
HHH
74 - Il mostro mangiapantofole
Alberto Bellini, Alice Del Giudice Feltrinelli, 2024
27 p. : ill. ; 21 cm
(I bruchi : per lettori che metteranno le ali)
ISBN 9788807924576 : € 7,90
La piccola Marta, travestita da aliena per una festa, esce e nel bosco incontra un piccolo mostro con cui fa amicizia, scoprendo che non mangia bambini bensì pantofole e lampadine e che ama ascoltare le storie proprio come lei.
Età: 5-7 HH
75 - Penny dal cuore grande
Cristal Snow ; traduzione di Irene Sorrentino ; illustrazioni di Kati Vuorento Piemme, 2024
232 p. : ill. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856694864 : € 16,50
Penny, una fatina minuscola di 10 anni a cui la genetica ha dato un cuore troppo grande per lei e quindi fragile, inizia a frequentare il suo fastidioso nuovo vicino di casa, il fatino Mark, per meglio raccogliere materiali utili a un incantesimo contro di lui, ma poi lo conosce meglio e inizia a pentirsi del proprio pessimo comportamento... Come rimediare?
Età: 8-10
HHHH
76 - La strada che ci porta a casa
Susanna Tamaro ; illustrazioni di Lida Ziruffo Piemme, 2024
185 p. : ill. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856697407 : € 16,50
Sam, ottenne italiano, perde di vista la madre e il patrigno in un autogrill e intuendo di essere stato abbandonato inizia un viaggio alla loro ricerca, senza immaginare che invece troverà sé stesso e l’indipendenza della propria stella interiore.
Età: 10-12 HHH
77 - I Tillerman
Cynthia Voigt
Il Barbagianni, 2024
428 p. ; 21 cm (Il volo)
ISBN 9788897865414 : € 18,90
Abbandonati all’improvviso nel Connecticut dalla madre disoccupata i fratelli Tillerman - Dicey, Sammy, James e Maybeth, dei quali la maggiore ha soltanto 13 anni - cercano di raggiungere, tra mille difficoltà, la casa di qualche parente. Età: 12-14 HHHHH
78 - L’amico inatteso
Ivan Canu e Gianni De Conno Lapis, 2024 [32] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9791255190134 : € 15,00
Il lupo non riesce a trovare un animale che sia disposto a essere suo amico perché hanno tutti paura di lui e non si fidano e soltanto l’incontro con un altro grande predatore, il cacciatore, gli darà la possibilità di realizzare il suo desiderio.
Età: 5-7 HHHH
79 - La foresta che cresce
Andrea Valente, Lucia Scuderi Lapis, 2024
104 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9791255190165 : € 17.50
Il castagno d’India (o ippocastano) del giardino di fronte al rifugio segreto di Anne Frank, gli abeti rossi che selezionava Stradivari per i suoi strumenti e altri 14 alberi legati a personaggi famosi in 16 brevi racconti.
Età: 10-11 HHHH
80 - Il barattolo dei desideri
Eleonora Fornasari ; illustrazioni di Sara Brienza
Il Castoro, 2024
131 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9791255332244 : € 14,00
Dopo essere diventato famoso a scuola – e perfino sui giornali – per aver casualmente aiutato una celebre presentatrice che stava per partorire il piccolo Lollo si convince che grazie a un barattolo vinto a una pesca di beneficenza i suoi desideri si stiano esaudendo! Sarà veramente così? E intanto un suo compagno di classe, a lui ostile, gli chiede di soddisfarne uno... Età: 9-10 HHH
81 - Il caso Drilla
Andrew Clements ; traduzione di Beatrice
Masini
Rizzoli, 2025
239 p. ; 20 cm
ISBN 9788817191555 : € 16,00
L’undicenne appassionato d’informatica Josh, alle prese con un segreto scoperto per caso e un insegnante che sembra ostile alla tecnologia, finisce per capeggiare una pacifica ribellione dagli imprevedibili risvolti.
Età: 9-11 HHHHH
82 - Come un dente di leone
Attilio Facchini
Rizzoli, 2024
169 p. ; 22 cm
ISBN 9788817187381 : € 16,50
L’undicenne Grazia Pia Letizia, derisa per il suo nome, vittima di bullismo e dotata di una grande immaginazione che le fa assimilare ogni persona con una specifica pianta, stringe un’intensa amicizia con un nuovo compagno di classe - e suo nuovo vicino di casa - che è gravemente malato di tumore.
Età: 11-13
83 - Felice abbastanza
HHHH
Kari Stai ; traduzione di Maria Valeria
D’Avino
Camelozampa, 2025
165 p. : ill. ; 22 cm
(I peli di gatto)
ISBN 9791254641927 : € 15,90
Il norvegese Juri, 11 anni, che sta attraversando un momento difficile a causa della separazione dei suoi, s’interroga al contempo sulle proprie vocazioni e sull’amore, le cui emozioni e dinamiche gli stanno complicando la vita, dentro e fuori di sé.
Età: 10-11
84 - In nome di Chris
HHHH
Claudine Desmarteau ; traduzione di Caterina Ramonda Terre di Mezzo, 2025
325 p. ; 22 cm
ISBN 9791259962737 : € 16,00
Adrien - un quattordicenne irrequieto che non ha mai conosciuto il padre, ha un rapporto problematico con la madre, soffre di nostalgia per un’amica che ha traslocato, fa sedute psicoterapeutiche e subisce gravi atti di bullismo - inizia a frequentare di nascosto un adulto che lo spinge a crescere ma in modo inquietante.
Età: 14-16
HHHHH
85 - Lark. Il volo dell’allodola
Anthony McGowan ; traduzione di Mara Pace Rizzoli, 2024
129 p. ; 22 cm
(Best BUR)
ISBN 9788817185318 : € 13,00
Durante un’escursione i fratelli preadolescenti Kenny e Nicky si perdono nella brughiera e vengono inoltre sorpresi da una nevicata.
Età: 11-13
HHHH
86 - Il mio amico Percy e Buffalo
Bill
Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi
Iperborea, 2025
214 p. : ill. ; 19 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870917536 : € 15,00
Il piccolo Ulf, in vacanza dai nonni, ospita l’amico Percy, che con la sua innata e grande simpatia piace proprio a tutti, cavallo compreso!
Età: 10-12
HHHH
87 - Le mirabolanti avventure di Élisabeth a Parigi
Vincent Cuvellier, Guillaume Bianco ; traduzione di Simona Mambrini
Mondadori, 2025
278 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788804781943 : € 17,00
Nel 1920 la piccola Elisabeth, che è scappata da un orfanotrofio e ha raggiunto Parigi sperando di trovarvi notizie sui propri genitori, s’imbatte in esserini malefici che si nutrono dell’infelicità e si lega a personaggi bizzarri che invece la aiutano. Età: 9-11 HHH
88 - Salto mortale
Arndís Thórarinsdóttir ; traduzione di Silvia Cosimini
Iperborea, 2024
242 p. ; 20 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870917956 : € 16,00
Il dodicenne islandese Álfur, che pratica ginnastica artistica e ambisce ad andare alle Olimpiadi, inizia a frequentare di nascosto una sua zia che adesso vive isolata ma è stata una campionessa nella disciplina da lui amata e intanto si ribella alla diagnosi di autismo decretata dai medici per il fratellino.
Età: 12-14 HHHHH
89 - La scuola
Britta Teckentrup ; traduzione di Maria Carla Dallavalle
Uovonero, 2024
[128] p. : ill. ; 25 cm
(I geodi)
ISBN 9791280104571 : € 20,00
Una voce non identificata racconta una scuola elementare alunno per alunno, ciascuno con i suoi problemi, talenti, desideri, paure, prepotenze, mentre il mondo degli insegnanti e degli adulti in generale appare lontano e poco comprensivo.
Età: 7-9 HHHHH
90 - L’unica via d’uscita
Oskar Kroon ; traduzione di Samantha K. Milton Knowles
Terre di Mezzo, 2025
133 p. ; 22 cm
ISBN 9791259962409 : € 14,00
Per difendere l’adorato fratello maggiore Krister dai bulli della scuola il ragazzino Kaj ordisce con l’aiuto dell’amica Naima una vendetta che innescherà conseguenze disastrose.
Età: 11-14 HHHHH
91 - Come volpi in mezzo ai lupi
Christian Antonini
Piemme, 2024
191 p. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856687378 : € 17,00
Varsavia, 1939: dopo aver perso i suoi in un bombardamento nazista Eliza, 9 anni, rimasta sola perché il fratello ora è un partigiano, è adottata da un ex docente (Karol Borsuk) da cui apprende un affascinante gioco e intanto si unisce alla Resistenza.
Età: 12-14 HHHH
92 - Il Conte di Montecristo raccontato da Fabrizio Silei ; illustrato da Ernesto Anderle
Lapis, 2024
352 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9791255190202 : € 15,90
Vittima di un inganno il giovane e promettente Edmond Dantés finisce in carcere per 15 anni, peraltro perdendo così anche l’amata, ma riuscito a evadere e arricchitosi grazie a un tesoro si vendicherà sistematicamente di chi gli ha cospirato contro.
Età: 9-11
HHH
93 - Cronache e leggende di ragazzi strani : storie del passato per diventare maschi del presente
Alessandro Giammei
Mondadori, 2024
141 p. ; 22 cm
ISBN 9788856694567 : € 16,00
Salvador Dalì, il re biblico David, l’astronauta Ron McNair, Ruggiero dell’Orlando Furioso, il partigiano Ugo Forno, Spider-Man, Arthur Rimbaud, Ifi delle Metamorfosi di Ovidio, il rapper Sfera Ebbasta: nove personaggi scelti dall’autore per
esplicare altrettante peculiarità emblematiche dell’universo maschile.
Età: 12-14 HHHH
94 - Eravamo il suono
Matteo Corradini
Lapis, 2024
214 p. ; 20 cm
ISBN 9788878749658 : € 12,90
Dietro stimolo dell’insegnante due ragazze che stanno preparandosi per un concerto provano ad ascoltare da una conchiglia - e ci riesconole storie di 8 delle 56 musiciste prigioniere nel campo di Auschwitz che furono costrette dalle capo blocco ad allestire un’orchestra per dilettare gli ufficiali nazisti.
Età: 11-13 HHHH
95 - In viaggio con Isa : un’alpaca giornalista alla scoperta del mondo che cambia
Gianmarco Sicuro ; illustrazioni di Sara Ugolotti
Mondadori, 2025
157 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788804796305 : € 16,00
Un’alpaca di peluche, inseparabile dal suo umano, che è un giornalista inviato all’estero, lo accompagna e racconta con lui di Amazzonia, Ucraina e Palestina, fornendo anche tante informazioni sul suo delicato e impegnativo lavoro.
Età: 9-11 HHHH
96 - La lunga discesa : il graphic novel
Jason Reynolds ; illustrazioni di Danica Novgorodoff
Tunuè, 2024
208 p. : ill. ; 28 cm
(Prospero’s Book)
ISBN 9788867905232 : € 21,00
Will, adolescente nato e cresciuto nei sobborghi statunitensi, decide di vendicare la morte del fratello Shawn, ucciso da una banda rivale.
Età: 14-16 HHHH
97 - Il ragazzaccio
Angeliki Darlasi, Iris Samartzi ; traduzione di Tiziana Cavasino
Camelozampa, 2024
50 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9791254641811 : € 18,00
Un ragazzo povero che comincia rubacchiando per necessità e poi viene armato da una banda di giovani criminali trova un’occasione di profondo cambiamento quando rapina un maestro di musica che in cambio della pistola gli promette un violino, invitandolo a provare a suonare.
Età: 8-10 HHHHH
98 - L’abito non fa il lupo
Sid Sharp
Giralangolo, 2024
122 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788859290629 : € 17,50
Per non farsi sbranare nel bosco, dove ama raccogliere more, il montone Greg cuce un costume da lupo, travestimento con il quale riesce a ingannare un gruppettino di questi predatori senza affatto prevedere il colpo di scena che l’aspetta!
Età: 6-8 HHHHH
99 - La custode delle falene
K. O’Neill ; traduzione di Serena Tardioli
Il Castoro, 2024
257 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791255332480 : € 16,00
Per confortare lo spirito della luna che soffre di solitudine una comunità decide di vivere di notte ed è in questo contesto che Anya accetta la responsabilità di custodire le falene impollinan-
ti l’albero magico che dona benessere a tutte e tutti loro; ma star sempre da sola e la curiosità di scoprire com’è il giorno mettono a dura prova la ragazzina...
Età: 12-14
100 - È tutto una scintilla
HHHH
Lily Williams, Karen Schneemann ; traduzione di Maria Laura Capobianco
Il Castoro, 2024
325 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791255331735 : € 16,00
Nuove vicende quotidiane delle inseparabili amiche Brit, Christine, Abby e Sasha - che adesso frequentano la terza di un liceo statunitense - e in particolare il dilemma che scuote Christine: come trovare il coraggio di rivelare ad Abby che si è innamorata di lei?
Età: 12-14
HHHHH
101 - Mira : #viaggi, #Parigi, #mimanchi
Sabine Lemire e Rasmus Bregnhøi ; traduzione dal danese di Claudia Valeria
Letizia e di Eva Valvo Sinnos, 2024
99 p. : ill. ; 24 cm
Leggimi! Graphic
ISBN 9788876095863 : € 14,00
A Mira, che sta attraversando un periodo difficile ed è spesso nervosa e insofferente, all’improvviso muore l’adorata nonna materna, con la quale stava progettando un viaggetto a Parigi.
Età: 9-11
HHHH
102 - La prima volta di ogni cosa una storia vera di Dan Santat ; traduzione di Laura Tenorini
Il Castoro, 2024
308 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791255332329 : € 16,50
Nel 1989 il protagonista e autore Dan fece un viaggio in Europa con altre ragazze e ragazzi statunitensi e per tutte e tutti fu l’occasione di scoprire per la prima volta il mondo fuori dalle loro città e di vivere nuove emozioni formative e di crescita.
Età: 11-14
103 - Rumore
HHHH
scritto da Samuel Sattin ; disegnato da Rye Hickman ; traduzione di Omar Martini
Il Castoro, 2025
205 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9791255332855 : € 16,00
Ossessionato dai pensieri in forma di ronzii, Isaac, 12 anni, che soffre di disturbo ossessivo compulsivo, comincia a stare meglio da quando si unisce a un gruppo di coetanei partecipando con loro a un gioco di ruolo.
Età: 12-14
HHH
(Up)
ISBN 9788807910883 : € 15,00
La libertà di piangere, il rapporto con il proprio pene, il bullismo, l’alcol e le droghe, l’affettività e altri temi importanti per un ragazzo e per un uomo in un dialogo tra padre e figlio.
Età: 12-14 HHH
106 - Il magico potere del disordine
Einat Tsarfati ; traduzione di Maria Laura Capobianco
Il Castoro, 2024
215 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9791255332459 : € 18,00
Chi è veramente disordinato e chi invece pensa solo di esserlo? Tante osservazioni ironiche su come convivere con il proprio disordine insieme a consigli per fare un po’ d’ordine, ma solo in casi estremi e senza diventare ordinati per davvero.
Età: 14-99 HHHHH
107 - Crac
Matteo Pompili, Lorenzo Monaco, Luogo Comune
Camelozampa, 2024
[56] p. : ill. ; 31 cm
(Le sinapsi)
ISBN 9791254641835 : € 23,00
Le rotture sono spesso nuovi inizi: l’uovo che si schiude, la nascita, le stelle che si spezzano, montagne che si sono frantumate dando vita a nuove formazioni geologiche, idee innovative che distruggono quelle precedenti.
Età: 7-9 HHHH
108 - Nevario : le forme della neve
Sarah Zambello, Susy Zanella ; realizzato con la collaborazione del Centro Valanghe di Arabba Nomos, 2024
80 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9791259581914 : € 24,90
Polverosa, trasformata, crostosa: queste e altre tipologie di neve presentate ciascuna con le proprie caratteristiche, possibili manifestazioni e pratiche di misurazione e studio.
Età: 10-12 HHHHH
104 - Che cos’è l’antisemitismo?
Lia Levi
Piemme, 2024
171 p. ; 19 cm
ISBN 9788856698213 : € 14,00
Come mai gli ebrei non hanno riconosciuto in Gesù il Messia? e perché sono stati oggetto di così tanta avversione? Risposte a questi e a molti altri interrogativi sul popolo ebraico e sull’antisemitismo.
Età: 11-14
HHH
105 - Cose che ai maschi nessuno dice : baciare, fare, dire
Alberto Pellai
Feltrinelli, 2024
126 p. ; 23 cm
109 - The body confidence book : il libro del corpo e della fiducia in sé Philippa Diedrichs e Naomi Wilkinson ; traduzione di Laura Fontanella Settenove, 2024
159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9791281477032 : € 16,00
Cosa sono l’immagine e la fiducia corporee, come si può essere influenzati dai modelli estetici dominanti, come vivere con serenità il rapporto con il proprio corpo e trarne benessere in un libro rivolto prevalentemente agli e alle adolescenti.
Età: 11-14 HHHHH
110 - Bosco
Christie Matheson Emme, 2024 [44] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788829606153 : € 14,50
La variegata vegetazione del bosco e i molteplici
animali che la abitano, ciascuno con proprie peculiarità e proprie esigenze, descritti anche come invito alla tutela di questo specifico habitat.
Età: 4-6 HHH
111 - Brevi lezioni di meraviglia : elogio della natura per genitori e figli
Rachel Carson ; nota di Lella Costa ; illustrazioni di Elisa Talentino ; traduzione di Miriam Falconetti Aboca, 2024
64 p. : ill. ; 21 cm
(Aboca kids)
ISBN 9788855232715 : € 15,00
Il racconto delle esplorazioni lungo le coste del Maine dell’autrice con il nipotino diventa un’occasione esemplare di elargire spunti e consigli per innamorarsi della natura e insegnarne l’ammirazione ai bambini.
Età: 9-11 HHHH
112 - Digestario : gli apparati digerenti più affascinanti del regno animale
[Aina Bestard] Camelozampa, 2024
171 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9791254642085 : € 24,90
Spugna di mare, ape, barbagianni, squalo bianco, cavallo, leone, tragulo di Giava: analisi dettagliata dell’apparato digerente di questi e altri 63 animali.
Età: 10-12 HHHH
113 - Insectarium : il grande libro degli insetti
Emily Carter, Dave Goulson ; traduzione di Francesco Orsenigo Rizzoli, 2024
[100] p. : ill. ; 38 cm
ISBN 9788817188432 : € 27,00
Alla scoperta degli insetti, a partire dalle loro caratteristiche generali, la loro evoluzione e ampie sezioni con notizie specifiche raggruppate per famiglie e per habitat di diffusione.
Età: 9-11 HHHHH
114 - La vita segreta degli alberi
Laura Fraile, Rena Ortega
Aboca, 2025
[48] : ill. ; 33 cm (Aboca kids)
ISBN 9788855233149 : € 22,00
Di numerosissime specie di alberi vengono puntualmente descritte le principali peculiarità, relative a fusto, foglie, chiome, radici, fiori, frutti, habitat di appartenenza, ambiente circostante, sottosuolo e funzioni.
Età: 7-9 HHH
115 - Claude Monet : vedeva il mondo come un’esplosione di luce e colore
scritto da Amy Guglielmo ; illustrato da Ginnie Hsu Gribaudo, 2024 [56] p. : ill. ; 26 cm
(Lo sguardo dell’artista)
ISBN 9788858048900 : € 12,00
La vita personale ma soprattutto artistica di Claude Monet, dall’infanzia ai sacrifici iniziali, fino al successo, con la sua continua ricerca della rappresentazione della luce e della natura.
Età: 7-9
HHH
116 - Piccoli tesori : cerca-trova
Charlotte Klein Lapis, 2024 [24] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788878749870 : € 13,00
Orto, parco giochi, biblioteca, bosco, luna park, spiaggia, montagna, mercatino dell’usato, piscina, museo d’arte contemporanea: 10 scenari nei quali il lettore è invitato a individuare le 100 figure che ne vengono estrapolate, contrassegnate dai termini corrispondenti.
Età: 4-5
117 - Animali d’Egitto : un bestiario antichissimo
Martine Laffon, Magali Attiogbé Lapis, 2024
[48] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9791255190066 : € 18,00
HH
umani di 23 animali presenti nell’antico Egitto, con approfondimenti su come gli egizi li consideravano su un piano simbolico-religioso.
Età: 7-9 HHH
118 - L’antica Grecia : a fumetti
Dominique Joly, Emmanuel Olivier Lapis, 2024
47 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9791255190233 : € 15,90
Raccontata a fumetti la storia dell’antica Grecia: cultura, arte, religione, costumi sociali, organizzazione politica, diversificazione dei ruoli rivestiti da uomini e donne e altro ancora.
Età: 8-10 HH
119 - Regine
Olivia Godat, Rémi Giordano, Laura Pérez Lapis, 2024
45 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9791255190226 : € 17,00
Cleopatra, Andromaca, Wu Zetlan, Gunhild Kongemor, Caterina de’ Medici, Maria Antonietta d’Austria, Caterina II di Russia, Giuseppina di Beauharnais, Sissi, Elisabetta II: in varie forme descrittive informazioni e curiosità su queste 10 regine, presentate in ordine cronologico.
Età: 9-11 HHH
120 - Soldati romani
testi di Tegen Evans ; illustrazioni Tom Froese ; traduzione dall’inglese di Alessandro Barchiesi Lapis, 2024
25 p. : ill ; 30 cm
ISBN 9791255190028 : € 15,90
Numerose informazioni e curiosità sui soldati dell’antica Roma: chi erano, come si allenavano, le tecniche di combattimento, le armi in dotazione, le cure mediche quando erano feriti, gli accampamenti e molto altro.
Età: 8-9 HHH
Caratteristiche zoologiche e interazioni con gli
Il numero rimanda a quello della scheda
A casa 1
A volte arriva il buio 2
Abbassa la cresta 3
L’abito non fa il lupo 98
Ada e lo specchio magico 66
Un agente troppo segreto 59
Aiuto, sono finito nello smartphone! 48
L’amico inatteso 78
Ande Lande 61
Animali d’Egitto : un bestiario antichissimo 117
L’antica Grecia : a fumetti 118
La bambina con la grande mano verde 4
La bambina e l’orsa 55
Il barattolo dei desideri 80
Batti cuore 49
Bim bum bam 5
The body confidence book : il libro del corpo e della fiducia in sé 109
Bosco 110
Brava chiocciolina! 6
Brevi lezioni di meraviglia : elogio della natura per genitori e figli 111
Il bruco misuratutto 7
C’era una volta un coniglio gigante 8
Caccia alle uova 50
Un cappotto piccolo piccolo 51
Il caso Drilla 81
Che cos’è l’antisemitismo?
104
Cinque topolini 9
Claude Monet : vedeva il mondo come un’esplosione di luce e colore 115
Come crescere un mostro nell’armadio! 10
Come si fanno le caramelle magiche 11
Come un dente di leone 82
Come volpi in mezzo ai lupi 91
Con le mani posso : diciotto filastrocche per giocare con il corpo 52
Il Conte di Montecristo 92
Cosa fanno i sentimenti di notte? 12
Cose che ai maschi nessuno dice : baciare, fare, dire 105
Crac 107
Cronache e leggende di ragazzi strani : storie del passato per diventare maschi del presente 93
La custode delle falene 99
Decidi sempre tu! 13
Digestario : gli apparati digerenti più affascinanti del regno animale 112
I disobbedienti del mondo nuovo 62
Dolci magie. Apprendista pasticciera 67
Dolci magie. Nel regno del cioccolato 68
Dov’è Momo? In giro! 14
Dove sei, Randolph? 47
È tutto una scintilla 100
Einstein il pinguino 69
Era sirena 70
Eravamo il suono 94
La famiglia Gattoni 60
Fate : le storie e gli antichi miti 56
Felice abbastanza 83
I fiori di Carlo 15
La foresta che cresce 79
Il frutto rosso 16
La giacca rossa 17
La grande avventura e altre storie 18
Grigio 19
In nome di Chris 84
In viaggio con Isa : un’alpaca giornalista alla scoperta del mondo che cambia 95
Insectarium : il grande libro degli insetti 113
Irma la strega 71
La ragazza che perse il leopardo 72
Il ladro di neve 20
Lark. Il volo dell’allodola 85
Lumpi Lumpi. Capricci e pasticci 73
La lunga discesa : il graphic novel 96
La maestra è tornata! 21
Il magico potere del disordine 106
La merenda 22
Le mini fiabe box 4 57
Il mio amico Percy e Buffalo Bill 86
Mira : #viaggi, #Parigi, #mimanchi 101
Le mirabolanti avventure di Élisabeth a Parigi 87
Il mostro mangiapantofole 74
Nanà è arrabbiata 23
Nanà ha paura 24
Nevario : le forme della neve 108
Ogni volta che parti 53
Ora ti prendo 25
L’orco del piano di sotto 26
Ossa che cantano : immagini ispirate alle fiabe dei fratelli Grimm 58
Ovunque 27
I pantaloni di Luisa 28
Penny dal cuore grande 75
Petrademone : la saga completa 63
Piccoli tesori : cerca-trova 116
La prima volta di ogni cosa 102
Questo è molto strano... 29
Il ragazzaccio 97
Redwall 64
Il regalo delle fate formiche 30
Regine 119
Rumore 103
Saltafossi 31
Salto mortale 88
Salverò la principessa! 54
La scuola 89
Se non ci sei tu 32
Un sogno per Piccolo Orso 33
Soldati romani 120
Splendide creature 34
La storia vera 35
Storie di paura 36
La strada che ci porta a casa 76
Ti leggerò una storia 37
I Tillerman 77
I topi ballano 38
Troppo tardi 39
Tutino con la terra 40
Tutino nella neve 41
Tutti zitti, per piacere! 42
L’unica via d’uscita 90
Il vento 43
Villa Zombie 65
La vita segreta degli alberi 114
Voglio andare senza rotelle! 44
Vola! 45
Zucca, Osso e Pelliccia. Straccio è giù di corda 46
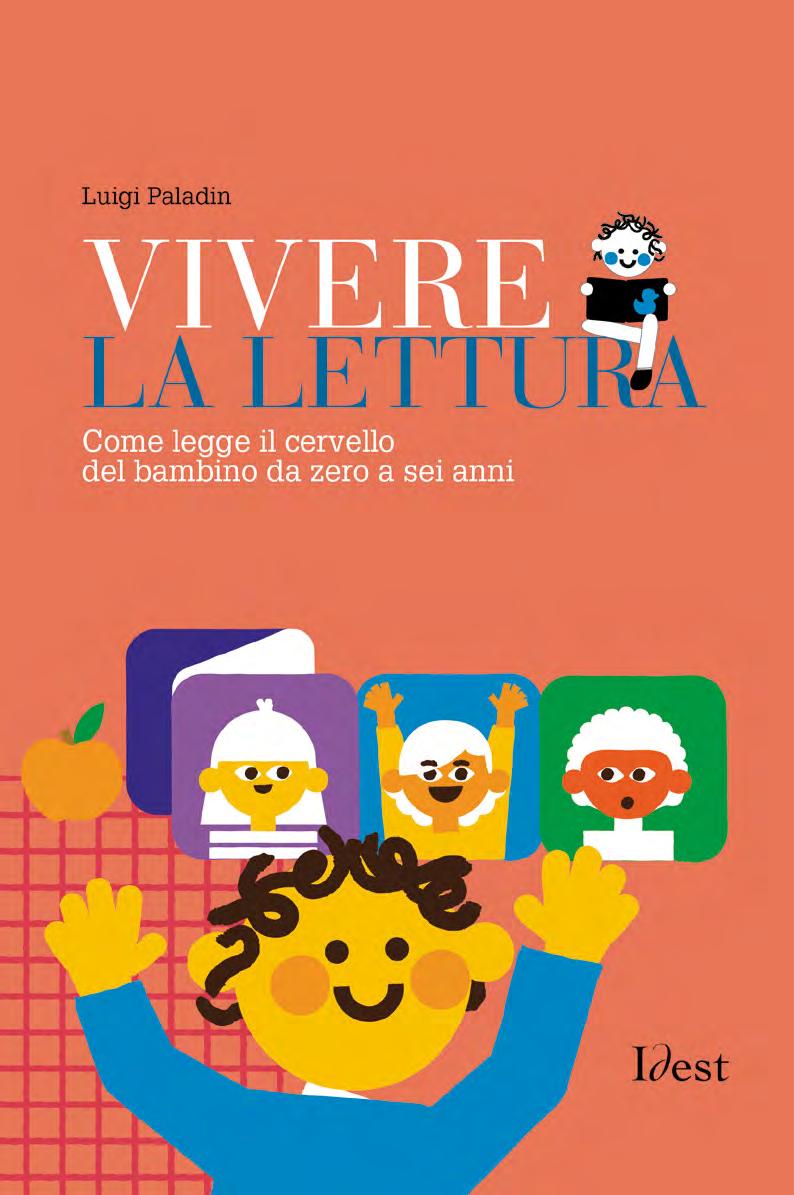
Il saggio raccoglie riflessioni, riscontri e approfondimenti per comprendere come lavora il cervello del bambino, allo scopo di facilitare una sua lettura attiva e partecipata utilizzando le grandi risorse che i libri contengono e propongono.
Luigi Paladin. Psicologo, bibliotecario, saggista, esperto in libri e lettura per l’infanzia. Docente presso l’Università Cattolica e l’Università Statale di Brescia, ha coordinato e insegnato per molti anni nei Corsi per bibliotecari della Scuola IAL-Lombardia. Attivo divulgatore con interventi di formazione e aggiornamento. La passione e lo studio sulla produzione di libri per l’infanzia si riflettono nella sua raccolta storica, costituita da oltre ventimila libri.
Il mondo del libro per bambini e ragazzi a portata di mano

Se sei entrato in possesso della rivista puoi trovare qui l’informativa aggiornata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 relativa al trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 La informiamo di quanto segue.
1. Il Titolare del trattamento è la Idest srl, Via di Limite 15, 50013 Campi Bisenzio (di seguito anche il “Titolare”). I Suoi dati personali da Lei forniti, verranno trattati dal Titolare stesso per le finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività svolta dal Titolare del trattamento e quindi per dare esecuzione alle prestazioni contrattualmente convenute, adempiere a obblighi di natura contabile e amministrativa, adempiere a tutti gli obblighi di legge posti a carico del Titolare del trattamento. Saranno inoltre effettuate dal Titolare, in relazione alle suddette finalità, attività di carattere statistico in forma aggregata anonima.
2. Il trattamento verrà effettuato nel rispetto dei principi di liceità, limitazione, esattezza, integrità e riservatezza disposti dall’art. 5 del GDPR e dalle altre norme vigenti in materia. Tutti i dati saranno trattati con correttezza e trasparenza, sia manualmente, sia con strumenti elettronici e informatici; saranno inseriti in appositi archivi cartacei e/o informatici, o in ogni altro tipo di supporto adeguato, e tenuti sotto costante controllo con procedure e misure di sicurezza adeguate, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016, a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
LA RIVISTA LIBER
Editore Fondazione Accademia dei Perseveranti
Abbonamento annuale a 4 numeri:
Italia: € 50,00 - Estero: € 72,00
LiBeR in versione digitale
I singoli fascicoli in pdf nei principali store a € 4,99
LIBER DATABASE
Abbonamenti
- accesso singolo: € 115,00 + iva 22%
- accessi multipli:
- da 2 a 5 accessi sconto 10%
- da 6 a 10 accessi sconto 15%
- da 10 a 20 copie sconto 20%
- ulteriori sconti oltre i 20 abbonamenti
BONUS DOCENTI
Tutti gli insegnanti possono utilizzare il bonus docenti per acquistare LiBeR, LiBeR Database e le pubblicazioni di Idest per l’aggiornamento professionale
A www.liberweb.it
PER ABBONARSI
- http://www.liberweb.it
- email: sbenelli@idest.net
Pagamento intestato a Fondazione Accademia dei Perseveranti tramite:
- bollettino di c/c postale n. 15192503
- bonifico: IBAN - IT15P0760102800000015192503
A Attiva l’abbonamento in LiBeRWEB
A Acquista LiBeR in versione digitale nei principali store
Visita il portale di LiBeR e iscriviti a LiBeRWEB News per ricevere gratuitamente la newsletter A www.liberweb.it

Promosso dal Comune di Campi Bisenzio
Socio International Board on Books for Young People Italia

Membro del comitato promotore del Premio Nazionale Nati per leggere
LiBeR è una rivista riconosciuta dalle associazioni pedagogiche per le valutazioni nazionali della ricerca
personali, al fine di prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
3. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali di cui al punto 2 è rappresentata dallo specifico rapporto contrattuale instaurato e dall’adempimento agli obblighi di legge a esso connessi. Il trattamento dei dati da lei forniti è necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale citato del quale lei è parte. Il consenso si intende prestato mediante il pagamento relativo all’abbonamento o all’acquisto della pubblicazione. L’eventuale mancato consenso al trattamento comporta l’impossibilità di procedere alla esecuzione della fornitura.
4. Il trattamento dei dati personali da Lei forniti potrà essere effettuato, oltre che da personale interno del Titolare espressamente autorizzato, da società, enti o consorzi, nonché consulenti e professionisti nominati responsabili esterni del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato, che, per conto del Titolare, forniscono specifici servizi organizzativi o elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto al Titolare nell’ambito delle attività di cui sopra. L’elenco delle persone autorizzate e dei responsabili esterni è reperibile presso il Titolare del trattamento.
5. I dati personali di cui sopra potranno essere comunicati a soggetti ai quali la facoltà di accedere a tali dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. I Suoi dati personali potranno inoltre essere diffusi soltanto in base a quanto
richiesto da espressi adempimenti di legge. 6. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra indicate e, dunque, per il tempo necessario all’esecuzione del contratto, comunque nel limite di dieci anni stabilito dalle norme del Codice Civile in materia
7. Il GDPR riconosce all’ interessato una serie di diritti previsti dagli articoli da 15 a 22, tra i quali l’accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
8. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
I riferimenti di contatto del Titolare sono i seguenti: Fondazione Accademia dei Perseveranti - Piazza Dante, 23 50013 Campi Bisenzio (FI) Tel. 055 8979403 liberweb@ idest.net.
I riferimenti di contatto del Responsabile per la protezione dei dati designato dal Titolare sono i seguenti: Fondazione Accademia dei Perseveranti - Piazza Dante, 23 50013 Campi Bisenzio (FI) Tel. 055 8979403 liberweb@ idest.net
62A EDIZIONE
31 MARZO
3 APRILE 2025 BOLOGNA

PER UN FUTURO MIGLIORE
MOSTRA DI 150 TITOLI ECCELLENTI
DA TUTTO IL MONDO
SYDNEY SMITH
MOSTRA PERSONALE
DEL VINCITORE DELL’ HANS
CHRISTIAN ANDERSEN AWARD 2024
JELLA LEPMAN
I LIBRI COME PONTI
MOSTRA CREATA DA IBBY ITALIA
PER IBBY WORLD CONGRESS 2024
I DIRITTI DEL BAMBINO
LETTURA CORALE IN 42 LINGUE
CON ARTISTI, AUTORI, EDITORI
INSIEME PER LA PACE NEL MONDO









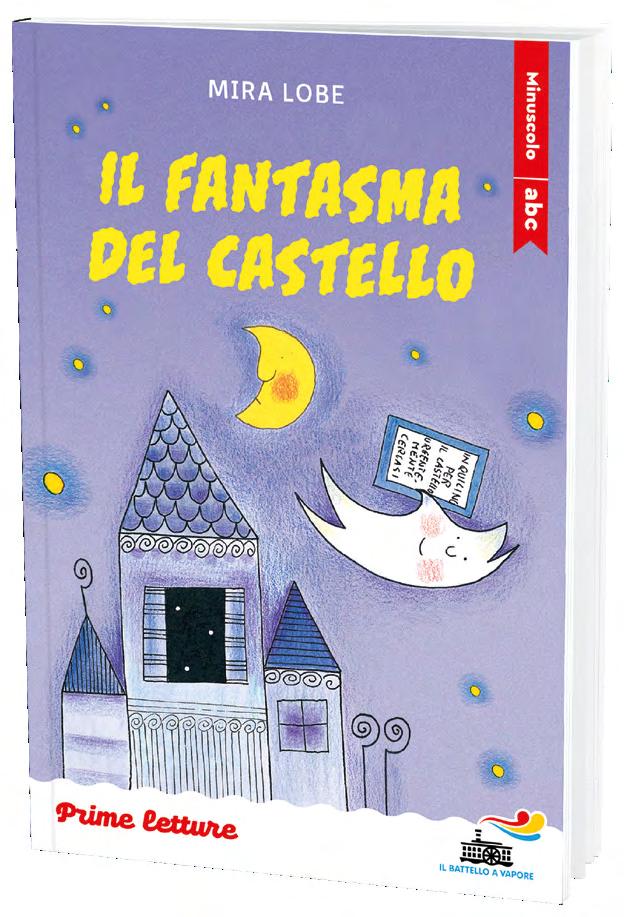
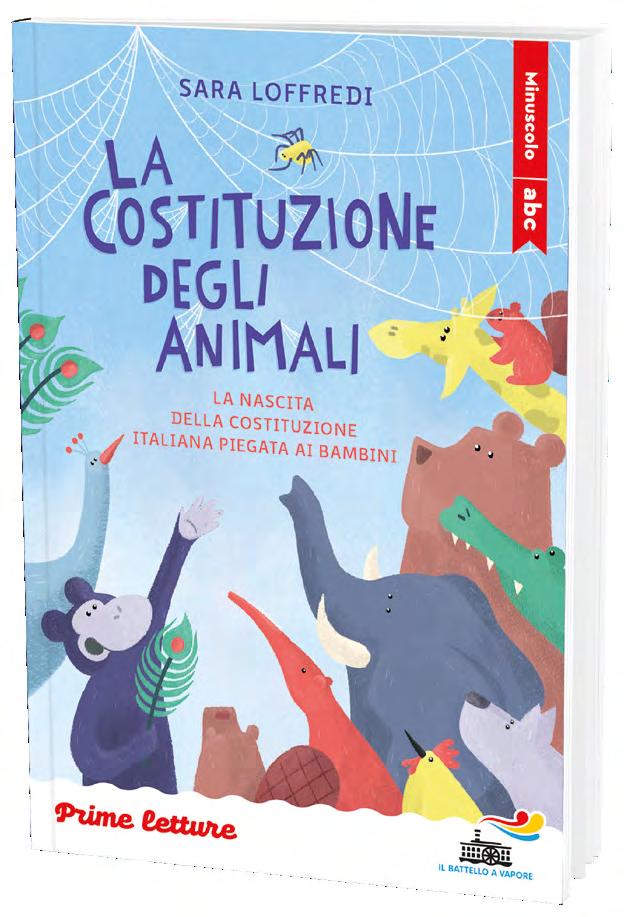


Con PRIME LETTURE , leggere diventa un’esperienza entusiasmante e senza barriere! Storie ILLUSTRATE , testi in MAIUSCOLO e MINUSCOLO, font a LEGGIBILITÀ
FACILITATA e un focus sulle PAROLE PIÙ DIFFICILI aiutano i primi lettori ad ampliare il loro VOCABOLARIO e scoprire il piacere della lettura!
