

MovieScapes 2024 - Concept e mission
La prima edizione di MovieScapes è stata promossa dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere nell'ambito delle proposte di Valorizzazione della Conoscenza per l'anno 2024
CONCEPT – Il paesaggio è da sempre uno dei temi più rappresentati dal cinema. È verso di esso che si rivolge in primo luogo l’occhio della macchina da presa. I luoghi percepiti, abitati, attraversati, vissuti diventano spesso un vero e proprio personaggio, quando non la chiave di volta dell’intero film. Quando poi la questione dell’appropriazione simbolica, materiale e funzionale del genere umano sull’ambiente, del suo impatto in termini di sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell’agire umano nel mondo, delle sue connessioni e interdipendenze transcalari diventano una preoccupazione forte della produzione discorsiva e culturale, esercitare uno sguardo consapevole sul paesaggio e sulle sue rappresentazioni diventa ancora più urgente.
MISSION – MovieScapes è un invito alla collettività: per riflettere su temi di stringente attualità legati al paesaggio attraverso una doppia rassegna di film - OPEN e FOCUS - introdotti e commentati da docenti del PhD in Landscape Studies for Global and Local Challenges, in dialogo con studiosi, esperti e professionisti del territorio. È anche un invito alla comunità accademica: per aprirsi al dialogo con il territorio, tramite l’occasione offerta dal cinema quale strumento immaginativo, estetico e critico utile a riflettere sul presente, sulle sue sfide e sulle sue interdipendenze.
MovieScapes 2024 - in tre parole
PAESAGGIO – patrimonio dell’umanità, luogo di sfide globali e locali, di interdipendenze tra territori e comunità; oggetto di progettazione, rigenerazione, valorizzazione, turismo, transizione ecologica; di immaginari cartografici, transmediali e digitali, di narrazioni e contro-narrazioni: il paesaggio è scenario dell’abitare e delle relazioni tra esseri umani e non umani nel sistema-mondo
DIALOGO – un dialogo a più voci, e fra generazioni e professionalità diverse, su tematiche rilevanti, sulla complessità dell’oggi, sulla necessità di riflessioni e azioni nel presente
SFIDE DELLA SOSTENIBILITA’
- Per condividere il più possibile le nostre linee di ricerca, favorendo una riflessione collettiva a partire da film recenti che hanno saputo interrogare il presente mettendo a tema questioni aperte e complesse sul paesaggio
I temi della prima edizione
• La mediatizzazione del paesaggio e la sua rappresentazione
• La narrazione di spazi e paesaggi periferici, marginali, lontani o non-canonici
• Simboli, pratiche e forme dell’abitare
• La città come spazio dell’immaginario, dell’interdipendenza, del conflitto
• Il rapporto fra paesaggio, ambiente e sostenibilità anche alla luce della condizione di crisi ecologica, politica ed economica contemporanea
• Il cinema animato come luogo di sperimentazione di forme e linguaggi transgenerazionali
… e molti altri ancora
MovieScapes 2024 – La parola a dottorande/i in Landscape Studies for Global and Local Challenges
A cura di Lorenzo Amato, Damiano Canella, Elena Canovo, Jacopo Daldossi, Daniela Desperati, Michele Galella, Matteo Locatelli, Elio Moschini, Gregorio Pezzoli, Roberta Valsecchi


Jacopo Daldossi / Wall-E - Parole in chiaro
• Insostenibilità – il film si concentra sull’insostenibilità dello stile di vita adottato dagli umani, che ha portato il pianeta terra a spopolarsi lasciando spazio solo a rifiuti che il robot Wall-E prova a «smaltire» creando interi edifici. Il pianeta non presenta forme di vita al di fuori di un piccolo insetto che segue Wall-E durante i suoi spostamenti. Il paesaggio rappresentato è arido, insalubre e di fatto sterile e che richiama l’abbandono
• Distopia – Nel mondo di Wall-E, una grande azienda chiamata Buy-N-Large (BnL) ha avuto un ruolo centrale nell'espansione incontrollata del consumismo. Questa azienda ha monopolizzato ogni aspetto della vita umana, portando alla saturazione del pianeta con prodotti e rifiuti. In una distopia, è comune che una forza economica o politica centralizzata causi il collasso della società, e in questo caso la BnL rappresenta un simbolo di tale potere.
• Speranza - Nonostante il tono distopico, il film offre un messaggio di speranza. Wall-E, un semplice robot, diventa il simbolo del cambiamento e della resilienza, dimostrando che anche in una situazione apparentemente senza speranza è possibile ricostruire e rimediare agli errori del passato. Questo contrasto tra il degrado distopico e la possibilità di redenzione lo rende particolarmente potente.
• Cormac McCarthy, La strada, 2006
• Ray Bradbury, Fahrenheit 451, 1953
• George Orwell, 1984, 1949
Jacopo Daldossi / Wall-E - Diario di bordo
Dopo la visione del film sono emersi diversi spunti che hanno generato una discussione e hanno fatto sì che emergessero altri concetti chiave come la disumanizzazione e il controllo da parte delle macchine, tema ricorrente per chi vive sul nuovo pianeta dove gli umani sono completamente assoggettati da dispositivi elettronici che assecondano ogni loro movimento. Per questo motivo, gli umani sono tutti sovrappeso, risultato di un totale scollegamento dalla natura. Un altro aspetto importante del film è la totale dipendenza degli umani nei confronti degli schermi. Alcuni abitanti di questo «nuovo mondo» non si erano mai accorti della presenza delle aree esterne con spiagge attrezzati, perché perennemente «guidati» da input elettronici. Fortissimo il concetto di degrado ambientale come risultato di una totale disattenzione verso la cura del pianeta, che si manifesta anche nella totale perdita di conoscenza degli elementi naturali. Questa perdita di «know how» fa riflettere su tema dello spopolamento delle aree interne, con conseguenti perdite di saperi che hanno modellato il paesaggio nei secoli e che oggi rischiano una rapida scomparsa. In generale, il film ha proposto un finale speranzoso nel quale gli umani decidono di riprendersi la terra, curandola e rigenerandola, ripartendo da azioni primordiali quali la piantumazione di specie vegetali, abbandonando le super tecnologie che avevano a disposizione e passando da una società iper-consumistica ad una più rispettosa dell’ambiente e dedita alla condivisone e alla cura degli spazi.



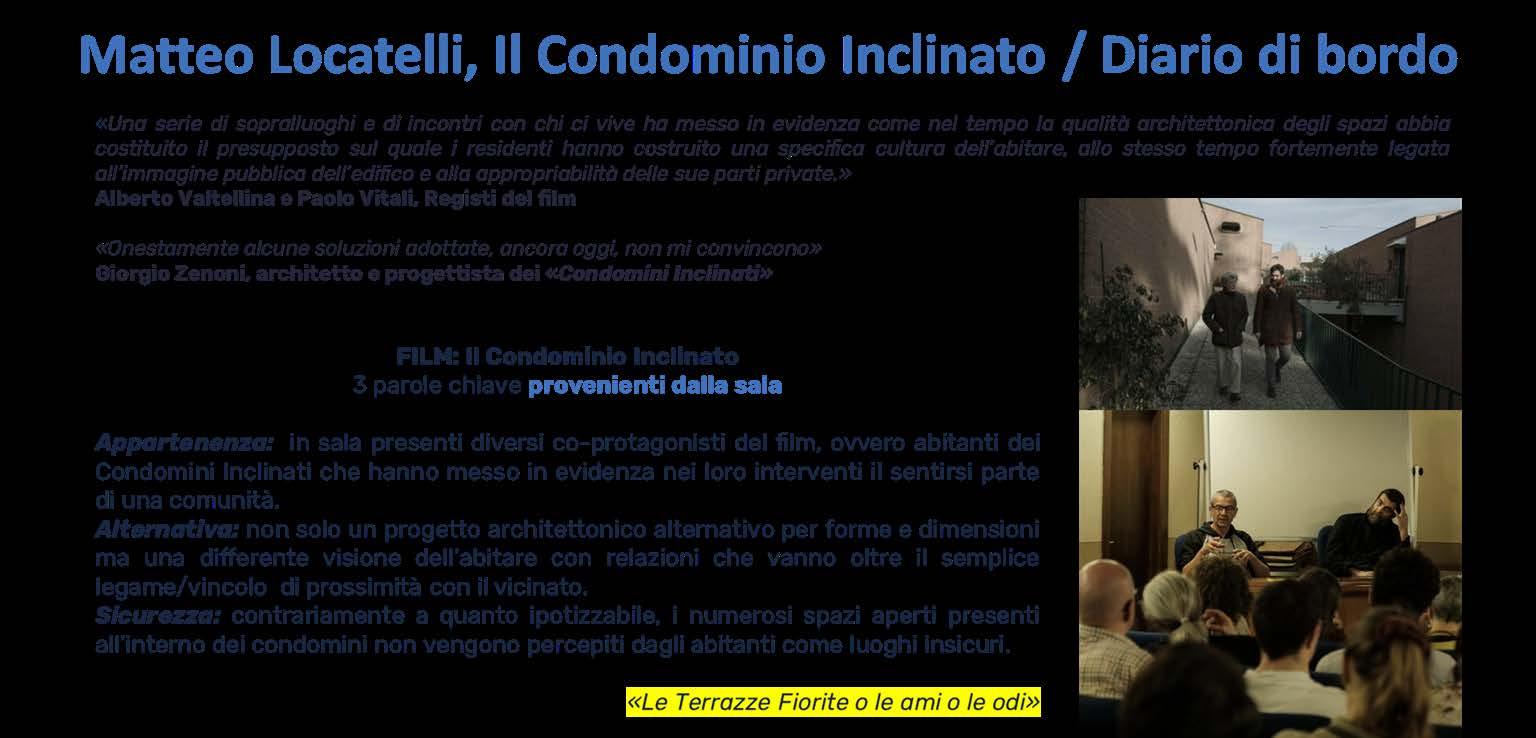


Daniela Desperati / Midnight in Paris - Parole in chiaro
SIGNIFICATI: Geografia – Semiotica. Il paesaggio come sistema di segni che si rifanno a un immaginario culturale. Sono gli iconemi, ovvero le unità di significato che permettono di interpretare quel che vediamo, sono espressione dei saperi territoriali che ci legano a un luogo. Sono i concetti chiave per la lettura del paesaggio. Nella scena iniziale la bella carrellata di iconemi parigini ci permette di “leggere” la città attraverso le diverse stratificazioni che nel tempo l’hanno plasmata: la città è cambiata pur senza cambiare mai, ma per notarlo è necessaria una adeguata "sensibilità a vedere", che nel film è posseduta da Gil e Adriana, sognatori e flâneur, mentre resta qualcosa di incomprensibile per la fidanzata Inez.
Bibliografia: Eugenio Turri, Il paesaggio come teatro, Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio Editore
SGUARDI: Antropologia – Parigi come espressione di molteplici identità. Il paesaggio è anche un concetto identitario: in quanto “forma visiva del territorio”, si configura in funzione dello sguardo del singolo e della collettività, che osserva, vive e interpreta. Abbiamo diversi punti di osservazione del paesaggio parigino: chi guarda il film, chi viaggia nel tempo e nello spazio. Ogni salto temporale produce una nuova lettura, a dimostrare che nello stesso luogo possiamo abitare, transitare, ospitare, osservare e essere oggetto di molteplici osservazioni.
Bibliografia: Clifford James, Ritorni. Diventare indigeni nel XXI secolo, Meltemi Editore, 2023
ARCIPELAGHI: Etnografia e ricerca sociale – L’insularità di alcuni luoghi, o momenti, in relazione con una dimensione globale, è un concetto di grande attualità. Gli Island Studies si concentrano sulla dimensione di vulnerabilità e al contempo di resilienza che le isole e le piccole comunità situate in aree remote dimostrano nei confronti delle sfide globali, rendendo indispensabile un approccio di tipo multidisciplinare. Ogni passaggio spazio-temporale apre una finestra su un mondo e una realtà altri, che esistono e hanno senso non in quanto luoghi remoti, lontani tra loro e separate dall’oceano ma connesse in una sorta di grande arcipelago. Ogni volta che approdiamo su una di queste “isole” - la Parigi degli anni 20, il Moulin Rouge della Belle époque, il caffè dell’Assenzio di Degas o la corte di Versailles - riusciamo a comprenderle e a viverle solo in relazione alla loro appartenenza a una dimensione globale, ovvero la Storia di Parigi, e quindi alla relazione che la lega e la connette con tutte le altre.
Bibliografia: Andri Snær Magnason, Il tempo e l’acqua, Iperborea, 2020
Daniela Desperati / Midnight in Paris - Diario di bordo
VIAGGIO - Il viaggio nel tempo, con tutti i salti, le considerazioni, le contraddizioni tra immaginazione e realtà, si configura ogni volta come una sorta di fuga dal presente e dalla realtà di ciascun personaggio alla ricerca di qualcosa. L’artista, la scrittrice, lo scrittore, la musa, non riescono più a trovare la propria ispirazione nel loro tempo, e si illudono di poterla trovare altrove, ovvero in un passato idealizzato.
NOSTALGIA - Il film è un viaggio all’insegna della nostalgia, non nel senso etimologico del termine - dal gr.
“nostos”, «ritorno» e -algia «dolore» - ma verso per qualcosa di cui le persone hanno un’esperienza solo “immaginaria”, e idealizzata, fortemente influenzata da letteratura, storia, arte, ecc. Tutti loro aspirano a un ritorno verso qualcosa che non c’è più, ma che non hanno mai vissuto, convinti che si possa in qualche modo, così, colmare il divario e l’insofferenza che provano rispetto al loro presente.
PASSEGGIATA - E’ la Parigi “a misura d’uomo”, percorribile a piedi. Il tema della passeggiata baudeleriana e benjaminiana, intesa come “vagabondare urbano” che permette di immergersi totalmente nella città, di entrare in simbiosi con essa e leggerne le trasformazioni, in un continuo dialogo che, per il poeta e l’artista, porterà all’ispirazione.


Gregorio Pezzoli / La grande bellezza -
Parole in chiaro
Paesaggio incompleto - Roma, la città in cui è ambientato il film, è mostrata tramite frammenti. Mentre il protagonista – Jep Gambardella – ne attraversa i paesaggi urbani, si percepisce però l’assenza di una dimensione fondamentale, quella sociale. Le persone, il traffico, i turisti, gli abitanti; nessuno di questi elementi viene rappresentato, rendendo quello mostrato dal film un paesaggio incompleto.
Arte - tutto il film ne è fortemente impregnato. All’arte classica e a quella architettonica si aggiungono varie manifestazioni d’arte contemporanea, spesso sottoforma di performance. Nonostante quest’abbondanza, l’unico momento in cui Jep si commuove è di fronte a centinaia di foto, autoscatti giornalieri dell’artista nel corso della sua vita: segnale dell’inesorabile scorrere del tempo.
Dal profano al sacro - il film è caratterizzato da un’alternanza tra situazioni ‘profane' e altre più sacrali. Questa alternanza è presente sia tra una scena e l’altra – il baciamano alla Santa viene immediatamente seguito dal selfie con la Santa – ma è altresì evidente lungo l’intero film, con la componente di mondanità che va scemando in favore di sacralità e introspezione, fino alla scena conclusiva dove Jep rivive il ricordo del suo primo, e forse unico, amore.
Secchi B, La città dei ricchi e la città dei poveri. Urbino: Laterza, 2013.
Cellamare C, Città fai-da-te: Tra antagonismo e cittadinanza. Storie di autorganizzazione urbana. Roma: Donzelli, 2019
Gregorio Pezzoli / La grande bellezzaDiario di bordo
Ossessione - dal secondo dopoguerra, la cinematografia italiana è stata ossessionata dalla città di Roma. Da ‘Roma Città Aperta’ a ‘La Dolce Vita’, questa città ha esercitato un fascino costante su registi e sceneggiatori, in particolare grazie all’incredibilmente ricca storia culturale, politica e artistica della città.
Assenza di trama - il film è caratterizzato dall’assenza di una trama tradizionale. La struttura è episodica, permettendo di soffermarsi sulla bellezza visiva e sul simbolismo. Questa assenza permette inoltre di dare spazio a un’esplorazione più profonda dei personaggi, delle loro psicologie e dei loro stili di vita.
Proustiano - il film cerca di evocare un mondo di sensazioni nostalgiche e delicate, introspettive.
Temi centrali sono il tempo, la memoria, la decadenza e la ricerca del senso profondo della vita. Il protagonista compie un viaggio attraverso i ricordi della giovinezza, interrogandosi sulla propria eredità artistica e sull’essenza della 'grande bellezza’. Inoltre, la bellezza è ambigua: esiste ovunque, ma spesso svuotata di significato. Jep si muove in questa contraddizione, alla ricerca dell’autenticità all’interno di un mondo di apparenze.

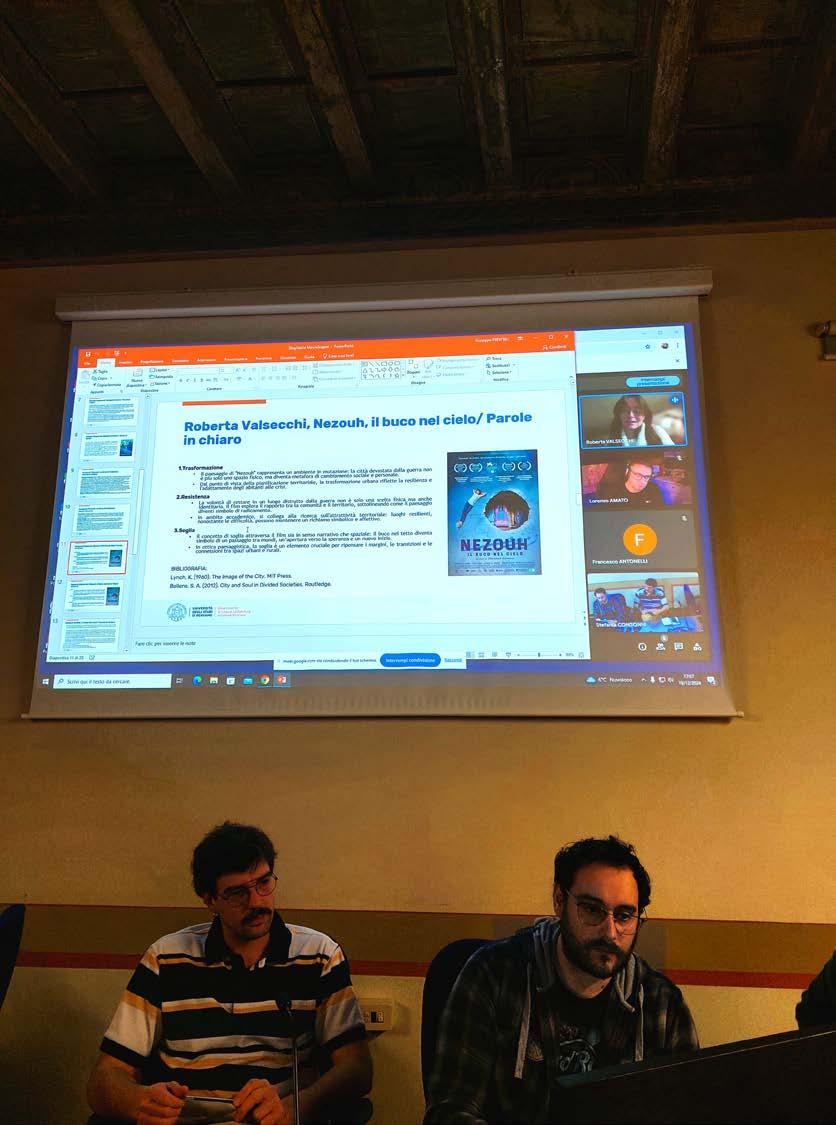
Roberta Valsecchi / Nezouh, il buco nel cielo -
Parole in chiaro
1. Trasformazione
▪ Il paesaggio di "Nezouh" rappresenta un ambiente in mutazione: la città devastata dalla guerra non è più solo uno spazio fisico, ma diventa metafora di cambiamento sociale e personale.
▪ Dal punto di vista della pianificazione territoriale, la trasformazione urbana riflette la resilienza e l'adattamento degli abitanti alle crisi.
2. Resistenza
▪ La volontà di restare in un luogo distrutto dalla guerra non è solo una scelta fisica ma anche identitaria. Il film esplora il rapporto tra la comunità e il territorio, sottolineando come il paesaggio diventi simbolo di radicamento.
▪ In ambito accademico, si collega alla ricerca sull'attrattività territoriale: luoghi resilienti, nonostante le difficoltà, possono mantenere un richiamo simbolico e affettivo.
3. Soglia
▪ Il concetto di soglia attraversa il film sia in senso narrativo che spaziale: il buco nel tetto diventa simbolo di un passaggio tra mondi, un’apertura verso la speranza e un nuovo inizio.
▪ In ottica paesaggistica, la soglia è un elemento cruciale per ripensare i margini, le transizioni e le connessioni tra spazi urbani e rurali.
Lynch, K. (1960). The Image of the City. MIT Press.
Bollens, S. A. (2012). City and Soul in Divided Societies. Routledge.

Roberta Valsecchi / Nezouh, il buco nel cielo -
Diario di bordo
1. Ruoli
▪ Il film evidenzia il cambiamento nei ruoli tradizionali di genere causato dalla guerra: la donna assume una posizione di guida morale e resilienza, mentre l'uomo spesso appare vulnerabile o escluso.
▪ La discussione ha sottolineato come questo riflesso delle dinamiche urbane e sociali rappresenti un'evoluzione della relazione tra individui e paesaggio, dove la narrazione cinematografica riscrive il rapporto uomo-donna in chiave simbolica.
2. Ricorrenza
▪ La distruzione fisica della città in "Nezouh" ricorda altre guerre e contesti urbani devastati. Durante la discussione è stato evidenziato il potenziale del cinema per creare una memoria collettiva visiva che collega luoghi e tragedie, rafforzando l'identità culturale globale.
▪ Si è discusso di come tali immagini possano ispirare progetti di recupero e valorizzazione dei luoghi distrutti.
3. Relazione
▪ Il film mostra come la crisi favorisca la nascita di nuove relazioni, indispensabili per la sopravvivenza. I luoghi in rovina diventano spazi di aggregazione e solidarietà, ridefinendo il concetto di comunità.
▪ Questo apre una riflessione sulla pianificazione partecipativa dei territori e sull'importanza delle reti sociali per la rigenerazione urbana.

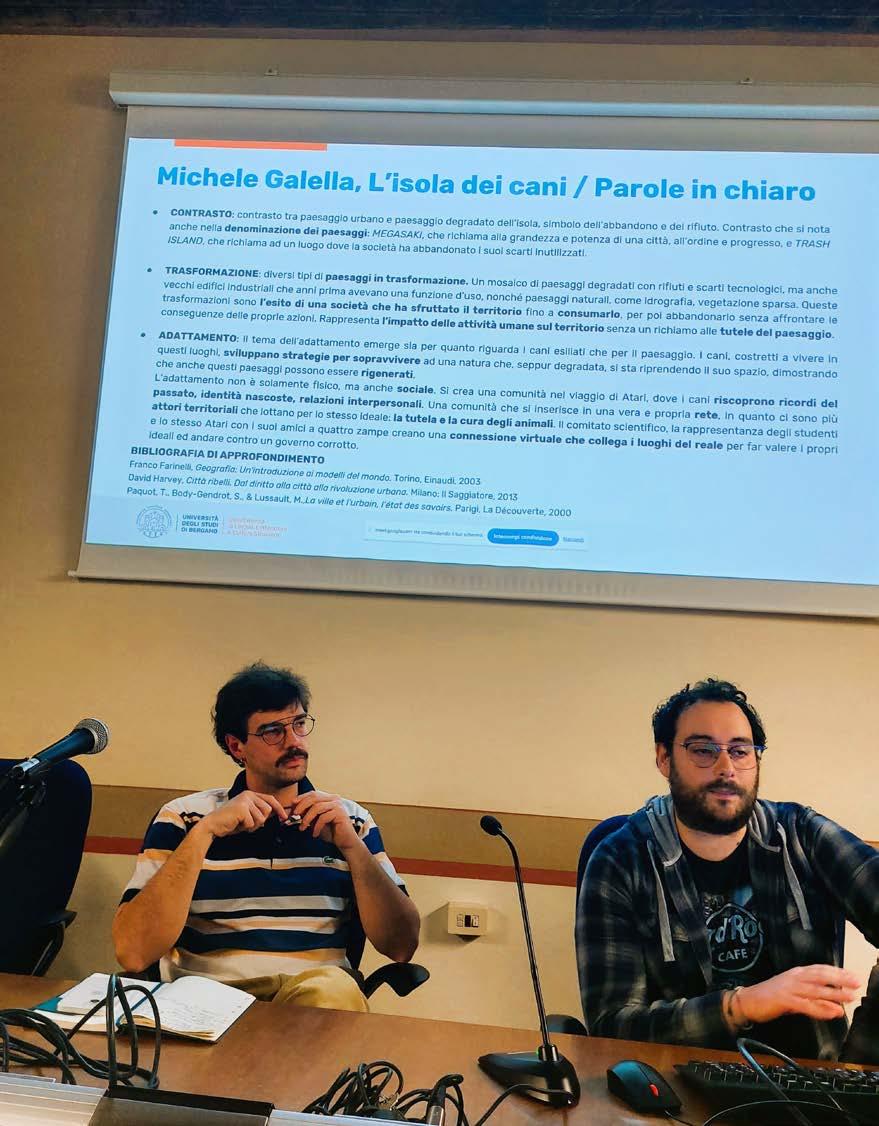
Michele Galella / L’isola dei cani - Parole in chiaro
● CONTRASTO: contrasto tra paesaggio urbano e paesaggio degradato dell’isola, simbolo dell’abbandono e del rifiuto. Contrasto che si nota anche nella denominazione dei paesaggi: MEGASAKI, che richiama alla grandezza e potenza di una città, all’ordine e progresso, e
TRASH ISLAND, che richiama ad un luogo dove la società ha abbandonato i suoi scarti inutilizzati.
● TRASFORMAZIONE: diversi tipi di paesaggi in trasformazione. Un mosaico di paesaggi degradati con rifiuti e scarti tecnologici, ma anche vecchi edifici industriali che anni prima avevano una funzione d’uso, nonché paesaggi naturali, come idrografia, vegetazione sparsa. Queste trasformazioni sono l’esito di una società che ha sfruttato il territorio fino a consumarlo, per poi abbandonarlo senza affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Rappresenta l’impatto delle attività umane sul territorio senza un richiamo alle tutele del paesaggio.
● ADATTAMENTO: il tema dell’adattamento emerge sia per quanto riguarda i cani esiliati che per il paesaggio. I cani, costretti a vivere in questi luoghi, sviluppano strategie per sopravvivere ad una natura che, seppur degradata, si sta riprendendo il suo spazio, dimostrando che anche questi paesaggi possono essere rigenerati. L’adattamento non è solamente fisico, ma anche sociale. Si crea una comunità nel viaggio di Atari, dove i cani riscoprono ricordi del passato, identità nascoste, relazioni interpersonali. Una comunità che si inserisce in una vera e propria rete, in quanto ci sono più attori territoriali che lottano per lo stesso ideale: la tutela e la cura degli animali. Il comitato scientifico, la rappresentanza degli studenti e lo stesso Atari con i suoi amici a quattro zampe creano una connessione virtuale che collega i luoghi del reale per far valere i propri ideali ed andare contro un governo corrotto.
Franco Farinelli, Geografia: Un'introduzione ai modelli del mondo. Torino, Einaudi, 2003
David Harvey, Città ribelli. Dal diritto alla città alla rivoluzione urbana. Milano: Il Saggiatore, 2013
Paquot, T., Body-Gendrot, S., & Lussault, M.,La ville et l’urbain, l’état des savoirs. Parigi, La Découverte, 2000
Michele Galella / L’isola dei cani - Diario di bordo
● INTEGRAZIONE - elementi culturali diversi vengono combinati e armonizzati; tradizioni culturali giapponesi (estetica teatrale kabuki, poetica, calligrafia) si mescolano con influenze occidentali (tecnica dello stop motion, dialoghi in inglese, riferimenti alla cultura pop). La coesistenza di lingue diverse – giapponese per gli umani e inglese per i cani – sottolinea una barriera culturale e comunicativa, ma allo stesso tempo invita a trovare modi universali di comprensione, nel tentativo di mettere in dialogo tradizioni e sensibilità. Rappresenta quindi un esempio di integrazione culturale.
● IDENTITÀ - si esplora il tema dell’identità culturale e personale – sia nei cani che nelle persone – dove il viaggio fisico rappresenta anche un viaggio verso la definizione di sé stessi. Il cane protagonista Chief, che all’inizio si identifica come un reietto rabbioso, dopo la relazione con Atari (il ragazzino protagonista), riscopre un lato affettivo e protettivo. Quindi si costruisce la propria identità grazie alle esperienze vissute.
● COINVOLGIMENTO - Il film, con la sua estetica visiva e il tono emotivo, lascia una sensazione di profondità per lo spettatore. Invita a riflettere su temi ecologici e sull’importanza di prendersi cura degli animali. Sottolinea il potere della collaborazione come motore di trasformazione, resistenza e salvezza, che si concretizza nella riconciliazione tra umani e cani. Lo spettatore viene quindi coinvolto in un sentimento di empatia nei confronti degli animali e delle loro lotte per ottenere giustizia.

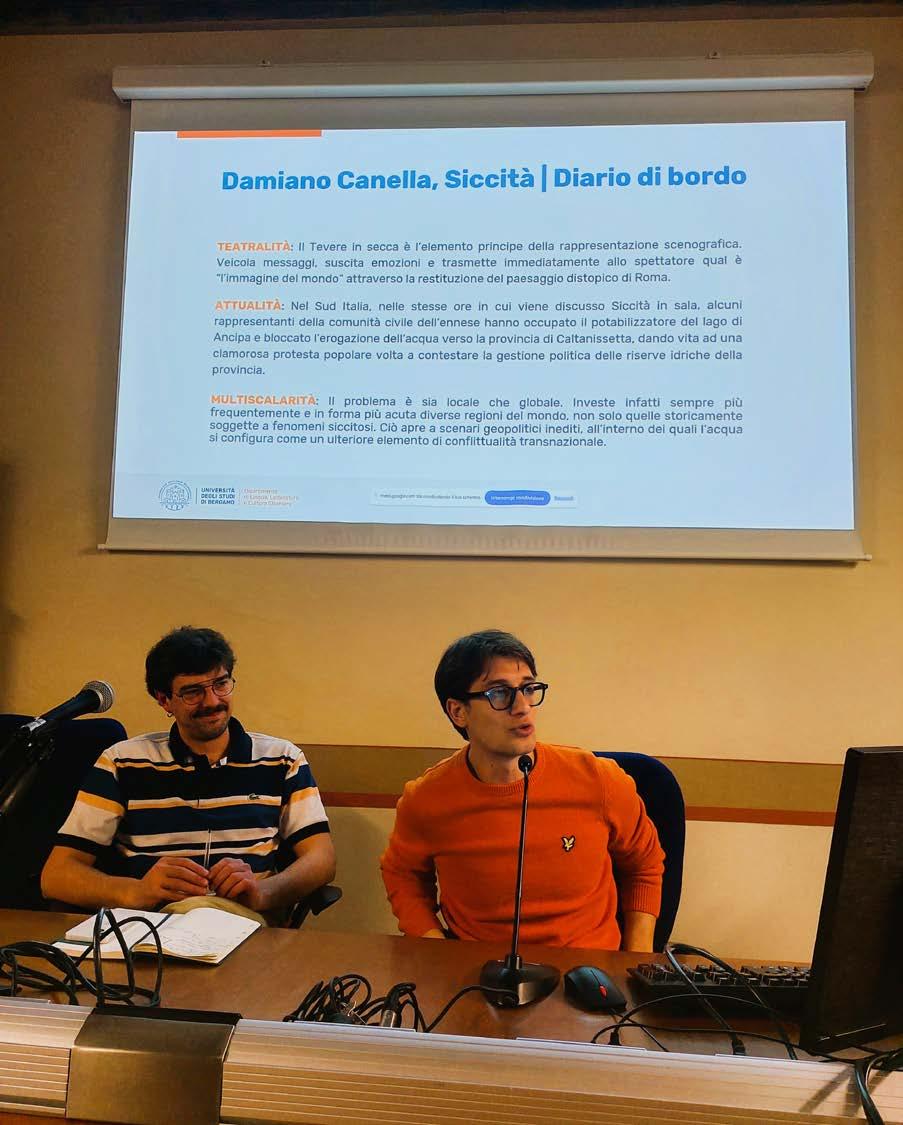
Damiano Canella / Siccità – Parole in chiaro
•CRISI La città di Roma è alle prese con una policrisi: idrica, ecologica, sociale, sanitaria, economica, mentre la popolazione resistere all’assurdo quotidiano come meglio può in attesa che il ritorno dell’acqua ristabilisca il normale ordine delle cose.
•CONFLITTUALITÀ Il protrarsi dell’emergenza idrica spinge la politica al ricorso di soluzioni impopolari e stringenti per far fronte alla penuria d’acqua, con la conseguenza di acuire le frizioni sociali ed esacerbare il divario economico tra quanti sono costretti a contingentarla e quanti invece continuano a farne uso impropriamente.
•CURA Se la soluzione al problema manca, l’alternativa all’inedia e alla rassegnazione è la cura, da intendere non come un’azione normativa frutto di moralizzazioni quotidiane, ma come uno stato affettivo vitale e un obbligo morale attraverso cui è possibile infondere vitalità e speranza ad una società sul lastrico e incattivita.
Terra-patria di Edgar Morin, Raffaello Cortina Editore, 1996.
Permacrisi: Un piano per riparare un mondo a pezzi, di Michael Spence, Mohamed El-Erian e Gordon Brown, Egea, 2024. Facciamoci sentire! Manifesto per una nuova ecologia, di Bruno Latour e Nikolaj Schultz, Einaudi, 2023. Laudato sì, di Papa Francesco, San Paolo Edizioni, 2015.
Damiano Canella, Siccità | Diario di bordo
TEATRALITÀ: Il Tevere in secca è l’elemento principe della rappresentazione scenografica. Veicola messaggi, suscita emozioni e trasmette immediatamente allo spettatore qual è “l’immagine del mondo” attraverso la restituzione del paesaggio distopico di Roma.
ATTUALITÀ: Nel Sud Italia, nelle stesse ore in cui viene discusso Siccità in sala, alcuni rappresentanti della comunità civile dell’ennese hanno occupato il potabilizzatore del lago di Ancipa e bloccato l’erogazione dell’acqua verso la provincia di Caltanissetta, dando vita ad una clamorosa protesta popolare volta a contestare la gestione politica delle riserve idriche della provincia.
MULTISCALARITÀ: Il problema è sia locale che globale. Investe infatti sempre più frequentemente e in forma più acuta diverse regioni del mondo, non solo quelle storicamente soggette a fenomeni siccitosi. Ciò apre a scenari geopolitici inediti, all’interno dei quali l’acqua si configura come un ulteriore elemento di conflittualità transnazionale.


Elio Moschini e Lorenzo Amato /
La strada infinita – Parole in chiaro
URBS-CIVITAS - La città non è costituita solo da una componente fisica fatta di manufatti (residenze, edifici produttivi, strade, ecc.) ma anche e soprattutto da persone che percepiscono la città in modo soggettivo (es. percezione del luogo di confine del quartiere) e che danno nuova vita agli edifici con una serie di iniziative culturali e sociali. Il paesaggio, in senso semiologico, si manifesta rivelando l’agire territoriale della società che in esso vive.
FUNZIONI - Ci troviamo in una zona della città che è certamente stratificata e complessa, ma che si configura anche molto come un "pezzo di città del '900», fatta cioè di grandi funzioni (mercato ortofrutticolo, ex manicomio, cimitero, la grande fabbrica) nella quale si è pensato alla collocazione delle funzioni stesse, con buoni profili di accessibilità e molto meno agli spazi che stanno tra le funzioni, che appaiono nel film come luoghi di risulta, non "a misura d'uomo" pesati maggiormente per la mobilità in auto e molto meno per i pedoni.
INNOVAZIONE SOCIALE - Il film mostra anche come le "periferie" siano paesaggi in cui avviene innovazione e cambiamento sociale e anche di come la "periferia" risulti viva e in fondo come essa stessa sia la città del nostro tempo. Una città che prova a recuperare una dimensione pubblica e comunitaria.
De Casaris, G. (2016). Periferie e rigenerazione urbana. Le politiche per la città contemporanea. Milano: Franco Angeli.
Soja, E. W. (2000). Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Oxford: Blackwell Publishers.
Sennet, R. (2018). Building and Dwelling: Ethics for the city. New York: Farar, Straus and Giroux.
Turri, E. (1998). Il paesaggio come Teatro – Dal territorio vissuto al territorio rappresentato.
Elio Moschini e Lorenzo Amato /
La strada infinita – Diario di bordo
NON-LUOGHI SIMBOLICI - La narrazione si concentra su una strada della città di Bergamo, che parte dalle zone più centrali e si snoda verso est, esplorando spazi spesso esclusi dall’immaginario urbano dominante (Cimitero Monumentale, Mercato ortofrutticolo, luna park, ex ospedale come sede di co-housing, centro commerciale, ex fabbrica, …) Elementi che non parlano solo di Bergamo, ma di una condizione globale in cui i confini tra urbano e rurale si dissolvono, lasciando spazio a territori ibridi e stratificati. Potrebbe essere stato girato in una qualsiasi città del mondo.
MEMORIA STRATIFICATA - La fisicità degli spazi si intreccia con le testimonianze di persone che li vivono o li hanno vissuti ; man mano che va avanti, il film si manifesta sempre più come un viaggio intimo che si snoda attraverso immagini, voci e racconti, alternando il passato e presente per riflettere sulle relazioni tra uomo, territorio e memoria. La città è fatta dalla stratificazione delle diverse epoche che ha portato tra le altre cose a una cementificazione dei corsi d'acqua, forse la risposta che oggi dovremmo dare per rendere la città più resiliente è quello di «lavorare per sottrazione».
CAMMINO (a piedi) - L’ «andare a piedi» è una chiave di lettura del film: non solo l’intera narrazione è in continuo movimento, ma racconta anche anche lo «stare con i piedi per terra», frequentare, con sapienza, il territorio. La S.I. invita a una nuova sensibilità verso il paesaggio, inteso come memoria collettiva e luogo di possibilità. Attraverso la potenza espressiva dell’animazione, il film suggerisce che l’umanità, pur immersa in un contesto planetario di crisi, può ancora reinventare il suo rapporto con lo spazio e il territorio, trovando nella fragilità e nella marginalità nuove forme di resilienza e significato.


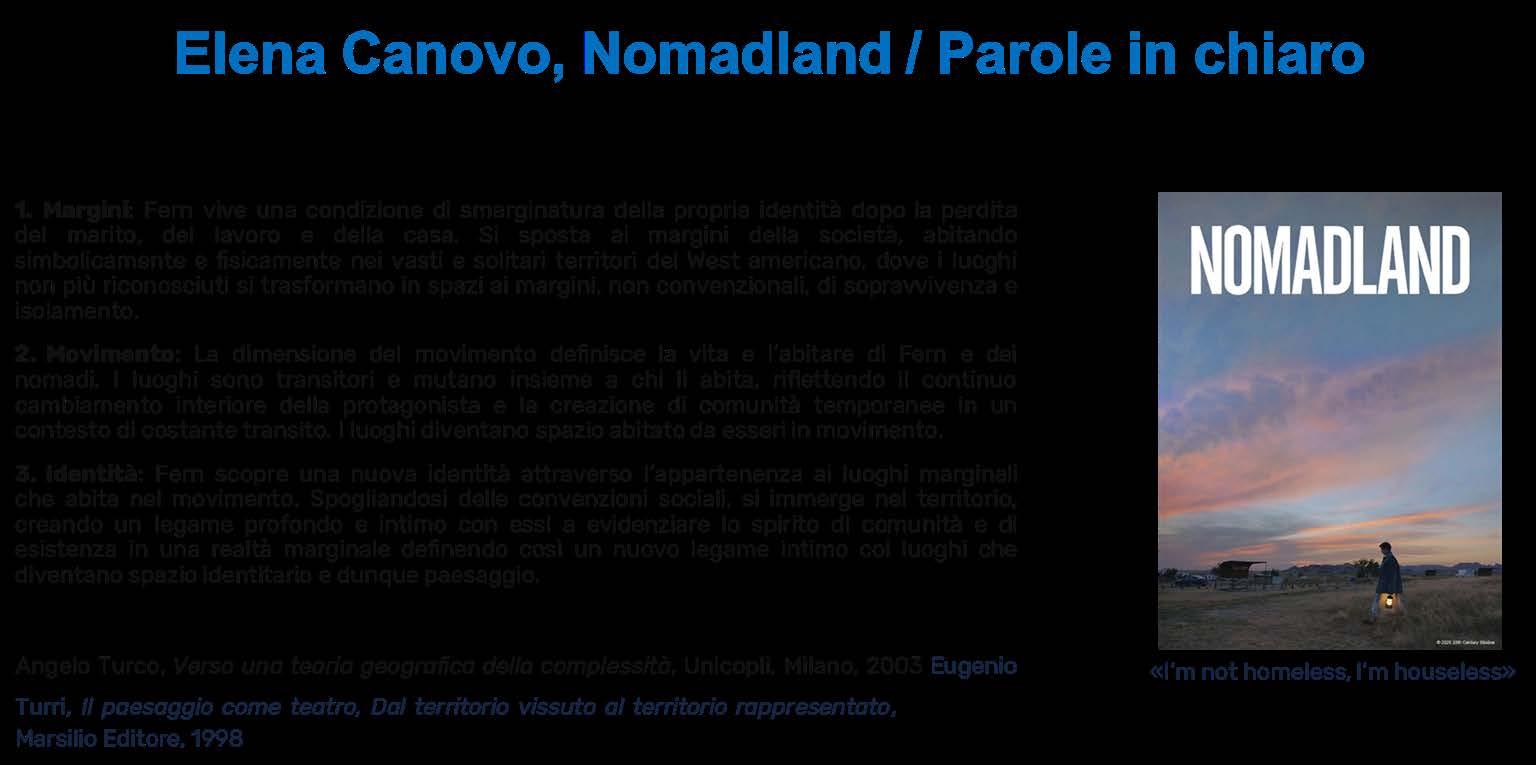

MovieScapes 2024 è un progetto di
Alessandra Ghisalberti (ideazione), alessandra.ghisalberti@unibg.it
Stefania Consonni (comunicazione), stefania.consonni@unibg.it
Stefano Morosini, stefano.morosini@unibg.it
Giuseppe Previtali, giuseppe.previtali@unibg.it
con la collaborazione di
Camilla Loro, moviescapes@unibg.it
e con il supporto social di
Elisa Consolandi, elisa.consolandi@unibg.it
Francesco Antonelli, francesco.antonelli@unibg.it
