Albertina Castellazzi Cominciammo così la nostra vita
Storia
di una
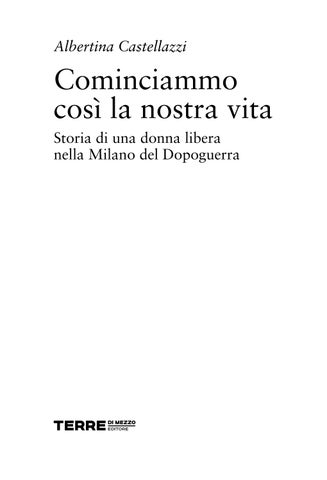
di una
di Guido Barbieri
La storiografia sulla condizione femminile e sul ruolo delle donne durante la Seconda guerra mondiale subisce una svolta ad angolo retto quando, nel 1976, Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina pubblicano un’opera di capitale importanza come La Resistenza taciuta. Dodici vite di partigiane piemontesi. Uno studio seminale seguito ad appena un anno di distanza da Compagne. Testimonianze di partecipazione politica femminile di Bianca Guidetti Serra. In entrambi i casi le autrici sono in un certo senso obbligate, per documentare la presenza delle donne negli scenari di guerra e in particolare nella lotta di liberazione, ad accantonare i tradizionali documenti scritti (archivi, fondi privati, fonti istituzionali) e a rivolgersi direttamente alle sorgenti orali: testimonianze, memorie, interviste, racconti in prima persona, narrazioni ecc. Un metodo necessario che provoca però un terremoto nella metodologia storiografica tradizionale. “Perché”, come scrive Iara Meloni in un libro recente, ma altrettanto prezioso, Memorie resistenti. Le donne raccontano la Resistenza nel Piacentino , “è proprio in quegli anni che la storiografia recepisce il desiderio, diffuso in diverse componenti della società tradizionalmente escluse dalla narrazione storica, di riprendersi la
parola ‘dal basso’ e si apre a nuove fonti, soggettive e orali, nonché a ricerche locali”.
L’irruzione delle fonti orali nella narrazione storiografica è un ciclone, soprattutto nell’ambito, solo apparentemente circoscritto, della cosiddetta “condizione di genere”. “Se prima”, prosegue Meloni, “l’unico statuto di scientificità era quello scritto, con l’apertura alle fonti orali comincia ad emergere l’importanza della vita quotidiana, in particolar modo quella dei settori sociali tradizionalmente esclusi dalla narrazione”. Il nuovo vento storiografico che soffia negli studi degli anni Settanta, favorito dalla diffusione dei gender studies negli Stati Uniti e preceduto dall’opera pionieristica della nouvelle histoire, si concentra soprattutto, e pour cause , sulle narrazioni femminili: sono queste ultime a portare nella ricerca storiografica il seme della novità, a imporre uno sguardo dal basso, un’attenzione alle differenze di genere, uno sguardo olistico sui conflitti e le contraddizioni sociali. Soprattutto sul nodo identitario imprescindibile che è stata, in Italia, la lotta di liberazione. Non a caso il testo forse più evoluto sotto questo profilo è un altro libro di donne sulle donne: In guerra senza armi. Storie di donne: 1940-1945 della stessa, instancabile, Anna Maria Bruzzone insieme ad Anna Bravo, pubblicato per la prima volta nel 1995.
Cominciammo così la nostra vita non racconta la lotta di Liberazione. La sfiora, naturalmente, dato che negli anni di guerra è racchiuso il cuore del libro. Ma la guarda da lontano, senza alcun coinvolgimento diretto, mettendone in luce, come vedremo, anche le contraddizioni irrisolte. Ma la “memoria” di Albertina Castellazzi (che abbraccia gli anni tra il 1937 e il 1972) possiede due tratti distintivi che la inseriscono nel grande solco della storiografia popolare degli italiani.
Da una parte perché, anche se non parla della Resistenza con la erre maiuscola, è intrisa di una resistenza con la erre minuscola che possiede ugualmente un profondo significato politico. Scorre sotto i nostri occhi la parabola di una donna che non si è rassegnata alle asfissianti convenzioni del proprio tempo e della propria famiglia, che non si è arresa al destino di una scolorita esistenza domestica, ma che al contrario si è ribellata, si è aggrappata alle proprie passioni, le ha nutrite e coltivate fino a uscire dal bozzolo familiare e a conquistare una posizione autonoma e indipendente nella società, affermando, con fierezza e con orgoglio, la “diversità” della propria identità femminile. Ma dall’altra parte la narrazione di Albertina (caratteristica di molte delle “vite di carta” conservate dall’Archivio Diaristico Nazionale) possiede una prorompente e a volte debordante “oralità”. Anche se memorie, fatti, avvenimenti, persone, racconti si sono cristallizzati nella pagina scritta, ogni pagina di questo libro è attraversata da un flusso verbale e sintattico tipico della narrazione orale: lo stile paratattico, il lessico non sempre omologato all‘italiano “illustre”, il flusso dei ricordi lasciati liberi di scorrere senza l’obbligo della consecutio temporale, il continuo alternarsi di vita privata e vita pubblica, il carattere monologante e quasi solipsistico di molti passi narrativi e autodescrittivi.
Cominciammo così la nostra vita possiede dunque un doppio statuto: per un verso è la testimonianza lucida e sofferta di un’esistenza individuale “anomala”, che scarta dalle norme e dalle convenzioni, dall’altro è essa stessa un documento, una fonte “orale”, preziosa e indispensabile, per leggere l’evoluzione della condizione femminile in un delicatissimo arco temporale della storia italiana: quello che precede e segue il Grande Trauma, individuale e collettivo, del Secondo conflitto mondiale.
Se la “memoria” di Albertina potesse o dovesse essere inclusa in un genere letterario (gesto scorretto che però consente di offrire una visione d’insieme del libro) sarebbe certamente quello del cosiddetto romanzo di personaggi, quei testi cioè in cui la trama narrativa è data dalla descrizione accurata dei singoli personaggi e delle relazioni tra loro, e non da una serie di avvenimenti esterni. Il modello, per intenderci, costituito da grandi capolavori come Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen o in un certo senso da Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa o ancora da tutta la prima, estesissima parte de I fratelli Karamazov di Dostoevskij. Modelli illustri che tra l’altro fanno sicuramente parte della originale, cocciuta, quasi clandestina formazione letteraria di Albertina, ma che in alcun modo condizionano la struttura del suo racconto. Sta di fatto però che larghe zone della narrazione sono dedicate a dipingere con cura meticolosa e grande precisione biografica i ritratti delle persone a lei più vicine, in particolare quelle che appartengono alla sua anomala famiglia: la madre (scomparsa quando Albertina aveva appena quattro anni), il padre Giacomo e le tre sorelle maggiori: Elisabetta, Anna e Piera.
La figura del padre è in tutti i sensi dominante. Uomo ombroso, taciturno, Giacomo Castellazzi rappresenta il principio d’ordine della casa. Autoritario, irascibile, incline al rimprovero e quasi mai alla lode, maniacale al limite dell’ottusità nel gestire le risorse economiche della famiglia, si trova a poco più di cinquant’anni vedovo e con quattro figlie femmine da crescere. La madre scompare infatti, all’improvviso, nel 1941 ed è la prima grande voragine di solitudine che si apre nella vita di Albertina. Più tardi, da adulta, quando cerca di mettere ordine nei pezzi mancanti della sua esistenza, Albertina – forse per
esorcizzare la sua figura – ricostruisce con meticolosità e dedizione, come stesse costruendo un fragile origami, tutti i piccoli e grandi avanzamenti di carriera del padre: poliziotto, carabiniere, guardia di città, agente delle forze speciali, impiegato della prefettura. Una vita nei corpi separati dello Stato si direbbe oggi, con in testa però una inderogabile “missione” privata: imprimere disciplina, ordine, rigore alla vita familiare, sconvolta dalla perdita della moglie. Un peso quasi insopportabile per lui: ogni giorno si trova di fronte quattro figlie, due adolescenti e due giovani, che non conosce e che non ha alcuna voglia di comprendere. Quelle quattro creature femminili sono e rimangono strumenti di quel delicato meccanismo a orologeria che è il suo astratto ideale di vita familiare. Un ideale di cui fanno parte il terrore, la punizione severa di ogni disobbedienza, le sfuriate e gli scoppi di rabbia. L’incipit del libro è – da questo punto di vista – fulminante: “Nei mesi caldi lo aspettavamo sul balcone della cucina: lo vedevamo arrivare col suo passo deciso, le mani dietro la schiena, la faccia proiettata in avanti, svoltava nel portone, lo attraversava e si avvicinava alla nostra scala (…). Noi eravamo già dentro, sapevamo che non gradiva vederci troppo al balcone. Quando lui entrava in casa i rumori si moltiplicavano”.
Un solo lampo di “celebrità” rischiara l’esistenza di quest’uomo prima burbero e autoritario, poi apatico e assente: un episodio che si perde nella mitologia famigliare, ma che rimarrà per molto tempo uno dei pochi avvenimenti per lui degni di memoria. Nel 1915 a una manifestazione a favore dell’ingresso dell’Italia in guerra partecipa, in piazza della Pilotta, a Roma, nientemeno che Benito Mussolini, allora direttore dell’Avanti, protagonista di una clamorosa svolta interventista che portò alla sua espulsione dalle fila del Partito Socialista. L’ordine della
questura è quello di arrestare i manifestanti “più facinorosi” e a Giacomo Castellazzi tocca in sorte di mettere le manette al capo del futuro Partito Nazionale Fascista. Per il resto Giacomo – soprattutto quando capirà di avere perduto il diritto di vita e di morte sulle figlie – assisterà quasi da spettatore alle piccole e grandi tragedie che colpiscono la sua famiglia. Parlando di lui e della difficoltà, per un uomo che aveva raggiunto l’apice del benessere durante il fascismo, di ripartire da zero nella nuova società del Dopoguerra, Albertina fa un bilancio crudele del rapporto tra il padre e le figlie: “Già, noi figlie”, scrive, “ognuna di noi aveva pagato un prezzo troppo alto, troppo per tacere, troppo per buttarselo alle spalle come niente fosse. Ognuna di noi era intenta a leccarsi le ferite e a fronteggiare quell’uomo-orco che a seconda dei momenti affascinava, spaventava, dominava per curarsi dei bisogni delle sorelle”. E Albertina è altrettanto lucida nel chiedersi – come milioni di altri figli nel Dopoguerra – se suo padre avesse aderito al fascismo solo per convenienza o anche per convinzione.
Sono le sorelle la vera spina dorsale della vita famigliare. I loro ritratti sono scolpiti dalla penna della più piccola con nettezza e precisione. Con Anna, dalla quale la separano appena tre anni (in realtà un abisso…), il rapporto è intenso e contraddittorio. Quando scoppia la guerra, nel 1940, le due sorelle minori vivono insieme l’esperienza traumatica del collegio, e rimangono sempre, forzatamente, una accanto all’altra. Ma parlano poco tra loro, non giocano insieme, si proteggono l’una con l’altra, ma senza mostrare, in apparenza, affetto o empatia.
Tante sono le tragedie che colpiscono questa famiglia, ma niente, davvero niente, può arrestare la rivendicazione
prepotente di indipendenza, di autonomia, a tratti la vera e propria ribellione che attraversano come un vento costante l’esistenza di Albertina. Il suo destino, in quanto figlia minore di un padre vedovo nell’Italia degli anni Cinquanta, sembra chiuso dentro una scatola di piombo: “Le tue sorelle andranno a lavorare e tu ti occuperai della casa”: questa è stata la sentenza pronunciata dal pater familias quando Albertina ha appena compiuto i quattordici anni. Ma a quella sentenza lei non si piega.
Prima di tutto si aggrappa al gioco più divertente che conosce: leggere. Non ci sono i soldi, in casa, per comprare libri nuovi e allora Albertina divora quelli della modesta biblioteca di suo padre. Però Albertina non vive soltanto negli universi immaginari della letteratura, abita, con concretezza e decisione, anche in quelli della realtà quotidiana. Innanzitutto, nel mondo del lavoro. Vuole a tutti i costi dedicarsi alla sua grande passione: l’insegnamento.
Vince la lotta contro il suo destino di “donna di casa”, anonima e ingrigita dal tempo. E si assicura l’indipendenza. A trentaquattro anni inizia davvero la “sua” vita, quella che nessuno le può più rubare: una casa nuova, un lavoro che la appassiona, i primi viaggi… Ma resta ancora da completare un’educazione sentimentale vissuta in modo caotico, senza un vero amore, lasciandosi portare dall’onda del momento, anzi rifiutando il più delle volte che quell’onda la portasse via. Fino a quando alla fine di una “strana serata” in casa di Arturo, un agente di borsa che abita in un grattacielo di Cinisello Balsamo non appare nella sua vita un uomo un po’ misterioso, uno “straniero” al quale sarebbe stata legata per tutta la vita: Sergio che diventerà il padre di sua figlia. Ma questa – come dice Albertina – è un’altra storia che merita di essere raccontata in un altro libro.
L’Archivio dei diari ringrazia sentitamente Bruno Tommassini per aver sostenuto il progetto editoriale.
Nota dell’editore
ll memoir che qui pubblichiamo è stato sottoposto al vaglio di una commissione redazionale composta dalla curatrice del libro e dai responsabili della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, che hanno definito i criteri di pubblicazione e hanno approvato il risultato editoriale. La normale operazione editoriale di revisione di un testo necessita di cure particolari nel caso di diari, memorie ed epistolari; per questo motivo, i criteri adottati variano in relazione al tipo di testo autobiografico pubblicato. In questo caso il testo è integrale, anche se purtroppo non siamo riusciti a riprodurre le fotografie dell’epoca che lo accompagnavano, perché troppo rovinate dal tempo.
Mio padre, io lo ricordo così da sempre, perché mi mise al mondo quando aveva cinquant’anni. Capelli sempre più bianchi, che lui pettinava ordinatamente lisciandoli. Credo di non averlo mai visto scompigliato; gli occhi azzurri che ti piantava in faccia e la voce tonante. Sempre vestito con abiti a giacca, magari con panciotto, cappello che negli ultimi anni aveva sostituito con un basco e cappottone blu. Era dignitoso e molto ordinato.
Quando lui non c’era la casa sembrava silenziosa e noi scandalosamente libere perché avevamo già perduto la mamma.
Nei mesi caldi lo aspettavamo sul balcone della cucina; lo vedevamo arrivare col suo passo deciso le mani dietro la schiena la faccia proiettata in avanti; svoltava nel portone lo attraversava e si avvicinava alla nostra scala che era l’ultima in fondo al giardino.
Noi eravamo già dentro; sapevamo che non gradiva vederci troppo al balcone. Quando lui entrava in casa i rumori si moltiplicavano.
Noi lo aspettavano in cucina: Piera appoggiata al buffet azzurro, con il cucchiaio rimestava nella pentola sul fuoco della stufa che in inverno faceva da riscaldamento e da cucina, Elisabetta alla parete opposta si appoggiava alla
macchina da cucire e guardava fuori dalla finestra lì vicino. Anna preferiva mettersi nella rientranza del cucinino dove c’era il lavello e la ghiacciaia pronta a nascondersi più che poteva se l’aria girava male. Io, la più piccola stavo un po’ vicino all’una o all’altra, ma siccome lo spazio era poco molto spesso veniva la richiesta “spostati”, allora mi mettevo vicino a un mobiletto alto dove era messa la radio che trasmetteva già il Gazzettino padano.
Il tavolo, che di solito era appoggiato al muro tra la macchina da cucire e il mobiletto della radio, era già stato messo al centro della stanza con la tovaglia, le posate, i piatti e i bicchieri, il nostro basso mentre quello di nostro padre a calice con il vetro disegnato con incisioni opache sul bordo. Nei mesi caldi vicino al suo bicchiere mettevamo un piattino con rapanelli o fave pelate, molto spesso questo era un compito che mi toccava e che svolgevo religiosamente. Lui li mangiava con olio e sale prima di iniziare il pranzo.
Appena entrato mio padre passava in bagno e poi in cucina. Noi assumevamo un atteggiamento di circostanza, sapevamo che prima di mangiare dovevamo passare l’esame.
Mio padre ci guardava, poi con voce noncurante iniziava a chiedere alle mie sorelle grandi cosa avevano fatto, a che ora erano uscite, dove erano state, cosa era stato detto e quale era stata la risposta, a che ora avevano ripreso il tram e quando erano rientrate.
Qualche volta le domande venivano rivolte anche a noi due sorelle minori ma erano meno importanti perché allora l’attenzione di mio padre era focalizzata sulle due figlie maggiori che potevano creare problemi perché ormai erano giovani donne. La tensione causata dalle risposte delle mie sorelle aumentava come una musica e l’acuto era certo di mio padre che cominciava bestemmiando a sgri-
dare le due figlie in due diverse scenate perché lo avevano contrariato in modo diverso. Elisabetta che come maestra in attesa di essere chiamata come supplente non aveva curato bene la minestra di fagioli che bollendo troppo non era più come doveva essere “si vede dai bordi scuri della pentola”; Piera che andava all’università aveva sempre delle richieste da fare, come l’acquisto delle dispense che lo avrebbe costretto a spendere soldi imprevisti.
Due esempi fra i tanti che mi vengono in mente.
Dopo la scenata che mio padre faceva camminando attorno al tavolo, fermandosi ogni tanto per sfogare meglio la sua ira verbale come in un andante piano la sua voce pur mantenendo il tono, scemava a toni più pacati e cominciavano le rievocazioni del suo tempo passato quando Dio non lo aveva ancora castigato lasciandolo solo con quattro figlie femmine e si sa che le donne o sono monache o sono baldracche. Mio padre aveva la capacità di sapere raccontare e noi lo seguivamo nel suo narrare sospese attonite anche se il suo racconto era ripetuto. Potevano essere piccoli racconti, rievocazioni che faceva per meglio rimuginare i torti avuti dal destino oppure lunghi tutta la durata del pranzo o della cena. Questo succedeva ogni giorno tra le dodici e trenta e l’una e la sera tra le sei e le sette al rientro dall’ufficio. Noi nel frattempo continuavamo nelle nostre faccende senza troppo evidenziarle per non irritarlo di più.
Così si scodellava, si mangiava, si sparecchiava, si lavavano i piatti e si riordinava ascoltando e subendo i suoi rimbrotti e le sue storie che alle volte avevano dell’incredibile ma che alla fine trovavano conferma.
Mio padre era nato nel 1887 tra il luglio e l’agosto, ma suo padre dovendo andare a lavorare nei campi andò a denunciarlo all’anagrafe con un mese di ritardo e così risulta nato il 30 settembre di quell’anno.
Doveva avere un carattere un po’ particolare, a sentire le mie zie, diciamo ribelle; fatto sta che a quattordici anni fu mandato a Milano per imparare il mestiere di sarto. Era il 1901 e a Cavezzo non tornò e non diede più sue notizie fino al 19 marzo 1922.
Questo è il ricordo di mia cugina Maria e di mia sorella Anna, ma dal fondo della mia memoria riaffiora la voce di mio padre che ci raccontava come sua madre Adalgisa fosse andata a cercarlo presso il Distretto militare basandosi sul calcolo del richiamo di leva e di averla sorpresa mentre parlava, parlava con un suo superiore del figlio che voleva ritrovare… Questo è il mio ricordo.
La data precisa di questo ritorno al paese (12/3/22) mi fu comunicata da mia cugina Maria una settimana fa (Pasqua 2002) e Anna si è ricordata e ha concluso il racconto: “Arrivato in paese lo vide vuoto e sentì suonare le campane a morto… A uno che passava di lì chiese chi era morto. ‘È l’Adalgisa’, rispose quello, era sua madre. Mio padre cambiò percorso, andò al cimitero, fermò la cerimonia dicendo che non potevano continuarla se prima lui non si fosse accertato che quella donna dentro la bara era sua madre. Non ci fu verso, dovettero aprire la bara e così lui poté vederla e salutarla per l’ultima volta”.
Le sue sorelle, specialmente la zia Rosa, non glielo perdonarono mai perché considerarono quel gesto una violenza nei confronti della madre e un atto di sfiducia nei loro confronti. Che cosa aveva fatto mio padre dal 1901 al 1922 quando tornò giovane baldanzoso al suo paese creando scandalo?
Oltre le date del suo curriculum lavorativo, inoppugnabili, noi abbiamo avuto solo i suoi racconti, privi di dati e di riferimenti ma intensi di emozioni. Nulli quelli del primo periodo (1901-1906) non so se perché Lui non li tenesse in considerazione o perché la mia memoria e
quella delle mie sorelle non li avesse trattenuti; di certi ho un ricordo vivo, di altri no.
Dalle carte risulta che mio padre fu chiamato alla leva militare il 23 luglio 1907. Aveva 20 anni.
Con maggior precisione un vecchissimo libretto d’arruolamento della Guardia Reale di Finanza fu rilasciato a mio padre. Maddaloni 31/12/1906. In questo centro urbano vicino a Caserta, esisteva una scuola militare e, proprio quell’anno, si era organizzato un corso per allievi di Guardia di Finanza. 1/12/1906. Probabilmente anche mio padre era stato uno degli allievi. Questo curioso libretto ha il pregio di rivelare lo sviluppo iniziale della sua carriera nei Servizi di Stato.
Sulle prime pagine sono riportate le norme del Corpo della Guardia di Finanza, le seguenti illuminano un pezzetto di vita militare dell’epoca. Risulta un encomio a mio padre per servizi resi durante una manovra come guardia marina a Savona il 30/10/1908.
Poche pagine più in là una punizione per abbandono del posto di servizio senza gravi conseguenze; avendo pernottato abusivamente presso la brigata Isella senza ritornare alla propria. La punizione andava dall’11 al 22 marzo 1908.
Le altre pagine sono in ordine di data e partendo dal 1906 sulla pagina di sinistra sono segnati i crediti di massa ovvero le diarie, su quella di destra l’elenco dei debiti di massa, ed esattamente l’elenco degli acquisti nel magazzino militare di capi di vestiario di cui era presumibilmente composta la sua divisa. La diaria si stabilizzò sulle sei lire dopo aver ricevuto un primo credito di lire 138,75 per primo corredo. È curioso notare che il debito per l’acquisto dei vari ammennicoli della divisa lievitava a tal punto da superare di gran lunga il credito di diaria. I timbri scoloriti e le annotazioni dei suoi superiori eviden-
ziano che mio padre prestò servizio in diversi posti. Fino al 1908 egli prestò servizio presso il comando di Circolo di Novara; dopo il 16 aprile 1908 fu “tramutato” a Savona.
A ogni passaggio, segnato ordinatamente sul libretto, ci sono le diarie e i debiti di massa e le prime riescono solo a diminuire il debito senza riuscire mai a estinguerlo.
Per esempio a Savona la diaria da sei lire sale a 9,50 ma se un credito di otto mesi raggiunge la cifra di 110,90, il debito di massa “trascinato” dal 1907, risulta essere di 190,60 lire.
Dopo la scuola di Maddaloni, dopo Novara e dopo Savona, mio padre fu “tramutato” ancora a Novara, il 16 maggio 1910 e da qui, il 30 giugno 1910 il suo comandante chiude le trascrizioni perché dal 1 agosto 1910 viene “tramutato” a Roma.
Stranamente per noi, con la nuova “trascrizione” si evidenzia che da gennaio 1911 la diaria ritorna a 6 lire. Il 23/9/1911 passa a un altro circolo sempre a Roma. Pur mantenendo la sua misera diaria, per la prima volta la voce “diaria” sale a 87,48 mentre il debito scende a 67,61 per cui il 30/6/1912 il suo debito scende a 9 lire.
Sono gli ultimi mesi nella Guardia di Finanza. Il 14 dicembre 1912 viene congedato e, liberatosi dell’ultimo debito, mio padre passa a un altro ruolo con 11 lire 90 centesimi in tasca.
Va segnalato che il terzo trimestre 1912 si riporta alla voce “ospedale”. Il costo è di lire 24,70. Di che cosa soffrì non lo sappiamo.
Lui raccontava: “Il mio diretto superiore era un capitano. Affidò a me e a un altro le chiavi della cassa dove erano custoditi i soldi. Ogni tanto il capitano ci chiamava, noi consegnavamo le chiavi; la cassetta veniva aperta, richiusa