
3 minute read
A cosa serve l’ingegneria del clima?
A cosa serve l’ingegneria del clima?
Siamo ormai tutti convinti che il clima stia cambiando. Le reazioni a questo stato di cose vanno da quelle più propriamente trumpiste di negazione o di totale indifferenza a quelle da guerra santa che si identificano ad esempio con Fridays for future.
Advertisement
La soluzione più ragionevole sembra quella di ridurre la produzione di gas serra, principalmente l’anidride carbonica (CO 2 ), ossia ridurre l’energia prodotta da combustibili fossili. La concentrazione di questo gas ha ormai superato le 415 ppm (parti per milione) partendo da una concentrazione in epoca preindustriale di circa 290 ppm.
Le speranze di ridurre o stabilizzare la concentrazione di anidride carbonica sono praticamente nulle. Infatti solo per stabilizzarne la concentrazione bisognerebbe ridurre del 60- 70% la sua produzione, cioè tornare ai livelli preindustriali. Anche se oggi si decidesse di azzerare la produzione di CO 2 occorrerebbero diverse centinaia di anni per tornare ai livelli preindustriali. situazione attuale, la comunità scientifica ha pensato in modo fantascientifico che si può intervenire e cambiare artificialmente il clima: è quella che si chiama “ingegneria del clima” ovvero geoengineering.
Si tratta come già detto di un’idea presa in prestito dalla fantascienza. Infatti il primo romanzo che avanza un’idea del genere è quello di Olaf Stapleton negli anni 30 con il titolo significativo di “Star maker”. Questa idea viene ripresa sul serio negli anni ’60 quando Freeman Dyson inventa la sfera ecologica di dimensioni planetarie che viene appunto chiamata “sfera di Dyson”. Questo tipo di interventi, che doveva tendere a rendere abitabili pianeti ostili come Venere o Marte, va allora sotto i nome di terraforming. Negli anni ’70, soprattutto su iniziativa del climatologo russo Mikhail Budyko, veniva suggerito un terraforming per il nostro pianeta sotto forma della creazione di eruzioni vulcaniche artificiali.
Quando si verifica un’eruzione vulcanica catastrofica vengono iniettate in stratosfera - fra 15 e 20 km di altezza - milioni di tonnellate di anidride solforosa che si trasforma rapidamente in acido solforico che forma nubi stratosferiche di aerosol assai simili per composizione chimica alle nubi che abbondano nell’atmosfera di Venere. Queste nubi hanno la proprietà di riflettere la luce solare e quindi in teoria possono raffreddare la superficie della Terra.
Storicamente ci sono state diverse eruzioni di questo genere; fra le più famose quella del 1815 del vulcano Tambora e quella del 1884 del Krakatoa. Effetti misurabili si sono visti con l’eruzione dell’Agung (1963), El Chichon (1982) e Pinatubo (1991). Queste eruzioni si stima abbiano immesso fra 15 e i 20 milioni di tonnellate di aerosol; le prime stime parlavano di riduzioni di temperatura di circa 1°C da sei mesi a un anno dall’eruzione solo in certe zone del globo. Stime più accurate hanno fortemente ridimensionato queste cifre fino a circa 0.5°C. L’idea di Budyko era quella di immettere artificialmente in stratosfera degli aerosol che potessero produrre lo stesso effetto delle eruzioni vulcaniche.
La cosa sembrò a quel tempo solo una curiosità ma venne ripresa nel 2006 da Paul Cruzten (premio Nobel per il buco nell’ozono e inventore dell’antropocene, ossia l’era dell’Uomo) che senza citare i precedenti rilanciava l’idea. Da allora la comunità scientifica si è scatenata su questo argomento che oggi va sotto il nome di Solar Radiation Management (SRM). Il principale sostenitore è un professore di Harvard, Brian Keith che ha costruito un laboratorio con fondi ricevuti persino da Bill Gates.
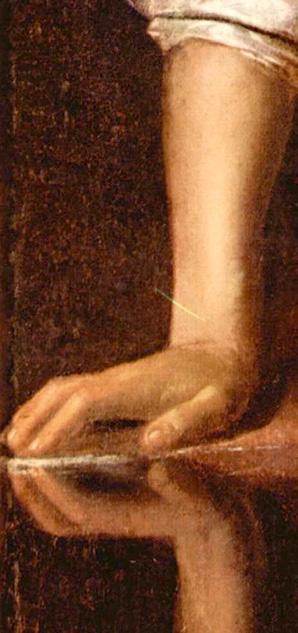
Questo progetto prevede l’uso di aerei - che non esistono ancora - in grado di immettere a quote comprese fra 15-20 km milioni tonnellate di anidride solforosa. Finora questo problema è stato studiato solo a livello modellistico con simulazioni più o meno realistiche circa i loro effetti. Ad esempio, non esistono studi di come costruire una nube di queste dimensioni dal rilascio dei singoli aerei ma soprattutto sulle questioni etiche e politiche che implicano queste strategie. Come verranno decisi gli interventi e per quali regioni della Terra? Come verranno sostenute le spese e a quali Paesi apparterrà la tecnologia?
Le stime più concrete si sono fatte sugli investimenti da sostenere. Per quanto riguarda gli aerei - da costruire appositamente - si parla di costi di sviluppo che vanno dai 5 ai 15 miliardi di dollari. Il costo operazionale ammonterebbe a circa 35 miliardi di dollari nei primi quindici anni con un numero di voli annui che parte da 4.000 fino ad arrivare a 60.000. Tenuto conto dei costi analoghi nel settore aerospaziale, queste cifre vanno moltiplicate per un fattore da 3 a 5. Rimangono in sospeso tutte le incognite legate al trasporto e alla produzione di materiali altamente corrosivi come l’anidride solforosa e, soprattutto, le conseguenze ambientali.
Per quanto le simulazioni siano affidabili, uno spiegamento completo di questo sistema comporterebbe una diminuzione della luminosità del cielo, conseguenze sul regime delle piogge e dei monsoni e un aumento delle piogge acide soprattutto nelle regioni che oggi sono immuni da questo fenomeno. Ciononostante un piccolo esercito di ricercatori, che chiamerei piccoli stranamore, seguitano a lavorare su questi progetti e a ricevere fondi per le loro ricerche. È uno dei lati oscuri delle ricerche sul clima.
Questa non è la sola opzione prospettata dalla geoingegneria; ce ne sono altre che riguardano come fronteggiare lo scioglimento dei ghiacci polari che vanno dalla costruzione di dighe sotto le calotte a innevamenti artificiali del continente Antartico. Pura fantascienza! Per costruire dei siti sperimentali per le dighe si tratterebbe di spostare fino a 100 km cubi di materiale con costi dell’ordine di 10.000 miliardi. Un affare, se si considera che il costo stimato causato da un aumento di 1 metro del livello del mare è attorno ai 50.000 miliardi. Non altrettanto buon affare sembrerebbe l’innevamento artificiale che potrebbe costare un minimo di 150.000 miliardi.
Guido Visconti





