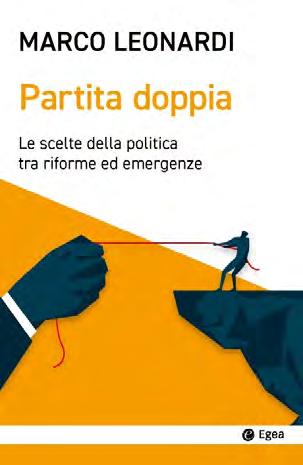11 minute read
Partita doppia. Le scelte della politica tra riforme ed emergenze
La pandemia ha reso possibile quel che prima era impensabile. Due governi, il Conte II e il Draghi, si sono succeduti nella scrittura prima e nell’implementazione poi del PNRR, il Piano di investimenti e riforme da cui dipendono la ripresa e la crescita del nostro Paese.
Negli anni 2020-2022, tuttavia, il dibattito politico ha vissuto un paradosso: mentre i governi annunciavano e realizzavano investimenti di lungo periodo con il PNRR, le riforme strutturali sono state messe da parte proprio per via dell’emergenza. E così, con l’insediamento del Governo Meloni, ci siamo ritrovati a parlare di reddito di cittadinanza e quota pensionistica come se 3 anni e 2 governi non fossero mai passati dato che durante il Governo Conte II e il Governo Draghi non si è riusciti a metter mano a nessuna grande riforma. Il Conte II era infatti un governo politico che in una parte della sua maggioranza si portava dietro proprio quegli errori che avrebbe poi dovuto risolvere; il Draghi invece è rimasto prigioniero dei veti incrociati dei molti partiti che lo componevano (e che magari guardavano già alle elezioni).
Personalmente ho avuto la fortuna di rivestire un ruolo in entrambi i governi, come consigliere del Ministro Gualtieri nel Conte II e come capodipartimento alla Programmazione Economica nel Governo Draghi, e ho potuto seguire la costruzione del PNRR fin dall’inizio. Una «partita doppia», perché si tratta di un Piano a cavallo tra due governi e perché il PNRR è fatto di due ingredienti fondamentali: investimenti e riforme.
L’iniziativa del Next Generation EU, con cui nel giugno 2021 per la prima volta l’Unione Europea ha finanziato con debito comune le spese per investimento dei Paesi aderenti per complessivi 750 miliardi in cinque anni (dal 2022 al 2026), non ha la stessa rilevanza per tutti i Paesi. La Germania, per esempio, ha ottenuto finanziamenti per un piano di investimenti piccolo e tutto sommato marginale nel bilancio del governo tedesco: circa 28 miliardi di euro.
Per l’Italia, complici i suoi tanti ritardi, il PNRR con i suoi 191 miliardi di euro – pari al 25,5% dell’intero Piano - è diventato una sorta di «ultima spiaggia» per ritornare su uno stabile sentiero di crescita, quando i progetti di investimento diventeranno vere e proprie opere di cemento e ferro - accanto ai molti investimenti verdi, come gli impianti di energie rinnovabili.
Il PNRR rappresenta però anche – e forse soprattutto – un cambiamento strutturale nel funzionamento della Pubblica Amministrazione e come tale potenzialmente è in grado di rilanciare la capacità di spesa in investimenti ordinari in un Paese che notoriamente non è capace di spendere che una piccola parte dei fondi per lo sviluppo e la coesione europei (FSE, FESR), e nazionali (FSC).
È nota la difficoltà dell’Italia nella spesa per investimenti; si mette a bilancio 1 miliardo ogni 3 stanziati: sulla base del dato storico dei pagamenti si prevede cioè che solo 1 miliardo su 3 venga effettivamente speso nell’anno in cui è stanziato, il resto rimane a bilancio per un numero molto alto di anni. Paradossalmente conviene anche al bilancio pubblico che lo stanziamento per investimenti sia solo una promessa politica dell’immediato e divenga una spesa effettiva solo nell’arco di molti anni: infatti, finché non si spende, non aumenta il deficit e il debito pubblico.
È evidente da tutti questi numeri come il tasso di realizzazione degli interventi sia insoddisfacente e questo deve rappresentare un utile monito per ripensare l’approccio alla programmazione e all’attuazione degli investimenti pubblici.
Più di una volta il Presidente Draghi sottolineò la necessità di un’accurata quanto celere programmazione delle risorse pubbliche, in grado di garantire tanto una loro efficiente allocazione quanto un loro efficace utilizzo.
Si conta che gli importanti passi in avanti avviati in ambito PNRR in termini di rafforzamento della capacità amministrativa e del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni locali - in particolare di quelle del Sud - dispiegheranno a breve i loro effetti sull’intera gestione delle risorse di investimento. Il modello PNRR, costituito da una metodologia di lavoro per scadenze e risultati, con un cronoprogramma di spesa e di attività definito e misurato tramite specifici obiettivi qualitativi e quantitativi, un monitoraggio proattivo, procedure semplificate e l’impiego di taskforce snelle ed efficaci, diverrà l’auspicata prassi amministrativa a cui ispirarsi per la gestione di tutte le risorse pubbliche e per l’esecuzione degli investimenti pubblici. E forse è questa la vera riforma – una vera e propria rivoluzione – che il PNRR sta contribuendo a realizzare in Italia.
Quel che conta ora è che il governo Meloni non torni indietro sul PNRR per paura di affrontare le riforme in esso contenute e per le difficoltà che i Comuni dovranno affrontare per spendere le risorse del Piano. Il Presidente Meloni sta infatti in parte seguendo le orme del precedente governo circa il suo orientamento sulla guerra ucraina e nella prudenza sui conti pubblici ma d’altro lato su tutta una serie di questioni, compreso il PNRR, sta imboccando una strada radicalmente diversa. Il Piano è ormai ben noto a tutti e non si può dire che riforme e difficoltà di attuazione degli investimenti non fossero ben note fin dall’inizio.
È ovvio che i Comuni - soprattutto quelli del Sud – affronteranno varie difficoltà nella sua attuazione ma la disciplina del PNRR deve essere utilizzata proprio per cambiare il funzionamento della PA e rilanciare la spesa per investimento che tanto serve soprattutto al nostro Mezzogiorno. Rinnegare i vincoli del PNRR spostando i progetti sulla programmazione ordinaria dei fondi di coesione può perfino essere popolare presso le amministrazioni che si sentono oberate di responsabilità ma significa rassegnarsi ai soliti ritardi e inconcludenze tipici degli investimenti finanziati sui fondi di coesione nazionali ed europei. Voler rinegoziare adesso il Piano in maniera sostanziale, magari cedendo terreno agli altri Paesi europei nelle trattative sugli aiuti di Stato e il Patto di stabilità, vorrebbe dire rinunciare in partenza al tentativo di migliorare strutturalmente il funzionamento della nostra PA e perdere tutta la nostra credibilità in Europa.
Marco Leonardi