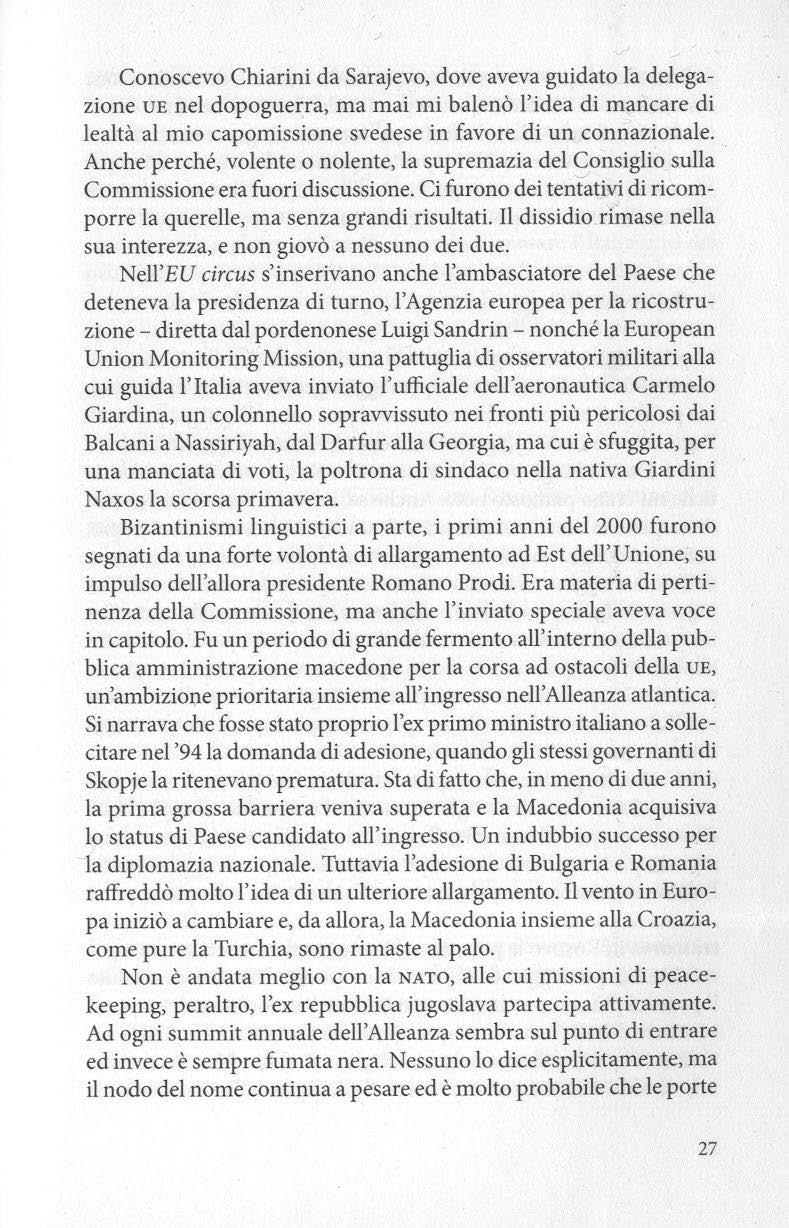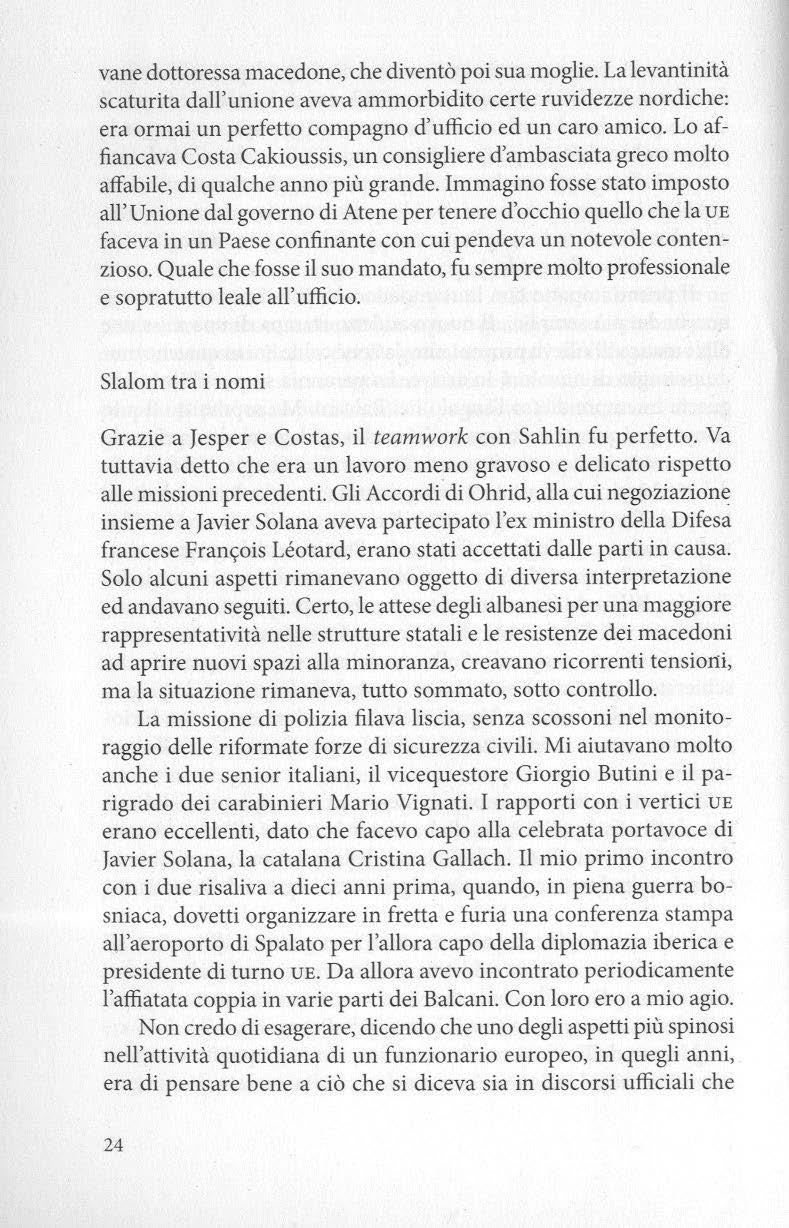
7 minute read
Slalom tra i nomi
from SENZA PACE
vane dottoressa macedone, che diventò poi sua moglie. La levantinità scaturita dall'unione aveva ammorbidito certe ruvidezze nordiche: era ormai un perfetto compagno d'ufficio ed un caro amico. Lo affiancava Costa Cakioussis, un consigliere d'ambasciata greco molto affabile, di qualche anno più grande. Immagino fosse stato imposto ali' Unione dal governo di Atene per tenere d'occhio quello che la UE faceva in un Paese confinante con cui pendeva un notevole contenzioso. Quale che fosse il suo mandato, fu sempre molto professionale e sopratutto leale all'ufficio.
Slalom tra i nomi
Advertisement
Grazie a Jesper e Costas, il teamwork con Sahlin fu perfetto. Va tuttavia detto che era un lavoro meno gravoso e delicato rispetto alle missioni precedenti. Gli Accordi di Ohrid, alla cui negoziazione insieme a Javier Solana aveva partecipato l'ex ministro della Difesa francese François Léotard, erano stati accettati dalle parti in causa. Solo alcuni aspetti rimanevano oggetto di diversa interpretazione ed andavano seguiti. Certo, le attese degli albanesi per una maggiore rappresentatività nelle strutture statali e le resistenze dei macedoni ad aprire nuovi spazi alla minoranza, creavano ricorrenti tensioni, ma la situazione rimaneva, tutto sommato, sotto controllo.
La missione di polizia filava liscia, senza scossoni nel monitoraggio delle riformate forze di sicurezza civili. Mi aiutavano molto anche i due senior italiani, il vicequestore Giorgio Butini e il parigrado dei carabinieri Mario Vignati. I rapporti con i vertici UE erano eccellenti, dato che facevo capo alla celebrata portavoce di Javier Solana, la catalana Cristina Gallach. Il mio primo incontro con i due risaliva a dieci anni prima, quando, in piena guerra bosniaca, dovetti organizzare in fretta e furia una conferenza stampa all'aeroporto di Spalato per l'allora capo della diplomazia iberica e presidente di turno UE. Da allora avevo incontrato periodicamente l'affiatata coppia in varie parti dei Balcani. Con loro ero a mio agio.
Non credo di esagerare, dicendo che uno degli aspetti più spinosi nell'attività quotidiana di un funzionario europeo, in quegli anni, era di pensare bene a ciò che si diceva sia in discorsi ufficiali che
in conversazioni semi-private. Molti nel mondo non sanno, altri l'hanno forse dimenticato, ma il nome ufficiale di quella che comunemente viene chiamata Macedonia è in realtà FYROM (per esteso: Tue former Yugoslav Republic of Macedonia). Così al Palazzo di Vetro, così nei palazzi di Bruxelles. Fu Atene, all'indomani della proclamazione d'indipendenza nel '91, a opporsi al riconoscimento della denominazione Republika Makedonija, perché foriera di rivendicazioni territoriali verso la regione della Grecia settentrionale così chiamata. Anche la bandiera, adottata ufficialmente nel '95 ( che ricordava il sole di Vergina, emblema di Alessandro Magno), venne contestata da Atene ed i raggi di sole dovettero essere ridotti da 16 a 8. Da allora, nonostante vari tentativi di mediazione, la questione del nome è rimasta irrisolta.
Ciò comportava che la parola Macedonia, come pure l'aggettivo, non potessero essere pronunciate (è tuttora così), né tantomeno scritta, pena un'immediata démarche della rappresentanza greca presso l'Unione europea, con la denuncia del funzionario tal dei tali, reo di aver usato il nome improprio, nel tal giorno e durante la tal riunione. Da Bruxelles arrivavano poi, inevitabilmente, lavate di capo; fino a due svarioni venivano perdonati, al terzo si rischiava di essere richiamati. Parallelamente, se si usava il termine FYROM, scendeva immediatamente il gelo con l'interlocutore nazionale. Chi ripeteva l'errore, rischiava di essere dichiarato persona non grata dal Paese ospitante e di dover fare le valigie in meno di 48 ore.
La scappatoia era dire/scrivere sempre the Skopje government o the country. Anche se poi qualche testata il giorno dopo non mancava di rimarcare ironicamente che il tal oratore, nel suo discorso, aveva pronunciato tot volte la parola country.
Ricordo un improvvido alto funzionario di Bruxelles scandire Macedonia con tanto di microfono alla cerimonia ufficiale di consegna delle medaglie UE ai membri della missione di polìzia, presente l'intero corpo diplomatico. La rappresentante greca, un'avvenente signora bionda, che sedeva nelle prime file, si alzò di scatto e, dopo poco, con sgommata non casuale si allontanò. Pe'r completezza, va aggiunto che sulla Mercedes nera della legazione greca, così come sulle altre vetture CD della rappresentanza ellenica, Atene aveva coperto con nastro adesivo la sigla MK presente nelle targhe automo-
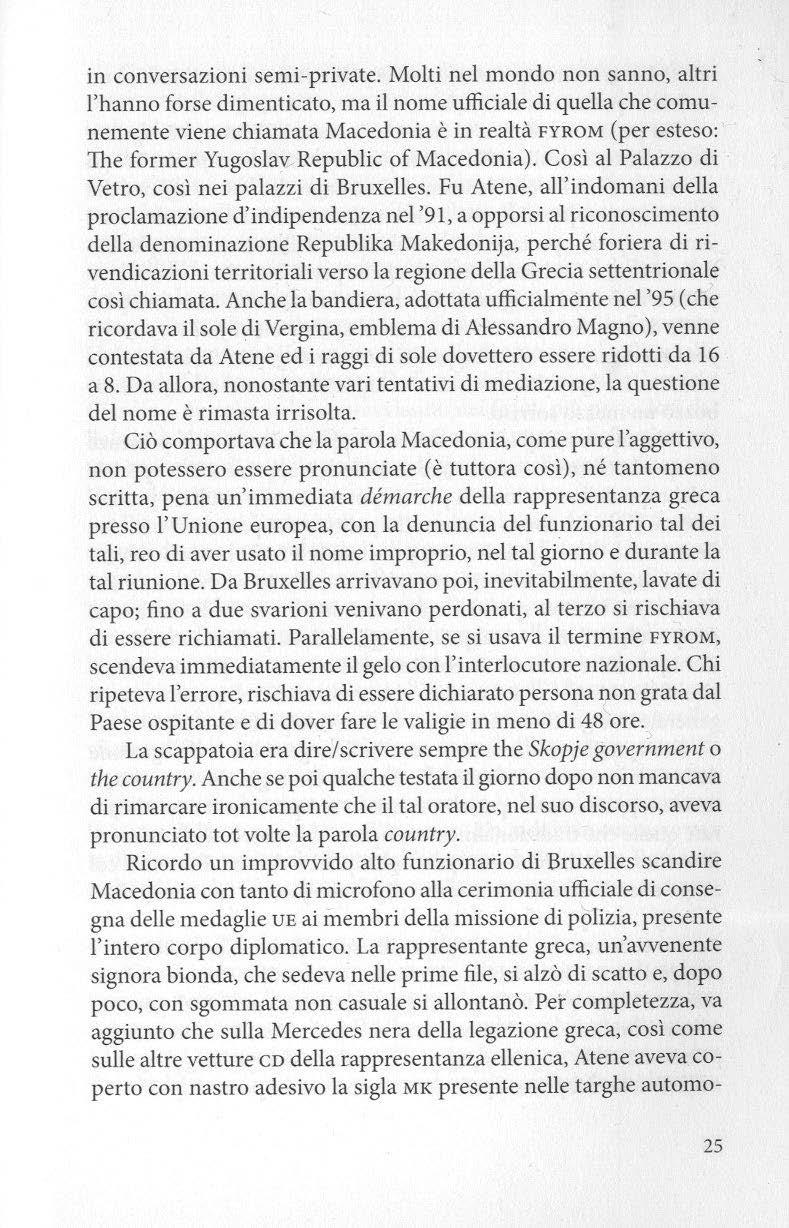
bilistiche: uno stratagemma su cui la polizia macedone chiudeva un occhio, seppur malvolentieri.
Per pura coincidenza, la stessa sera andai ali' Hunters Lodge, un ristorante tipico sulle colline della periferia est della capitale. Tra gli avventori c'era Dora Grossomanidou, capo del liaison office della Grecia (Atene, per marcare le distanze, non aprì mai un'ambasciata vera e propria) e protagonista involontaria dell'increscioso episodio della mattina. Cercai di svicolare, anche per il fatto che la conoscevo poco e male. Ma gli sguardi s'incrociarono e, con il massimo possibile di nonchalance, mi avvicinai al suo tavolo. I feel very sorry, your excellency, far what happened this morning, esordii, baciandole la mano. Lo sguardo corrucciato si ammorbidì e, nel salutarmi, abbozzò un mezzo sorriso.
Non meno semplice era tenere i rapporti con le altre presenze europee in teatro. La stessa coabitazione del rappresentante speciale e del capo della missione di polizia poteva a volte risultare problematica. Il primo aveva il controllo politico dei poliziotti UE. Una definizione di compiti non sempre chiara, o forse ]asciata volutamente vaga, che a volte creava malintesi e dissapori. Nei momenti di tensione toccava spesso a me - essendo l'unico funzionario con doppia dipendenza -e al politica[ officer della polizia Florian von Konigs (molto stimato da Sahlin) mediare tra un piano e l'altro. Non fu mai impresa ardua, dato che erano sia l'ambasciatore che il generale due gentiluomini dotati di notevole professionalità.
Più complesse le relazioni con l'ufficio gemello, la delegazione della Commissione. Infatti, nella dozzina di luoghi dove sono stati inviati rappresentanti speciali UE, hanno sempre continuato ad operare quelle che tradizionalmente vengono chiamate le ambasciate di Bruxelles. Una diarchia europea dagli equilibri delicati. Entrambi col rango di an1basciatore: uno, privo di portafoglio, ma con alle spalle il Consiglio europeo e forte della guida di Javier Solana; l'altro, con molte risorse economiche, facente capo alla subordinata Commissione. I rapporti tra Michael Sahlin e l'italiano Donato Chiarini non furono mai facili. Non c'era feeling tra il diplomatico con passato di governo e l'euroburocrate. Fu il quotidiano «Utrinski Vesnilo> a metterlo in piazza titolando in prima pagina EU ambassadors fighting far power nell'edizione del primo aprile 2005. E non era un pesce d'aprile.
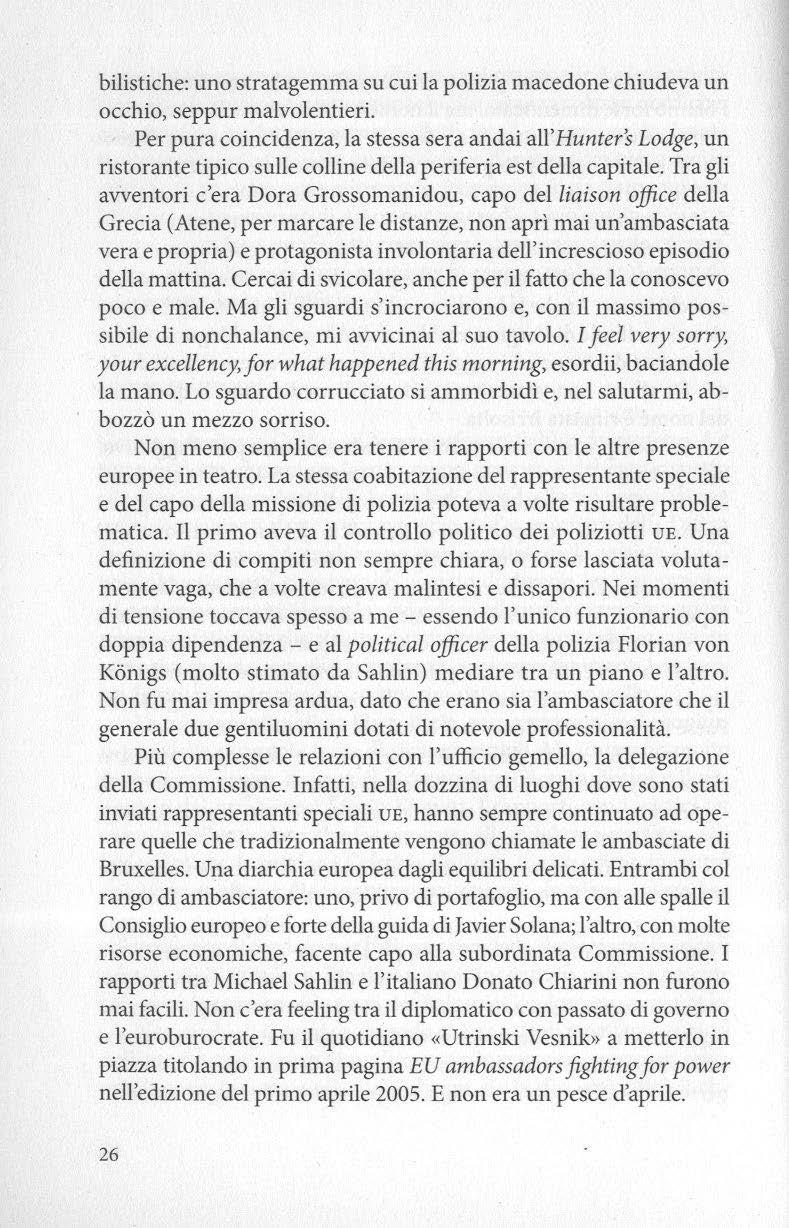
Conoscevo Chiarini da Sarajevo, dove aveva guidato la delegazione UE nel dopoguerra, ma mai mi balenò l'idea di mancare di lealtà al mio capomissione svedese in favore di un connazionale. Anche perché, volente o nolente, la supremazia del Consiglio sulla Commissione era fuori discussione. Ci furono dei tentativi di ricomporre la querelle, ma senza grandi risultati. Il dissidio rimase nella sua interezza, e non giovò a nessuno dei due.
Nell'EU circus s'inserivano anche l'ambasciatore del Paese che deteneva la presidenza di turno, l'Agenzia europea per la ricostruzione - diretta dal pordenonese Luigi Sandrin - nonché la European Union Monitoring Mission, una pattuglia di osservatori militari alla cui guida l'Italia aveva inviato l'ufficiale dell'aeronautica Carmelo Giardina, un colonnello sopravvissuto nei fronti più pericolosi dai Balcani a Nassiriyah, dal Darfur alla Georgia, ma cui è sfuggita, per una manciata di voti, la poltrona di sindaco nella nativa Giardini Naxos la scorsa primavera.
Bizantinismi linguistici a parte, i primi anni del 2000 furono segnati da una forte volontà di allargamento ad Est dell'Unione, su impulso dell'allora presidente Romano Prodi. Era materia di pertinenza della Commissione, ma anche l'inviato speciale aveva voce in capitolo. Fu un periodo di grande fermento all'interno della pubblica amministrazione macedone per la corsa ad ostacoli della UE, un'ambizione prioritaria insieme all'ingresso nell'Alleanza atlantica. Si narrava che fosse stato proprio l'ex primo ministro italiano a sollecitare nel '94 la domanda di adesione, quando gli stessi governanti di Skopje la ritenevano prematura. Sta di fatto che, in meno di due anni, la prima grossa barriera veniva superata e la Macedonia acquisiva lo status di Paese candidato all'ingresso. Un indubbio successo per la diplomazia nazionale. Tuttavia l'adesione di Bulgaria e Romania raffreddò molto l'idea di un ulteriore allargamento. Il vento in Europa iniziò a cambiare e, da allora, la Macedonia insieme alla Croazia, come pure la Turchia, sono rimaste al palo.
Non è andata meglio con la NATO, alle cui missioni di peacekeeping, peraltro, l'ex repubblica jugoslava partecipa attivamente. Ad ogni summit annuale dell'Alleanza sembra sul punto di entrare ed invece è sempre fumata nera. Nessuno lo dice esplicitamente, ma il nodo del nome continua a pesare ed è molto probabile che le porte