L ’ età contemporanea
Didattica per competenze
Attività linguistiche e grammaticali
Atlante geostorico integrato
Apprendimento cooperativo






Didattica per competenze
Attività linguistiche e grammaticali
Atlante geostorico integrato
Apprendimento cooperativo






1 Collegati al portale www.raffaellodigitale.it DIRETTAMENTE ON LINE
2
Clicca sull'icona Raffaello Player on line
Cerca i testi da attivare
3
All'interno del portale è presente tanto materiale da scaricare
1
2
3
Scarica il Raffaello Player dai seguenti store CON IL TUO DEVICE
Una volta installato il Raffaello Player apri la libreria
Cerca i testi da attivare
1
2
Inserisci il DVD che trovi in allegato al testo e clicca sul file “Raffaello Player” CON IL DVD
Una volta installato il Raffaello Player apri la libreria
3
Carica i testi presenti nel DVD, cliccando il tasto
Inquadra la pagina e attiva i contenuti multimediali
Lo puoi utilizzare off line anche senza connessione internet

La registrazione è facoltativa e consente di ricevere gli aggiornamenti del testo.
ATTIVA IL M.I.O. BOOK CON IL CODICE DI SBLOCCO RIPORTATO QUI
L ’ età contemporanea
Coordinamento editoriale: Emanuele Palazzi
Redazione: Luca Brecciaroli, Ilaria Cofanelli, Gabriella Giaccone, Emanuele Palazzi
Consulenza didattica: Giovanna Dolcini, Claudia Ferri
Progetto grafico: Alessandra Coppola, Giorgio Lucarini, Simona Albonetti
Illustrazioni: Ivan Stalio, Filippo Pietrobon
Impaginazione: Edistudio
Copertina: Simona Albonetti
Ritocco fotografico: Claudio Campanelli
Cartografia: LS International Cartography
Coordinamento M.I.O. BOOK: Paolo Giuliani
Ufficio multimediale: Enrico Campodonico, Paolo Giuliani, Claudio Marchegiani, Luca Pirani
Le parti ad alta leggibilità di quest’opera sono state realizzate con la font leggimi © Sinnos editrice
Stampa: Gruppo Editoriale Raffaello
Il Gruppo Editoriale Raffaello mette a disposizione i propri libri di testo in formato digitale per gli studenti ipovedenti, non vedenti o con disturbi specifici di apprendimento.
L’attenzione e la cura necessarie per la realizzazione di un libro spesso non sono sufficienti a evitare completamente la presenza di sviste o di piccole imprecisioni. Invitiamo pertanto il lettore a segnalare le eventuali inesattezze riscontrate. Ci saranno utili per le future ristampe.
Tutti i diritti sono riservati.
© 2019
Raffaello Libri S.p.A
Via dell’Industria, 21 60037 Monte San Vito (AN) www.grupporaffaello.it info@grupporaffaello.it
È vietata la riproduzione dell’opera o di parti di essa con qualsiasi mezzo, comprese stampa, fotocopie e memorizzazione elettronica se non espressamente autorizzate dall’Editore.
Nel rispetto delle normative vigenti, le immagini che rappresentano marchi o prodotti commerciali hanno esclusivamente valenza didattica.
L’Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, nonché per eventuali omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti.
Ristampa:
Referenze fotografiche
Archivi Alinari, Firenze - Engler / Ullstein Bild/Archivi Alinari - DeA Picture Library, concesso in licenza ad Alinari - 2001 / TopFoto / Archivi Alinari - Iberfoto / Archivi Alinari - World History Archive/Archivi Alinari - Granger, NYC /Archivi Alinari - Fine Art Images/Archivi Alinari - 2005/HIP / TopFoto / Archivi Alinari - The British Library Board/Archivi Alinari - Hervé Lewandowski / RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Christie's Images / Artothek/Archivi Alinari - © Mary Evans / Archivi Alinari - Imagno/Archivi Alinari - Veneranda Biblioteca Ambrosiana / DeA Picture Library, concesso in licenza ad Alinari - Per Concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Raffaello Bencini/Archivi Alinari - Turi Luca, 1991 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - EPA / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Antonio Monteforte, 1993 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Agence Bulloz / RMN-Rèunion des Musèes Nationaux/ distr. Alinari - Thierry Ollivier / RMNRéunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - CNAC/MNAM / RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Sergey Guneev / Sputnik/ Archivi Alinari - 2002/ UPPA / TopFoto / Archivi Alinari - UIG/Archivi Alinari - Ullstein Bild / Archivi Alinari - Archivio Bruni/Gestione Archivi Alinari, Firenze - Albert Harlingue / Roger-Viollet/ Alinari - Colección Gasca / Iberfoto/Archivi Alinari - Toni Schneiders / Interfoto/ Archivi Alinari - BPK/Archivi Alinari - Ronald Grant Archive / © Mary Evans / Archivi Alinari - ÷NB / Imagno/Archivi Alinari - Austrian Archives / Imagno/Archivi Alinari - Interfoto/Archivi Alinari - Quint Lox / Liszt Collection/Archivi Alinari - Gérard Blot / RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Roger-Viollet/AlinariGiuseppe Giglia, 2008 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Touring Club Italiano/Gestione Archivi Alinari - Archiv Friedrich / Interfoto/Archivi Alinari - Istituto Luce/Gestione Archivi Alinari - Heinrich Hoffmann / BPK/Archivi Alinari - Votava / Imagno/Archivi Alinari - awkz / Interfoto/Archivi Alinari - Paul Mai / Ullstein Bild / Archivi Alinari - RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Luca Zennaro, 1944 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Petit Palais / Roger-Viollet/ Alinari - Raffaello Bencini/Archivi Alinari - Touring Club Italiano/Gestione Archivi Alinari - BHVP / Roger-Viollet/Alinari - BeBa / Iberfoto/Archivi Alinari - Artothek/ Archivi Alinari - Conservatori Riuniti di Siena/Archivi Alinari - Hartramph / Ullstein Bild / Archivi Alinari - Kurt Hamann / Ullstein Bild / Archivi Alinari - © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Archivio Luigi Leoni / Archivi Alinari - EPA PHOTO / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Carlo Ferraro, 1999 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Musée Carnavalet / Roger-Viollet/Alinari - Mary Evans/Scala, Firenze - Scala, Firenze - Scala, Firenze su concessione Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo - Scala, Firenze/bpk, Bildagentur fuer Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin - DeAgostini Picture Library/Scala, Firenze - A. Dagli Orti/Scala, Firenze - White Images/Scala, Firenze - The British Library Board/ Scala, Firenze - Ann Ronan/Heritage Images/Scala, Firenze - Museum of Fine Arts, Boston/Scala, Firenze - Christie's Images, London/Scala, Firenze - Photo Josse/Scala, Firenze - Werner Forman Archive/Scala, Firenze- Mario Bonotto/Foto Scala, Firenze - Scala, Firenze/Luciano Romano - Scala, Firenze/Mauro Ranzani - Veneranda Biblioteca Ambrosiana/DeAgostini Picture, Library/Scala, FirenzeManuel Cohen/Scala, Flirenze - The Metropolitan Museum of Art/Art Resource/ Scala, Firenze - The Morgan Library & Museum/Art Resource, NY/Scala, FirenzeDUfoto/Scala, Firenze - Austrian Archives/Scala, Firenze - Scala Firenze/Heritage Images - The Print Collector/Heritage-Images/Scala, Firenze - Museo Nacional del Prado/Scala, Firenze - Stapleton Historical Collection/Heritage Images/Scala, Firenze - Mimmo Frassineti © 2018. AGF/Scala, Firenze - Cinecittà Luce /Scala, Firenze - Keystone Archives/Heritage Images/Scala, Firenze - National Portrait Gallery, London/ Scala, Firenze - Adagp Images, Paris, / SCALA, Firenze - Scala, Firenze/V&A Images/Victoria and Albert Museum, Londra - Trustees of the Wallace Collection, Londra/ SCALA, Firenze - Smithsonian American Art Museum/Art Resource/Scala, Firenze - 123RF - Istockphoto - Shutterstock - Getty imagesAlamy - archivio fotografico Gruppo Ed. Raffaello



















































































































































































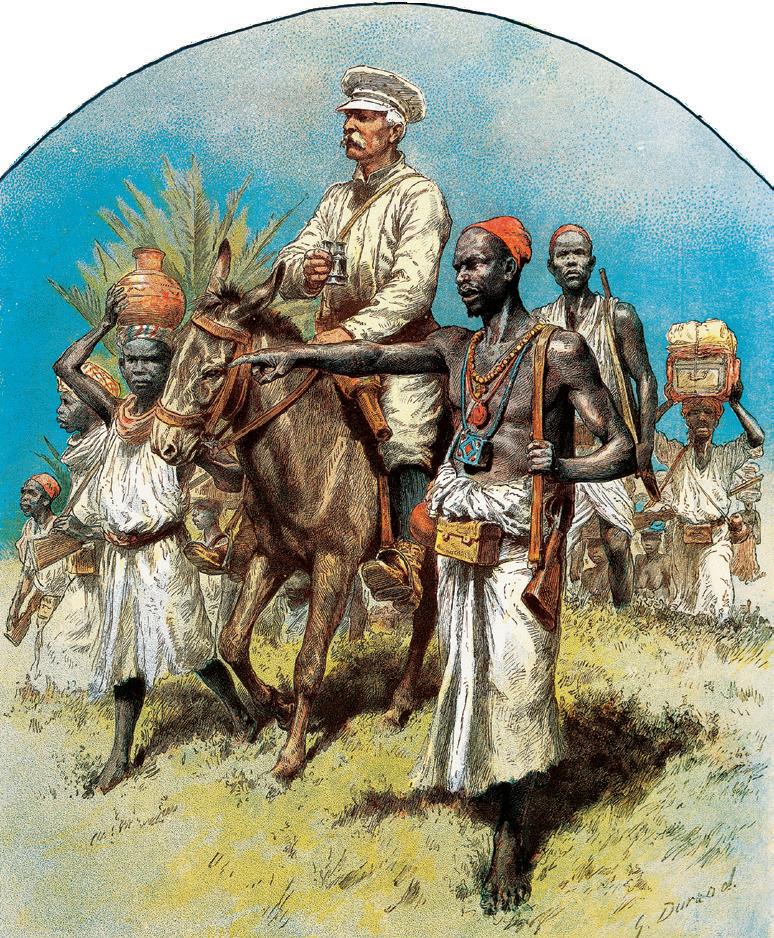
Nella seconda metà dell’Ottocento le potenze europee che avevano avuto un ruolo di primo piano all’epoca del colonialismo (XVI-XVIII secolo) diedero nuovo impulso alla conquista del pianeta e alla sottomissione di intere regioni e popoli ai loro interessi politici ed economici: è l’epoca dell’imperialismo. Ne furono protagonisti soprattutto Regno Unito e Francia, seguite da Germania, Belgio, Stati Uniti e Giappone. Anche l’Italia, che tra fine Ottocento e inizio Novecento stava diventando uno Stato liberale e cominciava il proprio decollo industriale, partecipò alla stagione imperialista. Vittime dell’imperialismo furono molti Paesi dell’Africa e dell’Asia.
1871-1888
Cancellierato di Bismarck
1876
Inizio età imperialismo
La regina Vittoria diventa imperatrice dell’India
1870
Sconfitta della Francia nella guerra franco-prussiana
v Nell’Ottocento, Francia, Olanda, Belgio e Germania diventano Paesi industriali. Aumenta la concorrenza fra i Paesi più sviluppati.
v I Paesi dell’Europa meridionale e centro-orientale rimangono estranei al processo di industrializzazione.
v Gli USA, dopo la guerra civile del 1861-1865, conoscono una rapida crescita demografica ed economica, gettando le basi per trasformarsi in un Paese capitalistico e industriale. La Russia, invece, rimane arretrata sia sul piano politico sia sul piano economico.
v L’Italia, dopo il Risorgimento e la conquista dell’unità, avvia un lento processo di modernizzazione, cercando di recuperare il ritardo nei confronti degli altri Paesi europei.
1878
Congresso di Berlino
1881-1895
Espansione francese in Africa
1882
Triplice alleanza
1887
Sconfitta di Dogali
1884-1885
Conferenza di Berlino

1889
Trattato di Uccialli
Gli Stati Uniti entrarono nell’impresa coloniale sostenendo l’indipendenza di Cuba dalla Spagna, per poi estendere la loro influenza su America latina e isole del Pacifico.

1896
Sconfitta di Adua
Le potenze europee diressero i loro obiettivi coloniali sull’Africa (occupandola quasi interamente e spartendosela a tavolino alla fine del XIX secolo) e sul Sud-Est asiatico.
Il Giappone espanse i suoi domini su isole del Pacifico, Corea e Manciuria, entrando in conflitto con la Russia.
1900
Presenza semi-coloniale di diverse potenze europee in Cina
1905
Guerra russo-giapponese
Prima rivoluzione russa
1911-1912
Guerra di Libia
1898
Guerra tra Stati Uniti e Spagna

1908
Rivolta dei Giovani turchi
1914-1918
Prima guerra mondiale
v Regno Unito, Francia, Germania, USA e Giappone sono protagonisti dell’imperialismo, cioè dell’assoggettamento politico ed economico di vaste regioni del pianeta e dello sfruttamento delle loro risorse.
v L’Italia partecipa alla spartizione imperialista, concentrando i suoi interessi sul Corno d’Africa e sulla Libia.
v L’Africa subisce il dominio imperialistico, specialmente di Francia e Regno Unito.
v L’Asia soffre sia l’imperialismo occidentale (Francia, Regno Unito, USA) sia quello interno (il Giappone espande la propria area d’influenza, anche a danno della Russia). La Cina rimane formalmente autonoma, ma in realtà è soggetta allo sfruttamento economico occidentale.
v L’Italia getta le basi per trasformarsi in un grande Paese liberale e industriale.
Quale fu la causa principale dell’espansione coloniale europea nel corso del XV e del XVI secolo? Sottolinea la frase che ti consente di rispondere.
Transoceanico
Dalla fine del XV secolo alla prima metà del XIX: il colonialismo
Tra XV e XVI secolo, le scoperte geografiche di Spagna e Portogallo, e in un secondo momento di Francia, Regno Unito e Olanda, avevano portato alla fondazione di colonie nei territori scoperti. I colonizzatori europei si erano stabiliti in regioni più o meno grandi, nelle quali avevano sottomesso le popolazioni locali (come nel caso delle potenze iberiche nelle Americhe) oppure fondato scali commerciali (come fece il Portogallo in Asia). La motivazione principale era per lo più economica, in quanto il possesso di colonie garantiva alle potenze europee il controllo sui commerci transoceanici. L’espansione europea aveva portato alla creazione di grandi imperi coloniali. Il più grande e importante era l’impero spagnolo, che comprendeva quasi tutto il continente americano dalle regioni dell’America settentrionale comprese tra la California e la Florida fino alla Patagonia, all’estremo sud dell’America meridionale (ad eccezione del Brasile, che era sotto la sovranità portoghese). Nella prima metà del XIX secolo, però, la «classifica» delle potenze coloniali subì un profondo cambiamento: la Spagna perse le sue colonie americane, mentre Regno Unito e Francia, pur avendo perso i possedimenti acquistati nel Nord-America a partire del XVII secolo, rafforzarono i loro domini in Asia e Africa imponendosi come potenze dominanti.
Il colonialismo europeo nel 1870
La carta mostra i possedimenti coloniali europei nella seconda metà del XIX secolo. Come vedi, attorno al 1870 il Regno Unito aveva il controllo di ampie regioni del mondo: da esse ricavava le materie prime che gli consentivano di mantenere un indiscusso primato economico mondiale. Nello stesso periodo la Francia concentrò le sue attenzioni sul SudEst asiatico e sul Mediterraneo meridionale. Rispondi alle domande.
1. Nel 1870 fra quali potenze europee risultano «spartiti» i continenti di Africa e Asia?
2. Spagna, Portogallo e Olanda, ossia le grandi potenze coloniali del XVI-XVIII secolo, occupavano ancora molti territori? Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda. No.


Verso la fine del XIX secolo il processo di colonizzazione subì una forte accelerazione. Tale processo assunse alcune caratteristiche che lo resero in parte diverso rispetto al colonialismo dei secoli passati:
• coinvolse un numero molto maggiore di potenze;
• usò quasi sempre le armi per imporsi;
• puntò al dominio politico, oltreché economico, di intere regioni
Gli storici chiamano imperialismo questa nuova forma di colonialismo. L’età dell’imperialismo ebbe inizio dopo il 1870 e si concluse nel 1914, con lo scoppio della Prima guerra mondiale. I protagonisti della stagione imperialista furono innanzitutto il Regno Unito e la Francia e, in seguito, anche il Belgio, la Russia, la Germania e l’Italia.
Alle potenze europee si aggiunsero gli Stati Uniti d’America (in America latina e nelle Filippine) e il Giappone (in Asia).


Gli imperialisti cercarono di giustificare moralmente e teoricamente la loro politica di sottomissione utilizzando in chiave politica le teorie sull’evoluzione delle specie del naturalista britannico Charles Darwin (18091882) secondo cui i soggetti più forti e capaci di adattarsi all’ambiente sono destinati a vincere la lotta per la sopravvivenza nei confronti degli individui più deboli. Questa teoria, elaborata da Darwin nel campo della biologia (cioè la scienza che studia gli esseri viventi), venne applicata anche allo studio della società umana.
Il risultato fu il «darwinismo sociale», cioè la teoria che afferma che anche nella società umana ci sono soggetti più forti destinati a dominare e soggetti più deboli destinati a essere oppressi. Il darwinismo sociale usava il linguaggio della scienza, ma in realtà non aveva nulla di scientifico: esso forniva una giustificazione ideologica e pseudoscientifica alla volontà di conquista dei Paesi più potenti a danno di quelli più fragili. Scienziati e filosofi basarono inoltre su quelle teorie la tesi della superiorità della «razza» bianca, dimostrata dal fatto che la civiltà dei bianchi aveva raggiunto un alto livello culturale e tecnologico. Questa considerazione portava a giustificare la sottomissione dei popoli colonizzati (di pelle nera o gialla) come «educazione» alla civiltà. Si arrivò addirittura a ritenere che fosse un compito morale dell’uomo bianco quello di innalzare popoli ritenuti inferiori. Il razzismo (la discriminazione fondata sulla presunta differenza tra «razze» superiori e inferiori) comprese anche il concetto di «purità della razza»: all’interno della «razza» bianca venivano individuate delle categorie considerate anomale, quali i portatori di handicap, gli omosessuali, i rom e gli ebrei. I pregiudizi verso quelle persone fomentarono discriminazioni che si tradussero spesso in violenza collettiva. In quel clima prese particolarmente vigore l’antisemitismo, cioè l’ostilità verso gli ebrei.
COMPRENDO IL TESTO
Sottolinea le caratteristiche che differenziano l’imperialismo dal colonialismo.

Charles Darwin raccolse i dati dell’evoluzione delle specie animali e vegetali, viaggiando intorno al mondo. Pubblicò i suoi studi nel libro L’origine delle specie per selezione naturale, nel 1859.
COMPRENDO IL TESTO
Perché le teorie di Darwin furono usate per giustificare l’imperialismo degli Stati europei?
a Perché sostenevano la superiorità della razza bianca.
b Perché affermavano il diritto del più forte a prevalere sul più debole.
c Perché si accordavano con la morale cristiana. X
LAVORO SULLA LINGUA
Elenca le sette parole chiave che definiscono il concetto di «nazione». L’esercizio è avviato.
1. Lingua
2. 3. 4.
Storia
Usi
Costumi
5. 6. 7. Indipendenza
Territorio con precisi confini
Libertà
L’imperialismo era sostenuto ideologicamente, oltre che dal darwinismo sociale, dal nazionalismo.
Il nazionalismo era un’eredità della Rivoluzione francese del 1789. Per i rivoluzionari la nazione era un soggetto storico formato da un popolo che condivideva lingua, storia, usi e costumi e da un territorio con precisi confini. Ogni popolo che formava una nazione, sostenevano i rivoluzionari, aveva diritto alla propria libertà e indipendenza.
Nella prima metà dell’Ottocento questa idea di nazione si era diffusa in Europa e nelle Americhe ed era stata uno strumento di liberazione: i greci, i polacchi, gli italiani, i tedeschi e i popoli latino-americani avevano fatto appello agli ideali nazionali nella loro lotta per liberarsi dall’oppressione straniera e per conquistare la propria indipendenza politica. L’idea di nazione, dunque, era un ideale democratico.
Nella seconda metà del XIX secolo, però, l’idea di nazione cambiò radicalmente di significato e diventò un’arma usata dai governi per rafforzare la loro politica di potenza. L’identità nazionale finì per esaltare lo spirito di competizione fra gli Stati e per convincere i cittadini di un certo Paese di essere superiori e migliori degli altri. Nacque così il nazionalismo, cioè la violenta rivendicazione della propria supremazia su altre nazioni.
LAVORO SULLA FONTE
La «religione della patria»
Nel saggio L’idea di nazione, pubblicato nel 1961, lo storico Federico Chabod (1901-1960) indaga sul significato del termine nazione. L’attuale significato nacque nell’Ottocento, influenzato dal Romanticismo. In quel contesto culturale all’idea di nazione, intesa soprattutto come Stato, si sovrappone quella di patria, cioè di territorio abitato da un popolo che condivide lingua, storia e tradizioni. Alla patria è attribuito un valore sacro e i popoli che vivono in una patria-nazione frammentata e soggetta allo straniero sentono di sacrificare la vita per essa.
Il secolo XIX conosce quel che il Settecento ignorava: le passioni nazionali.
[…] La nazione diventa la patria: e la patria diviene la nuova divinità del mondo moderno.
Nuova divinità: e come tale sacra. […] Patria, sacra; sangue versato per essa, santo. Ed ecco che da allora, effettivamente, voi sentite parlare di martiri per l’indipendenza, la libertà, l’unità della patria […]. Gran mutare del senso delle parole! Per diciotto secoli, il termine martire era stato riservato a coloro che versavano il proprio sangue per difendere la propria fede religiosa; martire era chi cadeva col nome di Cristo sulle labbra. Ora, per la prima volta, il termine viene assunto ad indicare valori, affetti, sacrifici politici: i quali dunque acquistano l’importanza e la profondità dei valori, affetti, sacrifici religiosi, diventano religione anch’essi […].
La “religione della patria”, cioè della nazione. I due termini sono equivalenti. [...]
Rispondi alle domande.
1. Da quando in Europa il termine «nazione» si identifica con il termine «patria»?
Dal XIX secolo.
2. Che cosa diventa la patria nel XIX secolo?
La nuova divinità del mondo moderno.
3. Che significato assume il termine «martire» a partire dal XIX secolo?
Chi versa il proprio sangue per valori, affetti, sacrifici politici.
Le cause dell’imperialismo occidentale in Africa e in Asia furono principalmente economiche. Le nuove terre conquistate, infatti, assicuravano la fornitura di materie prime necessarie all’industria (come il petrolio, i minerali pregiati o le fibre naturali per tessuti) e costituivano un mercato in cui vendere le merci prodotte.

L’economia delle colonie, dunque, si piegò agli interessi delle potenze imperialiste. Per esempio, la produzione agricola destinata al consumo locale fu limitata e venne sostituita dalla coltivazione in immense piantagioni di pochi o di un solo prodotto agricolo (monocoltura) destinato all’esportazione: cacao, caffè, arachidi ecc. Lo stesso avvenne nel settore minerario. L’importazione di prodotti occidentali realizzati in serie, e perciò meno costosi, distrusse l’artigianato locale, incapace di reggere la concorrenza.
Le colonie furono obbligate a importare solo i prodotti industriali dello Stato imperialista dove esportavano, invece, le loro materie prime. In questo modo, lo Stato imperialista aumentò la sua ricchezza, mentre le sue colonie non ebbero più possibilità di svilupparsi autonomamente.
L’imperialismo ebbe però anche obiettivi politici: in Francia, per esempio, l’occupazione di territori extraeuropei serviva a rafforzare il prestigio nazionale
Inoltre, fu utile per dare sfogo alle tensioni sociali interne ai Paesi industrializzati: il sogno dell’impero, infatti, «distraeva» milioni di lavoratori dai problemi economici e sociali che vivevano nella quotidianità, illudendoli con il miraggio di nuove opportunità di lavoro e di ricchezza.
Indigeni del Ghana lavorano in una piantagione di cacao per i coloni bianchi.
L’industria tessile del Regno Unito conobbe un notevole sviluppo nel XIX secolo: era favorita da macchinari, messi a punto nel Settecento, che potevano essere usati da donne e bambini (manodopera a basso costo), e godeva di una eccezionale disponibilità di cotone proveniente soprattutto dalle colonie indiane (anche questa risorsa era a basso costo).
COMPRENDO IL TESTO
Sottolinea con colori diversi:
• le conseguenze economiche dell’imperialismo nei Paesi sottomessi;
• le conseguenze economiche dell’imperialismo nei Paesi dominanti

Sottolinea con colori diversi le conquiste britanniche e quelle francesi in Africa.
Erano i coloni provenienti dall’Olanda che si erano installati nella zona del Capo di Buona Speranza dopo la fondazione di Città del Capo nel 1652. Il termine deriva dall’olandese boer, «contadino».

Le politiche di conquista degli Stati europei, soprattutto di Regno Unito e Francia, si rivolsero principalmente verso l’Africa.
L’espansione britannica si concentrò in Sudan, Uganda e Kenya e nelle regioni a nord della Colonia del Capo (l’attuale Sudafrica), che entrarono a far parte dei possedimenti britannici dopo una dura guerra contro i boeri, i discendenti dei coloni olandesi che abitavano la regione da oltre un secolo e mezzo.
La Francia, invece, occupò le regioni occidentali e centrali del continente, assicurandosi anche il controllo dell’Algeria. Pure il Belgio partecipò alla conquista dell’Africa: re Leopoldo II finanziò le spedizioni dell’esploratore Henry Stanley che risalì il fiume Congo stipulando per conto del re contratti commerciali con i capitribù locali. A seguito di queste operazioni fu fondato nel 1884-1885 lo Stato del Congo, sotto la sovranità belga.

Protettorato
È una forma di tutela politica e militare esercitata da uno Stato più potente nei confronti di un altro. In base a un accordo internazionale, lo Stato protettore può intervenire negli affari interni e internazionali dello Stato «protetto».
Le conquiste, però, scatenarono una forte rivalità e gravi tensioni fra le potenze europee, ciascuna delle quali voleva costruire un impero coloniale sempre più ampio. Per evitare la guerra e per giungere a un accordo generale, tra il 1884 e il 1885 si tenne la Conferenza coloniale di Berlino: quattordici Stati si accordarono per spartirsi il continente africano. La divisione fu fatta «a tavolino» sulla base degli equilibri politici e strategici tra le potenze, senza tenere conto delle realtà locali che da secoli vivevano in quelle terre.
In India il Regno Unito esercitava la sua egemonia grazie alla Compagnia delle Indie orientali, un’associazione privata che in realtà agiva come un vero e proprio Stato, dotato di un suo governatore (nominato dal governo britannico), di un esercito e del potere di stringere accordi diplomatici. Nella seconda metà del XIX secolo Londra, preoccupata per l’eccessiva autonomia del Governatore della Compagnia delle Indie, assunse direttamente il governo del Paese. L’India, infatti, era la colonia più importante per l’economia britannica. Nel 1876 nacque così l’Impero indiano, al quale si aggiunsero, nel 1886, anche la Birmania (l’attuale Myanmar) e la penisola malese: la regina Vittoria diventò «imperatrice d’India». Nel continente asiatico l’espansione francese, che mirava al possesso delle materie prime locali (fra cui gomma e riso) e a strappare l’egemonia dell’area al Regno Unito, si rivolse verso la regione sud-orientale. Fin dal 1860 la Francia aveva ottenuto il protettorato sulla Cambogia; nel 1884 essa riunì in un solo regime coloniale, detto Unione indocinese, il Vietnam del Sud (Cocincina), il Vietnam del Nord (Tonchino) e la Cambogia.

L’intervento dei Paesi occidentali in Asia suscitava grande preoccupazione in Cina. I rapporti tra il grande impero asiatico e l’Occidente erano già da tempo tesi. A metà Ottocento il Regno Unito aveva favorito il commercio illegale di oppio non rispettando le leggi cinesi nel commercio della droga, provocando così le cosidette guerre dell’Oppio (1839-1842 e 1856-1860). La vittoria dei britannici aveva costretto la Cina ad accettare trattati commerciali sfavorevoli sia con Francia, Regno Unito e Stati Uniti. A indebolire l’autorità della dinastia Manciù, che regnava da due secoli sull’immenso impero, contribuirono anche l’occupazione di alcuni territori nord-occidentali da parte dei russi, della Corea e dell’isola di Formosa (1894-1895) da parte del Giappone, mentre la Germania nel 1897 insediò una base commerciale sul mar Giallo. Nel 1900 scoppiò la rivolta popolare detta dei Boxer («pugili»): fu promossa dai patrioti dell’antica e segreta Società della giustizia e della concordia, gruppo popolare fortemente contrario alla presenza occidentale in Cina. Alla società aderivano molti allievi delle scuole di kung fu, «pugili» per gli europei. La rivolta causò molte vittime e provocò l’intervento armato delle potenze coloniali, che culminò con la presa di Pechino nell’agosto 1900: ci furono molti morti, saccheggi e violenze; l’imperatrice Ci Xi fu costretta a sottoscrivere pesanti condizioni di resa e accordi commerciali molto penalizzanti. All’inizio del XX secolo l’economia cinese era completamente controllata dalle potenze straniere.

La copertina di «Le Petit Parisien» illustrava nel 1901 le esecuzioni dei Boxer che, nella cittadina di Pao Ting Fu, avevano attaccato una missione cattolica facendo strage di connazionali.
La «torta» cinese
Questa vignetta comparve nel 1861 su un giornale satirico. Sono raffigurati diversi personaggi seduti attorno a un tavolo, in aperto conflitto tra loro.
Completa il testo con le parole mancanti e con il numero relativo a ciascun personaggio.
Possiamo riconoscere la del Regno Unito , il re di Prussia , lo zar di , la Francia (ritratta simbolicamente attraverso la figura femminile della Marianne, uno dei simboli della rivoluzione) , il Giappone rappresentato da un . La Cina è raffigurata come una grande da spartirsi tra le grandi potenze. Alcuni hanno in mano dei coltelli, a testimoniare sia le espansioni di tipo commerciale, sia le occupazioni militari da parte delle potenze industriali.
Dietro i diversi personaggi un mandarino
di opporsi alla spartizione, anche se invano. La Cina, infatti, non riuscì a fronteggiare le mire imperialistiche di europei e giapponesi.

Quale elemento comune all’economia tedesca e a quella giapponese spinse le due potenze a intraprendere la strada dell’imperialismo? L’industrializzazione.
Alla fine dell’Ottocento anche la Germania iniziò una politica imperialista: • in Asia occupò alcune isole del Pacifico; • in Africa s’impadronì del Togo e del Camerun e istituì le colonie dell’Africa sud-occidentale (l’attuale Namibia) e dell’Africa orientale (l’attuale Tanzania). Nel 1888, il nuovo imperatore Guglielmo II aveva cominciato a mostrare aspirazioni di grandezza espandendo i suoi domini. Gli industriali si mostravano favorevoli alla politica imperialistica, in cui vedevano un’opportunità di crescita e di sviluppo per l’industria siderurgica e navale e un possibile allargamento del mercato per i prodotti tedeschi. In quello stesso periodo il Giappone era un Paese in via di prepotente industrializzazione e questo influì sui rapporti con il mondo esterno. Infatti, al pari delle potenze europee, ben presto divenne una potenza imperialista: occupò l’isola di Formosa e la Corea, tentando poi di espandersi in Manciuria Questa politica aggressiva allarmò la vicina Russia e portò alla guerra fra i due Paesi (1905). Il Giappone vinse la guerra, occupò la Manciuria e si affermò come una potenza di primo piano in Estremo Oriente e nel Pacifico. Per la Russia, che credeva di essere una grande potenza in grado di controllare facilmente il piccolo Giappone, si trattò di una sconfitta umiliante che, come vedremo, schiuse le porte alla rivoluzione.
L’Europa conquista il mondo
Osserva i grafici che mostrano quanta parte del mondo l’Europa ha occupato in vari momenti storici.
Rispondi alla domanda.
• In quale anno l’estensione delle dipendenze coloniali europee raggiunse la sua massima espansione?
Nel 1914.

Gli Stati Uniti avevano mantenuto per decenni una politica estera isolazionista, cioè estranea alle vicende internazionali. Alla fine del secolo, però, Washington ruppe il tradizionale isolamento. Nel 1898 gli Stati Uniti si scontrarono con la Spagna per il controllo di Cuba, che si era ribellata al dominio spagnolo e aveva invocato il sostegno del potente vicino. In pochi giorni l’esercito statunitense ebbe ragione delle truppe spagnole. Negli anni successivi gli Stati Uniti estesero la loro influenza anche sulle Filippine e sulle isole Samoa, Caroline, Marianne e Hawaii nell’oceano Pacifico.
Inoltre, nel 1903, quando la Colombia non confermò agli Stati Uniti il consenso, precedentemente accordato, di costruire un canale artificiale per unire l’Atlantico al Pacifico, questi non esitarono a provocare un’insurrezione che si concluse con la nascita di uno Stato indipendente, lo Stato di Panama, che concesse agli statunitensi ciò che la Colombia aveva loro negato.
SVILUPPO LE COMPETENZE
Rielaboro le informazioni
Distingui i Paesi su cui gli Stati Uniti estesero la loro influenza in base alla loro collocazione geografica: - sull’oceano Atlantico: - sull’oceano Pacifico:
- tra i due oceani: Cuba Stato di Panama. Filippine, Samoa, Caroline, Marianne, Hawaii
1. Completa la mappa concettuale inserendo correttamente i termini elencati. allargamento dei mercati – darwinismo sociale – reperimento di materie prime – nazionalismo – manodopera a basso costo – razzismo
Imperialismo (1870-1914)
Conquista militare e sottomissione politica ed economica
È giustificato con il e alimentato da e da
darwinismo sociale nazionalismo
razzismo
Ha come obiettivi economici:
allargamento dei mercati reperimento di materie prime manodopera a basso costo
2. Riordina nella tabella gli imperi coloniali costituiti dalle potenze imperialiste. L’esercizio è avviato.
Colonia del Capo – Camerun – Africa centrale e occidentale – Uganda – Belgio – Kenya – Congo – Algeria – India – Isole del Pacifico – Sudan – Germania – Africa orientale e sud-occidentale – Regno Unito – Togo
imperialiste
Francia
Regno Unito
Belgio
Germania
[ASIA] Vietnam del Nord, Vietnam del Sud, Cambogia [AFRICA]
[ASIA] [AFRICA] [AFRICA]
Africa centrale e occidentale, Algeria
India
Sudan, Uganda, Kenya, Colonia del Capo
Congo
[ASIA] [AFRICA]
Isole del Pacifico
Africa orientale e sud-occidentale, Togo, Camerun
La realizzazione di una grande opera di ingegneria, un canale destinato a facilitare gli scambi di merci e di persone tra terre lontane, diventa il simbolo dell’inizio di una politica aggressiva e di sfruttamento delle potenze occidentali a danno dell’Egitto e, in generale, dell’intero continente africano.
1876, UNA DATA SIMBOLO 1
È difficile stabilire con certezza una data a cui far risalire l’inizio dell’età dell’imperialismo perché esso non fu un evento isolato, ma un processo storico complesso, con molti protagonisti nei panni delle vittime o dei carnefici. Quel che è certo è che è possibile individuare una data simbolo della nuova stagione (una di quelle date che gli storici assumono come riferimento nella linea del tempo per procedere a una periodizzazione): il 1876. In quell’anno, infatti, il Regno Unito acquisì dal governo egiziano il 44% delle azioni della società che controllava il canale di Suez. Si trattava di una grande opera d’ingegneria idraulica costruita tra il 1859 e il 1869 su progetto
dell’ingegnere italiano Luigi Negrelli e sotto la direzione dell’ingegnere francese Ferdinand de Lesseps, con capitali in parte egiziani e in parte francesi, che metteva in comunicazione il mar Mediterraneo con il mar Rosso. L’apertura di questa via d’acqua in mezzo al deserto rappresentava uno straordinario progresso nei commerci tra Europa e Asia: il canale di Suez, infatti, permetteva di risparmiare enormemente sui costi di trasporto navale, evitando d’intraprendere lunghi e incerti viaggi via terra o di dover circumnavigare la massa continentale africana per giungere fino all’oceano Indiano.

L’apertura del canale di Suez fu inaugurata con una grande cerimonia il 17 novembre 1869 alla presenza dell’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, dell’imperatore d’Austria e del viceré egiziano, come mostra questa incisione.
In seguito alla vendita delle azioni il governo egiziano perse ogni possibilità di controllo sul canale (decidere quali merci e quali Paesi potevano passare, stabilire le tariffe di transito ecc.). Questo evento, che solo in apparenza riguardava una questione tecnica e finanziaria, in realtà metteva seriamente in discussione la stessa sovranità politica del Paese africano. Le potenze occidentali, infatti, non si limitarono a sostituire la corrotta e inefficiente amministrazione egiziana con una ben più efficace amministrazione congiunta franco-britannica, ma iniziarono a comportarsi come se quello fosse il «loro» canale, proteggendolo dai pericoli esterni (compreso il governo egiziano!). Era il primo passo verso la definitiva sottomissione dell’Egitto agli interessi e alla volontà delle nuove potenze imperialiste occidentali.

Nel 1882, dopo soli sei anni dall’ingresso congiunto francobritannico nell’amministrazione del canale di Suez, il Regno Unito impresse una fortissima accelerazione alla sua politica imperialista in Egitto: approfittando di uno squilibrio politico e di una situazione di debolezza interna al Paese, Londra inviò un corpo di spedizione che assunse il controllo del Paese Questa operazione politico-militare non violava solo la sovranità dell’Egitto, ma rompeva la tacita alleanza con la Francia, che protestò inutilmente: ormai l’Egitto era diventato, di fatto, una colonia britannica.

Sottolinea con colori diversi gli obiettivi politici dei liberali, quelli dei conservatori e infine l’elemento che accomunava i due schieramenti politici

È una concezione dell’economia favorevole al libero scambio e contraria al ruolo attivo dello Stato in campo economico. Liberismo
Durante il lunghissimo regno della regina Vittoria 1901) la vita politica britannica fu dominata dal confron to fra liberali e conservatori. I governi liberali estendere i diritti politici (cioè il diritto di voto e di essere eletti nelle istituzioni) e assicurare a tutti i citta dini il pieno godimento dei diritti civili (per esempio il diritto di associazione o di libera espressione delle proprie opinioni in materie religiosa e politica). I governi conservatori, invece, volevano mantene re il più ristretto possibile il suffragio e avevano come obiettivo prioritario di assicurare il pre stigio e la ricchezza del Regno Unito. Quando i conservatori governarono il Paese, dal 1886 al 1905, s’impegnarono ad ampliare l’impero coloniale. Quando invece governarono i liberali si realizzarono importanti riforme sociali (giornata lavorativa a un massimo di otto ore, e pensione; assicurazione contro le malattie e la disoccupazione e assistenza medica gratuita ai bambini). Comune a liberali e conservatori era la fiducia nel sistema parlamentare e nel liberismo economico.
Vittoria (1819-1901) fu regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda per 64 anni, un lungo periodo definito dagli storici anche epoca vittoriana. Benché a capo di una grande potenza, il ruolo della regina fu soprattutto simbolico e di rappresentanza. Le scelte politiche erano in mano al Parlamento.
Il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, tuttavia, non dipese solo dalle riforme attuate dai governi liberali, ma fu soprattutto il risultato delle lotte del movimento operaio. Nel 1868 era nato nel Regno Unito il Tuc (Trade unions congress), il primo sindacato nazionale. Nel 1906 al sindacato si affiancò il Partito laburista indipendente, un partito di orientamento socialista molto legato al sindacato e al mondo del lavoro. Trade unions e Partito laburista indipendente si fusero nel Partito laburista e sostennero le masse lavoratrici, che erano escluse dalla vita parlamentare, cercando di affermare i loro bisogni e di difendere i loro interessi.
DENTRO LA STORIA
Le suffragette

Nella seconda metà del XIX secolo migliaia di donne britanniche si batterono con coraggio per conquistare il diritto di voto, cioè il suffragio femminile. Per questo motivo furono chiamate «suffragette». Si trattò di una lotta lunga e difficile perché la classe dirigente britannica, tutta maschile, non intendeva riconoscere alle donne questo elementare diritto di cittadinanza. Di fronte all’ostinata chiusura della classe politica maschile, le suffragette utilizzarono ogni possibile strumento
Nel 1870, quando l’imperatore Napoleone III era stato sconfitto a Sedan dai prussiani, la Francia aveva cessato di essere un impero ed era diventata una repubblica. L’orgoglio nazionale francese era stato ferito dalla perdita della guerra contro la Prussia: oltre a dover cedere al nemico regioni importanti dal punto di vista industriale come l’Alsazia e la Lorena, i francesi furono obbligati a pagare enormi somme di denaro a Berlino e a sopportare la presenza di truppe nemiche sul loro territorio. Per questi motivi, negli anni successivi, l’opinione pubblica coltivò una voglia di rivincita (revanche) contro la Germania. La politica interna ebbe un andamento altalenante: da una parte furono varate importanti riforme sociali (fra cui l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 13 anni), dall’altra scoppiarono gravi tensioni dovute ai tentativi di restaurare la monarchia o un regime autoritario In questo clima di scontro tra repubblicani e monarchici, di cocente delusione per la predita dell’Alsazia e della Lorena, di crescente nazionalismo e aumento dell’antisemtismo, ebbe enorme risonanza una questione giudiziaria su un caso di spionaggio militare, l’«affare Dreyfus».
La rivincita!
L’immagine a lato è il manifesto pubblicitario di una rivista francese nazionalista che accresceva il desiderio di riscattare la sconfitta contro la Germania. Era intitolata La revanche, «La rivincita».
Rispondi alla domanda.
• In che modo il manifesto illustra simbolicamente la rivincita? Scegli le descrizioni corrette.
a L’esercito francese avanza pronto al combattimento.
b I soldati francesi esultano per una vittoria.
c Ai piedi del soldato in primo piano c’è un soldato nemico morto.
d Ai piedi del soldato in primo piano c’è un elmo con una punta alla sommità, caratteristico dell’esercito prussiano.
e Il soldato in primo piano calpesta la bandiera della Germania.
di lotta: dalle pacifiche manifestazioni alla resistenza passiva fino alle azioni di guerriglia urbana (incendio di cassette postali, assalto a stazioni ferroviarie). Negli scontri con le forze dell’ordine caddero decine di donne e migliaia furono arrestate. La brutalità della repressione e le condizioni disumane della detenzione colpirono l’opinione pubblica, che cominciò a solidarizzare con le suffragette. L’esperienza della Prima guerra mondiale diede un notevole contributo alla lotta femminista: nel 1918 il Parlamento approvò il diritto di voto limitato alle spose dei capifamiglia con più di 30 anni; nel 1928, finalmente, le donne britanniche ottennero il pieno suffragio Francia.
Individua su una carta geografica la posizione dell’Alsazia e della Lorena e scrivi a quale Paese appartengono attualmente queste regioni.

DENTRO LA STORIA
L’«affare Dreyfus»: una vittoria contro l’odio antisemita

Albert Dreyfus.
Negli ultimi anni del secolo esplose il cosiddetto «affare Dreyfus». Alfred Dreyfus era un capitano dell’esercito francese di origine ebraica, condannato nel 1894 per spionaggio a favore della Germania. Lo scontro tra «colpevolisti» (la destra nazionalista, che fece ricorso all’odio antisemita per toccare l’opionione pubblica) e «innocentisti» (repubblicani e intellettuali, tra i quali s’impose la figura del grande romanziere Émile Zola) spaccò il Paese. Negli anni furono portate prove dell’innocenza dell’ufficiale, ma la conferma della condanna risultò tanto impopolare da influenzare le elezioni parlamentari del 1899: la coalizione tra sinistra e repubblicani conquistò la maggioranza. Dreyfus ottenne la revisione del processo e fu finalmente riconosciuto innocente e riabilitato. La vicenda aveva conquistato le prime pagine dei giornali perché Dreyfus era ebreo e, come tale, considerato da parte dell’opinione pubblica come un nemico della patria, espressione di una cultura antinazionale. Si trattò di un episodio importante perché, nonostante l’antisemitismo largamente diffuso nella società francese, l’ebreo Dreyfus, sostenuto da un’ampia mobilitazione dell’opinione pubblica più avanzata, poté alla fine vincere i pregiudizi e affermare la propria innocenza.
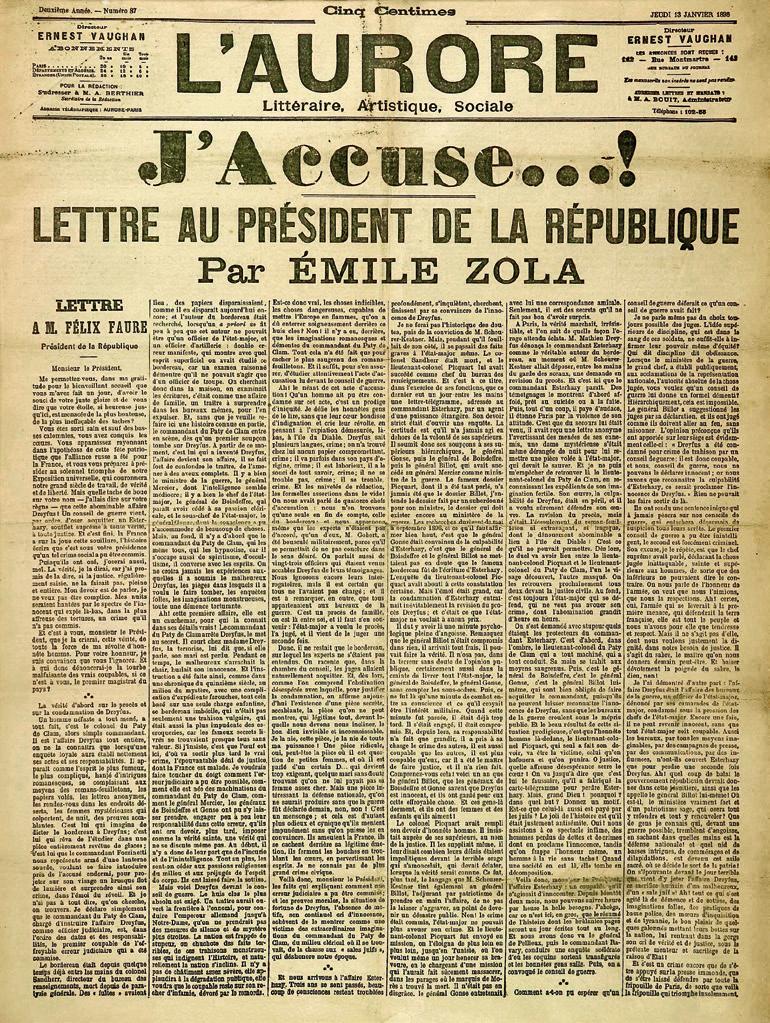
Lo scrittore Émile Zola (1840-1902) denunciò pubblicamente le irregolarità e le illegalità commesse nel corso del processo a Dreyfus, nel quotidiano «L’Aurore».
Cerimonia della proclamazione dell’impero (Reich) tedesco, avvenuta a Versailles il 18 gennaio 1871. Al centro l’imperatore Guglielmo I, alla sua sinistra il cancelliere Bismarck (in unifome blu).
L’Impero tedesco nacque nel 1871. La vittoriosa guerra della Prussia contro la Francia, infatti, aveva favorito l’unificazione dei tanti Stati, regni e principati tedeschi sotto la guida prussiana. Fra il 1871 e il 1888 la politica tedesca fu dominata dalla personalità del cancelliere Otto von Bismarck (1815-1898).
Bismarck era un fervente nemico del socialismo. Per limitarne l’influenza sui lavoratori tedeschi applicò misure repressive (per esempio il divieto di diritto di sciopero o «leggi eccezionali» contro il Partito socialdemocratico), ma era

perfettamente consapevole che ciò non sareb be bastato: era invece necessario che lo
Stato si facesse carico dei loro proble mi. Solo così le idee socialiste avreb bero avuto scarsa diffusione nel Paese.
A partire dal 1878, dunque, realizzò un vasto programma di riforme sociali che prevedeva un sistema di assicu razioni obbligatorie sugli infortuni, sulle malattie e sulla vecchiaia.
Secondo Bismarck anche il mo vimento cattolico rappresentava un pericolo per lo Stato. Dal 1871 i cattolici si erano riuniti in un Partito di centro (in tedesco, Zentrum), contrario al centralismo prussiano e favorevole a un ampio federalismo. I rapporti tra il Partito di centro e Bismarck erano molto tesi anche per motivi religiosi: il cattolico, mentre Bismarck (come gran parte della società prussiana) era di re ligione luterana. Per limitare l’influenza dei cattolici sulla vita politica dell’im pero germanico, Bismarck affermò con fermezza il principio della Stato, imponendo, tra l’altro, il inoltre quella che chiamò «Battaglia di civiltà»: rendendo obbligatori anche per i cattolici i matrimoni civili e imponendo l’approvazione dello Stato alla nomina di vescovi ed ecclesiastici.
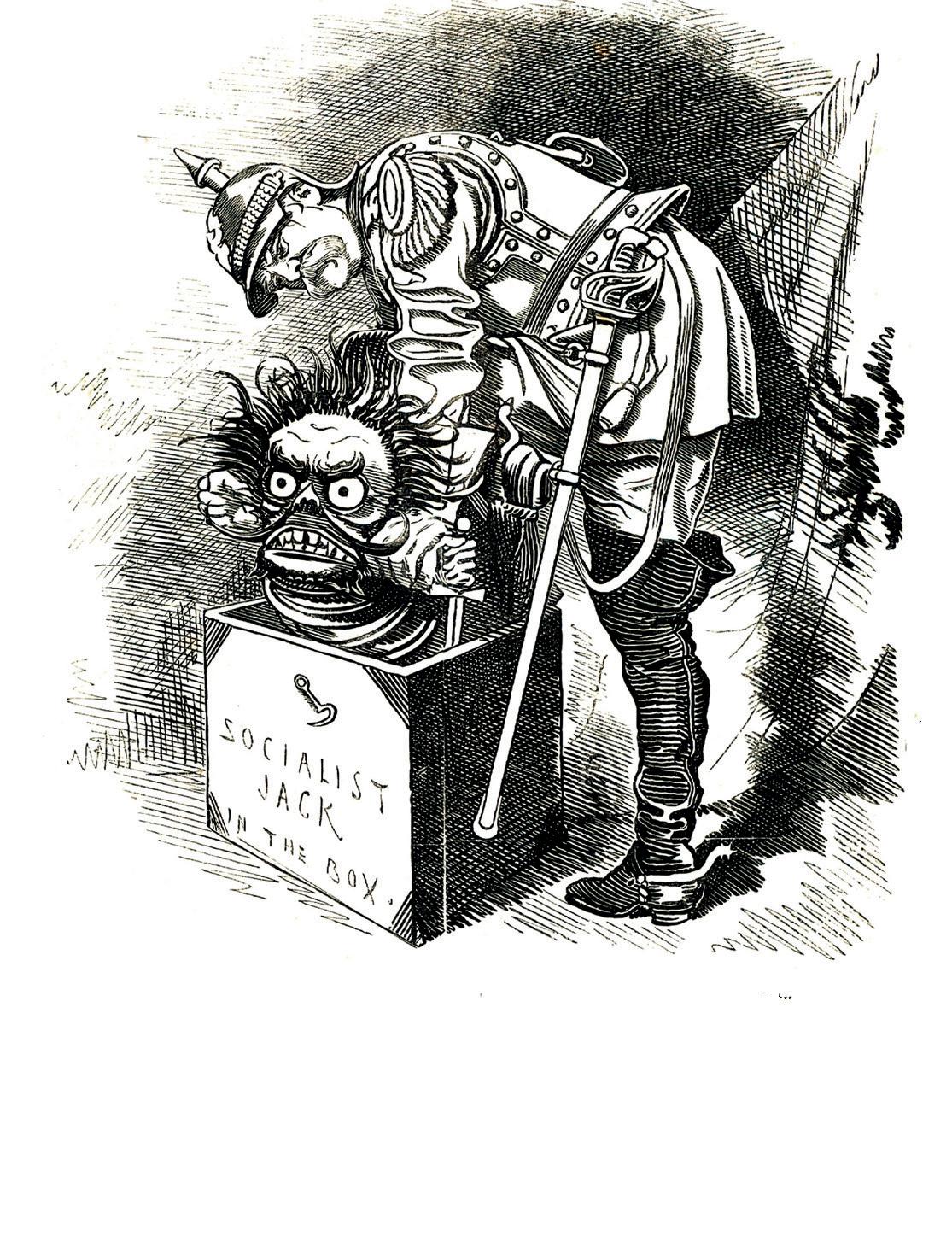
Sottolinea, con colori diversi, le misure politiche adottate da Bismarck nei confronti del movimento socialista e del movimento cattolico
La vignetta umoristica mostra il cancelliere Bismarck mentre cerca di reprimere il socialismo, rappresentato da un pupazzo a molla, che apre sempre il coperchio della scatola.
SVILUPPO LE COMPETENZE
Rielaboro le informazioni
1. Completa lo schema inserendo correttamente i termini elencati. instabilità politica – equilibrio – cattolici – riforme sociali
Regno Unito Francia Germania - età vittoriana - repubblica - cancellierato di Bismarck e - - voglia di rivincita - ostilità verso i socialisti e i - imperialismo -
instabilità politica
riforme sociali cattolici
I partiti e i sindacati – Lo Stato e i lavoratori – Il movimento cattolico – Il ruolo dello Stato equilibrio Otto von Bismarck riteneva pericolosa l’influenza del socialismo sui lavoratori, quindi represse il diritto di sciopero e ostacolò con leggi speciali il Partito socialdemocratico. I problemi dei lavoratori, secondo il cancelliere, dovevano essere affrontati dallo Stato attraverso l’attuazione di riforme sociali. Bismarck era luterano e vedeva nel movimento cattolico un nemico, non solo per questioni religiose ma soprattutto perché minacciava il centralismo e la laicità dello Stato, valori ritenuti fondamentali per la costruzione dell’Impero germanico.
2. Utilizzando la seguente scaletta, scrivi un breve testo sul pensiero di Otto von Bismarck, cancelliere dell’Impero tedesco.
PASSATO: 1840-1900
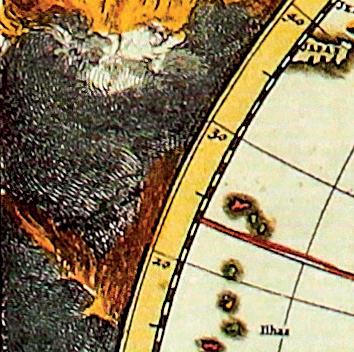
A fine Ottocento Regno Unito, Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Italia si proposero di trasformare la Cina in un terreno di conquista non limitandosi a inviare spedizioni commerciali, ma controllando politicamente l’immenso Paese asiatico, anche ricorrendo alle armi come nelle «guerre dell’Oppio», quando le truppe franco-britanniche sconfissero la Cina (1856-1860).
Le potenze imperialiste erano enormemente interessate alla sottomissione della Cina per controllare le sue sconfinate risorse naturali e penetrare con le loro merci nell’enorme mer cato cinese, fino ad allora «pro tetto» da alti dazi.
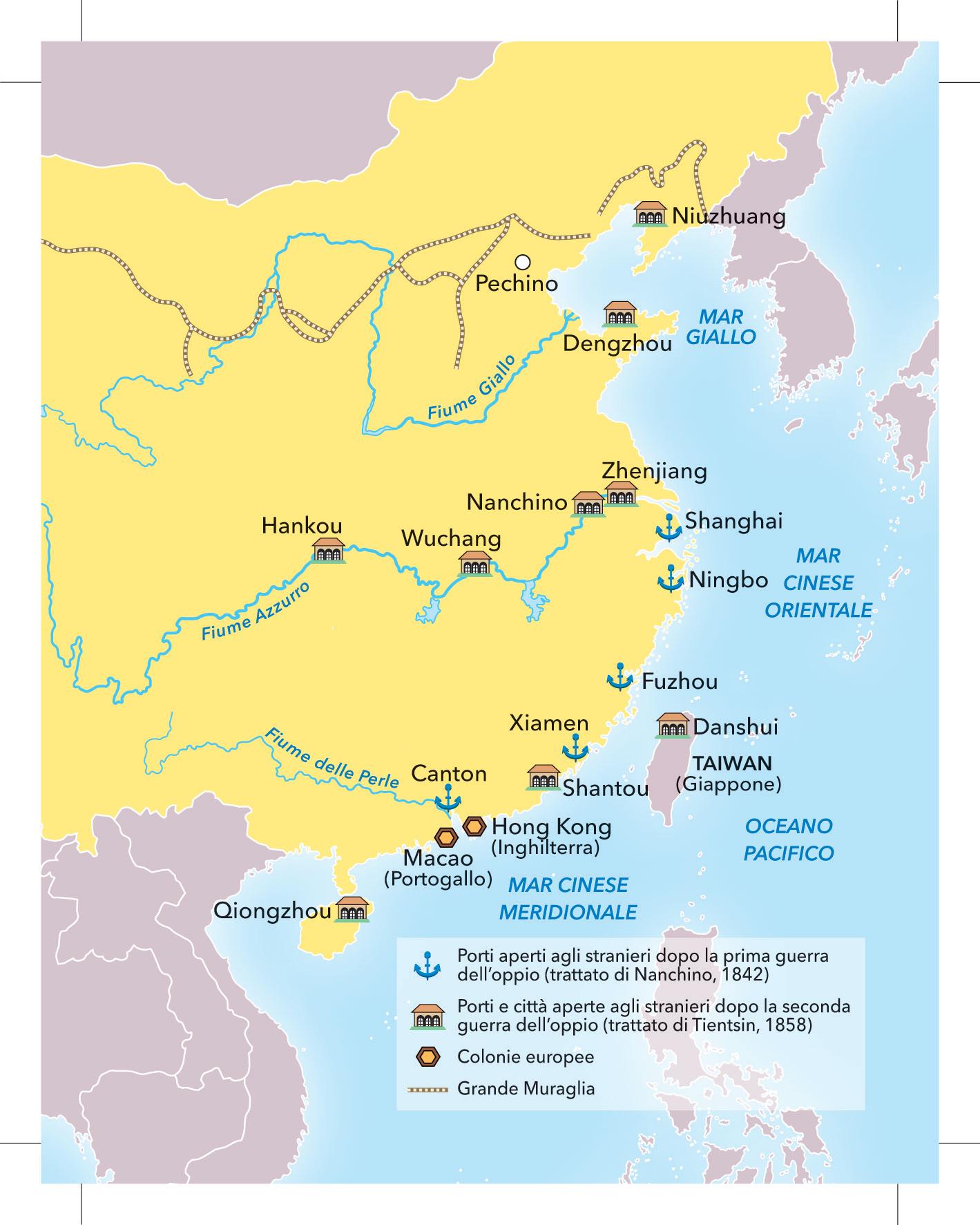
Dalla Cina giungevano in Europa svariati prodotti, sia alimentari (tè, zucchero, spezie), sia tessili (seta, cotone), sia artigianali (porcellane, ceramiche). Si trattava di prodotti pregiati, al centro di fiorenti e intensi traffici commerciali.
Il Regno Unito gestiva un consistente commercio di oppio dalle colonie indiane verso la Cina. Qui l’imperatore ne aveva vietato la diffusione: questo fu il motivo alla base delle guerre dell’Oppio che si scatenarono nella metà del XIX secolo.

PRESENTE: XXI SECOLO
Oggi la Repubblica popolare cinese è la seconda economia mondiale dopo gli Stati Uniti. Se manterrà il ritmo di sviluppo di questi ultimi anni, in breve tempo si trasformerà nella prima economia del pianeta. Da venti anni il governo, infatti, ha promosso un poderoso sviluppo economico e tecnologico trasformando in pochissimo tempo il Paese in una potenza economica globale. Esso, però, ha bisogno di enor mi risorse energetiche e di nuovi mercati verso cui indirizzare la propria produzione, perciò ha rivolto il suo interesse verso l’Africa, che è un immenso ba cino di risorse minerarie ed energetiche largamente non utilizzate. L’Africa è inoltre un continente aper to agli investimenti stranieri a causa della debolezza delle risorse finanziarie interne e un mercato in cre scita, considerati i tassi di incremento demografico africani.

La Cina ha creato un legame con gli Stati africani e offre loro manodopera specializzata e tecnologia per costruire grandi infrastrutture (strade, ponti, ferrovie, acquedotti, gasdotti, dighe ecc.) e industrie di lavorazione delle materie prime, nelle quali molti giovani africani trovano occasioni d’impiego. In cambio richiede ai governi africani il diritto a sfruttare in esclusiva per lunghissimi periodi di tempo le loro risorse naturali: giacimenti di diamanti, oro, terre rare, uranio, cadmio, tantalio, idrocarburi ecc.
COMPRENDO IL TESTO
Sottolinea, con colori diversi, le forme di arretratezza della società russa dal punto di vista politico, economico e sociale
Condizione, diffusa soprattutto in epoca medievale, che prevedeva l’obbligo per i contadini a non abbandonare il padrone o la terra su cui lavoravano e a svolgere gratuitamente il loro lavoro.
Battaglia di Port Arthur durante la guerra russo-giapponese.
Alla fine del XIX secolo la Russia era il Paese più grande e popolato d’Europa, con oltre 100 000 000 di abitanti, e gli zar aspiravano a estendere i confini dell’impero sia a Occidente, verso i Balcani (a danno dell’Impero ottomano), sia a Oriente, verso l’Asia. Queste aspirazioni, tuttavia, non facevano il conto con la generale arretratezza della Russia sul piano socio-economico e politico. L’economia russa era ancora prevalentemente rurale; l’agricoltura, però, non aveva conosciuto la modernizzazione dei Paesi occidentali e si basava ancora su metodi tradizionali. La produttività della terra era molto bassa e i contadini vivevano in condizioni molto precarie. Da poco tempo (dal 1861) era stata formalmente abolita la servitù della gleba ma di fatto le loro condizioni di vita non erano migliorate.
L’attività industriale era limitata ad alcune regioni intorno a grandi città come Mosca, San Pietroburgo o Kiev ed era ancora lontana dai risultati del Regno Unito o della Germania. Nonostante l’eccezionale disponibilità di risorse naturali, mancava una classe d’imprenditori russi con una mentalità moderna, disposta al rischio e in possesso di grandi capitali da investire. Per questo motivo l’industria russa dipendeva dagli investimenti di capitali stranieri (soprattutto francesi). Per quanto riguarda la vita politica, l’impero zarista era una monarchia assoluta autocratica (dal greco autokráteia «potere personale»), che reprimeva con la forza ogni forma di dissenso

L’aspirazione degli zar a espandersi a Oriente verso l’Asia si scontrò con la politica estera fortemente espansionista del Giappone. L’impero nipponico (Nippon era il nome ufficiale del Giappone dal VII secolo), infatti, aveva occupato la Corea nel 1895 e nel 1904 attaccò a sorpresa la base navale russa di Port Arthur, sulle coste della Manciuria (territorio della Cina nord-orientale occupato dai russi nel 1898) mentre l’esercito, partendo dalla Corea, avanzava verso l’interno. La guerra terminò nel 1905 con la schiacciante vittoria dei giapponesi.
Per l’Impero russo fu una gravissima umiliazione: entrata in guerra con la presunzione della grande potenza e la sicurezza di battere in breve tempo il nemico, la Russia ne usciva sconfitta, indebolita e con un prestigio internazionale fortemente ridimensionato.
La guerra con il Giappone mandò in frantumi la stabilità interna della società russa. I prezzi dei generi di prima necessità, infatti, aumentarono peggiorando le condizioni di povertà e fame della popolazione. Il 22 gennaio 1905 l’esercito aprì il fuoco contro migliaia di manifestanti che si erano riuniti davanti al Palazzo d’inverno (la residenza imperiale) di San Pietroburgo per presentare pacificamente una petizione allo zar nella quale chiedevano il riconoscimento di diritti politici e sindacali. Il tragico episodio è passato alla storia come la «domenica di sangue». La protesta contro la sanguinosa repressione si estese a tutto il Paese coinvolgendo contadini, operai (riuniti in soviet, cioè consigli) e anche parte della flotta militare. Lo zar Nicola II, di fronte a una rivoluzione che rischiava di mettere in discussione la sopravvivenza stessa della monarchia, nel 1906 riunì per la prima volta un Parlamento (la duma), eletto a suffragio limitato e con il compito di elaborare una carta costituzionale. In questo modo, lo zar cercava di soddisfare le richieste della ristretta borghesia liberale russa, che guardava con favore al modello della monarchia parlamentare e costituzionale britannica. Appena le tensioni si affievolirono, però, Nicola II sciolse la duma e revocò tutte le promesse fatte. La Russia, in sostanza, rimaneva l’unica monarchia assoluta in Europa.

Vogliamo la protezione dello zar!
Quello che segue è il testo della petizione che gli operai rivolsero allo zar nel corso della manifestazione del gennaio 1905.
Noi operai, abitanti di Pietroburgo, siamo venuti a Te. Noi siamo i miseri, gli schiavi oltrag giati, oppressi dal dispotismo e dall’arbitrio. Quando il calice della pazienza fu colmo, ces sammo di lavorare e chiedemmo ai nostri padroni di darci soltanto il minimo necessario. Ma tutto questo ci fu rifiutato dai fabbricanti. […] Sovrano! Non rifiutarti di aiutare il Tuo popolo! Ordina e giura che i nostri voti saranno realizzati e Tu renderai felice la Russia; se non lo farai siamo pronti a morire qui. Noi non abbiamo che due vie: o la libertà e la feli cità, o la tomba.
1. In quale città lavorano gli operai?
2. Che cosa avevano chiesto gli operai ai proprietari delle fabbriche?
3. Che cosa chiedono allo zar? Pietroburgo. Di ordinare ai proprietari delle fabbriche di soddisfare le richieste degli operai.
Il minimo necessario.

Quali cause determinarono la trasformazione dell’Impero d’Austria in Impero austroungarico?
La concessione di una forma di autogoverno all’Ungheria.
L’Impero asburgico era un grande mosaico composto di numerose nazionalità. Una delle principali ragioni del suo declino fu appunto la sempre più difficile convivenza fra le nazionalità che vivevano all’interno dei suoi confini. Dopo la sconfitta subita nel 1866 nella guerra contro la Prussia, l’imperatore Francesco Giuseppe era stato costretto a concedere agli ungheresi, che erano la seconda nazionalità dell’impero per numero di abitanti, una forma di autogoverno: l’Impero d’Austria aveva così assunto, nel 1867, il nome di Impero austro-ungarico e Budapest era diventata capitale con Vienna. Francesco Giuseppe rimaneva l’imperatore di tutti i sudditi, ma le due capitali ospitavano due diversi parlamenti. Rimanevano però, altri gruppi desiderosi di maggior autonomia: cechi, polacchi, ruteni (ucraini), italiani
L’attenzione dell’impero a mantenere gli equilibri politici della Penisola balcanica, inoltre, si scontrò con le ambizioni espansionistiche dell’Impero russo. Per questo motivo fra i due Stati (come vedrai nell’Unità 2) si creò una situazione di grave tensione diplomatica.
...ma è un «gigante dai piedi di argilla»
L’impero austro-ungarico aveva dimensioni enormi, ma la sua potenza si fondava su basi fragili: era come un «gigante dai piedi d’argilla», a causa di problemi politici, ma anche economici. Infatti, a eccezione di poche regioni industrializzate, come la Boemia (nell’attuale Repubblica Ceca) e la regione di Vienna, l’economia era ancora prevalentemente agricola, con una forte impronta feudale. La produttività era generalmente molto bassa e le tecniche più innovative faticavano ad affermarsi a causa della mentalità conservatrice dei contadini e dei proprietari terrieri. I funzionari dell’impero, inoltre, avevano perduto la loro proverbiale efficienza e non sembravano più in grado di amministrare uno Stato così grande e complesso, che aveva bisogno di competenze professionali moderne.
L’Impero austro-ungarico prima del 1866
L’Impero austro-ungarico occupava buona parte dell’Europa centro-orientale e comprendeva al suo interno popoli di nazionalità e religioni diverse.
Rispondi alla domanda.
• Su quali Stati europei attuali si estendeva l’Impero austro-ungarico?
Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Sud della Polonia, Sud-Ovest dell’Ucraina, Ungheria, parte della Romania (la regione della Transilvania), Nord della Serbia (regione autonoma della Vojvodina), Croazia, Slovenia, Nord-Est dell’Italia (Lombardo-Veneto).

Nel corso del XVII e del XVIII secolo l’Impero turco-ottomano era penetrato nei Balcani e nell’Europa centro-orientale, giungendo addirittura ad assediare Vienna (1683). Nell’Ottocento, invece, le potenze europee passarono alla controffensiva: diedero ampio sostegno alle popolazioni che si ribellavano alla dominazione turca cacciando gli ottomani e occupando a loro volta quelle regioni. L’estensione dei domini ottomani in Europa, quindi, si ridusse sempre di più Il ridimensionamento non dipese solo da cause esterne (la crescente pressione militare degli Stati europei), ma anche interne, riconducibili alla sua arretratezza politica e amministrativa.
Sul piano politico, l’Impero ottomano era una teocrazia assoluta: il potere politico, militare e religioso si concentrava nelle mani del sultano
Sul piano sociale, la società ottomana sembrava incapace di modernizzarsi e si caratterizzava per un forte immobilismo e per la chiusura verso il mondo esterno.
All’inizio del Novecento un gruppo di ufficiali dell’esercito e di funzionari statali diede vita al movimento riformatore dei Giovani turchi. La loro aspirazione era ottenere una Costituzione e avvicinare il mondo ottomano al modello degli Stati europei. Nel 1908 i Giovani turchi organizzarono una rivolta e obbligarono il sultano a concedere la Costituzione. Il nuovo governo, tuttavia, non riuscì a consolidarsi e, nel tentativo di centralizzare il potere, favorì le spinte autonomistiche dei popoli sottomessi causando la disgregazione dell’impero.

LAVORO SULLA LINGUA
Sottolinea la congiunzione che mette in rapporto la causa (controffensiva europea) all’effetto (riduzione dei domini ottomani in Europa).
Forma di governo in cui il potere civile e politico è esercitato da un leader religioso che è considerato interprete del volere divino. Teocrazia
Raffigurazione del sultano Abdul Hamid II tra due Giovani turchi al tempo dalla Costituzione del 1908.

SVILUPPO LE COMPETENZE
Rielaboro le informazioni
1. A quale o a quali imperi sono attribuibili le caratteristiche elencate? Indicalo con la lettera: Impero russo (R), Impero austro-ungarico (A), Impero ottomano (O).
a. Movimenti indipendentisti
b. Arretratezza economica
c. Economia basata sull’agricoltura
d. Scarsa industrializzazione
Mi oriento nel tempo
e. Inefficienza amministrativa
f. Movimenti rivoluzionari
g. Mire espansionistiche
2. Collega ciascun avvenimento nella colonna di sinistra alla data corretta nella colonna di destra.
1. Costituzione turca
2. Guerra russo-giapponese
3. Costituzione dell’Impero austro-ungarico
4. «Domenica di sangue»
a. 1867
b. 1905
c. 1908
d. 1904-1905
Completa lo schema relativo alle differenze tra Destra e Sinistra storica.
DESTRA
Personaggio politico:
Cavour
Classi sociali di riferimento:
classi possidenti
Orientamento politico:
conservatore
SINISTRA
Personaggio politico:
Depretis
Classi sociali di riferimento:
ceto medio
Orientamento politico:
riformista

Ritratto dello statista Agostino Depretis, divenuto Primo ministro nel 1876.
La Destra storica completa il suo programma di governo
Alla nascita del Regno d’Italia, nel 1861, fu la Destra storica ad assumere il governo del Paese (la denominazione di questa corrente politica è stata fatta a posteriori dagli storici per distinguerla dai partiti di destra sorti nel XX secolo).
Erede politica di Cavour (il politico protagonista degli eventi che avevano portato alla formazione de l Regno) la Destra storica era formata da liberali moderati e conservatori e rappresentava gli interessi delle classi possidenti. I governi della Destra storica «costruirono» le basi del nuovo Stato, affrontando tre grandi problemi:
• il completamento dell’unità d’Italia (1871);
• la costruzione di numerose opere pubbliche (strade, porti, ferrovie ecc.);
• il pareggio del bilancio, cioè il riequilibrio tra le spese e le entrate dello Stato (1876).
Per raggiungere questi obiettivi, però, i governi della Destra avevano dovuto sostenere grandi spese. Le risorse necessarie erano state ottenute con un forte innalzamento delle tasse, che aveva suscitato grande malcontento tra i cittadini.
Nel 1876, dopo il raggiungimento del pareggio di bilancio, la Destra storica non ebbe più la maggioranza dei voti in Parlamento e, quindi, il governo passò alla Sinistra, guidata da Agostino Depretis (1813-1837). La Sinistra riuniva liberali, democratici, ex garibaldini ed ex mazziniani ed esprimeva gli interessi di varie fasce sociali: piccoli proprietari, artigiani, commercianti, imprenditori e professionisti. Nella Sinistra si riconoscevano gli esponenti del ceto medio che vivono del proprio lavoro (e non di rendita) e dispongono di un buon grado di ricchezza e di cultura.
Per rispondere ai bisogni del ceto medio Depretis promosse alcune riforme sociali e politiche:
• portò a cinque anni la durata dell’istruzione elementare, con i primi due anni obbligatori e gratuiti (legge Coppino, 1877);
• abolì l’odiata tassa sul macinato che aveva fatto crescere il prezzo del pane, provocando grandi proteste;
• nel 1882 modificò la legge elettorale, abbassando il livello di ricchezza e d’età (da 25 a 21 anni) richiesti per votare. I cittadini maschi aventi diritto di voto passarono quindi da 450 000 a più di 2 000 000, circa il 7% della popolazione maschile totale.
Grazie alla nuova legge elettorale, per la prima volta la piccola e media borghesia e anche un piccolo numero di operai istruiti poterono finalmente partecipare alla vita politica del Paese. Nelle elezioni del 1882 la Sinistra ottenne la vittoria e conquistò la maggioranza parlamentare. Per la prima volta entrarono in Parlamento alcuni deputati d’orientamento socialista. La maggior parte degli italiani, però, rimaneva ancora esclusa dalla vita politica; i limiti di censo (ricchezza) previsti dalla riforma, infatti, estromettevano i contadini.
La politica economica della Destra era stata marcatamente liberista, cioè fondata sul libero scambio delle merci. Il liberismo, però, aveva penalizzato alcuni settori dell’industria, incapace di sostenere la concorrenza straniera. A pagare il prezzo maggiore era stata la fragile economia meridionale, fortemente penalizzata sia dalla concorrenza estera sia da quella interna.
Erano molti a chiedere una maggior protezione all’economia nazionale.
La Sinistra varò allora una politica economica protezionista. La «protezione» dei prodotti italiani dalla concorrenza straniera fu assicurata dall’introduzione di dazi, cioè d’imposte doganali. Il pagamento di forti imposte d’ingresso sui prodotti stranieri nel mercato italiano aumentò il loro prezzo, rendendoli sconvenienti a favore di quelli italiani. Attraverso questa politica la Sinistra si assicurò il consenso della grande industria e dell’alta borghesia.
Lo Stato, inoltre, finanziò alcuni settori industriali considerati d’interesse nazionale: nacquero così la prima acciaieria italiana (la Terni), le Officine metallurgiche Breda e le prime centrali idroelettriche.
Su alcuni problemi specifici, come la scelta fra liberismo e protezionismo o l’allargamento del suffragio, Destra e Sinistra avevano posizioni diverse; tuttavia, i parlamentari di entrambi gli schieramenti erano accomunati da alcuni elementi di fondo: erano quasi tutti borghesi e condividevano la fiducia negli ideali e nelle istituzioni liberali (la libertà dell’individuo, il libero mercato, il parlamento). Dopo i primi anni di governo, la maggioranza parlamentare che sosteneva Depretis si allargò: spesso i deputati della Sinistra e della Destra votavano insieme i provvedimenti esaminati in aula. In altre parole, Destra e Sinistra non erano più gruppi ben definiti della vita parlamentare, riconoscibili per le loro differenze ideologiche e programmatiche, ma parti di schieramenti sempre nuovi, che si «trasformavano» a seconda dei provvedimenti esaminati. Questo modo di interpretare la vita politica parlamentare è passato alla storia con il nome di trasformismo
COMPRENDO IL TESTO
Quale conseguenza ebbe la nuova legge elettorale?
a Restrinse il suffragio.
b Introdusse il suffragio femminile.
c Allargò il suffragio. X
Spiega le differenze fra liberismo e protezionismo in merito a: • libero commercio: • intervento dello Stato nella vita economica:
La vignetta satirica del 1882 mette in luce il trasformismo della politica di Depretis, qui definito il «camaleonte». il liberismo favorisce il libero scambio delle merci; il protezionismo impone dazi alle merci estere. il protezionismo prevede anche interventi di aiuto statale; il liberismo no.
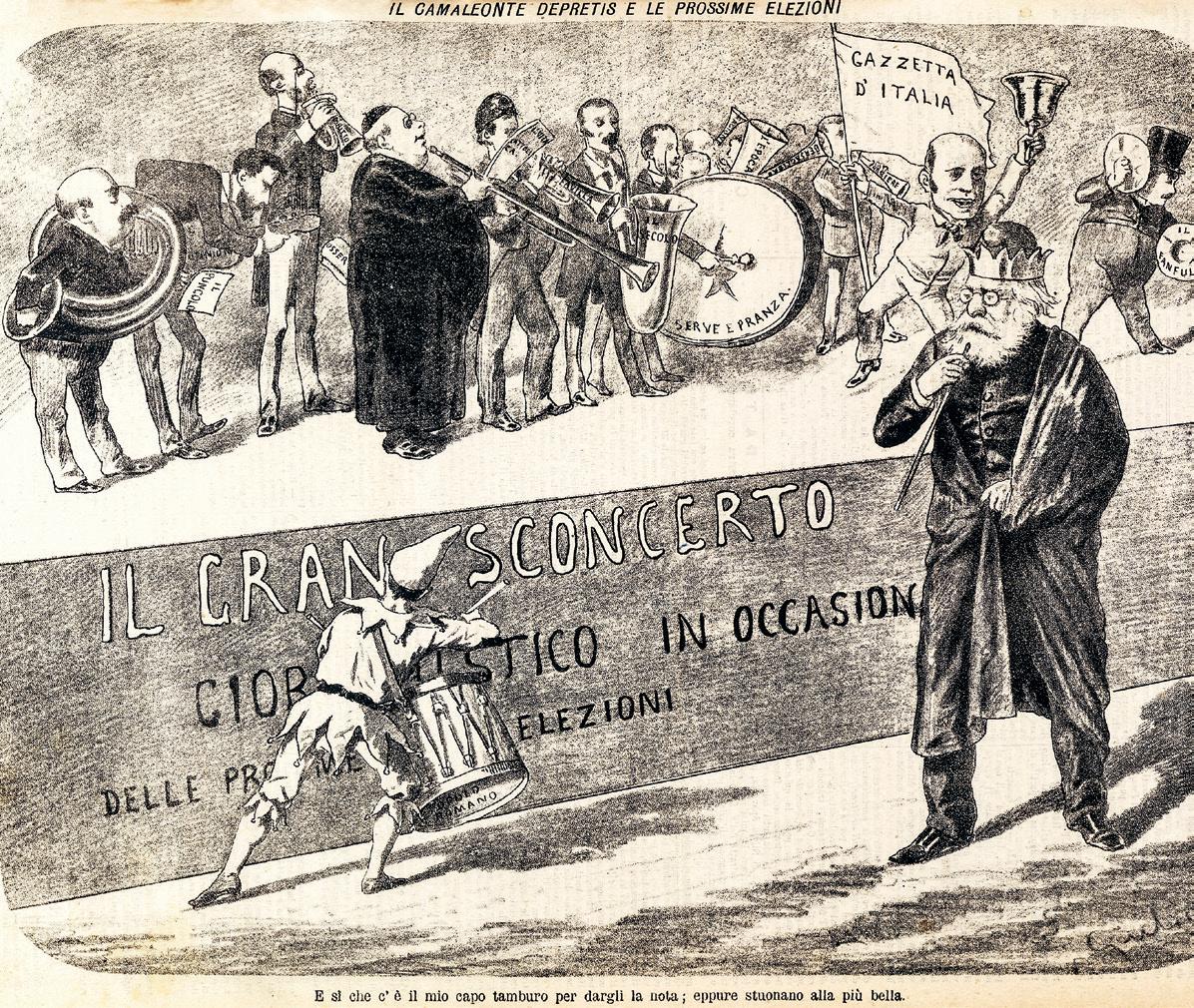
Truppe italiane sulla linea ferroviaria Massaua-Saati (dal mar Rosso verso l’interno), realizzata dall’Italia a scopi militari tra il 1887 e il 1888.

LAVORO SULLA LINGUA
Trascrivi il nome dell’accordo di politica internazionale che l’Italia siglò nel 1882 e scrivi il significato dell’aggettivo.
Triplice alleanza; «triplice»: sottoscritto da tre parti.
La Sinistra voleva fare dell’Italia un Paese moderno, forte economicamente e rispettato nel mondo. Perciò pensava che l’Italia dovesse entrare nella partita coloniale, specialmente in Africa. La Tunisia, poco distante dalla Sicilia, costituiva un obiettivo naturale, ma nel 1881 la città di Tunisi fu occupata dalla Francia ostacolando così le ambizioni italiane. L’iniziativa francese rappresentò uno smacco per le ambizioni italiane; i rapporti d’amicizia italo-francesi s’incrinarono e tra i due Paesi si aprì una grave crisi diplomatica. La vicenda tunisina mostrava l’isolamento dell’Italia nel contesto internazionale e l’assenza di alleati che appoggiassero le sue rivendicazioni. Per uscire dall’isolamento Depretis nel 1882 abbandonò la tradizionale politica estera filo-francese e filo-britannica e strinse con Germania e Austria un patto difensivo: la Triplice alleanza.
Molti italiani considerarono la Triplice alleanza uno scandalo inaccettabile, in quanto sembrava rinnegare il Risorgimento, superando d’un colpo decenni di ostilità nei confronti dell’Austria. Inoltre, i liberali italiani, che erano cresciuti nel mito della Francia rivoluzionaria e del Regno Unito borghese e liberale, ora si ritrovavano alleati a due Paesi simbolo del conservatorismo e dell’autoritarismo.
La Triplice alleanza fece uscire l’Italia dall’isolamento diplomatico e le consentì d’intraprendere una politica coloniale di ampio respiro, nella certezza di avere i necessari appoggi internazionali. Nel 1882 il governo acquistò da una società di navigazione privata (Compagnia Rubattino) il porto di Assab in Eritrea, per usarlo come base per l’espansione in tutta la zona costiera della regione. Il tentativo di penetrazione all’interno del Corno d’Africa (la penisola africana sull’oceano Indiano che comprende Eritrea, Etiopia, Gibuti e Somalia), però, si rivelò più difficile del previsto. Le truppe italiane, infatti, si scontrarono con quelle del negus (sovrano) d’Abissinia (oggi Etiopia) e furono duramente sconfitte nel 1887 a Dogali.
Nel 1887 la guida del governo fu assunta da Francesco Crispi (18181901). Ex ufficiale garibaldino, protagonista di primissimo piano del Risorgimento, dopo la conquista dell’unità d’Italia aveva abbandonato gli ideali repubblicani ed era diventato monarchico. Crispi aveva sempre giudicato con severità il trasformismo tipico dei governi di Depretis, sostenendo invece le virtù del sistema politico britannico, fondato su due partiti, liberali e conservatori, alternativi. La sua critica al trasformi smo, però, aveva finito per coinvolgere l’intera vita parlamentare, giudi cata fonte di corruzione. Per combattere il malcostume del trasformismo, Crispi pensava che si dovesse rafforzare lo Stato, aumentando i poteri del governo a svantaggio di quelli del Parlamento. Il suo modello era la Germania del cancelliere Otto von Bismarck.

Crispi giudicava positivamente l’intervento statale in campo economico e sociale. Sotto il suo governo furono assunte alcune importanti iniziative:
• fu varato un nuovo codice penale più moderno, con cui si aboliva la pena di morte;
• venne affermato il controllo statale sugli enti ecclesiastici di beneficenza;
• fu istituito un sistema sanitario pubblico.
Il Primo ministro pensava inoltre che lo Stato non dovesse tollerare condizionamenti di alcun genere alla propria azione. L’autoritarismo crispino risultò evidente tra il 1893 e 1894 in occasione dell’ondata di scioperi organizzata dal movimento dei Fasci siciliani dei lavoratori. Alle rivendicazioni della divisione delle terre demaniali, di contratti di lavoro e salari equi, il governo rispose proclamando lo stato d’assedio: i Fasci furono sciolti e vi furono scontri armati che causarono alcune morti e migliaia di arresti.
In campo economico e coloniale, Crispi seguì la linea di Depretis. In campo economico, nel 1887 varò nuove e più rigide misure protezionistiche sia nel settore agricolo, sia in quello industriale.
In campo coloniale, riprese la penetrazione italiana in Etiopia e nel Corno d’Africa. Nel 1889 firmò il trattato di Uccialli con il negus Menelik, grazie al quale l’Italia otteneva il protettorato sulla costa somala e il possesso di alcune città e zone dell’Eritrea. Nel 1895, però, gli italiani ripresero la loro espansione verso l’interno. Menelik si ribellò e oppose una fiera resistenza armata. Il conflitto terminò nel marzo del 1896 con la sconfitta di Adua.
La brusca interruzione dell’avventura coloniale italiana fece perdere di credibilità la politica estera di Crispi e il Primo ministro fu costretto alle dimissioni.
COMPRENDO IL TESTO
Quale fu l’atteggiamento di Crispi nei confronti del trasformismo? a Adesione. b Forte critica. c Disinteresse. X
Stato d’assedio
È un provvedimento giuridico eccezionale. Ha come conseguenza la sospensione di alcune leggi o della stessa Costituzione, fino all’assunzione dei poteri civili da parte dell’autorità militare.
COMPRENDO IL TESTO
Quali furono i luoghi relativi all’impresa coloniale di Crispi?
Etiopia, Corno d’Africa, Eritrea, Adua.
Emigrare
Lasciare il luogo di origine per stabilirsi in un altro luogo, di solito molto lontano, in cerca di lavoro.
Spiega le differenze in merito a livello d’istruzione e livello di reddito nelle classi sociali italiane a fine XIX secolo.
I lavoratori erano per lo più analfabeti; pochi cittadini godevano di elevato tenore di vita, di buona istruzione e alti redditi.
Il protezionismo ha effetti negativi sull’economia italiana
Il protezionismo aiutò la nascente industria del Nord, difendendola dalla concorrenza straniera, ma suscitò la reazione degli altri Paesi industriali, che a loro volta assunsero misure protezioniste contro l’importazione di prodotti italiani. L’industria non fu molto penalizzata, perché la società italiana assorbiva l’intera produzione. L’agricoltura, invece, entrò in crisi penalizzando soprattutto i settori della viticoltura e della seta, che ricavavano la maggior parte dei propri profitti proprio dalle esportazioni verso la Francia, Paese con cui c’erano tensioni diplomatiche. Tra Ottocento e Novecento molti contadini, provenienti per lo più dalle campagne del Mezzogiorno e del Veneto, non ebbero altra scelta che emigrare negli Stati Uniti, in Argentina o in Brasile.

La società italiana era profondamente divisa: • da un lato c’era la maggioranza dei lavoratori, composta da salariati; persone per lo più analfabete, quasi sempre costrette a lavorare per dodici o più ore al giorno in cambio di una misera paga, escluse dalla vita politica del Paese; • dall’altro c’era un’esigua minoranza di cittadini che godeva di un elevato tenore di vita, di una buona istruzione e di alti redditi e che partecipava attivamente alla vita politica.
Per almeno venti anni dopo l’unificazione, i lavoratori salariati rimasero esclusi dalla vita politica e privi di un partito che ne rappresentasse gli interessi. Solo dopo il 1880 si cominciò a pensare a un partito che difendesse, in parlamento e con metodi legali, gli interessi dei lavoratori. Nel 1892 Filippo Turati (1857-1932) e Leonida Bissolati (1857-1920) fondarono il Partito socialista italiano (Psi), ispirato agli ideali del marxismo comuni agli altri partiti socialisti europei. Finalmente, chi non godeva del diritto di voto poteva militare in un partito che difendeva i suoi interessi tra i banchi del Parlamento.
Tessera di riconoscimento degli iscritti al Partito socialista italiano, nell’anno 1906.

Nel 1870, quando Roma era stata annessa al Regno d’Italia e lo Stato Pontificio era stato ridotto alla sola Città del Vaticano, papa Pio IX aveva espressamente vietato ai cattolici di partecipare alla vita politica attraverso una disposizione chiamata non expedit («non conviene»). Il suo successore Leone XIII assunse una posizione più aperta. Nell’enciclica Rerum novarum («Sulle cose nuove») del 1891 il papa riconobbe il diritto dei lavoratori a organizzarsi per difendere i propri interessi e invitò i fedeli a battersi per migliorare le condizioni di vita dei ceti più poveri: un chiaro appello perché s’impegnassero nella vita sociale. Ben presto nacquero migliaia di associazioni cattoliche (istituzioni caritative, casse rurali) e negli ultimi anni dell’Ottocento i cattolici tornarono a partecipare alla vita politica sostenendo quei candidati liberali che si fossero impegnati a difendere gli ideali del cattolicesimo. Un partito cattolico sarà fondato solo nel 1919
Gli ultimi anni dell’Ottocento furono caratterizzati da gravi scontri sociali e politici; perciò gli storici parlano di «crisi di fine secolo».
Nella primavera del 1898 l’improvviso aumento del prezzo del pane mise sul lastrico migliaia di famiglie. Di fronte alle manifestazioni organizzate in tutta Italia, il governo proclamò lo stato d’assedio in alcune città. A Milano tra l’8 e il 9 maggio una manifestazione popolare fu dispersa a cannonate dal generale Bava Beccaris: vi furono circa 100 morti. Il governo dispose anche provvedimenti per limitare la libertà di stampa e di associazione appoggiato in ciò dal re Umberto I (salito al trono nel 1878), ma il Parlamento li respinse.
Alle elezioni del giugno 1900 le opposizioni (socialisti, repubblicani e radicali) ottennero la maggioranza dei voti e il re fu costretto ad affidare il governo al moderato Giuseppe Saracco (1821-1907). Un mese più tardi, a Monza, l’anarchico Gaetano Bresci uccise Umberto I (1844-1900) per vendicare le vittime di Milano.
Le due espressioni Non expedit e Rerum novarum sono in latino, che era la lingua ufficiale della Chiesa. Verifica con una ricerca se ancora oggi la Santa Sede usa il latino nei documenti ufficiali.
Sì, la Chiesa usa ancora oggi il latino nei documenti ufficiali.

L’assassinio del re Umberto I, avvenuto il 29 luglio a Monza, in una illustrazione della «Domenica del Corriere».
In questo passo dell’enciclica Rerum novarum, papa Leone XIII indica ai lavoratori e ai padroni quali sono i rispettivi doveri.
Obblighi di giustizia, quanto al proletariato e all’operaio, sono questi: prestare interamente e fedelmente l’opera che liberamente e secondo equità fu pattuita; non recar danno alla roba, né offesa alla persona dei padroni; nella difesa stessa dei propri diritti astenersi da atti violenti, né mai trasformarla in ammutinamento; non mescolarsi con uomini malvagi, promettitori di cose grandi, senz’altro frutto che quello di inutili pentimenti e di perdite rovinose.
Dei capitalisti poi e dei padroni sono questi i doveri: non tenere gli operai in luoghi di schiavi; rispettare in essi la dignità dell’umana persona […]. Non imporgli lavori sproporzionati alle forze, o mal confacenti con l’età e con il sesso.
Principalissimo poi tra i doveri è dare a ciascuno la giusta mercede […].
Rispondi alle domande.
1. Secondo quello che hai letto, la Chiesa era favorevole o contraria agli scioperi?
2. Chi sono, a tuo avviso, gli «uomini malvagi, promettitori di cose grandi»?
3. Che cosa significa «dare a ciascuno la giusta mercede»?
La Chiesa era contraria agli scioperi. Lo si I rivoluzionari seguaci del pensiero marxista. Il giusto compenso per il lavoro svolto. deduce dall’invito ad astenersi dall’ammutinamento, cioè dal rifiuto a eseguire i compiti preposti.

Il politico italiano Giovanni Giolitti (1842-1928).

La crisi di fine secolo rappresentò un punto di svolta. All’inizio del XX secolo la situazione politica trovò finalmente un nuovo punto d’equilibrio: dal 1903 al 1914 il governo fu guidato, tranne una breve pausa, da Giovanni Giolitti (1842-1928).
Il ministro esercitò sulla vita italiana un tale influsso che gli storici chiamano questo periodo età giolittiana.
Giolitti, già ministro del Tesoro nel governo Crispi (1889-1890), presidente del Consiglio nel 1892 e poi ministro dell’Interno (1901-1903), era un liberale aperto ai valori della democrazia. Pensava che il Parlamento dovesse avere un ruolo importante nelle scelte politiche e che i ceti borghesi colti e benestanti avessero il compito di dirigere il Paese. Era convinto che la borghesia incarnasse i valori migliori della nuova Italia: lo spirito d’iniziativa, la serietà industriosa, l’apertura verso le novità della vita moderna.
COMPRENDO IL TESTO
Quale funzione assegnava Giolitti ai ceti colti borghesi?
a Funzione dirigente.
b Funzione subalterna.
c Funzione socioeconomica ma non politica. X
Giolitti, però, non ignorava la realtà italiana: conosceva le enormi ingiustizie sociali che la dilaniavano, sapeva che il Paese non era ancora al livello economico delle grandi potenze europee. Vedeva inoltre che gran parte della popolazione, estranea alla vita politica del Paese, percepiva interesse per le proprie condizioni soltanto dai movimenti socialisti e da quelli cattolici.
Sulla base di questa analisi della società italiana, Giolitti indirizzò la sua politica verso due obiettivi:
• il consolidamento della democrazia, rendendo possibile la partecipazione alla vita politica di una parte più ampia della popolazione;
• lo sviluppo dell’industria, come mezzo per creare maggior benessere nel Paese.

Giolitti guardò al mondo del lavoro e ai cambiamenti sociali in corso in modo diverso dai suoi predecessori. Convinto che il progresso sociale avrebbe favorito anche quello economico, non ostacolò la formazione di associazioni sindacali: la Confederazione generale del lavoro (Cgdl) nacque nel 1906 durante il suo governo.
Giolitti riteneva inoltre che l’esistenza (dal 1892) del Partito socialista e del sindacato, e il riconoscimento del diritto di sciopero non erano di per sé fatti negativi: alla lunga, avrebbero potuto rafforzare lo Stato liberale perché allontanavano i rischi di una rivoluzione. I conflitti fra lavoratori e imprenditori non dovevano perciò ridursi a uno spietato regolamento di conti, ma andavano regolati pacificamente, senza ricorrere alla violenza.
Il Primo ministro s’impegnò perché le forze dell’ordine rimanessero imparziali e si limitassero a garantire lo svolgimento pacifico delle manifestazioni. Gli imprenditori non accolsero favorevolmente questa nuova impostazione, ma Giolitti mantenne le proprie posizioni e stabilì il principio della neutralità dello Stato nei conflitti tra lavoratori e datori di lavoro.
Nel gruppo di partecipanti a un Congresso del Partito socialista, compare in primo piano il suo fondatore, Filippo Turati (1857-1932).
La nascita di associazioni sindacali favorì le trattative fra le parti sociali (lavoratori e imprenditori) per gli aumenti dei salari degli operai. La concessione era vista dal nuovo governo non solo una questione di solidarietà umana, ma anche di convenienza economica: una maggior disponibilità di denaro, infatti, favoriva l’aumento dei consumi e, quindi, della produzione di beni di consumo da parte del settore agricolo e manifatturiero.
Giolitti realizzò poi molte riforme sociali in favore delle donne lavoratrici, dei fanciulli, degli anziani e degli invalidi ed estese l’obbligo dell’istruzione elementare fino a dodici anni.
Altre importanti riforme riguardarono le condizioni delle classi lavoratrici:
• fu assicurato il riposo settimanale;
• gli orari di lavoro furono regolati per legge: orario massimo giornaliero (12 ore per le donne e 11 per gli adolescenti);
• al lavoro in miniera si poteva accedere solo da 14 anni in su;
• il lavoro festivo e notturno era limitato;
• alle madri lavoratrici era concesso il congedo per gravidanza;
• furono aumentati i sussidi per malattia e per invalidità
Nel 1912 Giolitti varò una riforma del sistema elettorale che istituiva il suffragio universale maschile: per godere del diritto di voto, la norma stabiliva che il cittadino sapesse leggere e scrivere o avesse almeno 30 anni di età o avesse fatto il servizio militare. Nonostante queste limitazioni la riforma elettorale rappresentò uno straordinario progresso democratico perché ampliava la base elettorale a 8 milioni di persone.
Bisognerà attendere ancora quasi 35 anni, invece, prima che la possibilità di votare fosse concessa anche alle donne.

Spiega il nesso di causa-effetto tra aumento dei salari operai e sviluppo economico.
Salari più alti comportano aumento di consumi e maggiore produzione dei beni.

Nel 1913 si tennero le prime elezioni a suffragio universale maschile.
COMPRENDO IL TESTO
In politica economica Giolitti era liberista o protezionista?
Protezionista.
Con questa espressione s’intendono i trasferimenti di denaro effettuati da un lavoratore straniero (emigrante) a beneficio di un altro individuo residente nel suo Paese di origine (in genere familiari, parenti o amici).
Nel primo decennio del XX secolo l’Italia iniziò il suo decollo industriale: l’economia crebbe a un ritmo vertiginoso, specialmente nei settori della metallurgia, della chimica (fertilizzanti, gomma) e della meccanica (macchinari, automobili: nel 1899 fu fondata la Fiat). Si sviluppò anche l’industria idroelettrica, che produceva elettricità sfruttando, invece che il carbone, l’energia dei corsi d’acqua. Gli industriali del Nord sfruttarono inizialmente due fattori:
• i lunghi orari di lavoro;
• i bassi salari dei lavoratori italiani, tra i peggio pagati d’Europa. Grazie a ciò, le industrie italiane poterono superare i problemi e affermarsi. In seguito, i miglioramenti salariali e sociali promossi da Giolitti e le rimesse degli emigranti, stimolarono i consumi e la circolazione della ricchezza. La politica economica di Giolitti si mosse su quattro piani:
• sostegno diretto al settore industriale; lo Stato finanziava fabbriche e industrie che necessitavano di denaro;
• mantenimento della politica protezionista;
• aumento delle commesse pubbliche, cioè della domanda dello Stato di beni industriali necessari allo sviluppo del Paese: in tal modo, l’industria italiana non soffriva le conseguenze del protezionismo degli altri Paesi, perché lo Stato acquistava gran parte della sua produzione;
• costruzione di un sistema di trasporto efficiente e non condizionato da interessi privati: la rete ferroviaria, che alcune imprese private gestivano inadeguatamente, fu nazionalizzata. Inoltre, Giolitti fece estendere la rete ferroviaria e portare a termine il traforo del Sempione, aprendo una strategica via di comunicazione con le regioni nordeuropee.
Operai impegnati nello scavo della galleria del Sempione. L’impresa fu molto impegnativa e costò la vita ad alcuni minatori.
L’eccezionale sviluppo economico e sociale dei primi anni del Novecento riguardò soprattutto l’Italia settentrionale, in particolare il «triangolo industriale» che aveva come vertici le città di Genova, Torino e Milano. Il Mezzogiorno rimase escluso: l’industria non mise radici e l’agricoltura continuò a essere legata a metodi tradizionali, con la prevalenza del latifondo improduttivo. La miseria diffusa provocò una nuova impressionante ondata di emigrazioni: tra il 1901 e il 1913 emigrarono verso le Americhe circa 8 milioni d’italiani.

Giolitti non era un sostenitore dell’avventura coloniale e, infatti, aveva abbandonato i progetti dei suoi predecessori. Nazionalisti e industriali, però, continuavano a sostenere le ragioni del colonialismo italiano. I nazionalisti volevano che l’Italia diventasse una grande potenza e consideravano la conquista delle colonie un passaggio decisivo. Gli industriali speravano che una guerra coloniale desse loro grandi occasioni di guadagno
La forte pressione dei nazionalisti spinse infine Giolitti a occupare la Libia, che allora faceva parte dell’Impero ottomano. La guerra iniziò nel 1911. Mentre l’esercito italiano doveva confrontarsi con la forte resistenza della popolazione libica, le operazioni militari furono estese al mar Egeo, dove gli italiani occuparono l’isola di Rodi e il piccolo arcipelago del Dodecaneso. Nel 1912 l’Impero ottomano fu costretto a firmare la pace di Losanna con cui cedeva la Libia all’Italia.

Rielaboro le informazioni
Avanzata delle truppe italiane nel deserto.
COMPRENDO IL TESTO
Completa le frasi indicando i gruppi motivati a riprendere la politica coloniale.
a. I ritenevano che il possesso di colonie potesse consentire all’Italia di diventare una grande potenza.
b. Gli erano convinti di poter trarre occasioni di guadagno dalle colonie.
1. Completa la tabella inserendo le iniziative politiche del governo Depretis elencate. Poi, sulla base della tabella, fai una sintesi orale del paragrafo.
• Protezionismo: dazi e dogane introdotti per «proteggere» i prodotti italiani dalla concorrenza straniera
• Patto con la Germania e l’Austria: Triplice alleanza (1882)
• Abolizione della tassa sul macinato (1884)
• Modifica della legge elettorale: estensione del suffragio (1882)
• Introduzione dell’istruzione elementare obbligatoria: legge Coppino (1877)
• Partecipazione alla spartizione coloniale dell’Africa
Riforme politiche e sociali
Politica economica
Politica estera
• Modifica della legge elettorale: estensione del suffragio (1882)
• Introduzione dell’istruzione elementare obbligatoria: legge Coppino (1877)
• Protezionismo: dazi e dogane introdotti per «proteggere» i prodotti italiani dalla concorrenza straniera
• Abolizione della tassa sul macinato (1884)
• Patto con la Germania e l’Austria: Triplice alleanza (1882)
• Partecipazione alla spartizione coloniale dell’Africa
2. Utilizza gli elementi elencati per costruire sul tuo quaderno una mappa concettuale dell’espansione coloniale italiana in Africa orientale. Soluzioni in Guida.
1882 – Truppe del negus d’Abissinia – Governo italiano – 1887 – Compagnia Rubattino – Dogali – Porto di Assab – Corno d’Africa – Truppe italiane nazionalisti industriali
Il diritto di autodeterminazione dei popoli consiste nella libertà di ciascun popolo, costituitosi in Stato, di decidere autonomamente del proprio destino e di utilizzare secondo i propri obiettivi le risorse di cui dispone. L’imperialismo è la più chiara ed evidente negazione di tale diritto. Le potenze imperialiste, infatti, sottomettono popoli e territori e impongono i loro interessi, se necessario anche ricorrendo all’uso della forza.
OTTOCENTO, UN SECOLO CONTRADDITTORIO: «RISVEGLIO DEI POPOLI» E IMPERIALISMO
Prima metà del XIX secolo: il «risveglio dei popoli»
È possibile dividere il XIX secolo in due parti molto diverse tra loro: la prima metà del secolo fu contraddistinta dal «risveglio dei popoli», cioè dalla prepotente affermazione delle nazionalità contro la dominazione straniera; l’autodeterminazione dei popoli è stato il criterio guida dei primi cinquanta-sessant’anni del secolo. La seconda metà del secolo, invece, fu caratterizzata dall’imperialismo, cioè da un fenomeno di segno completamente opposto.
Nella prima metà dell’Ottocento numerose nazionalità, specialmente in Europa, si batterono per conquistare il diritto ad autodeterminarsi, liberandosi dall’oppressione di potenze straniere. Si pensi a vari casi di «risorgimento nazionale»:
• i greci contro i turchi;
• i polacchi contro la triplice oppressione di Austria, Prussia e Russia;
• gli italiani contro l’Impero austriaco.

Seconda metà del XIX secolo: l’imperialismo
Nella seconda metà del XIX secolo, invece, numerosi Paesi europei, anche quelli che fino a pochi decenni prima si erano battuti per conquistare la propria indipendenza nazionale, praticarono politiche imperialiste a danno di altri popoli, sottomettendoli con la forza e sfruttandone le risorse.
Pensiamo all’Italia: fino al 1860 fu impegnata nel Risorgimento nazionale contro la dominazione austriaca; a partire dai primi anni Ottanta, invece, condusse una politica imperialista nell’Africa del Nord e in quella orientale.
NEO-IMPERIALISMO E DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE
Nel corso del XX secolo, il declino delle grandi potenze imperialiste (Regno Unito e Francia) e l’avvio del processo di decolonizzazione in Africa e in Asia hanno fortemente ridimensionato lo sfruttamento coloniale europeo nei confronti dei Paesi in via di sviluppo. Ciò, tuttavia, non ha posto fine al fenomeno imperialista, che ha assunto semmai nuove facce. Dopo la Seconda guerra mondiale, infatti, il mondo è stato diviso in sfere d’influenza dominate dalle due grandi superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, vincitrici sul nazifascismo. Entrambe hanno praticato politiche imperialiste nelle parti del mondo soggette al loro dominio.
• Stati Uniti: la politica di Washington nei confronti dell’America latina, per esempio ha l’obiettivo di mantenere il controllo sui governi del Centro e del Sud America (considerato come «il cortile di casa»,
Volontari garibaldini impegnati in un combattimento contro gli austriaci durante la Terza guerra d’indipendenza (1866).

cioè un territorio confinante su cui si ritiene legittimo estendere il potere) e di sfruttarne le risorse naturali e le materie prime.
• Unione Sovietica: Mosca, fino agli anni Novanta del XX secolo, ha praticato una politica imperialista sia nei confronti delle «democrazie popolari» dell’Europa centro-orientale (Polonia, Repubblica democratica tedesca, Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria, Repubbliche baltiche), sia nei confronti di alcuni Stati, come per esempio l’Afghanistan, collocati a ridosso delle sue frontiere asiatiche.
Esiste ancora l’imperialismo?
Oggi, l’imperialismo, così come l’abbiamo conosciuto tra il XIX e il XX secolo, non esiste più o, per lo meno, non si manifesta con la stessa violenza del passato. Tuttavia, molto spesso le relazioni internazionali tra gli Stati sono ancora improntate a una logica imperialista
• In Africa, le antiche potenze coloniali europee esercitano sia un ruolo fondamentale nella politica e nell’economia di molti Stati, nonostante quasi tutti i Paesi del continente siano formalmente indipendenti.
• In Medio Oriente, una regione strategica per l’economia mondiale a causa della presenza del petrolio e di altre risorse energetiche, le grandi potenze intervengono nelle relazioni conflittuali tra gli Stati, arrivando anche a limitare o negare il diritto all’autodeterminazione di molti popoli (per esempio i curdi o i palestinesi).

I termini elencati qui sotto costituiscono una parte del campo semantico legato all’argomento di questo approfondimento. A coppie o piccoli gruppi leggete queste parole, ricercate nel dizionario quelle che non conoscete e arricchite l’elenco con altri termini che vi vengono in mente.
Carta delle nazioni unite
secessione
controllo politico comunità internazionale rivendicazione imperialismo autonomia separatismo decolonizzazione colonizzazione nazionalismo oppressione sionismo
Utilizzate le seguenti domande per condurre una discussione in classe e confrontare le vostre idee.
1. Quale differenza caratterizza l’imperialismo della seconda metà del XIX secolo dall’imperialismo del secondo dopoguerra?
2. A partire dagli anni Novanta del XX secolo a oggi, nei Paesi dell’Est europeo e nell’area balcanica si sono diffusi numerosi movimenti separatisti e indipendentisti: individuate le cause che portano alla separazione dei popoli e quali nuovi Stati si sono costituiti pacificamente e quali, invece, a seguito di conflitti militari.




Lezione 1 La nascita dell’imperialismo


Tra il 1870 e il 1914 il colonialismo assunse i caratteri di conquista militare e sottomissione politica ed economica dei popoli: si trasformò così in imperialismo, giustificato dal darwinismo sociale e dai diffusi nazionalismi. Nella Conferenza di Berlino del 1884, quattordici Stati si divisero il continente africano «a tavolino». In Asia il Regno Unito s’impossessò dell’India, la Francia della parte sud-orientale e la Cina finì per essere completamente controllata dalle potenze europee. A fine secolo emersero altre potenze: Germania, Giappone e Stati Uniti.
Lezione 2 Le potenze imperialiste in Europa
Durante il regno della regina Vittoria, il Regno Unito fu governato dai conservatori e poi, dal 1905, dai liberali, che attuarono importanti riforme sociali e politiche. Nel 1906 nacque il Partito laburista, di orientamento socialista e impegnato nella difesa dei lavoratori.
Nel 1870, dopo la sconfitta di Napoleone 3° con la Prussia, la Francia tornò a essere una Repubblica e avviò importanti riforme sociali.
L’Impero tedesco, nato nel 1871, diventò una grande potenza politica ed economica sotto la guida del cancelliere Bismarck.
Lezione 3 Crisi e declino degli imperi multinazionali
Verso la fine dell’Ottocento, Impero russo, Impero asburgico e Impero ottomano erano caratterizzati da arretratezza economica e inefficienza amministrativa. Dominavano inoltre su vasti territori occupati da gruppi etnici diversi che aspiravano all’autodeterminazione. Questi fattori causarono il loro graduale declino.
Lezione 4 L’Italia: dalla Sinistra storica all’età giolittiana Dal 1876 al 1887 la Sinistra storica di Depretis attuò riforme sociali e politiche, tentò l’espansione coloniale in Africa e firmò con Germania e Austria la Triplice alleanza. Il successore Crispi incrementò l’intervento statale in economia e nella vita sociale (con misure autoritarie e repressive) e tentò, fallendo, una nuova avventura coloniale
A fine secolo nacque il Partito socialista italiano; l’enciclica Rerum novarum di papa Leone 13° favorì il ritorno dei cattolici alla vita politica.
Il governo Giolitti (1903-1914) rafforzò la democrazia e il decollo industriale, promosse riforme sociali e riprese l’espansione coloniale in Libia.
Completa la mappa dell’Unità inserendo le parole mancanti.
Snaturamento delle economie locali – Occupazione di Asia e Africa – Darwinismo sociale – Materie prime – Nazionalismo esasperato – Merci – Protezionismo
Cause
Nazionalismo esasperato
Rafforzamento economico
Effetti
Protagonisti


Darwinismo sociale
legittimato da e
Razzismo
Protezionismo
Fornitura di
Occupazione di Asia e Africa materie prime merci
Esportazione delle prodotte
Regno Unito vittoriano
Conquista militare Francia della 3° Repubblica
Sinistra storica
favorisce
Colonialismo
Sottomissione politica Germania di Bismarck
Asservimento economico
Snaturamento delle economie locali
Giappone
Stati Uniti
Italia
governata da
Decollo industriale

1. Indica se le affermazioni sono vere o false.
a. Protagonista del colonialismo tra XVI e XVII secolo fu il Regno Unito.
b. L’espansione europea del XIX secolo coincise in Cina con la crisi della dinastia Manciù.
c. Le «guerre dell’Oppio» furono combattute dal Regno Unito contro l’Impero ottomano.
d. Nel 1898 Cuba divenne un protettorato statunitense.
e. Il Giappone nel 1905 occupò la Manciuria.
f. Bismarck salì al potere grazie all’aiuto del Partito socialista.
g. La Russia aveva un’industria solida grazie agli investimenti delle classi alte della società.
h. L’Impero austro-ungarico, all’inizio del Novecento, era una delle principali potenze europee.
i. La Sinistra storica era erede del pensiero politico di Cavour.
l. Depretis inaugurò la pratica parlamentare del trasformismo.
m. Crispi considerava la Germania di Bismarck il proprio modello politico.
n. Giolitti era il rappresentante politico della grande borghesia industriale.
2. Completa la tabella relativa alle forme di governo presenti in Europa all’inizio del Novecento.
Russia
Regno Unito
Francia
Germania
Austria-Ungheria
Autocrazia
Monarchia costituzionale
Repubblica
Monarchia
Monarchia
3. Completa il testo con i termini o le espressioni corrette.
Sinistra
Stato
penale
Etiopia
Francesco Crispi, un altro esponente della parlamentare, aveva come obiettivo principale il consolidamento dello . Perciò rafforzò i poteri del governo a scapito di quelli del Parlamento, favorì l’intervento statale in campo economico e sociale, varando un codice più moderno, costruendo un sistema pubblico, incrementando il controllo statale sugli enti ecclesiastici di beneficenza, intervenendo con durezza in occasione delle proteste dei . Come il suo predecessore, egli continuò una politica economica protezionista e riprese il tentativo di penetrazione dell’Italia in e nel d’Africa. Il tentativo di controllo coloniale italiano fallì definitivamente con la sconfitta di , in seguito alla quale Crispi fu costretto a
dimettersi
sanitario
lavoratori siciliani
Corno
Adua
4. Termina le frasi scegliendo il completamento esatto.
1. La Rerum novarum era: a un’enciclica papale. b una legge dello Stato. c un documento di propaganda.
2. La Rerum novarum sosteneva: a la lotta di classe.
b il diritto dei lavoratori ad associarsi. c il diritto alla ribellione armata.
5. Collega ogni parola nella colonna di sinistra al suo contrario nella colonna di destra. Assumi come riferimento il significato che le parole hanno nell’Unità appena studiata.
1. Nazionalismo
2. Supremazia
3. Laburisti
4. Liberismo
5. Destra
6. Socialisti
a. Sottomissione
b. Protezionismo
c. Cosmopolitismo
d. Sinistra
e. Capitalisti
f. Conservatori
6. Completa la tabella relativa alla politica di Depretis (l’esercizio è già avviato).
Obiettivi
Politica sociale Rispondere ai bisogni del ceto medio
Politica economica
Politica estera
Consenso della grande industria e dell’alta borghesia
Trasformazione dell’Italia in un moderno Paese europeo
Strategia
Promozione di riforme sociali e politiche
Azioni
- Istruzione : 5 anni (di cui 2 obbligatori e gratuiti)
- Abolizione della
elementare tassa sul macinato
- Modifica della
- Introduzione di
Varo della politica protezionista
- Partecipazione alla spartizione coloniale dell’
Africa
- Mutamento delle alleanze: stipula della Triplice alleanza
- Sovvenzione di alcuni
legge elettorale dazi settori industriali
- Firma della
Triplice alleanza
- Tentativo di conquista del
Corno d’Africa
7. Completa la linea del tempo inserendo gli eventi elencati.
a. Prima rivoluzione russa c. Rivolta dei Boxer
b. Inizio dell’età dell’imperialismo d. Conferenza di Berlino
8. Date le definizioni, scrivi il termine corrispondente.
a. Teoria che afferma la presenza nella società umana di soggetti più forti destinati a dominare:
Darwinismo sociale.
b. Rivendicazione violenta della supremazia della propria nazione sulle altre:
c. Forma di tutela politica e militare esercitata da uno Stato più potente nei confronti di un altro:
Protettorato.
d. Contadini che vivono in una condizione servile senza poter abbandonare la terra in cui lavorano:
Servi della gleba. Nazionalismo.
9. Esegui sulla carta le attività indicate.
• Distingui con colori diversi i territori sotto il dominio coloniale di Regno Unito, Francia e Giappone.
• Inventa un simbolo per indicare la guerra e collocalo sulle due nazioni che combatterono tra loro nel 1904-1905.


Rudyard Kipling (1865-1936) è stato uno scrittore e poeta britannico vissuto nel XIX secolo, all’epoca della massima espansione dell’Impero britannico. Trascorse in India, la «perla dell’Impero», molti anni e fu dunque immerso nel mondo e nella mentalità coloniale. In questa famosa poesia, Kipling si rivolge ai «fratelli» americani impegnati nelle loro prime imprese di colonizzazione.
Tipo di documento: testo, poesia
Autore: Rudyard Kipling
Epoca: XIX secolo
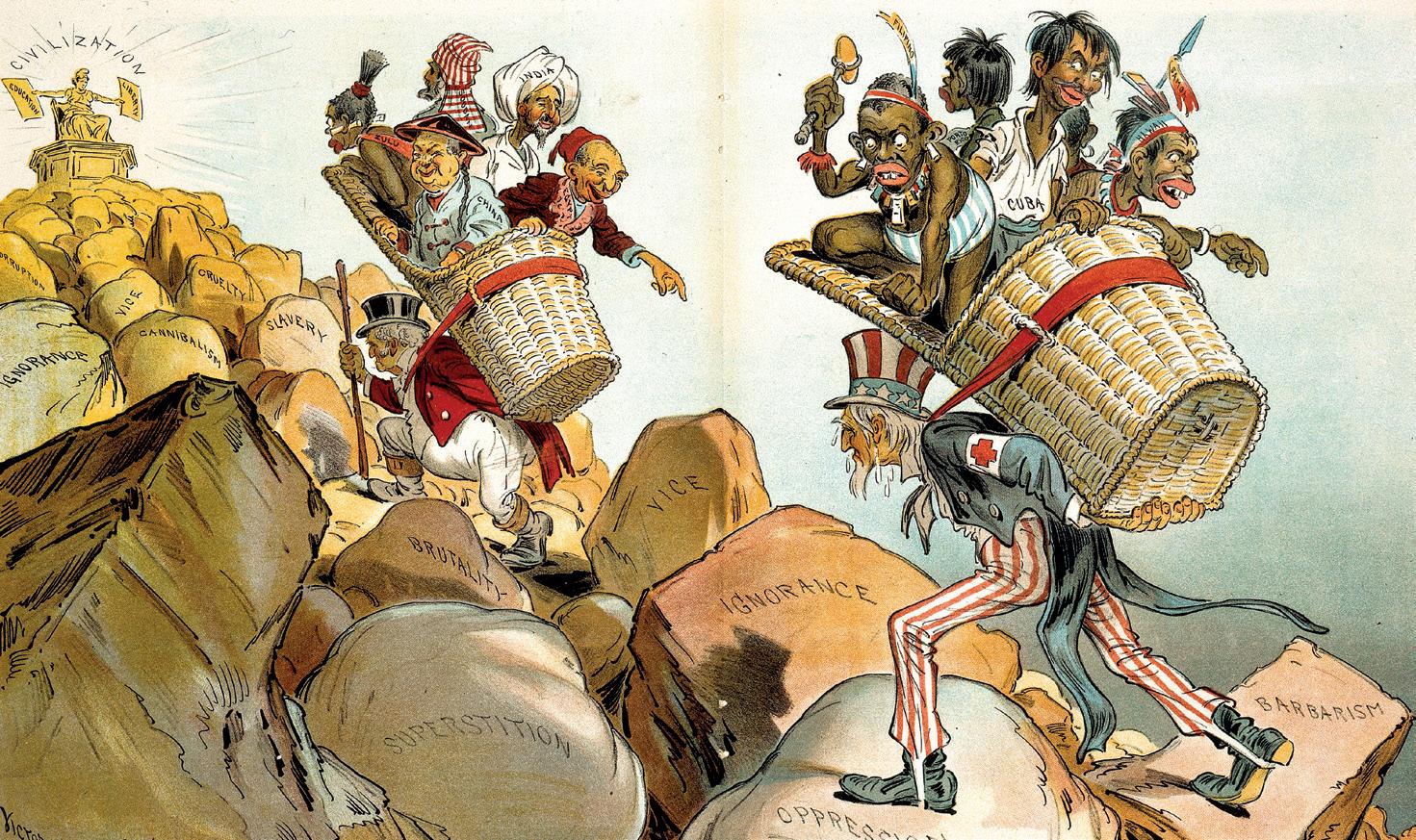
A coppie rispondete alle domande dopo aver letto il testo, quindi confrontate le risposte con quelle dei vostri compagni.
1. Che cosa significa «fardello»?
2. Che cosa significa dunque l’espressione «fardello dell’uomo bianco»?
3. Sottolinea le parti del testo che indicano la missione dell’uomo bianco.
4. Secondo te, perché l’autore afferma che sono finiti i giorni dell’infanzia e che sono sopraggiunti gli anni ingrati?
5. Qual è il soggetto degli ultimi quattro versi?

Il fardello dell’uomo bianco raccogliete…
Mandate lontani i giovani migliori…
Legate all’esilio i vostri figli, per mettervi al servizio dei nostri prigionieri a mantenere in alta uniforme l’ordine tra i selvaggi…
Popoli ostili, da poco assoggettati, per metà demoni e per metà bambini.
[…]
Il fardello dell’uomo bianco raccogliete…
Sono finiti i giorni dell’infanzia…
Gli allori ottenuti facilmente, le lodi profferite con larghezza. La vostra virilità ad appurare sarà ora, negli anni ingrati, e spietato – per saggezza acquisita a caro prezzo –solo il giudizio dei vostri pari!
Utilizzate le seguenti proposte di lavoro per confrontare le vostre idee e opinioni.
Dopo la Seconda guerra mondiale (1945) è nata l’Organizzazione delle nazioni unite (ONU), con sede a New York.
I suoi ambiti d’intervento erano essenzialmente due:
• politico: discutere pacificamente e democraticamente i grandi problemi del mondo;
• militare: intervenire nelle aree di crisi per imporre con la forza il «cessate il fuoco».
Nella seconda parte del XX secolo e in questo inizio di XXI secolo, si è imposto il concetto di «guerra umanitaria»: il «fardello» oggi è dunque la responsabilità della comunità internazionale riunita nell’ONU di fronte a crisi umanitarie che richiedono un intervento diretto e pratico per essere affrontate.
Individuate con una ricerca almeno due esempi di «guerra umanitaria».
Nell’estate del 1914, a Sarajevo, l’erede al trono d’Austria-Ungheria Francesco Ferdinando è vittima di un attentato da parte di un nazionalista serbo. A quarant’anni dall’ultimo conflitto sul suolo europeo, il continente precipita in una crisi gravissima sfociata nello scoppio di una grande guerra mondiale, che dura fino al 1918 e coinvolge anche moltissimi Stati extra-europei. conflitto senza precedenti nella storia dell’umanità non solo per la quantità di morti, feriti e distruzioni che lascia dietro di sé, ma anche per le conseguenze destabilizzanti sul piano politico e diplomatico e per le profonde trasformazioni dell’apparato industriale. La Prima guerra mondiale cambia per sempre il volto del mondo e la mentalità degli uomini e delle donne.

1900
1907
Triplice intesa tra Regno Unito, Francia e Russia
v Nell’ultima parte dell’Ottocento le grandi potenze europee, soprattutto Regno Unito e Francia, avviano una politica imperialista.
v Le principali vittime dell’imperialismo europeo sono il continente africano e quello asiatico.
v Nel 1876 la Sinistra scalza la Destra storica al governo dell’Italia. Sotto i governi Depretis e Crispi l’Italia allarga le basi del suffragio elettorale e promuove una politica di riforme sociali ed economiche. Sotto i governi Giolitti, l’Italia diventa uno Stato liberale e si avvia al decollo industriale.
v L’Italia partecipa all’avventura coloniale insediandosi nel Corno d’Africa e in Libia.
1912-1913
Guerre balcaniche
1914
Attentato di Sarajevo: inizia la Prima guerra mondiale
1919
Conferenza di pace di Versailles
1915
L’Italia in guerra a fianco dell’Intesa


1918
Fine della Prima guerra mondiale
1917
Gli Stati Uniti in guerra a fianco dell’Intesa Rivoluzione russa

Nell’Europa centrale gli imperi che dichiararono la guerra nel 1914 occupavano la maggior parte del territorio.

1922
Grande sviluppo economico degli Stati Uniti
1923
Nasce la Repubblica turca

1929
Crollo di Wall Street
Gli Stati dell’Intesa avevano l’appoggio di un gran numero di altri Paesi in altri continenti. Nonostante ciò la guerra fu lunga e logorante per entrambi gli schieramenti.
1932
Presidenza di Roosevelt e avvio del New Deal
v All’inizio del XX secolo i cittadini europei sono convinti di vivere in un’epoca di progresso (Belle Époque). In realtà, gravi contraddizioni politiche, economiche e militari minacciano la pace europea.
v Nei Balcani si concentrano le maggiori tensioni e il nazionalismo slavo entra in conflitto con gli interessi di potenza dell’Impero asburgico.
v Nel 1914 l’assassinio dell’erede al trono asburgico a Sarajevo fa precipitare la crisi. In breve le maggiori potenze europee entrano in guerra: da un lato l’Intesa (Regno Unito, Francia, Russia e, dopo il 1915, Italia), dall’altro gli Imperi centrali (Germania, Austria, Turchia). La guerra si conclude nel 1918 con la vittoria dell’Intesa.
v Gli anni dell’immediato dopoguerra sono tormentati da conflitti sociali e politici. Nel 1929, a partire dagli Stati Uniti d’America, si diffonde una devastante crisi economica e finanziaria.
Sottolinea le parole chiave che descrivono il clima della Belle Époque e confronta le tue scelte con quelle dei tuoi compagni.
Il pittore Toulouse-Lautrec rappresentò il mondo della Belle Époque con figure quasi grottesche, esprimendo così la percezione delle contraddizioni di quell’epoca.

L’ultima guerra combattuta sul suolo europeo risali va al 1870, cioè ai tempi della guerra franco-prussia na. All’inizio del Novecento, quindi, milioni di europei vivevano la condizione di pace si era accompagnato un periodo di stra ordinario sviluppo economico, tecnologico e sociale, che aveva radicalmente trasforma to la vita quotidiana di milioni di esseri umani. La vita delle classi medie era no tevolmente migliorata, tanto che molte persone erano in grado di permettersi svaghi, per esempio un periodo di va canza durante l’anno, che in passato erano stati esclusivo privilegio delle classi più ricche e benestanti. Gli ope rai e i contadini continuavano a subire condizioni di lavoro molto dure, con bassi salari, ma la crescente consapevo lezza dei divari sociali e dei propri dirit ti, li portò a lottare con maggior determinazione per migliorare la loro esistenza.

Gli anni compresi tra il 1870 e l’inizio del XX secolo vengono ricordati con il nome di Belle Époque, «età bella», proprio a causa del generale clima di speranza e di ottimismo che regnava nella società europea.
Particolare del dipinto di Henri Grevex, Una serata al Pre-Catelan. Il Pre-Catelan era un ristorante parigino alla moda.
In realtà, la Belle Époque fu molto meno «bella», armoniosa e pacifica. La società europea, infatti, era percorsa da gravi tensioni e contraddizioni di tipo politico, economico e militare, pronte a esplodere da un momento all’altro.
Nei prossimi due paragrafi cercheremo di capire sia le cause storiche remote, cioè i fenomeni che duravano da tempo, che concorsero a preparare il terreno per lo scoppio del conflitto (vedi paragrafo 2), sia le cause occasionali, cioè gli eventi particolari e circoscritti che servirono da pretesto per l’inizio delle ostilità (vedi paragrafo 3).
All’inizio del XX secolo, la questione coloniale rappresentava uno dei principali motivi di tensione internazionale.
Tra la fine del XIX e il principio del XX secolo, il primato della Francia e del Regno Unito era stato messo in discussione dalla Germania, che aveva avviato la propria politica coloniale conquistando territori in Africa e sul Pacifico, minacciando così gli imperi coloniali britannici e francesi.
In Francia, inoltre, dopo l’umiliante sconfitta del 1870, l’opinione pubblica coltivava un accesissimo spirito di revanche («rivincita»): molti aspiravano a riprendersi l’Alsazia e la Lorena, cioè le regioni occupate dalla Germania al termine della guerra franco-prussiana.
Il diffuso nazionalismo spingeva ogni potenza a emergere sulle altre ma, per raggiungere tale obbiettivo, era necessario creare un sistema di alleanze. All’inizio del Novecento lo scenario politico presentava quindi due schieramenti contrapposti:
• dal 1882, Germania, Austria e Italia erano unite da un patto difensivo, la Triplice alleanza, che prevedeva l’entrata in guerra di tutti i membri se uno dei Paesi fosse stato aggredito;
• dal 1907, Francia, Regno Unito e Russia erano legate da accordi politici, militari ed economici, la Triplice intesa
Le aree di tensione nell’Europa dei primi anni del Novecento
Su questa carta le aree colorate sono quelle che, per ragioni diverse, erano oggetto di contesa da parte di alcuni Stati. Si tratta di situazioni di grave conflittualità che nel loro insieme contribuirono a fare dell’Europa una polveriera pronta a esplodere.
Rispondi alla domanda.
• Quali terre rivendicava l’Italia? Ricordi a quale Stato appartenevano?
Il Trentino e la Venezia-Giulia. Appartenevano all’Impero austroungarico.
COMPRENDO IL TESTO
Perché la Germania costituiva una minaccia per il Regno Unito?
Perché tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo aveva avviato una politica coloniale conquistando territori in Africa e nel Pacifico.


In che modo il riarmo favorì l’economia delle potenze europee?
Il riarmo favorì lo sviluppo dell’industria siderurgica e stimolò la ricerca tecnologica: offrì occasione di occupazione della forza lavoro e aumentò i guadagni degli industriali.
Nel clima di tensione politica internazionale che si era creato, molti Paesi europei intrapresero una vera e propria corsa agli armamenti. Gli Stati investirono sempre maggiori risorse economiche per rafforzare gli eserciti: nel 1880 le potenze europee avevano sostenuto spese militari per 132000000 di sterline; nel 1914 la cifra era triplicata, giungendo a 400000000 di sterline. Il riarmo, del resto, non era solo una spesa, cioè non com portava solo una sottrazione di ricchezza dello Stato, ma era anche un elemento di sviluppo dell’economia costruzione di nuove armi, infatti, faceva lavorare a pie no ritmo l’industria siderurgica e stimolava la ricerca tecnologica. Da un lato dava occupazione a migliaia di lavoratori, dall’altro era un’ottima occasio ne di guadagno per gli industriali. Dopo decenni di pace, il clima culturale era nel complesso favorevole alla guerra. I movimenti nazionalistici, che proclamavano il diritto del proprio Paese a espan dersi anche a danno dei Paesi vicini, vedevano nella pace un adeguamento a situazioni di co modo e un ostacolo al vero progresso. Queste idee erano esaltate anche da molti intellettuali: in Italia, il poeta Filippo Tommaso Marinetti de finì la guerra la «sola igiene del mondo», cioè un mezzo per rinnovare la società dando spazio a uomini dinamici, forti, pronti a lottare coraggiosamente per la propria patria.

Nel 1898 e nel 1900 il governo tedesco finanziò la costruzione di una potente flotta da guerra provocando un peggioramento dei rapporti con il Regno Unito. I britannici lanciarono a loro volta un piano per la costruzione di navi da guerra : tra il 1906 e il 1914 realizzarono 20 corazzate e 9 incrociatori da battaglia; i tedeschi , nello stesso periodo, costruirono 13 corrazzate e 5 incrociatori da battaglia. Le dimensioni di un incrociatore da battaglia come il tedesco Seydlitz (lunghezza 200 metri circa, peso 23 700 tonnellate, corazza in acciaio spessa quasi 30 centimetri) possono dare un’idea dell’enorme sforzo produttivo ed economico messo in atto.

I Balcani erano considerati una «polveriera» pronta a esplodere da un momento all’altro. In quella regione, infatti, si concentravano enormi problemi legati alla crisi dell’Impero ottomano, alle aspirazioni indipendentiste di alcuni popoli e agli interessi geopolitici delle grandi potenze, specialmente dell’Impero austriaco e di quello russo.
In Turchia, la «rivoluzione dei Giovani turchi», che nel 1908 aveva portato al potere un gruppo di giovani ufficiali ben decisi a fare della Turchia un Paese moderno e sviluppato, era sostanzialmente fallita: l’Impero ottomano rimaneva il grande «malato» della politica internazionale ed era sempre più debole; di questa debolezza intendevano approfittare sia i Paesi balcanici che ancora desideravano l’indipendenza, sia le potenze europee per estendere la loro egemonia. Così fu:
• nel 1908 la Bulgaria ottenne l’indipendenza; l’Austria invece annettè al suo impero la Bosnia-Erzegovina (su cui esercitava una specie di protettorato fin dal 1878);
• nel 1912 l’Italia occupò la Libia, possedimento turco;
• negli stessi anni la Serbia, nel corso di due guerre (le cosiddette «guerre balcaniche»), diventò il Paese balcanico più potente e si alleò strettamente alla Russia, che aspirava a diventare la potenza di riferimento per tutti i popoli slavi.
Serbia e Russia non gradivano che l’Austria avesse possedimenti diretti nei Balcani. In Bosnia, inoltre, vivevano numerosi serbi che volevano riunire la Bosnia alla Serbia. Tra i due schieramenti la tensione aumentò sempre più.
Il 28 giugno 1914 a Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d’Austria, e sua moglie Sofia furono uccisi in un attentato. L’assassino, Gavrilo Princip (1894-1918), era un giovane studente serbo che apparteneva a un’organizzazione clandestina che si batteva contro gli austriaci per l’indipendenza della Bosnia.
Nel contesto europeo, attraversato come abbiamo visto da tensioni fortissime, questo attentato ebbe conseguenze enormi e costituì la causa scatenante del conflitto mondiale
L’arresto dell’attentatore Gavrilo Princip.

Il leader dei Giovani turchi, Mehmed Talaat Pascià (a destra) con il suo attendente.
Che cosa accomunava Russia e Serbia e cementava la loro alleanza?
a Comune fede protestante. b Comune identità etnica slava.
c Erano entrambi Stati socialisti. X

COMPRENDO IL TESTO
Quale Stato dà il via alla Prima guerra mondiale? Attraverso quale atto?
L’Austria, dichiarando guerra alla Serbia dopo l’attentato all’arciduca austriaco
Francesco Ferdinando a Sarajevo.
Panslavismo
Sentimento di solidarietà fra tutti i popoli slavi finalizzato alla creazione di un’unione politica di quei popoli sotto la guida del più grande e importante fra essi: la Russia.
Nel giro di appena due mesi l’intera Europa precipitò nella guerra. Il sistema delle alleanze tra gli Stati si trasformò, infatti, in un meccanismo implacabile che nessuno riuscì a fermare.
Questa l’impressionante sequenza dei fatti:
• 23 giugno – l’Austria pose alla Serbia un ultimatum difficile da accettare: la Serbia doveva riconoscere le proprie responsabilità nell’attentato e lasciare che le autorità austriache indagassero anche in territorio serbo (rinunciando così alla propria sovranità);
• 28 luglio – l’Austria dichiarò guerra alla Serbia, nonostante il governo di Belgrado avesse accettato le durissime condizioni austriache;
• 30 luglio – la Russia scese in guerra a fianco della Serbia in nome del panslavismo;
• 1 agosto – la Germania dichiarò guerra alla Russia e il 3 agosto alla Francia;
• 2 agosto – la Germania invase il Belgio, Paese neutrale, per colpire la Francia;
• 4 agosto – il Regno Unito dichiarò guerra alla Germania;
• 11-12 agosto – Francia e Regno Unito dichiararono guerra all’Austria.
Prima guerra mondiale: le forze in campo
La carta mostra gli schieramenti che si fronteggiarono in Europa nel primo conflitto mondiale.
Rispondi alla domanda.
• Gli schieramenti creatisi nel conflitto mondiale rispecchiano quelli della Triplice alleanza (Imperi centrali) e della Triplice intesa? Se no, in che cosa differiscono?
Gli schieramenti differiscono: la Triplice alleanza perde l’Italia come alleata e viene appoggiata da Bulgaria e Impero ottomano. L’Italia si unisce alla Triplice intesa.


Nel giro di pochi mesi, il conflitto diventò mondiale:
• il Giappone dichiarò guerra alla Germania per impossessarsi dei suoi possedimenti coloniali nel Pacifico;
• la Turchia entrò in guerra a fianco della Germania;
• gli Stati Uniti entrano in guerra a fianco di Regno Unito e Francia. Vedremo nella prossima lezione come si sviluppò il conflitto e quale fu il ruolo dell’Italia.
Corazzata giapponese impiegata durante la Prima guerra mondiale. Il Giappone entrò in guerra a fianco della Triplice intesa.
Rielaboro le informazioni

1. Completa la mappa concettuale inserendo correttamente i termini elencati. ottomano – Germania – russo – Francia – austro-ungarico
Fra Germania e per Alsazia e Lorena
Francia
Rivalità fra gli Stati
L’Europa nel 1914
Movimenti indipendentisti
Fra Regno Unito, Francia e per ragioni coloniali
Germania
Fra Impero e austro-ungarico per egemonia nei Balcani
Nell’Impero
Nell’Impero
russo ottomano austro-ungarico
2. La mappa riassume la situazione dell’Europa alla vigilia della Prima guerra mondiale e focalizza gli aspetti più rilevanti. Se dovessi dare un titolo alla mappa, quale ti sembrerebbe il più appropriato?
a L’Europa della Belle Époque
b L’Europa alla vigilia del conflitto: le cause dello scontro
X
c L’Europa dopo Sarajevo
d L’Europa prima di Sarajevo
X
e Nessuno dei titoli indicati. Propongo:
Soluzione libera.
Possono due soli proiettili di pistola uccidere nove milioni di persone? Sembra assurdo. Eppure i due proiettili sparati a Sarajevo il 28 giugno 1914 furono la scintilla che fece esplodere una guerra terribile.
Quando l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo decise di recarsi a Sarajevo davvero non si aspettava di ricevere un’accoglienza simile. Quel distinto aristocratico dai baffoni all’insù, destinato a succedere sul trono imperiale al vecchio Francesco Giuseppe, era notoriamente favorevole alle rivendicazioni dei popoli slavi. Tutti lo sapevano. Era talmente favorevole da affermare pubblicamente che, una volta salito al trono, li avrebbe aiutati a soddisfare le proprie aspirazioni autonomiste. Perciò era sicuro di raccogliere affetto e consenso nelle strade della capitale bosniaca. La folla festante assiepata sui marciapiedi lungo il percorso che lo avrebbe condotto al ricevimento ufficiale sembrò confermargli quella impressione: una giornata di festa in una città amica.
Tra le famiglie entusiaste accorse a salutare il futuro sovrano si nascondeva, però, un gruppo di giovani serbobosniaci (alcuni non avevano ancora compiuto vent’anni) le cui intenzioni non erano amichevoli. Militavano in una formazione clandestina antiaustriaca, la «Mano nera», che combatteva per l’indipendenza delle province balcaniche. Ma l’arciduca non era amico dei popoli slavi? Già, è così; ma la faccenda è un po’ più complicata perché, com’è accaduto spesso nel corso della Storia, avere opinioni simili non sempre aiuta ad andare d’accordo. Il futuro imperatore, infatti, era sì filoslavo, ma non abbastanza da permettere che gli slavi abbandonassero l’impero e dessero vita a uno Stato indipendente. Insomma: amici, ma uniti.

Ma torniamo ai fatti. Il 28 giugno 1914 a Sarajevo tutto è pronto per accogliere l’ospite. Finalmente il corteo delle automobili su cui viaggiano i due ospiti si muove: nell’attesa che l’arciduca giunga a tiro, Gavrilo Princip, uno studente che fa parte del gruppo della «Mano nera», controlla nervosamente il revolver che nasconde nel panciotto della giacca. L’arciduca sfugge a un primo attentato condotto da uno dei complici di Princip. Francesco Ferdinando, arrivato al municipio della città, è visibilmente scosso e nervoso. Dopo un po’, decide di ripartire. Gavrilo Princip, forse convinto che il piano
sia fallito, si è allontanato dalla sua posizione, quando si accorge che il corteo di automobili si avvicina. Il giovane studente impugna la pistola, si fa largo tra la folla, prende la mira e spara. L’erede al trono si accascia nell’automobile. Con lui cade anche la moglie Sofia. La gente grida spaventata, i soldati si gettano sull’attentatore e lo immobilizzano. È accaduto tutto in un attimo: Francesco Ferdinando è ferito a morte Nessuno in Europa e nel mondo sa ancora quale terribile destino si stia preparando. Nel volgere di un mese, tutti sapranno.

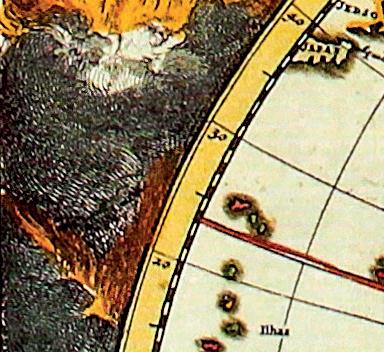
Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo si formano due sistemi di alleanze internazionali:
• Triplice alleanza: Impero austro-ungarico, Germania e Italia (1882);
• Triplice intesa: Regno Unito, Francia e Russia (1907).
A partire dal 1914 le due alleanze si scontreranno nella Prima guerra mondiale, attirando a
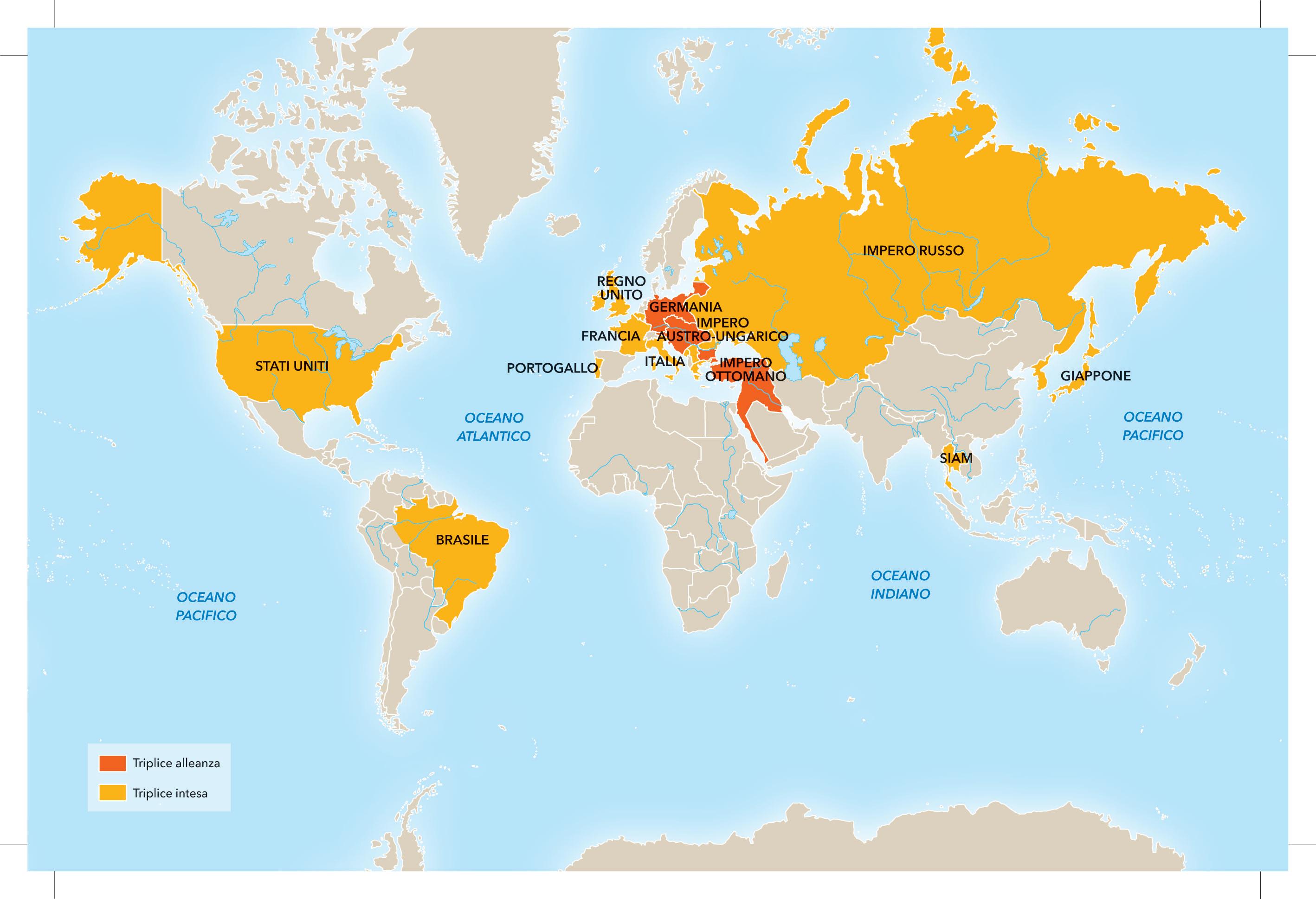
2 1 Schieramenti di guerra al completo
Alleanze «impure»
Per ambizione di potenza l’Italia si alleò con l’Austria, contro cui aveva combattuto tre guerre d’indipendenza. Regno Unito e Francia si allearono con la Russia, simbolo dell’autocrazia e dell’assolutismo.
Triplice alleanza con Impero ottomano e Bulgaria. Triplice intesa con Serbia, Belgio, Montenegro, Giappone, Italia (dal 1915), Portogallo e Romania (dal 1916), Stati Uniti, Grecia, Siam e Brasile (dal 1917).

PRESENTE: XX-XXI SECOLO
Dopo la Seconda guerra mondiale (1945) e fino al 1991 il mondo è stato diviso in due grandi blocchi politico-militari: il blocco occidentale, guidato dagli Stati Uniti d’America, e il blocco comunista, guidato dall’Unione Sovietica.
Dopo il crollo dell’Unione Sovietica (1991), il mondo ha cessato di essere bipolare (due poli) ed è diventato multipolare (numerosi poli), con l’ascesa di nuove potenze globali come l’In

Il blocco occidentale e il blocco comunista si formarono intorno alle due potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale. La contrapposizione fu politica, militare e ideologica e fu definita «Guerra fredda».

COMPRENDO IL TESTO
Colloca in uno dei due schieramenti, Imperi centrali (IC) e Intesa (I), i seguenti Stati: Turchia ( ), Serbia ( ), Bulgaria ( ).
IC IC I

1914: il fronte occidentale e il fronte orientale
Il 28 luglio 1914 l’Austria dichiarò guerra alla Serbia e in pochi giorni, per effetto del sistema delle alleanze internazionali, si delinearono due schieramenti:
• gli Imperi centrali, cioè Austria e Germania, cui si aggiunsero Impero ottomano e Bulgaria;
• Francia, Regno Unito e Russia (la Triplice intesa), al fianco della Serbia. Il conflitto si sviluppò inizialmente su due fronti principali, uno in Europa occidentale, l’altro in Europa orientale.
Neutralità
È la condizione di uno Stato che sceglie di rimanere estraneo a un conflitto.
Sul fronte occidentale nell’agosto 1914 le truppe tedesche varcarono il confine con il Belgio, nonostante la sua neutralità, e proseguirono in territorio francese; a settembre furono però arrestate sul fiume Marna
Sul fronte orientale l’esercito tedesco si scontrò con le truppe russe, che erano penetrate nella Prussia orientale, bloccandone l’avanzata. L’Austria, dal canto suo, avanzò in Galizia (una regione situata tra le attuali Polonia e Ucraina) dove fu però fermata nelle due battaglie di Leopoli (la città ucraina di Lvov) in agosto e settembre 1914, e dovette ritirarsi.
In breve tempo i due fronti si stabilizzarono e iniziò una sanguinosa guerra di posizione, combattuta cioè nelle trincee sui fronti, che nei primi mesi di guerra costò la vita a centinaia di migliaia di soldati.
LAVORO SULLA CARTA
Il fronte occidentale e quello orientale
Le due carte mostrano la penetrazione tedesca sul fronte occidentale e orientale tra il 1914 e il 1918.
Rispondi alle domande.
1. Quali furono i territori occupati dalle truppe tedesche sul fronte occidentale? Fin dove si spinse l’offensiva tedesca?
Belgio e Francia, arrivando nei pressi di Parigi.
2. Quali furono i territori occupati dagli Imperi centrali sul fronte orientale?
Polonia, Serbia, Romania.
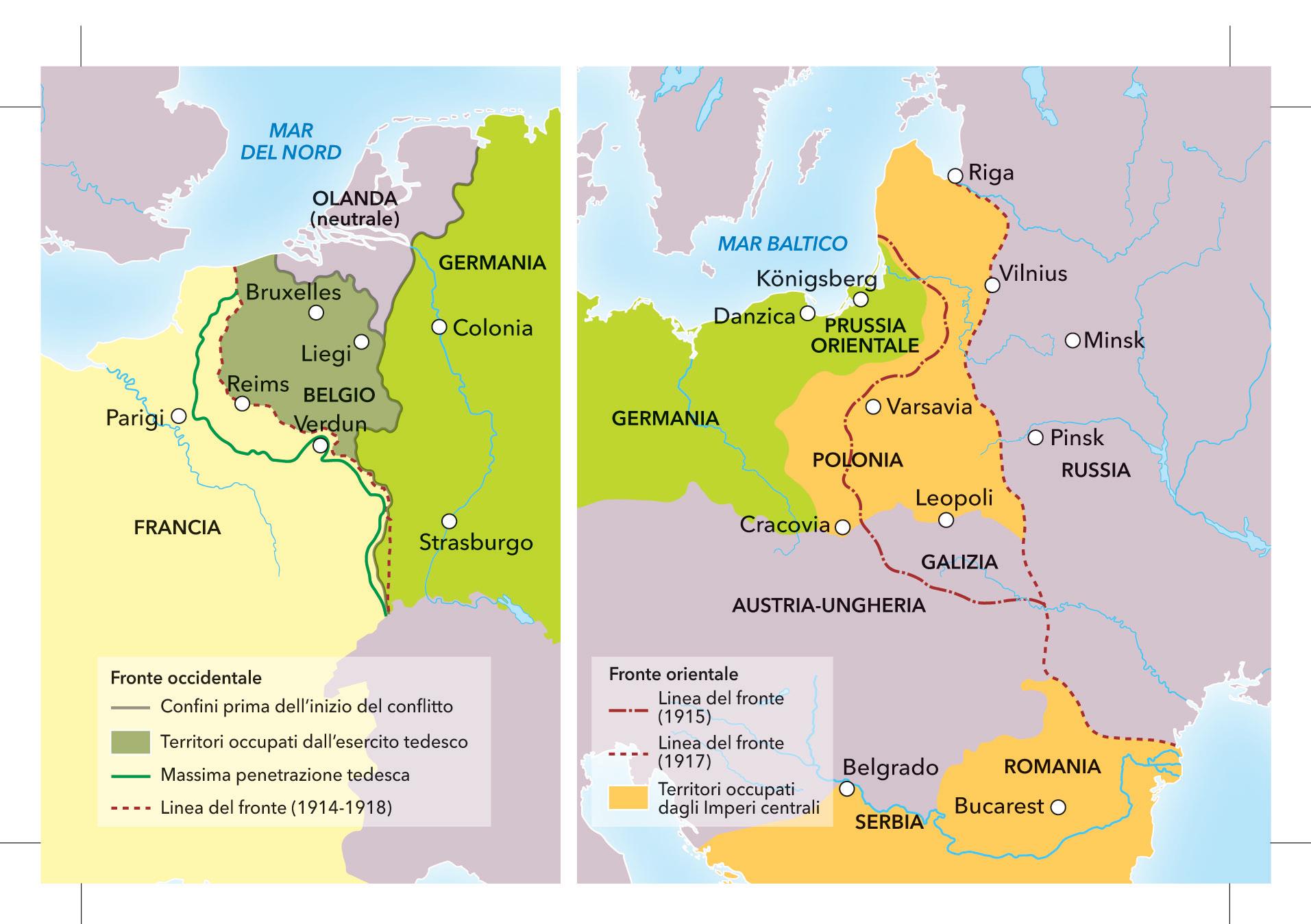
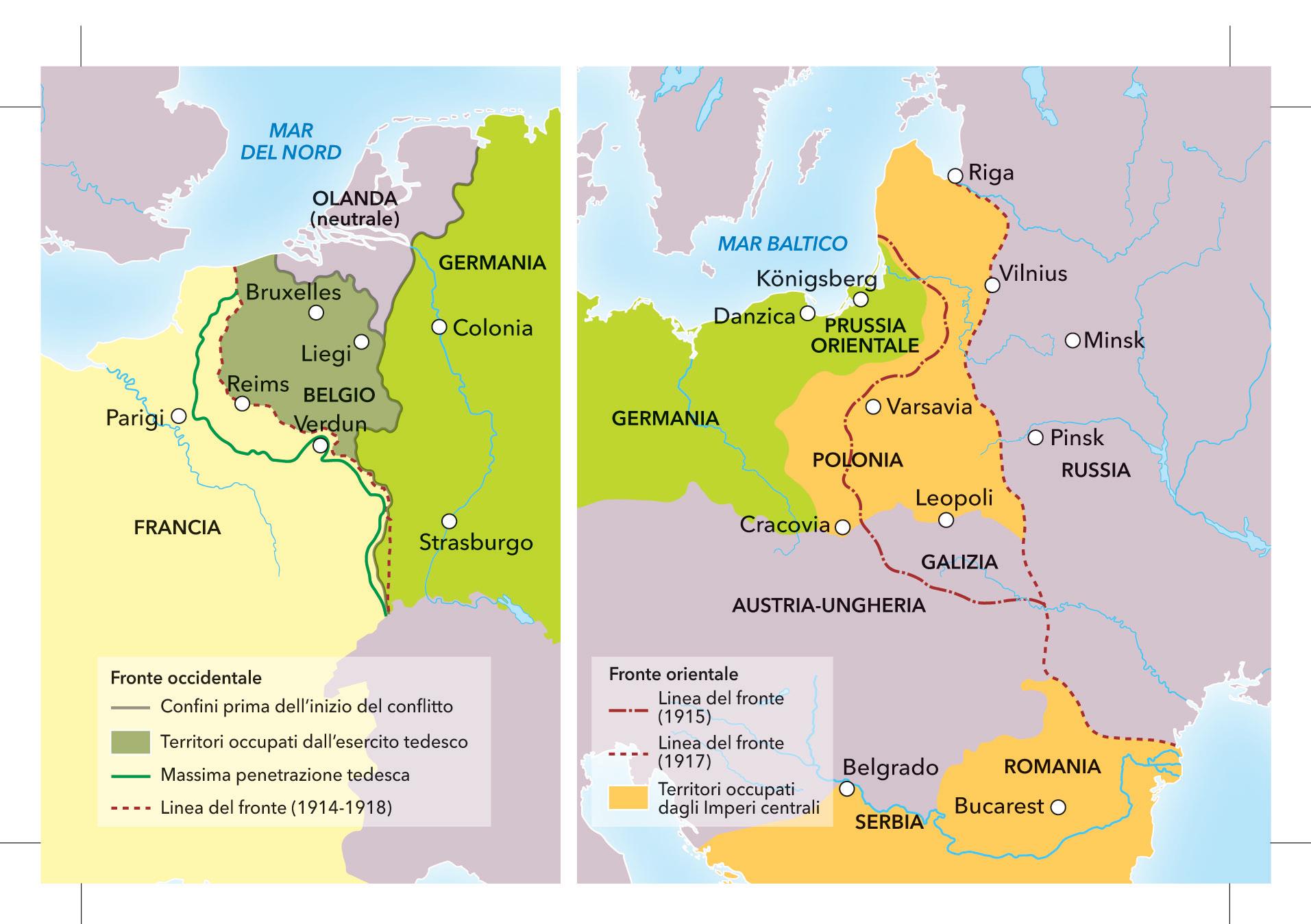
L’Italia dichiara la sua neutralità, ma gli italiani si dividono
La Triplice alleanza che legava l’Italia all’Austria e alla Germania era un patto difensivo che impegnava ciascun Paese ad aiutare un alleato in caso di aggressione esterna. Questa volta, però, era stata l’Austria a dichiarare guerra alla Serbia e, quindi, l’Italia poteva scegliere legittimamente di non partecipare al conflitto. Nell’agosto 1914 il governo italiano, presieduto da Antonio Salandra, proclamò dunque la sua neutralità, suscitando lo sdegno e la rabbia degli austriaci e dei tedeschi, che si sentirono traditi.
Al tempo stesso l’opinione pubblica italiana era profondamente divisa: da un lato c’erano gli interventisti, che volevano partecipare al conflitto, dall’altro i neutralisti, che volevano restarne fuori.
Il fronte interventista ha molti e diversi motivi a favore della guerra
Nel fronte interventista si riconoscevano tante e diverse posizioni:
• i nazionalisti vedevano nella guerra un’occasione per fare dell’Italia una grande potenza, in grado di confrontarsi da pari a pari con le maggiori potenze continentali;
• il re Vittorio Emanuele III (1869-1947) era favorevole alla guerra perché pensava che la neutralità avrebbe screditato il prestigio internazionale dell’Italia;
• gli irredentisti consideravano l’ingresso in guerra contro gli Imperi centrali come l’ultimo atto del Risorgimento perché avrebbe permesso di liberare quei territori, come Trento e Trieste («terre irredente»), che erano ancora sottoposti all’Austria;
• i grandi industriali credevano che la guerra potesse essere un buon affare per loro grazie ai guadagni che avrebbero realizzato con le commesse militari, cioè con i beni venduti allo Stato per sostenere lo sforzo bellico.
I neutralisti e i pacifisti erano la maggioranza della popolazione italiana:
• i socialisti si opponevano alla guerra perché la consideravano uno scontro tra potenze imperialiste estraneo ai bisogni e alle speranze dei lavoratori. Una minoranza socialista, però, si manifestò a favore vedendo nella guerra una strada verso la rivoluzione sociale;
• i cattolici erano contrari per motivi religiosi e morali e anche perché l’Austria era una monarchia cattolica;
• alcuni liberali, tra cui Giolitti, pensavano che l’Italia avrebbe potuto ottenere dall’Austria, in cambio della neutralità, le regioni di Trento e Trieste.

COMPRENDO IL TESTO
Perché gli irredentisti consideravano l’intervento in guerra come il momento conclusivo del Risorgimento?
a Perché esistevano ancora territori italiani soggetti alla sovranità tedesca.
b Perché esistevano ancora territori italiani soggetti alla sovranità austriaca.
c Perché volevano ricontrattare i rapporti tra Stato italiano e Santa Sede. X

Era il movimento politico a cui appartenevano coloro che volevano liberare i territori ancora soggetti all’Impero austro-ungarico, abitati da popolazioni di lingua italiana.
COMPRENDO IL TESTO
Sottolinea i motivi del pacifismo socialista e di quello cattolico
Il socialista Benito Mussolini venne arrestato durante una manifestazione interventista.
LAVORO SULLA LINGUA
Quale funzione grammaticale ha la parola «radioso»? Che cosa significa?
Aggettivo. Significa luminoso, raggiante.
Il 26 aprile del 1915 il governo Salandra firmò, all’insaputa del Parlamento, il patto di Londra, un accordo segreto con l’Intesa in forza del quale l’Italia avrebbe partecipato alla guerra a fianco di Francia, Regno Unito e Russia e in cambio avrebbe ottenuto Trentino, Venezia Giulia, Tirolo meridionale, Istria e parte della Dalmazia. Nei giorni seguenti, poi definiti le «radiose giornate di maggio», le piazze delle maggiori città italiane furono invase dalla rumorosa iniziativa politica dei gruppi nazionalisti, che reclamavano a gran voce l’ingresso in guerra dell’Italia. Nonostante queste manifestazioni esprimessero le posizioni della minoranza del Paese, sembrava che gli italiani non desiderassero altro che partecipare al conflitto. Sollecitato dall’iniziativa nazionalista, il parlamento approvò l’accordo e il 24 maggio 1915 l’Italia entrò in guerra.

La testata del quotidiano «Corriere della Sera» del 24 maggio 1915.
Compravendita illegale di prodotti alimentari o di altro tipo che, in tempo di guerra, non sono più disponibili nei negozi: i prodotti costano di più e chi gestisce questi traffici si arricchisce.
LAVORO SULLA LINGUA
L’espressione «mercato nero» è una metafora: spiega con le tue parole a che cosa allude l’«oscurità» del mercato. Alla clandestinità, all’essere fatto di nascosto perché illegale.
Il nuovo fronte italo-austriaco apertosi nel maggio 1915 era lungo circa 700 chilometri: andava dal golfo di Trieste al Trentino-Alto Adige, passando per il Veneto.
Per l’esercito italiano la guerra si mostrò subito un impegno terribile, difficile da sostenere: in pochi mesi, nelle quattro battaglie sul fiume Isonzo morirono circa 250 000 uomini, senza ottenere alcun risultato.
La guerra scoppiata nel 1914 è stata chiamata «Grande guerra» per le sue dimensioni e le sue conseguenze. Si trattò della prima guerra di massa della storia:
• fu combattuta da eserciti di dimensioni mai viste, composti da milioni di soldati;
• coinvolse direttamente l’intera società civile: individui, famiglie, partiti e sindacati, organizzazioni culturali, giornali e riviste, scuole e università, imprese industriali. La popolazione civile dovette affrontare condizioni di vita molto dure perché divenne via via più difficile trovare i generi alimentari, i prezzi aumentarono e si diffuse il mercato nero.
Tutte le attività economiche si piegarono alle necessità della guerra, cioè alla produzione di armi, munizioni ed equipaggiamenti per i soldati. Sul piano sociale, l’effetto più importante causato dalla guerra fu che le donne sostituirono gli uomini impegnati al fronte e cominciarono a lavorare fuori dall’ambiente domestico.
Per la prima volta nella storia, milioni di donne uscivano dalle case e abbandonavano i campi per trasformarsi in lavoratrici (operaie, impiegate, autiste, infermiere ecc.) che guadagnavano un salario o uno stipendio. Si trattò di un’enorme novità, che cambiò per sempre il ruolo delle donne nelle società occidentali.

Un altro grande cambiamento riguardò il ruolo della stampa e dei media: giornali, manifesti e cerimonie pubbliche furono gli strumenti di una fortissima propaganda a favore della guerra.
I governi le utilizzarono per guadagnare il consenso della popolazione e convincere le persone ad affrontare un terribile sacrificio nell’interesse della patria perché, in caso contrario, non sarebbe stato possibile mandare a combattere milioni di uomini.
Spiega il nesso di causa-effetto tra: necessità di guadagnare il consenso della popolazione nello sforzo bellico B uso politico dei mass media.
I governi dovevano convincere gran parte della popolazione ad affrontare enormi sacrifici perciò utilizzarono i mass media per esaltare la guerra e il valore del sacrificio compiuto per la patria.
LAVORO SULLA FONTE
La campagna propagandistica a favore della guerra
I manifesti documentano la massiccia campagna a sostegno della Grande guerra che fu promossa dai governi delle potenze belligeranti. Quelli a lato riguardano sia il reclutamento sia la vendita di titoli di Stato come fonte per finanziare gli investimenti pubblici per la guerra.
Rispondi alle domande.
1. Osservando attentamente alcuni particolari e identificando la lingua dei messaggi scritti, sai dire a quali Paesi belligeranti appartengono questi tre manifesti? 1. 2. 3.
Stati Uniti. Russia. Italia. Quello statunitense.
2. Quale manifesto, secondo te, chiama al reclutamento?





La Grande guerra fu tale anche perché i progressi tecnologici resero possibile la costruzione di nuove armi dall’immenso potere distruttivo. Le moderne tecniche di produzione industriale, come per esempio la catena di montaggio, ne permisero la realizzazione in grande serie. Fu così che sui vari teatri di guerra (sia terrestri sia marini) comparvero armi non ancora sperimentate come:
i carri armati;
• i sommergibili;
• i gas venefici (cioè mortali).
Per la prima volta nella storia della guerra ebbe un ruolo importante aviazione militare, con compiti sia di ricognizione (cioè di raccolta delle informazioni) sia di bombardamento di obiettivi civili e militari.
Come hai già letto a inizio di questa lezione, la guerra si trasformò nel giro di pochi mesi in una guerra di posizione. I comandi tedeschi avevano messo a punto un piano strategico, chiamato Blitzkrieg, «guerra lampo», che li avrebbe portati a una rapida vittoria, con rapidi spostamenti di truppe e in poche settimane. Il Blitzkrieg, però, fallì: la resistenza francese all’invasione tedesca, infatti, fu ben maggiore di quanto previsto dagli strateghi tedeschi. Il conflitto durò quasi cinque anni e fu combattuto prevalentemente su fronti stabili.

La guerra di posizione attorno alle trincee implicava l’uso inevitabile di bombe a mano, di mortai e di mitragliatrici, che stroncavano facilmente qualsiasi attacco delle fanterie. Ma si utilizzarono anche altre armi ancora più micidiali: i lanciafiamme e i gas asfissianti, proibiti dalle convenzioni internazionali, furono impiegati massicciamente, prima dai tedeschi e poi da tutti i belligeranti. Gli aeroplani, che erano stati inventati all’inizio del secolo, furono perfezionati proprio durante la guerra: usati inizialmente per l’osservazione del nemico, divennero un’arma di attacco e di bombardamento. Un’arma nuova fu il carro armato: il tank fu inventato dai britannici per muoversi su terreni accidentati. Alle sue prime apparizioni terrorizzò i nemici, ma era ancora troppo lento e vulnerabile per costituire un’arma offensiva efficace.
Verso la fine del conflitto fu comunque adottato sia dall’Intesa sia dagli Imperi centrali con accorgimenti tattici (attacco congiunto di un gran numero di carri seguito dalla fanteria) per sfondare le linee nemiche.
Non fu invece mai usato sul fronte italiano perché il territorio era montuoso.
Soldati tedeschi alla mitragliatrice.
La trasformazione della guerra di movimento in guerra di posizione comportò essenzialmente due cose:
• gli eserciti contrapposti si bloccarono sui fronti di guerra;
• sulle aree del fronte furono costruite linee difensive.
Per sfondare le linee trincerate nemiche, gli eserciti usavano una tattica comune, basata su due fasi:
• nella prima fase un massiccio bombardamento d’artiglieria doveva sconvolgere le trincee nemiche e ucciderne i difensori;

• nella seconda fase un attacco in massa della fanteria doveva occupare la trincea nemica.
Questa tattica si rivelò un fallimento: anche se i bombardamenti uccidevano molti soldati dentro le trincee, i superstiti, aiutati dal tiro delle loro artiglierie e dalle mitragliatrici, decimavano con relativa facilità gli attaccanti. Così ogni attacco, dell’uno e dell’altro esercito, si trasformava in una strage, per di più destinata a non spostare gli equilibri bellici. Questo spiega perché la Prima guerra mondiale fu molto più sanguinosa dei conflitti precedenti.
Rielaboro le informazioni
1. Indica se le affermazioni sono vere o false.
a. La Prima guerra mondiale fu la prima guerra di massa.
b. Le attività industriali intensificarono la produzione di armi e munizioni.
c. Il conflitto si sviluppò prima sul fronte occidentale, poi su quello orientale.
d. La guerra di posizione si trasformò ben presto in guerra di movimento.
e. L’Italia entrò in guerra nel maggio 1915 al fianco della Triplice alleanza.
f. I socialisti e i cattolici italiani erano per lo più contrari alla guerra.
Individuo i nessi di causa-effetto
2. Collega le cause nella colonna di sinistra alle conseguenze nella colonna di destra.
1. I governi cercano il consenso dei cittadini…
2. Le industrie utilizzano la catena di montaggio…
3. Gli uomini sono impegnati al fronte…
4. È difficile trovare generi alimentari nei negozi…
a. …le donne cominciano a lavorare in fabbrica.
b. …si diffonde il «mercato nero».
c. …vengono prodotte armi in serie.
d. …massiccia campagna di propaganda.
Perché, secondo te, le nuove strategie militari basate sulle trincee favorivano i difensori sugli attaccanti? Nel rispondere, considera due elementi: l’uso di armi automatiche (fucili, mitragliatori a ripetizione, cannoni) e la natura prevalentemente pianeggiante del fronte occidentale.
La fanteria che attacca la trincea si muove allo scoperto perché il terreno è pianeggiante ed è facile bersaglio delle armi da fuoco.
Soldati italiani in trincea presso l’Isonzo.
DENTRO LA STORIA
La vita in trincea
Che cos’è la trincea?

Durante le campagne del 1915 e del 1916 i contendenti cercarono di risolvere la guerra a loro favore in una sola battaglia decisiva. Ma questi sforzi accaniti, che costarono la vita a decine di migliaia di soldati, fallirono: le tattiche militari a cui erano costretti dalla guerra di posizione, come hai potuto leggere nella precedente lezione, favorivano nettamente chi difendeva rispetto a chi attaccava. Si creò quindi un sistema tale per cui nonostante le numerose e sanguinose offensive, il fronte occidentale rimase sostanzialmente stabile per quattro anni.

Il fronte occidentale era segnato da lunghe trincee. La trincea è il più semplice sistema di fortificazione difensiva: un fossato scavato nel terreno, nel quale i soldati possono ripararsi dal fuoco dei nemici. Nella Prima guerra mondiale, quando la guerra di movimento (cioè basata sull’avanzata rapida) si dimostrò impraticabile, le trincee divennero la sede dei battaglioni e delle divisioni della prima linea.
Sia sul fronte franco-tedesco sia su quello italiano fu rapidamente costruita una fitta rete formata da due o tre linee di fossati (così se gli attaccanti superavano la prima linea, dovevano affrontare altri difensori), collegati tra di loro per mezzo di camminamenti.
La difesa venne poi rafforzata con reticolati di filo spinato, sorretti da pali infilati nel terreno, postazioni di mitragliatrici, parapetti formati da sacchi di tela riempiti di sabbia o terra e, infine, muretti rafforzati da piastre d’acciaio dotati di feritoie per i tiratori scelti, i temuti «cecchini».
Vivere o sopravvivere?
Per i soldati vennero costruiti ricoveri sotterranei, ma le condizioni di vita erano durissime. Essi erano esposti alla pioggia, alla neve e al freddo d’inverno e al caldo d’estate. Con la pioggia e con la neve le trincee si trasformavano in stagni di acqua fetida o di fango gelato; le carenze igieniche favorivano la diffusione di malattie infettive: lavarsi era quasi impossibile e anche i cambi di biancheria erano poco frequenti.
A tutto ciò si aggiungeva la quotidiana e terribile esperienza della morte dei compagni, delle urla dei feriti, dei terrificanti e lunghi bombardamenti, degli assalti che si trasformavano in stragi. Nella Grande guerra, infatti, il valore della vita umana era scarsamente considerato dagli ufficiali e dagli alti comandi degli eserciti: per conquistare poche centinaia di metri, che con ogni probabilità sarebbero andati perduti nella controffensiva avversaria, gli ufficiali non si facevano alcun scrupolo a comandare l’assalto contro le mitragliatrici nemiche, pur sapendo che dei loro uomini, dopo un simile attacco, ne sarebbero sopravvissuti pochissimi.
Di fronte alla stabilità del fronte occidentale, gli Imperi centrali decisero di attaccare il fronte orientale. Nell’estate del 1915 una serie di grandi offensive fece retrocedere di 500 km i russi, i quali perdettero 2 000 000 di uomini. Per sostenere la Russia, i francesi sferrarono una poderosa offensiva, ma le battaglie di Artois e di Champagne terminarono con due cocenti sconfitte e con enormi perdite: 350 000 francesi morirono e 700 000 furono feriti senza riuscire a rompere il fronte.
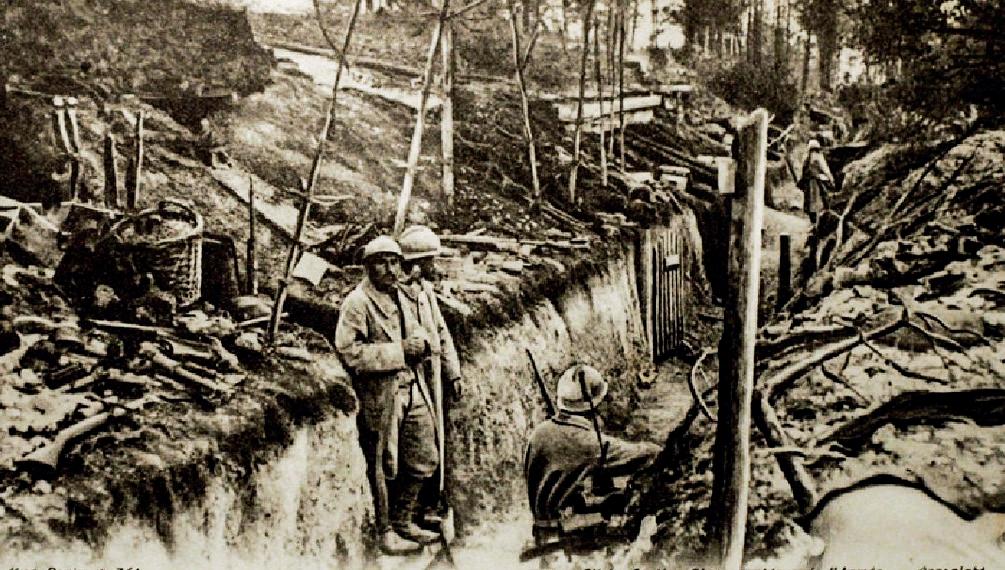
Soldati tedeschi in trincea nella battaglia di Champagne del 25-30 settembre 1915.
Nel 1915 entrarono in guerra l’Italia al fianco della Francia e la Bulgaria al fianco degli Imperi centrali aprendo nuovi scenari. La Bulgaria occupò la Serbia, mentre l’Intesa attaccò l’Impero ottomano, alleato con la Germania e l’Austria, con l’obiettivo di conquistare il controllo dello Stretto dei Dardanelli, ristabilendo così le comunicazioni con la Russia. L’operazione fu tuttavia un insuccesso. L’Italia, convinta ad allearsi con l’Intesa dalle promesse di sostanziose concessioni territoriali, aprì un fronte sulle Alpi orientali Il bilancio delle campagne del 1915 fu chiaramente favorevole agli Imperi centrali, che tuttavia non ottennero una vittoria definitiva. La guerra di logoramento che si andava profilando dava però speranze ai Paesi dell’Intesa poiché avevano maggiori riserve umane e materiali e il dominio sui mari.

Nel 1916 sul fronte orientale la contesa si estese alla Mesopotamia e alla Palestina, dove l’esercito ottomano, sostenuto dalla Germania, si batté contro i britannici. I russi ottennero due vittorie nel Caucaso (Erzurum e Trebisonda).
In quel periodo, tuttavia, il fronte occidentale continuò a essere il principale scenario bellico. I comandi militari impiegarono una nuova strategia: la guerra di logoramento. Ideata dal capo di Stato maggiore tedesco Falkenhayn, questa tattica di guerra si proponeva di portare al totale esaurimento, materiale e fisico, il nemico in modo da obbligarlo a chiedere la pace.
L’espediente fu adottato per la prima volta nella battaglia più famosa della Grande guerra: la battaglia di Verdun.
Iniziata dai tedeschi con l’obiettivo di fiaccare l’esercito francese, durò dieci mesi, uccidendo mezzo milione di uomini, in parti quasi uguali fra attaccanti e difensori. Nonostante le gravissime perdite umane, le trasformazioni del fronte risultarono quasi impercettibili
Nell’ultima frase viene usato un complemento di specificazione per definire il nuovo tipo di guerra che si andava profilando. Quale?
La battaglia di Verdun ebbe inizio il 21 febbraio 1916 e si concluse a dicembre. di logoramento

Perché, secondo te, l’offensiva austriaca contro gli italiani fu battezzata Strafexpedition («spedizione punitiva»)? Di che cosa doveva essere punita, secondo gli austriaci, l’Italia? Di essere entrata in guerra a fianco dell’Intesa nonostante fosse tra i firmatari della Triplice alleanza.
Il generale Cadorna (a destra, di profilo) incontra una brigata sull’Isonzo.
Quasi contemporaneamente l’esercito franco-britannico lanciò la controffensiva nella battaglia della Somme con una strategia simile. Nonostante i franco-britannici contassero su una evidente superiorità negli armamenti, non riuscirono a rompere le linee difensive tedesche. I caduti furono oltre un milione (un numero molto superiore a quelli di Verdun) e non ci furono risultati apprezzabili.
Dal canto loro, i russi lanciarono durante l’estate varie offensive contro l’esercito austro-ungarico, nelle quali ottennero successi parziali, ma a costo dell’esaurimento delle risorse umane e degli armamenti.
Sul fronte italiano gli austriaci organizzarono un attacco (la Strafexpedition, «spedizione punitiva») contro l’ex alleato italiano, che venne arrestato a fatica sull’altopiano di Asiago. Nei mesi seguenti il comandante italiano Cadorna riprese le offensive già messe più volte in atto a partire dal 1915 nei pressi del fiume Isonzo, senza ottenere nulla di significativo.


Nel 1916 le potenze dell’Intesa organizzarono contro la Germania il blocco di rifornimento di materie prime via mare. Questa iniziativa spinse la Germania ad attaccare la flotta britannica, nella battaglia dello Jutland, la sola battaglia navale di tutta la guerra. I tedeschi si ritirarono davanti all’evidente superiorità della flotta nemica e le navi tedesche non tornarono più a uscire dai porti in cui erano protette.
La flotta britannica impegnata nella battaglia dello Jutland (31 maggio – 2 giugno 1916).
La guerra decimò i soldati e compromise le risorse materiali degli Stati. La capacità di sopportare lo sforzo umano ed economico fu però molto diversa da Paese a Paese. I Paesi economicamente più deboli erano l’Impero austro-ungarico e l’Italia. Senza l’aiuto degli alleati, entrambi avrebbero dovuto abbandonare la contesa molto prima della fine. Anche la Russia aveva un’economia fragile e un apparato industriale inadeguato a una guerra moderna e tecnologica, ma le sue immense risorse umane e naturali le consentirono di resistere più a lungo fino a quando le ripetute sconfitte militari, il collasso della sua debole rete di trasporti e il mancato approvvigionamento dell’esercito e delle città diffusero la sensazione di lottare in condizioni di evidente inferiorità.
Anche per i Paesi economicamente più solidi la guerra era uno sforzo enorme:
• la Francia soffriva gli effetti dell’invasione del suo territorio, che aveva causato perdite enormi; poteva contare su un elevato grado di coesione nazionale e, sull’aiuto del Regno Unito, che le garantiva l’accesso al mercato americano;
• il Regno Unito era lo Stato belligerante che vantava la posizione migliore, grazie al suo enorme impero coloniale e all’egemonia assoluta sui mari;
• la Germania aveva dimostrato di possedere una macchina bellica eccezionale. In varie occasioni era stata sul punto di ottenere la vittoria definitiva, ma alla fine del 1916 mostrava segnali di stanchezza ed esaurimento delle proprie risorse umane e materiali, a causa del blocco navale a cui era stata sottoposta, e fu costretta a una mobilitazione generale per continuare a combattere.
COMPRENDO IL TESTO
Fra le grandi nazioni coinvolte nella Prima guerra mondiale, Italia, Austria-Ungheria e Russia erano i Paesi più fragili economicamente. La Russia, però, aveva un vantaggio rispetto agli altri due Paesi, quale?
Immense risorse umane e naturali.
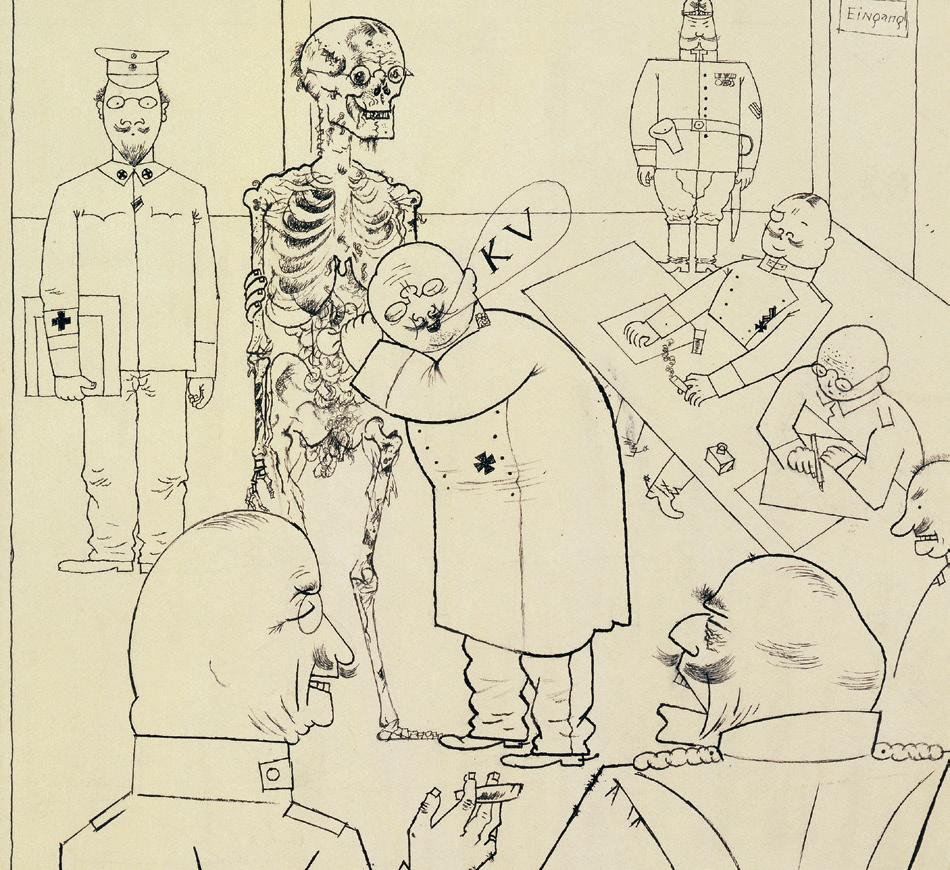
In questa fase del conflitto, l’adesione popolare a favore della guerra andò raffreddandosi. Le ferite e i traumi dei soldati al fronte e i tormenti delle loro famiglie determinarono un cambiamento profondo della mentalità collettiva: l’iniziale entusiasmo per la guerra si trasformò presto in disperazione, rabbia e attesa della pace.
Anche le condizioni di vita della maggior parte delle persone che non combattevano sul fronte, ma sostenevano con il loro lavoro lo sforzo bellico, erano molto difficili. Il potere d’acquisto dei salari e degli stipendi, infatti, si contrasse in modo generalizzato e il razionamento dei principali beni di consumo si estese. Papa Benedetto XV lanciò, invano, un appello ai governi perché ponessero fine a quella che definiva un’«inutile strage».
L’artista George Grosz (18931959) denuncia, in questa vignetta, come il bisogno di nuove reclute costringesse l’esercito tedesco ad accettare chiunque.
LAVORO SULLA LINGUA
Con quale aggettivo papa Benedetto XV definisce la strage della guerra? Inutile.
COMPRENDO IL TESTO
Prima ancora del loro ingresso diretto nel conflitto, gli Stati Uniti erano già stati coinvolti nella guerra. Come?
a Finanziavano l’Intesa.
b Finanziavano gli Imperi centrali.
c Vendevano armi al Regno Unito. X

L’affondamento del Lusitania in una illustrazione della «Domenica del Corriere» di giugno 1915.
Lo stato di guerra spinse gli Stati belligeranti a ridurre drasticamente le libertà pubbliche, specialmente la libertà di stampa, e i parlamenti perdettero parti essenziali delle loro prerogative. In pratica, la maggior parte dei Paesi coinvolti fu sottomessa, di fatto, a un regime di dittatura di guerra. Gli enormi consumi di materie prime e le spese sostenute per far fronte all’impegno bellico obbligarono i governi ad assumere misure economiche eccezionali: lo Stato iniziò a dirigere la vita economica, fissando prezzi, regolando il mercato del lavoro, stabilendo che cosa importare ed esportare. Di fatto, la direzione dell’economia fu assunta dagli Stati.
In quindici giorni, fra il 17 marzo e il 2 aprile 1917, due eventi di segno contrario ruppero l’equilibrio esistente fra i due blocchi che si affrontavano nella contesa:
• la rivoluzione in Russia (vedi Unità 3);
• l’ingresso in guerra degli Stati Uniti a fianco dell’Intesa.
La rivoluzione in Russia avrebbe potuto avvantaggiare l’alleanza austro-tedesca perché l’esercito russo cominciò a indebolirsi a causa delle diserzioni di massa, cessando di essere in pratica una forza combattente e rendendo più concreta la possibilità che la Russia uscisse dalla guerra.
L’ingresso in guerra degli Stati Uniti, invece, poteva far pendere la bilancia definitivamente a favore dell’Intesa.
Nel 1914 gli Stati Uniti avevano scelto di mantenersi ai margini del conflitto europeo. Durante gli anni della guerra, però, erano diventati i principali finanziatori e fornitori di materie prime per i Paesi dell’Intesa. Dal 1915, la Germania aveva combattuto il Regno Unito con i sottomarini, cercando d’interrompere le sue linee di approvvigionamento. All’inizio del 1917 annunciò di voler includere all’offensiva sottomarina l’affondamento delle navi neutrali che commerciavano con il Regno Unito. Questa svolta, rappresentava una evidente minaccia per gli armatori nordamericani che inviavano navi verso il Regno Unito o la Francia, penalizzando di conseguenza l’economia del Paese. A ciò si aggiunse la divulgazione delle notizie sulle manovre occulte della Germania per cercare di provocare una guerra fra Messico e Stati Uniti.
L’opinione pubblica statunitense, già toccata dall’affondamento (avvenuto nel 1915) del Lusitania, un transatlantico britannico che trasportava passeggeri americani verso New York, si era andata sempre più orientando verso la guerra. Il 6 aprile 1917 il Congresso degli Stati Uniti dichiarava guerra alla Germania. Questo evento ruppe l’equilibrio esistente fra i fronti di guerra, sebbene gli Stati Uniti precisassero che sarebbe stato necessario almeno un anno per poter avere una mobilitazione effettiva.
Nella primavera del 1917, il nuovo comandante in capo francese, il generale Nivelle, lanciò nuove offensive, che si risolsero tutte in clamorosi insuccessi. Nelle file dell’esercito scoppiarono rivolte e ribellioni, ma in realtà i soldati di tutti gli eserciti belligeranti, esausti, provavano una profonda ostilità nei confronti dei loro ufficiali e dei governanti. Anche la popolazione civile, come si è già detto, era duramente provata. La sinistra socialista europea manifestò pubblicamente la propria opposizione alla continuazione della guerra. Questa posizione (come vedrai nell’Unità 3) nel 1917 trovò le condizioni per avere maggior seguito in Russia. Lì Lenin e i bolscevichi (cioè la parte più radicale del fronte rivoluzionario) fecero uscire il Paese dal conflitto.
L’uscita della Russia dal conflitto chiuse il fronte orientale. Gli austro-tedeschi poterono così concentrare i loro eserciti sugli altri fronti e sferrare nuovi attacchi, in particolare sul fronte italiano: per l’Italia fu una catastrofe. A Caporetto (oggi località della Slovenia) gli austriaci, rafforzati da reparti tedeschi, sfondarono il fronte. Ai soldati italiani non restò che una ritirata che si trasformò per molti in una fuga precipitosa e disordinata (la famosa «rotta di Caporetto»). Molti soldati si spogliarono della divisa sfidando il rischio di venire fucilati come disertori: ciò era il risultato di una conduzione della guerra autoritaria e crudele che non aveva mai tenuto conto della vita dei soldati.
In quel momento difficile l’Italia riuscì tuttavia a reagire:
• l’esercito oppose una forte resistenza lungo il fiume Piave e sul monte Grappa, anche grazie all’arrivo di giovanissime reclute, i diciottenni nati nel 1899 (vedi Noi e la storia, Ragazze & Ragazzi in questa Unità);
• il generale Cadorna venne sostituito dal generale Armando Diaz;
• si formò un nuovo governo, presieduto da Vittorio Emanuele Orlando, appoggiato anche dall’opposizione.
COMPRENDO IL TESTO
Chi era Lenin?
a Un rivoluzionario francese.
b Uno statista tedesco.
c Il leader dei bolscevichi russi. X
La ritirata dell’esercito italiano dopo la disfatta di Caporetto.


COMPRENDO IL TESTO
Perché l’uscita dalla guerra della Russia rappresentò un evidente vantaggio per gli Imperi centrali?
Perché potevano disporre di più risorse umane sul fronte occidentale.
Armistizio
È la sospensione temporanea delle ostilità tra due parti in guerra.
Firma del trattato di pace di Brest-Litovsk tra Russia e Imperi centrali.

La Russia esce dalla guerra e la Germania si prepara allo scontro finale
Come sarà spiegato più dettagliatamente nell’Unità 3, nell’ottobre 1917 in Russia una rivoluzione portò al potere i bolscevichi. Una delle prime loro decisioni fu la firma di un armistizio il 3 marzo 1918, che in seguito si tramutò nella pace con la Germania firmata a Brest-Litovsk (nell’odierna Bielorussia).
L’uscita della Russia dalla guerra permise all’Alto comando tedesco, diretto dai marescialli Hindenburg e Ludendorff, di allineare sul fronte francese il grosso delle loro truppe. L’intenzione era di scatenare un’offensiva definitiva, prima che gli Stati Uniti potessero svolgere un ruolo determinante. Nel marzo 1918 i tedeschi disponevano, per la prima volta in tutta la guerra, la superiorità numerica su questo fronte decisivo.
A metà luglio 1918, Ludendorff lanciò l’offensiva che avrebbe dovuto permettere alla Germania di occupare Parigi, ma le sue truppe, esauste, fallirono: il contrattacco alleato le obbligò a una ritirata generalizzata, che si aggravò nelle settimane successive a causa di nuovi attacchi franco-britannici, ora rinforzati dalla partecipazione attiva statunitense. Alla fine dell’estate, il sistema delle alleanze della Germania cominciò a disgregarsi;
• il 29 settembre la Bulgaria firmò l’armistizio;
• il 30 ottobre i turchi abbandonarono la guerra;
• il 3 novembre l’Austria-Ungheria fu sconfitta dall’esercito italiano nella battaglia di Vittorio Veneto (il 4 novembre, giorno dell’armistizio, in Italia si celebra ancora la fine della Prima guerra mondiale). La Germania era rimasta sola.
I numeri della strage
I dati in tabella mostrano l’entità delle vittime di guerra nelle principali potenze coinvolte nel primo conflitto mondiale.
Rispondi alle domande.
1. Quale dei Paesi dell’Intesa ebbe il maggior numero di caduti?
2. Quale dei Paesi degli Imperi centrali ebbe il maggior numero di caduti?
3. Quale Paese in assoluto conta il maggior numero di caduti?
Russia. Germania. Germania.
La situazione militare era tanto chiara che il 29 settembre l’Alto comando comunicò all’imperatore Guglielmo II l’impossibilità per l’esercito di continuare a combattere e la necessità di avviare trattative diplomatiche per giungere al più presto a un armistizio.
I moti rivoluzionari organizzati dai comunisti tedeschi, che scoppiarono in tutta la Germania a partire dal 3 novembre, obbligarono l’imperatore ad abdicare il 9 novembre. Lo stesso giorno fu proclamata la repubblica. Due giorni più tardi, venne firmato l’armistizio.
La Grande guerra era finita.
SVILUPPO LE COMPETENZE
Rielaboro le informazioni
1. Completa la mappa concettuale inserendo correttamente i termini elencati.
Russia – Italia – Regno Unito – Stati Uniti – Impero ottomano – Francia
1914: scoppia la Grande guerra

Vignetta satirica sull’esilio dell'imperatore tedesco in Olanda.
Germania, Austria-Ungheria,
Impero ottomano
1917: intervento degli
Stati Uniti
1918: fine della guerra
Guerra di posizione: 1915-1917
Regno Unito
Francia
Serbia, , e Russia
Italia
1915: l’ entra in guerra
1917: la esce dalla guerra
Russia
2. Utilizzando la seguente scaletta, scrivi un breve testo sugli epiloghi della Prima guerra mondiale.
Guerra di logoramento – Rivolte e ribellioni nelle file degli eserciti – Condizioni di vita dei civili – Uscita della Russia dalla guerra – Entrata in guerra degli Stati Uniti
La lunga guerra di logoramento porta i soldati di vari eserciti ad atti di ribellione. Crolla anche il consenso tra la popolazione sfinita per le dure condizioni di vita. Ciò ha risvolti particolarmente pesanti in Russia, che decide di uscire dalla guerra, mentre il contemporaneo ingresso degli Stati Uniti contribuisce a piegare definitivamente la Germania.
Mi oriento nel tempo
3. Completa la linea del tempo inserendo gli eventi elencati.
Ingresso in guerra dell’Italia (A) – Attentato di Sarajevo (B) – Battaglia della Marna (C) – Battaglia della Somme (D) –
Uscita della Russia dalla guerra (E) – Fine della guerra (F) – Ingresso in guerra degli Stati Uniti (G)
COMPRENDO IL TESTO
Quali grandi imperi uscirono distrutti dalla Prima guerra mondiale?
1. 2. 3. 4. Austro-ungarico Ottomano Russo Tedesco

I nuovi equilibri politici determinatisi con la fine della guerra e con la vittoria dell’Intesa furono definiti attraverso trattati di pace (il principale fu il trattato di Versailles del 1919). Questi trattati tracciarono una nuova carta politica del continente europeo e del Medio Oriente. Ben quattro imperi, austro-ungarico, ottomano, russo e tedesco, furono smembrati o ridimensionati. Le principali novità furono:
• la nascita di tre nuovi Stati (Austria, Ungheria, Cecoslovacchia) dalla disgregazione dell’ex Impero austro-ungarico;
• la perdita di controllo della Penisola araba, dei territori della Palestina, del Libano, della Siria e dell’Iraq da parte dell’ex Impero ottomano, che per secoli aveva dominato il Medio Oriente;
• il distacco dall’ex Impero russo di Estonia, Lettonia, Lituania e Finlandia, che divennero Stati indipendenti;

la perdita da parte dell’ex Impero tedesco delle regioni industriali dell’Alsazia e della Lorena a ovest e di alcuni territori a est; il riconoscimento della Polonia come Stato sovrano, con territori sottratti a Russia, Germania e Austria; la nascita del Regno di Iugoslavia dall’unione di Serbia, Slovenia, Croazia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina; l’ottenimento per l’Italia del Trentino, del Sud Tirolo sino al Brennero (che prese il nome di Alto-Adige), di Trieste e dell’Istria.
Dal punto di vista militare e politico il bilancio della Grande guerra fu chiaro: vittoria dell’Intesa e sconfitta degli Imperi centrali. Ma questo non fu l’unico esito della guerra.
La Grande guerra, infatti, cambiò completamente la vita e la mentalità di tutti coloro che la attraversarono. Per milioni di uomini e donne la morte, la fame, le sofferenze erano state realtà quotidiane; nacque così la sensazione angosciosa che nulla sarebbe più tornato come prima. Si radicò in questo modo un senso di smarrimento e di spaventata attesa davanti al futuro. Il primo decennio del XX secolo era stato caratterizzato dalla fiducia nel progresso tecnico, nella libertà e nella democrazia.
Dopo il 1918 dominavano i sentimenti della paura e della rabbia. Sul piano culturale, il pacifismo e l’umanesimo avevano lasciato il posto a ideologie violente e aggressive, figlie del trauma della guerra.


L’assetto politico formatosi dopo il trattato di Versailles era frutto di una serie di incontri e discussioni tra i governanti dei Paesi vittoriosi. Un grande peso ebbe l’intervento del presidente statunitense Woodrow Wilson (1856-1924) con la proposta di un programma in 14 punti per una pace giusta e durevole. Il documento s’ispirava al principio dell’autodeterminazione dei popoli, cioè al diritto di ogni popolo di decidere da solo le proprie istituzioni politiche. Applicando questo principio, molti popoli avrebbero potuto rivendicare il diritto di dar vita a nuovi Stati indipendenti in cui potersi riconoscere. Gli antichi imperi multinazionali, come quello austro-ungarico o quello ottomano, ne sarebbero usciti distrutti.
L’applicazione di tale principio fu però parziale: per esempio, nei nuovi Stati della Polonia, della Cecoslovacchia e dell’Ungheria esistevano comunità di lingua tedesca, mentre in Romania viveva una minoranza ungherese. Anche queste «nuove» minoranze si sentirono oppresse nei nuovi Stati. Nel Regno di Iugoslavia, poi, si trovavano popoli che erano vissuti a lungo all’interno di imperi multietnici e che erano stati in conflitto tra loro.
COMPRENDO IL TESTO
A quale principio s’ispirava il presidente statunitense Wilson nella ricostruzione dell’Europa?
a Omogeneità razziale.
b Omogeneità religiosa.
c Autodeterminazione dei popoli. X

Sovranazionale
Si dice di un’organizzazione che è al di sopra di più Stati indipendenti e sui quali può esercitare un governo.
Con quale aggettivo viene definita la pace imposta alla Germania a Versailles? Per quale motivo?
Punitiva, poiché prevedeva condizioni durissime.
COMPRENDO IL TESTO
A quale categoria di problemi appartiene l’impossibilità per la Germania di onorare i propri debiti di guerra?
a Problemi politici.
La Società delle nazioni ha una vita tormentata fin dall’inizio
Il quattordicesimo punto del programma del presidente statunitense Wilson per una pace giusta aveva previsto anche la nascita di un organismo sovranazionale, la Società delle nazioni, con il compito di risolvere le tensioni tra Stati e favorire la cooperazione in campo economico e sociale. Anche in questo caso non si raggiunsero gli obiettivi posti: non vi aderirono, infatti, né l’URSS (il nuovo Stato nato dopo la Rivoluzione russa) né la Germania e già nel 1920 gli stessi Stati Uniti, che pure l’avevano promossa, decisero di non farne più parte perché temevano che questo organismo potesse limitare la loro autonomia e sovranità. La Società perse così credibilità e potere.
Il trattato di Versailles considerò la Germania la vera responsabile dello scoppio della Grande guerra e quindi stabilì nei suoi confronti una «pace punitiva», con condizioni durissime, che prevedeva:
• la rinuncia a tutte le colonie;
• la restituzione dell’Alsazia e della Lorena alla Francia;
• la cessione della Slesia alla Polonia;
• il pagamento di un’altissima indennità di guerra ai Paesi vincitori (6,5 miliardi di sterline, una cifra enorme, che nessun Stato avrebbe potuto restituire);
• la fortissima riduzione dell’esercito (sei navi da guerra, 100 000 soldati e nessuna aviazione).
Tali condizioni si rivelarono dannose da molti punti di vista:
• economico: la Germania non aveva la possibilità di pagare l’indennità di guerra. Inoltre, non era previsto alcun piano di sviluppo e di ricostruzione dell’economia tedesca;
b Problemi economici.
X
c Problemi psicologici.

• politico: minoranze tedesche si trovarono a vivere, contro la loro volontà, sotto governi di altri Stati;
• psicologico: nel popolo tedesco si affermarono sentimenti di paura, disperazione, rabbia e rivincita.
Neanche i vincitori furono pienamente soddisfatti dei trattati del dopoguerra: i francesi, per esempio, pensavano che la Germania non fosse stata adeguatamente punita per le sue responsabilità e gli italiani rimasero delusi per la mancata annessione della città di Fiume e della Dalmazia (che andarono alla Iugoslavia), contro quanto previsto dal patto di Londra del 1915.
I nazionalisti più esagitati cominciarono a parlare di «vittoria mutilata», cioè di una vittoria non all’altezza del sacrificio e delle aspettative degli italiani.
I trattati di pace, insomma, non solo non risolsero i contrasti esistenti tra gli Stati, ma diedero vita a nuovo quadro politico che conteneva ancora pericolosi «germi» di guerra.
Il pittore Schulz simboleggia le dure condizioni del trattato di Versailles per la Germania: il Paese sconfitto non vedrà più il sole.
Il trattato di pace di Sèvres (1920) stabilì importanti menomazioni territoriali anche per l’Impero ottomano:
• cessione alla Grecia di tutti i territori europei sotto la sua sovranità;
• trasformazione di Iraq, Siria, Transgiordania e Palestina in protettorati britannici o francesi.
Di fronte a queste umilianti misure punitive, i nazionalisti turchi, guidati dal generale Mustafà Kemal (1881-1938), poi chiamato Ataturk («padre dei turchi»), si ribellarono contro il sultano e conquistarono il potere: nel 1923 venne proclamata la repubblica, che metteva fine alla secolare storia dell’Impero ottomano.
Ataturk aspirava a una profonda modernizzazione della Tur chia in senso occidentale.
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo procedette a riforme radicali, che cambiarono d’improvviso aspetti importanti del la vita quotidiana di milioni di suoi connazionali:
• costruì uno Stato laico nel quale il potere religioso era se parato da quello politico;
• abolì la poligamia e l’obbligo di indossare il velo per le donne;
• concesse alle donne il diritto di voto;
• proclamò il turco lingua nazionale;
• sostituì l’alfabeto arabo con quello latino.
La modernizzazione in senso occidentale della Turchia non significò però la sua trasformazione in una democrazia: sot to la guida di Ataturk, la Turchia fu un regime autoritario in cui gli oppositori venivano fatti tacere con metodi violenti.

Durante la Prima guerra mondiale fu compiuto quello che molti storici considerano il primo genocidio del XX secolo. Il governo turco aveva messo in atto la deportazione e lo sterminio sistematico del popolo armeno, che fin dal VII secolo a.C. viveva nella zona fra il Caucaso meridionale e l’Anatolia orientale. Gli armeni erano un popolo di religione cristiana all’interno di uno Stato in prevalenza islamico.
A partire dal 1915, soffiando sul fuoco di un’ostilità che aveva una storia molto più antica, il partito dei Giovani turchi, nel quale aveva militato anche Ataturk, cominciò a perseguitare gli armeni: quasi un milione e mezzo di persone fu costretto alla fuga o sterminato. Per giustificare una tale violenza, gli armeni fu accusato di sostenero i russi, nemici della Turchia. Ancora oggi il governo turco minimizza, o addirittura nega, la responsabilità del genocidio armeno.
COMPRENDO IL TESTO
In che senso l’abolizione della poligamia fu una misura che rompeva con le tradizioni turche?
a Perché da sempre i turchi accettavano la poligamia.
b Perché i turchi, dai tempi della loro conversione all’islam, accettavano la poligamia come un fatto naturale.
c Perché la poligamia era un simbolo della loro identità religiosa pagana.
Poligamia
Matrimonio con più persone dell’altro sesso. La pratica è consentita dalla religione islamica.
Mustafà Kemal, detto Ataturk.
Distruzione, eliminazione pianificata di un popolo per motivi etnici, religiosi o razziali.
Diaspora
È la dispersione di un popolo e delle sue istituzioni nel mondo.
Un gruppo di ebrei europei in partenza per la Palestina.
Alla fine della Grande guerra si posero le premesse di quello che diverrà un nodo irrisolto della politica contemporanea: lo scontro fra ebrei e palestinesi. Da oltre duemilacinquecento anni comunità ebraiche erano sparse ovunque nel mondo. La diaspora che aveva portato gli ebrei lontano dalla loro terra d’origine, in Medio Oriente, era iniziata nell’VIII-VI secolo a.C., e poi dopo il 70 d.C. Nei Paesi in cui si stabilivano però erano spesso soggetti a vere e proprie persecuzioni a causa della loro resistenza a rinunciare alle proprie tradizioni religiose e culturali, e spesso considerati corpi estranei e potenziali minacce all’ordine sociale.

Con quale aggettivo è definito il conflitto tra ebrei e arabopalestinesi? Che cosa significa? Insoluto. Significa che non è risolto.
Alla fine dell’Ottocento era nato un movimento, chiamato sionismo, che si batteva per la richiesta di una terra per il popolo ebraico: tale terra, secondo la maggior parte dei sionisti, doveva essere la Palestina, la terra dei padri dove mille anni prima di Cristo era sorto il regno d’Israele. Già a partire dall’inizio del XX secolo, piccole comunità di ebrei europei cominciarono a stabilirvisi, comprando terre e abitazioni dalle popolazioni arabe che vi risiedevano. Quel territorio faceva parte dei possedimenti persi dall’Impero ottomano nei primi anni della Grande guerra. Su di essa si rivolsero quindi gli interessi della Triplice intesa. Nel 1916 Francia e Regno Unito stipularono un accordo segreto (l’accordo Sykes-Picot, dal nome dei diplomatici che lo firmarono) con cui si definivano le aree di influenza delle due potenze occidentali e della Russia sul Medio Oriente. Furono quindi disegnati a tavolino dei confini che non tenevano conto di etnie, tribù, religioni. La Palestina avrebbe dovuto cadere sotto il controllo internazionale (i Paesi della Triplice intesa) ma nell’immediato dopoguerra, divenne un protettorato del Regno Unito. I britannici si dichiararono favorevoli alla richiesta sionista e il numero di ebrei che si stabilì in quelle terre cominciò a crescere. La convivenza fra gli arabo-palestinesi e gli ebrei fu però subito segnata da gravi tensioni e i britannici non riuscirono a controllare la situazione. Fu l’inizio di un conflitto che purtroppo è rimasto insoluto fino ai nostri giorni.
DENTRO LA STORIA
Sionismo: alle origini
dello Stato di Israele
La parola sionismo (Sion significa in ebraico «collina di Gerusalemme») comparve per la prima volta nel 1890. A usarla fu l’intellettuale ebreo-austriaco Nathan Birnbaum (1864-1937): egli sosteneva la nascita di un partito «sionista» che realizzasse l’aspirazione di tanti ebrei dispersi nel mondo di tornare, dopo secoli di diaspora, in Palestina, l’antica «terra promessa».
La nascita del movimento sionista
Nel 1897, il giornalista ebreo-ungherese Theodor Herzl (1860-1904) convocò il Primo congresso mondiale dell’organizzazione sionista per promuovere la nascita di uno Stato ebraico in Palestina, dove già da alcuni decenni era cominciata una lenta e pacifica immigrazione ebraica
Furono gli ebrei dell’Europa orientale (specialmente russi) a spingere in questa direzione. In Russia, infatti, le comunità ebraiche erano vittime di episodi di brutale violenza (i pogrom, che in russo significa «devastazione»), ed erano anche sottoposte a una propaganda diffamatoria effettuata con documenti falsi (i Protocolli dei savi di Sion) che avrebbero dovuto dimostrare l’esistenza di un piano degli ebrei per dominare il mondo.
Rielaboro le informazioni
1. Indica se le affermazioni sono vere o false.
Palestina, una terra contesa
Al Congresso, la scelta della Palestina fu però oggetto di discussioni. La Palestina era la terra dei padri, l’antica culla dell’ebraismo da cui gli ebrei erano stati scacciati dai Romani dopo le rivolte del 70 e del 135 d.C. Tuttavia alcuni sionisti (una netta minoranza) osservavano che il ritorno in Palestina avrebbe creato tensioni con le popolazioni arabe: gli arabi, che là vivevano da secoli, non avrebbero interpretato il progetto sionista come un’aggressione? Essi dunque, proponevano di creare una loro patria in una regione disabitata, per esempio la Patagonia argentina. Il fascino delle origini, però, finì per prevalere: lo Stato d’Israele sarebbe sorto solo in Palestina.
La nascita dello Stato d’Israele
Dopo la Prima guerra mondiale, la Palestina venne affidata all’amministrazione del Regno Unito, che inizialmente favorì l’insediamento degli ebrei. L’emigrazione ebraica accelerò in seguito alle persecuzioni naziste (1933-1945) e a fine del Secondo conflitto mondiale l’ONU elaborò un piano di spartizione della Palestina che riconosceva agli ebrei il diritto a uno Stato
Rotoli della Torah, i libri che contengono i precetti della religione ebraica.

a. La pace imposta alla Germania fu una pace ragionevole e non punitiva.
b. Il presidente statunitense Wilson affermò il diritto dei popoli all’autodeterminazione.
c. La Società delle nazioni rappresentò uno strumento efficace di mediazione dei conflitti.
d. I nazionalisti italiani pensavano che quella ottenuta fosse per l’Italia una vittoria «mutilata».
e. Ataturk guidò la Turchia verso una modernizzazione autoritaria.
f. La Turchia si rese responsabile del primo genocidio della storia a danno degli armeni.
Uso il linguaggio specifico
2. Collega ciascun termine nella colonna di sinistra alla sua spiegazione nella colonna di destra.
1. Indennità di guerra
2. Sionismo
3. Genocidio
4. Diritto dei popoli all’autodeterminazione
a. Sterminio pianificato ai danni di un popolo.
b. Corrispettivo in denaro riconosciuto come risarcimento per i danni subiti durante un conflitto.
c. Possibilità di un popolo di dare vita a uno Stato autonomo.
d. Movimento politico per la costituzione di uno Stato ebraico.

Nel primo dopoguerra la Germania attraversò una stagione importantissima della sua storia, durata dal 1918 (anno della sconfitta tedesca) al 1933 (quando Hitler diventa cancelliere e sopprime le libertà democratiche). Quindici anni, dunque, passati alla storia come gli anni della Repubblica di Weimar.
IL CROLLO DELL’IMPERO TEDESCO 1
In Germania, l’imperatore Guglielmo II aveva abdicato subito dopo la fine della guerra. Sulle macerie dell’Impero germanico, nato nel 1870 dopo la vittoria sulla Francia di Napoleone III, era stata proclamata la repubblica. Fu quindi istituito un governo provvisorio all’interno del quale prevalsero il Partito socialdemocratico (Spd) e la Lega di Spartaco. Nel gennaio 1919 la Lega di Spartaco (un partito comunista di stampo bolscevico, che aveva assunto il nome del famoso schiavo romano ribelle) promosse un’insurrezione rivoluzionaria finalizzata alla conquista del potere e all’instaurazione di un regime simile a quello russo. Il governo provvisorio represse i moti con estrema durezza, usando anche i corpi paramilitari di estrema destra (Freikorps, «Corpi Franchi»). I capi della lega spartachista, Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, furono uccisi e l’ordine pubblico fu ristabilito nel sangue.
Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, i capi della Lega di Spartaco.
LA NASCITA DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR 2
In seguito alla repressione del colpo di Stato, furono indette le elezioni, in cui prevalse l’Spd. L’Assemblea costituente si riunì nella piccola cittadina di Weimar, e quindi il nuovo Stato tedesco prese il nome di «Repubblica di Weimar». Presidente della Repubblica fu nominato il socialdemocratico Friedrich Ebert (1871-1925). Si trattava di una novità eccezionale: per la prima volta nella storia della Germania un esponente del partito socialdemocratico, cioè del partito più importante e prestigioso dell’intero movimento socialista mondiale, assumeva un incarico tanto importante. La Germania divenne un modello di riferimento per tutte le democrazie parlamentari europee. La Costituzione di Weimar, infatti, era molto avanzata sul piano dei diritti sociali e individuali garantiti ai cittadini tedeschi, a partire dal fatto che finalmente veniva affermato il suffragio universale maschile e femminile. Inoltre, la Costituzione configurava uno Stato democratico fondato sull’assoluta centralità del Parlamento, che era il cuore del sistema politico tedesco e che aveva ampi poteri. Per converso, si riduceva l’importanza dell’esecutivo, cioè del governo. La Repubblica di Weimar si fondò su tre partiti: il Partito socialdemocratico (di orientamento socialista), il Centro cattolico-moderato e il Partito democratico (di orientamento liberale di sinistra).



1 Scarica e installa l’app RAFFAELLO PLAYER dagli store.
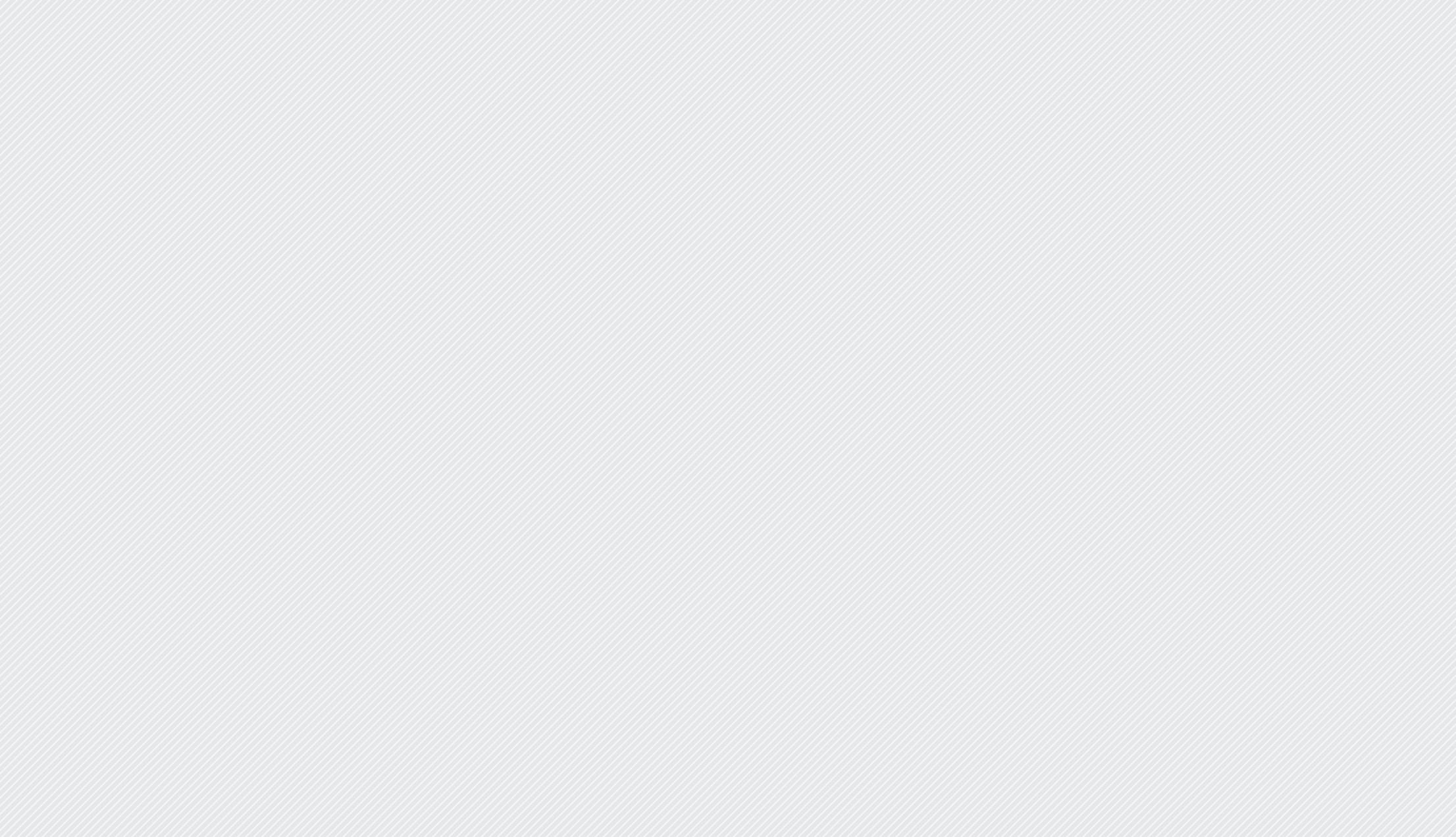
3 Attiva il testo con il CODICE DI SBLOCCO indicato nella pagina “Attiva il testo digitale M.I.O. BOOK”.
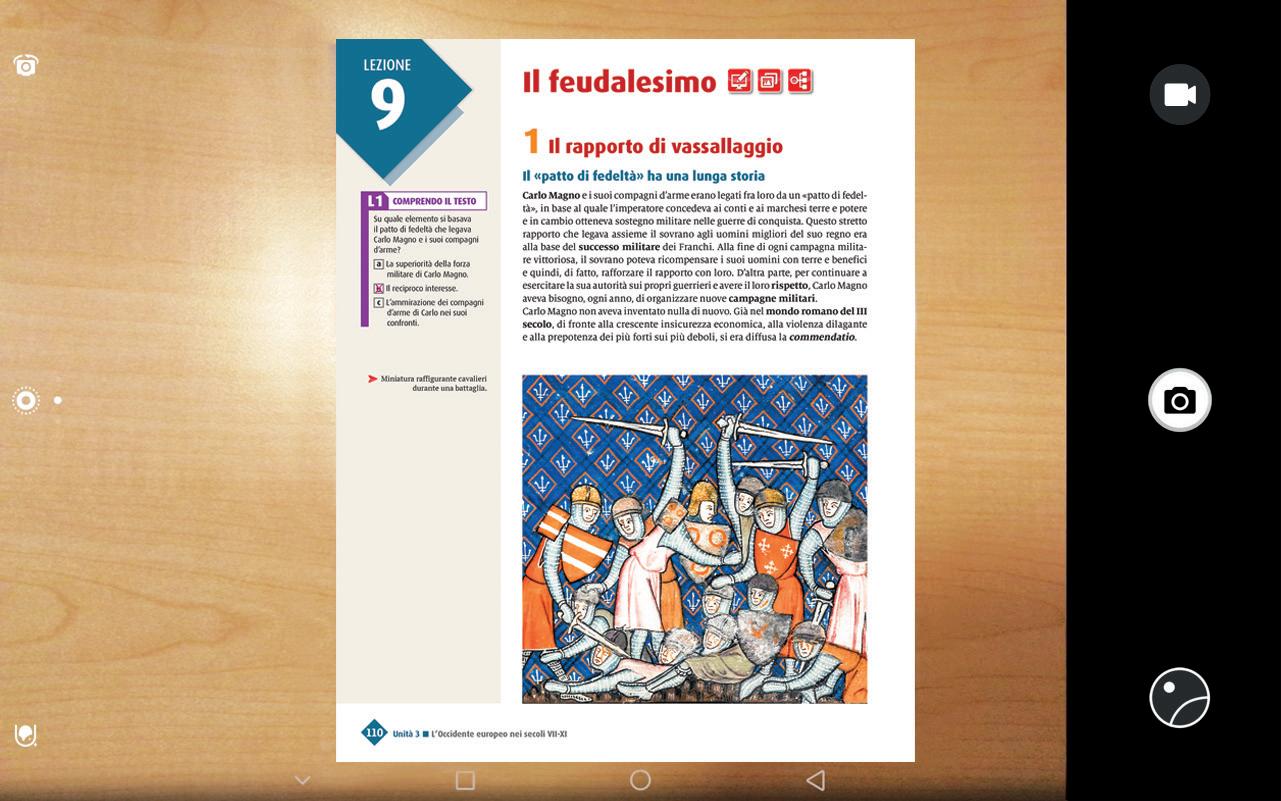
2 Clicca sulla voce Realtà Aumentata.


4 Inquadra la pagina e visualizza i contenuti.





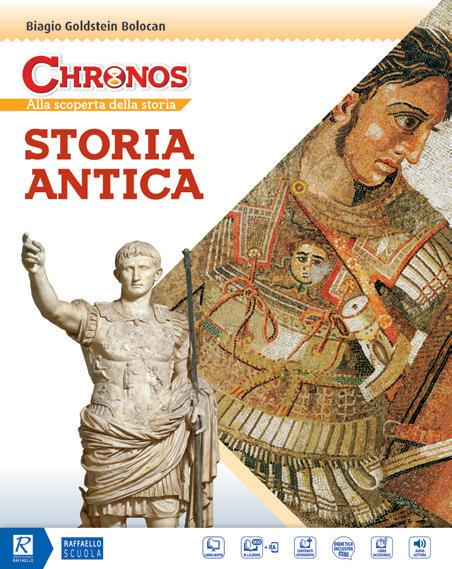



Completano il corso: Quaderni delle competenze 1, 2 e 3
Disponibili su richiesta: Volumi per BES 1, 2 e 3 + CD Audio MP3
Guida per il docente + DVD + CD Audio MP3
Il corso è disponibile anche nella modalità di tipo c (solo digitale) su www.scuolabook.it
• Audiolibro integrale a cura di speaker professionisti
• Alta leggibilità (formato ePub) con testo modificabile
• Servizio di traduzione e dizionario di italiano integrato
Realtà Aumentata: inquadra la pagina con il tuo dispositivo e accedi ai contenuti digitali
Prezzo di vendita al pubblico Volume
€ 20,90


