Alla scoperta della storia 2
L ’ età moderna
Didattica per competenze
Attività linguistiche e grammaticali
Atlante geostorico integrato
Apprendimento cooperativo
Competenze di cittadinanza






Didattica per competenze
Attività linguistiche e grammaticali
Atlante geostorico integrato
Apprendimento cooperativo
Competenze di cittadinanza





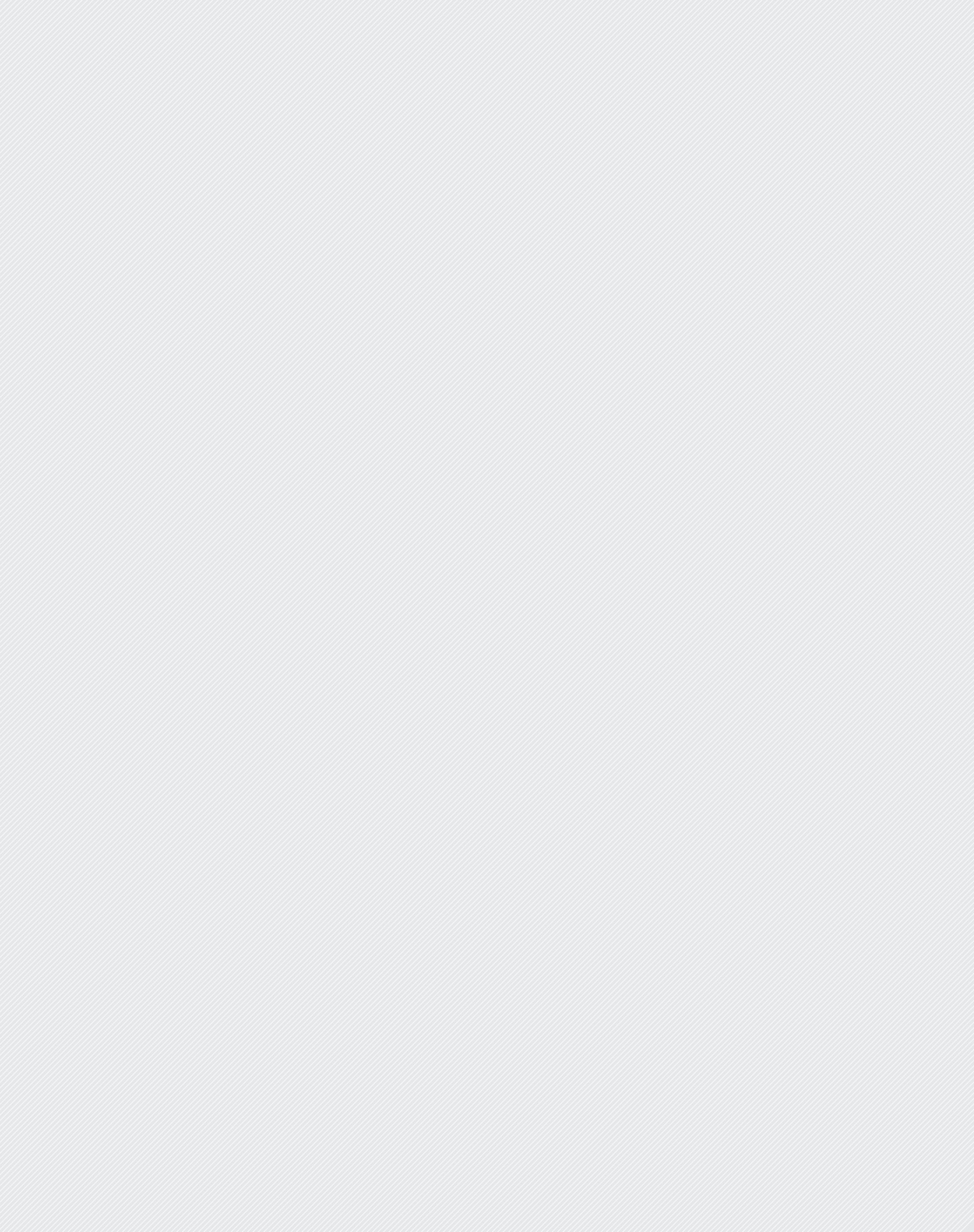
DIRETTAMENTE ON LINE
1 Collegati al portale www.raffaellodigitale.it
2
3
1
Clicca sull'icona Raffaello Player on line
Cerca i testi da attivare
All'interno del portale è presente tanto materiale da scaricare
2
Scarica il Raffaello Player dai seguenti store CON IL TUO DEVICE
Una volta installato il Raffaello Player apri la libreria
Cerca i testi da attivare
3
1
2
Inserisci il DVD che trovi in allegato al testo e clicca sul file “Raffaello Player” CON IL DVD
Una volta installato il Raffaello Player apri la libreria
3
Carica i testi presenti nel DVD, cliccando il tasto
Inquadra la pagina e attiva i contenuti multimediali
Lo puoi utilizzare off line anche senza connessione internet

La registrazione è facoltativa e consente di ricevere gli aggiornamenti del testo.
ATTIVA IL M.I.O. BOOK CON IL CODICE DI SBLOCCO RIPORTATO QUI
Coordinamento editoriale: Emanuele Palazzi
Redazione: Luca Brecciaroli, Ilaria Cofanelli, Gabriella Giaccone, Emanuele Palazzi
Consulenza didattica: Claudia Ferri, Barbara Vilone
Progetto grafico: Alessandra Coppola, Giorgio Lucarini, Simona Albonetti
Illustrazioni: Ivan Stalio, Filippo Pietrobon
Impaginazione: Edistudio
Copertina: Simona Albonetti
Ritocco fotografico: Claudio Campanelli
Cartografia: LS International Cartography
Coordinamento M.I.O. BOOK: Paolo Giuliani
Ufficio multimediale: Enrico Campodonico, Paolo Giuliani, Claudio Marchegiani, Luca Pirani
Le parti ad alta leggibilità di quest’opera sono state realizzate con la font leggimi © Sinnos editrice
Stampa: Gruppo Editoriale Raffaello
Il Gruppo Editoriale Raffaello mette a disposizione i propri libri di testo in formato digitale per gli studenti ipovedenti, non vedenti o con disturbi specifici di apprendimento.
L’attenzione e la cura necessarie per la realizzazione di un libro spesso non sono sufficienti a evitare completamente la presenza di sviste o di piccole imprecisioni. Invitiamo pertanto il lettore a segnalare le eventuali inesattezze riscontrate. Ci saranno utili per le future ristampe.
Tutti i diritti sono riservati.
© 2019
Raffaello Libri S.p.A
Via dell’Industria, 21 60037 Monte San Vito (AN) www.grupporaffaello.it info@grupporaffaello.it
È vietata la riproduzione dell’opera o di parti di essa con qualsiasi mezzo, comprese stampa, fotocopie e memorizzazione elettronica se non espressamente autorizzate dall’Editore.
Nel rispetto delle normative vigenti, le immagini che rappresentano marchi o prodotti commerciali hanno esclusivamente valenza didattica.
L’Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, nonché per eventuali omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti.
Ristampa:
Referenze fotografiche
Archivi Alinari, Firenze - Engler / Ullstein Bild/Archivi Alinari - DeA Picture Library, concesso in licenza ad Alinari - 2001 / TopFoto / Archivi Alinari - Iberfoto / Archivi Alinari - World History Archive/Archivi Alinari - Granger, NYC /Archivi Alinari - Fine Art Images/Archivi Alinari - 2005/HIP / TopFoto / Archivi Alinari - The British Library Board/Archivi Alinari - Hervé Lewandowski / RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Christie's Images / Artothek/Archivi Alinari - © Mary Evans / Archivi Alinari - Imagno/Archivi Alinari - Veneranda Biblioteca Ambrosiana / DeA Picture Library, concesso in licenza ad Alinari - Per Concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Raffaello Bencini/Archivi Alinari - Turi Luca, 1991 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - EPA / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Antonio Monteforte, 1993 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Agence Bulloz / RMN-Rèunion des Musèes Nationaux/ distr. Alinari - Thierry Ollivier / RMNRéunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - CNAC/MNAM / RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Sergey Guneev / Sputnik/ Archivi Alinari - 2002/ UPPA / TopFoto / Archivi Alinari - UIG/Archivi Alinari - Ullstein Bild / Archivi Alinari - Archivio Bruni/Gestione Archivi Alinari, Firenze - Albert Harlingue / Roger-Viollet/ Alinari - Colección Gasca / Iberfoto/Archivi Alinari - Toni Schneiders / Interfoto/ Archivi Alinari - BPK/Archivi Alinari - Ronald Grant Archive / © Mary Evans / Archivi Alinari - ÷NB / Imagno/Archivi Alinari - Austrian Archives / Imagno/Archivi Alinari - Interfoto/Archivi Alinari - Quint Lox / Liszt Collection/Archivi Alinari - Gérard Blot / RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Roger-Viollet/AlinariGiuseppe Giglia, 2008 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Touring Club Italiano/Gestione Archivi Alinari - Archiv Friedrich / Interfoto/Archivi Alinari - Istituto Luce/Gestione Archivi Alinari - Heinrich Hoffmann / BPK/Archivi Alinari - Votava / Imagno/Archivi Alinari - awkz / Interfoto/Archivi Alinari - Paul Mai / Ullstein Bild / Archivi Alinari - RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Luca Zennaro, 1944 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Petit Palais / Roger-Viollet/ Alinari - Raffaello Bencini/Archivi Alinari - Touring Club Italiano/Gestione Archivi Alinari - BHVP / Roger-Viollet/Alinari - BeBa / Iberfoto/Archivi Alinari - Artothek/ Archivi Alinari - Conservatori Riuniti di Siena/Archivi Alinari - Hartramph / Ullstein Bild / Archivi Alinari - Kurt Hamann / Ullstein Bild / Archivi Alinari - © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Archivio Luigi Leoni / Archivi Alinari - EPA PHOTO / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Carlo Ferraro, 1999 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Musée Carnavalet / Roger-Viollet/Alinari - Mary Evans/Scala, Firenze - Scala, Firenze - Scala, Firenze su concessione Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo - Scala, Firenze/bpk, Bildagentur fuer Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin - DeAgostini Picture Library/Scala, Firenze - A. Dagli Orti/Scala, Firenze - White Images/Scala, Firenze - The British Library Board/ Scala, Firenze - Ann Ronan/Heritage Images/Scala, Firenze - Museum of Fine Arts, Boston/Scala, Firenze - Christie's Images, London/Scala, Firenze - Photo Josse/Scala, Firenze - Werner Forman Archive/Scala, Firenze- Mario Bonotto/Foto Scala, Firenze - Scala, Firenze/Luciano Romano - Scala, Firenze/Mauro Ranzani - Veneranda Biblioteca Ambrosiana/DeAgostini Picture, Library/Scala, FirenzeManuel Cohen/Scala, Flirenze - The Metropolitan Museum of Art/Art Resource/ Scala, Firenze - The Morgan Library & Museum/Art Resource, NY/Scala, FirenzeDUfoto/Scala, Firenze - Austrian Archives/Scala, Firenze - Scala Firenze/Heritage Images - The Print Collector/Heritage-Images/Scala, Firenze - Museo Nacional del Prado/Scala, Firenze - Stapleton Historical Collection/Heritage Images/Scala, Firenze - Mimmo Frassineti © 2018. AGF/Scala, Firenze - Cinecittà Luce /Scala, Firenze - Keystone Archives/Heritage Images/Scala, Firenze - National Portrait Gallery, London/ Scala, Firenze - Adagp Images, Paris, / SCALA, Firenze - Scala, Firenze/V&A Images/Victoria and Albert Museum, Londra - Trustees of the Wallace Collection, Londra/ SCALA, Firenze - Smithsonian American Art Museum/Art Resource/Scala, Firenze - 123RF - Istockphoto - Shutterstock - Getty imagesAlamy - archivio fotografico Gruppo Ed. Raffaello









































12
LA STORIA Per saperne di più La rivolta contadina ....................................
conseguenze della Riforma in Europa
VEDERE LA STORIA Per saperne di più La Compagnia di Gesù
L’Europa dell’intolleranza
NOI E LA STORIA Ragazze & Ragazzi

13
VEDERE LA STORIA Per saperne di più
per informarsi, dibattere e divertirsi




















































LEZIONE 23
LEZIONE 24
LEZIONE 25
LEZIONE 26
L’Illuminismo ...........................................................................................................................................
VEDERE LA STORIA Per saperne di più I caffè
Guerre ed equilibrio 224
Le riforme in Europa ..........................................................................................................................
L’Italia tra riforme e conservazione ......................................................................................... 238
ATLANTE STORIA Passato & Presente La geografia della conoscenza 244
NOI E LA STORIA Ragazze & Ragazzi L’educazione di Teresa 246

PAROLE DELLA CITTADINANZA Riforme ................................................................................ 248 DIDATTICA INCLUSIVA Sintesi e Mappa ..............................................................................
FACCIAMO STORIA INSIEME
Pietro Leopoldo e il rinnovamento del pensiero giuridico ........................................ 255













LEZIONE 27
LEZIONE 28
LEZIONE 29
LEZIONE 30
LEZIONE 31
La nascita di una nuova nazione: gli Stati Uniti d’America
La Rivoluzione francese ................................................................................................................... 264
VEDERE LA STORIA Per saperne di più Il Terzo stato 274 La dittatura giacobina
Napoleone e l’impero
Il congresso di Vienna e la Restaurazione ...........................................................................
NOI E LA STORIA Ragazze & Ragazzi
La riforma della scuola in epoca rivoluzionaria
PAROLE DELLA CITTADINANZA Diritti/Privilegi

DIDATTICA INCLUSIVA Sintesi e Mappa ..............................................................................
FACCIAMO STORIA INSIEME «Uguaglianza» vale anche per le donne





























LA STORIA Per saperne di più Giuseppe Garibaldi
NOI E LA STORIA Ragazze & Ragazzi I giovani sulle barricate .............................



























Con la «scoperta» dell’America da parte di Cristoforo Colombo, il 12 ottobre 1492, si fa cominciare la storia moderna. Da quel momento, la storia dell’Europa si intreccia con quella degli altri continenti.
Nei territori americani, ricchi di metalli preziosi e di una grande varietà di nuove piante e animali, si insediano spagnoli e portoghesi che assoggettano e distruggono le antiche civiltà presenti.
In Europa giungono ricchezze straordinarie, mentre lungo le coste dell’Africa comincia la tratta delle popolazioni nere, deportate nelle Americhe come manodopera e ridotte in schiavitù.
Intanto in India, Cina e Giappone si sono costituiti tre grandi imperi. 1480
1494
Trattato di Tordesillas: Spagna e Portogallo si spartiscono le rispettive sfere di influenza nel Nuovo mondo
1487
Bartolomeo Diaz doppia il capo di Buona Speranza e apre la rotta occidentale verso l’Asia
v L’età umanistica e rinascimentale dà all’uomo una rinnovata centralità nell’universo e lo rende padrone del proprio destino.
v I progressi delle conoscenze astronomiche migliorano le tecniche di viaggio.
v Le monarchie nazionali si strutturano e si mostrano sempre più interessate ad ampliare la propria sfera d’influenza.
1492
Cristoforo Colombo sbarca sull’isola di Haiti dopo aver attraversato l’oceano Atlantico
1497
I fratelli Caboto sbarcano in Canada Vasco da Gama raggiunge l’India


1500
Pedro Álvares Cabral sbarca sulle coste del Brasile

Nel 1492 Cristoforo Colombo tentò di raggiungere le Indie dalla Spagna viaggiando verso ovest e sbarcò nell’attuale San Salvador: scoprì a sua insaputa un nuovo continente.
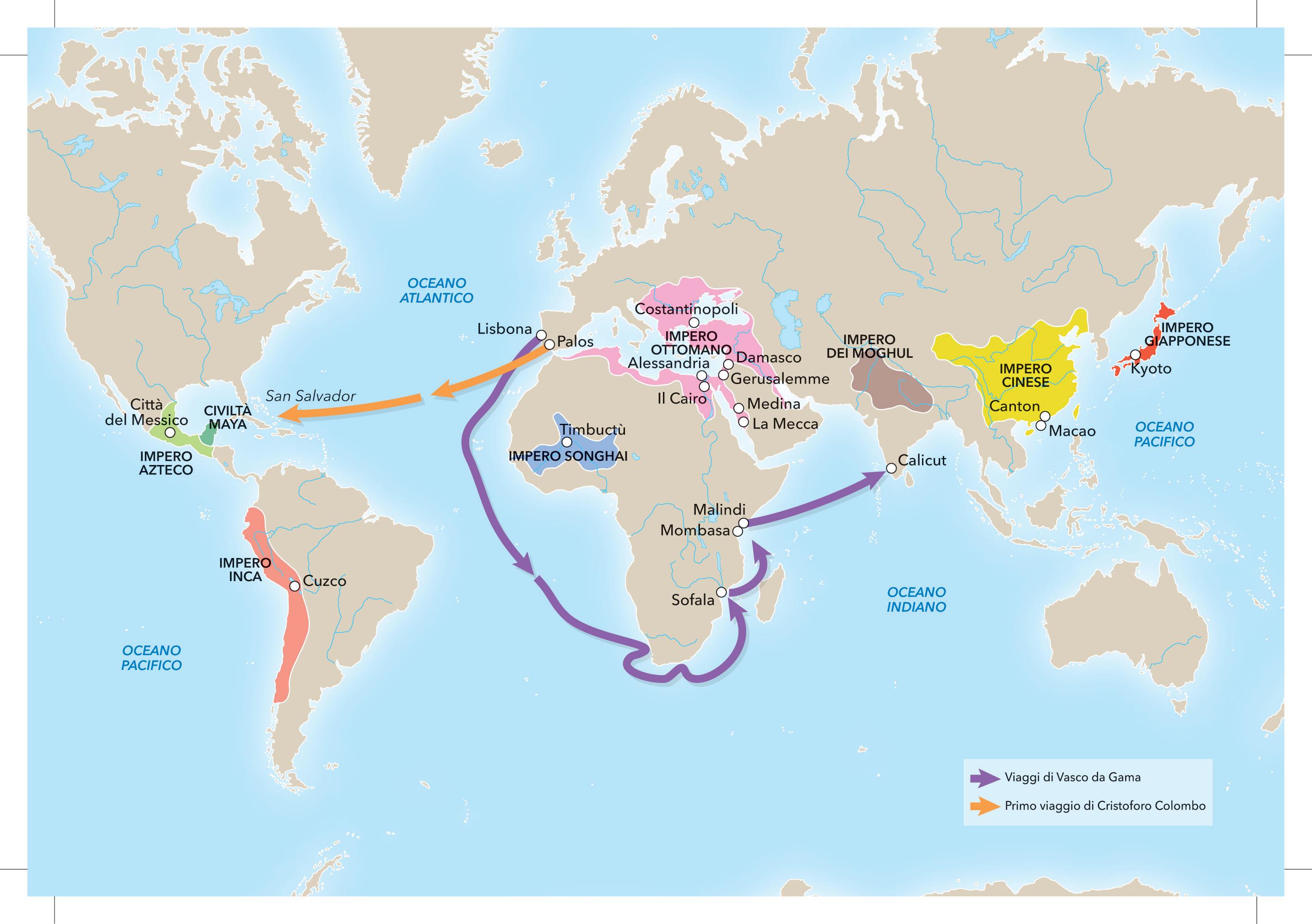
Nell’Est asiatico nel XVI secolo si trovavano i grandi e fiorenti imperi Moghul, cinese e giapponese.
Nel 1498 una spedizione portoghese guidata da Vasco da Gama raggiunse Calicut, in India, doppiando la punta estrema dell’Africa.
Nel nuovo continente si erano sviluppate civiltà culturalmente avanzate: i Maya, gli Aztechi e gli Inca.
1510
1519
Hernán Cortés inizia la conquista dell’Impero azteco
1520
1521
Ferdinando Magellano raggiunge l’oceano Pacifico doppiando il Sud America
Gli spagnoli si impadroniscono del Messico
1530
1529
Francisco Pizarro conquista l’Impero inca

v Fra XIII e XV secolo i navigatori portoghesi e genovesi migliorano le tecniche di navigazione. v L’obiettivo è raggiungere via mare l’Estremo Oriente; per farlo i portoghesi circumnavigano il continente africano.
v La «scoperta» dell’America schiude le porte della penetrazione occidentale nel continente americano. A pagarne il prezzo saranno le civiltà indigene dei Maya, degli Inca e degli Aztechi.
v Nel XV secolo il Medio Oriente e l’Estremo Oriente ospitano grandi civiltà, come quelle islamico-ottomana, indiana, cinese e giapponese.
Riordina correttamente, secondo i nessi di causa-effetto, i seguenti fenomeni inserendo la lettera corrispondente nei quadratini.
a. Drastica riduzione dei traffici commerciali.
b. Espansione ottomana.
c. Le strade per l’Oriente diventano pericolose.
Causa b Effetto 1 c Effetto 2 a

Tra la metà del XV e i primi decenni del XVI secolo, i Turchi ottomani ampliarono in modo significativo i propri possedimenti (vedi Lezione 2) occupando:
• l’Asia minore (l’Anatolia, la regione siriaca);
• la regione ellenica;
• la Penisola balcanica;
• le regioni africane affacciate sul mar Mediterraneo. La loro espansione cambiò gli equilibri politici ed economici del Mediterraneo orientale: le antiche strade che conducevano in Oriente, infatti, divennero pericolose per i mercanti europei e gli scambi commerciali che per molti secoli avevano attraversato quelle regioni poste tra l’Europa e l’Asia si ridussero drasticamente.
Particolare dell’Atlante catalano (1375 ca.), un portolano che riporta i percorsi verso l’Oriente sperimentati da viaggiatori cristiani e islamici. La mappa è illustrata con immagini di viaggiatori: qui vediamo una carovana di mercanti.

La crisi degli scambi commerciali con l’Oriente ebbe due conseguenze per l’Occidente:
• le spezie e gli altri prodotti provenienti dall’Oriente divennero sempre più rari e quindi costosi;
Contraccolpo
Conseguenza negativa derivata da un certo evento o azione.
• le grandi città mercantili affacciate sul Mediterraneo (per esempio Genova e Venezia), che si erano enormemente arricchite grazie ai rapporti commerciali con i mercati asiatici, subirono un grave contraccolpo.
La chiusura delle rotte terrestri e marittime per l’Oriente imponeva la necessità di cercare altre strade

La presenza dell’Impero ottomano rappresentava un ostacolo insormontabile tra Europa e Asia, una specie di muro che impediva ai mercanti di viaggiare e di fare affari. Per risolvere questo problema, alcuni cominciarono a prendere in considerazione la circumnavigazione del continente africano per raggiungere l’Asia passando dall’oceano Atlantico all’oceano Indiano. Era una rotta lunga e rischiosa, ma aveva il vantaggio di evitare il lungo tragitto terrestre della via della seta e il percorso via mare lungo il mar Rosso. Il continente africano era inoltre ricco di oro e altri metalli preziosi, sempre più necessari per acquistare in Oriente spezie, gioielli, tappeti e stoffe pregiate.
Tra la fine del XIII e la fine del XV secolo, nei secoli di passaggio tra la tarda età medievale e la prima età moderna, i navigatori europei avevano sensibilmente migliorato la propria capacità di navigare nelle acque degli oceani, uscendo dal bacino mediterraneo e spingendosi lungo rotte sconosciute e pericolose. L’antica tradizione marinara dei Fenici, dei Greci e dei popoli nordici, che prima dell’era cristiana già si erano spinti oltre le «colonne d’Ercole» e, come ormai sembra accertato nel caso dei navigatori scandinavi, nelle pescose acque del Canada e della Groenlandia, venne rinverdita nel tardo Medioevo dai navigatori genovesi. Alla fine del XIII secolo i genovesi aprirono una rotta mediterraneo-atlantica che, varcando lo stretto di Gibilterra e appoggiandosi allo scalo di Lisbona, stringeva in una fitta rete commerciale la città ligure ai ricchi centri mercantili fiamminghi (Bruges, Gand, Anversa).
I genovesi detenevano, insieme ai veneziani e ai pisani, il monopolio dei traffici con l’Oriente. Nel 1291 avevano addirittura tentato di sfidare l’oceano in cerca di una rotta occidentale verso le Indie, così come nel 1492 fece Cristoforo Colombo: i fratelli Vivaldi morirono nell’impresa, ma il loro coraggioso tentativo già segnala la nuova importanza dell’Atlantico.

LAVORO SULLA LINGUA
Individua nel testo il sostantivo che corrisponde a questa definizione: «navigazione attorno a un elemento geografico (isola o continente) attraverso una rotta perimetrale».
Circumnavigazione.
Con riferimento a un racconto mitologico, in cui l’eroe Ercole separò in due parti (due colonne) il monte che segnava il limite estremo del mondo, questa espressione indica appunto il limite del mondo conosciuto.
La rocca di Gibilterra, nel Sud della Penisola iberica, fronteggia la costa del Marocco. Le due estremità protese sullo stretto nell’antichità furono identificate con le mitologiche «colonne d’Ercole».
Portolani
Libri che contengono descrizioni dettagliate delle caratteristiche delle coste e dei relativi tratti di mare: presenza di porti, tipologia dei fondali, approdi accessibili. Sono usati ancora oggi in navigazione.
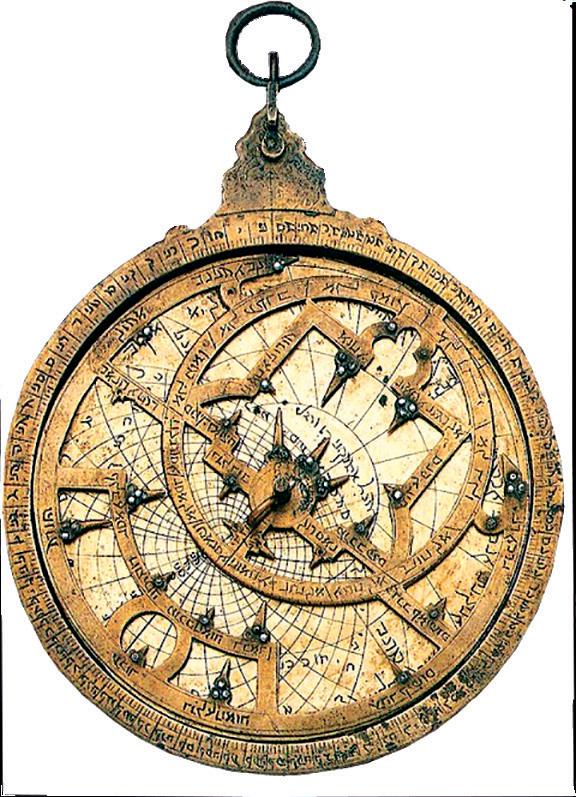
Nel XIV e XV secolo gli strumenti di navigazione compirono grandi progressi. L’uso della bussola e dell’astrolabio si diffuse largamente e ciò da un lato migliorò la capacità di orientamento negli spazi aperti, dall’altro permise di sapere a quale latitudine ci si trovava.
Inoltre, geografi e cartografi perfezionarono i loro studi e riuscirono a realizzare carte geografiche e portolani più precisi.
Dal punto di vista nautico, furono introdotte le caravelle, navi più leggere e manovrabili che permettevano anche a piccoli gruppi di marinai di intraprendere viaggi di esplorazione di eccezionale rilievo e impegno. L’insieme di questi miglioramenti tecnici senza dubbio favorì la ricerca di nuove rotte. Per converso, la necessità di scoprire nuove rotte oceaniche per l’Estremo Oriente rappresentò un forte stimolo all’innovazione tecnologica in campo navale.
L’astrolabio serviva a calcolare la posizione del Sole, della Luna e Caravella.
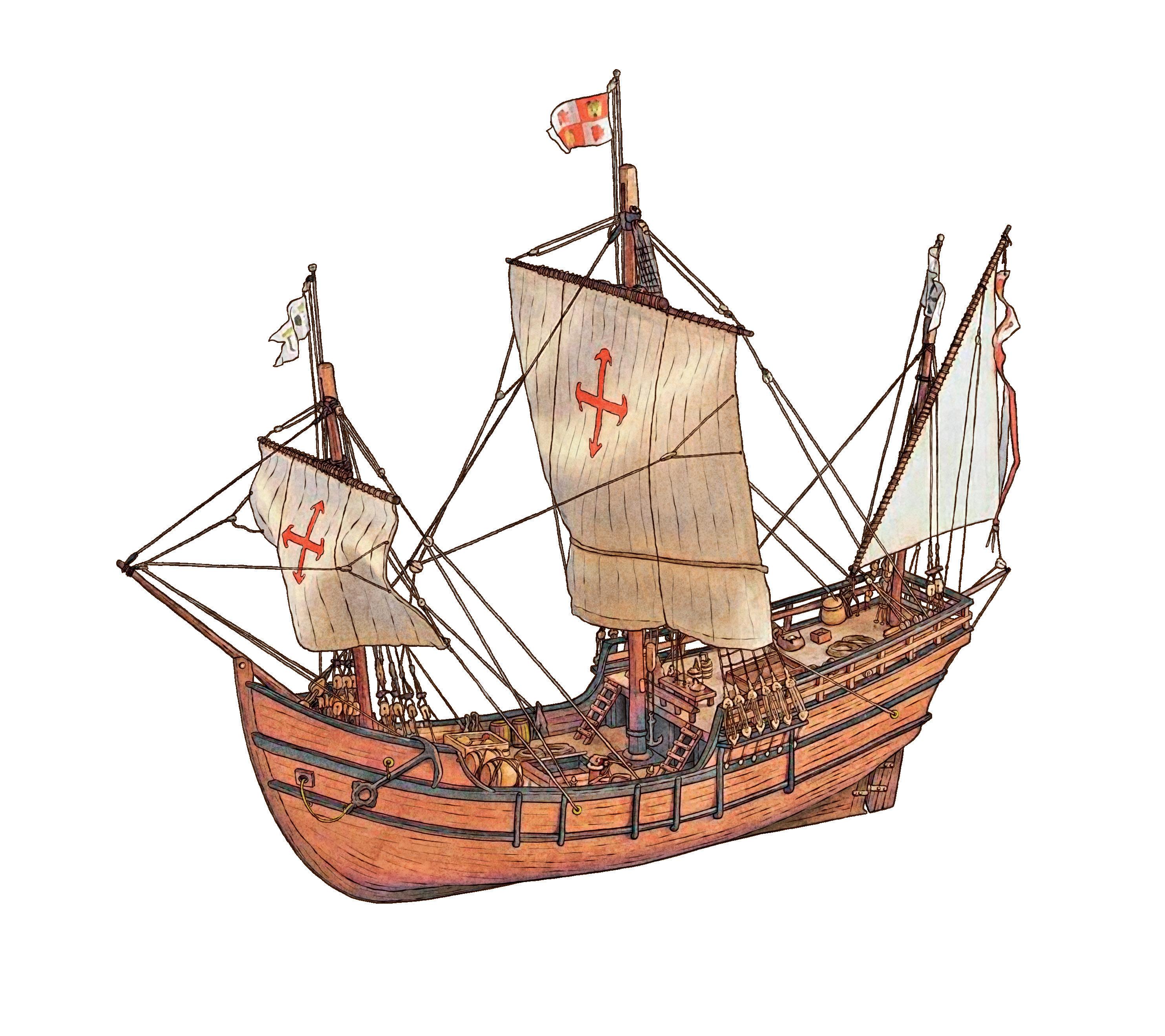
Lo scafo era più leggero rispetto a quello di altre imbarcazioni
Vela triangolare, detta anche «vela latina»
Albero di poppa
di coperta
Cabina del comandante
Al fianco dei genovesi, furono i navigatori portoghesi a giocare un ruolo di primissimo piano nei viaggi di scoperta e nell’apertura di nuove rotte oceaniche. Il regno lusitano (Lusitania era l’antico nome dell’odierno Portogallo) era un Paese di modeste dimensioni e non molto popolato. Ciò nonostante, la capitale Lisbona, grazie alla sua posizione geografica strategica, era un importante scalo commerciale e un porto ideale per le navi europee che navigavano nell’Atlantico. Il Portogallo fu il primo Paese europeo che si propose di raggiungere l’Oriente navigando lungo le coste dell’Africa. La monarchia portoghese diede un sostegno concreto a questi progetti, organizzando e finanziando le imprese oceaniche dei suoi navigatori. Gli obiettivi della corona portoghese erano essenzialmente due:
• consolidare la posizione preminente del regno in ambito commerciale;
• soddisfare le esigenze della classe nobiliare: in Portogallo soltanto i primogeniti ereditavano le proprietà dei genitori e, quindi, molti nobili non disponevano né di terre, né di ricchezze. I commerci e le esplorazioni oltremare erano un modo per ottenerle.
Già nella prima metà del XV secolo, sotto l’impulso del principe Enrico il Navigatore (1394-1460) equipaggi portoghesi avevano raggiunto le coste occidentali dell’Africa, in cerca soprattutto di oro, ma anche di grano. Non si deve però pensare a grandi imprese e a velieri maestosi: il più delle volte si trattava di piccole imbarcazioni e di modesti equipaggi, che spesso finivano inghiottiti dall’oceano e non facevano più ritorno a casa. Dopo anni di tentativi, di fallimenti e di piccole conquiste, finalmente nel 1487 il navigatore portoghese Bartolomeo Diaz (1450-1500) riuscì nell’impresa di doppiare l’estremità Sud del continente africano, chiamata in seguito capo di Buona Speranza (nell’attuale Sudafrica).
COMPRENDO IL TESTO
Distingui con colori diversi gli obiettivi economici e gli obiettivi sociali dell’impegno della corona portoghese nei viaggi di esplorazione.
Il Monumento alle scoperte, sulle rive del fiume Tago a Lisbona, celebra l’epoca delle grandi esplorazioni oceaniche portoghesi tra XV e XVI secolo.

Nel 1497 una spedizione sotto il comando di Vasco da Gama (1469-1524) salpò da Lisbona per raggiungere le Indie. Con questo termine si definiva nel passato tutta l’Asia sud-orientale, un’area che fu poi chiamata «Indie orientali» (con il termine «Indie occidentali» furono invece chiamate le isole Antille e Bahamas, nei Caraibi, scoperte dagli europei alla fine del XV secolo). Le navi di Vasco da Gama doppiarono il capo di Buona Speranza e, dopo aver attraversato l’oceano Indiano, nel 1498 approdarono nel porto di Calicut, in India: i portoghesi erano riusciti per la prima volta ad aprire una via marittima per le Indie.
LAVORO SULLA LINGUA
Polisemico significa «che può assumere diversi significati a seconda del contesto». Individua nel testo un sostantivo polisemico e spiega la tua scelta.
Indie. Può indicare sia l’Asia sud-orientale, sia le isole dei Caraibi.
L’obiettivo strategico dei portoghesi non era conquistare un grande impero coloniale, ma scoprire nuove rotte per i commerci intercontinentali. Durante i loro viaggi, i portoghesi si limitavano a stabilire lungo le coste scali commerciali nei quali raccogliere e smistare le merci. In questo caso, il massimo dell’impegno richiesto era quello della difesa militare di tali avamposti. Almeno inizialmente, pertanto, essi non sottomisero le popolazioni con le quali entrarono in contatto e non occuparono vasti territori, ma solo città costiere in posizioni strategiche per gli scambi, o isole che permettessero loro di controllare i commerci tra Oriente e Occidente. La ragione di questa scelta è piuttosto semplice: il Portogallo non disponeva delle necessarie risorse umane per stabilire un controllo diretto di vaste regioni già popolate da altre civiltà.
LAVORO SULLA CARTA
Le rotte marittime portoghesi
Sulla carta si possono osservare le direttrici delle principali spedizioni portoghesi del XV secolo. Come si può vedere, i portoghesi raggiunsero l’Oriente sia circumnavigando l’Africa, sia passando per il mar Mediterraneo e il mar Rosso.
Rispondi alle domande.
1. Osserva le direttrici dei quattro navigatori portoghesi; chi raggiunse l’Oriente passando per il mar Mediterraneo e il mar Rosso?
Pero da Covilhã.
2. Presta attenzione alle date in legenda; quale navigatore compì i primi viaggi alla scoperta delle coste africane?
Enrico il Navigatore.
3. Chi raggiunse l’estremo Sud dell’Africa e chi circumnavigò il continente africano?
Bartolomeo Diaz giunse fino al capo di Buona Speranza; Vasco da Gama circumnavigò l’Africa.
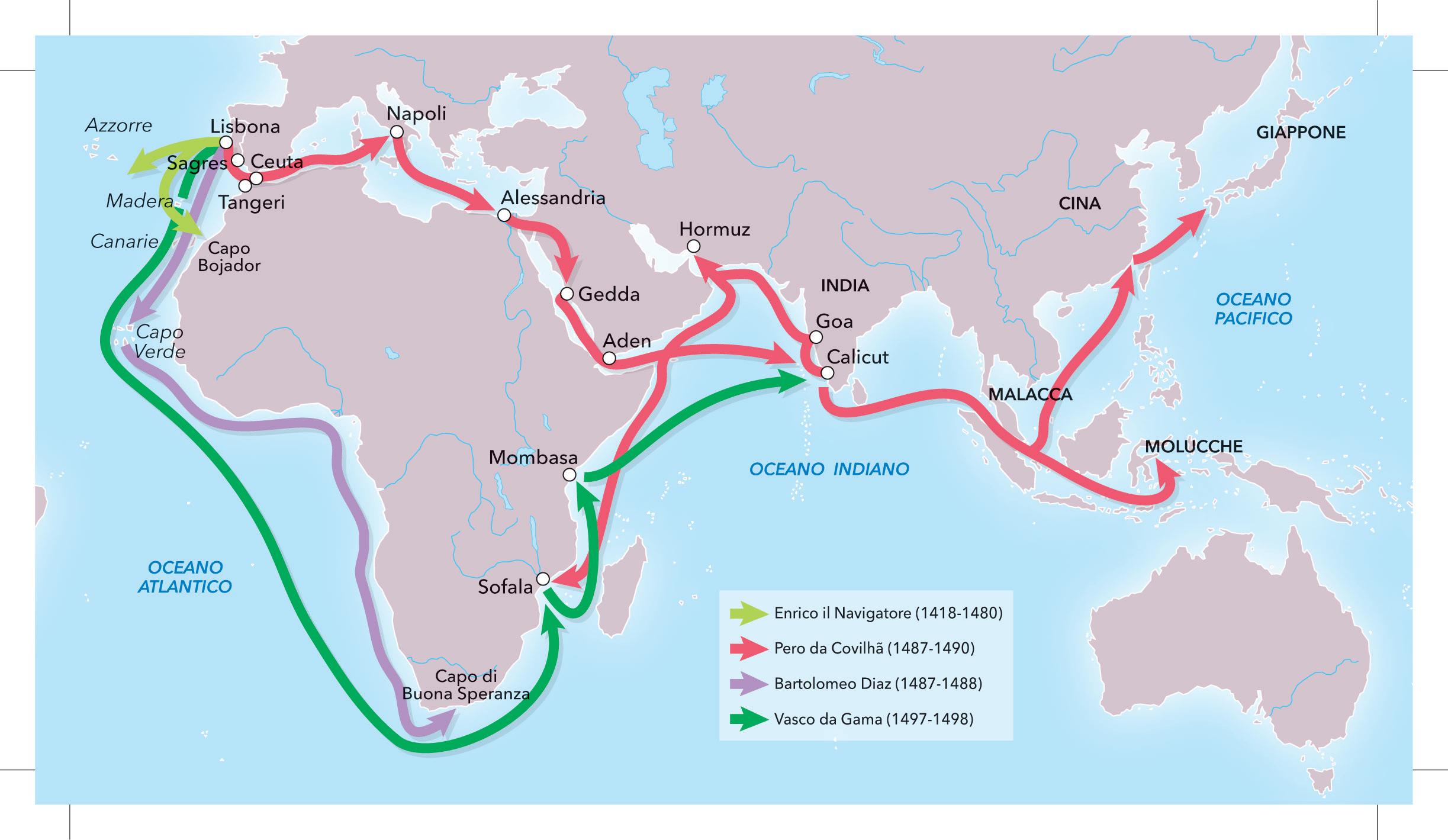
Nella prima metà del XVI secolo i portoghesi:
• stabilirono basi fortificate sulle coste dell’Africa;
• assunsero il controllo dello stretto di Hormuz sul golfo Persico;
• s’insediarono sulla costa occidentale dell’India a Goa, che divenne il centro dell’impero commerciale portoghese;
• occuparono Ceylon (l’attuale Sri Lanka);
• posero basi commerciali nella penisola di Malacca e nell’arcipelago delle Molucche.
A partire dalla metà del XVI secolo strinsero rapporti commerciali anche con il Giappone. Le navi portoghesi partivano da Lisbona cariche di merci di poco pregio che negli scali del golfo di Guinea venivano scambiate con l’oro delle miniere africane; proseguivano poi verso l’Oriente per acquistare, grazie all’oro, le preziose merci orientali. Lungo le coste dell’Africa i portoghesi avevano dato inizio, già a partire dal 1441, al commercio degli schiavi.
Ai motivi economici che muovevano gli europei verso nuove terre si univano motivi religiosi: la Chiesa cercava di contrastare l’avanzata dei Turchi, di religione islamica, convertendo nuove popolazioni alla fede cattolica. Papa Niccolò V, nel 1454, aveva così concesso al re del Portogallo Alfonso V di «invadere, conquistare, espugnare, sconfiggere e soggiogare tutti i Saraceni e pagani e altri nemici di Cristo ovunque vivono […] e le loro persone ridurre in perpetua schiavitù».
Rielaboro le informazioni

1. Completa la mappa concettuale inserendo correttamente i termini elencati. Attenzione: non tutti sono da utilizzare. Africa – Arabia – Vasco da Gama – Magellano – Portogallo – cartografia – rotte – piste carovaniere – Indie – Americhe –caravelle – porti strategici
Necessità di nuove per l’Oriente
Vasco da Gama Portogallo porti strategici Africa rotte cartografia
Perfezionamento degli strumenti nautici e più precisa. Introduzione delle , navi più leggere
Possibilità di raggiungere le circumnavigando l’
Grazie a il è il primo Paese europeo a raggiungere le Indie via mare
Mi oriento nel tempo
2. Completa la linea del tempo inserendo la lettera corrispondente agli eventi elencati.
a. Vasco da Gama raggiunge l’India.
b. Bartolomeo Diaz doppia l’estremità Sud dell’Africa.
1487 1497 c b a caravelle Indie
c. I Turchi ottomani conquistano Costantinopoli.
1453
I portoghesi controllano città e per i commerci tra Oriente e Occidente
L’Anatolia, da cui si espansero gli Ottomani, è una penisola dell’Asia occidentale. Cerca sull’atlante quale Stato odierno la comprende e trascrivilo.
Turchia.
L’assedio dei Turchi ottomani in una miniatura di un manoscritto del XV secolo.
Prima di procedere nel racconto dell’epoca dei grandi viaggi di scoperta e delle esplorazioni europee, cerchiamo di comprendere le caratteristiche delle più importanti civiltà con le quali gli europei entrarono in contatto.
Partiamo dal grande e complesso mondo islamico, costituito da popoli di varia stirpe accomunati dalla fede in Allah. Tra XV e XVI secolo questo mondo era molto vitale. Sulle sponde del Mediterraneo orientale, la tradizione mercantile delle città della Siria e dell’Egitto era stata rinverdita dai Mamelucchi, dinastia di condottieri di origine turca che tenevano vive le relazioni politiche ed economiche con l’Occidente, attraverso l’intermediazione di Venezia. Più a Oriente, in Anatolia, nelle steppe iraniche e attorno alle sponde del mar Caspio, l’islam aveva a lungo subìto le scorrerie dei Turcomanni, dei Mongoli di Gengis Khan e dei Turco-mongoli di Tamerlano

Nella Penisola anatolica nel corso del XIV secolo si erano insediati gli Ottomani, una popolazione turcomanna, che deve il suo nome al capostipite Otman, convertita all’islam e molto potente sul piano militare. Dall’Anatolia avevano cominciato a muoversi verso Occidente, giungendo, come hai già studiato lo scorso anno, a conquistare Costantinopoli (1453) sotto la guida di Maometto II. Posero così fine alla storia millenaria dell’Impero romano d’Oriente e Costantinopoli, l’antica Bisanzio, diventò la capitale dell’Impero ottomano con il nome di Istanbul (si continuò tuttavia a utilizzare anche il nome Costantinopoli fino al XX secolo). Negli anni seguenti assoggettarono la Grecia e i territori intorno al mar Nero. Si espansero quindi nei Balcani, arrivando alle porte di Belgrado.
L’espansione territoriale dell’Impero ottomano continuò inarrestabile soprattutto durante i regni di Selim I (1512-1520) e di Solimano I, detto il Magnifico, che governerà dal 1520 al 1566 (vedi Lezione 9). Con Selim I gli Ottomani sottomisero i Mamelucchi, un’altra tribù di origine turca, e s’impossessarono dei loro territori mediorientali: la Siria, l’Egitto, la Palestina e parte della Penisola arabica. In questo modo, anche le tre città sante per i musulmani, cioè Gerusalemme, Medina e La Mecca, furono inglobate nell’Impero turco.
Sul finire del XV secolo, prima ancora dell’arrivo degli Ottomani, nella società e nell’élite intellettuale iraniane cominciarono a manifestarsi i segni di un nuovo spirito d’identità nazionale. Gli iraniani persiani professavano con orgoglio la propria fede musulmana, nella sua variante sciita, contro ogni invasore. Nel 1500 Ismail, membro della potente famiglia dei Safavidi, dopo essersi fatto incoronare scià («re dei re»), procedette alla riunificazione del Paese. Ottomani-sunniti e iraniani-sciiti rappresentavano i due estremi del variegato mondo islamico. Nei primi decenni del XVI secolo, sunniti e sciiti entrarono spesso in conflitto; più volte i Turchi ottomani, grazie alla loro superiore preparazione militare e tecnologica, furono sul punto di travolgere le armate iraniane, ma la guerra non si risolse mai in favore dei Turchi i quali, dalle rive meridionali del mar Caspio a quelle settentrionali del golfo Persico, per secoli contesero alle stirpi iraniche il controllo della regione.

L’espansione ottomana tra XV e inizio XVI secolo
Gli Ottomani, che nel XIV secolo si erano insediati in Anatolia, nel corso del XV secolo iniziarono a espandersi. La carta mostra l’area interessata dall’espansione fino al regno di Selim I.
Rispondi alle domande.
1. Quale città d’importanza strategica fu conquistata a Nord dell’Anatolia?
2. L’occupazione ottomana all’inizio del XVI secolo aveva raggiunto i confini con l’Ungheria e i confini con un altro grande impero. Quale?
COMPRENDO IL TESTO
Completa indicando il tipo di islamismo professato dai seguenti popoli.
Turchi ottomani → Musulmani
sunniti sciiti Costantinopoli. Il Sacro romano impero.
Persiani o Iraniani → Musulmani
Sunniti e sciiti
Sono gli appartenenti alle due correnti dell’islam. I sunniti seguono le regole di comportamento (la «sunna») del Corano e affidano la guida dell’islam a un califfo ritenuto meritevole; gli sciiti ritenevano che la guida dell’islam spettasse a un consanguineo del profeta e con il tempo si differenziarono anche su questioni dottrinali.
Rappresentazione della battaglia di Merv (nell’attuale Turkmenistan) in cui nel 1501 lo scià Ismail sconfisse gli invasori uzbechi, rafforzando così il suo impero.
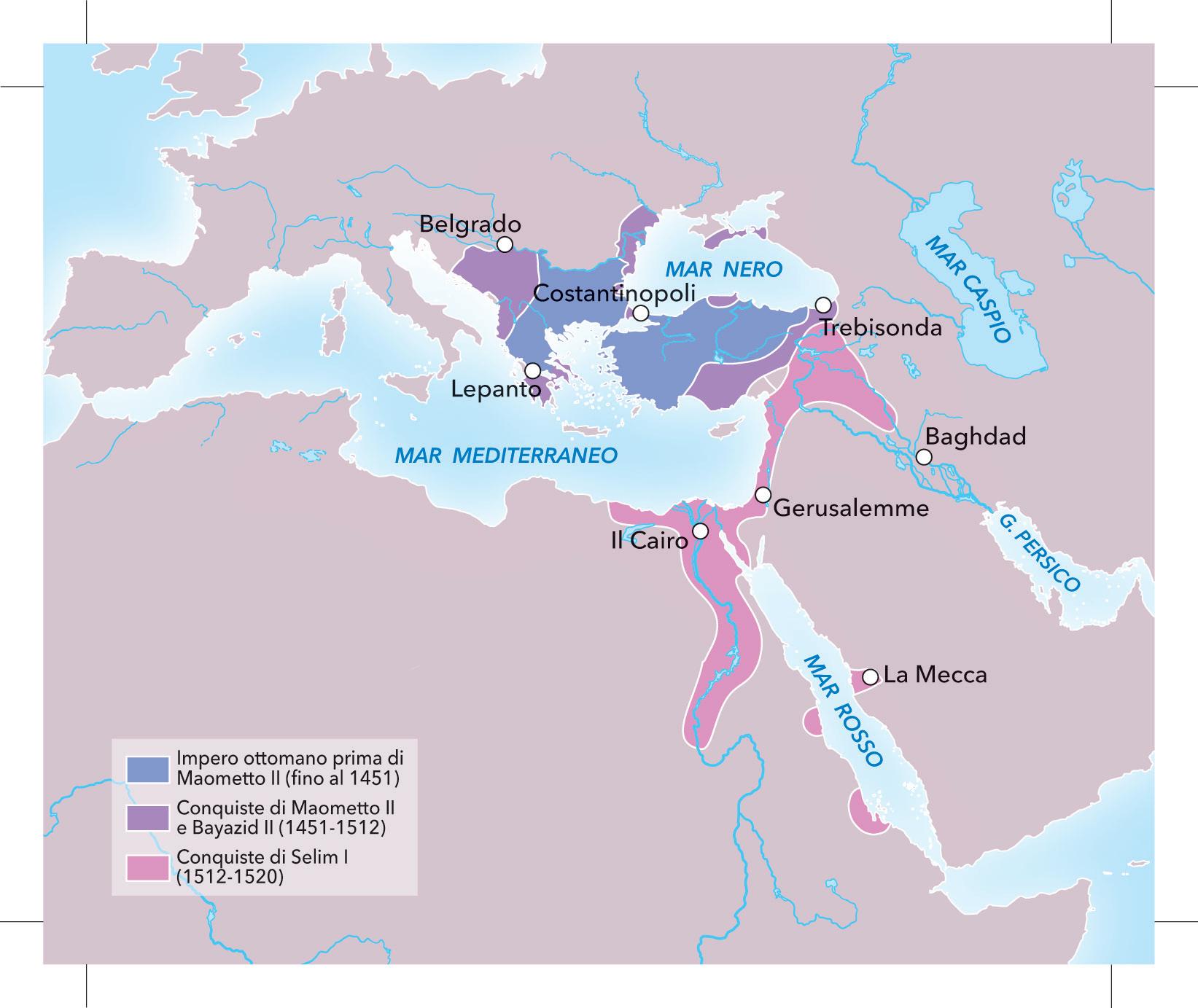
L’IMPERO DEI MOGHUL


L’assalto alla città di Samarcanda (1497), nell’attuale Uzbekistan: una delle tante imprese di Babur il conquistatore.
L’India era un Paese prospero ma diviso
Fin dall’antichità l’immenso mondo indiano era dotato di straordinarie ricchezze, ma era anche fragile e vulnerabile dal punto di vita politico: esso, infatti, ospitava tanti popoli, con culture e religioni diverse, ma non aveva un’organizzazione politica unitaria perché nessuno dei vari potentati indù era mai riuscito a imporsi sugli altri e a controllare l’intero subcontinente.
Nei primi decenni del Cinquecento, Babur il conquistatore (1483-1531), un condottiero d’etnia turco-mongola proveniente dall’Afghanistan, incalzato dai mongoli cominciò a muoversi dalle sue terre d’origine penetrando nell’India settentrionale. Dopo aver sconfitto i potentati locali, egli diede vita, nel 1526, a un impero che sarebbe durato fino all’inizio del XVIII secolo: l’Impero indiano-musulmano dei Moghul.
Dopo la morte di Babur l’impero attraversò un periodo di crisi, che si concluse con la salita al trono di suo nipote Akbar (1556-1605).
Akbar rafforzò lo Stato, assoggettò tutta l’area settentrionale dell’India e mantenne l’unità del Paese. Egli, infatti, integrò i conquistatori turco-mongoli di religione musulmana con le popolazioni indiane e garantì a tutti libertà di culto.
Il suo impero era diviso in province affidate a governatori con poteri civili e militari, e amministrate da tesorieri provinciali dipendenti da un ministro delle Finanze.
Gli abitanti dell’India vivevano in villaggi, dove praticavano agricoltura e allevamento. Il lavoro dei contadini si ripeteva sempre uguale da secoli: la grandissima disponibilità di manodopera, infatti, rendeva inutile e costosa l’introduzione di nuovi e più moderni strumenti.
La natura offriva grandi risorse, ma allo stesso tempo causava grandi calamità naturali, come uragani e inondazioni, alle quali seguivano talvolta lunghi periodi di siccità, che portavano carestie.
I raccolti erano comunque sufficienti a sfamare la popolazione. Ciò permise lo sviluppo di fiorenti città, nelle quali prosperavano attività manifatturiere di grande qualità, come la produzione di tessuti, o la lavorazione di metalli preziosi e legni pregiati. Il loro prestigio giungeva fino all’Europa, e i mercanti occidentali rivaleggiavano con i mercanti arabi per conquistare il controllo dei commerci con il meraviglioso Oriente.
A nord dell’India, oltre le catene montuose del Tibet, si esten deva il grande Impero cinese. La Cina, ancor più dell’Europa, aveva risentito della pressione dei Mongoli che, nel XIII seco lo, avevano raggiunto la loro massima espansione. Qubilay Khan (1214 ca.-1294), erede del grande condottiero Gengis Khan, aveva stabilito a Pechino la capitale di un impero così grande che la Cina ne rappresentava solo una parte. Alla morte di Qubilay, la Cina era caduta nelle mani dei suoi eredi diretti, che avevano dato vita alla dinastia Yuan. Nel 1368 la dinastia Yuan fu travolta dalle rivolte contadine, lasciando il posto a una nuova dinastia nazionale, destinata ad assolvere una fun zione decisiva nella storia della Cina moderna: i Ming. Con l’avvento dei Ming al potere le frontiere imperiali furo no stabilizzate, sia verso la Mongolia sia verso la Manciuria. La stabilità politica e territoriale favorì la modernizzazione della società e dell’economia cinese: alle tradizionali attività agricole si affiancarono nuove attività mercantili e manifatturiere.

La Cina era un grande Paese agricolo. L’agricoltura era praticata in modo intensivo, concentrando le colture vicino ai grandi fiumi (fiume Giallo, fiume Azzurro). Sulle rive di questi grandi fiumi vivevano milioni di persone, che lavoravano nelle risaie inondate, le cui rese erano molto superiori a quelle di un campo seminato a grano. Un ampio e sofisticato sistema idraulico, costruito e controllato dall’autorità imperiale, assicurava un regime delle acque funzionale a questo tipo d’agricoltura.
L’enorme territorio era amministrato da un efficiente corpo di funzionari pubblici, i mandarini, selezionati in concorsi aperti a ogni ceto sociale. L’agire e la formazione ideologica dei mandarini si fondava sugli insegnamenti di Confucio (VI-V sec. a.C.), il filosofo che ha lasciato un’incisiva impronta culturale e religiosa sulla Cina. Il grande Paese possedeva inoltre un elevato livello tecnologico. Grandi invenzioni che hanno segnato l’età moderna dell’Occidente, erano state messe a punto dai cinesi già tra il X e il XII secolo: ricordiamo la polvere da sparo, la stampa a caratteri mobili, la bussola e la carta moneta
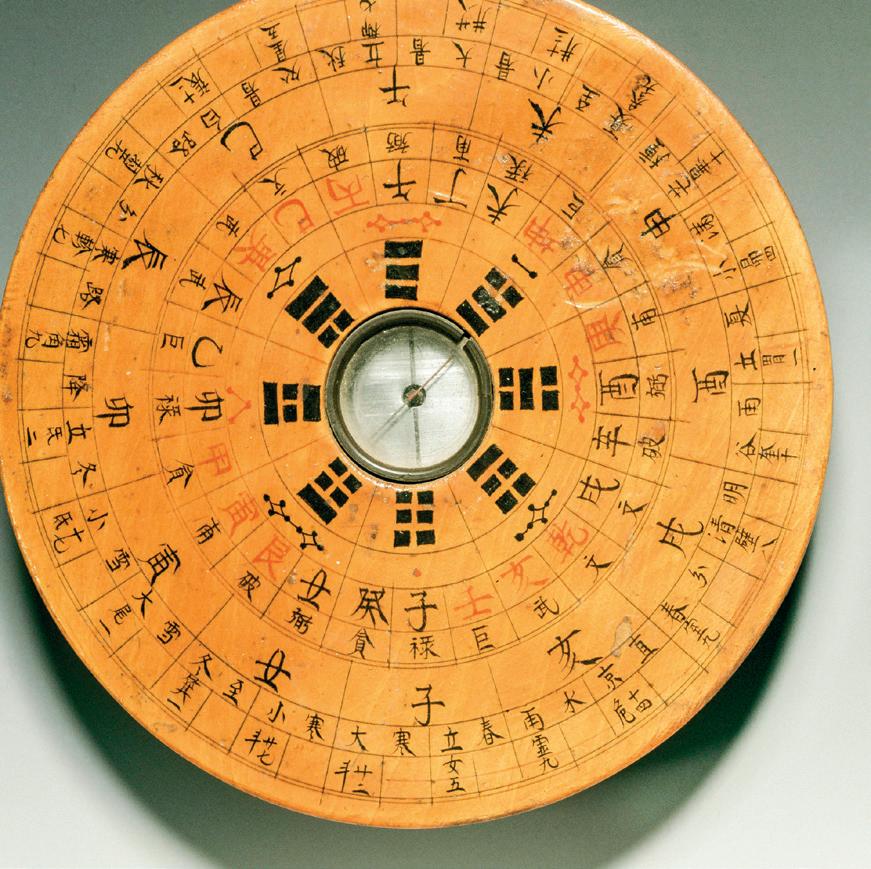
La bussola fu inventata dai cinesi prima dell’anno Mille, ma per parecchio tempo fu utilizzata principalmente a scopi divinatori. Fu invece probabilmente merito degli amalfitani la diffusione dello strumento in Europa e il suo uso in navigazione. LA CINA DEI MING NEL
Quale tempo verbale prevale in questo paragrafo? Perché? . . .
Imperfetto. Si tratta della descrizione di una situazione che durò per molto tempo, non momentanea.
Quale analogia accomuna la storia del Giappone alla storia dell’Europa medievale?
La struttura feudale.

Statua dello shogun Tokugawa Ieyasu, fondatore dell’ultimo shogunato feudale. Il clan governò dal 1603 al 1868.
La storia del Giappone è stata condizionata dalla vicinanza con la grande e potente Cina, da cui il Paese ha importato valori culturali e religiosi (il buddhismo) e modelli politici (l’impero e la burocrazia di corte). Analogie si riscontrano anche, nonostante la lontananza, con la storia europea; in Giappone, infatti, fra X e XIII secolo si affermò una struttura feudale. L’imperatore concedeva benefici a una casta guerriera radicata nel territorio, che aveva come compito la difesa dei contadini. Da questa élite feudale provenivano i samurai, guerrieri professionisti spesso coinvolti in conflitti fra le famiglie dell’aristocrazia militare. I samurai, come i cavalieri feudali occidentali, erano animati da ideali cavallereschi ed erano fedeli a un rigido codice di comportamento, ma a differenza di quelli erano ispirati dai valori religiosi buddhisti, tanto che spesso il confine tra monaco e guerriero si confondeva.
Nel XII secolo il potere dell’imperatore fu messo in discussione dall’ascesa di una nuova figura sociale e politica: lo shogun. Il termine, che in origine indicava il capo dell’esercito, divenne titolo del feudatario che prevalse nella competizione feudale, divenendo di fatto governatore del Paese. La carica (lo «shogunato»), inoltre, fu resa trasmissibile per ereditarietà. Il peso dell’aristocrazia guerriera giapponese continuò a crescere nel XIV e XV secolo, offuscando l’autorità dell’imperatore. Gli shogun vivevano a Kyoto, la capitale imperiale. I governatori delle province erano invece controllati e difesi da funzionari militari, i daymo, da cui dipendevano per vassallaggio, i samurai. I daymo erano le figure più dinamiche della società giapponese e finirono per imporsi sia sulla burocrazia imperiale sia sugli shogun. Ciò portò a una nuova frammentazione politica.
Un’Africa «bianca» e una «nera»
Nel XV secolo gli europei avevano la percezione di due Afriche:
• l’«Africa bianca» (o mediterranea), che era stata sottoposta alla dominazione araba e, quindi, era di religione islamica;
Popolazioni autoctone delle regioni settentrionali dell’Africa, corrispondenti agli attuali Stati del Marocco, dell’Algeria, della Tunisia e della Libia. Berberi
• l’«Africa nera» (o subsahariana), quasi del tutto sconosciuta agli europei e popolata da popolazioni di pelle nera.
Le aree più dinamiche erano quelle affacciate sull’oceano Indiano, compresa tra gli altipiani etiopici e il fiume Zambesi, e quella affacciata sul golfo di Guinea. Attraverso le piste tracciate dai mercanti berberi nel deserto, queste aree erano in contatto con i Paesi del Maghreb (la regione dell’Africa settentrionale situata tra il Mediterraneo e il Sahara) e con l’Egitto.
L’Africa nera ospitava da secoli fiorenti regni e civiltà. Il più importante era il Regno del Ghana, dove i mercanti berberi e arabi scambiavano il sale, un bene molto ambito nell’Africa subsahariana, con oro, avorio, animali esotici e schiavi
Le relazioni tra le popolazioni autoctone e gli arabi non furono sempre pacifiche: questi, infatti, cercarono di imporre la loro influenza e alla fine riuscirono a convertire la popolazione del Ghana all’islamismo.
Intorno al 1240 il Regno del Ghana venne assorbito dal Regno del Mali, che si estendeva tra i fiumi Senegal e Niger. Esso raggiunse il massimo splendore nel Trecento, per poi indebolirsi nel secolo successivo a favore dell’Impero Songhai, dal nome del popolo che gli diede origine. La città principale del regno era Timbuctù, un importante centro commerciale e anche sede di un’università.
Rielaboro le informazioni

COMPRENDO IL TESTO
Individua su una carta geografica dell’Africa il territorio compreso tra i fiumi Senegal e Niger, corrispondente all’antico Regno del Mali. Indica quindi la sua posizione corretta nel continente africano, scegliendo tra le seguenti.
a A nord, affacciato sul mar Mediterraneo.
b All’estremo sud dell’Africa.
c A sud-ovest del Sahara, affacciato sull’oceano Atlantico.
d A sud-est del Sahara, affacciato sull’oceano Indiano. X
La moschea Djinguereber a Timbuctù (Mali) risale all’inizio del XIV secolo: è stata inserita dall’UNESCO nella lista del Patrimonio dell’umanità.
1. Completa la mappa concettuale inserendo correttamente i termini elencati. Attenzione: non tutti sono da utilizzare.
samurai – Ghana – mandarini – sale – Ming – avorio – shogun – spezie – risaie – Moghul – Mali – Egitto – agricoltura –industria – manufatti
India
Impero dei
Moghul
Cina
Ming mandarini
• e allevamento
Agricoltura
• Artigianato raffinato
• Commercio di
Risaie spezie
Impero dei e amministrazione affidata ai e coltivazioni lungo i fiumi
Impero organizzato come una società feudale: continue lotte fra Giappone
samurai
Commercio: oro, , animali esotici e schiavi in cambio di sale Africa nera
Diverse civiltà, fra cui il Regno del , assorbito poi dal Regno del
Individuo i nessi di causa-effetto
2. Indica, in ciascuna delle seguenti coppie di frasi, qual è la causa (C) e quale l’effetto (E).
a. L’India era divisa i tanti Stati. ( ) – L’India era debole politicamente. ( )
b. Efficienza dello Stato cinese. ( ) – Selezione meritocratica dei mandarini. ( )
c. Crescente potere degli shogun. ( ) – Perdita di potere dell’imperatore del Giappone. ( )
d. Penetrazione dei mercanti musulmani. ( ) – Islamizzazione dell’Africa nera. ( )
In che senso Colombo intendeva seguire una direttrice opposta a quella dei mercanti europei dei secoli precedenti?
I mercanti seguivano una direttrice ovest-est, mentre Colombo si proponeva di raggiungere l’Oriente seguendo una rotta occidentale.


Il Portogallo non era il solo Paese europeo impegnato nei viaggi di scoperta: negli anni in cui Bartolomeo Diaz viaggiava lungo le coste africane, altri Paesi europei avevano cominciato a guardare con crescente interesse alle possibilità offerte dall’apertura di nuove rotte atlantiche. Verso la fine del XV secolo, le ambizioni di uno di questi Paesi, il regno di Spagna, si unirono ai progetti di un navigatore italiano, Cristoforo Colombo (1451-1506). Nacque così una straordinaria «scoperta» geografica che ha cambiato la storia dell’umanità. Cristoforo Colombo era un genovese che aveva vissuto a Lisbona. Nella capitale portoghese aveva acquisito una grande competenza nell’arte della navigazione: con navi portoghesi, aveva cominciato a navigare lungo le coste africane. Analizzando le carte nautiche e gli studi compiuti dal matematico e astronomo italiano Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482), si era convinto che, essendo la Terra di forma sferica, attraversando l’Atlantico verso ovest era possibile raggiungere le Indie, seguendo quindi una direttrice opposta a quella dei mercanti europei dei secoli precedenti (da Occidente verso Oriente).
Il saluto dei re di Spagna, Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona, a Colombo, in partenza da Palos, in una tavola illustrata.

Colombo sottopose il suo progetto al re portoghese che però lo respinse, ritenendolo eccessivamente rischioso. A quel punto, il genovese si rivolse alla corte spagnola, che invece decise di finanziare l’impresa. Il 3 agosto 1492 Colombo salpò con tre imbarcazioni dal porto andaluso di Palos, facendo rotta verso le isole Canarie e, da lì, verso il mare aperto. Era una sfida carica di rischi e di incognite: pochissimi avevano osato sfidare la navigazione in mare aperto nel grande oceano, senza una destinazione precisa, e di quei pochi, molti non erano mai più tornati indietro.
Il viaggio durò poco più di due mesi: il 12 ottobre 1492 le caravelle Niña, Pinta e la nave ammiraglia Santa Maria avvistarono terra.
Colombo è convinto di aver aperto la rotta occidentale verso le Indie
Le tre navi approdarono su una piccola isola che Colombo battezzò San Salvador e che oggi, con il nome di Watling, appartiene all’arcipelago delle Bahamas, nel mar dei Caraibi. Il navigatore genovese era convinto di aver raggiunto il Giappone (o qualche isola vicina) e, quindi, di avere aperto la rotta atlantica verso le Indie. Nelle nuove terre, però, non trovò le meravigliose ricchezze che tutti immaginavano, ma piccole comunità d’indigeni che vivevano come primitivi e che inizialmente lo accolsero con grandi onori, come fosse un dio. Convinto di trovarsi in Estremo Oriente, l’esploratore li chiamò indios («indiani»). Quando nel 1493 effettuò una seconda spedizione, le sue certezze cominciarono a vacillare: se non era il Giappone né l’India e neppure la Cina, in quale terra era mai giunto?
Nei viaggi successivi (nel 1498 e nel 1502) non trovò ancora le ricchezze auspicate e gli indigeni mostrarono di non gradire più gli stranieri. I sovrani spagnoli furono alquanto delusi e Colombo cadde in disgrazia: morì nel 1506 in miseria e dimenticato, senza sapere di avere «scoperto» un nuovo continente.
«Nuovo mondo»
Tra la fine del Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento le spedizioni spagnole e portoghesi verso occidente continuarono. Il fiorentino Amerigo Vespucci (1454-1512) guidò diverse spedizioni, prima a servizio della Spagna poi del Portogallo. Seguendo rotte molto più meridionali giunse addirittura oltre il Rio de la Plata, che scorre al confine fra gli attuali Stati dell’Uruguay e dell’Argentina. Vespucci fu il primo navigatore a intuire che era stato scoperto un nuovo continente e fu lui a chiamare «Nuovo mondo» la terra che più tardi, proprio in suo onore, verrà chiamata America.
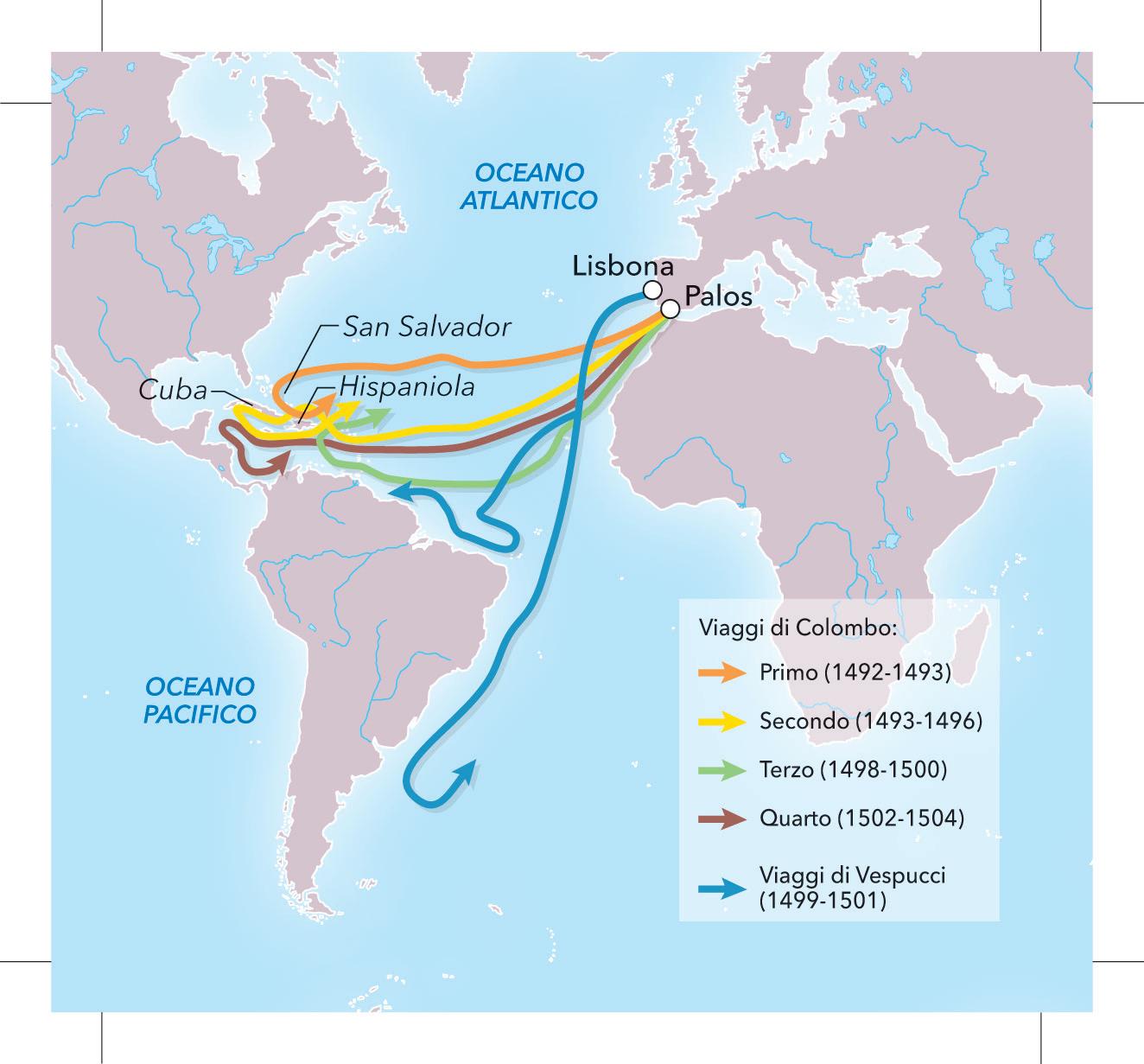
Nel paragrafo è presente una parola derivata dallo spagnolo che indica l’«errore» geografico commesso da Cristoforo Colombo. Di quale parola si tratta? Perché è indicativa dell’«errore»?
La parola è indios. Indica che il navigatore genovese credeva di essere giunto in Estremo Oriente, in India.
DENTRO LA STORIA
Chi era Cristoforo Colombo?
È probabile che, molto prima di Colombo, altri navigatori abbiano raggiunto le coste americane. Tuttavia, a distanza di oltre cinquecento anni, il navigatore genovese rimane lo «scopritore» del Nuovo mondo. Ma chi era Colombo? E com’era giunto a solcare gli oceani?
L’influenza del fratello Bartolomeo
Cristoforo Colombo nacque a Genova, nei pressi di Porta Sant’Andrea, fra l’agosto e l’ottobre del 1451 da Domenico Colombo e Susanna Fontanarossa. Fu il primo di cinque figli: a lui seguirono altri tre maschi e una femmina.
Il primo a battere la via del mare e, in qualche modo, a preparare il terreno alle avventure di Cristoforo, fu il fratello Bartolomeo, che si stabilì a Lisbona, in Portogallo, entrando in contatto con i migliori cartografi di quel regno di eccezionali navigatori e maturando una vasta competenza in materia. Cristoforo lo seguì nel 1479 dopo aver trascorso sei anni a navigare, in qualità di agente commerciale, nel Mediterraneo, lungo la costa atlantica e nel mare del Nord.
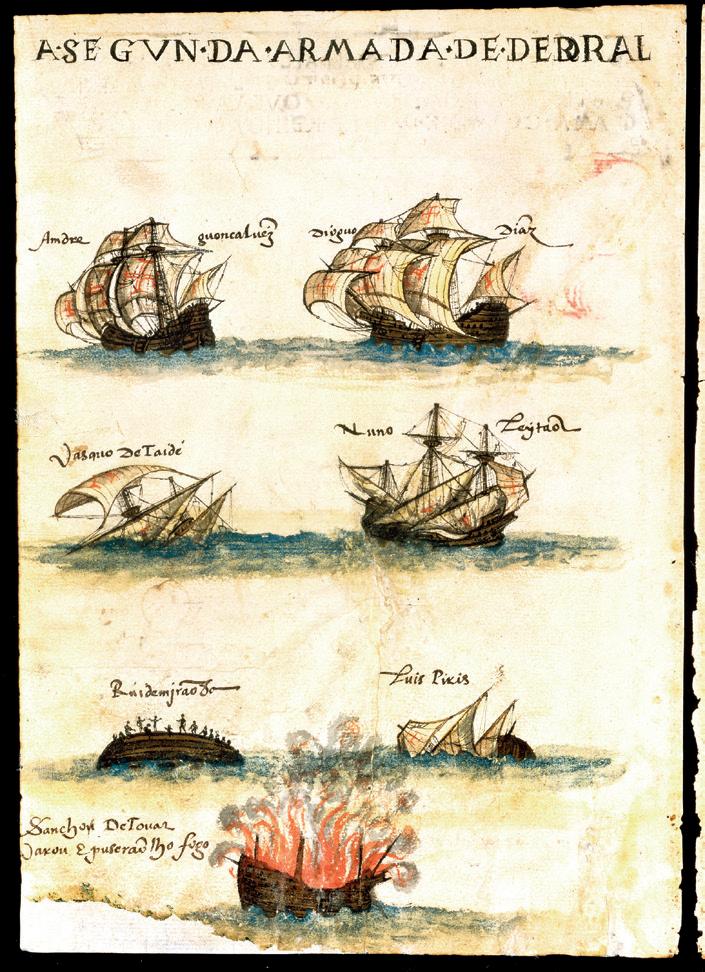
Monumento a Cristoforo Colombo a Santa Margherita Ligure.
L’esperienza portoghese
La nuova vita in Portogallo segnò per sempre il destino di Cristoforo. Qui non solo incontrò la sua futura sposa, Filipa Moniz, ma ebbe l’occasione di affinare la sua cultura marinara e di concepire la sua impresa. Il padre di sua moglie Filipa era Bartolomeo Perestrello, un genovese trasferitosi alla corte dei re portoghesi e divenuto governatore delle isole Azzorre; era un uomo notevole, colto e curioso, raffinato cartografo ed esperto marinaio. Alla morte del suocero, Cristoforo ne ereditò tutte le carte e i libri e, forte delle tante discussioni, dei racconti dei marinai e dei reperti naturali (canne, legni ecc.) rinvenuti al largo delle Azzorre, cominciò a maturare la convinzione che spingendosi in mare aperto al di là di quelle isole avrebbe potuto aprire la rotta occidentale verso l’Estremo Oriente. Dovette spostarsi dal Portogallo alla Spagna per ottenere i finanziamenti necessari, ma la sua impresa cambiò per sempre la storia del mondo moderno.

I viaggi di Colombo e di Vespucci convinsero altri Stati a finanziare nuove spedizioni verso il Nuovo mondo: tra il 1497 e 1498 gli italiani Giovanni (14451498) e Sebastiano Caboto (1477-1557), padre e figlio, effettuarono spedizioni verso ovest per conto della corona inglese.
Nel 1497 approdarono nell’attuale isola di Capo Breton, in Canada, avvistando anche l’isola di Terranova. L’anno successivo esplorarono altre zone del Canada alla ricerca del passaggio a Nord-Ovest verso il Giappone.
Nel 1500 il portoghese Pedro Álvares Cabral (1467-1520) era giunto per caso sulla costa nord-orientale di quello che oggi è il Brasile; restava da scoprire, navigando verso sud, dove terminava la costa e, quindi, dove si apriva una via per l’Oriente navigando verso occidente. In questa impresa si cimentò un grande navigatore portoghese al servizio della corona spagnola: Ferdinando Magellano (1480-1521).
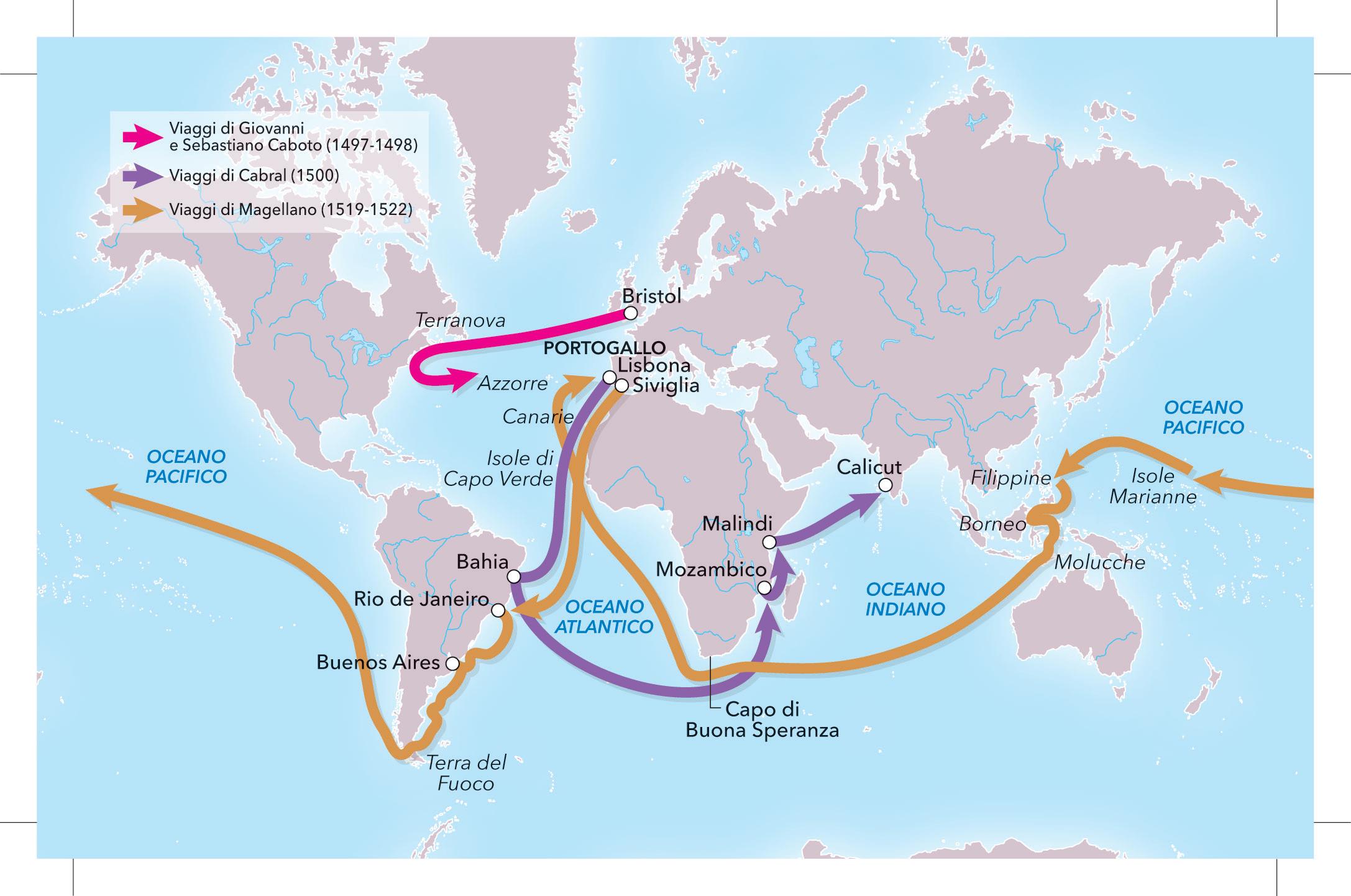
Nel 1519 Magellano salpò da Siviglia, in Spagna, al comando di cinque imbarcazioni. Navigò fino alla Terra del Fuoco, in Argentina, nell’estremità meridionale del continente americano. Dopo aver oltrepassato lo stretto che da lui ha preso il nome, lo stretto di Magellano, sfidò il «nuovo» oceano, che battezzò Pacifico a causa delle favorevoli condizioni ambientali che incontrò durante il viaggio. Nel settembre 1521 arrivò alle isole Molucche seguendo una rotta est-ovest. Il viaggio fu durissimo: molti marinai morirono per la fame e le malattie. Giunta nelle attuali Filippine, la flotta trovò oro in abbondanza, ma Magellano fu ucciso in uno scontro con gli indigeni. Dopo la sua morte, la spedizione attraversò l’oceano Indiano, superò il capo di Buona Speranza e, ormai ridotta a un solo vascello, costeggiò l’Africa e approdò a Siviglia nel settembre 1522. Essa aveva così compiuto il primo viaggio intorno al mondo. Tra i navigatori c’era il vicentino Antonio Pigafetta (1492-1525/1532 ca.) che in seguito scrisse un accurato resoconto del viaggio.
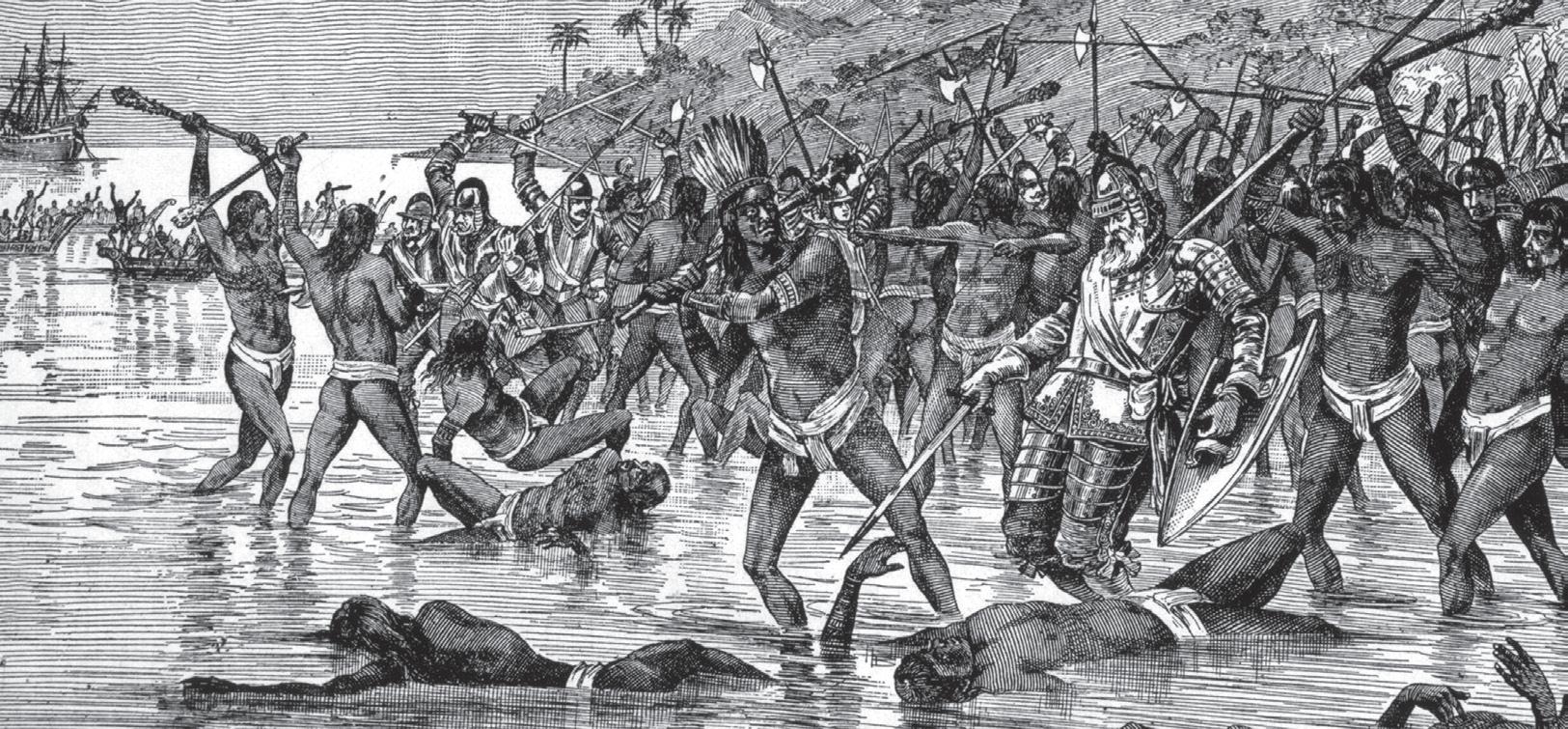
COMPRENDO IL TESTO
Quale primato vanta la spedizione guidata da Ferdinando Magellano? Fu la prima spedizione a circumnavigare il globo terrestre.

A sinistra, incisione del XIX secolo che rappresenta l’uccisione di Ferdinando Magellano, avvenuta nelle attuali Filippine. Sopra, ritratto postumo (XVI o XVII secolo) dell’esploratore.
LAVORO SULLA FONTE
I Diari scritti da Antonio Pigafetta offrono una straordinaria documentazione del primo viaggio intorno al mondo. Di seguito, la descrizione della storica scoperta del passaggio che sarebbe diventato lo stretto di Magellano.
Nel giorno delle Undecimila vergine1 trovassimo uno stretto, el capo del quale chiamammo capo delle undece mila vergine, per grandissimo miracolo. Questo stretto è lungo cento e dieci leghe, che sono 440 miglia2, e largo più o manco de mezza lega, che vada a riferire in un altro mare, chiamato mar Pacifico, circondato da montagne altissime caricate de neve. […] Se non era el capitano generale non trovavamo questo stretto, perché tutti pensavamo e dicevamo come era serrato tutto intorno: ma il capitano generale, che sapeva di dover fare la sua navigazione per uno stretto molto ascoso3, come vide ne la tesoreria del re di Portugal in una carta, mandò due navi, Santo Antonio e la Concezione, che così le chiamavano, a vedere che era nel capo della baia.[…] (Le navi) vitteno4 una bocca5 piccola, […] e come abbandonati se cacciarono dentro, sì che per forza discoperseno6 lo stretto; e vedendo che non era un cantone7, ma uno stretto de terra, andarono più uinnnanzi e trovarono una baia. Poi, andando più oltra, trovarono uno altro stretto e un’altra baia più grande che le due prime. Molto allegri, subito voltorno indietro per dirlo al capitano generale.
1. Nel giorno… vergine: 1 ottobre, giorno in cui si festeggia la ricorrenza del martirio di Sant’Orsola e delle 11000 vergini.
2. 440 miglia: circa 700 km.
3. ascoso: nascosto.
4. vitteno: videro.
5. bocca: imboccatura.
6. discoperseno: scoprirono.
7. cantone: spazio stretto e chiuso.
Rispondi alla domanda.
Prima mappa dello stretto di Magellano realizzata da Antonio Pigafetta. La parte alta della carta rappresenta il Sud, quella bassa il Nord.

• Perché Magellano era convinto dell’esistenza di un passaggio oltre la punta del Sudamerica, nella regione patagonica?
Perché lo aveva visto indicato su una mappa geografica alla corte del re del Portogallo.
3 Le conseguenze economiche, sociali e culturali della scoperta

LAVORO SULLA LINGUA
Sottolinea nel primo periodo i complementi di specificazione.
La scoperta delle Americhe ebbe sull’Europa conseguenze talmente importanti che gli storici hanno scelto il 1492 come anno d’inizio dell’età moderna.
La scoperta dell’America, infatti:
• fece conoscere vasti e sconosciuti territori;
• mise a disposizione grandi quantità di materie prime, di oro e argento;
• introdusse nuovi alimenti fino ad allora sconosciuti agli europei, che modificarono profondamente la loro alimentazione.
Di chi erano le terre del Nuovo mondo?
La scoperta di enormi territori inesplorati scatenò una contesa tra Spagna e Portogallo: entrambi gli Stati rivendicavano il possesso e lo sfruttamento delle loro risorse.
Per risolvere il contrasto tra i due regni cattolici intervenne addirittura papa Alessandro VI, che nel 1493 definì una linea di spartizione, detta raya Nel 1494 il trattato di Tordesillas fissò la posizione della linea all’incirca lungo il 50° meridiano che divide in due l’oceano Atlantico: le terre a est della raya (Asia e Africa) sarebbero appartenute al Portogallo, quelle a ovest alla Spagna. In seguito, il Portogallo ottenne anche il dominio del Brasile. Era la monarchia spagnola, però, a controllare quasi totalmente l’America centrale e meridionale.

SVILUPPO LE COMPETENZE
Rielaboro le informazioni
1. Completa la mappa concettuale inserendo correttamente i termini elencati. Attenzione: non tutti sono da utilizzare.
Magellano – Cabral – Vespucci – Marco Polo – Colombo – Caboto – Diaz
I grandi esploratori nei viaggi verso ovest
Colombo Cabral Vespucci
scopre un nuovo continente, ma non se ne rende conto approda in Brasile
giunge fino al Rio de la Plata e si rende conto di trovarsi di fronte a un nuovo continente
Individuo i nessi di causa-effetto
Caboto Magellano
Una spedizione guidata da compie il primo viaggio attorno al mondo I fratelli approdano nell’isola di Terranova
2. Collega gli eventi nella colonna di sinistra a quelli nella colonna di destra, individuando la relazione corretta.
1. Nel 1494 viene siglato il trattato di Tordesillas…
2. Colombo è convinto di essere approdato in Oriente…
3. Magellano supera per primo lo stretto che divide la punta dell’Argentina dall’oceano Pacifico…
4. La spedizione di Magellano parte da Siviglia, naviga fino alla Terra del fuoco, arriva alle Molucche, poi supera le Filippine, doppia il capo di Buona Speranza, costeggia l’Africa e approda a Siviglia…
a. tra 1519 e 1522 si compie la prima circumnavigazione del globo.
b. lo stretto sarà chiamato «stretto di Magellano».
c. il mondo viene diviso in due aree d’influenza: una sotto il controllo spagnolo e una portoghese.
d. …chiama gli indigeni che incontra indios
La «scoperta» del continente americano alla fine del XV secolo ebbe rilevanti conseguenze sugli equilibri dell’economia europea e mondiale. Essa, infatti, spostò il baricentro dei commerci e degli scambi europei dal bacino del Mediterraneo all’oceano Atlantico.
Dal XVI al XX secolo i Paesi affacciati sull’oceano Atlantico, sia sulla sponda europea sia su quella americana, hanno sfruttato questa posizione privilegiata, al centro dei flussi di merci e informazioni.

1 I porti atlantici e le navi commerciali all’inizio del XX secolo
• All’inizio del XX secolo oltre il 75% dei porti commerciali si affacciava sull’oceano Atlantico.
• All’inizio del XX secolo la quasi totalità delle navi commerciali era registrata nei porti dell’Atlantico.
• Nel XX secolo le maggiori economie mondiali, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, erano affacciate sull’oceano Atlantico.
• Nel XX secolo il più grande porto industriale del mondo era quello olandese di Rotterdam.
Tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo la globalizzazione ha radicalmente modificato gli equilibri industriali e commerciali mondiali. Lo sviluppo economico accelerato della Cina e di altri Paesi asiatici, dell’Oceania, del Brasile e di altri Paesi sudamericani, ha spostato il baricentro dell’economia mondiale dall’oceano Atlantico all’oceano Pacifico e all’oceano Indiano. In questa nuova geografia economica mondiale, il continente europeo, che per lunghi secoli era stato il perno del commercio mondiale, si è trasformato in un’appendice periferica.
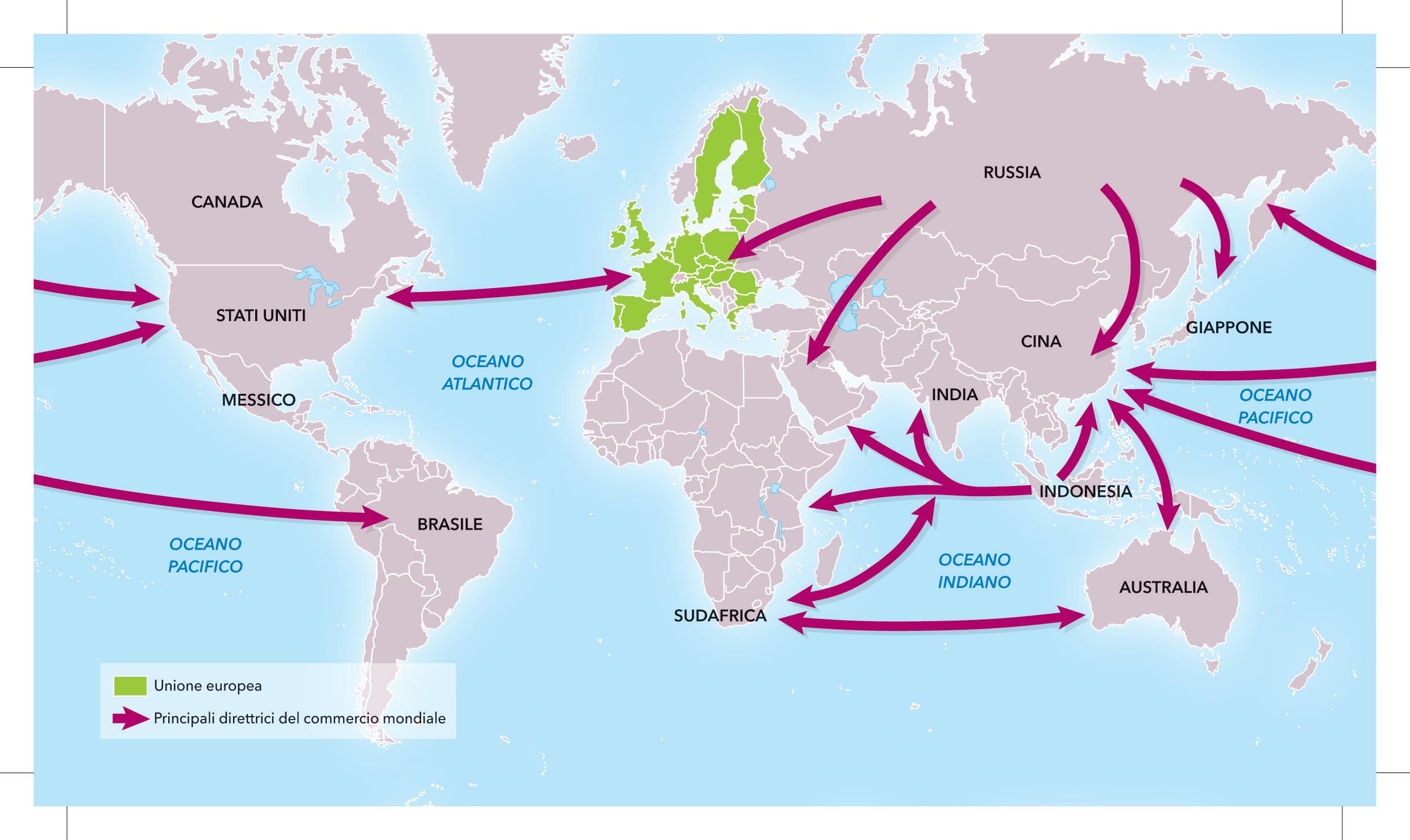
• Oltre il 40% della popolazione mondiale vive in Paesi che si affacciano sull’oceano Pacifico.
• Oltre metà del Prodotto interno lordo mondiale è generato sulle rive del Pacifico.
• Circa il 40% delle merci mondiali circola sul Pacifico.
• 8 dei primi 20 porti commerciali più importanti del mondo si trovano in Cina.
L’aggettivo «precolombiano»
è formato da due elementi.
Quali? Distinguili e spiegane il significato.
L’aggettivo è formato dal prefisso pre- «prima di» e dall’aggettivo colombiano «di Colombo», con riferimento alla scoperta di Colombo.
L’America precolombiana (cioè «prima» di Colombo) è a lungo sembrata un grande continente dominato dalle forze della natura, uno spazio occupato per millenni quasi esclusivamente da piante, fiumi e animali. Quest’immagine che si aveva del Nuovo mondo è completamente sbagliata: il continente americano, infatti, era stato popolato già 30-40 000 anni fa da gruppi umani provenienti dalla Siberia e giunti in Alaska attraverso lo stretto di Bering, grazie alla glaciazione del mare che aveva aperto un «ponte naturale» tra Asia e America settentrionale. Da lì, si erano diretti verso le regioni del Centro e del Sud, in cerca di temperature più miti e di condizioni ambientali più favorevoli all’insediamento umano. Alcuni tratti somatici delle popolazioni native americane (i cosiddetti «indiani d’America») sono la più evidente testimonianza della loro origine asiatica.
Quando gli spagnoli arrivarono in Messico e nella regione delle Ande, insomma, non trovarono terre desolate e spopolate, disponibili allo sfruttamento delle loro sterminate risorse, ma entrarono in contatto con importanti e raffinate civiltà, le civiltà amerinde, che popolavano da secoli il continente.
DENTRO LA STORIA
Dall’America alle tavole d’Europa
Molti alimenti che costituivano la dieta dei popoli amerindi erano del tutto sconosciuti agli europei. Colombo stesso, ma soprattutto i conquistadores spagnoli e portoghesi, conosciutili, li importarono nel Vecchio continente.
Alcuni prodotti ebbero un successo quasi immediato in alcune parti d’Europa e divennero presto parte della dieta comune. Altri ricevettero la giusta attenzione dai botanici molto più tardi ma, una volta conosciuti e apprezzati, ebbero una diffusione tale da farci dimenticare la loro… «esoticità».
Polenta e fagioli
La prima pianta amerinda a essere importata e apprezzata per la facilità di coltivazione e di crescita fu il mais, ma inizialmente soltanto in Spagna, Francia, Italia e Balcani: la coltura ebbe un rapido sviluppo soltanto a partire dal 1600.
Come già i Maya, gli europei impararono a trarre farina dai suoi chicchi e la polenta di grano turco (così veniva chiamata la pianta) divenne uno dei piatti popolari più consumati. Altrettanto immediato successo ebbero la coltivazione del fagiolo, della zucca e del peperoncino

Le civiltà amerinde stanziate nell’attuale Messico e nella cordigliera andina si confrontarono con diverse condizioni ambientali. In queste terre nel III millennio a.C., con l’inizio della pratica dell’agricoltura, si svilupparono civiltà articolate e raffinate.
Al centro della produzione agricola stava un vegetale sconosciuto in Europa, il mais, il cui elevato rendimento e la cui naturale esuberanza, che non richiedeva un rilevante intervento umano, garantiva una produzione sufficiente a sfamare le popolazioni indigene. Oltre al mais, le civiltà precolombiane si nutrivano di una vasta gamma di vegetali ignoti agli europei: la patata, il pomodoro, la zucca, il fagiolo, il peperone, il cacao.
La dieta dei popoli precolombiani stanziati tra Centro e Sud America non prevedeva grandi consumi di carne animale: in quelle regioni, infatti, non esisteva una varietà di animali paragonabile né all’Europa, né all’America del Nord. Ciò condizionava pesantemente sia lo sviluppo e la resistenza fisica degli uomini, indeboliti da un basso apporto di proteine animali, sia il livello di sviluppo dell’economia rurale, nella quale l’uomo lavorava senza l’aiuto (energia) e le risorse (concimi e alimenti) fornite da buoi e cavalli, maiali e pecore. Questi fattori naturali determinarono lo sviluppo di tecniche per lo sfruttamento dell’acqua, ma non motivarono particolari metodologie per lo sfruttamento dei campi, né l’utilizzo di strumenti come l’aratro per dissodarli e seminarli in profondità. In campo scientifico e tecnologico si nota l’arretratezza tecnologica rispetto alle civiltà mediterranee: agli Amerindi erano infatti sconosciuti sia la ruota sia la lavorazione del ferro, ma finissime erano le competenze matematiche e astronomiche.
COMPRENDO IL TESTO
Sottolinea nel testo la frase che si sofferma sulle conseguenze sociali della dieta alimentare tipica delle popolazioni amerinde.
Patate e pomodori
Se consideriamo il largo consumo, oggi, di patate e pomodori sembra strano non siano nati in Europa. Eppure è così, e non solo: trascorsero circa due secoli dal loro ingresso nel Vecchio continente prima di comparire sulle tavole. Nel Cinquecento, gli europei provarono a mangiare le foglie della patata ma riscontrarono la loro tossicità; il consumo del tubero ebbe inizio all’incirca nel XVIII secolo durante le grandi carestie che colpirono il continente.

Il pomodoro si adattò ai climi mediterranei solo grazie a interventi botanici che modificarono il frutto della pianta da giallo-oro al rosso che conosciamo; prima del Settecento era coltivata solamente a scopo ornamentale!
Dulcis in fundo…
Oggi presente in molte preparazioni dolciarie, il cacao fu importato dal Messico dove veniva utilizzato (amaro) in riti religiosi oppure come medicina o talvolta come moneta. Anche il cacao, e soprattutto la cioccolata ricavata da esso, fecero la loro comparsa sulle tavole di ricchi aristocratici a partire dal XVIII secolo.



Fin dal 2000 a.C., nell’attuale Messico meridionale e nelle regioni immediatamente a sud, si erano stanziati i Maya, uno dei più antichi popoli della regione. Essi diedero vita a una civiltà fiorente, come testimoniano gli eccezionali reperti archeologici che sono stati ritrovati nelle foreste dell’odierno Guatemala. I Maya non formarono un grande impero territoriale unitario, ma erano organizzati in città-stato tra loro indipendenti e governate da sacerdoti. Le principali erano Tikal, Copán e Palenque, centri religiosi e politici. Queste città si sviluppavano intorno a templi posti sulla cima di imponenti ed eleganti piramidi a gradoni, simili a quelle che costruirono sia i popoli della Mesopotamia, sia gli Egizi. I Maya si dedicavano soprattutto all’agricoltura, ma praticavano anche fiorenti attività commerciali. Possedevano inoltre profonde conoscenze matematiche (avevano un proprio sistema di numerazione) e astronomiche e una loro forma di scrittura. La religione era politeista: le divinità erano elementi della natura come il sole, la pioggia, la luna, il mais.
La civiltà maya raggiunse il suo massimo sviluppo tra la metà del IV e la fine del IX secolo d.C., quando un evento ancora sconosciuto spinse i Maya ad abbandonare il territorio originario di stanziamento e a spostarsi nel Nord della penisola dello Yucatán. Qui essi dovettero lottare contro un popolo invasore proveniente da territori più settentrionali, i Toltechi, che li assoggettarono militarmente, ma ne assimilarono la cultura.
LAVORO SULLA FONTE
Il tempio del Giaguaro Gigante
L’immagine mostra il tempio del Giaguaro Gigante di Tikal, in Guatemala. I Maya erano soliti costruire grandi piramidi a gradoni sulla cui cima era situato il tempio. L’abilità architettonica di questo popolo ricorda quella dei popoli mesopotamici e degli Egizi.
Anche quest’ultimi, infatti, prima delle note piramidi a pareti lisce, costruirono piramidi a gradoni.
Rispondi alle domande.
1. Osserva la foto: dove conduce la lunga scala centrale?
Al tempio.
2. Sai dire in che cosa si differenziava la funzione delle piramidi mesopotamiche e maya da quelle egizie?
Le piramidi mesopotamiche e maya erano edifici religiosi che comprendevano il tempio dedicato a un dio; quelle egizie erano sepolture di faraoni o di alti dignitari.

Attorno all’anno Mille, in Messico si stabilirono gli Aztechi, un popolo nomade proveniente da nord.
La loro eccezionale abilità militare permise loro di sottomettere i popoli vicini e di dare vita a un grande impero. La capitale dell’Impero azteco era Tenochtitlán, una città costruita nel 1325 su alcune isolette del lago Texcoco, sui cui resti oggi sorge Città del Messico.
Nel XVI secolo, quando gli spagnoli giunsero nell’America centrale, l’Impero azteco, sotto la guida dell’imperatore Montezuma II, dominava le regioni degli altipiani e quelle affacciate sul golfo del Messico. La forza militare azteca, però, non fu sufficiente a sostenere l’urto dei soldati europei. La società azteca, infatti, era divisa al suo interno in gruppi etnici diversi in conflitto tra loro e ciò costituì un fattore di debolezza quando arrivarono gli spagnoli.
Gli Aztechi erano politeisti e attribuivano una grandissima importanza alla religione; adoravano il dio del Sole, il dio della guerra (Huitzilopochtli) e il dio della saggezza e della civiltà (Quetzalcoatl) e a essi offrivano sacrifici umani. La loro economia era basata soprattutto sull’agricoltura. Come i Maya, possedevano una propria scrittura della quale conserviamo traccia grazie a preziosi manoscritti giunti fino a noi. Anche gli Aztechi, infine, elaborarono forme di arte e architettura raffinate.
Resti di colonne, pilastri e sculture raffiguranti guerrieri che sorreggevano il tetto del tempio dedicato a Quetzalcoatl a Tula, l’antica capitale dei Toltechi, in Messico.

COMPRENDO IL TESTO
Quale fattore sottrasse efficacia alla grande forza militare azteca? a La grandezza dell’impero. b La mancanza di unità etnica. c La fragilità organizzativa dell’esercito.

Il dio della guerra Huitzilopochtli è rappresentato come un guerriero, rivestito con un manto colorato e un elmo piumato, simbolo del potere.
Il dio della saggezza e della civiltà Quetzalcoatl è rappresentato come un serpente piumato. Qui è raffigurato nell’atto di divorare un uomo.

COMPRENDO IL TESTO
Completa la seguente piramide con la gerarchia sociale e politica degli Inca.
Imperatore Governatori
Ispettori

Gli Inca erano abilissimi artigiani: lavoravano oggetti ornamentali di metallo sbalzato, decorato con motivi geometrici o antropomorfi e arricchiti con oro o pietre preziose.
Nell’America meridionale, sugli altipiani e sulle altissime vette della cordigliera delle Ande, a partire dal XIII secolo si sviluppò la grande civiltà degli Inca All’inizio del XV secolo gli Inca avviarono una politica espansionista che li portò a sottomettere i popoli vicini e a dar vita a un vero e proprio impero.
L’Impero inca era diviso in quattro grandi regioni e governato da una rigorosa gerarchia:
• al vertice c’era l’imperatore, era l’Inca (cioè il figlio del Sole) e incarnava nella sua persona il potere politico, religioso e militare;
• sotto di lui c’erano i governatori, appartenenti alla stessa famiglia dell’imperatore, che amministravano le province;
• alle loro dipendenze, infine, c’era un corpo d’ispettori che agivano sul territorio e riferivano all’autorità centrale.
Le città erano spesso circondate da robuste mura ed erano disposte a terrazze, così da adattarsi alla morfologia dei rilievi andini. Gli Inca erano abilissimi ingegneri: crearono un’ampia ed efficiente rete stradale che collegava la capitale, Cuzco (a circa 3 400 metri d’altitudine, nell’attuale Perù), con le regioni più lontane dell’impero, ma soprattutto seppero realizzare un avanzato sistema di canalizzazione che permetteva di convogliare le acque dei fiumi e dei torrenti. A differenza dei Maya e degli Aztechi, gli Inca non conoscevano la scrittura; come loro, invece, adoravano quali divinità elementi e forze della natura.
Le comunità agricole inca erano piuttosto sviluppate, grazie anche agli interventi di terrazzamento dei pendii per renderli adatti alla coltivazione. I territori degli Inca erano costituiti da tre fasce dove, a seconda dell’altitudine, si praticavano attività diverse:
• una prima fascia di pianure, dove si coltivava il cotone;
• una seconda fascia di altipiani, in cui si coltivavano patate e mais;
• una terza fascia di montagne, dove pascolavano i lama (oltre i 3500 metri di altitudine).

La pesca e le colture irrigue erano praticate lungo le coste. Gli Inca non conoscevano l’uso della moneta: i beni prodotti venivano raccolti e distribuiti dall’autorità centrale. Un terzo serviva per il mantenimento dell’imperatore, dell’esercito e di chi non era in grado di mantenersi, un terzo era destinato ai religiosi e l’altro terzo al soddisfacimento dei bisogni popolari.
Dei lama, animali tipici della cordigliera andina, sugli antichi terrazzamenti del Machu Picchu, il sito archeologico inca situato a 2 430 metri d’altitudine.
LAVORO SULLA CARTA
Le principali civiltà amerinde
La carta mostra le aree del continente americano nelle quali si svilupparono le civiltà amerinde: gli Aztechi in Messico, i Maya nella penisola dello Yucatan, gli Inca lungo la costa occidentale dell’America del Sud.
Rispondi alle domande.
1. Su quali Stati odierni gli Inca estesero la maggior parte del loro impero?
Ecuador, Perù, territori andini di Bolivia e Argentina, Cile.
2. Su quali, invece, erano collocati Maya e Aztechi?
Messico, Guatemala, Honduras.
3. Confrontando questa carta con una carta fisica dell’America latina, quale impero era situato in un territorio prevalentemente montuoso?
Quello degli Inca.
Rielaboro le informazioni

1. Collega correttamente le definizioni nella colonna di sinistra ai termini nella colonna di destra.
1. Avevano città-stato governate da sacerdoti, costruivano templi sulla sommità di piramidi e conoscevano la scrittura.
2. Erano un popolo di combattenti e crearono un grande impero; praticavano sacrifici umani e conoscevano la scrittura.
3. Il loro impero era diviso in quattro regioni; disponevano di una rete stradale e di un efficiente sistema di canalizzazione; non conoscevano la scrittura.
a. Aztechi
b. Inca
c. Maya
2. Elabora un breve testo sulle differenti modalità di sfruttamento delle colture, tra europei e Amerindi nel XV-XVI secolo, utilizzando la seguente scaletta. Soluzione libera.
Dissodamento del terreno con aratro trainato da buoi – Concimazione – Coltivazione del mais – Intervento umano poco necessario – Mancanza di presupposti per l’invenzione di strumenti agricoli
Mi oriento nel tempo
3. Completa la linea del tempo.
a.C.
800 d.C.
2000 Messico maya
1000 d.C.
I Maya si stabiliscono nel del Sud
Massimo sviluppo della civiltà
Gli si stabiliscono in Messico Aztechi
I Maya ci hanno lasciato un’eredità culturale preziosissima: non solo raffinate costruzioni architettoniche ma, grazie al loro elaborato sistema di scrittura, anche alcuni testi sacri che in qualche caso, fortunosamente, sono giunti sino a noi.
La civiltà dei Maya si sviluppò lungo un arco storico di 3000 anni su un territorio molto ampio e per nulla uniforme, caratterizzato dalla presenza di coste e alte montagne, zone aride e zone umide, estese in una regione che attualmente comprende gli Stati dell’Honduras, del Belize, del Guatemala, del Salvador e della regione messicana dello Yucatán.
I Maya, insomma, non vanno considerati come un popolo unitario, ma come una specie di federazione di popoli, delle cui diverse espressioni artistiche e culturali troviamo ampia traccia in siti archeologici, destinati a unificarsi nel I millennio d.C. formando la raffinata civiltà dell’America centrale.


Una meravigliosa testimonianza della complessa identità culturale dei Maya è rappresentata dai diversi libri sacri: il Popol Vuh («libro della comunità» o «del consiglio») dei Maya Quiché del Guatemala e il Chilam Balam dei Maya dello Yucatán.
Nel Popol Vuh i Maya Quiché raccontavano la formazione e la storia antica del loro popolo, dando conto delle migrazioni e degli scambi con le popolazioni vicine (Olmechi, Toltechi e Maya dello Yucatán). Il libro inizia con il mito della creazione maya, poi prosegue con le storie di due eroi gemelli, figure salienti della mitologia dei Maya; infine viene narrata la fondazione e la storia del regno quiché, per mostrare come il potere della famiglia reale provenga dagli dei. Così inizia il Popol Vuh: «Questo è il racconto di come tutto era sospeso, tutto calmo, in silenzio; tutto immobile, tranquillo, e la distesa del cielo era vuota. Questo è il primo racconto, la prima narrazione. Non c’era né uomo, né animale, né uccello, né pesce, né granchio, né albero, né pietra, né cave, né gole, né prati, né foreste: c’era solo il cielo». Il Chilam Balam era un testo sacro un po’ diverso: erano dodici quaderni in cui racconti mitologici si accompagnavano a cronache storiche dei periodi precedenti l’invasione spagnola e la successiva colonizzazione e a profezie.
astronomia, astrologia ed erboristeria.
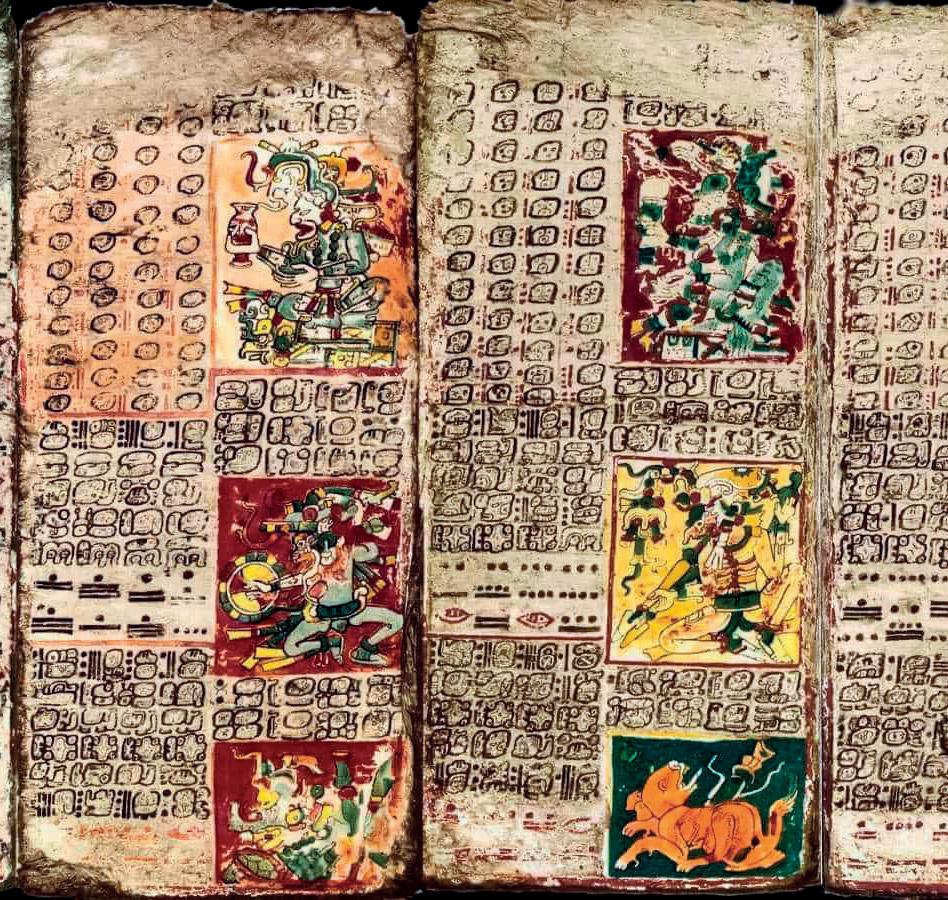
Quando gli spagnoli conquistarono il Guatemala, oltre a proibire alle popolazioni locali di praticare la propria religione, vietarono anche di parlare la propria lingua e imposero l’uso dello spagnolo. Alcuni sacerdoti maya quiché, allora, nel tentativo di mantenere in vita le antiche tradizioni, trascrissero di nascosto il Popol Vuh in latino. Nel 1702 il sacerdote spagnolo Francisco Ximénez (1666-1729) trovò nella cittadina di Chichicastenago, in Guatemala, una di queste copie e vi aggiunse anche una traduzione in castigliano. Questo testo fu poi ritrovato alla metà dell’Ottocento a Città del Guatemala e finalmente pubblicato con traduzioni in inglese e francese.
Una pagina del Popol Vuh tradotto da Ximénez. Il manoscritto oggi è conservato in una biblioteca di Chicago.

Conquistadores
Parola spagnola che significa «conquistatori». Erano avventurieri, finanziati dai sovrani oppure da privati, che avevano al loro servizio piccoli eserciti.

Monumento a Hernán Cortés a Medellin, sua città natale, in Spagna.


A partire dai primi anni del XVI secolo la monarchia spagnola organizzò e finanziò numerose spedizioni verso il Nuovo mondo allo scopo di prendere stabile possesso di nuovi territori e sfruttarne le risorse minerarie e agricole. Il compito fu spesso affidato ad avventurieri, i cosiddetti conquistadores. I conquistadores si mostrarono spesso crudeli e privi di scrupoli nei confronti delle popolazioni indigene e furono loro, nel corso del XVI secolo, i protagonisti della colonizzazione dell’America centrale e meridionale.
Uno dei primi conquistadores è considerato lo spagnolo Hernán Cortés (14851547). Nel 1519 egli partì per il Messico, la «terra dell’oro» di cui tanto si fantasticava in Europa. Quando giunse in Messico, gli Aztechi subito accolsero benevolmente gli spagnoli: secondo una leggenda, una profezia annunciava loro l’arrivo di un dio dal mare e, pertanto, i nuovi venuti furono accolti come divinità. L’atteggiamento ospitale cambiò solo quando compresero che i conquistadores volevano sottometterli e conquistare le loro terre.
La reazione di Cortés fu spietata: assediò Tenochtitlán, la capitale, e uccise l’imperatore Montezuma II (1466-1520). Nel 1522 la conquista del Messico era quasi conclusa e l’Impero azteco era definitivamente abbattuto.
Tenochtitlán fu la capitale dell’Impero azteco. Fondata nel 1325, sorgeva su un’isola nel lago di Texcoco, nell’attuale Messico centrale.

Diversi fattori contribuirono alla vittoria di Cortés:
• sul piano militare disponevano di armi tecnologicamente superiori: le lance e gli archi degli Aztechi non potevano reggere il confronto con i moschetti e i cannoni degli europei; inoltre, grazie ai cavalli, animali sconosciuti agli indigeni, gli spagnoli potevano muoversi molto più velocemente;
• sul piano politico, i conquistadores furono molto abili nel dividere il fronte amerindo stringendo alleanze con popolazioni che desideravano liberarsi dalla dominazione azteca;
• moltissimi indigeni, infine, morirono a causa delle nuove malattie portate dall’Europa, che il loro sistema immunitario non riusciva a contrastare.
Gli spagnoli avevano conquistato il Messico con relativa facilità e ciò li spinse a continuare la penetrazione e la conquista di nuovi territori. Nel 1531 un altro conquistador, il capitano Francisco Pizarro (1475-1541), sbarcò in Perù alla testa di un piccolo esercito di soli 180 uomini. Sulle montagne andine si scontrò con gli Inca, avendone la meglio. Alla fine del 1533, dopo aver ucciso il sovrano Atahualpa (1497-1533), Pizarro fece il suo ingresso trionfale nella capitale Cuzco.
Gli Inca cercarono di resistere agli invasori e continuarono a combattere: la loro resistenza fu definitivamente spezzata solo nel 1572, con la decapitazione del sovrano Tupac Amaru (1545-1572).
La spedizione di Pizarro permise alla Spagna di prendere possesso di vasti territori, corrispondenti agli Stati attuali del Perù e dell’Ecuador, oltre alla parte settentrionale del Cile.

COMPRENDO IL TESTO
Completa la seguente frase relativa ai popoli precolombiani o amerindi.
Gli Amerindi erano militarmente inferiori agli spagnoli perché non
Monumento equestre di Francisco Pizarro nella sua città natale, Trujillo, in Spagna. avevano le armi da fuoco né i cavalli.

A Cuzco, in Perù, è stato dipinto in questi ultimi anni un enorme murales, di cui vedi un particolare, con la storia del popolo inca fino alla sconfitta subita per mano dei conquistadores.
COMPRENDO IL TESTO
Sottolinea le novità introdotte dagli spagnoli nell’agricoltura amerinda.
Dal punto di vista politico-amministrativo, le colonie spagnole erano governate da viceré, funzionari statali che agivano in rappresentanza del sovrano di Madrid. Dal punto di vista economico, gli spagnoli cambiarono radicalmente le abitudini secolari dei contadini indigeni sostituendo le coltivazioni locali di cereali e ortaggi con quella, molto più redditizia, della canna da zucchero; inoltre, introdussero l’allevamento del bestiame, prima quasi sconosciuto.
L’organizzazione di una encomienda.
La Spagna introdusse nel Nuovo mondo il sistema dell’encomienda («affidamento»). Il viceré assegnava a ogni colono spagnolo un lotto di terra, compresi gli indigeni che vi abitavano: gli indios infatti venivano considerati come parte dell’encomienda ed erano costretti a lavorare per il colono, come avveniva nel Medioevo europeo con i servi della gleba. I ritmi e le condizioni di lavoro erano, specialmente all’inizio della colonizzazione, disumani; non meno disperate erano le condizioni di lavoro nelle miniere di argento e di mercurio. Sebbene tra i compiti dei coloni ci fossero la protezione e l’evangelizzazione dei propri contadini, la dura realtà del lavoro servile fu alla base di un autentico genocidio.
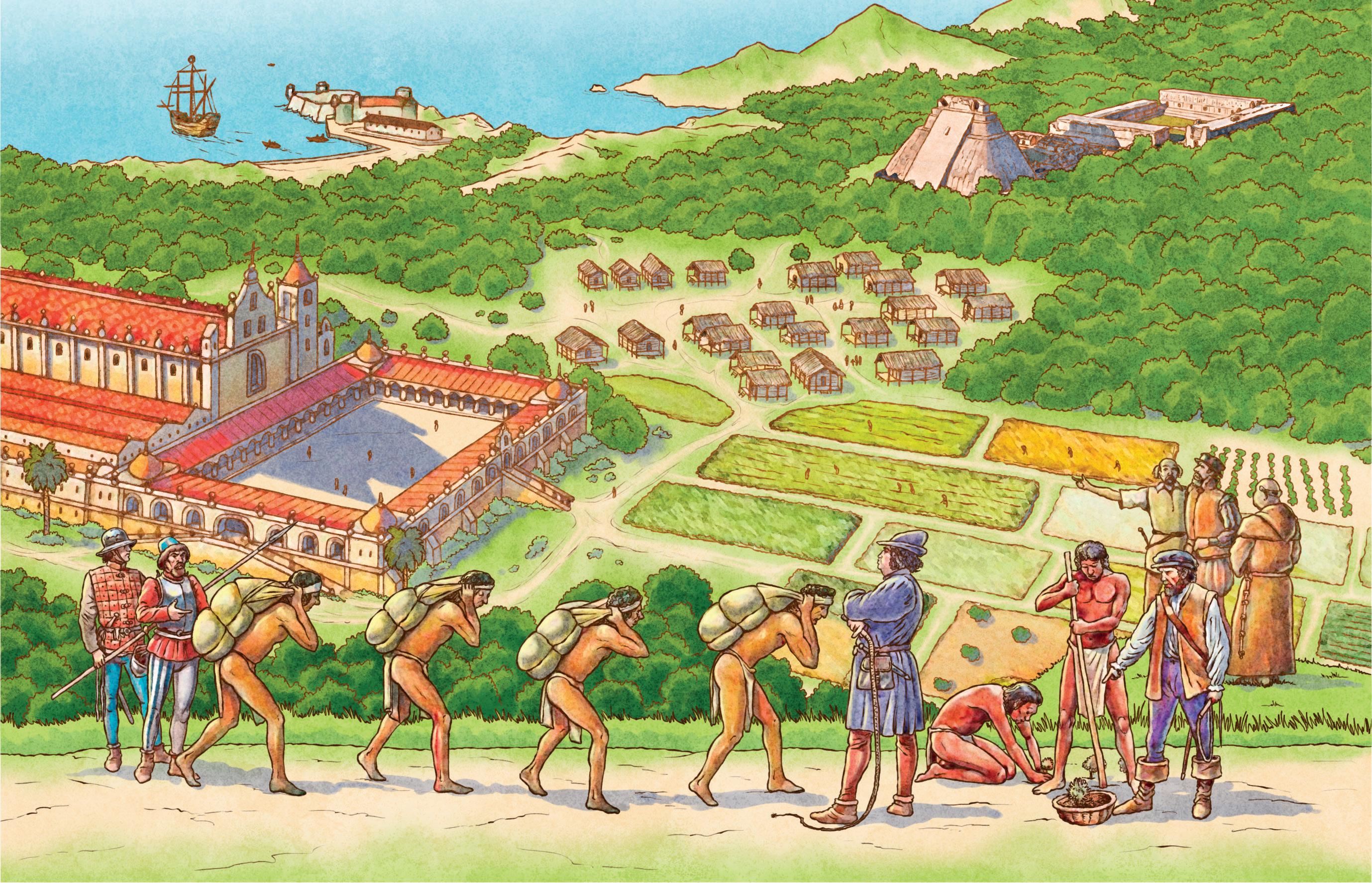

La colonizzazione spagnola fu per le civiltà indigene dell’America una vera e propria catastrofe. Gli indios, considerati da tanti più simili ad animali che a esseri umani, furono obbligati con la forza ad abbandonare la propria cultura, la propria religione e la propria lingua per convertirsi al cristianesimo e imparare lo spagnolo. Si calcola che la colonizzazione causò nel giro di alcuni decenni la scomparsa di decine di milioni di indios, che morirono per svariate ragioni:
• negli scontri militari con i conquistadores;
• a causa delle nuove malattie portate dall’Europa;
• di stenti per il duro lavoro a cui erano obbligati nelle grandi piantagioni coloniali o nelle miniere.
Solo poche personalità si opposero a questo genocidio. Fra queste, il più noto fu il domenicano Bartolomé de Las Casas (1484-1566).
DENTRO LA STORIA
Uomini o no?

Le grandi civiltà precolombiane erano cresciute per secoli nel reciproco isolamento e avevano raggiunto punte di altissimo sviluppo culturale, specie in campo matematico e astronomico. Nonostante il loro alto grado di sviluppo, esse vennero però letteralmente distrutte dall’incontro con i conquistadores spagnoli.
Indios: popolazioni annientate e schiavizzate
Per le popolazioni precolombiane l’impatto con i conquistadores spagnoli fu devastante. Fin da subito, i coloni ridussero gli indigeni a una condizione di schiavitù, costringendoli a piegarsi al duro lavoro delle piantagioni o delle miniere.
La ferocia mostrata dai colonizzatori indusse la Chiesa spagnola ad aprire un vivace dibattito sul modo in cui dovevano essere trattati gli indios. La stessa monarchia, del resto, aveva cercato di regolamentare in qualche modo i rapporti di lavoro attraverso le encomiendas e riconoscendo agli indigeni costretti ai lavori forzati una quota minima di diritti.
Il tentativo di legittimare lo sfruttamento e la schiavitù
Era giusto sottomettere gli indios e ridurli alla schiavitù?
Umanisti ed ecclesiastici spagnoli aprirono una vivace discussione sulla «natura» degli indios: ci si poneva persino la domanda se essi avessero un’anima e potessero essere considerati «uomini». Il dotto umanista Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) sostenne che gli
LAVORO SULLA LINGUA
Scrivi i verbi con cui è presentato lo sradicamento degli indios dalla loro cultura operato dai conquistadores.
Furono obbligati, abbandonare, convertirsi, imparare.
Genocidio
Distruzione, eliminazione pianificata di un popolo per motivi etnici, religiosi o razziali.
indigeni fossero da paragonare a bestie e come tali andassero trattati. A dimostrazione della sua tesi portava il fatto che gli indios non si erano opposti ai conquistadores e, anzi, li avevano accolti benevolmente. Era pertanto legittimo che, data la loro presunta inferiorità naturale («homuncoli»), essi fossero naturalmente servi di chi invece era più forte e più capace. Era dunque opera meritoria costringerli con la forza ad adattarsi alla superiore civiltà cristiana.
Un’opinione controcorrente
Non tutti gli europei concordavano con l’opinione di Sepúlveda. Il frate domenicano Bartolomé de Las Casas (14841566), per esempio, pensava che gli indios fossero esseri umani meritevoli di rispetto, la cui dignità non doveva essere calpestata. Egli scrisse:
«Tutte queste genti Iddio le creò del tutto semplici, senza malizia, né doppiezza, obbedientissime, fedelissime ai loro Signori e ai cristiani […] non sono rissose, non querule, non parlano alle spalle, non provano odio né desiderio di vendetta […]. Sono inoltre genti poverissime, che posseggono poco e non vogliono possedere altri beni materiali: perciò non sono superbe, ambiziose o avare […]. Anche il loro intelletto è puro e vivace, sono molto capaci, e docili in ogni buona dottrina, molto propensi a ricevere la nostra santa fede cattolica e ad apprendere costumi virtuosi» Ritratto di Bartolomé de Las Casas.
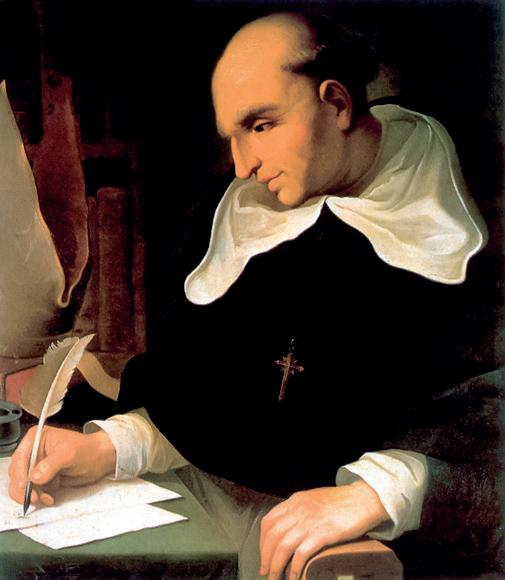
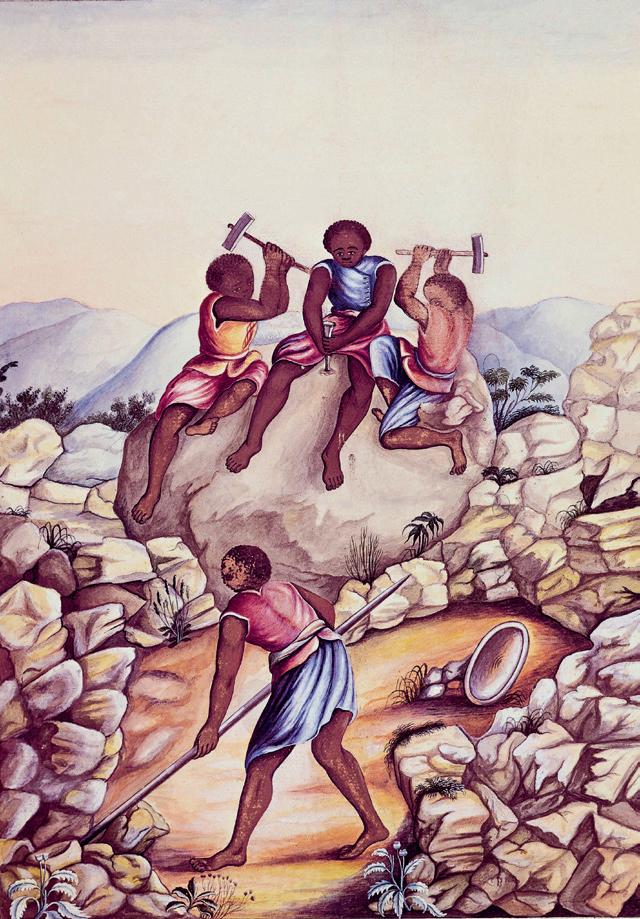
Mentre gli spagnoli costruirono un vero e proprio impero coloniale, i portoghesi costituirono un proprio vicereame nella fascia costiera del Brasile, che il trattato di Tordesillas assegnava al regno lusitano.
All’inizio, queste aree furono sfruttate per la coltivazione della canna da zucchero e per il legno chiamato brazil, da cui si ricavava una sostanza rossastra per tinteggiare le stoffe. Solo alla fine del XVII secolo la scoperta di ricchi giacimenti di argento aumenterà il valore economico di quei possedimenti.
Anche sotto il dominio portoghese gli indios, duramente sfruttati nelle piantagioni, subirono un drammatico calo demografico. Per questa ragione gli europei decisero di integrare la scarsa manodopera locale con nuova manodopera, più forte e resistente: quella degli schiavi africani.
Il commercio di schiavi era già praticato da secoli dai mercanti arabi a danno delle popolazioni dell’Africa subsahariana. Col tempo, anche i navigatori portoghesi avevano cominciato a praticare questa attività.
Dopo la conquista dei territori americani e la presa d’atto che gli indios non garantivano prestazioni all’altezza dei bisogni dei colonizzatori, gli schiavi neri divennero una «merce» preziosissima, che alimentò un intenso commercio di proporzioni sempre maggiori.
I mercanti di schiavi portoghesi acquistavano la «merce» umana da mercanti africani in cambio di merci di scarso valore o di armi. Una volta trasportati in America, li vendevano sia ai proprietari terrieri portoghesi, sia a quelli spagnoli in cambio di merci e metalli preziosi, che poi rivendevano in Europa. Gli schiavi neri venivano impiegati nelle piantagioni e spesso affiancavano o sostituivano gli indios sterminati dalla fatica e dalle malattie.

LAVORO SULLA FONTE
Mitigare i mali della conquista, della colonizzazione, dell’avidità
Nel volume L’Europa del Cinquecento, edito da Laterza, gli storici H.G. Koenigsberger, George L. Mosse e Gerard Q. Bowler, mettono in luce come l’espansione portoghese in altri continenti alla ricerca di oro, schiavi e vantaggiosi traffici commerciali fosse in parte giustificata dalla volontà di combattere gli arabi, da una parte, e di convertire gli atei. Tutto ciò era legittimato dai papi del XV secolo, e tale spinta si tradusse in crudeltà ed efferatezze che alcuni religiosi tentarono di mitigare.
Tuttavia vi furono alcuni portoghesi, specialmente domenicani e gesuiti, che cercarono di mitigare i mali peggiori prodotti dalla conquista, dalla colonizzazione e dall’avidità. Il loro più grande successo lo ottennero forse in Brasile, dove […] si prodigarono per […] istruire sia i bambini bianchi che quelli di colore, e riformare la morale e i costumi dei colonizzatori europei, “che […] erano propensi a fondarsi sulla teoria che a sud dell’equatore non esistessero più i dieci comandamenti”.
Rispondi alle domande.
1. Chi sono i domenicani e i gesuiti? Aiutati, se non lo sai, con un dizionario o una ricerca in internet.
Religiosi appartenenti all’ordine domenicano i primi, alla Compagnia di Gesù i secondi.
2. Che cosa facevano a favore delle persone di colore?
Istruivano i bambini.
3. Che cosa significa la frase riferita ai costumi dei colonizzatori europei «propensi a fondarsi sulla teoria che a sud dell’equatore non esistessero più i dieci comandamenti»?
Lontano dalla patria gli europei non seguivano le norme di comportamento richieste dalla loro religione.
SVILUPPO LE COMPETENZE
Rielaboro le informazioni
1. Completa la mappa concettuale inserendo correttamente i termini elencati. spagnolo – portoghese – canna da zucchero – tratta degli schiavi – cristianesimo – Brasile – argento – Cortés – Pizarro
conquista il Messico
conquista il Perù Conquista del
Cortés Pizarro Brasile
Impero coloniale : rende schiavi gli indigeni, sfrutta le miniere di e di mercurio, converte a forza gli indigeni al
spagnolo portoghese argento canna da zucchero cristianesimo tratta degli schiavi
Impero coloniale : sfrutta la e il legno, pratica la dall’Africa
2. Collega ciascun nome nella colonna di sinistra alla descrizione che lo riguarda nella colonna di destra.
1. Hernán Cortés
2. Montezuma II
3. Atahualpa
4. Tupac Amaru
5. Francisco Pizarro
6. Bartolomé de Las Casas
a. Conquistatore spagnolo del Perù.
b. Re inca decapitato nel 1572.
c. Sovrano azteco ucciso nel 1520.
d. Conquistatore spagnolo del Messico.
e. Domenicano spagnolo difensore degli indios
f. Re inca ucciso nel 1533.
La diversità, spesso, fa paura. Chi non conosciamo, chi vive in modo diverso rispetto alle nostre abitudini, ci inquieta e ci spaventa, ci sembra non solo diverso, ma anche peggiore, inferiore. I Greci e i Romani chiamavano «barbari» (cioè balbuzienti) chi non parlava la loro lingua. Con questa parola esprimevano disprezzo per esseri umani che consideravano inferiori. Imparare a convivere pacificamente fra uomini e donne diversi è oggi la sola risposta possibile al razzismo.
Una delle esperienze più importanti di relazione fra culture e persone «diverse» risale ai tempi della scoperta del Nuovo mondo da parte degli europei. Quando i conquistadores spagnoli giunsero nelle Americhe, infatti, entrarono in contatto con popoli indigeni: i cosiddetti popoli pre-colombiani, completamente diversi da loro, ma certamente evoluti sul piano politico, culturale e artistico. Ciò nonostante, i Maya, gli Inca, gli Aztechi spesso furono considerati non-uomini.
Nel Novecento è nata una scienza, chiamata antropologia culturale (dal greco àntropos, «uomo»), che studia tutti gli esseri umani (dagli abitanti delle grandi metropoli del mondo occidentale alle comunità indigene dei piccoli villaggi dell’Amazzonia) dal punto di vista culturale e sociale.
Quando gli antropologi studiano lo stile di vita di un avvocato di New York laureato in una prestigiosa università e quello di un contadino analfabeta delle Ande non considerano l’uno «migliore» dell’altro, ma lo giudicano semplicemente «diverso», cioè espressione di una cultura differente.
Nel linguaggio quotidiano, parlando della «cultura» di una persona, generalmente vogliamo dire che quella persona ha tante conoscenze, ha studiato; insomma, che non è «ignorante».
Il concetto non è sbagliato, ma non esaurisce tutti i significati della parola «cultura».
Gli antropologi, infatti, chiamano «cultura» l’insieme dei modi di vivere, di pensare, di organizzare la famiglia di un certo gruppo sociale.
Oggi nessuna persona di buon senso direbbe che la cultura dei giapponesi è superiore o inferiore a quella degli indiani: riconoscerebbe solo che sono due culture diverse.
I conquistadores, però, non erano antropologi (anche se qualcuno si sforzò di capire le genti con cui entrava in contatto); erano avventurieri, uomini d’arme che trattarono gli indigeni al pari di bestie. Anche gli uomini di Chiesa si divisero tra chi considerava gli indigeni come animali e chi, invece, pensava che fossero anch’essi figli di Dio.
Oggi, nella realtà del mondo globale, le diverse culture umane spesso entrano in contatto fra loro e persino si mescolano, si rendono familiari l’una all’altra. Fino a pochi decenni fa, un giovane di Pechino poteva apparirci quasi come un abitante di un altro mondo, mentre oggi quel giovane vive, più o meno, come un suo coetaneo di Roma, Parigi o Berlino. La moda, lo sport, la musica, il cinema e soprattutto internet hanno ridotto le distanze e creato una cultura comune capace di superare gli spazi e le frontiere. L’«altro» non è più un «marziano».
Eppure, ancora oggi, il contatto con persone diverse genera spesso paura e diffidenza e, nel peggiore dei casi, reazioni di ostilità e di razzismo


L’arrivo di migranti provenienti da Paesi lontani causa spesso, nei cittadini dei Paesi ospitanti, fenomeni di rigetto, episodi di rifiuto e di chiusura. L’altro, il «diverso», viene visto come pericolo o come minaccia al proprio stile di vita e al proprio benessere.
La convivenza fra persone di culture diverse pone certamente seri problemi culturali, sociali ed economici, ma occorre comprendere che essa non solo è necessaria, ma possibile purché non si dimentichino alcuni princìpi:
• il rispetto (quello reciproco e quello delle regole giuste);
• la tolleranza;
• l’idea che tutti possono diventare cittadini con eguali diritti e doveri.
I princìpi che ispirano le leggi del nostro Paese sono, in merito, molto chiari.
A tale riguardo, riportiamo due importanti articoli della Costituzione, l’articolo 3 e l’articolo 19.
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (articolo 3).
«Tutti hanno diritto a professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e inoltre di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume» (articolo 19).
I termini elencati qui sotto costituiscono una parte del campo semantico legato all’argomento di questo approfondimento. A coppie o piccoli gruppi leggete queste parole, ricercate nel dizionario quelle che non conoscete e arricchite l’elenco con altri termini che vi vengono in mente.
straniero diffidenza
ostilità
accoglienza uguaglianza fratellanza barbari scambio interazione interculturale integrazione interazione multiculturale tolleranza razzismo condivisione apertura
Utilizzate le seguenti domande per condurre una discussione in classe e confrontare le vostre idee.
1. Che cos’è la «cultura» secondo gli antropologi?
2. L’articolo 3 della Costituzione italiana parla di «pari dignità sociale». Che cosa significa secondo voi questa espressione?





Lezione 1 Le grandi esplorazioni via mare


L’avanzata dei Turchi ottomani rese pericolose le vie tra l’Europa e l’Oriente. Nuove tecniche e strumenti per la navigazione permisero di esplorare rotte sconosciute: tra il 15° e il 16° secolo i traffici commerciali con l’Asia si spostarono nell’oceano Atlantico.
Lezione 2 Asia e Africa tra 15° e 16° secolo
All’inizio del 16° secolo l’Impero ottomano raggiunse la sua massima espansione sottomettendo la Penisola balcanica. In India i Moghul crearono un prospero Impero indiano-musulmano. In Cina dal 1368 regnava la prestigiosa dinastia Ming, mentre in Giappone, dove vigeva ancora il sistema feudale, gli shogun instaurarono governi di tipo militare. L’Africa, bacino di schiavi e di oro, era divisa in due: l’Africa bianca a nord e l’Africa nera a sud, dove esistevano grandi e antichi regni.
Lezione 3 La scoperta del Nuovo mondo
Il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo, convinto di raggiungere le Indie attraverso una rotta occidentale, approdò sul continente americano. L’America deve il suo nome ad Amerigo Vespucci, che per primo si accorse di aver raggiunto un «Nuovo mondo». Nel 1520 Ferdinando Magellano circumnavigò l’America meridionale; la sua spedizione proseguì compiendo, per la prima volta, il giro intorno al mondo. Con il trattato di Tordesillas i portoghesi e gli spagnoli si divisero il controllo dei territori oltremare.
Lezione 4 L’America precolombiana
Nel continente americano vivevano civiltà evolute come i Maya, esperti di matematica e astronomia, e gli Aztechi; nel Sud America vivevano gli Inca, un popolo avanzato dal punto di vista politico, urbanistico ed economico.
Lezione 5 La nascita degli imperi coloniali
L’America fu colonizzata dai conquistadores. Hernán Cortés conquistò il Messico nel 1522, Francisco Pizarro l’Impero inca in Perù nel 1572. La Spagna sfruttò i possedimenti coloniali sotto tutti i punti di vista e la colonizzazione provocò la scomparsa di decine di milioni di indios. I portoghesi occuparono il Brasile e si servirono di schiavi africani come manodopera.
Completa la mappa dell’Unità inserendo le parole mancanti.
Maya – Rotte commerciali – Brasile – Cortés – Inca – Colombo – Asia
Ricerca di nuove
Progressi nella navigazione


rotte commerciali
Spagna
favoriscono
supportata da 1492
Studi di geografia e astronomia
Cortés maya inca
Espansione in e in Africa
Pizarro conquista l’Impero conquista l’Impero azteco e i territori
Asia
nel
Colombo
grazie a spartito tra
SCOPERTA DI UN «NUOVO MONDO»
Portogallo
Occupazione del Tratta degli schiavi dall’Africa
Brasile

1. Indica se le affermazioni sono vere o false.
a. L’Impero ottomano rappresentava uno sbarramento per i commerci fra Europa e Asia. V F
b. Con l’avanzamento dei Turchi le antiche strade conosciute diventarono pericolose e si cercarono nuove vie di collegamento marittimo con l’Oriente.
c. Dall’oceano Atlantico si cercò di giungere nell’oceano Indiano circumnavigando l’Africa. V F
d. Dal continente africano giungevano spezie sempre più rare.
e. Tra XIV e XV secolo si diffuse l’uso della bussola, dell’astrolabio e si realizzarono carte geografiche e portolani più precisi.
f. Le grandi città mediterranee come Genova e Venezia aumentarono i loro guadagni.
g. L’evangelizzazione forzata degli indios portò alla distruzione dei luoghi di culto preesistenti.
h. Gli spagnoli monopolizzarono i traffici commerciali che gestivano la tratta degli schiavi.
i. Le popolazioni precolombiane coltivavano piante sconosciute in Europa.
2. Completa la tabella riguardante l’India inserendo le informazioni che hai studiato.
FONDÒ UN IMPERO DURATA DELL’IMPERO
Babur il conquistatore.
1526-inizio XVIII secolo.
CLIMA E CONDIZIONI NATURALI
Uragani e inondazioni alternati a periodi di siccità.
3. Completa il testo relativo al Giappone.
Agricoltura e allevamento
Metodologia inalterata per secoli: non sono adottati nuovi strumenti perché c’è gran quantità di manodopera.
ECONOMIA
Manifatture Commercio
Artigianato tessile, lavorazione di metalli preziosi e legni pregiati.
mar della Cina feudale
Commercio delle manifatture a mercanti arabi e occidentali.
Non lontano dal grande Impero cinese, circondato dalle acque del , sorgeva il Giappone. Lì, fra il X e il XIII secolo si era affermata una società di tipo : l’imperatore concedeva dei privilegi ai suoi fedeli e nobili guerrieri, i quali proteggevano la popolazione che viveva nel territorio a loro affidato. Di questa nobiltà feudale facevano parte i , che erano dei guerrieri . Con il tempo le famiglie aristocratiche acquistarono un grande potere e finirono per mettere in discussione il potere e il prestigio dell’
samurai professionisti imperatore
4. Indica se le affermazioni sono vere o false.
a. I navigatori inglesi furono i primi a entrare in contatto con i popoli dell’Africa nera. V F
b. Le civiltà africane erano in contatto con i Paesi del Maghreb e con l’Egitto. V F
c. Le principali civiltà africane sorgevano nella zona affacciata sull’oceano Indiano e nella zona occidentale, sulla costa atlantica a nord dell’equatore.
d. Il regno più importante dell’Africa orientale era quello del Ghana.
e. Il Ghana vendeva ai mercanti dell’Africa settentrionale soprattutto tessuti di seta.
f. I rapporti del Ghana con i mercanti dell’Africa settentrionale furono sempre pacifici.
5. Completa la tabella in modo da ricostruire gli aspetti fondamentali delle civiltà amerinde.
Stato/i attuale/i di stanziamento
Messico, Honduras e Guatemala
Messico Ecuador, Perù, Bolivia, Cile e Argentina andina
Economia Politica (sistema di governo) Religione Cultura Città più importante/i
Agricoltura, commercio
Agricoltura
Città-stato indipendenti con a capo un sacerdote
Impero.
Dominio militare su etnie diverse
Agricoltura, pesca, allevamento
Impero con struttura gerarchica
Politeismo Politeismo Politeismo
Profonde conoscenze matematiche e astronomiche. Uso della scrittura.
Uso della scrittura.
Arte e architettura raffinate.
Tikal, Copán, Palenque
Tenochtitlán Cuzco
6. Metti in ordine cronologico i seguenti fenomeni storici, indicando nelle caselle l’ordine di successione con un numero. Individua poi lo schema che li rappresenti adeguatamente scegliendo tra i modelli proposti.
a. Ricerca da parte degli europei di nuove vie per procurarsi spezie, tessuti e altri prodotti.
b. Conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi.
c. Blocco delle vie commerciali verso Oriente.
d. Espansione musulmana.
Abilità ingegneristiche. Non conoscevano scrittura né usavano moneta. 4 2 3 1 X
7. Scrivi la definizione dei seguenti termini.
a. Indie orientali:
Asia sud-orientale.
b. Indie occidentali:
c. Subcontinente:
d. Gerarchia:
e. Indigeno:
f. Encomienda:
Antille e Bahamas.
Grande parte di un continente con elementi geografici caratteristici.
Sistema organizzato secondo un principio di valore e di importanza. Colui o colei che è originario del luogo in cui vive. Forma di amministrazione delle terre e degli uomini in vigore nei vicereami spagnoli in
8. Esegui sulla carta le attività indicate.
• Indica sulla carta muta, utilizzando colori diversi, le aree dove si svilupparono le civiltà amerinde.
• Realizza poi una legenda per spiegare la tua carta storica.
9. Scrivi sul tuo quaderno un breve testo che illustri le imprese di Cristoforo Colombo. Puoi impiegare la seguente scaletta. Soluzione in Guida.
• Stato promotore e sostenitore dell’impresa
• Inizio, durata e conclusione dell’impresa
• Terre che si intendeva raggiungere
• Terre realmente raggiunte
• Aspettative di ricchezza
• Difficoltà dell’impresa
• Successive spedizioni
• Fine di Colombo
Impero azteco Civiltà maya Impero inca America latina.
soluzioni dell’es 8: da riportare sulla carta M I
In questa relazione, il domenicano Bartolomé de Las Casas, famoso per le sue posizioni umanitarie nei confronti degli indios, racconta l’orrore e l’assurda violenza di un’azione militare di un manipolo di conquistadores spagnoli in un villaggio indigeno.

Las Casas
[Giunti in un villaggio] all’improvviso uno spagnolo (nel quale si può pensare fosse entrato il demonio) trae la spada dal fodero, e subito gli altri cento fanno altrettanto; e cominciano a sventrare, a trafiggere e a massacrare pecore e agnelli, uomini e donne, vecchi e bambini che se ne stavano seduti tranquillamente lì vicino, guardando pieni di meraviglia i cavalli e gli spagnoli. In pochi istanti, non rimase vivo nessuno. Entrati allora nella grande casa vicina (poiché tutto era venuto alle soglie di essa), gli spagnoli si misero a uccidere, colpendoli di taglio e di punta, tutti coloro che vi si trovavano; il sangue colava dappertutto, come se fosse stata scannata una mandria di vacche […].
Epoca: XVI secolo

COMPRENDO IL TESTO
A coppie rispondete alle domande dopo aver letto il testo, quindi confrontate le risposte con quelle dei vostri compagni.
1. Che cosa fanno gli spagnoli appena giunti nel villaggio?
2. Che cosa stavano facendo, invece, gli abitanti del villaggio?
3. Chi ispira, secondo il frate che ha scritto questo testo, le azioni degli spagnoli?
4. Rifletti sul documento: la violenza esercitata dagli spagnoli ti sembra commisurata al pericolo che correvano?
5. Da che cosa può dipendere l’uso eccessivo, inutile e mostruoso della violenza indiscriminata?
Utilizzate le seguenti proposte di lavoro per confrontare le vostre idee e opinioni.
Nel secolo scorso sono state raggiunte vette inimmaginabili di violenza a danno non solo dei soldati, ma anche delle popolazioni civili. Per questo motivo, dopo il 1945 gli Stati democratici hanno cercato da un lato di stabilire delle regole dei conflitti bellici, dall’altro di istituire degli organismi, come la Corte internazionale di giustizia dell’ONU o la Corte penale internazionale, che potessero intervenire in caso di palesi violazioni del diritto internazionale, soprattutto in presenza di crimini contro l’umanità.
1. Cercate in internet informazioni sui principali casi di violazione dei diritti umani e di crimini contro l’umanità, con riferimento, ad esempio, alle vicende della ex Iugoslavia o al genocidio del popolo armeno.
2. Riflettete in classe: è sufficiente istituire un tribunale perché il diritto venga rispettato? Di quale altro strumento deve dotarsi la comunità internazionale per affermare e tutelare i diritti dell’uomo?
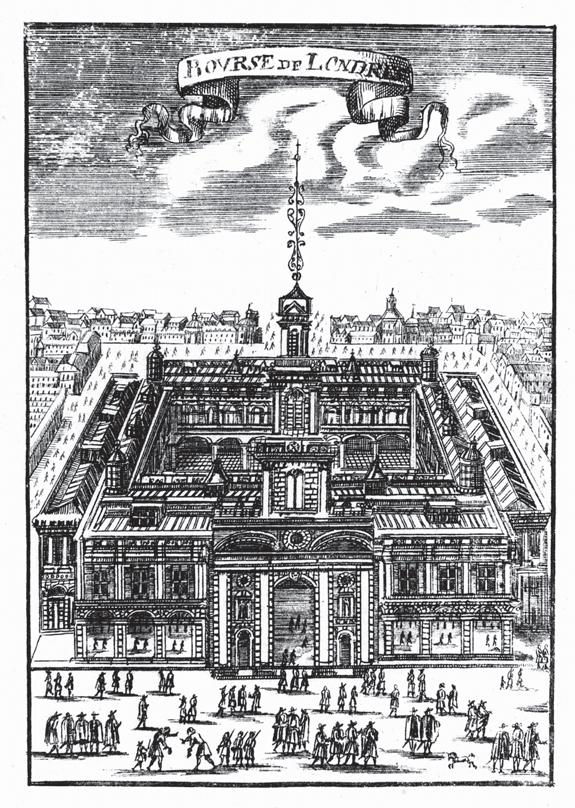


1492
Cristoforo Colombo «scopre» l’America
La «scoperta» dell’America fa aumentare in modo molto significativo gli scambi commerciali ed economici e dà una dimensione mondiale alla vita sociale, economica e politica europea.
I domini dell’imperatore Carlo V comprendono gran parte dell’Europa e le Americhe sottoposte alla colonizzazione spagnola, tanto da far dire che sul suo impero «non tramonta mai il Sole». Carlo V propone una visione universale del potere. Il sogno di un impero universale, però, si scontra con gli interessi delle monarchie nazionali europee, specialmente della Francia, e con l’espansione dell’Impero ottomano, che conquista vasti territori dell’Europa orientale.
1519
Carlo V diventa imperatore
1516
Carlo V re di Spagna
v L’età umanistica e rinascimentale dà all’uomo una rinnovata centralità nell’universo e lo rende padrone del proprio destino.
v La «scoperta» dell’America schiude le porte della penetrazione occidentale nel continente americano. A pagarne il prezzo saranno le civiltà indigene dei Maya, degli Inca e degli Aztechi.
v Le monarchie nazionali si strutturano e si trasformano in attori della scena politica europea.
1521
I Turchi ottomani conquistano la Serbia
1525
Il re di Francia Francesco I sconfitto a Pavia da Carlo V
1526-1534
Prosegue l’espansione dell’Impero ottomano


Carlo V, nipote dell’imperatore Massimiliano I e del re di Aragona Ferdinando I, aveva ereditato i domini asburgici e quelli spagnoli, i quali comprendevano anche parte dell’Italia.

La Francia era stretta dai possedimenti di Carlo V.
1556
Abdicazione di Carlo V in favore del figlio Filippo II e del fratello Ferdinando
Sconfitta turca nella battaglia di Lepanto 1560 1580
1571

All’inizio del XVI secolo il Sacro romano impero comprendeva i domini asburgici di Massimiliano I e principati tedeschi.
Con Solimano I l’Impero ottomano si espanse fino a minacciare i confini del Sacro romano impero.
1600
v I grandi viaggi di scoperta creano una «economia-mondo», un sistema economico e politico che tiene insieme regioni del mondo distanti fra loro, connesse attraverso una fitta trama di scambi e relazioni.
v Grazie a legami dinastici Carlo V diventa prima re di Spagna (e dunque anche dell’impero coloniale americano) e poi, dopo l’acquisizione dei possedimenti asburgici, imperatore di un enorme soggetto politico esteso dall’Europa occidentale a quella orientale.
v L’ambizione di Carlo V di dare vita a un «impero universale» si scontra con la resistenza delle monarchie nazionali, specie della Francia. Alla fine Carlo V rinuncia, dividendo l’impero tra la Spagna, affidata al figlio Filippo II, e il mondo austro-germanico, affidato al fratello Ferdinando.
COMPRENDO IL TESTO
Sottolinea la frase che spiega le ragioni dell’accresciuta importanza degli Stati che si affacciavano sull’oceano Atlantico.

LAVORO SULLA LINGUA
Spiega il significato dell’espressione «perdita di centralità», qui usata a proposito del Mediterraneo.
Perdita di importanza strategica.
Il traffico navale nel porto commerciale di Lisbona, in un’incisione del XVI secolo.
La «scoperta» del Nuovo mondo a seguito delle imprese di Cristoforo Colombo e degli altri navigatori europei fece sì che grandi quantità di materie prime, di nuovi prodotti e di metalli preziosi giungessero sui mercati europei. Questo ampliamento del commercio internazionale, che rese disponibili nuove merci e garantì l’accumulo di enormi ricchezze, ebbe importanti e durature conseguenze sugli equilibri economici e politici mondiali. La prima e più significativa fu la crescita d’importanza degli Stati europei che si affacciavano sull’oceano Atlantico. Questi Stati, infatti, potevano utilizzare non solo rotte più brevi per raggiungere l’America, ma anche nuove rotte lungo le coste dell’Africa, aperte dai vari navigatori dopo che i Turchi avevano occupato le regioni mediorientali (ostacolando così i commerci tra Occidente e Oriente).
La seconda conseguenza, strettamente legata alla prima, fu che il mar Mediterraneo, che per secoli era stato il cuore della civiltà europea, cominciò a perdere d’importanza e di centralità.

La perdita di centralità del Mediterraneo contribuì alla relativa difficoltà di città come Venezia e Genova, che avevano prosperato proprio grazie agli scambi commerciali lungo le rotte mediterranee, e al crescente successo di altri porti:
• nell’Europa del Sud, Lisbona e Siviglia (che fino alla fine del XVII secolo ebbe accesso al mare tramite il fiume Guadalquivir, poi impantanatosi);
• nell’Europa continentale e settentrionale, Londra e Anversa.
Non si deve però pensare a una decadenza generalizzata delle città italiane: Venezia, per esempio, grazie ad accordi stabiliti con i Turchi e agli stretti contatti con i Paesi Bassi e la Spagna, tornò ben presto a occupare un posto di rilievo nel commercio mondiale.

I commerci transoceanici assicuravano guadagni enormi, ma per essere effettuati avevano bisogno di grandi investimenti perché i viaggi intercontinentali costavano molto. Servivano infatti grandi capitali per acquistare le imbarcazioni, pagare gli equipaggi e comprare i beni da scambiare. Per questa ragione, sia in Italia sia in altri Paesi europei, il controllo dei commerci mondiali finì nelle mani di un ristretto numero di potenti famiglie di mercanti. Questi grandi mercanti guadagnavano molti soldi.
A differenza del passato, però, non si limitavano a risparmiarli in vista di tempi peggiori, oppure a spenderli per acquistare beni di lusso, ma ne reinvestivano gran parte, cioè li spendevano in attività produttive con l’obiettivo di aumentare gli affari e ottenere guadagni ancora maggiori, per esempio, acquistavano più merci da rivendere, aprivano manifatture per realizzare in proprio alcuni prodotti, oppure fondavano banche. Il denaro investito, il «capitale», serviva dunque a generare nuova ricchezza. Il sistema economico che si basa sull’investimento produttivo di denaro viene detto «capitalismo». Poiché a quei tempi le ricchezze erano per lo più investite negli scambi commerciali, si parla a questo proposito di capitalismo mercantile
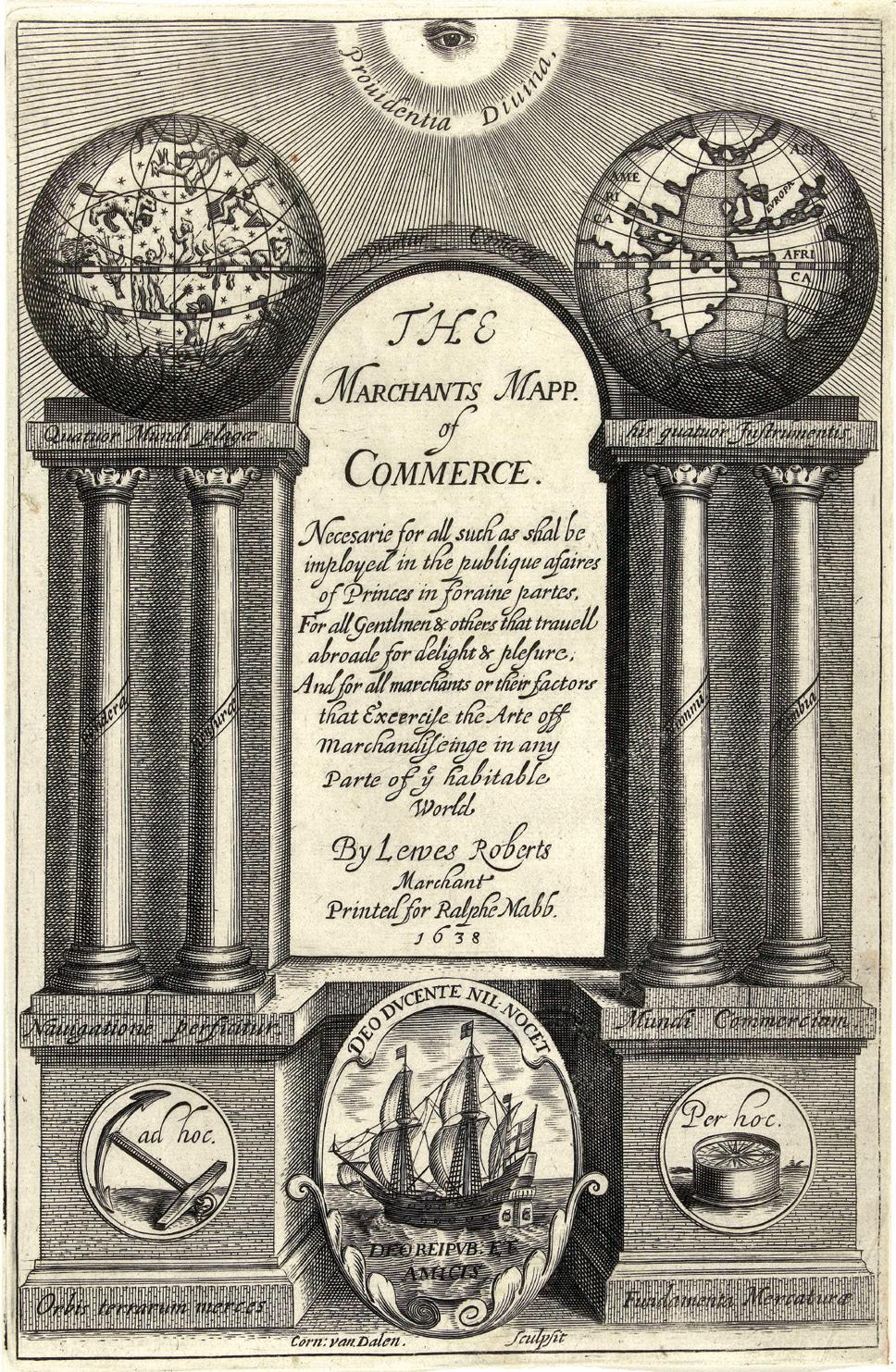
Frontespizio di un volume, pubblicato nel 1638, con informazioni su commercio internazionale, pesi e misure, cambio valute. L’illustrazione presenta elementi simbolo del commercio marittimo: la nave, l’ancora e la bussola.
Manifattura
In questa nuova economia, fondata sulla grande circolazione di denaro legata alle attività mercantili, il ruolo delle banche divenne decisivo: le banche, infatti, erano in grado di prestare ai loro clienti grandi somme di dena ro per effettuare investimenti. Per concedere i prestiti attinge vano al denaro che i loro clienti-risparmiatori depositavano nei loro forzieri, ai quali promettevano un certo interesse. A loro volta, le banche richiedevano degli interessi sul denaro prestato e in questo modo esse stesse si arricchivano enor memente.
Persino i sovrani arrivarono a chiedere denaro ai ban chieri per finanziare le proprie politiche di potenza: il re di Spagna Carlo V, per esempio, si rivolse per un prestito alla banca tedesca della famiglia Fugger, una delle banche più importanti dell’epoca, in occasione dell’elezione imperiale.
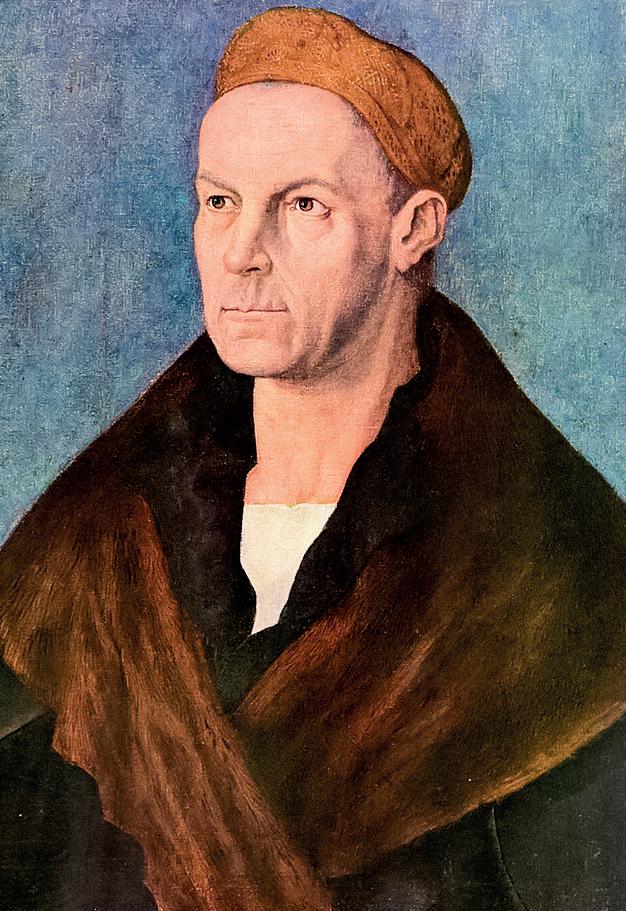
Il nome deriva dall’espressione latina manu facere, ossia «fabbricare», e indica i grandi laboratori artigianali dove il lavoro veniva eseguito manualmente.
LAVORO SULLA LINGUA
Completa la frase scegliendo il connettivo logico-causale corretto fra i tre proposti.
I sovrani europei s’indebitarono con i banchieri, dal momento che/pertanto/ne deriva che le politiche di potenza richiedevano enormi investimenti.
LAVORO SULLA LINGUA
Quali aggettivi qualificativi sono riferiti alla classe della borghesia? Dopo averli individuati scrivi il loro significato.
Dinamica: intraprendente e attiva.
Industriosa: ingegnosa.
Nel XVI secolo la società europea cambiò profondamente.
Dal punto di vista politico, nelle grandi monarchie nazionali che si erano formate in Europa, i re cercarono di rafforzare la propria sovranità e di governare senza dover sottostare alla volontà e agli interessi di altri poteri, per esempio quello dell’aristocrazia feudale o della Chiesa. Per realizzare questo obiettivo, cercarono di ridurre al minimo i privilegi e i poteri che gli aristocratici e gli ecclesiastici si erano assicurati durante i secoli precedenti.
Da un punto di vista sociale, cambiarono i rapporti fra borghesia e nobiltà Il grande sviluppo dei commerci, delle banche e degli investimenti di denaro fece emergere la borghesia come classe più dinamica e industriosa. I borghesi aspiravano ad affiancarsi, e persino a sostituirsi, ai nobili nella vita politica.
I rapporti tra nobiltà e borghesia variano a seconda dei Paesi
La situazione era molto diversa da Paese a Paese:
• in alcuni Paesi l’organizzazione dello Stato era affidata a borghesi, che lavorando come funzionari pubblici erano riusciti a fare carriera e ad accrescere il proprio prestigio sociale;
• in Francia e in Spagna i nobili cercarono di difendere la propria superiorità sociale, rifiutandosi, per esempio, di accettare la ricchezza proveniente dalle attività mercantili oppure consumando un’esistenza sfarzosa, completamente estranea ai principi economici della borghesia (lavoro, profitto e investimento);
• diversa era la situazione in Inghilterra, dove i nobili non erano un ceto chiuso e non vivevano in modo completamente diverso rispetto ai borghesi: gestivano la terra, si occupavano di commerci e accumulavano ricchezze.
Il cambiavalute
Il pittore fiammingo Quentin Metsys (1466 ca.-1530) dipinse Il cambiavalute e sua moglie. La coppia ritratta, vestita con stoffe pregiate, è seduta a un tavolo su cui sono presenti cristalli, perle e monete sparse. L’uomo, un banchiere, tiene in mano un bilancino; la donna tiene con la mano destra il segno su una pagina di un libro di preghiere miniato. Alcuni critici d’arte ritengono che il pittore abbia voluto contrapporre simbolicamente il sacro e il profano.
Rispondi alle domande.
1. In che cosa è impegnato l’uomo con il bilancino in mano?
A pesare i soldi.
2. E la donna?
Sfoglia un libro osservando, con espressione quasi dubbiosa, l’attività dell’uomo.

Tra la fine del XV e l’inizio del XVII secolo l’Europa creò un grande spazio economico costituito da «pezzi» di Asia, America e Africa, che le permise di assicurarsi un grande vantaggio rispetto ad altre regioni del pianeta, dove pure esistevano Stati di grandi dimensioni, spesso caratterizzati da una lunga tradizione di governo (come l’Impero cinese), o da grande forza militare (come l’Impero ottomano).
Attraverso una fitta rete commerciale nel Vecchio continente giungevano dai Paesi extraeuropei materie prime e metalli preziosi: dall’Oriente spezie, tè, seta, legname pregiato, dal Nuovo mondo prodotti prima sconosciuti, come per esempio il cacao e il tabacco, oro e argento.
Come sai già (vedi Unità 1) gli europei ottenevano dal Nuovo mondo materie prime a basso costo attraverso un drastico sfruttamento delle risorse naturali e umane. Ricorderai anche che la manodopera impiegata nei lavori dei campi e nelle miniere era costituita da indios costretti ai lavori forzati e da schiavi comprati in Africa. Più avanti (vedi Unità 5, Lezione 1) ti saranno descritte le caratteristiche di questo deprecabile commercio che legava l’Europa al continente africano
COMPRENDO IL TESTO
Quali continenti erano compresi nello spazio economico creato dall’Europa?
Europa, Asia, Africa, America.
Vecchio continente
Espressione usata per contrapporre l’Europa al «Nuovo mondo», cioè l’America.
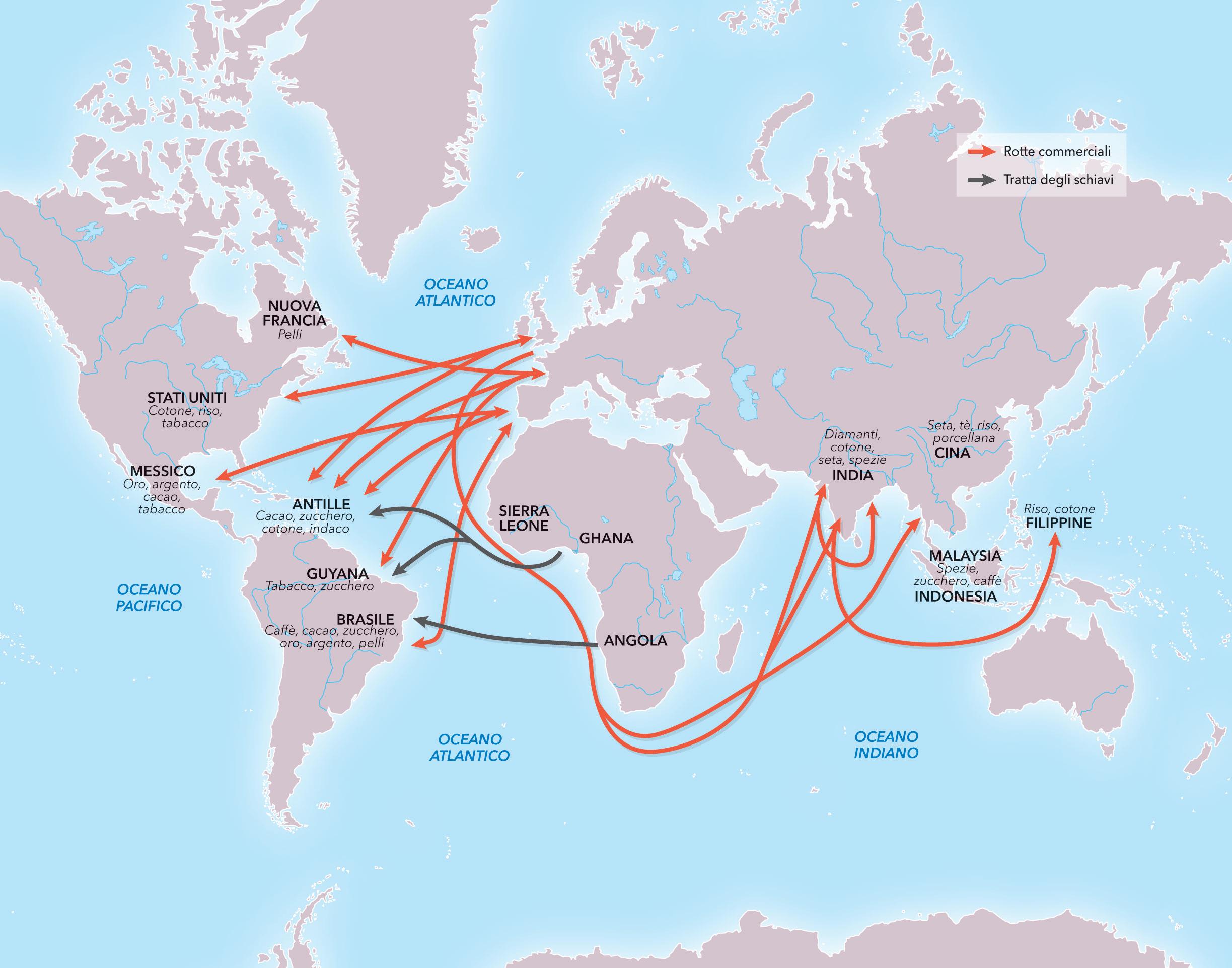
Questo «spazio» si era creato, come già sai, grazie alle scoperte di nuove rotte marittime avviate da Spagna e Portogallo. Ben presto fu gestito con maggior successo da altri Paesi europei, in particolar modo da quelli in cui, come Inghilterra e Olanda, erano maggiormente sviluppate le attività manifatturiere e commerciali. Le materie prime importate venivano trasformate in prodotti finiti che erano poi venduti anche al di fuori del proprio Paese; i mercanti veicolavano inoltre alcune merci da un Paese all’altro prima di importarne nel proprio.
La rete commerciale aveva dimensioni mondiali e diede vita a un’economia che scavalcava i confini degli Stati mettendo in contatto regioni del mondo che le rivalità statali tendevano a dividere e a contrapporre. Per questo motivo si dice che nel XVI secolo nacque una «economia-mondo»: merci, denaro, informazioni, idee circolavano a livello mondiale creando quella rete di scambi mondiali che per certi versi rappresenta una prima versione dell’attuale globalizzazione
SULLA FONTE
L’incontro tra popoli diversi
L’immagine, dipinta sul pannello di un paravento giapponese, fornisce dati molto interessanti sulle relazioni che si instauravano tra i popoli grazie ai commerci. Kano Domi, un’artista orientale, realizzò
l’opera tra il 1593 e il 1600, rappresentando l’arrivo di mercanti portoghesi in Giappone con porcellane, spezie e altri prodotti cinesi. La Cina aveva infatti vietato al Giappone di avere scambi commerciali con le proprie terre, ma la presenza di basi commerciali europee in Estremo Oriente consentiva comunque la circolazione di merci tra i vari Paesi. Come vedevano però i giapponesi questi Nanban, i «barbari provenienti dal Sud»? Un’idea possiamo farcela osservando il dipinto.
Rispondi alle domande.

1. Quali elementi dell’abbigliamento caratterizzano gli europei?
2. Noti un particolare, nei volti, particolarmente accentuato?
3. La raffigurazione ti appare realistica o caricaturale?
4. Che cosa sembra denotare l’atteggiamento dei giapponesi sullo sfondo?
I pantaloni a sbuffo e i cappelli alti e bombati. Il naso. Caricaturale. Curiosità e timore.
L’Europa era al centro di questo sistema di relazioni commerciali: alcuni storici hanno parlato per quell’epoca di «miracolo europeo», che fu la premessa della rivoluzione industriale del XVIII-XIX secolo.
I Paesi in relazione con l’Europa sono stati definiti invece da alcuni «periferie».
Le periferie erano le regioni in cui le attività economiche erano subordinate all’economia del centro. Nella gran parte dei casi, l’Europa riuscì infatti a esercitare una posizione dominante di controllo economico, politico e militare sui Paesi con cui commerciava.
Ma quali furono le ragioni di tale successo? Una delle ragioni del successo europeo fu che nel Vecchio continente si affermò lo Stato nazionale. Solo lo Stato nazionale disponeva di alcuni requisiti fondamentali:
• la dimensione territoriale;
• la forza demografica, cioè il numero di abitanti;
• gli apparati amministrativi in grado di gestire al meglio le proprie risorse umane, economiche e tecnologiche.
Al contrario, né l’antico Sacro romano impero, diviso tra centinaia di principati, vescovati e città più o meno autonome, né gli Stati regionali italiani, né le repubbliche cittadine di Genova e Venezia potevano contare su tutti questi elementi. C’erano inoltre altri fattori che spiegano le ragioni del «miracolo europeo»:
• l’ambiente naturale favorevole, al sicuro dalle ricorrenti catastrofi che sconvolgevano l’Asia o l’Africa (tifoni, piogge torrenziali, siccità ecc.);
• la libertà e l’autonomia dell’individuo, valori morali e sociali elaborati dalla cultura umanistica e rinascimentale;
• la predisposizione all’innovazione tecnologica, grazie anche all’imitazione delle civiltà orientali con le quali gli europei erano da tempo in contatto.
Rielaboro le informazioni
COMPRENDO IL TESTO
Qual era il centro dell’economiamondo?
a Asia.
b Americhe.
c Europa. X
1. Completa la mappa concettuale inserendo correttamente i termini elencati. Attenzione: non tutti sono da utilizzare. politica – Europa – famiglie – investimenti – mercantile – Atlantico – borghesi – banche – commerci
Commerci internazionali nell’oceano e lungo le sue coste
Lunghi tragitti che necessitano di grandi
Poche famiglie gestiscono i Importanza delle
Economia-mondo, che vede al centro l’ verso cui sono dirette tutte le ricchezze Nasce il capitalismo
2. Indica, con un tratto di penna sulla linea del tempo, l’arco temporale caratterizzato dall’economia-mondo.
COMPRENDO IL TESTO
Sottolinea gli indicatori demografici usati nel testo.

Verso la fine del XIV secolo, l’esaurimento delle terribili ondate di peste e di carestie ebbe conseguenze positive sulla popolazione europea, che finalmente cessò di diminuire. Nel XV e nel XVI secolo, anzi, la popolazione europea ricominciò a crescere, sia pure in modo non stabile: la peste, il tifo, il vaiolo e le carestie, infatti, erano sempre in agguato e pronte a falcidiare la popolazione, ma a differenza di quanto era avvenuto nel XIV secolo diventarono fenomeni più localizzati, che riguardavano di volta in volta alcune regioni europee, ma non tutto il continente.
Grazie a queste novità, alla fine del XVI secolo l’Europa giunse a contare complessivamente tra gli 80 e i 100 milioni di persone. Le condizioni di vita della popolazione europea, tuttavia, continuavano a essere molto difficili:
• la vita media della popolazione europea era molto bassa (34 anni per le donne, solo 28 per gli uomini);
• la mortalità infantile era molto elevata (20-25% dei nati).
LAVORO SULLA LINGUA
Espressione idiomatica è il termine tecnico per indicare un «modo di dire». Individua nel testo l’espressione idiomatica presente.
«Ritorno alla terra».
Nel XVI secolo, in Europa, l’agricoltura era l’attività più praticata e la principale fonte di ricchezza. Le città, grazie al commercio e all’artigianato, erano cresciute e si erano certamente arricchite, ma non erano ancora riuscite a sostituire le campagne come motore principale della vita economica.
A dimostrazione della centralità della terra nella cultura e nella società della prima età moderna, nel XVI secolo anche molti mercanti di città investirono parte dei loro capitali nelle attività agricole. Questi investimenti favorirono il miglioramento delle tecniche agricole ma, soprattutto, l’aumento dell’estensione dei terreni coltivati. Il fenomeno fu talmente consistente da indurre gli storici a parlare di un vero e proprio «ritorno alla terra», di cui furono protagonisti soprattutto i ceti urbani e borghesi.
Pieter Bruegel il Vecchio (1525/1530 ca.-1569), il grande pittore fiammingo noto per la cura con cui descriveva persone, oggetti e attività del suo tempo, nel dipinto Fienagione offre una preziosa testimonianza di come si svolgeva il lavoro nei campi nel XVI secolo.
Leggi attentamente le seguenti didascalie e riporta il numero che le contraddistingue sull’immagine corrispondente. L’esercizio è avviato.
1. I contadini tagliano l’erba con la falce, l’ammucchiano e la lasciano seccare al sole.
2. I contadini raccolgono il fieno, cioè l’erba essiccata da usare come nutrimento per gli animali, e lo caricano su un carro.
3. Donne si recano al campo con il rastrello per ammucchiare l’erba tagliata.
4. Un uomo affila la falce con uno strumento detto «cote», una pietra che i contadini tenevano in genere appesa alla cintura.

La fase di crescita demografica determinò l’aumento del fabbisogno alimentare, cioè della produzione di cibo, sia vegetale sia animale. Per questo motivo era necessario:
• aumentare l’estensione dei campi coltivati;
• aumentare la produttività, cioè la resa per ettaro dei campi.
Fra i nuovi prodotti importati dall’America, il mais avrebbe potuto prestarsi allo scopo, visto che la sua resa per ettaro è di gran lunga superiore a quella del frumento, ma la sua produzione venne avviata in Europa solo a partire dal XVII secolo. Anche il riso, che pure era conosciuto già da tempo, non era ancora molto diffuso nel continente europeo.
Di fronte alla crescente domanda di cibo, i proprietari terrieri adottarono la soluzione più semplice: riservarono la maggior parte dei terreni coltivati ai cereali tradizionali come il frumento, l’orzo e la segale. La produzione, però, risultò lo stesso insufficiente. Lo squilibrio tra domanda e offerta di beni alimentari (la domanda era nettamente superiore all’offerta) ebbe come conseguenza il notevole aumento dei prezzi dei prodotti agricoli. L’aumento dei prezzi riguardò certamente i prodotti agricoli, ma finì per investire l’insieme della produzione manifatturiera. Il fenomeno fu così rilevante che gli storici parlano di «rivoluzione dei prezzi».
COMPRENDO IL TESTO
Perché l’offerta di cibo non riusciva a soddisfare la domanda? Scegli le opzioni corrette.
a Perché la popolazione era in forte crescita.
b Perché il mais introdotto dall’America non aveva alte rese.
c Perché il clima distrusse i raccolti.
d Perché i proprietari terrieri non furono capaci di distribuire in modo adeguato le coltivazioni nei loro possedimenti.
e Perché le coltivazioni di riso, a più alto rendimento rispetto al frumento, erano poco diffuse. X
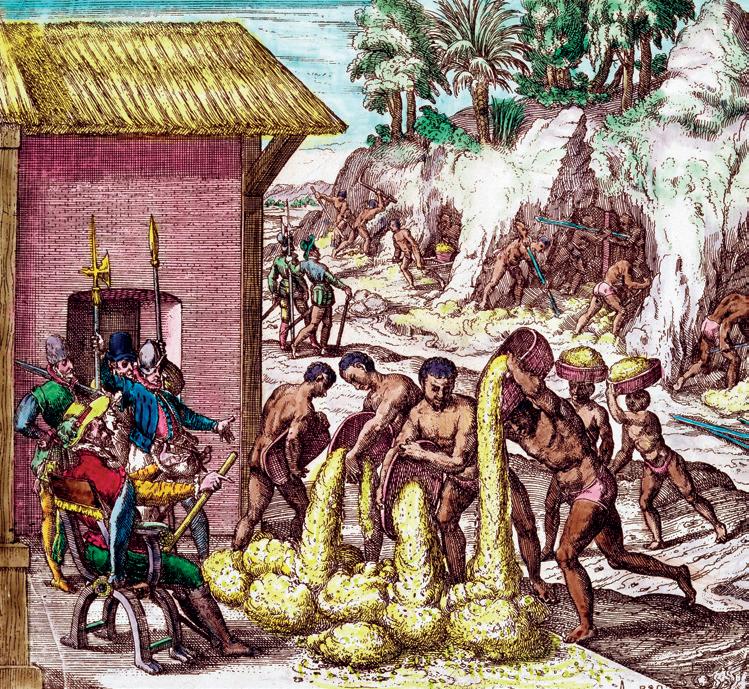
L’afflusso di metalli preziosi dall’America ha grandi conseguenze sulla
La crescita generalizzata dei prezzi fu causata non solo dall’aumento della domanda di cereali, ma anche dalle grandi quantità di metalli preziosi che affluivano in Europa dalle miniere americane. La maggiore disponibilità di metalli preziosi, infatti, faceva aumentare la quantità delle monete in circolazione: l’aumento della moneta in circolazione, però, diminuiva il suo potere d’acquisto. Inoltre, se i beni richiesti erano scarsi, il loro prezzo saliva; così, la quantità di denaro che prima permetteva di comprare un determinato bene, ora non era più sufficiente.
Nel linguaggio economico, la perdita del potere d’acquisto della moneta si chiama inflazione.
L’inflazione del XVI-XVII secolo danneggiò tutti coloro che percepivano un reddito fisso, cioè i lavoratori salariati, perché i compensi del loro lavoro (che erano relativamente fissi) non crescevano o crescevano meno di quanto crescessero i prezzi. A ricavarne un vantaggio, invece, furono soprattutto i mercanti perché potevano aumentare i prezzi delle merci vendute, ricavandone maggiori guadagni.
Sottolinea nel testo la parte in cui si spiega la differenza tra il fenomeno della povertà durante il Medioevo e nella prima età moderna.
In questa situazione economica aumentò sensibilmente il numero dei poveri . I poveri erano sempre esistiti, ma nel Medioevo molti contadini con scarsi mezzi di sostentamento potevano utilizzare terre comuni per coltivare o per cacciare, far pascolare il bestiame, fare legna, raccogliere frutti sponta nei.
Dal XV secolo, e poi sempre più spesso nel XVI secolo, le terre comuni (o campi aperti) cominciarono a essere trasformate in proprietà privata e a essere recintate per impedire che la popolazione vi entrasse. La conseguenza fu molto pesante: in caso di carestia o di perdita di lavoro i contadini non poterono più fare affidamento su di una fonte alternativa di sopravvivenza. Fu così che aumentarono i poveri, costretti a una vita di vagabondaggio, elemosina o furto.

La povertà si trasformò in un vero problema sociale, per affrontare il quale le autorità cittadine adottarono provvedimenti tra cui la «reclusione» dei poveri in ospizi (che assomigliavano a vere e proprie carceri), dov’erano obbligati a lavorare, oppure la concessione di chiedere l’elemosina solo se in possesso di un’apposita licenza.
La Spagna era la principale potenza economica e politica dell’Europa del XVI secolo. Questo primato le era assicurato dalle immense risorse di cui disponeva nelle terre americane. Tuttavia, l’economia spagnola mostrava gravi segni di debolezza. Gran parte delle risorse provenienti dal Nuovo mondo, infatti, veniva consumata per finanziare lo stile di vita dispendioso adottato dalla nobiltà. Per dominare i territori conquistati, inoltre, servivano mezzi eccezionali ed eserciti numerosi. La monarchia spagnola, dunque, fu costretta a indebitarsi con i banchieri genovesi, olandesi o fiamminghi e spesso non fu nemmeno in grado di restituire i prestiti.

Nei Paesi Bassi meridionali (corrispondenti all’incirca all’attuale Belgio) sorgevano numerose città che si erano arricchite grazie ai traffici commerciali e alle attività artigianali. Anversa, in particolare, divenne nel XVI secolo sede di uno dei principali mercati europei e si affermò come una delle grandi «capitali» dell’economia-mondo.
Nelle città dell’Europa settentrionale in cui si svolgevano intensi commerci, oltre ad Anversa soprattutto Londra o Amsterdam, si aprirono le prime Borse, cioè istituzioni specializzate nelle quali, come accade anche oggi, si fissava il prezzo delle merci e il valore di scambio delle diverse monete.
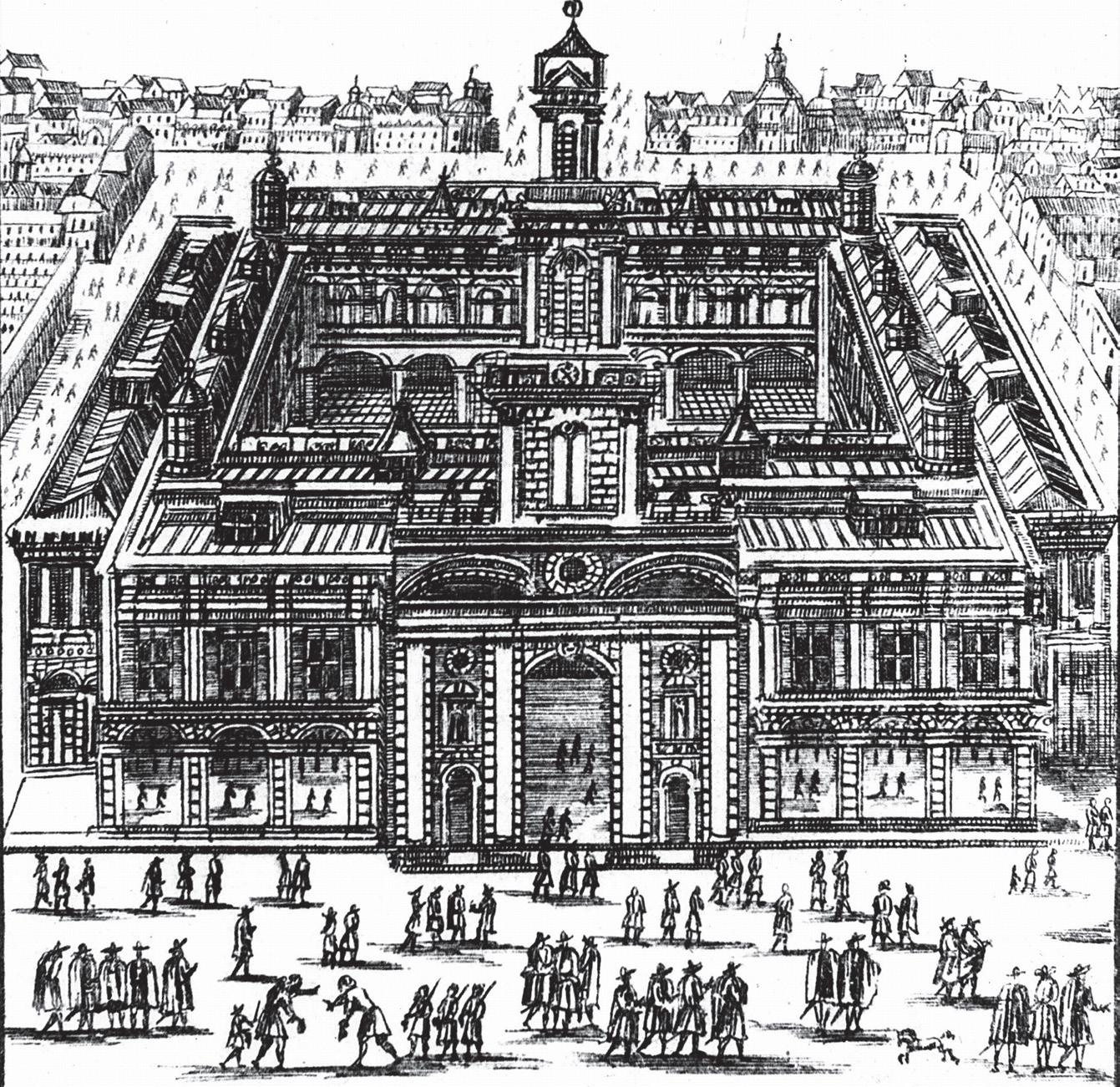
Quali settori dell’economia consentirono la crescita di città dell’Europa settentrionale come Anversa, Amsterdam, Londra?
La prima Borsa (la Royal Exchange) di Londra fu fondata nel 1565. L’illustrazione mostra l’edificio ricostruito nel XVIII secolo in luogo di quello distrutto dall’incendio di Londra del 1666. Anche questa costruzione subirà la stessa sorte nel XIX secolo. Commercio e finanza.
DENTRO LA STORIA
Anversa città libera
Anversa fu la città in cui meglio si realizzò il concetto moderno di libertà, soprattutto in senso economico.
La libertà di fare affari
Nell’Alto Medioevo libertà significava autonomia delle città dall’Impero e dalla Chiesa; nel XVI secolo significò possibilità di fare affari, industriarsi, commerciare, cambiare monete, investire, stimolare la concorrenza, abbattere i monopoli.
La città delle opportunità
Mercanti, banchieri e imprenditori, fiamminghi ma anche inglesi, olandesi, italiani, tedeschi, spagnoli, francesi e portoghesi, trovavano in Anversa non la città dei divieti e dei privilegi, ma la città delle opportunità. Ad Anversa chiunque poteva stabilirsi in città e fare affari, non occorrevano mediatori, né licenze. Il tipografo francese Christophe Plantin (1520-1589) ci ha lasciato una testimonianza in proposito:
«Secondo me, nessuna città al mondo poteva offrirmi maggiori facilitazioni per esercitare l’industria che avevo in animo. L’accesso alla città è facile; al suo mercato confluiscono varie nazioni; vi si trovano inoltre tutte le materie prime indispensabili per l’esercizio della mia arte; vi si incontra senza fatica per tutti i mestieri una mano d’opera che si addestra in poco tempo».
Al centro dello spazio economico europeo
Ma la vera originalità di Anversa fu che, più di Venezia, Genova e Bruges, essa seppe ampliare al massimo lo spazio economico nel quale agiva: era il centro di un sistema che metteva in collegamento parti lontane del globo in un solo sistema di produzione e di scambio. I suoi confini urbani erano aperti a tutti ed essa d’altra parte allargava i propri confini in modo illimitato.

Le ricchezze dal Nuovo mondo arrivano ad Anversa
Gli agenti commerciali di Anversa erano presenti a Cadice e a Lisbona, i porti in cui le merci del Nuovo mondo toccavano le coste europee. Essi compravano le derrate e le trasferivano al Nord, dove le immettevano nel circuito commerciale e produttivo. E così, anche se la Spagna aveva il monopolio dei commerci con il Nuovo mondo, Anversa partecipava con un ruolo di primo piano al commercio delle risorse americane e ne traeva grandi guadagni.
La mappa di Anversa, risalente al 1572, suggerisce l’intensità dei traffici nel suo porto.

Nel XVI secolo l’Italia centro-settentrionale aveva un ruolo di primissimo piano nell’economia europea. Le città italiane erano tra le più prospere d’Europa. Oltre all’agricoltura, nell’Italia centro-settentrionale si erano sviluppate la lavorazione della lana e della seta, attività che procuravano da vivere a circa metà della popolazione cittadina. Molto intensi e redditizi erano i commerci: i tessuti italiani, per lo più destinati all’esportazione, facevano arrivare grandi ricchezze. Oltre alle manifatture tessili fiorivano anche le lavorazioni metallurgiche, le vetrerie, si diffondevano le tipografie e le attività legate all’editoria. I banchieri italiani, inoltre, continuavano a essere fra i più influenti d’Europa.
Verso la fine del XVI secolo, però, l’economia italiana cominciò a declinare. L’Italia non solo risentì economicamente dell’apertura delle rotte atlantiche che toglievano centralità al Mediterraneo, ma a causa della sua divisione in piccoli Stati divenne terra di conquista da parte dei più grandi Stati nazionali europei (Spagna e Francia) e fu assoggettata per lunghi decenni al dominio spagnolo.
Rielaboro le informazioni

Abito del XVI secolo. L’esportazione dei manufatti tessili prodotti in città come Genova, Lucca, Firenze, Milano, Venezia, Bologna fu una delle voci più importanti dell’economia italiana fino alla prima metà del Cinquecento.
1. Completa la mappa concettuale inserendo correttamente i termini elencati. Attenzione: non tutti sono da utilizzare. cereali – Seicento – demografica – tipografie – monete – commerci – prezzi – manifatture – declino – Cinquecento –vetrerie – salari – beni – banche
Crescita
Aumenta la richiesta di
Aumenta la richiesta di
Inflazione, cioè aumento dei
Individuo i nessi di causa-effetto
2. Completa lo schema relativo a cause ed effetti.
Crescita demografica
Più bocche da sfamare
Afflusso di oro e argento dall’America
Grande quantità di monete in circolazione
In Europa:
• crisi in Spagna
• emerge il Nord Europa
In Italia:
• fioriscono le , le e le
Inflazione demografica beni monete prezzi manifatture vetrerie
• verso la fine del incomincia una fase di
Cinquecento declino banche
Maggiore richiesta di prodotti agricoli
Aumento della richiesta di beni da acquistare
Coltivazione di cereali
Rialzo dei prezzi
LAVORO SULLA LINGUA
Individua il verbo, nella forma di gerundio, che descrive la condizione dei grandi Stati nazionali europei.
Accanto al Sacro romano impero si rafforzano gli Stati nazionali

Il XVI secolo offriva un panorama politico molto complesso, nel quale convivevano elementi di grande «modernità» ed esperienze antiche: da un lato si andavano rafforzando i grandi Stati nazionali (come la Francia, l’Inghilterra e la Spagna), dall’altro, nel cuore dell’Europa continentale, sopravviveva il Sacro romano impero

Ritratto postumo di Carlo V a cavallo, realizzato all’incirca nel 1620 dal pittore fiammingo Antoon van Dyck. Rafforzando.
COMPRENDO IL TESTO
In quali continenti si estendeva l’impero di Carlo V? Europa e Americhe.
Il Sacro romano impero, però, era una realtà politica molto diversa da quella creata sette secoli prima da Carlo Magno. Dentro i suoi confini, infatti, si erano affermati dei veri e propri Stati, come i Ducati di Baviera, di Brandeburgo o di Sassonia, che avevano stabilito un rapporto molto autonomo nei confronti dell’imperatore. Quest’ultimo era nominato da sette principi elettori e ormai da molto tempo veniva scelto tra i membri della famiglia degli Asburgo
L’imperatore Massimiliano I d’Asburgo voleva ampliare i territori sottoposti alla sovranità della sua famiglia. Per realizzare tale obiettivo, ricorse a un’efficace politica matrimoniale, cioè ad alleanze basate su legami matrimoniali tra le maggiori dinastie europee. Massimiliano, infatti, fece sposare suo figlio Filippo con la principessa spagnola Giovanna, figlia di Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia. Da questo matrimonio, nel 1500, nacque Carlo d’Asburgo
Alla morte del nonno materno (nel 1516) Carlo divenne re di Spagna (e delle colonie americane), poiché la madre, già vedova di Filippo, era stata giudicata affetta da problemi psichici. Alla morte del nonno paterno (nel 1519) ereditò anche i domini degli Asburgo (Austria, Regno di Boemia e Paesi Bassi), ritrovandosi a capo di un territorio vastissimo Ciò destava grandi timori in molti Stati europei, per questo motivo, alla morte di Massimiliano I, il re d’Inghilterra Enrico VIII, il duca di Sassonia Federico e il re di Francia Francesco I si opposero in ogni modo all’elezione di Carlo a imperatore. Francesco I, soprattutto, si sentiva minacciato perché il regno di Francia, stretto tra Spagna e Germania, era praticamente circondato dai possedimenti degli Asburgo.
Per conquistare il trono imperiale Carlo comprò allora il favore dei principi elettori con un prestito ottenuto dai banchieri Fugger e, nel giugno 1519, fu eletto con il nome di Carlo V.
L’impero di Carlo V
La carta mette bene in evidenza l’estensione dei domini di Carlo V e il modo in cui ne entrò in possesso: alcuni territori li ebbe in eredità, altri li ottenne militarmente, altri ancora adottando la «politica matrimoniale», secondo una consuetudine diffusa tra i regnanti.
Rispondi alle domande.
1. Quali territori erano compresi nell’eredità spagnola?
2. Quali territori rientravano all’interno dei confini del Sacro romano impero?
Austria, Moravia, Slesia, Boemia, Ducato di Milano, Franca Contea, Paesi Bassi. Regno di Spagna, Regno di Napoli, Regno di Sicilia, Regno di Sardegna.

Dopo la pace di Lodi (1454), gli Stati italiani avevano vissuto alcuni decenni di tranquillità, soprattutto grazie all’abile azione diplomatica di Lorenzo il Magnifico, definito «l’ago della bilancia» della politica italiana. Quando però, nel 1492, Lorenzo morì, le reciproche ostilità fra gli Stati italiani tornarono a infiammare la penisola. La rinnovata instabilità politica diede nuovamente il pretesto agli Stati stranieri per intervenire in Italia, sostenendo questo o quell’attore politico ma, in realtà, imponendo i loro interessi di potenza. Il primo a muoversi fu il re di Francia Francesco I: sulle orme del suo predecessore Luigi XII, nel 1499 Francesco I (1494-1547) strappò agli Asburgo il Ducato di Milano, muovendo alla conquista dell’Italia settentrionale. A fermarlo fu Carlo V: nel 1525, a Pavia, Francesco I finì prigioniero dell’imperatore.
Il sacco di Roma

Una volta riacquistata la libertà, nel 1526, Francesco I tornò a contrastare con tutte le sue forze l’impero e per farlo si alleò con gli altri Stati che erano ostili a Carlo V (Firenze, Venezia, Genova, il Regno d’Inghilterra e lo Stato della Chiesa). Insieme ad essi costituì la Lega di Cognac (1526), detta anche «Lega santa» a causa della presenza del papa. Contro la Lega Carlo V inviò in Italia un esercito di mercenari, chiamati lanzichenecchi, che nel 1527 sottoposero Roma a un violento saccheggio, passato alla storia come il «sacco di Roma». Nel 1529, con la pace di Cambrai, Francesco I dichiarava di rinunciare definitivamente ai domini italiani.
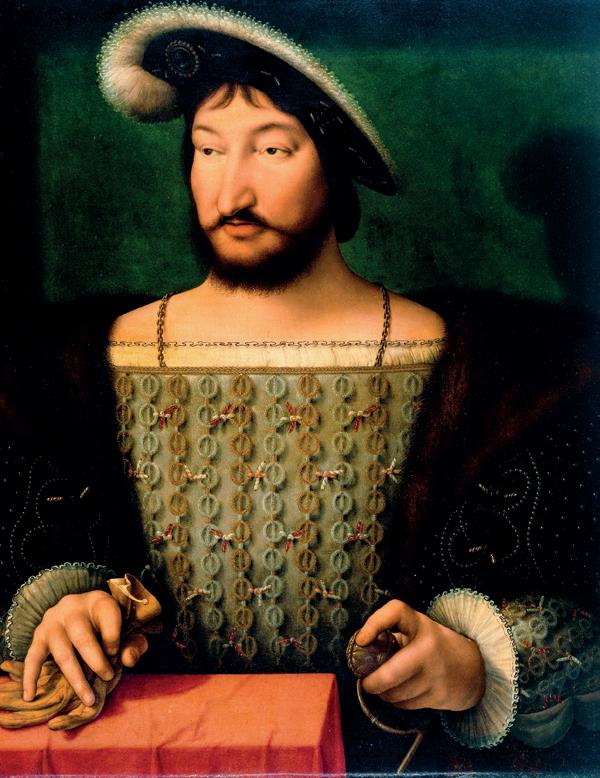
Con questo termine erano chiamati i soldati mercenari tedeschi. In tedesco il nome significa «servo» (knecht) «del paese» (Lands). Lanzichenecchi
I lanzichenecchi avanzano non ostacolati
Nella primavera del 1527 un esercito mercenario tedesco, composto di 18 000 lanzichenecchi, varcò le Alpi puntando verso Roma. Giovanni de’ Medici, detto «Giovanni dalle Bande nere», parente del papa Clemente VII e al cui servizio combatteva, tentò di fermarle nel mantovano, ma fu ferito mortalmente da una pallottola.
I lanzichenecchi saccheggiano Roma
Il 6 maggio le truppe al soldo dell’imperatore giunsero dinanzi alla «Città eterna» e misero sotto assedio Castel Sant’Angelo, dove si era rifugiato il papa.
COMPRENDO IL TESTO
Spiega le ragioni dell’ostilità della Francia nei confronti del sogno dell’impero universale di Carlo V.
Paura dell’accerchiamento.
Da quella fortezza lo scultore Benvenuto Cellini riuscì a uccidere con una fucilata il capo degli imperiali, Carlo di Borbone.
Privi del controllo del Borbone, i lanzichenecchi, da tempo senza paga, si abbandonarono a violenze e ruberie. Alti prelati, semplici preti, monache e migliaia di cittadini furono uccisi o brutalmente torturati; molte chiese furono devastate, i tesori d’arte profanati: il saccheggio durò circa nove mesi. L’evento fu sconvolgente e rese manifesta la debolezza della politica italiana. Da quel momento le sorti della penisola furono ancor più nelle mani delle potenze straniere.
Carlo V coltivava un progetto ambizioso: instaurare su tutti i suoi vastissimi domini un impero universale sotto la reggenza degli Asburgo. Numerosi fattori, però, ostacolavano la realizzazione di questo progetto:
• innanzitutto, l’ostilità della Francia: i sovrani francesi erano pronti ad allearsi con tutti i nemici di Carlo, compresi i Turchi, pur di spezzare l’accerchiamento dei domini asburgici;
• in secondo luogo, le rivendicazioni di autonomia dei principi tedeschi: essi, nonostante la comune identità germanica, rifiutavano un controllo troppo stretto da parte dell’imperatore;
• infine, la costante minaccia dei Turchi lungo i confini orientali dell’impero. Inoltre (come vedremo nella prossima Unità), in Germania e in altri regioni europee si stava sviluppando un movimento religioso, la Riforma di Martin Lutero, che avrebbe rotto l’unità religiosa dell’impero, portando Carlo V a scontrarsi con i principi tedeschi che avevano abbracciato la causa luterana.
Da quando era salito al trono, Carlo V aveva dovuto affrontare continue guerre e gravi tensioni interne all’impero. Per queste ragioni, si convinse che il progetto dell’impero universale non era realizzabile. Stipulò allora una tregua con la Francia e nel 1556 abdicò, cioè abbandonò volontariamente il trono, e divise il suo immenso impero in due parti:
• al fratello Ferdinando passò il titolo imperiale, i territori dinastici degli Asburgo, la corona di Boemia e quella d’Ungheria (acquisita dopo il 1526);
• al figlio Filippo II (1527-1598) diede la corona di Spagna, i possedimenti in Italia, i Paesi Bassi e le colonie americane.
L’abdicazione di Carlo V fallì nell’intento di riportare la pace in Europa: le ostilità tra la Francia di Enrico II e la Spagna di Filippo II, infatti, non terminarono. Nel 1557 le truppe spagnole, guidate dal duca Emanuele Filiberto di Savoia, sconfissero i francesi nella battaglia di San Quintino (nella Francia del Nord). Nel 1559, con la pace di Cateau-Cambrésis, la Spagna vedeva riconfermato il controllo sulla Penisola italiana. I suoi possedimenti comprendevano: Milano, Regno di Napoli, Sicilia e Sardegna.

Rielaboro le informazioni
1. Completa la mappa concettuale inserendo correttamente i termini elencati. Attenzione: non tutti sono da utilizzare. Francesco I – turca – autonomia – Inghilterra – impero – abdica – progetto – araba – principi tedeschi – feudatari tedeschi
L’opposizione di
Carlo V vuole creare un universale, ma ci sono vari ostacoli
Mi oriento nel tempo
La minaccia ai confini orientali
2. Completa la linea del tempo con le informazioni mancanti.
Le rivendicazioni di da parte dei 1519
Carlo V diventa 1556
Sacco di 1529 Cambrai impero
Carlo V 1559 Pace di 1527
Francesco I turca abdica autonomia feudatari tedeschi imperatore
Carlo V e divide l’impero
Roma Pace di abdica CateauCambrésis
Nel testo sono nominate quattro città capitali del mondo attuale. Quali? Di quali Stati sono capitali?
Belgrado (Serbia), Budapest (Ungheria), Vienna (Austria), Baghdad (Iraq).


Quasi contemporaneamente all’ascesa al trono imperiale di Carlo V, la guida dell’Impero ottomano, che minacciava i confini orientali dell’Occidente, fu assunta da Solimano I (1494-1566). Con Solimano, detto il Magnifico, l’Impero ottomano raggiunse il culmine del suo splendore e ampliò enormemente i suoi confini:
• nel 1521 i Turchi presero Belgrado e portarono a termine la conquista della Serbia;
• nel 1522 s’impadronirono dell’isola di Rodi, una roccaforte cristiana;
• nel 1526, dopo la battaglia di Mohàcs, occuparono Budapest e buona parte dell’Ungheria;
• nel 1529 giunsero persino ad assediare Vienna, senza però riuscire a espugnarla.

A questo punto Solimano volse le sue conquiste a Oriente, verso l’Iran: attaccò i Persiani, nemici secolari degli Ottomani, e nel 1534 riuscì a conquistare Baghdad. Nello stesso tempo furono annessi nell’impero vasti territori del Nord Africa
L’Impero ottomano
Al culmine della sua potenza l’Impero ottomano si estendeva su gran parte del Medio Oriente, dell’Africa settentrionale e dell’Europa orientale.
Rispondi alla domanda.
• Tenendo conto delle informazioni nella legenda, quale sultano arrivò a minacciare maggiormente, con la sua espansione, il Sacro romano impero?
Solimano I il Magnifico.
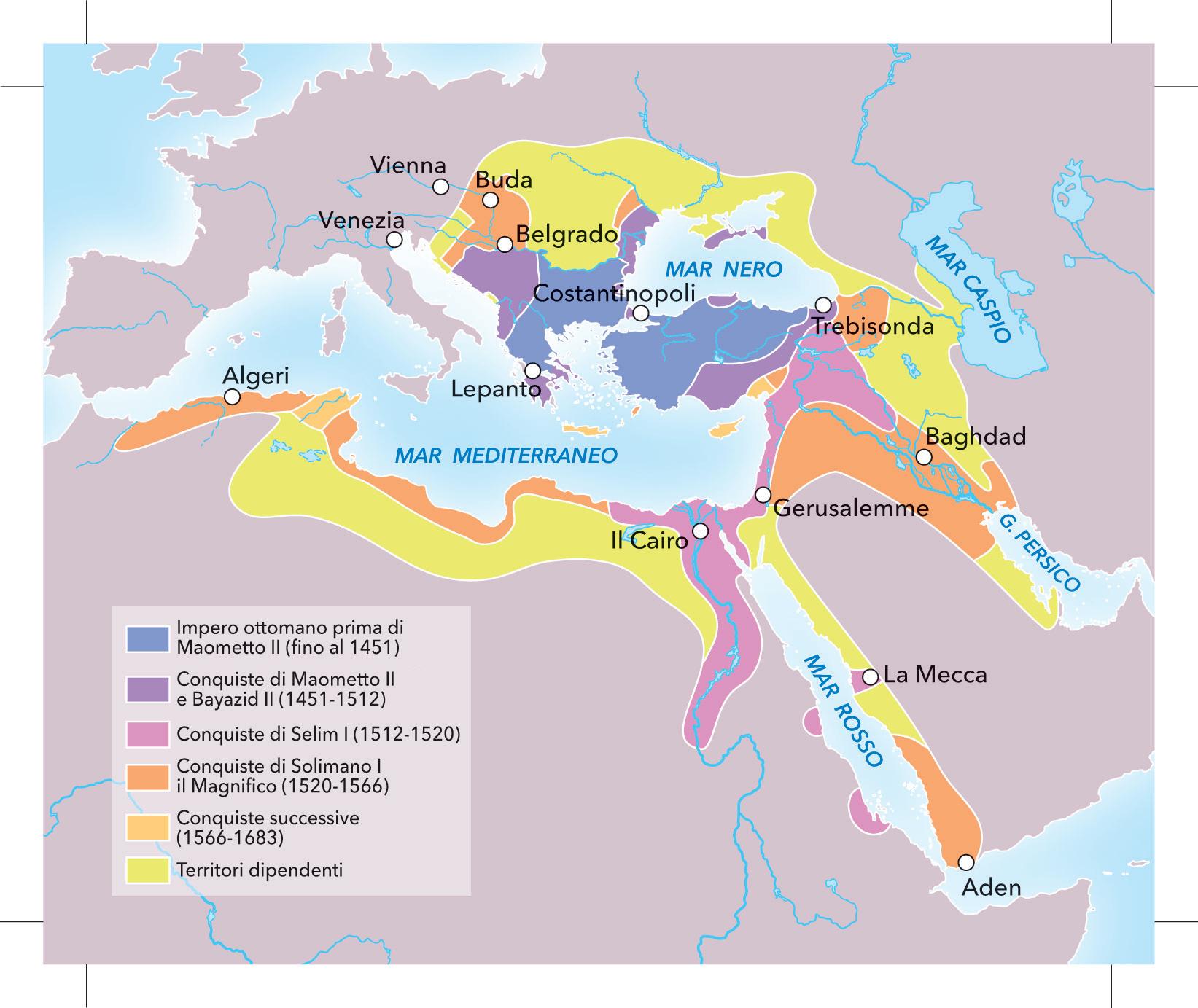

Gli Ottomani crearono un impero accentrato ma tollerante
Nel grande impero conquistato da Solimano il Magnifico vivevano diversi popoli, si parlavano molte lingue e si professavano varie religioni. Per riuscire a governare un territorio così vasto e una realtà etnica tanto complessa, il grande sultano divise l’impero in province, ognuna delle quali era governata da un suo funzionario
Grazie alle tasse che i funzionari imperiali riscuotevano nelle varie province, Solimano poteva sostenere le ingenti spese per mantenere e armare l’esercito, così ampio e ben organizzato da essere il più potente dell’epoca.
Dal punto di vista religioso, gli Ottomani mostrarono una certa tolleranza e un certo rispetto per le fedi religiose diverse dalla loro. Come avevano fatto i califfi musulmani prima di loro, lasciarono ai sudditi non musulmani la libertà di professare la propria religione e si limitarono a imporre loro una tassa, la cosiddetta Jizya
L’impero era diviso in province (dette «Sangiaccati») governate da funzionari.
Sottolinea il complemento di mezzo che indica che cosa permetteva a Solimano di sostenere ingenti spese.
La corte di Solimano il Magnifico.
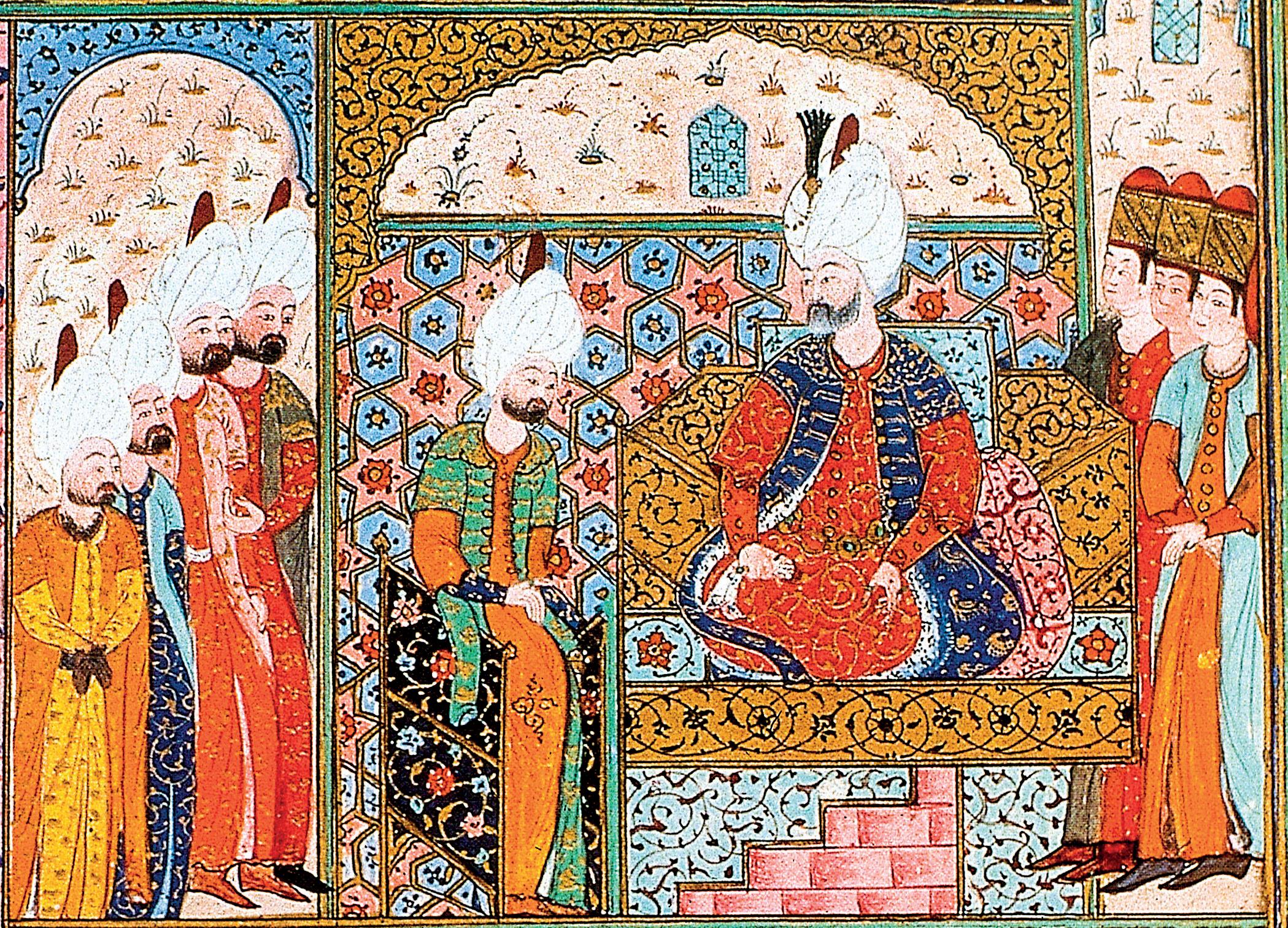
Il Gran Visir aveva un ruolo simile a quello del Primo ministro degli Stati moderni: si occupava soprattutto di questioni militari ed economiche.
Al tempo di Solimano il Magnifico il sovrano dell’Impero ottomano era chiamato sultano, che in arabo significa «forza», «autorità».
( L’Impero ottomano
COMPRENDO IL TESTO
Quali figure misero in pericolo il potere dei sultani che successero a Solimano I?
Visir e giannizzeri.
Dopo Solimano, i suoi successori cominciarono a perdere potere rispetto ai loro funzionari, i visir, o ai comandanti dei giannizzeri, il corpo speciale di soldati a difesa del sultano e del suo patrimonio. Questo corpo era formato, in origine, da giovani arruolati forzatamente, perlopiù cristiani in giovanissima età, tolti alle loro famiglie ed educati alla religione musulmana, di cui divennero anche i difensori più fanatici. Con il tempo, grazie al prestigio e all’importanza ricoperta da questa milizia nell’esercito, i giannizzeri misero in atto ribellioni per ottenere maggior benessere e privilegi. Nel XVII secolo riusciranno in alcune occasioni anche a destituire gli stessi sultani.

La debolezza interna dell’impero fu aggravata da una pesante sconfitta militare: nel 1571 i Turchi attaccarono la città di Famagosta, nell’isola di Cipro, che era allora un dominio di Venezia.
La città veneta, alleata al papato e alla Spagna, si scontrò con gli Ottomani nelle acque del golfo di Lepanto, in Grecia. Entrambe le forze misero in campo una potente flotta: lo scontro durò poche ore, ma fu sanguinosissimo e la flotta europea sconfisse duramente quella turca, dimostrando che, se gli europei combattevano uniti, erano in grado di opporsi ai Turchi.
L’Occidente cattolico visse l’evento come la vittoria della cristianità sugli infedeli. La battaglia di Lepanto, in realtà, non ebbe grandi conseguenze: Venezia era interessata a mantenere rapporti commerciali con l’Oriente e per questo motivo siglò una pace con i Turchi in cui dichiarava di rinunciare a Cipro.
Dopo Lepanto, l’Impero ottomano avrebbe continuato a recitare una parte di primo piano nella politica europea ancora per un secolo.
SVILUPPO LE COMPETENZE
Rielaboro le informazioni
1. Completa la mappa concettuale inserendo correttamente i termini elencati. Attenzione: non tutti sono da utilizzare. decadenza – rinascita – arabica – iberica – Solimano I – Lepanto – ottomano – perde – Egitto – Spagna – Palestina – Ungheria – Budapest
Serbia, Rodi, , Baghdad, territori del Nord Africa conquista
I Turchi subiscono una dura sconfitta nella battaglia di
Solimano I Lepanto Budapest
Dopo Solimano I si manifestano segni di dell’Impero decadenza ottomano

Mi oriento nel tempo
Il dipinto Allegoria della battaglia di Lepanto di Paolo Veronese (15721573) è una delle tante opere che all’epoca esaltarono il successo del mondo cattolico su quello musulmano.
In questa tela la scena della battaglia navale è sovrastata dalla figura della Madonna, con santi e angeli. Sulla destra un angelo scaglia saette sulle navi turche.
2. Collega ciascun avvenimento nella colonna di sinistra alla data corretta nella colonna di destra.
1. Conquista ottomana della Serbia
2. Battaglia di Mohàcs
3. Conquista ottomana di Rodi
4. Conquista ottomana di Baghdad
5. Solimano I diventa sultano
a. 1520
b. 1521
c. 1526
d. 1534
e. 1522
Lezione 9 ( L’Impero ottomano
PASSATO: XV-XVI SECOLO
La storia del mondo occidentale si caratterizza per una costante, a volte drammatica, tensione tra Occidente e Oriente. Durante il XVI secolo, mentre le grandi monarchie nazionali europee cominciavano i loro viaggi transoceanici, il mar Mediterraneo era ancora il cuore, il centro dei commerci e dei conflitti fra l’Impero degli Asburgo, geograficamente europeo e transatlantico, e quello degli Ottomani, a cavallo tra Asia, Europa e Africa. Prima di allora, fino a tutto il XV secolo, i Paesi affacciati sul Mediterraneo erano stati protagonisti di straordinarie avventure militari e commerciali: non solo le città marinare italiane, ma anche il regno catalanoaragonese, che nel Basso Medioevo aveva conquistato un grande impero mediterraneo.

Il Mediterraneo nel Basso Medioevo
• Genova, Venezia, Pisa e Amalfi erano state le città marinare dominanti nel Basso Medioevo.
• Tra il XIV e il XV secolo il regno catalano-aragonese aveva conquistato il controllo di gran parte del Mediterraneo centro-occidentale, con importanti basi anche in quello orientale, dove tradizionalmente operavano Venezia e Genova.
Il Mediterraneo conteso tra Asburgo e Ottomani
• Nel XVI secolo il Mediterraneo era un mare conteso: la parte occidentale era controllata dall’Impero asburgico di Carlo V, la parte orientale dai Turchi ottomani.
• Le basi navali più importanti dell’Impero asburgico di Carlo V nel Mediterraneo erano Napoli, Barcellona, Malta.
• Le basi navali più importanti dell’Impero ottomano nel Mediterraneo erano Costantinopoli, Salonicco, Lepanto.
PRESENTE: XX SECOLO
Nella seconda metà del XX secolo, la contrapposizione fra Occidente e Oriente si è manifestata attraverso la Guerra fredda combattuta tra gli Stati Uniti d’America e i loro alleati da una parte (che rappresentavano il mondo occidentale) e l’Unione Sovietica e suoi alleati dall’altra (che a loro volta rappresentavano il mondo orientale). Questa contrapposizione politica, militare e ideologica, per la natura stessa dei suoi protagonisti, si è consumata su scala globale, cioè su tutti gli oceani del pianeta. Il Mediterraneo, di conseguenza, è diventato uno dei tanti scenari della Guerra fredda, certamente importante ma non più unico: la carta mostra chiaramente la sua marginalità geopolitica del tempo.
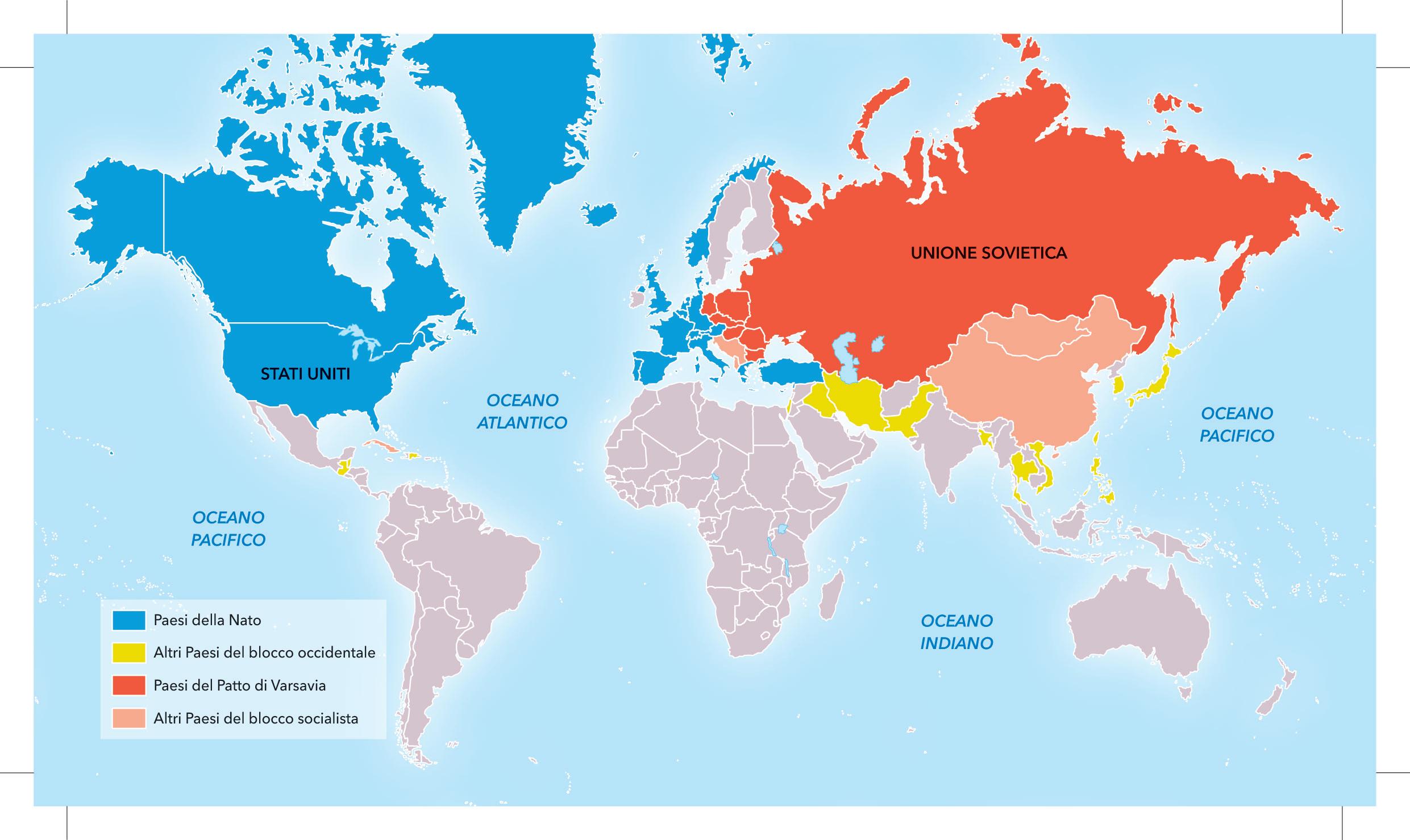
Né l’Unione Sovietica, né gli Stati Uniti d’America affacciano sul Mediterraneo. Gli Stati Uniti affacciano sull’oceano Atlantico e sull’oceano Pacifico; l’Unione Sovietica affacciava sul mar Glaciale Artico, sull’oceano Pacifico e sul mar Nero.
Gli Stati Uniti d’America hanno una posizione dominante nel Mediterraneo grazie all’alleanza politica e militare con Italia, Grecia, Turchia e Francia (nonché con le buone relazioni diplomatiche con la Spagna). L’Unione Sovietica ha una presenza nello scacchiere mediterraneo molto ridotta: fino a metà degli anni Cinquanta attraverso i Paesi comunisti di Iugoslavia e Albania, dopo grazie ai rapporti diplomatici con alcuni Paesi mediorientali (per esempio la Siria).
La globalizzazione economica è un processo di crescente connessione tra diversi mercati del pianeta. Oggi viviamo nel mondo globale: le merci, gli esseri umani e le informazioni viaggiano senza più frontiere da una parte all’altra del pianeta. Ma la globalizzazione ha una storia più antica, che inizia per lo meno nel XVI secolo, come effetto dei grandi viaggi transoceanici.
Dal punto di vista storico, si può cominciare a parlare di globalizzazione a partire dall’epoca dei grandi viaggi transoceanici, che videro protagonisti i navigatori europei dal XVI secolo in avanti. Il processo di globalizzazione si è via via fatto più intenso e importante dopo il XVIII secolo.
Le grandi potenze europee sono le protagoniste di questa prima fase della globalizzazione: monarchie e oligarchie promuovono, infatti, una politica coloniale e commerciale rivolta oltre i confini del Vecchio continente. Le prime potenze globali furono Spagna e Portogallo e, a seguire, Francia, Repubblica delle Province Unite (Paesi Bassi) e Regno Unito di Gran Bretagna.
Imprese coloniali e spedizioni commerciali si mossero tra l’Europa occidentale, le Americhe e l’Africa atlantica e poi, con sempre maggiore intensità, lungo le rotte dell’oceano Indiano e del Pacifico, verso le favolose ricchezze dell’Asia, verso le Filippine, le Molucche, l’India, la Cina e il Giappone.
I prodotti del commercio coloniale che affluivano in Europa dalle quattro parti del mondo erano soprattutto oro, argento, diamanti e pietre preziose, seta,
avorio, porcellane, tappeti, pepe e spezie, tè, caffè, tabacco e zucchero, ma anche patate e cereali. E, purtroppo, soprattutto schiavi, tra Africa e Americhe, ma anche verso l’Europa.
Da circa trent’anni stiamo vivendo una nuova fase della globalizzazione. A tal proposito si ricorre spesso all’immagine del «gomitolo globale». Con questa espressione s’intende rappresentare l’idea della fortissima interconnessione che lega fra loro Stati ed economie, società e culture, esperienze politiche e scelte religiose.



Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica (il cosiddetto gruppo dei BRICS), che fino agli anni Ottanta del Novecento erano ancora Paesi in via di sviluppo, oggi sono attori di primo piano del commercio e della produzione industriale internazionale. Dal punto di vista economico, invece, è la finanza, cioè quella parte dell’economia legata agli investimenti di capitali, a influenzare il mercato globale.
La globalizzazione attuale ha spostato il perno dell’economia mondiale. Oggi, accanto all’Unione europea e agli Stati Uniti, si sono affermati nuovi importanti poli dell’economia mondiale: in Asia (Cina, India, Indonesia e Giappone, ma anche Taiwan, Singapore, Corea del Sud, Filippine), nell’America del Sud (soprattutto il Brasile) e in Oceania (Australia). Nuovi Paesi industriali esportano numerose merci (materie prime, energia, acciaio, tessile) che i Paesi occidentali importano perché sono più convenienti di quelle prodotte sui mercati nazionali. Non tutte le merci, però, hanno forma, peso e colore: le «merci» oggi più scambiate sono quelle immateriali, cioè capitali e conoscenze.

CAMPO SEMANTICO
I termini elencati qui sotto costituiscono una parte del campo semantico legato all’argomento di questo approfondimento. A coppie o piccoli gruppi leggete queste parole, ricercate nel dizionario quelle che non conoscete e arricchite l’elenco con altri termini che vi vengono in mente.
investimenti internazionali
liberalizzazione concorrenza scala mondiale commercio planetario mercato globale rete dazi scambi
interdipendenze
sociali, culturali, politiche economia-mondo
Utilizzate le seguenti domande per condurre una discussione in classe e confrontare le vostre idee.
1. Che cosa significa globalizzazione?
2. Quali sono le merci più importanti scambiate oggi sui mercati globali?
3. Quale strumento permette a queste «merci» di circolare molto più rapidamente che in passato?

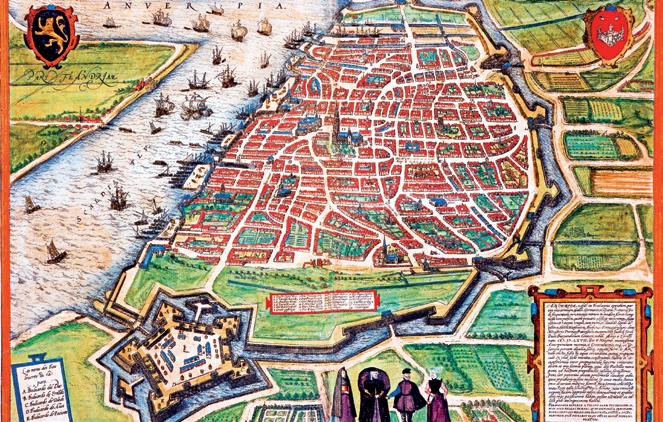

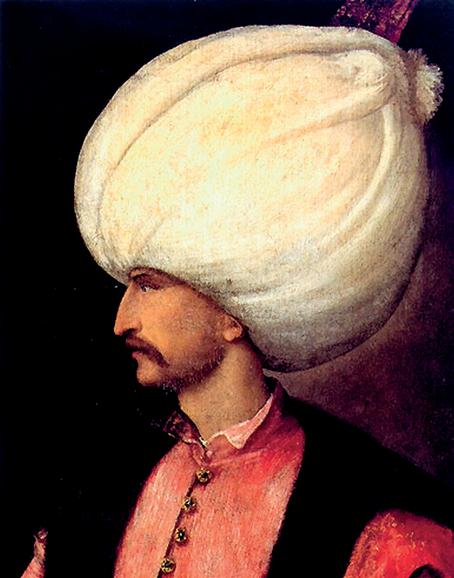


Lezione 6 Commercio planetario ed economia-mondo Le nuove rotte commerciali ampliarono il volume dei commerci, favorendo soprattutto le città affacciate sull’oceano Atlantico. Famiglie facoltose investirono i guadagni realizzati con il commercio in manifatture e banche, creando il capitalismo mercantile. La rete di commerci sempre più ampia diede vita all’economia-mondo nella quale l’Europa ebbe un ruolo economico e politico centrale.
Lezione 7 Popolazione ed economia in Europa (secoli 16°-17°)
Nel Cinquecento in Europa l’aumento della popolazione fece crescere la richiesta di prodotti alimentari mentre l’afflusso di metalli preziosi fece aumentare le richieste di beni e prodotti. Di conseguenza aumentarono i prezzi e si verificò l’inflazione. La Spagna non seppe sfruttare l’enorme ricchezza delle colonie per potenziare l’economia del Paese con investimenti. I Paesi Bassi avevano invece un’economia più dinamica. Il Centro-Nord dell’Italia conservò fino alla metà del Cinquecento un ruolo di primo piano, soprattutto nelle manifatture della lana e della seta.
Lezione 8 Carlo 5° e il progetto di un impero universale
Nella prima metà del Cinquecento l’imperatore Carlo 5° dominava sui possedimenti asburgici, quelli spagnoli e sui territori americani. Dovette però affrontare l’opposizione dei nobili tedeschi, la minaccia turca ai confini orientali dell’impero e, soprattutto, le guerre con la Francia. Nel 1556 Carlo 5° abdicò e divise l’impero in due parti. La Francia tentò in più occasioni di sottrarre l’Italia al dominio spagnolo: dopo una serie di scontri, con la pace di Cateau-Cambrésis la Spagna confermò il suo dominio sulla Penisola italiana.
Lezione 9 L’Impero ottomano
Sotto la guida di Solimano il Magnifico, il dominio degli Ottomani si estese ulteriormente in Asia, in Africa e in Europa, fino alla Serbia e all’Ungheria, minacciando anche Vienna. L’Impero ottomano era diviso in province amministrate da funzionari che divennero sempre più potenti, minando il potere del sovrano. Nel 1571 subì una dura sconfitta dalle potenze cattoliche nella battaglia navale di Lepanto.
Completa la mappa dell’Unità inserendo le parole mancanti.
Europa – Italia – Capitalismo – Tedeschi – Lepanto – Colonie – Espansione


Economia-mondo
caratterizzata da si scontra con arrestata da La scoperta del Nuovo mondo
Ruolo centrale dell’
determina
Impero universale di Carlo 5°
Organizzazione efficiente
Impero ottomano in Europa
Commerci planetari
Emergere di nuove potenze (Paesi Bassi)
Sfruttamento delle
Europa colonie capitalismo
Nascita del mercantile
Principi
Italia tedeschi
Minaccia turca Francia per il dominio sull’
Espansione Lepanto
Sconfitta di (1571)

1. Indica quali tra i seguenti fattori assicurarono all’Europa il vantaggio sulle altre regioni del pianeta.
a La realizzazione dell’impero universale di Carlo V.
b La presenza di solidi Stati nazionali.
c La presenza di grandi flotte mercantili a Genova e Venezia.
d L’ambiente naturale favorevole, al sicuro dalle ricorrenti catastrofi.
e I valori morali e sociali elaborati dalla cultura umanistica e rinascimentale.
f La predisposizione all’innovazione tecnologica.
g La mancanza di conflitti politici e militari tra gli Stati europei.
h La ricchezza e lo sviluppo culturale degli Stati regionali italiani nel Cinquecento.
2. Rispondi alle domande.
a. Quale fu l’andamento della popolazione nel Cinquecento?
b. Quanti erano gli abitanti in Europa alla fine del secolo?
c. Epidemie e carestie erano completamente sparite?
d. Qual era l’attività economica più praticata?
La popolazione torna a crescere anche se non 80-100 milioni.
e. La vita media della popolazione europea era alta o bassa?
f. Quali attività economiche favorivano la crescita delle città?
Bassa: 34 anni per le donne, 28 per gli uomini. Il commercio e l’artigianato.
g. Che cosa favorirono gli investimenti di capitali nelle attività agricole?
Favorirono un miglioramento delle No, ma avevano ridotto la loro intensità e frequenza. L’agricoltura. in modo stabile.
3. Completa il testo con le parole mancanti.
tecniche agricole e l’estensione delle terre coltivate. Spagna
Nuovo mondo lana corte prestiti Nord Nord seta nobili Paesi Bassi sviluppare
Grande protagonista dell’Europa del Cinquecento fu la , che importava grandi ricchezze dal . Essa, però, non utilizzò queste ricchezze per nuove attività ma le usò per mantenere la e per finanziare la vita dispendiosa dei . Fu dunque costretta a chiedere spesso ai banchieri. Invece le città dei , soprattutto Anversa, e del Europa, si erano arricchite grazie ai traffici commerciali e alle attività artigianali e investivano i guadagni in altre attività produttive e bancarie. Anche l’Italia del era tra le zone più ricche d’Europa, grazie all’agricoltura, allo sviluppo della lavorazione della e della , alle manifatture metallurgica e vetraria, alle attività editoriali, alle banche.
4. Completa la scheda con le informazioni sull’espansione ottomana nel Cinquecento.
Gli Ottomani in Europa
Gli anni del regno di Solimano
Territori occupati
Città assediata ma non conquistata dai Turchi
1520-1566
Serbia, Ungheria
Vienna
5. Collega ciascun avvenimento nella colonna di sinistra alla data corretta nella colonna di destra.
1. Battaglia di Lepanto a. 1525
2. Carlo V diventa imperatore b. 1556
3. Creazione della lega di Cognac c. 1521
4. Francesco I è sconfitto a Pavia d. 1519
5. Abdicazione di Carlo V e. 1571
6. I Turchi conquistano la Serbia f. 1527
7. Sacco di Roma per opera dei lanzichenecchi g. 1526
8. Pace di Cateau-Cambrésis h. 1529
9. I Turchi conquistano Baghdad i. 1534
10. Assedio turco di Vienna l. 1559
6. Date le definizioni, scrivi il termine corrispondente.
a. Commercio ad ampio raggio su nuove rotte che coinvolge soprattutto gli Stati affacciati sull’Atlantico:
b. Sistema economico fondato sull’investimento produttivo di denaro:
c. Ricchezza investita per produrre altra ricchezza:
d. Grandi laboratori artigianali dove il lavoro era eseguito manualmente:
Investimento. Manifatture.
e. Sistema economico in cui gli investimenti produttivi di denaro avvengono soprattutto negli scambi commerciali:
f. Istituzioni specializzate in cui si fissa il prezzo delle merci e il valore di scambio delle diverse monete:
Capitalismo mercantile. Capitalismo. Borse.
g. Sistema contemporaneo di relazioni economiche, politiche, culturali e sociali che coinvolge l’intero pianeta:
h. Forte aumento dei prezzi con conseguente perdita del potere d’acquisto del denaro:
Globalizzazione. Inflazione.
7. Collega correttamente ciascun termine nella colonna di sinistra al suo sinonimo o al suo contrario nella colonna di destra.
1. Abdicare
2. Universale
3. Sacco
4. Dominio
5. Autonomia
e. Possesso Commercio atlantico.
a. Particolare
b. Saccheggio
c. Rinunciare
d. Dipendenza
8. Esegui sulla carta le attività indicate.
• Crea una legenda con tre colori diversi per indicare:
– i territori corrispondenti all’impero di Carlo V; C
– lo Stato europeo che più di ogni altro contrastò il progetto di impero universale di Carlo V; F
– la potenza extraeuropea che minacciò i confini dell’impero di Carlo V. O
• Colora quindi i territori secondo quanto indicato in legenda.
9. Collega le cause nella colonna di sinistra agli effetti corretti nella colonna di destra.
1. La crescita della popolazione determina…
2. La pressante richiesta di cibo provoca…
3. La maggiore quantità di moneta in circolazione determina…
4. Il continuo aumento dei prezzi provoca…
a. …la perdita di valore della moneta.
b. il bisogno di sfamare un maggior numero di persone.
c. …un forte aumento dei prodotti agricoli.
d. …la crescita del numero dei poveri.
1 Scarica e installa l’app RAFFAELLO PLAYER dagli store.
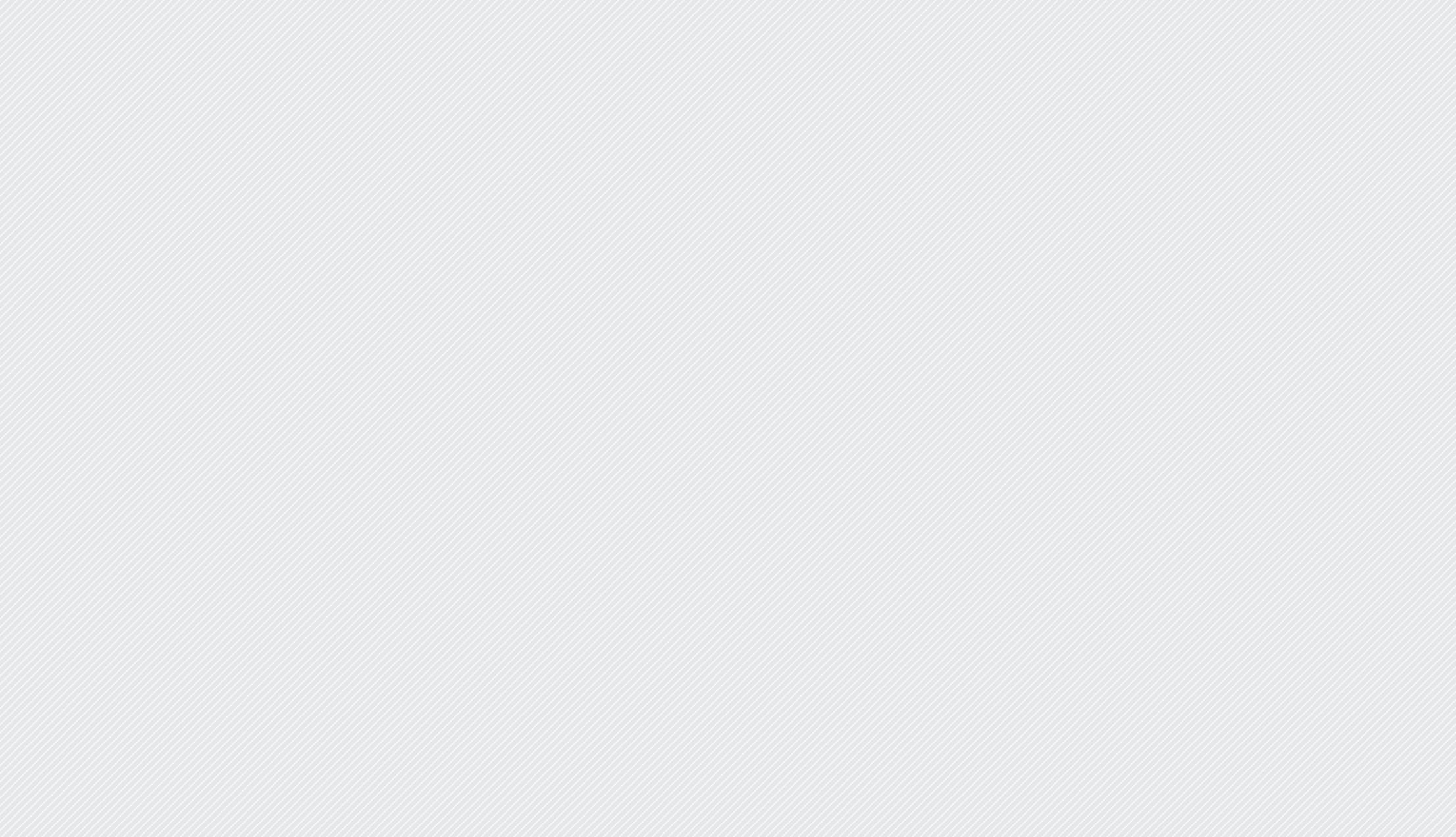
3 Attiva il testo con il CODICE DI SBLOCCO indicato nella pagina “Attiva il testo digitale M.I.O. BOOK”.
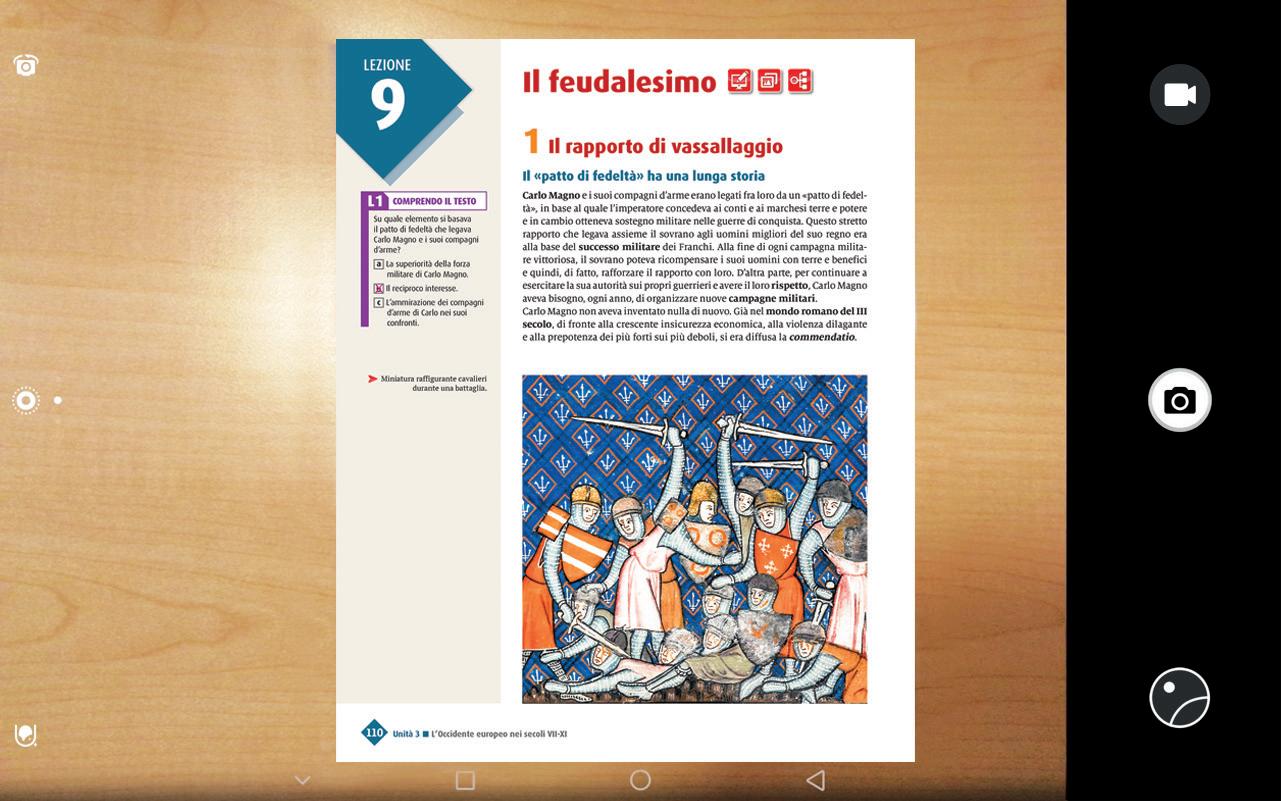
2 Clicca sulla voce Realtà Aumentata.


4 Inquadra la pagina e visualizza i contenuti.
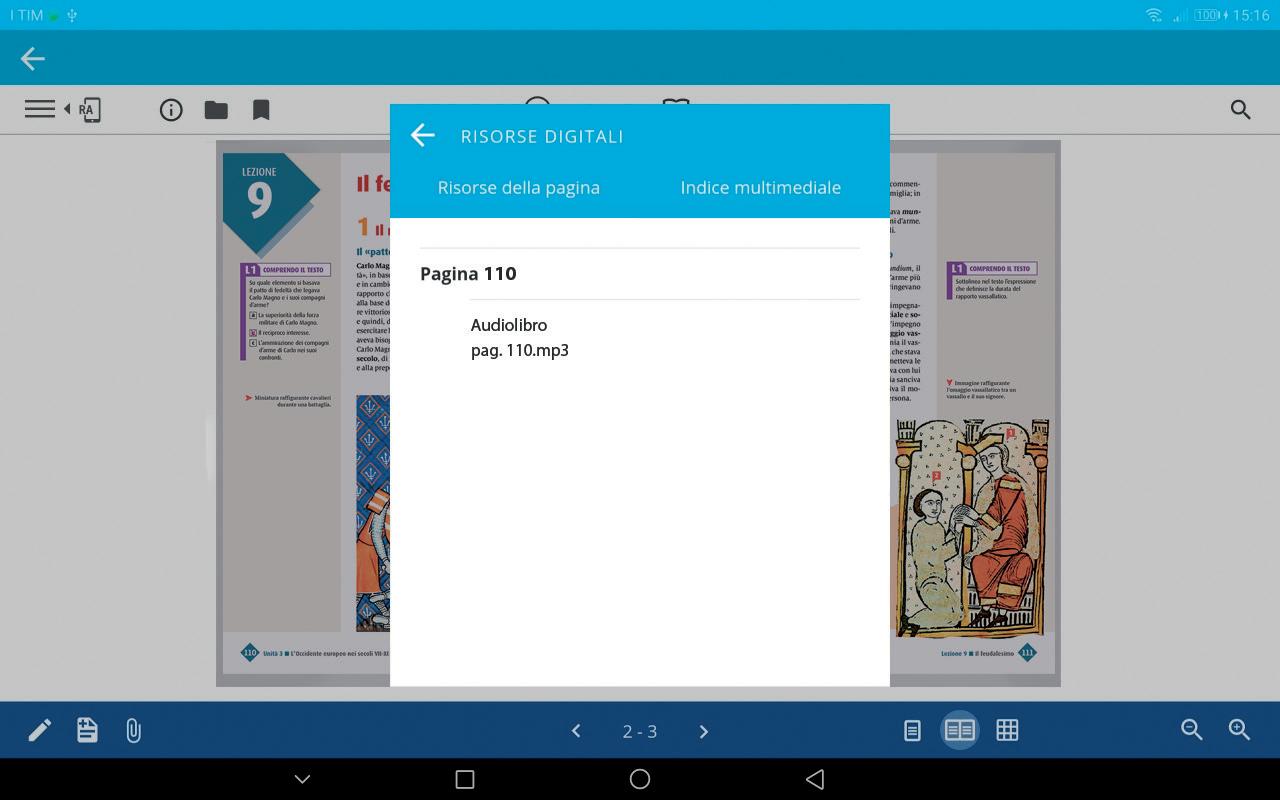
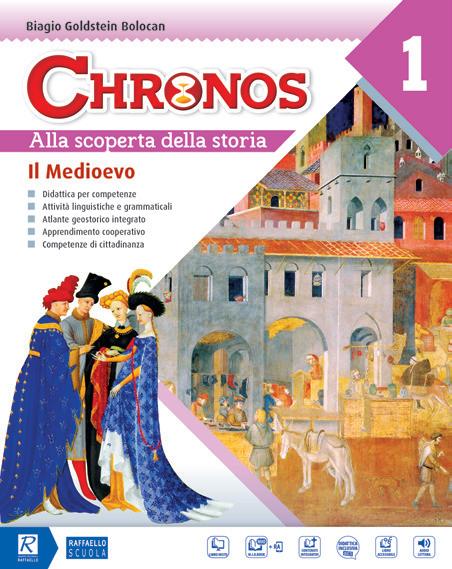

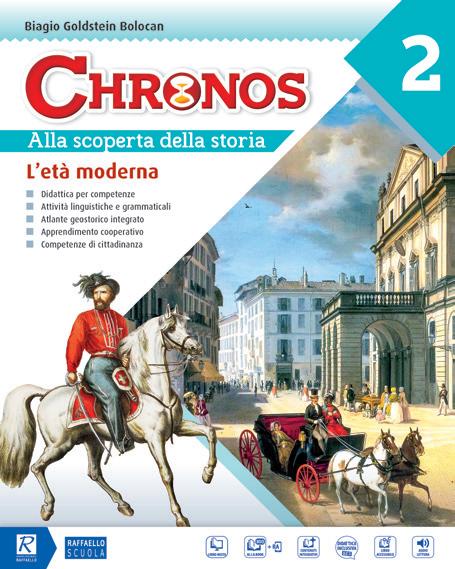

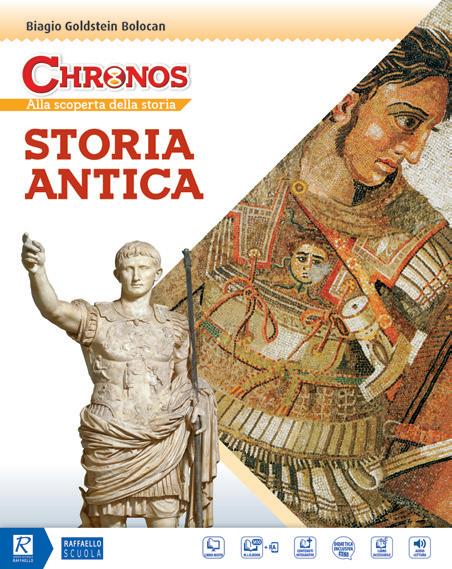
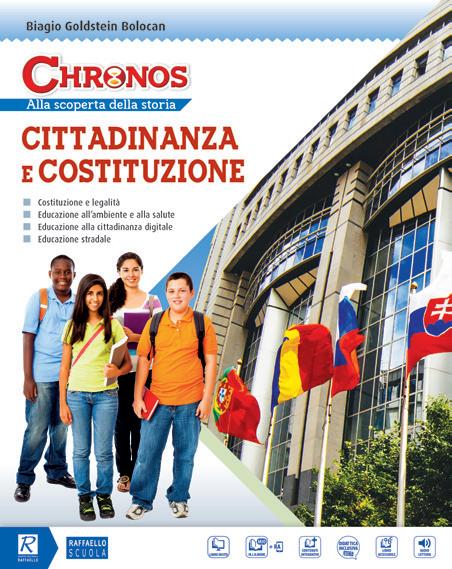


Completano il corso: Quaderni delle competenze 1, 2 e 3
Disponibili su richiesta: Volumi per BES 1, 2 e 3 + CD Audio MP3
Guida per il docente + DVD + CD Audio MP3
Il corso è disponibile anche nella modalità di tipo c (solo digitale) su www.scuolabook.it
• Audiolibro integrale a cura di speaker professionisti
• Alta leggibilità (formato ePub) con testo modificabile
• Servizio di traduzione e dizionario di italiano integrato
Realtà Aumentata: inquadra la pagina con il tuo dispositivo e accedi ai contenuti digitali
Prezzo di vendita al pubblico Volume

