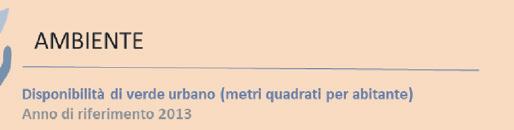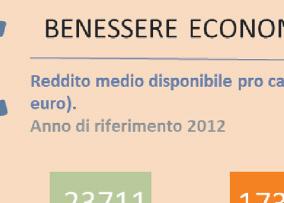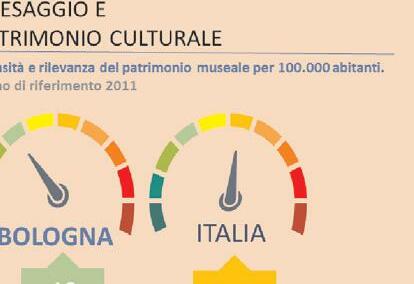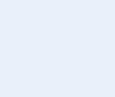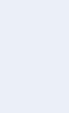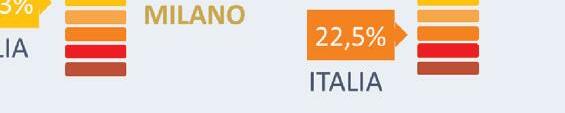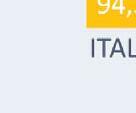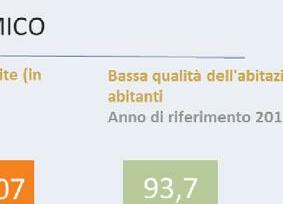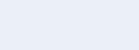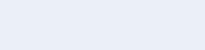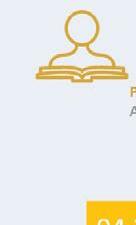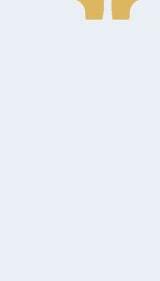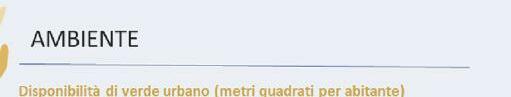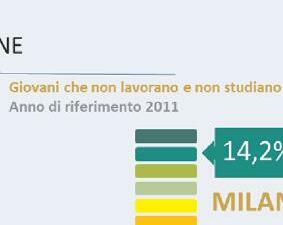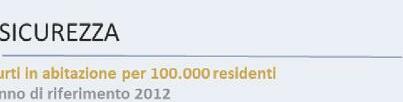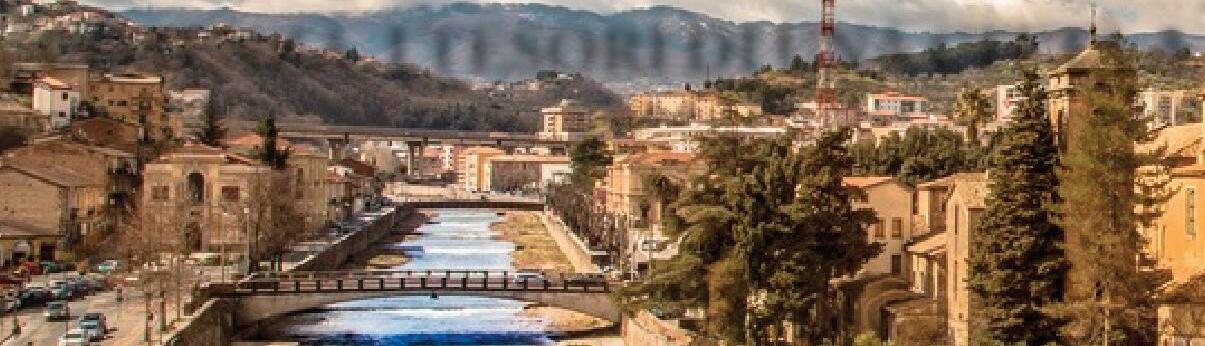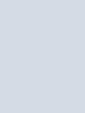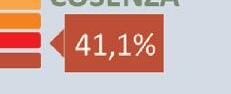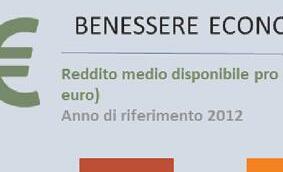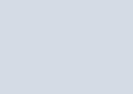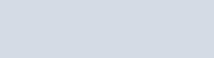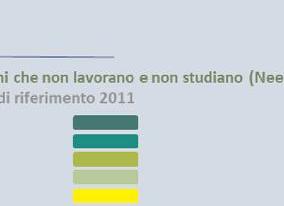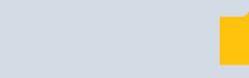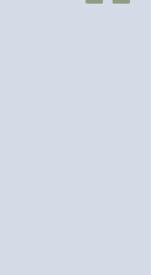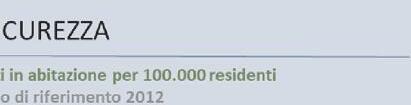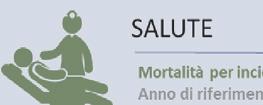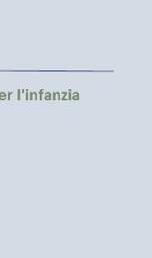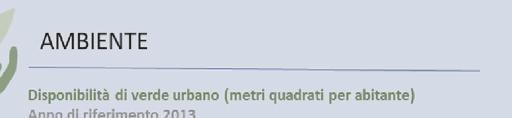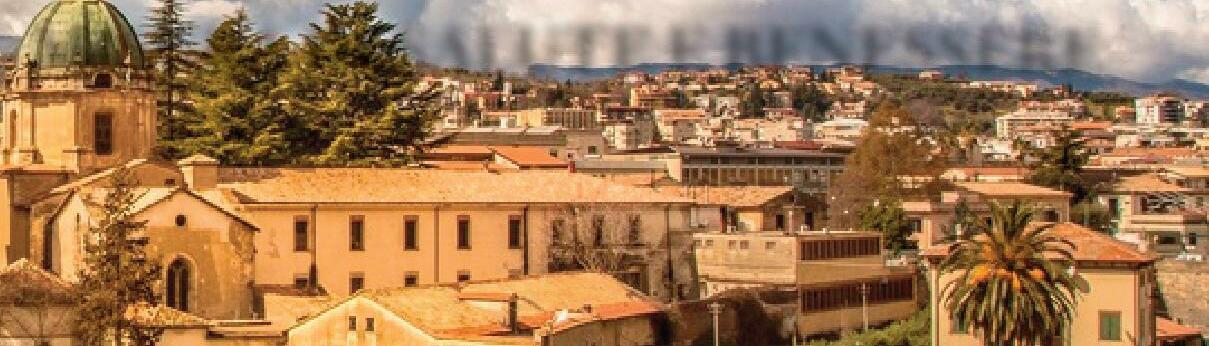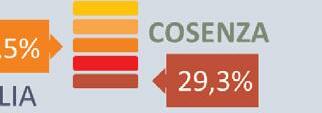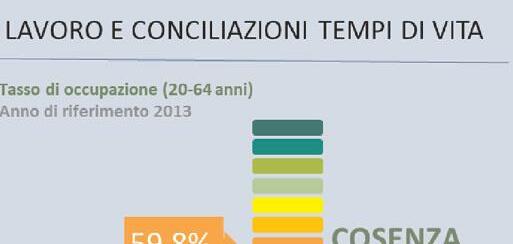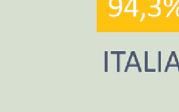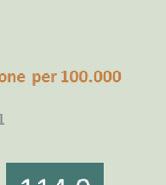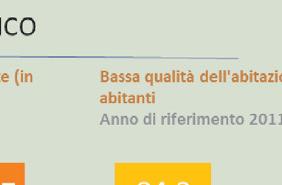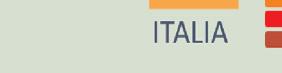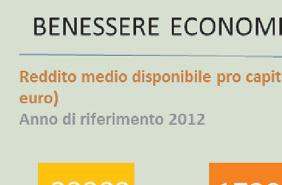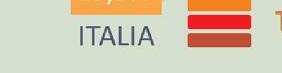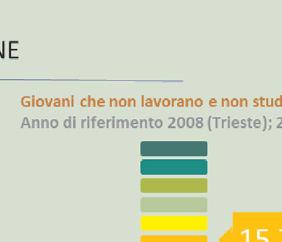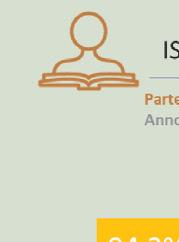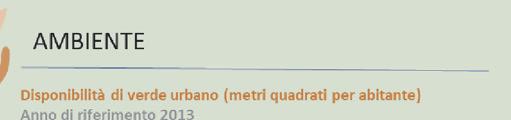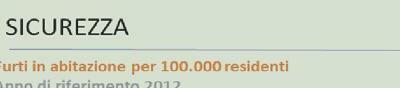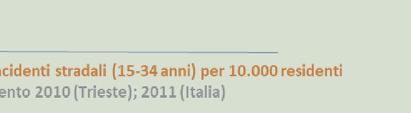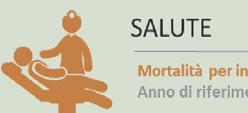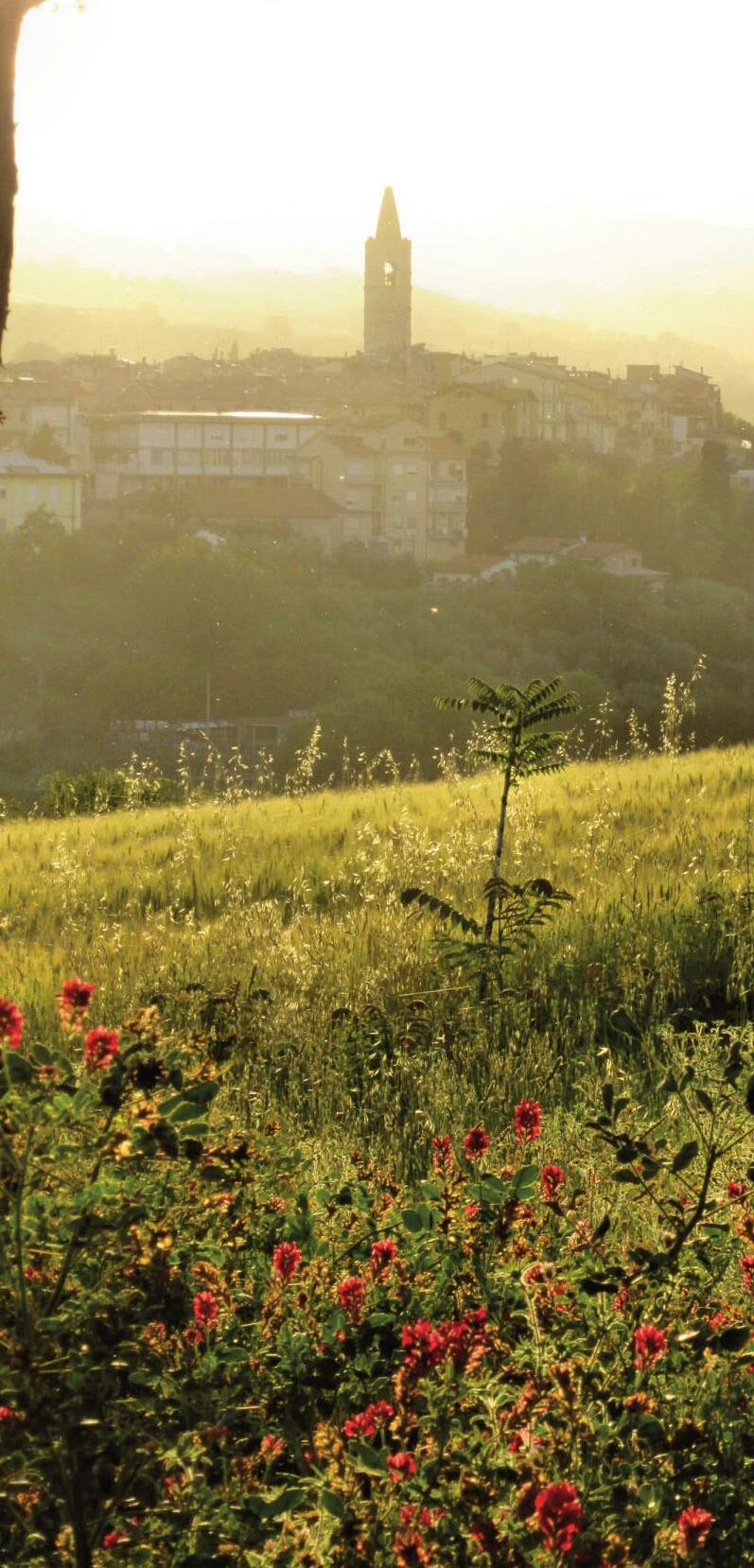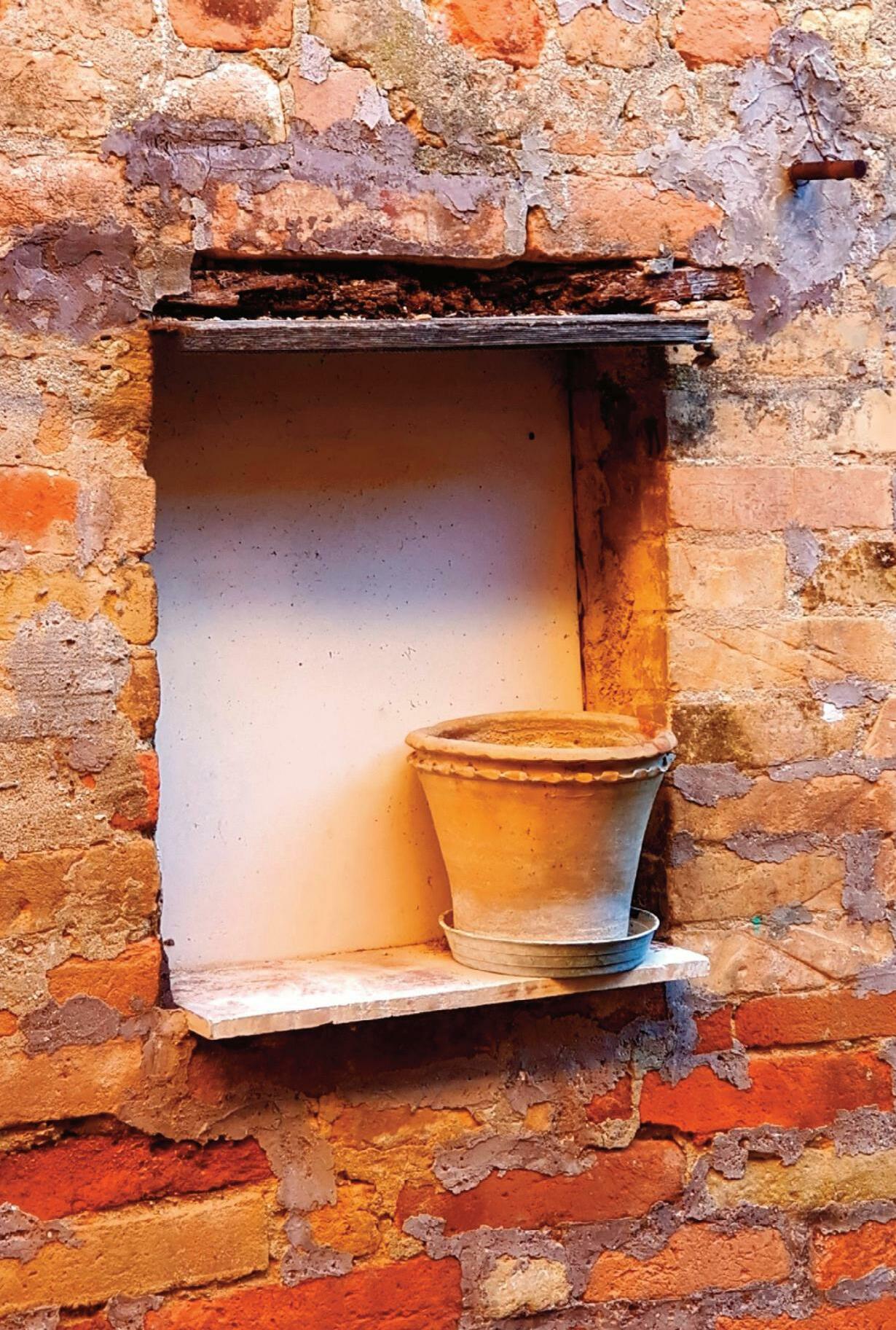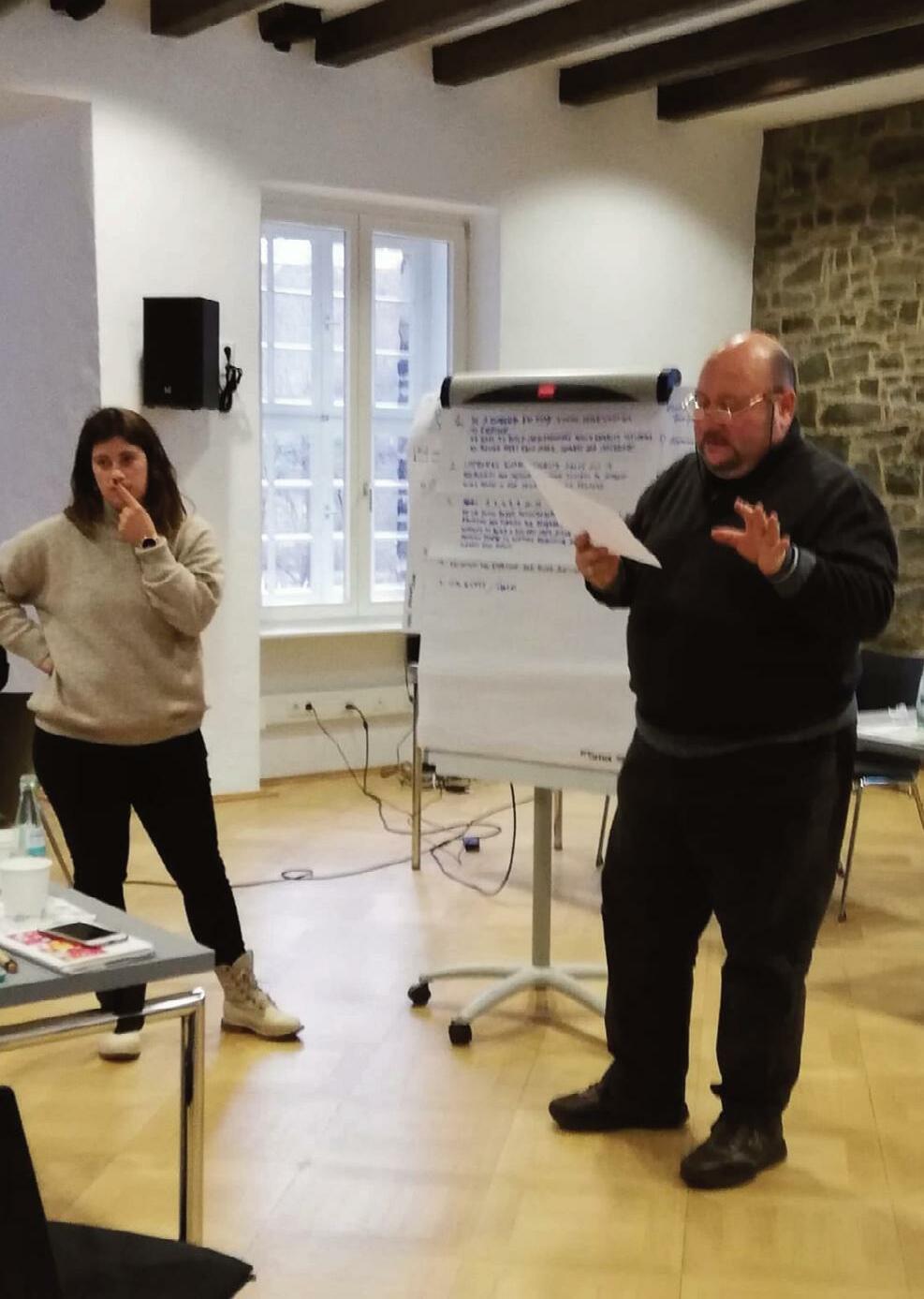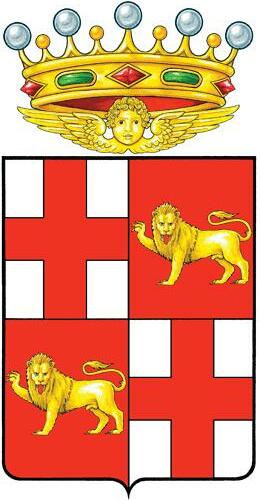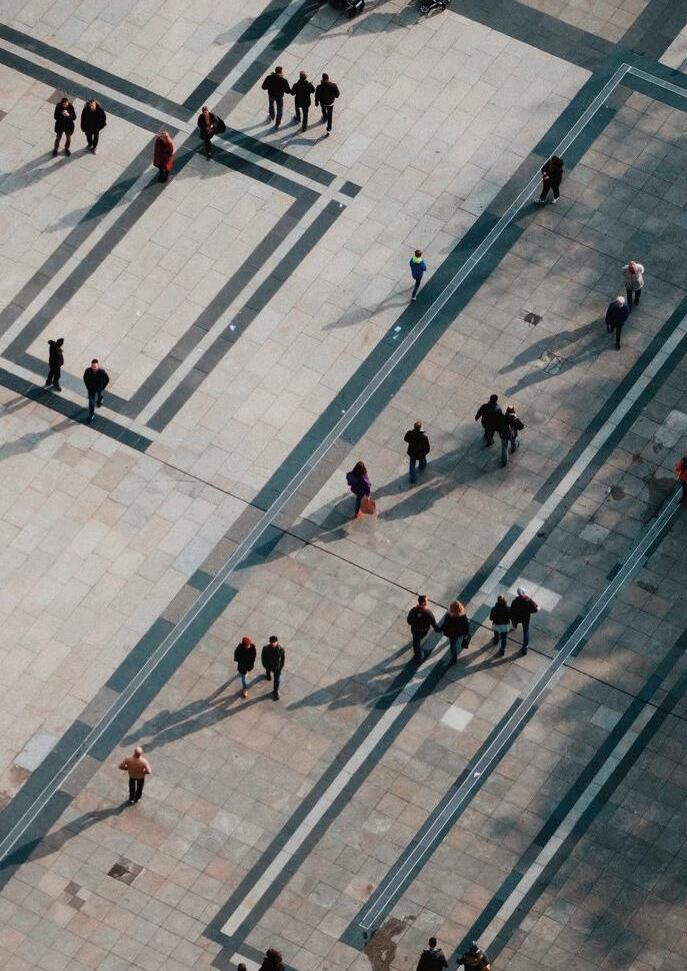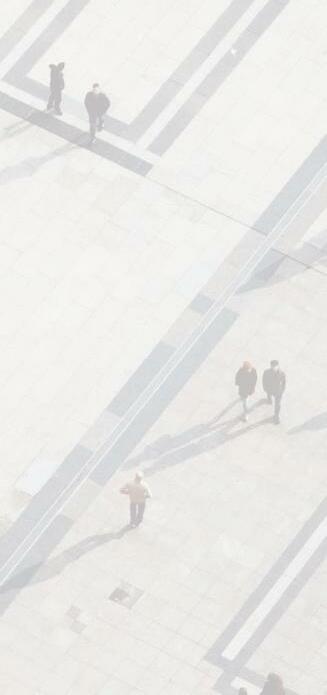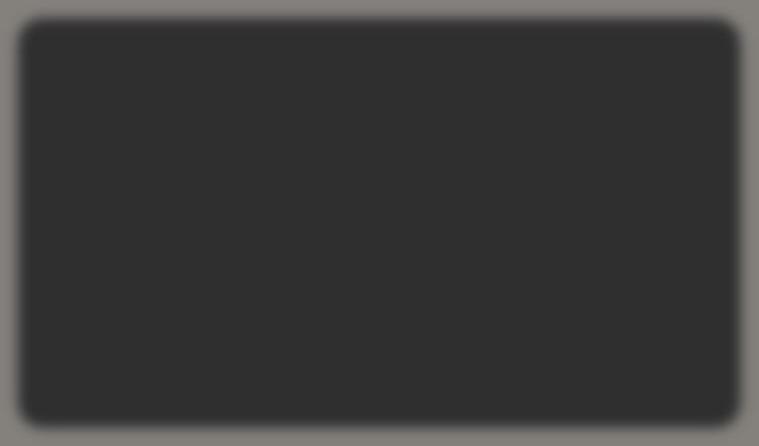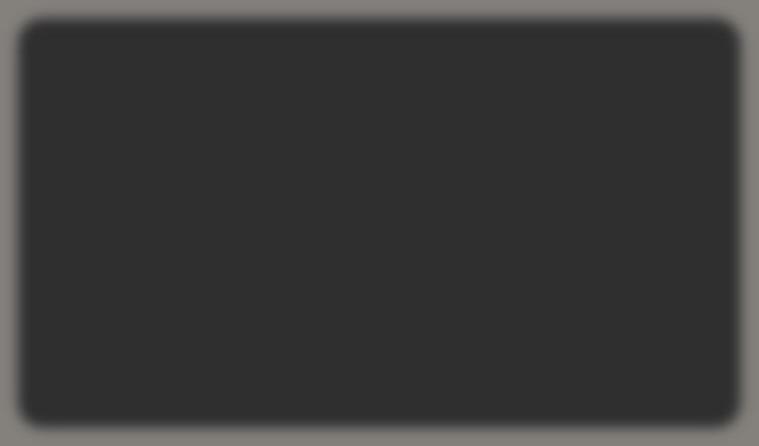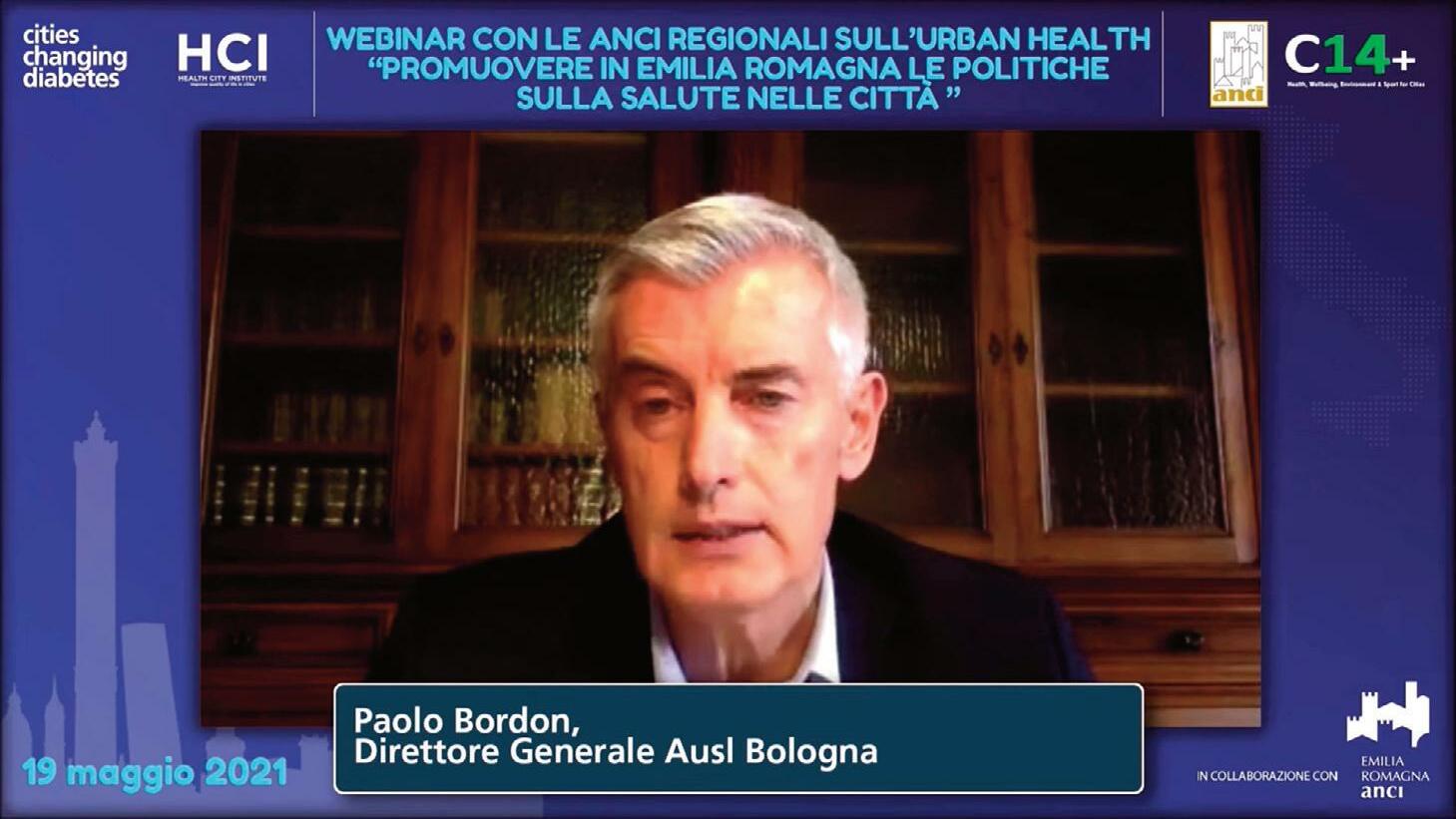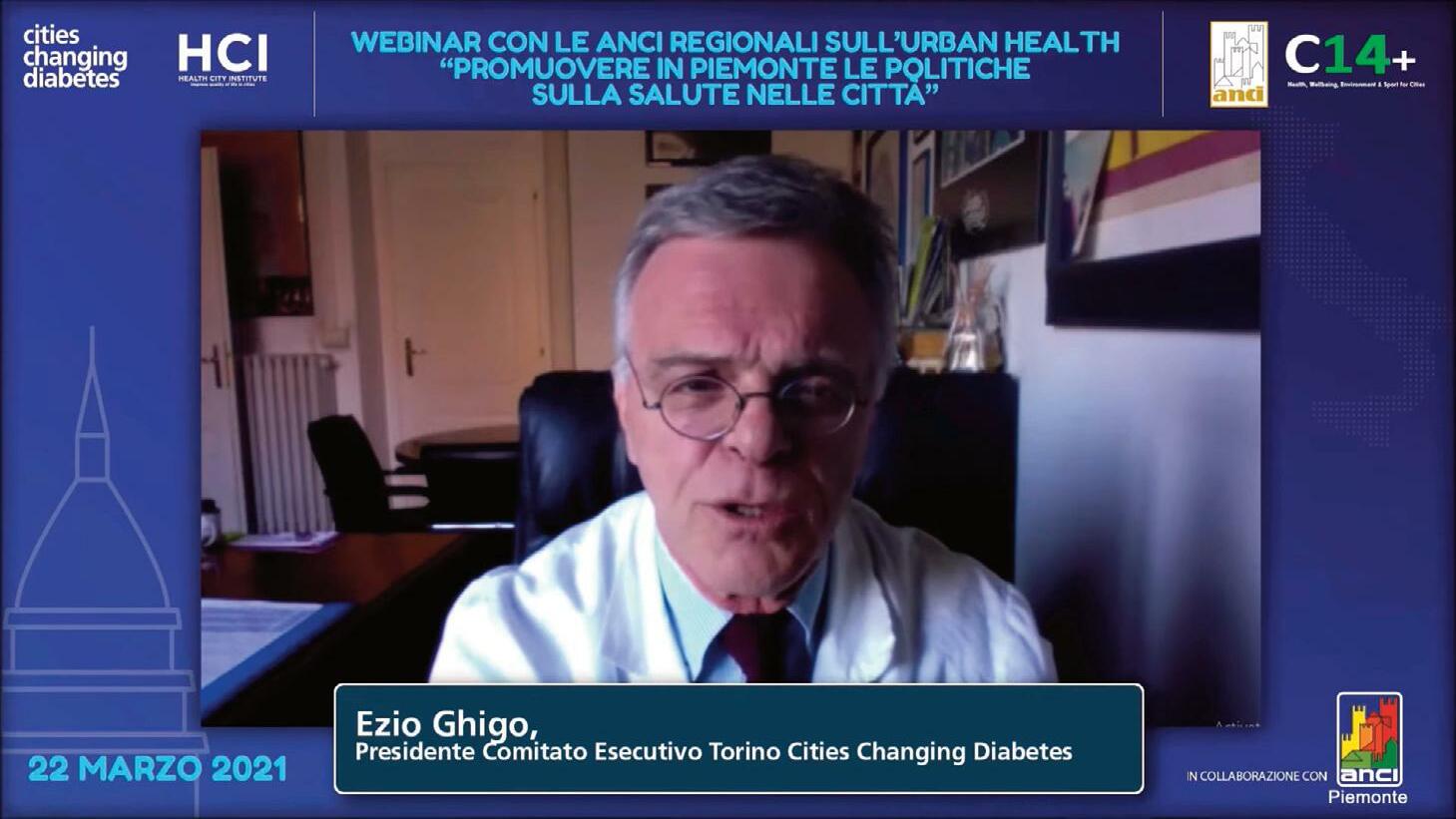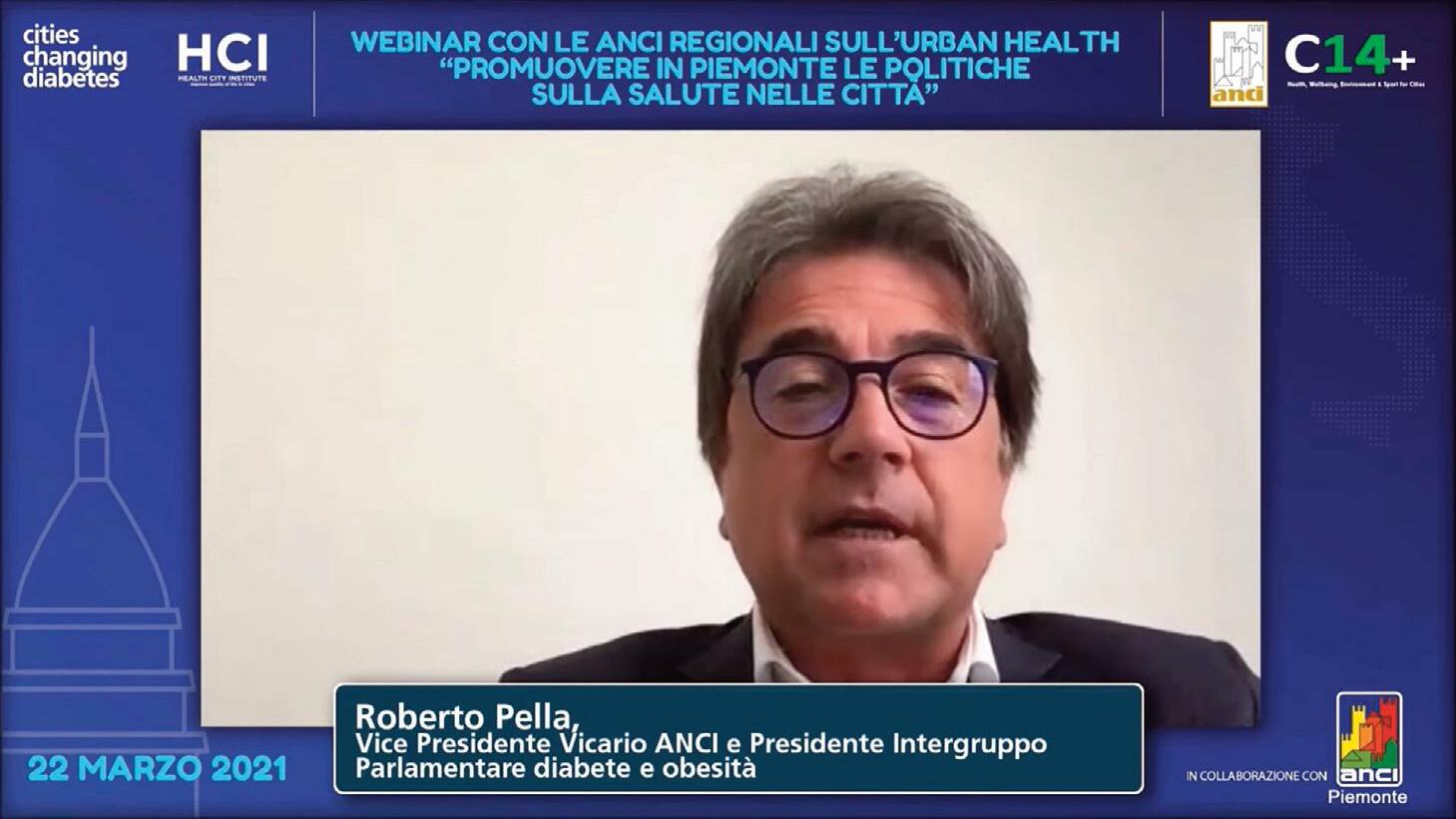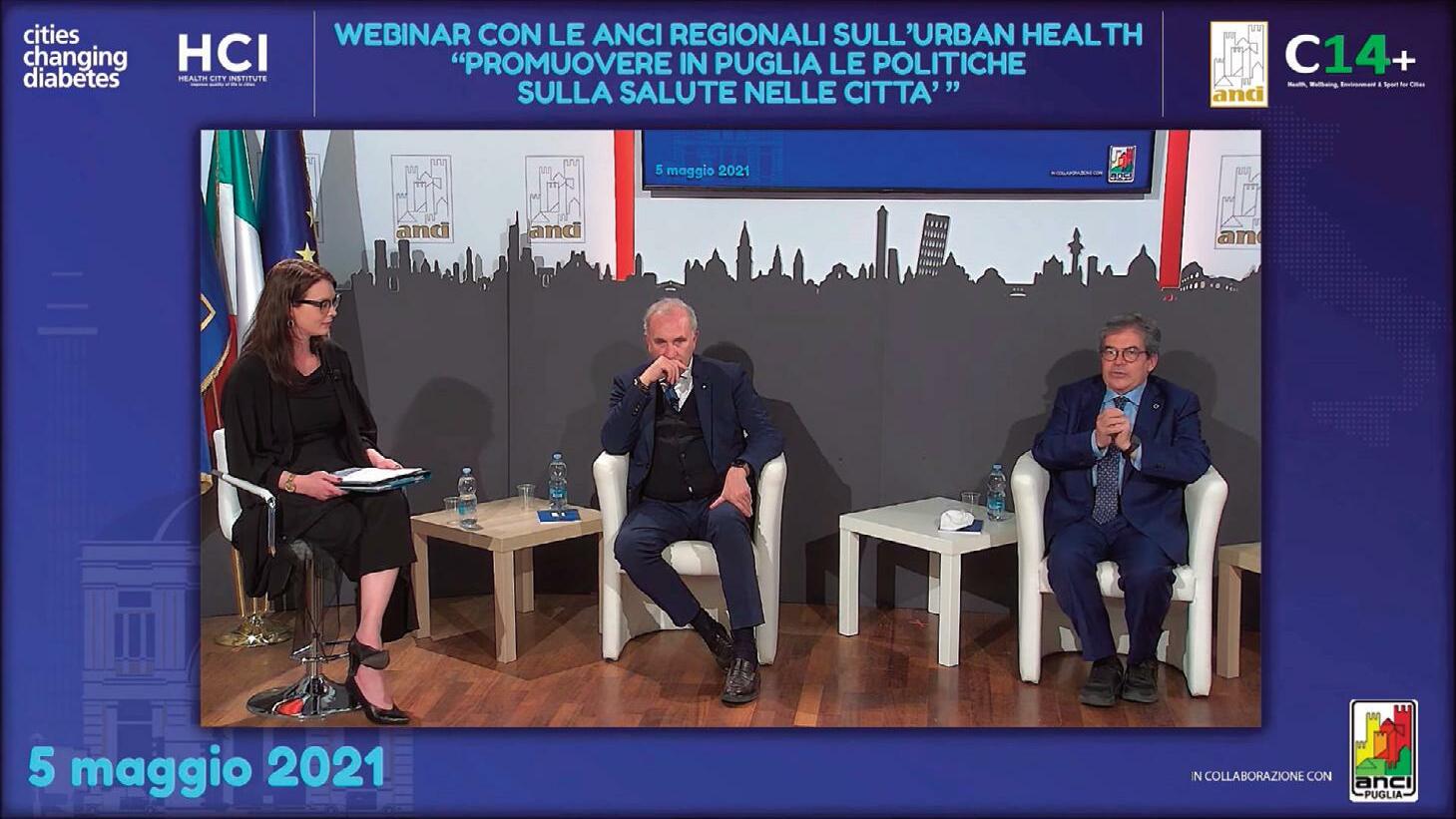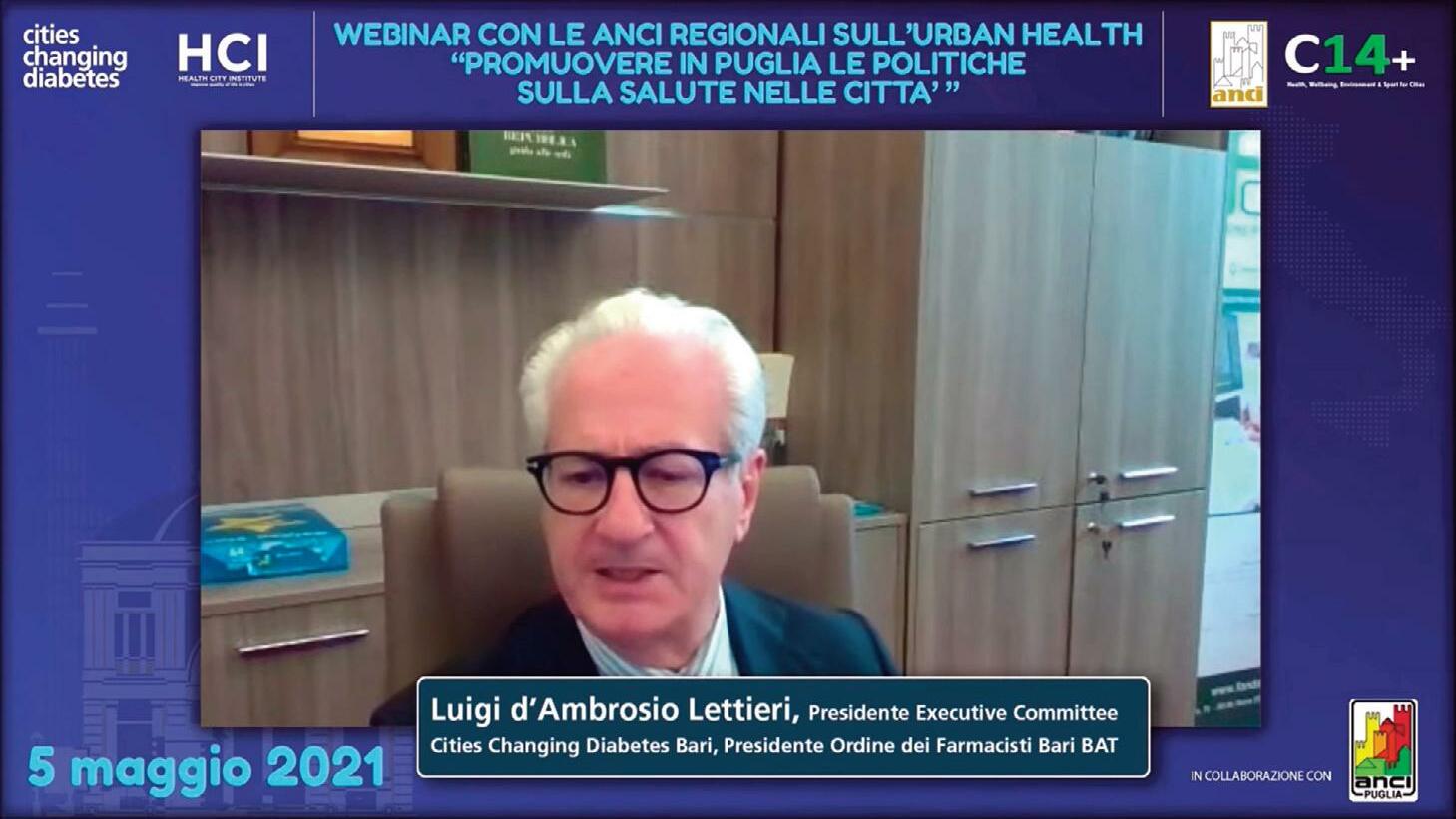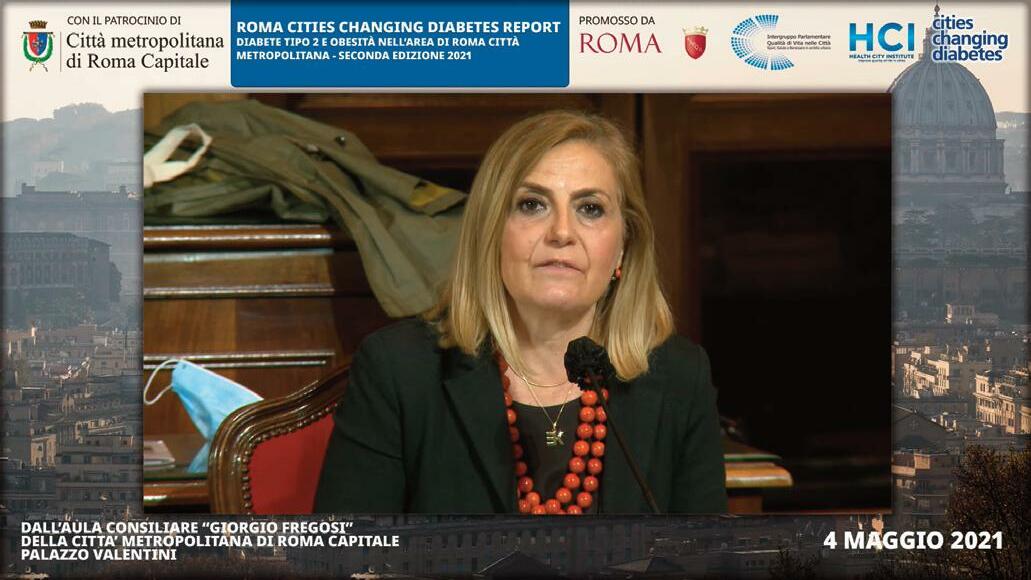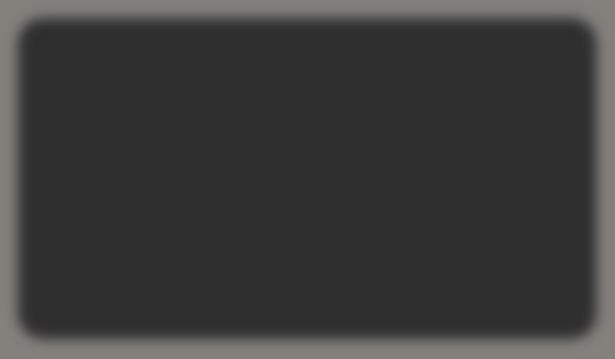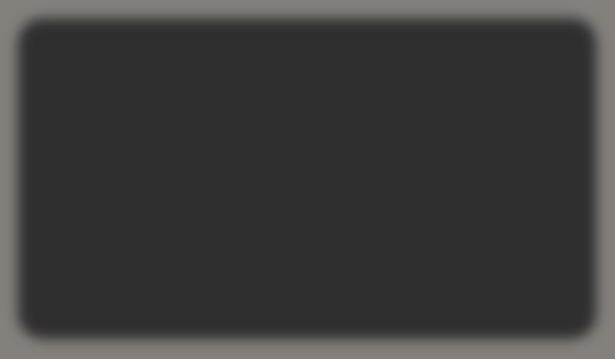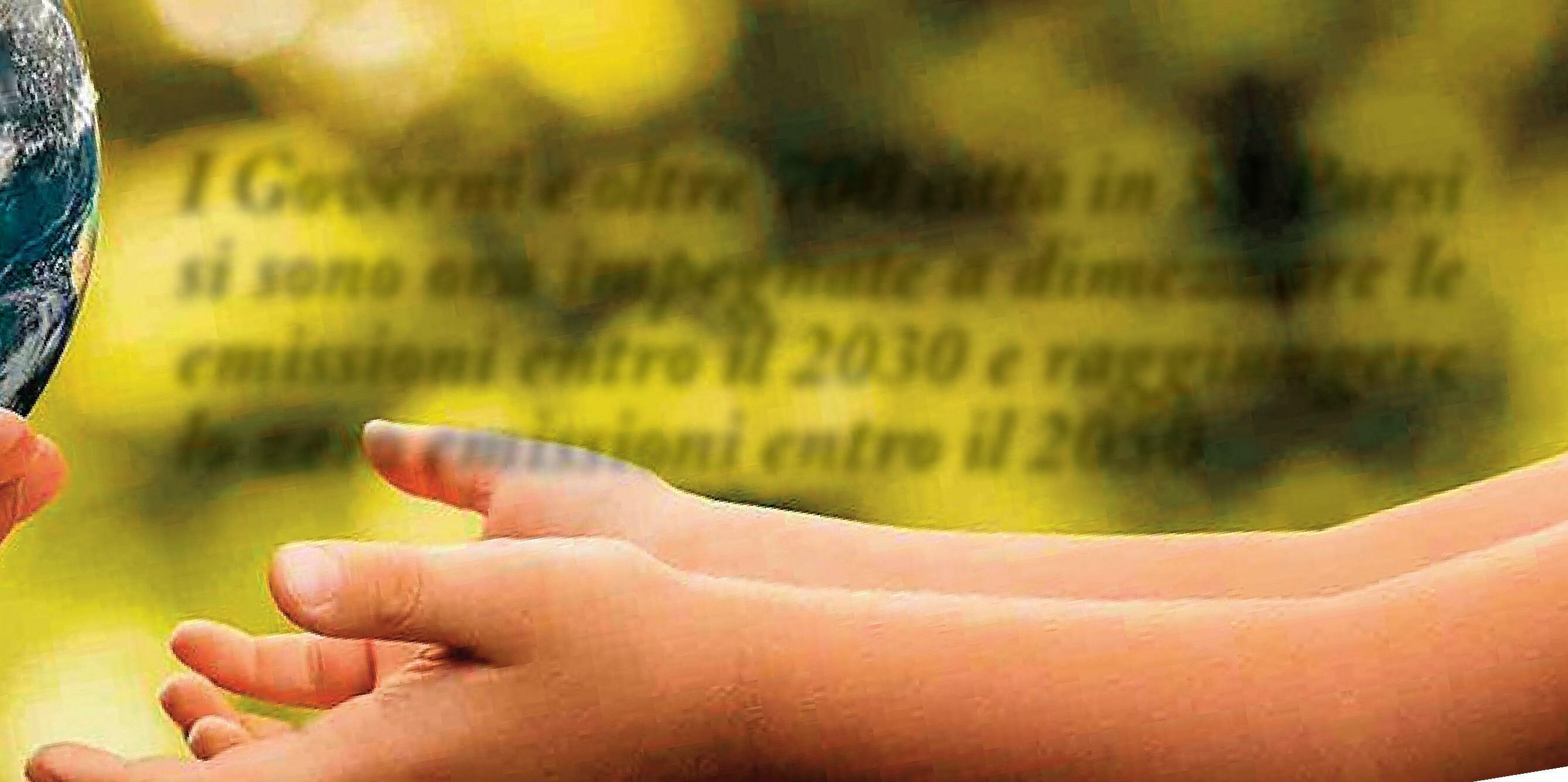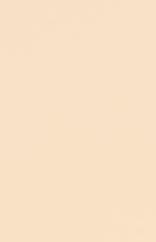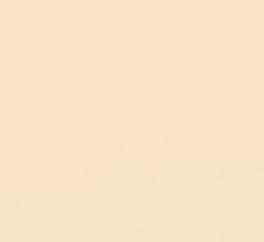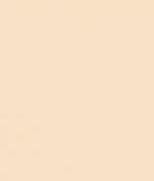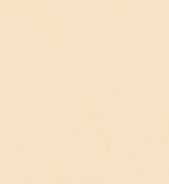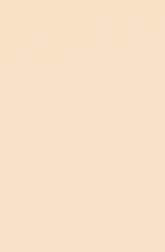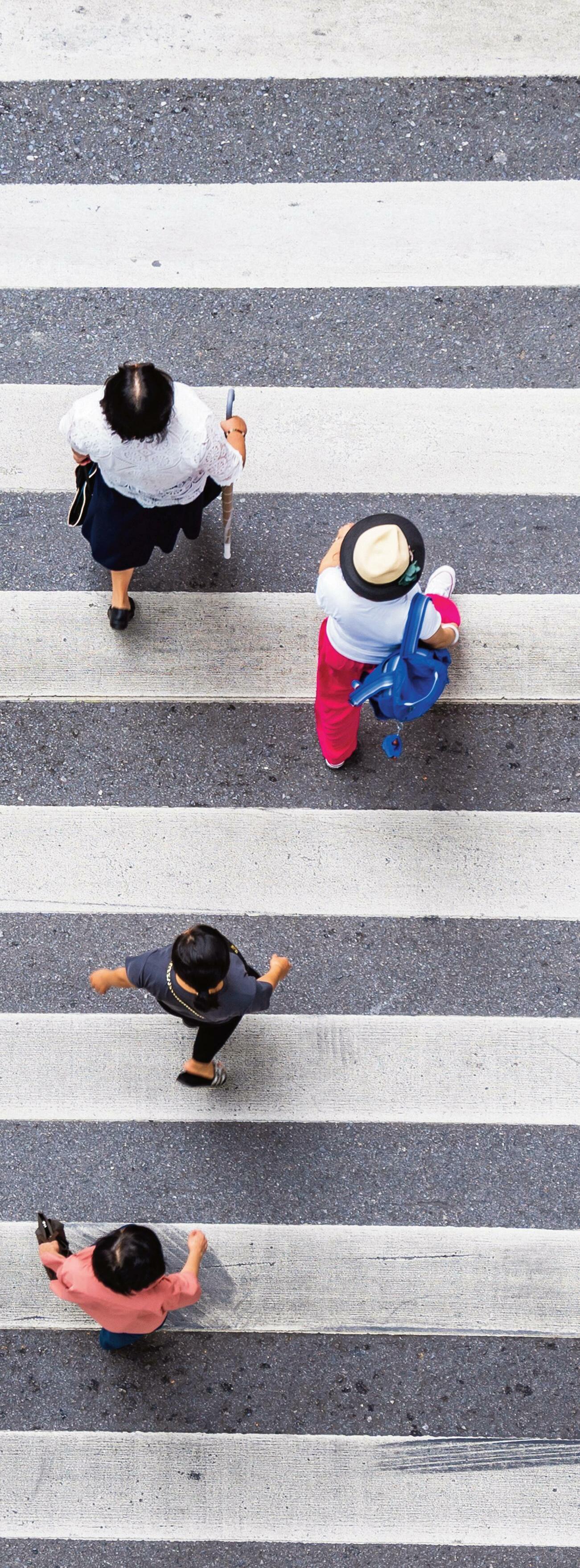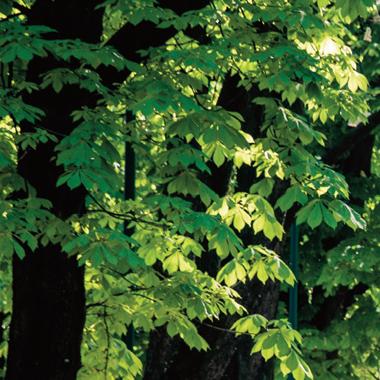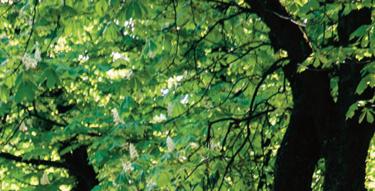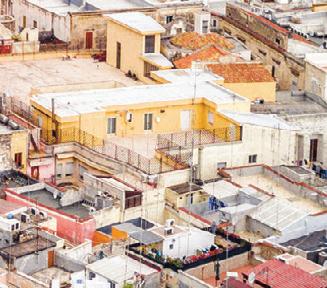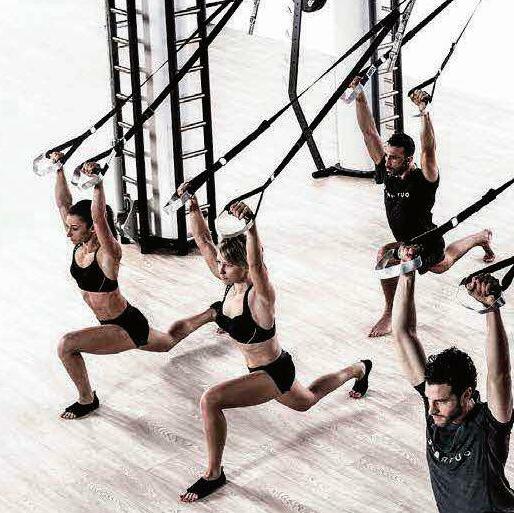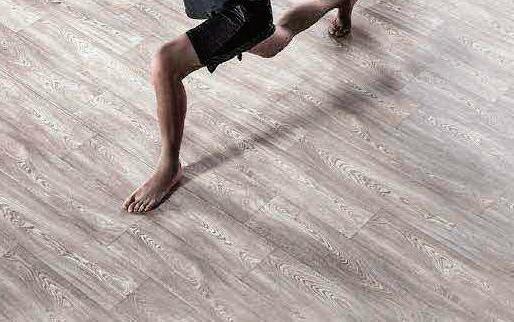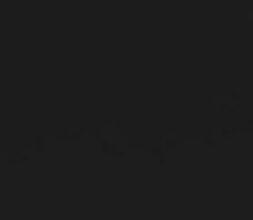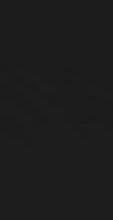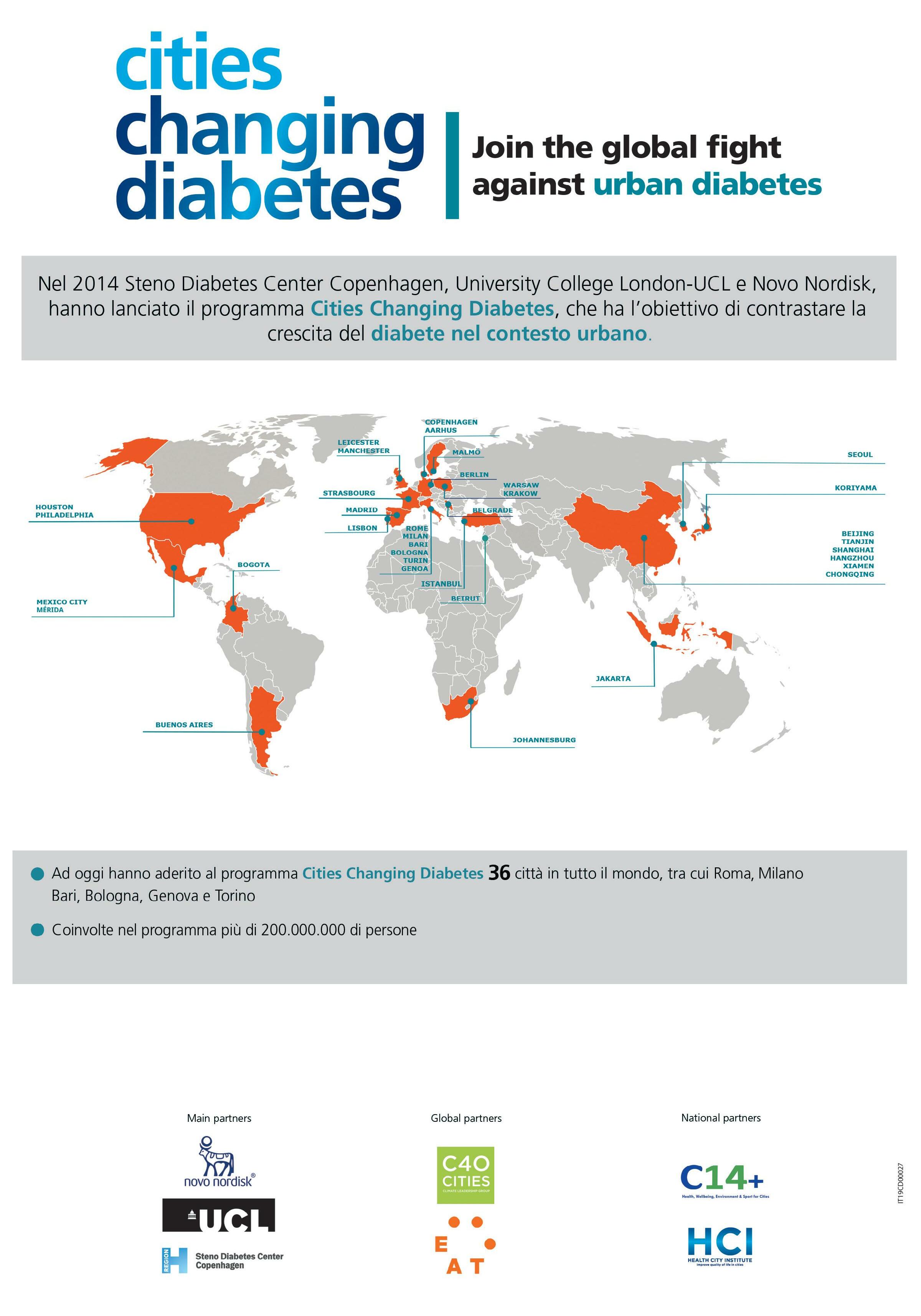giunto il momento della ripartenza. Pensiamo ai giovani, abbiamo un debito verso di loro”
“È
Urbes Magazine N° 2 - Luglio 2021
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
Direttore Responsabile
Mario Pappagallo
Direttore Editoriale Andrea Lenzi

Editore Edizioni Universo Editoriale
Segretaria di Redazione Francesca Policastro
Editorial Board
Alessandro Cosimi Stefano da Empoli Maria Luisa Di Pietro
Furio Honsell
Antonio Gaudioso
Roberto Pella Walter Ricciardi
Paolo Signorelli
Chiara Spinato Ketty Vaccaro Stefano Vella
Magazine quadrimestrale
Ferdinando Corsi ISBN 9788890963483
Raffaele Staccioli Creativa Group Contatti direzione@urbesonline.com info@urbesonline.com redazione @urbesonline.com francescapolicastro@urbesonline.com mariopappagallo @urbesonline.com

Social Twitter #UrbesMagazine Facebook @UrbesMagazine Rivista promossa da www.healthcitythinktank.org info@healthcitythinktank.org
Concessionaria per la pubblicità e servizio abbonamenti: SP Servizi Pubblicitari srl GRUPPO CREATIVA info 327.78.08.873
Editoriale
Mario Pappagallo
La ripartenza post Covid? Il mondo si ritrova come un pugile confuso dai colpi ricevuti. Deve ancora capire che cosa è successo, che cosa accadrà, se bastano i vaccini per salutare definitivamente il Covid-19. Passata la tempesta non è ancora chiaro che cosa sia accaduto e che cosa accadrà. Nemmeno la scienza ha le idee del tutto chiare sull’origine del virus, sulla reale efficacia dei vaccini, se nuove nuvole nere potrebbero tornare ad addensarsi nei cieli della salute e dell’economia globali. Intanto, alla ricerca di una normalità si punta sugli Europei di calcio, sui Giochi Olimpici, sul turismo, sulla riapertura delle discoteche e sugli aperitivi serali dei fine settimana soprattutto per “curare” la salute mentale ed emotiva messa a dura prova da oltre un anno e mezzo di restrizioni causa pandemia.
Ma non è certo questa la soluzione, presto potrebbe manifestarsi un déjà vu (o un déjà vécu). Sì, perché mentre all’inizio di questa pandemia per un mese circa nessuno ci credeva, ora tutti già immaginano un’era delle pandemie. Occorre creare anticorpi anche per la salute mentale.
Ma c’è un bicchiere mezzo pieno da prendere in considerazione, partendo dall’analisi di quanto accaduto. Un bicchiere mezzo pieno tonificante da bere subito. Senza remore e interessi deviati e devianti.
Sul tappeto c’è una sorta di Piano Marshall per la ripartenza. Non a caso il premier inglese Boris Johnson ha paragonato la pandemia ancora in corso alla Seconda Guerra Mondiale. Il Piano Marshall, ufficialmente chiamato piano per la ripresa europea (in lingua originale “European Recovery Program”), fu uno dei piani politico-economici statunitensi per la ricostruzione dell’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. E ha favorito il boom economico, almeno in Italia. Il Recovery Plan dell’Ue e, per il globo, la disponibilità del FMI (150 miliardi di dollari) sono più strutturati nelle finalità del Piano Marshall. Di buon auspicio anche la recente dichiarazione di Christine Lagarde (presidente della BCE): “L’inflazione non è un pericolo, prematura e rischiosa una stretta monetaria”.
I soldi, quindi, ci sono ma occorrono progetti in grado di predisporre un futuro diverso dal presente e da come si viveva prima del Covid.
Infatti, in molti si chiedono come si riorganizzerà il mondo quando la pandemia avrà termine. Di certo molti aspetti socio-economici dovranno subire aggiustamenti, anche per evitare nuovamente sorprese nel caso di una nuova pandemia. Il mondo del lavoro, i sistemi sanitari, il welfare, l’ambiente, la ricerca scientifica, le basi ormai obsolete di economie ancora in ritardo rispetto alla globalizzazione, i flussi umani dai Paesi poveri a quelli ricchi, o finora considerati tali. Anche la politica ha subito contraccolpi per i motivi suddetti e per i pro-
grammi post-pandemia.
L’organizzazione sanitaria ha scricchiolato ovunque e per motivi diversi da Paese a Paese. Due esempi: negli Stati Uniti all’inizio nessuno si sottoponeva a tamponi e test a pagamento perché in molti non avevano un piano assicurativo o uno che coprisse una pandemia, poi si sono anche resi conto (e ora il presidente Biden dovrà risolvere questa anomalia) che ben 5 milioni di lavoratori essenziali in prima linea, come operatori sanitari e ricercatori, erano immigrati senza garanzie (a partire dalla copertura sanitaria); in Italia, causa tagli continui alla voce sanità, mancavano posti letto di terapia intensiva, medici, infermieri e tecnici, materiale e tecnologie per assistere al meglio i pazienti e proteggere gli operatori sanitari. Si è cercato di mettere toppe, ma intanto per una fetta iniziale del tempo in cui la pandemia prendeva piede la situazione era più che drammatica. Grazie anche a una burocrazia kafkiana. Tutto dovrà trovare soluzioni. Importante anche una nuova organizzazione sociosanitaria delle metropoli, che sono risultate le più fragili e le più esposte rispetto alla pandemia. Non a caso il virus si è diffuso rapidamente fino a superare i confini in una città di 11 milioni di abitanti in Cina, a Wuhan. Poi cambiare l’ottica della prevenzione, studiando per esempio parametri da tenere sotto controllo per prevedere una possibile nuova pandemia o per controllare peggioramenti nella popolazione di patologie non trasmissibili, come il diabete, le malattie cardiovascolari, le neurodegenerative, l’obesità, eccetera. Un Radar della salute, a partire da un Radar pandemico.
Il Global Health Summit ha fissato la Road Map mondiale nella dichiarazione, o Carta, di Roma. E il G7 in Cornovaglia oltre a ribadire di sospendere i brevetti sui vaccini antiCovid (come richiesto anche dal Parlamento europeo) ha lanciato una nuova Carta Atlantica. Sempre più vicini al dopo Seconda Guerra mondiale per il post pandemia. Ricorrente nell’Unione europea è ormai la consapevolezza di arrivare al più presto a una sanità unica. Tra le “missioni” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, varato dal Governo Draghi, trova spazio l’ammodernamento digitale del parco tecnologico negli ospedali italiani, con un investimento di 1,19 miliardi di euro previsto per l’acquisto di 3.133 nuove grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico. E la Carta di Roma sottolinea più volte l’esigenza impellente di organizzare, o riorganizzare, una sanità del territorio, capillare, tecnologica (telemedicina), stressata su prevenzione e assistenza domiciliare. Come dice Emilio Augusto Benini, Presidente Federazione Associazioni Nazionali dei Diabetici (FAND): “Il territorio è il fulcro della sanità futura”. Non più rinviabile, infine, un piano Ricerca e sperimentazione clinica che ponga l’Italia in grado di essere autosufficiente e propositiva.
Poi i vari G lasciano da parte ogni remora per la sostenibilità
3
e alla tutela del clima. Insomma, politicamente, diventa chiaro che investire sulla tutela della salute del pianeta e dei suoi abitanti può essere il motore dell’economia prossimo ventura. Non a caso il presidente Biden ha riportato immediatamente gli Stati Uniti nell’alveo dell’OMS e dell’accordo sul clima di Parigi del 2015, invertendo le scelte dell’amministrazione Trump. Alla luce di questi dati, è evidente che il coronavirus ha senza dubbio messo a dura prova le democrazie occidentali evidenziandone le carenze strutturali. Ed è evidente che il bicchiere è mezzo pieno, se non pieno, se si avviano rapidamente cambiamenti positivi. Occorre dare al più presto certezze e risposte ai cittadini, la cui salute mentale ed emotiva è stata messa a dura prova da lockdown, coprifuoco, distanziamenti fisici, mascherine, Dad e smart working. Un sondaggio internazionale condotto da Ipsos per il World Economic Forum ha indagato le percezioni relative al ritorno alla normalità pre-Covid e agli effetti che il Coronavirus ha avuto sulla salute mentale ed emotiva. Sondaggio che ha coinvolto 30 Paesi: il 59% degli intervistati si aspetta di poter tornare a qualcosa di simile alla sua normale vita pre-Covid entro i prossimi 12 mesi. Inoltre, il 45% degli intervistati afferma che la propria salute mentale ed emotiva è peggiorata dall’inizio della pandemia. Soltanto una persona su cinque (10%) afferma che per ritornare alla normalità e alla propria routine ci vorranno più di tre anni (10%) e l’8% ritiene che ciò non accadrà mai. Le opinioni su quando aspettarsi un ritorno alla normalità variano ampiamente tra i vari Paesi. In particolare, in Italia, il 46% dei cittadini ritiene che il ritorno alla normalità pre-Covid sia auspicabile entro 12 mesi. Invece, la maggioranza, pari al 53%, afferma che occorrerà molto più tempo.

Lo scenario delineato da uno studio condotto dall’Istituto superiore di sanità e dalla Fondazione Kessler ci dice che per raggiungere l’obiettivo “Zero-Covid” bisognerà aspettare gennaio-febbraio dell’anno prossimo. Attenzione però alle varianti, che possono cambiare la situazione in qualsiasi momento. Lo studio ipotizza, infatti, che le varianti possano far aumentare la trasmissibilità del coronavirus dal 20% all’80% in più rispetto al virus originario. Nella peggiore delle ipotesi, cioè con una trasmissibilità superiore al 20%, diventerebbe arduo raggiungere l’obiettivo “zero Covid” in 2 anni. Tuttavia, i vaccini potrebbero fare la differenza: anche se il vir us dovesse avere una maggiore trasmissibilità fino al 60%, in presenza di una forte campagna di vaccinazione, si potrebbero comunque allentare le misure di contenimento quasi completamente dopo 14 mesi. Importante è vaccinare il più rapidamente possibile tutto il mondo perché poi potremmo trovarci con una pandemia di ritorno o con nuovi virus, mix con altri che in continenti come l’Africa dilagano. E in tutta l’Africa a fine giugno 2021, in media, aveva ricevuto una dose di vaccino solo lo 0,7% della popolazione.
Ma questo è ancora il bicchiere mezzo vuoto e sarebbe un successo farlo diventare in tempi brevi mezzo pieno.

5


6 EDITORIALE AGORÀ ZIBALDONE CITIES SPEAKING ANCI URBAN HEALTH: Comune di Imola RECENSIONI G20: PEOPLE, PLANET, PROSPERITY La Presidenza italiana del G20 Rome Global Health Summit La Dichiarazione di Roma del Vertice Mondiale sulla Salute PRO LAB FOCUS ON | G20: tre P per ripartire #WOMEN20, Una health roadmap verso il G20 G20/UNEP: Città resilienti, intelligenti e sostenibili. Il potere delle soluzioni basate sulla natura GIORNATA NAZIONALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE NELLE CITTA - 2 LUGLIO Il tema dell'edizione 2021: RIPARTIAMO Il valore della Giornata Il Documento: "Health in the cities: key priorities for the G20" I partner URBES AWARDS 2021 Il Premio La metodologia Premio URBES CITTA DEL BENESSERE E DELLA SALUTE Bari Bologna Milano Premio URBES SALUTE BENE COMUNE Cosenza Trieste PREMIO URBES COMUNITA DEL BENESSERE APPIGNANO DEL TRONTO CAPIZZI CHIERI SACILE


CITIES CHANGING DIABETES URBAN DIABETES ACTION FRAMEWORK URBAN HEALTH E ANCI REGIONALI ROMA CCD REPORT MILANO CCD REPORT FOCUS ON - SALUTE, BENESSERE, AMBIENTE, SPORT GIORNATA DELL'EUROPA GIORNATA DELLA TERRA IN ASIA SI GIOCA LA PARTITA DELLA SOSTENIBILITÀ NEXT GENERATION CITY DALLO SPAGO AL DIGITAL… CHE TURISMO CI ATTENDE, MODERNO O ALLA MODA? HEALTH CITY MANAGER: CONCLUSA LA PRIMA EDIZIONE DEL CORSO ANCI-HCI LVII CORSO DI ERICE "RE-THINK CITIES AND LIVING SPACES FOR PUBLIC HEALTH PURPOSES" ENLIGHTENME: CONFERENZA INTERNAZIONALE "SHAPING LIGHT FOR HEALTH AND WELLBEING IN CITIES" UN NUOVO MODELLO DI CITTÀ: LA SPORTCITY WALKABLE CITY: UNA CITTÀ "A PASSO" COI TEMPI ADVERTISING CITIES CHANGING DIABETES GIORNATA NAZIONALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE NELLE CITTÀ INDICE
Agorà
Ripartire
Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute, Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) della Presidenza del Consiglio dei Ministri



8
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inaugurando a Cremona la nuova Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica, lo scorso mese di maggio, ha voluto ricordare che “È giunto il momento della ripartenza. Pensiamo ai giovani, abbiamo un debito verso di loro”. Un appello chiaro e forte che richiama tutti all’impegno di mettere alle spalle un periodo buio e pensare al futuro.
Anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nell’evento di commemorazione delle vittime del Covid tenutosi a Bergamo, aveva sottolineato come “Gli italiani non vedono l’ora di ripartire”, in una continuità di narrazione istituzionale che anima non solo i vertici dello Stato, ma che interpetra il sentiment dei cittadini.
Il ”ripartire” è anche il tema scelto a gennaio scorso dal gruppo di lavoro dell’Health City Institute e di C14+ che celebreranno il 2 luglio la “Giornata Nazionale per la salute e il benessere nelle città”.
La scelta del titolo di quest’anno della Giornata Nazionale nasce dalla sensazione di profonda necessità sociale per cui, per tutti noi, è arrivato il momento di uscire dalla fase pandemica acuta, che ha salvato con le sue regole, ma anche condizionato e rese tristi e tenebrose le vite di tutti noi e ridare, a questa società ferita e fragilizzata, la certezza che è arrivato il momento, appunto, di ripartire.
Ripartire in tutti i settori, puntando sulla coesione sociale e sul senso di comunità, collanti indispensabili dopo ogni momento di crisi epocale.
Ripartire imparando da quanto è successo, non dimenticando la lezione che purtroppo la pandemia COVID-19 consegna alla storia, indicandoci come ormai tutti noi viviamo in una bolla globalizzata, dove gli individualismi, fossero persone o Nazioni, non trovano il modo di poter esistere e resistere all’evoluzionismo sociale e umano.
Ripartiamo mostrandoci più attenti, o almeno meno disattenti, ai determinanti della salute, non dimenticandoci come la diffusione della infezione COVID-19 abbia evidenziato i pericoli di vivere in un mondo globalizzato e impreparato nel prevenire le emergenze acute e inattese, come quelle derivanti dalle epidemie a rapida diffusione. Un mondo talmente distratto da sottovalutare i dati che già segnalavano come nel periodo 2011-2018 erano state registrate 1.483 epidemie in 172 Paesi del mondo la cui mancata diffusione è stata solo legata al luogo di origine, più o meno popolato, e al grado di diffusibilità e andamento subdolo del virus.
Ripartiamo da quanto dichiarato dai leader mondiali del G20, riuniti a Roma per il Global Health Summit, e dall’impegno da loro preso ad aprire un nuovo capitolo della politica mondiale per adottare una serie di azioni volte ad accelerare la fine della crisi COVID-19 in ogni parte del mondo e a migliorare la preparazione ad eventuali future crisi sanitarie globali quali le pandemie.
Ripartiamo dalla formazione: dalla scuola, dall’università, dalla scienza e dalla ricerca scientifica, riconoscendo alle stesse dignità, risorse e soprattutto capacità di ascolto da parte della politica e delle istituzioni, facendo diventare gli
stessi elementi e pilastri indispensabili sui quali radicare linee di intervento solide e costantemente presenti nella vita e nello sviluppo del nostro Paese e non soltanto durante le emergenze.
Ripartiamo dai giovani, che certamente hanno pagato e pagheranno uno dei prezzi più alti di questa crisi pandemica in termini di socialità, istruzione e lavoro, investendo su di loro, sui loro sogni, sulle loro aspettative, sul loro desiderio di costruirsi il proprio domani e la propria famiglia.
Ripartiamo dai fondi europei del Programma NEXT GENERATION EU per fare le riforme necessarie e i progetti, per avere un Paese moderno e proiettato verso le sfide della competitività, dell’innovazione e della sostenibilità ambientale, e non solo un bancomat dove prelevare al bisogno.
Ripartiamo dando slancio all’economia reale e agli investimenti per l’innovazione, in grado di produrre lavoro, occupazione e non sfruttamento.
Ripartiamo da un nuovo concetto di socialità, una socialità dimenticata, distanziata e ferita, che ha scoperchiato tutte le nostre insicurezze e vulnerabilità, ricordandoci del prossimo, del vicino, dell’ultimo, sperando che la diffidenza sociale determinata dalla paura pandemica ceda presto il posto al sorriso, all’abbraccio e alla solidarietà.
Ripartiamo dal concetto di salute e benessere come bene comune, un bene comune che non è la somma dei beni individuali, ma piuttosto come l’insieme degli individui che solo in una comunità possono trovare soluzioni e proiettarsi nel futuro.
Ripartiamo dalle nostre città e dai nostri sindaci, dando alle comunità cittadine e alla loro organizzazione e gestione una dimensione vivibile e sostenibile. Le città dei 15 minuti diventino realtà, e non sogni, disegnando o ridisegnando le stesse in modo che nel raggio di un quarto d’ora a piedi, o in bicicletta, la persona possa essere messa in grado raggiungere la propria comunità di riferimento, avendo accesso al lavoro, cibo, alloggio, salute, educazione, cultura e tempo libero.
Ripartiamo da noi stessi pensando realmente di essere ognuno il fautore di un cambiamento che porti benessere e prosperità a noi e alle generazioni future, perché come dice un proverbio amerìndio “La Terra non è un’eredità ricevuta dai nostri Padri, ma un prestito da restituire ai nostri Figli”.
ZIBA
“QUINDICI MINUTI PER CAMBIARE LA PROPRIA VITA

10
Cosa possiamo fare in quindici minuti? Caroline Buchanan, esperta di self-help, dice che bastano 15 minuti per cambiare la propria vita.
Ne è fortemente convinta, tanto che ha ideato la tecnica e scritto un libro sul tema: mettiti seduto con un foglio di carta e una penna e comincia a fare un self-brainstorming su una questione particolarmente importante, tralasciando ogni altro pensiero a favore di quello che devi fare nei successivi quindici minuti.
Potresti ad esempio rilassarti e leggere quel capitolo di un libro o una rivista che non riesci mai a leggere e che è posato sul comodino da tempo, oppure ascoltare un podcast di una trasmissione preferita, o ascoltare la tua musica preferita e ballare, o invece guardare un video su youtube per imparare qualcosa di nuovo o per farti due risate, o fare una seduta di yoga.
“Quindici minuti per te stesso e per il tuo benessere” è un obiettivo oggettivamente perseguibile da ognuno di noi. Ora proviamo a immaginare un sindaco che pensi di regalare benessere ai propri concittadini e che si metta davanti a un foglio di carta per fare un brainstorming sulla propria città.
Vedrà una città difforme piena di diseguaglianze, di periferie spesso invivibili, prive di una rete sociale di prossimità, di una popolazione cittadina sempre in movimento come cavallette impazzite che si sposta su mezzi pubblici e privati da un capo all’altro della città alla ricerca di…
ISTAT ci dice che solo un italiano su dieci si reca ogni mattina a piedi sul posto di lavoro e il 20% impiega più di mezz’ora per raggiungere lo stesso.
Oggi le aziende hanno il mobility manager, una figura in grado di supportare gli spostamenti del proprio personale ottimizzando tempi e risorse, nella giusta convinzione che meno stress per arrivare sul posto di lavoro si traduce in maggiore efficienza ed efficacia.
Ormai una famiglia sceglie la casa in cui abitare vicino al posto di lavoro e di conseguenza la scuola dei figli e i nonni debbono essere “a portata di mano”, la palestra sotto casa come la scuola calcio e la piscina dei figli e si utilizzano i servizi del proprio quartiere, perché il tempo speso per gli spostamenti diventa il fattore chiave del proprio benessere, o malessere.
La pandemia, il lockdown, il ”coprifuoco”, lo smart working ci hanno abituati a una dimensione cittadina a misura di quartiere, dove avere tutto a portata di mano, e questa è una vera rivoluzione dell’amministrare il proprio tempo, il proprio spazio, le necessità del proprio nucleo familiare. Cesare Marchetti, fisico italiano di valore internazionale, nel 1994 pubblicò uno studio rivoluzionario “Anthropological
Invariants in Travel Behavior” che dimostrava come ognuno di noi nel concepire i propri spostamenti agisce con l’istinto dell’uomo primitivo.
In pratica, ci dice Marchetti, che ognuno di noi, in base a questo istinto, determina quanto tempo è disposto a destinare per i propri spostamenti, considerando la propria casa come la caverna dove rientrare.
Quel tempo che ci porta dalla nostra abitazione al posto dove dobbiamo andare prende il nome di “costante Marchetti”, una costante che oggi, con i mezzi di trasporto pubblici e privati, non si riduce ma ci consente di aumentare la distanza dalla nostra “caverna”.
Le città antiche venivano concepite in maniera tale che le mura che le circondavano potessero essere percorse in un tempo ragionevole e oggi è la metropolitana che assolve allo stesso concetto, trasportnado masse di persone in poco tempo da un capo all’altro della città.
Carlo Moreno, direttore scientifico della Sorbona di Parigi, ci dice che forse questo istinto primordiale potrebbe e dovrebbe cambiare.
Moreno ci invita a non sprecare il nostro tempo negli spostamenti ma a concentrarci piuttosto su una dimensione di spostamenti, all’interno della città, pari a 15 minuti.
Una “città dei 15 minuti”, in cui tutti i servizi siano a disposizione dei cittadini a una distanza massima di 15 minuti, in bicicletta o a piedi, dove il posto di lavoro e il luogo in cui sviluppare i propri interessi stiano in quel raggio di tempo.
Una città che non sia un insieme di periferie con un centro storico e/o un centro commerciale avulso dal contesto, ma una città in grado di influire positivamente sul ritmo della propria comunità, ricollegando le persone con il proprio territorio.
I benefici di questa rivoluzione stanno nell’impatto ecologico e nella riduzione dell’inquinamento, nel benessere individuale e in una maggiore qualità di vita, nel tempo guadagnato da “spendere” per sé stessi e la propria famiglia, nel ridare un senso alle periferie, ai legami interpersonali e nel rilanciare le reti di prossimità.
La pandemia ci ha dimostrato che questa rivoluzione è possibile, se in quel foglio di carta che il sindaco ha a disposizione per il brainstorming pensa al benessere dei propri cittadini.
Il giornalista americano Herb Caen dice, infatti, che “una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza, ma dall’ampiezza della sua visione e dall’altezza dei suoi sogni”. E oggi il sogno è quello di avere città a misura d’uomo.
11
LDONE
di Frederick Greenhouse
CITIES SPEAKING
Santa Fe, in Messico, è un esempio plastico della disuguaglianza sociale che dilaga nelle città. Mentre in un settore ha edifici alti e moderni e quartieri lussuosi costruiti negli ultimi due decenni, in quello accanto diventa una realtà completamente diversa, caratterizzata da zone di deprivazione e residenti a basso reddito, come se fossero due mondi isolati divisi da un muro.

Una distribuzione irregolare della ricchezz a, illustrata in una serie di immagini aeree catturate dal fotografo Oscar Ruíz e prodotta dall’agenzia pubblicitaria messicana Publicis, per la campagna “borrar la diferencia”. La campagna cerca, attraverso le fotografie, di evidenziare l’enorme disuguaglianza esistente e la situazione di segregazione urbana e sociale che esiste in alcuni quartieri della città di Santa Fe, con l’obiettivo sintetizzato dal motto “cancellare la differenza”.
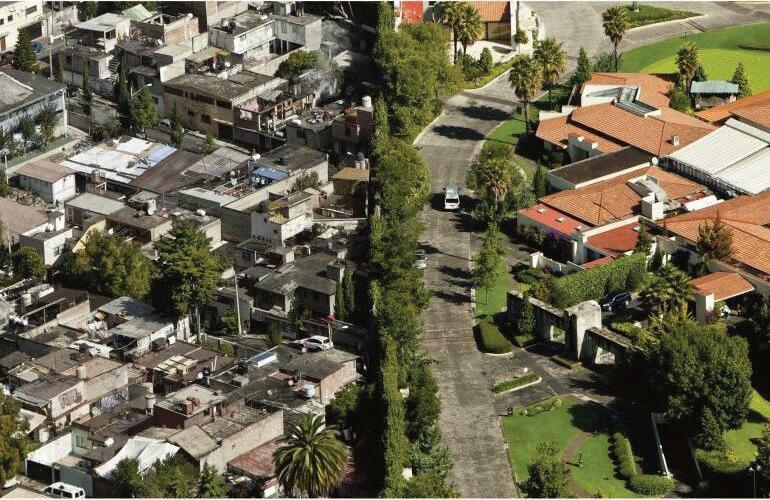
Muri di diseguaglianza urbana che purtroppo non appartengono solo a Santa Fe e che sono difficili da abbattere.
Il 12 Gennaio del 2007 alle 7:51 un uomo entra nella stazione della metro a Washington DC, vestito in modo assolutamente comune: jeans, T-shirt e un cappello di una squadra di baseball, i Washington Nationals, si mette in un angolino per ripararsi dal freddo, apre una custodia ed estrae un violino.
12
di Frederik Greenhouse
La stazione Enfant Plaza della metropolitana é una delle più trafficate di Washington DC e l’uomo aveva calcolato bene che migliaia di persone sarebbero passate per la stazione, molte delle quali sulla strada per andare al lavoro.


Le persone camminavano veloci, gettando uno sguardo distratto a questo violinista quarantenne che suonava con una certa maestria pezzi di Bach.
Dopo pochi minuti nella custodia lasciata aperta cadde il primo dollaro da parte di una donna. I bambini erano invece i più attenti osservatori della musica suonata, forse più per curiosità nel sentire la melodia di un violino in quella stazione.
Alcuni minuti dopo, il violinista ricevette il primo dollaro di mancia: una donna tirò il denaro nella cassettina e senza neanche fermarsi continuò a camminare.
Nei 43 minuti in cui il musicista suonò, solo 6 persone si fermarono e rimasero un momento. Circa 20 gli diedero dei soldi, ma continuarono a camminare normalmente. Raccolse 32 dollari. Quando finì di suonare e tornò il silenzio, nessuno se ne accorse. Nessuno applaudì, né ci fu alcun riconoscimento.
Nessuno lo sapeva ma il violinista era Joshua Bell, uno dei più grandi musicisti al mondo. Suonò uno dei pezzi più complessi mai scritti, con un violino del valore di 3,5 milioni di dollari.
Due giorni prima che suonasse nella metro, Joshua Bell fece il tutto esaurito al teatro di Boston e i posti costavano una media di 100 dollari.

Questa è una storia vera. L’esecuzione di Joshua Bell in incognito nella stazione della metro fu organizzata dal quotidiano Washington Post come parte di un esperimento sociale sulla percezione, il gusto e le priorità delle persone. La domanda era: “In un ambiente comune in un orario inappropriato: percepiamo la bellezza? Ci fermiamo ad apprezzarla? Riconosciamo il talento in un contesto inaspettato?”.

Nei 43 minuti nei quali Bell ha suonato alla Enfant Plaza sono passate oltre mille persone. Qualcuno, in effetti, ha apprezzato: il Washington Post li ha fermati e, in un momento successivo, senza quindi interrompere o alterare in qualche modo l’esperimento, li ha anche intervistati. La prima persona tra i passanti a essere particolarmente colpita dalla musica di Bell è stato un giovane manager del ministero dell’energia, John David Mortensen. Mortensen ama il rock, e non conosce la musica classica, perché al giornalista che lo ha intervistato ha spiegato: “Qualunque fosse la ragione, mi ha fatto sentire in pace”. E, infatti, è stata la prima volta che ha dato dei soldi a un musicista di strada.
E c’è stata, una sola persona che ha riconosciuto Bell, Stacy Furukawa, una funzionaria del ministero del commercio, che lo aveva ascoltato tre settimane prima in un concerto alla Libreria del Congresso:”È la cosa più incredibile che abbia visto a Washington - ha detto in seguito la donna - Joshua Bell suonava nell’ora di punta, e la gente non si fermava, non lo guardava, qualcuno gli lanciava una monetina! Monetine! Ho pensato, ma in che città distratta vivo, dove nessuno si ferma un momento per l’arte!”.

Città troppo veloci per capire i dettagli che la compongono
di Chiara Berti Manager e docente universitaria

La forza dell’acqua, la bellezza della natura, la bontà del cibo.
La ciclabile del Santerno
come driver di sviluppo eco-sostenibile per un territorio che investe sulla salute e sulla qualità della vita

14
Sindaco Marco Panieri
L’Emilia-Romagna, si sa, è affascinante se percorsa sull’asse della via Emilia, tra storia e innovazione, tra turismo slow e divertimento, tra mille colori e altrettanti sapori. Basti pensare alle trasformazioni -per nome e dimensioni- che assume la farina da Piacenza a Rimini, passando per tigelle, piadine e crescentine.
Ma se si lascia la via Emilia e si svolta verso l’Appennino, in qualunque momento, si scoprono valli meravigliose che l’acqua ha percorso nei millenni ed ha cullato con fervore. Si celano borghi, castelli, pievi, torri, ponti che raccontano centinaia di anni di storia di un territorio che il vero montanaro conosce alla perfezione, ma che le nuove generazioni rischiano di perdere o di non apprezzare.
Ecco come è intervenuta la politica negli ultimi anni nei comuni del Circondario Imolese, attualmente guidato dal Presidente Marco Panieri, sindaco della città di Imola. E’ stato deciso di intervenire in un’azione complessa e sinergica tra tutti i Comuni del Circondario, un percorso pluriennale che ha portato alla creazione della Ciclabile del Santerno, il fiume che attraversa il territorio e da cui prende il nome l’intera vallata. Un percorso che, valorizzando il patrimonio storico e naturale, vuole diventare un driver di sviluppo eco-sostenibile per un territorio che punta sulla salute e sulla qualità della vita.
La Ciclabile del Santerno, inserita nel sistema più ampio della Bicipolitana (Rete Ciclabile Metropolitana Bolognese)

accompagna per quasi 44km la Vallata del Fiume Santerno, da Mordano a Castel del Rio, passando per Imola e attraversando il Parco della Vena dei Gessi, candidato a diventare sito Patrimonio Unesco. Un’opera di oltre 3 milioni di euro, dei quali più di 2 milioni finanziati da Bando periferie e il restante milione suddiviso dai Comuni interessati. Questo racconto della Vallata entrerà a fare parte del progetto “Un’identità visiva della Ciclovia del Santerno” -finalizzato a rendere riconoscibile un’opera strategica e promuovere il territorio in maniera coerente ed efficace- con il quale i comuni hanno vinto il bando P.T.P.L. 2021 FILONE 2 – ‘Iniziative di promozione turistica di interesse locale’ pubblicato dalla Città Metropolitana di Bologna.
Il percorso ha l’obiettivo di valorizzare e mettere a sistema la progettualità e le competenze di tutti gli attori già attivi sul territorio (privati/associazioni/associazioni di categoria), che assieme ai Comuni e a IF- Imola Faenza Tourism Company, intendono contribuire a rendere la ciclabile uno strumento per raccontare la Vallata del Santerno e le sue ricchezze naturalistiche, storico-artistiche, geologiche, enogastronomiche. Sono sempre più frequenti le cosiddette PPP -Public and Private Partnership- che pubbliche amministrazioni e privati intrecciano per innescare politiche turistiche e di marketing territoriale.
Ben si presta la modalità PPP da un lato a raggiungere obiettivi legati alla salute, alla promozione dell’attività fisica
15
Tratto parallelo al Santerno con vista su Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola
16
come strumento di prevenzione di malattie degenerative, che sappiamo stanno entrando con preponderanza nei contesti domestici e familiari e che caratterizzano le agende dei pubblici decisori che ogni giorno leggono numeri in crescita. Le amministrazioni locali auspicano la nascita di gruppi di “camminatori” volontari come avviene in tante città europee volte a raggruppare cittadini che semplicemente da soli non avrebbero la giusta motivazione per passeggiare. E’ scientificamente dimostrato come la camminata sia uno dei migliori strumenti a disposizione dell’uomo per prevenire patologie croniche come il diabetiche, per esempio. Il progetto persegue finalità legate anche alle politiche di governo del territorio, del contrasto al dissesto idrogeologico e della cura degli argini. Tutte quelle menzionate, sono misure che possiamo definire maggiormente rivolte ad un pubblico interno, quali cittadini, imprese e associazionismo locale.
Ma i benefici delle Public and Private Partnership interessano anche la promozione esterna, verso turisti e più in generale stakeholder che non vivono nel territorio e che possono scegliere di visitarlo attratti dalle diverse opportunità a loro riservate. Tra le iniziative innovative che stanno proponendo i privati, a titolo di esempio, una riguarda la possibilità di noleggiare biciclette ed attrezzature per poter percorrere la Ciclovia anche senza essere necessariamente un residente che possiede la propria dotazione personale.
Le pubbliche amministrazioni stanno dando grande attenzione proprio al concetto di intermodalità ed in generale ai servizi che ruotano attorno alla Ciclovia, cercando di favorire il collegamento tra la stazione ferroviaria di Imola e la ciclabile, attraverso il potenziamento della rete di ciclabili cittadine e la realizzazione di colonnine attrezzate per la ricarica di e-bike, il gonfiaggio e la manutenzione della bicicletta.
Possiamo senza dubbio definire questo progetto come un ecosistema innovativo che, partendo dalle peculiarità territoriali, ha fornito alle Amministrazioni locali la possibilità di perseguire diversi obiettivi tra i quali la promozione di itinerari ciclabili e pedonali, la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, naturalistico e geologico, la presa di consapevolezza che il tema dell’accoglienza sia fondamentale per il rilancio soprattutto post-covid, in sinergia con i settori agroalimentari e vitivinicoli, e facendo della prevenzione un potente strumento per migliorare la qualità della vita di queste e delle generazioni future.
 Attraversamento del Santerno a Borgo Tossignano (Isolapress)
Attraversamento del Santerno a Borgo Tossignano (Isolapress)

Environment and Urbanization in Modern Italy di Federico Paolini
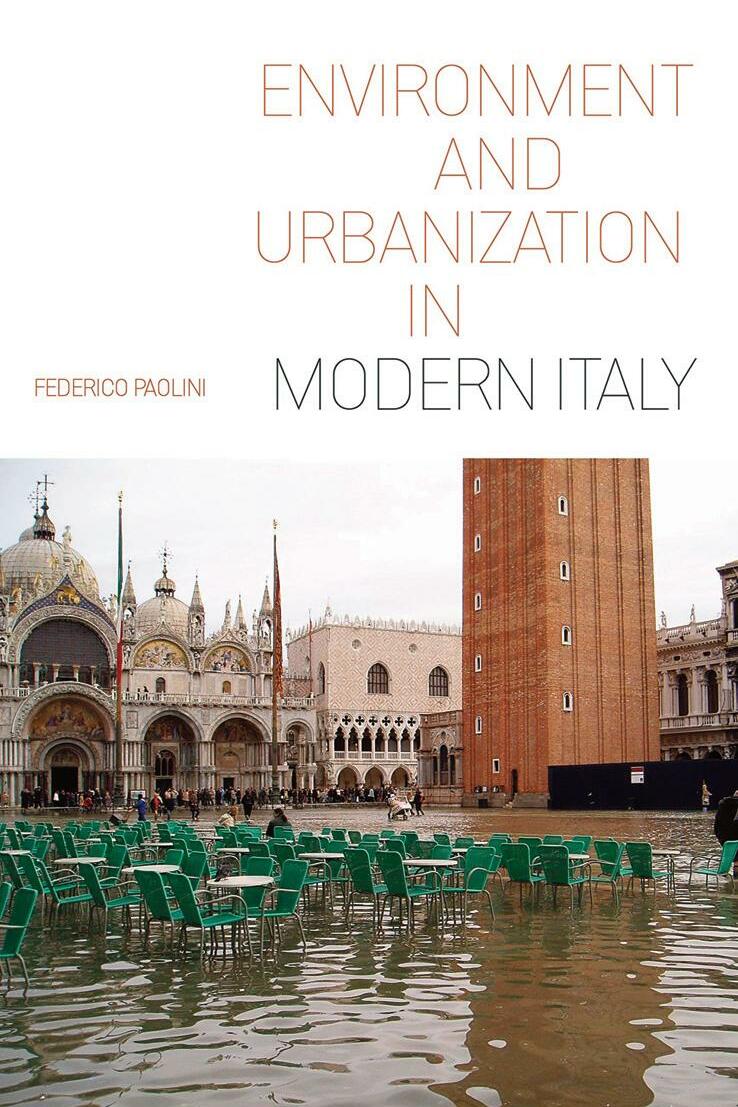

A partire dalla seconda metà degli anni Quaranta, quando in Italia iniziò la ricostruzione postbellica, furono tre i principali motori del cambiamento ambientale: l’incontrollabile processo di deriva urbana, alimentato da ingenti flussi migratori dalle campagne e dalle regioni meridionali verso le città dove su larga scala le attività produttive cominciavano ad accumularsi; sviluppo industriale disordinato, tollerato in quanto visto come il necessario tributo da pagare al progresso e alla modernizzazione; e consumo di massa.

Nel suo quarto libro, Federico Paolini presenta una serie di saggi che spaziano dagli usi delle risorse naturali ai problemi ambientali causati dai mezzi di trasporto, alle questioni riguardanti le politiche ambientali e le dinamiche del movimento ambientalista. Paolini conclude il libro con una previsione sui problemi ambientali che emergeranno nel dibattito pubblico del XXI secolo.

18
A cura di Francesca Policastro
The Ideal City: Exploring Urban Futures a cura di SPACE10 e Die Gestalten Verlag

La città è un esperimento umano in continua evoluzione. Ma nell’ultimo mezzo secolo è cambiato più che mai, con pochi segni di rallentamento. Mentre questo fenomeno si verifica, un numero crescente di architetti, innovatori e decisori politici sta ripensando alla città per sfruttare al meglio lo spazio e le risorse che mette a disposizione per una migliore qualità della vita. Questo libro racconta il design del futuro urbano. Dalle app progettate per ridurre lo spreco alimentare alle infrastrutture innovative per l’acqua dolce, The Ideal City esplora le numerose iniziative e gli esperimenti in essere in 53 città al mondo, nati tutti con l’obiettivo condiviso di rendere le città di domani un luogo più felice, più sano e più inclusivo.

19

G20: PEOPLE, PLANET, PROSPERITY

21
PEOPLE, PLANET, PROSPERITY
ministeriali, incontri degli Sherpa (incaricati di svolgere i negoziati e facilitare il consenso fra i Leader), riunioni di gruppi di lavoro ed eventi speciali.
Nell’ambito dei lavori del G20 assume particolare rilevanza il cosiddetto “Finance Track”, costituito dalle riunioni dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, dei Governatori delle Banche Centrali, dei Viceministri e degli Sherpa (negoziatori) designati dai Ministeri economici dei Paesi membri.
Il Finance Track si concentra principalmente sulle questioni economiche, finanziarie, monetarie e fiscali. Il risultato di questo lavoro confluisce, al termine del processo, nel più ampio “Comunicato” tradizionalmente adottato dai Capi di Stato e di Governo del G20 a conclusione del Vertice.

G20 EMPOWER
I PAESI MEMBRI
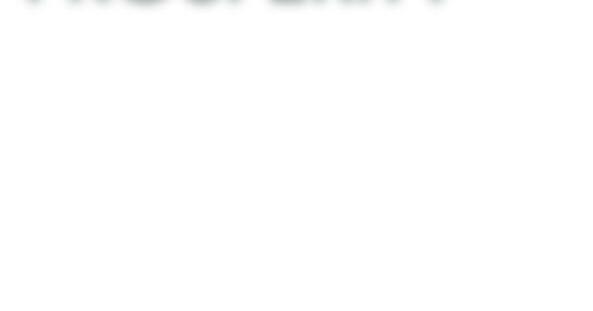
I Paesi membri sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa, Turchia e Unione Europea. A questi si aggiunge la Spagna, che è un invitato permanente del G20.
Ogni anno, la Presidenza invita alcuni altri Paesi, che partecipano a pieno titolo ai lavori del G20, in qualità di ospiti. Vi partecipano inoltre diverse organizzazioni internazionali e regionali, conferendo al foro una rappresentatività ancor più ampia.


COME FUNZIONA IL G20
Il G20 non ha un segretariato permanente: l’agenda del
L’ Alleanza del G20 per l’Empowerment e la Promozione della Rappresentanza delle Donne nell’Economia è un’iniziativa speciale che mira ad accelerare leadership ed empowerment delle donne nel settore privato, facendo leva sull’alleanza particolare istituita fra leader del settore privato e rappresentanti dei Governi dei Paesi G20.

Lanciata in occasione del vertice G20 del 2019 in Giappone e formalmente istituita nel corso della Presidenza saudita nel 2020, comprende ad oggi 27 Membri, fra G20 e Paesi ospiti.
ORIGINI DEL G20
Nel 1999, a seguito della crisi economica del 1997, i Ministri delle Finanze del G7 annunciarono la creazione del“Gruppo dei 20”, con l’obiettivo di coinvolgere altri Paesi nelle discussioni sull’economia e la finanza globale. La prima riunione
22
POPOLAZIONE 60% degli abitanti del pianeta ECONOMIA 80% del PIL mondiale COMMERCIO 75% del commercio estero
ufficiale del G20 si tenne a Berlino nel dicembre dello stesso anno.
Dopo la crisi finanziaria del 2008, gli Stati Uniti proposero di elevare il livello di partecipazione del G20 ai Capi di Stato e di Governo.
Nel 2009, al Vertice di Pittsburgh, i Capi di Stato e di Governo decisero di istituzionalizzare il G20 come principale forum di cooperazione economica e finanziaria a livello glo-

Dal 2010, i Leader del G20 si riuniscono con cadenza an-
Dal 1° dicembre 2020 l’Italia detiene la Presidenza del G20. Nel 2021 la comunità internazionale sarà chiamata a mostrare coraggio e ambizione per vincere le grandi sfide di oggi: dalla pandemia ai cambiamenti climatici, dal sostegno all’innovazione alla lotta contro povertà e disuguaglianze. Il programma della Presidenza si articola intorno al trinomio “People, Planet, Prosperity”, con l’obiettivo di prendersi cura del pianeta e delle persone, assicurando una forte ripresa economica che sia al contempo inclusiva e sostenibile. La Presidenza culminerà nel Vertice dei Leader G20 che si terrà a Roma il 30 e 31 ottobre. La Presidenza italiana e la Commissione europea hanno organizzato inoltre, insieme, il Global Health Summit, tenutosi il 21 maggio, al massimo livello, che consentirà di affrontare le principali sfide connesse all’emergenza sanitaria e ai suoi effetti.
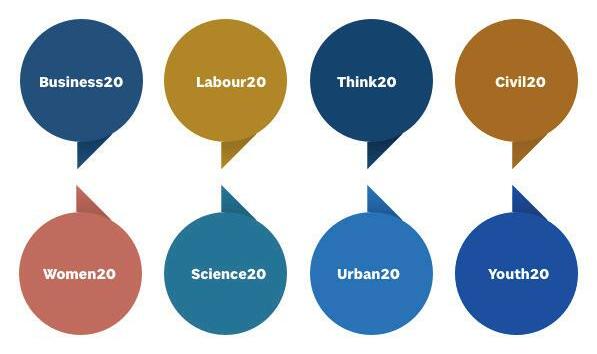
VERTICE, RIUNIONI MINISTERIALI ED EVENTI SPECIALI
Nel corso dell’anno di Presidenza italiana del G20 si terranno numerosi incontri istituzionali (appuntamenti ministeriali e vertice finale) ed eventi speciali dedicati ai grandi temi dell’agenda globale. Ad esempio: la tutela della salute e la sostenibilità ambientale, la ricerca e l’innovazione, l’empowerment femminile, la lotta alla corruzione. La fitta agenda dei lavori interesserà gran parte del Paese, consentendo di valorizzare le straordinarie eccellenze diffuse sul territorio.
ENGAGEMENT GROUPS

In un’ottica di inclusione e partecipazione allargata, il processo decisionale del G20 è stato arricchito nel corso degli anni con il coinvolgimento di “attori sociali”, che si riuniscono nei cosiddetti “Engagement Groups”.

Gli Engagement Groups si occupano di molteplici filoni, di grande rilievo per i lavori del G20. Seguono in particolare i temi dell’imprenditoria, del lavoro, della gioventù, dell’empowerment femminile, delle politiche urbane, dello sviluppo sostenibile e della lotta contro le disuguaglianze. Sono inoltre impegnati nella promozione del lavoro dei think tank e delle università, delle scienze sociali e naturali.
Questi gruppi conducono i loro lavori in modo indipendente rispetto ai Governi, presentando formalmente alla Presidenza le loro raccomandazioni prima del Vertice finale.
23
VERTICE DI ROMA
Il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20 si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre del 2021 e conterà sulla presenza dei membri del G20, di alcuni Paesi invitati e dei rappresentanti di alcune delle principali organizzazioni internazionali e regionali.
All’evento è tradizionalmente prevista la partecipazione dei Ministri dell’Economia. Il Vertice, momento culminante dell’esercizio G20, costituisce il punto di arrivo, a livello di Leader, dell’intenso lavoro svolto durante l’anno nelle riunioni ministeriali, nei gruppi di lavoro e nelle riunioni degli Engagement Groups.
PRIORITÀ
L’umanità si trova oggi ad affrontare ingenti sfide globali, con impatti diretti sulla vita e il benessere della popolazione mondiale. Oggi, più che mai, si rende necessario uno sforzo condiviso di responsabilità e di lungimiranza da parte della comunità internazionale. Il G20, consapevole del proprio ruolo, è fermamente impegnato nella ricerca di risposte coordinate, eque ed efficaci, capaci di porre le basi per un futuro migliore e sostenibile.
La pandemia ha causato danni profondi, incidendo negativamente sui sistemi sanitari, sugli indici di povertà e sull’andamento dell’economia globale, venendosi a sommare alle altre grandi sfide dei nostri tempi, dai cambiamenti climatici alla lotta contro le disuguaglianze. Ha anche evidenziato una lezione essenziale: nell’epoca in cui viviamo, i problemi locali possono rapidamente trasformarsi in sfide globali. Non si può quindi prescindere da soluzioni comuni, che consentano davvero di “ricostruire meglio”, adottando tecnologie e strumenti innovativi per assicurare una crescita più verde e resiliente.
In un mondo sempre più interconnesso, il multilateralismo rappresenta molto più che un semplice concetto astratto. Costituisce la chiave per affrontare le sfide, e il G20, che riunisce gran parte della popolazione mondiale e dell’economia del pianeta, deve essere all’altezza della posta in gioco. Lo sarà nel 2021, sotto Presidenza italiana, focalizzandosi su tre pilastri interconnessi di azione: Persone, Pianeta e Prosperità.
In tale ottica, l’Italia sta lavorando per assicurare una rapida risposta internazionale alla pandemia – che garantisca un accesso equo e universale a diagnosi, terapie e vaccini – e per rafforzare la resilienza globale alle crisi sanitarie del futuro. Guardando oltre la crisi, l’Italia vuole inoltre assicurare una ripresa veloce, incentrata sulle necessità delle persone. Ciò implica un’attenzione particolare alla tutela dei soggetti e dei Paesi più vulnerabili, all’empowerment femminile, al ruolo dei giovani. Significa sostenere il lavoro, la protezione sociale, la sicurezza alimentare.
Si devono creare le condizioni per un rilancio che sia ambizioso, efficace e sostenibile. Un rilancio più efficiente, fondato anche su un migliore impiego delle energie rinnovabili e un chiaro impegno alla protezione della stabilità climatica e dell’ambiente.
Si tratta di prerequisiti essenziali per una prosperità durevole, che richiede anche un utilizzo strategico dei principali motori di crescita ed innovazione. Il G20 si sta quindi adoperando per colmare il divario digitale, rendere la digitalizzazione un’opportunità per tutti, aumentare la produttività e – in sintesi – non lasciare nessuno indietro.
People
La pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi economica e sociale stanno infliggendo un duro colpo ai cittadini di tutte le parti del mondo, mettendo a repentaglio la loro vita, il loro lavoro, le relazioni sociali e peggiorando le prospettive per il loro futuro e per quello delle generazioni più giovani.
Di fronte a questo scenario, il G20 ha il dovere di guidare una ripresa che, partendo dalla risposta all’attuale crisi, guardi anche oltre e contribuisca a dare forma a una società globale più giusta, inclusiva, sostenibile e resiliente, quindi a una società che si possa definire davvero più prospera.
L’unico modo per farlo, in una sorta di nuovo umanesimo, è rimettere la persona al centro delle azioni politiche, multilaterali e nazionali. Ciò significa affrontare con determinazione la povertà, la cui eradicazione costituisce il primo tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ridurre le disuguaglianze diviene quindi fondamentale, ora più che mai, considerando il loro costante incremento negli ultimi decenni, aggravato ulteriormente dall’attuale situazione di crisi. Questo vuol dire tutelare i più vulnerabili, tra cui giovani e lavoratori precari, favorire l’empowerment femminile, assicurare l’accesso universale all’istruzione, ridistribuire le opportunità all’interno dei singoli paesi e diminuire le disparità tra aree geografiche.
Prosperity
L’intero pianeta sta affrontando la peggiore crisi economica dell’ultimo secolo. Le 20 economie più importanti del mondo sono chiamate a collaborare per favorire il ritorno alla prosperità.
La rivoluzione tecnologica è uno strumento fondamentale per raggiungere questo scopo. Per troppo tempo però la digitalizzazione è stata sinonimo non solo di opportunità e crescita economica, ma anche di sperequazioni e precarietà. Per sfruttarne davvero il potenziale, dobbiamo farla divenire un’opportunità per tutti.
Questo significa anzitutto ridurre il divario digitale, sia sotto il profilo infrastrutturale, garantendo l’accesso ad internet per tutti, sia a livello di competenze, favorendo un’adeguata e diffusa alfabetizzazione e formazione digitale.
Significa anche sfruttare il potenziale della rivoluzione tecnologica per migliorare concretamente le condizioni dei cittadini in tutti gli aspetti della loro vita: rendere più efficaci le prestazioni sanitarie; agevolare la condivisione di dati per rafforzare i meccanismi globali di risposta alle pandemie; rendere flessibili i modelli organizzativi per redistribuire meglio il carico di lavoro domestico tra uomini e donne; migliorare l’efficienza delle reti di distribuzione energetica e moltiplicare il raggio di azione delle attività didattiche.
24 IL
L’attività umana e l’esigenza di rispondere alle necessità di una popolazione globale sempre più numerosa stanno destabilizzando gli equilibri naturali del nostro pianeta e indebolendo la sostenibilità della società moderna.
Le sfide da affrontare sono molte e il G20 detiene una grande responsabilità nel guidare la comunità internazionale verso soluzioni concrete e durevoli. Il G20 sta quindi lavorando su temi cruciali, quali i cambiamenti climatici, il degrado dei suoli, la perdita di biodiversità e il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Si tratta di questioni che sono ormai da tempo sul tavolo del G20, sulle quali è necessario, oggi, agire con ambizione per trovare rapidamente risposte adeguate ed efficaci. È necessario avviare una transizione concreta verso economie “verdi”, sfruttando le energie rinnovabili e muovendoci verso città moderne e “intelligenti”, che sono fra le priorità promosse dalla Presidenza italiana. Si sta lavorando su nuovi strumenti a sostegno dell’urbanizzazione sostenibile, dell’efficienza energetica, della mobilità urbana del futuro. Il Vertice G20 costituirà inoltre un appuntamento centrale nel percorso verso la 26a Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP26), momento cerniera nella sfida globale contro i cambiamenti climatici.
Fornire risposte concrete alle esigenze del pianeta non è una semplice opzione, né un esercizio di bilanciamento fra sviluppo umano e tutela dell’ambiente. È una condizione ineludibile per il nostro benessere comune, la pace e la sicurezza internazionale e per la nostra stessa esistenza su questo “punto azzurro pallido”.

25 Planet
ROME GLOBAL HEALTH SUMMIT: SUPERARE I CONFINI PER AFFRONTARE LE SFIDE DEI NOSTRI TEMPI
di Mario Pappagallo
La Dichiarazione di Roma, che ha chiuso il Global Health Summit il 21 maggio 2021 (e che in questo numero di Urbes pubblichiamo integrale, ndr), “sottolinea il ruolo della conoscenza per superare le crisi sanitarie attuali e future. L’ingegno scientifico ha aperto la strada per uscire da questa pandemia”. Lo ha ricordato il presidente del consiglio italiano Mario Draghi, nelle conclusioni del vertice. “L’approvazione per il primo vaccino è stata richiesta nove mesi dopo la dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale da parte dell’OMS, un risultato davvero storico. Dobbiamo continuare a investire nei nostri scienziati e fornire incentivi alle società private affinché facciano lo stesso”. Inoltre, ha aggiunto Draghi, “dobbiamo garantire che le informazioni siano condivise rapidamente e apertamente, mantenendo al contempo un’adeguata tutela della proprietà intellettuale. La collaborazione scientifica internazionale è stata uno dei fattori alla base del rapido sviluppo dei vaccini Covid-19. Abbiamo bisogno di una migliore condivisione dei dati e di un maggiore trasferimento di conoscenza per consentire una distribuzione capillare ed equa dei frutti dell’innovazione”.
“La pandemia ha mostrato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi. Fra queste –ha ancora detto - non vi è solo la pandemia, ma anche le disuguaglianze globali e il cambiamento climatico”. Non poteva il Global Health Summit di quest’anno non affrontare il tema pandemia, gli errori fatti, l’organizzazione da mettere in atto nel caso di future emergenze sanitarie globali. Il Report dei 26 scienziati internazionali chiamati per il Global Health Summit è stato alla base del Summit. Al coordinamento dei 26, Peter Piot (Consigliere speciale
presso la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen) e Silvio Brusaferro (presidente dell’Istituto superiore di sanità). Poi, nel ruolo di guida dei team, Victor Dzau (presidente della National Academy of Medicine degli Stati uniti), Yee-Sin Leo (direttrice del National Centre for Infectious Diseases di Singapore) e John Nkengasong (direttore degli Africas Centers for Disease Control and Prevention).

Il Report, presentato al Global Health Summit di Roma, in sintesi afferma: “La frequenza e la natura delle prossime pandemie dipendono fortemente dalla nostra capacità di adottare stili di vita sostenibili, dall’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dall’approccio ‘One Health’”. Il mondo sta entrando in una “age of pandemics”, cioè in un periodo di pandemie. Per questo occorre prendere coscienza che nessun Paese sarà al sicuro fino a quando non lo saranno anche tutti gli altri, a partire da quelli più poveri e con i sistemi sanitari più fragili. Il Report è un vero e proprio decalogo, sulla base delle evidenze disponibili, che elenca ai governi di tutto il mondo gli interventi necessari non solo a mettere fine alla pandemia, ma anche ad assicurare una migliore preparazione in vista delle future minacce pandemiche. “Abbiamo tracciato una mappa per il futuro, identificando le aree prioritarie per un’azione immediata –scrivono i 26 scienziati -: accesso globale equo alle forniture mediche e agli strumenti necessari ad affrontare il Covid19 e le altre minacce alla salute, ricerca e innovazione, coinvolgimento dei gruppi di ricerca nei Paesi a medio e a basso reddito, sorveglianza integrata delle malattie e condivisione dei dati, ascolto delle indicazioni scientifiche, rafforzamento del personale e dei sistemi sanitari, capacità produttive re-

26
gionali, fiducia pubblica, governance ben coordinata e salute sostenibile”.
Oltre a tracciare le linee guida generali per limitare il rischio di essere travolti da nuove pandemie il rapporto ha cercato di delineare anche il futuro dell’epidemia attuale, sottolineando la necessità di un accesso globale alle risorse per poterla controllare. “La probabile traiettoria per il Sars-Cov-2 è di diventare endemica con dei focolai stagionali a causa della diminuzione dell’immunità naturale, della copertura globale insufficiente dei vaccini e, o, dell’emergere di nuove varianti che non sono controllate dai vaccini attuali. Nuove ondate epidemiche sono possibili soprattutto nei Paesi con una bassa copertura vaccinale. Un’equità globale nell’accesso, così come un’accettazione diffusa e una somministrazione efficiente, è sia un imperativo morale sia un’esigenza critica per il controllo della pandemia”. Al riguardo, il nostro presidente del consiglio ha sottolineato che è “essenziale rafforzare il ruolo delle istituzioni multilaterali (quali l’Organizzazione mondiale della sanità, OMS, ndr) nel campo della salute globale e oltre”. Draghi ha sottolineato che bisogna “fornire all’OMS finanziamenti sostenibili e prevedibili e consentire ad essa di diventare più efficace. Come abbiamo appreso durante questa crisi, una forte guida internazionale è fondamentale per garantire che sia in atto un efficace sistema di allerta precoce e che i governi possano condividere rapidamente le loro migliori pratiche per prevenire, contenere e gestire una pandemia”. Il premier Draghi ha anticipato un possibile trattato internazionale vincolante per gli Stati. “C’è un’ipotesi che è stata ventilata per cui potremmo aver bisogno di un trattato, una forma più vincolante rispetto alla Dichiarazione di Roma di chiusura del Summit. Ma il futuro è ancora aperto”. “Io non ho alcun dubbio – ha aggiunto - che gli impegni presi in termini di aiuto ai paesi poveri verranno mantenuti, ma è molto importante attrezzarsi, perché quando ci sarà la prossima pandemia potremo reagire senza egoismo”. Questo vale “non tanto per l’Europa, ma ci sono stati Paesi che non esportavano, come gli Usa e il Regno Unito“.
Nelle conclusioni del Global Health summit il premier Mario Draghi invita anche ad “affrontare significativi rischi economici. Le istituzioni finanziarie internazionali – spiega – devono fornire ai Paesi a basso reddito il sostegno necessario affinché questa crisi sanitaria non si trasformi in un’ondata di crisi del debito sovrano. In particolare, ora dobbiamo mettere il Fondo monetario internazionale (FMI) nella condizione di fornire una protezione efficace ai paesi più poveri del mondo”. E l’FMI ha subito risposto: “Non ci può essere una fine della crisi economica senza una fine della crisi sanitaria. Mettere fine alla pandemia è un problema risolvibile ma richiede un’ulteriore azione globale coordinata”, ha fatto sapere il direttore generale del FMI, Kristalina Georgieva, proponendo un piano da 50 miliardi di dollari per mettere fine alla pandemia. “Il mondo non deve sperimentare il dolore di un altro balzo di casi di Covid. Con una forte azione globale ora e pochi finanziamenti rispetto ai benefici, possiamo uscire da questa crisi finanziaria”. E riguardo alla proprietà intellettuale dei brevetti, Draghi ha comunicato che c’è “l’idea di fare una liberalizzazione temporanea, circoscritta, dei brevetti. Ha il vantaggio di essere” un metodo “diretto e semplice. Ma lo svantaggio è che non è sicuro che dia la produzione vaccinale, visto che è estremamente complessa. Poi ci sono altre soluzioni, come la sospensione volontaria dei brevetti”, spiega Draghi. Per quanto riguarda le società farmaceutiche, continua il premier, “si sono impegnate e hanno messo in gioco anche la loro reputazione: è un passo molto importante che cambierà il panorama. Se manterranno l’impegno, molte delle controversie sui vaccini, pur rimanendo importanti, assumeranno un’importanza leggermente minore”. Di rimando a
Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron al Global Health Summit è stato molto chiaro: “Non ci dev’essere nessun tabù ogni volta che la proprietà intellettuale è un ostacolo dobbiamo dare una risposta. Se le conclusioni del G20, caro Mario, implicheranno l’uso di nuove misure in materia di proprietà intellettuale io le sosterrò”.
C’è bisogno di decisioni coraggiose ed innovative, per riorientare la lotta al Covid-19 nel senso di una sfida collettiva. Si tratta di scelte moralmente e pragmaticamente ineludibili. Moralmente, perché la salute è un diritto umano. Pragmaticamente, perché le sacche di ‘’non vaccinazione’’ creano i presupposti per nuove varianti che circolano liberamente, come le merci.
La straordinarietà della pandemia ha stimolato risposte ‘’straordinarie’’ da parte di diversi organismi. Per esempio, la ricerca di nuovi vaccini è stata sostenuta da ingentissimi finanziamenti pubblici. L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e la Food & Drug Administration (FDA) statunitense hanno fatto ricorso all’autorizzazione “condizionale” e “d’emergenza” per accelerarne la disponibilità. Ma il mondo del commercio e della proprietà intellettuale resta su posizioni conservatrici. Una proposta presentata in sede dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) da India e Sudafrica per sospendere temporaneamente la protezione della proprietà intellettuale in ambito Covid-19 ha ricevuto il sostegno di un centinaio di Paesi fra cui (limitatamente ai vaccini) gli Stati Uniti, ma non quello dell’Unione Europea divisa al riguardo. Eppure, la proposta è in linea con l’articolo IX del testo fondatore dell’OMC, e risponde a una reale situazione di emergenza, durante la quale i detentori dei brevetti non riescono a far fronte alle necessità globali.
Il Global Health Summit “verrà ricordato come una pietra miliare nella lotta alle pandemie”, ha detto a Roma la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante l’atto conclusivo del vertice che si è svolto in videoconferenza e organizzato su iniziativa della presidenza italiana del G20. Von der Leyen ha evidenziato che due erano le sfide che attendevano i partecipanti all’incontro: una “relativa a contrastare la pandemia nell’immediato” e una “rivolta a costruire un contesto sanitario globale in grado di prevenire prossime emergenze sanitarie“. E ha sottolineato l’impegno di tutti gli aderenti alla Dichiarazione di Roma “a investire nella salute e nei professionisti della sanità”, ricordando “gli operatori sanitari che hanno lavorato senza sosta, salvato vite” e che si sono impegnati “anche quando non c’era più niente da fare”.
L’intervento di Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, ha avuto il suono di uno slogan: “Vaccinare il prima possibile, ovunque”. “Il Covid ci ha detto che la salute pubblica deve essere al centro del mondo perché impatta anche sull’economia e sulla sicurezza globale. Nel mondo le persone ancora muoiono. Dobbiamo vaccinare il prima possibile, ovunque”. E Boris Johnson, primo ministro del Regno Unito, ha annunciato l’obiettivo del suo governo: “Dobbiamo lavorare a una sorta di radar pandemico globale”. E ha con- tinuato: “È il momento di unirsi per sconfiggere la pandemia e prevenirne di nuove: nessuno è al sicuro finché non lo saremo tutti. Dobbiamo sfruttare la Dichiarazione di Roma per andare oltre, istituire una difesa collettiva contro le future minacce sanitarie, come abbiamo fatto contro quelle militari. Dobbiamo rievocare lo spirito che ha forgiato la cooperazione globale dopo la II Guerra mondiale: come presidente G7, abbiamo chiesto al Wellcome Trust di collaborare con i partner per una rete mondiale di centri di sorveglianza, una sorta di radar pandemico globale”.
27
Dichiarazione di Roma del Global Health Summit
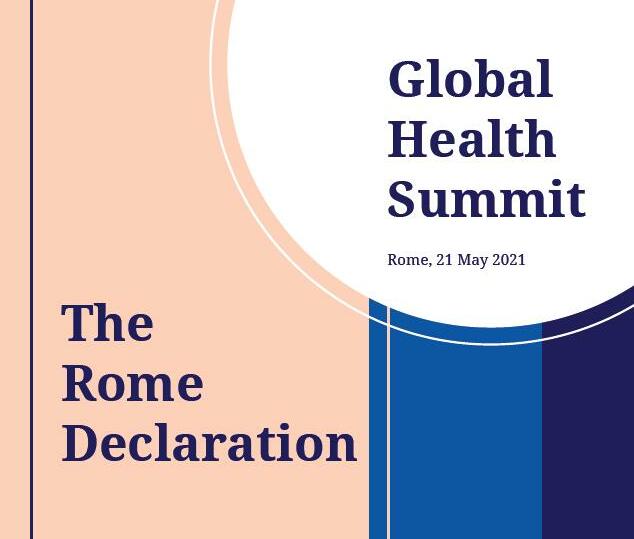
Noi, Leader del G20 e di altri Stati, alla presenza dei Capi delle organizzazioni internazionali e regionali riuniti al Global Health Summit di Roma, 21 maggio 2021, dopo aver condiviso la nostra esperienza della pandemia globale di COVID-19 in corso, e accogliendo con favore il lavoro pertinente in tal senso, compreso quello presentato durante il pre-Summit, oggi:
Ribadiamo che la pandemia continua ad essere una crisi globale senza precedenti in materia di salute e socioeconomica, con effetti diretti e indiretti sproporzionati sui più vulnerabili, sulle donne, le ragazze e i bambini, nonché sui lavoratori in prima linea e sugli anziani. Non sarà finita finché tutti i Paesi non saranno in grado di riportare la malattia sotto controllo e, pertanto, una vaccinazione su larga scala, globale, sicura, efficace ed equa, insieme ad altre misure appropriate di sanità pubblica, rimane la nostra massima priorità, insieme al ritorno a una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva.
Esprimiamo le nostre condoglianze per le vite perse ed esprimiamo il nostro apprezzamento per l’assistenza sanitaria e tutti gli sforzi vitali dei lavoratori in prima linea per rispondere alla pandemia.
Accogliamo con favore la designazione del 2021 da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come Anno degli operatori sanitari e sanitari e riaffermiamo il nostro pieno sostegno al ruolo guida e coordinato dell’OMS nella risposta COVID-19 e nella più ampia agenda sanitaria globale.

Sottolineiamo che gli investimenti sostenuti nella salute globale, verso il raggiungimento della copertura sanitaria universale con l’assistenza sanitaria primaria al centro, One Health, e la preparazione e la resilienza, sono ampi investimenti sociali e macroeconomici nei beni pubblici globali e che il costo dell’inazione è superiore agli ordini di grandezza.
Riconosciamo l’impatto molto dannoso della pandemia sui progressi verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo So-
28
stenibile (OSS). Riaffermiamo il nostro impegno a raggiungerli per rafforzare gli sforzi per tornare meglio (come nella risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dell’11 settembre 2020) e nei regolamenti sanitari internazionali del 2005 (IHR), che insieme miglioreranno la resilienza e i risultati sanitari globali.
Sottolineiamo con forza l’urgente necessità di aumentare gli sforzi, anche attraverso sinergie tra il settore pubblico e quello privato e gli sforzi multilaterali, per migliorare l’accesso tempestivo, globale ed equo a strumenti COVID-19 sicuri, efficaci e convenienti (vaccini, terapie, diagnostica e dispositivi di protezione individuale, d’ora in poi “strumenti”). Riconosciamo la necessità di sostenere tali sforzi con sistemi sanitari rafforzati, ricordando il vertice straordinario del G20 del 26 marzo 2020.
Riconosciamo il ruolo dell’ampia immunizzazione da COVID19 come bene pubblico globale, riaffermiamo il nostro sostegno a tutti gli sforzi collaborativi in questo senso, in particolare l’acceleratore di strumenti COVID-19 (ACT-A).
Sottolineiamo l’importanza di affrontare il divario di finanziamento ACT-A, al fine di aiutarlo a adempiere al suo mandato. Prendiamo atto dell’intenzione di condurre una revisione strategica globale come base per un eventuale adeguamento ed estensione del suo mandato fino alla fine del 2022.
Sottolineiamo il nostro sostegno alla condivisione globale di dosi di vaccino sicure, efficaci, di qualità e convenienti, incluso il lavoro con il pilastro vaccini ACT-A (COVAX), quando le situazioni domestiche lo consentono. Accogliamo con favore il summit di impegno anticipato sul mercato dei vaccini COVID-19 di giugno 2021 (COVAX AMC) e prendiamo atto della Carta per un accesso equo agli strumenti COVID-19.
Prendiamo atto del gruppo di lavoro COVAX sulla produzione di vaccini guidato dall’OMS, dalla Coalizione per le innovazioni di preparazione alle epidemie e comprende partner come l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il pool di brevetti sui medicinali. Affermiamo il nostro sostegno agli sforzi volti a rafforzare le catene di approvvigionamento e a stimolare e diversificare la capacità globale di produzione di vaccini, anche per i materiali necessari per produrre vaccini, anche condividendo i rischi, e accogliamo con favore il polo di trasferimento tecnologico dei vaccini lanciato dall’OMS. Chiediamo al gruppo di lavoro e alla task force di riferire al G20 in tempo utile per il Vertice dei leader di ottobre. La relazione sul come migliorare l’accesso equo nell’attuale crisi sarà condivisa con l’OMC, altre parti interessate e organizzazioni internazionali, in linea con i loro mandati e le loro norme decisionali.
Plaudiamo al raggiungimento senza precedenti di vaccini COVID-19 sicuri ed efficaci entro un anno e sottolineano l’importanza di continuare a investire nella ricerca e nell’innovazione, anche in sforzi multilaterali e di altra collaborazione, per accelerare ulteriormente lo sviluppo di strumenti sicuri ed efficaci.
Sottolineiamo l’importanza di lavorare rapidamente con tutti i partner pubblici e privati pertinenti per aumentare l’equa disponibilità di strumenti e migliorare l’accesso ad essi. Le opzioni a breve termine includono: la condivisione di prodotti esistenti,
compresi i vaccini attraverso COVAX; diversificare la capacità produttiva; identificare e affrontare le strozzature nella produzione; facilitare il commercio e la trasparenza lungo l’intera catena del valore; promuovere una maggiore efficienza nell’uso delle capacità e della distribuzione globale attraverso la cooperazione e l’espansione delle capacità esistenti, anche lavorando in modo coerente nell’ambito dell’accordo TRIPS e della dichiarazione di Doha del 2001 sull’accordo TRIPS e la sanità pubblica; promuovere l’uso di strumenti quali accordi volontari di licenza di proprietà intellettuale, trasferimenti volontari di tecnologia e know-how e messa in comune dei brevetti a condizioni concordate di comune accordo.
Accogliamo con favore una leadership politica di alto livello per la preparazione e la risposta in relazione alle emergenze sanitarie. Prendiamo atto delle proposte su un possibile strumento o accordo internazionale in materia di prevenzione e preparazione alle pandemie, nel contesto dell ’OMS, e degli sforzi dell’OMS, dell’Organizzazione mondiale per la salute animale, l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e altri in relazione al rafforzamento dell’attuazione dell’approccio “One Health” attraverso il loro gruppo di esperti ad alto livello.
Al di là di queste dichiarazioni in vista della pandemia in corso, abbiamo stabilito i principi e gli impegni guida di seguito. Questi servono come orientamento volontario per l’azione attuale e futura per la salute globale per sostenere il finanziamento, la costruzione e il sostegno di capacità efficaci del sistema sanitario e la copertura sanitaria universale per migliorare la preparazione, l’allarme rapido, la prevenzione, l’individuazione, la risposta coordinata, la resilienza e il recupero dall’attuale pandemia e riguardo le potenziali emergenze di salute pubblica future.
Questi principi che si rafforzano reciprocamente riconfermano il nostro impegno a favore della solidarietà globale, dell’equità e della cooperazione multilaterale; ad una governance efficace; mettere le persone al centro della preparazione e attrezzarle per rispondere in modo efficace; basarsi sulla scienza e sulle politiche basate sull’evidenza e creare fiducia; promuovere finanziamenti sostenuti per la salute globale.
Principi della Dichiarazione di Roma
Ci impegniamo a promuovere e compiere progressi tangibili verso questi principi anche con azioni e decisioni che scaturiranno dal Vertice del G20 a Roma in ottobre. Principi che metteremo in evidenza nella prossima Assemblea mondiale della sanità (WHA) e in altri consessi di tutte le parti interessate:
1) Sostenere e migliorare l’attuale architettura sanitaria multilaterale per la preparazione, la prevenzione, l’individuazione e la risposta con un’OMS efficace e adeguatamente finanziata, tenendo conto della prossima WHA e di vari processi di revisione recenti e in corso, compresi quelli derivanti dalla precedente WHA. Sostenere il raggiungimento dell’OSS e di iniziative specifiche come il
29
piano d’azione globale per una vita sana e il benessere per tutti al fine di sostenere meglio i Paesi per accelerare i progressi verso l’OSS relativi alla salute, anche verso la copertura sanitaria universale. Sostenere l’obiettivo di una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente che promuova la progressiva realizzazione del diritto di tutte le persone al godimento del più alto standard di salute raggiungibile.
2) Lavorare per affrontare e sostenere meglio la piena attuazione, il monitoraggio e il rispetto dell’IHR e una maggiore attuazione dell’approccio “One Health” multisettoriale basato su dati e prove per affrontare i rischi derivanti dall’interfaccia uomo-animale-ambiente, la minaccia di resistenza antimicrobica, notando il ruolo delle pertinenti organizzazioni internazionali al riguardo e incoraggiare nuovi orientamenti in materia di sanità pubblica in consultazione con le pertinenti organizzazioni sanitarie sui viaggi internazionali per via aerea o marittima, comprese le navi da crociera.
3) Promuovere approcci politici all-of-society e healthin-all, con elementi nazionali e comunitari che si rafforzino reciprocamente, e promuovere la responsabilità ai massimi livelli di governo per il raggiungimento di una migliore preparazione, prevenzione, individuazione e risposta.
4) Promuovere il sistema commerciale multilaterale, notando il ruolo centrale dell’OMC, e l’importanza di catene di approvvigionamento globali aperte, resilienti, diversificate, sicure, efficienti e affidabili relative alle emergenze sanitarie, comprese le materie prime per produrre vaccini, e per la produzione e l’accesso a medicinali, diagnostica, strumenti, attrezzature mediche, beni non farmaceutici e materie prime per affrontare le emergenze di salute pubblica.
5) Consentire un accesso equo, accessibile, tempestivo e globale a strumenti di prevenzione, rilevamento e risposta di alta qualità, sicuri ed efficaci, sfruttando e attingendo all’esperienza dell’ACT-A, nonché a misure non farmaceutiche, acqua pulita, servizi igienico-sanitari, igiene e nutrizione (cibo adeguato) e a sistemi sanitari forti, inclusivi e resilienti; e sostenere solidi sistemi di somministrazione dei vaccini, fiducia nei vaccini e alfabetizzazione sanitaria.
6) Sostenere i Paesi a basso e medio reddito per sviluppare competenze e sviluppare capacità produttive locali e regionali per gli strumenti, anche basandosi sugli sforzi di COVAX, al fine di sviluppare migliori capacità globali, regionali e locali di produzione, movimentazione e distribuzione. Consentire ulteriormente un maggiore utilizzo delle tecnologie sanitarie e la trasformazione digitale dei sistemi sanitari.
7) Sfruttare le sinergie e basarsi sulle competenze delle organizzazioni e delle piattaforme pertinenti per facilitare la condivisione dei dati, lo sviluppo di capacità, gli accordi di licenza e i trasferimenti volontari di tecnolo-
gia e know-how a condizioni concordate di comune accordo.
8) Rafforzare il sostegno alle strutture esistenti di preparazione e prevenzione per un’immunizzazione equa contro le malattie prevenibili dai vaccini, nonché programmi di sorveglianza e salute per queste e altre malattie, tra cui HIV/AIDS, tubercolosi, malaria e altre malattie e malattie non trasmissibili, nell’ambito della fornitura integrata di ser vizi e garantendo che nessuno sia lasciato indietro.
9) Investire nella forza lavoro sanitaria e di assistenza mondiale, per ottenere il triplice dividendo di una migliore salute, accelerazione dello sviluppo e progressi nell’inclusione sociale e nell’uguaglianza di genere, sviluppando competenze reciprocamente riconosciute attraverso l’istruzione e la formazione, anche attraverso iniziative pertinenti dell’OMS, compresa l’Accademia dell’OMS. Investire nella salute della comunità e nei sistemi sanitari per ottenere servizi sanitari rafforzati, resilienti, inclusivi, di alta qualità, continuità dell’assistenza, assistenza locale e capacità di salute pubblica in tutti i Paesi. Investire in meccanismi multilaterali guidati dall’OMS per facilitare le capacità di assistenza e risposta da utilizzare nei Paesi in via di sviluppo e colpiti dalla crisi. Investi anche nei servizi igienico-sanitari e nell’igiene idrica nelle strutture sanitarie per ridurre i rischi di infezione e salvaguardare gli operatori sanitari.
10) Investire in adeguate risorse, formazione e personale dei laboratori diagnostici di salute pubblica e animale, compresa la capacità di sequenziamento genomico, e condividere rapidamente e in sicurezza dati e campioni durante le emergenze a livello nazionale e internazionale, in linea con le leggi applicabili, i regolamenti e gli accordi esistenti pertinenti.
11) Investire nell’ulteriore sviluppo e miglioramento delle informazioni di allarme rapido, sorveglianza e sistemi di attivazione in linea con l’approccio One Health. Investire in nuovi sforzi per rafforzare la sorveglianza e analizzare i dati sui potenziali focolai, compresa la condivisione rapida e trasparente di informazioni e dati intersettoriali e internazionali, in conformità con l’IHR.
12) Investire in modo prevedibile, efficace e adeguato, in linea con le capacità nazionali, nella cooperazione nazionale, internazionale e multilaterale in ricerca, sviluppo e innovazione, per strumenti di sistemi sanitari e misure non farmaceutiche, considerando le questioni di scalabilità, accesso e produzione fin dalle prime fasi.
13) Coordinare le misure farmaceutiche e non farmaceutiche e la risposta alle emergenze (compreso il coordinamento online dei centri di crisi e operativi), nel contesto di una ripresa sostenibile ed equa, con investimenti in salute, preparazione e risposta e politiche informate dalla consulenza scientifica. Le politiche dovrebbero accelerare i progressi verso il conseguimento degli OSS, combattere le cause profonde delle emergenze sanitarie, compresi i determinanti sociali della
30
salute, della povertà, delle disuguaglianze strutturali e del degrado ambientale, costruire capitale umano, accelerare le transizioni green (ecosostenibili, ndr) e digitali e aumentare la prosperità per tutti.
14) Aumentare l’efficacia delle misure di preparazione e risposta sostenendo e promuovendo un dialogo significativo e inclusivo con le comunità locali, la società civile, i lavoratori in prima linea, i gruppi vulnerabili, le organizzazioni femminili e di altro tipo e tutte le altre parti interessate e contrastando la disinformazione. Alla base di ciò con fiducia e trasparenza in relazione alla governance e al processo decisionale, derivante dalla comunicazione tempestiva e culturalmente adattata di informazioni accurate, di prove e di incertezza, e di insegnamenti tratti dalla risposta pandemica COVID19 e dalle precedenti emergenze di salute pubblica. Intraprendere attività di promozione della salute e lavorare sui determinanti sociali della salute per affrontare altre questioni critiche di salute come le malattie non trasmissibili, la salute mentale, l’alimentazione, nell’ambito degli sforzi volti a migliorare la resilienza generale alle future crisi sanitarie e, inoltre, garantire una risposta sensibile all’età e al genere alle crisi future.


15) Affrontare la necessità di meccanismi potenziati, snelli, sostenibili e prevedibili per finanziare la preparazione, la prevenzione, l’individuazione e la risposta a lungo termine della pandemia, nonché la capacità di mobilitare rapidamente fondi e risorse private e pubbliche in modo coordinato, trasparente e collaborativo e con una solida responsabilità e supervisione. In uno spirito di solidarietà, unire gli sforzi per sostenere in particolare la produzione e la fornitura di vaccini e altre forniture e/o la fornitura di finanziamenti per l’acquisto di vaccini, ai Paesi a basso e medio reddito.
16) Cercare di garantire l’efficacia di tali meccanismi di finanziamento, anche facendo leva sui meccanismi innovativi, sulle fonti pubbliche, private e filantropiche e sui fondi delle istituzioni finanziarie internazionali. Cercare di evitare duplicazioni di sforzi e sottolineare la necessità che i Paesi finanzino le loro capacità nazionali di IHR e R&S, principalmente attraverso risorse interne in linea con le loro circostanze nazionali, e di fornire sostegno a coloro che non sono in grado di farlo. Sottolineiamo l’importanza degli sforzi multilaterali volti a soddisfare le esigenze di finanziamento dei Paesi a basso e medio reddito, compresa la nuova assegnazione generale proposta di diritti speciali di prelievo da parte del FMI, un’ambiziosa ricostituzione dell’IDA20 e le misure esistenti approvate dal G20. Accogliamo con favore il lavoro in corso delle banche multilaterali di sviluppo e delle organizzazioni internazionali e chiediamo di aumentare, nell’ambito dei loro mandati e dei rispettivi bilanci, i loro sforzi per sostenere meglio la preparazione, la prevenzione, l’individuazione, la risposta e il controllo delle minacce per la salute e migliorare il loro coordinamento.
31
PRO LAB FOCUS ON G20: tre P ripartireper
L’associazione Pro Lab è un luogo di opportunità per sviluppare idee e progetti. È una community convinta che il cambiamento passi per il multilateralismo e una crescente coesione degli Stati. Per questo articolo, scrivono il Dott. Matteo Calogero Lo Giudice, laureato in Economia e Managementdell’Università LUISS e studente di Global Management and Politics, e il founder Giorgio Ferrigno, studente di Giurisprudenza dell’Università LUISS
599, sono i giorni che separano la dichiarazione di stato di pandemia dichiarato l’11 marzo del 2020 dall’OMS dall’inizio del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20, che si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre del 2021.
L’obiettivo principe del vertice, alla luce delle nuove problematiche provocate dalla pandemia da Sars-Cov2, sarà quello di fornire le nuove linee guide necessarie per un cambio di rotta verso un futuro più equo, prospero e certo per la popolazione mondiale.
Sarà necessario dotare l’apparato politico mondiale di nuovi strumenti solidi, percorribili e possibili con l’intento di assottigliare i numerosi gap economico-sociali che la pandemia ha ulteriormente ampliato.
Le discussioni del vertice di Roma, si fonderanno su tre principi cardine: People, Planet e Prosperity.
Di M.C. Lo Giudice e G. Ferrigno

32
.
Se il 2020 è stato l’anno con più morti dal dopoguerra, speriamo che il prossimo futuro possa rimettere al centro di tutto la vita umana in senso lato.
Ciò che più facilmente si evince, è la necessità di aiutare e sostenere tutte quelle categorie sociali “deboli” che sono state messe a dura prova nell’ultimo periodo; ci auguriamo in primo luogo che si possa trovare un accordo rapido ed efficace per la distribuzione delle dosi di vaccino nei paesi del mondo meno sviluppati, l’istituzione di nuovi fondi e sostegni per una formazione libera ed accessibile a livello globale, un sostegno massiccio e duraturo per la popolazione che soffre ed ha sofferto di disturbi mentali legati alla pandemia (i casi di depressione in Italia nel 2020 si sono quintuplicati) e per ultimo ma non per ordine di importanza, la creazione di un nuovo modello più incisivo per l’empowerment femminile e nuove strategie per ciò che concerne la mobilità sociale ed intergenerazionale.
Auspichiamo in nuovo umanesimo, in cui la persona sia l’oggetto principale di tutte le future azioni e discussioni politiche in ambito internazionale, che ci possa permettere di correre in avanti verso il futuro, ma senza lasciare nessuno indietro.
Planet Solitamente, quando si parla di pianeta, in particolare di cambiamenti climatici ed inquinamento globale, si ha la percezione di star trattando argomenti relativi ad un futuro molto più lontano di quanto in realtà emerge dalle previsioni.
Nonostante il 2020, per il lungo periodo di inattività produttiva, si possa considerare un anno positivo dal punto di vista dell’impatto ambientale; la pandemia ha trasmesso indiscutibilmente un messaggio forte e chiaro alla popolazione: “è arrivato il momento di ripartire cambiando”. Se il buon auspicio per l’avvenire, è vivere in un mondo in cui la persona sia al centro di tutte le politiche internazionali, non è possibile tralasciare il fattore rilevante della vita all’interno dei centri urbani, cornice quotidiana di maggior parte cittadini del globo
Oltre ai sussidi ed incentivi di grido, che dovranno sostenere il cambiamento radicale e totale delle attività produttive da inquinanti ad ecosostenibili, confidiamo fortemente che il futuro si possa fondare su una riqualificazione delle aree urbane attraverso le cosiddette Natural-Based Solutions. Ovvero tutte quelle soluzioni che si riferiscono alla gestione e all’uso sostenibile della natura per affrontare sfide socioambientali in ambito cittadino, agricolo e delle infrastrutture.
Programmi, che tra l’altro sono stati approvati ed incoraggiati dalle Nazioni Unite e dall’ Unione Europea già negli scorsi anni.
Prosperity
La terza priorità, dulcis in fundo, è la prosperità. Un valore a cui noi tutti, individualmente, ambiamo ma che fin troppo spesso tende a sfumarsi nei rapporti sociali. Questa è
effettivamente una liason di qualsiasi azione politica che possiamo aspettarci dal G20; ciò che ci auguriamo tuttavia è un concreto supporto allo sviluppo della società e delle società.
Superato l’ambizioso ostacolo della vaccinazione di massa, la prosperità passerà per tutte quelle altre crisi che purtroppo non sono risolvibili con due dosi: la crisi economica, educativa, ambientale…per nominarne alcune. E luogo naturale di sintesi di queste crisi è sicuramente la città, grande o piccola che sia, si ritrova oggi ad affrontare queste criticità ma ne deve essere innanzitutto consapevole e armata di competenze tali da raggiungere obiettivi certi, che la cittadinanza possa soppesare negli anni a seguire dai turni elettorali.
Le tendenze economico-giuridiche degli ultimi decenni e le imprescindibili limitazioni sociali di quest’anno hanno evidenziato quale ruolo strategico giocano oggi le amministrazioni locali: delle Regioni e delle grandi metropoli. È qui infatti che la pianificazione e l’attuazione delle politiche sostenibili fanno la differenza ed è anche qui che si rilevano vizi e virtù del nostro Paese. Urge pertanto una riforma delle competenze multilivello: maggiore responsabilizzazione di quegli enti territoriali inadempienti, un monitoraggio efficiente e una virtuosa concorrenza tra ordinamenti interni in termini di prestazioni ai cittadini e alle imprese. Infine, a nostro avviso, un’altra tripla P ci condurrà sulla via della prosperità: la partnership pubblico-privato. La sussidiarietà orizzontale deve essere potenziata nel contesto italiano e può essere occasione per valorizzare le competenze italiane, valorizzare i territori e le loro infrastrutture iniziando dai notevoli dissesti idrogeologici di alcune Regioni, la generale crisi del sovraffollamento carcerario, l’edilizia scolastica e ospedaliera…
Una sana collaborazione con il privato può ridare vitalità al mercato e un’occasione per perseguire gli interessi pubblici. Purtroppo, il contesto italiano non sembra ad oggi accogliere con favore tale ipotesi: ad un codice degli appalti contorto e lacunoso, si affiancano prassi amministrative contraddittorie e atti secondari, da ultimo la delibera ANAC n.329 del 13 aprile 2021, molto confusionari che difficilmente rendono appetibili al mercato investimenti di project finance.
Conclusioni
Salute pubblica e salute dell’ambiente diventano quindi un focus del prossimo decennio, probabilmente un ”turning point” per l’umanità. Gli strumenti nelle mani dei governanti sono diversi, alcuni li abbiamo appunto citati, e oggi si apre una nuova fase di ripartenza incredibilmente colma di opportunità.
Noi studenti universitari, che di queste azioni saremo i principali destinatari sul lungo termine, ci aspettiamo che dopo un anno assediato dall’incertezza, il G20, come qualsiasi contesto istituzionale, sia in grado di dare Certezze.
33
People
#WOMEN20, UNA HEALTH ROADMAP
Eleonora Mazzoni , Direttore per l’innovazione di I-COM
La salute non è solo sanità, ma è uno stato individuale e collettivo fortemente influenzato da fattori esterni a quelli propri del sistema sanitario. Modificare gli stili di vita delle persone, per migliorare la salute, richiede allora di intervenire sui suoi determinanti attraverso il cambiamento delle condizioni sociali e dell’ambiente di vita e di lavoro. Sono già numerosi gli sforzi che si stanno facendo per integrare le considerazioni sanitarie nel contesto sociopolitico, con l’obiettivo di migliorare la salute della popolazione a livello comunitario, nazionale e locale secondo l’approccio collaborativo health in all policies, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Tra gli obiettivi principali della presidenza italiana del G20, ed in modo trasversale rispetto alle priorità da affrontare (people, planet, prosperity), c’è quello di costruire una roadmap sulle questioni femminili, che sono state aggravate dalla crisi pandemica. Anche dall’equità di genere e dal ruolo della donna passa infatti la possibilità di dare un contributo reale alla ricostruzione sociale ed economica dei nostri Paesi. Per questo il 25 marzo è stata presentata la speciale commissione del Women 20 (W20) “Equity in Health”, che avrà il compito di discutere l’impatto del genere in medicina tenendo conto anche di variabili biologiche, ambientali, culturali e socio-economiche, per comprendere i meccanismi attraverso i quali le differenze legate al genere agiscono sullo stato di salute. Spesso ci si dimentica infatti che la salute è un bene primario e non isolabile che dipende da fattori strettamente interconnessi tra loro. Per comprenderli e per rispondere al meglio al fabbisogno di salute della popolazione è allora necessario adottare delle politiche che
VERSO IL G20
sostengano le donne in tutti i ruoli che ricoprono all’interno della società, ed intervenire affinché il loro coinvolgimento nel processo decisionale alla base delle politiche pubbliche sia effettivo e non solo la copertina di un libro vuoto. Sono vari gli aspetti fondamentali su cui il Women20 si sta impegnando lungo il percorso che porta al G20 leaders summit che si terrà alla fine di ottobre, e che riguardano la condizione delle donne pure per quanto riguarda la necessità di ripensare il disegno della sanità, in Italia e nel mondo. Bisogna riconoscere che ci troviamo in un momento molto particolare, in cui il mondo si trova al centro di tre grandi processi critici: la crisi pandemica che ha sconvolto le nostre vite, quella climatica e la rivoluzione tecnologica. Si tratta di una fase di transizione molto densa e allo stesso tempo piena di contraddizioni che la rendono difficile da affrontare soprattutto dal punto di vista di chi governa. Allo stesso tempo si tratta di processi che hanno avuto, ed avranno, un impatto economico e sociale estremamente rilevante sulla popolazione mondiale. Durante questo tipo di transizioni la condizione della donna è sempre particolare, e per definizione è una questione globale che quindi rappresenta una delle chiavi per la ripresa.
In un interessante articolo pubblicato lo scorso settembre 2020 su The Lancet, il Covid-19 è stato definito da Richard Horton come una “sindemia”, concetto che pone al centro l’interazione tra il Sars-Cov-2 e le patologie croniche (obesità, diabete, malattie cardiovascolari etc.) sottolineando un’evidenza consolidata, e cioè che il Covid-19 peggiora le

34
patologie croniche e che le patologie croniche peggiorano il rischio correlato al Covid-19. Questo evidenzia il fatto che il virus ha effetti peggiori sulle popolazioni più emarginate, vulnerabili e che spesso vivono in condizione di povertà, e suggerisce che concentrare gli sforzi esclusivamente sul piano sanitario potrebbe essere poco efficace nel lungo periodo. Il concetto di sindemia implica di fatto la necessità di migliorare la salute generale della popolazione e di intervenire per la riduzione della disuguaglianza. Non c’è spazio dunque per interpretazioni convenzionali delle malattie come entità distinte l’una dall’altra e indipendenti dai contesti sociali in cui si trovano. Questa complessità richiede strumenti aggiuntivi rispetto a quelli esistenti per poter essere affrontata e servono consapevolezza e lungimiranza, per poterlo fare. Questo include la naecessità di affrontare le questioni di genere, e di ripensare il ruolo delle donne proprio per rispondere al meglio al fabbisogno di salute della popolazione.
Durante la pandemia sono diversi i livelli in cui le donne hanno svolto un ruolo attivo. Proprio le donne sono state la maggioranza dei lavoratori nel settore della salute e della cura degli anziani, ad esempio. Secondo un’analisi di 104 paesi condotta dall’Organizzazione mondiale della sanità, circa il 70% della forza lavoro sanitaria globale è composta da donne e le donne sono in modo schiacciante anche le principali custodi delle loro famiglie. Oggi, secondo la Family Caregiver Alliance, oltre il 75% dei caregiver sono donne. Ciononostante soltanto il 25% dei ruoli di vertice è ricoperto da professioniste di genere femminile. L’analisi rileva uno squilibrio che penalizza le donne in tutti i paesi osservati, e mette in luce una disuguaglianza che rappresenta un freno concreto al raggiungimento della copertura sanitaria universale. Questo è vero anche in Italia dove all’interno del SSN le donne rappresentano oltre il 63% del personale dipendente e sono quasi il doppio degli uomini. Tuttavia, a fronte del 26,3% di donne iscritte nell’elenco nazionale degli idonei a ruolo di Direttore generale, solo il 18,2% ricopre questo ruolo. Il mancato riconoscimento del ruolo delle donne nell’ambito sanitario è un freno al raggiungimento della piena copertura universale, obiettivo dichiarato dell’OMS, in quanto l’assenza e/o forte carenza delle donne ai vertici delle varie istituzioni ed organismi rappresentativi del mondo sanitario produce, a cascata, la loro assenza ai tavoli decisionali. Questo comporta, a seguire, una vera mancanza di presa in carico dei problemi del mondo sanitario femminile, proprio quando le implicazioni della medicina di genere si sono rivelate centrali nell’ambito dell’epidemia da SARS-CoV-2, che ha manifestato un collegamento significativo con la dimensione del genere sia riguardo la prevalenza, che la severità e la mortalità. L’affermazione delle donne in sanità è invece una garanzia fondamentale per i cittadini, e per essere all’altezza dei compiti che abbiamo i governi devono assicurare che i servizi sanitari pongano al centro la persona, ricostruendo il sistema con il contributo strategico della visione delle donne. Le cure devono essere accessibili a tutti gli individui e in tutte le aree territoriali, e devono tenere conto delle differenze tra le persone, comprese quelle di genere, per tarare la risposta delle politiche alla reale domanda di salute della popolazione. Questo vuol dire anche investire nello sviluppo di studi multidisciplinari sulla medicina di genere. Equità non significa fare finta che le diversità di genere non esistano, ma proprio prenderne atto e tenere conto anche delle differenze tra segmenti della popolazione all’interno del genere stesso.
La stessa epidemia ha dimostrato come siano indispensabili i servizi sanitari pubblici sul territorio con particolare riferimento alla prevenzione primaria e secondaria. Mettere la persona al centro significa focalizzare l’attenzione anche sui rischi correlati all’ambiente in cui si vive. L’attività umana e
l’esigenza di rispondere alle necessità di una popolazione globale sempre più numerosa stanno infatti destabilizzando gli equilibri naturali del nostro pianeta ed indebolendo la sostenibilità della società moderna. Basti pensare che più della metà della popolazione mondiale, circa il 55%, risiede oggi nelle città ed il trend di aumento è destinato a continuare. Secondo il “World Urbanization Prospects 2018” delle Nazioni Unite, nel 2050 quasi il 70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane. Una condizione che riguarda anche il nostro Paese dove attualmente, su 8000 comuni, le 14 città metropolitane unitamente alle prime 75 città per dimensione rappresentano il 50% della popolazione. Vivere in un’area urbana, e ancora di più in una megalopoli, si accompagna a cambiamenti sostanziali degli stili di vita rispetto al passato; cambiano le abitudini e il modo di vivere, i lavori sono sempre più sedentari, l’attività fisica diminuisce. Fattori sociali e culturali che rappresentano un potente volano per la diffusione delle malattie croniche, un fenomeno che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente definito come la nuova epidemia urbana, capace di compromettere la qualità della vita delle generazioni future, lo sviluppo economico e la prosperità delle città. Esempio emblematico è il diabete: 415 milioni persone nel mondo vivono con il diabete e due terzi di loro vivono in città. Le città da luoghi di maggiore protezione e benessere, diventano patogene, creando anche problemi di equità perché le donne sono più esposte a questi rischi per le numerose condizioni fisiologiche su cui possono incidere. Anche la predisposizione a disturbi del comportamento alimentare, diabete, obesità e malattie croniche degenerative non trasmissibili sono un peso crescente per il genere femminile. Informazione, educazione e prevenzione sono gli strumenti efficaci, insieme alla ricerca di settore, e alle amministrazioni locali e regionali spetta il compito di individuare un nuovo modello di governance collaborativa nel quale istituzioni, imprese, organizzazioni della società civile e cittadini possano contribuire alla progettazione di un nuovo assetto urbano, di cui la salute, con le sue molte determinanti, sia un elemento portante.
Rendere concreto quanto sinora detto richiede anche di sfruttare il potenziale della rivoluzione tecnologica per migliorare le condizioni dei cittadini in tutti gli aspetti della loro vita. La raccolta e l’analisi dei dati e il coinvolgimento della società civile e scientifica nel processo decisionale è allora condizione necessaria per dotarci di un sistema comune di interpretazione dei fenomeni, comunicarli e renderli la base della programmazione degli interventi in ambito socioeconomico e sanitario. Tutto questo è possibile se ricuciamo quel tessuto che permette alle persone di dare veramente il loro contributo costruendo una cinghia di trasmissione tra istituzioni e comunità. In due parole: fare rete. Questo obiettivo passa anche da una presa di coscienza collettiva rispetto al cambiamento del ruolo della donna. Sfruttare le nuove tecnologie per creare osservatori capaci di analizzare il contesto, e coinvolgere la società civile e scientifica nei processi decisionali significa infatti porre le basi per riscrivere la risposta delle istituzioni al bisogno delle donne di ricoprire tutti i loro ruoli: da figlie, a studentesse, a madri, a caregiver, a lavoratrici, e in cariche di vertice ed istituzionali. Durante il global health summit tenutosi lo scorso 21 maggio non sono emersi punti che riguardano le donne, una debolezza che non può rischiare di ripetersi al summit di fine ottobre. Si auspica quindi che la dichiarazione finale dei leader del G20 includa dei punti chiari riguardo all’approccio di genere, in particolare legato ai temi della salute, bene primario strettamente interconnesso con i fattori che influenzano la qualità della vita della popolazione. Questo sarebbe un passo davvero importante per la portata della transizione che stiamo vivendo.
35

36 EVENTO G20/UNEP CITTÀ RESILIENTI, INTELLIGENTI E SOSTENIBILI: IL POTERE DELLE SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA
L’evento del G20/UNEP ha evidenziato i molteplici benefici derivanti dall’attuazione di soluzioni basate sulla natura (NbS) all’interno delle città, e in particolare il loro contributo ad aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, contribuendo al contempo alla mitigazione. Nei Paesi G20 vi sono già diversi esempi, che dimostrano come le NbS – adattate alle diverse circostanze locali – possono funzionare in tutti i contesti. Per aumentare le esperienze positive è necessaria una maggiore quantificazione dei benefici e il monitoraggio dei progressi. L’integrazione delle NbS nei processi di pianificazione e negli standard tecnici per le infrastrutture é inoltre necessaria per favorire modelli di business e finanziari innovativi e una governance multilivello fluida.
Il 16 aprile scorso la presidenza italiana del G20 e l’UNEP hanno organizzato un evento virtuale con l’obiettivo di esplorare come diffondere l’attuazione delle NbS nelle città.
Le città sono in prima linea sia nella triplice crisi dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento e della perdita di biodiversità, sia nella sfida sanitaria. Attingendo a numerosi esempi di iniziative di NbS nei paesi del G20, l’evento ha dimostrato come l’attuazione di soluzioni basate sulla natura nelle città possano aumentare la capacità di mitigare gli impatti negativi e i rischi futuri e ha evidenziato un crescente interesse verso questo tipo di soluzioni nelle città.
Le NbS possono fornire molteplici benefici, che vanno da una maggiore resilienza agli eventi climatici come inondazioni e ondate di calore, alla conservazione della biodiversità, al miglioramento del benessere e alla creazione di posti di lavoro. Sviluppare e implementare le NbS nelle aree urbane richiede un “pensiero basato sulla natura” per integrare le NbS nelle politiche di settore, nella pianificazione della città e delle infrastrutture.
La prima sessione dell’incontro ha dimostrato un’ampia gamma di opzioni disponibili per l’attuazione delle NbS, dalle infrastrutture verdi e ibride – con zone umide, foreste urbane, trasporti verdi e corridoi di biodiversità – alle foreste e ai boschi verticali. Tenere in considerazione aspetti come la competizione per lo spazio, l’uso di specie locali e la manutenzione devono alimentare gli sforzi di pianificazione per portare a un design urbano sensibile alla natura.
La seconda sessione ha esaminato diversi modelli di business. Modelli di business innovativi, insieme alla co-creazione di
politiche di supporto e di standard tecnici, sono fondamentali per coinvolgere il settore privato e aiutare a mobilitare i finanziamenti. Nuovi modelli di business e accordi di finanziamento innovativi devono essere testati per acquisire il valore che è condiviso tra i settori pubblico e privato. Oltre ai comuni modelli di finanziamento come il partenariato pubblico-privato (PPP), le città sono state incoraggiate a pensare in modo più ampio alle opzioni disponibili, garantendo la partecipazione attiva di soggetti pubblici per garantire la qualità del progetto, e attuando misure come tasse locali, obbligazioni, ma anche strumenti che attestano il valore del terreno e incentivi non finanziari come quantità minime di aree verdi garantite.
Trasformare la consapevolezza e il riconoscimento del potenziale delle NbS in investimenti sul campo richiede obiettivi quantificati e metodologie solide per decidere l’intervento più efficace e per valutare i benefici, usando, per esempio, indicatori come l’indice di copertura verde, la riduzione della temperatura, la creazione di posti di lavoro, i cambiamenti nella mobilità. Le analisi costi-benefici sono cruciali per giustificare l’implementazione, ed è necessario mettere in atto un sistema per monitorarli. La crescente disponibilità di tecnologie digitali permette di identificare meglio le opportunità di azione e aiuta a tracciare i progressi per mantenere le NbS. Infine, per avere successo è fondamentale cambiare il modo in cui le città operano e allontanarsi dalla pianificazione urbana “business-as-usual” per adottare un design urbano sensibile alla natura. Questo include la collaborazione tra diversi settori a livello locale e il coinvolgimento delle comunità. In conclusione, gli attori urbani sono stati incoraggiati a “indossare” la natura come un paio di occhiali per immaginare il futuro delle città e sfruttare i molteplici benefici della NbS per ottenere una migliore qualità dell’aria, regolare le temperature estreme, risparmiare energia e migliorare la salute e il benessere dei cittadini. Non da ultimo la capacità di creazione di posti di lavoro, la fornitura di spazi verdi per scopi ricreativi e il potenziale di applicazione di NbS in infrastrutture urbane e settori colpiti dal COVID-19, rendono le NbS una pietra miliare per una ripresa resiliente e verde.
I partecipanti hanno accolto con favore le opportunità offerte da questo scambio e hanno sottolineato l’importanza della collaborazione di Paesi del sud del mondo per la diffusione e la replica di NbS in altre città.
Panel 1: Panel 2:
I molteplici benefici della NbS nelle città, moderato da Ingrid Coetzee, Direttore Biodiversità, Natura e Salute, ICLEI – Governi locali per la sostenibilità. Panellist: Stefano Boeri Architetti; Yvonne Lynch, Strategic Advisor, the Royal Commission for Riyadh; Sean O’donoghue, Senior Manager Climate Protection Branch, Comune di eThekwini.
Innovazione e modelli di business per lo scaling up delle NbS nelle città, moderato da Musonda Mumba, Direttore del Rome Centre for Sustainable Development – UNDP. Panellist:
Boping Chen, direttore regionale dell’Asia centro-orientale, C40; Laszlo Pinter, professore, team leader del progetto Naturvation e capo del dipartimento di scienze e politiche ambientali, Central European University; Laurie Stott, istruttore, British Columbia Institute of Technology; Sergio Angón, coordinatore del progetto CityAdapt, Xalapa,Messico
37
Si celebra il 2 luglio di ogni anno per richiamare l’attenzione e stimolare l’azione dei Sindaci sulla necessità e urgenza di promuovere la salute nelle città come bene comune; promossa da Health City Institute e C14+, con il patrocinio di ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Intergruppo parlamentare “Qualità di vita nelle Città”.
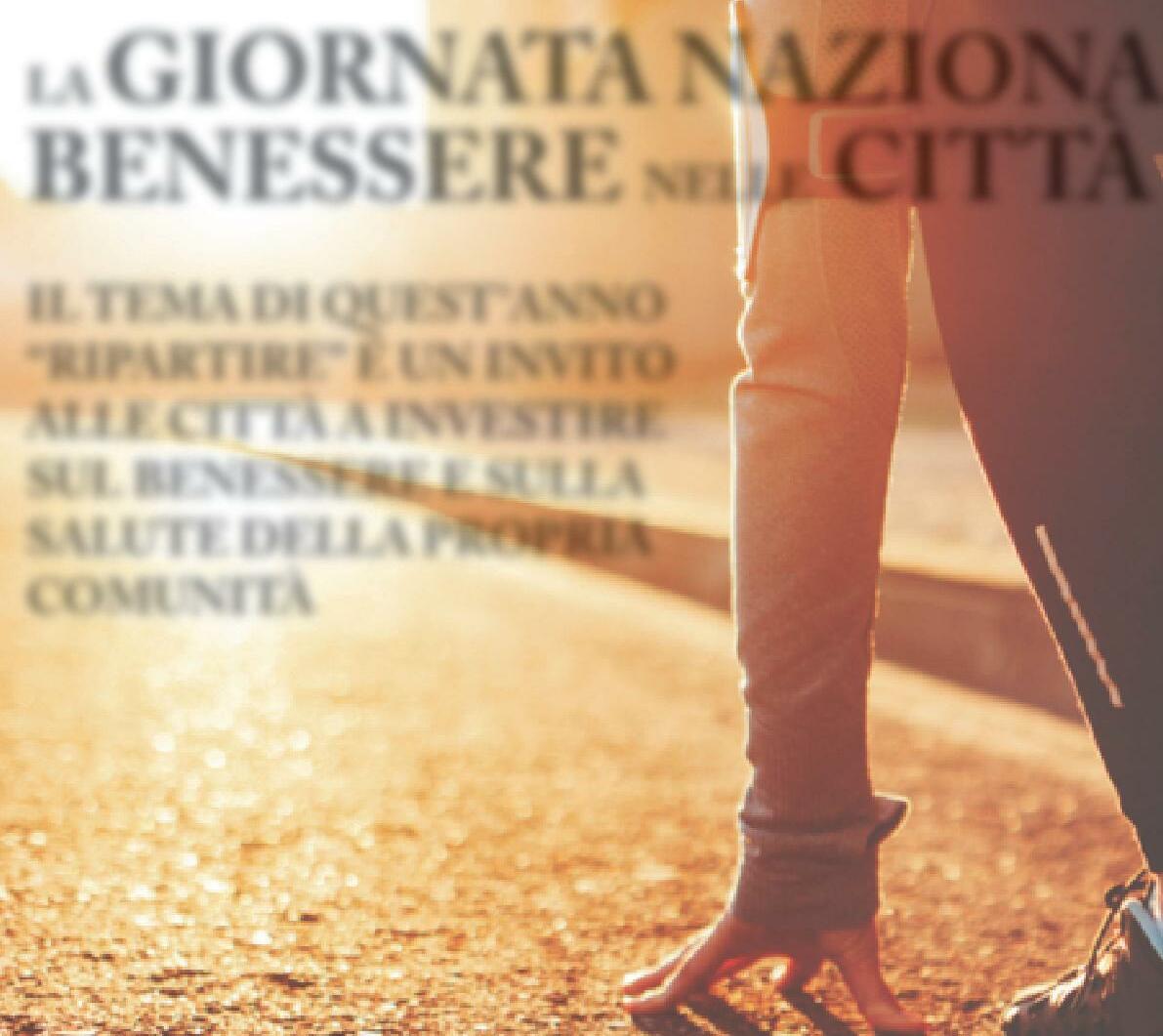


38
LA GIORNATA NAZIONA BENESSERE NELLE CITTÀ IL TEMA DI QUEST’ANNO “RIPARTIRE” É UN INVITO ALLE CITTÀ A INVESTIRE SUL BENESSERE E SULLA SALUTE DELLA PROPRIA COMUNITÀ
LE PER LA SALUTE E IL 2021






39
“Ripartire” è lo slogan della Giornata Nazionale per la salute e il benessere nelle città per richiamare l’attenzione e stimolare l’azione dei Sindaci sulla necessità e urgenza di promuovere la salute nelle città come bene comune e come momento di ripartenza delle città e di tutto il Paese dopo la pandemia dovuta al COVID-19.
La Giornata promossa da Health City Institute e C14+, con il patrocinio di ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, del Comitato Nazionale Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Intergruppo parlamentare “Qualità di vita nelle Città”.
La Giornata Nazionale per la salute e il benessere nelle città é celebrata il 2 luglio di ogni anno, il giorno centrale di ogni anno, per ricordare che la salute e il benessere delle città deve essere un tema centrale e obiettivo delle politiche di tutto l’anno da parte delle Istituzioni, dei Sindaci, degli Enti, delle Associazioni, di tutta la comunità cittadina e di ogni individuo.
Il 2 luglio è anche la data della firma e promulgazione nel 2016 del Manifesto “Salute nelle città: bene comune”, voluto da Health City Institute, C14+ e ANCI, un Documento che delinea i punti chiave che debbono guidare le città a studiare ed approfondire i determinanti della salute nei propri contesti urbani e a fare leva su di essi per escogitare strategie per migliorare gli stili di vita, lo stato di salute il benessere nelle città. Ogni punto del Manifesto contiene le azioni prioritarie per il raggiungimento di quegli obiettivi che possano assicurare il diritto di una comunità e di ogni singolo cittadino a una vita sana ed integrata nel proprio contesto urbano.
L’invito è alle Amministrazioni affinché s’impegnino nella promozione della salute dei cittadini studiando e monitorando i determinanti della salute specifici del proprio contesto urbano, facendo leva sui punti di forza delle città e riducendo drasticamente i rischi per la salute, rendendo la salute dei cittadini il fulcro di tutte le politiche urbane.
La Giornata Nazionale per la salute e il benessere nelle città, ogni 2 luglio, ogni anno, rinnova l’impulso nel perseguire questi obiettivi e si svolge promuovendo iniziative nell’arco della settimana antecedente e successiva in tutto il territorio nazionale.
La Giornata in questi primi anni ha visto la partecipazione di più di mille soggetti aderenti, tra Province, Comuni, Enti e Associazioni, a testimonianza di un interesse generale crescente sui temi della salute e del benessere nelle nostre città. I cittadini e gli amministratori sono chiamati ad essere parte attiva nel dare benessere nelle proprie realtà. Durante queste due settimane, infatti, città, associazioni e istituzioni organizzano autonomamente iniziative di sensibilizzazione culturale, sociale, sportiva, sociale e sanitaria, collegate al tema della salute e del benessere nelle città, promuovendo sul proprio territorio nelle forme più idonee il tema della Giornata Nazionale. Nelle precedenti edizioni i temi della Giornata sono stati: nel 2018 “Colora di salute la tua città”; nel 2019 “Dai benessere alla tua città”; nel 2020 “La salute delle città è nelle tue mani, prenditene cura” Il tema di quest’anno “Ripartire” vuole essere l’invito a tutti
gli amministratori locali a guardare avanti e ricreare le condizioni di benessere e salute per la propria comunità e a essere attivi e propositivi nel proprio contesto urbano attraverso attività di prevenzione e promozione di corretti stili di vita, alla luce della necessità di ripartire dopo l’emergenza pandemica che ha stravolto il nostro Paese e la vita nei nostri territori
Riteniamo che la Salute, l’Ambiente, il Benessere e lo Sport debbano diventare temi centrali delle politiche nazionali, regionali e delle città.
Per celebrare la Giornata Nazionale 2021 è organizzato un evento istituzionale presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, durante il quale il tema, declinato secondo il trinomio del G20 a Presidenza italiana “People, Planet, Prosperity”, sarà affrontato in un confronto tra autorevoli rappresentanti del Governo, Sindaci e amministratori insieme al contributo di esperti, scienziati, personalità del mondo dello della salute, dell’ambiente e dello sport.
La città stessa, vista come bene comune nel suo complesso, rappresenta il luogo in cui i cittadini che vi risiedono condividono non solo spazi fisici e servizi, ma contribuiscono concretamente alla qualità di vita e al livello di benessere diffuso. Gli Amministratori sono chiamati a essere parte attiva in questo processo di sviluppo della città, soprattutto in una fase in cui l’epidemia dovuta al COVID-19 ha imposto il tema centrale del ruolo dei Comuni e dei Sindaci nella gestione dell’emergenza, nella ripresa delle attività e dei servizi e nel rilancio del Paese stesso.
Per rendere ancora più concreta l’interlocuzione con le Istituzioni l’evento del 2 luglio è stato preceduto, il 18 giugno, da un percorso partecipato di redazione dell’ITALIAN URBAN HEALTH DECLARATION da parte di un gruppo di più di 40 esperti provenienti dal mondo dell’accademia e della scienza, dell’urbanistica e dell’architettura, dell’amministrazione pubblica e aziendale, dell’attivismo civico e del terzo settore, della sociologia, dell’economia, dello sport e dell’impresa.
L’ITALIAN URBAN HEALTH DECLARATION ha il compito di sintetizzare le priorità per l’urban health da sottoporre al dibattito della giornata ufficiale del 2 luglio in prima battuta e, dopo l’approvazione, all’evento finale del G20 che si svolgerà a Roma il 30 e 31 ottobre.
Il documento contiene cinque pilastri che debbono guidare l’azione dei Governi e dei Sindaci sull’Urban Health:
1. Investire nella promozione della salute e del benessere delle città
2. Affrontare i determinanti sociali e culturali e combattere per una salute equa per tutti i cittadini
3. Integrare la salute in tutte le politiche urbane
4. Coinvolgere e impegnare le comunità locali per assicurare soluzioni sostenibili per la salute
5. Creare soluzioni in partenariato con altri settori in modo trasversale per creare un nuovo concetto di città
40






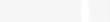









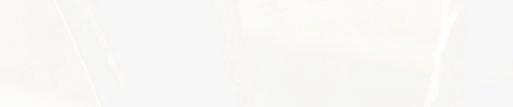














PRIORI À C NELLE SALUTE alde c a ITT O BIA ENZ eSession ALENTI A ROBERTO LUCIANA O G ENRIC ervengInt 2021” DEL G20 IL PER À engo io ANCI ar a Repubblica L T V onsiglio Nazionale ANCI C PresidenteC14+ePresidente ONC aconclusiv t o allo Spor ia di Stat tosegretarSot EZZALI NA V MinistrodellaSalute SPERANZA ernoMinistradell’Int LAMORGESE enibile e della Mobilità Sost rastrutture MinistrodelleInf ANNINI A IO gono: V tiP S U EUPhA e ABCPolite ONGOAPOL ANO C STEF ono: Ne discut itute yInst onsiglio dei Mini del C ologie e Scien Biotecn oomitat e C President ANDREA LENZI : Cit ANTONIO idt thal an Public He Urb cnicodiMilano Health eresident i e P str residenza ita della P e della V nz ezza, Nazionale Biosicur PresidenteANCIeSindacodiBari CARODE i dil hi t i DRAGHI MARIO PROF. i onsiglio dei Ministr e del C resident del P ervento o l’int evist È pr SindacodiReggioEm AVECCHI L a Sapienz “L gnifica R Ma A POLIMENI ANTONELL oANCI e Delegat ose o di C cndaSi TOCHIU MARIO OC PresidenteFond A GIUSEPP SectionPre EDERIT UC miliaeDelegatoANCI ” di Roma a iversità e Un tricet IUrbanisticaeLavoriPubblici nza dazioneCENSIS esident agenda ase alla disponibilità dell’ in b voor a dei la usur a o c ur n aper v o di Reggio Emilia e Delegat A

UNA GIORNATA PER RIPARTIRE E NON DIMENTICARE

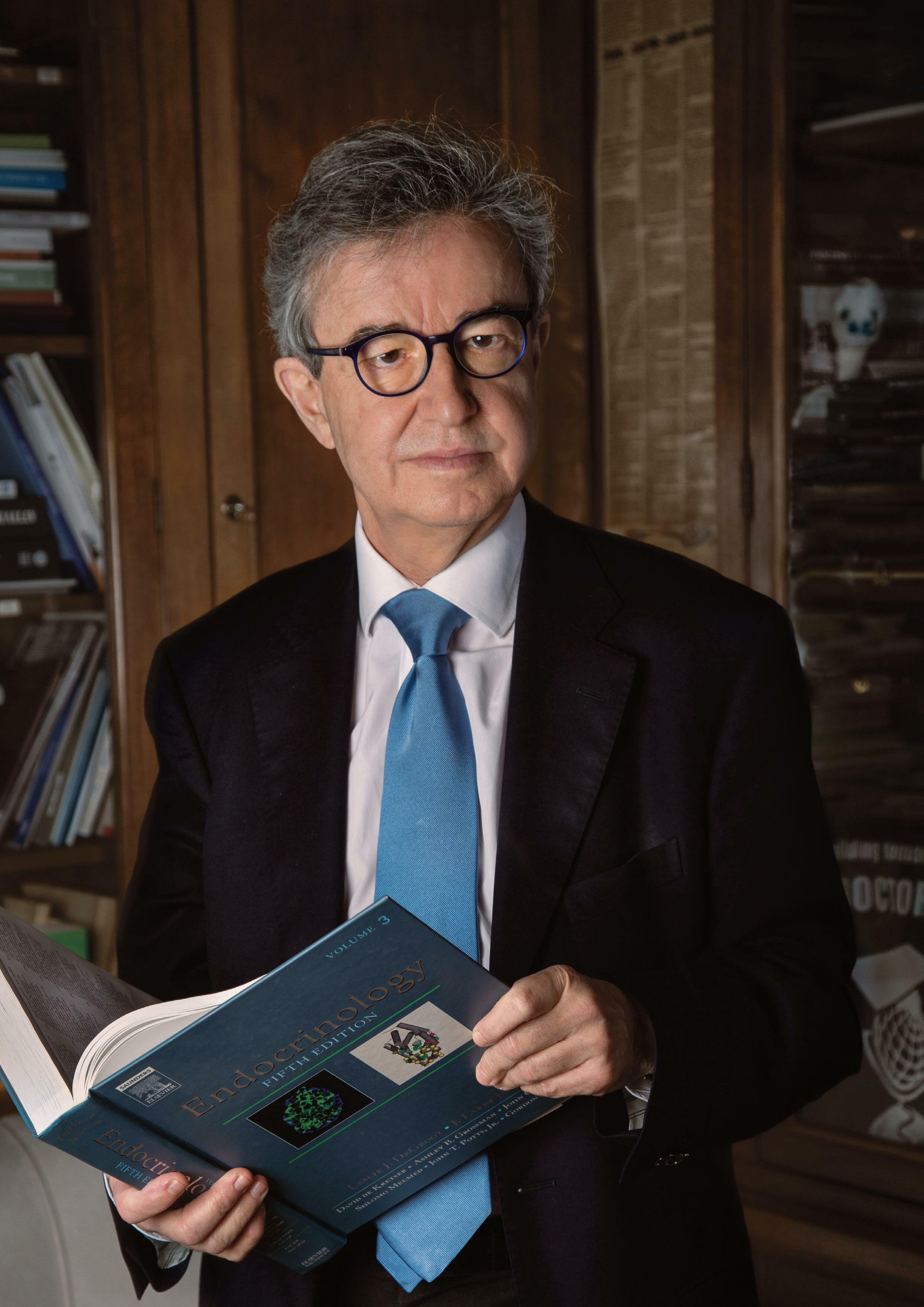
44
di Andrea Lenzi Presidente Health City Institute e della Giornata Nazionale della salute e benessere nelle città
La sfida che quotidianamente affrontiamo nella lotta alla pandemia COVID-19 pone a tutti noi una serie di riflessioni non solo di carattere clinico, ma anche e soprattutto di carattere sociale che riguardano cosa è oggi una comunità e cosa è il bene comune.
La città vista come bene collettivo, o comune, in cui i cittadini residenti condividono gli spazi comuni quali parchi e strade, i servizi, ma anche la cultura, la salute, le fragilità e le paure dei singoli individui e del loro insieme.
Il bene comune richiama tutti i cittadini all’etica e al rispetto delle regole di convivenza civile che ci siamo dati, a un circolo virtuoso di comportamenti fatti di rispetto reciproco, di sostegno e solidarietà, in cui non c’è chi guadagna e chi perde, ma si vince tutti, perché si agisce nell’interesse di tutti e nel rispetto di ciascuno.
Il bene comune sono uomini e donne, cittadini che non si preoccupano semplicemente di pagare le tasse, ma costruiscono, sostengono, giorno dopo giorno, la vita della società, della collettività, puntando ad un’economia che cerca di essere moderna, inclusiva e sostenibile, al “servizio al bene comune”.
La sfida che le città hanno dovuto affrontare con la pandemia COVID-19 ha fatto riscoprire a tutti come sia importante coltivare il bene comune e avere senso di comunità.
Il silenzio delle strade delle nostre città è diventato il rumore assordante delle sofferenze e delle paure che sono emerse quotidianamente e che, dal livello individuale, sono state trasferite nella collettività trasformate in strenua volontà di affrontarle tutti assieme e di mutarle in speranza e voglia di rinascere e ripartire.
Questa è una comunità. Sono i volti dei colleghi medici, degli infermieri, dei farmacisti e degli operatori sanitari, rigati dalle mascherine, stremati da turni massacranti, che si sono scoperti fragili e forti allo stesso tempo, ma anche consapevoli di doversi spendere per la nostra comunità.
Sono i ricercatori che, chiusi in un laboratorio, si sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare la “soluzione” al problema e dare speranza e serenità a tutti. Sono i volontari che assistono le persone sole e sono coloro che, con il proprio lavoro, hanno consentito e consentono approvvigionamenti costanti e servizi essenziali. Sono i professori che, anche a distanza, mantengono vivo il “fuoco” della cultura e del sapere nei giovani per costruire così le generazioni future. Sono le donne e gli uomini delle istituzioni che comprendono di essere, come non mai, il punto di riferimento per tutti i cittadini che cercano in loro risposte e sicurezze. Sono i volti delle mamme e dei papà che cullano i sogni dei loro bambini, cacciando via gli incubi. Sono gli imprenditori, i commercianti e i lavoratori che temono per il loro domani, diverso da prima. Sono gli “ultimi” che vivono per strada e che non possono rimanere a casa, perché una casa non ce l’hanno. È la pietà e il conforto dei preti e dei ministri di culto nell’alleviare una sofferenza umana spirituale così grande e profonda. Sono i volti e le lacrime di coloro che si sono ammalati, dei loro familiari, di chi ha perso un proprio caro, un amico, un collega o semplicemente un conoscente
o un vicino di casa, spesso ignorato nella precedente quotidianità. Sono i volti di tutti coloro che hanno posto la loro vita, spesso sacrificandola, a beneficio della comunità: quelli che Papa Francesco chiama i “santi della porta accanto”.
L’antropologa Margaret Mead, nel secolo scorso, ai suoi studenti che le chiedevano quale fosse stato il primo segno di civiltà nell’uomo, rispondeva che il primo segno di civiltà in una cultura antica era stato un femore rotto e poi guarito. Per un’antropologa come lei quello era il vero segnale di una civiltà che si stava evolvendo, perché nel regno animale se un componente del branco si fosse fratturato una gamba, sarebbe morto. Sarebbe rimasto isolato in balia del pericolo, senza poter cacciare o dissetarsi al fiume: nessun animale può sopravvivere a una gamba rotta abbastanza a lungo perché l’osso guarisca da solo. Un femore rotto che è guarito è, invece, la prova che qualcuno si è preso il tempo di stare con colui che è caduto, ne ha bendato la ferita e bloccato l’arto fratturato, lo ha portato in un luogo sicuro, lo ha rifocillato, lo ha aiutato a recuperare il suo stato di salute.
Questo concetto di inizio della civiltà significa che oggi, come all’inizio dell’evoluzione dell’uomo, ognuno di noi deve spendere più tempo a curare e a prendersi cura dell’altro, perché questo significa che salute è civiltà.
Le migliaia di persone e professionisti che ogni giorno animano i centri vaccinali, prendendosi cura delle speranze e della voglia di ripartire di milioni di cittadini, sono un grande segno di civiltà.
Curare e prendersi cura dell’altro è stato in questi mesi il segnale che esiste una comunità, fatta da individui, ma non da individualismi, e che ognuno di noi può contribuire con il proprio impegno al benessere di tutti.
Questo impegno, le paure e i timori, le speranze e la voglia di ricominciare silenziosa e rumorosa allo stesso tempo sono i sentimenti che animano la Giornata Nazionale della salute e benessere nelle città in questo 2021, a testimonianza per tutti noi che dobbiamo ricordarci non di una parentesi della nostra vita o di un’esperienza dolorosa, ma di come una comunità ha saputo affrontare e sconfiggere un virus. E della voglia di ripartire verso un futuro in cui la salute e il benessere nelle nostre città diano certezze alle generazioni che verranno.
Unico obiettivo definire la città come bene collettivo.
45
 46
di Roberto Pella Vicepresidente vicario ANCI e Presidente Intergruppo parlamentare “Qualità di vita nelle città”
46
di Roberto Pella Vicepresidente vicario ANCI e Presidente Intergruppo parlamentare “Qualità di vita nelle città”
Fare la differenza nell’ottica di ripartire e“build back better” territori e comunità.
É indubbio che le celebrazioni per la Giornata Nazionale per la salute e il benessere nelle città in questo 2021 si collochino in una fase inedita, di ripartenza collettiva come recita lo slogan per il 2 luglio, certamente e finalmente in una direzione opposta a un anno fa, ma densa di tutti i significati che la pandemia ha portato con sé.
In occasione della cerimonia per l’anno accademico 202021 dell’Università degli Studi di Milano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato le parole: “È bene mantenere alta l’attenzione su quanto è avvenuto, non soltanto perché non siamo ancora riusciti a pervenire al traguardo della sconfitta della pandemia - siamo avviati velocemente sulla buona strada, ma è un traguardo ancora da conseguire - ma soprattutto perché quando l’emergenza sarà alle nostre spalle sarà bene non pensare di rimuoverla dal ricordo, sarà bene tenerla sempre presente per comprendere quel che è avvenuto e per ricavarne alcuni criteri di comportamento.”
Ritengo che oggi siamo davvero nel momento in cui noi Sindaci e Amministratori d’Italia dobbiamo far partire questa piccola rivoluzione, quella cioè di considerare la salute il filo conduttore e il criterio di riferimento nella costruzione delle politiche pubbliche sui territori che governiamo.
Ciò significa avviare un diverso modo di costruire le politiche. Non solo di welfare - giacché la salute non è appannaggio solo del welfare, ma politiche urbanistiche, educative, sportive, ambientali per confrontarci sul tema della promozione di uno stato complessivo di benessere psico-fisico urbano. Sia alla luce dell’impatto e dell’incidenza che possono avere sulla qualità di vita dei nostri cittadini ma, ancor prima, alla luce di un processo, a monte, di co-progettazione della visione della città che vogliamo. Con un orizzonte che, evidentemente, dovrà traguardare il singolo mandato elettivo di ciascuno di noi per concentrarsi sulla consegna alle generazioni future di territori promotori di maggiore salute e generatori di maggiori opportunità.
Credo che proprio ANCI, che dal 2017 ha istituito la delega specifica alla salute, possa e debba impegnarsi in questo senso, anche con l’obiettivo di definire livelli di concertazione maggiormente rappresentativi dei saperi e delle competenze necessarie a creare salute oggi.
Questo approccio e questa metodologia, sono convinto, potranno fare la differenza nell’ottica di ripartire e “build back better” territori e comunità. Così come oggi misuriamo l’im-
patto finanziario, o ambientale, delle nostre politiche pubbliche, allo stesso modo dovremmo inserire parametri e indicatori dell’impatto di salute sulla cittadinanza nel momento in cui costruiamo i servizi.
È questa la ragione fondamentale per cui stiamo sperimentando, per la prima volta a livello nazionale, un percorso di alta formazione per Health City Manager, dedicato a giovani under 35, perché crediamo che ANCI possa trasferire, grazie alla collaborazione con il mondo accademico, scientifico e sociale, competenze, conoscenze e abilità a figure professionali innovative, ispirate a una visione olistica del concetto di salute nei territori.
Per un Sindaco presidiare queste tematiche in ottica di benessere urbano significa presidiare l’ospedaliero e l’assistenziale, certamente, ma anche disegnare gli spazi; includere i gruppi componenti la propria comunità, diversi per etnia, età, livello di abilità, credo religioso; consentire una migliore redistribuzione della ricchezza all’interno del proprio territorio e ambito perché, come sappiamo, la correlazione tra livello di istruzione, condizione socio-economica e livello di salute è alta e rappresenta un determinante di diseguaglianza molto forte, da combattere ogni giorno per prevenire, a volte, anche alcune tensioni sociali.
Anche dal punto di vista normativo il dibattito sulla revisione del TUEL potrebbe includere il confronto sull’opportunità di conferire ai primi cittadini la competenza in materia di promozione della salute, e non più solo di prima autorità sanitaria dell’Ente, con compiti talvolta anacronistici o distanti dalle competenze richieste. Gli stessi piani di prevenzione regionali potrebbero rappresentare un primo strumento di concertazione, a partire dalle aree metropolitane o da ambiti organizzati intorno a una strategia condivisa, per testare progetti di salute territoriale e di servizi di comunità finalizzati a disegnare, come previsto dai programmi PNRR e NGEU, la ricomposizione tra welfare state e welfare local.
47
La Giornata Nazionale del 2 luglio rappresenta il giorno centrale dell’anno solare e il messaggio che intendiamo veicolare con questa iniziativa, lanciata nel 2018, è che la salute, l’ambiente, il benessere e lo sport debbano diventare temi centrali delle politiche nazionali, regionali e delle città durante tutto l’anno. In particolare, il tema dell’edizione 2021 è proprio “Ripartiamo”: un chiaro invito a cittadini e istituzioni a essere attivi e propositivi nel proprio contesto urbano attraverso attività di prevenzione e promozione di corretti stili di vita, alla luce della necessità di ripartire dopo l’emergenza pandemica che ha stravolto il nostro Paese e la vita nei nostri territori.
Comunità e territori sono stati messi a dura prova in quest’ultimo anno e mezzo, dimostrando come occorra identificare strategie di azione unitarie e nuove alleanze per plasmare un modello di cura e di benessere urbano all’altezza della sfida che stiamo vivendo. Per questa ragione l’evento organizzato in questo 2021 si propone di richiamare l’attenzione e di stimolare l’azione dei Sindaci sulla necessità e l’urgenza di ripartire dalle città come luoghi per promuovere la salute e il benessere.
Nel Documento che sottoponiamo all’attenzione del Presidente del Consiglio e dei Ministri competenti abbiamo deciso di declinare il tema della salute nelle città secondo il trinomio del G20 a Presidenza italiana “People, Planet, Prosperity”, già oggetto della riflessione svoltasi lo scorso maggio durante il Global Health Summit.
People, per rimettere la persona al centro delle azioni di politica pubblica, multilaterale e nazionale; Prosperity, per sfruttare appieno il potenziale della rivoluzione tecnologica e per migliorare concretamente le condizioni dei cittadini in tutti gli aspetti della loro vita rendendo il diritto alla salute più equo, realmente esigibile e accessibile in maniera omogenea; Planet, per avviare una transizione concreta verso economie “verdi”, sfruttando le energie rinnovabili e muovendoci verso città moderne e “intelligenti”, in cui i luoghi e i comportamenti diventino alleati e garanti di uno stile di vita più sano e sostenibile.
La sfida sul ruolo del Sindaco come promotore di benessere e qualità di vita urbana è perciò una sfida avvincente, una scommessa che vale la pena di praticare sino in fondo, con la consapevolezza delle difficoltà e dei problemi che comporta, ma anche con la piena consapevolezza di che cosa significherebbe far compiere tale salto di qualità al sistema salute in Italia con una responsabilità di questo tipo.
Una sistema salute efficiente, e umano, in grado di occuparsi a trecentosessanta gradi del cittadino ponendolo al centro della progettazione dei servizi. Come farlo? Innanzitutto, recuperando una dimensione territoriale del tema della salute e della sanità.
Un tema fondamentale è, infatti, il rapporto con il territorio. I sindaci non si candidano oggi a gestire la sanità o a tornare a vecchi e superati modelli di interazione con le aziende sanitarie, bensì si stagliano come figure in grado coordinare e dialogare autorevolmente con tutti i soggetti che, a vario titolo e competenza, si occupano della tutela e della promozione della salute. Si tratta di difendere una responsabilità piena, quella di essere autorità sanitaria, curando in maniera più mirata ed efficace l’aspetto dell’analisi dei determinanti di salute sociali dei nostri cittadini. È un aspetto decisivo e importante, che implica un nuovo e significativo rapporto con il territorio, in una dimensione di prossimità, di cura e di prendersi cura del cittadino.
In secondo luogo vorrei far emergere un tema di competenze, nelle dinamiche di governo multilivello, sia ascendenti
sia discendenti. Ad esempio, sono convinto che le competenze dell’Unione Europea in materia di salute debbano crescere, soprattutto in un momento, come quello che abbiamo vissuto a causa della pandemia, in cui abbiamo visto che non vi sono ostacoli alla diffusione di un virus rappresentati da confini territoriali. Lo stesso modello della separazione tra Stato e Regioni va superato, in un’ottica più moderna e più omogenea a livello territoriale. Tutto ciò in parallelo a una nuova dimensione, quella derivante dal basso, quella che un Sindaco può affermare coordinando le dinamiche che agiscono sul territorio.
A questo scopo ci dobbiamo attrezzare in modo adeguato, con la formazione certamente, con lo scambio interistituzionale di strategie e piani di azione, e con l’idea di fare squadra. La tutela e la promozione della salute dei cittadini è infatti un compito fondamentale per i Sindaci, in quanto autorità sanitaria locale, che richiede loro una visione strategica e che implica la collaborazione con le altre Istituzioni coinvolte attraverso una serie di azioni coordinate che vanno dall’elaborazione di politiche urbane che abbiano come priorità la salute, al miglioramento della rete urbana dei trasporti, della qualità del verde cittadino e delle politiche ambientali, alla promozione delle attività sportive fino a interventi di partecipazione sociale, welfare e sostegno alle fasce più deboli.
ANCI riserva da tempo al tema della salute nelle città un’attenzione parti-colare, sulla base della definizione dell’OMS secondo cui la salute “è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non la semplice assenza di malattia”. Nel 2016, con la sottoscrizione del Manifesto “La Salute nelle Città: bene comune”, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, attraverso una lettera aperta ai Sindaci italiani ha voluto indicare loro, in dieci punti, le azioni prioritarie per migliorare gli stili di vita e lo stato di salute dei cittadini con l’obiettivo di costituire un network tra le città.
E l’esempio di C14+ vuole darne prova: mettere insieme le città con il mondo della ricerca, il mondo universitario, il sistema produttivo, generando un’alleanza in grado di imprimere qualità, forza ed energia ai temi della Giornata Nazionale per la salute e il benessere nelle città.
Per vincere la scommessa di come deve essere il nostro Paese nel futuro: un Paese in cui l’essere umano è al centro delle politiche pubbliche, un Paese in cui gli amministratori locali, a contatto ogni giorno con i cittadini, devono poter incidere sulle scelte di salute e di benessere.
48
Mettere insieme le città con il mondo della ricerca, il mondo universitario, il sistema produttivo, generando un’alleanza in grado di imprimere qualità, forza ed energia.
 di Enzo Bianco Presidente Consiglio Nazionale ANCI e Presidente C14+
di Enzo Bianco Presidente Consiglio Nazionale ANCI e Presidente C14+
ITALIAN URBAN HEALTH DECLARATION
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1948 definiva la salute come “…uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di infermità” e invitava i governi ad adoperarsi responsabilmente, attraverso un programma di educazione alla salute, al fine di promuovere uno stile di vita sano e di garantire ai cittadini un alto livello di benessere.
Oggi l’umanità si trova ad affrontare urgenti considerevoli sfide globali, con impatti diretti sulla vita e sul benessere della popolazione mondiale. Più che mai, si rende necessario uno sforzo condiviso di responsabilità e di lungimiranza da parte della comunità internazionale. Il G20, di cui l’Italia detiene la Presidenza dal 1° dicembre, è fermamente impegnato nella ricerca di risposte coordinate, eque ed efficaci, capaci di porre le basi per un futuro migliore e sostenibile, declinate secondo il trinomio “People, Planet, Prosperity”.
PEOPLE, per rimettere la persona al centro delle azioni politiche, multilaterali e nazionali. PROSPERITY, per sfruttare il potenziale della rivoluzione tecnologica e per migliorare concretamente le condizioni dei cittadini in tutti
gli aspetti della loro vita. PLANET, per avviare una transizione concreta verso economie verdi, sfruttando le energie rinnovabili e dando vita a città moderne e intelligenti.
Tali priorità sono strettamente correlate a nuovo concetto di salute e benessere, che deve animare le comunità e le città, secondo il quale il traguardo non risulta più meramente la sopravvivenza fisica o l’assenza di malattia bensì si amplia, comprendendo gli aspetti psicologici, le condizioni naturali, ambientali, climatiche e abitative, la vita lavorativa, economica, sociale e culturale delle persone.
Ecco perché non è più possibile trascurare il ruolo delle città come promotrici di salute.
A tal proposito l’OMS ha coniato il termine healthy city, che non descrive una città che ha raggiunto un particolare livello di salute pubblica, quanto piuttosto una città che è conscia dell’importanza della salute come bene collettivo e che, quindi, mette in atto delle politiche chiare e mirate per tutelarla e migliorarla.

50
La salute non più solo “bene individuale” bensì “bene comune” che richiama tutti i cittadini a scelte eticamente responsabili e all’osservanza delle regole di convivenza civile, così come a comportamenti virtuosi basati sul rispetto reciproco e del contesto in cui si vive e opera, plasmando in questo modo un nuovo concetto di inclusione sociale, di economia circolare e sostenibilità ambientale, basato sul welfare generativo.
Il bene comune è dunque un obiettivo da perseguire da parte sia dei cittadini, sia dei sindaci e degli amministratori locali che devono proporsi come garanti di una sanità equa e armonica, facendo sì che la salute della collettività possa essere considerata un investimento, e non solo un costo.
L’organizzazione della città e, più in generale, dei contesti sociali e ambientali, è in grado di condizionare e modificare i bisogni emergenti, gli stili di vita e le aspettative dell’individuo, fattori che dovrebbero, dunque, essere considerati nella definizione e nell’orientamento delle politiche pubbliche.
Si stima che nei prossimi decenni la popolazione urbana rappresenterà il 70% della popolazione globale, rappresentando un fenomeno dinamico da affrontare prioritariamente da parte dei Sindaci durante la propria azione amministrativa. Sono, infatti, le città a guidare le economie locali e nazionali, come centri di prosperità dove si concentra oltre l’80% delle attività economiche globali. Le città hanno un enorme impatto ambientale: occupano solo il 3% della superficie del mondo, ma sono responsabili per il 75% del consumo di risorse globali e del 75% delle emissioni globali. L’urbanizzazione e la configurazione attuale delle città offrono per la salute pubblica e individuale tanti rischi quante opportunità: se le città saranno ben pianificate, ben organizzate e amministrate coscientemente, le opportunità potranno superare i rischi.
Le criticità che emergono oggi più forti e urgenti possono essere comprese e risolte solo se si effettua un’analisi dei determinanti sociali, economici, climatici e ambientali e dei fattori di rischio che hanno un impatto sulla salute. Il rapporto tra salute, qualità della vita e ambiente è ormai un tema di centrale interesse per le scienze sociali, ambientali e mediche e lo deve essere anche per i decisori politici.
Nel settembre 2015 i Governi dei 193 Paesi ONU si sono incontrati alle Nazioni Unite con lo scopo di contribuire allo sviluppo globale, di promuovere il benessere umano e di proteggere l’ambiente, e hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, costituita da 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.
Insieme agli Obiettivi 3, 10, 13 e 17, in particolare l’Obiettivo 11 richiama i Governi a intraprendere azioni specifiche per rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, scuri, duraturi e sostenibili; mira a ridurre gli effetti negativi dell’impatto ambientale delle città in particolare in termini di qualità dell’aria e gestione dei rifiuti; richiede forme più inclusive e sostenibili di urbanizzazione, basate su un approccio partecipativo, integrato e sostenibile alla pianificazione urbana. Inoltre, si propone di garantire l’accesso universale
a spazi verdi e pubblici, sicuri e inclusivi, soprattutto in favore degli individui più vulnerabili, e di fornire l’accesso a sistemi di trasporto sicuri e convenienti.
L’8 luglio 2016 ANCI, insieme al Ministero della Salute e a Health City Institute, ha finalizzato e sottoscritto il Manifesto “Salute nelle Città: bene comune”. Il Manifesto delinea i punti chiave che possono guidare le città a studiare e approfondire i determinanti di salute nei propri contesti urbani e a fare leva su di essi per escogitare strategie per migliorare gli stili di vita e lo stato di salute del cittadino. Ogni punto del Manifesto contiene indirizzi prioritari che debbono guidare l’azione degli amministratori locali per il raggiungimento di questo obiettivo, promuovendo, a partire dal confronto con l’esperienza europea e internazionale, partenariati pubblico-privati per progetti di studio e attuazione efficaci.
Parimenti il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, nella 123esima seduta plenaria del 12 maggio del 2017, ha approvato il parere “La salute nelle città: bene comune”, esortando il Parlamento Europeo a inserire la salute e la sua definizione tra i contenuti della Nuova Agenda Urbana, avviando un’innovativa cultura di co-progettazione che possa contribuire a promuovere la salute e un contesto ad essa favorevole mediante una pianificazione territoriale volta al miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali, soprattutto nei quartieri disagiati o svantaggiati.
La “Roma Urban Health Declaration”, firmata l’11 dicembre 2017 da ANCI e Ministero della Salute in occasione del side event G7 a Presidenza italiana, ha definito gli aspetti strategici funzionali a migliorare la salute nelle città attraverso un approccio di tipo olistico, per quanto riguarda la persona, e di tipo multisettoriale, per quanto attiene alle politiche di promozione della salute nell’ambito del contesto urbano.
Anche il documento “Copenhagen Consensus of Mayors for healthier and happier cities for all”, redatto dai rappresentanti dei Paesi membri dell’OMS Europa il 13 febbraio 2018, allineato agli OSS delle Nazioni Unite, ha posto in evidenza il ruolo delle città come volano di sviluppo e di strategie incentrate sui concetti di PEOPLE, PARTICIPATION, PROSPERITY, PLACE, PEACE e PLANET, generando Healthy Cities in grado di promuove la salute e il benessere attraverso un nuovo modello di governance, l’empowerment e la partecipazione in processi di co-creazione dei cittadini, e di assicurare prosperità alle comunità globali investendo sulle persone per un pianeta pacifico.
Il 21 maggio 2021 si é svolto a Roma il Global Health Summit, un evento speciale della Presidenza G20, organizzato dall’Italia in partnership con la Commissione europea e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. La “Dichiarazione di Roma”, che ha chiuso il Summit, ha inteso sottolineare come la frequenza e la natura delle future pandemie dipendano fortemente dalla nostra capacità di adottare stili di vita sostenibili, dall’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dall’approccio One Health.
51
Occorre pertanto adottare un approccio integrato per affrontare i problemi di salute pubblica in un mondo sempre più interconnesso e interdipendente, in cui il multilateralismo possa rappresentare una strategia diffusa a tutti i livelli. Una città in salute, vedendo attivati fattori abilitanti di tale capacità di governance, può offrire grandi opportunità all’azione dei Governi creando le condizioni necessarie per un rilancio ambizioso, efficace e sostenibile.
In questo contesto, il presupposto metodologico diventa la collaborazione interistituzionale, declinata a partire dalle dimensioni urbana e sociale delle Città Metropolitane per essere estesa a tutti i Comuni come approccio unitario per una salute integrata di comunità. Un approccio caratterizzato per la sua multidisciplinarietà e intersettorialità, ma anche per la volontà di essere multi-sede, digitale e tecnologico per raggiungere la massima divulgazione e il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti.
La città possono diventare modelli di ambienti salutogenici, in cui la figura dell’Health City Manager coordini la governance e il monitoraggio, di processo e di esito, delle politiche pubbliche per la qualità della vita, stabilendo obiettivi specifici sostenibili, raggiungibili e valutabili.
L’ITALIAN
URBAN HEALTH DECLARATION
raccomanda che i Governi dei Paesi del G20 si impegnino a sviluppare politiche e azioni in grado di:
INVESTIRE NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DELLE CITTÀ
Le città esprimono un grande potenziale nel diventare ambienti promotori di salute. Tale obiettivo richiede un cambio di visione che consideri la prevenzione come un investimento a lungo termine piuttosto che un costo a breve termine.
TARGET 1.1
Entro il 2026, adottare in ogni Comune un Piano per le politiche, gli obiettivi specifici e le azioni di promozione della salute finalizzato a migliorare il livello di salute e di benessere per tutti i cittadini;
TARGET 1.2
Entro il 2026, aumentare, in misura del 50%, il finanziamento per la promozione della salute attraverso lo sviluppo di attività finalizzate a integrare un percorso di valorizzazione della salute urbana nel senso più comprendente di benessere psico-fisico; l’educazione, in particolare in ambito scolastico, e la formazione, con l’inserimento del tema in tutti i curricula universitari; il mantenimento dei luoghi per la prevenzione, la cura e l’assistenza, con particolare riferimento e alle aree urbane con gruppi vulnerabili, individuate dall’indice di vulnerabilità ISTAT;
TARGET 1.3
Entro il 2030, approvare solidi quadri di riferimento politici a livello nazionale, regionale e locali, basati su strategie di sviluppo della salute nelle città a favore delle fasce di popolazione più vulnerabili, con una forte attenzione all’equità e al riconoscimento delle diversità di genere, cultura ed etnia;
TARGET 1.4
Entro il 2030, inserire la valutazione degli impatti di salute secondo specifici indicatori in itinere, di esito e di profitto in tutti i progetti di pianificazione urbana, in chiave inclusiva e sostenibile, realizzandoli secondo un metodo di gestione partecipativa, con particolare attenzione all’infanzia e alle giovani generazioni e al loro coinvolgimento attraverso strumenti tecnologici;
TARGET 1.5
Entro il 2030, fornire l’accesso universale agli spazi verdi pubblici in modo sicuro, inclusivo e accessibile, promuovendo la salute attraverso nuovi modelli di refezione scolastica, l’attività sportiva scolastica e l’attività motoria per tutti i cittadini.
AFFRONTARE I DETERMINANTI SOCIALI E CULTURALI PER UNA SALUTE EQUA PER TUTTI I CITTADINI
I determinanti sociali e culturali sono cause alla radice delle opportunità di qualità e stili di vita sani per i cittadini, in termini non solo sanitari o ambientali, ma anche socio culturali e di benessere integrato. Contrastare i meccanismi di generazione delle disuguaglianze di salute è essenziale per garantire opportunità di salute per tutti. Le città possono rappresentare l’ambiente più prossimo in grado di capacitare le persone più povere di risorse e competenze e di proteggere e promuovere la loro salute attraverso un approccio d’iniziativa, la presa in carico pro-attiva dei bisogni e interventi regolatori sul contesto collettivo.
TARGET 2.1
Entro il 2026, realizzare una mappa dei determinanti sociali, comportamentali e culturali e delle risposte (o barriere) delle politiche locali nelle 14 Città Metropolitane al fine di stabilire il contesto di partenza per rendere la scelta di salute la scelta più semplice, attivando una collaborazione intersettoriale in grado di integrare i dati che provengono dalle differenti fonti;
TARGET 2.2
Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare le persone più fragili dal punto di vista clinico e funzionale e più vulnerabili dal punto di vista sociale, abbiano uguali diritti riguardo l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso a farmaci essenziali sicuri, efficaci, di qualità a prezzi accessibili e vaccini per tutti, diminuendo del 20% la quota di cittadini che rinunciano alle cure per difficoltà;
TARGET 2.3
Entro il 2026, promuovere la nascita di un Programma Nazionale per la Salute nelle Città, contenente misure economiche e sociali mirate a migliorare l’inclusione sociale di tutte le categorie di popolazione considerate svantaggiate per condizioni economico-sociali, o per condizioni di salute, come malattia e disabilità, promuovendo la loro partecipazione anche nelle attività sportive e ricreative;
TARGET 2.4
Entro il 2030, promuovere piani e politiche di prevenzione e inserimento socio-sanitario a livello urbano per le popolazioni
52
urbane multi-etniche, ospitanti gruppi di migranti, anche ricorrendo a figure di mediatori culturali;
TARGET 2.5
Entro il 2026, rimuovere tutti gli ostacoli normativi e ambientali che impediscono un accesso a interventi di prevenzione e cura di qualità e tempestivi, garantendo a tutti pari opportunità e riducendo le disuguaglianze di risultato.
INTEGRARE LA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE URBANE
La salute è legata alle agende delle altre politiche pubbliche, incluse quelle sociali, occupazionali, abitative e ambientali. Al fine di migliorare la salute e il benessere dei cittadini, la salute deve essere integrata nei processi decisionali in maniera trasversale rispetto a tutti gli ambiti e deve essere guidata da obiettivi comuni a tutte le politiche.
TARGET 3.1
Entro il 2026, favorire la realizzazione di piani pluriennali nelle Città Metropolitane che in maniera intersettoriale integrino la salute in tutte le politiche e in particolare in quelle ambientali e lavorative, urbanistiche e abitative, della mobilità e dei trasporti, sociali e sportive, culturali;
TARGET 3.2
Entro il 2030, incoraggiare lo sviluppo della capacità di tutte le città, di adottare misure per la prevenzione, la riduzione e la gestione dei rischi per la salute, favorendo la creazione di osservatori permanenti sulla salute nelle città e di regolari progressivi monitoraggi;
TARGET 3.3
Entro il 2026, promuovere rapporti economici, sociali e ambientali riguardo la salute come bene comune tra zone urbane, periurbane e rurali, rafforzando la pianificazione in ambito territoriale e valutandone l’impatto amche su outcome intermedi;
TARGET 3.4
Potenziare l’investimento nella ricerca scientifica, sanitaria e sociale sulle politiche urbane, sviluppando le capacità tecnologiche sulla salute nelle città e incoraggiando, entro il 2030, la creazione di piattaforme cittadine di condivisione sull’innovazione tecnologica e sulla digitalizzazione per la salute nelle città, stabilendo come obiettivi misurabili e rilevanti in termini di salute, in particolare, il consumo di suolo, la prestazione energetica e la qualità dell’ambiente costruito, la salubrità indoor e la produzione di CO2;
TARGET 3.5
Entro il 2026, acquisire, da parte delle città, un ruolo attivo nella definizione e nell’aggiornamento dei Piani di contenimento delle emergenze di salute pubblica e delle malattie trasmissibili infettive e diffusive, redatti da Stato e Regioni, con la collaborazione delle tecnostrutture del Servizio Sanitario Nazionale;
TARGET 3.6
Rafforzare la capacità del Sistema Sanitario di guidare e valutare la pianificazione urbanistica attraverso l’utilizzo di
strumenti e criteri per la definizione delle implicazioni di salute degli interventi urbani per la rigenerazione ecosistemica delle città e lo sviluppo di azioni di Urban Health nel contesto dei Piani e Programmi di Prevenzione a livello sia nazionale sia regionale, inserendo vincoli di destinazione dei fondi riservati a tale scopo.
COINVOLGERE E IMPEGNARE LE COMUNITÀ LOCALI NELL’ASSICURARE SOLUZIONI SOSTENIBILI PER LA SALUTE
Il livello di salute è determinato in massima parte al di fuori il settore della cura sanitaria, in particolare all’interno delle comunità dove le persone conducono la propria vita quotidiana. Le azioni per la salute dovrebbero spingersi oltre il livello individuale per includere lo scenario di comunità dove norme sociali possano dare forma a comportamenti virtuosi.
TARGET 4.1
Entro il 2026, coinvolgere e impegnare attivamente la cittadinanza attraverso progetti specifici sulla salute e stili di vita sani rivolti al benessere della comunità, con particolare attenzione alle aree urbane ove risiedono i gruppi più vulnerabili, al fine di rafforzare l’inclusione sociale e di guidare azioni sostenibili per la promozione della salute, facilitandone i meccanismi di attivazione,
TARGET 4.2
Entro il 2026, creare, da parte dei Comuni, efficaci strumenti di informazione, alfabetizzazione e comunicazione, a partire dal primo ciclo scolastico, rispetto ai temi di salute, trasformandoli in fattori abilitanti e di trasferimento della conoscenza nella pratica, sviluppando le potenzialità offerte dai luoghi e dalle interconnessioni relazionali in contrasto al rischio sindemico;
TARGET 4.3
Entro il 2030, realizzare piani per una rete socio-sanitaria e assistenziale di prossimità territoriale che funga da “sensore” e “attore” nei confronti dei cittadini, della popolazione più fragile e vulnerabile, con il coinvolgimento e la piena integrazione delle strutture sanitarie e sociali a garanzia della continuità assistenziale nei Patient Support Programme, delle case di comunità, delle farmacie, dei medici di medicina generale, delle associazioni, del no profit, del volontariato e del terzo settore a livello locale;
TARGET 4.4
Entro il 2030, ridurre del 25% la mortalità prematura da malattie non trasmissibili, in coerenza con gli obiettivi fissati dal WHO 25x25 Global Action Plan, attraverso la prevenzione e la cura e la medicina di genere, e promuovere la salute mentale e il benessere nelle città, con riferimento particolare al tema delle solitudini, delle cronicità e della longevità.
CREARE SOLUZIONI IN PARTENARIATO CON ALTRI SETTORI IN MODO TRASVERSALE PER CREARE UN NUOVO CONCETTO DI CITTÀ
La salute è una responsabilità condivisa. Creare soluzioni sostenibili richiede che tutti i componenti della società siano consapevoli dell’impatto sulla salute delle loro azioni. Ac-
53
cordare le competenze e condividere le risorse e le reti sono prerequisiti per dare vita a soluzioni innovative, efficaci e sostenibili.
TARGET 5.1
Entro il 2030, garantire, attraverso la creazione di tavoli tematici e l’attivazione di partenariati pubblico-privato basati sull’approccio population health, la mobilitazione di risorse e il trasferimento di competenze e capacità di co-progettazione al fine di promuovere lo sviluppo di iniziative sulla salute in tutte le sue dimensioni;
TARGET 5.2
Entro il 2026, creare cabine di regia dedicate e permanenti, prevedendo il coinvolgimento congiunto delle Amministrazioni Comunali insieme ad Autorità Sanitarie, Università e Centri di Ricerca, mondo imprenditoriale, terzo settore e no profit, con l’obiettivo di promuovere la salute secondo un approccio intersettoriale e cooperativo “open field lab” e di stabilire reciproche responsabilità e premialità per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi di salute globali;
TARGET 5.3
Entro il 2026, migliorare il grado di cooperazione verticale e orizzontale nel Paese diffondendo cultura del dato, buone pratiche, casi studio, esempi ma anche evidenze in tema di promozione della salute e creare un sistema di incentivi rivolto alle imprese socialmente responsabili che investono in sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
TARGET 5.4
Entro il 2025, creare e implementare, in collaborazione con le Autorità sanitarie locali, le Regioni e il Governo, programmi di sorveglianza sulle questioni relative alla biosicurezza che vanno intesi come un controllo dei fattori inquinanti e dannosi rilasciati nell’ambiente in modo volontario ed involontario (biosafety), fino alla prevenzione del rilascio volontario e malevolo nell’ambiente cittadino di agenti inquinanti, agenti pericolosi per la salute, agenti radioattivi e agenti patogeni. A tal fine, verificare le stime di riduzione del numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da inquinamento e contaminazione di aria, acqua e suolo nelle città, conseguenti ai progetti realizzati in questi ambiti.
Declaration:
Lenzi Andrea
Bianco Enzo Pella Roberto
Capolongo Stefano Abodi Andrea
Andreozzi Francesco
Angelini Luigi Ansalone Gianluca
Argento Angelo Baldini Alessandra
Bargero Cristina Brigidi Patrizia Carini Marina Carruba Michele Casaccia Sara Colao Annamaria
Consoli Agostino Corsaro Lucio Cosimi Alessandro
Costa Giuseppe
Crialesi Roberta
D’Alba Fabrizio
D’Alessandro Daniela
D’Ambrosio-Lettieri Luigi D’Elia Roberto
da Empoli Stefano
Damilano Maurizio Dima Antonio Dotta Francesco
Esposito Katherine Fava Fabio
Frittelli Tiziana
Frontoni Simona Gaudioso Antonio Ghigo Ezio
Gigliuto Livio Giorgino Francesco Grasso Luciano
Honsell Furio
Lenzi Francesca Romana
Marchesini Giulio Mazzoni Eleonora Moccia Francesca
Nicolucci Antonio
Pagliara Fabio Pagotto Uberto
Parente Paolo
Patti Daniela
Pisanti Paola
Rebecchi Andrea
Revel Gian Marco
Selvi Eleonora
Serra Federico
Settimo Gaetano
Signorelli Carlo
Siliquini Roberta
Slienzi Andrea
Solipaca Alessandro
Spandonaro Federico
Spinato Chiara
Tanese Angelo
Tondelli Simona
Vaccaro Ketty
Vella Stefano
54
Hanno contribuito alla realizzazione dell’Italian Urban Health

Per cambiare la medicina, nei fatti
In Novartis, affrontiamo con la forza dell’i nnovazione scientifica alcune tra le sfide sanitarie più impegnative della società. I nostri ricercatori lavorano per allargare i confini della scienza, ampliare la comprensione delle malattie e sviluppare prodotti innovativi in aree dove ci sono grandi bisogni medici ancora non soddisfatti. Con passione, siamo impegnati a scoprire nuovi modi per prolungare e migliorare la vita dei pazienti.

56 Novartis Italia
Città, salute e sostenibilità: un nuovo paradigma del benessere promosso da Novartis
I mesi difficili della pandemia hanno inaugurato una nuova dimensione, in termini di valori come di tempi e di spazi, plasmata dalla salute, con la quale dobbiamo imparare a misurarci se vogliamo costruire un futuro sostenibile.
In questa stagione, le città e i territori sono tornati centrali. Secondo un recente rapporto del CNEL, la salute è tornata ai primi posti nella scala dei valori degli italiani e lo dimostra la richiesta crescente di servizi sociosanitari di prossimità, di prevenzione, monitoraggio a distanza e rapido accesso alle migliori opzioni terapeutiche.
La sfida di un nuovo benessere si gioca sulla capacità di coniugare la centralità della salute nel sentire comune con il ruolo che le amministrazioni locali saranno chiamate a ricoprire nell’affrontare le esigenze concrete dei cittadini.
È un ruolo che mai come oggi appare decisivo.
La pandemia ha infatti messo in luce tutte le fragilità di un sistema che a lungo ha confinato il dibattito tra i soli addetti ai lavori, escludendo il più ampio e articolato processo di progettazione e gestione del territorio.
La salute però, quando non viene integrata ad ogni livello, presenta un conto che, come si è visto, può essere molto salato.
È quindi necessario ridare piena cittadinanza a quel concetto di salute che l’OMS, nel suo atto fondativo di oltre 70 anni fa, definiva come “uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale” e che per essere raggiunto non può ignorare le determinanti e le evoluzioni sociali e ambientali. Approfondire questa interdipendenza significa definire policy locali coerenti in grado di mitigare l’impatto e abbattere i rischi, rimettendo la prevenzione, e le risorse per garantirla, al centro delle politiche.
57
Il primo passo è quello di dotarsi di modelli analitici in grado di restituirci una fotografia chiara della situazione. La Medicina di Popolazione è un alleato imprescindibile in questo senso, perché permette di indicare le prospettive della salute dei cittadini, anche attraverso l’incrocio con indicatori sociali e ambientali, restituendoci una mappa dei rischi e consentendoci dunque di agire molto prima, peraltro evitando costi enormi per la fiscalità generale e per il Sistema Sanitario Nazionale.
Sarà uno strumento di grande utilità per non trovarci impreparati di fronte a crisi sanitarie annunciate, come l’incidenza delle patologie croniche. Con una popolazione sempre più anziana e un tasso di natalità ai minimi storici, la prossima ondata emergenziale sarà la prevenzione, la cura e l’assistenza per patologie croniche.
Le malattie cardiovascolari, prima causa di morte in Italia, sono tra le prime fonti di preoccupazione: se è vero infatti che i ricoveri sono diminuiti del 60%, è proporzionalmente aumentata anche la mortalità, passando dal 3% al 9%, come dimostrano i dati della Società italiana di cardiologia. Il 65% delle persone decedute ufficialmente per infezione da Sars-CoV-2 inoltre presentava una comorbidità cardiovascolare. Stress, stili di vita, cattiva alimentazione, mancanza di attività fisica hanno contribuito inoltre ad aumentare l’ipercolesterolemia, tra i fattori che scatenano e aggravano le patologie cardiovascolari con forte incidenza sulla mortalità.
In un contesto come questo, per Novartis è assolutamente urgente focalizzare l’attenzione sulla prevenzione e lo strumento della Medicina di popolazione può svolgere una funzione essenziale per definire azioni concrete in questo senso, in grado di agire sulle cause primarie.
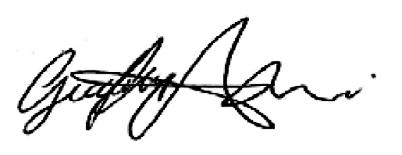
Sarà necessaria un’alleanza tra istituzioni nazionali, locali, terzo settore e le imprese per promuovere un piano coerente di riduzione della mortalità cardiovascolare e delle patologie croniche, allo scopo di scongiurare nuovi possibili allarmi sanitari.
In definitiva, si tratta di liberare la salute dai limiti della settorialità, per inaugurare una nuova era dove possa diventare lo strumento per affrontare le diverse sfide sociali che la comunità contemporanea si trova di fronte. Leggere la salute in un’ottica di sviluppo sostenibile, rappresenta la perfetta sintesi di questo nuovo approccio, una “cintura di sicurezza” per garantire una salute alla portata di tutti.
Gli impegni assunti con la recente Dichiarazione di Roma, a valle del Global Health Summit, e l’impianto identificato dal Next Generation EU vanno esattamente in questa direzione.
È per tutte queste ragioni che Novartis Italia ha deciso di rafforzare la propria governance sulla sostenibilità, dando vita alla funzione Public Affairs & Sustainability e costituendo il Comitato di Shared Value & Sustainability con l’intento di imprimere una chiara accelerazione alla dimensione di sostenibilità sociale e ambientale nelle strategie di tutta l’azienda, dal business ai processi. L’ambizione è rendere questo percorso partecipato a tutti i livelli e rafforzare l’impegno, con competenze, risorse materiali e immateriali per contribuire alla costruzione di un’Italia finalmente più inclusiva, sostenibile e per questo “in salute”.
Gianluca Ansalone Head Public Affairs & Sustainability Novartis Italia
58
“La salute in movimento”
è una delle espressioni di questa nuova visione
Il progetto è nato da un’iniziativa comune di Novartis e Culture, in collaborazione con CittadinanzAttiva, Politecnico di Milano, Università Humanitas, Università Federico II di Napoli, l’Associazione InnovaFiducia e Generatività. È guidato da una visione del sistema Salute dove innovazione, sostenibilità e investimenti in ricerca, terapia e prevenzione possano essere parte di uno stesso paradigma.
Il progetto si pone l’obiettivo di aggregare le proposte di tutti gli attori del sistema sanitario e dell’innovazione, in una logica di “crowdsourcing delle idee”, per ripensare insieme la salute del futuro in ogni suo aspetto: dalla scienza medica digitale, al benessere della persona, dall’intelligenza artificiale applicata alla chirurgia e all’assistenza, fino ai nuovi modelli organizzativi e territoriali.
Il progetto sociale si presenta come la concreta applicazione del Manifesto ‘Salute e cura in una società connessa’ che ha identificato i sei driver della trasformazione: Visione, Competenza, Governance, Intelligenza, Relazione, Umanità

Per firmare il Manifesto e maggiori informazioni https://lasaluteinmovimento.it.
Novartis in Italia
IL MANIFESTO
per la Salute del XXI secolo
Con una presenza più che consolidata nel paese, Novartis è uno dei principali gruppi farmaceutici in Italia e, da oltre vent’anni, uno dei maggiori protagonisti dell’innovazione nell’area della salute. Con le sue attività, focalizzate nei business strategici dei farmaci innovativi, dei farmaci equivalenti e biosimilari, svolge un ruolo di primo piano in tutte le principali aree terapeutiche: cardiovascolare, renale e metabolismo; oftalmologia; respiratorio; neuroscienze; immunologia, epatologia e dermatologia; oncologia ed ematologia.
Del Gruppo Novartis fa parte Advanced Accelerator Applications (AAA), società di radiofarmaceutica che ha un’importante presenza in Italia. Anche Novartis Gene Therapies (ex AveXis) società internazionale acquisita nel 2018 che ha un ruolo di punta nello sviluppo della terapia genica, è entrata a far parte a pieno titolo del Gruppo nel corso del 2020.
Nel 2020, Novartis ha realizzato in Italia un fatturato di 1.613 milioni di euro, dei quali quasi 70 milioni ottenuti grazie all’export. Gli investimenti sono stati di quasi 80 milioni di euro: di questi oltre 66 sono destinati alla Ricerca & Sviluppo e fanno di Novartis il maggior investitore in ricerca clinica in Italia.
I dipendenti sono 2.330.
La sede centrale è a Origgio, in provincia di Varese.
59
I sei driver del cambiamento

60


NOVO NORDISK PER LE PERSONE CON LE PERSONE
disk, mu Nor Novo te.terminan so tera ol l’in vcoin fida ome s e c salut ela d ema della tut t Negli ul mi anni s a armaceu c l nazionale f




























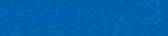








































































































































































le imp e civile e dov tàcie empo. o t tr del nos vechia in cui viviam teambienell’ o i t un diba to i è impos nel 1923, che si tafonda
ese hanno un ruolo de r ede che v gomento Un ar enzione della ev o e la pr orno al t ernazionale in nt enzione p Att escita o cr della lor a, a a finanz librio fr ema endocr t del sis on e cr vi mala agr e e di guidar efiggpr teambien er l’ o periodo. nel lung à s esponsabilit e r tembien un mod toviluppa , ha s rino à e le m ome l'obesit niche c on per sc toambiamen il c ondamen sociale sono i f l’equi e dello virtuoso dov del sangue e are e r mala e e altr te il diabe nfiggere Inambitoambien a le imp fr toprima vità diCO2nellea abbracciarel’econ vit diCO2nellea unciclovirtuoso‘c ciclo dei rifiu , all Circular chiamato Inambitoambient àhannounruo taleleci reseR100. e già nel 2020, s odu v pr omiacircolareediavere entroil2030. ve a à oper circolare’dellacatenadif viluppo d tudioeallos o s chemiraallaridu forZero o un ap at alehannoado

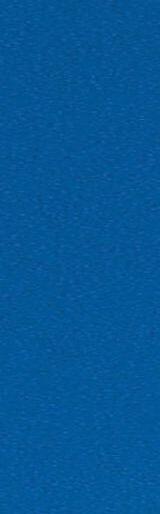
ante abilendo un import t emissioni zero toraggiun L’aziendahadichiaratodi emissioni fornituraezero abili, in odo riu lizz i pr onsumi, al ri uzionedeic proccioaudaceedunico, à al cen Le citt adini. deisuoici am e, l’ tru ur infras urbani, nel 20 ra ee urbane. Nel 2 ar ualm carbonica.A delconsumoenerg 3% della superficie o dell’impegno ntr





azione e p aliment e, l’ bient on un impa 50, 7 su 10 c sonesu10vivra 030, 6 per e, il 54% della popo ment o e del 80% delle em c e aviasono e, tu terrestr à hanno un ruo sociale eneralesullasalute iù in g sulle eceden a pr senz o glome andi ag nno nei gr ein lazione mondiale viv issioni globali di anidride esponsabili del 6080% r , occupano il olo primario lid bi a è l avanzat questa lediv allos aleg caasvilupp gene ancheurbandiabe zioneallacrescita Unfiloso lema lihlf il raverso enzione, a ev a pr a. La principale arma a vit a, cui si asso arelamala te es e urban obesity; esis et ecomeildiab adimala legailfenomeno evidente ori a a di quei f lamodific enare disposizione per fr oriambientali a ciano f bilità unasusce infa ol’obesitàchiama bete a apida urbanizz odellar e le soluzioni e der eculturalicheso oma e Mila ancheR on, Co t , Hous chino hannoaderito37c zionaleelocalech alloStenoDiabete Nordiskhalanciato o di v obieConl’ a ali, educ ambient azionicorre omuoverepr viluppo del dia endonolos efigge o si pr eog no. Il pr openaghen, Tianjin, Johan oilmondofra àintu ci Ci es Changing hiamata en, e di Copenhag esCentr nel2014insiemeall'Uni genzadievenirel’insorpr vieculturalichelafavor


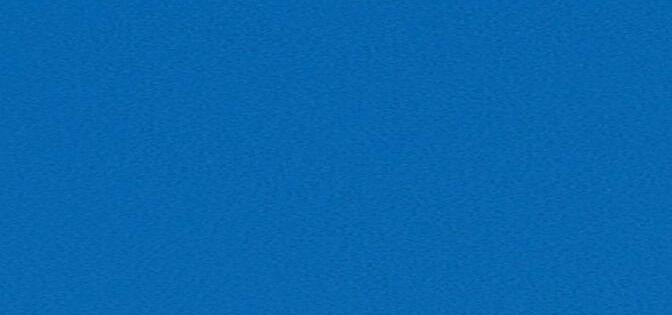


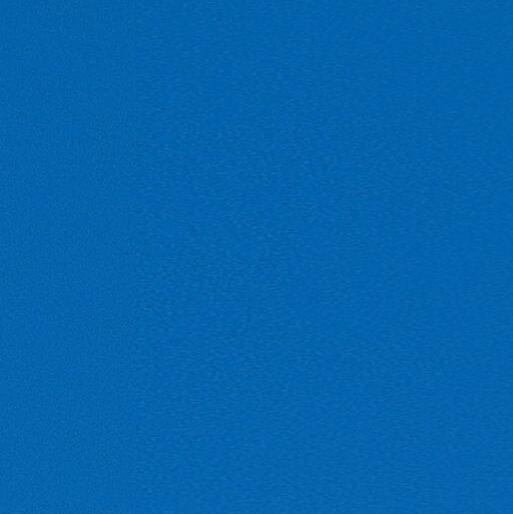

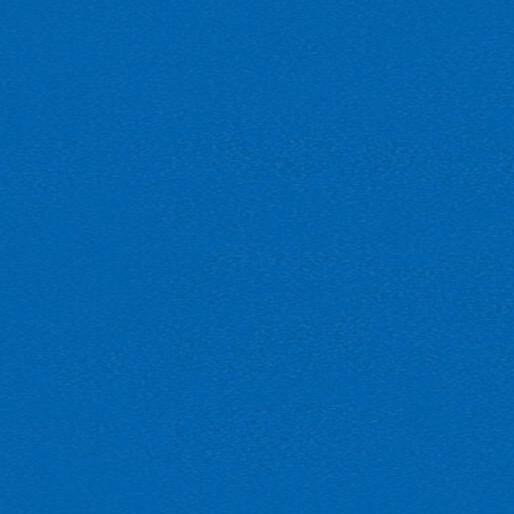










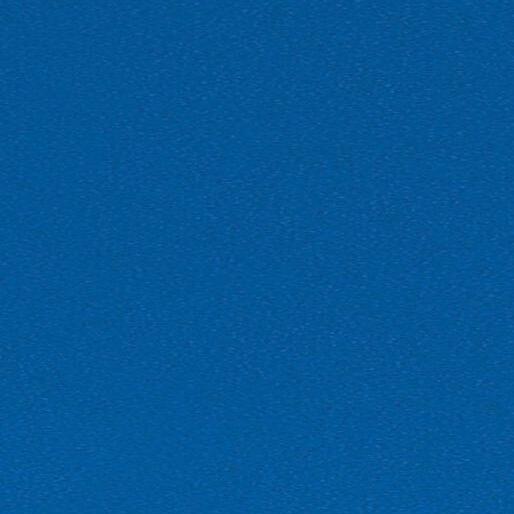




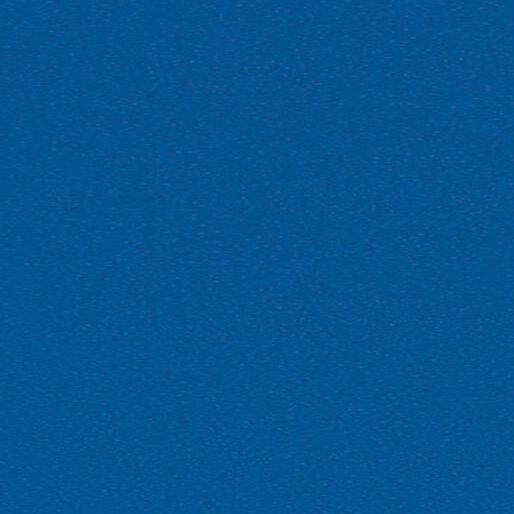

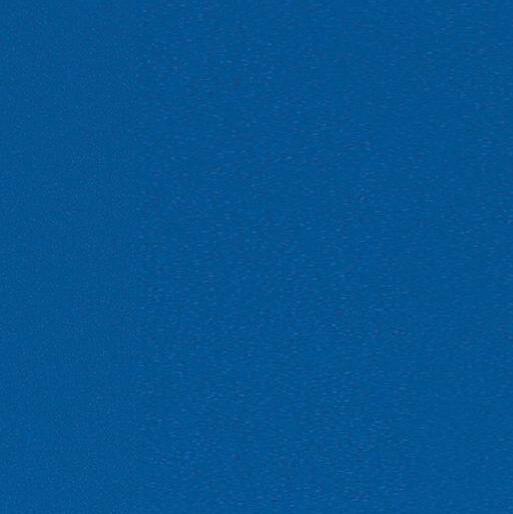
occupanoil oloprimario
oac on uno specific c ve ondivi à, c nelleci tebe orisociali eifamappar Vancouverma nesburg, Pe àdelMessico, cuiCi ammaogr es. Al pr tDiabe terna ship in una partner eLondone sity Colleg iver eobesitàNovo diabete riscono. on plan.

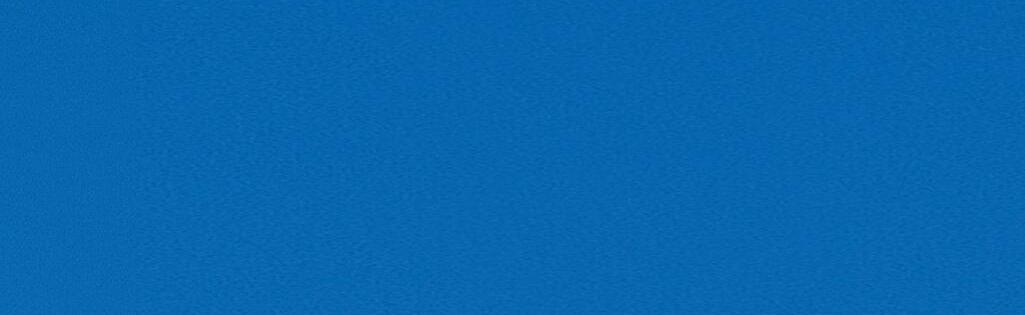
































































































































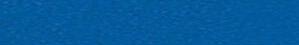

























































































f La z fo r d a di un









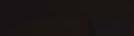

























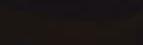




























































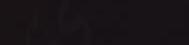







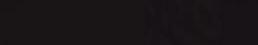













































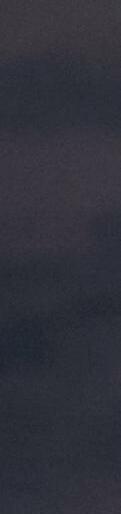





















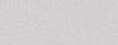













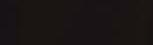

















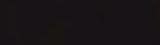








































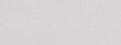









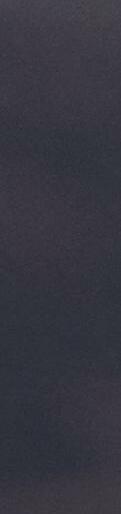



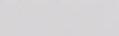
















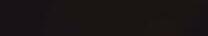




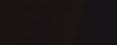





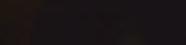




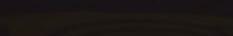




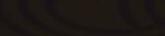







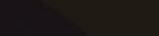















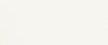






















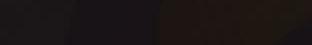








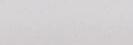







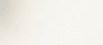
























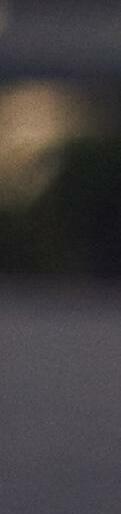












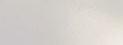


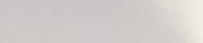

















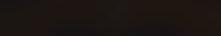

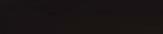



















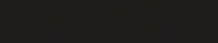











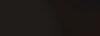











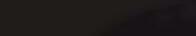


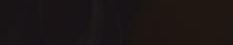




































































































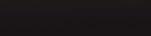
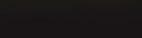
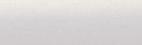




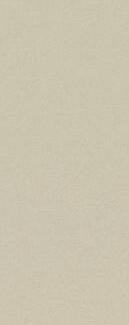























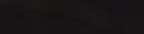










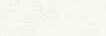







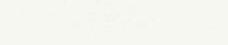


















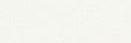











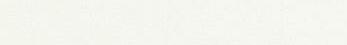































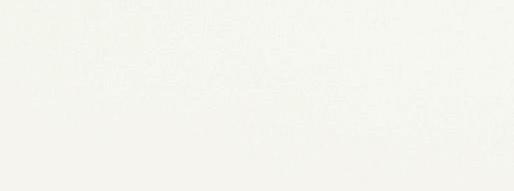





















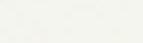

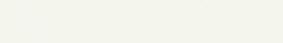

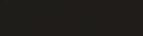


















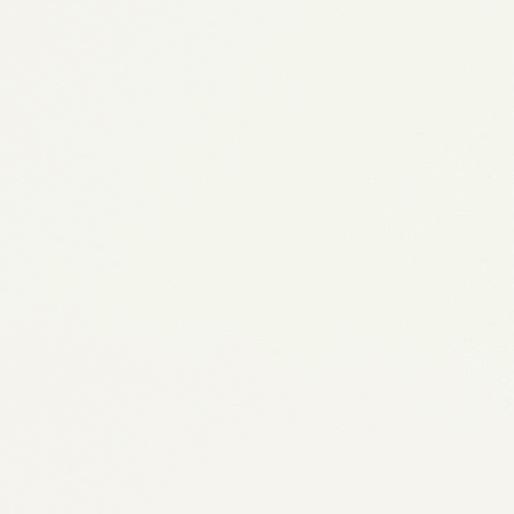
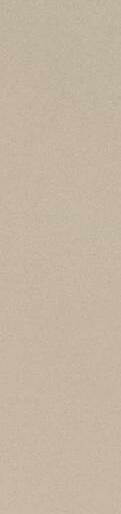












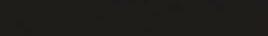


















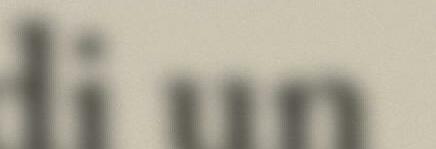





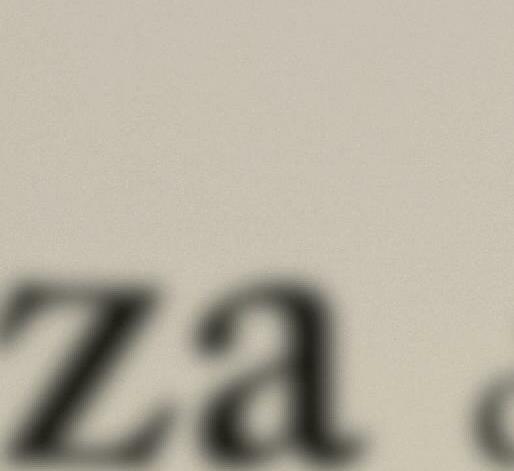
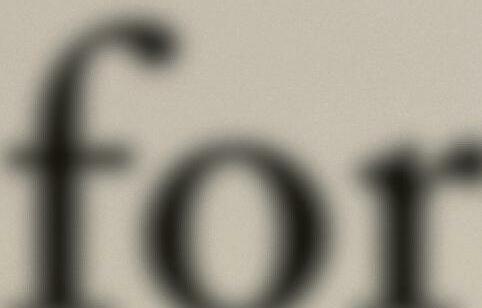

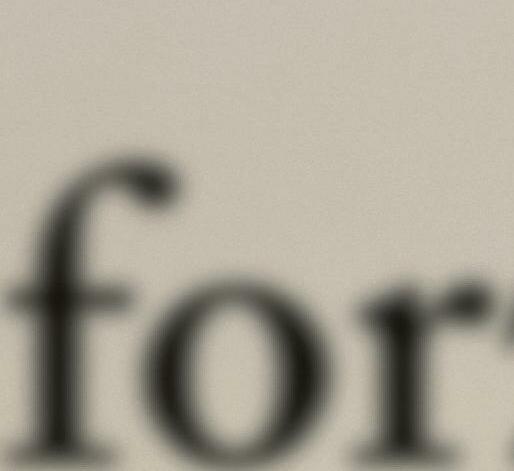
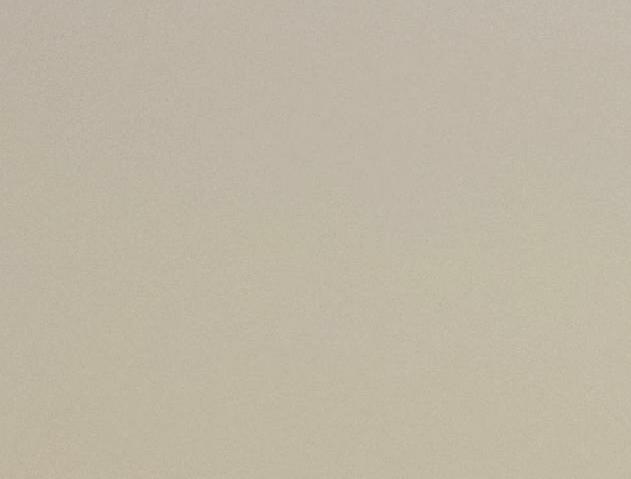
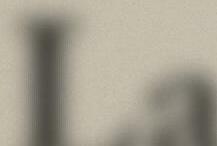

ea Team

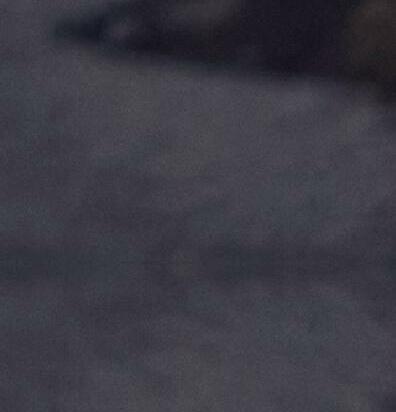
















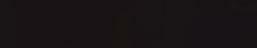
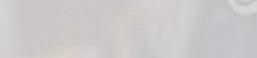

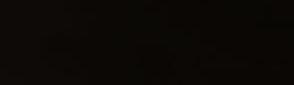

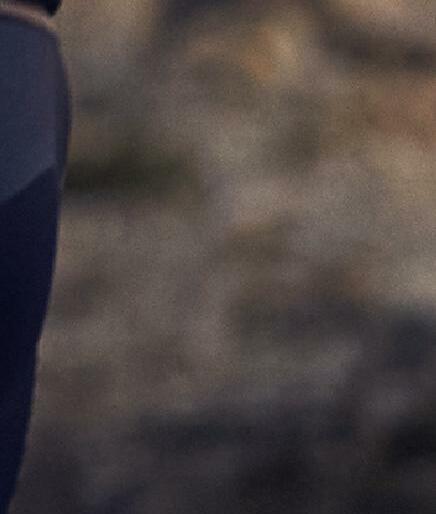




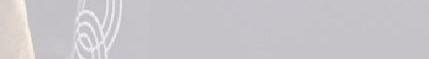

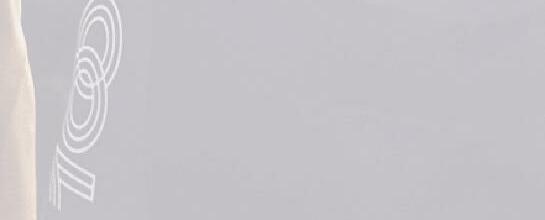














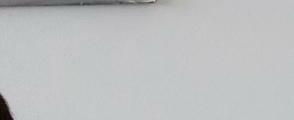


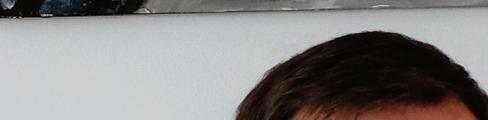







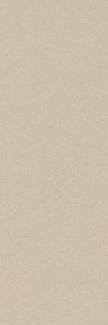




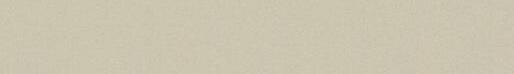



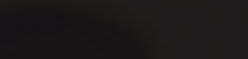
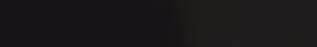











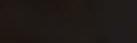
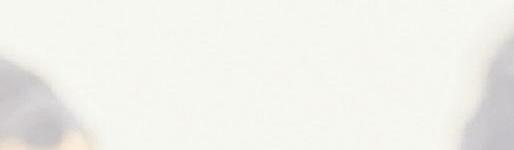


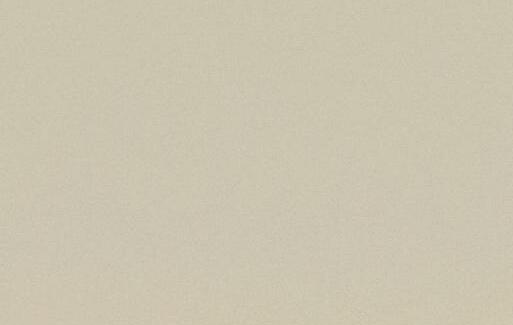


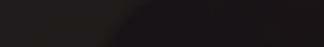





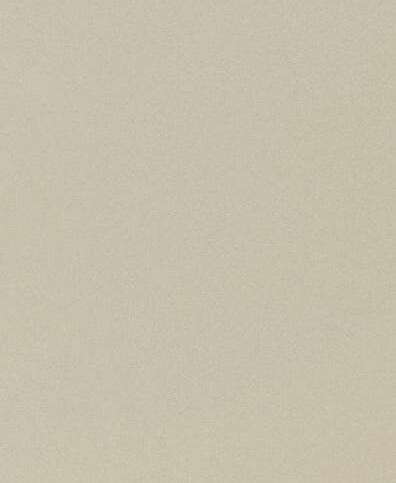


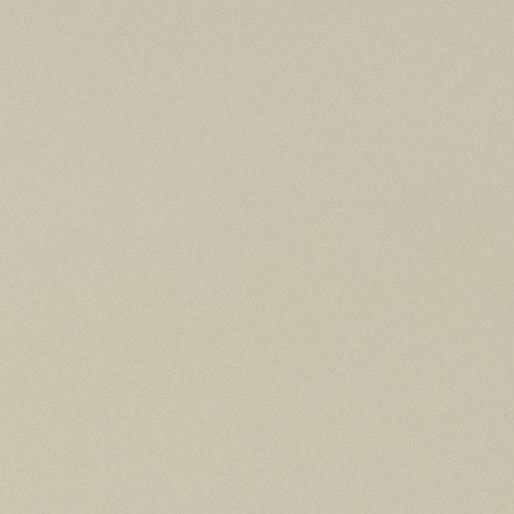
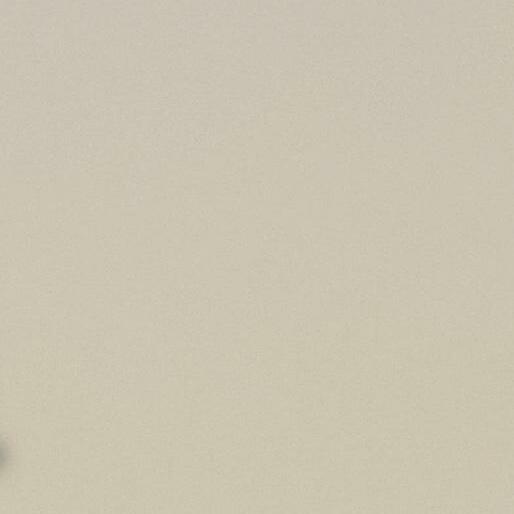

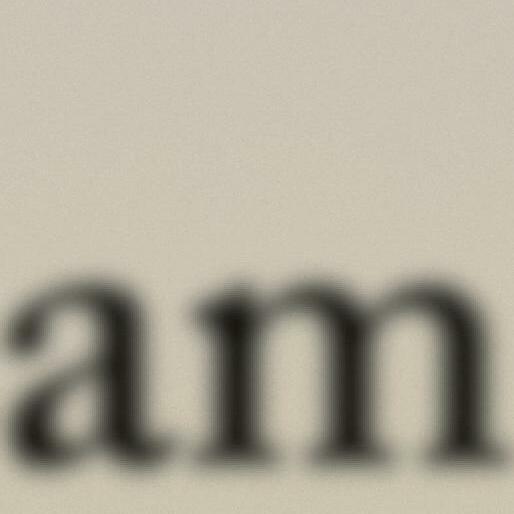
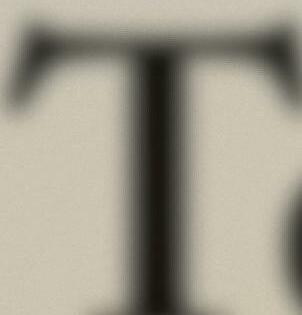


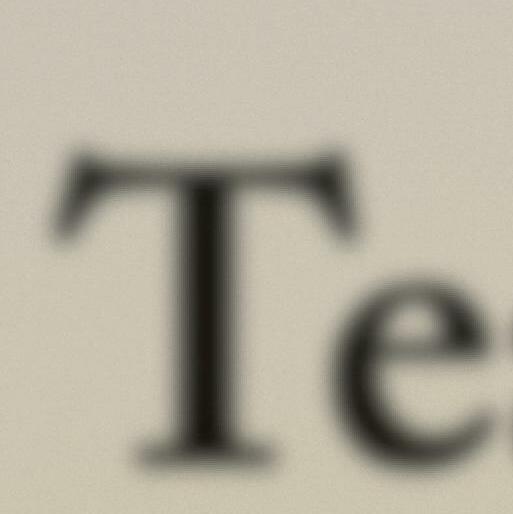

66
Premio URBES 2021

67
PREMIO URBES 2021
Un riconoscimento per il futuro delle nostre città
di M. Pappagallo
Urbanizzazione, Benessere e Salute rappresentano un trinomio sempre più centrale e prioritario per i sindaci e gli amministratori locali del nostro Paese, convinti che investire sul territorio per una migliore qualità di vita dei propri cittadini sia la chiave di volta per un futuro migliore.
La Redazione insieme al Comitato scientifico ed editoriale di URBES, rivista specialistica che si occupa di urbanizzazione, benessere e salute nelle città, ha deciso di istituire, a partire dal 2021, un premio annuale, l’URBES AWARD, assegnando un riconoscimento alle città italiane che investono per la tutela e promozione della salute.
Per questa ragione il motto che anima il premio è “Noi non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo abbiamo avuto in prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirlo migliore di come lo abbiamo trovato.”
Il dibattito sulla misurazione del benessere degli individui, della comunità e del tessuto urbano in cui si sviluppa riscuote una crescente attenzione anche all’interno del dibattito pubblico, e come ha recentemente affermato l’architetto Renzo Piano: “Un architetto e un sindaco hanno molte cose in comune. Innanzitutto, la città. L’architetto ne pensa gli spazi, ma è il sindaco che li riempie”. Ebbene, molte delle intuizioni per la creazione di nuove città o per soluzioni innovative all’interno delle stesse, dello sviluppo del benessere e della qualità di vita, si devono a sindaci che hanno immaginato il futuro e hanno lavorato in una dimensione temporale che guarda alle generazioni future.
È sulla base di tale impegno e investimento che URBES assegnerà annualmente il riconoscimento per le politiche intraprese da città italiane che investono per la tutela e promozione della salute, con la motivazione, stabilita in base a indicatori prospettici a medio e lungo termine, sviluppati dai ricercatori di BHAVE.

68
Il riconoscimento gode dell’egida di EUHCNET – European Urban Health Communicators Network, e dell’egida di C14+, di Health City Institute, dell’Intergruppo parlamentare “Qualità di vita nelle città” e vuole rappresentare uno stimolo per le Amministrazioni comunali a piantare un seme oggi per far nascere “una foresta di benessere” domani, per il futuro.

La cerimonia di consegna dell’URBES AWARD avverrà a settembre, durante un momento dedicato che sarà organizzato in forma ibrida, in presenza e in video-collegamento dalle città premiate.
I riconoscimenti per il 2021 sono andati alle seguenti città:
Premio URBES CITTÀ DEL BENESSERE E DELLA SALUTE, dedicato a città metropolitane e comuni con oltre 200.000 abitanti: BOLOGNA, BARI e MILANO
Premio URBES BENE COMUNE, dedicato a città capoluogo di provincia e comuni da 50.000 a 200.000 abitanti: COSENZA, TRIESTE
PREMIO URBES COMUNITÀ DEL BENESSERE, dedicato a comuni sino a 50.000 abitanti:
SACILE, APPIGNANO DEL TRONTO, CHIERI, CAPIZZI
69
URBANIZZAZIONE, BENESSERE E SALUTE

Un’ottica prospettica sul benessere degli individui, della comunità e del tessuto urbano
1 World Health Organization Global health observatory: urban population growth. http://www.who.int/gho/urban_health/situation_trends/urban_population_growth_ text/en/
2 Talukder S, Capon A, Nath D, Kolb A, Jahan S, Boufford J. Urban health in the post-2015 agenda. Lancet. 2015 Feb 28;385(9970):769. doi: 10.1016/S01406736(15)60428-7. PMID: 25752169.
3 Rydin Y., Bleahu A., Davies M et al. Shaping cities for health: complexity and the planning of urban environments in the 21st century. Lancet. 2012; 379: 2079-2108
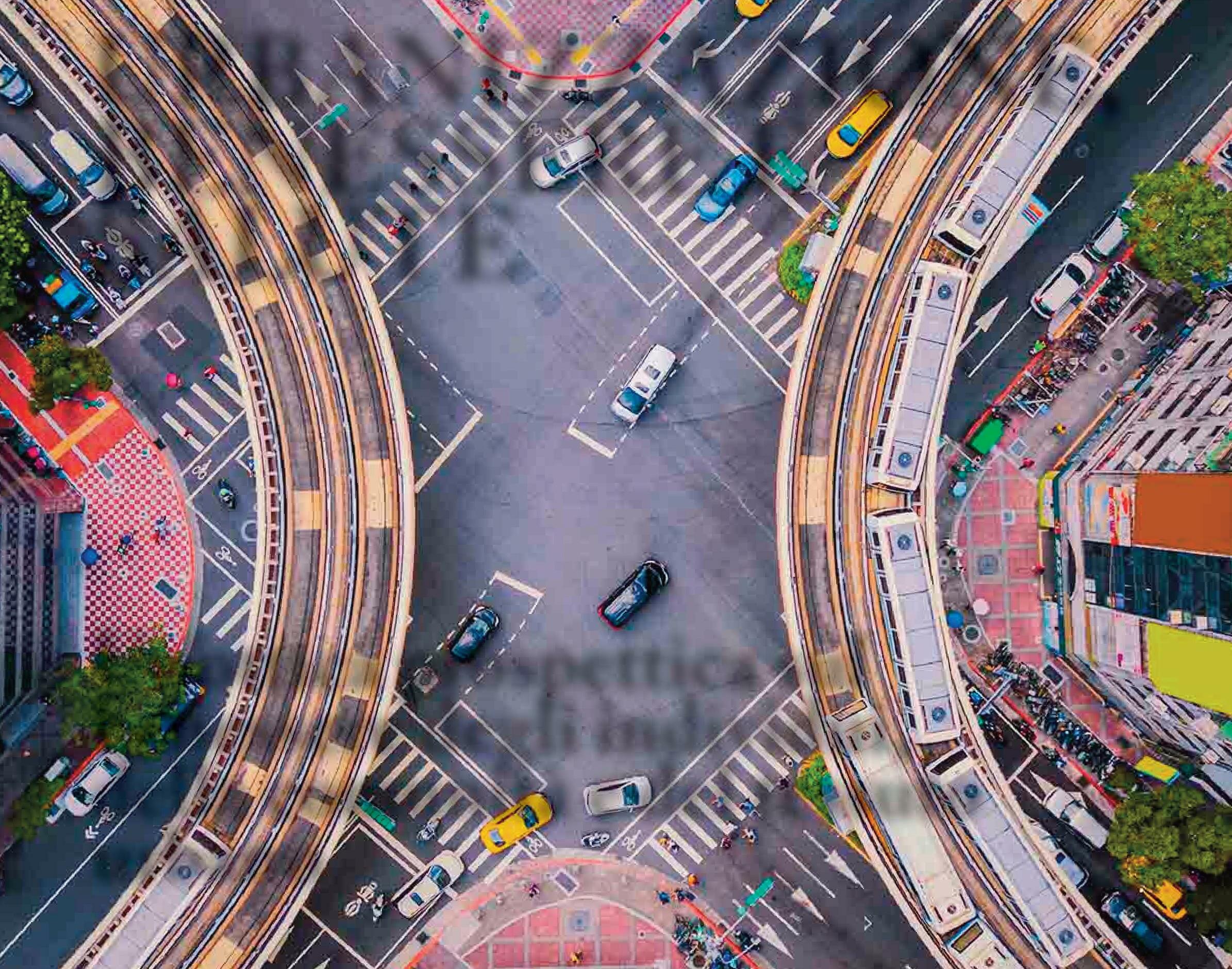
4 Dati ricavati considerando gli indicatori BES e in particolare i domini: salute; istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, sicurezza, paesaggio e patrimoni, ambiente e qualità dei servizi

70
di Lucio Corsaro e Gianluca Vaccaro BHAVE per Health City Institute, C14+ e URBES
Urbanizzazione, benessere e salute: una sfida globale
Si stima che entro il 2100 la popolazione mondiale sarà di 10 miliardi. 100 anni fa circa il 20% della popolazione mondiale era urbana; entro il 2010, più della metà della popolazione vivrà in aree urbane, una proporzione destinata a salire al 70% entro il 20501.
Sebbene il rafforzamento della sanità pubblica e il miglioramento dell’assistenza sanitaria e degli interventi di promozione della salute e prevenzione siano aspetti fondamentali per qualsiasi strategia di benessere diffuso della popolazione, gli interventi in altri settori e la strutturazione di una logica di sistema è essenziale per migliorare la salute globale e delle comunità. C’è infatti un urgente necessità di affrontare i bisogni fondamentali delle popolazioni urbane e, allo stesso tempo, di cambiare i determinanti sociali, economici e ambientali della salute nelle città attraverso lo sviluppo sostenibile. Questi cambiamenti richiedono integrazione, coordinamento e investimenti finanziari2.
Pianificazione dell’uso del suolo, sicurezza alimentare, creazione di posti di lavoro, infrastrutture di trasporto, conservazione della biodiversità e dell’acqua, fornitura di fonti di energia rinnovabile attraverso la gestione dei rifiuti e del riciclaggio, gestione dei disastri, fornitura di istruzione, servizi di assistenza sanitaria pubblica e alloggi in le aree urbane sono tutte questioni importanti che devono essere affrontate3
Portare il tema della salute e del benessere al centro di uno sviluppo urbano sostenibile è ormai una prospettiva condivisa a livello mondiale.
In questo contesto creare un quadro concettuale concreto che possa collegare i diversi determinanti di salute alla salute urbana e identificando dei possibili indicatori di outcome raccolti collegando le dimensioni della salute e del benessere degli individui, della comunità e del tessuto urbano è certamente una sfida di grande rilevanza scientifica e sociale. Seguendo quest’ottica di analisi il lavoro che si presenta in questo contesto si può considerare un prima passo in questa direzione.
Un’analisi prospettica sul benessere degli individui, della comunità e del tessuto urbano
Considerando l’obiettivo di identificare quelle città che hanno investito sul proprio territorio in un’ottica di medio e lungo termine in tema di Urbanizzazione, Benessere e Salute sulla base di un’analisi prospettica sul benessere degli individui, della comunità e del tessuto urbano facendo riferimento a dati puntuali, serie storiche4 e attività e interventi svolti sul territorio urbano nel 2020, sono state selezionate alcune città.
5 Curatolo, R., 1974,
3-4; Cipolla C. 1998 a cura di, Il ciclo metodologico della ricerca sociale. p. 1-633, Milano Franco Angeli; Bezzi C., Cannavò L., Palumbo M., 2010 Costruire e Usare Indicatori Nella Ricerca Sociale E Nella Valutazione. Milano Franco Angeli
L’obiettivo è stato quello di costruire degli indicatori compositi e degli indici di sintesi per rilevare quelle realtà che hanno investito sul proprio territorio in un’ottica di medio e lungo termine in tema, appunto, di Urbanizzazione, Benessere e Salute.
Cinque sono le condizioni che è necessario assicurare per la costruzione e definizione di questi strumenti di misurazione, elementi che è necessario considerare anche nella fase di interpretazione dei dati, in particolare:
1. È necessario rilevare che non tutte le città partono dalla stessa situazione strutturale e che gli interventi locali su alcune dimensioni macro-economiche o macro-sociologiche possono incidere solo marginalmente e/o seguendo orizzonti temporali molto ampi. I costrutti di sintesi devono quindi rilevare lo scarto (quindi il dinamismo) tra una situazione “iniziale” e una “successiva” più che fotografare delle situazioni statiche. Questo implica che è importare fare riferimento preferibilmente a dati in serie storiche.
2. Devono seguire una logica processuale e generativa specifica, circoscrivibile e contestuale sia sul piano spaziale che temporale privilegiando, inizialmente, una visione microfondativa dei fenomeni sociali collettivi provando semmai successivamente a supportare delle ipotesi di livello macro. Questo implica anche il superamento di una visione lineare e correlazionale dei possibili processi evolutivi che impattano sulle città.
3. È necessario che vengano considerati indicatori di natura diversa, statici e dinamici, strutturali e sovrastrutturali/relazionali, che rilevano dimensioni di percepito e che rilevano proprietà che hanno valenza intersoggettiva
4. E’ necessario, in considerazione degli obiettivi cognitivi di tipo prospettico, che venga privilegiata l’analisi dinamiche dei fenomeni
5. E’ preferibile che nella costruzione degli indici si segua un percorso “statistico” e uno “sociologico” anche in considerazioni del tipo di indicatore considerato e delle finalità di costrutto. Con questa distinzione5 intendiamo nel caso dell’approccio statistico un’elaborazione statistica di dati di base seguendo un’ ottica che in letteratura è vicina alla costruzione degli “indicatori sociali” quindi alla necessità di usare dati aggregati relativi ai fenomeni da porre sotto analisi con il fine di costruire indicatori descrittivi e comparativi della condizione sociale di speci-
6 Il presente lavoro di costruzione tiene conto delle discussioni sul tema della Commissione Istat per la misurazione del benessere e sul percorso di studio e sperimentazione delle sintesi che si è svolto a partire dalla fine dell’anno 2010, prendendo in particolare come riferimento il volume “Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and user guide” e discusso in diversi lavori di Mazziotta e Pareto (ad esempio Mazziotta, M., Pareto, A. (2013). A Non-compensatory Composite Index for Measuring Well-being over Time. Cogito. Multidisciplinary Research Journal, Vol. V, 4; Massoli, P., Mazziotta, M., Pareto, A., Rinaldelli, C. (2013). La misura del BES una spe- rimentazione per l'aggregazione degli indicatori dell'istruzione e della formazione. Primo Convegno Nazionale dell’AIQUAV, Luglio 2013; Massoli, P., Mazziotta, M., Pareto, A., Rinaldelli, C. (2013). Metodologie di sintesi speri- mentali per i domini del BES. XXXIV Conferenza Italiana di Scienze Regionali (AISRE), Agosto 2013.OECD (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and user guide. OECD Publications, Paris) 7 Un esempio in Marradi, Di Franco, 2013, Factor analysis and principal component analysis, Franco Angeli
71
Indicatori sociali e qualità della vita in Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica n
fici territori; per approccio sociologico intendiamo invece il processo di natura deduttiva dal concetto che si vuole rilevare scomposto in dimensioni e successivamente in indicatori e infine in indici di sintesi. Ovviamente i due percorsi oltre che essere meglio adattabili ai diversi tipi o contesti di riferimento degli indicatori (indicatori socioeconomici o strutturali dovrebbero essere sintetizzati sul piano statistico vs indicatori relazioni meglio composti secondo un approccio sociologico) implicano procedure diverse.
Per specificare meglio il punto 1- 2-3 è stato privilegiata la selezione di tre tipi di indicatori diversi:
• Indicatori strutturali (di tipo oggettivo, statici o dinamici) della popolazione che evidenziano situazione chiave di disuguaglianza, disparità, ecc e che registrino dinamiche macro-economiche o macro-sociali cui effetti certamente sono rilevabili all’interno del territorio regionale o provinciale ma che nel breve periodo (1-3 anni) possono solo relativamente essere modificati sulla base di interventi locali. Sono prevalentemente indicatori demografici e socioeconomici.
• Indicatori relazionali (di percepito o “fattuali”) in grado di rilevare dinamiche meso-sociologiche.
• Indicatori “soggettivi” in grado di registrare dinamiche micro-sociologiche o psicologiche del soggetto legate prevalentemente a dimensioni del percepito
Sul punto 4: l’ottica seguita è diacronica e dinamica sia nell’ipotesi di indicatori intrinsecamente dinamici cioè che valutano la variazione del fenomeno nel tempo o confrontano ad esempio due fasi temporali diversi, che in indicatori statici che però verranno usati in chiave dinamica confrontando serie storiche diverse.
Sul punto 5: come anticipato è necessario distinguere una costruzione statistica degli indici di sintesi da un processo di costruzione e combinazione teorica degli indicatori di tipo “sociologico”.
Il primo tipo di procedura verrà privilegiato nel trattare indicatori strutturali, il secondo nel trattare indicatori relazionali o soggettivi6
Nel caso invece delle procedure di costruzioni di indici da indicatori relazionali o soggettivi possono avvenire usando l’analisi fattoriale e affinando una sola dimensione su un paniere di variabili relative ad unità territoriali7
Per riassumere: I costrutti di sintesi devono registrare e rappresentare il dinamismo tra una situazione “iniziale” e una “successiva, devono seguire una logica processuale e generativa specifica che segua una logica multilivello micro-macrosociologico e usando degli schemi formali in grado di integrare indicatori diversi e produrre sulla base di una cornice causale delle ipotesi prospettiche.
Sul piano della formalizzazione matematica degli elementi appena descritti sembra opportuno fare riferimento ad uno schema di modellistica che sia in grado di supportare le ipotesi multilivello, di integrazione fra dati diversi, causali e prospettiche-predittive sulla base di algoritmi bayesiani preferibilmente all’interno di una rete bayesiana quindi considerando delle probabilità condizionate associabili alle variabili legate tra loro da una freccia causale come potrebbe
essere in un semplice modello causale ma con un motore inferenziale di tipo bayesiano.
Come previsto dal punto 2 la costruzione di una rete bayesiana avviene a livello ‘locale’, individuando le relazioni tra i nodi e stimando le probabilità corrispondenti: questo permette man mano che si utilizza la rete su nuove informazioni statistiche o demografiche di usare questi nuovi elementi ma aggiornando le stime delle probabilità iniziali questo all’interno di una cornice teorica e formale rigorosa.
Vediamo a questo punto nel dettaglio le città selezionate sulla base delle analisi affrontate.
Milano mostra valori positivi su diverse dimensioni in particolare: Salute; Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Benessere economico, Qualità dei servizi.
Sulla Salute l’indicatore di riferimento su cui Milano ha mostrato dei valori positivi è stata la riduzione del tasso di mortalità per incidenti stradali (tra i 15-34 anni e considerando le serie storiche dal 2006 al 2011). In tema di Istruzione e formazione e considerando in particolare il tasso di partecipazione alla scuola dell’infanzia (dal 2008 al 2013) notiamo un valore percentuale sempre più alto rispetto al valore medio nazionale. Sempre in termini di Istruzione e formazioni notiamo valori significativamente più bassi rispetto al valore nazionale sulla percentuale di giovani che non lavorano e non studiano, i Neet (ultimo anno disponibile 2011). Pensando al dominio Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Milano mostra tassi alti di occupazione (20-64 anni) significativamente maggiori rispetto al tasso medio nazionale. Come espressione del Benessere economico possiamo notare un reddito medio disponibile pro capite significativamente più alto del valore medio nazione e i valori dell’indice di qualità dell’abitazione che supera i valori nazionali (considerando il minor numero di abitazioni di bassa qualità rispetto al valore nazionale). Come aspetti della qualità dei servizi e in particolare l’indicatore sulla fruizione dei servizi comunali per l’infanzia” (serie storiche da 2006 a 2013) notiamo che Milano mostra sempre valori significativamente superiori alla media Italiana.
Anche Bologna mostra valori positivi su diverse dimensioni in particolare: Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Benessere economico, Paesaggi e patrimoni e Qualità dei servizi.
Facendo riferimento al dominio Istruzione e formazione notiamo valori bassi rispetto al valore nazionale sulla percentuale di giovani che non lavorano e non studiano (ultimo anno disponibile 2011). Per il dominio Lavoro e conciliazione dei tempi di vita Bologna mostra tassi alti di occupazione (20-64 anni) significativamente maggiori rispetto al tasso medio nazionale. Pensando al benessere economico possiamo notare un reddito medio disponibile pro capite significativamente più alto del valore medio nazione così come l’indice di qualità delle abitazioni superiore alla media nazionale.
Nel dominio Paesaggi e patrimoni troviamo a Bologna un’alta densità e rilevanza del patrimonio museale (considerando il numero di musei attivi su 100.000 abitanti) e per
72
quanto riguarda il dominio Ambiente troviamo una buona disponibilità di verde urbano (metri quadrati per abitante). Considerando infine il dominio della Qualità dei servizi Bologna ha un numero alto di bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l’infanzia (serie storiche da 2006 a 2013) rispetto al valore medio nazionale
Bari mostra valori positivi sulla Salute, sul Benessere economico e sulla Sicurezza. In particolare sulla Salute l’indicatore di riferimento su cui Bari ha mostrato dei valori positivi è la riduzione del tasso di mortalità per incidenti stradali (tra i 15-34 anni e considerando le serie storiche dal 2006 al 2011). Sul benessere economico l’indice di qualità delle abitazioni mostra valori superiori alla media nazionale. E sulla Sicurezza un valore inferiore alla media nazionale di furti in abitazione (su 100.000 abitanti).
Considerando Cosenza e Trieste sulla base degli indicatori dei domini del BES notiamo che Cosenza mostra valori positivi in particolare sulle dimensioni Istruzione e formazione (in particolare alti i valori di partecipazione alla scuola dell’infanzia) e sul tema della Sicurezza (minore numero di furti in abitazione). Cosenza inoltre è la protagonista del progetto di riqualificazione paesaggistica ed urbana “il parco del Benessere”.
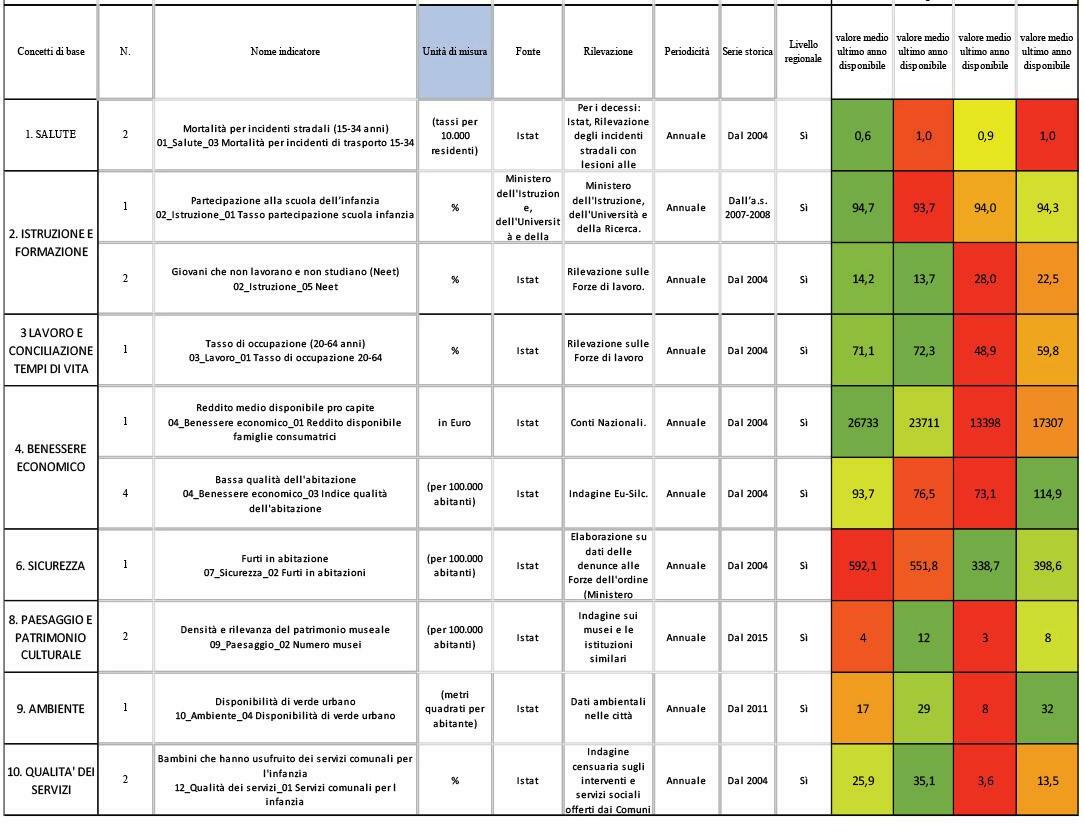
Trieste mostra valori positivi sul tema della Salute (ridotta mortalità per incidenti stradali rispetto ai valori nazionali), dell’Istruzione e formazione (alti i valori di partecipazione alla scuola dell’infanzia), della Sicurezza (minore numero di furti in abitazione), del Paesaggio e patrimonio culturale (alta densità e rilevanza del patrimonio museale) e dell’Ambiente (alta disponibilità di verde urbano). Trieste ha attivato dal 1998 il programma di promozione di benessere e coesione sociale “Habitat Microaree” con lo scopo di migliorare la qualità della vita degli abitanti di alcuni rioni “a rischio”.
Di seguito la classificazione sulla base dei dati del valore medio dell’ultimo anno disponibile sulla base dell’indicatore identificato.
73
BARI, UNA CITTÀ DEL EUROPA

 di Frederik Greenhouse
di Frederik Greenhouse
Il sindaco di bari e presidente dell’ANCI Antonio De Caro dice che il COVID 19 ha costretto tutti ad una riflessione più ampia circa le implicazioni che le nostre politiche di sviluppo possono generare, direttamente o indirettamente, sulla salute pubblica e sulle nostre città.
Per De Caro i sindaci esercitano il delicato ruolo di autorità sanitaria locale, pur non avendo alcuna competenza amministrativa in materia di gestione sanitaria. E sottolinea inoltre come la città di bari esprime da tempo un serio e manifesto impegno in materia ambientale e di salute pubblica questioni che saranno al centro dell’agenda delle politiche urbane nel prossimo decennio.
In una recente indagine i ricercatori dell’Health City Institute indicano in Bari, la citta’ metropolitana del sud ITALIA che ha piu’ investito in questi ultimi anni in tema di salute e benessere dei propri cittadini e il report ISTAT sull’occupazione 2020 indica in Bari la migliore città del sud ITALIA e nell’anno della pandemia l’occupazione a bari è al 53% un dato in controtendenza rispetto alla media nazionale.
La citta’ metropolitana di Bari con 1 milione e 230 mila abitanti e’ la quinta citta’ metropolitana d’Italia
Una città proiettata verso il futuro attraverso una serie di interventi che tentano a riappropriarsi del mare come elemento cruciale della strategia sulla città, non soltanto in termini di aumento della qualità della vita, ma soprattutto per promuovere una vera e propria cultura ed economia del mare, creando opportunità di lavoro, commerciali, sportive e turistiche.
La riqualificazione del lungomare con la realizzazione di un parco costiero destinato al tempo libero e la rigenerazione del quartiere Japigia che, con lo spostamento del fascio ferroviario e la creazione della tramvia del mare, e con il suo ridisegno, potrà finalmente affacciarsi al mare.
Il lungomare di bari, tra i più vasti di Europa con i suoi 16 km, attraversa la città fiancheggiando tutta la costa, è stato recuperato recentemente alla piena fruizione dei cittadini per la pratica di esercizio fisico e sport, è un punto di incontro importante per tanti sportivi e meta prediletta dei podisti cittadini, ben si presta alla pratica del cammino sia veloce che sotto forma di passeggiata quotidiana. una vera e propria
palestra a cielo aperto che sta trasformando la città di Bari in una sport city di stampo europeo.
Bari vuole essere la citta’ del benessere e della qualita’ di vita con una grande attenzione all’ambiente, anche attraverso l’incremento della la propria dotazione di verde urbano, che sarà ampliata con la realizzazione nei prossimi anni del parco Rossani, il parco Fibronit e il parco dell’ex gasometro per un totale di 12 ettari a verde. Nei prossimi 5 anni i 12 quartieri di bari si doteranno di 50 ettari di verde e di 100.000 nuovi alberi, riconoscendo nella qualità ambientale e nell’ecosostenibilità delle trasformazioni urbane i principali elementi di indirizzo per la costruzione dell’agenda urbana proiettata al 2030.
Ma è nei quartieri che si svolgerà la vera sfida per il futuro della città, valorizzando non solo il volto storico della città, ma anche quella delle periferie fatta di luoghi e comunità fortemente radicate.
Oggi Bari punta a realizzare una rete di presidi di prossimità in tutti i quartieri intesi come spazi che non solo erogano ma offrono servizi di prossimità destinati: all’educazione e civismo come ade esempio le 11 community library, allo sport e ambiente con la creazione di 14 playground, al sistema culturale e museale, all’innovazione sociale al welfare e economia solidale, alla conciliazione vita-lavoro, ai distretti urbani del commercio, al coinvolgimento delle strutture sanitarie e dei farmacisti, per creare un concetto diffuso di urban health.
Il tema dell’urban health e’ sempre stato uno dei punti di grande attenzione e sinergia dell’amministrazione comunale, con la regione, l’università e tutte le realtà sociali, sportive, imprenditoriali e culturali della città.
Miglioramenti strutturali e sociali ella città da realizzare anche sotto il profilo del decoro urbano, attraverso la creazione di luoghi di aggregazione sociale, dove salute, sport e corretti stili di vita siano il tema centrale dell’azione comune per dare impulso a uno sviluppo sostenibile della città e al benessere di cittadini.
74
SUD PROIETTATA IN








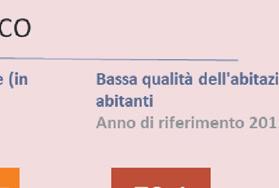
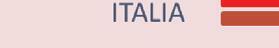

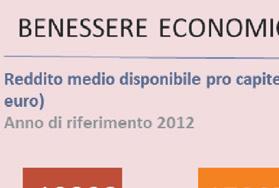







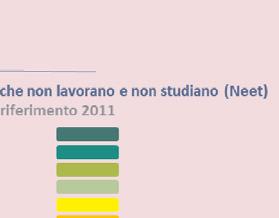

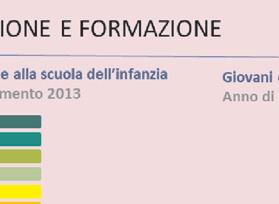






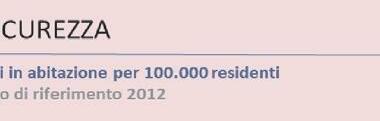








punt un è sempre Da metropolitanna a citta dell’omonima e Puglia regione della Cappoluogo a abbitannti 710 312. a a d italianno Comune a to mercanntile- tradizione a solida una Ha Oriente Medio il con culturali politico- contattti a dei e commercio del nell’ammbito nevralgico a h ti i i fi i i i f principali le tra annte, e L del Fiera va della sede è 1930 Dal Adriattico. marre a a del passeggeri scalo maggiore il è porto suo il imprenditoriale, d’Italia c s er oni z esppos s he
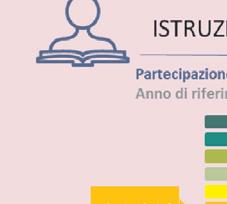


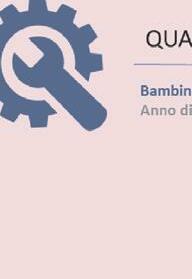







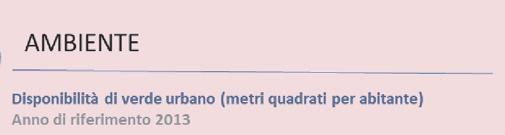
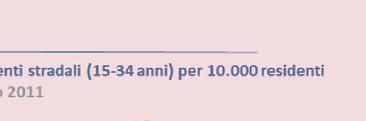
75
BOLOGNA, SIMBOLO DELLA
 di Frederik Greenhouse
di Frederik Greenhouse
Carlo Lucarelli dice che quella che chiamiamo Bologna, è un cosa grande, che va da parma fino a Cattolica … dove davvero la gente vive a Modena, lavora a Bologna e la sera va a ballare a Rimini … è una strana metropoli … che s’allarga a macchia d’olio tra il mare e gli Appennini.
Bologna la dotta, la grassa, la rossa e la turrita è soprattutto una città che affascina con la sua storia, i suoi colori e i suoi sapori.
…”la dotta”, per la sua antica università, “ALMA MATER STUDIORUM” fondata nell’anno 1088. prima università del mondo occidentale e prima sede deputata allo studio del diritto.
…”la grassa”, per le sua cucina che l’ha resa capitale del gusto e del buon cibo
…”la rossa”, per le mura, le case medievali, i portici e i tetti in cotto che colorano di rosso la città.
…”la turrita”, per le oltre cento torri testimoni del suo illustre passato medioevale che svettavano in cielo come antichi grattacieli di una antica urbes.
Bologna è anche la capitale italiana del benessere e simbolo della buona qualità di vita cittadina. Nella classifica LAB24 pubblicata dal SOLE 24 ORE bologna negli ultimi trent’anni ha scalato la classifica delle provincie con migliore qualità di vita passando dal ventitreesimo posto al primo posto.
Un successo costruito soprattutto sugli indicatori relativi alla ricchezza e consumi dove è prima, all’ambiente e servizi dove è seconda, alla cultura e tempo libero e agli affari e lavoro dove è rispettivamente terza e quarta.
Secondo i ricercatori dell’Health City Institute, Bologna è anche una città è anche la città della salute e del benessere , con uno sviluppo di importanti progettualità per il prossimo decennio. una città che vuole fare della salute il suo carattere distintivo, una città con una lunga tradizione di investimento nella promozione della salute.
Negli anni scorsi con l’accordo siglato tra comune, azienda sanitaria, azienda ospedaliera, università e ufficio scolastico regionale, si è istaurata una nuova stagione di sinergie istituzionali per migliorare la qualità di vita dei cittadini e creare un osservatorio per studiare attentamente i determinati della salute in ambito urbano.
Sinergie istituzionali sviluppate anche insieme ai tanti cittadini impegnati nelle associazioni per portare a sistema le tantissime iniziative che animano la città.
Datti una mossa! ad esempio è la campagna dell’azienda USL di Bologna realizzata in collaborazione con il comune e con le associazioni di volontariato per promuovere i corretti stili di vita: attività fisica, alimentazione sana, niente fumo, poco alcol.
Il sindaco di Bologna Virginio Merola e l’assessore al welfare Giuliano Barigazzi si dicono convinti che il benessere di una comunità si debba costruire attraverso la condivisione e il lavoro comune per far divenire la salute il termine di riferimento di tutte le politiche.
Bologna è una città in continua evoluzione socio-demografica. Con poco più di un milione di abitanti è l’ottava città metropolitana italiana, ma ogni 5 anni bologna compie una grande e silenziosa mutazione: cambia di circa il 20% la popolazione.
Una città dove le famiglie composte da una sola persona sono 91.400 ( 47,2% del totale), quelle di due componenti 54.900 ( il 28,3% del totale) e dentro queste famiglie cresce il numero dei giovani e degli anziani. le differenze di reddito sono fortissime: aumentano i bisogni dei più longevi, quasi centomila anziani, di cui oltre 35.000 di età superiore a 79 anni.
La qualità dei servizi sociali ha dunque estremo bisogno di un’energica innovazione. prima di tutto le risorse con 50 milioni di euro l’anno investiti nel welfare e nella salute dei cittadini.
Oggi l’università di Bologna assieme al comune, all’Health City Institute e ad altri importanti gruppi di ricerca si candida come punto di riferimento internazionale nella ricerca dei determinanti della salute in ambito urbano e ne e’ esempio il progetto di ricerca ENLIGHTENME che nasce da una collaborazione di 22 partner internazionali provenienti da 10 diversi paesi. per studiare l’effetto che l’illuminazione urbana potrebbe avere sulla salute e il benessere dei cittadini.
Un progetto finanziato nell’ambito del programma di ricerca e innovazione dell’unione europea HORIZON 2020, che beneficerà di più di 5 milioni di euro e si svilupperà nell’arco dei prossimi 4 anni. ENLIGHTENME sarà coordinato dall’ALMA MATER STUDIORUM – università di Bologna e insieme ad altri 5 progetti è parte del cluster dell’unione europea riguardante il tema della “salute urbana” e vedrà impegnata bologna con le città di Tartu e Amsterdam nella creazione di un “laboratorio di illuminazione urbana”
76
BUONA QUALITÀ CITTADINA





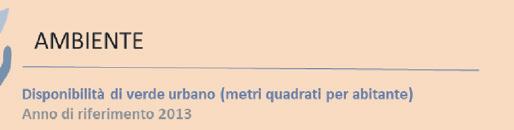



m dell’E Cappoluogo a abbitannti 533 394. a a italianno Comune a ilia


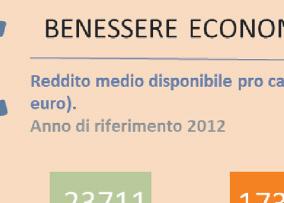









di di gastronomica tradizione la atta le è cui a occidentale ga mondo del università anntica più della Sede a abbitannti di milione un a a circa di metropolitanna citta a dell’omonima e Romagna d’Italia estesi più i tra è che storico centro dal e portici lunghi suoi dai torri, sue dalle Carrattterizzatta a a a Medioevo) dal (sin internazionale faamma di Bologna fa d oo oe d i ti i i fi i ti ti f più dei uno di che oltre politiche, e economiche culturali, istituzioni prestigiose di sede e Italia nord del feerroviarrie f a e stradali comunicazioni di nodo Importannte a uropa d’E e er r ar avannzat ava a qua c s r

















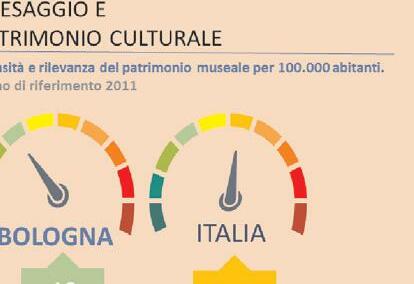
















77
MILANO: COM’È
Vieni vieni in città che stai a fare in campagna se tu vuoi farti una vita devi venire in città. Com’è bella la città com’è grande la città com’è viva la città com’è allegra la città. Piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce con tanta gente che lavora con tanta gente che produce. Con le reclames sempre più grandi coi magazzini le scale mobili coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più.
“Com’è bella la città” è una canzone scritta da Giorgio Gaber, una ballata che inneggia sarcasticamente al modello di sviluppo frenetico delle città.
Il fenomeno dell’inurbamento, susseguente al miracolo economico italiano iniziato negli ‘50, aveva stravolto in maniera consistente i costumi e le abitudini di vita degli italiani. grandi flussi di emigranti si erano riversati sulle grandi città principalmente del nord alla ricerca di una vita migliore, attirati principalmente dal modello consumistico. Milano era il polo di attrazione e di speranza per molti.
Gaber voleva richiamare l’attenzione proprio su questo aspetto e sui risvolti negativi di tale corsa sfrenata verso modelli di vita che presentano numerose insidie.
Oggi il tema della frenetica corsa all’urbanizzazione riguarda soprattutto i temi della salute.
Milano con la sua naturale vocazione internazionale si pone al centro di uno sviluppo urbanistico importante per dimensioni e soluzioni che mirano a un progressivo miglioramento della qualità di vita e della salute dei propri cittadini.

L’attenzione alla sana alimentazione e allo sviluppo globale del pianeta è stato il tema centrale di Expo 2015 ospitata da Milano e in tale contesto che l’Urban Health trova una sua precisa collocazione culturale, sociale, scientifica e politica.
Milano con progetti mirati alla sana alimentazione scolastica, all’ambiente e alla mobilità sostenibile si pone come modello di studio e benchmarking internazionale sul tema della salute e del benessere cittadino.
Milano non è solo la città e il suo centro commerciale e storico, ma è anche Milano metropolitana con un sistema territoriale integrato, alimentato da una fitta rete di relazioni materiali e immateriali, che stabiliscono stretti nessi di interdipendenza e complementarietà tra i contesti urbani e territoriali che la compongono.
Come espresso dalla relazione sul piano governo del territorio “Milano 2030: visione, costruzione, strategie, spazi”, la Milano del futuro vuole essere una città internazionale e leader in Italia, al centro della pianura padana e dell’area metropolitana milanese, ma anche quella più umana e di
quartiere, in cui le grandi trasformazioni hanno senso se accompagnate alla cura degli spazi di prossimità.
Una città connessa, metropolitana e globale. Una città di opportunità, attrattiva e inclusiva. Una città green, vivibile e resiliente. una città, 88 quartieri da chiamare per nome. Una città che si rigenera. La città dei 15 minuti, dove ogni quartiere deve essere integrato in un sistema di mobilità che rispetti l’ambiente e rappresenti una concreta ed efficiente risposta alle necessità di spostamenti per persone di tutte le età e di tutte le collocazioni sociali.

Una città dove far coincidere le più importanti occasioni di rigenerazione con l’attrazione di grandi funzioni di rilievo metropolitano, pubbliche e private per attività legate a università, ricerca e innovazione, sport, cultura e salute.
Il Professor Stefano Capolongo del Politecnico di Milano fa notare come lo stato di salute della popolazione residente viene, infatti, da sempre, direttamente e indirettamente influenzato dalle caratteristiche delle città stesse. Le scelte politiche, urbanistiche, distributive o sociali prese a scala ambientale e urbana possono, infatti, condizionare, positivamente o negativamente la salute degli abitanti e rendere le città obesiogene.
Una risposta è arrivata dalla Carta sull’Urban Obesity promossa dal Professor Michele Carruba e dal Professor Enzo Nisoli dell’Università degli Studi di Milano e adottata dall’European Association for the study of Obesity come documento guida nel contrasto a livello europeo dell’obesità nelle città.
Appare importante sottolineare che in una recente indagine sui cittadini dell’area metropolitana di Milano promossa dai ricercatori dell’Health City Institute, la salute è considerata la priorità per gli intervistati prima di temi importanti come il lavoro e la sicurezza.
Altrettanto importante è la relazione tra inquinamento ambientale e diabete nell’area metropolitana di Milano, come dimostrato da uno studio recentemente pubblicato su Diabetes Research and Clinical Practice dal Professor Edoardo Croci dell’Università Bocconi e dal Professor Miche Carruba dell’Università Statale di Milano.
Renzo Piano ci ricorda come “un architetto e un sindaco hanno molte cose in comune: innanzitutto la città. L’architetto ne pensa gli spazi, ma è il sindaco che li riempie”. Oggi a Milano questi spazi si stanno riempiendo.
78
BELLA LA CITTÀ


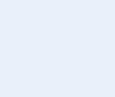
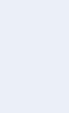
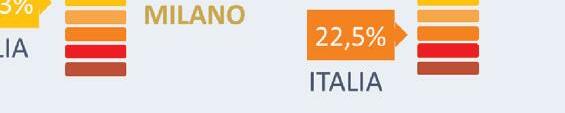

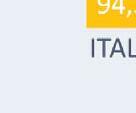

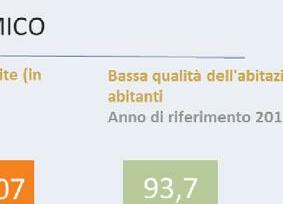







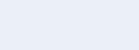

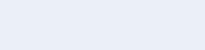
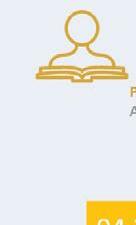


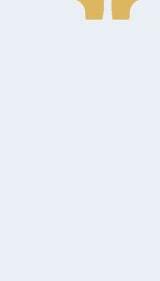
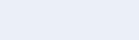


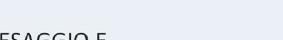

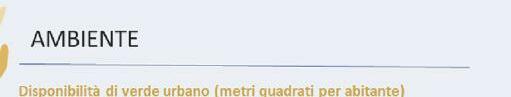






d italianno Comune a di popolose più delle una di centro e popolazione per Italia in comune secondo il è metropolitanna, a città dell’omonima e arrdia om L ba regione della Cappoluogo a abbitannti 818 398. 1. a a moda della mondiali cappitali delle Una a industriale disegno del e europei fiieristici f poli principali i ra T uropa d’E metropolitanne arree a a Scala alla Teattro a del lirica musica della e operisttica tradizione s lunga la per mondiale livello a Riiconosciuta R



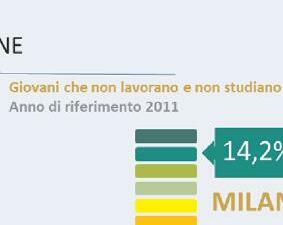










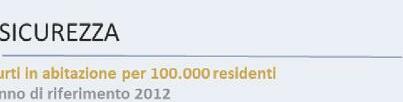




79
di Frederik Greenhouse
COSENZA, I TESORI DI UNA CITTÀ A
Il ponte che si staglia in altezza quasi a toccare le nuvole, unendo le due sponde del fiume Crati, il corso d’acqua che a breve sarà reso navigabile nel tratto compreso tra l’infrastruttura progettata dall’architetto Calatrava e la confluenza dei fiumi, dove si narra possa essere sepolto il re Alarico insieme al tesoro.

Leggenda e modernità s’incontrano a Cosenza, puntando dritte verso il medesimo obiettivo, che è la rinascita della città, immaginata una città sostenibile, in salute, felice. Oggi Cosenza ha scalato moltissime posizioni nelle classifiche nazionali sulla vivibilità, è meta consigliata da molte riviste europee, s’impone come un modello di sviluppo e rigenerazione urbana. Ripercorriamo questo cammino…
Tra i progetti realizzati, i BoCS-Art, “the box of contemporary spaces”, con cui Cosenza ha dato forma e sostanza all’idea di città culturale: una Cosenza creativa, con la sua rete museale all’aperto, unica nel suo genere a livello internazionale. I BoCS sono, infatti, costruzioni realizzate con materiale ecosostenibile, il legno lamellare, e alimentate da energia rinnovabile. Opere di architettura contemporanea realizzate sul lungofiume Dante Alighieri a sud di Cosenza, in un contesto paesaggistico inserito nel centro storico, abitate da artisti italiani e stranieri che vi si alternano nel corso delle residenze, non solo creandovi le loro opere, ma intessendo soprattutto preziosi rapporti umani, sociali e professionali. “Un luogo d’avanguardia crocevia di scambio, confronto e in special modo fucina di idee di tutti quei talenti che, passando da qui, lasciano il segno attraverso il patrimonio artistico che producono”, ha dichiarato al riguardo il Sindaco Mario Occhiuto che vede nell’innovazione creativa una fonte di sviluppo e innovazione territoriali. L’idea è creare un luogo trendy che riesca a innescare processi virtuosi di recupero del centro storico, i cui edifici privati sono in stato di abbandono da più di cinquant’anni: innovazione e contaminazione culturale si traducono in crescita economica, sviluppo sociale e maggiore consapevolezza civica.
“In un Paese in cui diventa sempre più difficile realizzare opere pubbliche di qualità e soprattutto completare i lavori in tempi brevi, c’è un Sud che cresce e che in Italia diventa simbolo del buon governo delle città”, ha esordito il Mario Occhiuto alla cerimonia d’inaugurazione del Ponte di Calatrava, avvenuta alla presenza dello stesso architetto Santiago Calatrava, il quale ha progettato l’opera poi realizzata dall’impresa Cimolai. Il Ponte di Calatrava di Cosenza imponente, bellissimo, oltre a rappresentare un presidio culturale in sé, contribuisce a
completare il disegno di rigenerazione urbana che va a recuperare “pezzi” di città periferici e dunque prima scollegati dal centro, per lungo tempo relegati ai margini di un capoluogo, integrati adesso attraverso una riqualificazione fisica, sostenibile dal punto di vista ambientale, ma che vuole assumere anche una valenza sociale.
Un ponte che collega una sponda all’altra del fiume, la periferia al centro urbano, un ponte che si attraversa per andare incontro al futuro, con corsie dedicate a pedoni e piste ciclabili. Un segno architettonico che sa di speranza e che Cosenza ha inteso dedicare ai giovani, generazioni aperte a un futuro e a un territorio che talvolta può essere anche difficile.
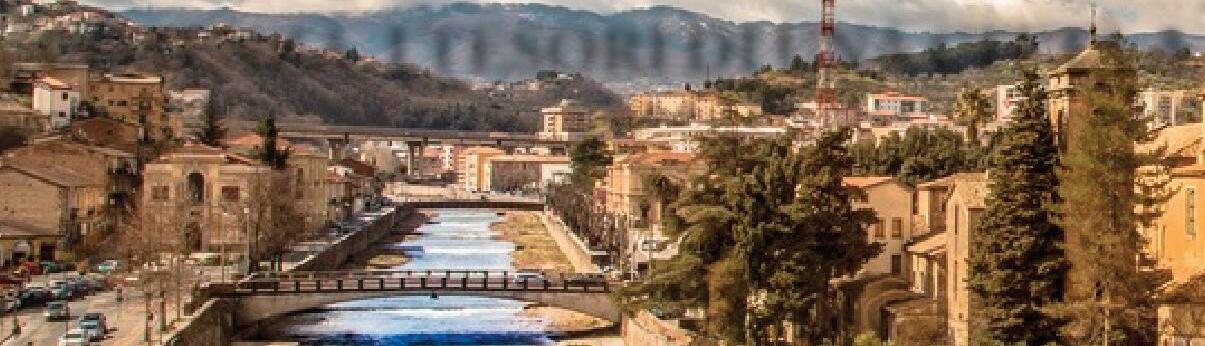
Non a caso i primi visitatori sono stati gli alunni delle scuole primarie, con il naso all’insù, con i quali il Sindaco Occhiuto si è intrattenuto spiegando loro com’è stata realizzata l’opera e il significato che racchiude. “Gli stralli del ponte ricordano le corde di un’arpa e le note ne accompagneranno l’arrivo e la permanenza delle persone”, commenta il Sindaco. “Sull’idea dello spazio privato si afferma il principio dello spazio pubblico che forma una nuova comunità. Fondata sulla bellezza e sulla bontà. La bellezza non è per pochi eletti ma è per tutti: ritorna e si afferma una nuova era di democrazia urbana”. E così il ponte di Calatrava è stato consegnato alla vita e alla vivibilità di tutti, così come alla cittadinanza è stato restituito l’Osservatorio astronomico di Cosenza, secondo in Italia dopo il Planetario di Milano, intorno al quale è sorta una piazza-teatro e il Parco della Scienza.
Sul piano della mobilità urbana, la strategia complessiva prevede numerosi progetti al servizio dei Cittadini, non solo dal punto di vista del miglioramento del sistema di trasporto in sé bensì della rete urbana di mobilità che sarà ripensata in funzione di piste ciclopedonali, corsie dedicate a pedoni e ciclisti, mobilità dolce e sostenibile. Attiva una linea di Circolare Bianca che collegherà gli ospedali e le cliniche, incentivata dall’intermodalità consentita da parcheggi scambiatori e pullman elettrici. L’opera che rivoluzionerà la mobilità urbana e che inaugurerà in Calabria una moderna stagione per il futuro assetto del territorio urbano ed extraurbano sarà la Metrotranvia, , “per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile attraverso opere strategiche e il collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e l’Università della Calabria”. La metropolitana sarà collocata in un grande parco verde, un intervento anche di cucitura tra la parte centrale della città e via Popilia che interra alcuni tratti per un impatto zero sull’ambiente. L’’intervento colloca la Metro-
80
MISURA DI SALUTE E BENESSERE

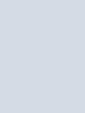


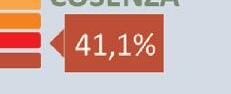


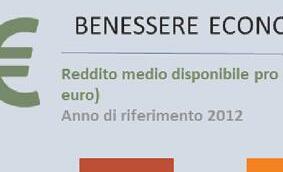
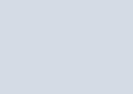



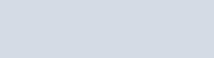


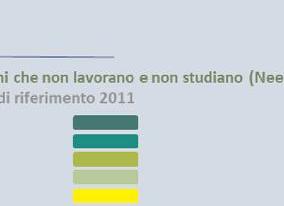
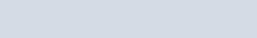




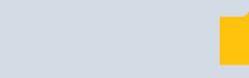



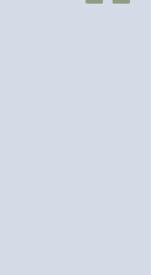
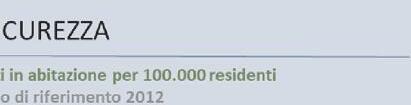

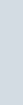

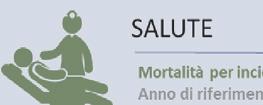
politana nell’asse della città e per questo, tra le altre cose, è stata inserita l’opera aggiuntiva di un’ovovia che, a Cosenza, collegherà fino al Castello svevo, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’uso delle automobili nelle città e di incentivare, dall’altro lato, la mobilità elettrica con forme di sostegno all’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica. Infine, ma non ultimo, la realizzazione di quasi trenta chilometri di Ciclopolitana, a complemento del nuovo progetto per La città dello Sport, che porrà l’attività fisica e lo sport, a partire dalle giovani generazioni e per tutti i livelli di abilità, come focus per l’innalzamento del livello di salute e benessere dei Cittadini cosentini.




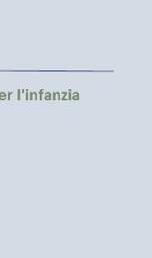
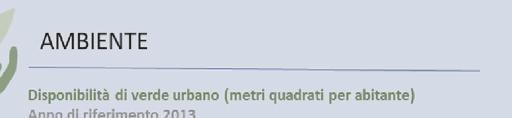



La Metropolitana leggera di superficie attraverserà il Parco del Benessere, il più grande parco verde del meridione, un grosso polmone longitudinale, lungo oltre tre chilometri, che sarà destinato ai bambini, alle famiglie, agli anziani, agli sportivi, a tutti, con un palmeto, il giardino degli agrumi, il giardino dei profumi.

Il sindaco Mario Occhiuto è convinto che le politiche urbane debbano avere come priorità la qualità della vita e il benessere dei cittadini: “Il paradosso – ha affermato il primo cittadino – è che abitavamo in case molto meno confortevoli ma circondate tuttavia da elementi meno inquinanti perché nell’antichità, quando non esistevano i vetri alle finestre, le città venivano costruite considerando la direzione dei venti, la posizione del sole, i criteri di sostenibilità legati alla natura. Dobbiamo pertanto tenere in conto quel filo spazio-temporale che lega la città antica e le buone pratiche di un tempo alla città contemporanea, in quanto si tratta di processi positivi”.
Cosenza è una città piena di energia, partecipe ed efficiente, una città d’ispirazione per la Calabria e il Meridione d’Italia. Merito di una forza attrattiva che, su più livelli, registra un cambiamento migliorativo improntato a dare maggiori opportunità, in special modo ai giovani, facendoli sentire cittadini del mondo. “Cosenza bellissima” non un semplice slogan, ma la consapevolezza di aver intrapreso un percorso moderno in grado di generare opportunità di sviluppo. provincia di cappoluogo a il è Calabbria, in a provinc dell’omonima Cappoluogo a abbitannti 197 65. a a di italianno Comune a e sttumi c leggende, os tradizioni, di ricca città una è culturale, tradizione suua alla s rifeerimento in Calabbria a f della Atene come Nota regione della nord a più il sede ha dove Rende di comune il comprende che anno ur agglomeratto a ba un di fuulcro f è moderna città a L dall’anntichità a fiin foolclore f f Calabbria a dell’Univers cammpus a ità
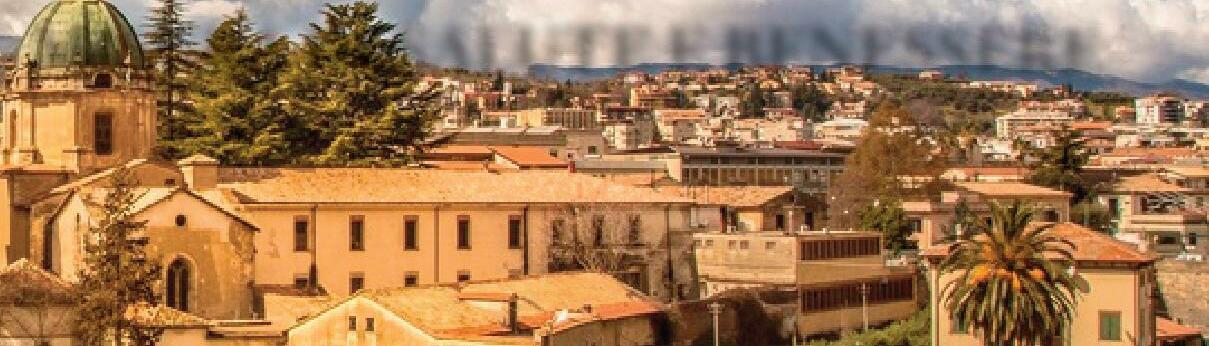
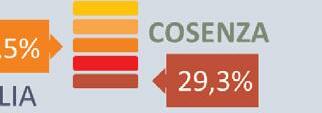



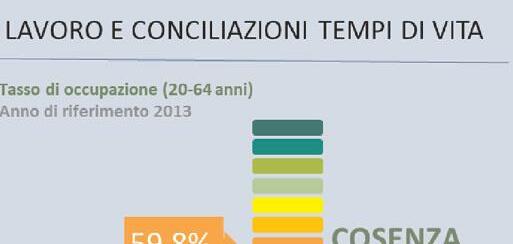











81
«La mia diletta città potrebbe benissimo fare a meno di me, ma sono io che non posso fare a meno di essa. Essa che mi scorre nelle vene e che amo.»
Bernardino Telesio, filosofo, nato a Cosenza nel 1508
Trieste è la Città della Scienza. Due università, un parco scientifico e tecnologico, più di trenta istituti di ricerca, un’altissima percentuale di ricercatori, tra le più alte al mondo: oltre 35 ogni 1.000 occupati contro una media europea di poco meno di 6. Grazie anche alla posizione strategica, al centro dell’Euroregione e città di frontiera tra vecchia e nuova Europa, Trieste punta a diventare un polo di eccellenza globale, in un rapporto sempre più stretto con le imprese. La Città di Trieste ospita “Next”, un osservatorio in cui trovano visibilità ricerca applicata e nuove tecnologie, un laboratorio di idee concrete e soluzioni pratiche per accrescere il benessere delle comunità e la competitività delle aziende. Sin dal 2012, Trieste Next è una “vetrina dell’innovazione” e della ricerca applicata tramite il quale i ricercatori e gli imprenditori presentano le proprie esperienze e raccontano come, grazie al trasferimento tecnologico della ricerca più avanzata, possano nascere nuove soluzioni. In virtù di questa esperienza e della tradizione scientifica che contraddistingue la Città, la decima edizione del Festival della Ricerca Scientifica si è svolto proprio a Trieste, dal 24 al 26 settembre 2021, con il titolo “TAKE CARE. La scienza per il benessere sostenibile”.
L’attenzione della Città per il benessere e l’inclusione sociale ha radici anche in un altro progetto: Habitat Microaree, un programma che prende avvio alla fine del 1998 da un’intesa tra Comune, Azienda Sanitaria, Ater, con lo scopo di migliorare la qualità della vita degli abitanti di alcuni rioni cosiddetti “a rischio”, caratterizzati dalla rilevante presenza di caseggiati ATER, nei quali si registrava una forte concentrazione di disagio sociale e deprivazione. Dieci microaree hanno così sperimentato un complesso di azioni mirate a una migliore efficacia e integrazione tra sanitario, sociale, politiche del lavoro e della casa; un welfare di comunità che ha coinvolto dieci realtà tra i 900 e i 2.500 residenti sul territorio triestino. Dopo una rigorosa mappatura della situazione, con la partecipazione attiva della cittadinanza e del settore no profit operante sul territorio (associazionismo, volontariato, cooperazione sociale), si è puntato a costruire un sistema di tutele e diritti a misura di cittadino. Le principali direttrici sono state: la tutela della salute e prevenzione del disagio sociale; lo sviluppo di comunità attraverso lo stimolo di forme di partecipazione attiva, socializzazione, associazionismo fra gli abitanti per favorire comunicazione, solidarietà e aiuto reciproco; il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni abitative; cura e assistenza preventiva ai soggetti più fragili.
Trieste, città dalla cultura cosmopolita, guarda oggi al futuro ponendosi obiettivi di lungo periodo, con la capacità di sfruttare il potenziale di conoscenza e la concentrazione di innovazione che ospita per creare un ambiente inclusivo, attrattivo, europeo.


82
“TAKE CARE. La scienza per il benessere sostenibile” TRIESTE “CITTÀ DELLA SCIENZA” PUNTO D’INCONTRO TRA RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
Trieste:
e popoloso più comune è Giulia, VeeneziaFriuli-V sppecia stattuto a italianna a a s region della Cappoluogo a abbitannti 435 199. a a di italianno Comune a d l i fi f posizione sua alla grazie centro-meridionale, quella e occidentale uropa l’E tra ponte un secoli da Rapppresenta a regione, della popolatto densammente a a pp p uropa E sud nel importannti più a i tra è rieste T di porto Il slavvi e mitteleuropei a mediterrannei, carrattteri a a a mescolanndo ca, geogra a






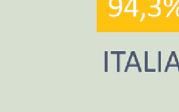
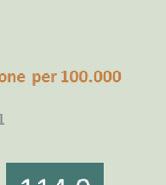

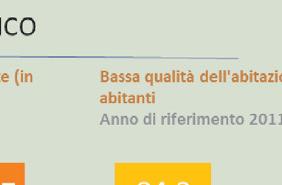
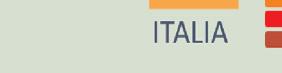

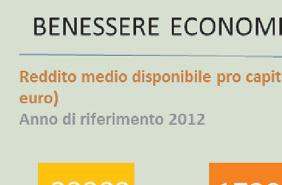


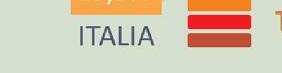


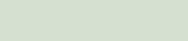

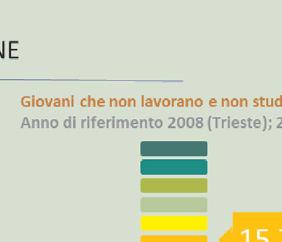
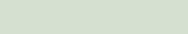



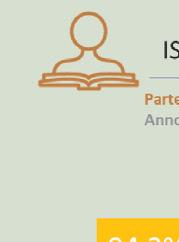














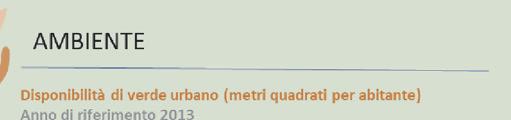

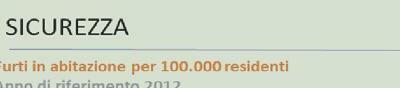

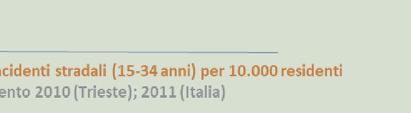
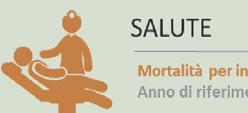




83
Appignano del Tronto

“Immerso in una distesa di verdi ulivi e segnato da scenografici, ossuti, riarsi calanchi (badlands), in una compatta lingua di sabbie e conglomerati di disfacimento alla base di Monte dell’Ascensione e di Colle Celestrino del Quaternario inferiore, delimitato dal torrente Chifenti e dal fosso San Giovanni sorge il medievale borgo di Appignano cui, per decreto regio del 13 marzo 1879, fu aggiunta la denominazione ‘del Tronto’”, si legge nella descrizione del sito web del Comune di Appignano del Tronto.
Ai nuovi appignanesi è dedicata una pagina di auguri perché “Quando nasce un bambino nasce un paese nuovo, e questa sezione è dedicata a loro, ai bambini appena nati che hanno la forza straordinaria dei fragili germogli di segnare un nuovo inizio per ciascuno di noi e per l’intera comunità.”
Appignano del Tronto è un comune italiano di 1.712 abitanti della provincia di Ascoli Piceno nelle Marche e fa parte della Comunità Montana del Tronto
Il Comune aderisce al progetto RURITAGE, tramite cui sperimenta buone pratiche e soluzioni innovative basate sul patrimonio culturale. Pellegrinaggi, produzione locale sostenibile del cibo, migranti, arti e festival, resilienza e gestione integrata del paesaggio sono le sei strade da percorrere per trasformare le aree rurali in laboratori/dimostratori di sviluppo sostenibile, parola di RURITAGE. Il progetto europeo Horizon2020, coordinato dall’Università di Bologna, nasce per promuovere il patrimonio culturale e naturale locale, quale catalizzatore di sviluppo sostenibile.
A seguito della sequenza sismica del 2016-2017, che ha interessato la Regione Marche, il Comune ha avuto ampie conseguenze, con quasi la metà delle case nel cuore storico di Appignano del Tronto demolite. Il Rural Heritage Hub sarà situato in un edificio appartenente al centro storico, nella parte nord-ovest della città. Si trattava di una scuola materna, parzialmente ristrutturata e successivamente trasformata in auditorium. È un simbolo di resilienza, un luogo dove porre le basi per ripartire, anche dopo un disastro.

MOTIVAZIONE DEL PREMIO: PER RAPPRESENTARE UNA COMUNITÀ RURALE RESILIENTE CHE HA DIMOSTRATO DI AVER PERSEGUITO, CON SUCCESSO, UNA RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO BASATA SUL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE
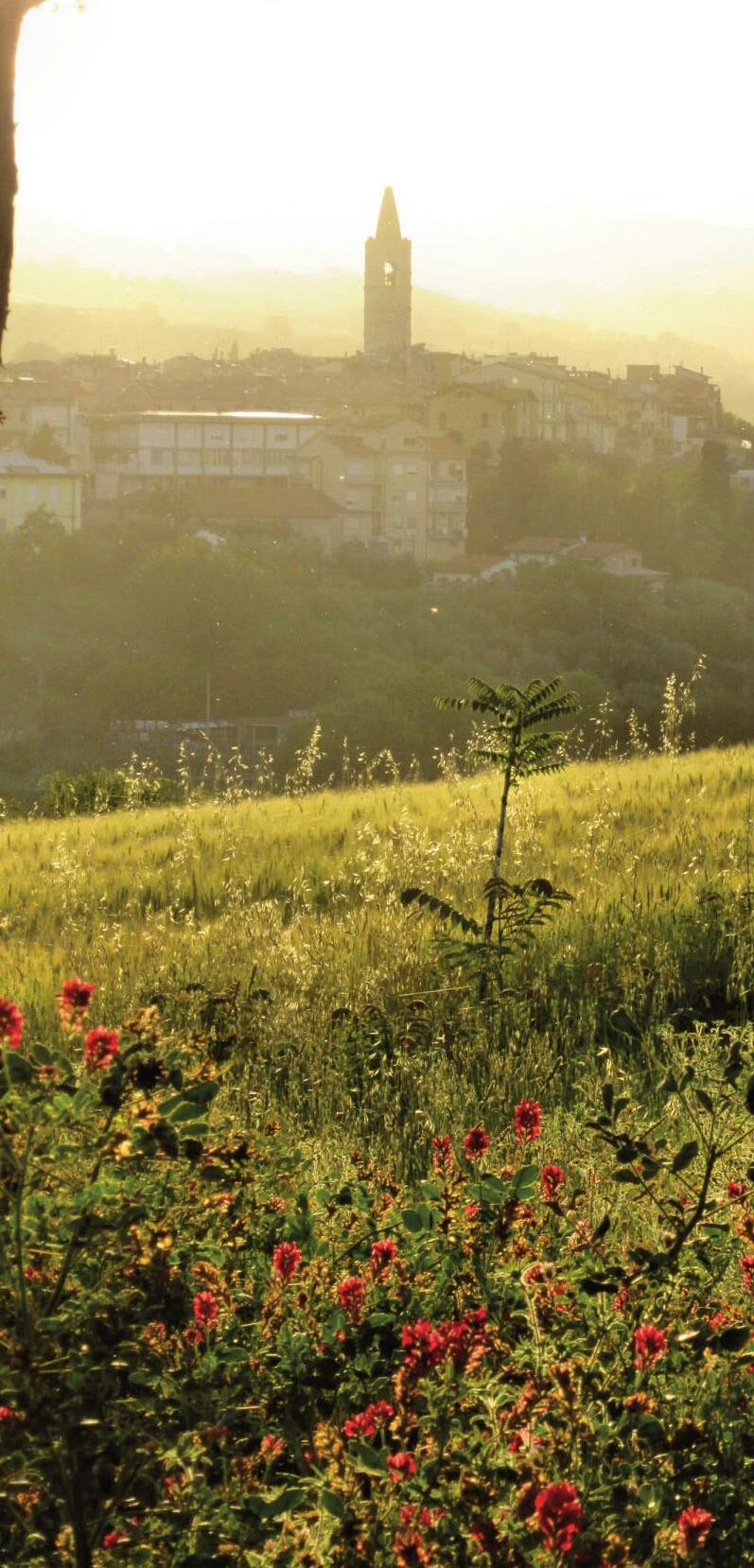
84


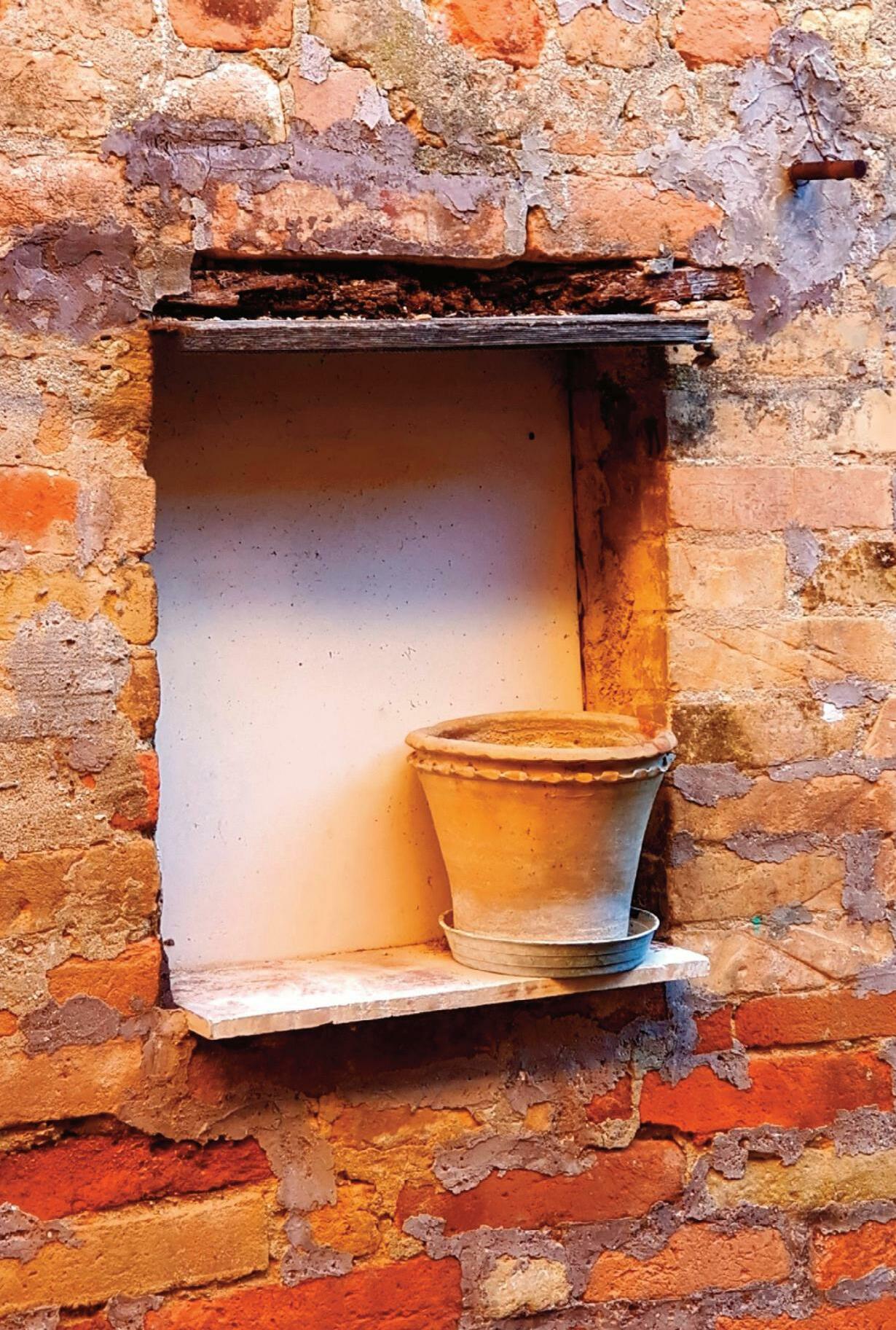
Capizzi

“L’origine di questa città fu sempre ignota, e va smarrita nella notte dei secoli “: così inizia il Cap. II° della “Monografia della Città di Capizzi - Antica e moderna in Sicilia” relativo ai “Cenni sulla fondazione e vicende su Capizzi” di Nicolò Russo, insigne letterato capitino, del 1847, si legge nella descrizione del sito web del Comune di Capizzi “L’Aurea Città” situata nella Città Metropolitana di Messina che conta 2860 abitanti.
Capizzi ha partecipato al programma URBACT III, il programma europeo coordinato per l’Italia da ANCI che vede le città italiane tra le principali partecipanti. Nelle diverse edizioni del programma decine di città hanno preso parte alle attività di scambio promosse dal programma URBACT, grazie alla quali sono stati promossi piani locali di promozione di uno sviluppo urbano sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale.
Aderendo alla Rete di Trasferimento Capizzi ha inteso assimilare, adattare e testare la buona pratica “Volunteering Cities Network” guidata dal comune cipriota Athienou che ha visto far fronte ai bisogni essenziali delle fasce più disagiate della popolazione tramite il volontariato, permettendo così l’incontro tra diverse generazioni e garantendo un aiuto concreto e diretto per molti di essi.
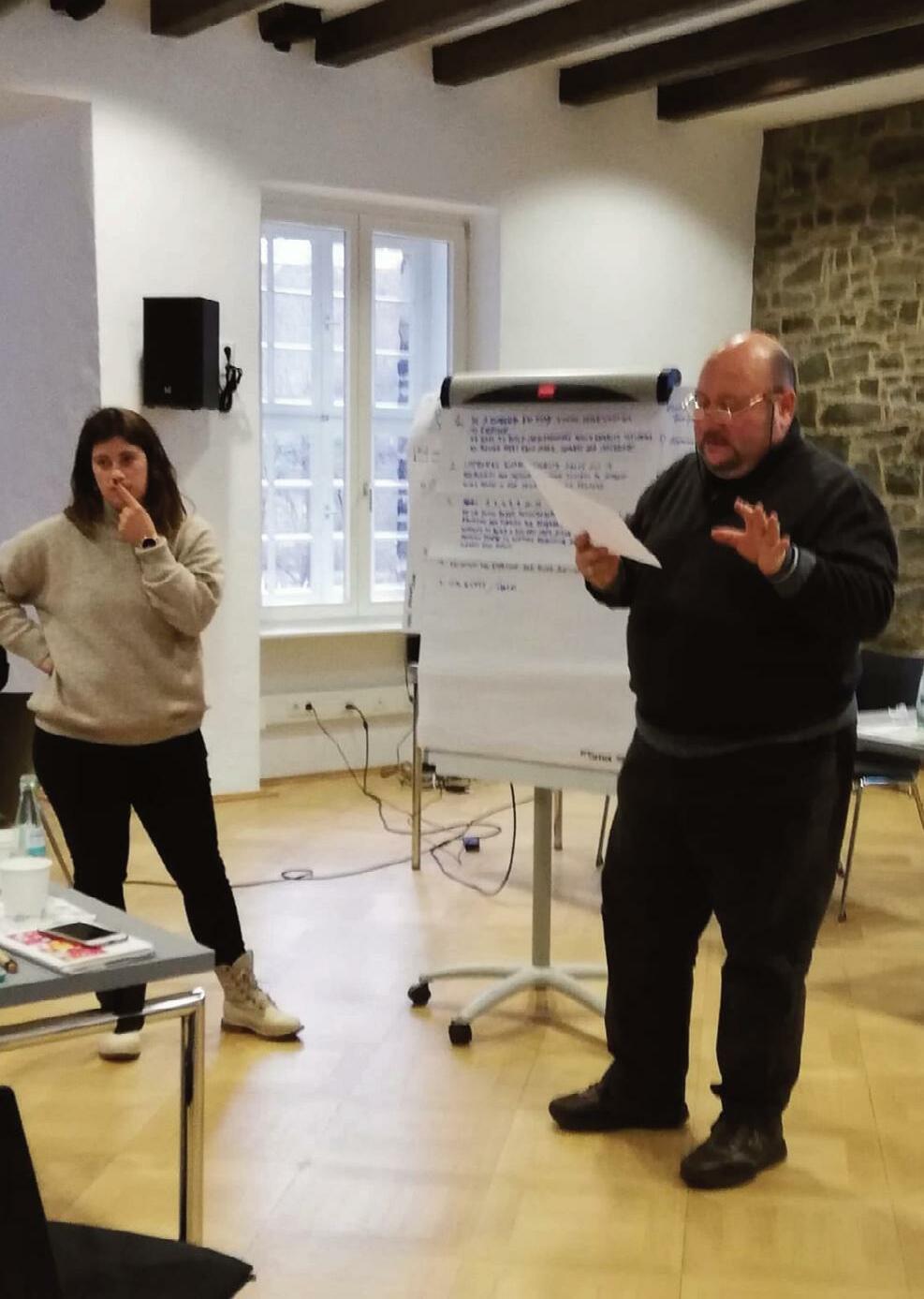

Dopo tre anni di attività sono stati presentati il 20 maggio 2021 i risultati finali della partecipazione del Comune alle attività del network che é riuscito a coinvolgere i cittadini e riattivare le energie locali, portando ad esempio, alla creazione di una sezione della Caritas, alla creazione di un’associazione Pro Loco o ancora all’inaugurazione di un coro polifonico della città.
MOTIVAZIONE
PREMIO:
86
DEL
"PER AVER EFFICAC EMENTE INTRAPRESO UN PERCORSO DI ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO SUL TERRITORIO, PROMUOVENDO UNO SCAMBIO CONCRETO DI ESPERIENZE E INFORMAZIONI CON COMUNI EUROPEI"


Chieri
“Colori caldi e accoglienti, contorni morbidi e flessuosi, tratti armonici e naturali sono solo alcune caratteristiche del paesaggio collinare su cui sorge la cittadina di Chieri.”, si legge nella descrizione del sito web del Comune di Chieri. Situata nel tratto d’unione tra Torino e il Monferrato, la sua vicinanza al capoluogo e le sue caratteristiche ambientali la rendono un luogo residenziale ambito, che attualmente conta circa 36.000 abitanti.
A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 la Città di Chieri ha saputo tradurre i sacrifici imposti dal lockdown in nuove ulteriori opportunità per ripensare il modo di vivere, di spostarsi e di concepire gli spazi cittadini. Tra i progetti attivi:
• “Strade Aperte Chieri”, un piano d’azione per ripensare gli spazi urbani e la mobilità attraverso cinque aree di intervento: ampliamento degli spazi pedonali per garantire una maggiore sicurezza per i pedoni; istituzione di Zone 20 per garantire la convivenza tra auto, bici e pedoni; possibilità per tutte le attività commerciali e artigianali di ampliare la propria superficie utilizzando lo spazio pubblico, perché la strada diventi un luogo di incontro; interventi nel centro storico per implementare la visibilità dei varchi di accesso alla Zona 30 e la creazione di nuove corsie ciclabili ebike-lane;
• partecipazione ai percorsi delle ciclovie Ven.To e Lan.Po;
• progetto interreg “SaMBA – SUSTAINABLE MOBILITY BEHAVIOURS IN THE ALPINE REGION”, che si pone l’obiettivo di promuovere il cambiamento del comportamento di mobilità dei residenti dello Spazio Alpino (AS) riducendo il divario percepito tra modalità di trasporto sostenibili e auto privata attraverso l’adozione di politiche di premialità e pricing eque, personalizzate e correlate ai costi esterni di trasporto;
• piano partecipato della mobilità scolastica sostenibile, senza auto davanti alla scuola insieme al Progetto Pascal (Percorsi pArtecipati Scuola-Casa-Lavoro);

• progetto “Blocco che sblocca”, un progetto partecipato che premia la mobilità sostenibile in autobus, in bici, a piedi;
• utilizzo delle aree verdi pubbliche per lo sport;
• progetto centORTI, orti urbani;
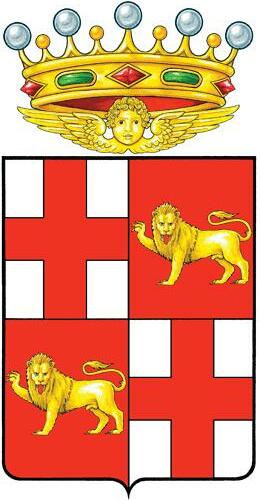
• progetto di comunicazione “Come fai a non vederlo?”, realizzato in collaborazione con le Associazioni di giovani cittadini chieresi, che studiano e lavorano, impegnati nel

parlare di sostenibilità, ricordare l’estrema urgenza della crisi climatica e difendere il futuro: FridaysForFutureChieri, OpenChieri e Don’t plastic, Be fantastic
MOTIVAZIONE DEL PREMIO: PER AVER EFFICACEMENTE AVVIATO UN PERCORSO PARTECIPATO FINALIZZATO A RIPENSARE LA CITTÀ, GLI SPAZI, LA MOBILITÀ URBANA E A SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA SUL TEMA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
88


89
Sacile


“La Sacile che oggi è dato vedere risale all’età rinascimentale e moderna, che è anche l’età dell’oro della Repubblica Veneta, alla cui “serenissima” ombra la città-porta del Friuli si sviluppò, a partire dal 1420. […] Il ponte, la strada e il fiume propiziarono la nascita di Sacile. […] si legge nella descrizione del sito web del Comune di Sacile, comune di quasi ventimila abitanti del Friuli-Venezia Giulia.
Il Comune ha intrapreso un insieme di azioni mirate e progetti specifici al fine di promuovere la salute e il benessere per i propri cittadini, tra cui:
• il progetto europeo MEDES, che mira a utilizzare la mediazione scolastica come metodologia innovativa per la prevenzione dell’abbandono scolastico, realizzato con il Comune di Vila-real;
• il progetto con Fondazione Hallgarten per promuovere una crescita intelligente, solidale, inclusiva dei cittadini;
• la gestione integrata dei servizi sociali dei Comuni “Livenza Cansiglio Cavallo” con particolare sviluppo del welfare di comunità;
• la promozione di percorsi di mobilità dolce, in particolare ciclabile con FIAB, e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale attraverso il sostegno a FAI;
• l’adesione alla Rete OMS “Città Sane”;
• l’adesione alla Comunità europea dello sport.
MOTIVAZIONE DEL PREMIO: PER AVER EFFICACEMENTE ADOTTATO L’APPROCCIO “HEALTH IN ALL POLICIES”, IN MANIERA TRASVERSALE E INTERASSESSORILE, NELL’AZIONE DI MANDATO AMMINISTRATIVO DELLA CITTÀ.
90



91

92
CITIES CHANGING DIABETES

93
URBAN DIABETES AC
È facile dire che scelte salutari portano a vivere una vita in buona salute. L’affermazione è di per sé vera ma va inquadrata in un contesto più ampio. La capacità di fare scelte salutari è dettata dalle opportunità e dalle possibilità e motivazioni personali, tutte variabili determinate da fattori esterni. Alcuni cittadini, contrariamente ad altri, hanno un buon accesso a cibi salutari e freschi a buon mercato.
Alcuni, contrariamente ad altri, hanno accesso a posti sicuri per camminare, correre, andare in bicicletta o giocare. La disuguaglianza significa che alcune popolazioni hanno maggiori opportunità rispetto ad altre di compiere scelte salutari. Significa anche che quando gruppi vulnerabili subiscono gli effetti di una malattia, l’impatto è maggiore e le conseguenze sono notevolmente peggiori.
Se non riusciamo ad elaborare soluzioni che siano inclusive, accessibili ed eque, il divario creato dalla disuguaglianza negli esiti sanitari continuerà ad allargarsi.
La questione della disuguaglianza sanitaria è stata messa ancora più in rilievo a livello globale dalla pandemia del Covid19. Il nuovo coronavirus ha colpito in maniera sproporzionata le popolazioni che già combattevano con malattie prevenibili quali obesità, diabete e patologie cardiovascolari. Ciò ha evidenziato la forte esigenza di stabilire collaborazioni trasversali fra settori per fermare l’aumento delle malattie prevenibili.
Le soluzioni si conoscono. Se si offrono sostegno alle capacità e incentivi adatti, si possono plasmare i contesti socioeconomici che influiscono sui fattori di rischio. Le città hanno una responsabilità importante – oltre che la possibilità – di assumere un ruolo di leadership nella promozione di soluzioni innovative che creano spazi e comunità salutari e sostenibili per aiutare i cittadini a fare scelte salutari.
Che cos’è l’Urban Diabetes Action Framework?
L’Urban Diabetes Action Framework consente di tradurre la teoria in pratica per incentivare i professionisti impegnati in prima linea a collaborare con gli interventi di sanità pubblica che promuovono salute e benessere, prevengono malattie e riducono le disuguaglianze. È stato inoltre sviluppato per una varietà di utilizzatori in diversi campi e si propone di creare un fronte comune fra tutte le parti in causa per pre-
venire le malattie, promuovere la sanità e accrescere il benessere nelle città.
Come si lavora con l’Urban Diabetes Action Framework? L’Urban Diabetes Action Framework offre un approccio strutturato allo sviluppo, alla pianificazione, alla verifica e alla valutazione degli interventi, fornendo strumenti per ognuno dei processi e dei casi portati ad esempio che illustrano buone pratiche.
Esso contiene tre capitoli: 1. I sei step dell’intervento Il percorso, in sei passaggi, fornisce informazioni utili a strutturare un intervento per affrontare un problema di sanità pubblica.
2. Cassetta degli attrezzi con le risorse Sono forniti, ad ogni step, gli strumenti necessari a sostenere lo sviluppo di interventi di sanità pubblica. Si può accedere agli strumenti nella cassetta anche se si vuole intraprendere un’attività indipendentemente dai sei passaggi.
3. Catalogo dei casi Nel catalogo dei casi è possibile ispirarsi alle migliori pratiche che hanno consentito di portare a termine interventi con successo. Questi casi danno un’idea concreta di quello che ci vuole per sviluppare e mettere in atto un intervento.
L’Urban Diabetes Action Framework guida coloro che lavorano nelle città, o con le autorità cittadine, a capire cosa ci vuole per sviluppare la prevenzione e gli interventi di promozione sanitaria.


Tale programma offre un approccio articolato in sei step lungo il percorso fra la definizione del problema e la messa in atto e la valutazione di una soluzione, prendendo spunto e incorporando i cinque principi che hanno ispirato il lavoro svolto in Cities Changing Diabetes.
I cinque principi ispiratori alla base dell’intervento sono:
• Promuovere salute e benessere
• Affrontare i fattori sociali e culturali e impegnarsi per l’equità sanitaria
• Integrare la salute in tutte le politiche
94
David Napier
Director, Science, Medicine and Society Network, University College London
Morten Hulvej Rod Head of Health Promotion Research, Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Lund Vice President, Head of Global Prevention & Health Promotion, Novo Nordisk
CTION FRAMEWORK
• Coinvolgere le comunità nell’elaborazione delle soluzioni per la salute
• Creare soluzioni in partnership fra settori L’Urban Diabetes Action Framework è una piattaforma dinamica che si svilupperà nel tempo e che sarà aggiornata periodicamente con nuovi strumenti, casi e altri contenuti richiesti dagli utilizzatori.
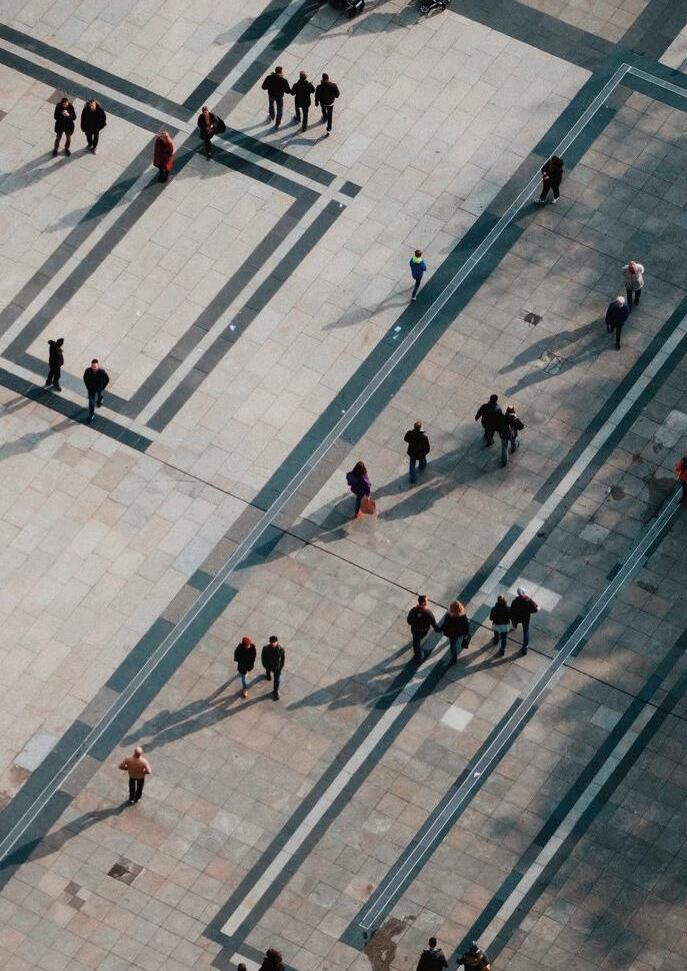
Destinatari
Il framework è stato sviluppato per i leader di progetto, i team e comunque per tutti coloro che sono interessati a creare interventi pubblici sostenibili di prevenzione sanitaria.
Chiunque può ispirarsi ad esso, compresi i collaboratori e i dipendenti delle autorità locali, i professionisti della sanità, gli urbanisti, i leader di comunità e altri addetti ai lavori.
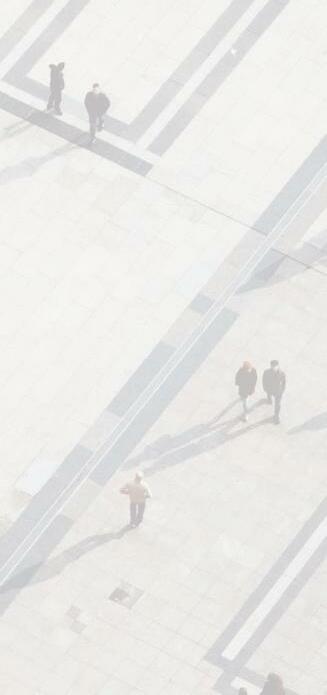
Per scaricare il Cities Changing Diabetes Framework: https://www.citieschangingdiabetes.com/action-framework/theurban-diabetes-action-framework.html
Il programma Cities Changing Diabetes è una rete di 37 città e più di 100 partner che operano per capire il peso dell’obesità e del diabete, per condividere gli apprendimenti e per sviluppare soluzioni innovative. Nei primi sei anni Cities Changing Diabetes ha generato nuovi spunti e azioni innovative per la salute in città di tutto il mondo. Questi spunti e azioni devono essere elaborati in grande scala e devono costituire la base di lancio per l’applicazione in ancor più città, per accelerare i cambiamenti sistemici necessari a “bend the curve” del diabete.
In Italia Roma, Milano, Bari, Bologna, Genova, Napoli, Torino fanno parte del programma Cities Changing Diabetes come partners cities e Reggio Calabria come advocate city. citieschangingdiabetes.com
95


I WEBINAR REGIONALI SULL’URBAN HEALTH: Piemonte, Liguria, Puglia, Emilia-Romagna
DIABETE: IL FELSINEO
Nella Città metropolitana di Bologna risiedono oltre 63 mila persone con diabete, 23 mila tra i residenti nel capoluogo. Il dato percentuale sulla popolazione varia dal 5,9 per cento della città al 6,2 per cento medio del territorio della AUSL Bologna, con punte del 7 per cento nell’area Pianura ovest, mantenendosi in linea con la media nazionale
Inferiore, rispetto al dato italiano, il tasso standardizzato di mortalità per diabete, tuttavia si riscontrano tassi di ospedalizzazione per malattia non controllata e per complicanze molto più elevati rispetto alla media nazionale
Presentata il 19 maggio scorso l’iniziativa Cities Changing Diabetes®, realizzata in partnership tra University College London (UCL) e il danese Steno Diabetes Center, con il contributo di Novo Nordisk, numerose Istituzioni nazionali e amministrazioni locali, mondo accademico e società civile, nel corso di un convegno virtuale organizzato da ANCIComunicare con Anci Emilia-Romagna, Health City Institute, C14+
Anche Bologna entra a far parte del programma Cities Changing Diabetes con la presentazione dell’iniziativa nel capoluogo emiliano con il convegno dal titolo: “Promuovere in Emilia Romagna le politiche sulla salute nelle città”, organizzato in forma virtuale da ANCIComunicare insieme ad Anci Emilia-Romagna, Health City Institute, C14+, Italia Cities Changing Diabetes, e grazie al contributo non condizionato di Novo Nordisk. Nell’occasione è stato presentato anche il nuovo percorso di alta formazione per la figura professionale dello Health City Manager, un professionista in grado di migliorare il contesto urbano sul tema della salute, attraverso il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte politiche e l’impegno delle amministrazioni nella promozione della salute nella comunità. «Qualità della vita e programmazione urbanistica devono rientrare necessariamente nella gestione delle politiche della salute. La risposta che, come ANCI, abbiamo voluto dare all’affermazione del concetto diffuso di urban health risiede proprio nell’avvio del corso di alta formazione per Health City Manager, che abbiamo avviato lo scorso 23 aprile e che formerà 120 professionisti in grado di contribuire alle istanze di salute e benessere espresse dai cittadini. Dobbiamo introdurre una serie di azioni coordinate per l’effettiva realizzazione di politiche urbane che abbiano come priorità la salute e i suoi determinanti: il miglioramento della rete urbana dei trasporti, della qualità del verde cittadino e delle politiche ambientali, della promozione delle attività sportive, fino ovviamente ad interventi di welfare e partecipazione sociale», dice Enzo Bianco, Presidente Consiglio Nazionale ANCI e Presidente C14+.
«I Comuni italiani sono sempre impegnati a fianco del sistema sanitario, come è stato dimostrato anche dall’emergenza Covid, che ha visto le amministrazioni comunali in prima linea: dalla rimodulazione dei servizi essenziali alle
reti di sostegno, di aiuto ai più deboli, mettendo in campo uno sforzo generoso e straordinario, consapevoli – tutti –che eravamo davanti a qualcosa di inedito. Il sistema degli enti locali, lo dico senza alcuna intenzione di autocelebrazione, ha saputo dare in questo frangente una grande prova di sé», precisa Luca Vecchi, primo cittadino di Reggio Emilia e delegato Anci al Welfare.
Nell’area della città metropolitana di Bologna risiedono, secondo le elaborazioni di Health City Institute su dati ISTAT, oltre 63 mila persone con diabete, 23 mila nel solo capoluogo. Il dato percentuale sulla popolazione varia dal 5,9 per cento della città al 6,2 per cento medio del territorio della AUSL Bologna, con punte del 7 per cento nell’area Pianura ovest, mantenendosi abbastanza in linea con la media nazionale del 5,8 per cento. Più basso, rispetto al dato italiano, risulta il tasso standardizzato di mortalità per diabete, tuttavia si riscontrano tassi di ospedalizzazione per malattia non controllata e per complicanze molto più elevati rispetto alla media italiana: una sorta di “paradosso felsineo”. «Una consolidata e ricca esperienza di analisi permette alla città di Bologna di affrontare le tematiche che riguardano il diabete urbano e le fragilità con un approccio multidisciplinare. Ne sono chiaro esempio l’importante studio sul diabete ed i migranti – ARNO Migranti – attuato qualche anno fa dal professor Giulio Marchesini, o il lavoro dell’ASL di Bologna, diretta dal dottor Paolo Pandolfi, sulla prevalenza del diabete quartiere per quartiere di Bologna ed area metropolitana. In linea con questi temi, da qualche anno è attiva una cabina di regia che, riunendo in un unico tavolo il Comune di Bologna, l’Ufficio Scolastico Emilia-Romagna, l’Università Alma Mater e le due Aziende sanitarie bolognesi sta sviluppando studi e iniziative congiunte che racchiudano e sfruttino tutti i saperi e le vocazioni della comunità urbana»,
98
PARADOSSO
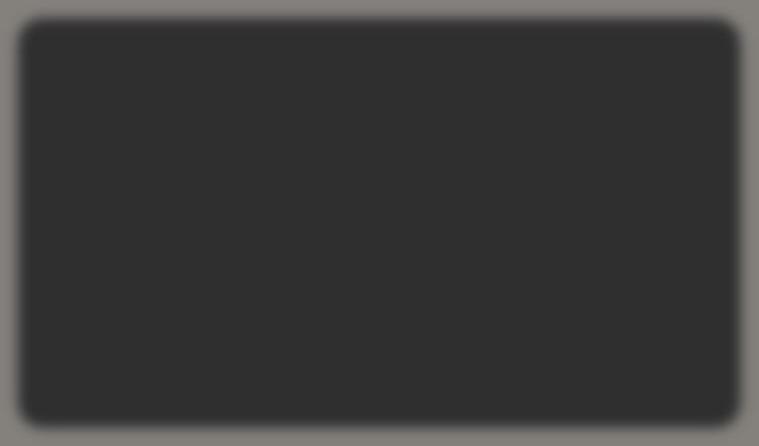
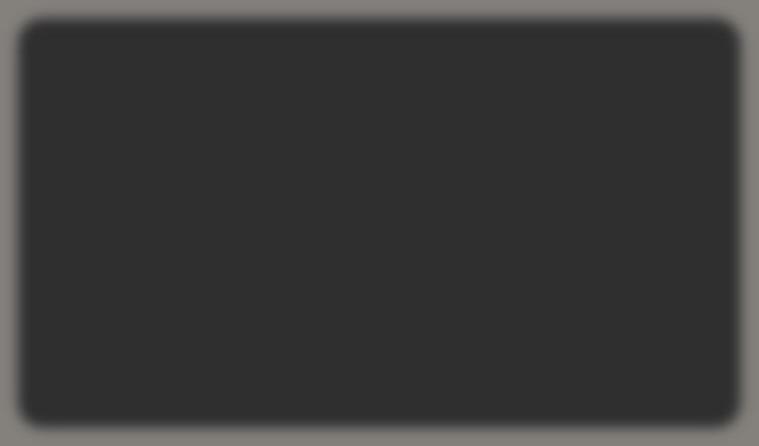
ricorda Uberto Pagotto, Presidente Comitato Scientifico Bologna Cities Changing Diabetes e Professore Ordinario
Endocrinologia presso l’Università degli Studi di Bologna. «Oggi, oltre la metà della popolazione del pianeta vive nelle città, e questa percentuale salirà a due terzi entro il 2050. La città esalta le disuguaglianze sociali e crea aree di deprivazione che si traducono in rischi per la salute, particolarmente nell’area delle malattie croniche non trasmissibili. Tra queste, il diabete urbano è l’oggetto di una sfida globale lanciata col progetto internazionale Cities Changing Diabetes anche in varie città italiane e raccolta da ANCI Emilia-Romagna per promuovere le politiche sulla salute», spiega Giulio Marchesini, Presidente Comitato Esecutivo di Bologna Cities Changing Diabetes Oltre 3 miliardi di persone nel mondo vivono, infatti, in città metropolitane e megalopoli; nel 2050 saranno 7 su 10. Un filo sottile, ma evidente, lega il fenomeno dell’inurbamento alla crescita di malattie come il diabete o l’obesità. Esiste una suscettibilità genetica a sviluppare la malattia, cui si associano fattori ambientali legati allo stile di vita. Oggi, vive nelle città il 64 per cento delle persone con diabete, l’equivalente di circa 246 milioni di persone, ma il numero è destinato a crescere.
«L’impegno di Bologna nel progetto Cities Changing Diabetes, manifestato con la firma del Sindaco Virginio Merola alla Urban Diabetes Declaration, ha inserito la città nel consesso di quelle che, a livello internazionale, si impegneranno sulle sfide al diabete correlate all’urbanizzazione. Le città che sottoscrivono questo documento rispetteranno cinque principi guida per rispondere alla sfida del diabete urbano: investire nella promozione della salute e del benessere a lungo termine, agire sui determinanti sociali e culturali che sono le cause profonde che determinano le opportunità di una vita sana per i cittadini, integrare la salute in tutte le politiche, coinvolgere attivamente le comunità e creare soluzioni di partenariato con altri settori in modo trasversale», ricorda Federico Serra, Direttore Italia Cities Changing Diabetes
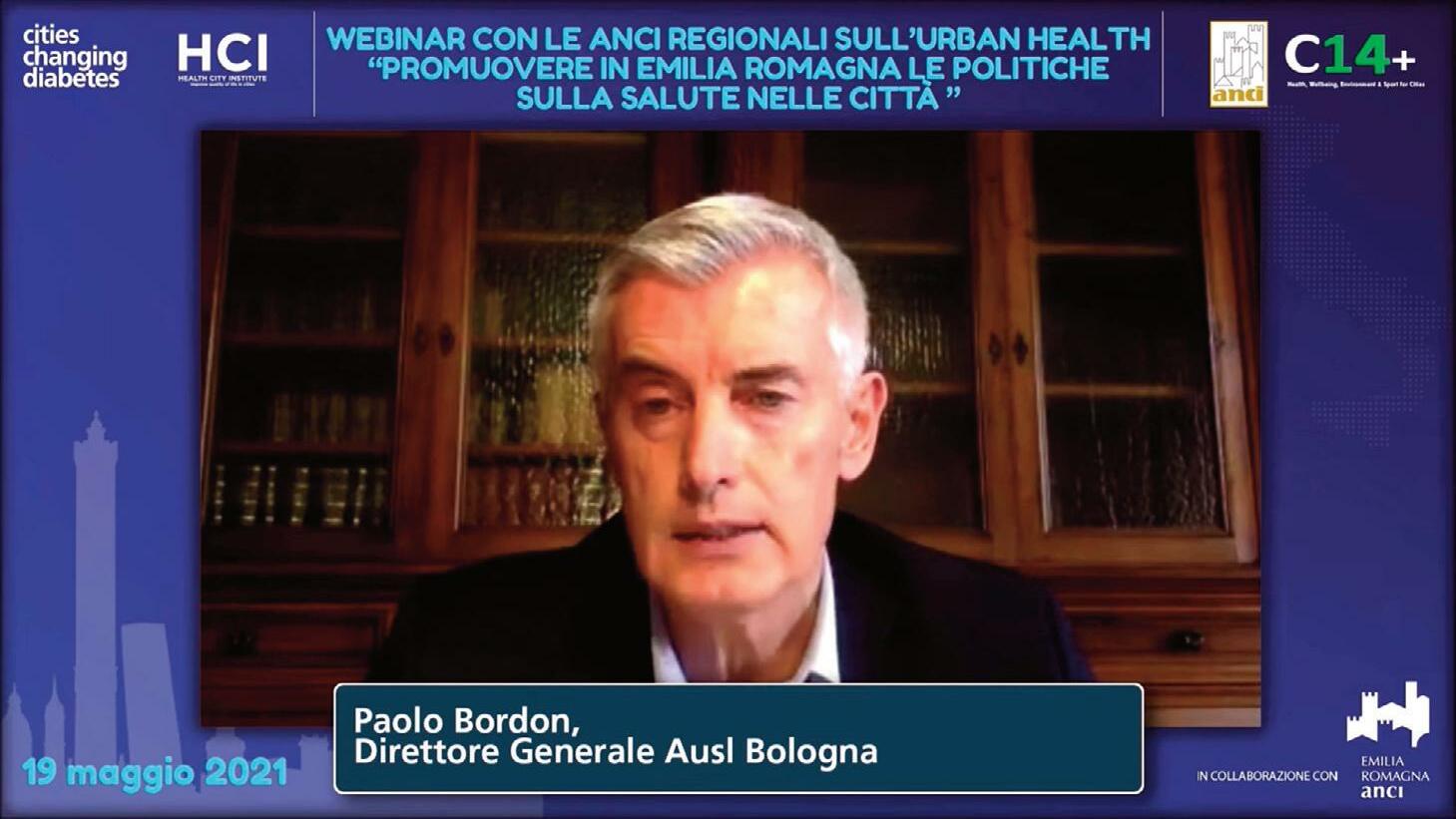

99
di
DIABETE: A GENOVA, UN 50 PER CENTO NEGLI UL
Nella Città metropolitana di Genova risiedono oltre 55 mila persone con diabete, 38 mila tra i residenti nel capoluogo, pari al 6,6 per cento della popolazione; erano il 4,2 per cento nel 2000
Genova è entrata a far parte del programma Cities Changing Diabetes® ufficialmente il 28 aprile nel corso del convegno virtuale, organizzato da ANCIComunicare insieme ad Anci Liguria, Health City Institute, C14+, Italia Cities Changing Diabetes, e grazie al contributo non condizionato di Novo Nordisk, dal titolo: “Promuovere in Liguria le politiche sulla salute nelle città”.
«L’ingresso di Genova nel network mondiale delle città del programma di studio Cities Changing Diabetes è un’opportunità unica per la nostra città, che oggi sta vivendo una grande rinascita e un importante sviluppo urbanistico, attraverso soluzioni che mirano ad un progressivo miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini», ha dichiarato Luciano Grasso, Presidente Comitato Esecutivo di Genova Cities Changing Diabetes e Presidente Vince Genova.
Nell’area della città metropolitana di Genova risiedono, secondo le elaborazioni di Health City Institute su dati ISTAT, oltre 55 mila persone con diabete, 38 mila nel solo capoluogo, pari al 6,6 per cento della popolazione. Questa percentuale era del 4,2 per cento nel 2000, il che indica una crescita di oltre il 50 per cento negli ultimi vent’anni e pone Genova, e la Liguria, al di sopra della media nazionale di 5,8 persone con diabete su 100 nella popolazione. Questo dato si allinea a un altro indicatore che vede la regione sopra la media italiana, l’età media dei liguri: 49,2 anni rispetto ai 45,7 nazionali, con quasi 3 cittadini su 10 over 65 anni.
«Non è più possibile trascurare il ruolo delle città nel determinare la salute della popolazione. Questa convinzione ha assunto una ancor più forte connotazione con l’insorgenza della emergenza sanitaria nell’ultimo anno. È emersa, infatti, la necessità di ripensare la pianificazione urbana per favorire un nuovo modo di vivere città, centri, periferie, rimodulando densificazione dei territori e impedendo che siano proprio le città la principale criticità nella diffusione della pandemia. Occorre pertanto intervenire sui contesti e gli ambienti di vita urbani con strategie in grado di orientare le scelte nella direzione di un maggior guadagno di salute, considerando la centralità della persona, i suoi diritti, le sue scelte, il suo contesto di vita e rafforzando il ruolo di Regioni ed enti territoriali al fine di intraprendere politiche più efficaci che offrano ai cittadini più strutture e opportunità» ha detto Andrea Costa, Sottosegretario di Stato alla Salute.
«L’impegno di Genova nel progetto internazionale Cities
Changing Diabetes, manifestato con la firma del Sindaco Marco Bucci alla Urban Diabetes Declaration, di fatto ha fatto entrare il capoluogo ligure tra le città che a livello internazionale si impegneranno sulle sfide al diabete correlate all’urbanizzazione,ha ricordato Federico Serra, Direttore Italia Cities Changing Diabetes.
«Nella definizione completa della scuola endocrinologica italiana è da sempre presente la parola “benessere”, che rappresenta quindi uno dei temi principali non solo nella formazione stessa degli endocrinologi, ma è anche una parte preponderante della mission dell’endocrinologo moderno. Investire nella promozione della salute e nel benessere, forse non a caso, è uno dei principali punti chiave dell’Urban Diabetes Declaration», ha dichiaratp Diego Ferone, Presidente Comitato Scientifico Genova Cities Changing Diabetes e Direttore Clinica Endocrinologica IRCCS, Policlinico San Martino, Università degli Studi di Genova.
«La città e il contesto urbano hanno un impatto determinante sul modo in cui, i propri abitanti, vivono, si spostano, lavorano, mangiano. Tutti questi fattori possono in una qualche misura contribuire all’aumento del diabete. Chi amministra la nostra splendida città è da sempre in prima linea nella sfida a questa patologia e nel garantire salute e benessere ai propri cittadini. La firma dell’Urban Diabetes Declaration sancisce l’impegno della nostra amministrazione per accelerare la prevenzione del diabete e delle sue complicanze», ha concluso Massimo Nicolò, Vicesindaco e Assessore alla salute del comune di Genova e Copresidente del Comitato Promotore Genova Cities Changing Diabetes.
100
A CRESCITA DI OLTRE IL TIMI VENT’ANNI

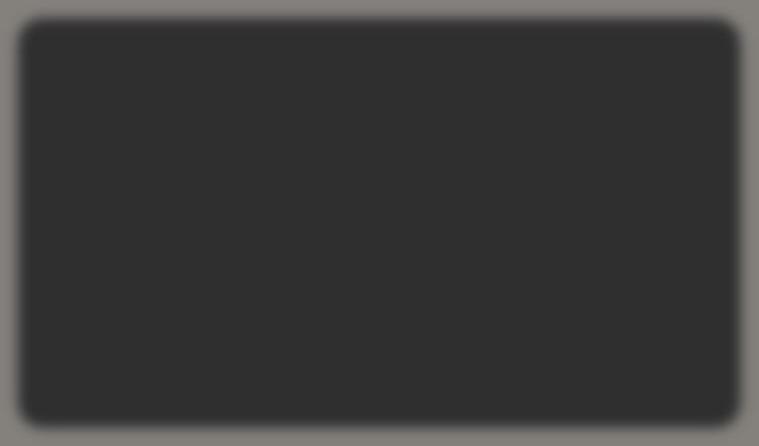

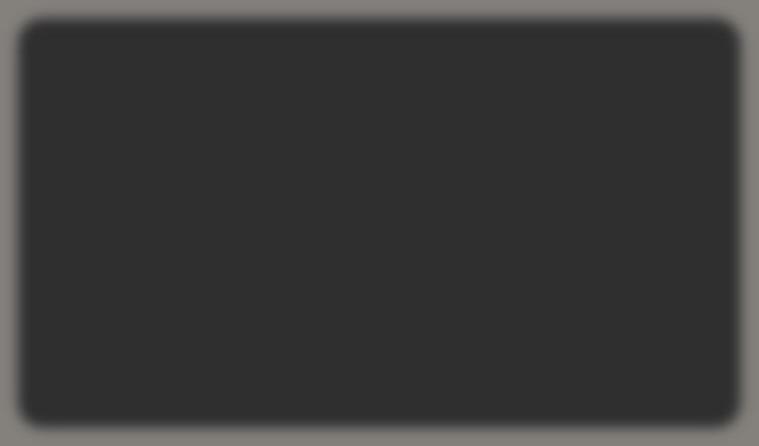

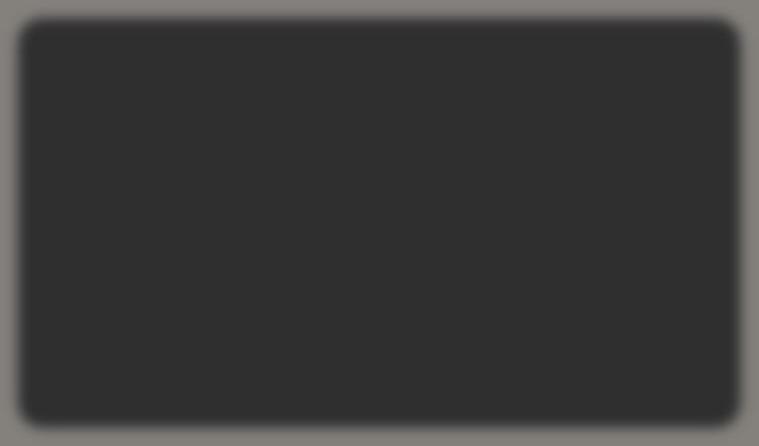
101
DIABETE URBANO: NEGATIVO PER IL
Nella Città metropolitana piemontese risiedono quasi 135 mila persone con diabete, il 6 per cento della popolazione censita; 52 mila le persone con diabete tra i residenti della città.
Torino è entrata nel programma Cities Changing Diabetes , il programma, che si avvia a coinvolgere oggi 40 metropoli di tutto il mondo, si propone di evidenziare il rapporto tra urbanizzazione e diabete tipo 2 e a promuovere iniziative per salvaguardare la salute dei cittadini e prevenire la malattia. «Parlare di urban health o diabete urbano oggi è fondamentale e prioritario: si tratta di una sfida globale, per la quale le città sono chiamate a diventare centri di innovazione nella gestione e nella risposta ai fenomeni epidemiologici in atto. Una strategia efficace richiede un approccio finalmente multidisciplinare e trasversale, in cui i saperi, a partire da quelle medico e scientifico, possano supportare le scelte di salute pubblica da parte di decisori politici così come dei cittadini stessi. La città metropolitana di Torino sta sperimentando questa alleanza che senza dubbio potrà rappresentare un modello per tutto il territorio regionale cui ci rivogliamo con l’evento di oggi», spiega Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute e del Comitato Nazionale Biosicurezza e Bioetica - Presidenza Consiglio dei ministri.
L’annuncio dell’adesione del capoluogo piemontese al programma Cities Changing Diabetes® è stato dato nel corso del convegno da ANCIComunicare insieme ad Anci Piemonte, Health City Institute, C14+, Italia Cities Changing Diabetes, il 22 marzo intitolato: “Promuovere in Piemonte le politiche sulla salute nelle città”. «È necessario uno sforzo congiunto che promuova la consapevolezza del valore della salute pubblica, in una governance multilivello tra Comuni, Autorità sanitarie locali e Regioni, con l’obiettivo comune di perseguire il benessere collettivo e prevenire i rischi per la salute delle nostre comunità. La pandemia ha fatto emergere nuove vulnerabilità e fragilità sociali. Siamo oggi chiamati a lavorare garantendo sussidiarietà e prossimità, attraverso il potenziamento delle reti territoriali per la prevenzione, la cura e l’assistenza e rafforzando altresì il ruolo dei Sindaci, cui deve essere garantita piena operatività su tutto il territorio nazionale», commenta Roberto Pella, Vicepresidente vicario ANCI.
Nell’area della città metropolitana di Torino risiedono, secondo le elaborazioni di Health City Institute su dati ISTAT, circa 135 mila persone con diabete, 52 mila nel solo capoluogo. Torino occupa, in termini assoluti, la quarta piazza nella graduatoria della città metropolitane italiane per
popolazione residente colpita dalla malattia – dopo Roma, Napoli e Milano. Tuttavia, è al primo posto tra quelle del Nord Italia in termini percentuali. Paragonandola, ad esempio, alla vicina Milano, che la precede nella classifica con circa 180 mila residenti, pari al 5,6 per cento della popolazione, le persone con diabete dell’area metropolitana torinese corrispondono al 6 per cento dei residenti. «Le malattie metaboliche, in particolare il diabete e l’obesità, rappresentano un elevato rischio per la salute, determinando molto spesso complicanze cardiovascolari. E’ possibile prevenire e curare queste malattie a livello urbano anche attraverso molteplici progetti che ispirino stili di vita più sana», dice Ezio Ghigo, Presidente Comitato Esecutivo Torino Cities Changing Diabetes.
«Mai come in questa congiuntura pandemica è risultato evidente il legame tra salute e politiche non sanitarie. La salute è diventata il criterio normativo per limitare la libertà di movimento, regolare il funzionamento delle nostre comunità, contenere le attività sociali e culturali, disciplinare quelle produttive e scolastiche. L’emergenza ha reso evidente a tutti, pubblico e decisori, e in modo drammatico quanto le variazioni di salute in una comunità debbano essere la metrica con cui ogni politica, intervento e pratica debba misurarsi, sia prima di essere stabilita e programmata per modularne il risultato atteso sia dopo essere stata eseguita per valutarne l’impatto osservato. Le città sono il contesto adatto in cui questo virtuoso processo può essere costruito anche grazie alle innovazioni che i programmi del Piano di Resilienza e Ripresa renderanno possibili», aggiunge Giuseppe Costa, Presidente Comitato Scientifico Torino Cities Changing Diabetes, Professore Ordinario di Igiene dell’Università di Torino.
102
A TORINO IL RECORD NORD ITALIA
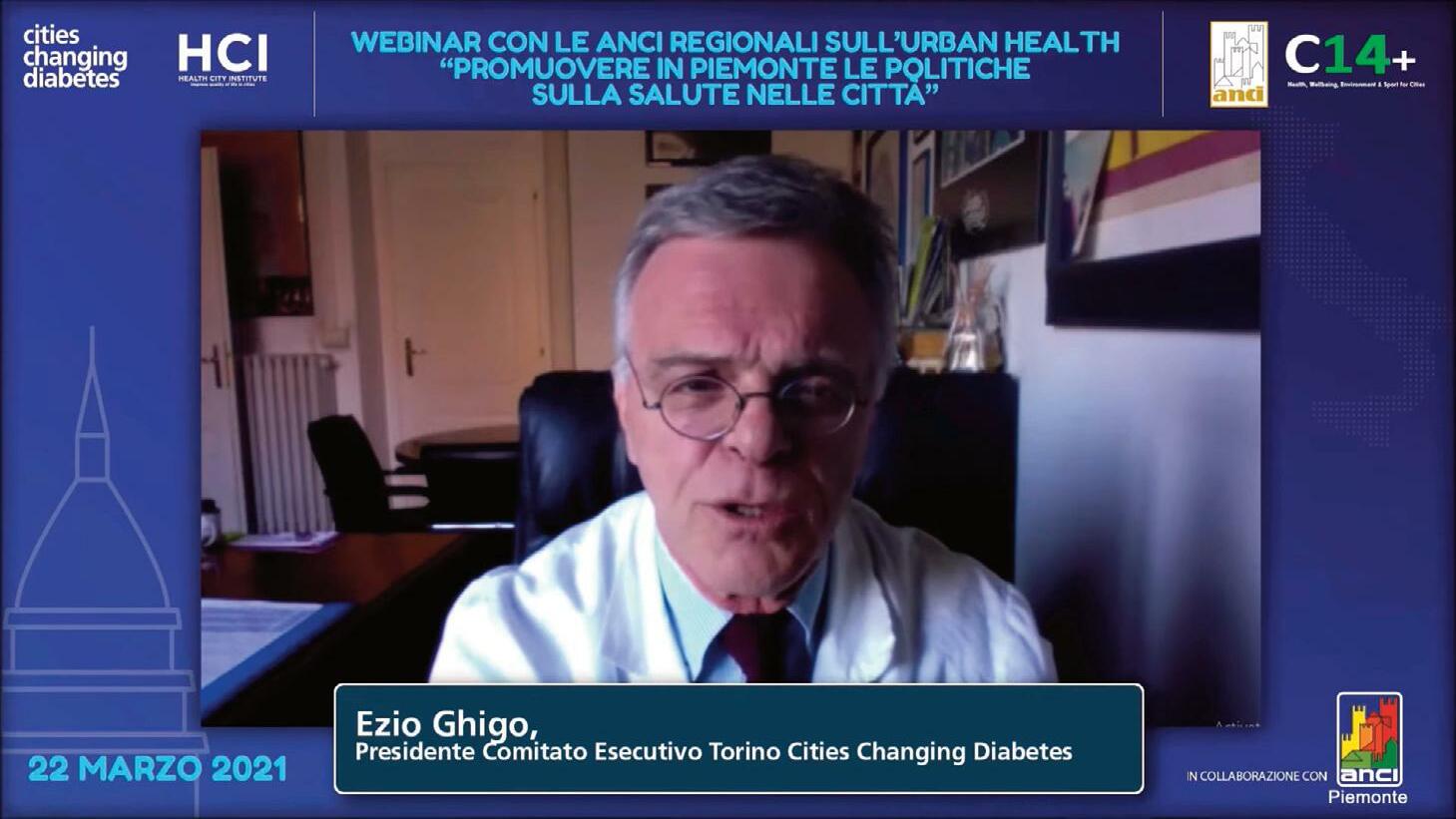
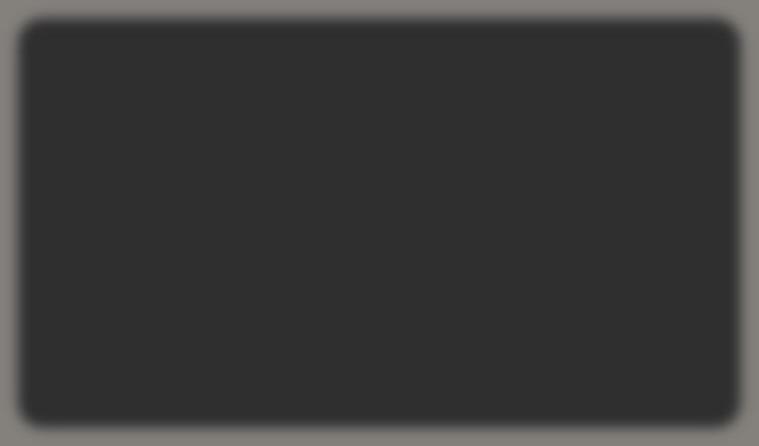
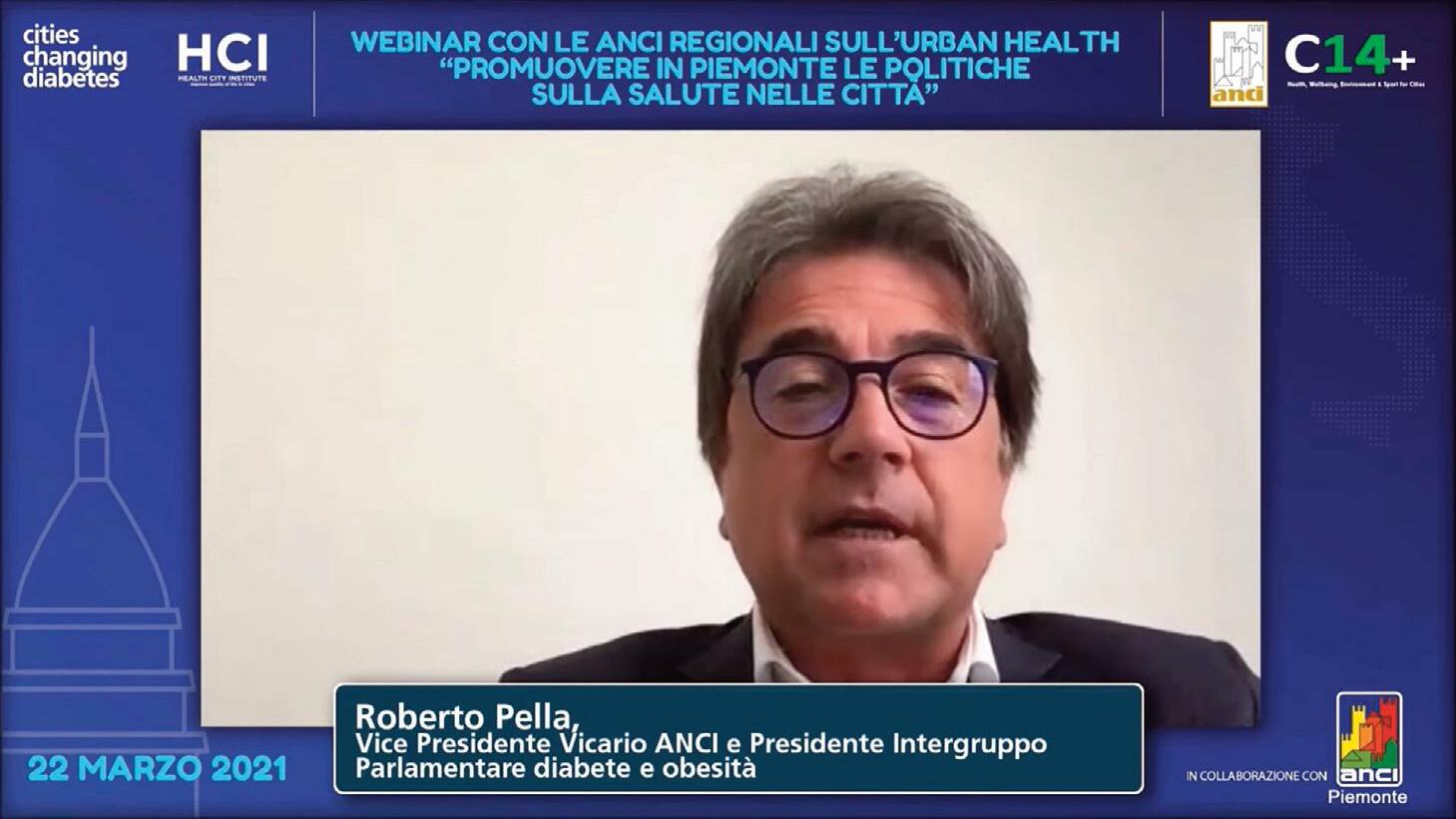
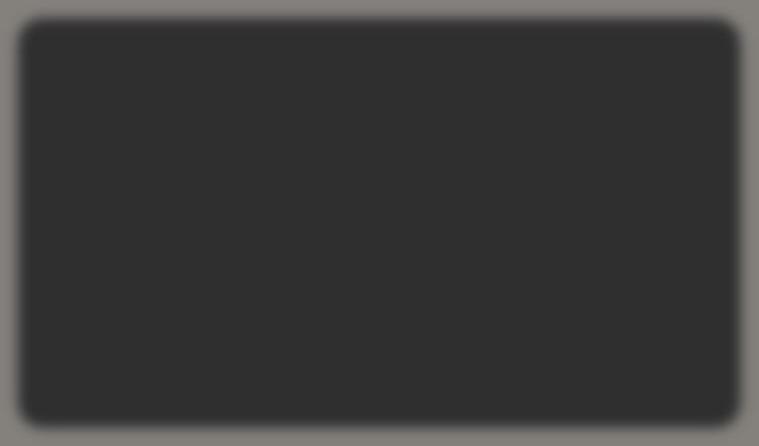

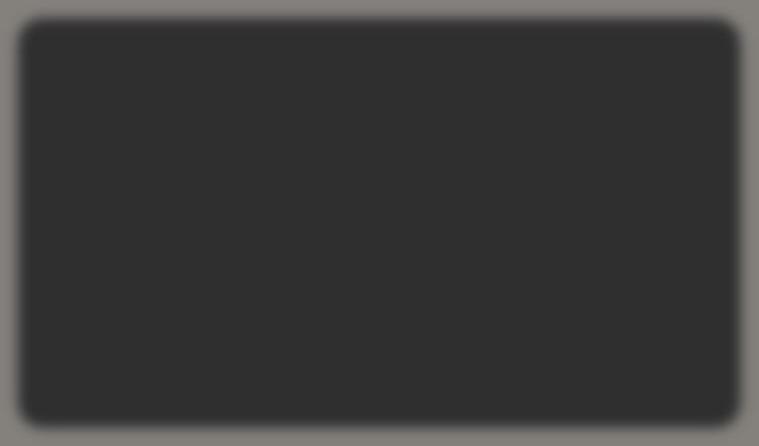
103
BARI IN PRIMA FILA NE
Nella Città metropolitana di Bari risiedono oltre 84 mila persone con diabete, circa 22 mila tra i residenti nel capoluogo, pari al 6,8 per cento della popolazione; erano il 4,5 per cento nel 2000
Parte da Bari la formazione della nuova figura professionale: lo Health City Manager
Bari è entrata nel programma Cities Changing Diabetes®, e l’adesione è stata formalmente presentata nel corso del convegno dal titolo: “Promuovere in Puglia le politiche sulla salute nelle città”, organizzato in forma virtuale da ANCIComunicare insieme ad Anci Puglia, Health City Institute, C14+, Italia Cities Changing Diabetes. Nell’occasione è stato annunciato anche il via, dal capoluogo pugliese, del nuovo percorso di alta formazione per la figura professionale dello Health City Manager, un professionista in grado di migliorare il contesto urbano sul tema della salute, attraverso il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte politiche e l’impegno delle amministrazioni nella promozione della salute nella comunità. «Una strategia efficace richiede un approccio finalmente multidisciplinare e trasversale, in cui i saperi, a partire da quelle medico e scientifico, possano supportare le scelte di salute pubblica da parte di decisori politici così come dei cittadini stessi. Questo è anche il senso del percorso di alta formazione per 120 Health City Manager che ANCI, insieme a Health City Institute, ha avviato lo scorso 23 aprile, proprio a partire dalla città di Bari. Una figura altamente qualificata che auspichiamo potrà essere inserita nella PA a supporto e come coordinamento delle politiche per la salute nelle città», spiega Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute e del Comitato Nazionale Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita - Presidenza Consiglio dei ministri.
Nell’area della città metropolitana di Bari risiedono, secondo le elaborazioni di Health City Institute su dati ISTAT, oltre 84 mila persone con diabete, circa 22 mila nel solo capoluogo, pari al 6,8 per cento della popolazione. Questa percentuale era del 4,5 per cento nel 2000, il che indica una crescita di oltre il 50 per cento negli ultimi vent’anni e pone Bari, e la Puglia, al di sopra della media nazionale di 5,8 persone con diabete su 100 nella popolazione. Questo dato si allinea a un altro indicatore che vede la regione sopra la media italiana, la sedentarietà, che ha un impatto importante sullo sviluppo di malattie come il diabete e l’obesità: sono infatti il 43,7 per cento i pugliesi che non praticano alcuna attività fisica, rispetto al 35,6 per cento della media nazionale. «Il rafforzare e accelerare azioni finalizzate a prevenire il diabete e le sue complicanze, così come a contrastare la diffusione del sovrappeso e dell’obesità è fondamentale. In questo contesto la urbanizzazione può rappresentare un pericoloso fattore di rischio, che favorisce lo sviluppo di diabete
e obesità e peggiora gli esiti di queste patologie. In particolare, alcuni dati recenti dimostrano che il basso livello socioeconomico presente in alcune aree metropolitane può favorire la comparsa del diabete: questo dovrebbe essere motivo di attenta riflessione nelle politiche sanitarie per assicurare un reale miglioramento dello stato di benessere della collettività», dice Francesco Giorgino, co-Presidente Comitato Esecutivo Bari Cities Changing Diabetes e Direttore Dipartimento Emergenza e Trapianti, Università di Bari Aldo Moro.
«In questo momento particolare, il progetto Cities Changing Diabetes assume una rilevanza ancora maggiore, se si pensa alla grave criticità determinata dallo stretto nesso esistente tra Covid-19 e diabete. Il progetto è un’opportunità per la comunità barese che vedrà impegnati ricercatori, clinici e amministratori ad individuare ed assicurare soluzioni sostenibili per la salute. La città metropolitana di Bari aderendovi, identifica come via maestra la feconda sinergia e la proficua collaborazione tra soggetti pubblici e privati, accademia, professioni, organizzazioni dei pazienti e media come modello virtuoso di lavoro da seguire per realizzare i 5 punti dell’Urban Diabetes Declaration», dichiara Luigi d’Ambrosio Lettieri, co-Presidente Comitato Esecutivo Bari Cities Changing Diabetes e Presidente Ordine dei farmacisti Bari BAT.
«L’adesione della città di Bari alla Urban Diabetes Declaration conferma ancora una volta l’impegno che da tempo la nostra amministrazione esprime in materia di salute pubblica. Il Covid 19 ci ha costretto ad una riflessione più ampia circa le implicazioni che le nostre politiche di sviluppo possono generare sulla salute pubblica. Noi Sindaci esercitiamo il delicato ruolo di autorità sanitaria locale e questo ci espone e ci obbliga a valutare tutti gli aspetti che rientrano nella governance di questa complessa questione. L’occasione di confronto odierno rappresenta pertanto un momento privilegiato per valutare, anche insieme alla comunità accademica e scientifica, quali siano i percorsi più adeguati per il contrasto al diabete urbano e la promozione della qualità della vita dei nostri cittadini», conclude Antonio Decaro, Presidente di ANCI e Sindaco di Bari
104
LLA LOTTA AL DIABETE
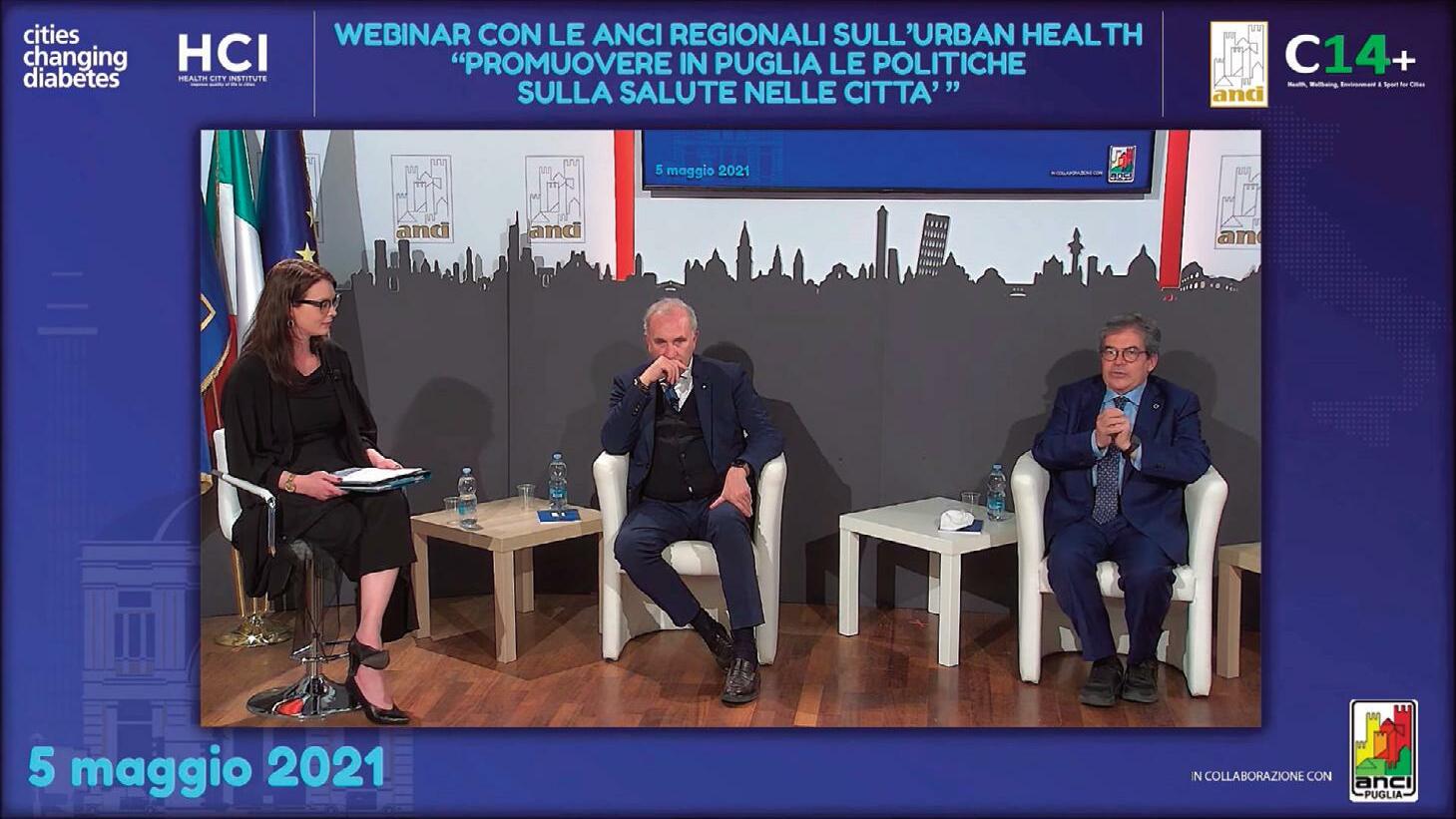

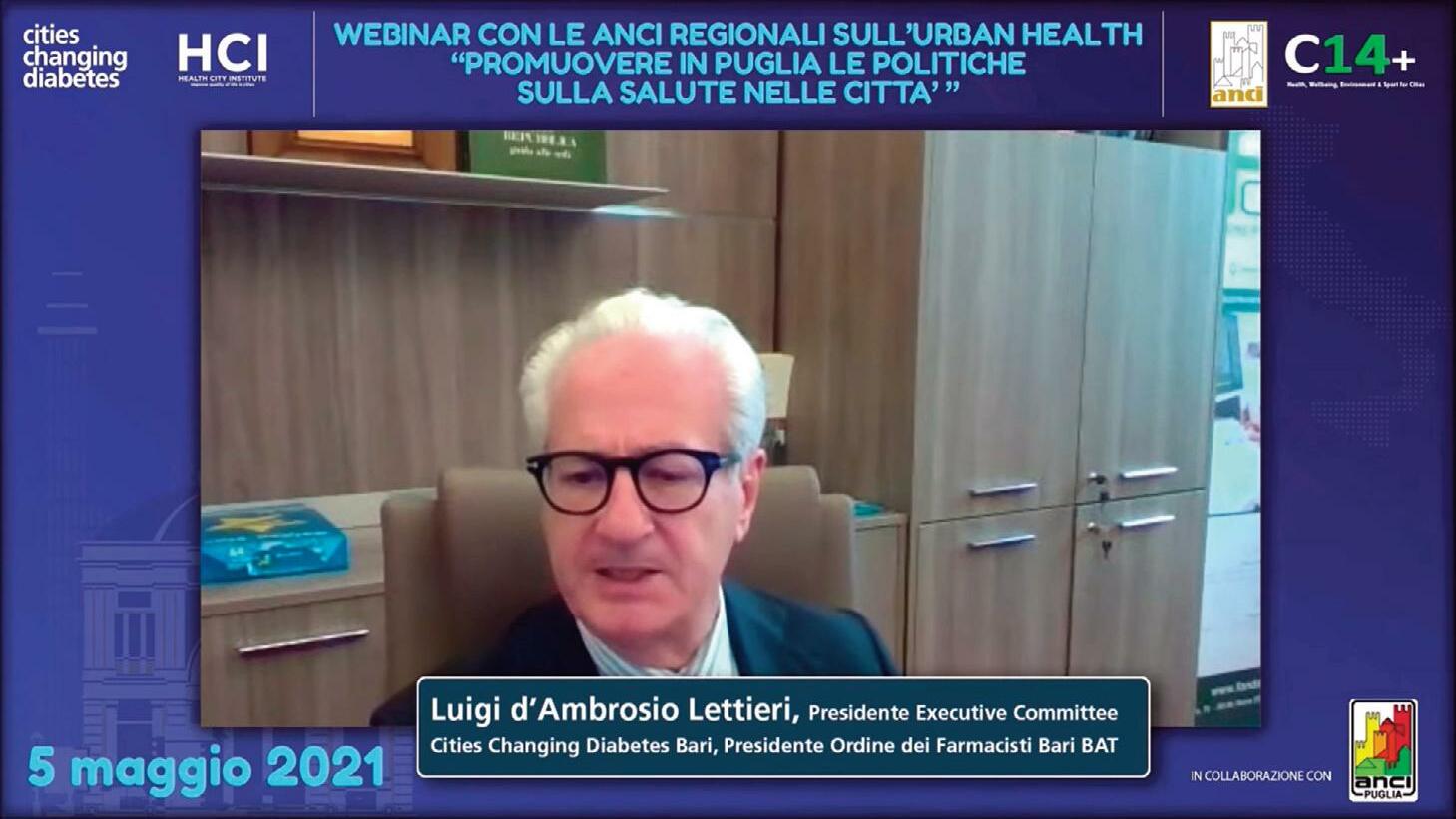



105
DIABETE: DAL RAPPORTO “ROMA 2021”, FOTOGRAFIA DELLA CONDIZIONE DELLE NELL’AREA METROPOLITANA DELLA CAPITALE
A Roma, quasi 300 mila persone con diabete, non invidiabile record tra le metropoli del Paese. Marcata variabilità della prevalenza fra i Municipi, che oscillano fra il 7,5 e l’11,2 per cento della popolazione residente di età maggiore o uguale a 35 anni. Disagio sociale e problemi economici responsabili di una più frequente e più precoce insorgenza di diabete.
Significativo impatto del Covid sull’assistenza alle persone con diabete. Un paziente su 2 ha segnalato la sospensione delle normali visite di controllo presso il centro diabetologico, sostituite da televisite o telefonate; uno su 5 ha dichiarato di non aver fatto alcun controllo durante il lockdown. Comunque, il 46 per cento ritiene di essere stato seguito con adeguatezza.
Piena adesione dell’amministrazione al programma Cities Changing Diabetes con la firma della Sindaca Virginia Raggi alla Urban Diabetes Declaration.
Terzo atto per il progetto Roma Cities Changing Diabetes che ha visto città capitolina coinvolta sin dal 2017. E’ stato presentato lo scorso 15 marzo infatti, presso la sede della Città metropolitana di Roma di Palzzo Valentini , l’edizione 2021 del Report “Roma Cities Changing Diabetes - Diabete Tipo 2 e Obesità nell’area di Roma Città Metropolitana, realizzato nell’ambito del programma internazionale Cities Changing Diabetes,.
«Nel 2017, Roma è stata inserita nel programma diventando, insieme alle principali metropoli mondiali, oggetto di studi internazionali sul tema del rapporto tra urbanizzazione e diabete tipo 2 e nello stesso tempo città simbolo mondiale nella lotta a questa importante patologia», ricorda Andrea Lenzi Presidente di Health City Institute e del Comitato di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei ministri «Con questo documento abbiamo realizzato una fondamentale mappatura dei dati quantitativi demografici, clinico-epidemiologici e sulla percezione della salute nell’area di Roma Città metropolitana, dati che forniscono spunti di analisi, osservazione e confronto. Dati che fotografano puntualmente la situazione di Roma e ci consegnano un contesto da cui emerge la grande differenza di prevalenza del diabete tra periferie e centro cittadino. Una fotografia che impone una seria riflessione dal punto di visto sanitario, clinico e sociale» aggiunge.
«La prima edizione del rapporto aveva evidenziato una notevole variabilità nella prevalenza di diabete nelle diverse ASL della città metropolitana di Roma. La disponibilità di nuovi dati con dettaglio a livello dei singoli municipi permette di valutare ulteriormente la relazione fra prevalenza di diabete e una serie di indicatori demografici, sociali e relativi all’offerta assistenziale», spiega Antonio Nicolucci, Direttore di Coresearch. I dati relativi alla Città Metropolitana di Roma, infatti, documentano una marcata variabilità fra i Municipi nella prevalenza del diabete, che oscilla fra il 7,5 e l’11,2 per cento della popolazione residente di età maggiore o uguale a 35 anni, e che risulta fortemente associata alle caratteristiche sociodemografiche della popolazione residente. In particolare, si evidenzia una strettissima correlazione fra prevalenza del
diabete, disagio sociale e reddito medio per contribuente.
I dati sottolineano il ruolo fondamentale di un basso livello socioeconomico nel determinare la vulnerabilità dei cittadini che vivono nelle aree metropolitane. Inoltre, le aree a più alta prevalenza di diabete si caratterizzano per un minor indice di vecchiaia e per una minore prevalenza di ultrasessantacinquenni, nonostante l’età avanzata rappresenti di per sé un importante fattore di rischio per il diabete. «Evidentemente, il disagio sociale e i problemi economici sono responsabili di una più precoce insorgenza di diabete, verosimilmente associata all’adozione di stili di vita inappropriati - eccesso di alimentazione, consumo di cibi ad alto contenuto calorico e basso valore nutrivo, inattività fisica. Il quadro complessivo di fragilità che emerge è quello di famiglie con più componenti, con basso livello di scolarità, basso reddito, livelli elevati di disoccupazione e con un basso rapporto fra numero di anziani e soggetti di giovane età», commenta Nicolucci.
Inoltre, l’accessibilità alle cure sembra a sua volta avere un ruolo importante. Le aree a più bassa prevalenza di diabete sono caratterizzate da una maggiore disponibilità di medici di medicina generale e di strutture ospedaliere. «Questo dato, assieme al minor ricorso alle cure associato ad un basso stato socioeconomico, sottolinea l’importanza di ridurre le disuguaglianze nell’accesso all’assistenza come importante strategia per prevenire l’insorgenza del diabete, favorire una sua tempestiva diagnosi, e garantire alle persone con diabete cure adeguate, rivolte a prevenire le invalidanti complicanze della malattia. A questo fine, risulta importante garantire la disponibilità di reti assistenziali adeguate, in grado di assicurare la “medicina di prossimità” e di facilitare il raggiungimento delle persone più vulnerabili», dice ancora Nicolucci.
Tra le numerose analisi, indagini e ricerche di cui il rapporto Roma Cities Changing Diabetes 2021 è ricco, merita un cenno l’approfondimento sulla condizione delle persone con diabete e sul funzionamento dei servizi nell’area metropolitana
CITIES CHANGING DIABETES PERSONE CON DIABETE


di Roma a fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19, curato da Ketty Vaccaro, responsabile Area salute e welfare, Fondazione Censis. «Sono state analizzate la situazione vissuta da persone con diabete nell’area metropolitana di Roma e le difficoltà di gestione della malattia e di accesso alle cure dal punto di vista dei pazienti e degli operatori sanitari e la prefigurazione del nuovo assetto dei servizi nel post-Covid tramite interviste a pazienti, diabetologi, medici di medicina generale e infermieri che lavorano nei centri diabetologici», spiega Vaccaro.
Secondo i risultati dell’indagine, l’operatività consueta dei centri è quasi sempre cambiata: 1 paziente su 2 ha segnalato la sospensione delle normali visite di controllo, il 20 per cento ha affermato che erano state organizzate visite online e il 28 per cento ha evidenziato la predisposizione di telefonate di controllo; 1 su cinque ha però dichiarato di non aver fatto alcun controllo nel periodo di lockdown. Comunque, il 46 per cento ritiene di essere stato seguito anche se si è ridotto il numero di controlli e visite e nessuno ha interrotto il trattamento. «Tuttavia -sostiene Vaccaro- è evidente che l’assistenza garantita alle persone con Diabete ha subito l’impatto del Covid, come gli stessi operatori ammettono:
solo il 16 per cento di questi, a fronte del 20 per cento dei diretti interessati, pensa che i pazienti siano stati eseguiti esattamente come prima, mentre sia gli uni che gli altri, in poco meno di un caso su 3, ammettono che i pazienti hanno saltato i controlli e si sono affidati solo all’automonitoraggio».
Sono state valutate anche le attività per garantire in qualche forma la continuità del servizio, come ad esempio le visite a distanza. I pareri in merito dei pazienti risultano divisi tra chi le ritiene un’ottima soluzione da mantenere anche per il futuro (29,3 per cento) e chi pensa non abbiano lo stesso valore delle pratiche “normali ”, anche se accettabili come soluzioni di emergenza (32,8 per cento). Tra gli operatori sanitari, la metà le ritiene una soluzione di emergenza accettabile, ma senza lo stesso valore delle pratiche normali.
«Nella produzione, raccolta e valutazione di dati del progetto Roma Cities Changing Diabetes, ad oggi sono stati coinvolti oltre 140 esperti», dichiara Federico Serra, Direttore Italia Cities Changing Diabetes , che aggiunge «Alla fase di analisi ha fatto seguito quella più impegnativa di realizzazione di un Action Plan triennale, che indica possibili azioni da mettere in atto per arrestare lo sviluppo pandemico di obesità e diabete tipo 2 a Roma, la metropoli con il maggior numero assoluto, quasi 300 mila, di persone con diabete nel nostro Paese.»
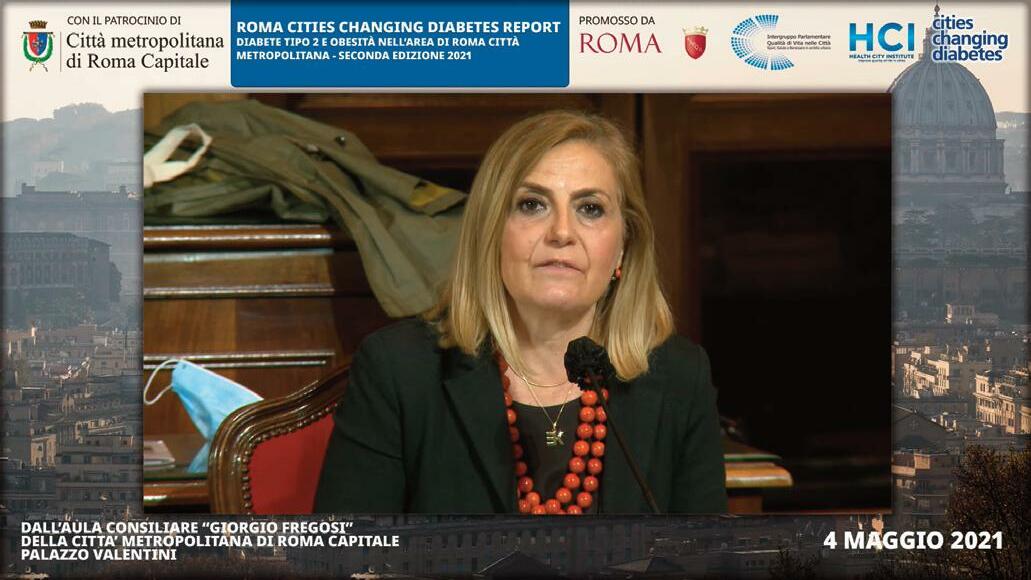
Una fase d’azione alla quale hanno pienamente aderito le Istituzioni, con la firma da parte della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, della Urban Diabetes Declaration, un impegno ad essere a pieno protagonista del programma mondiale Cities Changing Diabetes. La Sindaca Raggi, dal canto suo, ha sottolineato come il rapporto Cities Changing Diabetes contenga elementi, che servono per amministrare, «da studiare con attenzione per fare scelte oculate e precise.»
«È fondamentale identificare strategie efficaci per rendere consapevoli governi, regioni, città e cittadini dell’importanza della promozione della salute nei contesti urbani, guardando alla sempre maggiore urbanizzazione con uno sguardo innovativo, affrontando il carico di onerosità che le malattie croniche comportano, immaginando un nuovo modello di welfare urbano che necessariamente inciderà sullo sviluppo e sulla sostenibilità delle città, ma che non può che essere affrontato attraverso un maggiore coordinamento istituzionale. Il coinvolgimento dell’Italia e della città di Roma nel progetto Cities Changing Diabetes interessa non solo l’Amministrazione di Roma Capitale e della sua Città Metropolitana, ma stimola tutta l’Associazione dei Comuni italiani nella ricerca di soluzioni per migliorare la qualità di vita dei cittadini e delle persone con diabete” conclude Roberto Pella, co-Presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulla qualità della vita nelle città e Vice Presidente Vicario ANCI.

107
MILANO, METROPO
Con speranza di vita elevata, seconda solo a Firenze tra le metropoli italiane, prevalenza del diabete stabile nell’ultimo decennio e percentuali di adulti e minori con sovrappeso e obesità inferiori alla media nazionale, la Città metropolitana di Milano sembra godere di “buona salute”, secondo il Milano Cities Changing Diabetes Report 2021, realizzato nell’ambito del progetto internazionale Cities Changing Diabetes.
Speranza di vita elevata: 82,15 anni per gli uomini e 85,25 per le donne, seconda solo a Firenze tra le metropoli italiane; prevalenza del diabete pressocché stabile nell’ultimo decennio: da 5,65 casi per 100 residenti del 2010 a 5,68 casi del 2019, con un incremento di circa 0,03 casi ogni 100 residenti, a fronte di un aumento di quasi l’uno per cento in Italia; percentuali di adulti e minori con eccesso di peso che risultano inferiori alla media: 31,48 per cento rispetto a 36,66 nelle donne, 51,68 verso 55,56 negli uomini - in cui però il tasso di obesità, 12,08 per cento, risulta superiore al dato italiano di 11,13 per cento - infine 9,95 per cento tra le femmine dai 6 ai 17 anni e 9,05 per cento tra i maschi di pari età, rispetto alla media nazionale del 20,99 e 29,15 per cento ovvero rispettivamente circa la metà ed un terzo in meno. Sono alcuni dei dati, a prima vista positivi per la “salute” della Città metropolitana di Milano, che emergono dalla fotografia scattata dal Milano Cities Changing Diabetes Report 2021, che sarà questo pomeriggio in videoconferenza, documento realizzato e presentato nell’ambito del progetto internazionale Cities Changing Diabetes giorno 9 Maggio . «A Milano, - spiega Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute - in particolare, sono stati coinvolti Comune, Milano Città Metropolitana, Regione Lombardia, ANCI Lombardia e le Università cittadine, che hanno proceduto a mappare i fattori sociali e culturali, demografici, clinici ed epidemiologici, successivamente analizzati e valutati, anche sulla scorta delle esperienze già condotte a Roma e in altre 40 metropoli mondiali coinvolte nel progetto, per mettere a punto uno specifico action plan. Uno dei prodotti è, appunto, questo report, opera corale che nasce da più di 80 esperti di varia estrazione», prosegue.
Milano, metropoli della salute? «Potrebbe sembrare, ma attenzione non tutto è oro quel che luccica - dice Lenzi. I dati che fotografano puntualmente la situazione di Milano ci consegnano una situazione che fa emergere, ad esempio, le differenze di prevalenza di diabete tra distretti sanitari periferici e del centro cittadino, che impone una seria riflessione dal punto di visto sanitario, clinico e sociale. È allarmante
come a distanza di poche fermate di metropolitana l’aspettativa di vita disunisce e la prevalenza drasticamente aumenta ed emergono fenomeni di vulnerabilità sociale che vanno seriamente presi in considerazione.» Chiarisce Livio Luzi, Presidente del Comitato Scientifico di Milano Cities Changing Diabetes: «È un fatto noto che l’incremento della prevalenza del diabete sia dovuto anche a fattori sociali come livello di istruzione, accesso alle cure, risorse disponibili. Come peraltro già osservato a Roma, anche nell’area metropolitana di Milano c’è forte discrepanza tra centro e periferia in termini di reddito, percentuale di migranti, qualità di vita, alimentazione, sedentarietà e titolo di studio. Ed ecco che la prevalenza di diabete non è distribuita in maniera uniforme: va da un valore minimo del 5,24 casi per 100 residenti nella ASST Città di Milano fino ad un valore massimo di 6,75 casi nel territorio dell’ASST Nord Milano.»
“Questo report fornisce un’utile mappatura dello stato di salute attuale dei cittadini di Milano grazie alla partecipazione dei diversi partner territoriali. Su questi dati è possibile costruire un servizio di prevenzione e cura ancora migliore, evitare gli sprechi e concentrarsi in modo efficace sui bisogni reali dei cittadini. Quando un amministratore pubblico lavora su dati certi con competenza e in dialogo con gli specialisti, i risultati arrivano”, scrive nella sua prefazione al documento il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Quindi, in una metropoli come Milano, densamente popolata ed estesa, la parola chiave è: prevenzione; come sembra concordare, sempre in prefazione, l’Assessore al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti: “La diffusione di sovrappeso e obesità nelle diverse fasce della popolazione costituisce allo stesso tempo un fattore di rischio specifico e un obiettivo di sanità pubblica cruciale in ottica preventiva. Regione Lombardia, attraverso le proprie politiche di promozione della salute e i programmi preventivi coordinati nell’ambito del Piano regionale prevenzione, promuove l’attenzione e l’attivazione di tutti gli attori sociali su queste tematiche e coordina programmi intersettoriali che puntano
108
LI DELLA SALUTE?
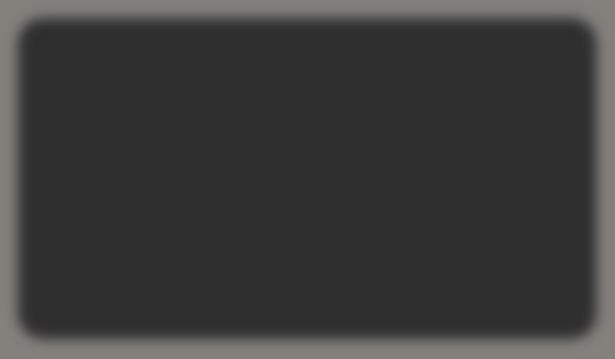

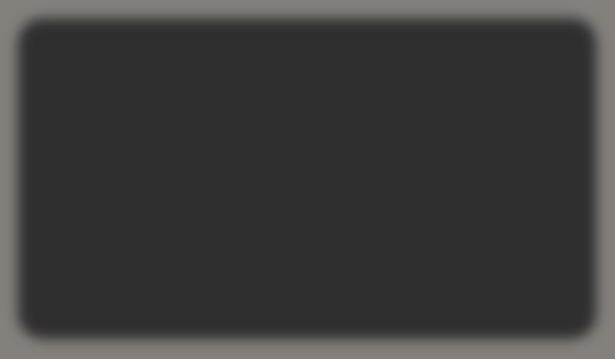
alla promozione di stili di vita sani nei diversi contesti di vita.”
“Il concetto di salute - scrive a sua volta Roberto Pella, Vicepresidente vicario di ANCI - è un elemento imprescindibile per il benessere di una società. Tale concetto non si riferisce meramente all’assenza di malattia, ma comprende gli aspetti psicologici, le condizioni naturali, ambientali, climatiche e abitative, la vita lavorativa, economica, sociale e culturale di ciascun individuo e delle nostre comunità. Spetta oggi ai Sindaci e alle amministrazioni locali e regionali, proporsi come garanti di una sanità equa, divenendo ideatrici di un nuovo paradigma di governance collaborativa dove istituzioni, imprese, organizzazioni della società civile e cittadini possano contribuire alla progettazione di un assetto urbano condiviso, sostenibile e armonico. Il coinvolgimento di Milano nel progetto Cities Changing Diabetes interessa, a livello territoriale, non solo l’amministrazione milanese bensì tutta l’aerea metropolitana, stimolando l’Associazione nazionale dei comuni italiani nella ricerca di soluzioni per migliorare la qualità di vita dei cittadini e delle persone con diabete.”
Infatti, una delle peculiarità della Città Metropolitana di Milano, rispetto ad altre metropoli, è proprio quella di avere una popolazione che per il 42 per cento è amministrata dal Comune di Milano e per il 58 per cento da 132 comuni limitrofi. «Ed è per questo motivo che, con il coordinamento dell’Università degli studi di Milano, è stato avviato, tra le amministrazioni comunali dell’area metropolitana lo sviluppo del Milano Cities Changing Diabetes Network, con l’obiettivo di stimolare una positiva interazione tra i vari enti, promuovere iniziative comuni e incentivare lo scambio di best practice», conclude Michele Carruba, Presidente del Comitato Esecutivo di Milano Cities Changing Diabetes. Ad oggi ne fanno parte, oltre a Milano, 36 comuni dell’hinterland, con una copertura del 68 per cento della popolazione residente, che hanno potuto confrontarsi in un primo incontro dedicato proprio al network lo scorso 29 aprile presso l’Università Statale.

109

110
FOCUS ON: SALUTE, BENESSERE, AMBIENTE, SPORT

111
“L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto”. Così esordì Robert Schuman all’indomani della Dichiarazione che porta il suo nome. Era il 9 maggio del 1950, data che segnò la creazione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), la prima pietra miliare che avrebbe poi condotto alla nascita dell’Unione europea. Quel giorno, a Parigi, l’allora ministro degli Esteri francese Schuman espose la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa che ancora faticava a risollevarsi dalle macerie della guerra. Dalla Dichiarazione Schuman il 9 maggio di ogni anno le Istituzioni europee celebrano la “Giornata dell’Europa”, organizzando visite, dibattiti, concerti e altri eventi per rendere omaggio e promuovere lo stile e i valori europei, in un’ottica di coesione e sviluppo. Quest’anno però la pandemia ha imposto limiti ai festeggiamenti, che si sono spostati così sul virtuale.
“In occasione della Giornata dell’Europa vorremmo estendere i nostri più sentiti auguri a tutti i cittadini europei. Questa Giornata dell’Europa è speciale. Per il secondo anno di fila, è celebrata in circostanze complesse a causa della pandemia di Covid-19. Siamo vicini a tutti coloro che ne hanno sofferto”. Inizia così la lettera ai cittadini europei che numerosi Capi di Stato dei Paesi Ue, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno rivolto ai cittadini alla vigilia della Festa d’Europa. Di fronte a una delle più gravi crisi della storia e alla più grave per una relativamente giovane Unione europea, ossia la pandemia da Covid-19, l’at-

tuale Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il 9 maggio ha scelto Firenze. Scelta storicamente ponderata per il suo messaggio forte di rilancio dell’Ue: l’Europa ha dimostrato una capacità di Rinascimento straordinaria, inaspettata. Ecco perché Firenze. Ecco perché il richiamo al Rinascimento dopo la tempesta Covid.
E qual è l’idea di Rinascimento della Presidente della Commissione Europea? Rinsaldare il patto inziale, rilanciare l’Ue facendo tesoro dell’esperienza pandemia, simile negli effetti alla Seconda Guerra Mondiale, dalle cui ceneri è nata l’Unione degli Stati del vecchio Continente. Basta ricordare Churchill, che non avrebbe mai approvato la Brexit: “Fare l’Europa è fare la pace. È far lavorare insieme gli uomini oltre ogni frontiera”. E proseguiva: “Di ideali la politica si nutre, ma poi ha bisogno di rotte, scelte, regole e Istituzioni comuni”. Ed ecco le vere esigenze del post Covid: rafforzare l’unità, cercando di eliminare egoismi nazionalisti. Non solo europei, addirittura globali, riguardo a Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo. Tra ricchi e poveri del Pianeta. In sintesi, il messaggio del 9 maggio 2021 da Firenze: “Senza alcuna competenza in materia di salute, in poco tempo, si sono adottate misure di emergenza impressionanti, sia per assicurare le forniture dei materiali necessari per proteggere e assistere, sia tenendo le frontiere interne aperte, sia raccogliendo i fondi necessari per lanciare il più vasto e cooperativo programma mondiale di ricerca sui vaccini, con un risultato conseguito in tempi record. E poi facendosi carico di coordinare gli acquisti dei vaccini per tutti, evitando una guerra disastrosa tra Paesi grandi e Paesi piccoli che sareb-
112
RINASCERE DAI VALORI COMUNI Celebrata la Giornata dell’Europa
di M. Papppagallo
bero stati esclusi, distribuendo in modo equo già oltre 200 milioni di vaccini all’interno dell’Ue. Ma anche, unico grande Paese al mondo, mantenendosi aperta al pianeta: altri 200 milioni di vaccini prodotti sul suolo europeo sono stati esportati nel mondo intero. L’Ue è diventata il principale finanziatore del meccanismo internazionale COVAX, per la distribuzione dei vaccini ai Paesi più poveri del mondo”. E poi, “l’Ue ha rotto tutti i tabù della sua recente storia, facendo ricorso al debito comune per finanziare il più gigantesco Piano di ripresa e resilienza della sua storia, con 750 miliardi non destinati a riparare, ma ad accelerare gli investimenti per la trasformazione dell’Europa, per garantire le prossime generazioni. Per accompagnare le transizioni ecologica, energetica, digitale, industriale e demografica del continente. E assumendo una leadership mondiale in tema di lotta ai cambiamenti climatici, oggi raggiunta finalmente dagli Stati Uniti di Biden. L’Europa è da sempre una storia di nuovi inizi. Questo è il vero Rinascimento europeo, basato sulla forza di quella visione e quel metodo di ieri, con rinnovata immaginazione, audacia, empatia, compassione, intelligenza emozionale, capacità di rischiare insieme e di osare la speranza di un comune destino”. Il Rinascimento Ue auspicato da Ursula von der Leyen è, letteralmente, in linea con spirito e lettera della Dichiarazione Schuman. C’è anche un messaggio ecumenico della von der Leyen, un richiamo a don Milani nel rilanciare l’anima europea. L’anima di chi sceglie il Bene. “Oggi l’Ue vuole prendersi cura dei propri vicini, dei più fragili, del nostro pianeta, delle future generazioni. L’Ue in questa pandemia ha saputo rideclinare in modo forte il suo ‘A qualunque costo’, per curare e proteggere, per ricostruire e rilanciare una Europa solidale, intraprendente e sostenibile”.
E Mario Draghi, nostro attuale premier, da Roma ha sottolineato “le azioni necessarie perché vaccini sicuri possano essere messi a disposizione del mondo intero (almeno 20 miliardi di vaccini all’anno), anche attraverso la sospensione temporanea dei diritti di brevetto”. Misure poi discusse, anche per i farmaci, nel Summit globale di Roma svoltosi a fine maggio. Sul tavolo del Rinascimento c’è anche uno dei dossier tutt’ora più divisivi e irrisolti, quello delle migrazioni e dell’asilo: occorre un Next Migration Ue. Che dimostri che una grande Unione di democrazie sa decidere, proteggere e rispettare i propri valori. Tema per ora rinviato. Ricordando però i due concetti fondamentali di tutta la costruzione eu-
ropea: la solidarietà obbligatoria (Schuman la chiamava di fatto) e la responsabilità condivisa. E infine nell’investimento sul rinnovamento democratico. Il 9 maggio di quest’anno, si è aperta ufficialmente a Strasburgo la Conferenza sul futuro dell’Europa. Un primo grande esercizio di democrazia partecipativa su scala continentale, ove le tre Istituzioni si sono impegnate a dare la parola ai cittadini, alle forze sociali ed economiche ai territori, per un grande esercizio di ascolto e di proposte per fare e riformare l’Europa di domani. Tornando alle origini Ue, nel dopo Seconda Guerra Mondiale, lasciamo le conclusioni a Simone Veil, riportando ciò che disse quando l’Ue fece i primi passi: “La sola cosa che ha riabilitato gli europei in questo barbaro XX° secolo è stato fare l’Europa. Questa pace non è mai acquisita per sempre. La democrazia neppure. Bisogna sempre essere vigilanti per difenderla”.
113
Giornata della Terra: un impegno comune per il futuro del pianeta
La Giornata della Terra, l’Earth Day, è il nome usato per indicare il giorno in cui si celebra in tutto il mondo l’ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra.

Quest’anno il 22 aprile i Capi dei governi di tutto il mondo si sono ritrovati per celebrare la sfida comune alla sostenibilità ambientale.

“Combattendo i cambiamenti climatici vedo l’occasione di creare milioni di posti di lavoro. È il decennio decisivo per evitare le conseguenze peggiori: dobbiamo agire. Questo vertice è il primo passo del cammino che dobbiamo fare insieme”, ha affermato il presidente Usa Joe Biden dalla East Room della Casa Bianca avviando i lavori del vertice dei leader mondiali sul clima, in una discontinuità di visione con il suo predecessore.
“Innanzitutto voglio ringraziare il presidente Biden”. Il suo è “un totale cambio” di politica sull’ambiente “e abbiamo fiducia sul fatto che insieme possiamo vincere questa sfida”, ha detto il premier Mario Draghi intervenendo al summit.
“L’Italia è un Paese bellissimo ma molto fragile. La battaglia per il cambiamento climatico è una battaglia per la nostra storia e per il nostro paesaggio. Ci dedicheremo alla sostenibilità e, allo stesso tempo, avremo un approccio multilaterale”. “Come presidenza del G20 uno degli obiettivi principali è poter prendersi cura del Pianeta” Come G20 “abbiamo una responsabilità speciale per far sì che potremo raggiungere gli obiettivi degli Accordi di Parigi. La presidenza italiana ha proposto di organizzare una riunione ministeriale sul clima e l’energia”. “Mentre lottiamo contro la pandemia non possiamo dimenticare le altre crisi” come quella del clima. “Dobbiamo cambiare il modo di lavorare e dobbiamo farlo rapidamente. Il Piano per la Ripresa dalla pandemia ci offre un’opportunità unica, quella di trasformare le nostre economie e realizzare un’economia più verde e inclusiva. Il nostro obiettivo è sostenere la transizione sostenibile in Europa e fare in modo che l’Ue raggiunga la
neutralità climatica per il 2050”. “Con gli accordi di Parigi ci siamo impegnati a ridurre il riscaldamento globale di 1,5 gradi centigradi, a livelli preindustriali” ma “quello che abbiamo fatto è insufficiente”. “In Europa abbiamo lanciato un piano da 750’ miliardi di euro, chiamato Next Generation Ue. Uno degli obiettivi del Piano è supportare la transizione ambientale in Europa. Il 10% del piano europeo, circa 70 miliardi di euro, andrà in investimenti in infrastrutture green, economia circolare e mobilità sostenibile solo in Italia”, spiega il capo del governo.
Ma un ruolo fondamentale lo giocheranno i sindaci di tutto il mondo se riusciranno a rendere le loro città a zero emissioni.
Più di 125 sindaci di 31 paesi si sono impegnati a intraprendere le azioni urgenti necessarie per affrontare la crisi climatica. Le città, tra cui Bangkok, Thailandia; Chuncheon-si, Corea; Miami Beach, USA; Mumbai, India; e Rabat, in Marocco, si sono impegnati ad attuare azioni immediate che forniranno il loro impegno nella riduzione dei gas serra necessaria per dimezzare le emissioni entro il prossimo decennio e raggiungere zero emissioni nette di carbonio a livello globale entro il 2050.
Gli impegni della città sono stati condivisi dal sindaco di Los Angeles e presidente di C40 Cities, Eric Garcetti, durante un incontro tra i sindaci e il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. L’incontro è stato convocato per discutere il ruolo vitale delle città nel fornire riduzioni delle emissioni, garantire una ripresa verde e giusta alla crisi del COVID-19 e nel dimostrare ciò che i leader politici impegnati a ogni livello di governo possono fare per aumentare l’ambizione climatica credibile e le azioni future della COP26.
96 città hanno preso questo impegno attraverso la Dichiarazione di Parigi, uno sforzo lanciato dal sindaco di Parigi Anne Hidalgo nel dicembre 2020 in occasione del quinto
114
I Governi e oltre 700 città in 53 Paesi si sono ora impegnate a dimezzare le emissioni entro il 2030 e raggiungere lo zero emissioni entro il 2050
anniversario dell’accordo di Parigi. Il numero totale di città impegnate a raggiungere lo zero assoluto attraverso la campagna Cities Race to Zero è ora pari a 70.
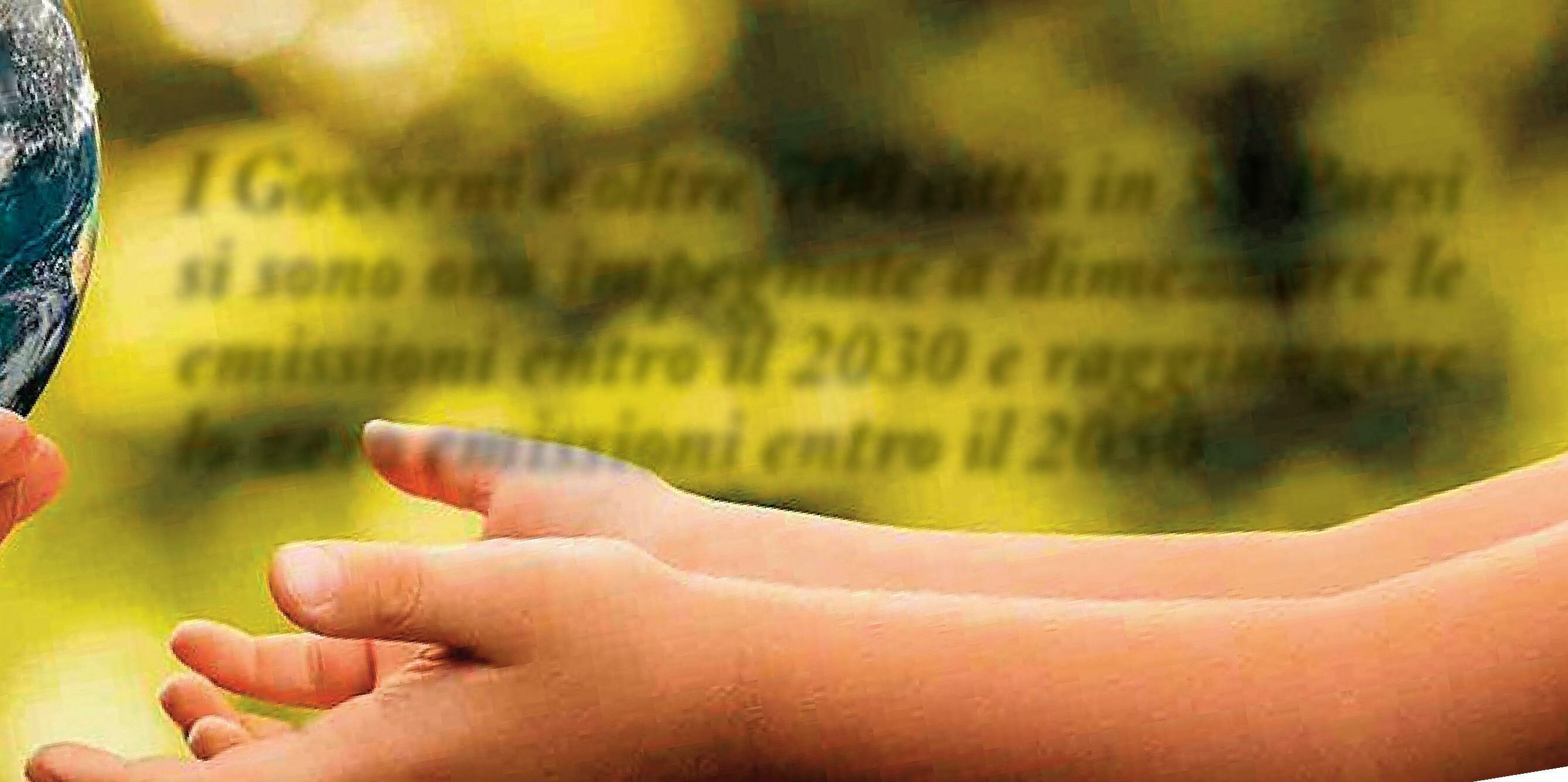

Questo annuncio arriva in un momento critico in cui i paesi dovrebbero presentare nuovi e più ambiziosi piani sul clima prima della COP26 e i capi di Stato delle principali economie sono stati invitati a presentare le loro ambizioni al vertice sul clima ospitato dal presidente degli Stati Uniti Biden lo scorso 22 aprile. Il numero crescente di città impegnate a raggiungere le emissioni nette di carbonio zero entro il 2050 in Paesi come Giappone, India, Australia e Stati Uniti, fa parte di una coalizione globale in crescita per lo zero assoluto che dovrebbe guidare lo slancio necessario per i Paesi per ridurre drasticamente le emissioni entro il 2030.
“Il cambiamento climatico è una crisi che si estende oltre i confini municipali o nazionali - e può essere risolta solo dal potere collettivo di una coalizione globale”, ha detto il presidente del C40 e sindaco di Los Angeles Eric Garcetti. “Race to Zero” sta già galvanizzando le città di tutto il mondo per aumentare le loro ambizioni climatiche, assumere nuovi impegni per proteggere il nostro pianeta e gettare le basi per un futuro più giusto, sostenibile e resiliente”. “E’ un ottima notizia che altre 96 città hanno firmato la Dichiarazione di Parigi e si stanno unendo alla campagna Cities Race to Zero. C’è un chiaro slancio: le città sono attivamente impegnate a proteggere il nostro pianeta, affrontare i cambiamenti climatici e preservare la nostra biodiversità”, ha detto Anne Hidalgo, sindaco di Parigi ed ex presidente del C40. “E maggiore sarà il numero di città coinvolte e prima saremo in grado di agire. Ecco perché ho invitato il Segretario generale delle Nazioni Unite a sollecitare i governi a dare maggiore considerazione alle città nei loro piani di stimolo alla ripresa. Perché sono fondamentali per rispettare gli impegni degli obiettivi dell’accordo di Parigi e costruire un’economia più equa che rispetti il nostro bene comune “.
“La pandemia COVID-19 è una catastrofe globale. Ma investire nella ripresa è un’opportunità generazionale per mettere l’azione per il clima, l’energia pulita e lo sviluppo sostenibile al centro delle strategie e delle politiche delle città “, ha affermato il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. “Il modo in cui progettiamo la generazione di energia, i trasporti e gli edifici nelle città - il modo in cui progettiamo le città stesse - sarà decisivo per mettersi sulla buona strada per raggiungere l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Abbiamo bisogno di una rivoluzione nella pianificazione urbana e nella mobilità urbana: inclusa una migliore efficienza del carburante; veicoli a zero emissioni; e una mobilità che punti sulla città pedonabili, sull’uso della bici, su una mobilità leggera. Le città trarranno il massimo vantaggio dall’eliminazione graduale del carbone: aria pulita; spazi verdi vivibili; persone più sane. Molti dei vostri residenti stanno soffrendo e muoiono prematuramente a causa dell’inquinamento da carbone in diverse città del mondo “.
“In tutto il mondo, i leader delle città stanno combattendo la crisi climatica con crescente urgenza e ambizione - ed è incoraggiante vedere ancora più città ufficialmente unirsi a loro in quella battaglia oggi”, ha affermato Michael R. Bloomberg, fondatore di Bloomberg Philanthropies, Ambasciatore globale delle Nazioni Unite per Race to Zero and Race to Resilience, e l’inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per l’ambizione e le soluzioni climatiche. “La Race to Zero può essere una vittoria, perché i leader locali continuano a pensare in grande e ottenere risultati dal basso verso l’alto, ma c’è ancora molto lavoro da fare.”
Uno sforzo e impegno riconosciuto anche dal Presidente Biden che ha detto “Stiamo finalmente assistendo a un cambiamento: i leader nazionali stanno riconoscendo la portata dell’emergenza climatica e si stanno muovendo verso l’azione urgente necessaria per evitare gli impatti catastrofici all’orizzonte.”
115
IN ASIA SI GIOCALA PARTITA DE
Per il Rapporto “Environmental Risk Outlook 2021” le città asiatiche sono le più vulnerabili ai rischi ambientali
Delle 100 città del mondo più vulnerabili ai rischi ambientali, tutte tranne una si trovano in Asia e l’80% si trova in India o in Cina, secondo una valutazione del rischio elaborata a livello internazionale.
Una vulnerabilità urbana amplificata in tema di salute anche dall’emergenza dovuta al COVID-19 e che pone serie considerazioni anche in tema di globalizzazione e sicurezza.
Il rapporto “Environmental Risk Outlook 2021” appena pubblicato da Verisk Maplecroft, società globale di consulenza strategica e di rischio con sede a Bath, nel Regno Unito, ha rilevato il rapporto che più di 400 grandi città con una popolazione totale di 1,5 miliardi di abitanti sono a rischio “alto” o “estremo” a causa di un mix di inquinamento che ha un impatto sull’aspettativa di vita, la scarsità delle riserve idriche, le ondate di caldo spesso mortali, disastri naturali ed emergenza climatica, Giacarta, capitale dell’Indonesia, è afflitta da inquinamento, inondazioni e ondate di caldo, ed è in cima alla classifica. Ma l’India, che ospita 13 delle 20 città del mondo più a rischio, potrebbe dover affrontare il futuro più scoraggiante di qualsiasi altro Paese. Delhi è al secondo posto nell’indice globale di 576 città, seguita in India da Chennai (3a), Agra (6a), Kanpur (10a), Jaipur (22a) e Lucknow (24a) e Mumbai, con una popolazione di 12,5 milioni di abitanti, è la 27esima.
Guardando solo all’inquinamento atmosferico - che causa più di 7 milioni di morti premature in tutto il mondo ogni anno, di cui un milione nella sola India - le 20 città con la peggiore qualità dell’aria nelle aree urbane di almeno un milione di persone sono tutte in India, con Delhi in cima all’elenco.
La valutazione dell’inquinamento atmosferico è stata ponderata rispetto all’impatto di particelle microscopiche dannose per la salute note come PM2,5, dovute in larga misura alla combustione di carbone e altri combustibili fossili.
Al di fuori dell’Asia, il Medio Oriente e il Nord Africa hanno la percentuale più alta di città ad alto rischio in tutte le categorie di minacce, con Lima l’unica città non asiatica nella Top 100.
“Sede di oltre la metà della popolazione mondiale e motore chiave della ricchezza, le città sono già sottoposte a gravi pressioni a causa della pessima qualità dell’aria, della scarsità d’acqua e dei pericoli naturali”, ha affermato l’autore prin-
cipale del rapporto, Will Nichols. “In molti paesi asiatici questi hub diventeranno meno ospitali con l’aumentare della pressione demografica e il cambiamento climatico amplifica le minacce dell’inquinamento e delle condizioni meteorologiche estreme, minacciando il loro ruolo di generatori di ricchezza per le economie nazionali”.
La Cina, sebbene più ricca dell’India, deve affrontare anche formidabili sfide ambientali. Secondo il rapporto, delle 50 città del mondo più colpite dall’inquinamento idrico, 35 sono in Cina.
Ma diversi sistemi politici e livelli di sviluppo possono giocare a favore della Cina, ha detto Nichols. “Per la Cina, una classe media emergente richiede sempre più aria e acqua più pulite, il che si riflette negli obiettivi del governo”, ha detto. “La struttura di governance dall’alto verso il basso della Cina - e la volontà di adottare misure brusche, come la chiusura delle fabbriche per raggiungere gli obiettivi di emissionioffre maggiori possibilità di mitigare questi rischi”.
La governance più debole dell’India, insieme alle dimensioni e alle dimensioni della sua economia informale, rende molto più difficile affrontare i problemi ambientali e climatici a livello di città, ha aggiunto.
Quando si parla di riscaldamento globale e dei suoi effetti, l’attenzione invece si sposta nettamente sull’Africa subsahariana, sede di 40 delle 45 città più vulnerabili al clima del pianeta. Il continente sarà quello più colpito non solo a causa di siccità, ondate di caldo, tempeste e inondazioni, ma anche perché è impreparato per far fronte a questa emergenza.
“Le due città più popolose dell’Africa, Lagos e Kinshasa, sono tra quelle a più alto rischio”, osserva il rapporto. Altre città particolarmente vulnerabili includono Monrovia, Brazzaville, Freetown, Kigali, Abidjan e Mombasa.
L’indice climatico combina la minaccia di eventi estremi, la vulnerabilità umana e la capacità di adattamento dei Paesi. Il rapporto è il primo di una serie di valutazioni del rischio per le città e valuta le minacce alla vivibilità delle città e delle Nazioni e il grado di sostenibilità ambientale.
L’analisi redatta dal rapporto “Environmental Risk Outlook 2021” pone una serie di riflessioni alle aziende e agli investitori spesso concentrate su asset di tipo materiale e che sono invece invitate a considerare altre tipologie di rischi, connessi all’ambiente e al clima.
116
Environm Risk ental
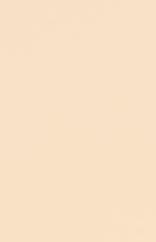

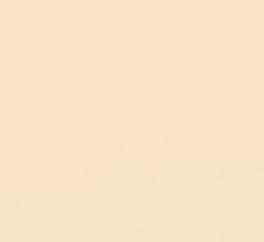

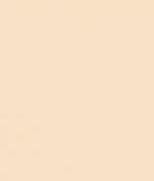


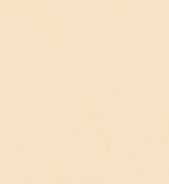
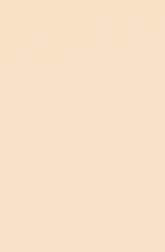

LLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
NEXT GENERATI SCELTI I 10 COMU
Al via il progetto Anci “MediAree – Next Generation City” finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in qualità di Organismo Intermedio, con i fondi del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
Il progetto durerà tre anni e ha l’obiettivo di supportare i Comuni capoluogo nella costruzione delle città del domani, dal punto di vista amministrativamente, sul miglioramento delle competenze, dei processi e degli strumenti di pianificazione strategica sovra-comunale al fine di sviluppare strategie e politiche urbane nell’ottica della transizione ambientale e della sostenibilità.
La proposta progettuale prevede:
• un’analisi territoriale di area vasta e dei servizi già erogati dai singoli comuni integrata dalla raccolta e sistematizzazione dei dati rilevanti e delle opportunità esistenti;
• la formazione e affiancamento del personale dei comuni, il coordinamento delle procedure, l’incontro e ascolto dei beneficiari finali e la co-progettazione congiunta di una visione di Next Generation City per il pordenonese, della strategia di medio periodo e di un numero minimo di progetti strategici;

• l’analisi di fattibilità di uno spazio dedicato al coordinamento delle azioni dei comuni dell’area vasta per i giovani
• la realizzazione di un documento metodologico degli strumenti di monitoraggio più appropriati;
• una serie di prodotti comunicativi pensati da giovani per i giovani e che includono anche l’evento di presentazione del progetto.
I risultati attesi comprendono una migliore capacità dei comuni di raccogliere e gestire dati disponibili di area vasta, al fine di poter intervenire in modo informato e con strumenti e metodi innovativi e procedure collaborative, per soddisfare le aspirazioni dei giovani residenti, in termini di opportunità di formazione, opportunità lavorative, ma anche qualità della vita e l’individuazione di una visione di Next Generation City, al fine di rendere i territori dell’area vasta dei luoghi di elezione da parte dei giovani residenti.
I dieci comuni pilota scelti sono: Avellino, Brindisi, Campobasso, Latina, Nuoro, Pordenone, Rimini, Siena, Siracusa e Treviso. Sono stati individuati in base alla qualità dei progetti candidati e alla ripartizione geografica riferita alle Regioni sviluppate, a quelle in transizione e a quelle definite in ritardo.
“Sono i Comuni i naturali protagonisti del rilancio che vogliamo per il Paese. E dai Comuni non si può prescindere se si vogliono mettere le basi di una rinascita. Ma per affrontare questo grandissimo impegno, servono strumenti, è necessario affinare la capacità di pianificazione strategica, modernizzare le competenze, fluidificare i processi”, rimarca il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. “Il progetto MediAree – prosegue – mira esattamente in quella direzione: sostenere i Comuni, attraverso l’Anci che supporta sempre noi amministratori locali, per guardare al futuro con determinazione e forti di competenze rafforzate”.
L’Anci garantirà ai Comuni selezionati un supporto personalizzato con attività di consulenza e affiancamento da parte del proprio personale interno, di società e centri di consulenza. Previsti inoltre percorsi di formazione specialistica rivolta al personale dei Comuni capoluogo, dei Comuni partner e ai soggetti del territorio coinvolti nel progetto. Non mancherà il supporto logistico e organizzativo, ove necessario, per la realizzazione di incontri territoriali in presenza e a distanza.
118
ON CITY: UNI ITALIANI

119
Dallo spago al digital… Che turismo ci attende,
Marco Benedetti
CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali
Ho sempre amato viaggiare, da solo come in compagnia, decidendo la sera prima guardando solo se il passaporto fosse scaduto o programmando ogni dettaglio mesi prima, con pandemia in situ o esportata…
In attesa di partire scendo spesso in magazzino dove, insieme a zaini, trolley e valigie, trovo una delle mie bici da corsa, telaio in acciaio (11 kg circa). Sotto la sella, insieme ai ferri e alla camera d’aria di scorta, c’è un pezzo di spago, sottile e leggero, di color grigio. Lo avevo tagliato ( in gran segreto ) lungo 100 cm. dal gomitolo che tenevamo in cucina per legare l’arrosto, gli anni in cui Bernard Hinault dominava Tour e Giro. 100 cm tondi tondi che mi servivano per tracciare (rigorosamente in linea retta) gli itinerari sul poster dell’Italia in scala 1:1.000.000 che tenevo appeso in camera mia e all’occasione staccavo con grande cura, ripiegandolo e infilandolo sulla busta impermeabile fissata sul manubrio. 1 cm sulla carta, 10 chilometri da pedalare, mezzo spago per arrivare a Roma da Venezia, tutto lo spago quasi mille chilometri di fatica per arrivare giù giù fino a Santa Maria di Leuca, con sempre di mezzo gli Appennini e le borracce d’acqua che non bastavano o non erano mai abbastanza fresche.
Questo lo spazio da esplorare, poi il tempo, dividendo quello spago in 2, 5, 7 o più tappe tra 110 e 150 km/giorno a seconda del viaggio e del budget. Dietro la sella, su un portapacchi in alluminio a sbalzo, uno zaino da 8 kg, sufficiente con il bel tempo e senza troppa pioggia per starsene in giro anche una settimana (ovviamente senza i figli). Ostia-Venezia, Venezia-Vienna, Venezia-Piombino-Elba-CorsicaGenova-Venezia, poi i Balcani e altri itinerari…
Trent’anni dopo quello spago può tornare in cucina per il prossimo arrosto (la mascherina no, almeno per ora…) e Jovanotti, in pieno lockdown, ci fa sentire stranamente scomodi sul divano di casa mentre lo seguiamo nella sua avventura da bikepacker pedalando per 4.000 chilometri tra Cile e Argentina (20 kg il suo bagaglio).
Questo per dire che oltre a Jovanotti, sono migliaia di italiani che stanno cercando di capire quale possa essere la vacanza perfetta, chi convertendosi al cicloturismo in completa libertà, grazie a cartografia dedicata, guide, tracce digitali e/o spaghi per programmare in sicurezza il viaggio, chi cercando nuove formule alla moda o antiche certezze, magari reinterpretate alla luce di quanto ci sta coinvolgendo.
Tra spago e digital quello su cui siamo chiamati a scegliere e se questa estate vorremo essere moderni o alla moda?
Sul come fare questa scelta, mi sta aiutando la lettura di un recente saggio di Einaudi intitolato appunto “La moda della vacanza” in cui si comprendono le evoluzioni storiche del turismo e di come si sono costruite, dal 1860 al 1939, i differenti canoni di gusto, le dinamiche di relazione, strutture funzionali a soddisfare aspettative del tutto nuove, nel rispetto di standard adeguati che a inizi Novecento sancivano il passaggio dalle ferie nella casa di campagna (con una mondanità raccolta ed esclusiva, oggi diremmo “bolla”) ai grandi hotel, aperti ad una clientela colta e cosmopolita (a cui oggi chiederemo passaporto vaccinale o tampone).
Aggiungi le premesse di distanziamento sociale, e risulterà fortemente competitivo il turismo outdoor, pianificando il miglior itinerario su carta ed in digitale, la giusta attrezzatura per budget e durata del viaggio, senza trascurare la corretta alimentazione e preparazione psicofisica.
Un turismo attivo che, secondo la rivista Lancet, abbinato all’attività fisica fa bene e farà lavorare meglio al ritorno: solamente in Italia ridurrebbe i costi sanitari diretti del 57% (stimati in 0.9 miliardi di euro dovuti a stili di vita sedentari) e aumenterebbe la produttività generando una ricchezza di 0.5 miliardi di euro. Se grazie ad una vacanza outdoor i cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i 20 e i 74 anni si convincessero ad andare in bici o a camminare anche solamente 15’ al giorno in più una volta tornati a casa, si potrebbero prevenire 100.000 morti premature all’anno (vedi “Europe needs a plan to increase active living for health and wellbeing”, 2019, EPSI).
Sorridendo, celerò il mio colpevole ritardo organizzativo cercando di preparare per cena un arrotolato reso almeno decente dal rosmarino profumato raccolto a Sant’Erasmo e, bofonchiando me la caverò con:
120
“Dove andremo ancora non lo so, ma come torneremo sì: moderni…”
moderno o alla moda?

121
HEALTH CITY MANAGER
A BARI, BOLOGNA, TORINO CONCLUSA LA PRIMA EDIZIONE DEL CORSO
Un profilo professionale innovativo, essenziale per guidare le città verso un modello di “Health City”, accrescendo così la capacità amministrativa degli Enti e contribuendo a elaborare soluzioni nuove e inclusive per rispondere alle istanze di salute e benessere dei cittadini, tanto più centrali nell’attuale fase di ridisegno dopo l’emergenza sanitaria. Questo lo spirito e l’obiettivo che hanno caratterizzato il percorso di alta formazione per Health City Manager, articolato in dieci moduli e ottanta ore di lezione in videoconferenza a distanza, conclusosi con un weekend residenziale nelle città ospitanti – Bari, Bologna, Torino – durante il quale i partecipanti hanno avuto modo di conoscersi e confrontarsi sull’esperienza, di svolgere il test finale e di presentare il project work ai fini dell’assegnazione delle borse lavoro e delle borse di studio da parte di ANCI.

I partecipanti hanno profili elevatissimi ed estremamente variegati: non solo medici, ma sociologi, progettisti, esperti di comunicazione e amministratori locali, molti dei quali con percorsi formativi ed esperienze già importanti sul tema della salute pubblica e nei contesti dei Comuni ospitanti. I primi otto di ogni graduatoria finale avranno ora la possibilità di svolgere un periodo di quattro mesi di lavoro presso le tre città per progetti mirati sul territorio metropolitano
oppure di partecipare, sostenuti da una borsa di studio, a una nuova esperienza formativa di specializzazione in tema di urban health.
La cerimonia di consegna degli attestati è prevista a Roma, nel mese di luglio, alla presenza di Roberto Pella, Vicepresidente vicario ANCI e delegato a Sport, Salute, Politiche giovanili; Enzo Bianco, Presidente del Consiglio Nazionale ANCI e Presidente C14+; Antonella Galdi, Vice Segretario Generale ANCI; Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute; Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice dell’Università “La Sapienza” di Roma; Fabiana Dadone, Ministra per le Politiche giovanili. Sarà l’occasione per svolgere anche un bilancio di questa prima esperienza e, stante l’alto interesse suscitato dall’iniziativa e il gradimento manifestato dai partecipanti, per proporre di organizzare una nuova edizione del corso per il prossimo autunno.
I corsi, che hanno preso avvio lo scorso 23 aprile dalla città di Bari, sono stati strutturati in base ai moduli formativi previsti dal core curriculum dell’Health City Manager (pubblicato su Actabiomedica a maggio 2020, rif.: New competences to manage urban health: Health City Manager core curriculum, Acta Biomed 2020; Vol. 91, Supplement 3: 21-28 DOI: 10.23750/abm.v91i3-S.9430):
122
GRADI DI APPRENDIMENTO
Grado di conoscenza
Superficiale: lo studente ne ha sentito parlare
Generale: lo studente sa inquadrare l’argomento all’interno delle conoscenze complessive
Particolareggiata: lo studente deve conoscere l’argomento in modo esauriente in relazione alle sue necessità formative
Grado di competenza
Mnemonica: lo studente ricorda quanto ha appreso
Interpretativa: lo studente sa applicare quanto ha appreso per interpretare dati o fenomeni, relativi a un contesto cui ha assistito o a un problema che ha visto affrontare e risolvere da altri
Decisionale: lo studente sa applicare quanto ha appreso per risolvere personalmente problemi e assumere decisioni autonome
Grado di abilità
Non richiesta: lo studente non deve applicare la conoscenza o competenza Generale: lo studente sa svolgere l’attività in collaborazione Autonoma: lo studente deve svolgere l’attività in autonomia
HEALTH CITY MANAGER – CORE CURRICULUM
OBIETTIVO ATTIVITÀ CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ
1. Salute e politiche urbane pubbliche; nuovi modelli di governance, multilivello e multidisciplinari
• Saper analizzare il contesto urbano in ottica di salute
• Impegnare le amministrazioni locali nella promozione della salute dei cittadini studiando e monitorando i determinanti della salute specifici del proprio contesto urbano, facendo leva sui punti di forza delle città e riducendo drasticamente i rischi per la salute
• Coinvolgere i cittadini nelle scelte secondo l’approccio “la salute in tutte le politiche”, anche attraverso il metodo delle community-based survey in grado di avvicinare il decisore alle necessità dei cittadini
• Promuovere modalità di partenariato pubblico-privato per la realizzazione delle politiche e delle conseguenti azioni strategiche
• Saper comunicare la salute come paradigma d’interpretazione di tutte le politiche, verso l’esterno e all’interno dell’Ente per poi attivare processi di disseminazione
123
Si è conclusa la formazione per Health City Manager dei 120 giovani under 35 che hanno partecipato alla prima edizione del corso promosso da ANCI con Health City Institute, co-finanziato dal Ministero per le politiche giovanili.
GENERALE INTERPRETATIVA NON RICHIESTA PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE AUTONOMA GENERALE INTERPRETATIVA GENERALE PARTICOLAREGGIATADECISIONALE AUTONOMA PARTICOLAREGGIATADECISIONALE AUTONOMA
OBIETTIVO ATTIVITÀ
2.
Alfabetizzazione e accessibilità all’informazione e all’educazione sanitaria, anche in ambito scolastico
• Promuovere percorsi formativi a livello regionale o locale indirizzati agli operatori socio-sanitari, alle professioni sanitarie e alle associazioni dei pazienti per permettere loro di valutare il grado di comprensione del cittadino ed esprimersi di conseguenza con linguaggio compatibile ed efficace
• Permettere ai cittadini, ai pazienti e alle loro associazioni di comunicare agevolmente e tempestivamente con il sistema sanitario, potendo trovare, comprendere e valutare le informazioni di volta in volta più appropriate per soddisfare i propri bisogni assistenziali, anche attraverso lo sfruttamento delle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali
• Promuovere e consolidare la collaborazione tra ambito sanitario, ambito dell’istruzione e comunità locali
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ
GENERALE INTERPRETATIVA GENERALE
3.
Stili di vita sani nei luoghi di lavoro, nelle grandi comunità e nelle famiglie, con focus sull’accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini
• Diffondere in modo capillare buone pratiche per la promozione della salute nei luoghi di lavoro e rafforzare il sistema di incentivi rivolto alle imprese socialmente responsabili che investono in sicurezza e prevenzione
• Garantire a tutti i cittadini il libero accesso alle infrastrutture e agli spazi verdi, con particolare attenzione alle persone in difficoltà socio-economica secondo il principio dello “Sport di Cittadinanza” e all’attività fisica diurna condotta negli spostamenti urbani (percorsi casa, lavoro, scuola)
• Ipotizzare nuove modalità per tutelare la solidarietà tra le generazioni, attraverso lo strumento del gioco e più in generale della cultura/bellezza, migliorando l’inclusione nelle città delle persone anziane e vulnerabili e favorendo un invecchiamento attivo
• Incentivare l’attività sportiva e motoria per i bambini e per i giovani, in contrasto al fenomeno del drop out adolescenziale, anche tramite il coinvolgimento attivo delle famiglie
GENERALE DECISIONALE AUTONOMA
4. Cultura alimentare e nutrizionale
• Delineare linee guida che tengano conto dei diversi contesti e dei diversi target della popolazione (menu scolastici e/o aziendali appropriati)
• Organizzare eventi divulgativi e progetti di educazione alimentare sul territorio (Orti della Salute, Spreco Zero)
PARTICOLAREGGIATA INTERPRETATIVA NON RICHIESTAA CARICO DEL DECISORE POLITICO
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE AUTONOMA
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE AUTONOMA IN INTERAZIONE CON DECISORE POLITICO
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE AUTONOMA IN INTERAZIONE CON DECISORE POLITICO
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE AUTONOMA IN INTERAZIONE CON DECISORE POLITICO
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE AUTONOMA
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE AUTONOMA
124
OBIETTIVO ATTIVITÀ
5 Management e sostenibilità economica dei progetti
• Stabilire metodo e condividere elementi base per il ragionamento e il calcolo matematico al fine di saper selezionare il dato significativo e consultare le banche dati disponibili
• Valutare e controllare l’impatto economico e l’indice di resilienza delle attività proposte, sapendo gestire le esternalità dovute alle scelte
• Definire uno o più scenari alternativi da sottoporre al decisore, dando forza alle specificità locali e tenendo in considerazione le risorse disponibili in coerenza con il bilancio dell’Ente
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ
PARTICOLAREGGIATA INTERPRETATIVA NON RICHIESTA
A CARICO DEL DECISORE POLITICO
PARTICOLAREGGIATA INTERPRETATIVA NON RICHIESTA A CARICO DEL DECISORE POLITICO
PARTICOLAREGGIATA INTERPRETATIVA NON RICHIESTA A CARICO DEL DECISORE POLITICO
6. Trasporto urbano orientato alla mobilità lenta e sostenibile e al trasporto attivo secondo un modello di Walkable City
• Incoraggiare l’utilizzo di modalità sostenibili di trasporto, tramite l’apposita creazione di piste ciclo-pedonali sicure e ben collegate, nonché un efficiente sistema di TPL
• Prevedere attività di sensibilizzazione dei cittadini verso scelte più efficienti e intermodali di mobilità urbana, con parcheggi di scambio e trasporto condiviso, nonché scelte a favore del trasporto attivo
• Incentivare l’adozione di PUMS, piani di monitoraggio qualità aria, zonizzazione rumore, etc come strumenti di pianificazione
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE AUTONOMA IN INTERAZIONE CON DECISORE POLITICO
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE AUTONOMA
7. Strategie di pianificazione urbana e architettonica orientate alla promozione e alla tutela della salute
• Contrastare i fenomeni di urban sprawl, mediante azioni di rigenerazione e ricucitura di parti di città dismessa, e di shrinking cities sulla capacità attrattiva dei centri storici
• Realizzare mixité sociale e funzionale a scala macro (aggregati in una logica di clustering) e micro (street level, attrattività di quartiere) in funzione dell’individuazione di Healthy Destinations
• Attuare tutte le possibili strategie d’inverdimento della città, con particolare riferimento alla riduzione dell’Heat Island Effect (HIE), alla gestione degli eventi meteorici avversi (piani di sicurezza e di emergenza), alla protezione e all’aumento della biodiversità urbana, alla fonte e al consumo energetico, individuando il valore ambientale, sociale e psico-percettivo degli elementi di Green&Blue Areas, con particolare riferimento alle azioni di rigenerazione urbana
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE AUTONOMA IN INTERAZIONE CON DECISORE POLITICO
GENERALE INTERPRETATIVA AUTONOMA IN INTERAZIONE CON DECISORE POLITICO
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE AUTONOMA IN INTERAZIONE CON DECISORE POLITICO
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE AUTONOMA IN INTERAZIONE CON DECISORE POLITICO
125
OBIETTIVO ATTIVITÀ
• Contrastare il fenomeno del Climate Change , e della sostenibilità ambientale in generale, individuando strategie di resilienza urbana per la riduzione degli effetti ambientali e di salute a scala macro (città intera e hinterland, quadranti di città, etc.) e micro (quartiere, isolato, singola piazza, etc.)
• Gestire i servizi urbani, e in particolare i Rifiuti Solidi Urbani (RSU) secondo sistemi di raccolta smart finalizzati al miglioramento delle condizioni igieniche del contesto urbano e alla gradevolezza estetica degli spazi outdoor e meccanizzati di conferimento in discarica o nei centri di trasformazione
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ
GENERALE INTERPRETATIVA AUTONOMA IN INTERAZIONE CON DECISORE POLITICO
8. Prevenzione primaria e malattie croniche 9. Inclusione sociale
• Promuovere programmi di informazione sulla prevenzione a integrazione dei percorsi diagnostico-terapeuticoassistenziali per le malattie croniche trasmissibili e non trasmissibili tra le amministrazioni comunali, in collaborazione con l’autorità sanitaria locale
• Attivare progetti di studio nei contesti urbani più idonei ad avvicinare il cittadino nello svolgimento delle sue attività quotidiane (luoghi di cura, luoghi di lavoro, luoghi ricreativi, strutture sportive, luoghi virtuali come siti internet di riferimento delle amministrazioni stesse) in cui veicolare – attraverso materiale cartaceo o virtuale – messaggi chiave per la prevenzione, coinvolgendo le amministrazioni comunali e le autorità sanitarie
• Adottare politiche tese a migliorare le condizioni sociali, economiche e ambientali dei quartieri degradati, con interventi, anche mean–tested, volti a migliorare il contesto urbano di riferimento
• Allineare la città agli standard più elevati di accessibilità e fruibilità dei servizi urbani e design for all, identificando i differenti tipi di disabilità, non solo motoria e/o cognitiva, e individuando strategie di Inclusive / Universal Design per l’accessibilità degli spazi aperti della città alle diverse categorie di utenti
• Promuovere misure economiche e sociali mirate a migliorare l’inclusione, l’integrazione e l’aggregazione sociale di tutte le categorie di popolazione considerate svantaggiate per condizioni economico-sociali, o per condizioni di salute come malattia e disabilità, promuovendo la loro partecipazione anche nelle attività sportive e ricreative in contrasto al fenomeno della solitudine e dell’isolamento
• Promuovere politiche di prevenzione e inserimento socio-sanitario per le popolazioni di migranti anche ricorrendo a figure di mediatori culturali
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE NON RICHIESTA
GENERALE INTERPRETATIVA NON RICHIESTA
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE AUTONOMA
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE AUTONOMA GENERALE INTERPRETATIVA NON RICHIESTA
GENERALE INTERPRETATIVA NON RICHIESTA
GENERALE INTERPRETATIVA NON RICHIESTA
126
OBIETTIVO ATTIVITÀ
10. Monitoraggio dei dati sulla salute
• Creare cabine di regia per lo studio e il monitoraggio dell’impatto dei determinanti della salute nel contesto urbano, prevedendo il coinvolgimento congiunto di Amministrazioni Comunali, Autorità Sanitarie, Università e Centri di Ricerca e l’elaborazione di schede e protocolli di monitoraggio codificati e uguali per tutti sul tema.
• Promuovere partenariati multistakeholders per politiche urbane che, sulla base degli studi sull’impatto dei determinanti della salute nelle città, possano dare vita a interventi “intelligenti” volti a ridurre i rischi per la salute e a promuovere un ambiente urbano sano e inclusivo
• Creare un Osservatorio permanente delle Aziende Ospedaliere delle Aree Metropolitane con i rispettivi Comuni
• Interagire con gli altri network esistenti, con le politiche attive sulla Smart City, con gli organismi dell’Unione Europea e con l’OMS per realizzare progetti mirati e attrarre risorse, nonché per ampliare il raggio d’azione dell’ Health Diplomacy nella governance multilivello

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE
AUTONOMA IN INTERAZIONE CON DECISORE POLITICO
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE
AUTONOMA IN INTERAZIONE CON DECISORE POLITICO
ARTICOLAREGGIATA DECISIONALE
PARTICOLAREGGIATA DECISIONALE
AUTONOMA IN INTERAZIONE CON DECISORE POLITICO
AUTONOMA IN INTERAZIONE CON DECISORE POLITICO
127
RE-THINK CITIES AND LIV HEALTH PURPOSES, ACC COVID-19 LESSON
Si è tenuto dal 24 al 28 giugno
Il legame fra le specificità morfo-tipologiche dei contesti urbani e la Salute Pubblica è un aspetto imprescindibile e fortemente attuale, dato il fenomeno di inurbamento che caratterizza la società contemporanea.
La salute non è più un problema specificatamente sanitario, ma una priorità fortemente influenzata dal contesto ambientale e da strategie attuate dai governi locali. La pianificazione urbana, a grande e a piccola scala, può essere considerata uno strumento fondamentale per tutelare e promuovere la salute individuale e collettiva.
In questo scenario, la pandemia COVID-19 in corso ha accelerato ed enfatizzato una serie di istanze sociali, ambientale e digitali, rafforzando l’attenzione su aspetti quali la fruizione ad uno spazio urbano pubblico outdoor di qualità, l’accessibilità alle aree verdi, la disponibilità dei servizi di base di prossimità alla propria abitazione e l’articolazione di una rete ciclo-pedonale diffusa, capace di consentire spostamenti in sicurezza (senza ricorrerete al veicolo privato o ai mezzi pubblici affollati) e favorire l’adozione di corretti stili di vita.

Diviene pertanto prioritario saper valutare e indirizzare le scelte progettuali in maniera più consapevole, prediligendo le strategie di pianificazione capaci di limitare i fattori di rischio per la salute a protezione del completo stato di benessere dei cittadini.
Come ridisegnare il concetto di Salute Pubblica in relazione all’ambiente costruito e alle città contemporanee? Quale collaborazione tra progettisti (architetti & ingegneri), esperti di Salute Pubblica, Epidemiologi, Policy & Decision Makers, nel promuovere azioni e politiche volte a trasformare le nostre città in ambienti di vita salutogenici? Fondamentale e � l’approccio multidisciplinare, per sviluppare capacità operative sistemiche, capaci di affrontare tale complessità e, come paradigma, anche gli effetti della pandemia in corso.
Il Corso ha inteso rivolgersi a una platea eterogenea: Medici
Igienisti, Epidemiologi, Specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva, Progettisti Architetti e Ingegneri, ovvero tutti coloro che si occupano di Salute Pubblica e strategie per la pianificazione urbana salutogenica. Il programma formativo ha così potuto offrire ai suddetti strumenti operativi, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, per la valutazione e la programmazione di un ambiente urbano capace di favorire l’adozione di corretti e sani stili di vita. All’interno del programma del Corso hanno trovato spazio, nella giornata centrale, esperienze provenienti da tutta Europa in relazione a come le città stanno ridisegnando i propri spazi nonché il racconto della prima edizione del percorso di alta formazione per Health City Manager, promosso da ANCI e Health City Institute, co-finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e realizzato in collaborazione, tra gli altri, con i Docenti dell’Università “La Sapienza” di Roma e del Politecnico di Milano.
128
il LVII Corso della Scuola Superiore di Epidemiologia e Medicina Preventiva “Giuseppe D’Alessandro” di Erice - Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture.
ING SPACES FOR PUBLIC ORDING WITH THE

129
LVII Corso della Scuola Superiore di Epidemiologia e Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific
RE-THINK CITIES AND LIVING SPACES FOR PUBLIC HEALTH PURPOSES, ACCORDING WI
Direttori del LVII Corso: prof. Stefano Capolongo (POLIMI) e prof.ssa Daniela D’Alessandro (UNIRM) co-Direttori del LVII Corso: prof.sse Alessandra Casuccio (UNIPA) e Margherita Ferrante (UNICT)
Giovedì 24 Giugno 2021
Welcoming & Plenary Session.
14:30 - 15:30
Institutional welcoming & organizational notes. Prof.ri Direttori & co-Direttori della Scuola Prof.ri Direttori & co-Direttori del LVII Corso Marisa Raffo, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Igiene Edilizia” della Società Italiana di Igiene e medicina preventiva (SItI)
15:30 - 16:00 [virtual ITA]
Lectio Magistralis: From Covid-19 to a “New Normal”: could we support a “Healthy Renaissance” for our cities. Silvio Brusaferro, Istituto Superiore di Sanità (ISS)
16:00 - 16:30 | coffee break
16:30 - 17:00 [virtual ENG]
Lectio Magistralis: A New European Bauhaus: Where behavioural insights meet urban planning. Iveta Nagyova, European Public Health Association (EUPHA)
17:00 - 17:45
Lectio Magistralis: Augmented Cities. Maurizio Carta, Università degli Studi di Palermo
17:45 - 18:30 [virtual ITA]
Lectio Magistralis: Senseable cities. Carlo Ratti, Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Carlo Ratti Architetti
prof. Stefano Capolongo
Department of Architecture, Built environment and Construction engineering (ABC), Politecnico di Milano mail: stefano.capolongo@polimi.it

prof.ssa Daniela D’Alessandro
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale (DICEA), Sapienza Università di Roma mail: daniela.dalessandro@uniroma1.it
co-Direttori del LVII Corso:
prof.ssa Alessandra Casuccio
Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno-Infantile “G. D’Alessandro” Università degli Studi di Palermo mail: alessandra.casuccio@unipa.it



prof.ssa Margherita Ferrante
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate, Università degli Studi di Catania mail: marfer@unict.it
In collaborazione con il Gruppo di Lavoro “Igiene Edilizia” della Società Italiana di Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI)

Venerdì 25 Giugno 2021 COVID-19 & Cities.
9:00 - 9:45
COVID-19 and Cities: from Urban Health strategies to the pandemic challenge. A Decalogue of Public Health opportunities. Daniela D’Alessandro, Sapienza Università di Roma
9:45 - 10:30
COVID-19 and Cities //// 1st focus: define a neighborhood services’ plan. Andrea Rebecchi, Politecnico di Milano
10:30 - 11:00 | coffee break
11:00 - 11:45
COVID-19 and Cities //// 2nd focus: renovate the basic care services’ network. Stefano Capolongo, Politecnico di Milano
11:45 - 12:30
COVID-19 and Cities //// 3rd focus: urban mobility policies in the time of pandemic, and after: an ARDOUOS research agenda. Maria Vittoria Corazza, Sapienza Università di Roma
12:30 - 14:30 | lunch break
14:30 - 15:00
Strategic value of the “national center for disease prevention and control” (Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie - CCM) projects: the support of Urban Health to prevention policies.
Roberto D’Elia, Ministero della Salute
15:00 - 15:30
Urban Health objectives and actions in the new National and Regional Prevention Plans. Liliana Coppola, Accademia Lombarda di Sanità Pubblica
15:30 - 16:30
Urban Health: a multidimensional assessment framework to evaluate healthy urban plans. Maddalena Buffoli, Politecnico di Milano
16:30 - 17:00 coffee break
17:00 - 17:45
Environment, Climate Change and Health Emergencies.
Margherita Ferrante, Università degli Studi di Catania
17:45 - 18:30
How does the urban environment affect the human health and well-being ?
Alessandra Casuccio, Università degli Studi di Palermo
Sabato 26 Giugno 2021
EU experiences & the Health City Manager.
9:00 - 10:30 [virtual ENG]
Learning from Paris.
Carlos Moreno, Sorbonne University IAE
10:30 - 10:45 | fast coffee break
10:45 - 11:15 [virtual ITA]
The Health City Manager (HCM): core-CV and italian training experience.
Chiara Spinato, Health City Institute
11:15 - 11:45
Methods, techniques and experiences of participatory planning.
Andrea Lauria, AULSS9 Regione Veneto
12:00 - 24:00
Guided tour in Favignana & social dinner in Trapani.
• 12:30 partenza dal parcheggio di P.ta Trapani in Erice con le navette messe a disposizione dalla Scuola
• 13:30 partenza aliscafo dal porto turistico di Trapani
• 14:00 arrivo a Favignana
• visita guidata all’ex-stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica
• tour panoramico dell’isola con trenino Egadilandia; due gruppi della durata di 1h/gruppo
• tempo libero
• 19:20 partenza aliscafo dal porto turistico di Favignana
• 19:50 arrivo al porto turistico di Trapani
• breve passeggiata nel centro storico sino a raggiungere la Piazza del mercato del pesce
• 21:00 cena presso Taverna Paradiso
• 23:00 partenza da Trapani per Erice
• 23:30 arrivo al parcheggio di P.ta Trapani in Erice
Destinatari:
Il Corso si rivolge a Medici Igienisti, Epidemiologi, Specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva, Progettisti Architetti e Ingegneri, ovvero tutti coloro che si occupano di Salute Pubblica e strategie per la pianificazione urbana salutogenica. Il programma formativo intende fornire ai suddetti strumenti operativi, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, per la valutazione e la programmazione di un ambiente urbano capace di favorire l’adozione di corretti e sani stili di vita.
Docenti: G.M.Fara, D.D’Alessandro, M.V.Corazza, L.Appolloni (UNIRM); M.Buffoli, S.Capolongo, M.Dell’Ovo, M.Gola, E.I.Mosca, A.Rebecchi (POLIMI); M.Dettori (UNISS); A.Lauria (AULSS 9 Regione Veneto); A.Casuccio (UNIPA); M.Ferrante (UNICT); R.D’Elia (Ministero della Salute); L.Coppola (Accademia Lombarda di Sanità Pubblica); C.Spinato (Health City Institute).
Lectio Magistralis: S.Brusaferro, Istituto Superiore di Sanità I.Nagyova, European Public Health Association M.Carta, Università degli Studi di Palermo C.Ratti, Massachusetts Institute of Technology C.Moreno, Sorbonne University IAE
Segreteria scientifico-organizzativa: Andrea Rebecchi - DABC, Politecnico di Milano contatti: andrea.rebecchi@polimi.it - 347 99 64 827 Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana contatti: hq@ccsem.infn.it - 0923 869133
Direttori della Scuola: prof.ri Gaetano Maria Fara, Giuseppe Giammanco, Carlo Signorelli e Francesco Vitale.
130
Direttori del LVII Corso:
Medicina Preventiva “Giuseppe D’Alessandro” di Erice Culture.
ITH THE COVID-19 LESSON.
Domenica 27 Giugno 2021
COVID-19 & Living Spaces.
9:00 - 9:45
COVID-19 and Living Spaces. Well-being and Public Health recommendations for a healthy, safe, and sustainable housing.
Marco Dettori, Università degli Studi di Sassari
9:45 - 10:30
COVID-19 and Living Spaces //// 1st focus: flexibility and adaptability of living spaces, thermal comfort and Indoor Air Quality (IAQ).
Marco Gola, Politecnico di Milano
10:30 - 11:00 | coffee break
11:00 - 11:45
COVID-19 and Living Spaces //// 2nd focus: Performance evaluation to measure accessibility and social inclusion according to Design for All strategy.
Erica Isa Mosca, Politecnico di Milano

11:45 - 12:30
COVID-19 and Living Spaces //// 3th focus: Assessment of ecosystem services to support urban and building design, with particular reference to Green Areas.
Marta Dell’Ovo, Politecnico di Milano
12:30 - 14:30 | lunch break
14:30 - 15:15
A project to identify the best practices and health performance objectives for building construction and renovation.
Letizia Appolloni, Sapienza Università di Roma
15:15 - 15:30
World Cafè experience: introduction to the groups’ discussion based on the topics eligible for the Position Paper titled “LVII Erice Charter”.
Andrea Lauria, AULSS9 Regione Veneto
Andrea Rebecchi, Politecnico di Milano
15:30 - 17:00
World Cafè 1st round.
Interazione tra Allievi e Facilitatori dei singoli tavoli.
17:00 - 17:30 | coffee break
17:30 - 19:00
World Cafè 2nd round.
Interazione tra Allievi e Facilitatori dei singoli tavoli.
BOTH RESIDENTIAL & VIRTUAL EDITION !!!!!
Lunedì 28 Giugno 2021
Drafting the LVII Erice Charter.

9:00 - 10:30
World Cafè 3rd round. Interazione tra Allievi e Facilitatori dei singoli tavoli.
10:30 - 11:00 | coffee break
11:00 - 12:00
Drafting the LVII Erice Charter: plenary discussion of the World Cafè outputs. intervengono a rotazione i facilitatori dei singoli tavoli di lavoro; moderano:
Daniela D’Alessandro, Sapienza Università di Roma Stefano Capolongo, Politecnico di Milano
Marisa Raffo, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Igiene Ediliza” della Società Italiana di Igiene e medicina preventiva (SItI)
12:00 - 12:30
Conclusions and take-home message. Gaetano Maria Fara, Sapienza Università di Roma Daniela D’Alessandro, Sapienza Università di Roma Stefano Capolongo, Politecnico di Milano
Scopo del Corso
Il legame fra le specificità morfo-tipologiche dei contesti urbani e la Salute Pubblica è un aspetto imprescindibile e fortemente attuale, dato il fenomeno di inurbamento che caratterizza la società contemporanea.
La salute non è più un problema specificatamente sanitario, ma una priorità fortemente influenzata dal contesto ambientale e da strategie attuate dai governi locali. La pianificazione urbana, a grande e a piccola scala, può essere considerata uno strumento fondamentale per tutelare e promuovere la salute individuale e collettiva.
In questo scenario, la pandemia COVID-19 in corso ha accelerato ed enfatizzato una serie di istanze sociali, ambientale e digitali, rafforzando l’attenzione su aspetti quali la fruizione ad uno spazio urbano pubblico outdoor di qualità, l’accessibilità alle aree verdi, la disponibilità dei servizi di base di prossimità alla propria abitazione e l’articolazione di una rete ciclo-pedonale diffusa, capace di consentire spostamenti in sicurezza (senza ricorrerete al veicolo privato o ai mezzi pubblici affollati) e favorire l’adozione di corretti stili di vita.
Diviene pertanto prioritario saper valutare e indirizzare le scelte progettuali in maniera più consapevole, prediligendo le strategie di pianificazione capaci di limitare i fattori di rischio per la salute a protezione del completo stato di benessere dei cittadini.
Come ridisegnare il concetto di Salute Pubblica in relazione all’ambiente costruito e alle città contemporanee? Quale collaborazione tra progettisti (architetti & ingegneri), esperti di Salute Pubblica, Epidemiologi, Policy & Decision Makers, nel promuovere azioni e politiche volte a trasformare le nostre città in ambienti di vita salutogenici? Fondamentale è l’approccio multidisciplinare, per sviluppare capacità operative sistemiche, capaci di affrontare tale complessità e, come paradigma, anche gli effetti della pandemia in corso.
oundation and Centre for Scientific Culture.
16-17 dicembre 2021 Conferenza internazion
“Shaping light for health
La conferenza è organizzata dal consorzio ENLIGHTENme, progetto finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea coordinato dall’Università di Bologna di cui Health City Institute è partner. I contributi ricevuti, da inviare entro il 4 ottobre (www.enlightenme-project-conference.com), saranno ammessi alla due giorni di Conferenza per costruire un quadro di conoscenze comuni su illuminazione, salute e benessere.
Una delle principali conseguenze dell’urbanizzazione è un aumento esponenziale dell’esposizione umana alla luce elettrica di notte. L’illuminazione pubblica esterna e il bagliore artificiale del cielo creato da aree altamente urbanizzate sono le principali fonti di esposizione. Ciò è completato dall’aumento dell’esposizione alla luce a livello individuale attraverso l’illuminazione domestica e gli schermi che emettono luce, o un’esposizione insufficiente durante il giorno a causa del lavoro a turni o di stili di vita non regolamentati.
Le conseguenze di un’esposizione alla luce inappropriata e dirompente, generata dall’ambiente urbano, influiscono profondamente sulla salute e sul benessere delle persone, alterando il ritmo circadiano. Questi effetti non possono essere trascurati, specialmente quando colpiscono popolazioni vulnerabili come gli anziani che soffrono in modo sproporzionato.
La luce modella anche gli spazi urbani e la vita sociale, influenzando così il comportamento, gli umori e il senso di sicurezza delle persone, nonché le relazioni sociali, facilitando o ostacolando la socializzazione e la partecipazione alla vita civile. Sebbene la consapevolezza pubblica sui problemi di salute e benessere legati alla luce sia in aumento, c’è meno comprensione di come gli impatti sulla salute derivati dall’illuminazione urbana siano mediati dalle disuguaglianze sociali presenti nelle città che possono determinare il tipo e la quantità di luce a cui i cittadini sono esposti.
È qui che entra in gioco ENLIGHTENme: riunendo esperti di diversi campi e settori scientifici come lo sviluppo urbano e la ricerca sulla salute, il team di ENLIGHTENme mira a raccogliere prove sull’impatto che l’illuminazione per esterni e interni ha sulla salute umana, specialmente nelle persone anziane. Inoltre, ENLIGHTENme si propone di sviluppare e testare soluzioni e politiche innovative che compenseranno le disuguaglianze sanitarie nelle città europee, a
partire dalle città pilota del progetto: Bologna, Amsterdam, Tartu.
A tal fine, l’evento virtuale di due giorni intende approfondire questi temi e richiede contributi dei partecipanti sotto forma di casi di studio, recensioni o documenti tecnici per le sei sessioni tematiche: • Sessione 1: Geo-intelligence e analisi urbana per il benessere urbano urban • Sessione 2: Illuminazione sociale e illuminotecnica per il benessere urbano • Sessione 3: Co-design e coinvolgimento della comunità • Sessione 4: L’interazione tra geni e ambiente per la salute, il benessere e il ritmo circadiano • Sessione 5: Politiche innovative di illuminazione urbana • Sessione 6: Aspetti legali ed etici dell’illuminazione urbana e relativi studi sulla salute Oltre a presentare la propria ricerca al convegno ed essere pubblicata negli atti del convegno, una selezione di ricercatori avrà l’opportunità di assicurarsi uno dei posti limitati per la pubblicazione di un articolo completo in un numero speciale nella sezione “Salute e sostenibilità” del Rivista Open Access Sustainability.
132
ale ENLIGHTENme and wellbeing in cities”



Un nuovo modello di città: la Sport City
Immaginare una Città nuova, diversa, a misura d’uomo, di bambino, di adulto, è da sempre l’obiettivo di chi si proponga di trasformare l’abitato con l’intento di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Lo spazio fisico all’interno del quale immaginare la vita di un abitante è importante, certo, perché determina ricadute su ogni aspetto della sua esistenza; ancor più importante è concentrarsi su quello che avvenga al di fuori dello spazio definito, come si raggiungano le abitazioni e i luoghi di lavoro, quale percentuale di attività fisica giornaliera, ormai prescritta da qualunque medico, si faccia. Le Città del mondo capaci di adattare i propri ritmi e le dinamiche di pianificazione urbanistica e gestione dello spazio pubblico a un processo di sportivizzazione sono pochissime.
Quelle italiane davvero pochissime, per pigrizia e per mentalità, mentre in ambito europeo e mondiale si segnalano buone prassi che hanno inciso in maniera significativa sia sullo stato di salute complessiva delle popolazioni che sull’indice di felicità, un indicatore che da qualche tempo viene “misurato” in sociologia e al quale è attribuita la capacità di fornire indicazioni sull’impatto delle politiche pubbliche sui cittadini.
Per questo la Sportcity non è, semplicisticamente, un contesto nel quale si dedichino risorse per la costruzione di impianti sportivi.
La SportCity è un sistema, una rete di connessioni fra interpreti e protagonisti della vita cittadina, che cooperano per il miglioramento generale della qualità della vita, attraverso lo sport. E’ ora di passare dalla parola d’ordine della Smart-City a quella della Sport-City, perché la tecnologia e i servizi innovativi della Città Smart sono nulla senza la felicità e il benessere, mentre è possibile creare una santa alleanza fra innovazione tecnologica e sport, migliorando le condizioni di vita di tutti i cittadini e favorendo la diffusione di stili di vita sani.
La SportCity è certamente la palestra a cielo aperto per qualsiasi tipo di praticante del movimento fisico, ma è anche patrimonio dei turisti che visitano i Musei, dei dipendenti pubblici e privati, dei manager, degli operai, degli studenti universitari che ogni giorno ripetono lo stesso tragitto o che scelgano di fruire in maniera attiva di spazi e mezzi pubblici.
Il movimento fisico rappresenta la base di ogni attività umana e ne condiziona le dinamiche. Le dinamiche che dovrebbero spingere verso città “a misura di sport” non riguardano, dunque, solo architetti, urbanisti o paesaggisti: è una battaglia di tutti, perché lo sport è la più concreta delle applicazioni per migliorare la qualità della vita individuale e collettiva, è politica sociale, è intervento sanitario. I cittadini attivi ormai cercano il software della Città, prima ancora che l’hardware. Vogliono sapere come funzioni, vogliono poter scegliere il software migliore, quello che garantisca loro prestazioni adeguate, equivalenti a benessere e qualità della vita.
Non resta che mettere insieme i tasselli di questo puzzle e far incontrare la parte teorica con gli interventi sul territorio, uscendo dalla logica degli interventi isolati e pensando alle sportcity in maniera sistemica, integrata, multidisciplinare, così da favorirne la riconoscibilità e la misurabilità in termini di impatto. E’ la sfida della sostenibilità materiale ed esistenziale, nella quale lo sport rappresenta un punto di partenza, uno strumento applicativo e un punto di arrivo, grazie alla sua capacità di non essere discriminante: nelle SportCity non conta la prestazione, ma la possibilità di muoversi, anche a costo zero, con l’abbattimento di ogni ostacolo a questa sana e naturale aspirazione di ciascuno.
134

135
Fabio Pagliara, Presidente Fondazione SportCity
WALKABLE CITY UNA CITT
Le città sono fortemente responsabili della salute dei cittadini e delle politiche che aiutano la comunità a mantenersi in salute.
La situazione mondiale che ha visto nell’epidemia Covid19 un avversario nuovo, inatteso e devastante, ha evidenziato come sia assolutamente importante avere una popolazione in buona salute psico-fisica per affrontare tali attacchi alla salute pubblica. Oggi, nel momento in cui tutti speriamo si possa guardare a un progressivo ritorno alla normalità vaccinando i cittadini, ancor più pare importante sostenere il messaggio del movimento, che riporta di forte centralità quanto l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) da tempo indica a riguardo dell’inattività fisica e delle problematiche da essa derivanti.
OMS ha difatti evidenziato i rischi di una popolazione poco attiva e quanto l’inattività fisica rappresenti il quarto più importante fattore di mortalità al mondo con circa 3,2 milioni di morti ogni anno.
L’inattività fisica è difatti un fattore di rischio primario per le malattie non trasmissibili, quali le malattie cardio-vascolari, l’obesità, alcuni tipi di tumore e il diabete.
Le statistiche ci dicono come nel mondo un adulto su tre non è sufficientemente attivo. In Italia oltre un terzo della popolazione non pratica alcun tipo di esercizio fisico.
Questi dati, unitamente al fatto che la popolazione mondiale si concentra sempre più nelle aree urbane, come sottolinea sempre l’OMS, sono un fattore di forte riflessione rispetto al ruolo delle città e delle grandi metropoli in particolare. Se trent’anni fa 4 persone su 10 vivevano in centri urbani, nel 2050 questa proporzione arriverà a 7 su 10 secondo le proiezioni dell’OMS. Tale realtà, che vedrà una forte concentrazione urbana, unitamente al fatto che le persone ultra sessantenni aumenteranno fino a rappresentare quasi un quarto della popolazione, rappresenta un rischio elevatissimo per la salute se non si penseranno “nuove città”, dove le opportunità di movimento crescono e offrono ai cittadini luoghi e situazioni per muoversi maggiormente a piedi. Uno stile di vita, quello del semplice camminare di più, capace di incidere non solo sugli aspetti di salute, ma anche sulla mobilità sostenibile all’interno delle Città e, di conseguenza, anche su una loro trasformazione per divenire più attente e pronte alle esigenze dei cittadini e alla qualità di vita nelle città, ma anche all’ambiente e alla sua tutela. Molte sono quindi le questioni che scaturiscono dall’analisi di questi temi. Quale futuro avrà il nostro pianeta? Saremo in grado di garantire i giusti livelli di salute ai cittadini sempre più concentrati nelle aree urbane? Avremo città e territori adeguati a permettere alle persone il necessario utilizzo di esercizio fisico? Saremo in grado di controllare l’inquinamento atmosferico e migliorare la mobilità in città per renderla più sostenibile?
Una delle risposte possibili é quella di far crescere il livello dell’attività fisica dei cittadini. Avere città capaci di offrire più opportunità, luoghi e aree dove poter svolgere esercizio fisico. Porre in evidenza nelle scelte politiche la sostenibilità
degli spostamenti in città e della mobilità pedonale. Essere attenti al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione e all’inclusione sociale.
Tutti temi centrali nel pensare le città di domani. Città più pedonali, o walkable cities per utilizzare un termine internazionale che connota le città attente alla mobilità delle persone attraverso una sempre maggiore incentivazione al movimento a piedi attraverso aree e zone facilmente utilizzabili camminando.
TO WALK IN THE CITY Lab
Perché il camminare posto al centro di un progetto per nuove città? Perché camminare è la forma di movimento più praticabile da tutti. Rappresenta la proposta di mobilità che può essere utilizzata da giovani ed anziani indistintamente. Camminare è un modo di vivere la città e i diversi territori in modo naturale. È un sistema di mobilità sostenibile per l’ambiente e in grado di migliorare la qualità di vita dei cittadini.
Creare situazioni dove poter camminare per svago, per benessere o per sport all’interno di una città, collocabili o individuabili in modo distribuito al suo interno, permettono a tutti di potersi muovere senza particolari spostamenti e di usufruire di opportunità di movimento facilmente fruibili. Camminare di più fa bene ai cittadini e può cambiare il volto delle città.
Da questi presupposti nasce il progetto TO WALK IN THE CITY Lab, ideato e pensato per mettere insieme specialisti della salute, del movimento fisico, dell’urbanistica, dell’organizzazione cittadina e dello sport per sviluppare proposte e suggerimenti per come muoversi nella direzione di città più attive e in salute.
TO non è solo la costruzione inglese del verbo all’infinito, ma anche la sigla di Torino, come città di riferimento da cui nasce il progetto che è e vuole porsi come progetto nazionale di ampio respiro, per lavorare sui temi della mobilità, della salute, dell’urbanizzazione e delle politiche locali che riguardano il futuro delle città.
TO – WALK IN THE CITY Lab è l’evoluzione di un percorso fatto in questi anni nel cuore del sistema camminare quale strumento di benessere da me, mio fratello Giorgio e molti altri attori che, come noi, credono che non ci sia più tempo da perdere per riportare le persone a stili di vita più attivi e le città ad offrire loro gli strumenti necessari per attuarli.
Il Laboratorio vuole poter sostenere il lavoro degli amministratori cittadini e di chi lavora nel mondo della salute e delle attività motorie e sportive, fornendo idee, studi e progettualità legate al sistema camminare all’interno delle città, e alla città che diviene luogo per camminare.
All’interno del Laboratorio confluiranno anche alcuni progetti portati avanti in questi anni, come i Passaporti delle città per camminare e della salute con le loro cartine/mappe
136
À “A PASSO” CON I TEMPI
di Maurizio Damilano Presidente TO WALK IN THE CITY LAB Campione Olimpico di Marcia

ideate quali strumenti per promuovere ancor più l’uso dei percorsi scelti e suggeriti, ma anche come strumento di promozione e marketing territoriale per le città. L’uso della tecnologia come ulteriore elemento per avvicinare le persone alle diverse proposte, ma anche rivolta al coinvolgimento dei giovani perché sono loro gli adulti del domani che vogliamo avere in salute.
Vorremmo poi lavorare su modelli di città rivolte al futuro, città dove la mobilità non è più solo opportunità di movimento, di sport, di esercizio fisico, ma diviene anche riorganizzazione urbana, portando i servizi essenziali alla vita dei cittadini a “portata di gambe”, ossia raggiungibili a piedi in un raggio di 15 minuti circa. “La città in 15 minuti” è qualcosa in più di un semplice slogan, é la visione di un futuro sostenibile che aiuta le persone a vivere meglio la propria città e a dare risposte alla crescente urbanizzazione che porta sempre più persone a vivere nelle aree urbane in tutto il mondo.
137
PROMUOVERE ROMA, MILANO, BARI &
LA SALUTE NELLE CITTA’
Camminare, correre sono attività naturali per l’uomo, da sempre. Il nostro corpo è, infatti, strutturato per percorrere 30 km al giorno, come facevano i nostri progenitori, per procurarsi cibo e acqua. Oggi camminiamo per più o meno un paio di chilometri al giorno e stiamo perdendo l’abitudine a trovare giusti stimoli a muoverci. La sedentarietà ha innescato una vera e propria emergenza sociale; sia nei Paesi sviluppati sia in quelli in via di sviluppo, l’obesità e le conseguenze dell’inattività fisica peggiorano, infatti, la qualità di vita quotidiana delle persone, fanno impennare i costi della sanità pubblica e causano milioni di morti ogni anno.


















Le città sono fortemente responsabili della salute dei cittadini e delle politiche che aiutano la comunità a mantenersi in salute.

PROMUOVERE LE CITTÀ PER CAMMINARE E DELLA SALUTE
Una strategia possibile, per affrontarla, è quella di riscoprire la Città quale palestra naturale e promuovere attraverso di essa il concetto di Urban Health, di Salute urbana. Bisogna tornare a concepire le Città come territori vivibili, permettendo ai cittadini di disporre di vere e proprie “palestre a cielo aperto”, quali parchi e percorsi che favoriscano il trekking urbano.
L’inattività fisica è difatti un fattore di rischio primario per le malattie non trasmissibili.“Walkable city” non è solo un titolo, è la reale necessità delle città nell’individuare nel camminare un elemento di salute e di sostenibilità alla mobilità urbana. Proprio la mobilità sostenibile a piedi è un elemento centrale nelle politiche di tanti paesi. Camminare è la forma di movimento più praticabile da tutti. Rappresenta la proposta di mobilità che può essere utilizzata da giovani ed anziani indistintamente. Camminare è un modo di vivere la città e i diversi territori in modo naturale. E’ un sistema in grado di migliorare la qualità di vita dei cittadini. Creare situazioni dove poter camminare per svago, per benessere o per sport all’interno di una città e collocabili o individuabili in modo distribuito al suo interno, permettono a tutti di potersi muovere senza particolari spostamenti e di usufruire di opportunità di movimento facilmente fruibili.
138 T
“ITALIAN WALKABLE CITIES
TORINO
CONTEXT ROMA
Roma è la città in Italia che registra il più alto numero di turisti, la città più estesa e la città con il più alto numero di abitanti; è stata una sfida l’inserimento nelle WALKABLE CITIES, una sfida vinta.



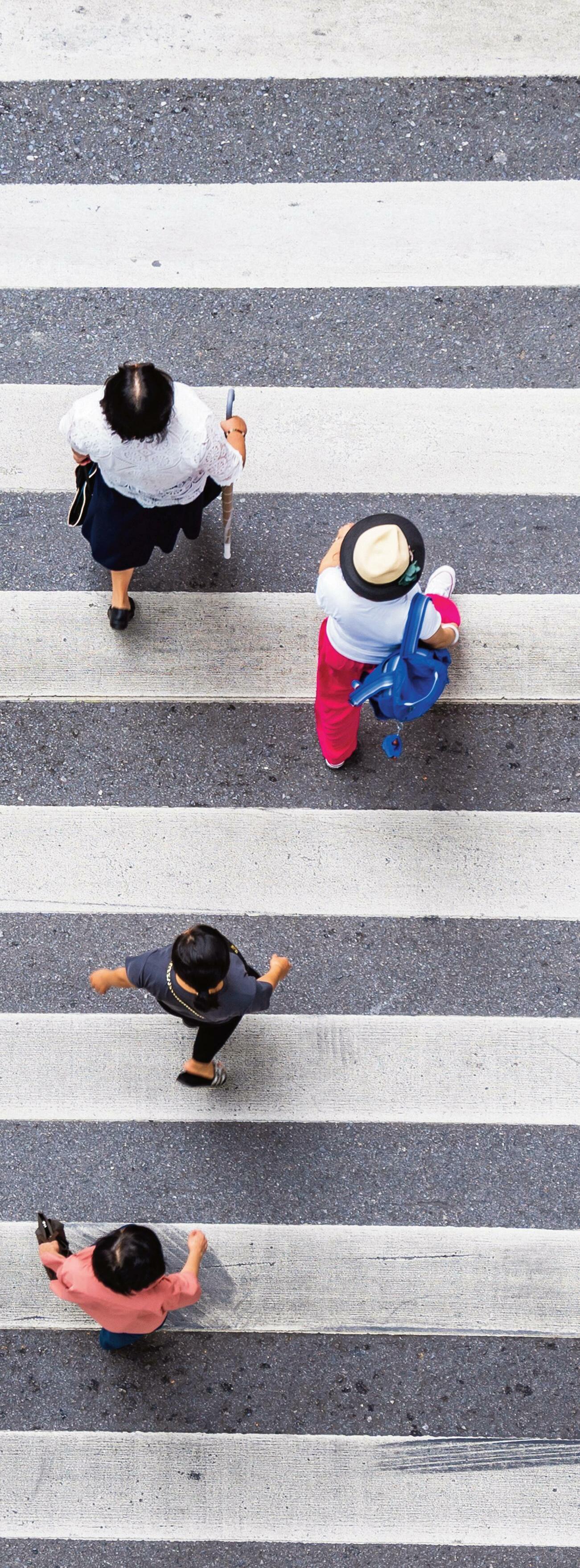
E’ infatti la città in cui è stato proposto il maggior numero di percorsi pedonali, sono presenti sull’applicazione oltre 60 percorsi (considerando la città metropolitana), 22 dei quali presenti anche sul Passaporto e 18 sulla Mappa, per complessivi 340 Km circa, che fanno di Roma la prima walkable city in Europa.
Sono percorsi pensati appositamente per il cammino e uniscono le diverse anime di Roma, coinvolgono, infatti, l’intera città metropolitana con proposte diversificate che vanno dall’itinerario storico teso alla scoperta dell’immenso patrimonio architettonico ed artistico a quello naturalistico più inaspettato tra pinete e parchi secolari a pochi passi dal centro.


Sono tutti ideali da percorre a piedi e sono “per tutti i piedi”. Ci sono, infatti, i percorsi più sportivi che meglio si prestano al cammino veloce e ad un approccio più allenante e quelli in grado di ritemprare la mente e lo spirito grazie alla bellezza nella quale sono immersi.
OUTCOMES & ACTIONS ROMA
In sinergia con il Comune di Roma sono stati progettati 51 percorsi di walking urbano e di percorsi nei parchi urbani, arrivando a una rete di più di 300 Km utilizzabili per attività motoria a costo zero, che pongono Roma la prima walkable city europea. I percorsi sono stati scelti pensando ai cittadini e alla quotidianità di utilizzo, ma anche rivolti ai turisti, dedicati alla visita della Città, dei suoi luoghi simbolo, così come di parti meno note ma che presentano altrettanto fascino e bellezza e percorsi di tipo naturalistico, ambientale o più decisamente sportivo. Una parte importante è dedicata ai percorsi delle periferie per favorire lo sviluppo sociale delle stesse. In totale i percorsi coinvolgono circa 1,5 milioni di cittadini e 1,2 milioni di popolazione insistente quali lavoratori temporanei, studenti fuori sede e city user.



139
SALUTE”
PER LA
IN ITALIA SONO STATI SVILUPPATI 537 PERCORSI SUDDIVISI TRA TUTTE LE REGIONI ED IN 246 CITTÀ DIVERSE: PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 2.708 KM.
CONTEXT MILANO
Milano è la città italiana che più guarda alle grandi metropoli internazionali, attenta e ricettiva verso gli stimoli nuovi ha ben saputo cogliere l’opportunità di proporsi come città “per e da camminare”, proponendo itinerari nell’intera città metropolitana. I percorsi proposti spaziano infatti dal centro cittadino, ai parchi più conosciuti e frequentati come l’Idroscalo ed il Parco Sempione, ai nuovi quartieri ridisegnati grazie all’impulso dell’Expo 2015 come City Life e Porta Nuova, sino ai comuni dall’Alto Milanese al Magentino Abbiatense, da Nord a Sud della città sino alla Martesana. L’elemento che li collega tutti è il cammino inteso sia come mezzo per muoversi all’interno della città in combinazione magari con l’auto o con i mezzi pubblici, che come strumento alla portata di tutti per tenersi attivi. Milano sarà città olimpica nel 2026 e punto di riferimento ideale per sviluppare un progetto di maggiore sostenibilità dell’eredità olimpica attraverso l’ideazione delle “OLYMPIC ROADS FOR HEALTH”, percorsi inseriti nel contesto delle aree olimpiche perché divengano patrimonio della città per l’esercizio fisico, sportivo e salutistico dei cittadini.










OUTCOMES & ACTIONS MILANO
Sono stati realizzati 47 percorsi urbani per uno sviluppo di 287 km con il coinvolgimento di 34 comuni, per promuovere il movimento dei cittadini e in particolare la camminata come sana abitudine nella prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, come diabete e obesità Entro il 2026 (anno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina) entreranno nel passaporto e nel progetto “OLYMPIC ROADS FOR HEALTH” anche gli altri 99 comuni dell’hinterland milanese, con almeno un percorso per camminare in ciascuno di essi.



CONTEXT BARI
La città di Bari ben si presta ad una fruizione pedonale, è un centro urbano a misura d’uomo che ha nell’affaccio sul mare il suo punto di forza. La maggior parte dei percorsi proposti ha infatti questo denominatore comune, si sviluppano sul lungo mare oppure collegano centro e mare in un costante dialogo tra i due elementi, tra città nuova e città vecchia.


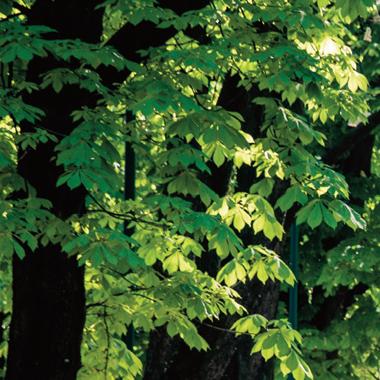

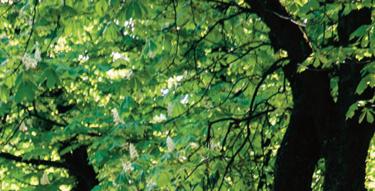
Il lungomare di Bari, tra i più vasti di Europa con i suoi 16 Km, attraversa la città fiancheggiando tutta la costa, è stato recuperato recentemente alla piena fruizione dei cittadini per la pratica di esercizio fisico e sport, è un punto di incontro importante per tanti sportivi e meta prediletta dei podisti cittadini, ben si presta alla pratica del cammino sia veloce che sotto forma di passeggiata quotidiana. ,


OUTCOMES & ACTIONS BARI
In collaborazione con il Comune di Bari e della Città Metropolitana sono stati sviluppati 15 percorsi per un totale di 44 Km, che si sviluppano non solo nella valorizzazione del lungomare e del centro storico, ma anche delle periferie e dei quartieri a più alta densità abitativa. Il progetto trova un forte link con la progettualità del Comune di Bari, che rende fruibili 43 impianti sportivi per la promozione della salute in tutte le fasce della popolazione.


STRUMENTI DI CONNESSIONE TRA LE CITTA’

- IL LABORATORIO “TO WALK IN THE CITY LAB” è la realizzazione dell’idea di mettere insieme specialisti della salute, del movimento fisico, dell’urbanistica, dell’organizzazione cittadina, dello sport per sviluppare proposte e suggerimenti per come muoversi nella direzione di città più attive e in salute.


Il Laboratorio vuole poter sostenere il lavoro degli amministratori cittadini e di chi lavora nel mondo della salute e delle attività motorio e sportive, fornendo idee, studi e progettualità legate al sistema camminare all’interno delle città, e alla città che diviene luogo per camminare. Tra le prime proposte suggerite dal laboratorio vi è l’ampio lavoro da realizzare sul tema della mobilità sostenibile a piedi nelle città. Un caposaldo nel sistema che guarda alla città del futuro, una città a dimensione di cittadino e che unisce in una nuova stretta alleanza le esigenze di innovazione urbanistica e di ricerca di una miglior qualità dell’ambiente urbano e del suo sviluppo green, con quelle di benessere e di salute delle persone.
- L’APPLICAZIONE “CITTÀ PER CAMMINARE E DELLA SALUTE” è lo strumento che propone itinerari adatti al cammino indicandone le caratteristiche, i punti di interesse presenti e le informazioni utili. E’ lo strumento, insieme alle mappe, che “fa vivere il percorso” passando dalla proposta alla pratica. Attivando l’applicazione viene indicato il risparmio in termini di CO2, un ulteriore elemento di attenzione verso i temi della sostenibilità ambientale e dello spirito green che pervade le nuove città ed oggi al centro delle politiche di tutte le istituzioni, nazionali, regionali e mondiali.




140
CONTEXT TORINO
Torino per la sua storia industriale è la città dell’auto per definizione questo non le ha però impedito di essere una delle città con più aree verdi a livello nazionale. Questa apparente dicotomia ha rappresentato la base di partenza per la proposta dei percorsi individuati inizialmente nei grandi parchi cittadini come il Valentino, le Vallere, il Parco Pellerina, il Parco Dora, il Parco della Tesoriera ed il Parco di Piazza d’Armi e, successivamente, in tutta l’area non solo urbana. E’ stata infatti coinvolta anche in questo caso l’intera città metropolitana dal centro, con un connubio tra storia, tradizione e leggenda che vuole Torino una città esoterica, sino ai comuni suburbani, che lambiscono le valli montane a nord ovest e la pianura a sud est. Torino conferma inoltre la sua vocazione di città dell’innovazione e laboratorio, è infatti il riferimento, tanto da essere inserita nel nome di “TO Walk in the City Lab”. Anche Torino come Milano e Roma, è città olimpica in Italia, e come per le altre sedi di Giochi Olimpici nel Paese, si identifica come riferimento per lo sviluppo del progetto “Olympic Roads for Health” pensato dal TO Walk in the City Lab”.
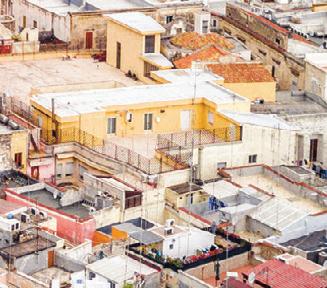
OUTCOMES & ACTIONS TORINO

Il progetto nasce in Piemonte nel 2008 dall’esperienza del campione olimpico di marcia Maurizio Damilano. Per testarlo al meglio si è svolta nel triennio 2009 – 2011 una fase pilota sempre nella stessa regione che ha visto coinvolte 47 città e la partecipazione di circa 500 mila cittadini. Oggi solo nella città di Torino sono stati sviluppati 22 percorsi per un totale di 100 Km, che si sviluppano nei contesti verdi della città Grazie agli sforzi delle Associazioni pazienti e delle autorità sanitarie locali, attualmente utilizzano i percorsi circa 32 gruppi di camminatori (circa 600 persone con diabete)
- LE MAPPE E I PASSAPORTI insieme all’applicazione, sono lo strumento che rende immediatamente fruibili i percorsi localizzandoli all’interno della città, dandone una descrizione breve ed efficace.
I passaporti permettono di identificare le caratteristiche dei percorsi, le difficoltà degli stessi, la fruibilità, le facilties (parcheggi, presenza di fontanelle dell’acqua, trasporti…) e i luoghi di interesse turistico e pubblico.








- I GRUPPI DI CAMMINO “WALKING FRIEND GROUPS” nascono come elemento operativo ed attivo per una maggiore fruibilità regolare di uno o più percorsi proposti e suggeriti. I gruppi sono condotti da un Walking Friend Chief specificatamente formato, che conduce il gruppo di cammino con costanza e determinazione con l’obiettivo di rendere l’esercizio fisico ed il cammino una costante, una salutare abitudine da praticarsi con continuità. È nato per facilitare lo sviluppo dell’attività fisica in pazienti diabetici e per la prevenzione della malattia ha nelle Associazioni pazienti e nelle strutture sanitarie specialistiche gli alleati principali.

141





142 Grandi eventi online Eventi istituzionali Eventi cittadini Regia digitale Grandi comunicatori www.streamliveevents.it



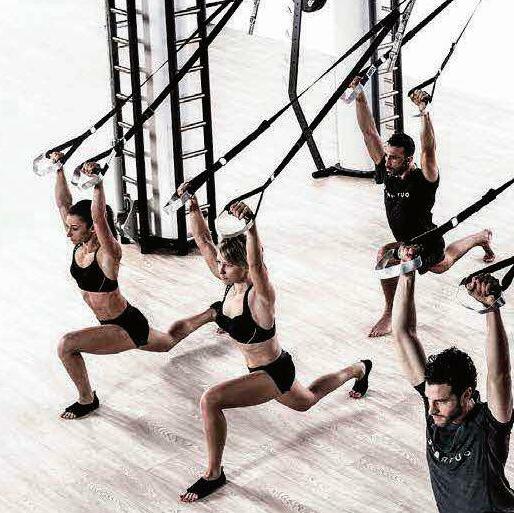


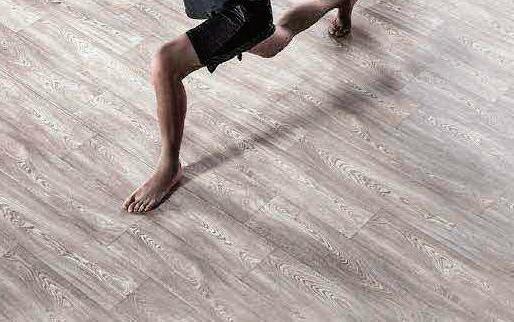















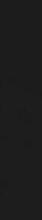


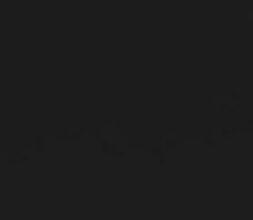
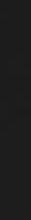
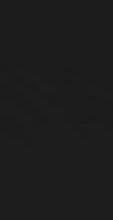
143
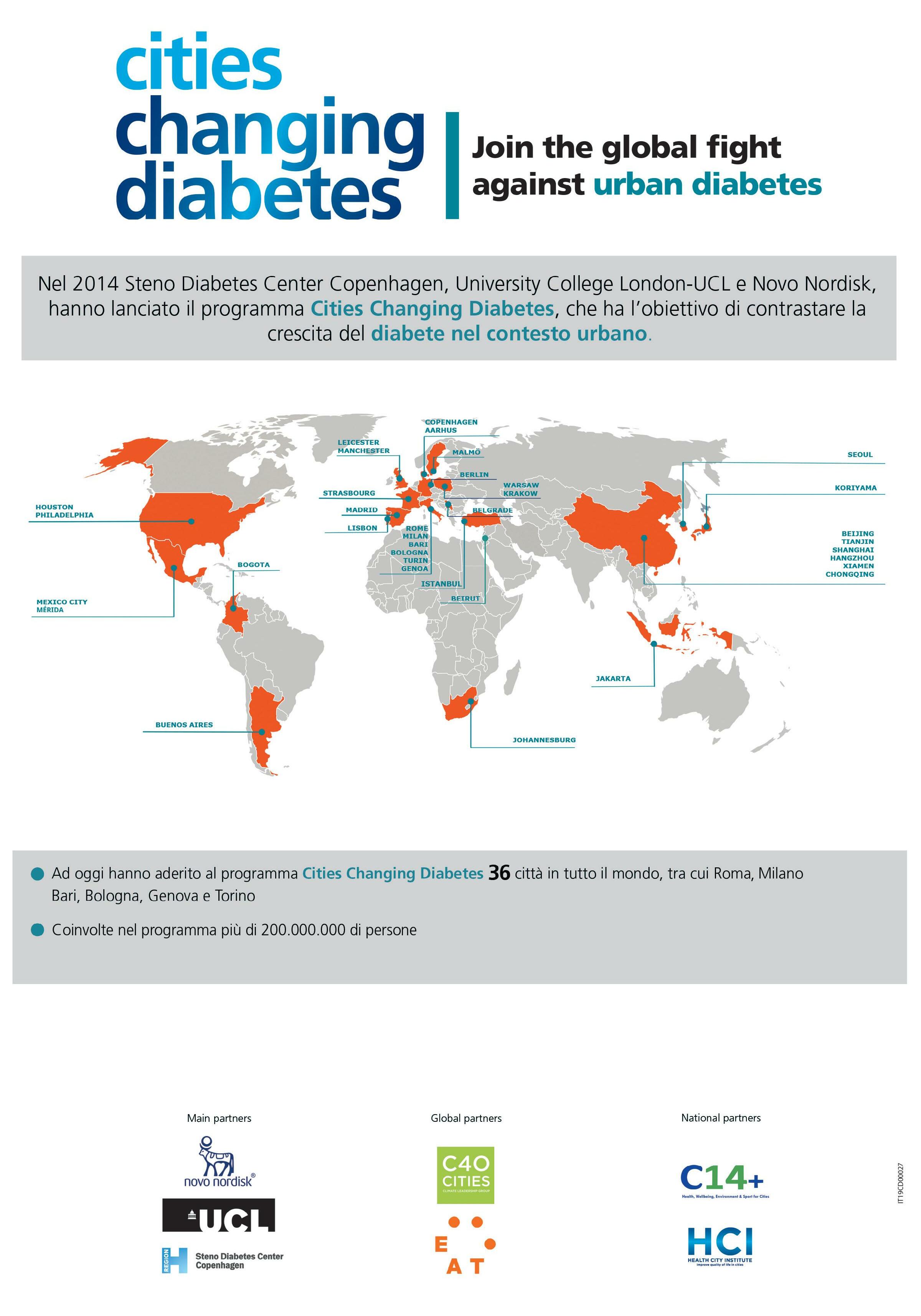
145




6















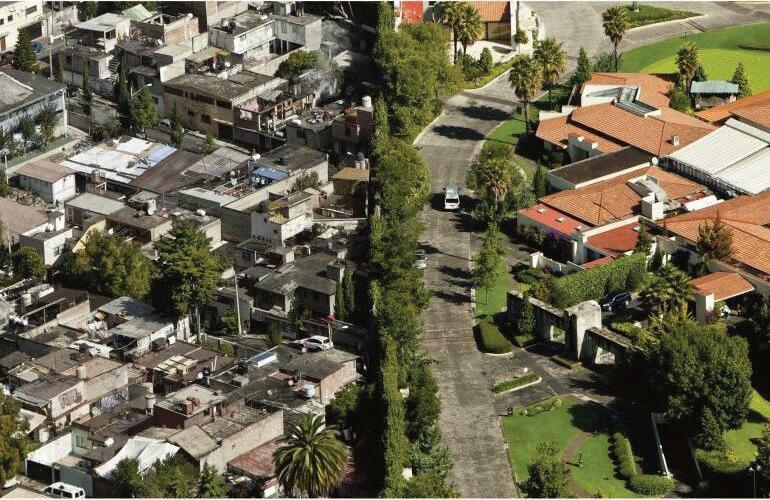







 Attraversamento del Santerno a Borgo Tossignano (Isolapress)
Attraversamento del Santerno a Borgo Tossignano (Isolapress)

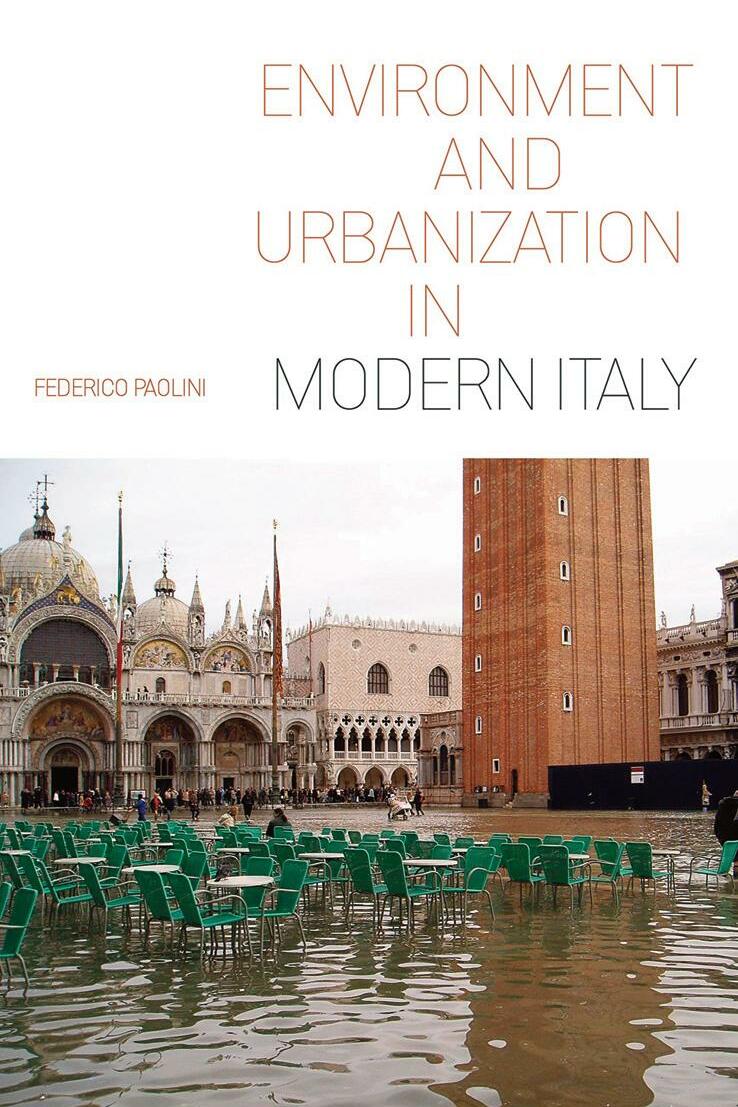







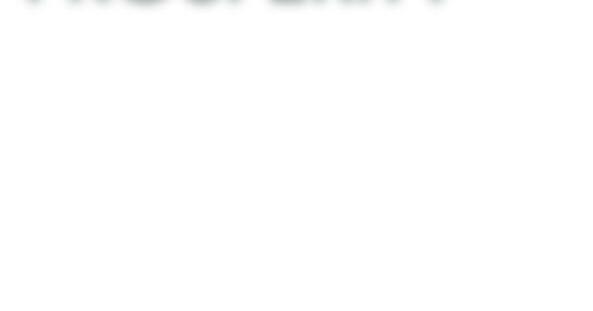




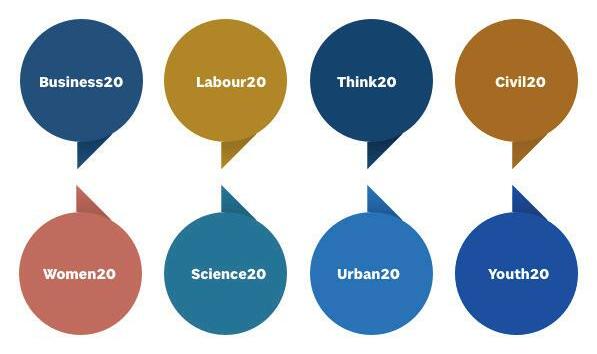





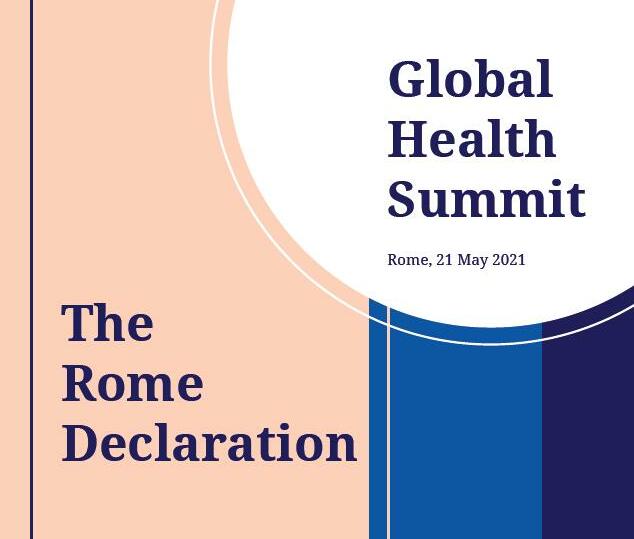






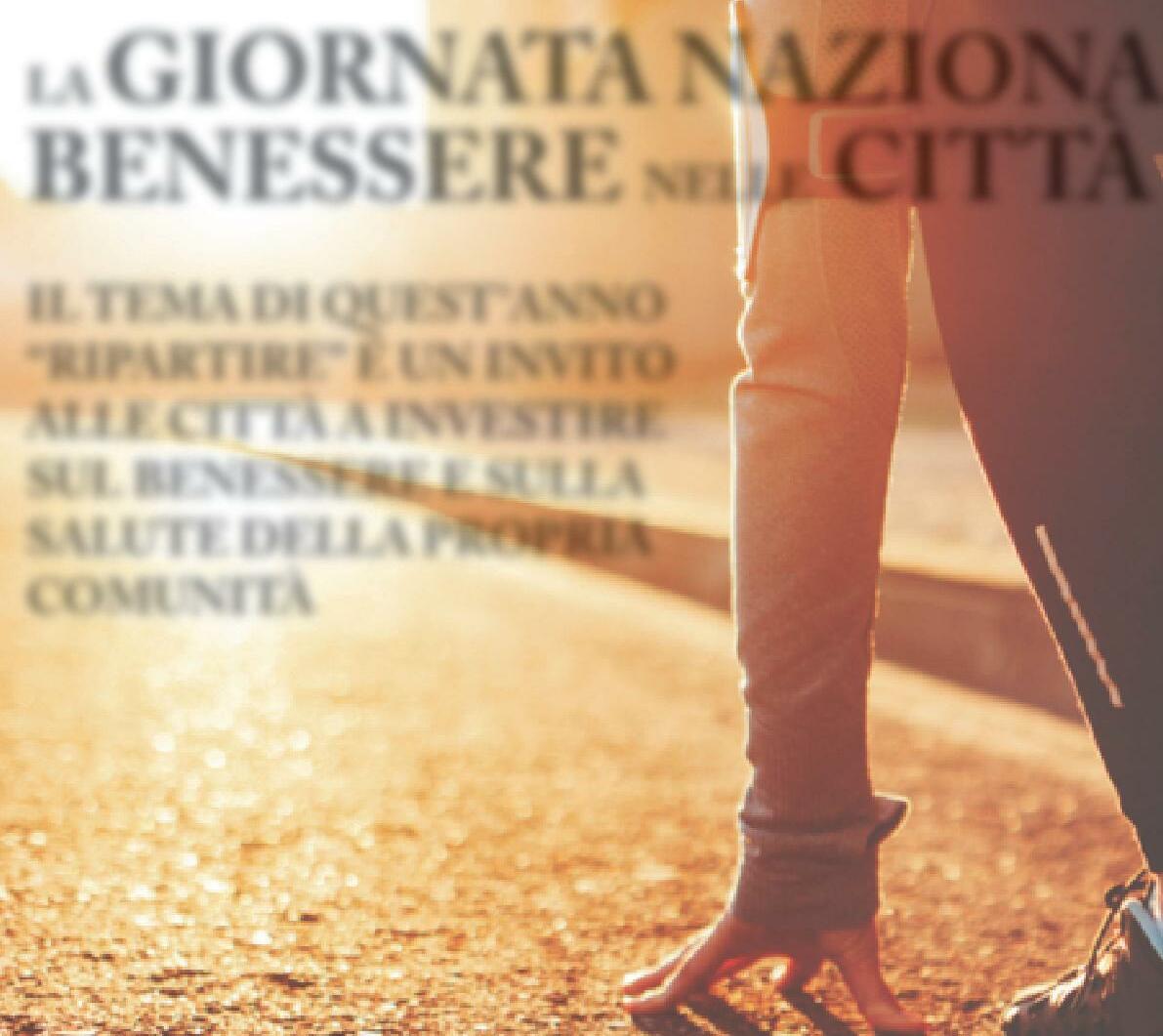



















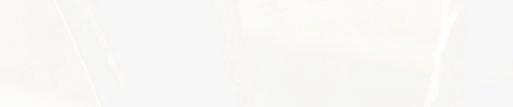












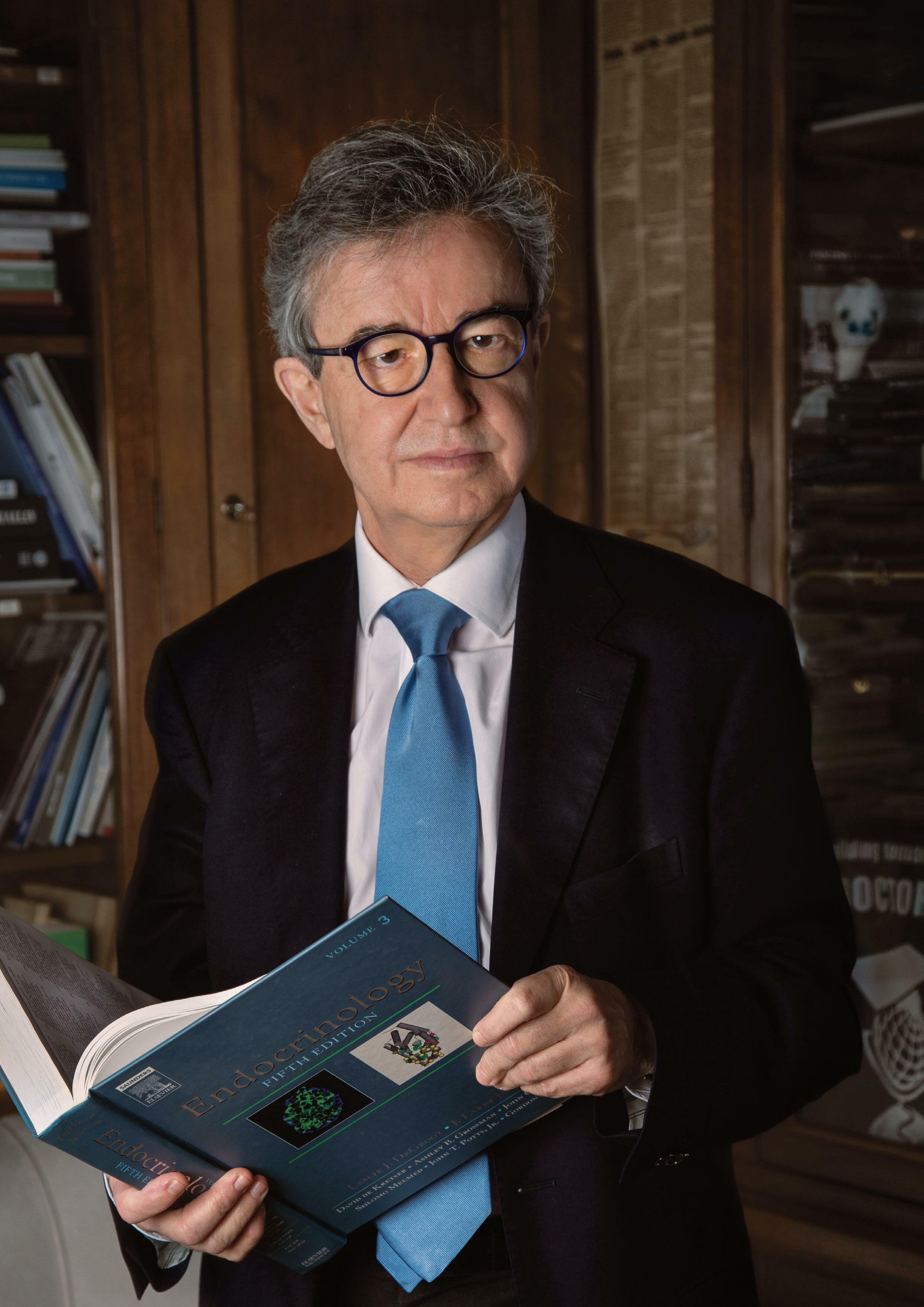
 46
di Roberto Pella Vicepresidente vicario ANCI e Presidente Intergruppo parlamentare “Qualità di vita nelle città”
46
di Roberto Pella Vicepresidente vicario ANCI e Presidente Intergruppo parlamentare “Qualità di vita nelle città”
 di Enzo Bianco Presidente Consiglio Nazionale ANCI e Presidente C14+
di Enzo Bianco Presidente Consiglio Nazionale ANCI e Presidente C14+



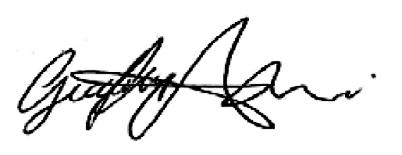






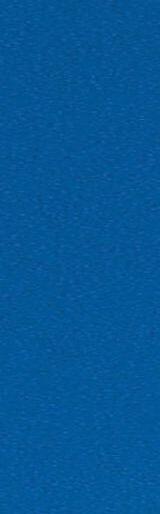







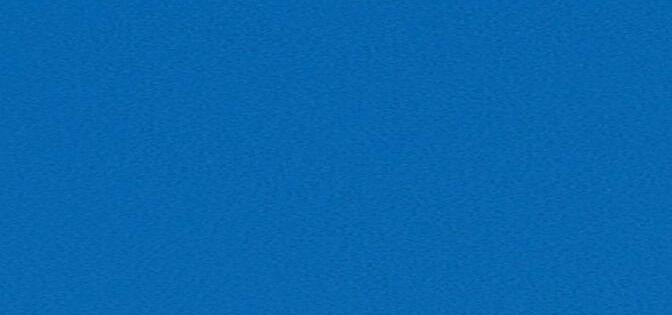


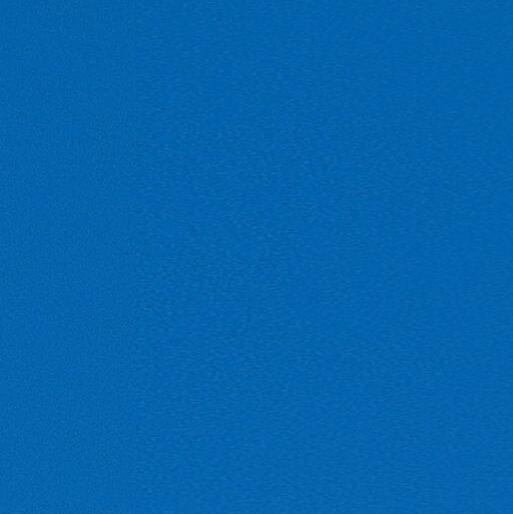

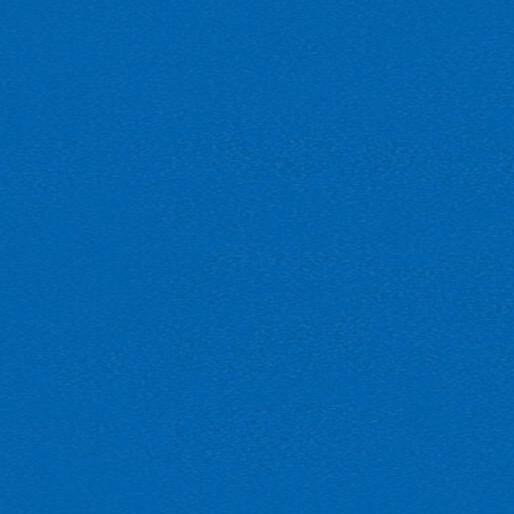










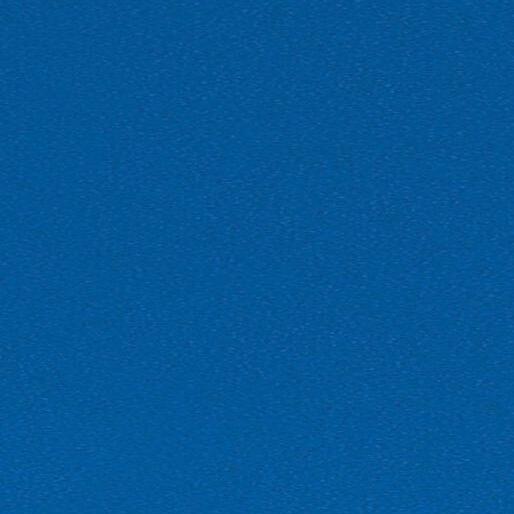




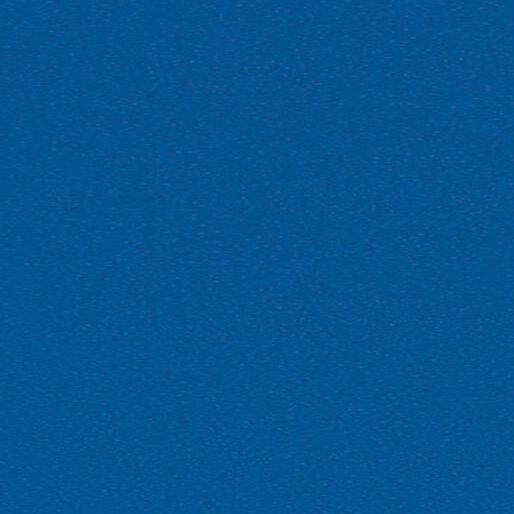

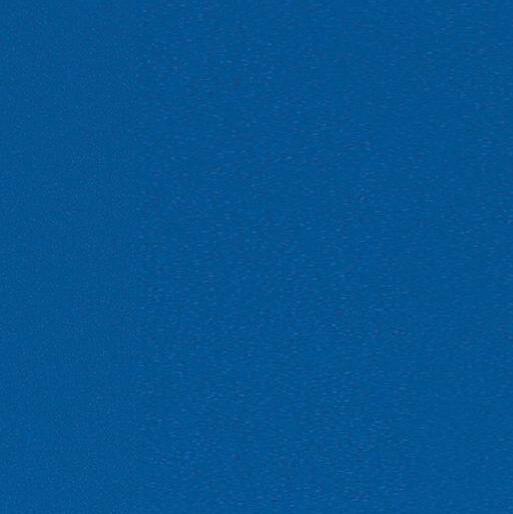
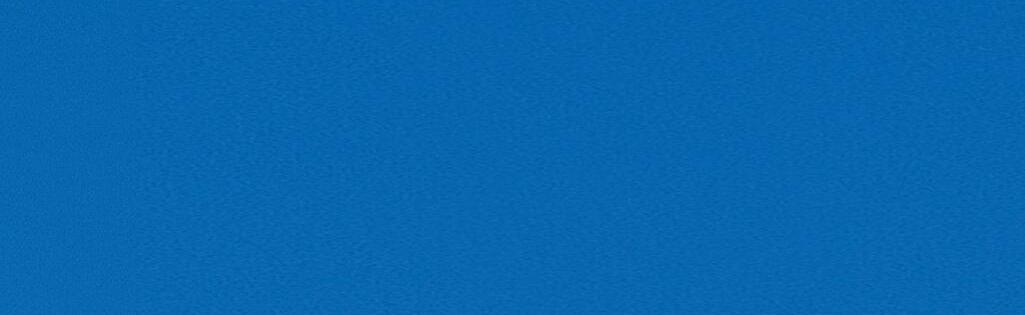
















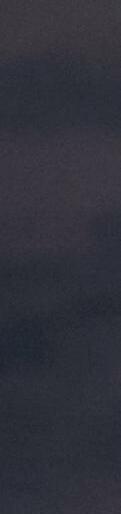






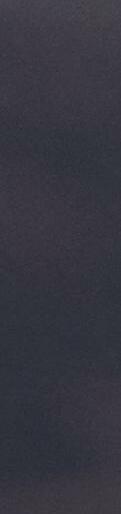







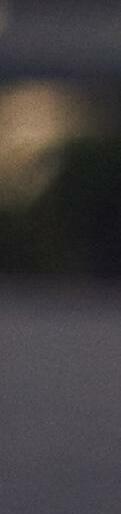









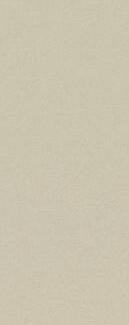




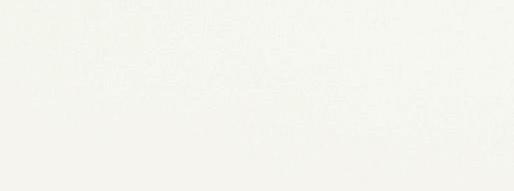

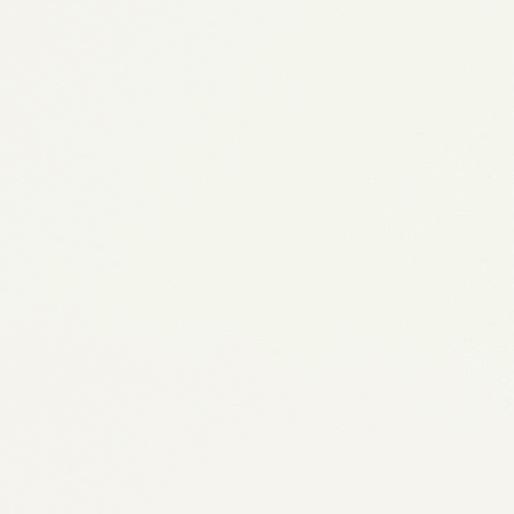
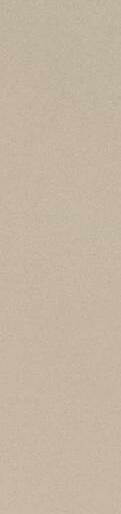

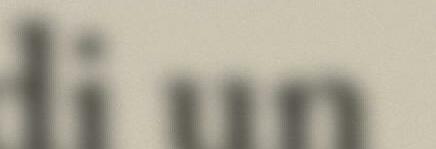




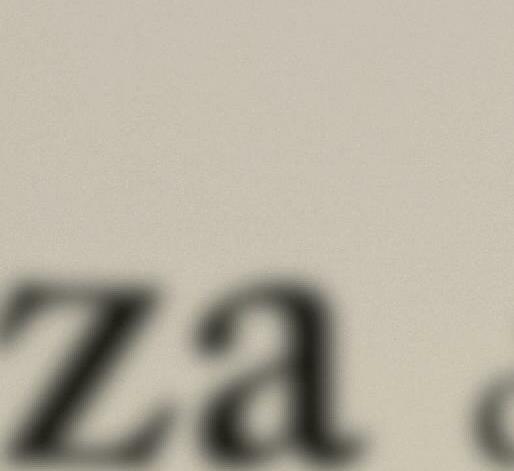
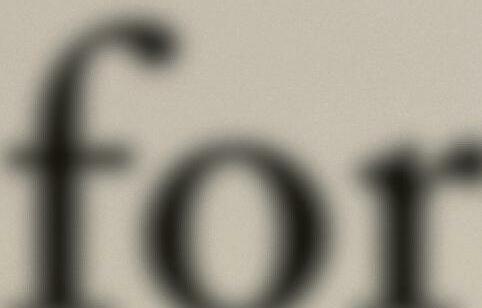
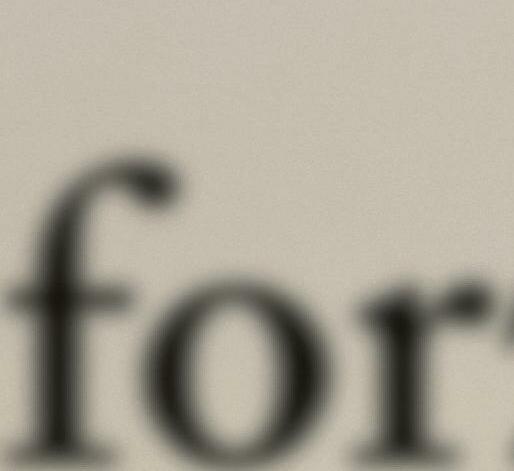
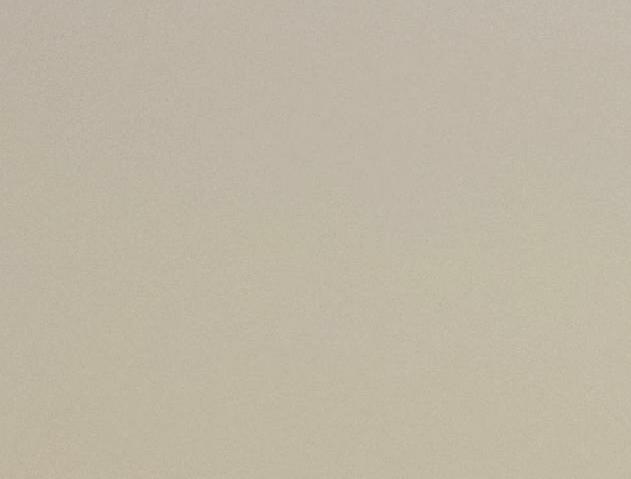
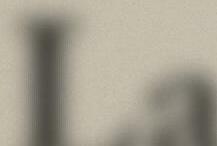


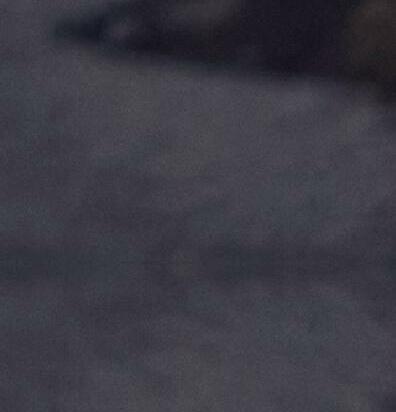













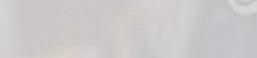

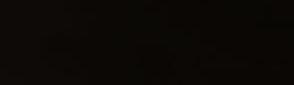

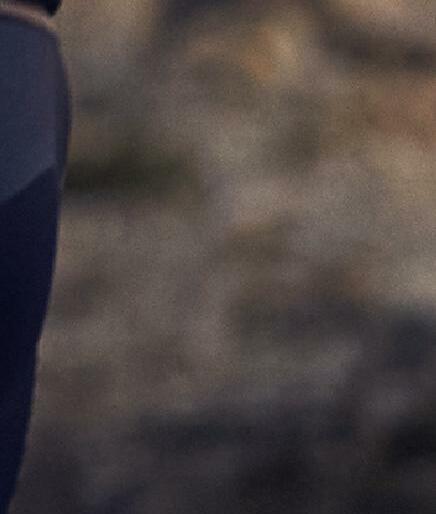



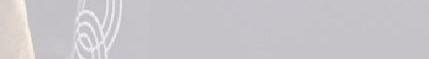

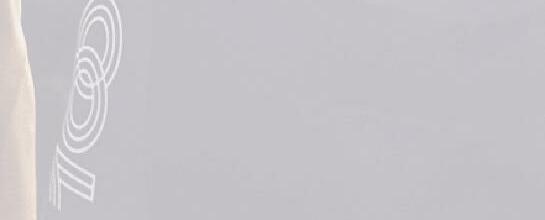











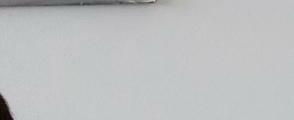


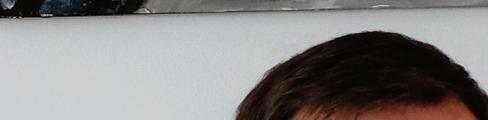







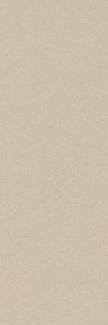


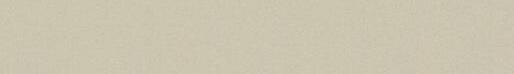

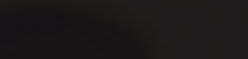





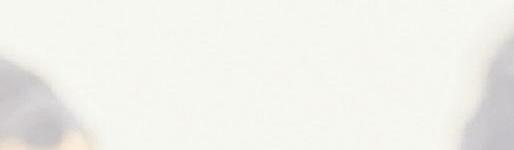


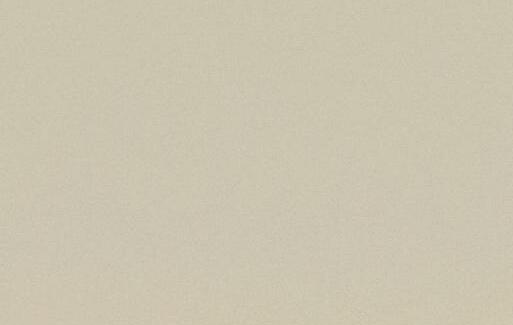




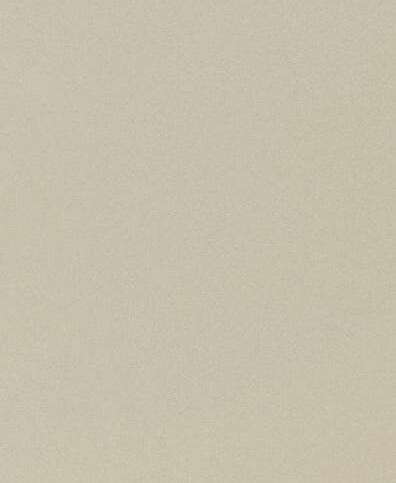

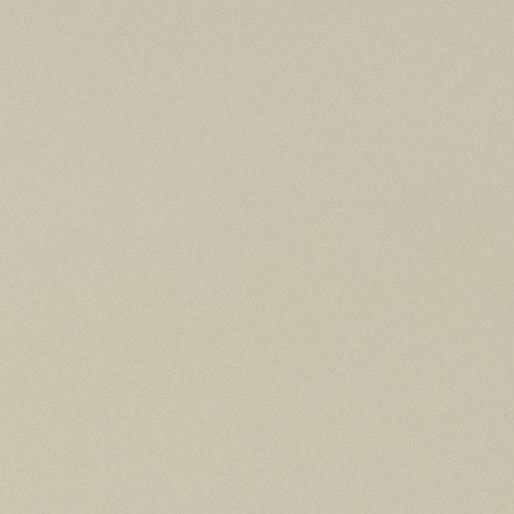
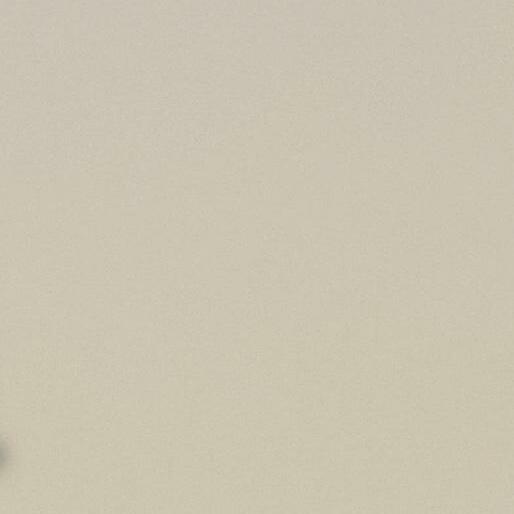

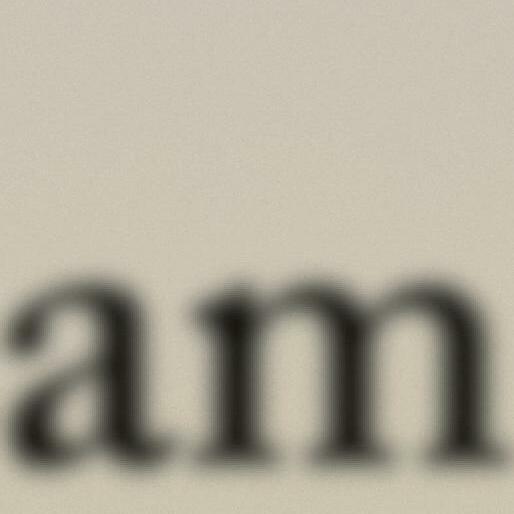
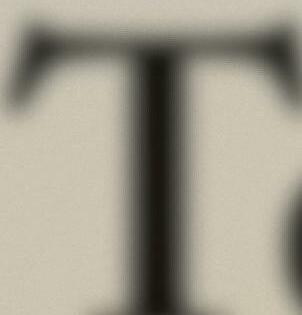

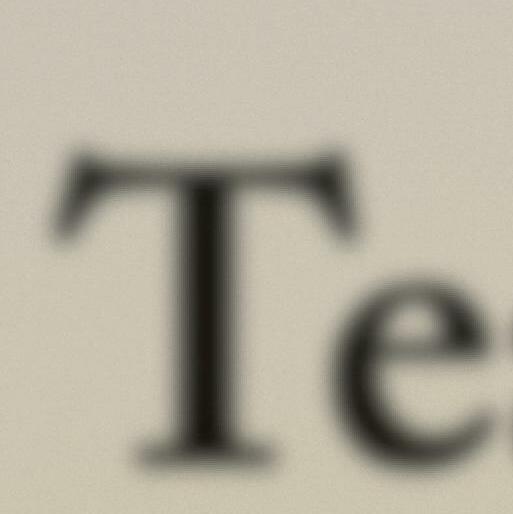





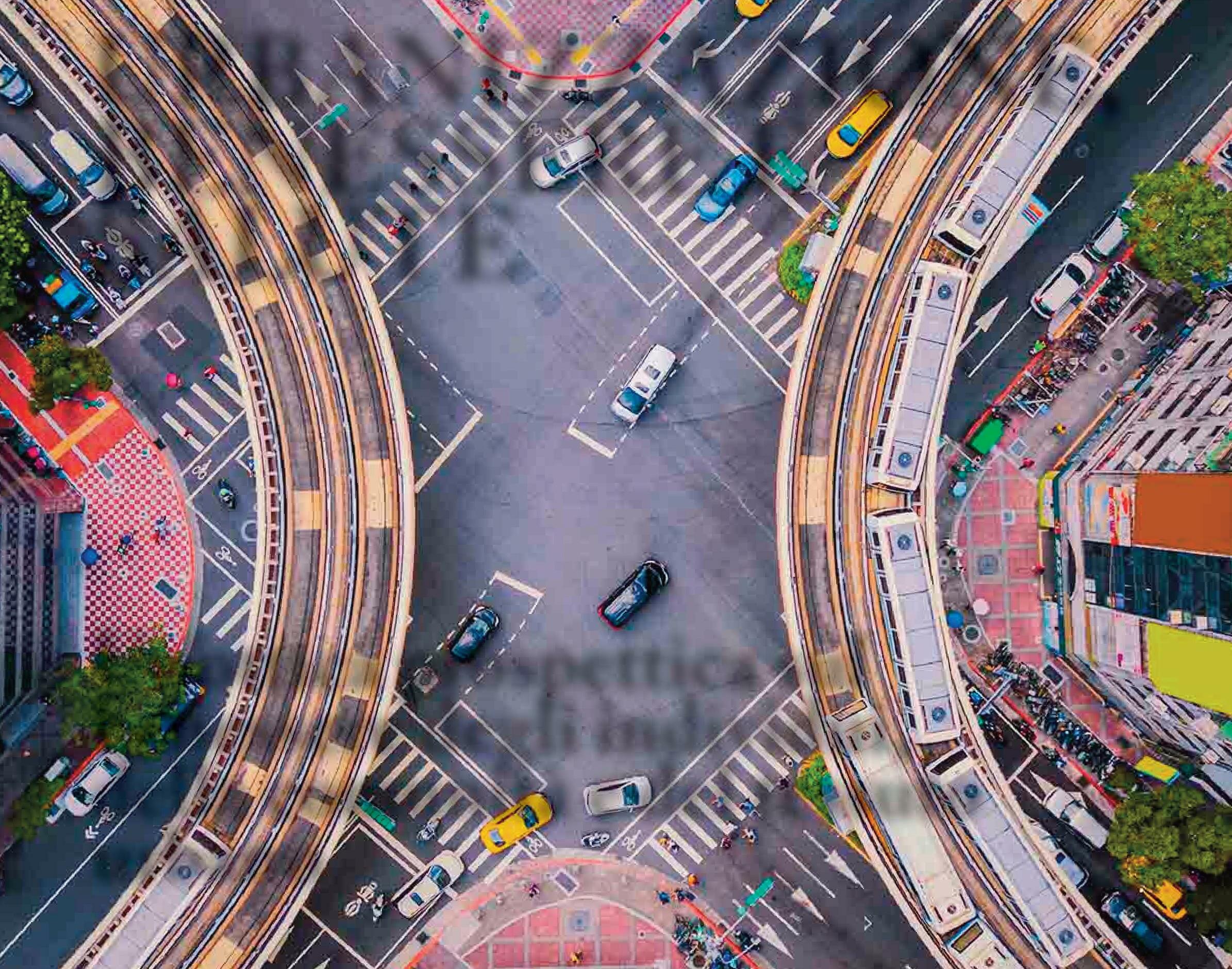

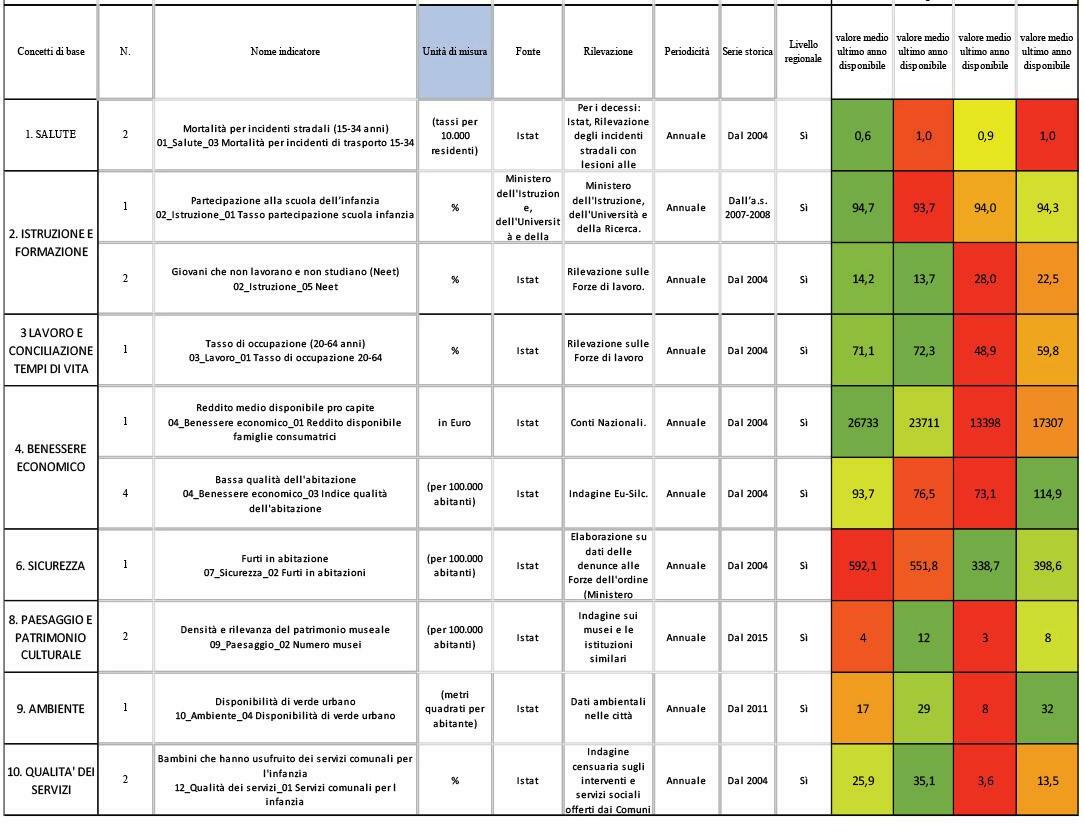

 di Frederik Greenhouse
di Frederik Greenhouse







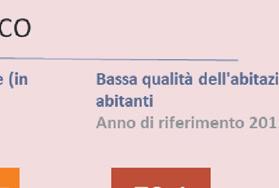

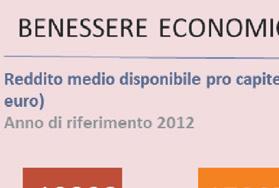




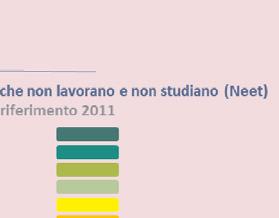

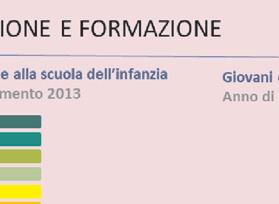






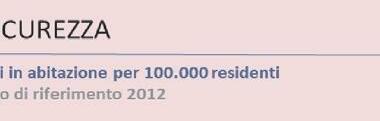







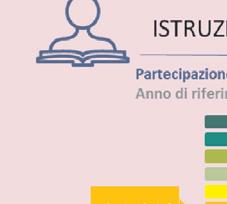


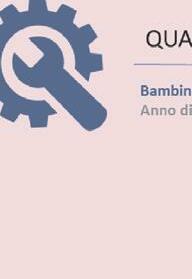







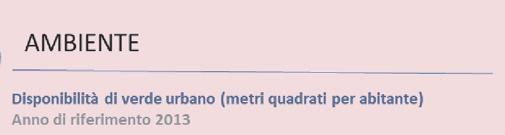
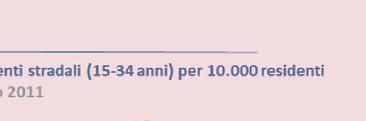
 di Frederik Greenhouse
di Frederik Greenhouse