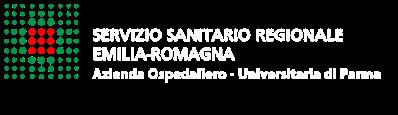

IL NUOVO OSPEDALE
DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

ATTRAVERSO IL DISEGNO ATTENTO DEGLI
AMBIENTI, LA QUALITÀ E LA GARANZIA DELLE
RELAZIONI, L’APPLICAZIONE DELLE PIÙ AVANZATE
TECNOLOGIE CLINICHE E LE MIGLIORI CONDIZIONI
DI COMFORT AMBIENTALE E DI STIMOLI
SENSORIALI, L’ARCHITETTURA DIVENTA INTERPRETE
ATTIVA DI UN GRANDE PROCESSO DI INNOVAZIONE, IN GRADO DI INCIDERE POSITIVAMENTE NEL
QUOTIDIANO PERCORSO DI CURA DEL BAMBINO E
DELL’ADOLESCENTE MALATI
CREDITS
COMMITTENTE
Fondazione Ospedale dei Bambini di Parma o.n.l.u.s.
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Sergio Beccarelli Architetto
Coordinatore e responsabile della progettazione architettonica e della direzione artistica dei lavori
Pier Paolo Corchia Ingegnere
Filippo Viaro Ingegnere


Paolo Brescia Architetto
Tommaso Principi Architetto
PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Pier Paolo Corchia Ingegnere
Responsabile della progettazione strutturale e della direzione operativa dei lavori
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E DATI
Luciano Zanni Ingegnere
Responsabile della progettazione e della direzione operativa dei lavori
PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI
Filippo Borrini Ingegnere
Responsabile della progettazione e della direzione operativa dei lavori
Ubaldo Nocera Ingegnere
STUDIO GEOLOGICO - GEOTECNICO
Carlo Caleffi Geologo
Francesco Cerutti Geologo
STUDIO ACUSTICO E PROGETTO SICUREZZA
STUDIO QSA
Gabriella Magri Ingegnere
PROGETTAZIONE INTEGRATA DEGLI ARREDI
Sergio Beccarelli Architetto
Responsabile della progettazione e della direzione operativa dei lavori
PROGETTO SANITARIO E MODELLO PEDIATRICO
Giancarlo Izzi Dottore
Direttore della struttura complessa Pediatria e oncoematologia - Dipartimento Materno Infantile
CONSULENTI PER GLI STUDI SPECIALISTICI IN COLLABORAZIONE CON
PSICOLOGIA AMBIENTALE
LIGHT DESIGN
SOUND MASKING E SOUND DESIGN
ACCESSIBILITÀ ED ERGONOMIA








Giuseppe Virciglio Psicologo
Paolo Bertozzi Ingegnere
Alessandro Carlo Bertetti Ingegnere
Michele Grigolini Ingegnere
CRIBA E.R. - Centro Regionale d’informazione sul Benessere Ambientale
Marco Bondani Architetto
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA



Documento di presentazione
IL NUOVO OSPEDALE
DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
5











PREMI E RICONOSCIMENTI

“LA CERAMICA E IL PROGETTO 2013”
VINCITORE NELLA CATEGORIA “ISTITUZIONALE”
Il nuovo Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” è stato selezionato quale progetto vincitore per la categoria “Istituzionale” del prestigioso concorso “La Ceramica e il Progetto 2013”, promosso da Confindustria Ceramica
“DIECI ANNI DI ARCHITETTURA: LE CENTO MIGLIORI OPERE REALIZZATE IN ITALIA”
PROGETTO SELEZIONATO
Il nuovo Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” è stato selezionato ed inserito da “Edilizia e Territorio” del Gruppo Sole 24 Ore nella prestigiosa classifica fra le cento migliori opere di architettura realizzate in Italia negli ultimi dieci anni
“THE PLAN AWARD 2015”
FINALISTA NELLA CATEGORIA “HEALTH”
Il nuovo Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” è stato selezionato quale progetto finalista per la categoria “Healt” (strutture e complessi sanitari) del prestigioso concorso “The Plan Award 2015”, promosso dalla rivista internazionale “The Plan - Architecture & Tecnologies in Detail”
“CENSIMENTO DELLE ARCHITETTURE ITALIANE DAL 1945 A OGGI”
IL PROGETTO DELL’OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA È STATO CENSITO IN QUANTO SODDISFA I SEGUENTI CRITERI DI VALUTAZIONE:
1. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale.
2. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale.
3. L’edificio o l’opera di architettura introduce e sperimenta significative innovazioni nell’uso dei materiali o nell’applicazione delle tecnologie costruttive.
4. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata.
MIC MINISTERO DELLA CULTURA
LA SOSTENIBILITÀ, L’ETICA ED IL RISPETTO DEL CONTESTO
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI / IL CANTIERE VERDE
SAPER LEGGERE ED INTERPRETARE IL CONTESTO
SODDISFARE I BISOGNI DELLA COLLETTIVITÀ
L’IMPLEMENTAZIONE DELL’OFFERTA DI SERVIZI IL COMFORT AMBIENTALE SOSTENIBILE
COMPETENZA, AFFIDABILITÀ E PROCESSO INTEGRATO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEI MATERIALI / L’INTEGRAZIONE FRA LA PROGETTAZIONE E IL PROCESSO COSTRUTTIVO PER IL RISPETTO DEI TEMPI DI COSTRUZIONE E DEL BUDGET

IL MODELLO PEDIATRICO DI RIFERIMENTO
SI RIFERISCE AGLI ODIERNI CRITERI DI ALLEANZA TERAPEUTICA, GRADUALITÀ
DELLA CURA E UMANIZZAZIONE DEGLI
AMBIENTI OSPEDALIERI, ASSECONDANDO
IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE “NON TUTTO DEL BAMBINO MALATO È MALATO”.
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
6

OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
COMMITTENTE: FONDAZIONE OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA onlus per conto di AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
LOCALITÀ: PARMA
ANNO: 2006/2013
IMPORTO DELLE OPERE: € 34.000.000
PRESTAZIONE: CONCEPT, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI STATO DI ATTUAZIONE: REALIZZATO
INAUGURAZIONE: GENNAIO 2013

L’Ospedale dei Bambini di Parma “Pietro Barilla”, del quale Policreo s.r.l. ha realizzato concept, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento di un team multidisciplinare di specialisti, è stato realizzato sulla base di un articolato quadro esigenziale, formulato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria, come primo obiettivo funzionale di un più ampio intervento afferente alla realizzazione del Nuovo Polo Materno Infantile; il modello pediatrico di riferimento si riferisce agli odierni criteri di alleanza terapeutica, gradualità della cura e umanizzazione degli ambienti ospedalieri, assecondando il principio secondo il quale “non tutto del bambino malato è malato”.
Un ospedale interpretato secondo questa chiave di lettura è chiamato a divenire un luogo estremamente stimolante dal punto di vista percettivo, offrendo opportunità ludiche, di svago e di creatività ai bambini e, al contempo, rispondere alle molteplici esigenze tecniche, funzionali e sanitarie garantendo i più elevati livelli di assistenza clinica, di comfort e qualità degli ambienti.
In quest’ottica il Nuovo Ospedale dei Bambini di Parma è la risultante dell’interazione e del dialogo costruttivo fra diverse competenze scientifiche e tecniche specialistiche opportunamente integrate e coordinate (progettisti, pedagogisti, psicologi ambientali e dell’età evolutiva, sound designers, specialisti nella facilitazione dell’accessibilità), supportate dalla puntuale condivisione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria finalizzata ad individuare le soluzioni più efficienti rispetto al quadro esigenziale e al modello sanitario. Tale percorso ha interessato la scala insediativa ed edilizia fino a raggiungere livelli di dettaglio relativi agli arredi e alle finiture interne perseguendo un approccio progettuale organico e integrato, ispirato ai criteri dell’umanizzazione e della psicologia ambientale per le diverse tipologie di ambienti e di utenti.
Particolari approfondimenti hanno riguardato la stanza di degenza, elemento cardine del Nuovo Ospedale dei Bambini, riconoscendo l’importanza di ricreare un luogo il più possibile domestico, accogliente e rassicurante in cui vengano favorite la relazione diretta e intima con il genitore e le opportunità di relazione e di gioco fra bambini, familiari e volontari.
Attraverso il disegno attento degli ambienti, la qualità e la garanzia delle relazioni, l’applicazione delle più avanzate
tecnologie cliniche e le migliori condizioni di comfort ambientale e di stimoli sensoriali, l’architettura diventa interprete attivo di un grande processo di innovazione, in grado di incidere positivamente nel quotidiano percorso di cura del bambino e dell’adolescente malati.
Il quadro esigenziale formulato dall’AOU di Parma prevede la riorganizzazione e l’accentramento dell’offerta sanitaria materno-infantile in un nuovo Polo Materno Infantile da realizzarsi con due sequenzialità funzionali e temporali. L’Ospedale dei Bambini accentra le funzioni di area neonatologica e pediatrica, degenza day hospital, area ambulatoriale polispecialistica, di transizione e adolescentologia, diagnostica per immagini, blocco operatorio, astanteria e aree di integrazione socioassistenziale, la distribuzione delle funzioni prevede la connessione e l’integrazione con il futuro Ospedale delle Mamme che comprenderà le funzioni afferenti a ginecologia e ostetricia e area Universitaria per didattica e ricerca.
L’Ospedale dei Bambini prevede una dotazione complessiva di 99 posti letto, per una superficie di circa 14000 m2, con un rapporto superficie/posto letto di 141,5 m2; le dotazioni a verde risultano pari a 1800 m2. Sono presenti 28 camere doppie (di cui 3 filtrate) e 14 singole filtrate suddivise fra degenza ordinaria, day hospital, degenza chirurgica e astanteria; gli ambienti di multidegenza sono suddivisi in Osservazione Neonatale (14 culle di cui 2 isolate), Terapia Intensiva Neonatale (6 posti letto isolati), Terapia intensiva pediatrica (4 posti letto isolati), Day Hospital Oncoematologico (5 posti di terapia); diverse camere singole sono state realizzate per consentirne l’ampliamento a degenze doppie.
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
7






1. Prospetto Nord 2. Stanza di degenza a 2 posti letto 3. Pronto soccorso 4. Area di ingresso al piano terra 5. Day Hospital 6.
centrale 1 3 4 5 6 2
Cavedio

A. area di futura realizzazione
“Ospedale delle Mamme” Lotto II - polo materno infantile
1. Ingresso veicolare da ambito ospedaliero
2. Ingresso pedonale da ambito ospedaliero (manutenzione, approvvigionamento locali personale)
3. Rampa di accesso al piano interrato
4. Accesso dedicato operatori sanitari
5. Ingresso operatori sanitari e consulenze interne
6. Ingresso principale
7. Camera calda
8. Ingresso mezzi di soccorso
9. Accesso pedonale di urgenza (astanteria)
10. Ingresso pedonale principale




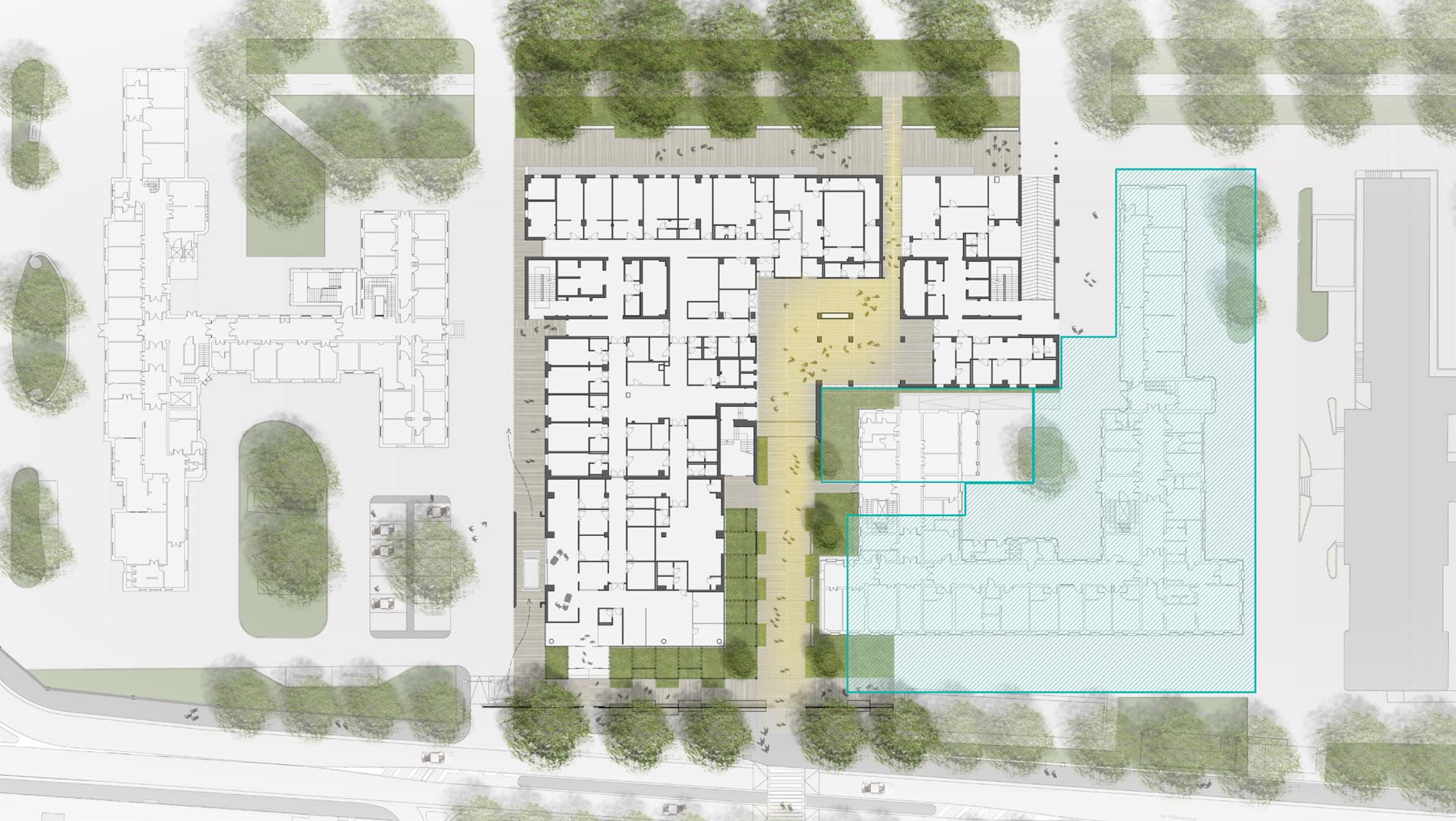
OSPEDALE DEI BAMBINI OSPEDALE DEI BAMBINI
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA 1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 A AMBITO TIPOLOGICO STORICO A PADIGLIONI OSPEDALE MAGGIORE DI PARMA AMBITO TIPOLOGICO A POLIBLOCCO 9


5° LIVELLO PIANO TERZO
4° LIVELLO PIANO SECONDO
2° LIVELLO PIANO TERRA
3° LIVELLO PIANO PRIMO
SUPERFICIE TOTALE 14.000 M2 TOTALE POSTI LETTO 99
TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA 4 posti letto isolati
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 6 posti letto isolati
OSSERVAZIONE NEONATALE 14 culle (di cui 2 isolate)
DAY HOSPITAL ONCOEMATOLOGICO 5 posti letto
CAMERE SINGOLE 14 filtrate
CAMERE DOPPIE 28 (di cui 3 filtrate)
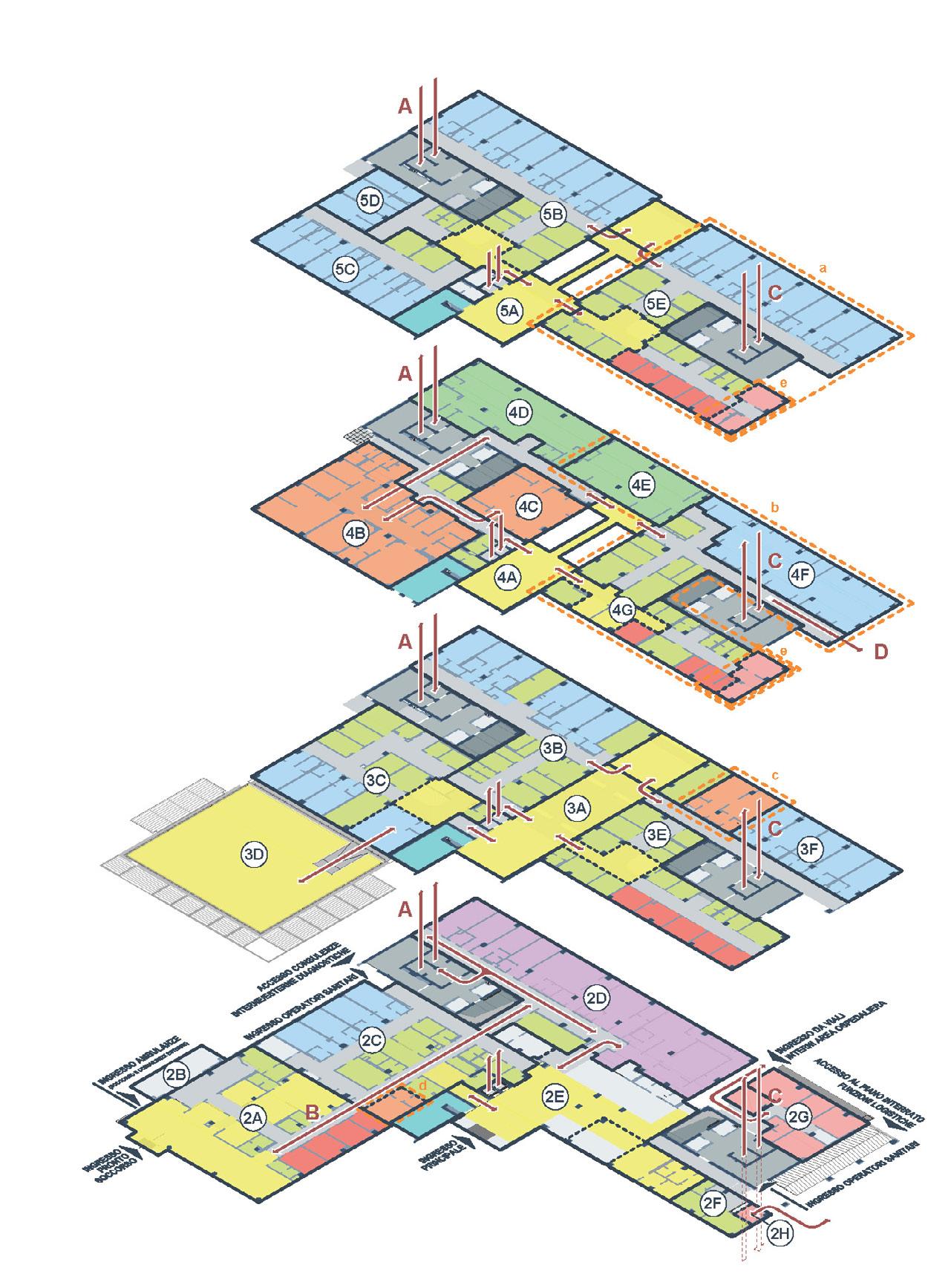
DEGENZE POLISPECIALISTICHE
AMBULATORI | MEDICHERIE
LOCALI PER ATTIVITÀ SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DI REPARTO PREVISTE DALL’ ACCREDITAMENTO ACCOGLIENZA | ATTESE | SOGGIORNI
COMPARTO OPERATORIO
TERAPIA INTENSIVA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
LOCALI CON DESTINAZIONI SPECIFICHE
SOLUZIONI DISTRIBUTIVE E FUNZIONALI
SOLUZIONI DISTRIBUTIVE SPECIFICHE
AREA DI DEGENZA POLISPECIALISTICA ATTIVABILE IN PERIODI EPIDEMIOLOGICAMENTE INTENSI
AREA DI NEONATOLOGIA IN PROSSIMITÀ DEL FUTURO “OSPEDALE DELLE MAMME”
PRESENZA DI AMBULATORIO ALL’INTERNO DELL’AREA DI DAY SURGERY / DAY HOSPITAL
AREA DI DEGENZA POLISPECIALISTICA ATTIVABILE IN PERIODI DI PICCO EPIDEMICO
COLLOCAZIONE PROTETTA DEI LOCALI DI OSSERVAZIONE SALMA NEGLI AMBITI DI DEGENZA b c d e a
SISTEMA DEI PERCORSI
OFFERTA VERTICALE DIRETTA DEL BLOCCO OPERATORIO, DI TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA E NEONATALE
PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON FUTURO “OSPEDALE DELLE MAMME” A B C D
LIVELLO 5° PIANO TERZO
RELAZIONE DIRETTA DA FUNZIONI DI ASSISTENZA E URGENZA ALLA DIAGNOSTICA
MONTALETTIGHE DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE LOGISTICA
ACCESSO AL PIANO - ATTESA
DEGENZA ORDINARIA POLISPECIALISTICA
DEGENZA ISOLATA PER PATOLOGIE DIFFUSIVE
CAMERE DI POTENZIALE IMPLEMENTAZIONE DELL’OFFERTA DEGENZIALE
DEGENZA ORDINARIA POLISPECIALISTICA
ACCESSO AL PIANO - ATTESA
COMPARTO OPERATORIO
OSSERVAZIONE E RISVEGLIO
TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
OSSERVAZIONE NEONATALE
ACCETTAZIONE E AMBULATORI VISITE NEONATOLOGICHE
ACCESSO AL PIANO - ATTESA
ONCOEMATOLOGIA
LIVELLO 3° PIANO PRIMO
DAY-HOSPITAL ONCOEMATOLOGIA
GIARDINO PENSILE
AMBULATORI DAY SURGERY - DAY HOSPITAL
DEGENZA DAY SURGERY - DAY HOSPITAL
ATTESA, ACCETTAZIONE TRIAGE LIVELLO 2° PIANO TERRA
CAMERA CALDA
OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
ATRIO INGRESSO PRINCIPALE(ATTESA DIAGNOSTICA E CAFFETTERIA)
PREPARAZIONE PAPPE / LATTI
AREA DIREZIONALE, FORMAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
NUCLEI SCALA PER GLI OPERATORI SANITARI
NUCLEI SCALA PER L’UTENZA CONNETTIVI
LOCALE
REDATTO
DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
DA:
5A 5B 5C 5D 5E
3A 3B 3C 3D 3E 3F
EMERGENZE
DEL FUOCO 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H LIVELLO
VIGILI
4° PIANO SECONDO
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G
10

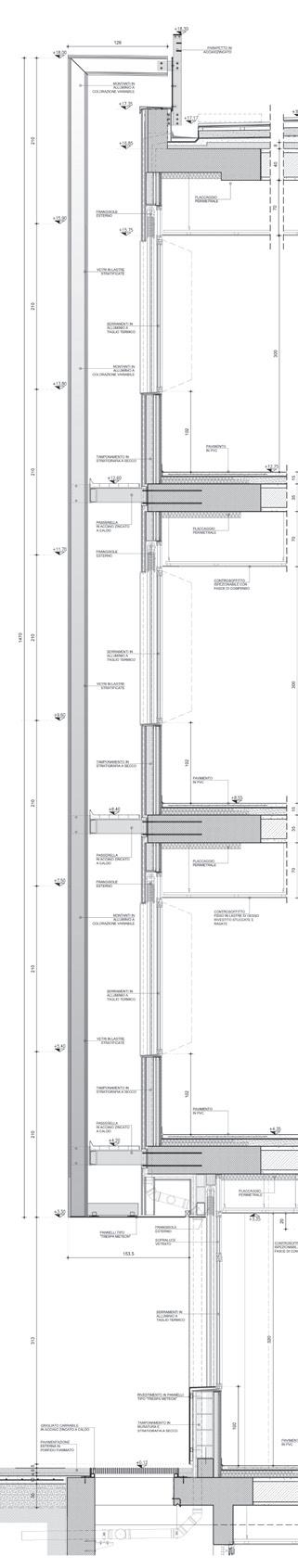

1. PACCHETTO DI COPERTURA
POTERE FONOISOLANTE RW 61 DB
TRASMITTANZA TERMICA 0,273 W/M2 K
SFASAMENTO > 24 H

2. SOLAIO INTERPIANO TIPO
TRA LOCALI RISCALDATI
POTERE FONOISOLANTE RW 56 DB

3. MURO ESTERNO DEI PIANI SUPERIORI CON SISTEMA A SECCO
POTERE FONOISOLANTE RW 66 DB
TRASMITTANZA TERMICA 0,267 W/M2 K
SFASAMENTO 15 H
POTERE FONOISOLANTE RW 56 DB
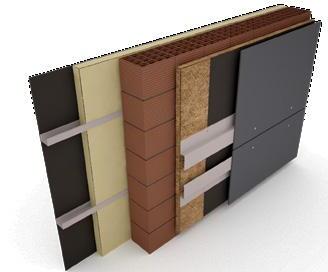
4. MURO ESTERNO DEL PIANO TERRA CON SISTEMA UMIDO
POTERE FONOISOLANTE RW 62 DB
TRASMITTANZA TERMICA 0,191 W/M2 K
SFASAMENTO 10 H




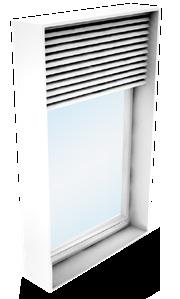
B. SERRAMENTO CON DISPOSITIVI DI OSCURAMENTO
POTERE FONOISOLANTE RW 45 DB
TRASMITTANZA TERMICA < 1,6 W/M2 K



SOLUZIONI DISTRIBUTIVE E FUNZIONALI
La morfologia architettonica e le soluzioni distributive adottate sono basate su schemi semplici e razionali al fine di assicurare ottimali interrelazioni fra funzioni interne ed esterne, l’impianto distributivo prevede l’organizzazione dei reparti di degenza per aree omogenee e per intensità di cura, sono state inoltre applicate le soluzioni più appropriate per garantire la massima fruibilità da parte degli utenti prevedendo un sistema di accessi dedicati, la collocazione dei servizi generali in aree facilmente accessibili dall’esterno, e l’aggregazione di tutti i servizi di diagnosi e cura senza posti letto.
I percorsi interni sono suddivisi lungo due direttrici principali: una riservata al pubblico ed una, più interna, ai flussi di tipo operativo, i visitatori accedono attraverso percorsi controllati, chiaramente identificabili e riconoscibili mentre appositi nuclei contenenti scale, montalettighe/montacarichi, sono predisposti per il collegamento verticale del personale, dei degenti e delle merci.L’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche sono elemento fondamentale nella definizione dei percorsi e degli itinerari per il Nuovo Ospedale dei Bambini, la collaborazione con il centro CRIBA di Reggio Emilia ha consentito di massimizzare la facilitazione della fruizione degli ambienti a tutte le categorie di utenti.
UN OSPEDALE ACCOGLIENTE, FAMILIARE E ATTENTO ALL’AMBIENTE
Nel nuovo ospedale dei Bambini di Parma la massima efficienza e funzionalità rispetto agli aspetti diagnostici, terapeutici, tecnologici trovano un ideale punto di contatto con la confortevolezza sostenibile degli ambienti, in termini di spaziosità, luminosità, colore, suoni, facilità di orientamento e possibilità di vivere sia spazi di privacy sia spazi relazionali. Le caratteristiche prestazionali ambientali, microclimatiche ed il benessere termico delle varie aree sono assicurate dalla scelta dell’orientamento dell’edificio e da innovative soluzioni tecnologiche integrate con la progettazione impiantistica. L’involucro dell’edificio è caratterizzato da una prima “pelle” prestazionale costituita da un tamponamento perimetrale ad alta efficienza di isolamento termico e acustico e serramenti vetrati a taglio termico; la seconda pelle, realizzata con elementi verticali in vetro temperato, stratificato e con particolari caratteristiche di protezione emissiva regola il livello di interazione climatica tra interno ed esterno caratterizzandosi, inoltre, come l’elemento identitario della struttura. I pacchetti murari previsti si differenziano a seconda del livello edilizio, prevedendo tecnologie a umido per il piano terra e partizioni verticali realizzate con tecnologia stratificata a secco per i livelli superiori, aumentando notevolmente la flessibilità e la sostenibilità dell’edificio in tutte le fasi del proprio ciclo di vita.
L’impiego di sistemi tecnologici innovativi, materiali naturali ed ecologici e di accorgimenti volti a ottenere la massima efficienza prestazionale dell’edificio, favoriscono il massimo comfort degli ambienti minimizzando al contempo i consumi energetici rendendo il Nuovo Ospedale dei Bambini un edificio sostenibile e rispettoso dell’ambiente.
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
A. FACCIATA PRESTAZIONALE INTEGRATA
1 2 3 4 A B 11
REDATTO DA:
LA QUALITÀ DELLA LUCE
L’illuminazione di ogni ambiente è stata studiata in base alla diversificazione delle funzioni: spazi di attesa, degenze, percorsi, luoghi di lavoro e ambulatori presentano scenari luminosi personalizzabili che integrano luce artificiale, con intensità e temperature opportune, alla luce naturale.
Un orientamento ottimale e specifiche analisi parametriche hanno condotto a definire le superfici illuminanti più consone ai diversi ambienti garantendo adeguati livelli di illuminazione naturale, nella consapevolezza del ruolo che riveste l’ambiente luminoso nel percorso di cura.



LA PSICOLOGIA AMBIENTALE
Specifiche analisi sulla psicologia ambientale hanno condotto a definire le finiture cromatiche, tattili, sonore e olfattive più appropriate per le diverse tipologie di ambienti.
Sono stati definiti ambienti sonori e olfattivi particolari negli spazi di relazione e, in maniera più personalizzabile, nelle degenze ottenendo una stimolazione multisensoriale volta a favorire il percorso di guarigione; è’ stata inoltre sviluppata una mappa sonora che individua le zone più sensibili e ad alto livello di privacy prevedendo opportuni isolamenti acustici supportati da sistemi di sound masking.

IL PROGETTO INTEGRATO DEGLI ARREDI
Le soluzioni architettoniche mirate alla realizzazione di un ospedale a misura di bambino sono state rafforzate attraverso un progetto integrato degli arredi che prevede inoltre l’impiego di soluzioni su misura o commerciali contribuendo a ricreare un ambiente familiare, di elevato comfort e qualità estetica anche nei luoghi dedicati al lavoro medici e operatori, nonchè a stimolare fantasia e creatività degli adolescenti e dei piccoli pazienti con elementi ludici e sensoriali; il cablaggio degli arredi consente inoltre maggior fruibilità e accessibilità degli ambienti e più elevati livelli di sicurezza per pazienti e operatori.




1. Studio illuminotecnico
2. Ingresso dell’Ospedale dei Bambini
3. Day Hospital
4. Ambulatorio medico
5. Soggiorno
DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
1 2 3 4 5 12


IMPIANTI MECCANICI
Gli impianti meccanici a servizio e corredo del nuovo fabbricato di Pediatria si inseriscono nella rete generale di distribuzione impiantistica dell’Ospedale. La produzione del calore destinato al riscaldamento ambientale è realizzata dalle sottostazioni di scambio termico ubicate al piano interrato. Il fluido caldo ed il vapore sono prelevati dalla rete generale dell’Ospedale. La sottostazione termica è costituita da due scambiatori di calore a piastra per una potenza scambiata di circa 2’000 kW cad. di cui uno è di scorta all’altro. Le pompe ed il collettore acqua calda sono installati nel locale tecnico al piano interrato; esso è dotato di n° 3 partenze con relative pompe di circolazione: un circuito per le batterie di riscaldamento sulle CTA e per le batterie di postriscaldamento in ambiente, un circuito acqua calda alle travi fredde 4 tubi ed un circuito per il primario ai bollitori produttori di acs.
La produzione di acqua refrigerata è effettuata da due refrigeratori di acqua monoblocco con condensazione ad aria del tipo a bassa emissione sonora dotato di compressori scroll e fluido frigorigeno R410a a basso impatto sullo strato di ozono stratosferico dimensionati per fornire una potenza frigorifera complessiva di 1’650 kW. Le pompe ed il collettore acqua refrigerata sono ubicati nel locale tecnico in copertura, vicino alla zona dei refrigeratori; il collettore freddo è dotato di due partenze con relative pompe di circolazione, una per le batterie acqua refrigerata delle CTA ed una per il circuito refrigerato delle travi a quattro tubi.
La produzione di acqua calda sanitaria è effettuata mediante N°2 accumulatori di acqua tecnica da 5’000 Litri cadauna al cui interno è presente un serpentino per la produzione istantanea. I termo accumuli sono integrati da scambiatore sferico alimentato da impianto solare termico in copertura per una superficie captante di circa 80 m2. L’acqua fredda a servizio delle cassette WC è alimentata e distribuita con un circuito a parte per l’eventuale impiego di acqua di recupero. Tutta l’acqua fredda potabile, ad eccezione di quella dei WC, è trattata da impianto di addolcimento. A servizio dell’impianto di produzione dell’ACS è presente un sistema di dosaggio di biossido di cloro per la disinfezione antilegionella. Le tubazioni dell’acqua fredda e calda potabile sono realizzate in AISI 316 con raccordi a pinzare, mentre quelle a servizio dei WC sono realizzate in multistrato.
Il vapore sterile per umidificazione è ottenuto con N°1 generatore indiretto completamente in acciaio inox. Lo scambiatore a fascio tubiero è alimentato con vapore di centrale in circuito chiuso da rete generale a servizio dell’intero comparto ospedaliero. Si è stimato un fabbisogno di vapore saturo da rete generale pari a 1360 kg/h a 5,5 bar. Dal lato mantello lo scambiatore è alimentato con acqua osmotizzata che evapora per produrre il vapore di consumo a perdere. La distribuzione del vapore sterile avviene con reti ed accessori in acciaio nero ad eccezione degli scaricatori di condensa. Il generatore è dotato di sistema automatico di spurgo in funzione del contenuto salino dell’acqua al fine di evitare incrostazioni.
L’impianto di climatizzazione a servizio delle degenze, degli ambulatori e dei locali a bassa specializzazione sanitaria è del tipo misto con aria primaria e terminali del tipo a Trave Fredda.
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
A B C D E F A B C D E F 13
L’impianto di climatizzazione a servizio degli ambienti ad alta specializzazione sanitaria (tarapie intensive, neonatologia, comparto operatorio, ecc...) è del tipo a tutt’aria.
Le degenze filtrate sono servite da impianto a tutt’aria con batteria di postriscaldamento installata sul canale di mandata in ambiente: l’aria è immessa attraverso diffusori a getto elicoidale con filtro assoluto a bordo (H13) ed è ripresa da griglie a frontalino forato 60 x 60 cm installate a controsoffitto. Le degenze filtrate sono dotate di sofisticato sistema di regolazione della portata d’aria con valvole di regolazione a profilo venturi con controllo elettronico ad altissima precisione della portata d’aria in mandata e ripresa, con possibilità di commutazione di polarità; sono installate per ogni degenza n° 5 valvole, rispettivamente sul canale di mandata e sul canale di ripresa della degenza, sul canale di mandata e sul canale di ripresa del filtro e sul canale di estrazione del bagno.
All’esterno della degenza, sulla parete divisoria dal corridoio, verrà posizionato un monitor di controllo per sistema di commutazione di polarità (da infettivi a immuno depressi) e per la visualizzazione dello stato di pressione della stanza. Il controllo della temperatura in questi ambienti avverrà tramite sonde con potenziometro installate negli ambienti serviti, che controlleranno le valvole di regolazione a due / tre vie della batterie di postriscaldo installate in controsoffitto. Non è possibile un controllo diretto dell’umidità ambiente, che viene regolata come valore “medio di zona” dall’impianto di ventilazione meccanica.
La supervisione e la regolazione automatica degli impianti di climatizzazione è eseguita da un sistema di Building Management (BMS) costituito da una unità centrale composta da un PC, video a colori, stampante e scheda di comunicazione. L’unità centrale è in grado di visualizzare a video, secondo schemi funzionali già utilizzati dalla Azienda Ospedaliera, sia le centrali termo frigorifere, che le centrali di trattamento dell’aria che i regolatori ambiente. E’ inoltre in grado di visualizzare e modificare i set point, di temperatura dei fluidi e temperatura ambiente, i valori letti dalle sonde, la percentuale di apertura dei servomotori, lo stato e l’allarme delle pompe, dei ventilatori.
L’impianto di distribuzione di gas medicinali ha una configurazione ad anello in modo tale che ogni compartimento antincendio (tipicamente mezzo piano) possa essere intercettato senza creare disservizi agli altri. Le alimentazioni di O2, la CO2 e il N2O sono derivate dalla rete generale del comparto Ospedaliero mentre il vuoto Endocavitario e l’aria medicinale e tecnica sono garantite da centrali a servizio esclusivo del fabbricato posta al piano interrato.
L’impianto è stato progettato e realizzato per soddisfare le contemporaneità massime di funzionamento delle prese terminali definite dagli standard in uso dalla AO.PR.
L’impianto idrico antincendio sarà alimentato dalla rete idrica generale dell’ospedale. La protezione interna è garantita da N°62 idranti UNI45 da incasso a parete disposti nel rispetto della UNI 10779, mentre la protezione esterna è affidata a idranti soprasuolo UNI70 disposti lungo il perimetro del fabbricato ad una distanza l’uno dall’altro non superiore a 60 m e a circa 7 m dal filo del fabbricato.
Essendo il fabbricato dotato di facciata del tipo a doppia pelle si è deciso di rispettare la circolare 5643 del 31/03/2010 recante i “Requisiti di sicurezza antincendio nelle facciate
degli edifici civili”. Dal punto di vista dell’impianto idirico antincendio questa ha compartato la progettazione e l’installazione di impianto sprinkler a diluvio in grado di erogare 10 l/min a m nelle zone di facciata sovrastanti le uscite di sicurezza. Sono quindi presenti n°4 valvole sprinkler a diluvio ciascuna a servizio di una zona attivabile singolarmente mediante pulsante manuale collocato nel locale di gestione delle emergenze. Lungo la viabilità di accesso degli automezzi dei VV.F. sono presenti in apposito manufato segnalato e protetti contro il gelo n°3 attacchi motopompa conformi alla UNI 10779 a servizio singolarmente dei seguenti circuiti: sprinkler, idranti interni UNI45 e idranti esterni UNI70. E’ inoltre presente all’interno dello stesso manufatto un attacco di prelievo utile ai VVF per il riempimento dell’autobotte in caso di incendio in altro edificio.
REDATTO DA:

1. Schema generale di impianto di climatizzazione
2. Sistema di controllo delle pressioni e delle portate
3. Trave fredda
4. Degenza polispecialistica
5. Osservazione neonatale
6. Sala operatoria
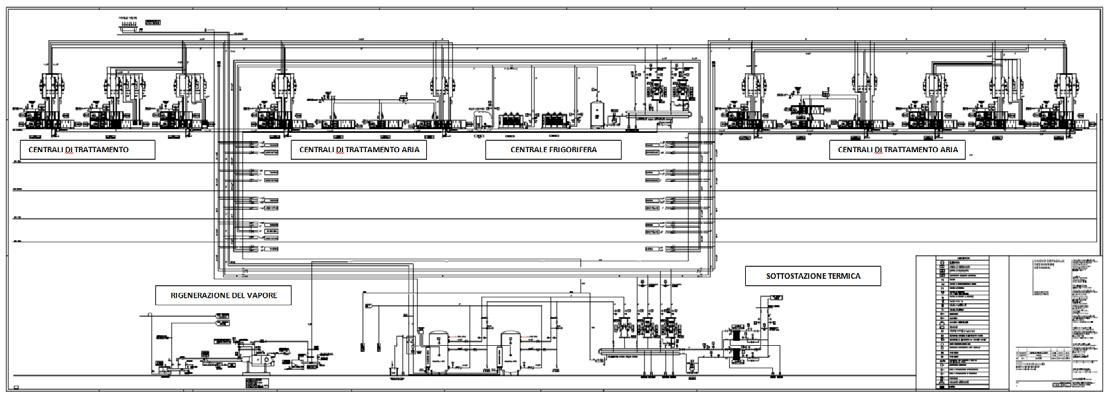
1
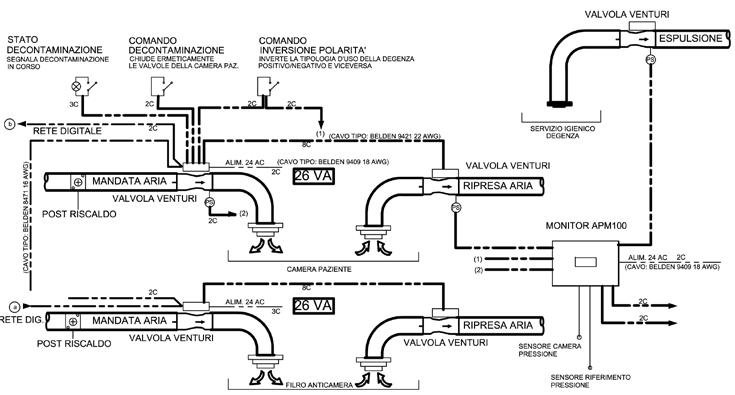

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
2
3 14
REDATTO DA:

Note:
A. Gas medicali integrati nell’arredo
B. Trave fredda
C. Griglie di mandata e di ripresa Integrate nel controsoffitto metallico a tenuta
D. Gas medicinali
E. Diffusore
F. Griglie di ripresa



DEGENZA POLISPECIALISTICA
Le degenze ordinarie, oltre agli studi medici, alle attese ed ai corridoi, sono servite da impianto di climatizzazione del tipo misto con aria primaria e travi fredde a quattro tubi. Le travi fredde sono installate a controsoffitto dei vari ambienti; l’aria primaria è immessa attraverso la trave fredda stessa, e regolata da una serranda di regolazione manuale installata sul canale di collegamento alla trave. La ripresa dell’aria dagli ambienti avviene dai servizi igienici per quanto riguarda le degenze e da griglie a controsoffitto 60 x 60 cm con frontalino forato negli ambulatori, lavoro infermieri e medici e negli studi medici. Per le zone corridoi è effettuata solo una immissione dell’aria, in quanto la ripresa avviene per bilanciamento delle portate estratte dalle zone servizi igienici presenti nelle zone comuni, ai vari piani. Le prese dei gas medicinali sono integrate nell’arredo.
OSSERVAZIONE NEONATALE
Le terapie intensive e la Neonatologia sono servite da impianto a tutt’aria con batterie di post, installate sul canale di mandata in controsoffitto ciascuna in corrispondenza dell’ ambiente servito. L’aria è immessa attraverso diffusori a getto elicoidale con filtro assoluto a bordo (H13), e ripresa da griglie a frontalino forato 60 x 60 cm installati a controsoffitto. I Box della terapia intensiva e le degenze isolate della neonatologie sono dotate di sistema di controllo elettronico venturi della portata d’aria e della pressione con cambio di polarità da infettivi a immuno depressi. Il controllo della temperatura avverrà tramite sonde con potenziometro installate negli ambienti serviti, che controlleranno le valvole di regolazione a due/tre vie della batterie di postriscaldo installate in controsoffitto. Le prese dei gas medicinali sono presenti sia sui pensili che a parete per le emergenze.
SALA OPERATORIA
ll reparto operatorio al piano secondo, è servito da CTA dedicate, con cassette VAV dotate di batteria di post, installate sul canale di mandata in controsoffitto ciascuna in corrispondenza dell’ ambiente servito. L’aria è immessa attraverso diffusori a getto elicoidale con filtro assoluto a bordo (H13), e ripresa da griglie a frontalino forato 60 x 60 cm installati a controsoffitto. Nelle due sale operatorie ISO 7 l’aria è immessa attraverso un diffusore speciale per sale operatorie “atollo” dotato di diffusori con filtro assoluto H13 a bordo; la ripresa avviene attraverso angoliere in acciaio inox integrate nel lay-out della stanza. Il controllo della temperatura avviene tramite sonde con potenziometro che controllano le valvole di regolazione a due/tre vie delle batterie di post-riscaldo.
Ciascuna delle due sale operatorie è servita da sistema dedicato di umidificazione.
DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
C A D E F B 4 5 6 15

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Gli impianti elettrici a servizio e corredo del nuovo Padiglione Pediatrico si inseriscono nella rete generale di distribuzione impiantistica dell’Ospedale a partire dalla cabina di MT BT di Via Abbeveratoia. Gli impianti speciali ed in particolare quelli di rivelazione incendio sono interconnessi alla centrale generale di gestione delle emergenze dell’intero plesso ospedaliero, quelli di trasmissione dati estesi si collegano al CED con un centro stella di fabbricato ubicato al piano seminterrato. Gli impianti distribuzione dei segnali TV, gli impianti interfonici, di diffusione sonora e di controllo accessi sono gestiti a livello locale. Partendo dalla cabina elettrica MT/BT di via Abbeveratoia con relativo gruppo elettrogeno, si alimentano il quadro generale Power Center di piede fabbricato dal quale partono le dorsali in blindosbarra per i quadri e sottoquadri di distribuzione, fino ai quadri terminali rispettando le compartimentazioni e suddividendo i carichi in modo corretto. Per i servizi essenziali dei locali medici di gruppo 2 (sale operatorie, terapie intensive, ambulatori chirurgici) sono installati UPS di potenza adeguata in grado di assicurare la fornitura di energia elettrica senza alcuna interruzione (classe 0 sec).
I percorsi dei canali porta cavi sono ubicati nei controsoffitti, nei corridoi e nei cavedi montanti, così come le distribuzioni dorsali ai piani, gli impianti sono in vista nei locali tecnologici. I percorsi sottotraccia sono limitati, ovunque possibile alle utenze terminali di stanza, mentre per le dorsali principali si utilizzano le colonne montanti ed i cavedi previsti. Normalmente non sono previsti impianti sotto pavimento, se non i soli collegamenti equipotenziali.
I montanti verticali e le linee provenienti da cabina sono opportunamente segregati e compartimentati.
La rete di messa a terra è intercollegata alle reti esistenti. La rete di distribuzione, prendendo origine da una propria cabina di trasformazione, è del tipo TN-S. Le protezioni delle condutture (cavi) sia contro i cortocircuiti, che contro eventuali guasti a terra, sono assicurate da opportuni interruttori automatici magnetotermici e magnetotermico differenziali, dimensionati in modo da garantire la sicurezza dei cavi contro sovraccarichi (sovra riscaldamenti), contro i corti circuiti (rischio incendio) e delle persone contro i pericoli derivanti da contatti; inoltre è assicurata la opportuna selettività in tempo e corrente delle protezioni omopolari per tutte le reti. Nei locali speciali quali le sale operatorie ed i locali medici assimilabili sono installati i trasformatori di isolamento così come richiesto dalle norme CEI 64-8 sez. 700.
Per l’alimentazione di tutto l’edificio si utilizzano impianti realizzati in parte in vista (canalette generali di distribuzione in controsoffitto a vista nei corridoi), tubazioni di diametro adeguato in traccia, in parte incassati sottotraccia e/o sottopavimento, ad esclusione dei locali tecnologici in cui la distribuzione avverrà tramite cavi posati in canaletta ed in tubo posato esclusivamente a vista.
Tutte le utenze elettriche presenti sono alimentate dai sotto quadri di settore che contengono gli interruttori di protezione terminale per i circuiti luce e forza motrice dei vari locali secondo una suddivisione logica per zone e compartimenti di appartenenza; tutte le utenze sono protette con interruttore automatico differenziale, in genere uno per ogni ambiente da 30 mA secondo le CEI 64-8 sez. 700. Le protezioni

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
A B C D E A B C D D 16
delle condutture (cavi) sia contro i cortocircuiti, che contro eventuali guasti a terra, sono assicurate da opportuni interruttori automatici magnetotermici e magnetotermicodifferenziali, dimensionati in modo da garantire la sicurezza dei cavi contro sovraccarichi (sovra riscaldamenti) e contro i corti circuiti (rischio incendio) e delle persone contro i pericoli derivanti da contatti e viene distribuito a tutte le utenze un impianto di terra di protezione.
Premesso che tutti gli impianti luce dei nuovi interventi della struttura ospedaliera devono essere sottesi alla rete sotto gruppo elettrogeno, si precisa che lungo i percorsi principali, nei corridoi, nelle vie di fuga e nei locali filtro, ad integrazione dell’impianto di illuminazione normale realizzato con corpi illuminanti equipaggiati con lampade a basso consumo energetico, esiste un impianto di illuminazione di sicurezza costituito da corpi illuminanti autoalimentati da batterie autonome e possibilità di controllo del funzionamento e della scarica centralizzato per le prove di manutenzione.
Tutti i cavi utilizzati sono del tipo con guaina o isolamento di tipo auto estinguente non propagante l’incendio secondo le norme CEI. Tutti i locali classificati ad uso medico secondo le CEI 64-8 sez. 700 sono realizzati in modo conforme alle richieste di detta normativa.
L’impiantistica elettrica ed a correnti deboli di tutto l’edificio comprende:
• quadro generale di piede fabbricato (esclusa alimentazione da Cabina elettrica sia per le reti normali che sotto gruppo elettrogeno).
• gruppi di continuità assoluta ; per l’alimentazione dei carichi sensibili e critici della struttura (come previsto dalla norma) sono installati, a lato del locale gruppo elettrogeno, due gruppi di continuità assoluta della potenza singola di 100 kVA con batterie al piombo ermetico con vita 10 anni in grado di garantire una autonomia di 60’ per ogni gruppo da 100 kVA e soddisfare pertanto la richiesta di autonomia della utenze ospedaliere di almeno 1 ora.
• quadri di bassa tensione principali e secondari; il quadro principale di distribuzione è il Quadro di piede fabbricato ubicato al piano interrato in apposito locale dedicato a lato di uno dei cavedi; da esso e da quello ad esso simmetrico, in cavo, partiranno le linee di alimentazione ai condotti sbarra e/o ai quadri utilizzatori. Ai piani, derivandosi dalle blindo sbarre, si alimentano, dai quadri principali di piano, tutte le successive alimentazioni di zona e di settore delle aree est ed ovest.
• tubi canale e passerelle (utilizzati per la posa dei cavi); le passerelle sono previste sempre di tipo metallico e complete di coperchio per limitare al massimo le emissione elettromagnetiche dei conduttori ospitati e sono divise per servizi di impianti elettrici di potenza e di impianti a correnti deboli.
• cavi e condutture. Sono sempre del tipo a bassissima emissione di fumi e di gas corrosivi tranne che nelle centrali tecnologiche e nei luoghi non a destinazione ospedaliera e/o con presenza di pubblico od operatori; i cavi derivati dai gruppi di continuità assoluta sono resistenti al fuoco per un’ora.
• impianto di distribuzione luce e fm. Comprende tutte le distribuzioni e gli allacciamenti terminali.

• corpi illuminanti. Sono del tipo adatto all’ambiente ed assicurano i livelli di illuminamento previsti dalle normative vigenti.
• allacciamento utenze tecnologiche. Sono stati previsti tutti gli allacciamenti di potenza e gli allacciamenti ai circuiti ausiliari e di comando e controllo degli impianti tecnologici.
• impianto di terra, equipotenziali e parafulmine.
• setti e barriere tagliafuoco. Negli attraversamenti dei compartimenti antincendio sono stati previsti setti tagliafuoco realizzati con sacchetti costipati nelle canalette e/o con sistema approvato e omologato dai Vigili del Fuoco.
Nel complesso sono presenti i seguenti impianti speciali a correnti deboli:
• impianto di rivelazione incendio esteso a tutta la struttura ospedaliera e organizzato in modo da seguire le nuove compartimentazioni di progetto.
• impianto telefonico e trasmissione dati.
• impianto centralizzato TV.
• impianto di diffusione sonora (limitati alle zone comuni).
• impianto di controllo accessi limitato alle zone che necessitano di sorveglianza speciale.
• impianto chiamata infermieri dalle degenze di tipo moderno con possibilità di viva voce tra degenza e locale lavoro infermieri.
• impianto interfonico limitato ai comparti operatori.
• impianto citofonico ingresso reparti.
Per quanto riguarda l’impianto telefonico si fa capo ad un centralino principale unico esistente; sono state installate prese telefoniche fino alle singole utenze con terminale RJ 45
• Impianto di cablaggio strutturato per reti di trasmissione dati.
Gli impianti speciali ed a correnti deboli installati nella degenza tipo sono:
• impianto di rivelazione incendio esteso a tutta la struttura ospedaliera ed organizzato in modo da seguire le compartimentazioni antincendio dell’edificio.
• impianto telefonico e trasmissione dati.
• impianto centralizzato TV.
• impianto di diffusione sonora (limitati alle zone comuni).
• impianto di controllo accessi (limitato alle zone che necessitano di sorveglianza speciale).
• impianto chiamata infermieri con possibilità di viva voce tra degenza e locale lavoro infermieri.
• impianto interfonico (limitato ai comparti operatori).
• impianto citofonico all’ingresso dei reparti.
Per quanto riguarda l’impianto telefonico si fa capo ad un centro stella principale unico installato al piano interrato. Sono state installate prese telefoniche fino alle singole utenze con terminale RJ 45 ed impianto di cablaggio strutturato per reti di trasmissione dati.
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
17
DEGENZA POLISPECIALISTICA
Gli impianti elettrici della degenza sono stati progettati al fine di consentire la massima ergonomia degli stessi, la miglior gestione dei sistemi d’illuminazione congiunta al massimo risparmio energetico (sistemi dimmerabili, luci di cortesia e di lettura a led) e di confort visivo sia dal punto di vista del colore della luce che della facilità dei sistemi di comando delle accensioni. Per tutte le degenze si sono utilizzati impianti di chiamata infermieri con sistema a voce. Gli impianti TV consentono la visione di canali digitali e di canali per bambini della rete satellitare. In tutte le degenze è presente la rete dati e sono previste le prese per personal computer con la possibilità di utilizzare videogiochi. Le dotazioni di sicurezza prevedono prese dedicate per il monitoraggio, alimentabili da rete sotto continuità assoluta. Il quadro elettrico di degenza, ubicato all’ingresso della stanza, da chiuso presenta una superficie liscia che ne mitiga la presenza, sufficientemente ampio da consentire una facile manutenzione e meccanicamente “robusto”.
OSSERVAZIONE NEONATALE
Tutti gli impianti elettrici delle terapie intensive e semintensive (locali di gruppo 2) sono alimentati da rete elettrica sotto continuità assoluta con sistema di alimentazione “doppio radiale” per consentire ogni intervento di manutenzione senza interruzioni di servizio. Tutte le alimentazioni ai pensili ed alle travi di terapia intensiva sono derivate sempre da almeno due trasformatori di isolamento al fine di avere la ridondanza doppia dei sistemi. Le prese dati e le prese di monitoraggio per gli elettromedicali provengono da rak dedicati alimentati da Trasformatore di isolamento. Tutti i corpi illuminanti sono dimmerabili ed hanno caratteristiche adatte a garantire il grado di tenuta del controsoffitto inoltre sono sempre suddivisi su più linee.
SALA OPERATORIA
Tutti gli impianti elettrici delle Sale Operatorie sono alimentati da rete elettrica sotto continuità assoluta con sistema di alimentazione “doppio radiale” per consentire ogni intervento di manutenzione senza interruzioni di servizio. Tutte le alimentazioni ai pensili sono sempre doppie ed alimentate da trasformatori di isolamento; sono sempre previste prese su pannelli a parete al fine di avere la ridondanza doppia dei sistemi. Le prese dati e le prese di monitoraggio per gli elettromedicali provengono da rak dedicati alimentati da Trasformatore di isolamento. Tutti i corpi illuminanti sono dimmerabili ed hanno caratteristiche adatte a garantire il grado di tenuta del controsoffitto inoltre sono sempre suddivisi su almeno due circuiti sempre sotto continuità assoluta.






Note
In questa pagina:
A. Luce dimmerabile
B. Rilevatore impianto antincendio
C. Tv e prese integrate nell’arredo
D. Luce di cortesia
E. Luce di lettura a led
F. Prese integrate nell’arredo
G. Quadro elettrico
H. Rilevatore impianto antincendio
I. Corpo illuminante a soffitto dimmerabile
L. Prese fm e dati
M. Corpo illuminante a soffitto dimmerabile
N. Pacs
O. Lampada scialitica e pensili con prese
Nella pagina a fianco:
P. Orologio a parete
Q. Sondaggio
R. Litostratimetria
S. Modello geotecnico
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
H I A B C D F G E L M N P O 1 2 3 18
1. Degenza polispecialistica
2. Osservazione neonatale
3. Sala operatoria
4. Diagramma degli aspetti geologici e geotecnici
5. Modello tridimensionale delle strutture REDATTO
CARATTERISTICHE STRUTTURALI IN RAPPORTO ALLA FUNZIONALITÀ
DELL’EDIFICIO
Il Nuovo Ospedale dei Bambini di Parma, attualmente in fase di ultimazione, è formato da due edifici strutturalmente indipendenti, uno pluripiano, principale, composto da piano interrato e 4 piani fuori terra oltre alla copertura del vano impianti tecnologici ed uno monopiano, adibito ad Astanteria Pediatrica (Piastra Astanteria) composto dal solo piano terra. Entrambi gli edifici sono caratterizzati da struttura portante in c.a. gettato in opera, solai a lastre tralicciate, e sono disposti in affiancamento l’uno all’altro, separati solo da un giunto strutturale. Le strutture di fondazione sono del tipo diretto per la Piastra Astanteria ed indiretto su pali (platee e plinti su pali) per il pluripiano, le strutture di elevazione sono entrambe intelaiate a travi e pilastri; nell’edificio pluripiano sono inoltre inseriti nuclei e pareti in c.a. allo scopo di irrigidimento agli effetti delle azioni orizzontali.
ASPETTI GEOLOGICI E GEOTECNICI
Le indagini geognostiche eseguite, consistenti in n° 15 prove penetrometriche statiche con punta elettrica e piezocono, e 2 sondaggi trivellati a carotaggio continuo, hanno consentito di ricostruire l’assetto litostratimetrico del terreno, che vede nei primi 13-18 m da piano campagna terreni fini, prevalentemente argillosi e argilloso limosi; localmente sono presenti livelli con elevati tenori di sostanza organica; oltre la profondità di 13-18 m sono presenti i depositi granulari della paleoconoide del torrente Parma (ghiaie eterometriche in matrice limoso sabbiosa).
Dal punto di vista geotecnico il livello più superficiale risulta caratterizzato da terreni coesivi, sovraconsolidati, mentre con l’aumentare della profondità la consolidazione diminuisce; a maggior profondità le ghiaie, risultano da addensate a molto addensate e pertanto presentono un buon valore dell’angolo di resistenza al taglio.
La prova Down-hole eseguita per l’ottenimento del parametro Vs30 ha consentito di adottare per il terreno di fondazione la classe C.
IL PROGETTO DELLE STRUTTURE
Il quadro normativo di riferimento utilizzato in accordo con la committenza, è stato il D.M. ’96 e la Circolare n. 65 del 1997, essendo la progettazione iniziata prima dell’ entrata in vigore del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.
Per il calcolo delle strutture è stata effettuata una schematizzazione di tipo spaziale utilizzando il programma di calcolo agli elementi finiti ModeSt ver. 7.15, prodotto da Tecnisoft s.a.s. di Prato.
La modellazione è stata fatta nel suo complesso, inserendo nel codice di calcolo sia tutti gli elementi portanti verticali e orizzontali, che gli elementi di fondazione. Al modello ottenuto sono stati quindi applicati i carichi permanenti ed accidentali previsti.
Fra i carichi di esercizio distribuiti, è importante ricordare che sono stati considerati anche carichi particolari quali le apparecchiature per la risonanza magnetica, i carichi concentrati appesi ai solai dovuti ai vari pensili polifunzionali, ecc.

Le azioni del sisma orizzontale sono state valutate effettuando un’analisi simica dinamica della struttura.
Le opere non strutturali previste in progetto, quali le pareti divisorie e di tamponamento, i pannelli di rivestimento, le vetrate, i controsoffitti e i parapetti, le opere impiantistiche, costituendo elementi portatori di massa, sono stati considerati nella modellazione e nel calcolo strutturale; le suddette opere sono state accuratamente verificate al fine di comprovarne la funzionalità e la resistenza sia in condizioni di esercizio che in concomitanza di eventi sismici.
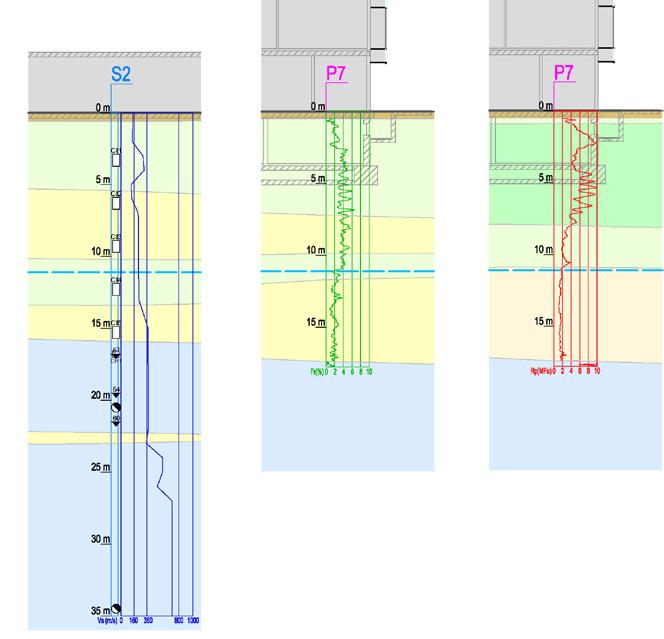

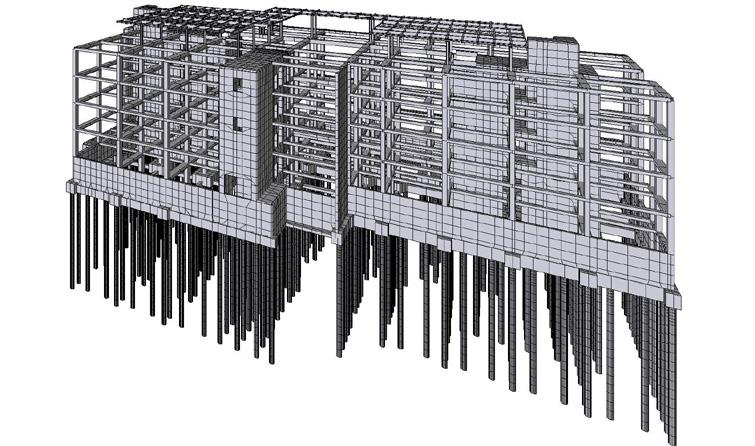
DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
DA:
4 5 Q R S 19
REDATTO DA:
EDIFICIO PLURIPIANO
Le fondazioni sono costituite da platee di alto spessore in corrispondenza dei nuclei scale ed ascensori, da una serie di plinti anch’essi di alto spessore, da travi perimetrali, da travi di centramento e da puntoni di collegamento. Tutte queste entità sono fondate su pali in c.a. con diametro di 62 cm e lunghezza variabile da 15 a 16 m, realizzati mediante la tecnologia fdp “Full Displacement Pile” (1), caratterizzata da perforazione in assenza di asportazione di terreno, ovvero con un sistema di trivellazione con costipazione laterale del terreno, che consente di migliorare lo stato di addensamento del terreno con conseguente miglioramento di resistenza sia per attrito laterale che per resistenza di punta.
Gli elementi di fondazione sono poi collegati da un’unica platea a spessore ridotto avente oltre che funzione statica anche funzione di contenimento della falda (2).
I telai dell’edificio (3) pluripiano sono caratterizzati da maglie strutturali prevalenti di circa 7,00x6,00 m, 8,10x6,00 m e 7,80x7,30 m. La presenza dei nuclei scala ed ascensori, il cui ruolo è principalmente quello di assorbire le azioni orizzontali sulla struttura è fondamentale per il comportamento dinamico della struttura in occasione degli eventi sismici.
Le strutture orizzontali sono realizzate con solai a lastre tralicciate e alleggerimento con blocchi di polistirolo (4), con soletta superiore collaborante di spessore superiore a 5 cm. L’altezza di interpiano è stata ridotta ed ottimizzata, in accordo con la committenza, e grazie a importanti affinamenti progettuali a 4.20m.
Sono infine presenti alcune parti strutturali in carpenteria metallica come la struttura di copertura del vano impianti (5), i sostegni dei grigliati e degli elementi a vetro della facciata, le passerelle e la copertura del patio centrale.
EDIFICIO MONOPIANO – PIASTRA ASTANTERIA
Per l’edificio della Piastra Astanteria la tipologia delle fondazioni è del tipo diretto con un graticcio di travi a “T rovescia”, ordito secondo le due direzioni.
Le strutture in elevazione sono composte da pilastrature a sezione in parte rettangolare ed in parte circolare, disposte secondo una maglia regolare di 7,30x7,80 m circa e 5,40x7,80 m circa.
Il solaio di copertura è realizzato con lastre tralicciate con alleggerimento in pani di polistirolo, ad orditura incrociata dei travetti.
Tutte le strutture portanti in c.a. sono state dimensionate prevedendo un copriferro tale da garantire le opportune caratteristiche prestazionali in caso di incendio.
La costruzione del nuovo plesso ospedaliero ha comportato inoltre la realizzazione di opere provvisionali di presidio della porzione del Padiglione Pediatria rimasto sempre perfettamente in funzione durante tutte le fasi di costruzione: sono state realizzate una berlinese di micropali di diametro pari a 250 mm, lunghi 9 m, tirantata mediante micropali inclinati realizzati con tecnologia auto perforante, e una paratia di pali tipo FDP, sempre lunghi 9 m, collegati in testa da cordolo in c.a.




1. Realizzazione pali con tecnologia FDP
2. Fondazioni edificio pluripiano
3. Solaio a lastre tralicciate
4. Getto pilastri e nuclei scale
5. Struttura in carpenteria metallica di copertura impianti


DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
1 2 4 3 5 20
1. Prova di carico dei pali di fondazione mediante martinetto idraulico
2. Cantiere durante la fase di getto in opera delle strutture in cemento armato
DIREZIONE LAVORI ED ASSITENZA AL COLLAUDO
L’attività di Direzione Lavori svolta per la realizzazione dell’Ospedale dei Bambini di Parma “Pietro Barilla” ha comportato una perfetta organizzazione per garantire il controllo delle attività svolte dai vari Appaltatori. Infatti l’intervento edilizio è stato affidato dalla Committente a più Appaltatori, suddivisi per opere strutturali, opere civili ed impianti, in assenza di un unico General Contractor. E’ stato quindi necessario costituire un Archivio sia cartaceo che informatico, organizzato e gestito dal Direttore dei Lavori e dai propri Assistenti, nel quale sono stati raccolti , suddivisi per categorie di lavorazioni e per ciascun Appaltatore, Subappaltatore e Fornitore , tutta la documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell’opera. In particolare nelle varie sezioni dell’archivio sono stati raccolti i documenti progettuali (elaborati grafici, relazioni e relativi aggiornamenti), i documenti contrattuali, la corrispondenza, i verbali e gli ordini di servizio, i documenti riguardanti la consistenza delle risorse impiegate sul cantiere dall’Appaltatore, e la raccolta delle certificazioni fornite dall’Appaltatore stesso in materia di previdenza, infortunistica, nonché quelle relative alla legge antimafia. Prima dell’inizio dei lavori è stato valutato ed esaminato il programma di dettaglio dei lavori di ciascun Appaltatore, ed è stato concordato un Manuale delle procedure di cantiere a cui ciascun Appaltatore era obbligato ad attenersi per la corretta gestione dei lavori in presenza di più imprese esecutrici. Sono stati pure analizzati e valutati, suggerendo le necessarie integrazioni e modifiche, i Manuali per il controllo della qualità predisposti da ciascun Appaltatore. Durante tutte le fasi di realizzazione delle opere il Direttore dei Lavori ed i suoi Assistenti hanno concorso costantemente ad indirizzare i vari Appaltatori , senza interferire con le loro gestioni delle attività e senza ridurne le responsabilità, verso le metodologie organizzative che rendessero più efficaci e più sicure le varie lavorazioni anche se interferenti, sempre nel rispetto del Piano della Sicurezza e di quanto ordinato dal Coordinatore della Sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. L’attività di controllo, sviluppatasi lungo tutto l’arco


di tempo intercorrente tra la data di inizio lavori e la data di collaudo finale, è stata estesa a tutte le categorie di lavoro (strutture, opere civili, impianti, finiture, arredi e opere esterne) ed ha riguardato la sicurezza, la qualità, la tempistica e la contabilità. In particolare per quanto riguarda la sicurezza, oltre ai normali controlli del rispetto del Piano Operativo, è stato verificato il rispetto delle normative ambientali e degli accorgimenti operativi atti a minimizzare gli effetti dei lavori sull’ambiente circostante, caratterizzato da plessi ospedalieri in attività. Per quanto concerne il controllo della qualità, il personale della Direzione dei Lavori ha assistito congiuntamente con i vari Appaltatori ai prelievi dei campioni di materiale (calcestruzzo e acciaio per le strutture in c.a., profilati metallici per le strutture in ferro, inerti e malte per intonaci e sottofondi, ecc..) così come previsto nel Manuale di controllo qualità, nel Manuale delle procedure, nelle specifiche tecniche e nei documenti contrattuali in genere, richiedendo all’Appaltatore, in caso di “non conformità”, ulteriori prelievi ed esami e prove di laboratorio. Inoltre prima delle varie forniture, sono state richieste tutte le campionature nel tipo e nella quantità ritenuti necessari per l’approvazione dei materiali e dei metodi di posa; di tutti i materiali forniti è stato redatto apposito verbale di accettazione. Durante lo svolgimento dei lavori la Direzione Lavori ha esercitato una costante azione di sollecito nei confronti dei vari Appaltatori per il rispetto delle varie fasi operative interferenti; il risultato di tale attività, esperita mediante note scritte sul giornale dei lavori, comunicazioni scritte e riunioni quotidiane, è stato quello di verificare anticipatamente che azioni, rapporti e consegne anche parziali previste avvenissero alle scadenze e con le modalità prestabilite nel programma lavori e nei documenti contrattuali. Infine è stata redatta la contabilità in contradditorio con gli Appaltatori, producendo tutta la documentazione contabile e di controllo prevista nei documenti contrattuali.
La DL ha da ultimo fornito la necessaria assistenza ai Collaudatori, predisponendo gli elaborati grafici e di calcolo necessari per le prove di carico (su pali FDP, sulle varie tipologie di solaio e per i vari tipi di carico), per tutte le prove previste dalla normativa (ammettenza meccanica e prove vibrazionali su pali, ecc.), nonché raccogliendo tutta la documentazione ed i certificati da allegare al verbale di collaudo.

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
REDATTO DA:
2 1 21
DIVANO-LETTO

PER PREPARARE IL LETTO...
TAVOLINI

PER APRIRE IL TAVOLINO...

TOGLI I CUSCINI E SOLLEVA IL MATERASSO

SOLLEVA IL RIPIANO

SOLLEVA LA RETE E RIPONI I CUSCINI NEL CONTENITORE

ABBASSA LA RETE E IL MATERASSO

L’azione in cui devi operare la massima attenzione è la chiusura della rete per evitare il possibile rischio di schiacciamento.

ALLARGA ENTRAMBI I SOSTEGNI RUOTANDOLI
PORTA ROTOTRASLANTE DEL BAGNO




ALZA IL RIPIANO E SPINGI I SOSTEGNI OLTRE IL FERMO


IL TAVOLINO È PRONTO
Assicurati sempre che i tavolini siano aperti correttamente e bloccati con il fermo e che non vengano utilizzati per sedersi.
Per richiudere il tavolino esegui al contrario le stesse azioni prestando la massima attenzione.
Per garantire la massima fruibilità degli ambienti la porta del bagno è stata studiata in modo che, anche se lasciata aperta, non ingombri l’area di ingresso.
Se il tuo bambino è piccolo accompagnalo in bagno manovrando direttamente la porta.
Se il tuo bambino è grande spiegagli il corretto funzionamento della porta.
L’azione in cui devi operare la massima attenzione è la chiusura della porta per evitare il possibile rischio di schiacciamento, in particolare nell’area evidenziata in azzurro.
REDATTO DA:


OSPEDALE DEI
BAMBINI DI PARMA “ PIETRO BARILLA”

GUIDA AL CORRETTO USO DELLE DOTAZIONI DELLA CAMERA DI DEGENZA
LA
LA
LA PORTA È CHIUSA PUOI APRIRLA TIRANDO VERSO
CAMERA
PORTA E’ APERTA
ORA PUOI SISTEMARE LE LENZUOLA.
DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA 22
In basso:
Pieghevole informativo, consegnato ai piccoli pazienti e alle famiglie, redatto con un linguaggio semplice e supportato da immagini e schemi fortemente intuitivi che costituisce una guida al corretto uso delle dotazioni della camera di degenza
FASE DI ESERCIZIO
Le attività di assistenza sono inoltre proseguite nella fase di esercizio della struttura mediante specifici progetti di comunicazione volti a favorire l’utilizzo corretto delle molteplici opportunità offerte dalla struttura e dedicate ai piccoli pazienti e alle famiglie.
Nello specifico è stato predisposto un pieghevole informativo che si costituisce come una guida al corretto uso delle dotazioni della camera di degenza, redatto con un linguaggio semplice e supportato da immagini e schemi fortemente intuitivi.
DOTAZIONI DELLA CAMERA
INTERRUTTORI LUCI A SOFFITTO E A PARETE
LA STANZA HA MOLTE LUCI REGOLABILI PER CREARE L’AMBIENTE CHE PREFERISCI, PUOI UTILIZZARE LA LUCE A SOFFITTO E, TENENDO PREMUTO L’INTERRUTTORE REGOLARNE L’INTENSITÀ, OPPURE PUOI UTILIZZARE LE LUCI A PARETE, SOPRA I LETTI O SUI TAVOLINI.
INTERRUTTORI LUCI DI CORTESIA
SE VUOI LEGGERE PUOI UTILIZZARE L’APPOSITA LUCE SUL DIVANO LETTO, ANCHE IL LETTO DEL TUO BAMBINO HA UNA LUCE PER LEGGERE O GIOCARE.
DIVANO LETTO PER IL FAMILIARE
IL DIVANO PUÒ ESSERE TRASFORMATO FACILMENTE IN UN LETTO PER PERMETTERTI DI RESTARE GIORNO E NOTTE A FIANCO DEL TUO BAMBINO, SCOPRI COME SUL RETRO DELL’OPUSCOLO!
INTERRUTTORE TAPPARELLA
DURANTE IL GIORNO PUOI REGOLARE COME VUOI LA QUANTITÀ DI LUCE NATURALE NELLA STANZA ALZANDO O ABBASSANDO LA TAPPARELLA CON L’APPOSITO INTERRUTTORE.
LAVAGNA MAGNETICA
E’ POSSIBILE PERSONALIZZARE LA CAMERA CON FOTO O DISEGNI DEL TUO BAMBINO PER FARLO SENTIRE A CASA, CHIEDI AGLI INFERMIERI GLI APPOSITI MAGNETI!
TV LCD
CHIEDI AGLI INFERMIERI IL TELECOMANDO E LE ISTRUZIONI PER L’USO DELLA TV.
MOBILETTO PER EFFETTI PERSONALI
I MOBILETTI ALL’INGRESSO DELLA STANZA TI PERMETTONO DI SISTEMARE COMODAMENTE GLI EFFETTI PERSONALI E I VESTITI.
ARMADIETTI PER GIOCHI E LIBRI
GLI ARMADIETTI DI FRONTE AI LETTI INVECE SONO STATI PENSATI PER CONTENERE I GIOCHI E I LIBRI DEL TUO BAMBINO.
TAVOLINI

Tale opuscolo, distribuito in ogni stanza di degenza dell’Ospedale dei Bambini, riporta le numerose dotazioni presenti nella camera, indicandone la collocazione e le corrette modalità d’uso al fine di favorirne la consapevolezza e l’utilizzo.






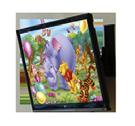





LA CAMERA DI DEGENZA IN CUI TI TROVI È STATA PENSATA PER OFFRIRE LE MASSIME COMODITÀ
CON POCHE E SEMPLICI AZIONI PUOI APRIRE IL TAVOLINO PER PRANZARE O GIOCARE CON IL TUO BAMBINO. PUOI APRIRE CONTEMPORANEAMENTE
TAVOLINI, SCOPRI
RETRO DELL’OPUSCOLO!
A TE E AL TUO BAMBINO, SCOPRI COME UTILIZZARE AL MEGLIO LE DOTAZIONI PRESENTI! 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 8 7 9 9 9
PIÙ
COME FARE SUL
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
23
01 IL PROGETTO INTEGRATO DEGLI ARREDI 02 LA PSICOLOGIA AMBIENTALE 03 LA STANZA INTONATA 04 LIGHT DESIGN 05 SOUND MASKING E SOUND DESIGN 06 L’ACCESSIBILITÀ E L’ERGONOMIA SCHEDE DI APPROFONDIMENTO DI STUDI SPECIALISTICI



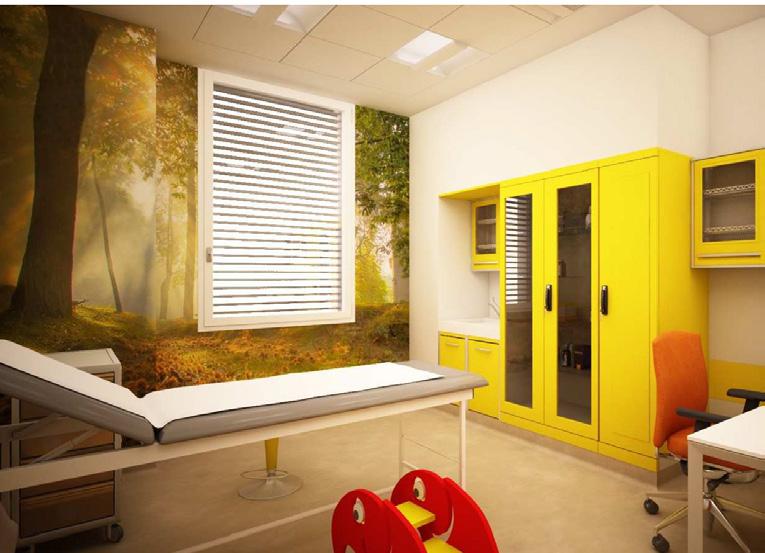


REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA 01 1 3 5 4 2 26

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO DI STUDI SPECIALISTICI
IL PROGETTO INTEGRATO DEGLI ARREDI
1. Degenza ordinaria due posti letto
2. Ambulatorio medico, di medicazione, ecografico e prelievi
3. Lavoro medici
4. Cucinetta e sala relax
5. Locale osservazione pazienti-risveglio
6. Hall ed aree di ingresso
7. Area di ingresso e accoglienza, area ludica
8. Ambienti di soggiorno



Nell’ottica di creare un ambiente che tenga in considerazione in primo luogo il benessere psicofisico della persona anche gli arredi, in quanto elementi fortemente caratterizzanti lo spazio fisico, risultano essere attori di fondamentale importanza.
I tradizionali arredi e dotazioni sanitarie ed ospedaliere, seppur efficienti da un punto di vista funzionale non offrono, in larga parte, quella qualità estetica che determina fortemente la qualità percettiva dell’ambiente; l’impiego di arredamenti non consoni compromette in molti casi la qualità architettonica di un luogo contribuendo di conseguenza all’insorgere di stress dovuto alla disomogeneità e alla freddezza dell’ambiente ospedaliero.
Si ritiene invece importante proporre un progetto integrato in cui materiali, colori, arredi, luci e decorazioni sono pensati assieme per creare un ambiente ospitale.
Ulteriori aspetti da approfondire riguardano la creazione di ambienti sonori e olfattivi particolari sia negli spazi più pubblici sia, in maniera più specifica, nelle degenze, in modo da favorire una stimolazione multisensoriale volta a ridurre lo stress ospedaliero e accelerare, in alcuni casi, il percorso di guarigione.
L’impiego di arredi commerciali affiancati da arredi su misura e il cablaggio dei mobili permettono di sfruttare appieno le nicchie e gli spazi interstiziali presenti, oltre ad eliminare completamente la presenza di ripiani aggettanti, fonte di intralcio per le movimentazioni di lettighe e dispositivi.
Inoltre nella scelta del colore dei diversi arredi vengono proposte cromie pertinenti agli ambienti in cui verranno collocati e alle pigmentazioni delle pareti adiacenti, individuate mediante i criteri di psicologia del colore volti a creare ambienti stimolanti in relazione alle diverse funzioni che sono chiamati a svolgere.
Tra i principali effetti che il Colore produce sugli esseri viventi possono essere ricordati gli effetti foto biologici, comunicativi, psicologici e terapeutici.
La giusta definizione della tonalità, saturazione e luminosità per ogni colore utilizzato negli ambienti può essere progettata negli ospedali considerando:
• coerenza cromatica, in rapporto all’utilizzo degli ambienti ed alla loro volumetria, in considerazione dei fruitori, sia operatori sanitari che pazienti;
• diversificazione tra gli ambienti, non solo per una migliore identificazione degli stessi, ma per la diversa tipologia di cura e di utilizzo;
• soluzioni di attenzione, mediante definizioni cromatiche caratterizzate da colori che aiutino la respirazione, attutiscano i rumori e gli odori, etc., per l’attivazione di sinestesie percettive;
• per l’attivazione di sinestesie o miglioramento della visibilità dei percorsi e degli accessi, tramite soluzioni di luce e colore.
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
8 7 6 27

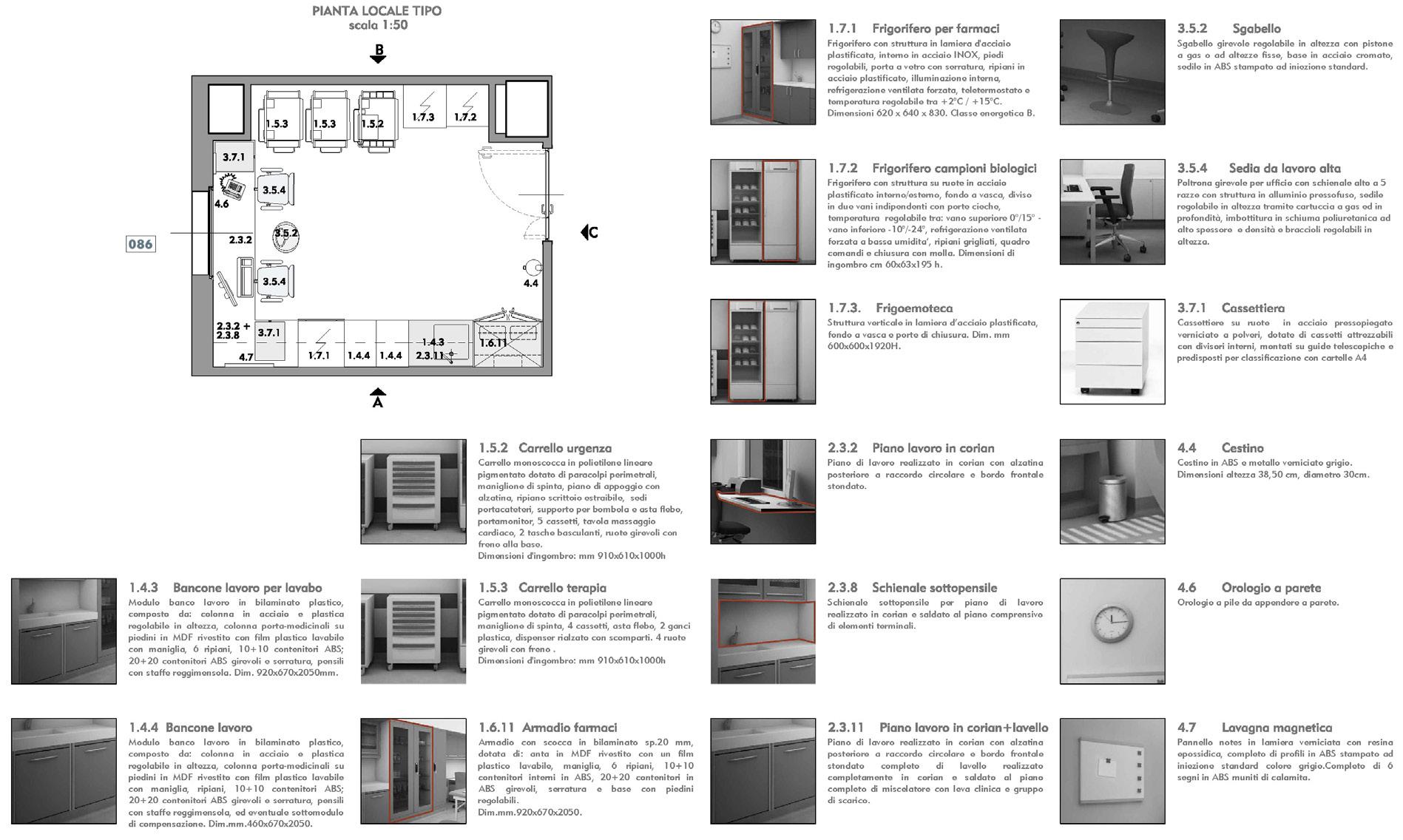
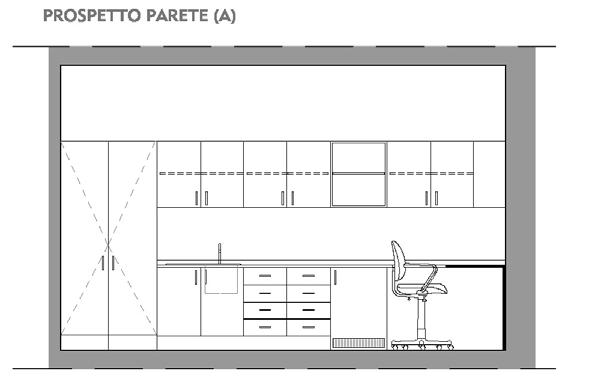
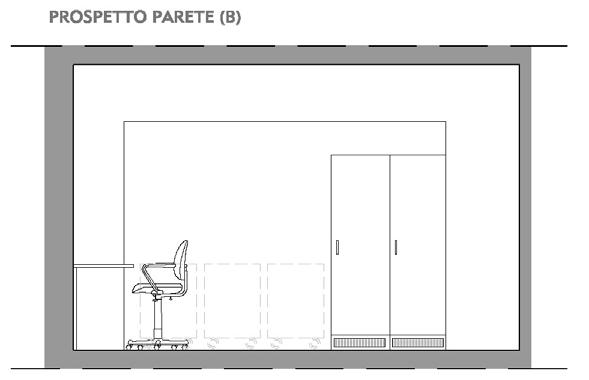




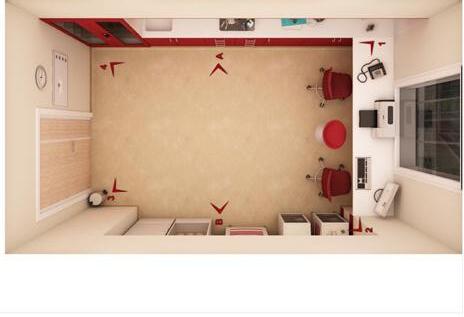
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA 1 2 28
1. Scheda tipologica di un locale con elenco dettagliato e descrizione delle dotazioni e dei complementi di arredo
2. Sezioni, prospetti e simulazioni virtuali
3. Simulazione virtuale del day hospital
4. Foto del day hospital realizzata
5. Simulazione virtuale dell’ambiente coordinamento infermieri
6. Foto dell’ambiente coordinamento infermieri realizzato
LA PROGETTAZIONE
Le soluzioni architettoniche mirate alla realizzazione di un ospedale devono essere rafforzate attraverso un progetto integrato degli arredi che prevede l’impiego di soluzioni commerciali o su misura che contribuiscano a ricreare un ambiente di elevato comfort e qualità estetica sia nei luoghi destinati ai pazienti che nei luoghi dedicati al lavoro di medici e operatori.
Metodologicamente appare corretto procedere offrendo uno studio complessivo strutturato secondo il seguente schema:
• schede di layout distributivo e funzionale per i vari livelli dell’edificio con



individuazione della destinazione e ambito funzionale dei singoli locali;
• quadro sinottico complessivo delle tipologie dei locali suddiviso per ambiti e livelli;
• schede delle finiture interne, delle dotazioni degli arredi e delle attrezzature e delle dotazioni impiantistiche per singola tipologia di locale;
• analisi psicomedicoantropologica dei vari ambienti con individuazione dei fattori fisici in grado di garantire adeguato comfort ambientale e loro possibile utilizzo funzionale;
• definizione di materiali ed elementi di finitura secondo i criteri di psicologia ambientale e psicologia del colore per individuare finiture materiche e cromatiche dei vari ambienti e relative associazioni applicative;
• schede di dettaglio per le diverse tipologie di ambienti con individuazione degli specifici elementi di arredo e attrezzature collocati nell’ambiente e verificati mediante rappresentazione con simulazione tridimensionale.


REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
3 SIMULAZIONE DI PROGETTO
FOTO DELL’AMBIENTE REALIZZATO SIMULAZIONE DI PROGETTO 5 4 6
FOTO DELL’AMBIENTE REALIZZATO
DALLA PROGETTAZIONE
29
ALLA REALIZZAZIONE
La Psicologia Ambientale è un campo disciplinare che ha fornito prove empiriche a sostegno della qualità dell’ambiente sulla salute e sul benessere delle persone; essa, sin dalle sue origini, ha manifestato uno spiccato interesse per il miglioramento degli ambienti ospedalieri in una prospettiva centrata sui fruitori del servizio.
In quest’ottica, anche la Psicologia della Salute sposta il focus del processo terapeutico non solo sulla malattia da curare, ma sull’individuo come portatore di emozioni, esigenze e bisogni unici e particolari. In tale accezione rivestono pertanto notevole importanza le misure organizzative e gestionali atte a migliorare la fruizione del servizio e a rendere meno traumatici i ricoveri ospedalieri.
Tornando alla Psicologia Ambientale e ai suoi ambiti di intervento, tale disciplina si delinea alla fine degli anni ’50 partendo da un iniziale interesse sulle caratteristiche fisiche dell’ambiente (Proshansky,1958) e successivamente si focalizza anche sugli aspetti di interfaccia tra comportamento umano e ambiente socio-fisico (Stokols,1978, Altamn, 1987, Bonnes-Sacchiaroli, 1992, Lewin, Barak…): l’attenzione dunque viene posta al contesto psico-fisico-sociale.
I contributi empirici della disciplina rintracciabili in letteratura sugli effetti dell’umanizzazione fisico-spaziale sono ad oggi ancora scarsi, mentre sono maggiormente reperibili analisi descrittive e idiografiche o Linee Guida per la progettazione sanitaria.
Tali contributi confluiscono in una prospettiva teoricooperativa, condivisa da architetti, ingegneri, medici, infermieri e psicologi, che sottolinea il potenziale salutogenico dell’ambiente ospedaliero che si esplica direttamente nei confronti del paziente che indirettamente sui familiari e lo staff sanitario.
Altre fonti di studio hanno dimostrato che la presenza di ambienti multisensoriali all’interno o nelle immediate vicinanze dei reparti nei quali i pazienti vengono sottoposti a procedure diagnostiche e terapeutiche invasive o sgradevoli e in modo frequente, può contribuire a tranquillizzare il paziente riducendo i loro livelli di ansia e di agitazione. Attraverso l’impiego di luci, colori, odori, suoni modulati tra loro, la stanza può assumere così connotazioni sensoriali stimolanti o calmanti, anche su scelta del paziente (R. Del Nord, 2006).
In generale, in riferimento alle condizioni sensoriali (R. Del Nord, 2006) quali il rumore, la temperatura, gli odori,ecc., essi possono dunque costituire elementi di discomfort sui quali intervenire: il rumore è un riconosciuto stressor ambientale (Evans, Cohen, 1991) ed è la variabile più frequentemente studiata in relazione ai suoi potenziali effetti negativi sulle persone che permangono all’interno dell’ospedale (Devlin, Arneill, 2003), anche per il personale operante all’interno della struttura (Ulrich et al. 2004).
Anche l’illuminazione può assumere una valenza stressogena soprattutto in mancanza o scarsità di luce naturale (Keep, Jamnes, Innan, 1980, Walch et al, 2004), così come la
temperatura, generalmente valutata negli ospedali come troppo calda (Weinberg, Creed, 2000); infine, appunto, gli odori che rappresentano un ulteriore connotato sensoriale negativamente associato all’ospedale e che può rappresentare come tale uno stimolo stressogeno (Zimring, Reizenstein, Michleson, 1991).
I principali fattori fisici che possono condizionare il grado di comfort ambientale e la risposta psicologica ad un ambiente sono molteplici e comprendono:
• i suoni;
• i colori;
• l’illuminazione;
• gli odori;
• la risposta tattile alle superfici.
• le dimensioni fisiche degli spazi;
• le forme degli ambienti;
• la sistemazione degli arredi.
Ad esempio, la saturazione e la brillantezza determinano la risposta emozionale di una persona al colore; i suoni regolano le nostre emozioni in relazioni alla loro presenza o assenza (silenzio), al ritmo, all’intensità, alla presenza di coloriture tonali, ecc.; gli odori, processati dalla stessa parte dl cervello che regola le emozioni, influenzano in modo rilevante l’umore della persona, la qualità visuale influenza il desiderio di rimanere in un posto; l’illuminazione naturale accresce il benessere, favorisce l’orientamento, stimola i sensi, contribuire ad accrescere la fiducia in se stessi e aiuta nel percorso di cura.
I fattori fisici, sono pertanto da declinare, per favorire la migliore risposta psicologica all’interno dello stesso spazio, utilizzando uno o più fattori determinanti in relazione alla libertà concessa dai vincoli tecnici-funzionali, alla semplicità/ complessità nel poter ottenere l’effetto desiderato, ai costi dell’intervento, ecc.

A Fianco: AREA ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E ATTESA Scheda tipo di analisi psicomedicoantropologica dei vari ambienti con individuazione dei fattori fisici in grado di garantire adeguato comfort ambientale e loro possibile utilizzo funzionale
1. Planimetria del piano terra dell’Ospedale dei Bambini di Parma con individuazione dell’ Area accoglienza, informazione e attesa.
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
02 30

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO DI STUDI SPECIALISTICI
LA PSICOLOGIA AMBIENTALE
suoni / TIPOLOGIA ED INTENSITÀ DI FRUIZIONE
alto
Ambiente Rilassante Ambiente Stimolante basso (1) medio medio basso alto
colori (2)
illuminazione (5) (5) odori (3)
risposta tattile (4) risposta visiva (6)
1. Diffusione in zone ristrette o in cuffia solo nell’area d’attesa
2. Tendenza al neutro, con riduzione del senso di affollamento
note
3. Zona attesa evitando sovrapposizioni odorigene con area cafeteria
4. Sedute morbide area attesa, aree pavimentate in gomma colorata.
AREA ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E ATTESA
5. Rilassante nella zona attesa, stimolante-intensa nelle aree della comunicazione, della reception, della vetrina espositiva. Luci di transizione giorno/notte all’ingresso,
6. Localizzazione di stimoli visivi ) plastico) nell’area attesa

AREA ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E ATTESA
SCHEDA TIPO DI ANALISI PSICOMEDICOANTROPOLOGICA DEI VARI AMBIENTI CON INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI
FISICI IN GRADO DI GARANTIRE ADEGUATO COMFORT
AMBIENTALE E LORO POSSIBILE UTILIZZO FUNZIONALE
FATTORI FISICI E IL LORO UTILIZZO FUNZIONALE
Obiettivi
Ridurre l’ansia e lo stress da attesa, ridurre la paura della paura, ridurre la sensazione del tempo di attesa
Suoni/Rumori
No musica o sonorità diffuse ovunque, meglio campi sonori localizzati nelle sedute dell’area di attesa, ritmi lenti rilassanti, suoni biotici per ridurre la sensazione del tempo di attesa.
I rumori degli altri invadono la nostra privacy e ci infastidiscono, nei locali affollati la somma degli effetti delle tanti voci e suoni determina un aumento del rumore di fondo che motiva uno
spontaneo innalzamento del tono della nostra voce. E’ necessario localizzare superfici ad alto fono assorbimento nell’area caffetteria (controsoffitto, poltroncine, arredi)..per evitare che voci e operazioni del bar si propaghino e nell’area dell’attesa. Un trattamento fonoassorbente del controsoffitto deve essere esteso a tutta la sala con particolare attenzione alle aree di contatto tra gli utenti e il personale della reception che devono essere il meno riverberanti possibili. La pavimentazione in materiale smorzante (gomma, …) dell’area di attesa attenua il suono dei passi, per segnalare un confine all’interno del quale l’attesa è “speciale”. Il plastico da quel lato offre una scena interessante che continua girando in tondo
Colori
Non devono incentivare l’aggressività e la vivacità del bambino. Ridurre il senso di affollamento, creare contenuti emozionali riequilibranti con tonalità neutre (verde).
Azione di indirizzamento dell’utenza (way finding) e di delimitazione dei percorsi con colori a pavimento
Illuminazione
Intensa nell’area dei corridoi della comunicazione, della reception, dell’ingresso, della vetrina espositiva, rilassante nell’area riservata ai bambini. Luci al led a colore variabile possono illuminare il plastico. La zona di adattamento visivo della hall è quella in cui avviene il passaggio dalla luce del giorno alla più scura parte interna dell’ospedale di giorno e, viceversa, dal buio dell’esterno a un ambiente illuminato di sera. Per aiutare l’occhio ad abituarsi ai diversi livelli di luminosità, la zona di adattamento deve essere dotata di una illuminazione all’entrata particolarmente chiara di giorno, con un livello di illuminazione interna calante verso la zona di uscita la sera.
Odori
Evitare sovrapposizioni tra aromi della caffetteria (stimolanti) con altre fragranze. Se adottate potrebbero sottolineare con delicatezza l’area dell’attesa dei bambini piccoli (....talco, vaniglia,....) e fragranze fresche (lavanda, muschio,…) per i più grandi.
Risposta tattile
Arredi con finiture morbide al tatto, sedute e divani con tessuti morbidi e accoglienti
Risposta visiva
il plastico ha la funzione di attrarre l’attenzione dei bambini e degli adulti, rompere la tensione suscitando attenzione, permettendo al tempo di trascorrere più rapidamente in attesa della chiamata. Specchi che deformano l’immagine. Luci che muovono la visione statica.
Note al lay-out arredi
La sala d’attesa può essere articolati in tre aree differenziate( sottolineate da tonalità di colore –intorno al verde-, con forme e disposizione delle sedute: un’area contenitiva-circolare dedicata ai bambini molto piccoli, una centrale per adulti, fanciulli e preadolescenti che “ascoltano suoni della natura” e una terza area audiovisiva (sedute con auricolare o audio vicino al capo), mista per età. Quindi, tre aree distinte per “l’accoglienza multisensoriale”, corrispondenti alle diverse età evolutive e a differenti risposte psicologiche alla tensione dell’attesa: ludico-motoria, uditiva, audiovisiva, tattile, luminosità.
REDATTO DA:
DI PRESENTAZIONE
NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
DOCUMENTO
IL
1
31
All’interno del progetto architettonico e progetto integrato degli arredi predisposto per il Nuovo Ospedale dei Bambini di Parma, gli ambienti di degenza, essendo i luoghi più importanti e al contempo delicati dell’intera struttura, sono stati oggetto di una approfondita analisi multidisciplinare che ha portato alla definizione di un progetto integrato al quale si è dato il nome di “LA STANZA INTONATA”. “LA STANZA INTONATA”, è il luogo in cui l’emotività e la personalità del paziente, le aspettative dei genitori, la professionalità e la dedizione degli operatori sanitari possono trovare un’armoniosa sinergia, una “intonazione”, finalizzata a raggiungere il traguardo della guarigione.
Tali obbiettivi sono stati raggiunti mediante un approccio progettuale fortemente supportato da ricerche psicologiche che si traduce in varie linee di intervento che coinvolgono:
• qualità della distribuzione degli spazi e delle funzioni;
• qualità dei materiali e dei colori;
• qualità della luce ambiente;
• qualità dell’ambiente sonoro.
Il progetto architettonico prevedeva la realizzazione di specifici interventi per attuare gli obbiettivi precedentemente descritti; si è operato mediante la colorazione delle pavimentazioni in PVC, delle pareti e dei controsoffitti, nonché l’inserimento di particolari arredi fissi, posti in prossimità dei letti di degenza, per il pernottamento del genitore.
E’ stato così possibile caratterizzare l’ambito di ogni singolo paziente, proteggendone le relazioni e l’intimità con il proprio genitore, pur garantendo le necessarie condizioni cliniche di igienicità ed efficienza assistenziale.
Nella distribuzione funzionale degli spazi particolare attenzione è stata posta al posizionamento e alla relazione fra il letto e il pertinente divanetto in quanto chiamati a favorire la vicinanza e il continuo contatto fra il bambino e il genitore, che viene preservato anche nei momenti di visita o di medicazione del paziente pediatrico; la colorazione a smalto delle pareti predilige tinte tenui e rilassanti, l’utilizzo di elementi in legno contribuisce a rafforzare l’idea di calore e di intimità all’interno della stanza di degenza. Questa condizione particolare, sospesa tra una importante fase di relazione e condivisione e una altrettanto importante necessità di determinare spazi distinti, ricreando una idea di privacy, è stata affrontata mediante soluzioni percettive come l’utilizzo di colori differenti in corrispondenza dei due letti e l’allestimento di controsoffittature che, oltre a contenere i corpi illuminanti puntuali sulle due postazioni letto, sottolineano, anche sull’elemento di soffitto, una precisa distinzione fra i due spazi. Anche l’illuminazione è appositamente studiata per risultare regolabile autonomamente nelle due postazioni nonché minimamente invasiva nei confronti della postazione adiacente.
La disposizione speculare dei divanetti, oltre a garantire la vicinanza e l’intimità individuale fra genitore e paziente, crea uno spazio vuoto fra i due letti: un corridoio che segna un
ulteriore confine ma soprattutto un percorso per gli operatori sanitari che non interferisce con lo spazio di contatto fra il bambino e il genitore, aumentando considerevolmente il senso di sicurezza e protezione anche nelle delicate fasi di visita o medicazione.
Anche le minime dotazioni tecniche normalmente presenti nelle sale di degenza come le prese di ossigeno, solitamente integrate in una canaletta metallica posta immediatamente sopra le testiere dei letti, possono risultare oggetti invasivi e disturbanti per la paura che possono incutere al bambino; si è optato pertanto per una soluzione che integra tali elementi all’interno di una controparete cablata e rivestita in laminato e che contribuisce a disegnare il layout architettonico della stanza mediante una cornice che maschera i corpi illuminanti. Oltre all’opportuno valore attribuito all’illuminazione naturale mediante le ampie finestrature, per quanto riguarda il tema della Luce ambiente l’obbiettivo è stato la realizzazione di un’illuminazione degli ambienti di degenza realizzata secondo le esigenze emotive e funzionali del paziente in età pediatrica e di chi lo assiste. Infatti, la qualità della luce in ambito ospedaliero, deve essere in grado di assecondare l’intero quadro delle emotività infantili, riducendo lo stress e promuovendo una predisposizione positiva rispetto al luogo di ricovero e di cura.
Relativamente alla qualità della luce particolare attenzione è stata posta al controllo della temperatura di colore e dell’indice di resa cromatica. In particolare, per gli spazi di degenza si è fatto riferimento alla indicazione normativa che prevede un indice di resa cromatica 1B o RA compreso tra 80 e 90, valori che consentono di scegliere temperature di colore della luce più basse (intorno ai 3000 gradi Kelvin) in grado di offrire una luce più calda e maggiore comfort ambientale senza ridurre troppo i valori di efficienza (lumen/watt).
L’obbiettivo è stato inoltre quello di rendere il bambino attivo nella definizione dello scenario luminoso in cui dovrà vivere la propria esperienza di ricovero, al fine di integrare la percezione visiva nel percorso di cura e, qualora possibile rispetto al quadro clinico del paziente, offrire le migliori condizioni di relazione rispetto ad attività ludiche e formative.
L’illuminazione della camera prevede quindi:
• una illuminazione generale dell’ambiente in tutti i toni del bianco e colore che ricrei atmosfere variabili per aiutare il benessere psico-fisico, anche attraverso l’attenzione all’influenza della luce sui ritmi circadiani, e garantisca al tempo stesso il corretto illuminamento per i momenti più operativi e di diagnosi;
• uno o più punti di luce bianca che permettano di garantire una corretta illuminazione in tutte le situazioni più personali o operative dando anche la possibilità di ricreare un proprio spazio per svolgere alcune attività senza disturbare le altre persone eventualmente presenti nella stanza.
Riguardo l’ambito sonoro si sottolinea come gli elevati valori di fonoisolamento di facciata imposti agli ospedali

1 e 2. Simulazioni virtuali delle stanze di degenza con indicazione della posa dei pvc e di varie tipologia di tinteggi
DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA 03
REDATTO
32

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO DI STUDI SPECIALISTICI
LA STANZA INTONATA
A. PAVIMENTAZIONI SOLUZIONI DI FINITURA

B. PAVIMENTI IN GRES E RIVESTIMENTI IN KERLITE SOLUZIONI DI FINITURA




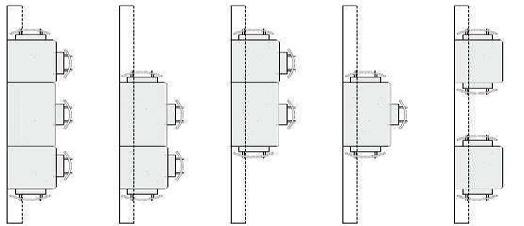
SISTEMA FLESSIBILE DEI TAVOLINI
dalle norme e regolamenti nazionali, il controllo dei rumori di origine impiantistica, i materiali dei pavimenti ad alta impedenza (gomma, linoleum, ecc.), determinino, all’interno dell’ospedale, la presenza di un ambiente che può risultare estremamente silenzioso; tale situazione può condizionare lo stato d’animo, l’attenzione verso ciò che succede in prossimità, i sensi diventano più reattivi e rimangono “in ascolto”. Quando lo stato della malattia è critica, l’ambiente sonoro deve essere tale da ridurre il rapporto segnale/ rumore, quando le energie aumentano possono aumentare anche le occasioni di ascolto.

COMBINAZIONI POSSIBILI PER FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE, IL GIOCO E LO STUDIO
RAPPORTO VISIVO DIRETTO CON IL GENITORE
FINITURE CROMATICHE DEFINITE IN BASE ALLA PSICOLOGIA DEL COLORE
AREE DEDICATE AL GIOCO E ALLA RELAZIONE
ARREDI ED ELEMENTI LUDICI E VIVACI
C. RIVESTIMENTO
PARETI E CABLAGGI
DELLE SOLUZIONI IN LEGNO
TIPO RIGATINO
INTEGRAZIONE LUCE NATURALE-ILLUMINAZIONE PERSONALIZZABILE
POSSIBILITA’ DI VISUALE SULL’ESTERNO DAL POSTO LETTO

Ciò premesso, il progetto ha previsto la predisposizione delle stanze di degenza per l’immissione di suoni che potranno essere personalizzati per ogni singolo paziente, mediante la realizzazione di un sistema di diffusione sonora con controllo centralizzato. L’immissione di suoni ambientali sarà caratterizzata da livelli e ritmi dosabili in modo differenziato in base alle prescrizioni e ad un protocollo predisposto sia dagli operatori sanitari, sia sulla base di una fase di screening operata mediante il coinvolgimento di uno psicologo dell’infanzia. La principale finalità è di innalzare il fondo acustico ambientale a valori di comfort psicologico per i degenti: nelle stanze i suoni saranno resi differenziati rispetto ai corridoi ed ai luoghi di passaggio in genere e potranno seguire i ritmi della giornata (mattino - risveglio, pomeriggio sera, notte). Il clima acustico della stanza potrà essere inoltre correlato all’intensità della luce immessa nell’ambiente.
La stanza intonata alla soggettività rappresenta la massima espressione di attenzione al paziente in cura.
La privacy implica la possibilità di avere preservato un livello di intimità, ovvero devo poter staccare dall’ambiente circostante e poter stabilire un limite. Il limite è la soglia del mio spazio che deve essere preservato e preservabile.
Dire che la stanza intonata è un momento privato a tonalità pubblica è riconoscere alla cura la dignità della soggettività personale, in connessione con la dimensione della cura nella sua valenza pubblica.
Perché la stanza sia intonata deve prevedere da parte del “gestore” il riconoscimento di un “sistema multiplo di condivisione della soggettività”, ovvero la possibilità che quel luogo diventi, in funzione del benessere, il luogo dei rispecchiamenti di emozioni, azioni, visioni, suoni, imitazioni, empatia e relativo scenario della intersoggettività. La musica, le sonorità, possono segnare come una colonna sonora gli accenti della cura e delle cure, nelle differenti necessità di rilassamento e riattivazione, per riaprire il dialogo tra corpo e mente dalla funzione curativa alla funzione accuditiva e creativo-ricreativa. La sensazione del gestibile, ovvero che la malattia sia gestibile, può necessitare della flessibilità per riconoscersi flessibili partendo dal proprio limite.
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
A B C 33






1 e 2. Ospedale dei Bambini di Parma - L’area del pronto soccorso pediatrico è progettata per adattare i suoi livelli di illuminamento a seconda delle condizioni esterne; il bancone di accettazione cambia in modo dinamico di colorazione grazie ad un sistema a led
3. Ospedale dei Bambini di Parma - Dettaglio del sistema di illuminazione dimmerabile delle stanze di degenza
4. Ospedale dei Bambini di Parma - La luce naturale, gli elementi cromatici della facciata ed il rapporto con l’esterno accompagnano i momenti del ricovero in day hospital
5. Ospedale dei Bambini di Parma - Il cavedio centrale diffonde in maniera generosa luce naturale all’interno, garantendo un corretto rapporto con l’esterno, eliminando la sensazione si spazio confinato tipica degli spazi di distribuzione ospedaliera
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA 04 1 3 4 5 2 34

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO DI STUDI SPECIALISTICI
LIGHT DESIGN
La luce può svolgere un ruolo fondamentale nella costruzione di un rapporto positivo con l’ambiente in cui si è momentaneamente costretti.
Attraverso un attento utilizzo della luce si ricrea un “environment” più sensibile alle necessità del paziente e dei suoi famigliari, che li accompagna in questa esperienza fornendo supporto agli stati emotivi.
Infatti la luce può agire secondo diversi livelli nella limitazione dello stress e nella creazione di un rapporto di identificazione e appropriazione dello spazio. Questo rende l’ospedale un luogo non vissuto come un “altrove ostile” ma fa percepire lo spazio come un ambiente che può essere sentito proprio, più vicino ad una quotidianità domestica.
L’ interpretazione della luce a favore del benessere dell’individuo deve essere attenta non solo agli aspetti sensoriali psicologici ma anche a quelli fisiologici, all’influenza che la luce naturale e artificiale ha sui bioritmi umani.
Il corpo umano tende a sincronizzarsi con il ciclo giornaliero e stagionale della luce naturale, mantenendo in questo modo un equilibrio fisiologico e psicologico prezioso. È intuibile perciò l’importanza di mantenere uno stretto rapporto tra le persone e l’ambiente esterno, soprattutto nei casi di lunga permanenza in ambienti chiusi.
Anche per questo motivo l’architettura deve essere studiata per creare un intenso rapporto di scambio tra l’interno e l’esterno, soprattutto valorizzando l’apporto della luce naturale. Per consentire il rispetto totale dell’equilibrio dei bioritmi legati alla luce, deve essere data la possibilità di interagire nel bilanciamento tra luce naturale e artificiale. La luce va interpretata come uno strumento flessibile e adattabile ai bisogni psicologici e fisiologici oltre che funzionali ed operativi del paziente, dei suoi famigliari e del personale medico.
Attraverso la sua variabilità controllata la luce ricrea privacy, senso di appartenenza e comfort, atmosfere rilassanti o stimolanti, interazione. . Per ottenere e soddisfare in pieno questo senso di appartenenza e di confidenza con lo spazio
nelle aree più private dell’attesa e negli spazi della degenza la gestione personale della luce deve essere diretta e semplice, in modo che si realizzi l’integrazione tra l’apporto di luce naturale ed artificiale.
Il Light Design si occupa dunque di controllare le esigenze personali legate ad un progetto di luce, governando in maniera professionale le sinergie fra emozione e comfort visivo, caratterizzazione e funzionalità.
Attraverso software innovativi ed esperienza maturata nel settore si è in grado di impiegare le combinazioni di luce naturale e artificiale come strumento per la modellazione dello spazio in modo che divenga un elemento architettonico sostanziale ma anche flessibile alle esigenze specifiche di ogni ambiente nelle diverse condizioni dell’arco temporale giornaliero piuttosto che a variazioni di carattere atmosferico.
A tal proposito si sottolinea come precedenti esperienze abbiano fornito utili indicazioni in merito alla necessità di approfondire alcuni fondamentali aspetti interconnessi all’uso della luce:
• un attento studio dei diagrammi di analisi dell’irraggiamento solare per riuscire a filtrare in facciata la luce naturale e riuscire a creare una sorta di porosità visiva tra interno ed esterno;
• utilizzare la luce naturale in testa ai percorsi distributivi orizzontali per consentire un corretto orientamento rispetto all’esterno e per manifestare all’interno i cambiamenti naturali e climatici;
• attenta modellazione dei livelli di illuminamento naturale per riuscire ad integrare correttamente l’apporto di illuminamento artificiale negli ambienti ritenuti fondamentali dove intervenire per aiutare il benessere psico-fisico del paziente.
Il Light Design quindi non si prefigge l’obiettivo di illuminare semplicemente ma piuttosto di ottenere, da un punto di vista prestazionale, il più alto livello, sia nell’ambito estetico che funzionale, dell’ambiente interessato dalla luce.
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
35
SOUND MASKING
Un tema recentemente inserito e studiato nell’ambito della progettazione di edifici è il cosiddetto “speech privacy”, che consente di valutare il grado di comprensibilità di un discorso da parte di una persona estranea ad esso. Il tema riguarda in prima battuta la riservatezza delle informazioni comunicate per via verbale, con graduazione differente in funzione della sensibilità e del valore delle informazioni (dati personali, dati sensibili, comunicazioni ordinarie, ecc.), ma le stesse problematiche determinano il “potenziale di distrazione” di una conversazione nei confronti di un soggetto non direttamente coinvolto nella stessa: la concentrazione di un soggetto, infatti, si riduce significativamente in presenza di un suono al quale il cervello è in grado di attribuire un significato e pertanto una conversazione risulta disturbante nel momento in cui si è in grado di comprendere le parole che la compongono.
Occorre infine sottolineare che gli ambienti di vita e di lavoro necessitano anche di caratteristiche acustiche tali da consentire una buona comprensione dei messaggi verbali perché questi possano essere fruibili, compresi i segnali immessi nell’ambiente per segnalare la possibilità o l’insorgenza di una situazione di pericolo; la progettazione deve pertanto dosare le varie componenti che influiscono sull’intelligibilità in modo tale da conseguire entrambi gli obiettivi.
OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE
L’esperienza comune dimostra come la sensazione di mancanza di privacy possa portare ad abbandonare la permanenza in un locale per trovare una collocazione di maggiore riservatezza; il disagio è in genere proporzionale all’attesa, pertanto maggiore è il grado di riservatezza richiesto e più elevato sarà la sensazione di fastidio prodotta da una eventuale deficienza.
Il requisito di privacy risulta di conseguenza rilevante rispetto alla fruibilità di un locale in misura proporzionale alla sensibilità dello stesso. In primo luogo, pertanto, la progettazione deve provvedere ad una analisi di screening sulla sensibilità delle diverse destinazioni d’uso previste nell’ambito del progetto, concentrandosi su quelle caratterizzate da requisiti prestazionali più elevati.
E’ quindi necessario procedere con una valutazione relativa alla configurazione progettuale iniziale, la rispondenza o meno con i valori attesi determina la necessità di interventi di adeguamento.
METODOLOGIA DI STUDIO
L’intelligibilità di una conversazione, che essa si svolga in un locale diverso da quello in cui è posizionato l’ascoltatore o che si svolga nello stesso locale, dipende sostanzialmente dagli stessi fattori e la corretta progettazione acustica deve pertanto agire su questi elementi:
• la riverberazione dei locali oggetto di indagine gioca un ruolo primario nella comprensione del parlato. A parità di sforzo vocale, in un locale riverberante si realizza un livello di pressione acustica più elevato rispetto allo stesso locale dotato di rivestimenti fonoassorbenti;
• l’attenuazione introdotta dagli elementi di separazione presenti, a tutta altezza (ambienti differenti) o ad altezza parziale (open space) riduce il livello di pressione percepita sul lato opposto dell’elemento. Una maggior attenuazione aumenta il livello di privacy;
• lo sforzo vocale, o la potenza dell’impianto di riproduzione, determinano il livello di pressione sonora alla sorgente, pertanto a valori più elevati corrispondono livelli di privacy inferiori;
• il rumore di fondo è un fattore che influenza significativamente il risultato finale in quanto agisce come elemento mascherante. Già da diversi anni sono stati introdotti sistemi di sound masking, il cui scopo è l’introduzione di rumori di fondo in ambienti eccessivamente silenziosi e che non consentono di realizzare diversamente il livello di privacy richiesto. L’efficacia dei sistemi di sound masking dipende sostanzialmente dallo spettro di rumore generato, in quanto l’obiettivo è quello di conseguire un livello di privacy sufficientemente elevato senza introdurre fenomeni di annoyance nei soggetti interessati.
Le verifiche progettuali dovranno innanzitutto riguardare la localizzazione degli ambienti in cui è maggiormente presente una domanda di privacy.
Occorre identificare i locali sensibili in cui potrà essere promossa, per esempio, la comunicazione diagnostica tra medico e paziente. Inoltre bisognerà prevedere comunque, elevate caratteristiche di flessibilità prestazionale e, pertanto, consentire di adottare i presidi di privacy anche con interventi futuri, qualora alcuni ambienti dovessero presentare la necessità di un maggiore isolamento acustico.

1. Studio acustico dell’ambiente interno con indicazione della distribuzione e definizione def50 a 1000 hz
2. Studio acustico dell’ambiente interno con indicazionedistribuzione dei livelli di pressione sonora a 8000 hz
DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA 05
REDATTO
36

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO DI STUDI SPECIALISTICI
SOUND MASKING E SOUND DESIGN


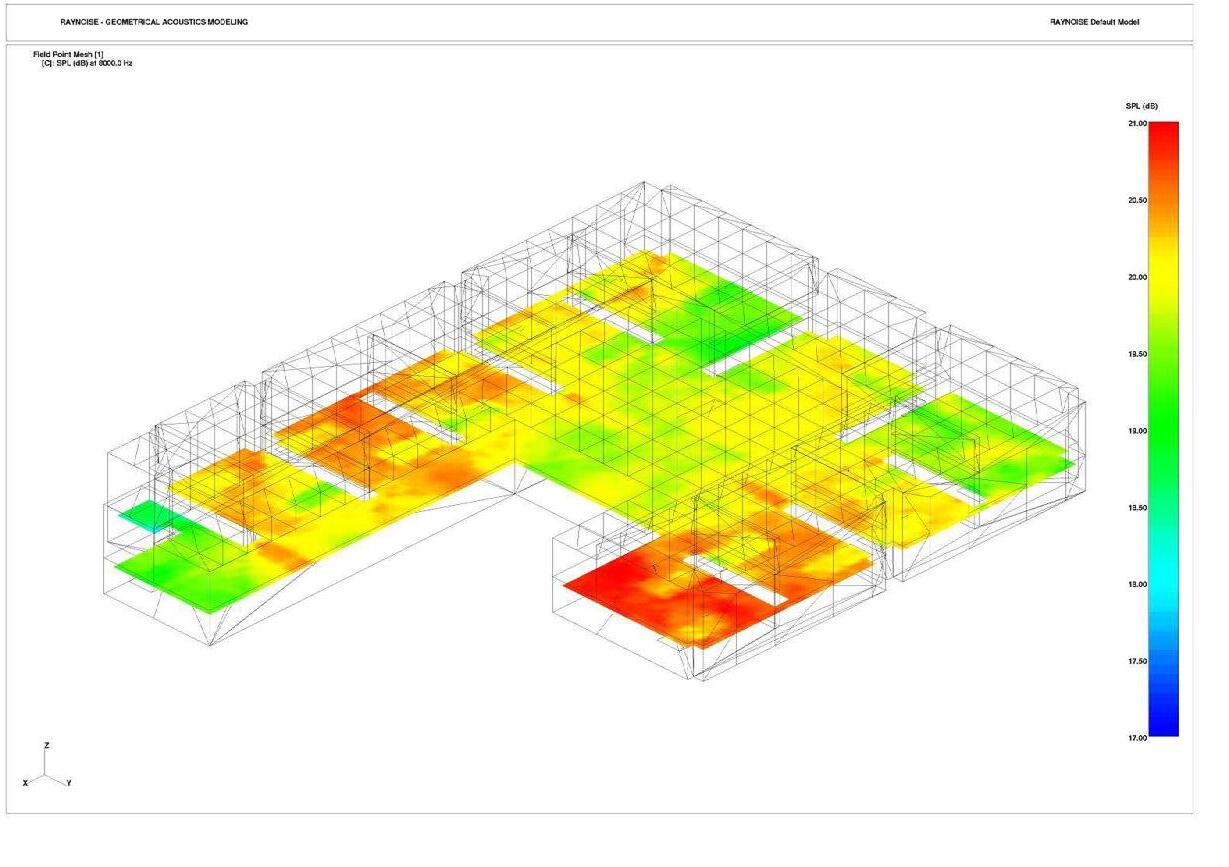
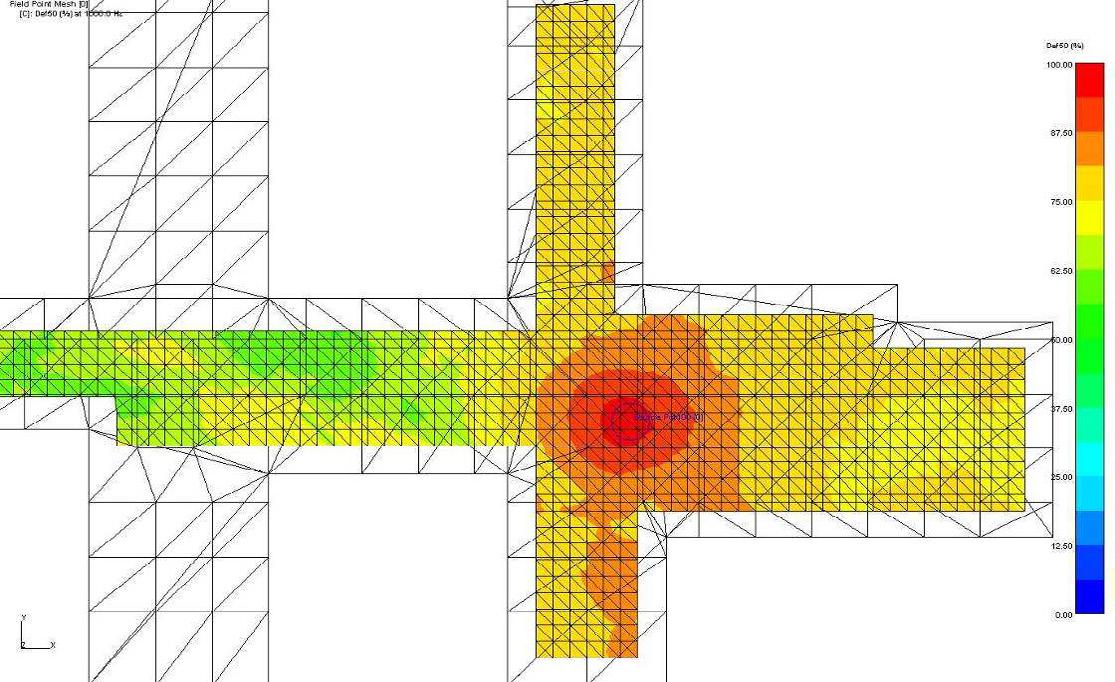
SOUND DESIGN
I suoni rappresentano un potente strumento con cui indirizzare gli stati d’animo che convivono in luoghi diversi dell’ospedale o nell’ambito dello stesso luogo.
Il primo passo consiste nella ottimizzazione della risposta acustica degli ambienti critici, quali sono le aree degenza e degli ambienti ad alta frequentazione (sale d’attesa, palestre, corridoi,..). Le scelte tecniche dovranno essere orientate all’architettura aurale o uditiva degli spazi.
Negli ambienti resi più “accoglienti” è importante attuare una gestione del silenzio e della sonorizzazione, a partire dalle aree in cui si localizzano le maggiori condizioni di stress, al fine di stimolare correttamente il paziente in funzione del suo stato clinico e/o psichico, anche con il ricorso alla immissione di suoni che possono ridurre il distacco dall’ambiente di vita familiare.
L’immersione in un ambiente silenzioso condiziona lo stato d’animo, l’attenzione verso ciò che succede in prossimità, i sensi diventano più reattivi e rimangono “in ascolto”. Un silenzio imposto in cui provarsi, un silenzio dove si colloca un corpo malato che emette suoni e una mente che può diventare “rumorosa”. Al malato è bene non fare sentire troppo questo corpo: meglio non ascoltare sè stessi, meglio non ascoltare i passi che si avvicinano, meglio non fare ascoltare le autoambulanze che arrivano in ospedale.
Quando lo stato della malattia è critica, l’ambiente sonoro deve essere tale da ridurre il rapporto segnale/rumore, quando le energie aumentano possono aumentare anche le occasioni di ascolto.
Nella fase di ristabilimento la musica-suono diventerà attraverso le onde sonore una sorta di massaggio stimolante, che aiuta a corroborare l’intenzione di azione, il senso della propensione all’intersoggettività, quasi a solleticare, avvertendo della presenza dell’altro, aprendosi alla connessività, recuperandosi ai possibili sé oltre il sé malato. I ritmi sonori possono corroborare i ritmi cardiaci che accompagnano alla pluralità delle emozioni, il corpo si incammina dopo essere stato allettato, si predispone al so-stare per ritornare ad imparare. Il limite della malattia ci accompagna come esperienza vissuta e data, ma sempre meno pervasa e sempre più ricordo del corpo già offeso ma ora proteso.
Si pone la necessità di individuare una sorta di SOUND MANAGER che possa orchestrare la diffusione, infusione, soffusione dei suoni e delle sonorità, figura che deve collaborare con “sound leader” presenti nei sub-luoghi. Gli uni e l’altro debbono avere una sound-teca da cui attingere per sviluppare le possibili colonne sonore della cura, da differenti diffusori collocati nelle strutture, diffusori che possono essere gestibili in parte in periferia e in parte in remoto dalla regia, comunque su uno spartito condiviso.
APPALTO
PROGETTAZIONE
PROGETTO
ELABORATI
APPALTO CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZA ZIONE DEI LAVORI DELL’“AMPLIAMENTO MONOBLOCCO E PIASTRA TECNICA OSPE DALE DI PARMA: 4° LOTTO” PROGETTO ESECUTIVO ELABORATI GENERALI Relazione Acustica in ottemperanza al D.P.C.M. del 5.12.1997 Raggruppamento Temporaneo di Imprese: TECNO –E S.r.l. (Mandataria) FIGURA 4.5.3-9 –D ISTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA A 8000 H Z REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
CONCORSO PER LA
E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELL’“AMPLIAMENTO MONOBLOCCO E PIASTRA TECNICA OSPEDALE DI PARMA: 4° LOTTO”
ESECUTIVO
GENERALI Relazione Acustica in ottemperanza al D.P.C.M. del 5.12.1997
1 2 37
segnalatore sonoro di arrivo al piano e segnalatore luminoso di allarme placca di riconoscimento del piano in rilievo e in Braille

autolivelamento al piano con tolleranza ± 2cm
porte non intrappolanti e aperte al piano almeno 8 sec, chiusura almeno 4 sec.
pulsantiera con numerazione in rilievo e scritte in Braille
segnale luminoso di conferma dell'avvenuta chiamata di allarme
luce di emergenza con autonomia di 3 ore
normativa tecnica europea UNI CEN/TS 15209:2008 "TACTILE PAVING SURFACE INDICATOR PRODUCED FROM
DIMENSIONI DI RIFERIMENTO E SPAZI DI MANOVRA

campanello di allarme e citofono h 110÷130cm

In caso di oggetti posti ad altezza da terra fino a cm 65 l'aggetto può avere qualunque misura
1. Dettaglio della scala dell’Ospeale dei Bambini di Parma, in evidenza le finiture delle pavimentazione, il disegno arrotondato dei corrimano posti ad altezze differenti per un uso da parte di adulti e bambini.
2. Posa di un percorso tattilo-plantare
3. Esempio di percorso per ipovedenti (in particolare la codifica per un “pericolo valicabile”)
PERICOLO VALICABILE 90÷150 70 15 15 0 40 80 80 40 0 80 40 20 60 100 140 180 40 67÷75 135÷150 125 27° 67 25 90÷95 65÷70 150 150 110 110 140 140 45 170 140 45 140 45 min 150 max 65 Standard americani ANSI
max 65 max 30 > 65 min 210 max 10 > 65 max 110÷130
max 35 normativa tecnica internazionale ISO/FDIS 23599:2012 "ASSISTIVE PRODUCTS FOR BLIND AND VISION-IMPAIRED PERSONS - TACTILE WALKING SURFACE INDICATOR"
CONCRETE, CLAY
STONE"
AND
dati
sedia a ruote Rotazione
90° Rotazione di 180° (inversione di direzione) Rotazione di 360° (cambiamento di direzione) Svolta 1.22≥120 0.97 0.82≥80 0.97 0.82≥80 0.85 1.77 0.70 0.85 6.50 2.48 2.19 3.71 1.23 0.30 1.22≥120 0.97 0.82≥80 0.97 0.82≥80 0.85 1.77 0.70 0.85 6.50 2.48 2.19 3.71 1.23 0.30 1.27 0.29 0.10 1.66 2.27 0.70 2.97 1.00 0.40 0.43 0.43 min 150 min 140 110 80 150 110÷140 luce di emergenza con autonomia di 3 ore segnale luminoso di conferma dell'avvenuta chiamata di allarme pulsantiera con numerazione in rilievo e scritte in Braille porte non intrappolanti e aperte al piano almeno 8 sec. tempo di chiusura almeno a sec. 35 campanello di allarme e citofono h 110÷130cm segnalatore sonoro di arrivo al piano e segnalatore luminoso di allarme placca di riconoscimento del piano in rilievo e in Braille autolivelamento al piano con tolleranza ± 2cm
antropometrici
di
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA 06 1 2 3 4 38

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO DI STUDI SPECIALISTICI
L’ACCESSIBILITÀ E L’ERGONOMIA
Dall’art. 1 del DPR 503/1996 si evince che per barriere architettoniche si intendono gli “ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea”. Quindi, di fatto, una serie di impedimenti che limitano un’agevole e sicura utilizzazione di spazi e attrezzature a chiunque.
La difficoltà che persone con difficoltà incontrano quando desiderano muoversi liberamente nell’ambiente non sono sempre da attribuire alla situazione di disabilità in cui si trovano, ma speso sono cause che riguardano un ambiente difficilmente accessibile ed una società non sempre formata rispetto alle diversità delle loro esigenze.
Il problema in questione concerne le cosiddette “barriere architettoniche” il cui termine fu introdotto nella normativa italiana alla fine degli anni sessanta. Mentre inizialmente il termine si riferiva solamente ai disabili fisici con problemi di deambulazione, oggi la filosofia delle barriere architettoniche si basa su un concetto globale della mobilità comprendendo un sempre maggiore numero di persone.
Per mobilità si intende la capacita, abilità e disposizione di affrontare in modo autonomo le diverse situazioni di circolazione con la massima di sicurezza, il minimo di sforzo e il massimo rendimento.
Perché non superare le limitazioni degli interventi realizzati a norma e che si prefiggono di relegare in un qualche spazio soluzioni “ad hoc” spesso di dubbia qualità architettonica anche se certamente allineate con i parametri imposti dalle norme vigenti.
Le norme possono essere quindi una guida piuttosto che una costrizione o un percorso limitante, verificando che il soddisfacimento delle esigenze di alcuni possono corrispondere al raggiungimento di un’eccellenza qualitativa fruibile da tutti, quali che siano le condizioni psico-fisiche permanenti o temporanee.
L’Italia, pur seguendo un percorso tortuoso, è arrivata a dotarsi di un corpus normativo, anche di carattere tecnico, che affronta in maniera organica il problema della disabilità, distinguendosi in ambito comunitario.
Elemento che risulta evidente è la mancanza di indicazioni specifiche relative all’edilizia di tipo assistenziale ed ospedaliero, condizione dettata dal fatto che il decreto di applicazione del DPR 503/1996 non sia stato pensato in modo specifico per gli edifici pubblici ma piuttosto semplicemente si sia utilizzato quello in uso per l’edilizia privata (D.M. 236/89).
Per quanto concerne i percorsi orizzontali, ad esempio, le norme tecniche forniscono indicazioni riguardo alle dimensioni minime: “I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, e avere allargamenti atti a
consentire l’inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote” (art. 8.1.9 D.M. 236/89). All’interno di un ospedale tuttavia, tale “misura” non può che essere considerata soltanto un livello minimo a cui fare riferimento. Infatti in considerazione del fatto che la movimentazione più significativa riguarda lo spostamento dei letti, risulta evidente la necessità di considerare misure minime molto differenti da quelle considerate minime dalla normativa.
La medesima semplice osservazione delle effettive necessità che si riscontrano in una struttura ospedaliera portano a considerare “normali” situazioni che potrebbero venire considerate “casi limite”, ma che in realtà si manifestano con regolarità.
La rotazione di un letto che dal corridoio viene fatto entrare in una stanza necessita di un dimensionamento minimo del corridoio stesso superiore ai due metri. L’agile movimentazione di tali supporti richiede spazi di manovra preventivamente pensati perché risultino realmente efficaci e non appena sufficienti come spesso ci si trova a constatare. Mentre le norme e la diffusione della sensibilità hanno privilegiato i temi legati alla persona su sedia a ruote, pochi sono stati gli studi e i conseguenti provvedimenti normativi relativi agli accorgimenti necessari per agevolare l’uso degli edifici e degli spazi urbani a coloro che soffrono di menomazioni alla vista e all’udito.
L’articolo 2, comma c) del D.M.LL.PP. 236/1989 sottolinea come per “barriere architettoniche” si intenda anche “la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.
Il testo legislativo più recente in tal senso è il D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.”. La definizione più recente di “barriere architettoniche” per disabilità visive e uditive la si trova all’art. 1.2 comma c: “la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.
La normativa stessa lascia ampia discrezionalità al progetto, pur riconoscendo la necessità di tenere conto della normativa come punto di partenza. Infatti all’articolo 1.4 si legge “agli edifici e spazi pubblici esistenti,…, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento”.
Le soluzioni progettuali devono essere sviluppate con specifica attenzione al superamento delle barriere architettoniche riguardanti anche la definizione di opportuni materiali ed elementi di finitura tutti puntualmente individuate sulla base della legislazione di riferimento e delle considerazioni svolte sulla specificità dell’ambiente ospedaliero.
REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
39




1. Ingresso all’edificio
2. Prospetto Est
3-4. Cavedio interno
5. Day hospital
6. prospetto Est
7. Giardino pensile in corrispondenza del day hospital e vista del prospetto ovest
8. Connettivo degenze specialistiche
9. Atrio ingresso principale
10. Accettazione degenze polispecialistiche
11-12. Aree verdi destinate al gioco e al relax


REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA 07 1 3 4 5 2 40

IL VIAGGIO NELL’OSPEDALE DEI BAMBINI







REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA
6 8 11 12 9 10 7 41

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE
IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA
PIETRO BARILLA
 SERGIO BECCARELLI ARCHITETTO
SERGIO BECCARELLI ARCHITETTO

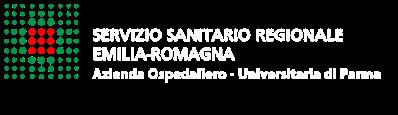





































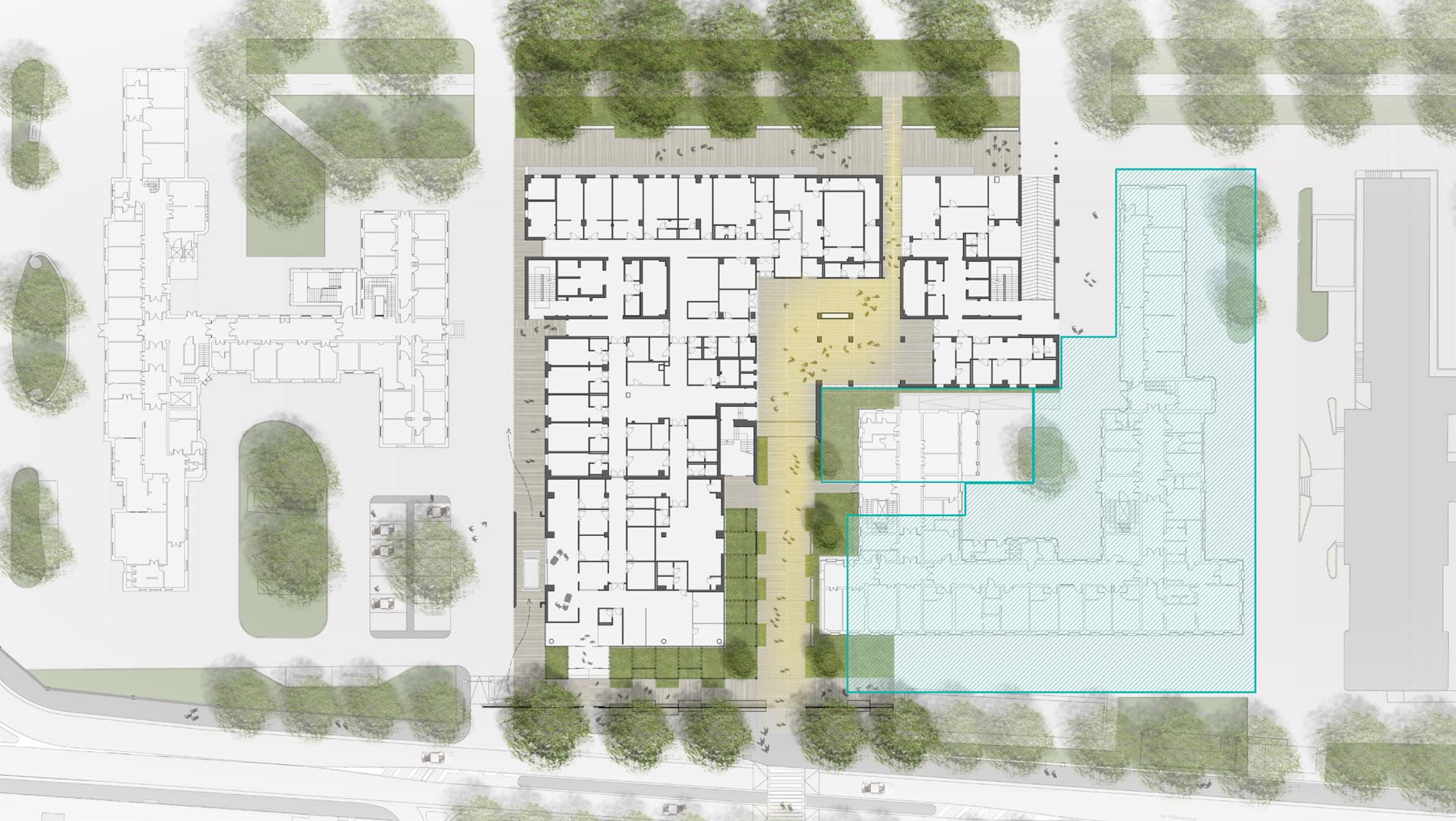

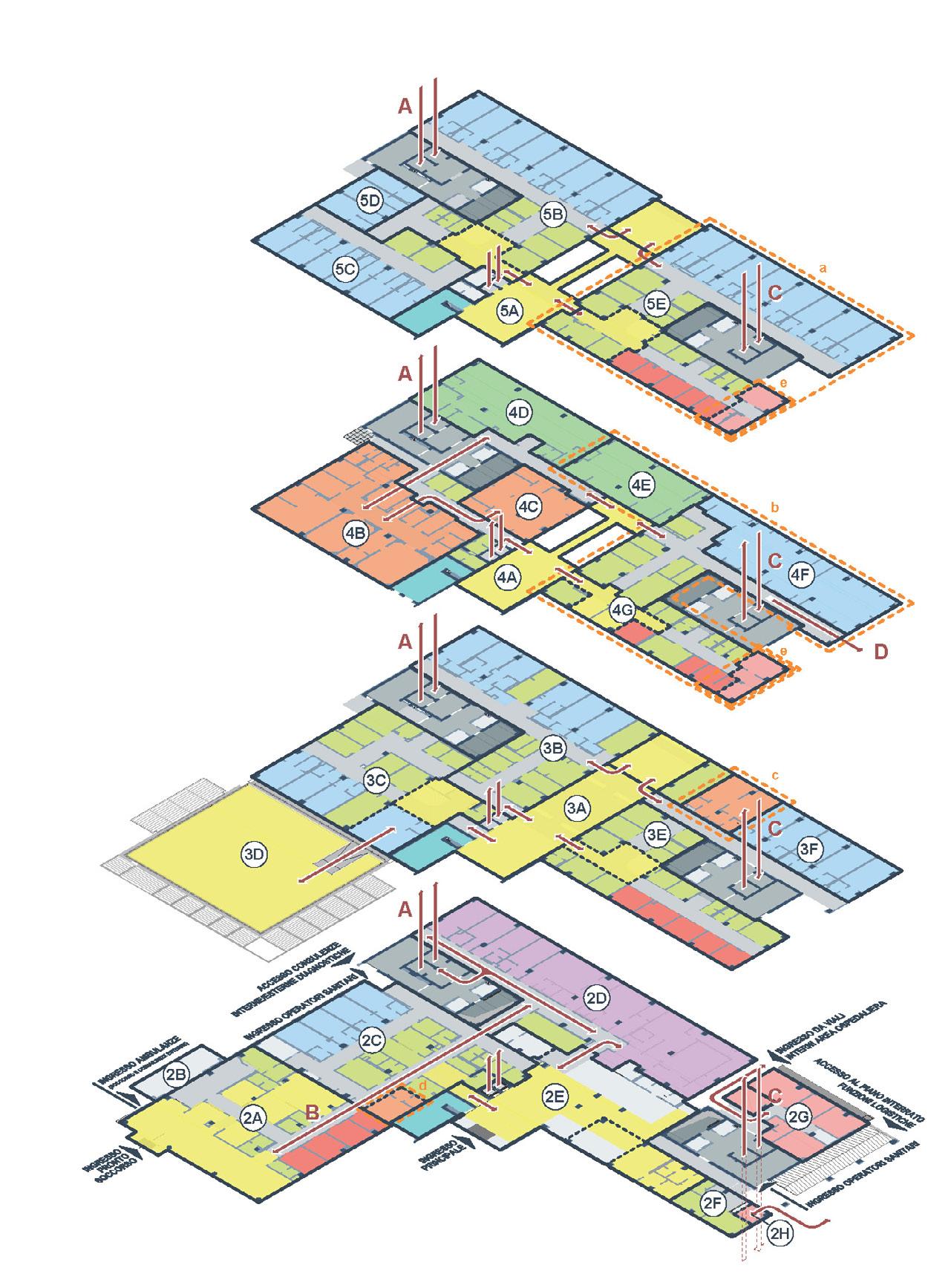
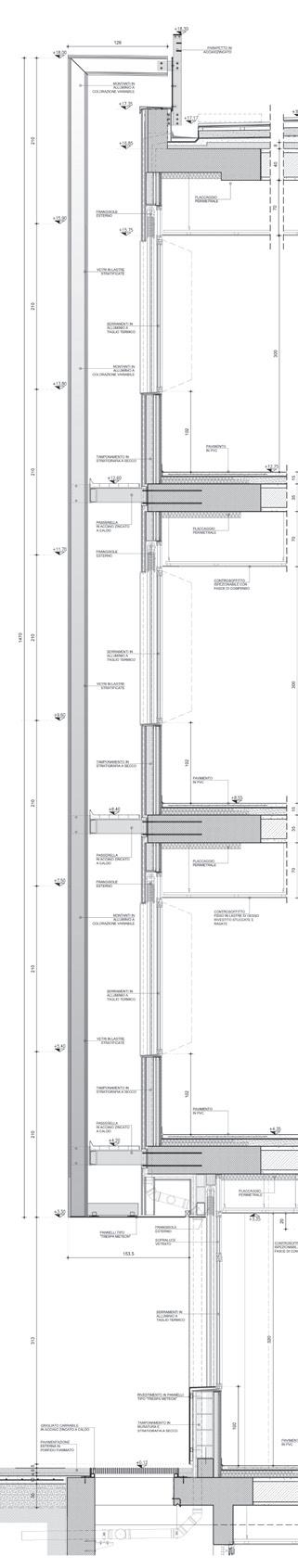



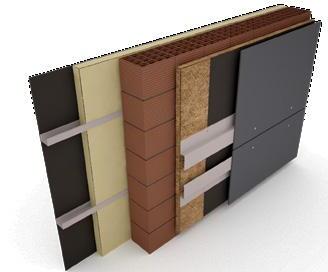




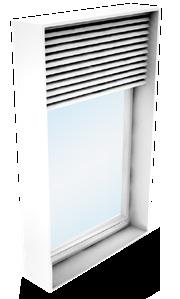











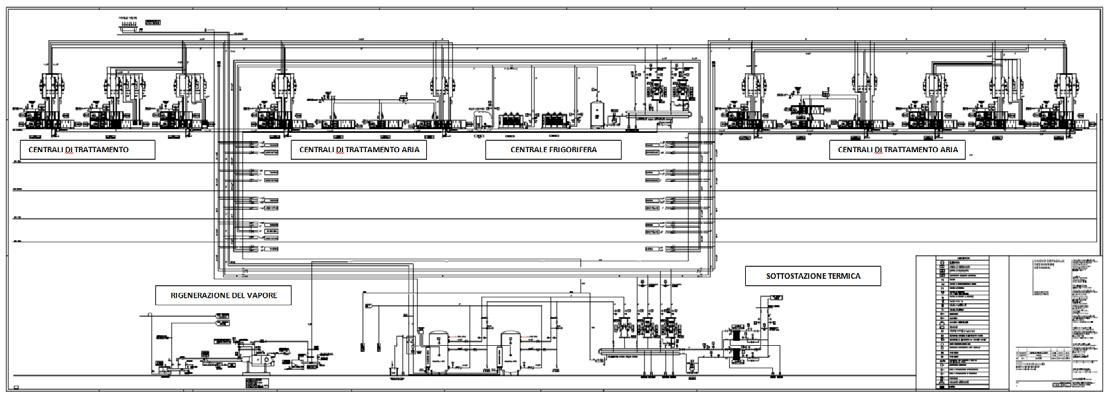
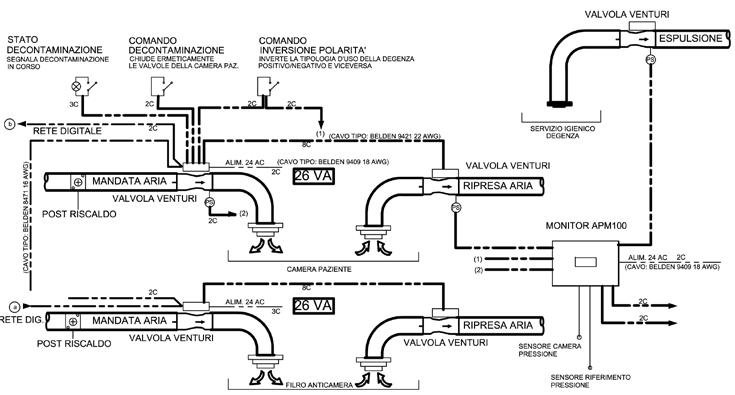







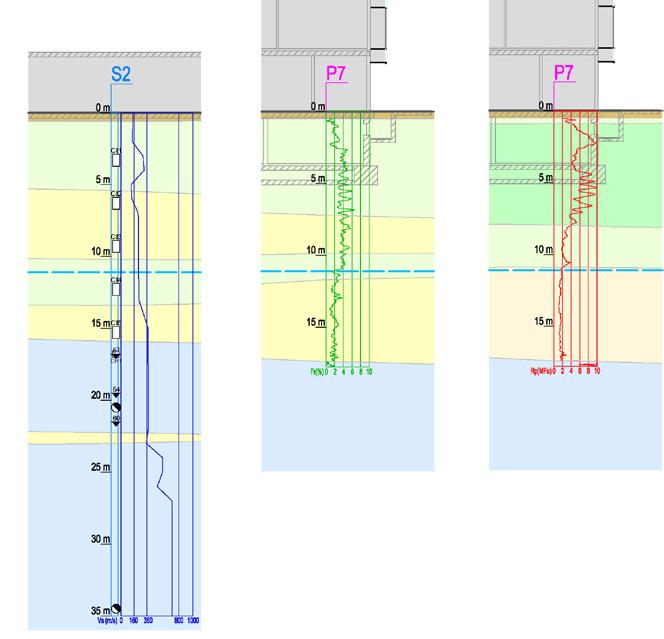

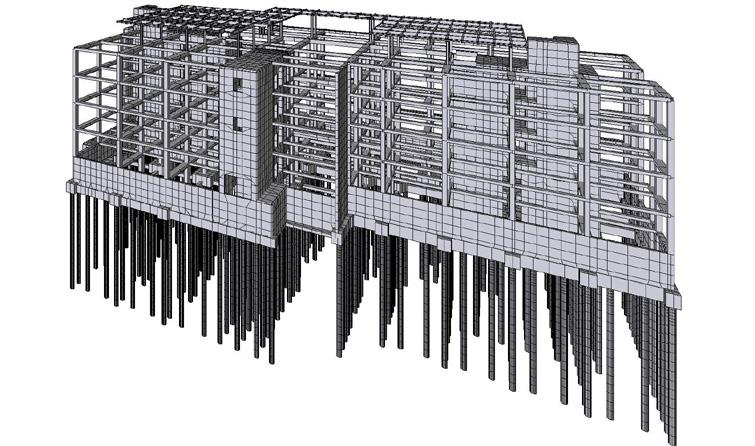





























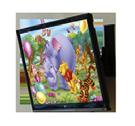







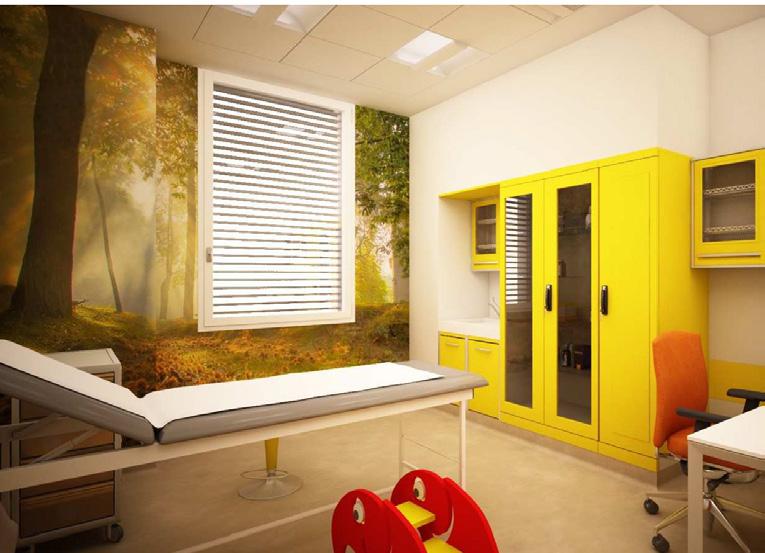





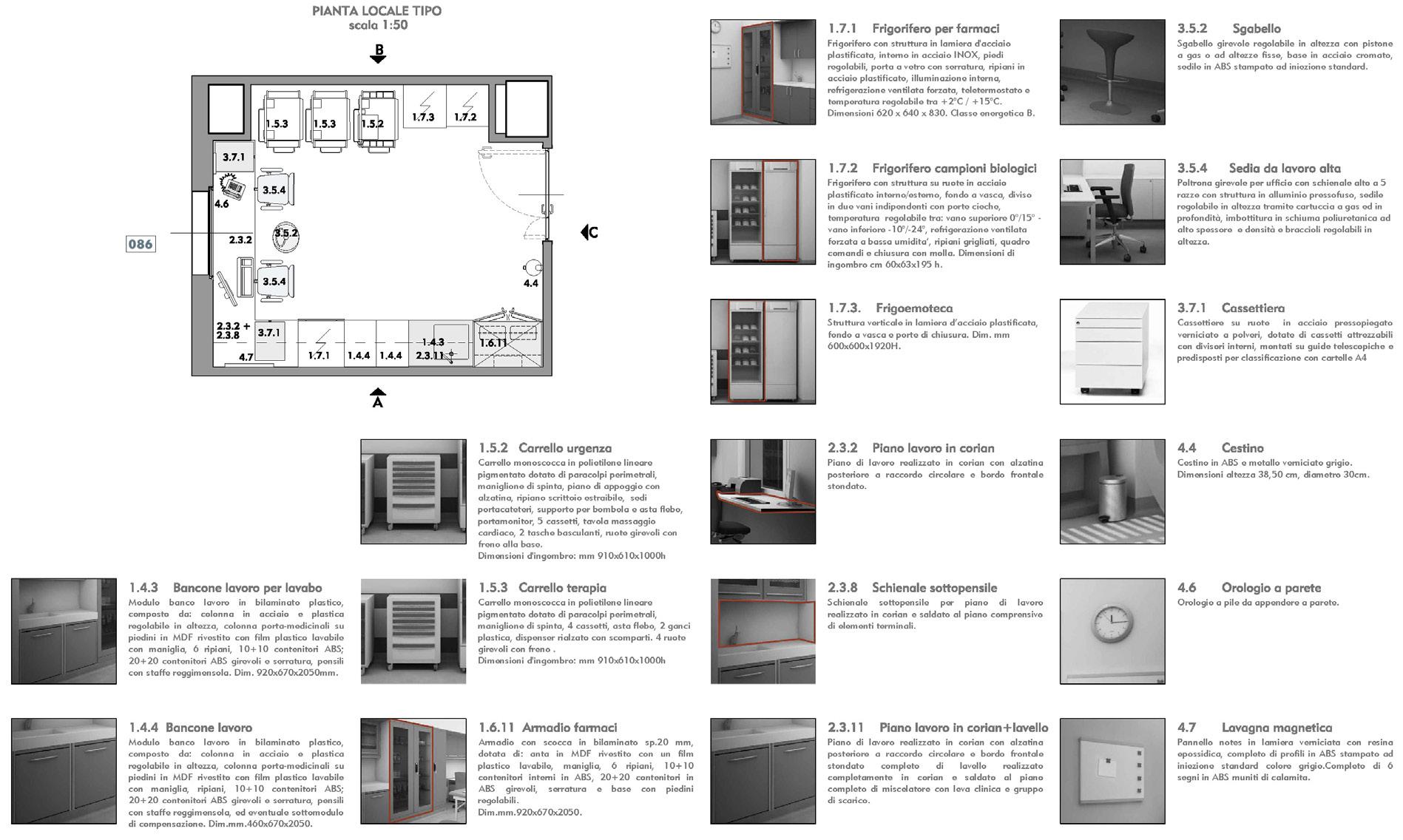
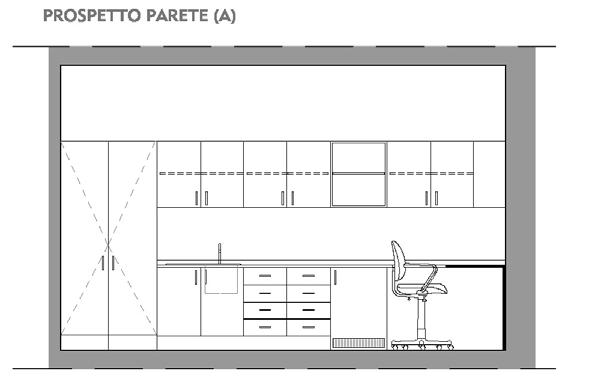
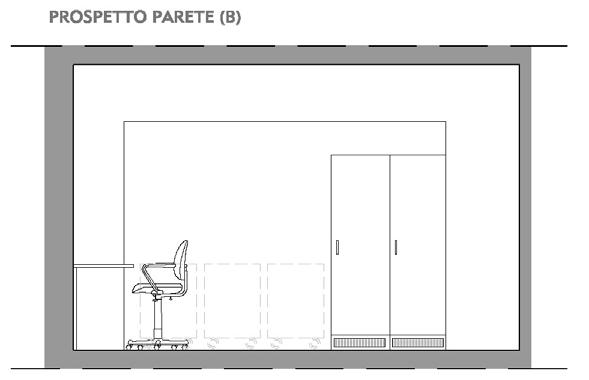




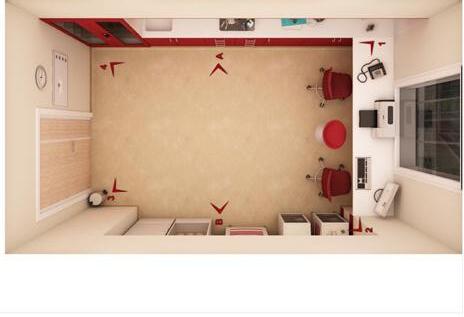








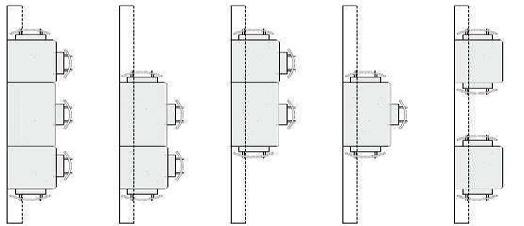









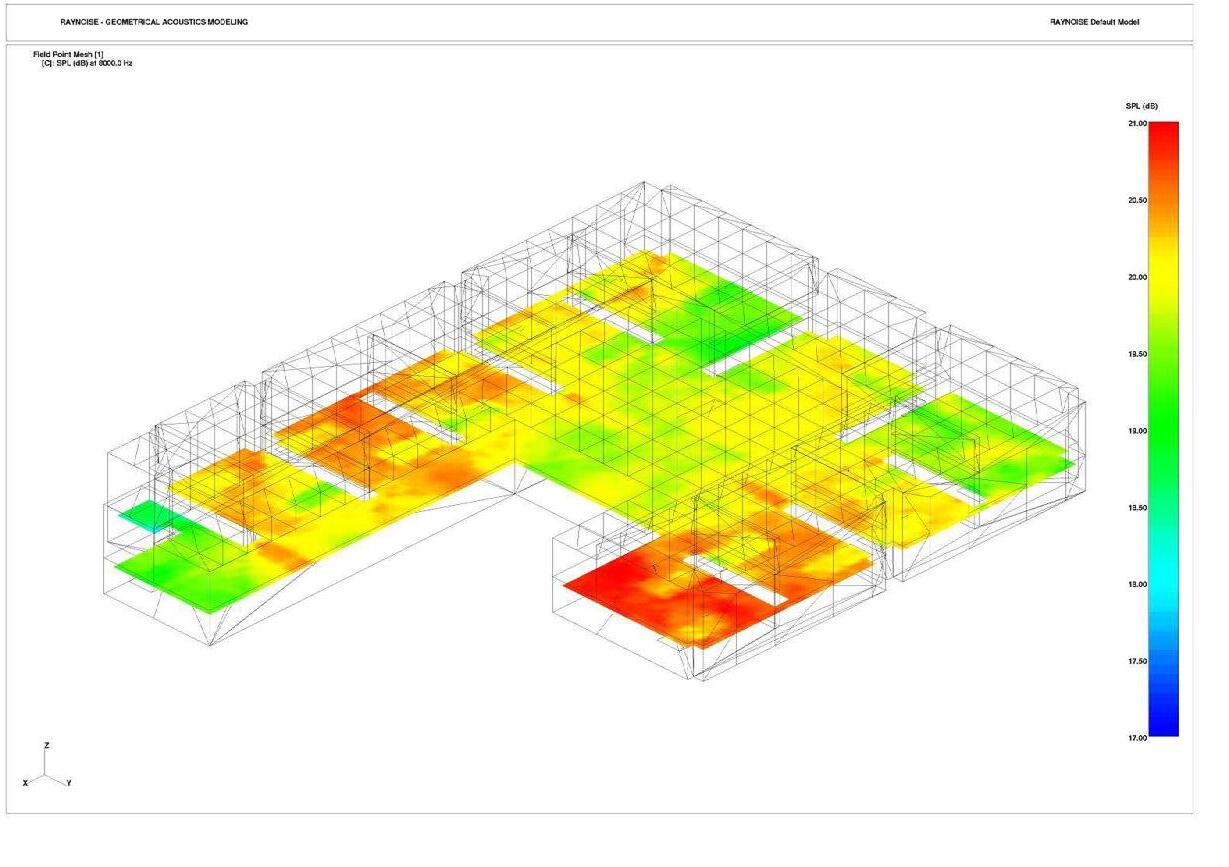
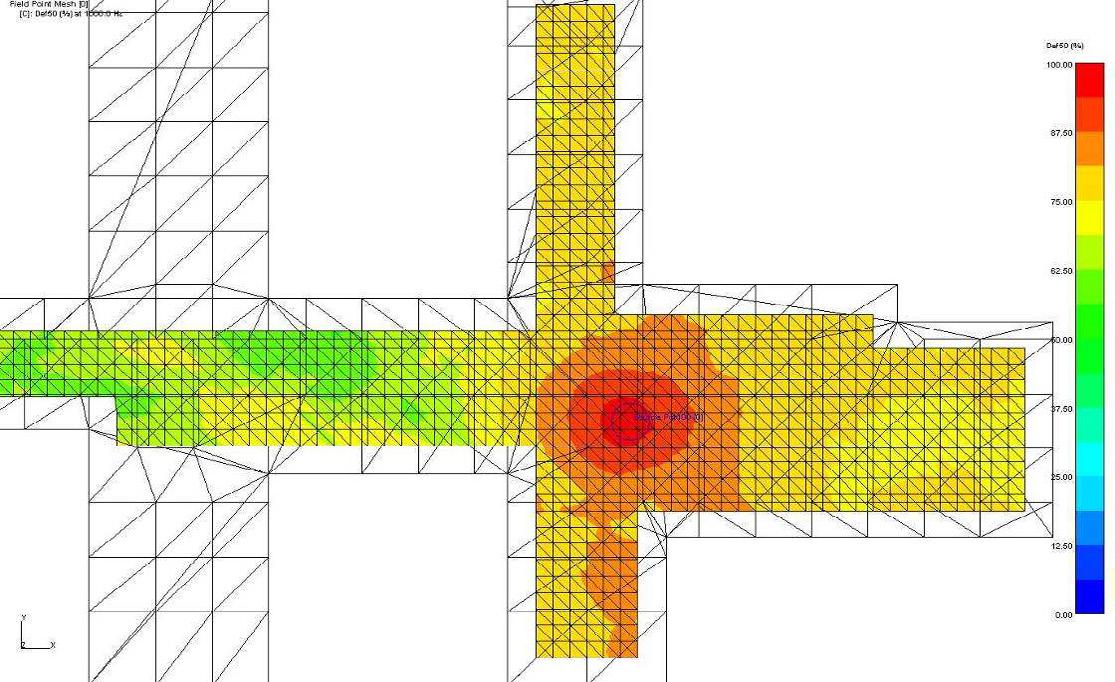














 SERGIO BECCARELLI ARCHITETTO
SERGIO BECCARELLI ARCHITETTO
