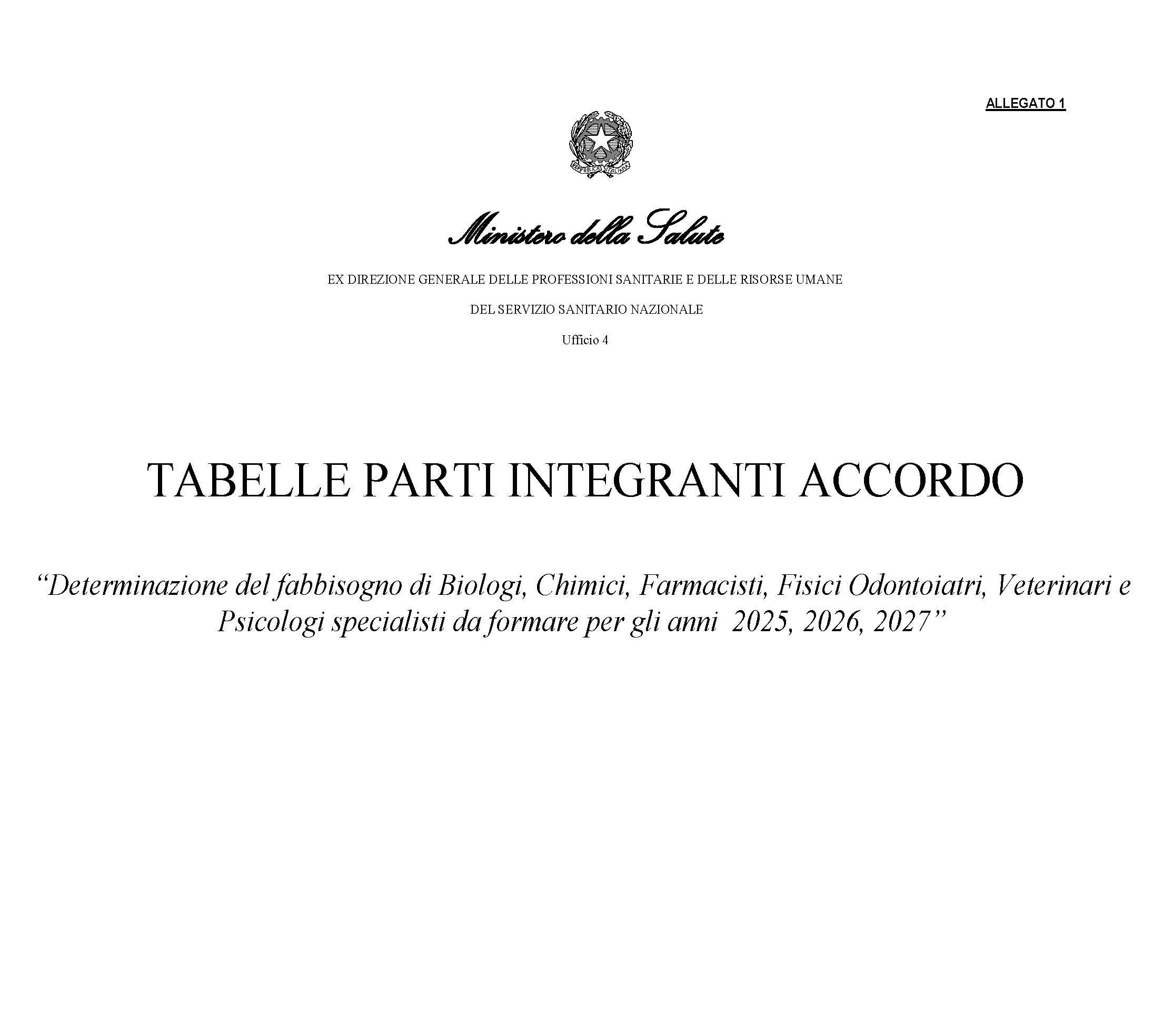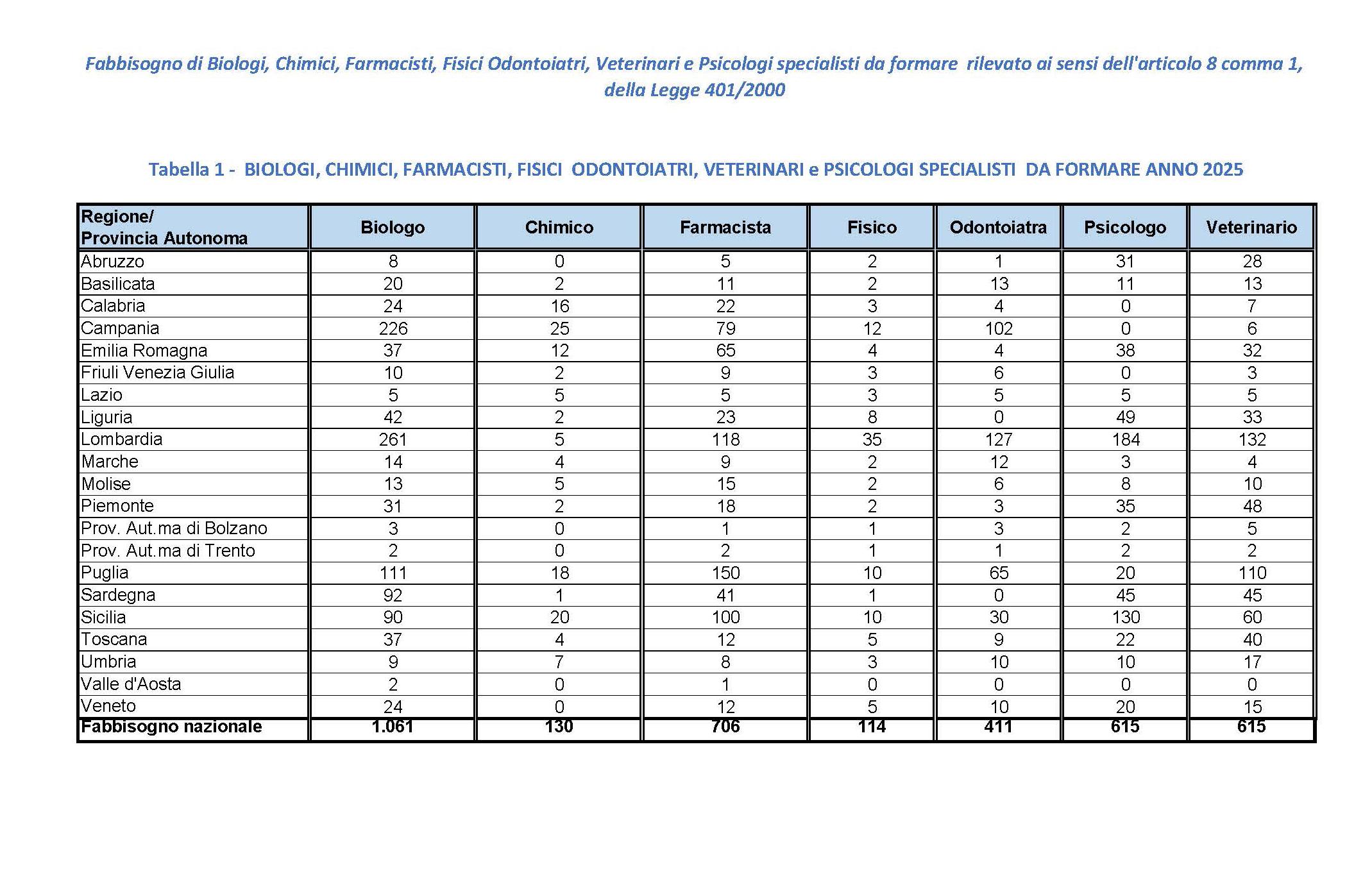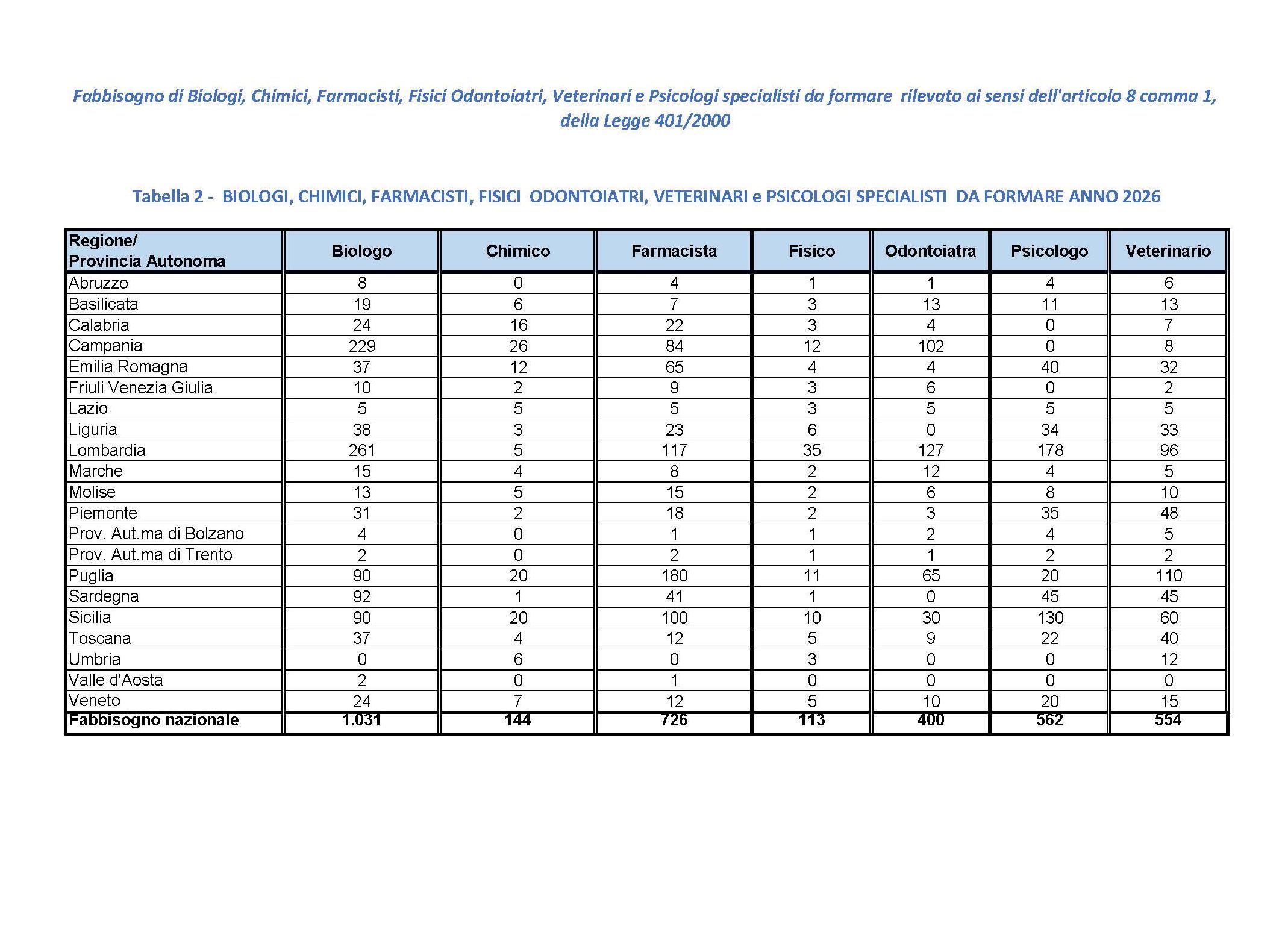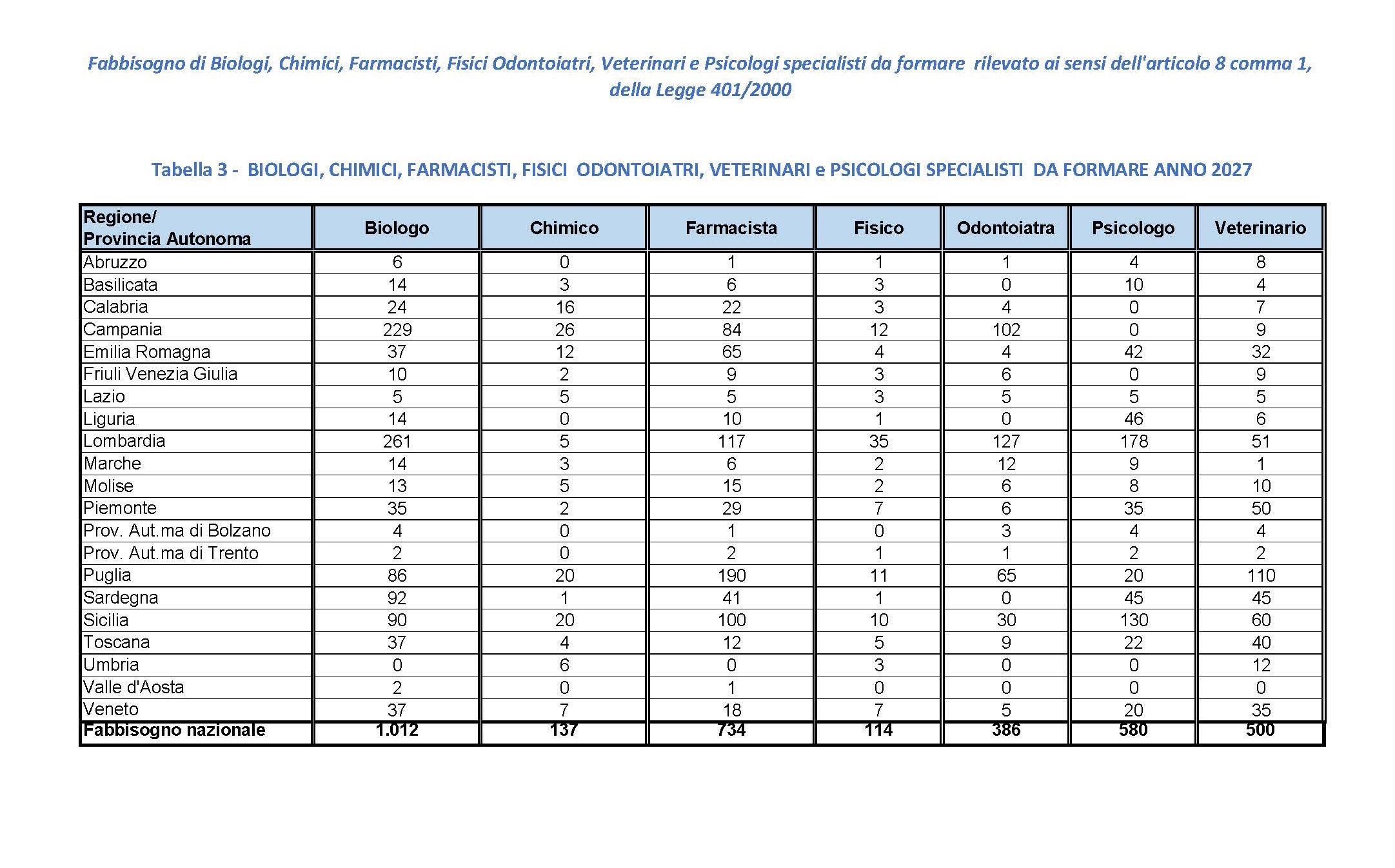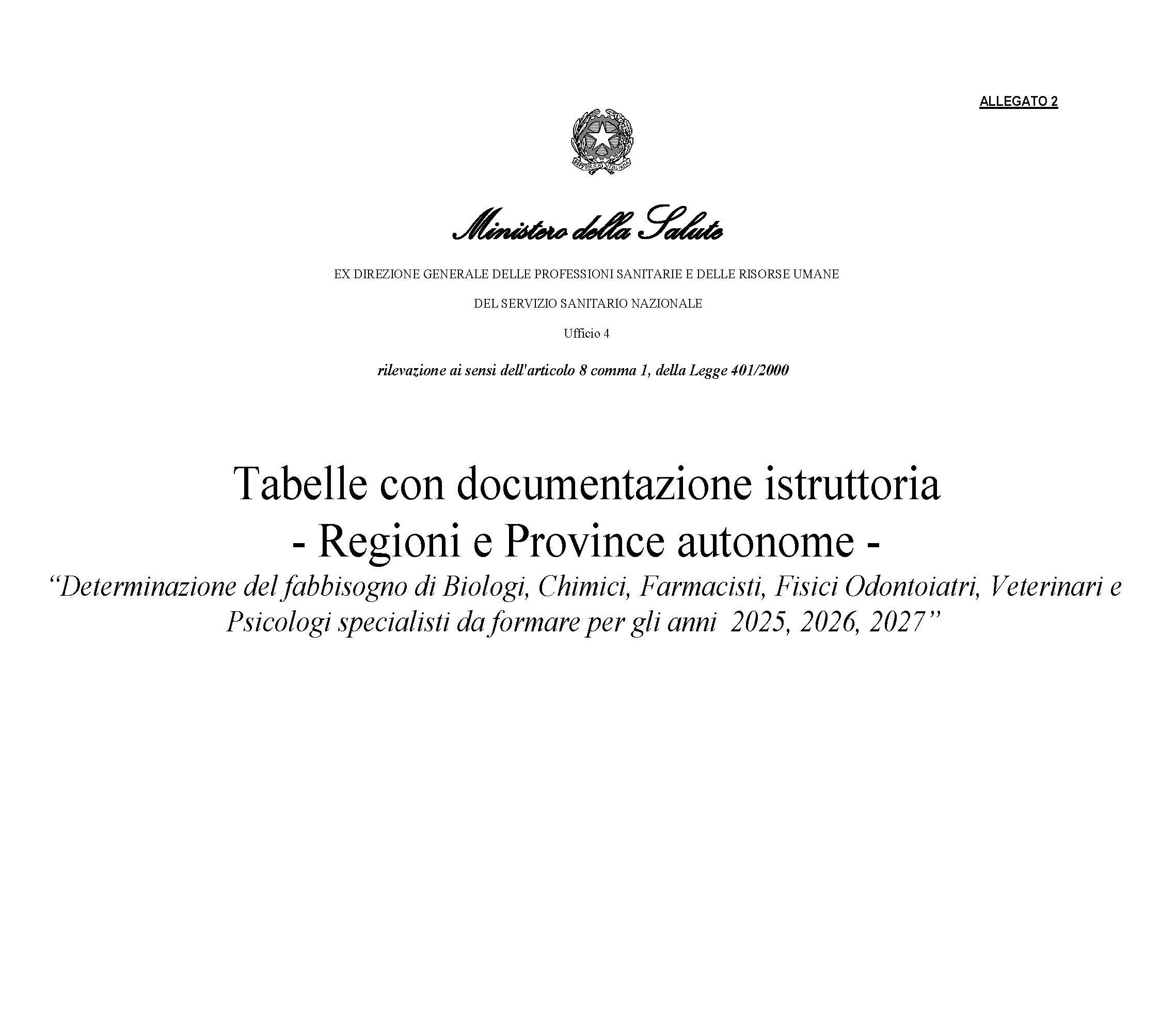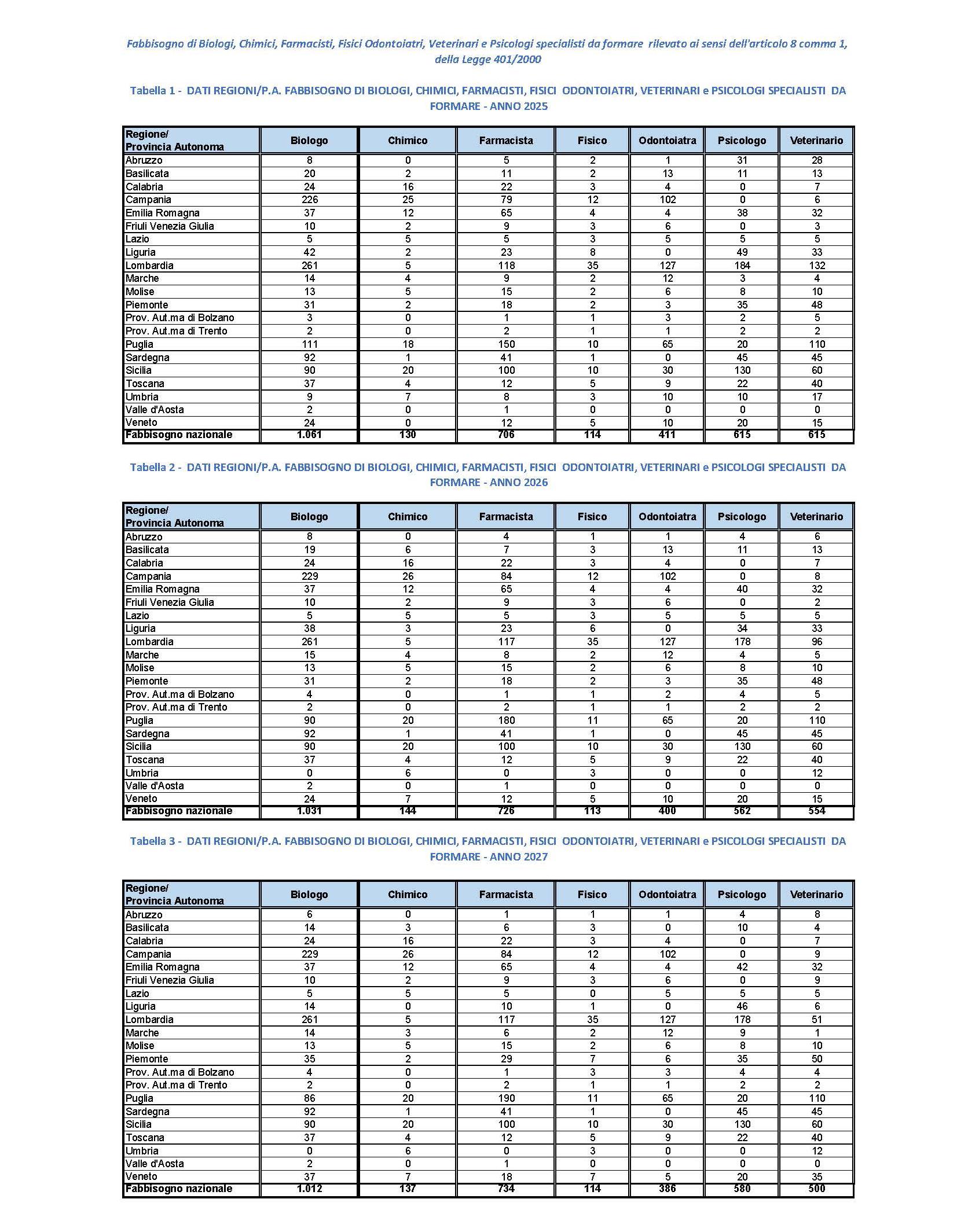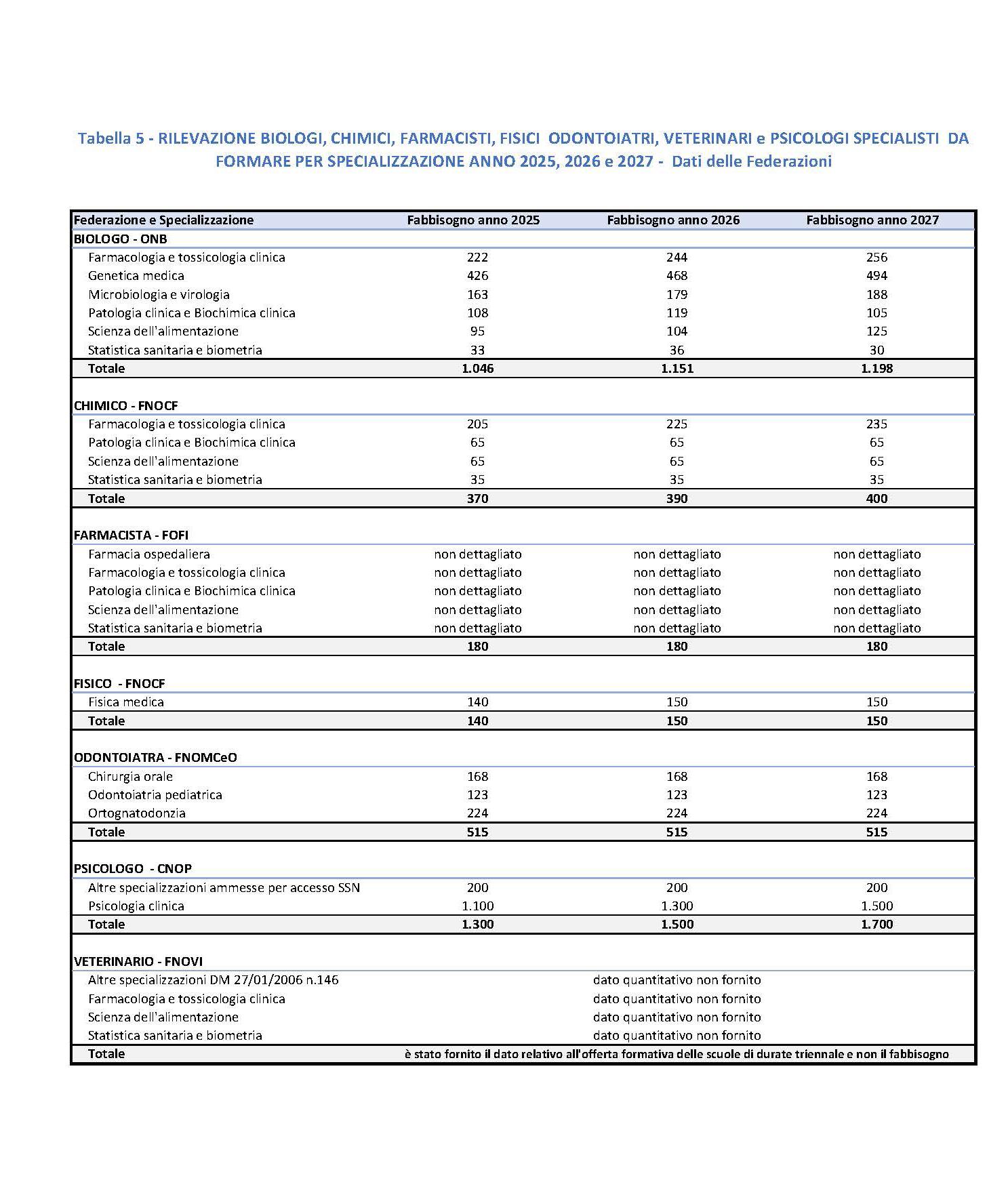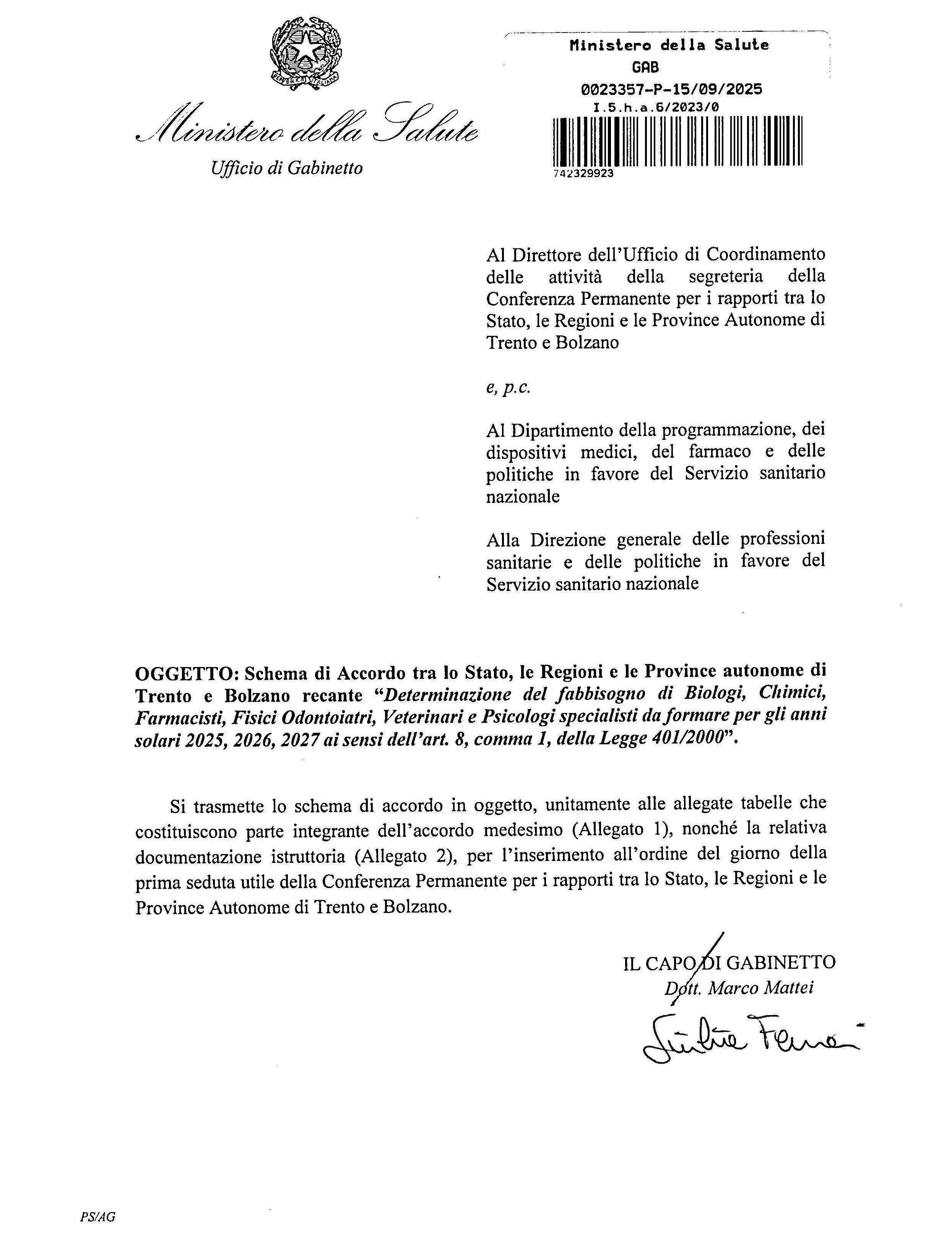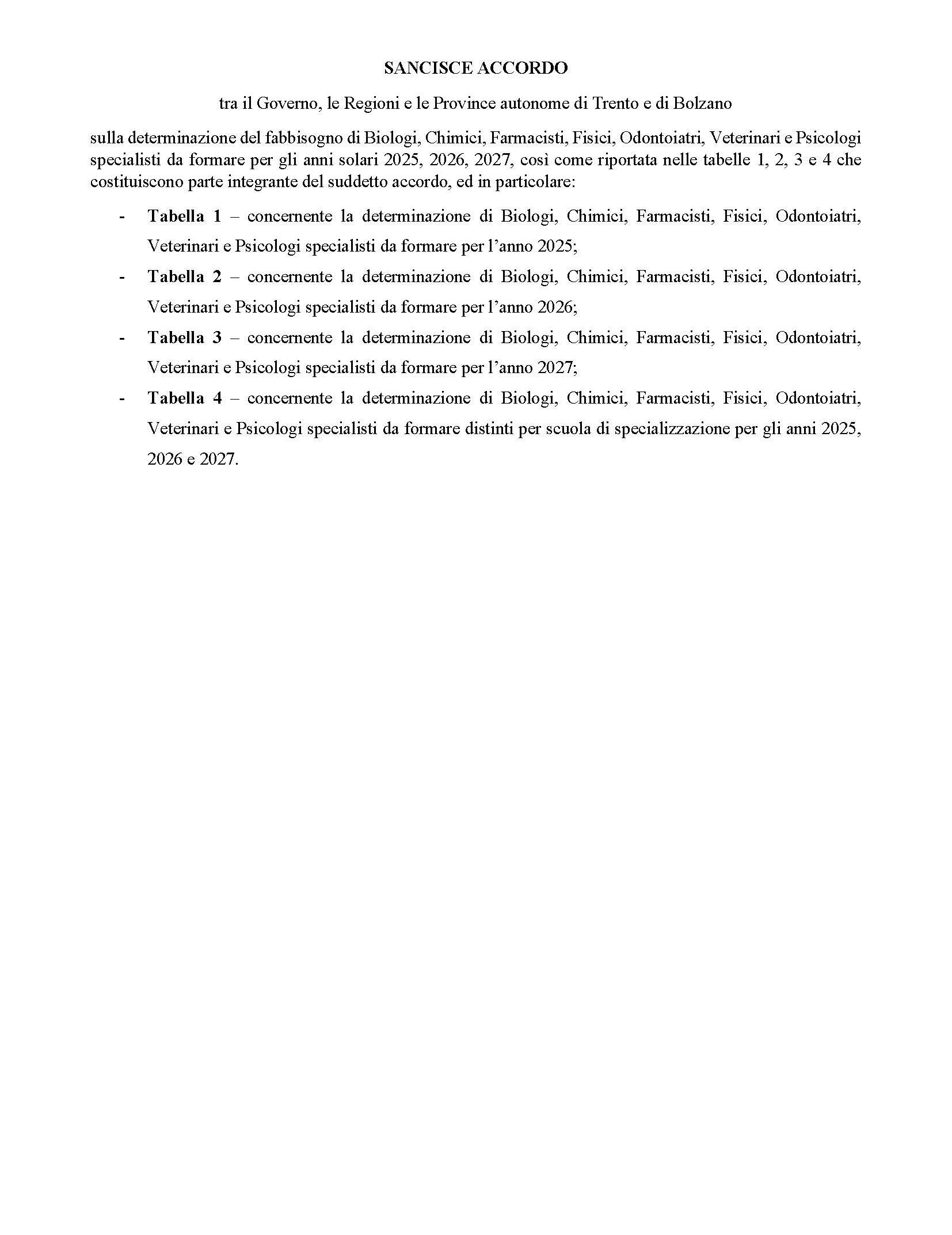Giornale dei Biologi

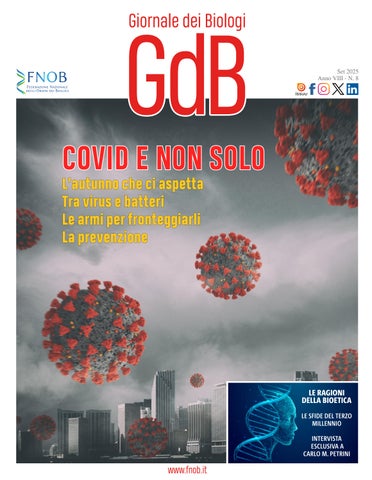

L’autunno che ci aspetta
Tra virus e batteri
Le armi per fronteggiarli
La prevenzione



22 Ottobre 2025 ore 08.00
Ecm in accreditamento
Covid, West Nile, influenza: sarà un autunno caldo tra virus e batteri di Rino Dazzo
Virus: nemici invisibili, alleati nascosti. Come la pandemia ha cambiato il nostro sguardo di Federica Passeggio
West Nile, il Lazio la regione più colpita di Rino Dazzo
ISS, salgono a 680 i casi di West Nile in Italia. Da inizio anno 48 decessi di Matilde Andolfo
L’influenza colpirà 16 milioni di persone di Matilde Andolfo
Botulismo, una grave
di Rino Dazzo
INTERVISTE
Malattie rare, analisi in 3D dei lisosomi per sviluppare terapie mirate di Ester Trevisan
Bioetica: le sfide del terzo millennio di Matilde Andolfo
SALUTE
Alleanza batteri-virus: un approccio innovativo per colpire i tumori di Sara Bovio
Individuata una nuova terapia per fermare la leucemia infantile di Sara Bovio
Individuato un promettente bersaglio contro le recidive del cancro ovarico di Sara Bovio
Resolve: ricostruire le origini delle mutazioni tumorali per cure su misura di Carmen Paradiso
Un cricchetto d’informazione per ridurre gli errori di riconoscimento del DNA di Carmen Paradiso
Fibrosi cistica: età biologica accelerata, reversibile con modulatori CFTR di Domenico Esposito
Pertosse, boom di casi tra i giovanissimi: il dato sui ricoveri allarma di Domenico Esposito
Mappati per la prima volta i movimenti dei lipidi nelle cellule di Sara Bovio
Il gene MUC19 ha aiutato l’uomo primitivo di Michelangelo Ottaviano
Epigenetica e nutrizione: come aiutare i nostri geni a farci vivere meglio di Giuseppe Passarino
Sovrappeso e obesità invecchiano il cervello di Elisabetta Gramolini
Ruolo della nutrizione di qualità come strumento di prevenzione e terapia nei tumori di testa e collo di Matteo Pillitteri
Microbiota-cervello, flagellina attiva il vago e spegne l’appetito di Carmen Paradiso
Caffè e antibiotici, mix da evitare: cosa succede se interagiscono di Domenico Esposito
Avena Sativa L. fermentata: azione antinfiammatoria e lenitiva per la pelle di Carla Cimmino
Riscarti, l’arte del riciclo incontra la scienza dei biologi e la cura per l’ambiente di Matilde Andolfo
Premiati i biologi con 50 anni di carriera di Matilde Andolfo
Scuole di specializzazione per i biologi di Matilde Andolfo
Scuole di specializzazione per i biologi: trattamento economico, determinazione dei fabbisogni, accesso a nuovi ordinamenti di Alberto Spanò
Raggi X e 3D, così i cristalli vulcanici svelano l’eruzione esplosiva di Gianpaolo Palazzo
Ricerca e tecnologia contro i parassiti per la frutticoltura del Lazio di Gianpaolo Palazzo
Pochi comuni virtuosi, l’Italia non tutela i suoi amici a quattro zampe di Gianpaolo Palazzo
La gestione dei rifiuti speciali è da record: il 73% torna utile di Gianpaolo Palazzo
Oceani, una risorsa da tutelare di Domenico Esposito
Svelato il mistero delle piante invasive di Domenico Esposito
Scoperto un coccodrillo del cretaceo a Trieste di Michelangelo Ottaviano
Uccelli migratori: prospettive in bilico di Michelangelo Ottaviano
Epilessia pediatrica: serve il cannabidiolo di Pasquale Santilio
Una proteina per la cura di malattie rare di Pasquale Santilio
Il glutine non scatena il diabete tipo 1 di Pasquale Santilio
Comunicazione wireless con la luce visibile di Pasquale Santilio
Pompei dopo l’eruzione: come la città sepolta dal Vesuvio tornò alla vita di Rino Dazzo
Volley, azzurre da leggenda: dopo le Olimpiadi i mondiali di Antonino Palumbo
Da Mattia a Nadia, atletica italiana da record ai mondiali di Antonino Palumbo
Tennis: sesto trionfo nella Billie Jean King Cup di Antonino Palumbo
Basket: tris d’oro per gli u20, ragazze sul podio di Antonino Palumbo
Rubrica letteraria
SCIENZE
Depressione post-partum: vulnerabilità materna e impatto sul neonato di Daniela Bencardino
Sindrome dell’ovaio policistico di Daniela Bencardino
Si informano gli iscritti che gli uffici della Federazione forniranno informazioni telefoniche di carattere generale dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Tutte le comunicazioni dovranno pervenire tramite posta (presso Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, via Icilio 7, 00153 Roma) o all’indirizzo protocollo@cert.fnob.it, indicando nell’oggetto l’ufficio a cui la comunicazione è destinata.
È possibile recarsi presso le sedi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi previo appuntamento e soltanto qualora non sia possibile ricevere assistenza telematica. L’appuntamento va concordato con l’ufficio interessato tramite mail o telefono.
UFFICIO CONTATTO
Centralino 06 57090 200
Ufficio protocollo protocollo@cert.fnob.it

Anno VIII - N. 8 Settembre 2025
Edizione mensile di Bio’s
Testata registrata al n. 113/2021 del Tribunale di Roma
Diffusione: www.fnob.it
Direttore responsabile: Vincenzo D’Anna
Giornale dei Biologi

L’autunno che ci aspetta
Tra virus e batteri
Le armi per fronteggiarli
La prevenzione
Questo magazine digitale è scaricabile on-line dal sito internet www.fnob.it
Questo numero del “Giornale dei Biologi” è stato chiuso in redazione il 29 settembre 2025.
Contatti: protocollo@cert.fnob.it
Gli articoli e le note firmate esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.
Immagine di copertina: @ alphaspirit.it/shutterstock.com


di Vincenzo D’Anna Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
Quelli che siedono ai vertici di un Ente composto da decine di migliaia di iscritti, come la FNOB, costituenti una categoria poliedrica, che esercita la professione in oltre ottanta diversi campi di applicazione, deve poter guidare coloro i quali è chiamato a rappresentare, essere cioè colui che “tiene la lanterna”, che illumina la strada. Per quanto mi riguarda e per quanto arduo sia il compito di battistrada di biologi italiani, mi sono sempre orientato in tal senso. La pubblicazione dei nuovi fabbisogni nelle Scuole di Specializzazione alle quali hanno accesso i biologi, l’aumento dei posti, a cui si potranno aggiungerne altri nella prospettiva di poter occupare quelli assegnati ai laureati in medicina se resi vacanti dai medesimi, rappresenta un altro evento epocale per la nostra categoria, traducendosi nella disponibilità di un numero di posti quasi sovrapponibile a quello dei nuovi iscritti per ogni annualità. L’imminente emanazione dei tre Decreti Ministeriali, attuativi della legge 163/2021 sulle lauree abilitanti,
La pubblicazione dei nuovi fabbisogni nelle Scuole di Specializzazione alle quali hanno accesso i biologi rappresenta un altro evento epocale
riformerà radicalmente la legge istitutiva dell’Ordine risalente al 1967, andando ad integrare le competenze professionali in ambiti che a quel tempo non erano prevedibili. Tutto questo andrà ad incidere positivamente sullo stato di precarietà e di incertezza dei diritti e delle opportunità per migliaia di colleghi, costretti finora ad operare senza
una certezza legislativa, per carenza di previsione legislativa. I decreti attuativi, inoltre, integreranno le pregresse specifiche carenze della professione, disciplineranno anche le modalità di accesso all’Albo ed i tirocini formativi. Anche in questo caso si tratta di un importante traguardo. Ma bisogna andare oltre, guardare avanti ed anche in alto, verso le nuove frontiere
L’imminente emanazione dei tre DM sulle lauree abilitanti, riformerà radicalmente la legge istitutiva dell’Ordine risalente al 1967
dello spazio. La riflessione è venuta di recente grazie all’assegnazione di una borsa di studio erogata dalla FNOB, per un biologo coinvolto negli esperimenti in condizioni di microgravità, condotti nei laboratori di una innovativa start-up napoletana, la “Space Factory”, riconosciuta dai principali stakeholder di settore (nazionali ed internazionali), fiore all’occhiello del settore aerospaziale.
Tale azienda conduce infatti esperimenti in condizioni di microgravità, sviluppa e produce tecnologie avanzate come mini-satelliti e sistemi per il rientro controllato di payload spaziali. Come dicevo, due nostri “camici bianchi” saranno attivamente coinvolti nei test microbiologici condotti dalla task-force multidisciplinare di
questa start-up. In particolare, i biologi saranno impegnati nella realizzazione di esperimenti in condizioni di microgravità, in ambito biotecnologico e farmaceutico, con l’utilizzo di un sistema di automazione elettronica per monitorare la produzione e la resa del biomateriale in tempo reale. E potranno farlo muovendosi in un ambiente all’avanguardia, attrezzato di tutto punto. Nella sede del Gruppo di via Gianturco sono presenti infatti due Clean Rooms per l’integrazione dei microsatelliti IRENESAT-ORBITAL e dei MiniLabs. Locali in cui si respira letteralmente aria di “spazio” e che, lo scorso 13 settembre mi hanno ospitato, come presidente della FNOB, in un vero e proprio “tour” alla scoperta
Due nostri “camici bianchi” saranno attivamente coinvolti nei test microbiologici condotti dalla taskforce multidisciplinare di Space Factory
delle meraviglie del polo aerospaziale, accompagnato dall’ingegnere Norberto Salza, lì dove ogni tutto trasuda eccellenza. Ho potuto così ammirare i laboratori miniaturizzati di Space Factory, “banco di prova” per test biologici in condizioni di microgravità: uno dei campi d’azione privilegiati per la ricerca e lo studio dei sistemi biologici e fisici con notevoli applicazioni nello sviluppo farmaceutico, nella biotecnologia, nell’agricoltura e nella scienza dei materiali. L’ambiente perfetto per poter portare avanti, con successo, gli esperimenti di “scienza della vita” condotti dal team diretto dal professor Giuseppe Falco dell’Università “Federico II” di Napoli, già operativo nel campo della cosiddetta “Medi -
cina di Precisione e Personalizzata”. In particolare con i test di efficacia di nuovi farmaci e molecole eseguiti su appositi “organoidi” ricavati da piccoli frustoli di tessuto organico e poi riprodotti, in piccolissime dimensioni, in laboratorio. Non è lontano il tempo in cui ciascuno potrà avere il proprio farmaco in grado di agire sull’organo colpito da patologie, con i laboratori di analisi cliniche pronti ad operare su organoidi miniaturizzati per rilevare i parametri biochimici che oggi si rilevano dal sangue. Il campo delle terapie immunologiche e dei test clinici preliminari saranno eseguiti in quel modo. Fantascienza? Niente affatto! Solo nuove frontiere della Biologia e per i Biologi del Terzo Millennio
sempre più schierati in prima fila. Protagonisti assoluti della ricerca in settori innovativi. Per farla breve ci siamo ormai avviati verso strade inimmaginate finora e che, per nostra fortuna, hanno al centro dell’interesse le Scienze Biologiche. Ed ecco che, prendendo la palla al balzo, ho chiesto al docente che se occupa, l’istituzione di un corso
I biologi del Terzo Millennio schierati in prima fila nella medicina di precisione. Protagonisti assoluti della ricerca del futuro
FAD facendogli anche elaborare un’organica proposta per l’istituzione di un nuovo corso di Laurea in Biologia e Bio Medicina Spaziale ed innovativa. Tale proposta è stata immediatamente trasferita ai competenti uffici del MUR dove ha riscosso grande interesse. Insomma: si viaggia tra le stelle, secondo il brocardo latino “Per aspera ad astra”.

Le prospettive dopo un’estate segnata dal moltiplicarsi di infezioni vecchie e nuove Mancano dati immediati (tamponi non più obbligatori), scarso il feeling coi vaccini

I bollettini dell’Ecdc e quelli dell’ISS evidenziano una circolazione più elevata del Covid. I casi sono in aumento, nonostante la difficoltà a mettere insieme dati esaustivi perché i tamponi non sono più obbligatori. Sbaglia però chi pensa si tratti di un ritorno: in realtà il virus Sars-CoV-2 non è mai andato via, è semplicemente diventato meno letale perché il sistema immunitario è un po’ più preparato rispetto agli anni scorsi, maggiormente in grado di contrastarne gli effetti più gravi
© OSORIOartist/shutterstock.com
Ilivelli di allerta, per fortuna, sono ben lontani da quelli di qualche anno fa.
Ma è stata in ogni caso un’estate all’insegna di virus e batteri. Le impennate di casi Covid, le segnalazioni relative a ricoveri e decessi legati al West Nile, i drammatici aggiornamenti sulle intossicazioni - anche mortali - da botulino e quelle legate ad altre malattie dai nomi esotici o tropicali, ma molto pericolose (Chikungunya, Usutu, giusto per fare qualche esempio), hanno caratterizzato i mesi più caldi della stagione in Italia, trovando vasta eco a livello mediatico.
Sarà così anche in autunno? Cosa dobbiamo aspettarci a proposito del coronavirus e delle infezioni, vecchie e nuove, che hanno accompagnato gran parte delle cronache vacanziere? Ci aspetta davvero un periodo ancor più caldo rispetto all’estate, visto che ai virus e ai batteri che sono stati scomodi compagni di viaggio nelle precedenti settimane è destinato ad aggiungersi un altro nemico abituale, tristemente puntuale nella sua ricomparsa? Siamo parlando, naturalmente, del virus influenzale.
I bollettini dell’Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, e quelli dell’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità, evidenziano una circolazione più elevata del
Covid. I casi sono in aumento, nonostante la difficoltà a mettere insieme dati esaustivi perché i tamponi non sono più obbligatori. Sbaglia però chi pensa si tratti di un ritorno: in realtà il virus Sars-CoV-2 non è mai andato via, è semplicemente diventato meno letale perché il sistema immunitario è un po’ più preparato rispetto agli anni scorsi, maggiormente in grado di contrastarne gli effetti più gravi.
Come si è rafforzato l’organismo? Attraverso i vaccini o le infezioni precedenti. Come spiega Giovanni Rezza, professore di Igiene e Sanità Pubblica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, «il Covid di oggi non è come quello dell’inizio della pandemia. Colpisce meno duramente, ma rimane un virus giovane e capriccioso. Non ha ancora una stagionalità assestata. Dà luogo a picchi in periodi imprevedibili».
Rispetto allo stesso periodo del 2024 i decessi sono diminuiti, ma il virus continua a girare, anche più rispetto al passato, nonostante la difficoltà crescente nel tracciamento. I numeri dei ricoverati nei reparti ordinari e in terapia intensiva sono molto bassi. Per gli over 80 e gli over 90 i rischi, in caso di positività, sono in ogni caso alti: il tasso di ospedalizzazione arriva a 22 per milione nella fascia 80-89
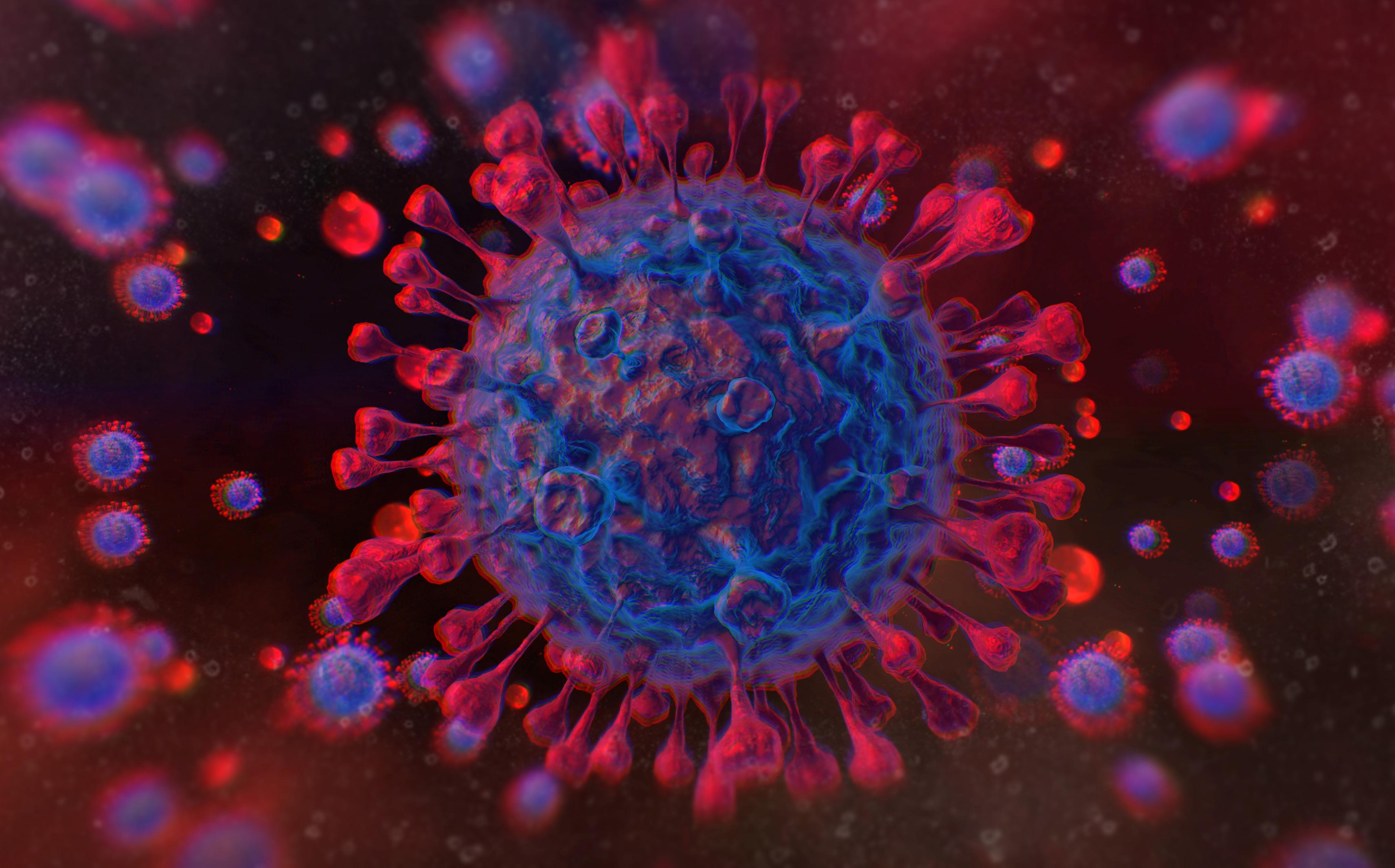
anni, a 26 per milione nella fascia 90-99 anni, con una mortalità dell’uno per milione.
Dati ben diversi e molto meno allarmanti rispetto alle fasi più tragiche della pandemia, che invitano comunque a non abbassare la guardia. Ma che tipo di versione del virus è in auge in questo momento in Italia e in altri paesi come Grecia, Irlanda, Francia e Romania dove il Covid è segnalato in espansione?
La variante dominante attualmente è chiamata Stratus, o XFG, ed è una sottovariante della famiglia JN.1 riscontrata per la prima volta negli Stati Uniti.
«Nei positivi al Covid stanno tornando i vecchi sintomi che abbiamo conosciuto nella prima fase della pandemia», la spiegazione all’Adnkronos di Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa. «Molti lamentano la mancanza improvvisa dell’olfatto e del gusto (e tra i casi più noti c’è la testimonianza, condivisa largamente attraverso i social, del cantante Stash, ndr), questo perché molto probabilmente l’ingresso del virus predilige queste sedi che vengono - momentaneamente - compromesse e non trasmettono lo stimolo percepito al cervello». Ma non solo. Tra i sintomi più ricorrenti e persistenti figurano «febbre, anche alta, e le difficoltà respirato-
rie che conosciamo». Dunque, fatte salve le dovute eccezioni, si tratta di una versione del virus più fastidiosa che letale, almeno per la stragrande maggioranza della popolazione, anche se in grado ancora in qualche caso di tenere bloccati a letto i malati per diversi giorni. Cosa succederà nel prossimo futuro? Al Covid in leggero aumento, alle infezioni da West Nile e botulismo o legate ad altri virus e batteri si aggiungeranno i picchi dell’influenza? «Se osserviamo i dati delle vaccinazioni non vediamo segnali positivi», la constatazione di Pistello. «È chiaro che c’è una fascia di popolazione vulnerabile, over 60-70, che ha perso nel tempo lo scudo immunologico, sia per una vaccinazione lontana nel tempo sia perché il Covid ha avuto una flessione e ci sono stati meno contagi. Alle autorità sanitarie nazionali suggerirei di lavorare sulla campagna vaccinale autunnale e spingere sia per l’antinfluenzale sia per l’anti-Covid. Alla popolazione invece direi di scegliere per la doppia vaccinazione, abbiamo visto che è sicura ed efficace». Inviti, purtroppo, che non sembrano far breccia: gli ultimi dati del ministero della Salute sulle coperture anti-influenzali della scorsa stagione indicano che meno di un italiano su cinque si è sottoposto a vaccinazione.
© eyeidea/shutterstock.com

«Nei positivi al Covid stanno tornando i vecchi sintomi che abbiamo conosciuto nella prima fase della pandemia», la spiegazione all’Adnkronos di Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa. «Molti lamentano la mancanza improvvisa dell’olfatto e del gusto, questo perché molto probabilmente l’ingresso del virus predilige queste sedi che vengonomomentaneamente - compromesse e non trasmettono lo stimolo percepito al cervello» © Pixel-Shot/shutterstock.com
© Lightspring/shutterstock.com

di Federica Passeggio*
Viviamo circondati da presenze invisibili. Non le vediamo, non le sentiamo, eppure sono ovunque: nei mari, nell’aria, nel nostro stesso corpo. I virus sono i parassiti più diffusi sulla Terra; non esiste organismo vivente che non ne ospiti almeno uno, dai batteri all’uomo. Un virus è poco più di un “pacchetto” di geni racchiuso in una corazza di proteine. Fuori dalla cellula è inerte, ma una volta entrato ne prende il controllo, trasformandola in una fabbrica di nuove particelle. Spesso la cellula muore e nascono così molte malattie.
Eppure i virus non sono soltanto minaccia. Nel nostro corpo convivono stabilmente trilioni di virus, senza causare danno. La maggior parte vive nei batteri intestinali, altri colonizzano pelle, vie respiratorie e urinarie. Questi ospiti invisibili contribuiscono allo sviluppo del sistema immunitario e mantengono l’equilibrio della flora microbica. La loro presenza non è marginale; in una sola goccia di acqua di mare se ne trovano più di un milione, ma ne conosciamo appena lo 0,1%.
Nonostante la loro fragilità - al di fuori delle cellule sopravvivono solo per poche ore o giorni - i virus hanno plasmato l’evoluzione. Mescolando i propri geni con quelli degli ospiti, hanno lasciato impronte profonde nel nostro DNA. Un terzo del genoma umano è di origine virale al punto che conserviamo frammenti di antichi “invasori” incorporati nei nostri cromosomi. Uno di questi ha persino reso possibile lo sviluppo della placenta grazie a una proteina, la sincitina, che 50 milioni di anni fa apparteneva a un virus.
La capacità di replicarsi in quantità impressionanti e di mutare rapidamente li rende maestri dell’adattamento. Una cellula infettata da HIV, ad esempio, può produrre migliaia di nuove particelle, e un individuo malato ne genera ogni giorno decine di miliardi. Questa fabbrica di mutazioni spiega perché i virus sappiano adattarsi con velocità sorprendente, passare da una specie all’altra e dare origine a nuove infezioni emergenti, come Ebola, HIV, SARS, fino alla recente pandemia di COVID-19.
Proprio il coronavirus ha segnato un punto di svolta nella percezione dei virus. Ha mo-
*Biologa
strato quanto possano sconvolgere la salute, l’economia e la vita quotidiana. Ha anche accelerato la scienza, portando a nuove tecnologie diagnostiche e vaccinali in tempi record. Per la prima volta milioni di persone hanno seguito aggiornamenti su studi clinici, vaccini e varianti. La corsa ai vaccini ha dimostrato il valore della cooperazione globale. Reti internazionali hanno sviluppato strumenti in pochi mesi che in altre epoche avrebbero richiesto decenni.
Se il passato ci spaventava con l’imprevedibilità dei virus emergenti, oggi abbiamo strumenti per reagire più in fretta. Tra le eredità più concrete lasciate dalla pandemia ci sono i POCT (point-of-care testing), dispositivi di analisi rapida che diagnosticano infezioni in pochi minuti senza bisogno di laboratori complessi. Sono sensibili, economici e integrabili con sistemi digitali. Portano la diagnosi precoce in pronto soccorso, ambulanze o in paesi con risorse limitate. Distinguere subito un’infezione virale da una batterica riduce l’uso inappropriato di antibiotici e permette terapie tempestive. È importante sottolineare che l’interpretazione dei risultati deve essere sempre affidata a personale qualificato. Questi strumenti rappresentano preziosi alleati per biologi e medici, che possono contare su diagnosi rapide e intervenire in modo tempestivo, limitando il peggioramento dei sintomi e migliorando la prognosi.
La pandemia ci ha consegnato una nuova visione della salute. Non è solo assenza di malattia, ma un equilibrio complesso che coinvolge società, economia, ambiente e stile di vita.
Paradossalmente, proprio un virus ci ha spinto a interrogarci sul perché della loro esistenza e sul loro ruolo nel grande disegno della vita. La risposta, per quanto ancora parziale, è sorprendente: senza i virus la Terra sarebbe un pianeta diverso, forse inabitabile. Regolano ecosistemi, sostengono cicli biologici fondamentali e hanno plasmato l’evoluzione delle specie, inclusa la nostra.
Da nemici invisibili, i virus stanno diventando anche protagonisti di una nuova consapevolezza. Conoscerli meglio non significa solo difenderci, ma anche riconoscere il posto che occupano nel grande disegno dell’evoluzione. Nel bene e nel male, continueranno a scrivere la storia della vita. Sta a noi imparare a leggerla.

Il coronavirus ha segnato un punto di svolta nella percezione dei virus. Ha mostrato quanto possano sconvolgere la salute, l’economia e la vita quotidiana. Ha anche accelerato la scienza, portando a nuove tecnologie diagnostiche e vaccinali in tempi record. Per la prima volta milioni di persone hanno seguito aggiornamenti su studi clinici, vaccini e varianti. La corsa ai vaccini ha dimostrato il valore della cooperazione globale. Reti internazionali hanno sviluppato strumenti in pochi mesi che in altre epoche avrebbero richiesto decenni

In costante aumento negli anni in Italia i casi della malattia trasmessa da punture delle comuni zanzare notturne
Tra le infezioni più documentate nei mesi estivi rientrano sicuramente quelle da West Nile Virus. A inizio settembre 2025 in Italia si sono registrati 502 casi con 33 morti. Il Lazio la regione più colpita con 218 casi totali, 187 dei quali concentrati nella provincia di Latina. Poco più di 100 i casi registrati in Campania, 56 quelli riscontrati nel Veneto. Come riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, poco meno della metà dei casi confermati si è presentata nella forma neuro-invasiva, con un numero analogo di infetti che ha manifestato una
semplice febbre. Una quarantina, invece, gli asintomatici. Siamo di fronte a una nuova epidemia da fronteggiare? Non proprio. Se è vero che i numeri di casi e decessi sono in leggero aumento rispetto al 2024, siamo ben lontani dai picchi del 2022 quando nel solo Veneto si sono registrati ben 531 casi, con 22 decessi. E lo stesso West Nile non rappresenta una novità per il territorio italiano: i primi casi in assoluto, infatti, sono stati riscontrati nel 2008.
Ma in cosa consiste la Febbre del Nilo Occidentale, nome italiano del virus West Nile? Né più né meno,
di una malattia infettiva virale trasmessa dalla puntura delle comuni zanzare notturne, appartenenti alla specie Culex Pipiens. La trasmissione da persona a persona non avviene se non in due casi specifici: attraverso trasfusione di sangue o trapianto di organo da una persona infetta a una sana, oppure da una madre incinta al nascituro durante la gravidanza. Il periodo di incubazione del virus può variare dai tre ai 14 giorni, una percentuale rilevante risulta asintomatica mentre il 20% circa incappa in lievi disturbi simili a quelli dell’influenza come febbre, mal di testa, dolori muscolari, nausea e vomito. Solo l’1% sviluppa forme neuro-invasive gravi, le più pericolose: meningite, encefalite e mielite flaccida acuta, che hanno un tasso di letalità del 20%. Tra i più vulnerabili, naturalmente, ci sono anziani e affetti da patologie croniche o pregresse.
A oggi non esiste una terapia specifica per il West Nile: in genere i sintomi regrediscono spontaneamente dopo alcuni giorni e i pazienti infetti sviluppano poi un’immunità che li preserva da successive infezioni della stessa malattia. Non esistono neppure vaccini o antidoti per tenersi al riparo dal virus. E allora, come difendersi? Con gli stessi accorgimenti da adoperare per prevenire le punture delle zanzare, utilizzando ad esempio zanzariere alle finestre o nelle aperture dei balconi, spray repellenti, cambiando spesso l’acqua nelle ciotole degli animali domestici o svuotando l’acqua che ristagna nei sottovasi delle piante, indossando pantaloni, magliette e camicie lunghe nelle zone a maggior rischio, tenendo le piscine gonfiabili o altre vasche in posizione verticale se non usate. Di solito le infezioni da West Nile in Italia regrediscono con l’avvento della stagione autunnale: il cambiamento climatico però, oltre a modificare l’ecosistema delle zanzare, sta anche allungando i periodi di proliferazione del virus. (R. D.).
Il bilancio parla di 680 casi in Italia, dall’inizio dell’anno, i casi confermati di infezione da West Nile Virus nell’uomo. E sono i 48 decessi. I dati sono stati riportati nell’undicesimo bollettino della sorveglianza pubblicato il 26 settembre dall’Istituto superiore di sanità (Iss).
Tra i casi certificati 321 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (15 Piemonte, 44 Lombardia, 27 Veneto, 2 Friuli-Venezia Giulia, 1 Liguria, 25 Emilia-Romagna, 8 Toscana, 1 Marche, 83 Lazio, 2 Molise, 79 Campania, 2 Puglia, 2 Basilicata, 5 Calabria, 1 Sicilia, 24 Sardegna).
Sono invece 54 i casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 296 casi di febbre (di cui 1 importato dal Kenya, 1 dall’Egitto e 1 dalle Maldive, 3 casi asintomatici e 6 casi sintomatici).
Tra i casi confermati sono stati notificati 48 decessi: 7 Piemonte, 5 Lombardia, 2 Emilia-Romagna, 17 Lazio, 14 Campania, 2 Calabria, 1 Sardegna.
La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive confermate e finora segnalate è pari al 14,9% mentre nel 2018 il 20%, nel 2024 il 14%.
Nello stesso periodo sono stati segnalati 9 casi di Usutu virus: 2 Piemonte, 2 Lombardia, 2 Veneto, 3 Lazio.
Salgono a 74 (contro 72) le Province con dimostrata circolazione del West Nile virus appartenenti a 17 Regioni (contro 17): Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Dal 1 gennaio al 23 settembre 2025 al sistema di sorveglianza nazionale risultano, inoltre, 309 casi confermati di Chikungunya, 166 casi confermati di Dengue, 4 casi di Zika virus, 39 casi di Tbe e 96 casi di Toscana virus. (M. A.).


Se l’estate ha già sperimentato l’ondata di virus come il covid, l’autunno si attende deflagrante. Gli esperti, infettivologi, immunologi, virologi, medici di famiglia, pediatri e geriatri rinnovano l’invito ad immunizzarsi soprattutto alle categorie a rischio in vista di un autunno-inverno che si preannuncia particolarmente tosto. Le previsioni parlano di 16 milioni, stando alle ultime stime degli infettivologi, i contagi attesi in Italia a causa dei virus respiratori, mentre le infezioni da virus SarsCoV2 sono in aumento già da alcune settimane. Un mix di vi-
rus che potrebbe rilevarsi la “tempesta perfetta” che potrebbe mettere a dura prova i servizi ospedalieri. Da ottobre inizia la campagna vaccinale contro l’influenza stagionale 2025-26, non c’è tempo da perdere. «Dopo due stagioni da record - spiega all’Ansa Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Università di Milano - anche quest’anno ci aspettiamo una circolazione sostenuta di virus influenzali e ‘cugini’ come Rhinovirus, SarsCoV2 e il virus respiratorio sinciziale, con un impatto che potrebbe coinvolgere il 15-25% della
popolazione, fino a interessare, potenzialmente, circa 16 milioni di italiani».
Già da metà ottobre potrebbe esserci un innalzamento dei casi fino al picco invernale. L’incremento dei casi rischia di far collassare un sistema, quello dei ricoveri ospedalieri, già fragile. Intanto negli studi dei medici di famiglia si attendono i vaccini per influenza e Covid che possono essere somministrati in contemporanea. Proprio i casi di Covid sono in aumento: secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute (settimana 11-17 settembre), i contagi sono arrivati a 3.692, in aumento rispetto ai 2.824 della settimana precedente, ed i deceduti sono stati 21 contro gli 11 della settimana prima.
Il ministero della Salute ha intanto emanato nei giorni scorsi una circolare in cui si comunica l’aggiornamento dei vaccini anti-Covid alla variante LP.8.1 del SarsCoV2 e si prevede un richiamo annuale per una serie di categorie, tra cui persone dai 60 anni in su e soggetti fragili. La vaccinazione resta il miglior strumento per salvaguardare la salute, ma lo scoglio da superare resta tuttavia la diffidenza. L’indagine di Human Highway per Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione), presentata a Milano, rivela che il 59% degli italiani riconosce la vaccinazione come strumento fondamentale di protezione, ma solo il 36,6% dichiara di volerla fare nella prossima stagione e la propensione è più alta tra gli over 65 (57%). Il dossier riferisce anche la consapevolezza degli italiani ad usare i farmaci: l’81,8% richiama la necessità di un uso responsabile dei farmaci di automedicazione, accompagnato da corrette informazioni. Ed aumenta, rispetto a cinque anni fa, la quota di chi sceglie di curarsi con farmaci da banco pari a quasi il 20% dei rispondenti, contro il 14,6% del 2020.
Il medico curante resta il punto di riferimento per il 64,6%, ed il farmacista lo è nel 23,5% dei casi. (M. A.).
Non solo i virus. Insieme alla recrudescenza dei casi Covid e alle infezioni da West Nile, hanno destato impressione e sgomento anche le tante intossicazioni provocate da un batterio, il botulino, registrate in particolare tra i mesi di luglio e agosto. Marcato l’aumento di ricoveri e decessi rispetto alla media annuale, con focolai concentrati soprattutto in Sardegna e in Calabria. Quatto le persone morte. L’Italia, purtroppo, storicamente si posiziona ai primi posti in Europa per l’incidenza di questa intossicazione, causata dalle tossine prodotte dal Clostridium botulinum, batterio molto pericoloso. È lui il microrganismo alla base delle intossicazioni, che possono avere conseguenze fatali visto che determinano paralisi respiratorie e asfissie. Sono le tossine rilasciate dal batterio a provocarle, anche se i primi sintomi dell’intossicazione possono essere scambiati per disturbi non particolarmente gravi, tipici di una gastroenterite. Il batterio, presente nel suolo o nella polvere sotto forma di spore, diventa nocivo quando ingerito.
La stragrande maggioranza dei casi più gravi, anche quelli dei mesi scorsi in Italia, sono riconducibili a botulismo di tipo alimentare: la contaminazione, cioè, si sviluppa a partire da alimenti conservati sott’olio, da carne e pesce in scatola o da salumi e altri essiccati non conservati in condizioni idonee. L’accumulo di tossine nell’organismo provoca l’intossicazione, che si manifesta in genere 18 o 36 ore dopo l’ingestione. I sintomi inizialmente sono quelli tipici di un disturbo di tipo alimentare: diarrea, vomito, nausea e dolori addominali. Poi sopraggiungono la difficoltà a deglutire e a parlare, i disturbi della vista, problemi respiratori, difficoltà a muovere i muscoli facciali, fino a una vera e propria paralisi. Le cure consistono in un trattamento medico specialistico e tempestivo, da esegui -

L’Italia si posiziona ai primi posti in Europa per incidenza
Diverse le infezioni mortali nel mese di agosto
re al pronto soccorso e che arresta l’avanzata dell’intossicazione. Per ristabilirsi completamente, però, possono essere necessarie settimane, se non addirittura mesi.
La forma più efficace di contrasto del botulismo è rappresentata dalla prevenzione, attraverso regole che possono sembrare scontate o banali, ma che è bene ricordare. Lavare accuratamente gli alimenti prima del consumo o della conservazione, ad esempio. Pulire con cura mani e utensili utilizzati per il trattamento del cibo. Evitare il consumo di cibi su cui non si hanno necessarie garanzie
o che si sospetta scaduti. E inoltre, nella preparazione di conserve fatte in casa, ricordarsi di cuocere le verdure in parti eguali di acqua e aceto, pastorizzando poi il barattolo immergendolo per circa 15-20 minuti in acqua bollente. Nel caso di marmellate o conserve di frutta vanno utilizzati frutta e zucchero in parti uguali o aggiungendo succo di limone in caso di minori parti di zucchero. Per olive e prodotti in salamoia vanno utilizzati 100 grammi di sale per ogni litro d’acqua, mentre massima attenzione va riposta anche nella marinatura di carne o pesce. (R. D.).
Intervista con Pietro Ferraro (Cnr-Isasi) e Diego Luis Medina (TIGEM) responsabili del team di ricerca che ha messo a punto la nuova tecnica di indagine
di Ester Trevisan

UI lisosomi - normalmente responsabili dei processi digestivi che avvengono all’interno delle cellule - sono coinvolti in oltre 60 tipi di malattie genetiche rare, dette anche malattie da accumulo lisosomiale (LSD). Si tratta di un insieme di patologie rare causate da difetti enzimatici o proteici nei lisosomi, con gravi conseguenze per organi e tessuti, in particolare il sistema nervoso centrale
© Designua/shutterstock.com
n team congiunto dell’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli (Cnr-Isasi) e del TIGEM (Istituto Telethon di Genetica e Medicina) di Pozzuoli ha sviluppato un nuovo approccio per osservare in 3D, in maniera quantitativa e senza marcatori fluorescenti, i lisosomi all’interno di cellule vive, in sospensione. Tali organi cellulari - normalmente responsabili dei processi digestivi che avvengono all’interno delle cellule - sono coinvolti in oltre 60 tipi di malattie genetiche rare, dette anche malattie da accumulo lisosomiale (LSD). Si tratta di un insieme di patologie rare causate da difetti enzimatici o proteici nei lisosomi, con gravi conseguenze per organi e tessuti, in particolare il sistema nervoso centrale: la diagnosi e il monitoraggio dell’efficacia terapeutica sono, ad oggi, ostacolati proprio dalla mancanza di strumenti che permettano un’analisi funzionale dei lisosomi in cellule vive.
Per mettere bene a fuoco la portata della sperimentazione e i suoi risvolti in termini terapeutici, il Giornale del Biologi ha intervistato i responsabili del team.
Qual è la novità principale della tecnica sviluppata dalla ricerca Cnr-Tigem e quali vantaggi apporta allo studio dei lisosomi?
Medina: La novità fondamentale della nostra tecnica, la tomografia olografica in configurazione citometrica a flusso (HTFC), è che per la prima volta ci permette di analizzare i lisosomi in modo quantitativo, tridimensionale e senza l’uso di marcatori fluorescenti.
Questo è un enorme passo avanti, perché possiamo misurare direttamente parametri biofisici come la densità e il volume dei lisosomi, che sono alterati in condizioni patologiche. In questo modo, non ci limitiamo a osservare, ma quantifichiamo le alterazioni fisiche dell’organulo.
Come è stata applicata questa nuova tecnica?
Ferraro: Abbiamo applicato questa tecnica a cellule vive in sospensione, un contesto molto più vicino a quello clinico rispetto alle cellule aderenti comunemente usate in laboratorio. La HTFC ci ha permesso di ottenere tomografie ad alto contenuto informativo basate sull’indice di rifrazione, analizzando migliaia di cellule in un tempo molto ridotto. Questo ha reso possibile identificare biomarcatori morfometrici 3D che distinguono in modo affidabile le cellule sane da quelle malate.
Diversamente dalle metodologie di analisi utilizzate comunemente, non avete impiegato coloranti o marcatori. Perché è importante poter osservare cellule “al naturale”?
Medina: Osservare le cellule “al naturale”, o “label-free”, è cruciale per diversi motivi. I marcatori fluorescenti possono alterare le cellule o modificarne la funzionalità, e la loro preparazione è spesso complessa e costosa. Il nostro metodo, non richiedendo coloranti, evita questi problemi. Ci fornisce informazioni intrinseche e più veritiere sulle cellule e sul loro stato fisiologico, rendendo l’analisi più affidabile e robusta.
Avete scelto di concentrarvi sulla malattia di Niemann-Pick tipo C1. Che tipo di malattia e perché è stata scelta come modello per questa ricerca?
Medina: La malattia di Niemann-Pick tipo C1 (NPC1) è una grave malattia genetica rara, a oggi incurabile, causata da un difetto enzimatico che provoca un anomalo accumulo di molecole, in particolare colesterolo, all’interno dei lisosomi. Abbiamo scelto di concentrarci su questa patologia perché la sua natura di “malattia da accumulo” la rende un modello ideale per dimostrare come il nostro approccio possa rilevare i cambiamenti fisici nei lisosomi, aprendo la strada a nuove strategie di monitoraggio e diagnostica.
Quali risultati concreti avete ottenuto osservando i lisosomi in 3D in questa patologia?
Ferraro: Abbiamo dimostrato che l’accumulo di colesterolo nelle cellule affette da NPC1 altera significativamente la posizione e la morfologia dei lisosomi. Grazie alla nostra tecnica, siamo stati in grado di misurare con precisione questi cambiamenti e di dimostrare che la correzione della localizzazione dei lisosomi, attraverso specifici interventi, risolve l’accumulo patologico.
Questo è un risultato molto importante che conferma l’utilità del nostro approccio per valutare l’efficacia dei farmaci a livello cellulare.
Quali sono i prossimi passi per portare questa tecnologia dal laboratorio alla pratica clinica?
Ferraro: I prossimi passi sono chiari: dobbiamo validare ulteriormente la tecnologia su cellule derivanti da pazienti reali, come i fibroblasti o le cellule ematiche. Contemporaneamente, puntiamo a migliorare la risoluzione spaziale per poter identificare e analizzare il singolo lisosoma. L’obiettivo finale è integrare la citometria olografica nel percorso di ricerca traslazionale e renderla uno strumento diagnostico e di screening terapeutico standard per le malattie da accumulo lisosomiale.


Diego Medina è nato a Siviglia. In Spagna ha conseguito la laurea in Biologia, un master in Neurofisiologia e un dottorato di ricerca in Biochimica e Biologia Molecolare. Ricercatore post-dottorato Marie Curie presso l’EMBL-Monterotondo, a Roma. Nel 2007 è entrato nel team di Andrea Ballabio al TIGEM di Napoli, occupandosi dei meccanismi biologici alla base delle malattie da accumulo lisosomiale (LSD). Dal 2011 è ricercatore associato e responsabile del laboratorio di High Content Screening Facility presso lo stesso istituto. Nel 2019 è diventato professore associato di biologia applicata all’Università Federico II di Napoli. Il suo attuale interesse di ricerca è incentrato sulla scoperta di nuovi bersagli terapeutici e sullo sviluppo di strategie farmacologiche per il trattamento di malattie genetiche rare utilizzando approcci di imaging e biologia cellulare.
Direttore della ricerca all’Institute of Applied Sciences & Intelligent Systems

“E. Caianiello” presso il CNR, Pietro Ferraro è un fisico ed appassionato scienziato le cui ricerche spaziano dalle biotecnologie e nuove applicazioni in medicina fino all’aerospazio. Negli ultimi anni le sue ricerche si sono concentrate sui sistemi intelligenti ed ha infatti sviluppato i cosiddetti Lab on a Chip, che consistono in dispositivi miniaturizzati utilizzati per la diagnostica sia in campo medico che ambientale. Fondatore nel 2016 dell’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti del CNR e autore di oltre 600 pubblicazioni scientifiche, nel 2020 è stato insignito del prestigioso premio internazionale “SPIE- Dennis Gabor Award”.

«Abbiamo dimostrato che l’accumulo di colesterolo nelle cellule affette da NPC1 altera significativamente la posizione e la morfologia dei lisosomi. Grazie alla nostra tecnica, siamo stati in grado di misurare con precisione questi cambiamenti e di dimostrare che la correzione della localizzazione dei lisosomi, attraverso specifici interventi, risolve l’accumulo patologico.» - spiega Ferraro


Intervista al direttore dell’Unità bioetica dell’Istituto Superiore di Sanità secondo cui il primo requisito di eticità è la scientificità
“Professor Petrini, la bioetica è una disciplina che si colloca a metà tra filosofia e scienza. Tante le questioni spinose. Nel loro progredire la scienza e la tecnologia possono offrire soluzioni in campi quali la medicina e la biologia. Ma la bioetica diviene fondamentale quando si cercano risposte. Quali sono i quesiti cui è chiamata a rispondere?
Il Nuffield Council on Bioethics, una nota fondazione britannica, aggiorna periodicamente un “Horizon Scan” per identificare le sfide per l’etica poste dall’avanzamento delle conoscenze e delle tecnologie. Le sfide sono suddivise per aree, quali, ad esempio: etica della ricerca; dati e tecnologie; salute e società; inizio della vita; ambiente e alimentazione. Ogni area comprende decine di argomenti, con orizzonti temporali differenti: a breve termine (es. gestione dei dati, terapie digitali, sperimentazioni innovative), a medio termine (es. organoidi, xenotrapianti), a lungo termine (es. utero artificiale, nuove tecnologie per il potenziamento cerebrale). Tra i temi centrali non può mancare l’intelligenza artificiale: le enormi potenzialità e il rapido sviluppo la pongono al centro dell’attenzione.
L’Italia è uno Stato laico. Sebbene il cattolicesimo abbia avuto un ruolo importante nella storia italiana. Come si concilia la matrice cattolica con temi quali l’eutanasia?
Ritengo epistemologicamente inadeguata la tendenza ad aggettivare la bioetica (laica, cattolica). I cattolici che si confrontano con le questioni poste dalla biomedicina e dalla tecnica non ricorrono ad argomentazioni teologiche, magisteriali o parenetiche, ma riconoscono che l’identità umana si fonda sull’essere uomo: l’uomo ha una natura e un’essenza che valgono per tutti, indistintamente. La bioetica deve affondare le sue radici nella ragione stessa dell’uomo e nel cuore della sua libertà. L’argomentazione nasce dalla ragione e dall’antropologia.
La figura di Dionigi Tettamanzi nel campo della bioetica è stata rilevante. Una branca che tiene conto anche dei principi della dottrina cristiana, con un’attenzione particolare alla dignità della persona umana e alla sacralità della vita. Cosa ne pensa?
La risposta a questa domanda deve partire dalla premessa già espressa: non esistono bioeticisti cattolici, bensì cattolici bioeticisti. Agli insegnamenti del cardinale Dionigi Tettamanzi, del cardinale Elio Sgreccia e di altre personalità cattoliche di grande levatura intellettuale hanno attinto, e continuano ad attingere, generazioni di bioeticisti, non solo in Italia.
Il cardinale Sgreccia fu tra i primi a introdurre la bioetica in Italia: propose un modello di pensiero solido, che definì «personalismo ontologicamente fondato». Il suo “Manuale di bioetica” è tradotto in tutte le principali lingue del mondo. Il cardinale Tettamanzi svolse un’attività accademica molto intensa nei campi della bioetica e della morale. A essa unì anche una vivace attività di divulgazione: contribuì in modo rilevante a far conoscere la bioetica anche tra i cittadini, al di fuori delle aule universitarie. Fondatore del Comitato Nazionale per la Bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fu il professor Adriano Bompiani, personalità cattolica di altissimo profilo istituzionale e scientifico.
In una società in continua evoluzione permangono temi complessi come la procreazione assistita, l’aborto, l’eutanasia, la sperimentazione scientifica e la donazione di organi quali sono i nodi che la bioetica deve sciogliere?
Oggi la prospettiva è la “Bioetica globale”, per due motivi principali. Primo: se la bioetica è nata e si è sviluppata soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, oggi ha una dimensione planetaria e sovra-territoriale.
Secondo: emergono nuove sfide globali, come le frontiere tecnologiche, il bioterrorismo e altri fenomeni.
Anche problemi locali possono avere ripercussioni globali.
La prospettiva globale può essere resa evidente mediante alcune esemplificazioni. La ricerca biomedica ha ormai una dimensione internazionale, ma la sperimentazione condotta in un Paese europeo solleva questioni diverse rispetto a quella condotta in un Paese africano. Le sensibilità, le raccomandazioni e le normative sviluppate negli ultimi decenni si sono affermate soprattutto in contesti economicamente avanzati, e non possono essere applicate in modo identico in Paesi a basso reddito.
Un altro esempio è l’intelligenza artificiale: sviluppo, applicabilità e accesso pongono sfide differenti a seconda delle aree geografiche. Temi quali la procreazione assistita, l’aborto, l’eutanasia, la sperimentazione scientifica e la donazione di organi sono, insieme ad altri, all’origine della bioetica come disciplina autonoma, che assunse una sua fisionomia autonoma tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso.
Da allora, lo sviluppo scientifico e tecnologico ha sollevato nuove criticità, sia su temi inediti, sia per temi già presenti da decenni che oggi pongono interrogativi nuovi.
La biologia è definita la scienza del futuro in quanto scienza in continua evoluzione soprattutto in campi quali la genomica, la diagnostica predittiva, la fecondazione medicalmente assistita, la microbiologia.
E tuttavia resta importante definire confini oltre i quali non bisogna spingersi. In tal senso è ipotizzabile una sinergia tra biologia e bioetica?
In senso letterale, la biologia è la scienza che studia gli esseri viventi. La definizione più classica di bioetica è: “Studio sistematico della condotta umana nell’area delle scienze della vita e della cura della salute, quando essa viene esaminata alla luce dei valori e dei principi morali”. Pertanto, la sinergia tra biologia e bioetica non è
un’ipotesi, ma una necessità.
Il primo requisito di eticità è la scientificità, come sintetizzato nella nota espressione: “Bad science, bad ethics”. Tuttavia, non necessariamente vale il contrario “Good science, good ethics”. È riconosciuto che non tutto ciò che è tecnicamente possibile è moralmente lecito: il rispetto della persona ha il primato rispetto al mezzo. Se mi è consentito, l’Unità di Bioetica dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che ho l’onore di dirigere, rappresenta un esempio concreto di sinergia tra biologia e bioetica. L’ISS, organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, è composto da sei Dipartimenti, diciotto Centri Nazionali e di Riferimento, quattro Servizi Tecnico-Scientifici e varie altre strutture, che coprono pressoché l’intero panorama della salute umana. L’Unità di Bioetica, fondata in uno specifico Centro Nazionale dell’ISS, fu presto posta tra le strutture centrali dell’Istituto stesso: collabora con tutte le strutture interne e con molte istituzioni esterne.
Il rispetto per la vita e l’autonomia del paziente. Qual è secondo Lei il limite da non oltrepassare?
È importante evitare la contrapposizione già accennata: è errato opporre una visione ritenuta chiusa, dogmatica e intollerante (cattolica), considerata inaccettabile in una società pluralista, a una visione aperta e rispettosa delle scelte individuali (“laica”).
La vera differenza è tra chi ritiene che l’etica sia vuota senza un radicamento nella verità, e chi propone un’“etica senza verità”, secondo una fortunata espressione coniata da Uberto Scarpelli. Ogni vita ha eguale valore, anche nelle condizioni di maggiore fragilità. La libertà individuale è un principio cardine, ma è sempre inserita in una relazione.
È giusto ancora oggi parlare di accanimento terapeutico?
La medicina contemporanea di-
spone di strumenti capaci di ritardare la morte, anche in assenza di benefici per la persona malata. Nell’approssimarsi della fine della vita, è fondamentale proteggere il paziente da un tecnicismo che rischia di diventare eccessivo e invasivo. L’espressione “accanimento terapeutico” è considerata ormai inadeguata ed è stata progressivamente abbandonata.
Il Comitato Nazionale per la Bioetica adotta l’espressione «ostinazione irragionevole delle cure», ritenuta più precisa e appropriata. L’ostinazione irragionevole è incompatibile con l’art. 16 (“Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati”) del Codice di Deontologia Medica, dove si stabilisce:
«Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita.
Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato. Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte».
La pandemia da Covid ha introdotto un prima e un dopo, quali sfide etiche e procedurali, anche in tema di approvazione rapida, ha dovuto affrontare la bioetica?
La pandemia ha costretto a confrontarsi, in condizioni di emergenza, con problematiche in larga parte già note: il delicato equilibrio tra rispetto delle libertà individuali e tutela della salute pubblica, il triage, l’allocazione delle risorse, l’utilizzo dei dati sanitari, e molte altre.
Tra queste, vi è anche la regolamentazione della sperimentazione clinica. Durante l’emergenza si è constatato che è possibile condurre sperimentazioni (nel caso specifico, di vaccini) mediante nuove tecniche, nuovi disegni e protocolli di studio, nuove metodologie senza compromettere il rispetto dei requisiti di etica e del rigore scientifico. L’urgenza ha evidenziato la possibilità di semplificazioni regolatorie, consentendo una rapidità di azione che, fino a quel momento, sarebbe parsa irrealizzabile.
Ciò ci riporta ai valori fondamentali già richiamati nelle risposte precedenti: non occorrono un’“etica della sanità pubblica”, una “etica dell’epidemiologia”, una “etica della ricerca”, una “etica della tecnologia”, bensì l’“etica nella sanità pubblica”, l’“etica nell’epidemiologia”, l’“etica nella ricerca”, l’“etica nella tecnologia”. I principi di riferimento sono sempre validi: devono essere applicati e bilanciati calandoli nei diversi contesti.

Carlo Maria Petrini è il Direttore dell’Unità di Bioetica dell’ISS ed è stato recentemente confermato come Presidente del Comitato Etico Nazionale per le sperimentazioni degli enti pubblici di ricerca (EPR). Il Comitato resterà in carica per un mandato triennale e avrà il compito di guidare e armonizzare la valutazione etica degli studi clinici e della ricerca biomedica a livello nazionale con un’attenzione particolare alla tutela dei diritti dei pazienti.
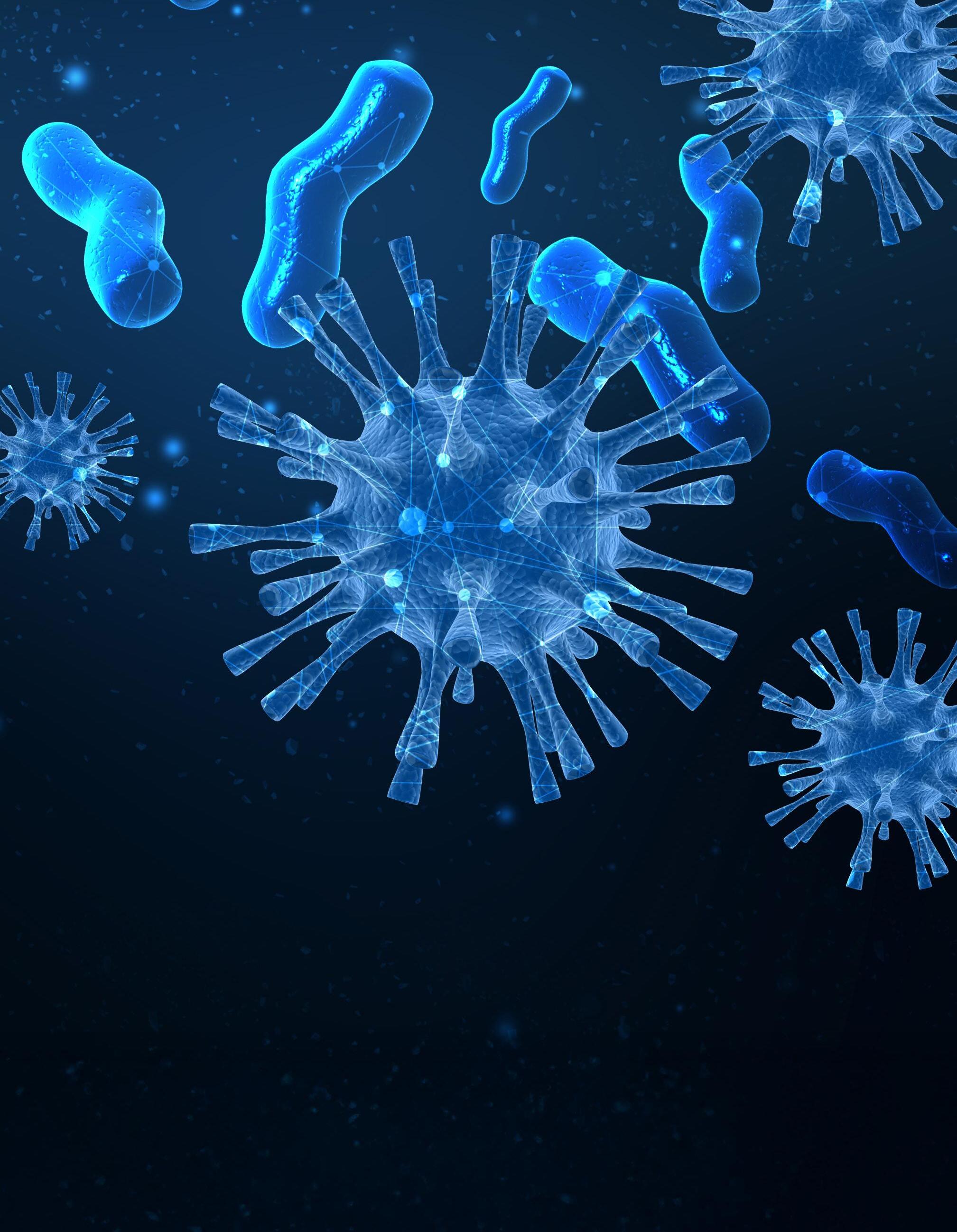
È questa la strategia della Columbia Engineering per aggirare le difese immunitarie e attaccare le cellule cancerose
Iricercatori della Columbia Engineering hanno ideato un sistema basato su batteri programmati per agire come un moderno “cavallo di Troia”: al loro interno nascondono infatti l’RNA di un virus capace di distruggere le cellule tumorali. In questo modo il virus risulta invisibile al sistema immunitario e può raggiungere il bersaglio, colpendo direttamente le cellule cancerose.
Nello studio, pubblicato su Nature Biomedical Engineering, i ricercatori hanno utilizzato un nuovo approccio che unisce la naturale capacità dei batteri di localizzare e attaccare i tumori con la naturale tendenza dei virus a infettare e distruggere le cellule cancerose. Tal Danino, professore associato di ingegneria biomedica alla Columbia Engineering, ha guidato il team nella creazione del sistema, chiamato CAPPSID (Coordinated Activity of Prokaryote and Picornavirus for Safe Intracellular Delivery, ovvero Attività coordinata di procarioti e picornavirus per un rilascio intracellulare sicuro).
«Il nostro obiettivo era migliorare la terapia batterica contro il cancro consentendo ai batteri di trasportare e attivare un virus terapeutico direttamente all’interno delle cellule tumorali, creando al contempo delle misure di sicurezza per limitare la diffusione virale al di fuori del tumore», afferma Jonathan Pabón, primo autore dello studio e ingegnere biomedico della Columbia University.
Gli autori della ricerca ritengono che la metodica da loro messa a punto rappresenti il primo esempio di cooperazione direttamente ingegnerizzata tra batteri e virus che prendono di mira il cancro. «Collegando l’ingegneria batterica con la virologia sintetica, il nostro obiettivo è quello di aprire la strada a terapie multi-organismo in grado di ottenere risultati molto più efficaci di quelli che un singolo microbo potrebbe ottenere da solo», afferma Zakary S. Singer, coautore principale dello studio. Grazie al nuovo approccio utilizzato
nello studio, gli scienziati sono riusciti a superare uno degli ostacoli più insidiosi della terapia che impiega virus oncolitici: l’eliminazione precoce del virus da parte del sistema immunitario. Se un paziente ha anticorpi contro il virus, derivanti da una precedente infezione o vaccinazione, tali anticorpi potrebbero neutralizzarlo prima che raggiunga il tumore. Il team della Columbia ha aggirato il problema inserendo il virus all’interno di batteri che individuano i tumori. «I batteri agiscono come un mantello dell’invisibilità, nascondendo il virus agli anticorpi circolanti e trasportandolo dove è necessario», afferma Singer. «Il nostro sistema - aggiunge Pabón - dimostra che i batteri possono essere potenzialmente utilizzati per somministrare un virus oncolitico per trattare i tumori solidi in pazienti che hanno sviluppato immunità a questi virus».
La parte batterica del complesso è costituita da Salmonella typhimurium, una specie che migra naturalmente verso l’ambiente povero di ossigeno e ricco di sostanze nutritive all’interno dei tumori. Una volta lì, i batteri invadono le cellule tumorali e rilasciano il virus direttamente all’interno del tumore. Sfruttando l’istinto dei batteri di dirigersi verso i tumori e la capacità del virus di replicarsi all’interno delle cellule tumorali, i ricercatori hanno creato un sistema di somministrazione in grado di penetrare nel tumore e diffondersi al suo interno, una sfida che ha limitato sia gli approcci basati solo sui batteri che quelli basati solo sui virus.
Il team è inoltre riuscito ad evitare la diffusione del virus all’esterno del tumore grazie a un trucco molecolare: «Le particelle virali diffondibili possono formarsi solo in prossimità dei batteri, necessari per fornire i meccanismi speciali essenziali alla maturazione virale nel virus ingegnerizzato, creando una dipendenza sintetica tra i microbi», afferma Singer. Questa salvaguardia aggiunge un secondo livello di controllo: anche se il virus sfugge al tumore, non si diffonderà nei tessuti sani. «Sono siste-
mi come questi, specificamente orientati a migliorare la sicurezza di queste terapie viventi, che saranno essenziali per tradurre questi progressi in applicazioni cliniche», aggiunge Singer. Secondo gli autori, questa pubblicazione segna un passo significativo verso future applicazioni cliniche. «In qualità di medico-scienziato, il mio obiettivo è quello di portare le terapie basate su organismi o cellule viventi nella pratica clinica», afferma Pabón. «Sono attualmente in corso sforzi per la traduzione clinica al fine di trasferire la nostra tecnologia fuori dal laboratorio» conclude l’autore.

«I batteri agiscono come un mantello dell’invisibilità, nascondendo il virus agli anticorpi circolanti e trasportandolo dove è necessario», afferma Singer. «Il nostro sistema dimostra che i batteri possono essere potenzialmente utilizzati per somministrare un virus oncolitico per trattare i tumori solidi in pazienti che hanno sviluppato immunità a questi virus»
Guardando al futuro, il team sta testando l’applicazione della metodica in una gamma più ampia di tumori, utilizzando diversi tipi di tumori e virus con l’obiettivo di sviluppare un “kit di strumenti” di terapie virali in grado di rilevare e rispondere a condizioni specifiche all’interno di una cellula. Sta inoltre valutando come questo sistema possa essere combinato con ceppi batterici che hanno già dimostrato la loro sicurezza negli studi clinici. (S. B.).

Uno studio delle Università di Yale e di Trento ha scoperto il meccanismo molecolare all’origine della patologia e dimostra come può essere bloccato
Iricercatori dell’Università di Yale insieme ai colleghi dell’Università di Trento hanno identificato il meccanismo alla base dell’insorgenza della leucemia megacarioblastica acuta (AMKL), una forma rara e aggressiva di tumore del sangue che colpisce in particolare i bambini. Lo studio aiuta a comprendere il coinvolgimento dell’RNA nello sviluppo della malattia e individua nuovi possibili percorsi terapeutici.
L’AMKL colpisce i megacariociti, le cellule del sangue che producono le piastrine. Si manifesta più comunemente sotto i cinque anni di età, in particolare in soggetti affetti dalla sindrome di Down. Purtroppo la chemioterapia e il trapianto di cellule staminali, ad oggi le principali terapie in uso, non sempre risultano efficaci. Tra i motivi, c’è anche la scarsa conoscenza del meccanismo di azione della patologia, oggetto specifico dello studio dei ricercatori di Yale.
La ricerca, pubblicata sulla rivista specializzata Blood, ha individuato il meccanismo alla base della relazione tra lo sviluppo della malattia e una specifica alterazione genetica che causa la formazione di una proteina mutante. Si tratta in pratica di due geni che normalmente nel genoma sono separati e che invece vanno a formare una proteina unica (RBM15-MKL1) attraverso un processo di fusione. Questa fusione provoca il tumore.
I ricercatori hanno quindi ipotizzato che la proteina mutante alteri un processo (chiamato modifica m6A), che guida il comportamento di particolari RNA responsabili della trasmissione di informazioni genetiche dal DNA. Hanno infine concluso che la proteina mutante può legare e modificare l’RNA, dirottando i normali processi di m6A e cambiando il modo in cui l’RNA si comporta normalmente, attivando in particolare una via di segnalazione critica per i tumori, chiamata WNT. «Grazie all’esperienza di diversi laboratori, siamo stati in grado di identificare come la proteina mutante RBM15MKL1 interagisce con l’RNA a un livello molto profondo e abbiamo dimostrato che questi contatti sono essenziali per la persistenza della leucemia. Si tratta di un enorme passo avanti nella comprensione di questa malattia», afferma Madeline Mayday, autrice principale dello studio. Durante gli esperimenti di laboratorio, i ricercatori hanno inoltre dimostrato che l’inibizione dell’attività del gene responsabile della formazione della proteina mutante, attraverso un farmaco sperimentale chiamato STM3675, ha ostacolato la crescita dell’AMKL e ucciso le cellule tumorali, evidenziando il ruolo della via di segnalazione WNT in questo specifico tumore del sangue. Una via di segnalazione del cancro si riferisce a una serie di molecole in una cellula che, quando attivate o disattivate in modo anomalo, portano a una disfunzione cellulare e possono indurre il cancro, come nel caso della
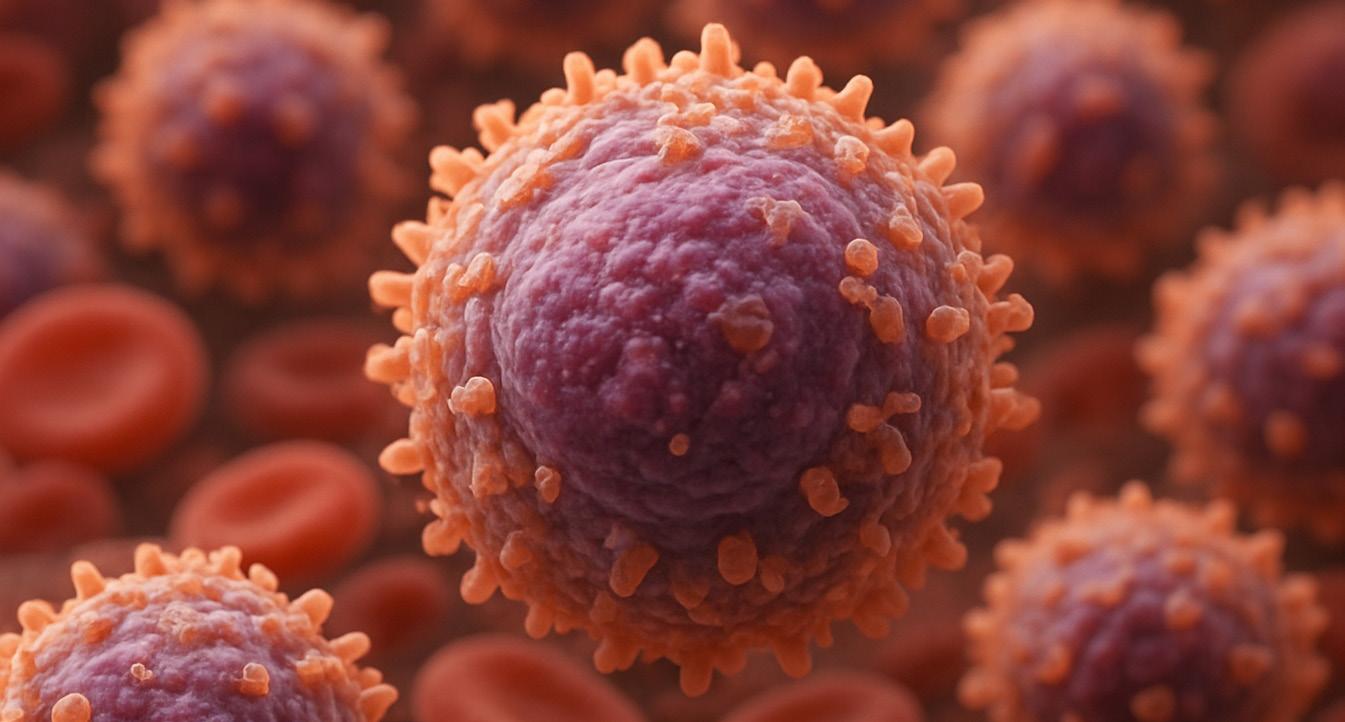
La ricerca ha individuato il meccanismo alla base della relazione tra lo sviluppo della malattia e una specifica alterazione genetica che causa la formazione di una proteina mutante. Si tratta in pratica di due geni che normalmente nel genoma sono separati e che invece vanno a formare una proteina unica (RBM15-MKL1) attraverso un processo di fusione. Questa fusione provoca il tumore
via WNT. Le terapie antitumorali sono spesso dirette a bloccare o modificare queste vie deregolamentate. «Abbiamo esaminato centinaia di campioni di pazienti affetti da diversi tipi di leucemia e abbiamo osservato che anche l’AMKL causata da altre alterazioni genetiche presentava una sovra regolazione del percorso WNT, suggerendo che tutte le forme di AMKL potrebbero essersi evolute con una dipendenza comune dalla segnalazione WNT e potrebbero quindi essere trattabili con farmaci che agiscono sul percorso WNT», spiega Diane Krause, autrice responsabile dello studio e direttrice del Krause Lab presso lo Yale Cancer Center.
«Il nostro studio sottolinea l’importanza della ricerca traslazionale cioè di riuscire a tradurre le scoperte scientifiche in soluzioni concrete da applicare in campo clinico. Abbiamo sviluppato modelli preclinici AMKL per studiare il legame dell’RNA e le alterazioni m6A causate da una proteina mutante leucemogena e abbiamo dimostrato che queste alterazioni possono essere corrette utilizzando un inibitore a piccole molecole con comprovata attività antitumorale», afferma Giulia Biancon, autrice principale dello studio ed ex membro dell’Halene Lab presso lo Yale Cancer Center.
«Questa scoperta fornisce un’ulteriore prova di come le alterazioni nella biologia dell’RNA causino malattie umane e dimostra il potere dell’analisi dei big data nello scoprire questi meccanismi cruciali», aggiunge Toma Tebaldi, autore senior dello studio e professore associato del dipartimento di biologia cellulare, computazionale e integrata dell’Università di Trento. «Adesso che sappiamo che la proteina mutante agisce sull’RNA e sulle sue modifiche - prosegue Tebaldi - l’obiettivo è provare a usare terapie innovative e farmaci mirati, già in fase di sviluppo, che vadano a colpire le alterazioni dell’RNA per correggerle».
Lo studio dimostra ancora una volta l’importanza della cooperazione internazionale e dello scambio bidirezionale di informazioni tra chi si occupa di ricerca in laboratorio e chi cura i pazienti sul campo, al fine di arrivare a definire in modo sempre più accurato l’origine delle patologie e sviluppare trattamenti innovativi sempre più efficaci.

Ricercatori dell’Imperial College scoprono che la struttura secondaria a quadrupla elica del DNA può rappresentare la chiave per invertire la chemioresistenza di questo carcinoma
Irisultati di un nuovo studio dei ricercatori dell’Imperial College di Londra aprono una nuova incoraggiante strada per il trattamento delle pazienti con recidiva di carcinoma ovarico. Il team inglese ha scoperto che nelle cellule tumorali che sviluppano resistenza ai farmaci si accumulano particolari strutture secondarie del DNA a quattro filamenti, note come G-quadruplex, e ritiene che questa caratteristica potrebbe rappresentare un nuovo bersaglio terapeutico per trattare il cancro ovarico che non risponde più alle cure tradizionali.
Il carcinoma ovarico causa ogni anno oltre 200.000 vittime in tutto il mondo. La maggior parte delle donne affette da questo tipo di tumore inizialmente risponde molto bene alla chemioterapia, ma nel 70% dei casi vede il cancro ripresentarsi. E sebbene molte pazienti rispondano alle cure una seconda o terza volta, alla fine i farmaci smettono di avere effetto. Così i ricercatori dell’Imperial College hanno cercato di capire come superare la chemioresistenza delle cellule tumorali e hanno individuato un potenziale bersaglio nella particolare struttura a quattro filamenti che il DNA può assumere al posto della tradizionale doppia elica. Nel nuovo studio, pubblicato su Genome Biology, il team inglese ha notato che le strutture G-quadruplex tendono ad accumularsi nelle cellule resistenti del cancro ovarico e contribuiscono ad attivare geni chiave che contrastano la chemioterapia, proteggendo efficacemente il tumore dal trattamento. Prendere di mira queste strutture del DNA potrebbe, secondo gli scienziati, ripristinare l’efficacia della chemioterapia nelle pazienti che non rispondono più al trattamento. Come spiegato dai ricercatori, le strutture secondarie del DNA a quadrupla elica, chiamate G-quadruplex stanno emergendo come potenziali marcatori rilevanti per l’evoluzione
del cancro, ma la loro prevalenza e distribuzione nei modelli di cancro ovarico non sono mai state studiate prima d’ora. Marco Di Antonio che ha guidato lo studio, ha dichiarato: «Si tratta di una scoperta entusiasmante. Da oltre un decennio sappiamo che il DNA G-quadruplex può formarsi nel genoma umano, ma questa è la prima volta che osserviamo una risposta funzionale diretta legata al suo targeting, che potrebbe essere sfruttata per applicazioni terapeutiche. Grazie a questa scoperta ora possiamo accelerare le ricerche per verificare se questi promettenti risultati possano portare benefici alle pazienti».
Il team dell’Imperial College ha studiato il ruolo dei G-quadruplex nelle cellule tumorali ovariche, analizzando in laboratorio i cambiamenti che avvengono nelle cellule quando diventano resistenti alla chemioterapia. Prendendo di mira i G-quadruplex con farmaci specializzati, i ricercatori sono stati in grado di risensibilizzare le cellule resistenti alle terapie standard, ripristinando la loro vulnerabilità alla chemioterapia.
Iain McNeish, autore dello studio e titolare della cattedra di oncologia presso il dipartimento di chirurgia e cancro dell’Imperial College di Londra, ha commentato: «Per molti anni si è pensato che la resistenza alla chemioterapia nel cancro ovarico fosse causata da rare mutazioni nel DNA delle cellule tumorali, mutazioni già presenti al momento dello sviluppo del tumore o indotte dalla stessa chemioterapia.
Ma recenti ricerche suggeriscono che le cellule tumorali ovariche possono modificare il loro comportamento senza alcuna alterazione nella sequenza di base del DNA». «Grazie a questa scoperta - ha proseguito McNeish - ora sappiamo come le alterazioni nella struttura tridimensionale del DNA possano essere un fattore determinante nella resistenza alla chemioterapia, offrendo nuove

Il team dell’Imperial College ha studiato il ruolo dei G-quadruplex nelle cellule tumorali ovariche, analizzando in laboratorio i cambiamenti che avvengono nelle cellule quando diventano resistenti alla chemioterapia. Prendendo di mira i G-quadruplex con farmaci specializzati, i ricercatori sono stati in grado di risensibilizzare le cellule resistenti alle terapie standard, ripristinando la loro vulnerabilità alla chemioterapia
opportunità alle pazienti: invertire la resistenza alla chemioterapia o prevenirne l’insorgenza».
Marie-Claire Platt, direttrice della ricerca e delle politiche di Ovarian Cancer Action, ente benefico britannico per la ricerca sul cancro ovarico, ha commentato: «Una diagnosi di cancro ovarico è devastante. Ma immaginate anche cosa può significare sottoporsi a trattamenti estenuanti, per poi scoprire che il cancro ovarico è tornato e non risponde più alle cure. Questa è la realtà per sette donne su dieci che convivono con questa malattia e vivono ogni giorno con la paura di andare incontro a una recidiva». «Questa ricerca - prosegue Platt - offre una reale speranza di poter rendere la resistenza un ricordo del passato e superare una delle sfide più grandi per migliorare i tassi di sopravvivenza».
Secondo gli autori dello studio, i risultati ottenuti aprono una nuova promettente strada per il trattamento delle recidive di carcinoma ovarico e si aggiungono alle crescenti prove scientifiche che le strutture alternative del DNA potrebbero essere potenti bersagli nella lotta contro malattie come il cancro e patologie neurodegenerative.
Il team sta ora proseguendo le ricerche per stabilire se anche altri tipi di tumori sfruttino le strutture G-quadruplex del DNA per diventare resistenti alla chemioterapia. (S. B.).
Pubblicato su Nucleic Acids Research: il nuovo metodo identifica firme mutazionali in 20mila genomi, distingue sottotipi e guida diagnosi, prognosi e terapie
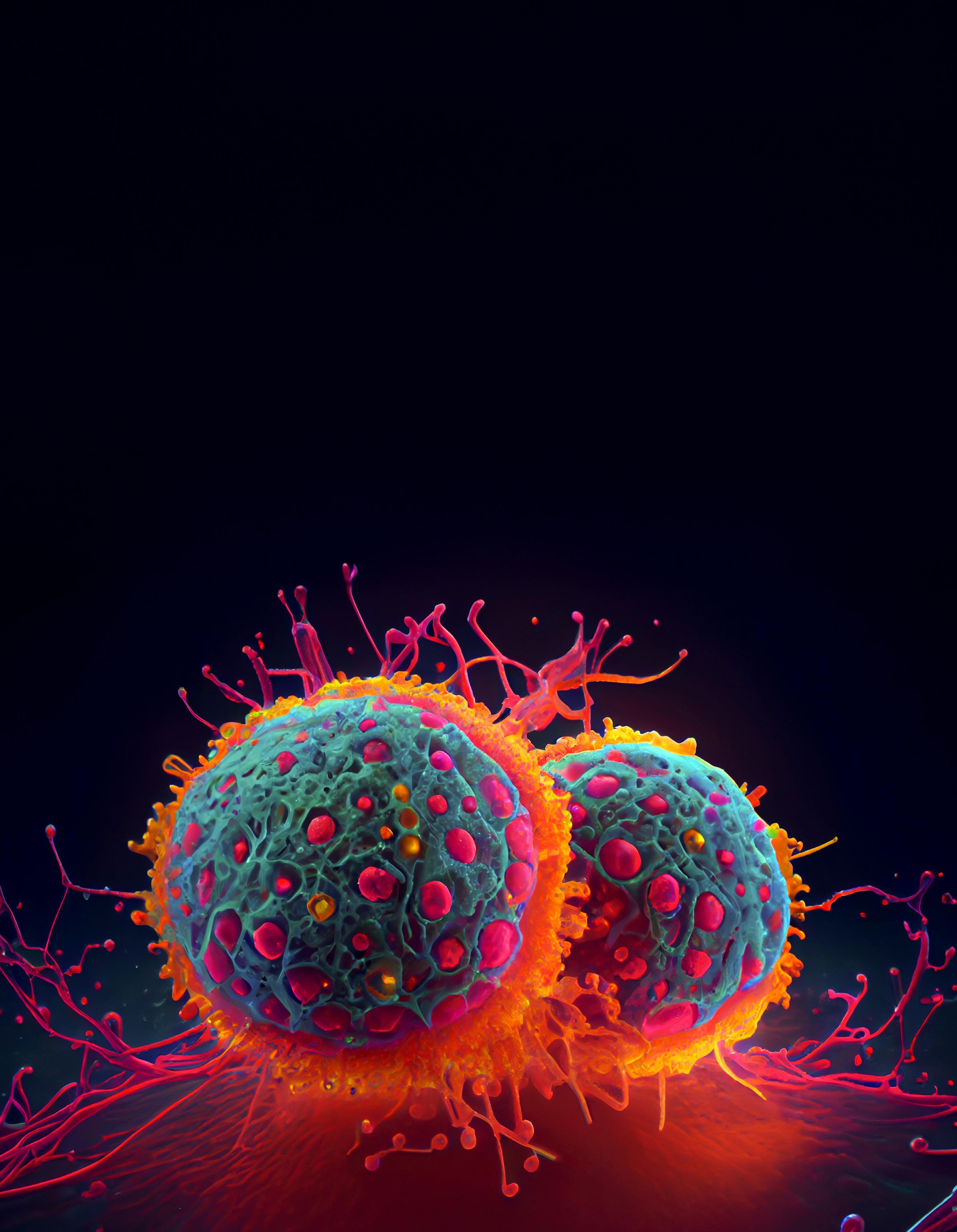
Kateryna Kon/shutterstock.com


Un gruppo multidisciplinare dell’Università di Milano-Bicocca, insieme all’Università di Trie ste, ha sviluppato Resolve (Robust EStimation Of mutationaL signatures Via rEgularization), un metodo computazionale che migliora l’analisi delle firme mutazionali, cioè gli schemi ricorrenti di alterazioni del Dna che raccontano quali danni hanno colpito le cellule. Il lavoro, pubblicato su Nucleic Acids Research, apre a diagnosi più accurate e terapie personalizzate. Le firme mutazionali sono modelli statistici che descrivono come si distribuiscono le mutazioni somatiche nel genoma. Da questi modelli si possono inferire i processi causali: l’invecchiamento fisiologico, l’esposizione al fumo o ai raggi Uv, oppure i difetti dei sistemi di riparazione del DNA. Analizzare le firme aiuta a ricostruire tempi e meccanismi dell’evoluzione tumorale. Ma l’estrazione e l’assegnazione delle firme restano delle sfide: i modelli possono sovra-adattarsi ai dati, i risultati dipendono dal catalogo di firme adottato (per esempio Cosmic) e le esposizioni stimate per i singoli pazienti possono essere instabili. Resolve affronta questi limiti con un’architettura integrata. La parte più importante è una Nmf (fattorizzazione a matrici non negative) con regolarizzazione, che evita soluzioni troppo complesse. Il metodo include una firma di fondo, sempre presente a bassa intensità, applica l’elastic-net per limitare l’overfitting e utilizza la bi-cross-validation per scegliere in modo oggettivo il numero ottimale di firme.
Inoltre, aggiunge un metodo per misurare quanto sono affidabili le stime in ogni campione, così da capire quando una firma è davvero presente e quanto contribuisce. Applicato a circa 20.000 genomi tumorali, in adulti e bambini, Resolve ha identificato con alta accuratezza un numero ristretto di firme dominanti. Questo risultato indica che pochi processi mutazionali spiegano la maggior parte delle mutazioni osservate. Il metodo produce stime più affidabili e più stabili tra coorti e istotipi diversi, e consente di suddividere i tumori in sottotipi molecolari associati a differenze prognostiche. Ne deriva una base più solida per usare le firme nella medicina di precisione. Rispetto ai metodi correnti, Resolve tende a spiegare i cataloghi con un set più contenuto di firme, evitando di includere contributi marginali che spesso confondono l’interpretazione clinica.
Stimare l’affidabilità di ogni campione consente di separare i segnali autentici, come le firme legate all’età o al fumo, dagli artefatti generati dall’analisi. Ne deriva una classificazione più allineata alle alterazioni dei geni driver e agli esiti clinici, requisito fondamentale per rendere le firme biomarcatori traslazionali solidi. Il quadro che emerge è coerente con una prospettiva evolutiva del cancro: fattori interni alla cellula e influenze ambientali imprimono tracce riconoscibili che guidano l’accumulo


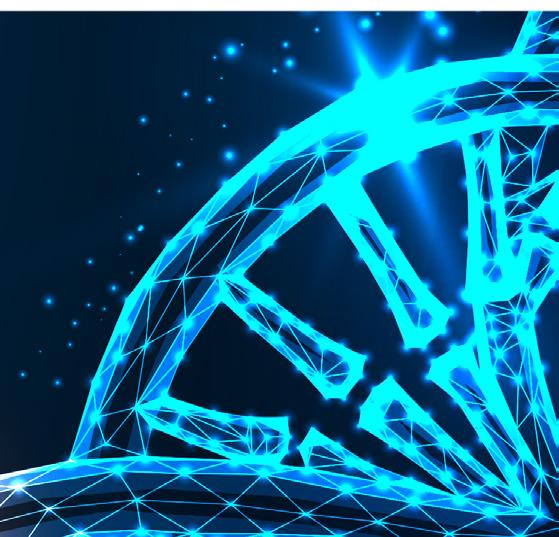

Le firme mutazionali sono modelli statistici che descrivono come si distribuiscono le mutazioni somatiche nel genoma. Da questi modelli si possono inferire i processi causali: l’invecchiamento fisiologico, l’esposizione al fumo o ai raggi Uv, oppure i difetti dei sistemi di riparazione del DNA. Analizzare le firme aiuta a ricostruire tempi e meccanismi dell’evoluzione tumorale. Applicato a circa 20.000 genomi tumorali, in adulti e bambini, Resolve ha identificato con alta accuratezza un numero ristretto di firme dominanti. Questo risultato indica che pochi processi mutazionali spiegano la maggior parte delle mutazioni osservate
delle mutazioni e la selezione dei driver. Resolve, eliminando rumore e falsi segnali, produce profili chiari e interpretabili, confrontabili tra coorti e utili per rilevare associazioni con alterazioni driver e risultati clinici. Integrare l’uso di Resolve nei flussi di analisi standard può guidare scelte più consapevoli Riconoscere una firma da difetto di mismatch-repair può orientare verso l’immunoterapia; rilevare contributi da esposizione a carcinogeni ambientali rafforza strategie di prevenzione secondaria; classificare i tumori in sottotipi molecolari può guidare l’arruolamento in studi clinici o l’ottimizzazione di combinazioni farmacologiche. Il pacchetto open-source su Bioconductor favorisce adozione, riproducibilità e confronto tra centri. L’impiego su più fasi consente di monitorare la risposta terapeutica, identificare firme generate dai trattamenti e guidare le modifiche del percorso clinico.
Restano alcune cautele. I cataloghi di firme, come Cosmic v3, sono in costante aggiornamento e l’etiologia di molte firme non è ancora definita con certezza. Per valutare l’impatto clinico serviranno studi prospettici che confrontino diversi metodi di nuova generazione (ad esempio MuSiCal) e l’adozione di standard condivisi. Anche la qualità dei dati, i bias di campionamento e la composizione clonale del tumore possono condizionare l’inferenza: per questo sono necessarie coorti con endpoint clinici in grado di tradurre le promesse in pratica. Il progetto dimostra che un numero limitato di processi mutazionali è responsabile della maggior parte delle mutazioni osservate. Questo apre nuove prospettive per diagnosi, prognosi e sviluppo di terapie mirate. Lo studio rappresenta un avanzamento metodologico che rende la storia scritta nel DNA dei tumori uno strumento più affidabile per guidare decisioni personalizzate. (C. P.).
Uno studio internazionale guidato dall’Italia mostra come aumentare l’accuratezza dell’appaiamento senza enzimi complessi, con ricadute biomediche
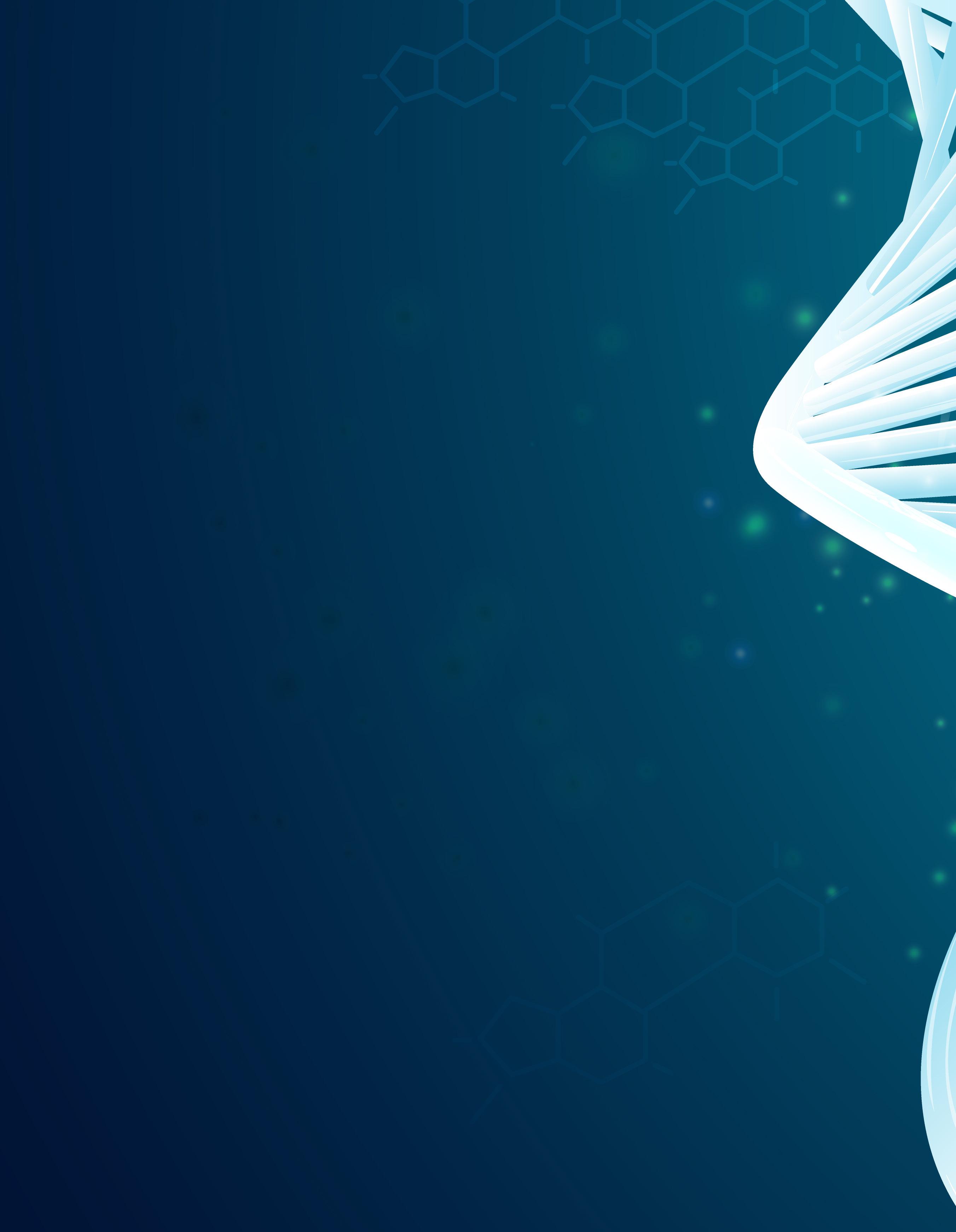
di Carmen Paradiso
Ridurre gli errori di appaiamento tra filamenti di DNA senza ricorrere a enzimi complessi non è più un’utopia: è quanto dimostra un recente studio condotto da un team internazionale guidato dall’Italia, con la partecipazione dell’Università di Padova, dell’Università di Roma “Tor Vergata” e della Northwestern University. Il progetto è stato coordinato da Leonard J. Prins (Università di Padova) e Francesco Ricci (Università di Roma “Tor Vergata”), con contributi fondamentali di Benjamin M. W. Roberts, Erica Del Grosso ed Emanuele Penocchio.
Il lavoro, pubblicato su Nature Nanotechnology, dimostra che è possibile aumentare in modo sostanziale l’accuratezza del riconoscimento tra brevi filamenti di DNA, ponendo le basi per catalizzatori più efficienti, sensori più sensibili e nuovi materiali ad alte prestazioni. In chimica, la selettività del rico-
noscimento molecolare è spesso determinata dall’equilibrio termodinamico: due partner giusti si riconoscono grazie alla loro complementarità di forma e alle interazioni. In processi biologici critici, come la replicazione del DNA, la natura spinge però i sistemi fuori dall’equilibrio e usa energia per correggere gli errori: è il cosiddetto kinetic proofreading.
Lo studio mostra un’analoga strategia abiota. Sfruttando l’ibridazione del DNA, i ricercatori hanno realizzato un meccanismo capace di ridurre gli errori senza l’impiego di macchine biomolecolari complesse. La parte più importante della scoperta è stata l’information ratchet, un cricchetto d’informazione: una rete di reazioni progettata in modo asimmetrico che, alimentata da energia dissipata, favorisce cineticamente la formazione del duplex corretto rispetto a quello errato. In condizioni di equilibrio, il sistema distingue il corretto dal-
lo scorretto con un rapporto di circa 2:1 (67% di appaiamenti corretti); in modalità a cricchetto, la preferenza sale a 6:1, pari a 86% di appaiamenti corretti. In termini pratici, significa una drastica riduzione dei falsi positivi rispetto a quanto previsto dalla sola termodinamica e, più in generale, una piattaforma quantitativa per modulare la fedeltà del riconoscimento molecolare.
Gli autori hanno quantificato anche il prezzo energetico dell’informazione acquisita: un aumento di circa 0,33 bit nella selettività richiede almeno 3,0 kJ/mol di energia libera. È un risultato importante perché lega, in modo misurabile, l’incremento della fedeltà di riconoscimento a un costo energetico minimo, offrendo a chimici, bioingegneri e fisici della materia uno strumento per progettare futuri sistemi di correzione degli errori molecolari basati su principi di termodinamica dell’informazione. A differenza
del proofreading enzimatico naturale, la piattaforma proposta opera con strutture minimali e agisce direttamente sul DNA. Questa semplicità architetturale amplia l’applicabilità del metodo in contesti dove introdurre enzimi sarebbe difficile, instabile o costoso, e apre la strada a dispositivi di riconoscimento più compatti e facilmente integrabili.
I possibili sviluppi potrebbero trovare applicazioni reali. In farmacologia, migliorare la fedeltà del riconoscimento significa selezionare con più rigore un bersaglio terapeutico, riducendo gli effetti off-target e aumentando l’efficacia dei farmaci potenziali, dai modulatori allosterici agli oligonucleotidi terapeutici. Nella sensoristica, una lettura più pulita dei segnali molecolari si traduce in limiti di rilevazione più bassi, maggiore specificità diagnostica e minori interferenze di matrice: qualità che tornano utili nei test point-of-care e nei biosensori impiantabili. Nella scienza dei materiali, matrici e gel programmabili basati su interazioni nucleiche più selettive possono esibire proprietà emergenti più controllate

(auto-assemblaggio, risposta a stimoli, robustezza funzionale), con ricadute su elettronica morbida, robotica soffice e sistemi di rilascio intelligente.
La ricerca getta nuova luce sui meccanismi all’origine della vita. Dimostra che un cricchetto d’informazione abiota può spingere la replicazione molecolare oltre i limiti dell’equilibrio, suggerendo come reti prebiotiche prive di enzimi complessi potessero trasmettere l’informazione genetica con maggiore affidabilità, aggirando in parte il cosiddetto paradosso di Eigen. Questo scenario è coerente con l’idea che la vita sia emersa non solo da molecole adatte, ma da flussi di energia capaci di imporre direzionalità ai processi di selezione e correzione. È un avanzamento concettuale e applicativo verso piattaforme molecolari sempre più precise e programmabili, con potenziali ricadute in farmacologia, sensoristica e scienza dei materiali, e con un richiamo alle origini della vita: la dimostrazione di come informazione, energia e materia possano intrecciarsi per dare forma a una chimica più affidabile.

Il lavoro dimostra che è possibile aumentare in modo sostanziale l’accuratezza del riconoscimento tra brevi filamenti di DNA, ponendo le basi per catalizzatori più efficienti, sensori più sensibili e nuovi materiali ad alte prestazioni
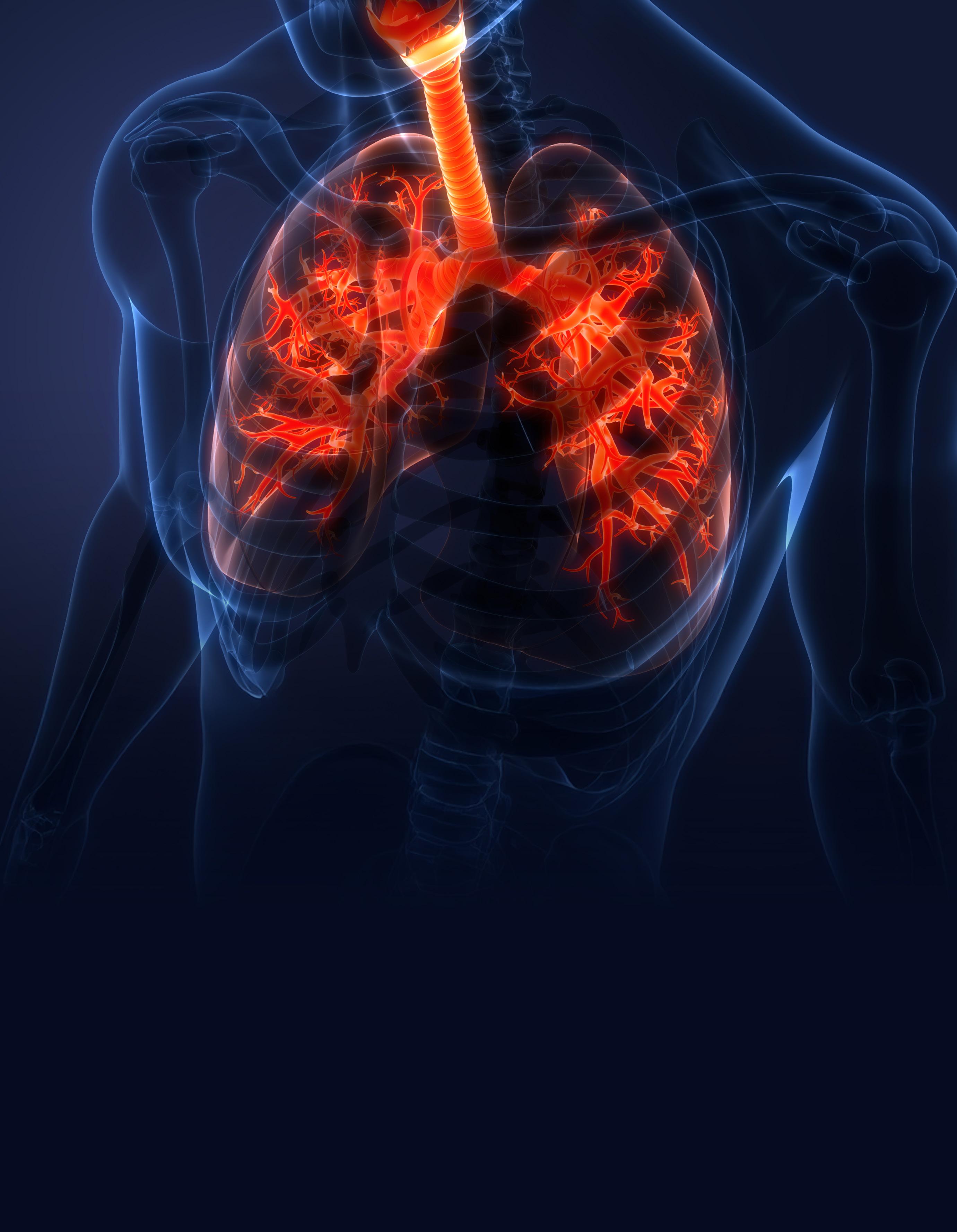
Studio italiano: nei pazienti FC l’età epigenetica è superiore di 3-4 anni
Dopo 12 mesi la malattia arretra, indicando terapie personalizzate
Una ricerca condotta al Ceinge–Biotecnologie
Avanzate “Franco Salvatore” di Napoli e pubblicata sull’International Journal of Molecular Sciences dimostra che, nelle persone con fibrosi cistica, l’età biologica risulta in media più avanzata di 3–4 anni rispetto a quella anagrafica. Il dato, ottenuto analizzando marcatori epigenetici, suggerisce che la malattia non si limiti a danneggiare apparato respiratorio e digerente, ma eserciti un impatto sistemico sul ritmo dell’invecchiamento. «I risultati ottenuti aprono le porte a importanti avanzamenti nella cura della fibrosi cistica e offrono un nuovo biomarcatore per monitorare la terapia più efficace per ciascun paziente», osserva Giuseppe Castaldo, ordinario di Scienze e tecniche di medicina di laboratorio, che ha coordinato il lavoro insieme a Lorenzo Chiariotti, ordinario di Patologia generale dell’Università Federico II di Napoli. Alla ricerca ha collaborato anche il Centro regionale per la Cura della Fibrosi Cistica della Campania coordinato da Vincenzo Carnovale. La fibrosi cistica è una delle malattie genetiche ereditarie più frequenti nelle popolazioni europee e nordamericane; in Italia interessa circa un neonato ogni 2.500–3.000 nati. È causata da mutazioni del gene Cftr, che codifica per una proteina deputata al trasporto del cloro attraverso le membrane cellulari. Quando la proteina è difettosa, le secrezioni diventano dense e disidratate: nel polmone ostruiscono le vie aeree e favoriscono infezioni ricorrenti; a livello pancreatico compromettono la digestione e lo stato nutrizionale; in altri distretti contribuiscono alla disfunzione multiorgano tipica della malattia.
Per misurare l’età epigenetica i ricercatori hanno utilizzato profili di metilazione del DNA, veri e propri orologi molecolari capaci di stimare il grado di usura dei tessuti. Confrontando pazienti con Fibrosi Cistica e controlli di pari età è emerso uno scarto medio di tre-quattro anni a sfavore dei primi, indicativo di un invecchiamento accelerato. La scoperta amplia la cornice patofisiologica della malattia e aiuta a spiegare la maggiore fragilità sistemica, talvolta sproporzionata rispetto ai soli danni d’organo visibili.
Il passo successivo è stato verificare l’effetto dei modulatori di Cftr, farmaci di nuova generazione che agiscono sul difetto molecolare in modo mutazione-specifico. Dopo un
anno di trattamento con il modulatore appropriato, i pazienti hanno mostrato un miglioramento della funzionalità polmonare e, parallelamente, uno spostamento all’indietro delle lancette dell’orologio epigenetico. In altre parole, la terapia non solo incide sui parametri clinici e respiratori, ma riduce l’accelerazione dell’invecchiamento biologico.
Dal punto di vista clinico, il risultato suggerisce due ricadute immediate. La prima è la possibilità di utilizzare l’età epigenetica come biomarcatore per monitorare la risposta ai modulatori, integrando gli indici tradizionali (sintomi, prove di funzionalità respiratoria, stato nutrizionale). La seconda è la prospettiva di terapie sempre più personalizzate: la dinamica dell’orologio epigenetico potrebbe aiutare a scegliere e ottimizzare il modulatore più adatto al singolo profilo genetico e clinico, favorendo una medicina di precisione realmente misurabile. Non mancano però i punti aperti. Occorrerà capire quanto la reversione dell’età epigenetica si mantenga nel tempo e se riguardi in modo omogeneo i diversi organi. Serviranno coorti più ampie e multicentriche, con fasce d’età e genotipi Cftr differenti, per chiarire se l’effetto dei modulatori sia comparabile tra combinazioni mutazionali e stadi di malattia. Andrà inoltre valutato l’impatto di fattori ambientali e dell’infiammazione cronica, possibili modulanti dell’orologio.

La fibrosi cistica è una delle malattie genetiche ereditarie più frequenti nelle popolazioni europee e nordamericane. È causata da mutazioni del gene Cftr, che codifica per una proteina deputata al trasporto del cloro attraverso le membrane cellulari. Quando la proteina è difettosa, le secrezioni diventano dense e disidratate: nel polmone ostruiscono le vie aeree e favoriscono infezioni ricorrenti; a livello pancreatico compromettono la digestione e lo stato nutrizionale; in altri distretti contribuiscono alla disfunzione multiorgano tipica della malattia © aytuncucaroglu/shutterstock.com
In prospettiva, collegare in modo robusto l’orologio epigenetico agli esiti clinicamente rilevanti (riacutizzazioni, ospedalizzazioni, progressione radiologica e funzionale) permetterà di trasformare un indicatore molecolare in uno strumento decisionale. Se questi risultati verranno confermati, l’età epigenetica potrà diventare un endpoint intermedio nei trial e un supporto nella pratica clinica, contribuendo a pianificare percorsi terapeutici precisi e a razionalizzare l’uso delle risorse, anche in vista dell’accesso ai farmaci modulatori. Il lavoro del gruppo napoletano rafforza l’idea che la Fibrosi Cistica sia una condizione sistemica il cui decorso può essere modulato intervenendo sul difetto di base. Dimostrare che l’invecchiamento accelerato è, almeno in parte, reversibile significa restituire tempo biologico ai pazienti: un obiettivo che va oltre il controllo dei sintomi e allinea la cura con la promessa della medicina di precisione. Per clinici e decisori, un biomarcatore sensibile come l’orologio epigenetico indica una strada concreta verso terapie personalizzate, follow-up mirati e una migliore qualità di vita. (C. P.).
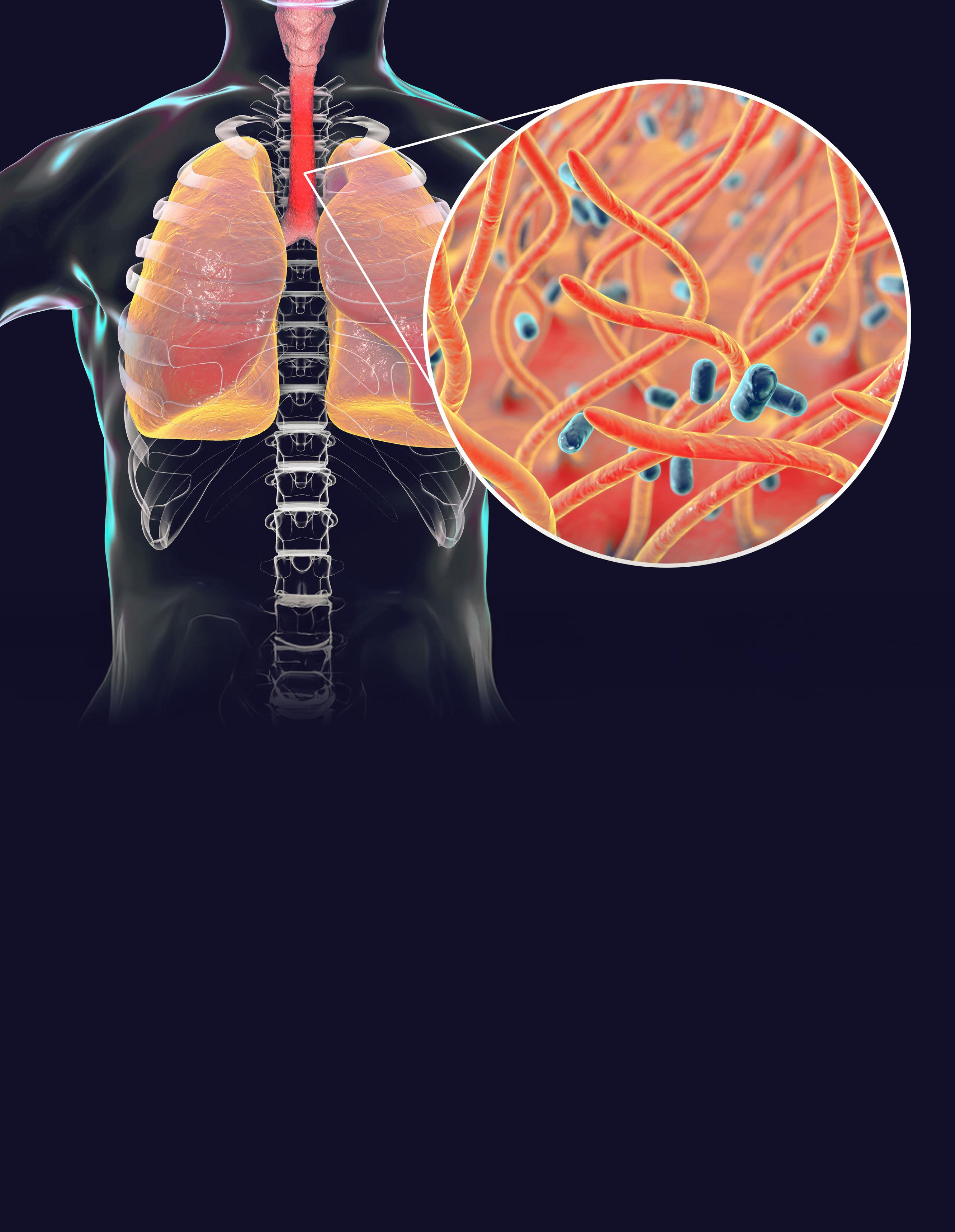
La fotografia dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze è preoccupante: nel 2024 ospedalizzazioni aumentate di nove volte rispetto al quadriennio 2016-2019, quali sono le cause
C’era chi la considerava una malattia del passato, un ricordo legato ad anni in cui le vaccinazioni non erano ancora diffuse e la tosse convulsa metteva in ginocchio famiglie intere. E invece la pertosse è tornata a farsi sentire e lo ha fatto con numeri preoccupanti. Nel 2024, i ricoveri di bambini e adolescenti sotto i 16 anni sono aumentati di nove volte rispetto al quadriennio 2016-2019. Non si tratta di un piccolo rialzo, ma di una crescita netta, fotografata con precisione dall’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, che ha raccolto e analizzato i dati ospedalieri per riportare l’attenzione su una malattia troppo spesso sottovalutata.
Il rapporto è chiaro: tra gennaio e dicembre 2024, 259 giovani pazienti sono stati ricoverati con una diagnosi confermata di pertosse. Un numero impressionante se confrontato con la situazione precedente, quando i casi erano relativamente contenuti e i picchi epidemici sembravano appartenere ad altri tempi. Ad allarmare gli esperti non è solo l’entità dell’aumento, ma anche il profilo dei malati. Per decenni, infatti, erano i neonati a rappresentare la fascia più fragile e colpita. Nel 2024, invece, più della metà dei ricoveri ha riguardato adolescenti tra i dieci e i 16 anni, un dato che segna un cambio di scenario e apre nuove domande sulla gestione della prevenzione.
Molti dei ragazzi ricoverati avevano infatti completato le vaccinazioni previste nell’infanzia, ma il tempo trascorso dalla somministrazione e i ritardi nei richiami hanno fatto la differenza. In Toscana, regione che vanta tassi di copertura vaccinale tra i più alti d’Italia, il 97,7% dei bambini di due anni e il 75,8% dei sedicenni risultano vaccinati contro la pertosse. Ma il dato, seppur positivo, nasconde una criticità: i vaccini non sono sempre stati somministrati nei tempi raccomandati. Nei neonati, i ritardi medi
per le prime tre dosi hanno superato un mese, mentre per gli adolescenti il richiamo consigliato a 12 anni è stato spesso rimandato, creando una finestra di esposizione alla malattia che in molti casi si è rivelata fatale.
Gli autori dello studio del Meyer sono stati chiari: «Il rispetto formale del calendario non è sufficiente. La somministrazione deve essere tempestiva». Perché basta poco, a volte un semplice rinvio, per aprire la porta al ritorno di malattie solo sulla carta sotto controllo. La pertosse non perdona, e il 2024 lo ha dimostrato con un’impennata di casi che ha sorpreso tutti.
Dietro i numeri ci sono poi le storie, quelle che restituiscono un volto concreto a un fenomeno che altrimenti rischierebbe di restare confinato nelle statistiche. Come quella di Andrea Vincenzi, dodicenne di Castiglione Torinese, morto lo scorso febbraio all’ospedale di Chivasso dopo tre accessi al pronto soccorso. Andrea era un giovane portiere, con la passione per il calcio e i sogni di una carriera tra i pali, che in pochi giorni ha perso la vita a causa di una pertosse non diagnosticata. Il suo caso ha scosso l’opinione pubblica e acceso un dibattito sull’adeguatezza delle procedure mediche. Due pediatre sono ora indagate per omicidio colposo, mentre la magistratura sta conducendo nuovi accertamenti per chiarire se siano stati commessi errori o se, come sostiene l’ospedale, i protocolli siano stati rispettati. La comunità di Castiglione lo ha ricordato con fiaccolate e iniziative di solidarietà, ma per i suoi genitori resta un dolore impossibile da lenire.
La vicenda di Andrea mostra quanto la pertosse possa essere insidiosa e difficile da riconoscere, soprattutto negli adolescenti. La tosse persistente e convulsa, che in un neonato accende immediatamente l’allarme, può essere scambiata per un’infezione comune nei ragazzi più grandi. Ed è proprio questo che, se -

Tra gennaio e dicembre 2024, 259 giovani pazienti sono stati ricoverati con una diagnosi confermata di pertosse. Ad allarmare gli esperti non è solo l’entità dell’aumento, ma anche il profilo dei malati. Per decenni, infatti, erano i neonati a rappresentare la fascia più fragile e colpita. Nel 2024, invece, più della metà dei ricoveri ha riguardato adolescenti tra i dieci e i 16 anni, un dato che segna un cambio di scenario e apre nuove domande sulla gestione della prevenzione
condo molti virologi, ha contribuito a far esplodere i casi del 2024. L’attenzione dei medici deve restare alta, perché la diagnosi precoce è la chiave per evitare complicazioni gravi e ricoveri prolungati.
Il ritorno della pertosse impone anche una riflessione sul ruolo delle vaccinazioni. L’Italia ha raggiunto negli anni risultati straordinari nella lotta a molte malattie infettive, ma l’esperienza del 2024 dimostra che non basta mantenere alte le percentuali: serve rispettare i tempi, rinforzare la comunicazione con le famiglie e sensibilizzare sull’importanza dei richiami. Alcuni esperti hanno sottolineato la necessità di intensificare le campagne di vaccinazione per le donne in gravidanza, così da trasferire una protezione immediata ai neonati nei primi mesi di vita, quando la malattia può avere conseguenze drammatiche.
La pertosse, in fondo, non è mai del tutto scomparsa. Era rimasta sotto traccia, con numeri bassi ma costanti, fino a quando il calo dell’immunità e la scarsa puntualità nelle vaccinazioni hanno creato le condizioni per la sua recrudescenza. Il 2024 deve quindi essere letto come un campanello d’allarme e non come un episodio isolato. La sanità italiana ha ora l’occasione di dimostrare di saper reagire anche di fronte a una malattia antica, evitando che si trasformi di nuovo in una minaccia diffusa. (D. E.).

Uno studio tedesco scopre come avviene il trasporto verso gli organuli cellulari e individua nuovi bersagli terapeutici per alcune malattie associate a queste molecole
Uno studio internazionale guidato dai ricercatori dell’Istituto Max Planck di Biologia Cellulare Molecolare e Genetica (MPI-CBG) di Dresda ha sviluppato un nuovo metodo di marcatura chimica per visualizzare i singoli lipidi all’interno delle cellule e ha scoperto come avviene il loro trasporto verso la membrana degli organuli a cui sono destinati.
Poiché uno sbilanciamento tra i tipi di lipidi presenti nelle cellule può determinare l’insorgere di malattie metaboliche e neurodegenerative, la nuova tecnica di imaging dei lipidi può accelerare ulteriori scoperte di nuovi bersagli farmacologici per le malattie associate a queste molecole, come per esempio la steatosi epatica non alcolica. Le cellule eucariotiche producono oltre
mille diverse specie di lipidi con diverse funzioni: regolare le proprietà delle membrane degli organuli interni, controllare la segnalazione, trasmettere informazioni e immagazzinare energia.
Il processo con cui il tipo di lipidi viene selezionato per mantenere le specifiche composizioni della membrana degli organuli è rimasto finora sconosciuto a causa della difficoltà di visualizzare il trasporto di tali molecole nelle cellule.
In particolare mancavano tecniche di microscopia in grado di tracciare con precisione la posizione dei lipidi e i loro movimenti nelle cellule.
Ora il team di Dresda ha superato questo limite grazie a nuova tecnica di marcatura chimica che permette di visualizzare utilizzando la microscopia a fluorescenza standard i singoli lipidi nelle cellule e tracciare il loro flusso verso le membrane degli organuli bersaglio.
«Abbiamo avviato il nostro progetto sintetizzando una serie di lipidi che rappresentano i tipi principali presenti nelle membrane degli organuli e che sono essenzialmente identici alle loro controparti native, con solo pochi atomi diversi che ci hanno permesso di tracciarli al microscopio» - spiega Kristin Böhlig, ricercatrice presso l’MPI-CBG di Dresda. I lipidi modificati imitano le molecole naturali e possono essere attivati dalla luce UV, causando il legame o la reticolazione del lipide con le proteine vicine.
Nello studio i ricercatori hanno utilizzato cellule umane in coltura, come cellule ossee o intestinali, poiché ritenute ideali per l’imaging. «Dopo il trattamento con la luce UV, siamo stati in grado di monitorare i lipidi con la microscopia a fluorescenza e di catturare la loro posizione nel tempo. Questo ci ha fornito un quadro completo dello scambio di lipidi tra la membrana cellulare e le membrane degli organuli» - conclude Kristin.
I ricercatori hanno poi combinato l’analisi delle immagini con la modellizzazione matematica associata all’intelligenza artificiale, realizzata da Björn Drobot presso l’Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR). Dai risultati è emerso che tra l’85% e il 95% del trasporto dei lipidi tra le membrane degli organuli cellulari è organiz -
zato da proteine trasportatrici che spostano i lipidi, piuttosto che da vescicole.
Questo trasporto non vescicolare è molto più specifico per quanto riguarda le singole specie di lipidi e la loro selezione nei diversi organuli della cellula.
Il team di Dresda ha anche scoperto che il trasporto dei lipidi da parte delle proteine è dieci volte più veloce rispetto a quello delle vescicole. Questi risultati implicano che la composizione lipidica delle membrane degli organuli è mantenuta principalmente attraverso un trasporto lipidico veloce, specifico per specie e non vescicolare.
Lo studio, pubblicato su Nature, ha compreso anche una serie di esperimenti paralleli portati avanti dal gruppo di Andrej Shevchenko dell’MPI-CBG con l’obiettivo di osservare, attraverso la spettrometria di massa ad altissima risoluzione, come i diversi lipidi cambiano la loro struttura durante il trasporto dalla membrana cellulare alla membrana degli organuli.
Alf Honigmann, autore dello studio e responsabile del gruppo di ricerca presso il Biotechnology Center di Dresda, afferma: «La nostra tecnica di imaging dei lipidi consente l’analisi meccanicistica del trasporto e della funzione dei lipidi direttamente nelle cellule, cosa che prima era impossibile. Riteniamo che il nostro lavoro apra le porte a una nuova era nello studio del ruolo dei lipidi all’interno della cellula».
André Nadler, autore responsabile della ricerca, a capo del gruppo di ricerca presso l’MPI-CBG, sottolinea l’importanza che hanno avuto la nascita e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il loro studio: «Prima della rivoluzione nell’uso dell’intelligenza artificiale nella segmentazione delle immagini, non saremmo stati in grado di quantificare correttamente i dati di imaging, quindi le nostre conclusioni sarebbero state molto più limitate».
Ai ricercatori resta ancora molto lavoro da fare, a partire da determinare quali proteine di trasferimento dei lipidi guidano il trasporto selettivo delle diverse specie.
Devono inoltre identificare le fonti di energia che alimentano il trasporto e garantiscono che ogni organello mantenga la propria unica composizione della membrana. (S. B.).

Uno sbilanciamento tra i tipi di lipidi presenti nelle cellule può determinare l’insorgere di malattie metaboliche e neurodegenerative, la nuova tecnica di imaging dei lipidi può accelerare ulteriori scoperte di nuovi bersagli farmacologici per le malattie associate a queste molecole, come per esempio la steatosi epatica non alcolica

Una variante genetica ereditata dai Denisoviani ha consentito all’essere umano di sopravvivere al gelo e migrare in America
Circa 20mila anni fa la Terra si trovava nel picco massimo della sua ultima glaciazione, nota come glaciazione di Würm. In questo passato dai tratti ancestrali tribù di esseri umani incedevano a passi lenti per le desolazioni bianche che caratterizzavano il mondo, provati dai morsi del freddo e dalle intemperie di un clima ostile, alla ricerca di luoghi sicuri e più adatti alla sopravvivenza.
Ma come ha fatto quindi l’uomo, che allora era già Homo sapiens, a sopravvivere in quest’ultima era glaciale? Ebbene, oltre all’ingegno
e all’innata capacità di adattamento propria di ogni essere vivente, la risposta potrebbe trovarsi anche nel suo, nonché nostro, DNA. Un recente studio dell’Università del Colorado Boulder, pubblicato sulla rivista Science e rilanciato da Sky TG24, ha identificato una variante del gene MUC19, il quale avrebbe aiutato gli esseri umani a resistere al freddo estremo durante la migrazione attraverso lo stretto di Bering.
Il gene in questione regola la produzione di mucine, delle proteine che formano il muco e proteggono i tessuti da agenti patogeni. La varian -
te scoperta è ereditata da una specie di ominidi estinta, i Denisoviani, che si è incrociata con gli uomini di Neanderthal e, successivamente, con l’Homo sapiens. Oggi è presente soprattutto tra le popolazioni indigene delle Americhe, con una diffusione significativa in Messico, mentre in Europa è quasi assente. Secondo i ricercatori, questa mutazione avrebbe migliorato la resistenza immunitaria e le capacità di adattamento a climi rigidi, contribuendo alla colonizzazione di ambienti ostili. Il tratto genetico denisoviano è circondato da sequenze di DNA neanderthaliano, che sono il segno di una storia evolutiva complessa e molto stratificata.
Il team di scienziati guidato da Fernando Villanea e David Peede ha analizzato migliaia di genomi umani, evidenziando come la selezione naturale abbia favorito la diffusione della variante in ambienti dove il freddo e le infezioni respiratorie rappresentavano una minaccia costante per l’essere umano. I Denisoviani, identificati per la prima volta nel 2010 grazie ai resti dei fossili ritrovati nella grotta di Denisova in Siberia, sono ancora poco conosciuti, ma il loro contributo per la scoperta della storia genetica della nostra specie si sta rivelando più importante delle previsioni degli esperti.
È chiaro, dunque, come la scoperta del gene MUC19 apra a nuove prospettive sulla comprensione dell’evoluzione umana, nonché sulle differenze e peculiarità stabilitesi a seguito delle antiche migrazioni.
Con ogni probabilità, nel nostro genoma ci sono ancora tante altre risposte che aspettano di essere codificate. E se mi fosse concesso concludere con un’ambiziosa considerazione, direi che la genetica, più di ogni altra scienza, è forse l’unica in grado di raccontarci il vero romanzo della vita, che non ci spiega soltanto quello che siamo oggi, ma anche come siamo riusciti a diventarlo. (M. O.).
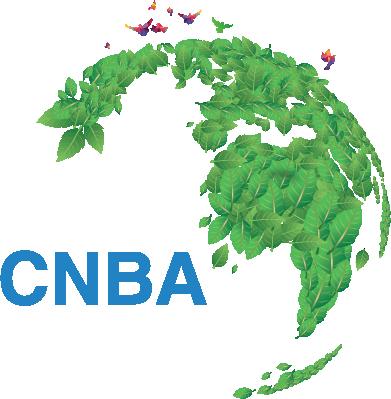
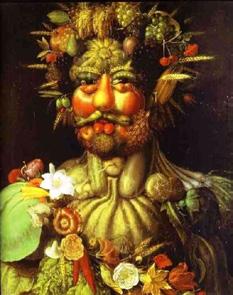
Scelte alimentari e stile di vita influenzano il destino genetico e la salute cellulare

di Giuseppe Passarino*
Negli ultimi anni sta crescendo molto l’attenzione verso l’epigenetica, cioè quella branca della biologia che studia le modifiche chimiche e strutturali del DNA e delle proteine che lo avvolgono, senza alterarne la sequenza. Queste modifiche determinano quali geni saranno “accesi” o “spenti” nelle cellule in un determinato periodo influenzando l’espressione genica, contribuendo allo sviluppo, al funzionamento e alla salute dell’organismo.
Si sta infatti comprendendo che il destino di ogni essere umano non dipende esclusivamente dalla sequenza dei geni che eredita dai propri genitori, ma anche da come l’epigenetica modula l’espressione del suo DNA. Poiché tali modificazioni epigenetiche sono influenzate dall’ambiente in cui viviamo e dalle esperienze che facciamo nel corso della vita, è evidente che l’idea che il nostro destino sia scritto nel nostro DNA deve essere superata. In altre parole, non pos-
*Professore di Genetica, Direttore del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’ Università della Calabria
siamo cambiare i nostri geni, ma possiamo influenzare il loro funzionamento.
A livello molecolare, i processi epigenetici più studiati sono:
• La metilazione del DNA, cioè l’aggiunta di gruppi metilici in regioni specifiche del DNA, con conseguente attivazione o repressione dei geni metilati.
• La modifica degli istoni, cioè delle proteine attorno alle quali il DNA si avvolge, che ne regolano l’accessibilità e quindi la trascrizione.
• L’attività di piccole molecole di RNA non codificanti (es. microRNA) che regolano l’espressione genica post-trascrizionale.
L’alimentazione come modulatore dell’epigenoma
L’alimentazione è uno dei principali fattori ambientali in grado di modulare l’epigenoma umano. Le sostanze presenti negli alimenti possono infatti agire direttamente su alcuni enzimi
responsabili delle modificazioni epigenetiche oppure fornire substrati necessari, come i gruppi metilici, fondamentali per i processi epigenetici. Un esempio affascinante viene dal mondo delle api: tutte le api di un alveare hanno un corredo genetico simile, ma quelle nutrite con pappa reale diventano regine fertili, mentre le altre diventano api operaie sterili. Anche negli esseri umani l’alimentazione ha effetti profondi. È stato dimostrato che la carenza di vitamina B12 in gravidanza (che insieme alle altre vitamine del gruppo B è un donatore di gruppi metilici) influenza la metilazione di geni
specifici, predisponendo in età adulta a disturbi metabolici e cardiovascolari.
Un caso molto studiato è la carestia in Olanda nell’inverno 1943-1944. È evidente che le donne incinte in quel periodo soffrirono di importanti carenze alimentari. I bambini nati da quelle gravidanze hanno portato i segni di tale evento catastrofico. Infatti, essi hanno sofferto, da adulti, di malattie cardiovascolari in misura maggiore rispetto ai bambini nati in precedenza o subito dopo. Le modifiche epigenetiche indotte in questo caso dall’assenza di alcuni nutrienti tendono quindi a persistere nel tempo, soprattutto se la disponibilità di tali nutrienti si verifica in corrispondenza di periodi critici dello sviluppo come, ad esempio, durante la vita intrauterina o l’infanzia, stabilendo schemi di espressione genica stabili e duraturi.
Non solo la nutrizione, ma anche lo stile di vita da adulti modula l’epigenoma. L’attività fisica è infatti associata ad un’età epigenetica (biologica) di diversi anni più bassa rispetto all’età cronologica dell’individuo che la pratica. Alcuni composti come i polifenoli (specialmente quelli presenti nel tè verde e nella curcuma) influenzano l’espressione di geni legati al metabolismo energetico, comportandosi quindi come fattori anti-obesità.
Studi recenti hanno osservato che una dieta basata su cibi prevalentemente vegetali nell’età adulta (tra i 30 ed i 65 anni) e/o l’adozione di un regime di digiuno intermittente (digiuno di 16 ore, ad esempio dalle 16 alle 8 del giorno dopo) o di digiuno periodico (cinque giorni di una dieta mima digiuno con circa 6-700 chilocalorie al giorno) possono portare a un miglioramento dei parametri vitali molto significativo e ad un ringiovanimento complessivo dell’organismo. È probabile che questi benefici siano legati a meccanismi epigenetici e diversi gruppi di ricerca stanno lavorando per identificare in maniera precisa le regioni genomiche coinvolte.

L’alimentazione è uno dei principali fattori ambientali in grado di modulare l’epigenoma umano. Le sostanze presenti negli alimenti possono infatti agire direttamente su alcuni enzimi responsabili delle modificazioni epigenetiche oppure fornire substrati necessari, come i gruppi metilici, fondamentali per i processi epigenetici
Nutrienti ed epigenetica del cancro
Sostanze come la curcumina (presente nella curcuma), la genisteina (soia) e i composti solforati (aglio, cipolla) sono state studiate per la loro capacità di modulare lo stato di metilazione di regioni particolarmente rilevanti per la regolazione dell’espressione del nostro genoma (introni ed enhancer), favorendo l’apoptosi delle cellule alterate piuttosto che la loro trasformazione in cellule tumorali. Anche in questo caso, diversi studi in corso stanno cercando di identificare quali siano regioni genomiche coinvolte con l’obiettivo di progettare farmaci (“epifarmaci”) che, mimando l’azione di tali sostanze, siano in grado di modificare lo stato di metilazione di tali regioni esercitando così un effetto antitumorale.
Microbiota ed epigenetica
Un altro ambito di ricerca molto affascinante riguarda lo studio dell’interazione tra microbiota intestinale ed epigenoma. Una flora equilibrata favorisce la produzione di vitamine del gruppo B, indispensabili per i processi di metilazione, e di acidi grassi a catena corta che modulano gli istoni, promuovendo l’eliminazione delle cellule senescenti mediante apoptosi.
In conclusione, nella definizione della nostra dieta e del nostro stile di vita, non contano solo calorie, grassi e zuccheri: è fondamentale considerare anche l’effetto che i diversi nutrienti esercitano sull’epigenoma. Comprendere come “accendere” o “spegnere” i nostri geni attraverso alimentazione e comportamenti salutari rappresenta quindi una delle sfide più promettenti per migliorare la nostra salute ed il nostro benessere.

L’eccesso di peso accelera l’atrofia cerebrale, con implicazioni che ricordano l’Alzheimer A rivelarlo è il più grande studio internazionale sul legame tra massa corporea e salute cognitiva

di Elisabetta Gramolini
Un peso corporeo eccessivo, in particolare il sovrappeso e l’obesità, è associato a un invecchiamento accelerato del cervello e a una maggiore atrofia cerebrale. Questa scoperta, emersa dal più ampio studio internazionale condotto finora sul rapporto tra i chili in più e la salute delle nostre cellule grigie, ha rivelato una correlazione particolarmente marcata tra gli uomini. Pubblicato sulla rivista eBioMedicine, il lavoro ha coinvolto un campione eccezionalmente vasto, composto da oltre 46mila persone partecipanti a 15 diversi progetti di ricerca.
I ricercatori hanno impiegato tecniche avanzate di imaging cerebrale e algoritmi sofisticati di apprendimento automatico per analizzare i casi di individui classificati come sovrappeso o obesi, ma che, al momento dell’analisi, non presentavano diagnosi di deficit cognitivi. L’obiettivo primario era comprendere se l’eccesso di peso potesse contribuire, in modo subdolo e silenzioso, all’invecchiamento cerebrale o a una perdita di volume cerebrale che presentasse somiglianze con quella osservata nella malattia di Alzheimer.
«Dall’analisi approfondita di questo ampio campione di risonanze magnetiche cerebrali è emerso che c’è una connessione tra lo stato di obesità e l’invecchiamento del cervello: un fenomeno più marcato tra gli uomini che tra le donne, e con effetti che diminuiscono con l’avanzare dell’età» - ha spiegato Filippos
cardiovascolari e renali che, unitamente all’invecchiamento generale della popolazione, mettono a serio rischio la salute di un numero sempre crescente di individui. È ormai un dato assodato che un aumento di peso significativo nell’età adulta è correlato a un rischio più elevato di sviluppare diverse forme di demenza. Si ipotizza che un elevato indice di massa corporea possa influire negativamente sull’integrità del cervello, portando all’atrofia della sostanza grigia e bianca e compromettendo la solidità dei circuiti neurali. Tuttavia, i meccanismi biologici precisi alla base di questi fenomeni non sono ancora del tutto chiari.

Si ipotizza che un elevato indice di massa corporea possa influire negativamente sull’integrità del cervello, portando all’atrofia della sostanza grigia e bianca e compromettendo la solidità dei circuiti neurali. Tuttavia, i meccanismi biologici precisi alla base di questi fenomeni non sono ancora del tutto chiari
Anagnostakis, primo autore dello studio. Anagnostakis, ricercatore affiliato presso la University of Pennsylvania e la Columbia University e neolaureato in Medicina dell’Università di Bologna, ha condotto questa ricerca innovativa durante il suo percorso di studi all’Alma Mater, collaborando con illustri studiosi di diversi atenei statunitensi, tra cui l’Università di Harvard e l’Università della California - San Francisco.
«I risultati che abbiamo ottenuto - ha aggiunto il ricercatore - sono un’opportunità preziosa di riflessione: ci invitano a ripensare l’impatto dell’obesità non solo dal punto di vista estetico, ma anche in relazione alla salute cerebrale».
L’obesità è ormai ampiamente riconosciuta come una vera e propria epidemia globale del nostro secolo. Le stime attuali indicano che entro il 2025 oltre la metà della popolazione adulta mondiale sarà in sovrappeso o obesa. A questa condizione sono associati numerosi disordini metabolici,
Per cercare di far luce su questa complessa connessione tra sovrappeso, obesità e salute cerebrale, gli studiosi hanno analizzato le risonanze magnetiche cerebrali sul campione. «I dati mostrano che un peso corporeo eccessivo è associato a un invecchiamento accelerato del cervello e a una maggiore atrofia cerebrale - ha ribadito Anagnostakis -, rispetto a chi ha un peso normale: cambiamenti cerebrali che possono assomigliare a quelli osservati nelle fasi iniziali della malattia di Alzheimer».
Il ricercatore ha inoltre specificato l’impatto differenziato tra i sessi: «Questo vale in particolare per gli uomini, quelli in sovrappeso mostravano un cervello che appariva ‘più vecchio’ di circa otto mesi, mentre in quelli con obesità, l’invecchiamento cerebrale era di circa due anni superiore rispetto ai coetanei con peso normale».
Un quadro diverso, e per certi versi sorprendente, è emerso per quanto riguarda le donne. Dall’indagine è risultato infatti che le donne con peso normale mostrano più segni di invecchiamento cerebrale e di atrofia simile a quella dell’Alzheimer rispetto alle donne in sovrappeso e persino rispetto agli uomini con peso normale. «Sappiamo che la differenza di sesso influisce in modo diverso sul rischio di sviluppare forme di demenza, ma restano da capire i percorsi che provocano queste disparità» - ha commentato Anagnostakis sottolineando la complessità delle interazioni biologiche.
Un altro elemento centrale emerso dallo studio è quello dell’età. L’impatto del peso corporeo sull’invecchiamento del cervello si è rivelato infatti più marcato nei soggetti più giovani, mentre tendeva ad attenuarsi con l’avanzare dell’età. Ciò suggerisce che l’intervento precoce sul peso corporeo potrebbe avere un’importanza cruciale per la prevenzione del declino cognitivo.

Il supporto nutrizionale personalizzato migliora la qualità della vita la risposta alle terapie e riduce il rischio di complicanze
Spesso gli aspetti nutrizionali sono più trascurati rispetto ad altre attività cliniche tipicamente associate al trattamento dei tumori.
Oramai è sempre più acclarata la necessità imprescindibile di dover ricorrere a supporto nutrizionale nella stragrande maggioranza dei pazienti con diagnosi di tumori del distretto testa-collo, prima di qualsivoglia procedura terapeutica.
Un corretto “intervento” nutrizionale deve iniziare prima dei trattamenti e continua durante e dopo, tenendo conto della necessità di un adeguato e personalizzato apporto calorico e composizione dei nutrienti. Tale necessità si riscontra soprattutto in pazienti con neoplasie in fase non precoce, dato il rischio notevole di malnutrizione che caratterizza il paziente con patologia in fase localmente avanzata e ricorrente/metastatica.
La malnutrizione è di solito multifattoriale e solo in parte dipende dalla disfagia associata alla presenza della neoplasia di per sé.
Ogni paziente oncologico dovrebbe essere sottoposto a screening nutrizionale entro quattro settimane dalla diagnosi al massimo.
Screening dello stato nutrizionale
Test di esecuzione rapida e semplice da fare entro 48h dal primo contatto con il paziente.
Obiettivi:
• Individuare il paziente a rischio nutrizionale, in considerazione delle condizioni attuali e/o future
• Avviare il paziente ad una valutazione dello stato nutrizionale più approfondita e ad un protocollo di trattamento adeguato
Gli strumenti validati nello scree-
* Biologo nutrizionista
ning dello stato nutrizionale sono:
• Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)
• Malnutrition Screening Tool (MST)
• Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002)
• Mini Nutritional Assessment Short Form-Revised (MNASF)
Gli strumenti per la valutazione della composizione corporea sono:
• Antropometria (pliche cutanee e circonferenze degli arti)
• Bioimpedenziometria (BIA)
• CT scan L3
• Dual X-ray absorptiometry (DEXA)
Finalità della terapia nutrizionale nel paziente oncologico
• Prevenire - trattare la malnutrizione (con le relative conseguenze)
• Migliorare la tolleranza alla terapia antitumorale
• Migliorare la qualità di vita
Pertanto è assolutamente necessario:
1. una precoce valutazione con validati questionari del rischio di malnutrizione
2. una valutazione del grado di malnutrizione
3. un accurato programma nutrizionale da iniziare il più precocemente possibile e da associare al trattamento oncologico.
Al momento della diagnosi, i pazienti affetti da tumori del distretto testa-collo presentano spesso una variabile compromissione della qualità di vita e dello stato di nutrizione, parametri che possono peggiorare nel corso dei trattamenti. È anche noto che uno stato di nutrizione alterato in maniera grave possa essere associato a una maggiore mortalità e a una più frequente necessità di sospendere i trattamenti oncologici.
• 40-57% dei pazienti affetti da tumore testa-collo al momento della diagnosi presenta proble-
matiche relative a deficit nutrizionali/capacità di alimentarsi
• 30% disfagia al momento della diagnosi
• La prevalenza di un calo ponderale “critico”, quale indicatore di malnutrizione, ossia di una perdita di peso involontaria ≥ 5% nell’ultimo mese o ≥ 10% negli ultimi 6 mesi, varia al momento della diagnosi dal 30 al 55%
• Anoressia e Cachessia associate a riduzione della massa muscolare e del tessuto adiposo - “sindrome da cachessia neoplastica” (con sintomi tipo anoressia, avversione per il cibo, disgeusia, oltre ad un incremento del metabolismo basale)
• Ripercussioni sulla qualità e quantità dell’alimentazione e variabilità della dieta
• Peggioramento della qualità di vita
I tumori testa collo hanno un impatto su molte funzioni della vita di tutti i giorni (sede, estensione neoplasia):
1. Masticatoria
2. Deglutitoria
3. Fonetica
4. Respiratoria
5. Funzioni sensoriali: propriocezione, dolore, gusto, olfatto
Diverse figure professionali sono necessariamente coinvolte nel percorso diagnostico, terapeutico e riabilitativo del paziente affetto da neoplasie del distretto testa e collo.
La valutazione dovrebbe essere completata richiedendo l’intervento di uno specialista logopedista in caso di presenza di aspirazione o di rischio che il trattamento stesso induca problematiche disfagiche.
La nutrizione di qualità nei trattamenti per i tumori di testa e collo non è solo prevenzione, ma rappresenta anche una vera e propria terapia di supporto, fondamentale nel percorso
oncologico, in quanto gioca un ruolo importante per:
1. Prevenzione delle complicanze
Durante i trattamenti oncologici (radioterapia, chemioterapia o chirurgia), i pazienti con tumori di testa e collo vanno spesso incontro a:
• Disfagia, mucositi, xerostomia - difficoltà nell’alimentazione
• Perdita di peso significativaspesso >10% del peso corporeo
• Malnutrizione o cachessiacondizioni che aumentano la tossicità del trattamento e ne riducono l’efficacia
Una nutrizione adeguata previene queste complicanze, riducendo il rischio di interruzione dei trattamenti o di ridotta risposta terapeutica
2. Supporto attivo alla terapia
Una nutrizione corretta ha effetti terapeutici perché:
• Migliora la risposta immunitaria
• Supporta la rigenerazione dei tessuti
• Riduce il rischio di infezioni
• Migliora tolleranza e aderenza ai trattamenti oncologici
• Favorisce un miglior decorso post-operatorio nei pazienti sottoposti a chirurgia
3. Ruolo nella riabilitazione
Nel post-trattamento, la nutrizione è parte integrante della riabilitazione funzionale:
• Favorisce il recupero della funzione deglutitoria
• Aiuta a ricostruire massa muscolare
• Contribuisce alla qualità della vita e alla riduzione della fatigue
È possibile riscontrare uno stato di malnutrizione sia per eccesso sia per difetto. La malnutrizione per difetto, in particolare, è determinata da una profonda discrepanza tra i fabbisogni
nutrizionali specifici e la reale utilizzazione dei nutrienti assunti. Uno dei più comuni tipi di malnutrizione è la malnutrizione proteico-energetica.
In presenza di una patologia come una neoplasia, una malnutrizione importante può sfociare in un quadro di cachessia, una grave forma di deperimento che ha forti effetti negativi sulla qualità di vita e sugli esiti delle cure. Nel paziente affetto da neoplasia, una grave perdita di peso dipende da vari fattori ed è associata ad una diminuita sopravvivenza, ad una scarsa risposta e/o tolleranza ai trattamenti radioterapici e chemioterapici, ad una ridotta qualità di vita, ad una più alta incidenza e durata di ospedalizzazione.

Recenti ricerche mostrano che la dieta mediterranea, che si avvantaggia del consumo regolare di frutta e verdura, cereali, legumi, latte e yogurt, olio di oliva, pesce e uova, basso apporto di carne, limitato consumo di dolci e moderate quantità di vino durante i pasti, può favorire la riduzione dei rischi di sviluppare un tumore nel distretto della testa e collo
Un ruolo determinante è svolto dall’ipofagia, cioè dalla riduzione dell’assunzione di cibo, che può dipendere dall’impedimento nell’alimentazione naturale a causa di un’ostruzione meccanica, dagli effetti collaterali dei trattamenti o alla perdita di appetito, nota come anoressia
neoplastica. Oltre che dalla ridotta assunzione di alimenti, tuttavia, le modifiche dello stato nutrizionale possono essere causate anche da alterazioni legate a come il metabolismo processa i nutrienti introdotti attraverso l’alimentazione.
Va infine considerata una marcata riduzione della massa muscolare, che si manifesta come astenia, ridotta funzione fisica, riduzione della qualità della vita, fino a una progressiva inabilità. Gli effetti della malnutrizione sono evidenti dal fatto che circa l’80% delle persone colpite da un tumore avanzato va incontro a cachessia e il 30% dei pazienti muore per le gravi conseguenze della malnutrizione.
A testimonianza dell’importanza che il supporto nutrizionale sta acquistando per i pazienti, negli ultimi anni molte società scientifiche e associazioni si sono impegnate nel produrre e diffondere materiale informativo sulla nutrizione in oncologia.
Eziologia della malnutrizione
Caratteristiche legate al paziente:
• Basso livello socio-economico
• Sesso maschile
• Età avanzata
• Dentizione scadente o edentulia
• Solitudine
• Abuso di alcol e fumo
Caratteristiche legate alla malattia:
• Localizzazione del tumore
• Stadio della malattia
Caratteristiche dei trattamenti:
• Trattamento radiante (tossicità acuta e tardiva: mucositi, infezioni alterazioni del gusto e ridotta salivazione, dolore, problematiche dentali, osteonecrosi)
• Trattamento chemioterapico (nausea, vomito)
• Trattamento chirurgico (alterazioni anatomiche e funzionali,
tracheotomia)
I pazienti che sono stati sottoposti a chirurgia e presentano un deficit nutrizionale vanno più facilmente incontro a complicanze (fistole, infezione della ferita chirurgica, sepsi, infezioni polmonari con aumento dei tempi di ospedalizzazione).
Il 57% dei pazienti con tumore del distretto testa-collo muore per le conseguenze dirette ed indirette della malnutrizione.
Le cause del dimagrimento dei pazienti con tumore del distretto testa-collo può essere dovuto sia alla malattia stessa per sintomi e sede interessata, ma anche al trattamento a cui il paziente viene sottoposto, che causa dolore, bruciore e difficoltà alla deglutizione. Infatti, tenendo conto di queste osservazioni, sono stati evidenziati 5 fattori prognostici per poter valutare fin dall’inizio il rischio di sviluppare questa complicanza in corso o dopo radioterapia:
• Stadio di malattia e grandezza del tumore (peggio se tumori grandi, T3-T4)
• Sede di radioterapia (peggio se interessa il collo da entrambi i lati)
• Perdita di peso precedente all’avvio delle cure
• Tipo di trattamento in programma (peggio se radioterapia accelerata e chemio-radioterapia concomitante)
• Sede di malattia (peggio se tumore del rinofaringe)
• Pertanto, è estremamente importante che il paziente con queste problematiche si sottoponga a visita nutrizionale prima-dopo e durante i trattamenti, in modo che il suo stato nutrizionale venga valutato in modo soggettivo e oggettivo mediante parametri specifici allo scopo di individuare il rischio o la presenza di una malnutrizione grave o moderata e/o di disfagia e adottare misu-
re atte a supportare il paziente e a ridurre il più possibile il rischio o l’entità della malnutrizione.
Dieci diversi studi hanno analizzato la necessità per questi pazienti di essere seguiti dal nutrizionista, al fine di garantire una nutrizione adeguata, in particolare monitorando l’introito energetico e proteico, per migliorare la qualità della vita del paziente e prevenirne l’ingresso in uno stato di deperimento, ma anche per aumentare le possibilità di successo delle terapie. È noto, infatti, che su un soggetto normopeso è possibile somministrare dosi di farmaco più elevate rispetto a uno sottopeso e anche i possibili effetti collaterali delle terapie, come ad esempio le infezioni, sono ridotti in un paziente che sia adeguatamente supportato dal punto di vista nutrizionale.
In alcune situazioni più gravi, quando ad esempio l’astensione dal cibo è prolungata o l’introito non è sufficiente a coprire almeno una determinata quota del fabbisogno, il medico può intervenire procedendo con la nutrizione artificiale, enterale (sondino nasogastrico o gastrostomia/digiunostomia endoscopica percutanea) e/o parenterale (periferica o centrale).
La nutrizione nei tumori di testa e collo non è solo prevenzione, ma ha un ruolo terapeutico cruciale.
Recenti ricerche mostrano che la dieta mediterranea, che si avvantaggia del consumo regolare di frutta e verdura, cereali, legumi, latte e yogurt, olio di oliva, pesce e uova, basso apporto di carne, limitato consumo di dolci e moderate quantità di vino durante i pasti, può favorire la riduzione dei rischi di sviluppare un tumore nel distretto della testa e collo. In presenza di tumori del distretto testa/collo sono utili alcuni consigli alimentari:
• il frazionamento dei pasti, cioè il consumo ridotto e frequente di pasti;
• l’utilizzo di cibi ammorbiditi;
• il bere molta acqua durante la giornata;
• il consumo di cibi che in un volume ridotto forniscano molta energia all’organismo;
• evitare/limitare cibi molto secchi, speziati, acidi, aspri e salati;
• evitare/limitare caffeina e alcolici.
In alcune situazioni più gravi, quando ad esempio l’astensione dal cibo è prolungata o l’introito non è sufficiente a coprire almeno una determinata quota del fabbisogno, si può intervenire procedendo con la nutrizione artificiale, enterale (sondino nasogastrico o gastrostomia/digiunostomia endoscopica percutanea) e/o parenterale (periferica o centrale).
L’approccio nutrizionale va pianificato in modo personalizzato e multidisciplinare, insieme a oncologi, nutrizionisti e logopedisti.
1. Muscaritoli M1, Lucia S1, Farcomeni A2, Lorusso V3, Saracino V3, Barone C4, Plastino F4, Gori S5, Magarotto R5, Carteni G6, Chiurazzi B6, Pavese I7, Marchetti L7, Zagonel V8, Bergo E8, Tonini G9, Imperatori M9, Iacono C10, Maiorana L10, Pinto C11, Rubino D11, Cavanna L12, Di Cicilia R12, Gamucci T13, Quadrini S13, Palazzo S14, Minardi S14, Merlano M15, Colucci G16, Marchetti P17,18; PreMiO Study Group. Prevalence of malnutrition in patients at first medical oncology visit: the PreMiO study. Oncotarget. 2017 Aug 10;8(45):79884-79896. doi: 10.18632/oncotarget.20168. eCollection 2017 Oct 3.
2. Capuano G1, Gentile PC, Bianciardi F, Tosti M, Palladino A, Di Palma M. Prevalence and influence of malnutrition on quality of life and performance status in patients with locally advanced head and neck cancer before treatment. Support Care Cancer. 2010 Apr;18(4):433-7. doi: 10.1007/s00520009-0681-8.
3. Leistra E1, van Bokhorst-de van der Schueren MA2, Visser M3, van der Hout A4, Langius JA2, Kruizenga HM5. Systematic screening for undernutrition in hospitals: predictive factors for success. Clin Nutr. 2014 Jun;33(3):495-501. doi:10.1016/j.clnu.2013.07.005

Cibo che Cura” è una guida pratica essenziale dedicata alla nutrizione e alle terapie di supporto durante il percorso della malattia oncologica
Questo libro prezioso offre informazioni dettagliate sulla corretta alimentazione, presentando un approccio completo attraverso una chiara suddivisione dei gruppi alimentari: cereali, proteine, verdura e frutta.
Il testo, curato da esperti del settore , fornisce consigli pratici e strategie nutrizionali specifiche per supportare il paziente durante il trattamento. La guida è arricchita da illustrazioni intuitive che rendono i concetti facilmente comprensibili, permettendo ai lettori di fare scelte alimentari consapevoli e appropriate per il loro percorso di cura. Un riferimento indispensabile per pazienti, familiari e operatori sanitari che desiderano approfondire il ruolo fondamentale dell’alimentazione nel processo terapeutico.
Il libro è acquistabile in libreria o su Amazon al costo di €15, parte del ricavato verrà devoluto alla FNOB, per sostenere la formazione di Biologi Nutrizionisti in ambito oncologico.



Studio su Nature (Duke): la proteina attiva neuropod intestinali, segnala al nervo vagale e riduce l’assunzione; implicazioni per obesità e disturbi mentali © Inkoly/shutterstock.com

Èormai acquisito che intestino e cervello comunichino tramite vie endocrine, immunitarie e neurali. Meno noto, finora, era se l’ospite potesse percepire in tempo reale i segnali dei microbi e convertirli subito in cambiamenti del comportamento alimentare. Un nuovo studio della Duke University, pubblicato su Nature, dimostra l’esistenza di un canale dedicato: un senso neurobiotico che trasforma un segnale batterico in un impulso nervoso verso il tronco encefalico, riducendo l’assunzione.
La chiave è la flagellina, proteina dei flagelli batterici. Dopo il pasto, alcuni batteri intestinali rilasciano flagellina nel lume del colon. Qui si trovano cellule epiteliali specializzate, affini alle enteroendocrine, dette cellule neuropod, che formano sinapsi con le fibre sensoriali del nervo vago. Queste cellule esprimono TLR5, un recettore conservato che riconosce la flagellina.
La sua attivazione induce il rilascio di PYY, che si lega a NPY2R sulle terminazioni vagali. Ne risulta un segnale afferente che viaggia verso il nucleo del tratto solitario e coinvolge i centri ipotalamici della sazietà.
Gli autori dello studio collegano in modo causale l’intera catena, dal lume intestinale al cervello, integrano strumenti di: biologia molecolare, imaging, registrazioni neurali, manipolazioni genetiche e interventi mirati. L’infusione colica di flagellina riduce l’intake entro pochi minuti, indicando che il solo pattern molecolare è sufficiente ad avviare la risposta. Il controllo di variabili metaboliche e infiammatorie supporta una via neurale diretta.
La specificità anatomica e recettoriale è verificata con approcci di perdita e guadagno di funzione: l’ablazione di TLR5 nelle neuropod PYY+ attenua la risposta, promuove iperfagia e aumento di peso; l’attivazione optogenetica del circuito produce un chiaro segnale di sazietà; il blocco di NPY2R ne riduce l’effetto. Registra-

Modulare il percorso TLR5-PYY-vago potrebbe offrire strategie contro l’obesità, riducendo l’iperfagia senza intervenire direttamente sui circuiti della ricompensa. Diete o probiotici che modificano la flagellina colica potrebbero ricalibrare l’appetito; farmaci diretti a NPY2R o PYY potrebbero rafforzare la sazietà in modo più fisiologico
zioni extracellulari identificano unità vagali sensibili alla flagellina.
Questo quadro sposta l’asse microbiota-cervello da una visione soprattutto infiammatoria a una prospettiva percettiva: alcuni segnali microbici si comportano come veri stimoli sensoriali, captati da un organo epiteliale e tradotti in impulsi nervosi integrati nei circuiti centrali che governano l’alimentazione. In termini evolutivi, il meccanismo potrebbe consentire all’ospite di tarare l’appetito sulla composizione microbica post-prandiale, frenando l’assunzione quando il lume indica abbondanza. In sostanza, il microbiota invia telemetria in tempo reale ai centri della regolazione energetica.
Se una via analoga fosse presente nell’uomo, modulare il percorso TLR5-PYY-vago potrebbe offrire strategie contro l’obesità, riducendo l’iperfagia senza intervenire direttamente sui circuiti della ricompensa. Diete o probiotici che modificano la flagellina colica potrebbero ricalibra-
re l’appetito; farmaci diretti a NPY2R o PYY potrebbero rafforzare la sazietà in modo più fisiologico. Gli studiosi mostrano cautela in quanto la flagellina è anche un potente ligando immunitario e il contesto mucosale ne condiziona gli esiti. Differenze di dieta, anatomia e innervazione richiedono studi clinici con misure integrate (ormoni intestinali, neuroimmagini del tronco, marcatori autonomici) per quantificare l’impatto su intake e bilancio energetico. Serviranno coorti longitudinali, approcci multiomici e trial con endpoint clinici robusti.
Lo studio ha evidenziato la rapidità della trasduzione: il segnale compare nelle fibre vagali a pochi minuti dall’esposizione luminale e raggiunge i neuroni del nucleo del tratto solitario, dove si integra con altri input viscerali e con ormoni come CCK e GLP-1. Questa convergenza spiega perché la risposta alla flagellina non funzioni come un interruttore binario, ma come un modulatore della sazietà. Nei modelli analizzati, la riduzione dell’assunzione riguarda sia il pasto in corso sia l’intervallo successivo, con un effetto sulla spinta appetitiva. L’effetto non dipende da alterazioni del gusto o da malessere: i test comportamentali escludono avversione al cibo e condizionamento negativo. Il circuito agisce a valle della percezione edonistica e a monte delle decisioni.
Il circuito colon-vago guidato dalla flagellina e mediato da cellule neuropod PYY+ mostra come il microbiota possa, in tempi brevi, contribuire alla decisione di interrompere il pasto. È un cambio di paradigma: segnali microbici immediati sono utilizzati dal sistema nervoso per regolare l’omeostasi energetica.
Comprendere e modulare questa via può aprire strade terapeutiche mirate per i disturbi del peso e forse per alcune condizioni neuropsichiatriche. Saranno cruciali studi che integrino fisiologia, microbiologia e neuroscienze cliniche. (C. P.).
Uno studio coordinato da una biologa molecolare rivela che la caffeina potrebbe indebolire l’efficacia di alcuni farmaci sul batterio dell’Escherichia coli

di Domenico Esposito
Ogni mattina milioni di persone nel mondo iniziano la giornata con una tazza di caffè. È un gesto semplice, quasi automatico, che accompagna i risvegli e scandisce le pause di lavoro. Ma dietro questo rito quotidiano, apparentemente banale, può nascondersi un intreccio complesso che riguarda la biologia più profonda delle cellule batteriche. È quello che ha spiegato uno studio condotto dalle Università di Tübingen e Würzburg, coordinato dalla biologa molecolare Ana Rita Brochado e pubblicato su Plos Biology. I ricercatori si sono interrogati su una domanda tanto curiosa quanto scientificamente rilevante: che cosa succede quando sostanze comuni della dieta, come la caffeina, incontrano i batteri e le terapie antibiotiche che servono a combatterli?
Il gruppo ha analizzato 94 composti diversi, spaziando da molecole note a farmaci, fino a ingredienti che assumiamo ogni giorno con il cibo. Il focus era capire come ciascuno di questi elementi potesse influenzare la regolazione genica dell’Escherichia coli, un batterio Gram-negativo largamente diffuso, che può convivere in equilibrio con l’organismo ma che, in determinate condizioni, diventa patogeno e causa infezioni anche gravi. Ciò che è emerso si è rivelato sorprendente: la caffeina, tra le sostanze più amate e diffuse nelle nostre abitudini quotidiane, ha un impatto diretto sull’attività di un regolatore genico chiamato Rob. Questa proteina, se attivata, avvia una cascata di reazioni che portano a ridurre la permeabilità della membrana batterica, rendendo più difficile l’ingresso di alcuni antibiotici fondamentali, come la ciprofloxacina. In altre parole, il caffè, almeno in laboratorio, sembra offrire ai batteri una sorta di piccolo scudo.
Per comprendere l’importanza di questa scoperta, bisogna ricordare che la membrana esterna dell’Escherichia coli non è una semplice barriera passiva. È un sistema sofisticato di canali proteici, le porine, e di pompe di efflusso, che gestiscono chi entra e chi esce dalla cellula. È come se i batteri avessero un portiere alla porta, capace di decidere quando aprire e quando respingere, proteggendosi così da sostanze tossiche. Gli esperti hanno osservato come la caffeina interferisca proprio con questi sistemi di controllo, modulandoli attraverso Rob e riducendo di fatto l’assorbimento degli antibiotici. È un dettaglio molecolare, ma ha implicazioni enormi: se replicato in condizioni cliniche, potrebbe significare che una sostanza innocua e quotidiana diventa un fattore di resistenza. «I nostri dati mostrano che diverse sostanze possono influenzare in modo sottile ma sistematico la regolazione genica nei batteri - spiega Christoph Binsfeld, primo autore dello studio -. I risultati suggeriscono che anche sostanze di uso quotidiano prive di un effetto antimicrobico diretto possono avere un impatto su alcuni regolatori genici che controllano le proteine di trasporto, modificando così ciò che entra e esce dal batterio».

La caffeina, tra le sostanze più amate e diffuse nelle nostre abitudini quotidiane, ha un impatto diretto sull’attività di un regolatore genico chiamato Rob. Questa proteina, se attivata, avvia una cascata di reazioni che portano a ridurre la permeabilità della membrana batterica, rendendo più difficile l’ingresso di alcuni antibiotici fondamentali, come la ciprofloxacina. In altre parole, il caffè, almeno in laboratorio, sembra offrire ai batteri una sorta di piccolo scudo
«La caffeina innesca una cascata di eventi che inizia con il regolatore genico Rob e culmina nella modifica di diverse proteine di trasporto in Escherichia coli, il che a sua volta porta a una riduzione dell’assorbimento di antibiotici come la ciprofloxacina», aggiunge Ana Rita Brochado. Un fenomeno, questo, che i ricercatori definiscono interazione antagonista. Ma questo effetto debilitante di alcuni antibiotici non è stato ad esempio rilevato nella Salmonella enterica, un agente patogeno strettamente correlato all’Escherichia coli. Ciò a dimostrazione che non esiste un unico copione. A tal proposito la professoressa Karla Pollmann ha dichiarato che «una ricerca così fondamentale sugli effetti delle sostanze assunte quotidianamente sottolinea il ruolo vitale della scienza nella comprensione e nella risoluzione dei problemi del mondo reale». E anche la centralità del lavoro dei biologi. Sono loro che hanno messo a punto lo screening dei 94 composti, costruendo un modello sperimentale robusto, capace di distinguere effetti reali da semplici coincidenze. Sono loro che hanno interpretato i dati molecolari, riconoscendo nell’attivazione della proteina Rob un meccanismo credibile e spiegando come questo influenzi porine e trasportatori. Sono sempre loro che hanno scelto la via della prudenza: un conto è la scoperta in laboratorio, un altro è l’impatto clinico. E infatti non hanno lanciato allarmi, ma hanno aperto la strada a nuove domande. Quante tazze di caffè servirebbero, nel corpo umano, per replicare l’effetto osservato? Esistono altre sostanze comuni in grado di modulare i sistemi di difesa batterici? E come possiamo integrare queste conoscenze nella lotta contro la resistenza agli antibiotici, che oggi rappresenta una delle sfide più urgenti della medicina moderna?
Nessuno studio dimostra che il caffè renda inefficaci le terapie antibiotiche, quindi non c’è motivo di rinunciare all’oro nero. Al tempo stesso, sapere che esistono interazioni possibili invita alla moderazione e alla consapevolezza, soprattutto quando si assumono farmaci specifici che possono amplificare gli effetti della caffeina.
Ricca di β -glucano, proteine e flavonoidi, risulta essere un cereale dalle innumerevoli proprietà per la cura e la bellezza della cute

© Davizro Photography/shutterstock.com
La pelle, organo più esteso del corpo, ha funzione di barriera di protezione, che i raggi ultravioletti (UVA e soprattutto UVB) possono danneggiare, con conseguenti infiammazioni, perdita di idratazione, alterazioni delle proteine strutturali (loricrina, filaggrina, transglutaminasi 1) con compromissione della barriera cutanea. L’eccesso di specie reattive dell’ossigeno (ROS) indotto dai raggi UV, innesca una serie di processi infiammatori, così da portare a rossore, secchezza e prurito.
L’avena (Avena sativa L.) è ricca di proteine, lipidi, polifenoli e β -glucano, con innumerevoli proprietà antinfiammatorie, idratanti e lenitive ed è già abbondantemente utilizzata in cosmetica, c’è però una problematica legata all’estrazione fatta con metodi tradizionali, che spesso lasciano residui di solventi, riducendo la presenza e disponibilità dei principi attivi.
Motivo questo che ha indotto ad ovviare con la fermentazione micro -
* Comitato Centrale FNOB

bica, che migliora la sicurezza, aumenta la concentrazione di composti bioattivi e ne facilita l’assorbimento cutaneo.
Nello studio: Dual-action fermented oats (Avena sativa L.): Anti-inflammatory and skin barrier restoration di : Manman Liu, Yue Li, Ping Zhang, Chuyang Wang, Yuxuan Wu, Yuyan Chen, Hu Huang, Xiang Li; l’avena viene polverizzata, idrolizzata enzimaticamente con α -amilasi, proteasi e maltosio amilasi, poi arricchita con sali nutritivi e sterilizzata, si procede alla fermentazione con Saccharomyces cerevisiae a 30 °C per 18 ore, e il prodotto ottenuto viene omogeneizzato, centrifugato e filtrato, generando l’estratto fermentato (FO), invece l’avena non fermentata (NFO), trattata nelle stesse condizioni ma senza microrganismi, viene utilizzata come controllo.
Da un approccio integrato di metabolomica, biologia molecolare e tecnologie di modelli cutanei 3D, vengono fornite molte informazioni sul ruolo dell’avena svelando po -
tenziali effetti antinfiammatori, di riparazione della barriera cutanea e di idratazione, evidenziando come la fermentazione di Saccharomyces cerevisiae altera il contenuto di aminoacidi e derivati nell’avena.
Il trattamento con FO ha evidenziato effetti antinfiammatori molto significativi sia sulle risposte immunologiche, che neuro-infiammatorie. In un modello cutaneo 3D esposto a radiazioni UVB, l’FO ha mostrato: 1) effetto lenitivo inibendo la secrezione di citochine IL-1 α e IL-6 abbassando i livelli di espressione di COX2 e NF- κ B; 2) ripristino della barriera cutanea, con la regolazione dei livelli di LOR, FLG, TGM1, Caspasi-14 e AQP3.
La fermentazione dell’avena con Saccharomyces cerevisiae modifica in modo significativo il suo profilo metabolico, con la produzione di numerosi metaboliti nuovi o trasformati rispetto all’avena non fermentata (NFO), dall’analisi metabolomica sono venuti fuori ben 341 metaboliti differenziali, in gran parte ammino -
In un modello tridimensionale di pelle umana irradiata con raggi UVB, l’avena fermentata ha ridotto i marcatori infiammatori, limitando i danni cellulari tipici delle scottature solari, ha migliorato la funzione di barriera cutanea ripristinando i livelli di proteine chiave


L’estratto di avena fermentata con Saccharomyces cerevisiae (FO) si distingue come un ingrediente naturale innovativo e multifunzionale. Da solo porta con sé un insieme di proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici della barriera cutanea, offrendo una protezione efficace contro i danni indotti dai raggi UVB e migliorando la salute generale della pelle
acidi e derivati, prodotti grazie all’idrolisi proteica mediata da enzimi e microrganismi, questo aumenta la biodisponibilità dei nutrienti e la loro efficacia, perché quelli ottenuti sono peptidi e amminoacidi molto più facilmente assorbibili dalla pelle. Dalla valutazione chimico-fisica si evince un sostanziale aumento dei principali componenti bioattivi dell’avena fermentata (FO): il contenuto di β -glucano è aumentato del 15%, quello delle proteine del 39% e, quelli che hanno registrato un incremento straordinario sono soprattutto, i flavonoidi, si parla del 600%,
che supera di gran lunga quello osservato in altri cereali (orzo, crusca d’avena) sottoposti a processi di fermentazione.
Si deduce, che l’arricchimento dei flavonoidi nell’FO sia dovuto all’azione sinergica degli enzimi del lievito e alla specifica matrice dell’avena, che interviene nella trasformazione dei precursori fenolici in composti bioattivi con forte potere antiossidante. Questo conferisce all’FO un duplice vantaggio: da un lato possiede potenti proprietà antiossidanti, dall’altro contribuisce al rafforzamento della barriera cutanea, e a differenza di altri estratti vegetali ottenuti con solventi, l’FO risulta anche più sicuro, in quanto privo di residui potenzialmente dannosi.
Gli studi biologici hanno evidenziato una marcata attività antinfiammatoria e lenitiva dell’FO, perché inibisce fino all’80% il legame tra TNF- α e il suo recettore TNFR1, rispetto a una inibizione modesta di circa il 20% osservata con l’NFO.
Inoltre, nei macrofagi di topo RAW 264.7 stimolati con LPS, FO ha ridotto in modo dose-dipendente il rilascio di ossido nitrico (NO) mediatore chiave dell’infiammazione. Questi effetti hanno avuto conferma in vivo su embrioni di zebrafish , dove FO ha diminuito l’aggregazione dei neutrofili in misura superiore al controllo positivo, evidenziando di saper modulare le risposte immunitarie innate.
Per quanto riguarda la neuroinfiammazione, FO ha mostrato di regolare negativamente l’espressione del recettore TRPV1, un canale ionico coinvolto nei processi di dolore e infiammazione, riducendo così i sintomi associati a stimoli nocivi cutanei come pizzicore, bruciore e sensibilità.
In un modello tridimensionale di pelle umana irradiata con raggi UVB, FO ha ridotto i marcatori infiammatori IL-1 α , IL-6, COX2 e NF-
κ B, limitando i danni cellulari tipici delle scottature solari, ha migliorato la funzione di barriera cutanea ripristinando i livelli di proteine chiave: loricrina (LOR) e transglutaminasi 1 (TGM1), responsabili della stabilità strutturale; filaggrina (FLG), essenziale per l’idratazione; e caspasi-14, impiegata a formare fattori idratanti naturali, questo ha garantito un miglioramento sinergico della resistenza cutanea, della capacità di trattenere acqua e della differenziazione cellulare.
Infine, l’FO ha dimostrato di aumentare significativamente l’idratazione cutanea, potenziando il contenuto di acqua nello strato epidermico, e favorendo l’eccessiva di AQP3, un canale per il trasporto di acqua localizzato nella membrana basale. Questi risultati spiegano l’effetto emolliente e idratante osservato.
In conclusione, l’estratto di avena fermentata con Saccharomyces cerevisiae (FO) si distingue come un ingrediente naturale innovativo e multifunzionale.
Da solo porta con sé un insieme di proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, lenitive, idratanti e riparatrici della barriera cutanea, offrendo una protezione efficace contro i danni indotti dai raggi UVB e migliorando la salute generale della pelle.
Nonostante i dati emergano risultati molto promettenti, si ritengono necessari ulteriori studi per chiarire i meccanismi molecolari alla base della sua azione, soprattutto tutto ciò che riguarda le vie di segnalazione coinvolte nella riparazione della barriera epidermica.
Bibliografia

Consulta gli eventi della Fnob che erogano i crediti formativi


La XII edizione della mostra contrassegnata dalla partnership con la FNOB Il ruolo del biologo di comunità

La mostra “Riscarti” - alla Vaccheria di Roma fino al 7 ottobre - è stata l’occasione perfetta per celebrare il ruolo del biologo di comunità nella promozione della sostenibilità ambientale. L’evento, organizzato in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), ha visto la partecipazione di biologi, artisti e attivisti ambientali che hanno condiviso le loro esperienze e conoscenze sul tema della riduzione degli sprechi e del riciclo creativo.
La mostra è allestita con opere realizzate con materiali di scarto, dimostrando come la creatività e l’ingegno possano trasformare gli oggetti di uso quotidiano in veri e propri oggetti d’arte. Tra le opere esposte, spicca la
scultura “3rd Spaces Boxes” di Giovanni Pellegrino, realizzata con scarti di legno e materiali riciclati. L’evento ha anche ospitato una serie di tavole rotonde e dibattiti sul tema della sostenibilità ambientale e del ruolo del biologo di comunità nella promozione di pratiche eco-friendly. I relatori hanno discusso di argomenti come la riduzione degli sprechi alimentari, l’educazione ambientale e la promozione di stili di vita sostenibili.
I campi per esercitare la professione di biologo sono molteplici come ha sottolineato il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi Vincenzo D’Anna. Concetto ribadito da Daniela Arduini presidente dell’Ordine dei Biologi a Lazio e Abruzzo e da

Elvira Tarsitano referente scientifica del progetto che ha promosso la partnership tra Riscarti e FNOB.
L’arte del riciclo, il riutilizzo dei materiali, ma anche l’educazione a una spesa consapevole che contribuisca a sanare quella che è una grande piaga: lo spreco alimentare, un abominio anche per l’ambiente. La mostra è allestita con opere realizzate con materiali di scarto, dimostrando come la creatività e l’ingegno possano trasformare gli oggetti di uso quotidiano in veri e propri oggetti d’arte

Salute e Ambiente, binomio inscindibile per poter tracciare un futuro di longevità e benessere. L’evento si è svolto in due sessioni con tavole rotonde e dibattiti che hanno affrontato più tematiche che hanno affinità con Riscarti. L’educazione all’ambiente deve essere prioritaria. A riguardo la presidente OBLA Daniela Arduini ha sottolineato che «il coinvolgimento dei biologi al Festival esprime appieno il messaggio di educazione ambientale». Elvira Tarsitano ha invece fatto riferimento a una visione più ampia «che coinvolga in toto uomo e ambiente, la città del futuro e una città verde ed ecosostenibile».
L’arte del riciclo, il riutilizzo dei materiali, ma anche l’educazione a una spesa consapevole che contribuisca a sanare quella che è una grande piaga: lo spreco alimentare, un abominio anche per l’ambiente. «Sprechiamo troppo - ha detto Livia Galletti membro del comitato centrale FNOB e delegata alla nutrizione della FNOB -, al punto che se dovessimo paragonare la quantità di cibo sprecato a una regione italiana questa sarebbe la Lombardia».
Nella prima sessione sono stati affrontati i temi green e la eco sostenibilità, nella seconda parte centrale è stato
il tema dell’alimentazione e dello spreco. Di grande interesse i talk moderati dalla segretaria della FNOB Carla Cimmino e dalla presidente OBLA Daniela Arduini che hanno alimentato il dibattito sull’educazione ambientale, la citizen science e le prospettive del biologo ambientale nella rigenerazione urbana. Nella sessione pomeridiana sono stati affrontati diversi aspetti sullo spreco alimentare «verso sistemi alimentari ecologici e solidali».
Il momento talk è stato un momento per il confronto e la formazione. L’economia circolare come soluzione allo spreco alimentare, l’educazione ambientale ed alimentare, gli stili di vita e i comportamenti alimentari. E ancora, il ruolo del biologo nutrizionista nella lotta allo spreco alimentare. A condurre la sessione Livia Galletti e Alessandro Coltré. A dibattere Daniela Arduini, presidente Ordine dei Biologi Lazio e Abruzzo, Pieralisa Di Felice, consigliera Ordine dei Biologi Lazio e Abruzzo, Cecilia Verga Falzacappa, consigliere segretaria Ordine dei Biologi Lazio e Abruzzo Michelina Petrazzuoli, coordinatrice CNBN.
La giornata si è conclusa con il questionario finale dei partecipanti e crediti Ecm. Il comitato scientifico è composto da Teresa Verde, Marlene Scalise e Pieralisa Di Felice. (M. A.).






Un tributo alla dedizione e all’eccellenza nella ricerca
In occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, si è tenuta una cerimonia di premiazione per i biologi che hanno dedicato 50 anni della loro vita alla ricerca e alla scienza. Istituito dall’Ordine dei Biologi di Campania e Molise, questo riconoscimento è un tributo alla loro dedizione, alla loro passione e al loro impegno nella ricerca scientifica.
I premiati hanno contribuito significativamente allo sviluppo della biologia e delle scienze correlate e il loro lavoro ha avuto un impatto positivo sulla società e sulla comunità scientifica. La cerimonia di premiazione è stata un’occasione per celebrare la loro carriera e il loro supporto alla scienza e per ispirare le nuove generazioni di ricercatori e ricercatrici.
“Complimenti ai colleghi insigniti della attestazione di merito, che credo rappresenti un doveroso riconosci -
mento del loro operato deontologicamente perfetto e professionalmente rilevante” - ha dichiarato il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, Vincenzo D’Anna, aggiungendo che “manifestazioni del genere sottolineano come il ruolo dei biologi sia cresciuto negli anni e sia destinato a divenire centrale nel campo della ricerca e della medicina predittiva e di precisione”.
“Attraverso tali iniziative l’Ordine dei Biologi di Campania e Molise evidenzia il proprio impegno a valorizzare la ricerca, la formazione e la professionalità, consapevole che la scienza è da sempre il pilastro della nostra esistenza - ha aggiunto Carla Cimmino consigliera di OBCM e segretaria FNOB -. La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori costituisce un momento rilevante, l’occasione per creare un dialogo tra comunità scientifica e società civile.
Infine - ha aggiunto Cimmino -, con l’istituzione del Premio Giovani Ricercatori, l’Ordine dei Biologi di Campania e Molise vuole sostenere le nuove generazioni di studiosi, riconoscendogli i giusti meriti e incoraggiarli per la crescita professionale”.
I premiati sono:
• Attilio Sofia
• Dario Spiteri
• Roberto Blundo
• Ciro Palmieri
• Ciriaco Rago
• Giuseppe Caputo
• Salvatore Scognamiglio
• Vittorio Caponigro
• Antonella Carsana
• Adriana Zatterale
• Antonio Cesare Rendina
Inoltre, in questa occasione, sono state premiate le ricercatrici: Serena Marullo e Annabella Di Mauro. (M.A.).
Primo passo verso l’equità ma il trattamento economico
è ancora insufficiente

È in discussione una ipotesi di riconversione dei posti lasciati liberi dai medici e delle correlate risorse in particolare nelle scuole di specializzazione aperte anche ai biologi e ad altre categorie sanitarie. L’ ipotesi di accesso a nuovi ordinamenti e l’incremento dei posti lasciati vacanti dai medici possono costituire ulteriori importanti opportunità per i biologi
Le scuole di specializzazione per biologi rappresentano una componente fondamentale nella formazione di questi professionisti.
Recentemente, è stata approvata una norma che riconosce un primo trattamento economico agli specializzandi biologi e alle altre categorie sanitarie, sanando così un’ingiustizia storica.
Nel dettaglio, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto una novità importante per gli specializzandi biologi e delle altre categorie sanitarie non mediche. Grazie all’emendamento presentato dall’onorevole Marta Schifone, è stato approvato un trattamento economico per gli specializzandi non medici, che prevede un contributo annuo di 4.773 euro.
Il contributo, sebbene iniziale, rappresenta un importante riconoscimento del valore della formazione specialistica dei biologi. È chiaro che si tratta di una cifra che dovrà essere incrementata nei tempi più brevi possibili per parificare il trattamento a quello già previsto per i medici.
Questa riforma rappresenta comunque un passo storico verso l’ulte -
riore riconoscimento del valore della formazione specialistica dei biologi e delle altre categorie sanitarie.
Inoltre, è in itinere la previsione dell’istituzione di nuove scuole di specializzazione per chimici e biologi oltre che per altre professioni sanitarie non mediche.
Questo rappresenta un importante passo avanti per ampliare gli ambiti disciplinari della formazione avanzata e specializzata dei professionisti sanitari non medici.
E ancora. È in discussione una ipotesi di riconversione dei posti lasciati liberi dai medici e delle correlate risorse in particolare nelle scuole di specializzazione aperte anche ai biologi e ad altre categorie sanitarie. L’ ipotesi di accesso a nuovi ordinamenti e l’incremento dei posti lasciati vacanti dai medici possono costituire ulteriori importanti opportunità per i biologi.
Una auspicabile ipotesi di riforma delle scuole di specializzazione potrà essere allargata a nuovi ambiti disciplinari attualmente scoperti e aperta all’accesso dei professionisti, consentendo così una maggiore flessibilità e opportunità di carriera. (M. A.).
L’art.8 della legge 29 dicembre 2000, n.401 prevedeva che “ Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall’ articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 , ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito del -
* Comitato Centrale FNOB
le risorse già previste.”
Trascorsi ormai venticinque anni la chiara e precisa previsione della Legge n.401 è ancora inattuata e solo ora, dopo l’approvazione nella Finanziaria 2025 L. 30 dicembre 2024, n.207, art.1, comma 339, dell’emendamento, presentato dall’On.le M. Schifone, per il finanziamento per le borse di studio per le scuole di specialità aperte ai laureati sanitari, il procedimento si sta avviando.
Negli anni sono stati effettuati diversi ricorsi collettivi da parte degli specializzandi finalizzati ad ottenere il trattamento economico. Tali ricorsi non hanno avuto esito ed anzi molte Università bloccarono tra il 2010 ed
il 2016 i bandi per alcuni anni per i laureati sanitari con i conseguenti gravissimi danni per i laureati in attesa di conseguire il titolo per l’accesso al S.S.N. pubblico e privato accreditato.
Tale abnorme situazione determinò nel 2016 con il D.L. 29 marzo 2016, n.42, art.2 bis l’abrogazione temporanea dell’art.8 e quindi della stessa previsione delle borse.
Per quanto attiene la determinazione del fabbisogno essa avrebbe dovuto ovviamente essere fatta prima, e non dopo, della definizione del finanziamento complessivo delle borse previsto per circa trenta milioni in finanziaria con un valore annuo individuale di circa 4.773 euro.
Ciò a fronte di un valore di Euro 25.000 per i primi due anni e 26.000 per i successivi, per i medici. Ciò, è bene precisarlo subito, a fronte di identici ordinamenti didattici per le medesime scuole per medici e sanitari, ed uguale entità e modalità del tirocinio pratico a tempo pieno previsto nelle strutture ospedaliere e sanitarie sede di formazione.
Inoltre per gli specializzandi medici son state introdotte possibilità di effettuazione parziale di attività lavorative integrative.
È del tutto evidente che l’enorme diversità degli importi economici dovuti agli specializzandi sanitari rispetto ai medici, quando sarà concretamente applicato il pagamento, determinerà rilevanti conflitti intercategoriali, oltre a mantenere insostenibili tutti i costi cui è soggetto lo specializzando per la formazione che spesso avviene in sedi lontane dai luoghi di residenza, anche extraregionali.
In altre parole la frequenza quadriennale delle scuole ed i relativi costi, non potranno non gravare se non sulle famiglie se non impedire in concreto allo specializzando di portare a termine il corso di studio. Appare evidente che con la Finanziaria 2026 andranno ricercate opportune soluzioni di finanziamento finalizzate a ridurre in modo significativo il divario dei trattamenti tra medici e non medici considerando che i fabbisogni calcolati per il triennio 2025-2027 per le categorie sanitarie sono significativamente inferiori ai fabbisogni oggettivi legati al turn-over dei servizi sanitari pubblici e privati accreditati ed ai fabbisogni degli altri settori compresi quelli libero professionali.
Per quanto riguarda la determinazione dei fabbisogni all’inizio del 2025 il Ministero della salute ha richiesto agli Ordini per la prima volta dal 2000 la previsione di calcolo dei fabbisogni per gli accessi delle diverse categorie alle singole scuole di specializzazione
cui è consentito l’accesso.
Gli ordini, non senza difficoltà, hanno inviato le proprie valutazioni avuto riguardo agli accessi stimati per i precedenti anni accademici. In questa fase il limite oggettivo ad un calcolo fondato sulle esigenze reali è stato costituito dal numero degli accessi nell’anno precedente stabilito autonomamente dalle singole Università e non dagli ordini.
Nel caso dei biologi appare opportuno segnalare che, a fronte di stime più elevate di accesso previste per i diversi settori, l’Ordine ha sistematicamente sollecitato le singole Università ad incrementare i posti messi a concorso, senza però soddisfare i bisogni effettivi.
Il Ministero ha poi richiesto e ricevuto le proposte di fabbisogno corrette dalle Regioni. Queste a loro volta si sono limitate a comunicare i valori corrispondenti ai posti messi a bando negli anni precedenti, anche qui senza una rivalutazione oggettiva delle modifiche dei fabbisogni correlate alla modifica degli ambiti professionali e delle conseguenze del turn-over.
L’esito di questo lavoro, dopo l’intervento delle Regioni, è stato inviato all’approvazione delle Conferenza Stato Regioni suddiviso per anno (2025/2026/2027), per categoria, per tipologia di Scuola, per Regione.
Ferma restando la rilevanza storica dell’approvazione del provvedimento, restano, ribadiamo, irrisolte le carenze di posti messi a disposizione dalle Università e dalle stesse Regioni e ciò in modo variabile anche in rapporto alle singole tipologie di Scuole che, in alcune regioni o non sono attivate per biologi e categorie sanitarie o si vedono attribuiti un numero irrisorio di accessi.
Sotto questo profilo l’incremento dello stanziamento richiesto già ai parlamentari interessati per la prossima finanziaria, dovrà riguardare non solo l’incremento del valore del -
la borsa ma soprattutto l’incremento dei posti messi a bando sulla base delle effettive esigenze delle singole Regioni. In tal senso il coinvolgimento degli ordini regionali appare necessario e determinante.
Sull’incremento dei livelli di accesso alla formazione specialistica per i biologi e per altre categorie sanitarie potrà incidere significativamente il sempre più elevato numero di posti lasciati liberi dai medici.
Le borse non assegnate ai medici per diverse scuole di specializzazione sono circa il 25 % con oltre 5.800 posti non occupati o abbandonati in scuole tra le quali sono comprese Microbiologia e Virologia, Patologia clinica e Biochimica clinica, Farmacologia e Tossicologia, Genetica medica, Statistica sanitaria e biometria, Scienza dell’Alimentazione ovvero le scuole cui hanno accesso biologi e laureati sanitari.
Si tratta di oltre 6-700 posti che potrebbero essere riassegnati ai biologi e laureati sanitari che hanno accesso a tali scuole rispondendo al fabbisogno ulteriore non soddisfatto per queste categorie, riutilizzando le risorse disponibili e dando risposta alla progressiva riduzione di medici in tali discipline e relative scuole di specializzazione.
Una situazione simile riguarda la scuola di Anatomia patologica per la quale andrebbe previsto l’accesso, con apposito indirizzo, dei biologi in considerazione delle competenze attribuite in cito-istopatologia. Ugualmente per le competenze in materia di Igiene ambientale andrebbe previsto l’accesso alla Scuola di Igiene e Medicina preventiva.
Una importante integrazione dell’ordinamento didattico vigente si rende necessaria anche per la Scuola di Genetica Medica prevedendo le conoscenze e competenze in materia di procreazione medicalmente assistita.
*Alleghiamo le tabelle a fine GdB.*


europei ha analizzato e studiato i segreti processi nascosti per evitare gravi rischi

di Gianpaolo Palazzo
Le eruzioni sono tra gli spettacoli più grandiosi e, al tempo stesso, più minacciosi che la Natura sappia offrire. In pochi minuti possono trasformare un paesaggio, oscurare il cielo, scuotere intere regioni. Quelle di maggiore violenza proiettano in atmosfera colonne di cenere e gas alte chilometri, lasciando dietro di loro strati di materiale che ricoprono vaste aree. Capire che cosa spinga la lava a comportarsi a volte in modo relativamente pacifico e altre con un’energia catastrofica non è solo una curiosità scientifica: è un nodo cruciale per la sicurezza di milioni di persone che vivono accanto a questi giganti.
Un gruppo internazionale di ricercatori, guidato dall’Istituto di scienza, tecnologia e sostenibilità per le ceramiche del Consiglio nazionale delle ricerche di Faenza, ha aperto una finestra nuova su questo mistero.
Lo ha fatto non osservando i vulcani dall’alto, ma andando a scrutare l’infinitamente piccolo: minuscole strutture solide che si formano all’interno del magma e che, pur invisibili a occhio nudo, hanno la capacità di cambiarne radicalmente il comportamento.
L’articolo, pubblicato su “Nature Communications”, ha approfondito la tecnica d’avanguardia messa in campo, la pticografia, in grado di restituire immagini tridimensionali a scala nanometrica. È un metodo disponibile nei grandi sincrotroni europei, capace di superare i limiti della microscopia tradizionale e di portare gli

Il magma non è solo roccia fusa: è una sostanza viva, in continua trasformazione, capace di conservare nella sua trama segreta la memoria del passato e di suggerire indizi sul futuro. Leggere quelle tracce significa avvicinarsi a decifrare il linguaggio stesso del Pianeta e se milioni di persone potranno vivere più sicure, sarà grazie alla capacità della scienza di guardare nell’invisibile per comprendere ciò che, un giorno, può scuotere il mondo intero
© ImageBank4u/shutterstock.com
scienziati al di là di barriere finora invalicabili.
Grazie a questo strumento si è potuto osservare direttamente la forma e la disposizione dei cosiddetti nanoliti, particelle più sottili di un micron: a titolo di paragone, un capello umano ha un diametro cento volte maggiore.
Finora questi minuscoli frammenti erano rimasti in gran parte sconosciuti. Eppure, la loro influenza sulla dinamica interna della lava si rivela decisiva.
Durante la risalita dai serbatoi profondi verso la superficie, il magma subisce trasformazioni complesse: si formano bolle di gas, s’innescano processi di cristallizzazione, varia la fluidità della massa incandescente. È proprio qui che entrano in gioco.
Come spiega Emily Charlotte Bamber, ricercatrice del Cnr-Issmc e prima autrice dello studio, «Attraverso la tecnica della pticografia a raggi X siamo riusciti, invece, ad acquisire informazioni cruciali per comprendere la forma, la distribuzione e l’interazione tra i cristalli, per capire il loro impatto sulla viscosità del magma e, in ultima analisi, sull’esplosività».
La scoperta più inattesa riguarda la tendenza di queste particelle ad aggregarsi. Un comportamento apparentemente banale che, però, cambia tutto: la loro unione ne aumenta il volume effettivo e rende la lava meno fluida, accrescendo la possibilità che la pressione interna salga fino al punto di provocare una liberazione violenta di energia.

Questo collegamento diretto tra la microstruttura interna della lava e le sue manifestazioni in superficie è una delle chiavi più preziose che la scienza abbia ottenuto negli ultimi anni. Come osserva ancora Bamber, «Il nostro studio ha importanti implicazioni soprattutto per la comprensione della struttura su scala nanometrica dei magmi basaltici, mostrando come la cristallizzazione e l’aggregazione dei nanoliti possano influire sulla viscosità del magma e, quindi, sulla probabilità di un’eruzione altamente esplosiva».
Il caso dell’Etna rende evidente il valore di queste nuove conoscenze. Il colosso siciliano, che per il mito ospitava la fucina del dio Efesto, alterna fasi di attività tranquilla, con colate spettacolari, ma poco pericolose, a episodi storicamente devastanti. Capire che cosa determini il passaggio da un comportamento all’altro è essenziale non solo per i vulcanologi, ma per le
comunità che vivono sulle sue pendici e per chi deve pianificare strategie di protezione civile. Il progetto ha coinvolto università e istituti di ricerca di Italia, Regno Unito e Germania, tra cui Manchester, Camerino, University College di Londra e l’Ingv di Catania. È un esempio concreto di come la collaborazione internazionale e le tecniche più sofisticate possano cambiare il nostro sguardo su fenomeni che sembrano immutabili da millenni.
Fino a poco tempo fa, i vulcanologi erano costretti a dedurre il comportamento del magma da osservazioni indirette: la composizione chimica, la forma delle rocce, la distribuzione dei depositi. Oggi hanno la possibilità di guardare dentro la materia, cogliendo il ruolo di entità infinitesimali che agiscono come direttori d’orchestra silenziosi di eventi immani.
la guida del principal investigator Danilo Di Genova, il progetto “Erc Nanovolc” continuerà a spingersi oltre, esplorando le geometrie e le interazioni delle particelle su scala sempre più fine. L’obiettivo è fornire strumenti predittivi sempre più accurati per la valutazione del rischio, ma anche arricchire la nostra comprensione di come la Terra respiri, accumuli energia e la liberi.
Il magma non è solo roccia fusa: è una sostanza viva, in continua trasformazione, capace di conservare nella sua trama segreta la memoria del passato e di suggerire indizi sul futuro. Leggere quelle tracce significa avvicinarsi a decifrare il linguaggio stesso del Pianeta e se milioni di persone potranno vivere più sicure, sarà grazie alla capacità della scienza di guardare nell’invisibile per comprendere ciò che, un giorno, può scuotere il mondo intero.
© Martin M303/shutterstock.com

L’indagine, tuttavia, non si ferma qui. Sotto Etna.
l caso dell’Etna rende evidente il valore di queste nuove conoscenze. Il colosso siciliano, che per il mito ospitava la fucina del dio Efesto, alterna fasi di attività tranquilla, con colate spettacolari, ma poco pericolose, a episodi storicamente devastanti. Capire che cosa determini il passaggio da un comportamento all’altro è essenziale non solo per i vulcanologi, ma per le comunità che vivono sulle sue pendici e per chi deve pianificare strategie di protezione civile

Con sensori e microcamere, delle trappole intelligenti inviano dati in tempo reale consentendo un intervento mirato e tempestivo per proteggere le coltivazioni dalle minacce
Nel cuore della Sabina, dove il 70% della frutticoltura laziale concentra la propria produzione, si combatte una campagna silenziosa contro nemici invisibili che minacciano raccolti, reddito e sostenibilità. I frutteti, ecosistemi fragili e da sempre vulnerabili agli agenti patogeni, oggi trovano alleati insospettabili nella scienza e nella tecnologia. Gli esperti di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), in collaborazione con la Società Agricola Colle Difesa, la Fondazione Fosan (Fondazione per lo studio degli alimenti e della nutrizione) e diverse imprese locali, hanno ideato un sistema innovativo di controllo e sorveglianza dei parassiti nell’ambito del progetto “Simodrofila”.
L’iniziativa è pensata per arginare specie invasive come la cimice asiatica, la mosca mediterranea e il moscerino asiatico, minacce già capaci di provocare danni rilevanti in altre regioni italiane e ora sempre più pressanti anche in Lazio. La strategia combina tecnologie d’avanguardia con un’analisi dettagliata del territorio. Dispositivi di cattura, distribuiti nei frutteti, raccolgono dati settimanali che consentono interventi immediati nei cosiddetti hot-spot, limitando la diffusione degli insetti. Le esche utilizzano miscele di vino rosso, aceto di mele e zucchero per Drosophila suzukii e formule chimiche mirate per Ceratitis capitata.
campo. La sperimentazione pratica è prevista nei prossimi mesi in aziende selezionate della Sabina, aprendo la strada a una gestione più intelligente e precisa.
Lo studio approfondisce anche il ruolo della biodiversità e delle piante spontanee nel favorire la sopravvivenza dei parassiti. Analizzando le aree limitrofe ai frutteti, gli esperti hanno individuato specie vegetali come bacche e more che, nei mesi invernali, costituiscono rifugi per il moscerino asiatico, consentendone la sopravvivenza e la ricomparsa al momento della stagione produttiva. «Con l’intensificarsi degli effetti del cambiamento climatico, inverni più miti e precipitazioni irregolari - chiarisce Elena Lampazzi, ricercatrice del Laboratorio Enea Agricoltura 4.0 -, il Mediterraneo e la Sabina sono sempre più vulnerabili all’attacco di insetti alieni e patogeni che mettono in seria difficoltà la frutticoltura».

I ricercatori hanno progettato e testato una trappola IoT alimentata a energia solare, dotata di microcamera e sensori di umidità e temperatura. Il dispositivo cattura gli infestanti e invia in tempo reale immagini e dati direttamente agli agricoltori, senza dover essere fisicamente sul campo
«Uno dei nostri pilastri - spiega Maurizio Calvitti, ricercatore della divisione Enea Sistemi Agroalimentari Sostenibili e coordinatore scientifico dell’iniziativa - è il monitoraggio territoriale georeferenziato, che consente la mappatura in tempo reale delle infestazioni. Con questo progetto puntiamo a innovare i modelli di gestione fitosanitaria, introducendo nuove tecnologie, modelli predittivi e strategie di controllo biologico. L’obiettivo è duplice: da un lato aumentare la competitività delle aziende locali, dall’altro ridurre l’impatto ambientale favorendo un uso più consapevole e mirato degli insetticidi da applicare solo quando realmente necessario e in corrispondenza dello stadio più vulnerabile dell’insetto».
Per perfezionare ulteriormente il sistema, i ricercatori hanno progettato e testato una trappola IoT (Internet of things) alimentata a energia solare, dotata di microcamera e sensori di umidità e temperatura. Il dispositivo cattura gli infestanti e invia in tempo reale immagini e dati direttamente agli agricoltori, senza dover essere fisicamente sul
Tra i nemici più insidiosi si segnalano Rhagoletis cerasi e Halyomorpha halys. «Da non sottovalutare - aggiunge l’entomologo Raffaele Sasso - la cimice asiatica, estremamente adattabile e vorace, già responsabile di danni ingenti a kiwi, nocciolo, pesco e ciliegio nel Nord Italia, ma ora emergente anche nel Lazio».
Un’altra linea di ricerca riguarda la selezione di varietà di ciliegio e pesco meno appetibili per gli insetti: «Abbiamo testato diverse cultivar in laboratorio e sul campo - precisa Sergio Musmeci, ricercatore Enea, - valutando maturazione, acidità, zuccheri e colore della buccia per misurarne attrattività e resistenza agli attacchi». Con il fine d’informare costantemente i coltivatori, il progetto prevede bollettini settimanali con aggiornamenti su infestazioni, meteo e consigli tecnici, privilegiando trattamenti a basso impatto. Lo scorso anno è stato avviato anche il rilascio controllato d’insetti antagonisti non dannosi per la frutta, contribuendo a limitare l’uso degli agrofarmaci. «Grazie al progetto “Simodrofila” - conclude Maurizio Calvitti - la Sabina Romana si presenta oggi come un laboratorio a cielo aperto dove agricoltura, ricerca e innovazione lavorano fianco a fianco per costruire un modello di produzione agricola più sostenibile e moderno senza rischi per l’ambiente e la salute dei consumatori. Un modello replicabile in altri territori italiani». Quest’iniziativa fonde tradizione e innovazione, sostituendo interventi chimici massicci con strategie basate sui dati. Così la frutticoltura trasforma le minacce in opportunità, costruendo un’agricoltura resiliente, intelligente e sostenibile, capace di garantire raccolti sicuri, consumatori protetti e territori valorizzati. (G. P.).

Legambiente evidenzia una gestione fallace da parte degli enti locali, con disparità nella disponibilità di servizi come aree cani, pensioni e regolamenti per il fine vita
Il legame tra persone e animali d’affezione è uno dei più profondi e solidi che si possano creare: un pilastro di sostegno per molte famiglie, in particolare per le più vulnerabili. Eppure, nonostante il ruolo crescente che gli amici a quattro zampe rivestono nella società, la loro tutela resta spesso relegata ai margini delle priorità pubbliche. Il quattordicesimo rapporto nazionale “Animali in Città” di Legambiente mette in luce, con dati alla mano, questa realtà: un quadro di lacune e disomogeneità tra amministrazioni locali che penalizza la qualità della vita dei cittadini e dei loro compagni.
Il campione dell’indagine include 734 comuni, pari al 9,3% del totale nazionale. Solo il 39,5% di essi raggiunge una performance minima sufficiente, rivelando una disparità territoriale netta tra località costiere e interne. Le differenze emergono in tutti i servizi fondamentali: aree dedicate ai cani presenti nel 36,2% dei centri sul mare contro il 10,4% di quelli dell’entroterra; strutture di pensione animale disponibili nel 57,3% dei luoghi costieri e solo nel 21,9% di quelli interni. Anche le direttive per il fine vitacremazione, tumulazione o inumazionesono ancora rare: 28% nelle amministrazioni marittime e 10% in quelle interne, lasciando le famiglie senza riferimenti in momenti delicati.
A completare il quadro c’è la gestione di botti e fuochi d’artificio, fonte di stress per gli animali: ordinanze presenti nel 21,9% delle città costiere e nell’8,3% dell’entroterra. Sportelli animali e garanti dei diritti legati ai quadrupedi compaiono nell’8,5% delle realtà sul mare e nel 4,4% di quelle interne; i contributi alla sterilizzazione riguardano appena il 14,6% dei primi e il 4,7% dei secondi. Sorprende la gestione delle spiagge: pur beneficiando del turismo, solo il 23,2% dei costieri dispone di un regolamento per l’accesso dei nostri pet.
Il cuore del problema è la scarsità di assistenza veterinaria pubblica di prossimità. In tutto il territorio nazionale esistono solo due ospedali veterinari pub-
blici, a Perugia e Napoli. La ripartizione della spesa nel 2024 evidenzia una netta sproporzione: il 74,9% dei fondi per il pet-care grava sugli enti locali, mentre le Asl coprono appena il 25,1%, pur dovendo garantire prestazioni essenziali per chi è in difficoltà. La conseguenza è una delega di responsabilità che limita l’accesso ai servizi, soprattutto nei territori più fragili.
Non mancano, però, esempi positivi. Il Premio “Animali in Città” celebra amministrazioni e Asl che hanno saputo distinguersi. Napoli è premiata per la copertura sanitaria e l’integrazione dei servizi socioassistenziali e veterinari; San Giovanni in Persiceto (BO) per l’attivismo civico, prestazioni integrate e direttive efficaci; Modena per investimenti significativi e regolamentazione urbana. Tra i piccoli comuni, Zocca (MO) e Campodolcino (SO) primeggiano per educazione civica e progetti sociali mirati al contesto locale. Sul fronte assistenziale, Asl Napoli 1, Bergamo e Vercelli emergono per la capacità di fornire dati accurati e integrare prestazioni con gli enti locali.
La prospettiva futura è chiara e urgente. «Il XIV “Rapporto Animali in città” - dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente -, conferma che solo grazie a solide alleanze tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati è possibile garantire il benessere delle famiglie con animali d’affezione. Per questo chiediamo di promuovere ed agevolare la firma di 1.000 accordi o patti di comunità in tutto il Paese. È urgente rilanciare la sanità veterinaria pubblica di prossimità, obiettivo per cui chiediamo al Governo di realizzare un piano nazionale a supporto delle Regioni che consenta l’assunzione stabile di 6.000 veterinari e alle Regioni il raggiungimento complessivo di 1.000 strutture veterinarie pubbliche (850 tra canili sanitari e gattili sanitari e circa 150 ospedali veterinari pubblici), distribuite equamente sul territorio in rapporto alla popolazione servita. Inoltre, alle Amministrazioni comunali l’appello è di potenziare le aree verdi con libero accesso dedicate alle

Il cuore del problema è la scarsità di assistenza veterinaria pubblica di prossimità. In tutto il territorio nazionale esistono solo due ospedali veterinari pubblici, a Perugia e Napoli
famiglie con cani, di valorizzare l’applicazione di regolamenti e ordinanze e rafforzare il senso civico grazie al supporto di 10.000 guardie ambientali e zoofile delle associazioni di volontariato, per migliorare concretamente la qualità della vita di cittadini e animali».
«Con il premio nazionale “Animali in Città” - aggiunge Antonino Morabito, responsabile nazionale Cites e Benessere animale di Legambiente e curatore del rapporto - che Legambiente promuove ogni anno, vogliamo valorizzare l’impegno di Amministrazioni, Asl, associazioni e istituzioni che si distinguono per l’attenzione verso gli animali e mostrare i tanti casi positivi che dimostrano, concretamente, che anche in questo settore un’Italia al servizio dei cittadini e dei loro amici a quattro zampe esiste e lavora alacremente. Un’iniziativa e un impegno a cui teniamo particolarmente è la nascita della Rete nazionale dei garanti per i diritti degli animali, figure nominate da Regioni e Comuni che svolgono un ruolo delicato quanto fondamentale».
L’Italia ha davanti a sé la possibilità di trasformare la cura degli animali da eccezione in norma. I comuni virtuosi dimostrano che risultati concreti sono realizzabili: basta combinare cifre, regole chiare, investimenti e partecipazione attiva dei cittadini. La vera misura di una società civile si vede da come protegge chi non ha voce. Rendere questa attenzione capillare significa garantire sicurezza, benessere e coesione sociale, facendo diventare il prendersi cura un segno distintivo di comunità responsabili e consapevoli. (G. P.).

Le statistiche dell’Ispra mostrano un marcato divario Nord-Sud, con il Settentrione che produce il 57% degli scarti, mentre il dato sullo smaltimento in discarica è positivo
Il 2023 racconta una storia di crescita economica contenuta, ma svela anche un’altra, più complessa realtà: l’incessante e crescente creazione di sottoprodotti industriali che accompagna la ripresa. L’Italia, in un anno di modesti incrementi del Pil, ha generato una quantità impressionante di materiali di scarto, tendenza che porta a interrogarsi sul vero costo del progresso. In questo scenario, il ventiquattresimo “Rapporto Rifiuti Speciali” dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) si presenta come una guida, illuminando un paradosso sorprendente: nonostante l’incremento di residui, abbiamo raggiunto un traguardo storico nel loro recupero, dimostrando una capacità di trasformazione senza precedenti.
L’analisi dei riscontri rivela una Penisola divisa tra la necessità di produrre e la virtù di valorizzare, con un’eccellenza che affronta le sfide strutturali. Il dato incoraggiante nella gestione è bilanciato, però, dalla costante e resistente leadership del comparto costruzioni e demolizioni, che, con circa 83,3 milioni di tonnellate, concorre per quasi la metà alla formazione complessiva dei detriti. Il panorama si completa con il 23,5% proveniente dalle attività per il trattamento materiali di scarto e risanamento, e con il 16,8% dal settore manifatturiero, che dimostrando ancora di essere il principale produttore di rimasugli pericolosi con una quota del 36,1%.
Anche geograficamente, il quadro non muta: il Settentrione si mantiene come l’area con la maggiore produzione, 94,1 milioni di tonnellate, un valore che la posiziona come il principale polo di generazione, trainata da una capolista indiscussa, la Lombardia, che da sola “offre” 35,9 milioni di t. Il Centro con 28,1 mil., vede la Toscana in testa (10,4), mentre al Sud, la Campania, con i suoi 11,1, domina la produzione della macroarea.
Tali cifre riflettono una sproporzione nella distribuzione industriale, ma dimostrano anche una capacità di reazione: il riciclo di sostanze inorganiche è l’operazione di lavorazione più utilizzata, riguardando circa 78,8 mil. di t. Gran parte di questi materiali, in particolare i detriti da costruzione e demolizione, pari a oltre 80 mil., vengono trasformati in sottofondi stradali e rilevati. Altrettanto favorevole è la rigenerazione di metalli e loro composti, ammonta a 21 mil. in t, con la gran parte recuperata dalle acciaierie del Nord, così come le sostanze organiche quali carta, cartone e legno, che vengono riutilizzate per il 7% del totale. Questa spinta virtuosa si riflette anche nella diminuzione del conferimento in discarica dei residui speciali, si riduce di 997mila t, segnando un
calo dell’11,2% rispetto all’anno precedente.
Nonostante il progresso, persistono ancora delle sfide: il Rapporto completa il proprio esame con un’analisi dettagliata su alcuni flussi che presentano le maggiori criticità. La produzione di esuberi contenenti amianto, pari a 240mila t, mostra una flessione contenuta, ma evidenzia la mancanza di un’attività di decontaminazione su larga scala. Nel settore dei veicoli fuori uso, malgrado un reimpiego e riciclaggio complessivo che raggiunge l’85,8%, il recupero totale rimane ancora lontano dagli obiettivi normativi. Similmente, per gli pneumatici fuori uso, pur con un recupero di materia dell’87,6%, è necessario rafforzare i sistemi di raccolta per valorizzare pienamente ogni flusso.
Un’altra prova riguarda i fanghi di depurazione provenienti da reflui urbani, di cui quasi la metà (47,6%) è ancora avviata a smaltimento. Circa le eccedenze da costruzione e demolizione, a dispetto di un reimpiego pari all’81% che supera ampiamente gli obiettivi, il documento evidenzia la necessità di “nobilitare” il loro utilizzo, trasformandoli in prodotti di maggior valore, anziché in semplici sottofondi stradali. Infine, per i rifiuti sanitari pericolosi, pur registrando una contrazione del 5,9%, presentano ancora un’incidenza di smaltimento che supera il 73%, numero che richiede una revisione delle pratiche.
A completare il quadro, arriva la conferma di essere un importante crocevia per il traffico internazionale legato ai risultati di scarto: nel 2023 sono state importate oltre 6,8 mil. di t, principalmente rottami metallici dalla Germania e Francia (421mila t), a fronte di un espatrio di 5,5 mil. Dalla Svizzera arrivano 452mila t di terre e rocce destinate quasi tutte alla Lombardia in attività di recupero ambientale. Il 67% delle esportazioni, 3,7 milioni t, è costituito da non pericolosi e il restante 33% (circa 1,8 milioni) da pericolosi. Sono prevalentemente diretti in Germania (1,2 milioni t, di cui 762mila t pericolosi).
SibFilm/shutterstock.com

L’aumento degli scarti riflette un’economia che, pur a fatica, riprende slancio, ma la vera sfida non è solo produrre ricchezza: consiste nel trasformare ogni avanzo in opportunità concreta
Tale scenario complesso, fatto di successi e insidie, descrive una nazione a un bivio. L’aumento degli scarti riflette un’economia che, pur a fatica, riprende slancio, ma la vera sfida non è solo produrre ricchezza: consiste nel trasformare ogni avanzo in opportunità concreta. I numeri sul riuso testimoniano una Penisola che inizia a scoprire il valore nascosto in ciò che prima appariva solo un peso. La strada verso un’economia completamente circolare è ancora lunga, ma chi saprà valorizzare ogni detrito e affinare ogni processo non solo vincerà la sfida della sostenibilità, ma scriverà la nuova storia del progresso italiano. (G. P.).

Dai mari profondi dipende la vita sulla Terra: i rischi legati alla crisi climatica e l’appello del biologo Danovaro
Tutelare gli oceani per tutelare il nostro futuro. Perché senza oceani non c’è può esserci un domani. Lo dice a chiare lettere, Roberto Danovaro, professore di Biologia marina presso l’Università Politecnica delle Marche e, secondo la piattaforma ExpertScape, il più influente scienziato marino nel decennio 2010-2020. Già presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, è stato tra i protagonisti della XXII edizione del Festival della Mente di Sarzana, in occasione del quale ha rilasciato un’intervista a Wired: ancora una volta, il biologo ha rimarcato
il ruolo decisivo degli oceani e quanto sia importante prendersene cura. Del resto, la vita è nata proprio negli oceani più di tre miliardi di anni fa: è da quegli organismi microscopici che popolavano la parte blu del pianeta che è iniziato tutto. I motivi per cui bisogna salvaguardarli sono diversi e tutti di stringente attualità. Perché il tempo a disposizione potrebbe non essere tanto per rimediare agli errori commessi. Danovaro sottolinea come «il 50% dell’ossigeno del pianeta viene rilasciato dall’attività di fotosintesi degli organismi marini ed è quello che respiriamo».
Ecco spiegato perché gli oceani, che coprono oltre il 70% della superficie terrestre, sono fondamentali per la vita sulla Terra. I fitoplancton, ovvero minuscoli organismi che sono presenti nelle acque oceaniche come ad esempio le alghe e i cianobatteri, producono ossigeno proprio come fanno le piante terrestri: assorbono anidride carbonica e, tramite la fotosintesi, rilasciano ossigeno. C’è poi un altro aspetto da tener conto. L’esperto ricorda che «gli oceani forniscono attualmente circa il 30% delle proteine necessarie e che il mare è la più importante risorsa di materie prime al momento presente sul pianeta».
A tal proposito, le previsioni a stretto giro legate al mancato contributo degli oceani spaventano. Tra il 2050 e il 2100 si stima che un milione e 400mila persone potrebbero non sopravvivere. Questo è lo scotto da pagare per inquinamento e cambiamenti climatici, che provocano una serie di reazioni a catena in grado di mettere a repentaglio ambiente e biodiversità. Il riscaldamento delle acque comporta la distruzione di ecosistemi marini ed effetti sulla pesca, l’acidificazione degli oceani riduce la capacità degli stessi di assorbire anidride carbonica, minacciando la catena alimentare marina, mentre la deossigenazione aumenta le morie di pesci. «Li abbiamo mandati fuori regime: gli oceani sequestrano circa il 40% dell’anidride carbonica che rilasciano nell’atmosfera e assorbono il 90% del calore lì accumulato per via dell’effetto serra, ma non è detto che possano farlo per sempre» - ha sottolineato Danovaro a Wired.
Infine, una potenziale ricchezza per la gran parte ancora ignota ed è quella rappresentata dagli abissi, che celano segreti capaci di migliorare le nostre vite. La collaborazione tra Paesi è un passo necessario, secondo il biologo marino, perché «nessuno da solo dispone di risorse economiche e tecnologiche per sostenere una missione negli abissi». (D. E.).
Grazie allo studio su scala globale di un biologo americano è stata fatta chiarezza sul motivo per cui alcune specie invasive si adattano e prosperano in nuovi ambienti meglio di altre. Tra gli autori della ricerca figura Nic Kooyers, professore associato presso la Facoltà di Scienze Biologiche dell’Università della Louisiana a Lafayette, che ha co-diretto un team internazionale comprendente ben 51 esperti, i quali hanno analizzato uno dei più grandi campionamenti di una pianta invasiva mai raccolti. I biologi si sono concentrati sul trifoglio bianco, ormai presente in ogni angolo del globo.
Si tratta di una delle specie di trifoglio più comuni e diffuse ed è proprio per questo motivo che ha fornito l’assist per esaminare in maniera dettagliata il processo di invasione della specie. Come spiegato in una nota sul sito dell’ateneo della Louisiana, la pianta è originaria dell’Asia centrale e dell’Europa, ma è stata introdotta in tutto il mondo secoli fa durante la colonizzazione. Due le ragioni dell’esportazione: una riguarda motivi legati all’agricoltura, l’altra di rinverdimento. La sua alta adattabilità ha consentito a questa specie di risultare invasiva in diverse zone del pianeta, come la Nuova Zelanda, l’Australia, gli Stati Uniti, il Cile e il Sudafrica. Ma c’è anche un’altra caratteristica che contraddistingue questa pianta: la resistenza. Proprio in virtù di questi aspetti, il trifoglio bianco si è dimostrato prezioso per la scienza e per lo studio condotto da Kooyers. La ricerca, di cui è primo autore il professore l’UL Lafayette, Brandon Hendrickson, è durata diversi anni, durante i quali sono stati sequenziati i genomi, ovvero le informazioni genetiche contenute nel DNA, di 2.660 esemplari di trifoglio bianco. Sotto la lente degli scienziati sia le popolazioni autoctone sia quelle introdotte al fine di comprendere i modelli di variazione naturale nella

Perché alcune specie si adattano meglio di altre
La scoperta grazie allo studio globale di un biologo americano
specie in questione. Dai risultati dello studio che è stato poi pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution è emersa la capacità del trifoglio bianco di adattarsi rapidamente ai nuovi ambienti per via di alcune variazioni strutturali del genoma.
«Una delle potenziali applicazioni di queste scoperte è che, comprendendo la quantità di varianti strutturali e la diversità genetica in una specie, potremmo prevedere quali specie hanno maggiori probabilità di adattarsi dopo l’invasione» ha spiegato il biologo Kooyers. «La nostra ricerca ha dimostrato in maniera empirica qualcosa che si
pensava accadesse da quasi 100 anniha continuato -. Fornisce quindi indizi su quali specie siano più propense ad adattarsi dopo l’invasione e per quali è necessario adottare misure di pre-introduzione oppure no».
Allo studio hanno fornito un contributo essenziale anche Paul Battlay e Kathryn Hodgins della Monash University in Australia e Marc Johnson dell’Università di Toronto, in Canada. «La forza di questo studio e dei suoi risultati si basa sul livello senza precedenti di collaborazione proveniente da tutto il mondo» ha chiosato Kooyers. (D. E.).

Nel lagerstätte del Villaggio del Pescatore tracce di alligatori e dinosauri di 80 milioni di anni fa
Nella frazione di Duino Aurisina, in provincia di Trieste, vi è un piccolo centro turistico chiamato Villaggio del Pescatore. Un nome che non suona di certo nuovo alle orecchie di esperti e appassionati, poiché tale villaggio ospita nel suo perimetro un importante geosito di interesse paleontologico. Proprio qui, nello stesso luogo dove nel 1994 veniva alla luce lo scheletro del celebre dinosauro Antonio (Tethyshadros insularis), uno dei più completi rinvenuti in Italia, gli studiosi hanno identificato i resti di un coccodrillo del Cretaceo
superiore, ufficialmente classificato solo in questi mesi.
Si tratta di Acynodon adriaticus, un rettile dalle caratteristiche molto curiose. La peculiarità di questa antica specie, vissuta circa 80 milioni di anni fa, stava nel fatto di non essere un predatore particolarmente aggressivo come magari ci si può aspettare pensando ai coccodrilli moderni, ma bensì un animale ben adattato all’ambiente costiero dell’epoca. Anche se il suo aspetto è molto simile a quello di un suo “parente” moderno, seppur più robusto, ciò che ha stupito i ricercatori è la sua dentatura. I denti
anteriori ricordano piccoli scalpelli, ed erano preposti ad afferrare piccole prede, ma quelli posteriori sono invece arrotondati e massicci, fatti per triturare oggetti duri come gusci e conchiglie. Questi venivano sostituiti da denti nuovi per compensarne l’usura molto più frequentemente rispetto a quelli anteriori: l’esatto opposto di ciò che avviene nei coccodrilli del nostro periodo. Tale adattamento è unico e fa capire come i coccodrilli che vivevano nel Villaggio del Pescatore durante il Cretaceo avessero un’alimentazione diversa.
Inoltre, la TAC ha rivelato anche aspetti che vanno oltre la biologia della specie: l’Acynodon del sito di Duino Aurisina era un esemplare adulto e robusto, ma affetto da una grave artrite alla mandibola, condizione dolorosa probabilmente dovuta all’età avanzata e ai ripetuti sforzi per triturare gusci. A rendere poi ancora più difficoltosa la sua vita erano un dente sovrannumerario cresciuto all’interno della mandibola e una frattura all’avambraccio destro, guarita da tempo al momento della morte. Le ricerche sono state condotte da un team multidisciplinare che ha coinvolto le Università di Bologna e Trieste, l’Istituto Zoic e il centro Elettra Sincrotrone Trieste.
L’equipe, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate come la tomografia computerizzata e la microscopia digitale, ha analizzato nel dettaglio la sua struttura ossea, riuscendo quindi a catalogare l’esemplare. Tali strumenti permettono agli studiosi di esaminare i fossili senza danneggiarli, offrendo una visione più precisa dell’anatomia e delle abitudini di vita degli animali preistorici. L’importanza del sito del Villaggio del Pescatore è dovuta anche a numerosi altri fossili (sedimenti, tracce vegetali e resti di altri organismi) che sono testimoni di un ecosistema complesso, ricco di biodiversità e che rendono questo luogo davvero speciale.
«Cambiano le prospettive al mondo» diceva Battiato nella sua canzone “Gli Uccelli”, uno dei capolavori assoluti del Maestro nel quale musica e parole sublimano la mente dell’ascoltatore al punto da renderlo partecipe dei loro “voli imprevedibili e ascese velocissime”. Purtroppo, va detto che il mondo queste “prospettive” non sembra volerle cambiare affatto. Secondo il report The Killing 3.0 di BirdLife International e EuroNatur, resoconto periodico che si preoccupa di riferire una valutazione dei progressi sulla cessazione delle azioni illegali ai danni degli uccelli selvatici nel Mediterraneo e in Europa, il 57% dei Paesi membri della Task Force intergovernativa non ha registrato nessun miglioramento significativo.
Nello specifico 17 paesi (37%) sono su livelli stabili di IKB (Illegal Killing, taking and trade of wild Birds) e persistono difficoltà importanti sui miglioramenti; in nove Paesi (20%) il trend è invece in peggioramento. Tra i 10 paesi che nel 2020 hanno registrato i livelli più elevati di IKB nessuno è stato valutato sulla buona strada per raggiungere la riduzione richiesta dalla Convenzione di Berna e dal Piano strategico di Roma 2020-2030 della Convenzione sulle specie migratorie (riduzione del 50% entro il 2030). In questo contesto l’Italia resta ai primi posti per uccisioni illegali con 5,6 milioni di esemplari in una sola stagione: il nostro Paese risulta infatti, di nuovo, come il peggiore, continuando a conservare gelosamente le proprie tradizioni illegali di trappole (reti, vischio, trappole a scatto) e richiami sonori, che sterminano regolarmente i piccoli uccelli migratori. Dal 2017 al 2023, secondo Ispra, sono oltre 32 milioni gli uccelli uccisi sul nostro territorio, con ben 5,6 milioni di esemplari nella stagione di caccia 2022/2023.
Questi dati delineano uno scenario drammatico, ma soprattutto chie -
© Steve Jangs/shutterstock.com

Milioni vengono uccisi ogni anno, ma le nuove tecnologie possono diventare alleate
dono a tutti i Paesi coinvolti di agire: seppur difficile l’obiettivo del 2030 non è impossibile. Secondo Justine Vansynghel, ricercatrice ed esperta di Euronatur intervistata da Wired, diverse iniziative legate alle tecnologie digitali si stanno infatti profilando come strumenti efficaci per contrastare il fenomeno.
Ad esempio, alcune campagne di sensibilizzazione sui social media, come “Flight for Survival”, mirano ad informare i cittadini nei paesi più colpiti, mentre app e progetti pilota che utilizzano la realtà aumentata permettono di trasformare il “pub -
blico” in una rete di osservatori attivi in grado di segnalare in tempo reale attività sospette. Inoltre, tecnologie avanzate come droni e termocamere sono in grado di monitorare aree remote e difficili da raggiungere e l’intelligenza artificiale, grazie all’analisi di grandi quantità di dati, si sta rivelando un alleato prezioso nel riconoscimento delle aree a rischio trappole e di comportamenti illeciti. Se ben integrate e supportate da iniziative di carattere politico, tali tecnologie potrebbero segnare un punto di svolta significativo nella tutela degli uccelli migratori. (M. O.)

Un componente non-psicoattivo della cannabis può ridurre i sintomi. La ricerca pubblicata sulla rivista Epilepsia
L’Istituto di genetica e biofisica Adriano Buzzati-Traverso del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli, in collaborazione con l’Istituto di chimica biomolecolare del Cnr di Pozzuoli, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), ha svolto una ricerca, pubblicata sulla rivista Epilepsia, che ha evidenziato come il trattamento con cannabidiolo (CBD), componente non-psicoattivo della cannabis, sia in grado di ridurre i sintomi di un modello preclinico di encefalopatia epilettica dello sviluppo (DEE1).
L’acronimo DEE1 non identifica una specifica sindrome (in inglese Developmental and Epileptic Encephalopathy). Si tratta di una rara forma di epilessia pediatrica causata da mutazioni del gene ARX, che si manifesta in maggior misura nei primi mesi di vita e che colpisce in prevalenza i bambini di sesso maschile, causando frequenti convulsioni e grave ritardo nello sviluppo cognitivo e motorio e, in alcuni casi, disturbi dello spettro autistico, con esiti a volte letali. Sono malattie di origine genetica, con esordio precoce e spesso caratterizzate da crisi epilettiche resistenti al trattamen-
to farmacologico. Le DEE rappresentano, inoltre, un carico sociale ed economico importante per i pazienti, le loro famiglie e il sistema sanitario.
Lucia Verrillo del Cnr-Igb, prima autrice dello studio, ha spiegato: «La nostra ricerca rappresenta la prima evidenza sperimentale dell’efficacia del CBD altamente purificato nel trattamento di questo tipo di epilessia infantile. Infatti, attraverso la somministrazione del cannabidiolo per iniezione, siamo riusciti a ridurre la frequenza e la gravità delle crisi epilettiche nei modelli che esprimono la mutazione genetica, migliorandone così l’aspettativa di vita».
Maria Giuseppina Miano, ricercatrice del Cnr-Igb e coordinatrice della ricerca, ha aggiunto: «Il CBD ha portato alla riduzione dei marcatori neuroinfiammatori e aiutato la microglia, cioè cellule che proteggono e supportano le funzioni dei neuroni all’interno del sistema nervoso centrale, a ripristinare una forma normale. Inoltre, il trattamento con cannabidiolo ha permesso di modulare l’attività elettrica dei neuroni malati, agendo direttamente sui meccanismi di comunicazione e trasmissione sinaptica». Il concetto è stato sottolineato da Sergio Fucile del Laboratorio di epilessia sperimentale dell’Ircss Neuromed, che ha dichiarato: «La rilevanza dell’azione del CBD nel contrastare l’ipereccitabilità dei neuroni affetti da mutazione del gene ARX incoraggia lo sviluppo di un nuovo approccio terapeutico per le crisi epilettiche legate a questa patologia».
Questo studio, che ha ricevuto il supporto di GW Research Ltd (oggi parte di Jazz Pharmaceuticals), Fondazione Telethon e fondi Pnrr, rappresenta un passo importante nella direzione dello sviluppo di terapie che possano contrastare le epilessie infantili rare, offrendo nuove prospettive di cura per bambini che al momento non hanno alternative terapeutiche efficaci.
Uno studio condotto dall’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Cnr di Napoli ha rivelato una funzione finora sconosciuta di DDX11, una DNA elicasi, cioè una proteina specializzata nell’aprire la doppia elica del DNA per permettere la replicazione e la riparazione. La scoperta apre nuove prospettive nella comprensione e nel possibile trattamento di malattie genetiche rare, come la Warsaw Breakage Syndrome, e di disturbi neurodegenerativi come il Parkinson e l’Alzheimer. La ricerca, guidata dal team diretto da Francesca M. Pisani, dirigente di ricerca del Cnr-Ibbc, e pubblicata sulla rivista Autophagy, è il risultato della collaborazione con Maurizio Renna del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Francesca M. Pisani, ha affermato: «La proteina DDX11 è mutata nei pazienti affetti dalla Warsaw Breakage Syndrome (WABS), una rara malattia genetica che compromette lo sviluppo fisico e neurologico. La WABS appartiene al gruppo delle coesinopatie, malattie genetiche rare causate da alterazioni del complesso proteico della coesina o delle sue proteine regolatrici, fondamentali perchè la divisione cellulare avvenga correttamente». Proprio per il suo coinvolgimento nella coesione dei cromatidi fratelli durante la divisione delle cellule, la DNA elicasi DDX11 è stata al centro di precedenti studi del gruppo di ricerca del Cnr-Ibbc. I nuovi esperimenti hanno permesso al gruppo di ricerca del Cnr-Ibbc di scoprire che la proteina DDX11 è attiva anche nel citoplasma delle nostre cellule, dove interviene direttamente nella regolazione dell’autofagia, il processo con cui sono riciclati organelli e proteine, danneggiati e non più funzionanti.
Raffaella Bonavita, prima autrice dello studio, ha spiegato: «Abbiamo osservato che, in assenza di DDX11, le

Pubblicato sulla rivista Autophagy uno studio che rivela le proprietà della DDX11, cruciale per la salute del DNA
cellule perdono la capacità di formare correttamente gli autofagosomi, le “navette” che trasportano rifiuti cellulari verso i lisosomi per la degradazione. Questo compromette la rimozione di aggregati tossici come quelli contenenti la proteina huntingtin mutata, associata alla Corea di Huntington». Un altro elemento chiave emerso dallo studio riguarda l’interazione tra DDX11 e la proteina p62/SQSTM1, un recettore fondamentale per selezionare e caricare le proteine e gli organelli deteriorati negli autofagosomi.
Raffaella Bonavita ha proseguito: «Anche le cellule derivate da pazienti
con WABS mostrano un flusso autofagico alterato, rafforzando l’ipotesi che il malfunzionamento dell’autofagia contribuisca alla patologia». L’autofagia è oggi considerata un meccanismo essenziale per la salute del sistema nervoso e la sua alterazione è stata collegata a numerose malattie neurodegenerative.
Francesca M. Pisani, ha concluso: «Capire come DDX11 regoli l’autofagia potrebbe rivelarsi decisivo non solo per la comprensione delle basi molecolari della WABS, ma anche per lo sviluppo futuro di strategie terapeutiche contro i disturbi neurodegenerativi». (P. S.).

Uno studio ha indagato la relazione tra iperglicemia e celiachia, patologie che spesso si presentano associate
Come è noto, il diabete tipo 1 è definito una patologia autoimmune che insorge nella maggior parte dei casi in età pediatrica-adolescenziale, ma che può manifestarsi anche in età adulta, in soggetti geneticamente predisposti: è causata da una scarsa o, del tutto assente, produzione di insulina, ormone che ha un ruolo chiave nel metabolismo del glucosio.
Si stima che in Italia ne sono affetti circa 300.000 mila individui, corrispondente all’incirca allo 0,5% dell’intera popolazione, di cui quasi la metà sono in età pediatrica. Anche
la celiachia è una patologia frequente e consiste nell’intolleranza alle proteine del glutine contenute nei cereali. Anche la celiachia, come il diabete di tipo 1, ha una rilevante componente autoimmune, che si caratterizza per la produzione di anticorpi contro la transglutaminasi, con un importante valore diagnostico.
Uno studio condotto dall’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli (Cnr-Ibbc), svolto in collaborazione con pediatri del Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università Federico II di Napoli, ha inteso
indagare la relazione tra diabete tipo 1 e celiachia, due patologie che spesso si presentano associate, soprattutto se sviluppate in giovane età. Poiché diversi studi indicano che una precoce esposizione al glutine nell’infanzia può essere considerata causa scatenante del diabete autoimmune, lo studio ha provato a fare luce, tramite una sperimentazione che ha coinvolto soggetti di età pediatrica, come un eventuale infiammazione sostenuta dal glutine a livello intestinale possa avere un ruolo nel processo autodistruttivo delle cellule che producono l’insulina (beta pancreatiche).
I soggetti che hanno preso parte allo studio erano affetti da diabete, da celiachia o da entrambe le patologie: lo scopo era osservare se nel loro intestino vi fossero segni di risposta infiammatoria al glutine, analizzando sia la presenza di anticorpi anti-transglutaminasi nel siero sia la presenza di linfociti T reattivi al glutine nelle biopsie intestinali. Carmen Gianfrani ricercatrice del Cnr-Ibbc e responsabile dello studio, ha spiegato: «Il nostro studio dimostra chiaramente che il glutine innesca una reazione infiammatoria a livello intestinale solo in un sottogruppo di bambini diabetici: sono gli stessi che hanno gli anticorpi antitransglutaminasi e, quindi, affetti da comorbidità diabete e celiachia.
Le cellule T specifiche per il glutine sono assenti nell’intestino di diabetici negativi per la celiachia: i nostri risultati dimostrano, cioè, che il glutine svolge un ruolo patogenetico solo in un sottogruppo di diabetici che hanno sviluppato la celiachia, ma non sembra averlo nella maggioranza dei diabetici, nei quali le cause della patologia devono essere ricercate prevalentemente nella predisposizione genetica e in altri fattori ambientali. Tutto questo porta a suggerire prudenza nel “demonizzare” il glutine come uno dei fattori scatenanti il diabete autoimmune». (P. S.).
Le riviste scientifiche internazionali, Scientific Reports e Advanced Optical Materials, hanno dato particolare risalto a recenti studi condotti da gruppi di ricerca italiani che hanno dimostrato un innovativo sistema di comunicazione basato sulla luce visibile (VLC) a LED e le antenne ottiche fluorescenti in applicazioni realistiche, mostrandone l’ottimo potenziale. Le ricerche realizzate sono state generate dalla collaborazione tra l’Istituto di Telecomunicazioni, Informatica e Fotonica, l’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio nazionale delle ricerche di Sesto Fiorentino, il Laboratorio LENS, l’Istituto di chimica dei composti organometallici del Cnr, il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università di Firenze e il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa.
Il sistema, che è stato testato presso i laboratori della Scuola Superiore Sant’Anna, mostra come sia possibile realizzare sistemi di trasmissione dati wireless, stabili e a basso costo utilizzando LED bianchi commerciali e concentratori solari fluorescenti: tale tecnologia, che sfrutta materiali in grado di assorbire e riemettere la luce visibile, consente di superare i limiti dei ricevitori tradizionali, offrendo un ampio campo visivo, maggiore efficienza nella raccolta del segnale e una velocità di risposta adeguata per applicazioni reali, come la trasmissione video in alta definizione o l’accesso a Internet in ambienti indoor. Una delle principali novità introdotte in questa ricerca è l’uso combinato di un Concentratore Luminescente e di LED ad alta potenza per l’illuminazione, sfruttando quindi la sinergia tra illuminazione e comunicazione.
Giulio Cossu, ricercatore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha affermato: «La comunicazione in luce visibile ha il potenziale di rivoluzionare le reti di comunicazione, offrendo un’alternativa sicura e per-

Recenti ricerche hanno individuato un innovativo sistema che utilizza non solo LED
vasiva alle tradizionali tecnologie wireless, dato che ogni sorgente luminosa a LED può essere trasformata in una sorgente di dati. Abbiamo dimostrato che è possibile realizzare un collegamento ottico wireless stabile e veloce usando componenti semplici e facilmente integrabili negli ambienti quotidiani, integrabile con le reti che si usano ogni giorno».
Jacopo Catani, dirigente di ricerca del Cnr-Ino, che ha coordinato la realizzazione ed anche la caratterizzazione dei nuovi ricevitori e il loro utilizzo in questo tipo di applicazioni, ha aggiunto: «Questi risultati di -
mostrano che è possibile progettare antenne ottiche innovative, calibrandole per la specifica applicazione, scegliendo il materiale più adatto in base alle esigenze di velocità, efficienza e stabilità. In particolare, il fluoroforo H2 rappresenta una piattaforma estremamente promettente per le future generazioni di sistemi di comunicazione, considerato che nel nuovo standard 6G le comunicazioni wireless basate sulla luce rappresenteranno un elemento centrale, soprattutto in combinazione con le nuove sorgenti LED e laser a luce bianca». (P. S.).

Nuovi scavi hanno fatto luce sulla rioccupazione del sito da parte di sopravvissuti Una enorme favela dove i piani inferiori erano riadattati in forni, focolari e mulini
Di Pompei si ha spesso un’immagine cristallizzata, come se la terribile eruzione del 79 d.C. avesse bloccato la città in un eterno presente, in un istante fatale resistente allo scorrere del tempo e al passare dei secoli. In realtà non è così. La vita tornò a rifiorire, sia pur tra notevoli difficoltà, tra le strade e le insulae della cittadina sepolta, che all’inizio si trasformò in un enorme accampamento, in una sorta di antica «favela», per poi ritrovare progressivamente le sembianze di una relativa normalità. A far luce sulla Pompei rioccupata dopo l’eruzione sono state le recenti ricerche che hanno coinvolto l’Insula Meridionalis della città e che hanno documentato le tracce dei reinsediamenti, emerse con sempre maggiori dettagli nel corso della campagna e che sono state oggetto di un articolo pubblicato sull’E-Journal degli Scavi di Pompei. L’ipotesi della rioccupazione della città era stata già avanzata in passato, adesso sono venute fuori le prove. Sempre più numerose, sempre più dettagliate. Come spiega il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, «l’episodio epocale della distruzione della città nel 79 d.C. ha monopolizzato la memoria. Nell’entusiasmo di raggiungere i livelli del 79, con affreschi meravigliosamente conservati e arredi ancora intatti, le tracce flebili della rioccupazione del sito sono state letteralmente rimosse e spesso spazzate via senza alcuna documentazione. Grazie ai nuovi scavi il quadro diventa ora più chiaro: riemerge la Pompei post 79, più che una città un agglomerato precario e grigio, una specie di accampamento, una favela tra le rovine ancora riconoscibili della Pompei che fu. Noi archeologi in questi casi ci sentiamo come gli psicologi della memoria sepolta nella terra: tiriamo fuori le parti rimosse dalla storia, e questo fenomeno ci dovrebbe indurre a una riflessione più ampia sull’inconscio archeologico, su tutto ciò che viene rimosso o obliterato o rimane nascosto, all’ombra di altre cose apparentemente più importanti».
diventarono le uniche parti delle costruzioni ancora affioranti tra la cenere e i piani inferiori invece erano ridotti a scantinati. Col passare del tempo questi piani inferiori furono trasformati. Gli scavi hanno messo in luce come nel secondo e nel terzo secolo forni, focolari e persino mulini furono realizzati negli ambienti che una volta erano al pianterreno di ville e abitazioni, a testimonianza della ripresa di una vera e propria economia cittadina, anche se a livelli elementari. Dalla cenere riemergeva anche la vegetazione e Pompei, sia pur non ai livelli precedenti l’eruzione, tornò a ospitare un discreto numero di abitanti.

© PompeiiParco Archeologico
Gli scavi hanno messo in luce come nel secondo e nel terzo secolo forni, focolari e persino mulini furono realizzati negli ambienti che una volta erano al pianterreno di ville e abitazioni, a testimonianza della ripresa di una vera e propria economia cittadina, anche se a livelli elementari
Gli abitanti della «nuova» Pompei erano presumibilmente sfollati e senza dimora sopravvissuti alla furia del Vesuvio, gente che aveva perso tutto e non aveva modo di trasferirsi altrove, a differenza di altri che - come documentato da nomi e iscrizioni pompeiane ritrovate in altre città - riuscirono a stabilirsi in altri centri della Campania. Sin dalle prime fasi successive all’eruzione ci fu un afflusso continuo di persone, in una Pompei in cui i piani superiori
Delle ventimila persone che abitavano a Pompei nel 79 d.C., infatti, non tutte persero la vita. A oggi, in cui si stima che i due terzi del perimetro dell’antica città siano stati riportati alla luce, sono state censite solo 1.300 vittime dell’eruzione. Ai sopravvissuti potrebbero essersi aggiunti nuovi arrivati, allettati dalla possibilità di scavare e di ritrovare oggetti di valore, monete, marmi o preziosi affreschi, e che spesso nel corso dei loro rudimentali scavi s’imbattevano invece nei corpi delle vittime. Esseri umani ma anche animali, come dimostra lo scheletro di un piccolo cavallo riemerso nell’ultima campagna di scavi. Certo, le infrastrutture tipiche delle città romane non furono più ristabilite. Si viveva nella precarietà, come in un agglomerato improvvisato, cercando fortuna e tesori nel sottosuolo. Una sorta di miniera, che continuò a ospitare persone per almeno quattro secoli. Del resto, lo stesso imperatore Tito all’indomani della sciagura aveva inviato sul posto due ex consoli quali “curatores Campaniae restituendae”, sorta di amministratori e sovrintendenti ante litteram incaricati di ripristinare le condizioni preesistenti al cataclisma, ma anche di occuparsi dei beni di chi non aveva lasciato eredi. La missione di rifondare Pompei e la stessa Ercolano non riuscì mai del tutto, ma in entrambe le città si costituirono comunque degli insediamenti capaci di prosperare in forme via via più organizzate fino al V secolo. Il colpo di grazia alla rioccupazione di Pompei l’avrebbe dato soltanto un’altra devastante eruzione del Vesuvio avvenuta nel 472 d.C. e detta “di Pollena”, di cui sono state trovate tracce consistenti in un livello di cenere alto otto centimetri perfino nella lontana Costantinopoli, odierna Istanbul. Un nuovo fenomeno eruttivo che spazzò via, in modo definitivo, i propositi di reinsediamento nell’area della vecchia Pompei. (R. D.).

Bissato il successo del 2024 in Nations League, le ragazze del ct Velasco sono tornate a conquistare il titolo iridato dopo 23 anni, grazie a due vittorie “sudate” con Brasile e Turchia
Se la sono dovuta sudare un po’ di più, stavolta. Dimostrando di saper vincere anche soffrendo. La Nazionale femminile di pallavolo ha allungato a 36 successi di fila la sua striscia d’oro. Ma, soprattutto, ha aggiunto questa estate altri due titoli a quello olimpico di Parigi 2024. Le ragazze di Julio Velasco hanno prima difeso con autorità il titolo di Nations League, a fine luglio, con 15 successi di cui appena un paio al tie-break (Germania e Turchia). Poi, tra fine agosto e inizio settembre, hanno resistito alle spallate - metaforiche - di avversarie fortissime per vincere il Campionato del Mondo, a 23 anni dal primo titolo. La brasiliana Gabi, in semifinale, e la turca Vargas, in finale, hanno rischiato di trasformarsi da straordinarie atlete a “incubi” fatali.
La determinazione delle azzurre e le scelte del ct hanno però risollevato ed esaltato l’Italia nei momenti decisivi. «Queste ragazze hanno lavorato con grande dedizione e giocato con coraggio anche quando eravamo in difficoltà. Questi sono valori che significano tantoha raccontato, a caldo, il ct Julio Velasco dopo il 3-2 in finale sulla Turchia - e credo che questo gruppo abbia meritato di vincere così. È una vittoria che è arrivata anche grazie al lavoro fuori dal campo aiutando a creare una mentalità che già c’era e che siamo riusciti a tirare fuori».
Già allenatore e mentore della Generazione di fenomeni maschile negli anni Novanta, Velasco è riuscito a toccare le corte giuste per esaltare i valori individuali di un gruppo dove il talento certo non mancava, già negli anni scorsi: «Queste ragazze andavano solo aiutate a tirare fuori questi valori e ci siamo riusciti. Volevo ragazze autonome ed autorevoli ed ho un gruppo che ha fatto grandissime cose. Questa vittoria mi ha dato emozioni maggiori rispetto all’Olimpiade perché questa è stata una competizione lunga, difficile, e pieno di insidie. Per questo ha un sapore diverso e bellissimo».
A Parigi 2024, dove Paola Egonu e compagne hanno rotto il digiuno azzur-
ro alle Olimpiadi, il percorso dell’Italia era stato travolgente oltre ogni aspettativa. Un set perso con la Repubblica Dominicana al debutto, poi solo 3-0 con Paesi Bassi, la Turchia di Daniele Santarelli che ci aveva eliminato a Euro 2023, la Serbia nei quarti, ancora la Turchia in semifinale e poi le campionesse uscenti degli Stati Uniti nella finalissima. Tutt’altro che scontato, anzi. Così come i 15 successi di fila in Nations League, quest’anno. Due soli al tie-break: con la Germania, nel secondo match della prima fase, senza Egonu, e con le campionesse d’Europa della Turchia. Stati Uniti e Polonia son rimaste a zero, il Brasile - in finale - si è portato in vantaggio ma ha ceduto infine per 3-1.

La determinazione delle azzurre e le scelte del ct hanno però risollevato ed esaltato l’Italia nei momenti decisivi. «Queste ragazze hanno lavorato con grande dedizione e giocato con coraggio anche quando eravamo in difficoltà. Questi sono valori che significano tanto - ha raccontato il ct Julio Velasco dopo il 3-2 in finale sulla Turchia - e credo che questo gruppo abbia meritato di vincere così
Il Mondiale, dunque. Ci siamo arrivati da favoriti, com’è normale che sia per una squadra imbattuta da 29 match: ultima sconfitta. Ed è filato tutto più che liscio fino ai quarti, con il solo Belgio a togliere lo “0” dalla casella dei set persi, nel girone. Negli ottavi la Germania ha
potuto solo applaudire, idem la Polonia nei quarti. In semifinale riecco il Brasile, ultima squadra a sconfiggere le azzurre il 1° giugno 2024. Il Brasile, mai battuto in un Mondiale. Il Brasile di Gabriela Guimarães, alias Gabi, premiata come miglior opposto della rassegna assieme a Mayu Ishikawa e capace di metter giù contro l’Italia ben 29 punti.
Proprio la sfida con le Verdeoro, però, ha confermato quanto siano state cruciali l’intuizione e la sensibilità di Velasco, che dal suo arrivo ha trasformato il dualismo Egonu-Antropova in una staffetta che nessun altro team può permettersi. La partita, finita 3-2 con strappo finale delle azzurre in chiusura di tie-break (15-13), ha anche detto quanto l’Italia sia capace di soffrire, visto l’infortunio che ha depotenziato Fahr nel riscaldamento e quello della palleggiatrice Orro nel primo set. Trovate le contromisure, trascinata anche da Sylla, l’Italia ha digerito anche il 28-30 del terzo set, per vincere al quinto.
Se il semifinale l’avversaria numero 1 era la straordinaria Gabi, in finale l’ostacolo più grande è stato Melissa Vargas, 25enne cubana naturalizzata turca, miglior marcatrice del Mondiale con 151 e miglior opposto nel team ideale della manifestazione. Apparsa a tratti ingiocabile, specie nel secondo e nel quarto set (persi malissimo dalle azzurre), l’opposta è stata infine contenuta al tie-break quando l’Italia ha chiuso in crescendo inanellando un muro dietro l’altro e sei punti di fila fino e alla medaglia d’oro. Di Antropova l’allungo sul 10-8. Poi, con Giovannini al servizio, sono arrivati nell’ordine il “no” di Fahr a Erdem, un errore offensivo delle turche e i muri consecutivi di Fahr (su Vargas), Antropova (su Aydin) e Sylla (su Erdem). Mai momento fu più opportuno. Ancora una volta è stato sottolineato come queste siano le vittorie del gruppo. E il senso di gruppo lo ha sintetizzato Miriam Sylla in una recente intervista: «Io sono disposto a mettere da parte il mio orgoglio, il mio io, per collaborare e arrivare a un obiettivo comune». Missione compiuta, decisamente.

Furlani oro nel salto in lungo Battocletti a podio due volte nel mezzofondo
Sette medaglie totali: Tokyo 2025 è stato un inno a un movimento tricolore in salute
La più preziosa, quella d’oro, è al collo di Mattia Furlani, 20enne lunghista romano di Marino, dalla folta chioma e dagli orizzonti sconfinati. La prima è stata quella dell’infinita marciatrice Antonella Palmisano, l’ultima porta la firma di Nadia Battocletti nei 10.000 metri piani. In mezzo, anche gli argenti della stessa Nadia nei 5.000 e Andrea Dallavalle nel triplo, il bronzo di Leo Fabbri nel getto del peso e quello di Iliass Aouani nella maratona.
Top 10 solo sfiorata nel medagliere, ma nuovo record di podi totali per l’Italia dell’atletica leggera ai Campionati del Mondo. Come alle Olimpiadi del 2021, Tokyo è stata generosa con il movimento azzurro, talmente forte e polivalente da essere considerato al suo apice storico. Il primato precedente di medaglie complessive, sei, risaliva a Göteborg 1995. E se il medagliere finale ci ha visti undicesimi, dietro squadre che hanno vinto più gare ma indossato meno della metà o di un terzo delle medaglie, numericamente solo gli Stati Uniti (26), il Kenya (11) e

Nel Day-1 dei Mondiali sono arrivate altre due medaglie per l’Italia: l’argento di Nadia Battocletti nei 10.000 metri e il bronzo di Leonardo Fabbri nel getto del peso. La trentina si è confermata stella del mezzofondo mondiale stabilendo anche il nuovo primato nazionale
la Giamaica (10) hanno fatto meglio. E nella classifica a punti, che tiene in considerazione i risultati delle cosiddette “finali”, l’Italia si è piazzata sesta grazie a due sesti, tre settimi e tre ottavi posti per un totale di 62 punti.
Il buon giorno degli azzurri a Tokyo 2025 si è visto dal mattino, in tutti i sensi. È maturata di buon’ora, nella prima giornata di gare, la medaglia d’argento della Antonella Palmisano nei 35km di marcia. La 34enne pugliese, olimpionica sulle strade giapponesi nella 20km quattro anni fa, ha ceduto solo alla spagnola Maria Pérez che ha staccato le avversarie al chilometro 23 per andare a vincere il titolo iridato. Alle spalle di Antonella, l’ecuadoriana Puala Milena Torres a 20 secondi e sulla cinese Peng Li a quasi un minuto. Terzo podio iridato per Palmisano, dopo i bronzi di Londra 2017 e Budapest 2023.
Sempre nel Day-1 dei Mondiali sono arrivate altre due medaglie per l’Italia: l’argento di Nadia Battocletti nei 10.000 metri e il bronzo di Leonardo Fabbri nel getto del peso. La trentina, figlia del mezzofondista e maratoneta italiano Giuliano Battocletti e dell’ottocentista marocchina Jawhara Saddougui, si è confermata stella del mezzofondo mondiale giungendo in scia alla kenyana Beatrice Chebet e precedendo l’etiope Gudaf Tsegay. Già (sorprendente) argento sulla distanza a Parigi 2024, Battocletti si è riconfermata stabilendo anche il nuovo primato nazionale in 30:38.23, abbattendo il precedente di 30:43.35 che l’azzurra aveva stabilito sulla pista lilla dello Stade de France di Parigi. Ed è toccato proprio a Nadia, con l’ultimo dei podi italiani al Mondiale sabato 20 settembre, sigillare il nuovo record nazionale di medaglie in una singola edizione. Battocletti ha infatti vinto il bronzo nei 5.000 metri, in scia alle kenyane Chebet e Kipyegon, diventando la prima donna italiana a conquistare due podi nella stessa edizione di una rassegna iridata.
Quanto a Fabbri, il gigante fiorentino stavolta ha ottenuto una meritata ricom-
pensa (il bronzo) in una finale tutt’altro che scontata. Basti pensare che, alle spalle di un autoritario Ryan Crouser, l’argento è andato a un outsider, il mezzicano Uziel Muñoz, che ha stabilito il nuovo record nazionale (21,97 metri). Fabbri ha fatto segnare 21,94m al quinto tentativo, eguagliando il neozelandese Tom Walsh ma precedendolo grazie a una seconda miglior misura.
Altra disciplina, altro bronzo: nella maratona è stato il milanese Iliass Aouani a portare a quattro il totale delle medaglie azzurre. Campione d’Europa in carica, Aouani ha chiuso in due ore, 9 minuti e 53 secondi, a soli cinque secondi dal duello da fotofinish fra Alphonce Felix Simbu (Tanzania) e il tedesco Amanal Petros. Quella di Aouani è la quinta medaglia di sempre per l’Italia nella maratona maschile ai Campionati del mondo. La più pregiata resta l’argento di Vincenzo Modica nel 1999, poi i bronzi dei futuri olimpionici Gelindo Bordin (1987) e Stefano Baldini (2001 e 2003).
Quello di Mattia Furlani nel lungo, giovedì 17 settembre, è stato un capolavoro. Di forza, ma anche di pazienza. Nullo al primo salto, poi un 8,13 metri per evitare il taglio. Davanti a tutti il giamaicano Gayle, con 20 centimetri in più. Altro nullo, poi 8,22m per Mattia, ancora insufficient per il podio. Questione di minuti: il suo record personale, 8,39m, è arrivato al quinto e penultimo salto della gara più importante dell’anno. Dietro di lui, Gayle (8,34m) e Shi (8,33m) non hanno avuto la forza di controbattere e hanno dovuto applaudirlo dal basso verso l’alto.
Prestazione da applausi anche per Andrea Dallavalle, nel triplo. Con Andy Diaz depotenziato da problemi fisici, è toccato al 25enne piacentino portare l’Italia a medaglia. Sfiorando l’oro. Sì, perché all’ultimo salto Dallavalle ha sfornato un clamoroso 17,64 metri che l’ha proiettato al comando prima che Pedro Pichardo, cubano naturalizzato portoghese, sfornasse il suo primato stagionale volando a 17,91 metri e vincendo la gara. (A. P.).

Le italiane Cocciaretto e Paolini battono gli USA, le azzurre conquistano il titolo dopo la semifinale contro l’Ucraina
Esono sei. L’Italia del tennis femminile ha conquistato l’edizione numero 62 della Billie Jean King Cup, il campionato mondiale di tennis femminile a squadre nazionali, confermandosi “regina” dopo il successo del 2024. Sesto successo per le azzurre nell’ex Fed Cup: staccate nell’albo d’oro Spagna e Russia. Come nel 2009 e nel 2010, l’Italia ha battuto in finale gli Stati Uniti, grazie all’impresa di Elisabetta Cocciaretto (n. 91 Wta) sulla più quotata Emma Navarro e al capolavoro di Jasmine Paolini. Cocciaretto ha sfornato la sua miglior
prestazione dell’anno, ripagando la fiducia della capitana Tathiana Garbin e domando la newyorkese con un doppio 6-4. Poi è toccato alla toscana. Vinto il primo set grazie a un break nel decimo game (6-4), Paolini ha ceduto il servizio all’inizio del secondo, poi ha vinto cinque giochi di fila per poi chiudere 6-2 sul servizio di Pegula, ex numero 3 al mondo. Alla finale, le azzurre erano arrivate battendo l’Ucraina in una durissima semifinale. Kostyuk (n. 26) troppo forte per una generosa Cocciaretto, poi era toccato a Paolini e Svitolina. Jasmine numero 8, Elina
numero 13. Ma i due precedenti sorridevano all’ucraina. Che si è presa il primo set grazie a due break e, grazie al suo tennis continuo e aggressivo, è volata sul 4-2 nel secondo grazie a otto punti di fila. Finita? Macché, quattro game consecutivi di Paolini e set pari.
Nel terzo set, Jasmine si è portata sull’1-1 in un secondo game cruciale, durato 16 minuti e 42 secondi, con 5 palle-break annullate. Il controbreak di Svitolina (4-4) è stato il canto del cigno: ha prevalso la tecnica dell’azzurra cheha regalato all’Italia il punto dell’1-1. Mezz’ora più tardi, Jasmine è tornata in campo con Sara Errani, per vincere il doppio che ha regalato all’Italia la terza finale di fila.
Nei quarti di finale, a Shenzen (Cina), Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini si erano regalate un’altra giornata da brividi, fugati da altrettante rimonte, rispettivamente con le cinesi Yue Yuan e Xinyu Wang, quasi al limite delle tre ore.
Intanto, è stato sorteggiato il tabellone delle “Final 8” della Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre prossimi. L’Italia insegue il terzo successo consecutivo nella massima competizione tennistica maschile per squadre nazionali. Gli ultimi a vincere più di due edizioni di fila sono stati gli Stati Uniti, che fra il 1968 e il 1972 fecero addirittura cinquina. La ciliegina sulla torta fu la finale vinta per 3-2 a Bucarest con la Romania di Ilie Năstase. Una bella rivincita sull’emergente campione che un mese prima aveva conquistato l’Us Open sconfiggendo in finale un altro asso, Artur Ashe, cui oggi è intitolato il campo centrale di Flushing Meadows.
Nei quarti di finale l’Italia, allenata da Filippo Volandri, affronterà l’Austria mercoledì 19 novembre. In caso di vittoria, per gli azzurri ci sarà una tra la Francia e il Belgio. La Spagna del numero 1 mondiale Carlos Alcaraz potrà essere incontrata solo in finale. (A. P.).
Iragazzi dell’under 20 campioni d’Europa. Le ragazze dei canestri a un passo dall’impresa, eliminate in una semifinale thrilling dal Belgio, poi campione d’Europa. Per gli uni e le altre, comunque, le parole al miele del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo scorso 15 settembre ha ricevuto le due Nazionali azzurre al Quirinale. «E auguri per il futuro. Vi aspetto qualche altra volta» il commiato del Capo dello Stato, che ha dedicato a entrambe le squadre discorsi dedicati.
L’Italia è tornata a vincere i Campionati europei di basket Under 20 a 12 anni dall’ultima volta, grazie al successo in finale sulla Lituania. A Creta, gli azzurrini hanno superato la nazionale baltica 83-66, dominando per larghi tratti della partita. Fra le altre, hanno spiccato le prestazioni di Francesco Ferrari, lungo classe 2005 di Cividale (club di Serie A2), premiato come Mvp - miglior giocatore della manifestazione e unico italiano nell’All Star Five. Ferrari, 15,6 punti e 5,4 rimbalzi di media agli Europei, ha chiuso la finale con 26 punti (9/16 dal campo e 3/5 da tre) e 4 rimbalzi.
Si tratta del terzo titolo europeo U20 per l’Italia, che si era imposta nell’edizione inaugurale del 1992, 6563 in finale ai Greci padroni di casa, e aveva concesso il bis nel 2013 a Tallinn, liquidando per 67-60 la Lettonia. Nel palmares anche due argenti e un bronzo. I ragazzi di Alessandro Rossi si sono presi il trofeo perdendo una sola partita, 67-71 con la Germania nel girone, superato in virtù dei successi su Belgio e Ucraina. Dagli ottavi in poi, l’Italia è stata inarrestabile: 101-58 all’Islanda, 89-80 a Israele, 8578 alla Serbia. Ma i punteggi non raccontano tutto. Con Israele, per spuntarla è servita una rimonta da 39-57, firmata soprattutto dai 22 punti di Elisee Assui. Con la Serbia l’allungo decisivo è arrivato nel primo quarto ed è stato strenuamente difeso per tutta

Italia batte in finale la Lituania agli Europei Under 20 di pallacanestro, l’Italbasket femminile vince il bronzo
la partita. Dominata, invece, la finale. La medaglia di bronzo, conquistata con un autorevole 69-54 ai danni della Francia, è stata invece il premio meritatissimo dalla Nazionale femminile a Euro 2025. Eppure Cecilia Zandalasini, ala della Famila Schio, e le sue compagne hanno davvero accarezzato il sogno di andare a giocarsi l’oro nella finale con la Spagna. Sotto all’intervallo della semifinale col Belgio, sprofondate a -14, le azzurre hanno trovato la forza per rimontare e mettere la freccia (60-57 a 3’ dalla fine), prima di essere nuovamente scavalcate all’ultimo minuto. Delaere
ha messo nella retìna la tripla del sorpasso, l’Italia non ha saputo replicare (64-66). E ha chiuso sotto di due, beffardi punti, gli stessi che nei quarti (76-74) avevano permesso di avere la meglio sulla Turchia.
Alla semifinale le ragazze di coach Capobianco sono arrivate vincendo tutte le partite, a cominciare da quelle con Serbia, Slovenia e Lituania. Battendo la Francia dopo 30 anni, l’Italia ha vinto una medaglia europea che mancava dall’argento conquistato proprio nel 1995 all’Europeo di Brno. E questo gruppo può ancora migliorare. (A. P.).
Un viaggio sorprendente tra l’architettura della memoria attraverso le neuroscienze
di Anna Lavinia
Sergio Della Sala
Perché dimentichiamo
Feltrinelli, 2025 – 18,00 euro
«Èuna ben povera memoria quella che funziona solo all’indietro» diceva il Re di Cuori ad Alice nel Pese delle Meraviglie.
Aveva ragione, tutti vorremmo una memoria che funzionasse in avanti ma quello che non sappiamo è che in realtà è già cosi. Se pensiamo infatti che la memoria serva solo a ricordare il nome della nostra maestra delle elementari o il titolo di quel film che ci è piaciuto tanto, ci stiamo illudendo. Ricordare è funzionale alla sopravvivenza. La memoria serve a programmare il futuro, a prevedere ciò che accadrà e a minimizzarne i rischi. Eppure come l’avvenire, anche il passato si può solo immaginare. Sì perché ogni qualvolta pensiamo a quello che è successo in precedenza ne ricostruiamo il ricordo, ne facciamo un racconto.
D’altronde gli errori di memoria,
non sono altro che errori di ricostruzione. La difficoltà sta nel fatto che non c’è un solo tipo di memoria: a seconda del tipo di informazione che dobbiamo archiviare utilizzeremo sistemi mnemonici differenti.
Questo interessante e curioso aspetto della memoria è rimarcato anche dalla lingua italiana. La parola ricordare ha infatti differenti sinonimi, ognuno con un’intenzione diversa chiamata in causa proprio durante l’atto di riportare alla memoria qualcosa. Alcuni verbi di uso più o meno comune contengono all’interno un aspetto biologico legato all’azione del ricordo. In primis il verbo ricordare che deriva dal latino cor cordis “cuore” e ci rimanda all’idea degli antichi che la memoria fosse conservata nel nostro organo vitale.
I ricordi non abitano solo il cuore o la mente come ci suggerisce peraltro il vocabolo “rammentare” ma anche lo spirito. Prendiamo ad esem -
pio il termine tanto caro a Leopardi e Silvia, rimembrare, questo delinea la funzionalità della memoria portando con sé un sentimento, qualcosa di poetico e nostalgico.
Indipendentemente dal riferimento anatomico che scegliamo, per ricordare occorre prima dimenticare. Come ci suggerisce l’autore, il processo di perdita dei ricordi ha una fama negativa e si associa ad una lacuna. Più che come un senso di colpa dovremmo invece prenderlo come una benedizione. La dimenticanza è un’arte: se non si dimentica non si può ricordare.
L’esempio più lampante suggerito dal libro è pensare a quando parcheggiamo la macchina. Se ci ricordassimo a memoria tutti i posti in cui l’abbiamo parcheggiata fin d’ora non potremmo ricordare facilmente l’ultimo posto in cui l’abbiamo lasciata. È proprio qui che entra in gioco l’aspetto positivo e necessario

del dimenticare o meglio della cancellazione involontaria dei ricordi. Può sembrare un ossimoro, ma se dimentichiamo ricorderemo bene e meglio.
Il problema è che non conosciamo il reale funzionamento della nostra memoria e puntualmente la massacriamo quando dimentichiamo. Le chiavi di casa, dove è la macchina o il nome di quella persona incontrata poco o tanto tempo fa. Dimenticare non è però sempre un male. E qui il neuroscienziato fa una cosa inaspettata: ci ricorda (per l’appunto) che l’oblio è una conquista per la mente, dimenticare è intelligente. La memoria è infatti un continuo gioco di equilibrio tra conservare e lasciare andare, tra richiamare e ricostruire.
L’oblio e la dimenticanza sono forse più importanti del ricordo stesso? A questo interrogativo cerca di rispondere Della Sala con un sorprendente viaggio nella mente, portando alla luce i meccanismi prodigiosi della memoria. Non un libro per migliorarla ma un racconto per conoscerla, studiarla e amarla (di più). Soprattutto quando dimentica.
Alcide Pierantozzi
Lo sbilico
Einaudi, 2025 – 19,50 euro
Quando l’intera esistenza si trova in bilico, in un equilibrio precario fisicamente e psicologicamente, come si fa a stare al mondo e sopravvivere? Nominando l’innominabile l’autore tenta di spiegare con coraggio e verità cosa accade dentro il suo corpo instabile carico di “difetti” diagnosticati e trattati con le migliori terapie. (A. L.).
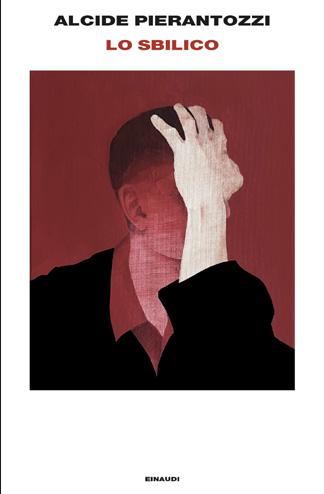
Amity Caige
Il cuore della foresta
NN Editore, 2025 – 20,00 euro
Un esperto naturalista e un fitto bosco del Maine sono solo due tanti protagonisti di questo avvincente thriller che mischia natura, indagini e legami famigliari. La misteriosa scomparsa di Valerie, un’ex infermiera e appassionata escursionista, si trasforma in una meditazione profonda nell’animo umano e nella ricerca di sé. (A. L.).
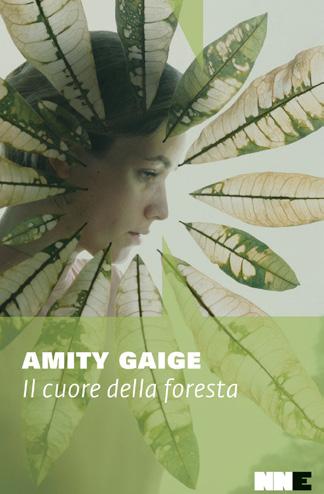
Mona Arshi
Il silenzio è la voce che ho scelto 8TTO Edizioni, 2025 – 18,00 euro
Cosa avviene nella mente di chi a nove anni smette di parlare? Figlia di immigrati indiani in una periferia inglese che fa fatica ad accogliere, Ruby si destreggia tra la malattia materna e una schiera di personaggi familiari indimenticabili. Un racconto acuto sulla forza del silenzio tra le piccole e grandi ferite della vita. (A. L.).
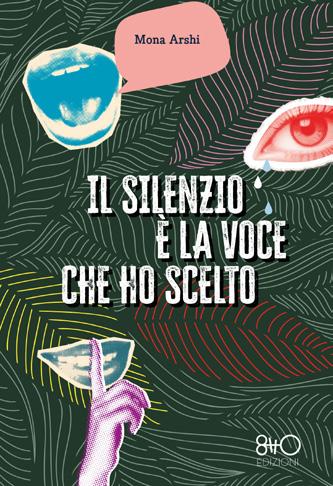
Fattori di rischio, sintomi e conseguenze sullo sviluppo infantile
La depressione post-partum (DPP) è una delle complicanze psichiatriche più comuni del periodo perinatale, con una prevalenza stimata che raggiunge il 20% delle donne. Il periodo perinatale rappresenta una fase di transizione biologica e psicologica che aumenta la vulnerabilità materna, con un maggior rischio di disturbi mentali e di necessità di trattamenti psichiatrici. L’insorgenza è strettamente legata ai profondi cambiamenti fisici, ormonali e psichici che accompagnano la gravidanza e il post-partum. I sintomi variano sia per intensità che manifestazione clinica e possono essere classificati in:
• emotivi/affettivi: tensione emotiva, sbalzi d’umore, senso di colpa, ansia, episodi depressivi;
• comportamentali/fisici: agitazione, insonnia, irritabilità, stati di confusione.
Questi sintomi possono portare la madre a un progressivo ritiro dalla vita sociale, a comportamenti ostili e a una ridotta capacità di riconoscere e rispondere ai bisogni del neonato. Le conseguenze si estendono quindi anche ai figli, che possono sviluppare deficit cognitivi, compromissioni delle funzioni esecutive e difficoltà nel linguaggio. Nei casi non trattati, la DPP può compromettere seriamente il legame madre-bambino con esiti drammatici come alterazioni neuro-comportamentali, ritardi nello sviluppo, infanticidio o suicidio della madre. I fattori di rischio maggiormente associati comprendono eventi di vita stressanti, una storia
* Comunicatrice scientifica e Medical writer
pregressa di disturbi psichiatrici, abuso di sostanze, mancanza di supporto sociale e familiare, gravidanze inattese o complicate e una predisposizione genetica [1,2].
I sintomi compaiono più frequentemente nelle prime 4 settimane dal parto, ma possono manifestarsi fino a 12 mesi di distanza. Per questo motivo, una diagnosi precoce e accurata, insieme a un trattamento tempestivo, sono fondamentali per evitare l’aggravamento del quadro. Tuttavia, gli abbassamenti del tono dell’umore nei primi giorni dopo il parto sono spesso considerati “normali” e si osservano nel 50–80% delle madri, questo rende più sfuggente l’individuazione precoce della DPP [3].
Le prime descrizioni di disturbi psichici post-partum risalgono addirittura al XIII secolo, quando si riteneva che: “se l’utero è troppo umido, il cervello si riempie d’acqua e l’umidità che scorre sugli occhi li costringe a versare lacrime involontarie”. Oggi, la DPP è classificata come disturbo depressivo maggiore a esordio in vicinanza del parto. Circa l’80% dei casi corrispondono a una ricaduta di depressione maggiore già presente, pur presentando caratteristiche peculiari legate al brusco riequilibrio ormonale dopo il parto. Tuttavia, la DPP presenta specificità biologiche, in particolare i cambiamenti ormonali gonadici legati al parto: durante la gravidanza si osserva un’elevata produzione di ormoni, seguita da un calo drastico e repentino subito dopo la nascita [4].
Implicazioni del trattamento farmacologico
I meccanismi fisiopatologici della DPP coinvolgono

diversi mediatori che sono così diventati bersagli nello sviluppo di interventi farmacologici, ormonali e non. Per le forme lievi o moderate, la psicoterapia o l’uso di antidepressivi sono raccomandati come trattamento di prima linea. Tra i farmaci maggiormente utilizzati rientrano quelli a base di monoamine, come gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina e noradrenalina e i triciclici. Questi trattamenti, però, non sono esenti da rischi: possono infatti causare teratogenicità, tossicità neonatale e avere effetti negativi sullo sviluppo a lungo termine. Pertanto, le madri dovrebbero limitarne l’uso durante la gravidanza e l’allattamento [1,5].
L’attenzione dei ricercatori si concentra principalmente sul sistema GABAergico, uno dei principali sistemi di comunicazione del cervello che funziona come “freno” dell’attività neuronale. L’allopregnanolone è un neurosteroide endogeno che esercita un’azione chiave sul sistema GABAergico riducendo rapidamente l’eccitabilità neuronale e modulando la risposta dell’asse ipotalamo–ipofisi–surrene allo stress postnatale, in questo modo si favorisce il ripristino dell’omeostasi. Un altro elemento di interesse riguarda la modulazione indotta dai neurosteroidi a livello dell’asse ipotalamo–ipofisi–gonadi. Questa modulazione sembra associarsi a una riduzione dei livelli di ormone luteinizzante e follicolo-stimolante, senza variazioni significative di estradiolo o progesterone. Quindi l’attivazione diretta dei recettori GABA ha un ruolo cruciale non solo nei processi depressivi, ma anche nella regolazione delle oscillazioni ormonali post-partum [6]. Anche altri ormoni, tra cui cortisolo, ormone di rilascio della corticotropina (CRH), ormone adrenocorticotropo (ACTH), ossitocina, prolattina, testosterone ed estradiolo, risultano coinvolti nel sistema. Gli estrogeni, per esempio, sono considerati
© Arsenii Palivoda/shutterstock.com
potenziali trattamenti per gli episodi depressivi, sebbene con efficacia variabile tra le pazienti. Studi sperimentali hanno mostrato che, in donne emotivamente stabili e non gravide sottoposte a soppressione ovarica, la somministrazione di alte dosi di estradiolo e progesterone seguita da una brusca interruzione può indurre un peggioramento dei sintomi depressivi, soprattutto in soggetti con anamnesi positiva per PPD. Al contrario, quando è stata farmacologicamente indotta una condizione di ipogonadismo simile a quella del post-partum tramite leuprolide, la somministrazione di dosi sovrafisiologiche di estradiolo e progesterone ha portato a un miglioramento dei sintomi depressivi nel 62% delle donne con precedenti episodi di PPD [7].
Nel complesso, queste evidenze mettono in luce il ruolo cruciale dei target ormonali nella patogenesi e nel trattamento della depressione post-partum, sottolineando l’importanza di integrarli nei programmi di screening e nello sviluppo di nuove strategie farmacologiche.
Fattori di rischio
• Fattori sociodemografici
Le analisi di una possibile correlazione tra DPP ed età della madre hanno prodotto risultati contrastanti. Alcuni studi parlano di un rischio maggiore nelle madri più giovani, in particolare sotto i 25 anni, con uno studio che ha riportato un rischio triplicato in questa fascia d’età. Da numerose altre ricerche, invece, non è emersa alcuna correlazione. Anche lo stato civile, di per sé, non rappresenta un fattore di rischio così rilevante come spesso si pensa. In uno studio, infatti, il rischio appariva significativo inizialmente, ma perdeva importanza una volta considerata la qualità effettiva della relazione. Quindi, all’inizio sembrava che “essere sposati” fosse un fattore protettivo (cioè
riducesse i rischi), ma quando i ricercatori hanno valutato se la relazione fosse sana o conflittuale, quel vantaggio “spariva”. Un altro elemento ampiamente indagato è la condizione socioeconomica. Basso reddito, basso livello d’istruzione, scarsa alfabetizzazione e disoccupazione sono stati associati a un rischio più elevato. Un basso livello di istruzione può limitare l’accesso a informazioni utili per affrontare la DPP e per esercitare la genitorialità in modo consapevole, mentre le difficoltà economiche possono restringere le risorse disponibili da destinare alla salute e al benessere materno. Infine, l’immigrazione rappresenta un fattore complesso: non è la condizione di migrante ad aumentare il rischio, ma le variabili a essa collegate, come il livello di acculturazione, il supporto sociale disponibile e lo status economico [8,9].
• Obesità, salute fisica e fattori genetici
Le donne obese presentano livelli più elevati di infiammazione e stress, due meccanismi ampiamente coinvolti nei disturbi depressivi. Un aspetto molto importante da non sottovalutare è la percezione del proprio corpo: gli studi disponibili indicano un’associazione positiva tra insoddisfazione e incidenza di DPP. In generale, il rischio tende a essere più elevato nelle madri con condizioni di salute precarie o con una storia di gravi patologie mediche. In questi casi, i problemi di salute possono minare la fiducia in sé stesse e nella propria capacità di prendersi cura del neonato [10].
Un ulteriore ambito di indagine riguarda i fattori genetici ed epigenetici. In presenza di eventi stressanti alcune varianti genetiche risultano associate alla DPP. Tra queste vi sono polimorfismi nei geni HMNC1, COMT, MAOT, PRKCB, ESR1, SLC6A4, e nel gene del BDNF (in particolare quando il post-partum avviene nei mesi autunnali e invernali). Inoltre, varianti nei geni OXT e OXTR sembrano correlarsi a un rischio maggiore nelle madri che hanno vissuto esperienze difficili durante l’infanzia [11].
• Fattori psicologici
Uno stato depressivo o di ansia durante la gravidanza, oppure una storia clinica di disturbi depressivi, rappresenta uno dei predittori più forti della DPP. Per esempio, le donne con precedenti episodi depressivi presentano un rischio più alto del 30% rispetto a chi non ha una storia psichiatrica. In questo gruppo è stata osservata anche una maggiore incidenza di “maternity blues”, un’alterazione dell’umore caratterizzata da labilità emotiva, irritabilità, tristezza, pianto facile, ansia e disturbi del sonno. Non è considerata una patologia psichiatrica vera e propria, ma una reazione fisiologica legata ai profondi cambiamenti ormonali, fisici ed emotivi che seguono il parto. Resta ancora aperto il dibattito se tale associazione sia dovuta a fattori psicosociali o a una vulnerabilità genetica [12].
Le madri con una buona autostima affrontano meglio
le pressioni dopo il parto, anche se questa fase di particolare fragilità può comunque limitare la fiducia in sé stesse, persino nelle donne più resilienti. È ormai consolidato che eventi di vita stressanti (lutti, separazioni, cambiamenti significativi come traslochi o perdita del lavoro) possano favorire lo sviluppo di depressione, ma gli studi retrospettivi rischiano di introdurre errori di valutazione, perché le donne possono sovrastimare eventi passati considerandoli possibili cause della malattia [13].
Anche la qualità della relazione di coppia e il supporto del partner svolgono un ruolo fondamentale. Le difficoltà coniugali durante la gravidanza sono state correlate a un maggior rischio di DPP, soprattutto per il senso di solitudine e la mancanza di sostegno percepito. Al contrario, un supporto coniugale adeguato risulta protettivo: riduce lo stress materno, abbassa il rischio di DPP e limita la progressione di sintomi depressivi già presenti in gravidanza. Infine, le donne che subiscono violenza in gravidanza sono più vulnerabili psicologicamente e presentano una sensibilità maggiore allo sviluppo di DPP. Il senso di vergogna, le barriere culturali e la mancata richiesta di aiuto possono aggravare la situazione, mentre i sintomi depressivi talvolta rappresentano una forma indiretta di richiesta di sostegno [9].
• Fattori ostetrici
Negli ultimi anni, il diabete gestazionale è diventato sempre più comune tanto che può essere considerato un fattore di rischio. Il meccanismo alla base non è ancora del tutto chiaro: vivere una gravidanza complicata dal diabete costituisce un’esperienza stressante e, tra i possibili fattori fisiopatologici che possono aumentare la vulnerabilità alla DPP, sono stati indicati la resistenza all’insulina e le risposte infiammatorie. Anche il parto cesareo è stato associato, in alcuni casi, a un rischio maggiore, probabilmente per l’aumento dello stress materno. Un possibile meccanismo coinvolge l’interleuchina-6, la cui concentrazione tende a crescere dopo un cesareo: poiché questa citochina è legata a fenomeni depressivi, potrebbe mediare la relazione tra intervento chirurgico e DPP. La carenza di vitamina D in gravidanza rappresenta un ulteriore potenziale fattore di rischio, con un ruolo sia nella depressione perinatale sia negli esiti negativi della gravidanza. Infine, le madri di neonati pretermine o con basso peso alla nascita presentano una probabilità più elevata di sviluppare DPP, soprattutto nel primo anno dopo il parto, verosimilmente a causa dello stress legato alla salute del bambino e alle possibili complicazioni [14,15].
• Effetti sull’attaccamento madre-neonato
La DPP influisce sull’attaccamento madre-neonato, un aspetto cruciale per lo sviluppo emotivo e sociale del bambino. Le difficoltà emotive della madre, come tristezza, affaticamento o ansia, possono ridurre la qualità del calore affettivo, compromettendo la sua capacità di rispondere in modo costante e adeguato ai bisogni del neonato. Ciò può
generare confusione e disagio nel bambino, che fatica a interpretare e prevedere i comportamenti materni. Le difficoltà nell’attaccamento possono avere conseguenze durature, favorendo lo sviluppo di schemi insicuri caratterizzati da ambivalenza, o resistenza nelle interazioni con la madre. Questi schemi, a loro volta, possono tradursi in problemi emotivi e comportamentali, come difficoltà nella regolazione delle emozioni, ridotta autostima e relazioni sociali compromesse con l’avanzare dell’età. Riconoscere l’impatto della DPP sull’attaccamento e offrire un supporto mirato è quindi fondamentale: diagnosi precoce, interventi tempestivi e terapie specifiche possono aiutare le madri a costruire legami più sicuri e affettuosi con i loro bambini, promuovendo uno sviluppo socio-emotivo sano e il benessere di entrambi [16].
Conclusioni
La DPP comporta conseguenze complesse e multifattoriali per le madri e per i bambini. Comprendere e ri-

conoscere queste implicazioni è essenziale per operatori sanitari, decisori politici e per la società nel suo insieme. Nonostante i progressi fatti, è necessario ampliare gli studi per arrivare a interventi mirati ed efficaci e migliorare l’accessibilità e la disponibilità di servizi e programmi di supporto per le madri che favoriscano il benessere della madre e del bambino.
1. Moreira LKS, Moreira CVL, Custódio CHX, Dias MLP, Rosa DA, Ferreira-Neto ML, Colombari E, Costa EA, Fajemiroye JO, Pedrino GR. Post-partum depression: From clinical understanding to preclinical assessments. Front Psychiatry. 2023 Apr 18;14:1173635
2. Su Y, D’Arcy C, Yuan S, Meng X. How does childhood maltreatment influence ensuing cognitive functioning among people with the exposure of childhood maltreatment? A systematic review of prospective cohort studies. J Affect Disord. (2019) 252:278–93
3. Hutchens BF, Kearney J. Risk factors for postpartum depression: an umbrella review. J Midwifery Womens Health. (2020) 65:96–108
4. Galea LA, Frokjaer VG. Perinatal depression: embracing variability toward better treatment and outcomes. Neuron. (2019) 102:13–6
5. Deligiannidis KM, Meltzer-Brody S, Gunduz-Bruce H, Doherty J, Jonas J, Li S, et al. Effect of Zuranolone vs placebo in postpartum depression: a randomized clinical trial. JAMA Psychiat. (2021) 78:951–9
6. Brunton PJ. Neuroactive steroids and stress axis regulation: pregnancy and beyond. J Steroid Biochem Mol Biol. (2016) 160:160–8
7. Wisner KL, Sit DK, Mc Shea MC, Rizzo DM, Zoretich RA, Hughes CL, et al. Onset timing, thoughts of self-harm, and diagnoses in postpartum women with screen-positive depression findings. JAMA Psychiat. (2013) 70:490–8
8. Akincigil A, Munch S, Niemczyk KC. Predictors of maternal depression in the first year postpartum: marital status and mediating role of relationship quality. Soc Work Health Care. 2010;49(3):227-44
9. Zhao XH, Zhang ZH. Risk factors for postpartum depression: An evidence-based systematic review of systematic reviews and meta-analyses. Asian J Psychiatr. 2020 Oct;53:102353
10. Ruyak SL, Lowe NK, Corwin EJ, Neu M, Boursaw B. Prepregnancy Obesity and a Biobehavioral Predictive Model for Postpartum Depression. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2016 MayJun;45(3):326-38
11. Elwood J, Murray E, Bell A, Sinclair M, Kernohan WG, Stockdale J. A systematic review investigating if genetic or epigenetic markers are associated with postnatal depression. J Affect Disord. 2019 Jun 15;253:51-62
12. Bloch M, Rotenberg N, Koren D, Klein E. Risk factors associated with the development of postpartum mood disorders. J Affect Disord. 2005 Sep;88(1):9-18
13. Zaidi F, Nigam A, Anjum R, Agarwalla R. Postpartum Depression in Women: A Risk Factor Analysis. J Clin Diagn Res. 2017 Aug;11(8):QC13-QC16
14. Robakis TK, Aasly L, Williams KE, Clark C, Rasgon N. Roles of Inflammation and Depression in the Development of Gestational Diabetes. Curr Behav Neurosci Rep. 2017 Dec;4(4):369-383
15. Accortt EE, Arora C, Mirocha J, Jackman S, Liang R, Karumanchi SA, Berg AH, Hobel CJ. Low Prenatal Vitamin D Metabolite Ratio and Subsequent Postpartum Depression Risk. J Womens Health (Larchmt). 2021 Jan;30(1):113-120
16. Saharoy R, Potdukhe A, Wanjari M, Taksande AB. Postpartum Depression and Maternal Care: Exploring the Complex Effects on Mothers and Infants. Cureus. 2023 Jul 4;15(7):e41381
Colpisce una donna su dieci in età fertile Ma esistono cure approvate
La sindrome dell’ovaio policistico è un disturbo endocrino che colpisce molte donne in età riproduttiva, ed è spesso associata a ovaie che si ingrossano perdendo la loro normale funzionalità, accompagnate da livelli elevati di androgeni e resistenza all’insulina. Si stima che circa 1 donna su 10 ne soffra prima della menopausa. Alla base della sua insorgenza vi è l’elevato rapporto tra l’ormone luteinizzante (LH), l’ormone follicolo-stimolante (FSH) e l’aumentata frequenza dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH). Ma l’eziologia e lo sviluppo completo della patologia non sono completamente conosciuti.
Gli studi disponibili suggeriscono il ruolo di diversi fattori esterni e interni, tra cui la resistenza all’insulina, l’iperandrogenismo, fattori ambientali, genetici ed epigenetici. Inoltre, è responsabile anche di ulteriori complicazioni come malattie cardiovascolari, diabete mellito di tipo 2, sindrome metabolica, depressione e ansia. Per gestire questa condizione, il passo più importante è perdere almeno il 5% del peso corporeo. Infatti, subito dopo la diagnosi, a ogni donna si raccomanda un piano di esercizio fisico regolare e diete prive di grassi e zuccheri, affiancata dall’utilizzo di contraccettivi orali combinati, agenti antiandrogeni, sensibilizzanti dell’insulina e induttori dell’ovulazione. Ad oggi, non esistono farmaci approvati e tutti quelli utilizzati nel corso di sperimentazioni cliniche attive sono “off-label”, cioè farmaci prescritti per un uso diverso da quello per cui sono stati approvati dalle autorità regolatorie. Questi spaziano da farmaci antidiabetici come pio-
glitazone, empagliflozin, sitagliptin, liraglutide, a inibitori della 3-idrossi-3-metil-glutaril-coenzima A (HMG-CoA) reduttasi, come simvastatina e atorvastatina, fino a farmaci mucolitici come la N-acetilcisteina [1].
Diagnosi
La sindrome dell’ovaio policistico non può essere diagnosticata tramite test diagnostici di base, come esami del sangue, colture o biopsie e non esiste un test specifico. La diagnosi differenziale consiste nell’escludere i disturbi correlati in base ai sintomi, restringendo così il campo. Per stabilire una diagnosi differenziale è necessario escludere l’iperprolattinemia, le malattie tiroidee, la sindrome di Cushing e l’iperplasia surrenalica, sulla base degli accertamenti clinici correlati. La valutazione della storia clinica, dei cambiamenti di peso e dei sintomi di resistenza all’insulina sono utili, ma le indagini maggiormente raccomandate sono l’esame pelvico, l’ecografia transvaginale e la misurazione dei livelli ormonali. I criteri diagnostici specifici includono: mestruazioni irregolari o poco frequenti, elevati livelli di ormoni androgeni (o sintomi associati), e riscontro ecografico di ovaie policistiche. Secondo i criteri diagnostici di Rotterdam, la diagnosi può essere confermata in presenza di almeno due dei seguenti tre criteri: iperandrogenismo, disfunzione ovulatoria e presenza di ovaie policistiche all’ecografia [2].
Fattori di rischio
• Epigenetica
Nelle donne con sindrome dell’ovaio policistico si
osserva spesso una maggiore attività dell’ormone luteinizzante (LH), un fenomeno che potrebbe essere legato a disfunzioni nello sviluppo dei follicoli ovarici e all’iperandrogenismo (eccesso di ormoni androgeni), due caratteristiche tipiche della condizione. Un elemento chiave di questo squilibrio è il recettore per LH/coriogonadotropina (LHCGR), coinvolto nella produzione di ormoni steroidei da parte delle cellule della teca, strutture del follicolo ovarico che sintetizzano androgeni. Quando il gene del recettore LHCGR è ipometilato, la sua espressione aumenta, rendendo le cellule più sensibili all’azione del LH. Uno studio ha evidenziato che proprio questa ipometilazione è associata a una sovraespressione del recettore LHCGR sulla superficie delle cellule della teca. Un altro protagonista è l’enzima epossido idrolasi 1 (EPHX1), che partecipa alla degradazione di composti aromatici. Anche in questo caso, l’ipometilazione del promotore del gene EPHX1 porta a un’aumentata produzione dell’enzima. Quando EPHX1 è presente in eccesso, riduce la conversione del testosterone
in estradiolo, contribuendo allo squilibrio ormonale caratteristico della sindrome. Infine, il recettore gamma attivato dai proliferatori dei perossisomi (PPAR- γ), importante per la funzione ovarica, risulta alterato nelle pazienti con ovaio policistico e iperandrogenismo. In particolare, si osservano: ipermetilazione del gene PPAR γ, ipometilazione del gene del co-repressore nucleare 1 (NCOR1), e alterazioni dell’acetilazione della deacetilasi istonica 3 (HDAC3), entrambi co-repressori di PPARγ. Queste modificazioni epigenetiche sono state riscontrate nelle cellule della granulosa, un altro tipo di cellula follicolare centrale nella regolazione ormonale dell’ovaio [3,4].
• Stress e alimentazione
Lo stress è una condizione che può avere effetti negativi sulla salute mentale e sull’autostima delle donne con l’ovaio policistico. Quello cronico favorisce la crescita e l’aumento di numero degli adipociti (cellule del tessuto adiposo), un processo mediato dall’azione dei glucocorticoidi sulla maturazione dei pre-adipociti. Inoltre, lo


© JitendraJadhav/shutterstock.com
stress prolungato è associato a: un’aumentata secrezione di adipochine, l’attivazione e richiamo di cellule immunitarie nel tessuto adiposo, un aumento di citochine infiammatorie come IL-6 e TNF- α e un disequilibrio tra ossidanti e antiossidanti. Tutti questi fattori concorrono a creare un ambiente pro-infiammatorio che può aggravare la sindrome. Lo stress ha anche un impatto diretto sull’insulino-resistenza. Attivando l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), stimola il rilascio di cortisolo che, a sua volta: favorisce l’accumulo di grasso viscerale, stimola la gluconeogenesi (produzione di glucosio nel fegato), aumenta la lipolisi (degradazione dei grassi), e contribuisce all’iperinsulinemia. Inoltre, è stato ipotizzato che lo stress possa interferire con i livelli dell’ormone anti-mülleriano (AMH) e alterare l’equilibrio degli ormoni sessuali, aggravando ulteriormente la disfunzione ovarica [5].
Anche l’alimentazione può influenzare lo sviluppo della sindrome. Il consumo eccessivo di acidi grassi saturi è associato a un aumento dello stato infiammatorio e una ridotta sensibilità all’insulina. Questi grassi promuovono l’infiammazione inducendo la produzione di TNF- α e l’espressione di specifici soppressori delle citochine. La carenza di vitamina D, invece, potrebbe aggravare sia la sindrome che le sue comorbidità dato che è associata a una maggiore risposta infiammatoria e quindi a una maggiore insulino-resistenza. Inoltre, inibisce l’attività del promotore dell’AMH, il cui aumento è spesso implicato nella disfunzione ovarica [6].
Diversi studi hanno rilevato un aumento di stress ossidativo che porta all’attivazione del fattore di trascrizione NF- κ B, coinvolto nei processi infiammatori, stimola la produzione di citochine pro-infiammatorie come TNF- α e IL-6, e contribuisce all’insulino-resistenza. Inoltre, lo stress ossidativo favorisce l’obesità attraverso l’aumento delle dimensioni degli adipociti maturi [7]. L’obesità viscerale è uno dei principali fattori scatenanti di infiammazione cronica di basso grado. L’accumulo di grasso addominale porta a: ipossia locale, necrosi adipocitaria e alla conseguente produzione di citochine infiammatorie da parte di cellule mononucleate presenti nel tessuto adi -
poso. Oltre al ruolo infiammatorio, l’obesità contribuisce allo sviluppo di iperinsulinemia, insulino-resistenza e iperandrogenismo. L’accumulo di grasso viscerale aumenta i livelli di acidi grassi liberi nel sangue che vengono utilizzati dai muscoli al posto del glucosio, causando iperglicemia e stimolando una risposta pancreatica eccessiva (iperinsulinemia). Il grasso viscerale, inoltre, è più coinvolto nella resistenza all’insulina rispetto a quello sottocutaneo per via di una maggiore espressione dei recettori β 1, β 2, β 3 adrenergici, elevata attività dell’enzima 11 β -HSD tipo 1, che converte cortisone in cortisolo, interferendo con la segnalazione insulinica.
Il tessuto adiposo non è solo un deposito energetico, agisce anche come organo endocrino, producendo adipochine che influenzano la funzione ovarica e metabolica. La leptina ne è un esempio: in concentrazioni elevate, inibisce l’espressione dell’aromatasi nelle cellule della granulosa, bloccando la conversione degli androgeni in estrogeni; livelli alti di leptina sono associati a blocco della follicologenesi. L’adiponectina, invece, ha effetti anti-infiammatori, insulino-sensibilizzanti e contribuisce alla produzione di estrogeni e progesterone, ovulazione, e regolazione dell’LH e del GnRH. Il tessuto adiposo, poi, ospita enzimi responsabili della conversione degli androgeni. L’enzima 17 β -HSD converte androstenedione in testosterone e estrone in estradiolo.
Questo contribuisce direttamente all’iperandrogenismo nelle donne obese affette da ovaio policistico. Inoltre, l’accumulo di lipidi nei tessuti non adiposi, come muscoli e fegato, provoca stress ossidativo ed endoplasmatico, aggravando l’insulino-resistenza. Nel fegato, l’eccesso lipidico riduce l’espressione del fattore HNF-4 α , diminuendo la produzione di SHBG, la proteina legante gli ormoni sessuali, con conseguente aumento di testosterone libero in circolo [8,9].
Trattamento
Il trattamento deve essere basato sulle priorità individuali della paziente e le esigenze possono variare. Alcune donne cercano una soluzione per l’infertilità, altre vogliono regolare il ciclo mestruale, perdere peso, o alleviare i sintomi iperandrogenici come acne, irsutismo o alopecia androgenetica. Non esiste un trattamento unico e ideale valido per tutte le pazienti. Per questo motivo, i medici adottano spesso un approccio sintomatico, concentrandosi sui disturbi specifici riportati dalla paziente.
L’aumento dei livelli di androgeni favorisce l’accumulo di grasso viscerale, soprattutto nella zona addominale, portando a una conformazione fisica a “mela” o a “pera”. La prima strategia consigliata in questi casi è la riduzione del peso corporeo e del consumo calorico. Anche una perdita del 5–10% del peso può essere sufficiente per ripristinare
il ciclo mestruale regolare. L’obiettivo, in particolare per le donne in sovrappeso e obese, dovrebbe essere il raggiungimento di un indice di massa corporea (BMI) nella norma.
La perdita di peso comporta benefici significativi, come la riduzione del testosterone libero e la diminuzione del rischio di sindrome metabolica. Non esiste una dieta “universale” ma una dieta efficace dovrebbe essere ricca di fibre, povera di grassi saturi e carboidrati ad alto indice glicemico. L’attività fisica è fondamentale non solo per la perdita di peso, ma anche per migliorare la sensibilità all’insulina. Le raccomandazioni dell’American Heart Association (AHA) prevedono: almeno 150 minuti a settimana di attività moderata, oppure 75 minuti di attività intensa.
In particolare, l’attività fisica riduce l’insulina e gli androgeni liberi, migliora la regolazione neuroendocrina della funzione ovarica, e può favorire il ritorno di un’ovulazione fisiologica, specialmente nelle donne in sovrappeso o obese [10].
Fornire consigli sullo stile di vita sano a tutte le donne con diagnosi di ovaio policistico è fondamentale prima di passare al trattamento farmacologico, indipendentemente dal peso corporeo, dai sintomi presenti o dal desiderio di una gravidanza. Questo perché, soprattutto nei casi lievi o moderati, molte donne possono trarre beneficio esclusivamente da dieta ed esercizio fisico.
Nei casi in cui questo non sia sufficiente, la scelta terapeutica deve basarsi sulle preferenze e condizioni cliniche della paziente.
Quando la paziente non desidera una gravidanza e il principale disturbo è l’irregolarità mestruale, il trattamento di prima scelta è rappresentato da contraccettivi orali combinati oppure progestinici. Alcuni farmaci come Yasmin® o Yaz® offrono anche effetti antiandrogenici, riducendo la produzione di androgeni. Questo li rende particolarmente utili in presenza di irsutismo e/o acne. La metformina, appartenente alla classe delle biguanidi, è spesso prescritta in associazione ai contraccettivi ed è utile per: aumentare la sensibilità all’insulina, favorire l’ovulazione, e, a breve termine, esercitare un effetto antiandrogenico.
Per le pazienti che vogliono trattare principalmente le manifestazioni dermatologiche da iperandrogenismo, come acne o irsutismo, sono indicati: antagonisti del recettore dell’aldosterone, come spironolattone, oppure inibitori della 5-alfa reduttasi, come finasteride. Nel caso di donne con problemi di fertilità, il trattamento si basa sull’induzione dell’ovulazione. I farmaci più utilizzati includono: citrato di clomifene, inibitori dell’aromatasi. Ogni terapia farmacologica presenta limiti e precauzioni, e non tutte le pazienti possono trarre beneficio da questi trattamenti a causa di effetti avversi e controindicazioni. I contraccettivi, per esempio, possono causare nausea, vomito, mal di testa, emicrania e depressione.
Questi effetti derivano dalla simulazione dello stato ormonale tipico della gravidanza. La metformina, nei primi giorni di assunzione, può provocare disturbi gastrointestinali che spesso portano a interrompere la terapia [11].
Conclusioni
L’insorgenza e lo sviluppo della sindrome dell’ovaio policistico non è ancora completamente chiara, però diversi fattori contribuiscono all’aggravamento della condizione, dalle alterazioni epigenetiche all’obesità, dall’infiammazione alla sedentarietà. Non esiste ancora un farmaco specifico o una cura definitiva, pertanto l’approccio terapeutico consiste in una terapia sintomatica con contraccettivi orali, antidiabetici e antiandrogeni, dopo aver fornito consigli sullo stile di vita e alcune indicazioni riguardanti la storia clinica. (D. B.).
1. Sadeghi HM, Adeli I, Calina D, Docea AO, Mousavi T, Daniali M, Nikfar S, Tsatsakis A, Abdollahi M. Polycystic Ovary Syndrome: A Comprehensive Review of Pathogenesis, Management, and Drug Repurposing. Int J Mol Sci. 2022 Jan 6;23(2):583
2. European Society of Human Reproduction and Embryology. International Evidence-Based Guideline for the Assessment and Management of Polycystic Ovary Syndrome. 2018. Available online: https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Polycystic-Ovary-Syndrome (accessed on 22 September 2021)
3. Li, Y.; Chen, C.; Ma, Y.; Xiao, J.; Luo, G.; Li, Y.; Wu, D. Multi-system reproductive metabolic disorder: Significance for the pathogenesis and therapy of polycystic ovary syndrome (PCOS). Life Sci. 2019, 228, 167–175
4. Abbott, D.H.; A Dumesic, D.; E Levine, J. Hyperandrogenic origins of polycystic ovary syndrome – implications for pathophysiology and therapy. Expert Rev. Endocrinol. Metab. 2019, 14, 131–143
5. Yang, S.; Yang, C.; Pei, R.; Li, C.; Li, X.; Huang, X.; Wu, S.; Liu, D. Investigation on the association of occupational stress with risk of polycystic ovary syndrome and mediating effects of HOMA-IR. Gynecol. Endocrinol. 2018, 34, 961–964
6. Ciebiera, M.; Esfandyari, S.; Siblini, H.; Prince, L.; Elkafas, H.; Wojtyła, C.; Al-Hendy, A.; Ali, M. Nutrition in Gynecological Diseases: Current Perspectives. Nutrients 2021, 13, 1178
7. Mizgier, M.; Jarząbek-Bielecka, G.; Wendland, N.; Jodłowska-Siewert, E.; Nowicki, M.; Brożek, A.; Kędzia, W.; Formanowicz, D.; Opydo-Szymaczek, J. Relation between Inflammation, Oxidative Stress, and Macronutrient Intakes in Normal and Excessive Body Weight Adolescent Girls with Clinical Features of Polycystic Ovary Syndrome. Nutrients 2021, 13, 896
8. Delitala, A.; Capobianco, G.; Delitala, G.; Cherchi, P.L.; Dessole, S. Polycystic ovary syndrome, adipose tissue and metabolic syndrome. Arch. Gynecol. Obstet. 2017, 296, 405–419
9. Watanabe, T.; Watanabe-Kominato, K.; Takahashi, Y.; Kojima, M.; Watanabe, R. Adipose Tissue-Derived Omentin-1 Function and Regulation. Compr. Pshysiol. 2017, 7, 765–781
10. Faghfoori, Z.; Fazelian, S.; Shadnoush, M.; Goodarzi, R. Nutritional management in women with polycystic ovary syndrome: A review study. Diabetes Metab. Syndr. Clin. Res. Rev. 2017, 11, S429–S432
11. Zeind, C.S.; Carvalho, M.G. Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs; Wolters Kluwer Health: Philadelphia, PA, USA, 2017