Elena Buccoliero



Strumenti per educare alle emozioni e sostenere i bambini vittime di violenza assistita
edizioni la meridiana partenze
Strumenti per educare alle emozioni e sostenere i bambini vittime di violenza assistita
Prefazione di Gloria Soavi
edizioni la meridiana partenze
Prefazione di Gloria Soavi ......................................11
Sole e tempesta: dalla storia di Nico al percorso in classe ...............15
PRIMA TRACCIA DI LAVORO
In un mondo di contraddizioni ..............................27
1. Papà di sole e papà di tempesta ......................28
2. Un papà, o forse due .......................................31
3. Gli incubi di Nico ............................................34
4. Il mondo su due colonne .................................35
5. Lo specchio magico ..........................................36
6. Il segreto del papà ...........................................39
SECONDA TRACCIA DI LAVORO
Comprendere la realtà, riconoscere le emozioni ...45
1. Trova l’intruso ..................................................46
2. Il mantello, il quaderno, lo specchio ...............49
3. Le emozioni di Nico ........................................52
4. Indovina come mi sento ..................................57
5. Lacrime di tanti colori ......................................60
6. Lo sgabuzzino ..................................................63
TERZA TRACCIA DI LAVORO
In particolare, la rabbia ..........................................71
1. Io mi arrabbio, tu ti arrabbi... tutti si arrabbiano .............................................72
2. La rabbia che trasforma ...................................76
3. La rabbia gialla, rossa, verde e viola ...............79
4. La paura e il coraggio ......................................88
5. Una rabbia indigesta.........................................94
6. Giocare con la tempesta ...................................97
Dalla pagina al palcoscenico: un’esperienza ..........99
Papà di sole e papà di tempesta: la favola ...........101
Bibliografia ...........................................................140
Ringraziamenti ......................................................141
di Gloria Soavi1
Nico, il protagonista della favola Papà di sole e papà di tempesta che troverai nelle ultime pagine di questo libro, vive una situazione particolare: il suo papà ha due facce, di sole e di tempesta appunto. Nico ha a che fare con queste due realtà in contraddizione fra loro, ma che coesistono: un papà giocoso e allegro ma anche un papà che si arrabbia tanto, da cui bisogna difendersi. Questo papà fa male alla mamma e provoca in Nico emozioni dolorose e difficili da sopportare. Accompagnando Nico nella sua storia, capiremo quanta fatica fa il bambino a tenere dentro di sé queste due realtà cercando di interpretarle con gli strumenti di cui dispone, e comprenderemo meglio i suoi vissuti. La rabbia, la tristezza, la paura, l’impotenza ma anche la gioia quando il papà è allegro, la voglia di stargli vicino e godere di quei momenti. Tutte queste emozioni contrastanti provocano in Nico dei problemi che lui manifesta a scuola, come succede a tutti i bambini e le bambine che vivono in contesti violenti e per loro incomprensibili. La realtà, infatti, è complessa: non è tutta bianca o tutta nera, ma variegata, e adattarsi non è facile, provoca dolore.
1. Psicologa e psicoterapeuta, formatrice, è stata a lungo presidente nazionale del CISMAI; il CISMAI è il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia. Al CISMAI si deve l’introduzione in Italia della violenza assistita nel dibattito scientifico sul maltrattamento minorile.
Alla fine Nico, grazie a un adulto diverso, la maestra, troverà la strada per capire e per attivare un cambiamento che condurrà a un lieto fine, come nelle favole. Ma le favole possono diventare realtà quando c’è la possibilità di chiedere aiuto all’esterno, e questo è l’altro messaggio importante che la storia ci lascia: si può e si deve parlare di violenza, con i dovuti modi, perché i bambini sappiano che c’è una via d’uscita, che altri adulti possono aiutarli. Questo messaggio è particolarmente importante perché restituisce fiducia in se stessi e nel mondo adulto a bambini che purtroppo sperimentano relazioni negative con le figure di riferimento più importanti per loro.
La violenza è un tema difficile che suscita reazioni di minimizzazione e di negazione. È facile mettere in atto questi meccanismi per esorcizzarla, per allontanarla, per difenderci, ma sicuramente non serve per farla sparire.
A tutti noi, adulti, risulta faticoso e a volte doloroso riconoscere che purtroppo la violenza esiste.
In particolare quella che si manifesta all’interno delle mura domestiche crea forti resistenze: è difficile pensare che proprio nella famiglia, luogo di intimità e di affetti, si possano creare condizioni che fanno soffrire i suoi componenti, compresi i più piccoli e fragili, i bambini; o che questi ultimi possano assistere a comportamenti violenti sulle persone care o possano essere loro stessi vittime. Queste reazioni, che sono sostanzialmente difensive (è naturale allontanare da noi situazioni connotate negativamente), non solo condizionano la possibilità di riconoscere la violenza, ma impediscono di fatto la lettura delle reazioni emotive che la accompagnano. È come se, non vedendola, la negassimo e negassimo anche tutto il dolore, la paura, l’impotenza di chi la sta purtroppo sperimentando. La negazione condanna al silenzio e all’indifferenza le vittime, specie se bambini e ragazzi.
La quotidianità, a volte attraverso la cronaca, altre volte negli incontri che contrassegnano il nostro lavoro di operatori o insegnanti, ci porta purtroppo a renderci conto che queste situazioni sono più frequenti di quello che ci piacerebbe pensare.
La reazione affiora immediata: è difficile parlarne fra adulti, perché allora parlarne con i bambini? Tante sono le resistenze e gli stereotipi che gli adulti mettono in atto sottovalutando la capacità di bambini e ragazzi di comprendere situazioni dolorose e difficili, e di esprimere emozioni e sentimenti congruenti.
Spesso si ritiene che i bambini non siano in grado di afferrare concetti astratti che riguardano le relazioni e i problemi dei grandi: questo pregiudizio porta al silenzio, a livello sociale e familiare2, su tematiche importanti o dolorose che non vengono affrontate dagli adulti con le parole, ma che il bambino percepisce e vive tutti i giorni. Pensiamo alle malattie – sia organiche che psichiatriche – che colpiscono persone del nucleo familiare, ai conflitti coniugali, ai lutti. Talvolta, nel tentativo di proteggerli, i genitori evitano il confronto con i propri figli, ma così facendo li lasciano soli e impreparati ad affrontare esperienze dolorose e difficili da decodificare, delegando più o meno consapevolmente ad altri il compito di informarli oppure sperando che dimentichino, o che trovino in loro stessi il modo di superare i brutti momenti. Più che strategie protettive per i più piccoli, questi atteggiamenti sono forme di evitamento cognitivo ed emotivo funzionali innanzitutto agli adulti, a non urtare le loro paure e le loro difese, legate a una incapacità di accompagnare i bambini. Altre volte gli adulti rompono il silenzio per consegnare ai bambini una versione edulcorata degli eventi dolorosi: dicono una parte della realtà ma ne mo-
2. Solantaus et al., 2010, pp. 883-892.
dificano altri aspetti per attutire il dolore. Resta il fatto che quando, nel breve o nel medio periodo, la discrepanza tra realtà osservata dal bambino e narrazione ricevuta dagli adulti diventa evidente, il bambino vive sentimenti di solitudine e di confusione. Si fida degli adulti, ma crede anche a ciò che vive e non sa come tenere insieme due versioni incompatibili. Da queste contraddizioni possono ingenerarsi meccanismi di scissione e distorsione nella percezione della realtà o, più in generale, si può compromettere nel bambino la capacità di pensiero. Questo intralcia anche la costruzione di adeguate strategie di coping (adattamento) per affrontare le situazioni difficili3.
L’idea di risparmiare sofferenze ai bambini evitando di dare loro spiegazioni realistiche e veritiere è, quindi, un pregiudizio errato: diverse evidenze scientifiche4 affermano che la capacità dei bambini di elaborare i traumi e le esperienze sfavorevoli è strettamente legata alla possibilità di parlare di ciò che li turba e di trovare nell’adulto un adeguato sostegno e accompagnamento nelle situazioni difficili5.
Tutto questo è vero anche se parliamo della violenza, quella conosciuta indirettamente e ancor più quella che accade in famiglia. Parlarne significa attrezzare i bambini ad affrontarla in modo meno traumatico e più consapevole.
Pensiamo a un bambino che sia vittima diretta, oppure testimone, di violenza familiare. Quasi sempre non ne può parlare con nessuno, si sente solo, impaurito, impotente, prova dolore, ha l’ingiunzione al segreto da parte degli adulti. Allo stesso tempo si vergogna perché si sente diverso dagli altri, non riesce a mettere in parola quello che gli sta succedendo, prova un coacervo di emozioni e sentimenti difficili da control-
3. Vadilonga et al., 2012, pp. 109-120.
4. Cohen et al., 2006, pp. 737-766.
5. Vadilonga, op. cit.
lare. Le ricerche e l’esperienza clinica ci dicono che questi bambini sviluppano sintomi attraverso i quali manifestano il loro dolore e la loro angoscia. In genere si esprimono a livello emotivo con atteggiamenti di chiusura o di attivazione eccessiva, oppure emergono nei comportamenti. Per questi bambini, rileggere la propria situazione anche indirettamente, attraverso una favola, rende la loro condizione più accettabile, non si sentono così diversi, capiscono di non essere gli unici a vivere quella realtà così difficile. È fondamentale per loro riconoscere le emozioni che stanno provando, dare loro un nome, non averne paura e imparare che quello che provano è normale e importante. Una storia che porta alla luce ciò che non può e non deve essere detto ha per questi bambini una funzione in parte riparativa , permette di venire allo scoperto, di chiedere aiuto. Il racconto trasmette il messaggio che gli adulti intorno possono fare qualcosa, ma prima di tutto conoscono queste situazioni e non si spaventano ad affrontarle. Si ripristinano quindi funzioni importanti nel rapporto fra adulti e bambini: quella della protezione , c’è qualcuno che può fare qualcosa per aiutarmi ad uscire da una condizione in cui mi sento intrappolato e impotente, e quella della costruzione della fiducia nel mondo adulto, che non mi lascia solo e si preoccupa del mio benessere. Un mondo adulto che si fa carico dei più fragili, non malevolo ma attento e riparatore, può contrastare efficacemente il vissuto dei bambini che sperimentano in famiglia una condizione di invisibilità, tra adulti che, per diverse ragioni e responsabilità, non riescono a occuparsi del benessere dei più piccoli, proprio come accade nella violenza assistita.
I bambini che, per fortuna, non vivono queste situazioni, attraverso una favola come Papà di sole e papà di tempesta, prendono contatto con emozioni complesse, come la rabbia e la paura, che appartengono a tutti, e sviluppano la capacità di
riconoscerle in se stessi e negli altri. È una preziosa opportunità poiché implementa e sviluppa, come si propone il testo, l’intelligenza emotiva 6 , cioè la consapevolezza di sé, che vuol dire autoconsapevolezza del proprio stato emotivo: imparare ad ascoltare, riconoscere ed esprimere le proprie emozioni apertamente e a decodificarle negli altri. Ciò permette lo strutturarsi dell’empatia, la capacità di sintonizzarsi emotivamente con chi ci è accanto, per aumentare la comprensione dell’altro e lo strutturarsi di relazioni interpersonali migliori sul piano della comunicazione e della condivisione.
Approcciare le emozioni, dare loro un nome, spiegarle, sperimentarle attraverso laboratori e attività – come quelle proposte in questo libro, pensate ad hoc per i bambini, che sono per noi straordinari maestri – diventa un passaggio estremamente importante.
La storia di Nico offre tutte queste possibilità. È uno strumento apparentemente semplice, ma al tempo stesso complesso perché affronta molte sfaccettature e offre numerosi spunti di approfondimento. Entra nel dettaglio piano piano, con molta cautela e rispetto. Esplora il mondo di un bambino che soffre, descrive il suo vissuto, dà un nome alle emozioni e agli affetti.
6. Goleman, 2011.
sato per le attività qui proposte è quello della facilitazione di un gruppo, non quello dell’insegnamento tradizionale. Questo libro non è per chi in quel periodo, magari per proprie comprensibili ragioni, fatica a guardare negli occhi i bambini, ad ascoltarli. La conduzione delle attivazioni richiede che occhi, orecchie e cuore siano aperti a cogliere ciò che avviene nella dinamica di gruppo perché è proprio il gruppo lo strumento principe, quello che consente anche al singolo di rielaborare pensieri ed emozioni e di strutturare modalità positive di relazione con gli altri.
A chi si rivolge questo libro?
I percorsi che in questo libro vengono proposti sono affidati a educatori, insegnanti, psicologi e operatori sociali interessati a svolgere percorsi educativi sulla consapevolezza emotiva, con un accento particolare sulle emozioni difficili: la rabbia, la tristezza, la paura. Impegnarsi su questo terreno è un modo per prevenire la violenza – chi ha confidenza con le proprie emozioni e riesce a parlarne, o a chiedere aiuto, più difficilmente avrà reazioni istintive e dannose per sé e per gli altri – oltre che per offrire sostegno ai bambini e alle bambine1 immersi in famiglie difficili. È probabile che questo libro sia per molti ma non proprio per tutti. Tanto per cominciare, questo libro non è per chi non si sente a proprio agio senza una cattedra o una scheda di valutazione da riempire. Niente da ridire sulle cattedre e sulle valutazioni – o almeno, non in questa sede – ma l’approccio pen-
1. Nel testo si usa a volte la dicitura “bambini e bambine”, come in questo caso, e in altre si ricorre all'espressione sintetica “bambini”, per ragione di sintesi e sempre intendendo il plurale esteso. Lo stesso quando si scrive “educatori” o “operatori”, avendo a mente anche le educatrici e le operatrici, e via di seguito.
Ancora, questo libro è sconsigliato a chi pensa che i piccoli siano adulti in miniatura, che non capiscano le cose difficili o non sappiano esprimersi su quello che vivono. Ma c’è da credere che adulti con queste convinzioni non si avvicinino neppure a un titolo come questo.
Infine, ma non ultimo, il libro non è una bacchetta magica per apprendisti stregoni. I percorsi indicati sono alla portata di insegnanti ed educatori come di psicologi o altre figure che operano nel sociale, purché abbiano una formazione e una esperienza di base nella conduzione dei gruppi. Il conduttore, anche quando svolge il mestiere di insegnante, nel corso delle attività diventa un facilitatore, garante della comunicazione e del rispetto tra pari. Non fa prediche preordinate e non cerca di imporre la propria visione, ma si mette in posizione di ascolto attivo ed è capace di dare stimoli che inneschino riflessioni e interazioni tra pari. Valorizza il contributo di tutti i bambini e le bambine senza giudicare le loro idee, e non dà voti ai disegni o ai prodotti. Questo libro è sicuramente indirizzato a coloro che come insegnanti, psicologi ed educatori hanno già esperienza e competenza come conduttori di gruppo e sono alla ricerca di uno strumento duttile, innovativo, basato sulla narrazione, per accompagnare i bambini e le bambine nella consapevolezza delle proprie emozioni.
C’era una volta un bambino...
Ho scritto Papà di sole e papà di tempesta nel 2013, di getto, una domenica mattina. Ero, allora, giudice onorario minorile e in quei giorni, durante un’udienza particolarmente intensa, un bambino mi aveva raccontato che il papà faceva del male alla mamma. Era sgomento, addolorato, confuso. Avrebbe voluto proteggere la mamma, nascondersi, cacciare via il padre, farlo sentire così amato da placarlo, tutte queste cose insieme.
Quando ho scritto questa favola ero carica di emozioni e di contraddizioni, ma più di tutto desideravo una trama che rendesse dicibile la violenza familiare e facesse sentire meno soli i bambini e le bambine che la sperimentano. La violenza chiusa dentro le case è distruttiva, incomprensibile, difficile da nominare. Guasta le relazioni, mette in allerta costante, costringe a gimkane emotive per resistere e per crescere, mentre la paura penetra nella carne e toglie il respiro. Dopo la prima stesura, la favola è stata sottoposta al vaglio di alcune esperte e di tante classi di scuola primaria, è stata arricchita ed è diventata, nel tempo, laboratorio maieutico per la scuola primaria, formazione per gli adulti, spunto per consulenze individuali, spettacolo teatrale.
Da oggi, anche la base per percorsi educativi da svolgere in gruppo, in un’ottica di prevenzione della violenza di genere e di educazione alle emozioni.
ni in carico ai servizi sociali italiani2 mentre decine di migliaia di donne con figli che chiedono aiuto ai centri antiviolenza (e non necessariamente sono seguite dai servizi sociali) riportano che i loro bambini e bambine sono esposti alle intemperanze del padre3.
E non è ancora tutto: ci sono famiglie, non sappiamo quante, nelle quali la violenza si ripete per anni e non c’è psicologa, educatore, assistente sociale o carabiniere ad arginarla perché tutto accade nel silenzio. Parliamo qui della violenza sulla madre, non perché questo esaurisca il tema (non sono le donne le uniche a subire maltrattamenti in famiglia) ma in quanto raccoglie la maggior parte della casistica riscontrata. Tante donne non denunciano, tanti papà non riconoscono il danno che stanno provocando. Gli adulti rimangono in quella relazione per anni prima di interromperla o di chiedere aiuto. Intanto il tempo passa, i bambini e le bambine continuano a respirare un’aria cattiva. Il fardello si fa più greve.
In un’indagine ormai datata tra giovani di 16/19 anni, incontrati in scuole e centri di formazione professionale (e dunque non necessariamente segnalati o seguiti da chicchessia), risultava che un adolescente su sei era stato spettatore di violenza fisica tra gli adulti della sua famiglia almeno una volta4.
Un dato preoccupante, che andrebbe verificato e aggiornato ma fa intuire che un grande numero di giovanissimi conosce la violenza molto da vicino. Coloro per i quali lo scenario si ripe-
Dove sono i bambini e le bambine testimoni di violenza familiare?
Vanno a scuola, frequentano gli oratori, le palestre e le biblioteche di quartiere proprio come tutti gli altri. Benché costituiscano una minoranza, non sono casi isolati: la violenza assistita è la seconda forma di maltrattamento tra i minoren-
2. La Terza indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, condotta dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con CISMAI e Terre des Hommes in collaborazione con Istat (2025), riporta che, al 31.12.2023, 13 minorenni ogni 1.000 residenti in Italia sono presi in carico dai servizi sociali per maltrattamento. Di essi, un terzo (il 34%) è in carico in quanto testimone di violenza familiare.
3. Dal report Istat 2024 sull’utenza in carico ai centri antiviolenza: nel 2023 le donne che si sono rivolte ai aentri sono state 61.514. Il 77,6% delle donne che hanno figli dichiara che questi ultimi sono testimoni della violenza familiare e il 23,0% riporta che sono coinvolti anche in quanto subiscono violenza diretta. Il 14,6% delle donne ha subito violenza anche durante la gravidanza. 4. Buccoliero, 2018.
te e assume livelli davvero allarmanti, invece, sono una piccola parte dei bambini e delle bambine che incontriamo.
Come facciamo a riconoscere la violenza assistita?
I bambini e le bambine testimoni di violenza non sono facilmente distinguibili dai coetanei, anche se spesso si sentono soli e diversi dagli altri per il carico emotivo che portano con sé ogni giorno. Riceveranno aiuto solo e soltanto se i genitori – o almeno uno dei due, e generalmente è la madre – chiederanno aiuto.
Quei bambini portano con sé una domanda silenziosa, o dirompente, cui occorre dare risposta. Offrono l’occasione ai loro coetanei e a tutti noi di imparare a riconoscere la violenza e di interromperla, per provare a trasformarla. Talvolta gli adulti, anche i più preparati – come insegnanti ed educatori – temono di avvicinarsi troppo alla sofferenza dei bambini, per la paura di non riuscire a consolarli, di non trovare le parole giuste o di sbagliare qualcosa dal punto di vista legale. Questi timori sono comprensibili e vanno riconosciuti, ma devono venire in un secondo momento.
vittime di maltrattamento. Spesso vincolati a tacere, disorientati dalla paura e dal segreto, sono in difficoltà nel comprendere i fatti e nel dar loro un nome perché quegli adulti annodati insieme, assorbiti dalle loro dinamiche, sono proprio il papà e la mamma ed è inaccettabile, durante l’infanzia, credere che le persone più amate, le più importanti, quelle su cui si conta di più, possano fare e farsi tanto male.
In futuro, quei bambini e quelle bambine saranno adolescenti e poi adulti a rischio. Non dei predestinati, no, ma avranno una maggiore probabilità, rispetto ai coetanei, di diventare (soprattutto, ma non soltanto i maschi) autori di violenza nei confronti del partner oppure (specialmente le femmine, ma non solo) vittime nel rapporto di coppia, riproducendo i modelli appresi dai genitori. Occuparci di loro, dunque, ha una doppia valenza: lenire la sofferenza del presente e prevenire quella di domani, aprendo il dialogo, offrendo modelli alternativi di relazione e di genere.
È importante trovare le parole per farlo. Costruire una narrazione per il disagio o la sofferenza è una mano tesa per chiunque si trovi in difficoltà ed è fondamentale per i bambini e le bambine testimoni di violenza, che dagli adulti ricevono orientamenti essenziali per dare un significato alla loro esperienza.
Che cosa accade ai bambini e alle bambine testimoni di violenza?
La violenza assistita intrafamiliare – appunto quella di cui bambini e ragazzi sono spettatori – è gravida di conseguenze. Bambine adultizzate precocemente, oppure drammaticamente insicure; bambini aggressivi che riportano nei rapporti con gli altri le stesse modalità relazionali osservate in famiglia; adolescenti che intervengono in difesa della mamma e diventano essi stessi
I groppi chiusi in gola devono sciogliersi in parole prima di farci soffocare e una favola può contenere le prime gocce della pozione magica che lo rende possibile. Ai piccoli testimoni di violenza la favola vuole offrire una possibilità di rispecchiamento e dire: “Queste cose accadono, tu non sei l’unico, l’unica a patirle e stare male è legittimo, ma è possibile chiedere aiuto”.
1. Papà di sole e papà di tempesta : sviluppa la suggestione del titolo attraverso diverse modalità che il conduttore può definire a seconda dell’età, delle caratteristiche dei partecipanti e del tempo a disposizione. Tra le modalità proposte ci sono il brainstorming , la scrittura e il disegno (ma altre ancora possono essere pensate, ad esempio ricorrendo al gioco teatrale). L’essenziale è introdurre il tema di fondo con il coinvolgimento diretto dei bambini e stabilire fin dal principio un rapporto di confidenza con la favola, in modo che possano comprenderla dal di dentro.
2. Un papà, o forse due: ci fa conoscere due emozioni difficili come la paura e la confusione, reazioni naturali dei bambini ma anche degli adulti di fronte a una minaccia inspiegabile o a un comportamento contraddittorio.
3. Gli incubi di Nico: è un gioco corporeo molto semplice per esorcizzare il tema dell’incubo. I bambini, guidati dall’adulto, mettono alla prova la propria fiducia negli altri e ne sperimentano in cambio la tenuta, l’accoglienza e la cura.
4. Il mondo su due colonne: si occupa delle contraddizioni ma, questa volta, di quelle che possiamo ritrovare in ciascuno di noi, o che possiamo mostrarci reciprocamente. Tutte le
persone hanno dentro una certa dose di sole e di tempesta, indipendentemente dall’età o dal sesso, dalle condizioni sociali o culturali.
5. Lo specchio magico : è un gioco che utilizza il teatro o il disegno per rendere manifesto ciò che resta celato nella vita di tutti i giorni. Svela come le emozioni che proviamo possano essere trattenute nell’invisibilità per non incorrere nel giudizio altrui, il che non significa che non esistano e non dispieghino tutta la loro potenza sui nostri pensieri e comportamenti. Quelle emozioni indigeste, quelle esperienze negative, quando restano troppo tempo compresse nel cuore e nella mente, irrancidiscono e danno un sapore cattivo a tutto ciò che gustiamo, a tutte le parole che diciamo.
6. Il segreto del papà: di tutte le attività enunciate è quella che chiude il cerchio riportandoci al tema della violenza familiare, questa volta per comprenderlo attraverso una possibile chiave di lettura. La storia dice che il papà di Nico diventava “di tempesta” perché vittima della sua infanzia difficile. Per i bambini questo significa imparare che abbiamo tutti bisogno di essere aiutati nei momenti di difficoltà, abbiamo il diritto di chiedere uno spazio di ascolto e il dovere di utilizzarlo per prenderci cura di noi, così da non soffrire –e non far soffrire in futuro – dolori più gravi. In questa attività viene data ai bambini anche la possibilità di trovare un proprio finale alla favola, riconsegnando ancora una volta alla loro fantasia il materiale narrativo.
Il conduttore informa i bambini che sta per leggere insieme a loro una favola intitolata Papà di sole e papà di tempesta e chiede che cosa fa venire loro in mente questo titolo.
Com’è e che cosa fa un papà di sole? E un papà di tempesta?
Il brainstorming che ne deriva viene annotato alla lavagna, seguito dal disegno o dalla scrittura individuale in cui ognuno spiega come immagina un papà di sole e un papà di tempesta. Si può distribuire la scheda di lavoro “Papà di sole e papà di tempesta” che comprende anche un piccolo esercizio di vocabolario, per ampliare il linguaggio dei bambini e delle bambine e quindi aprirli a una lettura più precisa della realtà.
Ci sarà infine un confronto in plenaria nel quale valorizzare il contributo di ciascuno. È fondamentale che il clima di classe non sia valutativo né competitivo. In questo momento tutte le interpretazioni di sole e tempesta sono valide.
L’attività si conclude con le prime parole della favola:
Incominciamo dal principio. Questa favola si intitola"Papà di sole e papà di tempesta". Come immaginate un papà di sole? È un papà che gioca con i suoi bambini, li coccola, li cura quando sono ammalati, insegna tante cose, ascolta, scherza… e qualche volta sgrida, eh, quando i suoi bambini combinano qualche marachella.
E il papà di tempesta che cosa fa? Non cura i suoi bambini, non li ascolta, non gioca con loro… Si arrabbia tanto e spesso, e non solo quando c’è un buon motivo.
E ora andiamo a raccontare.








Scrivi per ogni personaggio almeno 4 aggettivi e 4 azioni
Puoi trovare dei suggerimenti di termini nell’Armadio delle Parole. Se lì dentro ci sono parole che non conosci, chiedi il loro significato.
Suggerimenti dall’Armadio delle Parole
AGGETTIVI
Gentile
Arrabbiato
Chiacchierone
Generoso
Premuroso
Nervoso
Calmo
Furioso
Socievole
Agitato
Giocherellone
Serio
Attento
Irritabile
Vanitoso
Timido
Chiuso
Coccolone
Freddo
Spaventato
AZIONI
Cantare
Parlare
Pretendere
Chiedere
Piangere
Donare
Cucinare
Sgridare
Umiliare
Consigliare
Curare
Picchiare
Pretendere
Incontrare
Correre
Schiaffeggiare

Capace di ascoltare

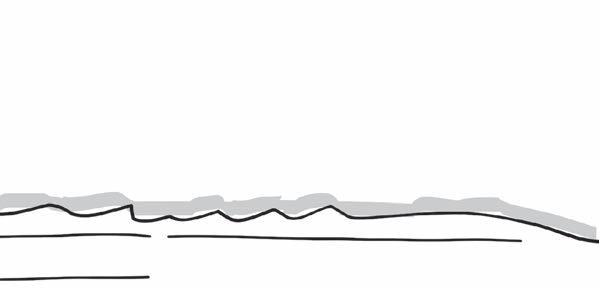
Accarezzare
Ordinare
Imporre
Sorridere
Abbracciare




Come immagini il papà di sole?Come immagini il papà di tempesta?








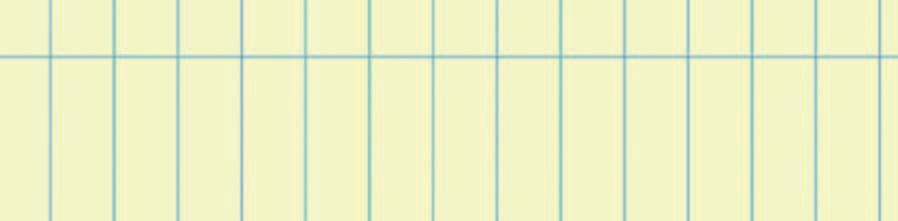


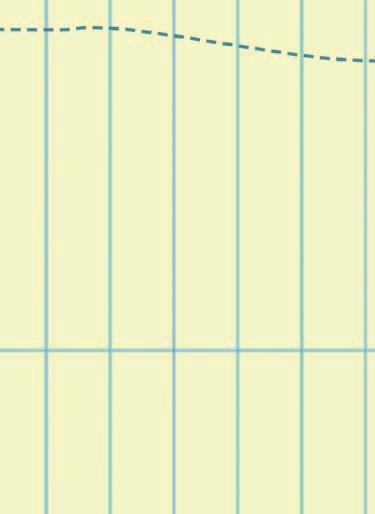




L’attenzione crescente per la violenza familiare non può lasciare in ombra i bambini che ne sono testimoni, spesso depositari di un segreto spaventoso e, per questo, ancora più soli e indifesi.
Aprire il dialogo nei luoghi in cui vivono (gli stessi di tutti i bambini: la scuola, i centri pomeridiani, la parrocchia...) è un modo concreto per mostrare che di violenza si può parlare. Un impegno che avvantaggia anche chi non la riceve: per imparare a riconoscerla – così da rifiutarla, domani, nelle proprie relazioni d’amore – e soprattutto per scoprire che la rabbia, la tristezza, la paura sono emozioni difficili da vivere ma sono anche le nostre migliori alleate, se sappiamo tradurle in consapevolezza, ascolto, vicinanza a chi è in difficoltà.
Questo libro vuole aiutare educatori, insegnanti, psicologi e operatori sociali a rompere il silenzio, fornendo indicazioni teorico-metodologiche e strumenti concreti per lavorare in gruppo. Lo fa attraverso la favola illustrata Papà di sole e papà di tempesta, che il lettore trova alla fine del libro, e 18 attività, suddivise in 3 piste di lavoro, di cui una tutta dedicata alla rabbia. Un materiale vivo e trasformabile, da reinterpretare e fare proprio attraverso la scrittura, il disegno e il teatro. Pagine che accompagnano grandi e piccoli in un viaggio di riconoscimento e trasformazione, dove parlare di violenza diventa il primo passo per prevenirla. Un libro per insegnanti, educatori, operatori sociali, adulti che hanno cura dei bambini e delle bambine.
Elena Buccoliero, sociologa e formatrice, si occupa da tempo di violenza sia nei gruppi di adolescenti, sia nei contesti familiari. È stata giudice minorile onorario e direttrice della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, attualmente collabora con l’Università di Parma. È autrice del romanzo L’ombra dentro (SEM, 2025), sempre sul tema della violenza familiare, e di filastrocche sulla giustizia minorile, letture teatrali, giochi di ruolo, racconti, video didattici.
Per le edizioni la meridiana ha curato Con voce bambina (2010) e pubblicato Tutto normale. Bulli, vittime e spettatori (2006), Papà di sole e papà di tempesta (2015, ebook) e I sogni hanno la testa dura (2021).
ISBN 979-12-5626-059-1
In copertina disegno di Giulia Boari
Euro 16,50 (I.i.)
9791256260591