di LEGISLAZIONE TECNICA
Bimestrale per il Professionista tecnico e l’Amministrazione 4 |2025

PRATICA PROFESSIONALE
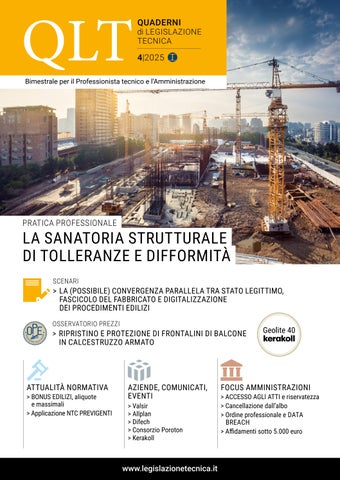
di LEGISLAZIONE TECNICA
Bimestrale per il Professionista tecnico e l’Amministrazione 4 |2025

PRATICA PROFESSIONALE
SCENARI
> LA (POSSIBILE) CONVERGENZA PARALLELA TRA STATO LEGITTIMO, FASCICOLO DEL FABBRICATO E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI EDILIZI
OSSERVATORIO PREZZI
> RIPRISTINO E PROTEZIONE DI FRONTALINI DI BALCONE IN CALCESTRUZZO ARMATO
ATTUALITÀ NORMATIVA
> BONUS EDILIZI, aliquote e massimali
> Applicazione NTC PREVIGENTI
AZIENDE, COMUNICATI, EVENTI
> Valsir
> Allplan
> Difech
> Consorzio Poroton
> Kerakoll
Geolite 40
FOCUS AMMINISTRAZIONI
> ACCESSO AGLI ATTI e riservatezza
> Cancellazione dall’albo
> Ordine professionale e DATA BREACH
> Affidamenti sotto 5.000 euro






Da più di un decennio Geolite, la linea di geomalte minerali di Kerakoll, rivoluziona il ripristino e il rinforzo del calcestruzzo armato mediante materiali innovativi realizzati con materie prime a basso impatto ambientale. Geolite garantisce ripristini monolitici ad elevata stabilità dimensionale e durabilità.
Kerakoll, la scelta per il tuo edificio più sicuro e protetto.



PUBBLICI. L’ANAC proroga l’utilizzo della piattaforma PCP
• Case study sul BIM per le infrastrutture: la strada regionale K2B in Svizzera (Allplan)
• Inerzia termica e risparmio energetico negli edifici (Consorzio Poroton)
• Siccità e crepe nei muri, i rischi aumentano (Difech)
• Drenaggio sifonico delle acque piovane: innovazioni e vantaggi del sistema Rainplus (Valsir)
• Geolite di Kerakoll: da oltre 10 anni ripristini monolitici a durabilità garantita (Kerakoll)
Quaderni di Legislazione Tecnica
Pubblicazione bimestrale registrata al Tribunale di Roma, il 15.03.2012, al N. 70/2012
Redazione, amministrazione e distribuzione
Legislazione Tecnica s.r.l. Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma Tel. 06.5921743 Fax 06.5921068 www.legislazionetecnica.it
Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) n. 7520
Abbonamento annuale € 52,00
Numeri arretrati € 13,00
ASSOCIATA ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA
Servizio Clienti servizio.clienti@legislazionetecnica.it
Redazione redazione@legislazionetecnica.it
Direttore Responsabile
Piero de Paolis
Direttore Editoriale Dino de Paolis
Osservatorio Prezzi
Antonio Caligiuri, Daniele Marini
Progetto grafico e impaginazione Roberto Santecchia
Fotografie
Per le immagini non fornite dagli autori: stock.adobe.com
La Direzione rende noto che i contenuti, i pareri e le opinioni espresse negli articoli pubblicati rappresentano l’esclusivo pensiero degli autori, senza per questo aderire ad esse. La Direzione declina qualsiasi responsabilità derivante dalle affermazioni o dai contenuti forniti dagli autori, presenti nei suddetti articoli.
Concessionaria di Pubblicità AGICOM S.r.l. www.agicom.it - agicom@agicom.it
Tel. 06.9078285 - Fax 069079256
Quaderni di Legislazione Tecnica
Bimestrale per il Professionista
tecnico e l’Amministrazione



ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA SNA
CON DECRETO DEL PRESIDENTE SNA N. 100/2025
La disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti prevede che il personale dell’ente riceva una formazione finalizzata ad acquisire e mantenere le competenze per gestire ciascuna fase del ciclo dell’appalto pubblico.
L’Area Formazione di Legislazione Tecnica, a seguito dell’accreditamento ricevuto con Decreto n. 100/2025 del Presidente della SNA, garantisce l’erogazione di percorsi formativi utili per assicurare sia la formazione di base, sia la formazione specialistica, sia la formazione di aggiornamento.
Il calendario formativo offre variegate proposte a copertura dell’intero panorama normativo dei lavori pubblici, servizi e forniture che sono indirizzate sia a professionisti di area amministrativa, sia tecnica e sia legale.
Riportiamo di seguito la nostra prossima programmazione, segnalando che gli eventi possono essere fruiti nelle date già calendarizzate oppure possono essere organizzati in house presso PPAA, Enti e Società esclusivamente a beneficio del loro personale. Informazioni, iscrizioni e offerte personalizzate possono essere richieste alla Direzione e alla Segreteria dell’Area Formazione.
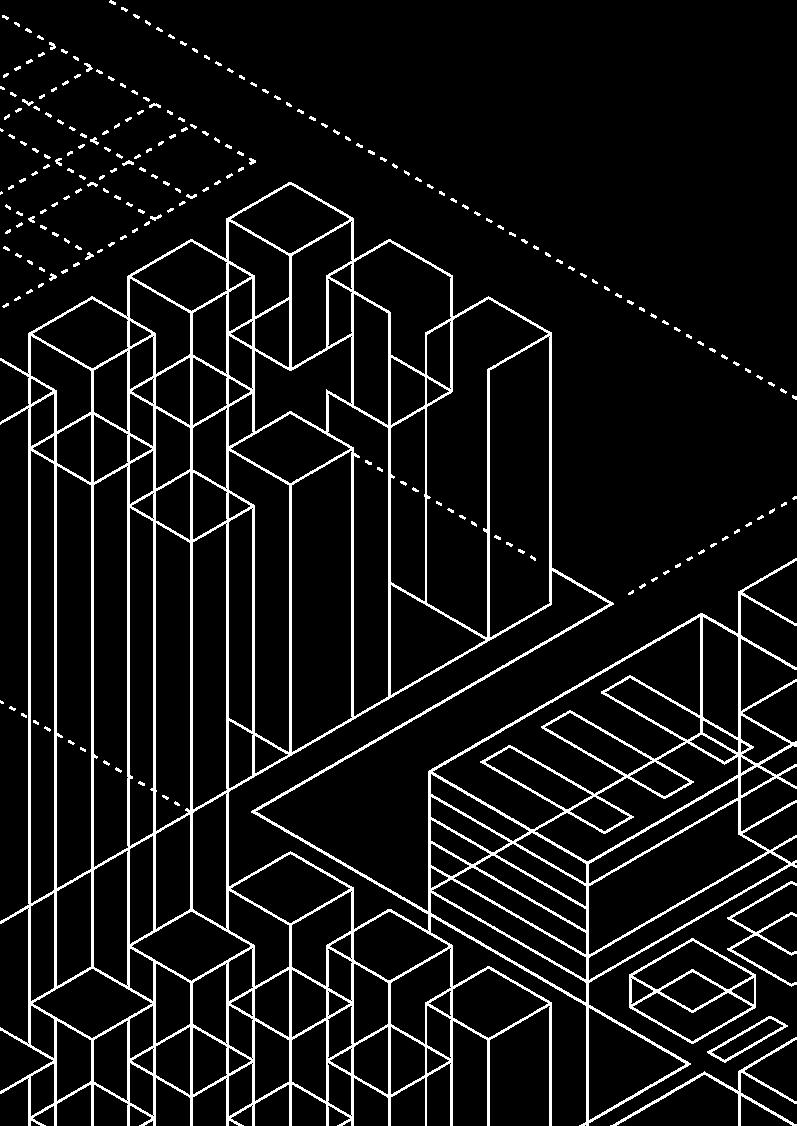





Formazione di base
Teoria e pratica dei contratti e degli appalti pubblici
Corso in fase di accreditamento – ID n. 2249278
dal 4 settembre al 25 settembre 2025
Formazione di base

Webinar | 21 ore
Teoria e pratica dei contratti e degli appalti pubblici
Corso in fase di accreditamento – ID n. 2249278
dal 30 settembre all’11 novembre 2025
Aggiornamento
Webinar | 21 ore
Il ciclo del contratto pubblico e il Project Management
Corso in fase di accreditamento – ID n. 2248091
dal 30 settembre al 9 dicembre 2025
Webinar | 31 ore


Formazione di base
RPCT e Responsabile della Funzione di Compliance
Anticorruzione: guida pratica agli adempimenti
Codice in fase di accreditamento SNA Id. 2247831
dal 2 ottobre al 20 novembre 2025

Webinar | 22 ore
Formazione di base
Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina dei lavori pubblici
dopo il Nuovo Codice Appalti
Corso in fase di accreditamento – ID n. 2248197
dal 13 ottobre al 3 novembre 2025


Aggiornamento
Appalti pubblici e concessioni: ciclo del contratto e focus specifici
Corso in fase di accreditamento – ID n. 2248005
dal 16 ottobre all’11 dicembre 2025
Formazione di base
Webinar | 31 ore
La contabilità di cantiere
Strumenti contabili, monitoraggio, soggetti, esercitazioni
Corso in fase di accreditamento SNA Id. 2248242
dal 22 ottobre al 6 novembre 2025
Formazione di base
Direzione e controllo dei lavori pubblici
Webinar | 21 ore
Focus su ruolo del DL, contabilità, subappalto e sicurezza nel cantiere
Corso in fase di accreditamento – ID n. 2248141
dal 23 ottobre al 27 novembre 2025


Webinar | 21 ore
Formazione specialistica
Corso di formazione sul Project Management: didattica ed esercitazioni
Corso in fase di accreditamento – ID n. 2248166
dal 15 ottobre al 3 dicembre 2025
Formazione di base

Webinar | 61 ore
Appalti pubblici e concessioni: guida pratica alla contrattualistica pubblica
Corso in fase di accreditamento – ID n. 2249253
dal 16 ottobre al 20 novembre 2025
Contatti Area Formazione
Webinar | 21 ore

Aggiornamento
Webinar | 21 ore
Impostazione e gestione delle gare d’appalto: esercitazioni
Attività preparatorie alla gara, svolgimento della procedura e focus sugli accessi
Corso in fase di accreditamento SNA Id. 2249354
dal 25 novembre all’11 dicembre 2025
Formazione di base
La gestione della gara: profili applicativi
Webinar | 32 ore
Attività preparatorie all’affidamento, impostazione della procedura di gara, gestione della gara, disciplina degli accessi, subappalto
Corso in fase di accreditamento SNA Id. 2248218
dal 26 novembre al 16 dicembre 2025
Formazione di base
Webinar | 22 ore
Il Project Management per Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici, enti controllati
Corso in fase di accreditamento SNA Id. 2313968
dal 12 gennaio al 2 marzo 2026
Webinar | 32 ore
email: direzione.areaformazione@legislazionetecnica.it
email: segreteria.corsi@legislazionetecnica.it
web: areaformazione.legislazionetecnica.it
Il ciclo del contratto pubblico tra normativa, Project Management e I.A.
Modulistica, predisposizione atti e casistica
Aggiornamento Corso in fase di accreditamento SNA Id. 2253250
dal 13 gennaio al 31 marzo 2026
Webinar | 61 ore
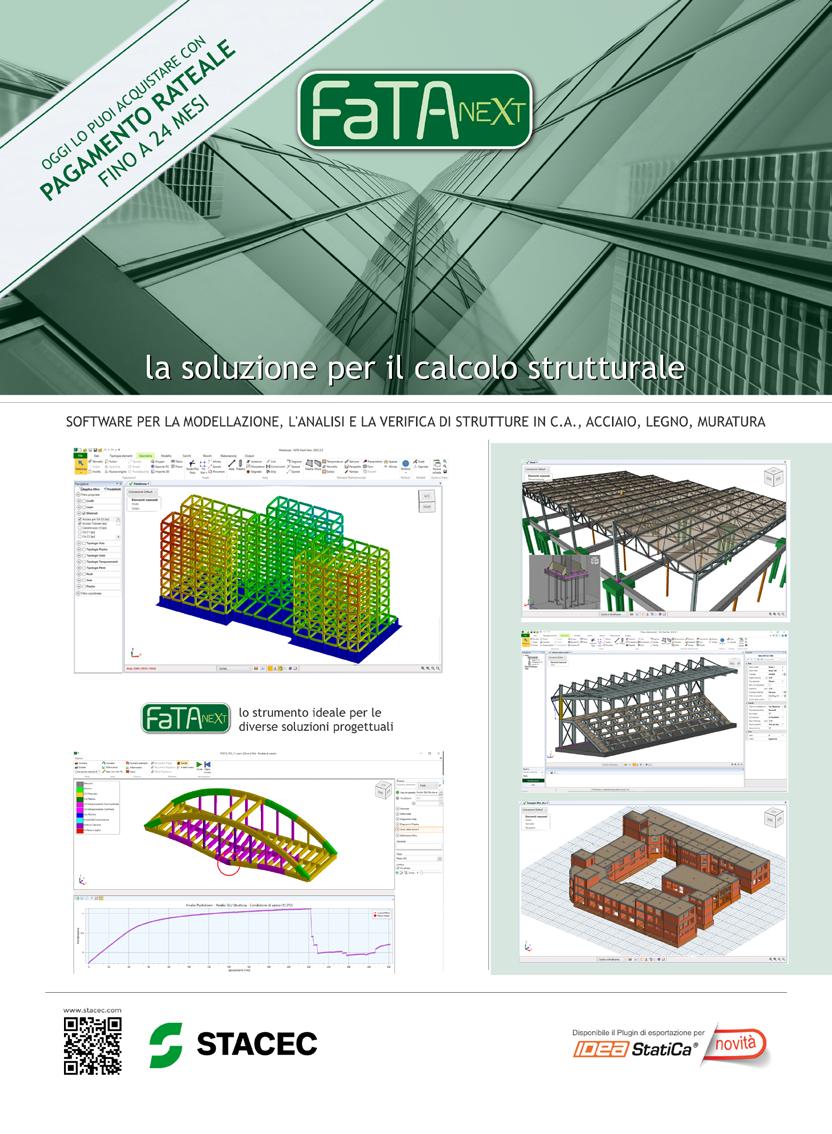
a cura di Roberto Gallia
Le vicende giudiziarie del comune di Milano hanno fagocitato qualunque altra notizia, facendo prevalere – come sempre – lo straordinario sull’ordinario.
In questo periodo, con l’avvio a regime dell’uso della modulistica aggiornata, ci si sarebbe aspettati un approfondimento dell’applicazione del salva-casa ai procedimenti abilitativi in edilizia.
Non tutte le Regioni hanno approvato il recepimento delle nuove disposizioni, e chi lo ha fatto ha inserito proprie indicazioni, senza preoccuparsi di correggere errori e inesattezze.
La generale indifferenza che, normalmente, accompagna le innovazioni in edilizia, questa volta è stata occultata dal grande scalpore suscitato dai provvedimenti della Magistratura sull’annosa questione dei grandi interventi di sostituzione edilizia realizzati a Milano nell’ultimo decennio.
In particolare, grande scandalo ha suscitato il (presunto) diverso orientamento del TAR di Milano e della Cassazione in merito alla legittimità di quanto edificato, con riferimento all’assenza di un piano particolareggiato.
Chi ha memoria e cultura non dovrebbe rimanre stupito e perplesso per le pronunce della Magistratura, il cui esame riguarda l’accertamento delle condizioni di legittimità dell’azione costruttiva, evitando di sindacare le scelte di sviluppo della città (che, in questo caso, l’amministrazione locale non ha avuto l’accortezza e il coraggio di esplicitare apertamente).
Nelle aree già edificate, l’opportunità di procedere alla pianificazione urbanistica, ovvero di intervenire con singole autorizzazioni edilizie, è un dibattito che risale nel tempo e che, in assenza di prescrizioni nella legge urbanistica nazionale, è stato variamente affrontato e risolto da diverse Regioni.
Su Milano ho detto più volte che avrebbero potuto evitare i casini nei quali si sono infilati se i progetti (che non discuto nel merito) fossero stati autorizzati tramite il permesso di costruire convenzionato; che costituisce, indubbiamente, una variante urbanistica puntuale.
Forse era troppo per i furbetti locali, che, anche in questo caso, confermano il costante abbinamento furbizia/ignoranza.
Se pensate che, parlando di abbinamento furbizia/ignoranza, mi riferisca ai provvedimenti di semplificazione normativa adottati negli ultimi vent’anni, avete azzeccato.
Non mi scandalizzo per l’urbanistica praticata anche tramite la regolamentazione edilizia.
Il piano regolatore generale, comunque denominato, è uno strumento che deve delineare scenari futuri, complesso sia nella definizione sia nell’aggiornamento.
Il permesso di costruire convenzionato, quale mini-variante, dovrebbe essere applicato a seguito di una convenzione-tipo adottata dal Consiglio comunale, con la quale definire le condizioni di applicabilità. Cioè, l’amministrazione comunale potrebbe, e dovrebbe, indicare le scelte urbanistiche a breve.
Quale amministrazione comunale ha adempiuto? Quale amministrazione comunale è stata lungimirante ed accorta, indicando le proprie scelte urbanistiche per il governo del proprio territorio nel corso della sindacatura? Non è dato saperlo. Non ci sono notizie e, apparentemente, non importa a nessuno conoscerle.
Comunque, l’urbanistica praticata tramite la regolamentazione edilizia non è una novità.
A seguito dell’Unità d’Italia, le leggi sull’unificazione amministrativa hanno attribuito ai regolamenti edilizi compiti anche di natura urbanistica; con norme rimaste immutate, in vigore fino a quando la legge urbanistica del 1942 ha introdotto il programma di fabbricazione allegato al regolamento edilizio.
Ragionarci sopra sarebbe non solo lecito, ma anche utile.
Difendiamo le nostre competenze, e approfondiamo le nostre conoscenze.
Spero che, in tal senso, possa dare un contributo anche il mio intervento su questo Quaderno; che si affianca ad un intervento sull’applicazione delle nuove norme edilizie, su tolleranze e difformità, nella cd sanatoria strutturale.
Completa questo numero un intervento, di natura tecnica, sulla manutenzione e ripristino del calcestruzzo nei balconi e nei frontalini; nonché le rubriche sugli opportuni adempimenti da adottare per risolvere aspetti tecnici (accesso ai bonus edilizi, applicazione NTC previgenti) e amministrativi (rispetto della privacy da parte degli Ordini, affidamento piccoli contratti, cancellazione dall’Albo).
Buona lettura.

Roberto Gallia (1951), architetto, docente, saggista. info@robertogallia.it
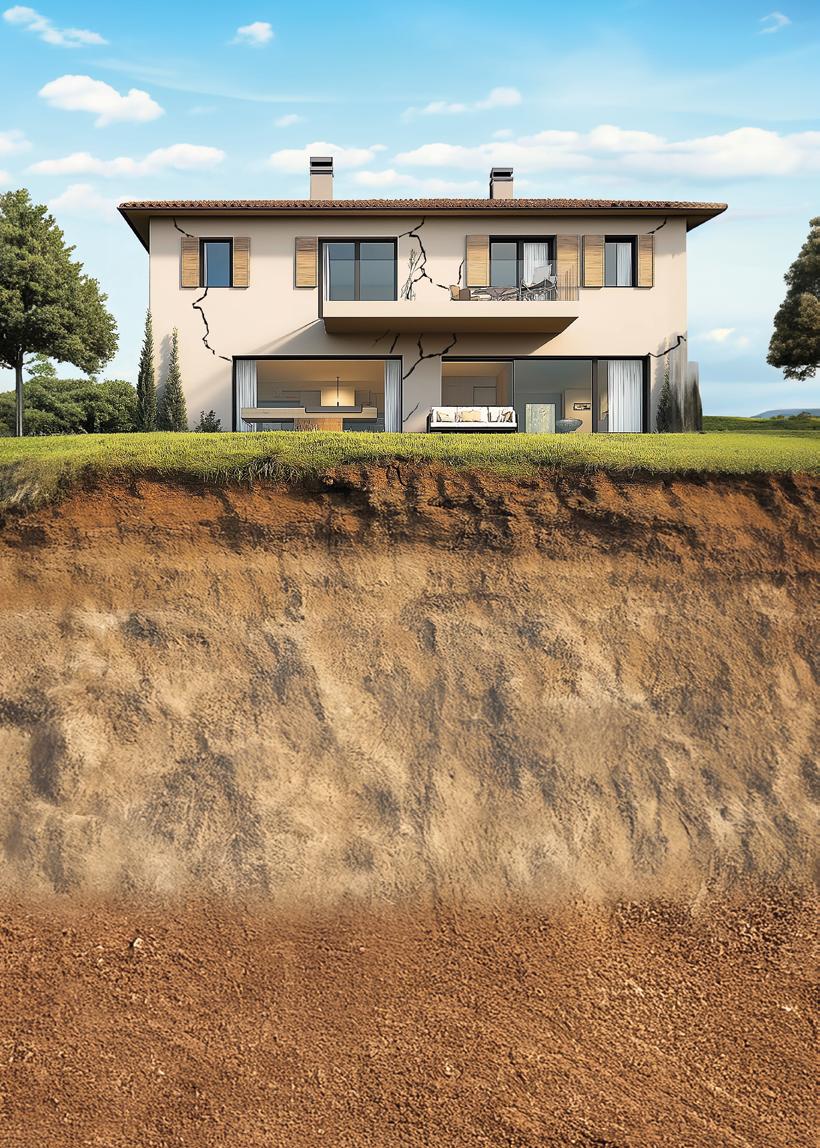
Utilizziamo le più moderne tecnologie per garantire interventi rapidi, poco invasivi e definitivi. I nostri tecnici qualificati ti sapranno consigliare la soluzione migliore per risolvere i cedimenti delle fondazioni. Contattaci subito per un Sopralluogo Gratuito.




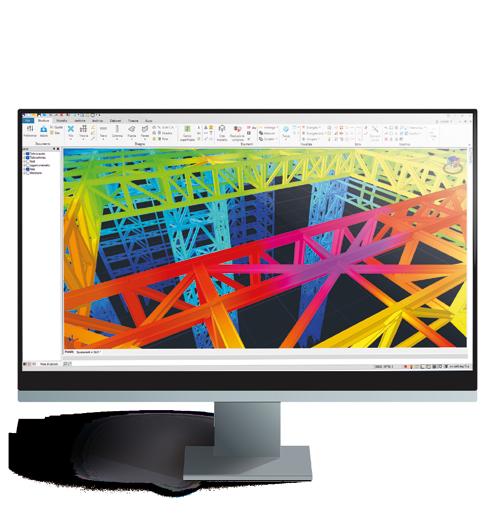

Guarda i tuoi progetti da una nuova prospettiva
Sismicad si evolve con un pacchetto innovativo importante ed un cambio di major release: arriva Sismicad 13. Nuova interfaccia 3D, sistema di gestione delle geometrie, accesso ai comandi e alle licenze. Si aggiungono anche miglioramenti su pareti, rinforzi agli edifici esistenti, BIM e molto altro ancora sta per arrivare.
Non riusciamo a scrivere tutto qui: provalo!

Procedure edilizie e titoli abilitativi: normativa e applicazioni
Edilizia libera, SCIA, permesso di costruire, agibilità, cambio destinazione d'uso Arch. Bonaventura Pianese
24 settembre 2025 14:00 - 18:00 | 4 ore

EDILIZIA E URBANISTICA
Tra le varie novità introdotte dal Decreto Salva Casa, di particolare rilevanza quella che prevede - per le opere realizzate su immobili in zone sismiche - che in caso di tolleranze o difformità sanabili il tecnico attesti che gli interventi rispettano le norme per le opere strutturali e/o in zone sismiche.

LA SANATORIA STRUTTURALE PRIMA DEL DECRETO SALVA CASA
Nell’ordinamento previgente al D.L. 69/2024 (c.d. “Decreto Salva Casa”), il controllo esercitato dall’amministrazione competente per gli interventi in zone sismiche era costruito dal legislatore in maniera preventiva, come si ricava da una serie di indici testuali contenuti nelle norme di riferimento:
• l’art. 65, D.P.R. 380/2001 prevede che le opere siano denunciate “prima del loro inizio”;
• l’art. 93, D.P.R. 380/2001, a sua volta, impone a chiunque intenda procedere ad interventi nelle zone sismiche, di darne “preavviso” scritto allo sportello unico, che provvederà alla trasmissione al competente Ufficio tecnico regionale;
• il successivo art. 94, D.P.R. 380/2001, infine, si riferisce ad una “preventiva autorizzazione”, sicché la procedura deve essere inequivocabilmente completata prima dell’esecuzione dell’intervento, nel rispetto delle formalità richieste.
Diversamente da quanto previsto per la costruzione di opere in assenza del permesso di costruire, pertanto, la disciplina antisismica non ha mai contemplato una sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo o in difformità dallo stesso Mancava in definitiva un procedimento che consenta all’interessato di richiedere un’autorizzazione (o procedere a una denuncia) postuma, in quanto il D.P.R. 380/2001 non contemplava espressamente alcuna procedura di sanatoria c.d. “strutturale”, ovvero riferita alla mancata denuncia preventiva o alla mancata richiesta di autorizzazione sismica.
INTRODOTTA
Il Decreto Salva Casa ha parzialmente posto rimedio a questa carenza legislativa. L’art. 34bis del D.P.R. 380/2001, comma 3-bis, ha infatti stabilito che - per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità - il tecnico è chiamato ad attestare che gli interventi nei quali sono state realizzate difformità rientranti nelle tolleranze rispettino le prescrizioni in materia di costruzioni in zone sismiche Seppure la norma indichi che l’attestazione di conformità vada riferita alle norme tecniche vigenti al momento di realizzazione dell’intervento, non è risultato chiaro se fosse l’ubicazione attuale in zona sismica, o quella del momento di realizzazione dell’intervento, a far scattare la necessità della procedura di sanatoria strutturale qui in argomento. Tuttavia, sembra più logico ritenere che anche per stabilire se l’edificio oggetto di intervento sia o meno ubicato in zona sismica, è necessario fare riferimento alla zonazione vigente
all’epoca della costruzione dell’immobile oggetto di sanatoria. Non è infatti logico e razionale, né concretamente attuabile, disporre il rispetto di norme tecniche datate, in quanto vigenti all’epoca di realizzazione dell’intervento, valutando però la classificazione sismica del momento attuale. In tal senso sembrano andare anche le interpretazioni e le norme di prassi delle regioni (ad esempio Nota R. Veneto 28/11/2024, n. 605513).
>> LA NORMA << Art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 (stralcio commi di interesse)
3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis, comma 2, corredata della documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, o l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

La nuova sanatoria strutturale, inserita nel comma 3-bis dell’art. 34-bis, fa riferimento alle tolleranze di cui all’art. 34-bis medesimo; tuttavia:
• l’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, comma 3-bis, ne richiama la disciplina in riferimento alla sanatoria per gli interventi in parziale difformità, con variazioni essenziali, in assenza o difformità da SCIA;
• l’art. 34-ter del D.P.R. 380/2001, comma 4, rinvia all’applicazione del regime delle tolleranze anche per le parziali difformità realizzate durante lavori oggetto di un titolo abilitativo accertate all’esito di sopralluogo con successivo rilascio dell’agibilità. Pertanto, l’ambito applicativo della procedura è il seguente:
A. tolleranze costruttive (commi 1 e 1-bis, art. 34-bis);
B. tolleranze esecutive (commi 2 e 2-bis, art. 34-bis);
C. interventi eseguiti con variazioni essenziali oppure in parziale difformità dal per-
messo di costruire o dalla SCIA alternativa, oppure in assenza o difformità dalla SCIA semplice (art. 36-bis);
D. parziali difformità tollerate in sede di agibilità (art. 34-ter, comma 4).
Si tratta in altri termini di opere eseguite:
• con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio;
• in parziale difformità rispetto al titolo edilizio;
• in difformità dalla SCIA;
• in assenza della SCIA;
• con difformità rientranti nel regime delle tolleranze costruttive di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001;
• con difformità rientranti nel regime delle tolleranze esecutive di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001;
• con parziali difformità accertate dai funzionari incaricati e successivo rilascio della certificazione di abitabilità o di agibilità, ai sensi dell’art. 34-ter, comma 4, del D.P.R. 380/2001.
La procedura prevede che il tecnico è chiamato ad eseguire, in sanatoria, la pratica necessaria nel rispetto delle norme per le opere strutturali e in zona sismica, a seconda del tipo di opere realizzate in difformità:
• l’autorizzazione sismica, in caso di interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità (comma 1, lettera a, art. 94-bis del D.P.R. 380/2001);
• il deposito del progetto, in caso di interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità (comma 1, lettera b, art. 94-bis del D.P.R. 380/2001);
• l’eventuale documentazione prevista a livello regionale per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità (comma 1, lettera c, art. 94-bis del D.P.R. 380/2001).
All’esito positivo della procedura sopra menzionata, il tecnico trasmetterà al SUE l’attestazione - riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento - corredata della dichiarazione relativa alle tolleranze di cui al comma 3, art. 34-bis del D.P.R. 380/2001, ai fini dello stato legittimo dell’immobile, e allegando:
• la documentazione progettuale mini-
Per una Scheda tematica completa sul tema della SANATORIA STRUTTURALE DI TOLLERANZE E DIFFORMITÀ
CLICCA QUI
Per il testo completo e coordinato del DPR 380/2001 TESTO UNICO EDILIZIA
CLICCA QUI
ma riferita all’intervento, come individuata dalla regione in base al disposto del comma 3, art. 93 del D.P.R. 380/2001;
• l’autorizzazione sismica o l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione stessa (30 giorni in base al disposto del comma 2, art. 94 del D.P.R. 380/2001);
• oppure, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.
La procedura può essere pertanto riassunta secondo i passaggi evidenziati di seguito.
La Conferenza unificata, nella seduta del 27/03/2025, ha modificato la modulistica edilizia relativa a SCIA, permesso di costruire, SCIA alternativa al permesso di costruire e CILA, al fine di adeguarla alle disposizioni del Decreto Salva Casa.
Le modifiche sono state apportate ai seguenti moduli:
• SCIA (Titolare, Relazione di asseverazione e Quadro riepilogativo della documentazione allegata);
• permesso di costruire (Titolare, Relazione di asseverazione e Quadro riepilogativo della documentazione allegata);
• SCIA alternativa al permesso di costruire (Titolare, Relazione di asseverazione e Quadro riepilogativo della documentazione allegata);
• CILA.
Molte regioni hanno già proceduto all’adeguamento, e nei propri moduli nuovi hanno inserito i pertinenti riquadri relativi alla sanatoria strutturale qui descritta.
A titolo meramente esemplificativo, si riportano qui di seguito alcuni stralci dai riquadri che le regioni hanno dedicato alla pratica in questione.

Modello SCIA, punto 3.6 della Relazione Tecnica di asseverazione all’interno del punto 3 dedicato alla “Dichiarazione delle tolleranze”. Un riquadro perfettamente analogo è stato inserito al punto
4.4.5 della Relazione Tecnica di asseverazione, all’interno del punto 4 dedicato a “Sanatoria e regolarizzazioni per gli interventi già realizzati e in corso di esecuzione”. Il riquadro prevede l’allegazione della pertinente documentazione, a seconda della rilevanza sismica dell’intervento.
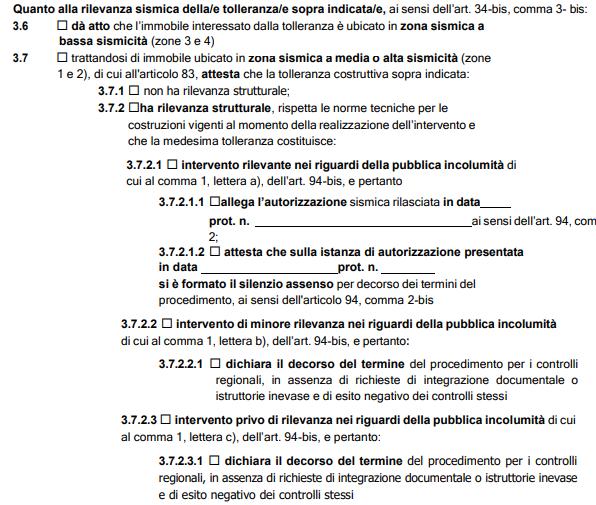

Modello SCIA, punto 1TER.6 della Relazione Tecnica di asseverazione all’interno del punto 1TER dedicato alla “Dichiarazione di tolleranze”. Un riquadro perfettamente analogo è stato inserito al punto 1QUATER.4.5 della Relazione Tecnica di asseverazione, all’interno del punto 1QUATER dedicato a “Sanatoria e regolarizzazioni per interventi già realizzati e in corso di esecuzione”. Come per la Campania, anche qui il riquadro prevede l’allegazione della pertinente documentazione, a seconda della rilevanza sismica dell’intervento.
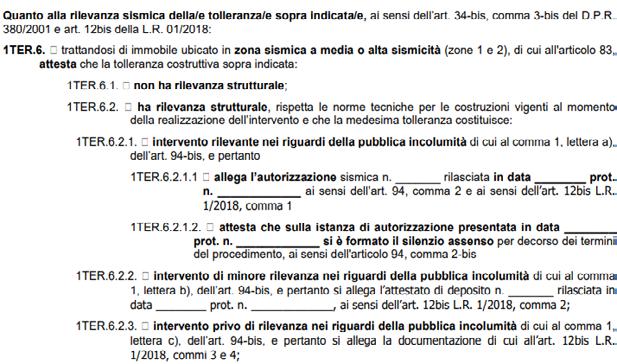

Modello SCIA, punto X) delle Asseverazioni del progettista. La scelta operata dalla Regione Piemonte è diversa dai due esempi sopra menzionati, in quanto la dichiarazione relativa agli aspetti sismici permette unicamente di dare atto “che l’immobile interessato dalla tolleranza è ubicato in zona sismica a bassa sismicità (zone 3 e 4)”, e che quindi non si applica la procedura descritta in questo articolo. In caso contrario, ai fini delle tolleranze (o della sanatoria) bisognerà allegare la documentazione necessaria indicata nel quadro della documentazione allegata.

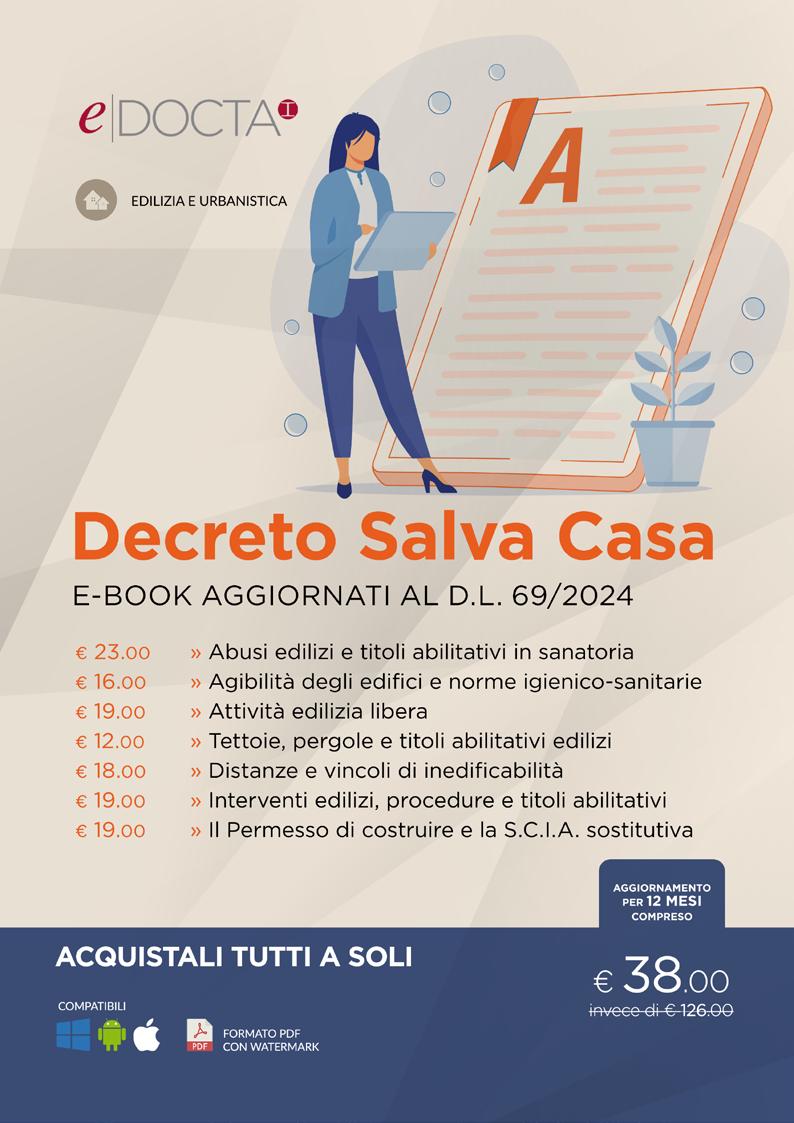


Non perdere i prossimi numeri dei Quaderni e tutti gli aggiornamenti di Legislazione Tecnica in tema di Opere e lavori privati e pubblici, Edilizia e urbanistica, Professioni tecniche.


Soluzioni termoisolanti Soluzioni acustiche
Soluzioni POROTON® per l’isolamento termico, con riferimenti normativi
Soluzioni POROTON® per l’isolamento acustico, con riferimenti normativi
Pareti tagliafuoco Muratura portante
Soluzioni di pareti tagliafuoco POROTON®, con riferimenti normativi
Strutture in muratura portante POROTON®, con riferimenti normativi
Richiesta di assistenza Domande&Risposte
Entra in contatto in modo diretto con i tecnici del Consorzio POROTON® Italia
Raccolta delle più frequenti ed interessanti domande, risposte dai nostri tecnici
A cura di Roberto Gallia
Architetto; membro esterno del Comitato regionale per il territorio (CRpT) del Lazio (dal 2020); ha lavorato in diverse strutture della PA (dal 1978 al 2010); ha insegnato presso il Dipartimento di Architettura di Roma Tre (dal 2012 al 2016) e presso la Facoltà di Architettura “L. Quaroni” della Sapienza di Roma (dal 2006 al 2011).

Il recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato, in merito allo stato legittimo di un immobile da dichiarare sia all’interno di un procedimento edilizio sia negli atti immobiliari, ritiene che la loro definizione sia stata resa più chiara con le innovazioni apportate al TUE dal cd decreto salva-casa.
Tuttavia, rimangono problematici gli aspetti ri-
feribili alla modificabilità nel tempo di quanto dichiarato e alla possibile individuazione della legittima assenza di un titolo abilitativo risalente.
Nel testo che segue si ragiona sulla opportunità di ricollegare questi aspetti critici alla discussa introduzione del “fascicolo del fabbricato” e alla digitalizzazione dei procedimenti edilizi.
Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ha diffuso lo studio «Lo stato legittimo degli immobili dopo il decreto cd. salva casa» (Studio n. 225-2024/P approvato il 26 marzo 2025); che illustra le «norme vigenti del bene esistente in oggetto, la cui situazione tecnico giuridica deriva da alcuni elementi che la norma provvede ad individuare esattamente», che devono trovare applicazione «sia all’interno della dichiarazione tecnica procedimentale [di progetto], sia nella relazione allegata agli atti [immobiliari]».
L’esposizione chiara e le argomentazioni precise, che caratterizzano lo studio, accompagnano efficacemente la comprensione del percorso logico-normativo e dei conseguenti adempimenti. Tuttavia, due aspetti rimangono problematici, in riferimento alla modificabilità nel tempo di quanto dichiarato e alla possibile individuazione della legittima assenza di un titolo abilitativo risalente, in quanto non previsto e non richiesto.
Appare inevitabile ricollegare questi due aspetti critici alla discussa introduzione di un “fascicolo del fabbricato” e alla opportuna digitalizzazione dei procedimenti edilizi.
L’Accordo, con il quale il 27 marzo 2025 la Conferenza Unificata ha approvato l’aggiornamento della modulistica edilizia, richiama nel dispositivo il tema dello “Stato legittimo degli immobili”, e ricorda l’applicabilità degli indirizzi forniti dal MIT, anche se «non aventi “valore vincolante”».
Le «Linee guida e i criteri interpretativi …» del cd decreto salva-casa, pubblicate dal MIT, vengono richiamate nella parte che indica come il requisito sussista quando «l’amministrazione competente abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi», ovvero quando sulle dichiarazioni e sulle indicazioni fornite «non sia stata formulata alcuna contestazione dall’Amministrazione». Questa indicazione appare eccessivamente
ARTICOLI RICHIAMATI
Rigenerazione urbana: che fare?, QLT n. 2/2024 (Fast Find AR1854)
Verso una nuova disciplina dell’edilizia e delle costruzioni, QLT n. 2/2025
L’edilizia insostenibile, QLT n. 1/2021 (Fast Find AR1777)
sommaria, e non tiene conto dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale:
• grava sul privato l’onere di dimostrare la legittimità di un immobile, per il principio della vicinanza della prova (di cui agli articoli 63, comma 1, e 64, comma 1, del D.Lg.vo 104/2010 Codice del processo amministrativo);
• il precedente rilascio di titoli edilizi, per altri interventi sul medesimo immobile, non implica una sanatoria tacita per la parte priva di legittimazione, qualora non risulti che l’amministrazione competente, in sede di rilascio/validazione del titolo abilitativo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.

Il documento del CNN, che dedica il Capitolo 6 a «Le questioni relative ai titoli edilizi, poste dallo stato legittimo», sintetizza così il problema [Nb: neretto mio].
«Possono essere agevolmente distinte nell’alveo normativo dell’art. 9 bis, comma 1 bis, TUE quattro questioni in funzione della determinazione dello stato legittimo:
a. la definizione dei “titoli abilitativi” idonei alla determinazione dello stato legittimo;
b. le ipotesi in cui può affermarsi che un immobile o un’unità immobiliare sia stato realizzato in virtù delle norme impositive dell’obbligo di un titolo abilitativo;
c. l’ipotesi di un immobile o di un’unità immobiliare realizzata in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio;
d. l’ipotesi di un immobile o di un’unità immobiliare realizzata in un’epoca nella quale era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio ed il titolo di legittimazione dell’immobile o dell’unità immobiliare siano stati dispersi, con l’inesistenza di copie dei medesimi, neppure informali».
LA GIURISPRUDENZA
RITIENE CHE “ IL CENTRO
ABITATO VA INDIVIDUATO
NELLA SITUAZIONE
DI FATTO COSTITUITA
DALLA PRESENZA DI UN
AGGREGATO DI CASE
CONTINUE E VICINE, ANCHE DISTANTE DAL
CENTRO, MA
SUSCETTIBILE DI
ESPANSIONE ”.
Nell’esposizione che segue, si pone attenzione su questi due ultimi punti.
Nella modulistica aggiornata si è evitato di ripetere la indicazione (farlocca) delle costruzioni realizzate anteriormente al 1° settembre 1967.
Questa data è riferita all’entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 31 agosto 1967, della Legge 6 agosto 1967 n. 765 [Fast Find: NN340]; la c.d. “Legge ponte”, che, in attesa di una riforma non ancora adottata, aveva introdotto significative innovazioni alla legge urbanistica n. 1150 del 1942, fra le quali anche l’estensione dell’obbligo della licenza edilizia a «chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno» (articolo 10 che sostituisce l’articolo 31 della Legge 1150/1942).
In precedenza, la legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150 [Fast Find: NN114] aveva imposto l’obbligo a «chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l’aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione» (articolo 31).
Appare opportuno ricordare che, in assenza di una definizione normativa di “centro abitato”, la giurisprudenza ritiene che «il centro abitato va individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione» (Consiglio di stato, sezione VI, sentenza 1222/2022). In precedenza, come vedremo più oltre, ogni Comune doveva definire il «perimetro dell’abitato, cui si debbono intendere assolutamente circoscritte le prescrizioni dei regolamenti [edilizi]».
La data del 1° settembre 1967 non rappresenta quindi una soglia riferibile a tutte le costruzioni realizzate in precedenza.

Nell’ordinamento previgente, a partire dall’unificazione nazionale e dalla proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861), la Legge 20 marzo 1865 n. 2248, per l’unificazione amministrativa [Fast Find: NN51], approva contestualmente (sotto forma di allegati) sei leggi che disciplinano materie diverse, fra le quali:
• la Legge sull’amministrazione comunale e provinciale (allegato A);
• la Legge sulla sanità pubblica (allegato C);
• la Legge sulle opere pubbliche (allegato F).
La legge sull’amministrazione comunale e provinciale attribuisce la potestà sull’attività edilizia ai Comuni, affidando loro la redazione dei «regolamenti di igiene, edilità e polizia locale», soggetti all’approvazione della Deputazione provinciale (articolo 138, punto 6).
Il regolamento di esecuzione (RD 2321/1865) prescrive i contenuti dei regolamenti edilizi; con riferimento alla composizione della Commissione edilizia consultiva, alla perimetrazione dell’abitato (dove trova applicazione il RE), ai piani di ingrandimento e livellazione, agli obblighi in merito alla «erezione, demolizione o restauro dei fabbricati», agli intonaci e alle tinteggiature, all’altezza massima, alle sporgenze, ai lavori sotterranei, ai numeri civici, ai marciapiedi e ai lastricati degli spazi pubblici (articolo 70).
Successivamente, queste disposizioni vengono sostanzialmente mantenute, sia dal testo unico della legge comunale e provinciale (RD

5921/1889, articolo 167, punto 5) sia dal regolamento (RD 6107/1889, articolo 83); preceduti, tuttavia, dalla legge sulla sanità pubblica (RD 5849/1888), che introduce l’autorizzazione per l’abitabilità delle «case di nuova costruzione, o in parte rifatte» (articolo 39) e una speciale disciplina per gli scarichi delle «case urbane o rurali, o di opifici industriali» (articolo 40).
Il regolamento di attuazione della legge sanitaria (RD 6442/1899) individua i requisiti minimi per la salubrità delle case di abitazione (articolo 84: minimo mq 10 di superfice per abitante, spazio scoperto fra fabbricati non inferiore alla quarta parte delle facciate, stanze non inferiori a otto mq), e dispone che, in esecuzione degli articoli 39 e 40 della legge, i regolamenti locali di igiene disciplinino, «in conformità delle apposite istruzioni del Ministro dell’Interno, le norme per la costruzione e le condizioni igieniche delle case agglomerate e Io norme per la costruzione e le condizioni igieniche delle case sparse nella campagna» (articolo 95).
Quindi, nella ripartizione settoriale delle competenze, che comunque confluivano nella potestà autorizzativa sindacale, il regolamento edilizio comunale avrebbe potuto prevedere un titolo abilitativo edilizio, e/o il regolamento di igiene avrebbe potuto prevedere una autorizzazione edilizia di natura sanitaria, preventiva all’esecuzione dei lavori, oltre a disci-
plinare l’autorizzazione all’abitabilità a lavori eseguiti, obbligatoria per legge. La preventiva autorizzazione edilizia di natura sanitaria, quale titolo abilitativo, già prescrivibile nei regolamenti comunali di igiene, è stata esplicitamente definita e disciplinata dalla circolare del Ministero dell’Interno, Direzione della sanità pubblica, 20 giugno 1896 «Istruzioni ministeriali sull’igiene del suolo e dell’abitato» [Fast Find NN4241], con riferimento sia agli aggregati urbani (Titolo IV “Dell’igiene delle case di abitazione negli aggregati urbani”, articoli 35-80), dove «Dovrà essere richiesto all’autorità comunale il consenso per costruzioni nuove, ricostruzioni, riadattamento di edifici e per qualunque lavoro interessante la fognatura domestica e la provvigione d’acqua» (articolo 35 “Concessione di costrurre [così nel testo] e vigilanza sanitaria relativa”), sia al territorio rurale (Titolo VII “Dell’igiene dell’abitato rurale”, articoli 114-136), dove «Per la costruzione di una casa rurale sarà richiesta l’autorizzazione dell’autorità comunale, presentando una pianta schematica della casa con le indicazioni più importanti circa il terreno scelto per la costruzione» (articolo 114 “Della vigilanza sulla costruzione e abitabilità delle case rurali”). Queste disposizioni sono rimaste in vigore fino alla promulgazione del Dpr 380/2001 TU edilizia.


Quindi, dalla promulgazione della legge sull’unità amministrativa (1865) fino a giugno 1896, i regolamenti edilizi avrebbero potuto prescrivere una autorizzazione a costruire, e i regolamenti di igiene una autorizzazione sanitaria delle attività costruttive. Nello stesso periodo, il titolo abilitativo edilizio avrebbe potuto essere prescritto all’interno dei piani urbanistici, la cui approvazione avveniva tramite legge. Infine, a partire dal 1896 diviene obbligatoria l’autorizzazione sanitaria quale titolo abilitativo edilizio
La situazione rimane praticamente immutata, anche al modificarsi delle leggi e alla compilazione dei testi unici, fino a quando il R.D.L. 25 marzo 1935, n. 640 «Norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti» [Fast Find: NN16222], prescrive, con riferimento a «tutti i Comuni del Regno non colpiti dai terremoti», che «coloro che intendano fare nuove costruzioni, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti debbano chiedere al Podestà apposita autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia e d’igiene comunali» (articolo 4).
Successivamente il R.D.L. 22 novembre 1937, n. 2105 «Nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le locali-
tà colpite dai terremoti» [Fast Find: NN16224], abroga e sostituisce le precedenti norme, confermando tuttavia l’obbligo dell’autorizzazione delle nuove costruzioni, e/o delle modifiche ed ampliamenti degli edifici esistenti, nei Comuni non colpiti da terremoti (articolo 6).
Quindi, a far data dal 25 marzo 1935, sull’intero territorio nazionale l’attività costruttiva risulta soggetta non solo all’autorizzazione sanitaria, ma anche all’autorizzazione edilizia.
L’obbligo viene modificato, come già detto, nel 1942 dalla legge urbanistica nazionale (articolo 31), nel 1967 dalla legge ponte (articolo 10) e, infine, nel 1977 dalla legge Bucalossi che introduce l’obbligo di approvare le varianti in corso d’opera dei progetti già autorizzati (articolo 15, comma 12).
Riepilogando, prima di dichiarare che un immobile sia stato «realizzato in un’epoca in cui non era obbligatorio un titolo abilitativo», occorre fare le opportune verifiche, tenendo conto che:
• l’obbligo del titolo abilitativo edilizio, per qualsivoglia costruzione si dovesse realizzare sull’intero territorio nazionale, è stato introdotto nel 1935 (articolo 4 del RDL 640/1935);
• i regolamenti edilizi comunali, ovvero i piani urbanistici, anche prima del 1935 avrebbero potuto prescrivere una autorizzazione edilizia;
• la preventiva autorizzazione sanitaria degli interventi edilizi, quale titolo abilitativo, prescrivibile nei regolamenti comunali di igiene, è stata esplicitamente definita e disciplinata nel 1896 (Ministero dell’Interno, Direzione della sanità pubblica, circolare 20 giugno 1896), ed è rimasta obbligatoria fino alla promulgazione del Dpr 380/2001 TU edilizia.
Nel 2010, il ministero dell’economia e delle finanze (MEF), con la circolare 16063 del 9 luglio 2010, ha prodotto delle «Linee guida per
la costituzione di un fascicolo immobiliare» degli immobili pubblici [Fast Find NN10303], quale base conoscitiva per una loro eventuale valorizzazione (come illustrato nel n. 9/2010 del BLT).
Nello stesso periodo venivano avanzate diverse proposte per la costituzione di un fascicolo del fabbricato quale anagrafe del patrimonio edilizio, pubblico e privato. In sede nazionale le proposte non sono mai state trasformate in legge, mentre diverse Regioni hanno provveduto in via autonoma, soprattutto a seguito di eventi catastrofici che hanno visto crolli di immobili e fatto registrare la perdita di vite umane.
Le iniziative regionali sono state sottoposte allo scrutinio della Corte costituzionale (a partire dalla sentenza 54/2003 relativa ad un provvedimento della Regione Campania), che, pur riconoscendo la doverosità della tutela della pubblica e privata incolumità, ha censurato le iniziative per irragionevolezza, in riferimento alla complessità degli accertamenti imposti, e per contrasto al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, cui spetta il compito di raccogliere, ordinare, custodire e rendere disponibili i dati necessari. Dopo un lungo oblio, recentemente è stata

rilanciata l’ipotesi di introdurre il fascicolo del fabbricato quale censimento del patrimonio edilizio, con particolare riferimento al 40% degli immobili costruiti prima del 1960, per programmare gli interventi necessari per garantire la sicurezza statica e adeguare l’efficienza energetica.
Al riguardo occorre ricordare come i parametri della sicurezza statica e dell’efficienza energetica, adottati per giustificare gli incentivi fiscali alla ristrutturazione edilizia, hanno prodotto, come effetto collaterale, la mancata attenzione all’adeguamento della complessiva qualità prestazionale sia degli edifici sia delle singole unità immobiliari. Per cui, ad esempio, abbiamo edifici che, alla conclusione dei lavori, sono dotati di cappotto termico ma presentano una impiantistica del tutto obsoleta.
Contemporaneamente, occorre ricordare che un eventuale fascicolo anagrafico di un fabbricato potrebbe duplicare e/o confliggere con i contenuti attribuiti all’istituto dell’agibilità; che attualmente deve attestare sia le condizioni di igiene e salubrità, di sicurezza statica e di sicurezza degli impianti, sia la conformità edilizia e urbanistica. Problema che richiederebbe un serio coordinamento dei due istituti, con la differenziazione delle loro finalità.
PROCEDIMENTI
Diverse Amministrazioni comunali hanno avviato da tempo la digitalizzazione dei procedimenti edilizi.
La Regione Puglia finanzia i propri comuni per digitalizzare gli archivi cartacei dei servizi edilizi.
Il testo del Codice delle costruzioni, elaborato nel 2019 dalla apposita commissione ministeriale, prevedeva la dematerializzazione e la digitalizzazione dei fascicoli e delle pratiche edilizie, al fine di costituire una anagrafe delle opere pubbliche e delle costruzioni private. Fra i venti temi rilevanti che il MIT aveva indicato, a fine gennaio 2025, quale base di partenza per il riordino del Testo unico dell’edilizia,

era ricompreso anche il punto 15 «Digitalizzazione delle procedure, istituzione dell’anagrafe e del fascicolo digitale delle costruzioni e interoperabilità delle banche dati».
Quindi, fra attività già in corso e prospettive per il futuro (indipendentemente se le stesse possano risultare veritiere o meno), ci si sta avviando concretamente a costituire una banca dati, di cosa si sta facendo e di cosa si farà nel prossimo futuro, che possa essere utilizzata anche per la semplificazione dei procedimenti edilizi e degli atti immobiliari.
Nulla si dice, o si è ancora detto, sul riordino e la digitalizzazione degli archivi storici.
La verifica dello stato legittimo delle costruzioni realizzate prima del 1960, che il Italia rappresentano oltre il 40 per cento dell’intero patrimonio immobiliare, spesso richiede di operare i necessari accertamenti presso gli archivi storici dell’edilizia; che, oltre gli archivi comunali (controllo attività edilizia e sanitaria), possono riguardare anche gli archivi notarili distrettuali (mutui edilizi e fondiari, convenzioni, atti d’obbligo, ecc.), dove sono
depositati gli atti dei notai che hanno cessato la propria attività (notizie al sito https://www. giustizia.it/giustizia/page/it/come_fare_per_richiedere_copia_atti_notarili#).
Questi accertamenti risultano, normalmente, molto onerosi sia per il tempo da impegnare sia per i costi da sostenere.
La digitalizzazione di questi archivi potrebbe essere l’occasione per ricostruire la storia di ogni singolo fabbricato, partendo dalle autorizzazioni sanitarie e dalle licenze di abitabilità rilasciate ai sensi delle norme in vigore, come illustrato in precedenza, dall’Unità d’Italia (leggi sull’unificazione amministrativa) fino al 1936 (leggi che introducevano l’autorizzazione edilizia).
Ovviamente, preliminarmente occorrerebbe costruire un archivio sia delle NTA dei piani regolatori, che venivano approvati con legge, sia dei regolamenti edilizi comunali; al fine di verificare non solo se prevedessero l’obbligatorietà di una autorizzazione a costruire (sopraelevare, demolire, ristrutturare), ma anche la presenza e la natura degli ulteriori adempimenti connessi alle prescrizioni imposte dai regolamenti di attuazione delle leggi comunali e provinciali.
Le materie attribuite ai regolamenti edilizi (vedi riquadro a lato), sono rimaste immutate nei provvedimenti regolamentari che si sono succeduti dall’Unità d’Italia alla Seconda guerra mondiale, a partire dal RD 2321/1865 fino al RD 297/1911. Quest’ultimo regolamento è rimasto in vigore anche con l’introduzione del TU delle leggi comunali e provinciali (RDL 383/1934), che non ha avuto un proprio regolamento ed è rimasto in vigore fino alla promulgazione della legge 142/1990 in materia di ordinamento delle autonomie locali.
Nel frattempo, la legge urbanistica nazionale 1150/1942, nel disciplinare i regolamenti edilizi (articolo 33), aveva disposto che, nei comuni sprovvisti di piano regolatore, dovessero «includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione, con l’indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le deli-
mitazioni in atto o da adottarsi, nonché con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona» (articolo 34).
Questo per quello che riguarda i contenuti e i
Regio Decreto 8 giugno 1865, n. 2321
Regolamento per l’esecuzione della Legge sull’amministrazione comunale e provinciale.
CAPO VIII - Dei Regolamenti municipali. Articolo 70.
Sono materie dè regolamenti edilizi le norme sopra:
1° La formazione delle Commissioni edilizie comunali con voto puramente consultivo;
2° La determinazione del perimetro dell’abitato, cui si debbono intendere assolutamente circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;
3° I piani regolatori dell’ingrandimento e di livellazione, o di nuovi allineamenti delle vie, piazze o passeggi pubblici;
4° L’erezione, demolizione o restauro dei fabbricati o costruzioni murali poste a vista del pubblico e gli obblighi relativi dei proprietari, ad oggetto che non siano violati i piani di cui al numero precedente, ed al fine che non sia impedita la viabilità e non sia deturpato l’aspetto dell’abitato;
5° L’intonaco e le tinte dei muri e delle facciate, quando la loro condizione deturpi l’aspetto dell’abitato, rispettando gli edifizi di carattere monumentale sì pubblici che privati;
6° L’altezza massima permessa per i fabbricati in correlazione all’ampiezza della via e dei cortili;
7° Le sporgenze di qualunque genere sull’area delle vie e piazze pubbliche;
8.° I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sotto-suolo e la forma delle ribalte destinate a dar luce od accesso ai luoghi sotterranei sì pubblici che privati, quando tali ribalte esistano nei luoghi di pubblico passaggio;
9° L’apposizione e conservazione dè numeri civici;
10° La formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi, dei lastricati dei portici e dè selciati nelle vie e piazze.

riferimenti normativi degli atti contenuti negli archivi storici; da verificare, raccogliere, ordinare e rendere disponibili.
Come già detto, la giurisprudenza amministrativa attribuisce al privato l’onere di dimostrare la legittimità di un immobile, richiamando l’applicazione D.Lg.vo 104/2010 Codice del processo amministrativo, che all’articolo 63 prescrive l’onere della prova, e all’articolo 64 l’onere di fornire gli elementi di prova.
Tuttavia, la Corte costituzionale ha costantemente ricordato come gli oneri imposti ai privati non possano essere irragionevolmente onerosi, surrogando i compiti della PA, che devono essere sempre orientati dal principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. Questo in numerose pronunce, a partire dall’esame della evoluzione della legislazione in materia di titoli abilitativi edilizi (sentenza 303/2003) e nella pluralità di decisioni in merito alla definizione del fascicolo del fabbricato.
Quindi, appare non solo possibile ma anche doveroso, che la digitalizzazione degli archivi edilizi storici costituisca un onere pubblico, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista organizzativo, perché catalogare e rendere fruibile un patrimonio storico è cosa diversa dall’organizzare la (pur importante) archiviazione e custodia di documenti.
La digitalizzazione degli archivi edilizi storici deve essere un progetto nazionale, promosso dallo Stato con la concorrenza di tutte le Regioni.
Professionisti e imprese, anche tramite le loro rappresentanze, lo dovrebbero reclamare a gran voce.
Nell’interesse di tutti.

Ida Faiella, Raffaele Faiella
• La consegna dei lavori
• Il subappalto
• I termini dell’appalto
• La contabilità dei lavori
• Le varianti e i lavori supplementari
• Controversie e responsabilità
• Risoluzione e rescissione contrattuale
• Il collaudo delle opere
• Raccomandazioni pratiche delle buone regole dell’arte
• Quadro sinottico della normativa
2a EDIZIONE
riveduta e aggiornata al “Correttivo” (D.Lgs. 209/2024)



Pantaleo De Finis euro
Requisiti, affidamento e compensi
Consegna dei lavori
Esecuzione del contratto
Perizie di variante e revisione dei prezzi
Attività al termine del contratto
Memorandum riepilogativo
Modelli di atti e verbali
4a EDIZIONE
riveduta e aggiornata al “Correttivo” (D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209)
Graziano Castello
GUIDA ALLE DICHIARAZIONI ASSEVERATE
PER PRATICHE EDILIZIE, TRANSAZIONI
IMMOBILIARI E RICHIESTE DI BONUS
• Analisi dello stato urbanistico-edilizio dell’immobile
• Sanatorie e altri strumenti per ripristinare lo stato legittimo
• Verifiche in termini di agibilità e norme igienico-sanitarie
• Verifica della conformità catastale
• Ripristino della legittimità per gli aspetti non edilizi
• Redazione delle certificazioni a cura del tecnico
2a EDIZIONE
Aggiornata con il Decreto
e le Linee guida del MIT
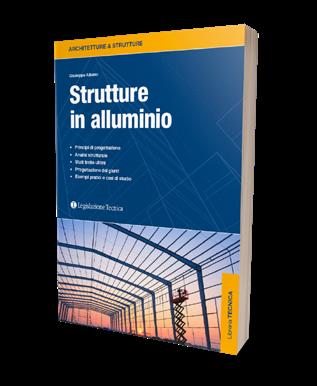
euro 38,00
euro 42,00
DOWNLOAD
› MODELLI EDITABILI in formato .DOC:
- Relazione di regolarità edilizia
- Certificazione di stato legittimo urbanistico-edilizio
- Certificazione di stato legittimo “esteso”
ARCHITETTURE & STRUTTURE
Giuseppe Albano
• Principi di progettazione
• Analisi strutturale
• Stati limite ultimi
• Progettazione dei giunti
• Esempi pratici e casi di studio

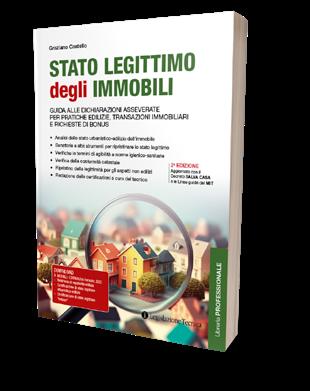

Con riferimento al triennio 2025-2027, l’Agenzia delle entrate ha chiarito vari aspetti dubbi riguardo all’applicazione dell’aliquota di detrazione più alta per i lavori svolti sull’unità adibita ad abitazione principale

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare 19/06/2025, n. 8/E, ha fornito chiarimenti e indicazioni sulle novità riguardanti i bonus fiscali edilizi contenute Legge di bilancio 2025 (commi 54, 55 e 56, art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207). Tale provvedimento è intervenuto con varie modifiche in tema di agevolazioni fiscali per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Bonus casa, Ecobonus, Sismabonus). In particolare, sono stati rimodulati i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo, altresì, regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (stralcio commi di interesse)
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile; b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico; h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
3-bis. La detrazione di cui al com-
ma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.
Art. 14 del D.L. 63/2013 (ECOBONUS - stralcio commi di interesse)
3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Art. 16 del D.L. 63/2013
(BONUS CASA e SISMABONUS stralcio commi di interesse)
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
Segue
22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una de-
trazione dall’imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli
Tra i chiarimenti forniti dalla Circolare 8/E/2025, risultano di particolare rilevanza quelli, molto attesi, riguardanti le aliquote maggiorate riservate ai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
Si ricorda infatti che nel nuovo assetto normativo sono previste aliquote di detrazione più alte (50% invece del 36% per il 2025; 36% invece del 30% per il 2026 e il 2027), per i proprietari o titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) su unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE
In primo luogo, la Circolare chiarisce che quanto al concetto di “abitazione principale” si deve fare riferimento all’art. 10 del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, c.d. “TUIR”), comma 3-bis: “Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
A tale proposito, tra i chiarimenti molto attesi forniti dall’Agenzia delle entrate, si segnala quanto segue:
• il proprietario potrà applicare l’aliquota maggiorata anche sull’unità adibita a dimora abituale di un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), ma solo in alternativae non insieme - alla detrazione sull’unità
anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
adibita a propria dimora abituale;
• la maggiorazione spetta anche nel caso di interventi sulle sole pertinenze.
PRINCIPALE DOPO I LAVORI
O DOPO L’ACQUISTO
L’Agenzia ha chiarito che qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta comunque, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori
Con riferimento invece ai bonus “acquisti” (Sismabonus acquisti di cui all’art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-septies; Bonus acquisto case in immobili ristrutturati di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 3; Bonus acquisto o costruzione di posti auto pertinenziali di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera d), per fruire dell’aliquota maggiorata l’unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione
LAVORI SU PARTI COMUNI
Molto attesi, infine, i chiarimenti sulla possibilità di applicare l’aliquota maggiorata anche in caso di lavori svolti su parti comuni immobiliari.
A tale proposito, la Circolare 8/E/2025 ha chia-

rito che la maggiorazione può essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino che sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Analogamente a quanto detto in precedenza, tali circostanze devono essere verificate all’inizio dei lavori per quanto attiene la titolarità dell’immobile e al termine dei lavori per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Quanto detto vale anche per le spese relative ad interventi su parti comuni effettuate in condominio minimo e in edificio interamente di unico proprietario.
MODIFICA DESTINAZIONE
AD ABITAZIONE PRINCIPALE
L’Agenzia delle entrate ha chiarito infine che se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata
Per una panoramica completa delle novità in tema di bonus edilizi introdotte dal 2025
CLICCA QUI
Per il quadro completo della situazione vigente in tema di bonus fiscali edilizi
CLICCA QUI
Per il testo completo della Circolare 8/E/2025
CLICCA QUI
Prorogato al 31/03/2026 del termine per la consegna dei lavori, in riferimento ai progetti di opere pubbliche redatti con NTC previgenti anche per progetti definitivi o esecutivi affidati entro il 21/03/2018

L’art. 15 del D.L. 14/03/2025, n. 25 (conv. L. 09/05/2025, n. 69), al comma 4, consente, nei casi e alle condizioni indicate dal comma 4, l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC) vigenti prima del 22/03/2018 (data di entrata in vigore delle vigenti NTC di cui al D.M. 17/01/2018).
La deroga sopra descritta si applica:
• alle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle ce-
lebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, di cui all’art. 1 della L. 234/2021, comma 422;
• alle opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla suddetta data del 22/03/2018. Per le opere suddette, il comma in esame ha stabilito che possono continuare ad applicarsi, con le procedure di cui all’art. 5 del D.L. 136/2004, comma 2-ter, del D.L. 136/2004, le
previgenti norme tecniche per le costruzioni (cioè quelle adottate con il D.M. 14/01/2008) purché la consegna dei lavori avvenga entro il 31/03/2026.
La relazione illustrativa motiva la disposizione in esame evidenziando che, tenuto conto che allo scadere del succitato termine del 22/03/2025 “per alcune delle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 di cui al DPCM 8 giugno 2023 si dovrebbe procedere alla predisposizione di una nuova progettazione, con conseguente riacquisizione di tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni, si rende necessario procrastinare il termine del 22/03/2025 al 31/03/2026”.
La deroga non appare peraltro limitata alle sole opere per il Giubileo, facendo riferimento in generale anche alle opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già stati affidati alla suddetta data del 22/03/2018.
In relazione alle “procedure di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136”, cui il comma in esame fa riferimento, si ricorda che tale comma 2-ter (introdotto nel testo del D.L. 136/2004 dall’art. 10 del D.L. 76/2020, comma 7-bis, e successivamente modificato dall’art. 9 del D.L. 68/2022, comma 10-quater), al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, ha stabilito, tra l’altro, che la
4. Per le opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 di cui all’articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per le opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano
verifica preventiva della progettazione accerta anche la conformità dei progetti alle NTC approvate con il D.M. 17/01/2018 o alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al D.M. 26/06/2014.
Ciò premesso, sembrerebbe quindi che la deroga disposta dall’art. 15 del D.L. 25/2025, comma 4 sia limitata alle sole modalità di espletamento della verifica preventiva della progettazione, prevedendo che per tale attività si faccia riferimento non alle vigenti NTC ma a quelle previgenti, adottate nel 2008. Si ricorda altresì che - ai sensi del secondo periodo del comma 2-ter, art. 5 del D.L. 136/2004 - l’esito positivo della verifica preventiva della progettazione esclude l’applicazione degli obblighi di denuncia e/o richiesta di autorizzazione per le opere strutturali e in zona sismica. I progetti corredati dalla verifica sono depositati con modalità telematica - a soli fini informativi - l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), così come le eventuali varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate.
CHIARIMENTI SULLA VIGENZA DELLE NTC 2018
Con il D.M. 17/01/2018 (pubblicato sulla G.U. 20/02/2018, n. 42, Suppl. Ord. n. 8, ed in vigore dal 22/03/2018) si è provveduto all’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC), sostituendo, con le disposizioni transitorie che saranno di seguito meglio precisate, il
LA NORMA <<
Art. 15 del D.L. 25/2025, comma 4
già affidati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, possono continuare ad applicarsi, con le procedure di
cui all’articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, le previgenti norme tecniche per le costruzioni purché la consegna dei lavori avvenga entro il 31 marzo 2026.
precedente D.M. 14/01/2008.
Come detto, il D.M. 17/01/2018 è entrato in vigore dal 22/03/2018 (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Quanto al periodo transitorio di applicazione, è stato previsto, per le opere pubbliche, che:
• per le opere in corso di esecuzione al 21/03/2018, è possibile continuare ad applicare la normativa precedente;
• per i lavori già affidati al 21/03/2018, è possibile continuare ad applicare la normativa precedente, a patto che la consegna dei lavori avvenga entro il 22/03/2025 (7 anni dalla data di entrata in vigore - termine inizialmente stabilito in 5 anni e poi così prorogato ad opera del D.M. 09/03/2023);
• per i progetti definitivi o esecutivi già affidati al 21/03/2018, è possibile continuare ad applicare la normativa precedente, a patto che i progetti siano redatti in base al D.M. 14/01/2008 ed a patto che la consegna dei lavori avvenga entro il 22/03/2025 (7 anni dalla data di entrata in vigoretermine inizialmente stabilito in 5 anni e poi così prorogato ad opera del D.M. 09/03/2023);
• in tutte le altre fattispecie occorre fare riferimento alle nuove norme.
Con il D.L. 25/2025 è stata stabilita l’ulteriore deroga sopra descritta, che in pratica consente di prorogare al 31/03/2026 il termine per la consegna dei lavori, in riferimento ai progetti redatti con NTC previgenti anche per progetti definitivi o esecutivi affidati entro il 21/03/2018.
Per le opere private, è stato invece previsto che:
• se già depositato il progetto esecutivo presso le competenti strutture entro il 21/03/2018, è possibile continuare ad applicare la normativa con la quale sono state progettate;
• per i progetti esecutivi depositati a far data dal 22/03/2018 occorre fare riferimento alle nuove norme.
Per una panoramica completa, con tutti i testi delle normative tecniche a partire dal 1908 fino alle NTC 2018 attualmente vigenti
Per il quadro completo delle zone sismiche attuali e storiche
Per un approfondimento in tema di norme e procedure per interventi strutturali sull’esistente
Tecnico

Abbonati al Bollettino di Legislazione Tecnica
Dal 1933, il più affidabile strumento di supporto per:
• Professionisti e Studi tecnici
• Uffici tecnici di Enti, PA e Aziende

L’abbonamento al Bollettino di Legislazione Tecnica offre:
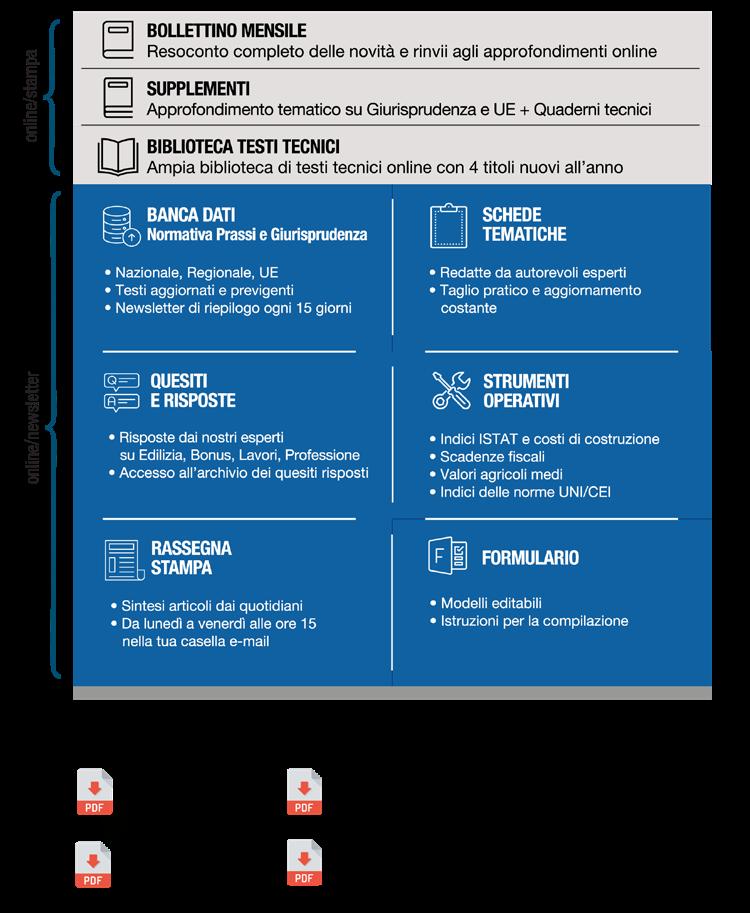

Il ripristino del frontalino di un balcone è un intervento edilizio frequente, specialmente in ambito condominiale. Le normative che regolano questi lavori riguardano la sicurezza, l’edilizia e il decoro urbano, e variano a seconda del tipo di intervento e del Comune in cui si trova l’immobile.

Geolite 40
I CODICI DEI PRODOTTI E DELLE
OPERE COMPIUTE FANNO
RIFERIMENTO AI PREZZARI NAZIONALI
EDITI DA LEGISLAZIONE TECNICA
PREMESSA
Affrontare la questione della durabilità delle strutture in calcestruzzo armato richiede un esame comparativo di due variabili principali: le sollecitazioni, comprese quelle aggressive provenienti dall’ambiente e la resistenza di un elemento strutturale specifico rispetto a tali sollecitazioni Pertanto, prima di procedere con la definizione di un intervento di recupero, è essenziale identi-
ficare le cause alla base degli impatti macroscopici derivanti dall’alterazione, dal deterioramento e/o dal dissesto degli elementi in calcestruzzo armato, nonché eventualmente, dell’intera struttura. Per molto tempo si è creduto che il calcestruzzo armato fosse un materiale praticamente esente da difetti e quindi indistruttibile, la disillusione è stata così grande quando si è dovuto verificare che le strutture esposte agli agenti atmosferici, in particolare in ambienti aggressivi, hanno periodi di obsolescenza fisica piuttosto modesti rispetto ai materiali della tradizione storica. Allora i parapetti e le solette dei balconi in particolare e più in generale le strutture snelle a cielo aperto, sono tra gli elementi costruttivi più vulnerabili al degrado, dipendendo la loro efficienza da numerose cause: la durabilità dei materiali costituenti, la progettazione, la messa in opera, il calcolo strutturale Alcuni fattori, tra cui l’anidride carbonica, l’acqua, le sostanze aggressive come cloruri e solfati, le variazioni termiche (gelo e disgelo), e possibili errori di progettazione ed esecuzione, concorrono a generare forme di deterioramento, tra cui efflorescenze, infiltrazioni, corrosione delle armature, fessurazioni e distacchi. Il ripristino del calcestruzzo armato rappresenta, quindi, un’operazione che richiede competenze specifiche. Questo processo inizia con l’analisi delle cause del degrado e si estende fino alla definizione di adeguate strategie d’intervento, compresa la selezione delle tipologie di prodotti idonei da impiegare.
Riepilogando, prima di intervenire è importante individuare le cause del degrado, che possono includere (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo. “Le cause di degrado”):
- Carbonatazione: reazione chimica tra CO₂ e idrossido di calcio che riduce il pH della matrice cementizia e favorisce la corrosione dell’armatura;
- Penetrazione di cloruri: tipico in ambienti marini o in presenza di sali disgelanti, accelera la corrosione delle armature;
- Aggressione chimica: da solfati, acidi o altre sostanze aggressive;
- Cicli di gelo-disgelo: causano microfessurazioni e distacchi superficiali;
- Errori progettuali o esecutivi: come copriferro insufficiente, porosità eccessiva, o calcestruzzo di bassa qualità
Le cause di degrado
Le cause di degrado del calcestruzzo possono essere molteplici e spesso si sovrappongono tra loro, compromettendo la durabilità e la sicurezza delle strutture. Si possono suddividere in cause chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche (queste legate alla progettazione o posa in opera).
1. Cause chimiche: coinvolgono reazioni chimiche che alterano la composizione e le proprietà del calcestruzzo o delle armature.
• Carbonatazione: la CO₂ presente nell’aria reagisce con l’idrossido di calcio (Ca(OH)₂) nel calcestruzzo, abbassando il pH da circa 12-13 a valori inferiori a 9. Questo rende possibile la corrosione delle armature;
• Attacco da cloruri: i cloruri (presenti in ambienti marini o nei sali disgelanti) penetrano nel calcestruzzo e, una volta raggiunta l’armatura, favoriscono la corrosione localizzata (pitting) ;
• Attacco da solfati: i solfati possono reagire con componenti del cemento (come l’alluminato tricalcico), causando espansioni e fessurazioni;
• Reazione alcali-aggregato (ASR): alcuni aggregati reattivi possono reagire con gli alcali del cemento in presenza di umidità, generando gel espansivi che portano a fessurazioni interne.
2. Cause fisiche: sono legate all’ambiente e ai fenomeni climatici:
• Gelo-disgelo: l’acqua penetrata nei pori del calcestruzzo gela, aumentando di volume
(~9%) e provocando microfessure e distacchi superficiali;
• Variazioni termiche: :Le dilatazioni e contrazioni ripetute possono indurre fessurazioni da fatica termica.
• Abrasioni e usura: In strutture soggette a traffico (ponti, pavimentazioni), l’azione meccanica provoca consumo e polverizzazione superficiale.
3. Cause meccaniche: dovute a sovraccarichi, urti, vibrazioni o cedimenti.
• Sovraccarico statico o dinamico: può causare fessurazioni strutturali, schiacciamento del calcestruzzo o scorrimento dell’armatura;
• Sisma: sollecitazioni dinamiche cicliche eccezionali possono provocare fessure, danneggiamenti ai nodi e collasso della struttura;
• Urti e impatti: generano rotture localizzate, sfondamenti o distacchi.
• Cedimenti differenziali: il movimento del terreno può portare a fessure e disallineamenti.
4. Cause tecnologiche (errori di progettazione o costruzione)
• Copriferro insufficiente: espone l’armatura agli agenti esterni, accelerando la corrosione. (vedi scheda);
• Malta o calcestruzzo poveri di cemento o mal compattati: portano a porosità, segregazioni e scarsa resistenza;
• Cura inadeguata durante la maturazione: se il calcestruzzo non viene mantenuto umido dopo la posa, si creano ritiri plastici e fessure;
• Armature male posizionate o non ancorate correttamente.
5. Cause biologiche (meno comuni)
• Crescita di alghe, muschi o batteri, specie in ambienti umidi, può aumentare la ritenzione di umidità e favorire la penetrazione di agenti aggressivi;

Degrado chimico

Degrado fisico
Le cause di degrado del calcestruzzo.

Degrado meccanico
Una delle ragioni che ha reso possibile e diffuso l’utilizzo delle strutture in calcestruzzo armato, è la capacità del cemento, grazie alla sua elevata alcalinità (pH 12-13), di garantire una protezione efficace dalla corrosione dei ferri d’armatura. In tali condizioni, infatti, si forma un film passivante di ossido di ferro, che impedisce il progredire del processo corrosivo. Tuttavia, anche in ambiente secco, dove l’umidità relativa è inferiore al 70%, questa protezione può essere compromessa dal processo di carbonatazione. In tale fenomeno, l’anidride carbonica presente nell’atmosfera penetra nel calcestruzzo e reagisce con l’idrossido di calcio formando carbonato
di calcio, questa reazione determina un abbassamento del pH della matrice e la conseguente depassivazione e corrosione delle armature. La corrosione dei ferri comporta la perdita di capacità resistente delle barre d’acciaio, la diminuzione dell’aderenza con il calcestruzzo e un aumento di volume dei prodotti di corrosione (fino a 6 volte) che genera tensioni interne nel calcestruzzo circostante. Queste provocano fessurazioni, delaminazioni ed espulsioni del copriferro (fenomeno di spalling). Per limitare la carbonatazione, la principale strategia è ridurre la permeabilità del calcestruzzo rendendolo più compatto. Questo si ottiene adottando un rapporto acqua/cemento (a/c) inferiore a 0,60, in modo da ridurre i pori e le vie di accesso per anidride carbonica e umidità. Tuttavia, anche un calcestruzzo ben confezionato non garantisce una protezione duratura se il copriferro non ha uno spessore adeguato: in genere si considera uno spessore minimo di 20–25 mm, a seconda delle condizioni ambientali. La corrosione può, inoltre, essere favorita da difetti esecutivi, come la presenza di armature parzialmente scoperte o non adeguatamente inglobate nel calcestruzzo, la formazione di differenze di potenziale elettrico tra le barre dovute a inclusioni, scalfitture o discontinuità, la disomogeneità del calcestruzzo causata da vuoti, nidi di ghiaia o variazioni di densità e composizione, nonché errori nella messa in opera o nella corretta collocazione delle armature. Per prevenire o limitare i processi corrosivi e garantire la durabilità e la funzionalità delle strutture in calcestruzzo armato, è possibile adottare diverse tecniche di protezione, come la zincatura a caldo, rivestimenti protettivi, come le resine epossidiche, acciaio inossidabile in ambienti critici, la protezione catodica e gli inibitori di corrosione. Questi trattamenti possono consentire anche la riduzione dello spessore del copriferro, con benefici sul peso complessivo della struttura e sull’estetica, prevenendo la formazione di macchie di ruggine sulla superficie esterna del manufatto.
* Il potenziale di corrosione dei ferri di armatura è una misura elettrochimica utilizzata per valutare lo stato di salute delle armature in una struttura in calcestruzzo armato. Indica la propensione delle barre metalliche a subire processi corrosivi, come la carbonatazione o l’attacco da cloruri.
Fasi del ripristino
1. Ispezione e diagnosi
- Rilievo visivo dei danni;
- Saggi e indagini non distruttive (ultrasuoni, sclerometro, termografia);
- Analisi chimico-fisiche su campioni.
2. Preparazione del supporto
- Rimozione del calcestruzzo degradato (con martelli pneumatici leggeri, idrodemolizione, o sabbiatura);
- Pulizia delle armature (spazzolatura, sabbiatura o idroscarifica).
3. Trattamento delle armature
- Protezione passivante (malte o prodotti anticorrosivi) ;
- Eventuale integrazione delle armature se danneggiate.
4. Ripristino del calcestruzzo
- Applicazione di malte tixotropiche o colabili a base di cemento o resina (scelte in base alla posizione e alla geometria del danno) ;
- Malte strutturali fibrorinforzate, premiscelate, spesso con additivi per migliorare adesione e durabilità.
5. Finitura e protezione
- Lisciatura e uniformazione della superficie;
- Applicazione di rivestimenti protettivi: pitture elastomeriche, idrorepellenti, rivestimenti anti-carbonatazione o epossidici.
La UNI EN 1504 è la normativa europea di riferimento per la protezione e riparazione delle strutture in calcestruzzo armato o precompresso, recepita anche in Italia. Questa norma è obbligatoria per tutti i lavori di ripristino di strutture in calcestruzzo, in quanto stabilisce criteri, metodi, materiali e controlli per garantire interventi sicuri, duraturi ed efficaci.
Struttura della norma UNI EN 1504: la norma è composta da 10 parti, ciascuna focalizzata su un aspetto specifico del processo di riparazione.
UNI EN 1504-1: Definizioni - Fornisce le definizioni dei termini utilizzati in tutto il pacchetto normativo.
UNI EN 1504-2: Sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo - Descrive metodi per proteggere il calcestruzzo sano (non danneggiato) da agenti aggressivi (carbonatazione, cloruri, gelo-disgelo ecc.), tramite:
• rivestimenti protettivi;
• impregnazioni idrofobe;
• sigillature dei pori.
UNI EN 1504-3: Riparazione strutturale e non strutturale del calcestruzzo - Specifica i requisiti dei materiali per la ricostruzione del calcestruzzo, distinguendo tra:
• malte per riparazioni non strutturali (estetiche o superficiali);
• malte per riparazioni strutturali (che contribuiscono alla resistenza).
UNI EN 1504-4: Incollaggio strutturale - Tratta l’impiego di adesivi strutturali per:
• unione di elementi in calcestruzzo;
• incollaggio di lamine in fibra (FRP) o piastre in acciaio.
UNI EN 1504-5: Iniezioni - Definisce i materiali e i metodi per l’iniezione di fessure, vuoti e cavità mediante resine (epossidiche, poliuretaniche o cementizie).
UNI EN 1504-6: Ancoraggio delle barre di armatura - Specifica i materiali e i metodi per ancorare nuove barre d’armatura a strutture esistenti, inclusi adesivi e malte per ancoraggi.
UNI EN 1504-7: Protezione delle armature d’acciaio contro la corrosione - Definisce i materiali per la protezione passivante dell’armatura, come primer anticorrosivi e inibitori.
UNI EN 1504-8: Controllo di qualità e valutazione di conformità - Stabilisce le modalità di prova, ispezione e certificazione dei prodotti.
UNI EN 1504-9: Principi generali per l’uso dei prodotti e sistemi - Descrive 11 principi di intervento (ad es. riempimento delle fessure, aumento della resistenza, protezione dalla corrosione) e metodi associati. Serve a guidare la progettazione degli interventi.
Principio 1 – Protezione contro la penetrazione
Principio 3 – Ripristino del calcestruzzo
Principio 4 – Rinforzo strutturale
Principio 7 – Preservazione o ripristino del passivamento dell’armatura
Principio 11 – Controllo delle aree anodiche
Ogni principio ha metodi associati e tipi di prodotto da utilizzare in base al danno.
UNI EN 1504-10: Controllo dell’applicazione dei prodotti e sistemi in cantiere - Descrive le buone pratiche operative, i controlli in fase di applicazione e la verifica dell’efficacia dei sistemi utilizzati.
Tutti i prodotti per la riparazione del calcestruzzo devono: essere conformi alla UNI EN 1504,
• avere marcatura CE,
• essere accompagnati da dichiarazione di prestazione (DoP). Collegamenti con altre norme
• NTC 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni): richiedono il rispetto delle UNI EN 1504 per la manutenzione e il ripristino del calcestruzzo.
• Eurocodici (EN 1992-1-1, ecc.): per il calcolo strutturale e verifiche meccaniche.
In sintesi:
La UNI EN 1504 standardizza gli interventi di riparazione per garantire che siano:
• duraturi,
• efficaci dal punto di vista tecnico e strutturale,
• compatibili con il calcestruzzo esistente,
• sicuri per gli utilizzatori e l’ambiente.
Parte Titolo Contenuto principale Esempi di applicazione
1504-1 Definizioni
1504-2 Protezione della superficie
1504-3 Riparazione del calcestruzzo
1504-4 Incollaggio strutturale
1504-5 Iniezione
1504-6 Ancoraggi
1504-7 Protezione armature
1504-8 Controllo qualità prodotti
1504-9 Principi generali
1504-10 Controlli in cantiere
Termini tecnici utilizzati in tutta la norma
Protezione del calcestruzzo sano o riparato
Ripristino con malte (strutturali o non)
Adesivi per unione strutturale o incollaggio di rinforzi
Sigillatura di fessure, vuoti o nidi di ghiaia
Fissaggio di nuove barre d’armatura
Trattamenti contro la corrosione delle armature
Controlli di laboratorio e marcatura CE
Undici principi di intervento e relativi metodi
Buone pratiche di posa, controlli e collaudi
Tabella 1 - Schema Riassuntivo, UNI EN 1504.
Lessico comune tra progettisti e imprese
Rivestimenti anticarbonatazione, pitture elastomeriche, impregnanti
Rifacimento di spigoli, reintegro di porzioni ammalorate
Incollaggio FRP, piastre d’acciaio
Iniezione con resine epossidiche o poliuretaniche
Barre chimiche, spinotti in acciaio ancorati
Primer passivanti, inibitori di corrosione
Verifica dei dati tecnici forniti dal produttore
Scelta del tipo di riparazione in base al danno
Controlli sull’applicazione di malte o resine
I balconi di un edificio condominiale, in linea generale, non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 del Codice civile, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso. Alla luce della conformazione particolare e, soprattutto, del
vuoto normativo, si continua a distinguere i balconi (soprattutto dal punto di vista giurisprudenziale) in aggettanti e incassati I balconi “aggettanti” sono quelli che sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono. Questi balconi non svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura, come viceversa è riscontrabile per le “terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio”, con la conseguenza che mentre i primi, quelli aggettanti, non determinano volume dell’edificio, nel secondo caso essi costituiscono corpo dell’edificio e contribuiscono quindi alla determinazione del volume (C. Stato 16/10/2020, n. 6275).
Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche quelle relative alla piattaforma o soletta, all’intonaco, alla tinta e alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell’appartamento che vi accede, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (Cass. civ. 12/03/2020, n. 7042). Unica eccezione a questo principio, il caso in cui il rivestimento dei frontalini e quello delle solette dei balconi in un edificio svolgano una prevalente funzione estetica, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata, e pertanto beni ricadenti in condominio.
A tal proposito, secondo i giudici, gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio - come i cementi decorativi relativi ai frontali ed ai parapetti - svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio e inserendosi nel suo prospetto, costituiscono parti comuni con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione grava su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (Cass. civ. 29/10/2018, n. 27413).
Il balcone incassato sporge rispetto alla facciata dell’edificio, ma è posto all’interno del perimetro esterno dell’edificio, inserito nella sua struttura portante e non si protende autonomo nel vuoto. Infatti, la conformazione del balcone incassato fa sì che esso funga, contemporaneamente, da sostegno del piano superiore e da copertura del piano inferiore (Cass. civ. 17/07/2007, n. 15913). Di conseguenza, secondo la posizione in esame, le spese per il rifacimento o la manutenzione straordinaria per il balcone incassato, nello specifico del parapetto in muratura, delle relative strutture portanti come travi e pilastri, dovranno essere poste a carico dei condomini poiché essi fanno parte integrante della facciata dell’edificio o perché parti comuni. Inoltre, secondo altra posizione dei giudici di merito, per i balconi incassati, la relativa soletta è di proprietà comune dei condomini dell’appartamento del piano superiore e di quello del piano inferiore, cui serve, rispettivamente, da piano di calpestio e da copertura (Trib. Roma 19/09/2019, n. 17785).
Preparazione dei supporti È fondamentale per garantire la durabilità e l’efficacia dell’intervento. Prima di applicare la malta occorre:
- bonificare il substrato in calcestruzzo e irruvidirlo con asperità di almeno 5 mm, mediante scarifica meccanica o idrodemolizione, provvedendo all’asportazione in profondità dell’eventuale calcestruzzo ammalorato;
- rimuovere la ruggine dai ferri d’armatura, che dovranno essere puliti mediante spazzolatura (manuale o meccanica) o sabbiatura;
- pulire la superficie trattata, con aria compressa o idropulitrice;
- bagnare a rifiuto fino ad ottenere un substrato saturo, ma privo di acqua in superficie. In al-
ternativa, su superfici orizzontali in calcestruzzo, applicare Primer Uni su supporto asciutto, al fine di garantire un regolare assorbimento e favorire la naturale cristallizzazione della geomalta.
Valutare l’idoneità della classe di resistenza del calcestruzzo di supporto. In presenza di riporti a spessore e su superfici estese prevedere opportuna armatura metallica di contrasto ancorata al supporto.
La malta si prepara mescolando 25 kg di polvere con l’acqua indicata nei dati tecnici (è consigliabile utilizzare l’intero contenuto di ogni sacco).
La preparazione dell’impasto può essere effettuata, ponendo attenzione alla rapidità del prodotto, tramite:
- betoniera, mescolando fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi;
- idonea pompa miscelatrice;
- mescolatore per malta o trapano a basso numero di giri con frusta.
Applicazione
- Per il ripristino localizzato e/o generalizzato, che prevede l’applicazione della malta in spessori variabili da 2 a 40 mm (max per strato), applicare la malta manualmente a cazzuola o mediante macchina spruzzatrice (facendo attenzione all’eccessiva rapidità di presa della geomalta);
- Per la realizzazione di una rasatura protettiva, applicare la malta manualmente (con spatola d’acciaio) o a macchina in spessori non inferiori a 2 mm, previo irruvidimento delle superfici con asperità di 1 – 2 mm;
- Per l’inghisaggio di barre, riempire il foro precedentemente realizzato con la malta tramite estrusione del materiale con apposita pistola e inserire la barra con movimento rotatorio. Curare la stagionatura umida delle superfici per almeno 24 ore. La pulizia degli attrezzi e delle macchine da residui di malta si effettua con acqua prima dell’indurimento del prodotto.


Intervento di ripristino.


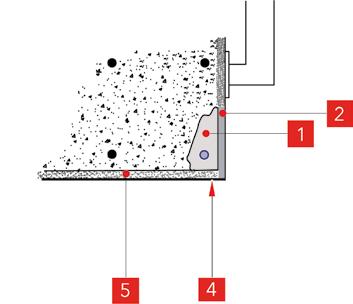
Dettaglio intervento.
Legenda stratigrafia intervento 1 Malta tissotropica monocomponente, a ritiro compensato e a presa rapida, di classe R4, specifica per la passivazione e il ripristino
Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito 2 Intonaco frontale di malta di cemento 6 Pavimentazione in piastrelle in gres porcellanato 3 Gocciolatoio
02.R04 INTERVENTI SU STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO UM PREZZO %AT %PR %RU
02.R04.A05
02.R04.A05.001
Fornitura e posa in opera di malta minerale, tixotropica a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche per il ripristino monolitico localizzato o generalizzato di sezioni danneggiate o degradate di elementi in calcestruzzo armato e per il contestuale trattamento dei ferri di armatura e rasatura protettiva. La malta è provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504 3, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥ 20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: preparazione della superficie, irruvidimento del calcestruzzo e spazzolatura delle barre di armatura; inserimento di eventuale armatura integrativa (da contabilizzare a parte) e bagnatura a rifiuto del supporto; applicazione di malta tixotropica minerale per riprofilare e ripristinare il copriferro. La quantificazione è espressa per metro quadro di sezione ricostruita, considerando uno spessore medio di 10 mm.
PR.P02.A12
PR.P02.A12.002

Clicca per conoscere i prodotti GEOLITE
Fornitura e posa in opera di malta minerale, tixotropica a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche per il ripristino monolitico localizzato o generalizzato di sezioni danneggiate o degradate di elementi in calcestruzzo armato e per il contestuale trattamento dei ferri di armatura e rasatura protettiva. La malta è provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504 3, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥ 20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).
Confezione da 25 kg kg € 1,34
Dati tecnici
Massa volumica apparente: 1320 kg/m³
Natura mineralogica: aggregato silicatica-carbonatica
Intervallo granulometrico: 0 – 0,5 mm
Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra; teme l’umidità
Spandimento dell’impasto: 160 – 180 mm
Acqua d’impasto: 4,6 l / 1 sacco 25 kg –0,9 l / 1 sacco 5 kg
Massa volumica dell’impasto: 2010 kg/m³
pH dell’impasto: ≥ 12,5
Inizio / Fine presa: 35 – 40 min. (180 – 195 min. a +5 °C) – (25 – 30 min. a +30 °C)
Temperature limite di applicazione: da +5 °C a +40 °C
Spessore: minimo 2 mm
Spessore massimo: per strato 40 mm
Resa: 17 kg/m² per cm di spessore
02.R04.A05.001
INTERVENTI SU STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
CODICE
AT.N500.001.001
AT.N015.010.017
CODICE
PR.P02.A12.002
Trasporto materiali sul luogo del cantiere - con carico da 4000 kg a 6000 kg
Utensili manuali e elettrici - Mescolatrice per malte h
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (PR)
Malta minerale, tixotropica a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche per il ripristino monolitico localizzato o generalizzato di sezioni danneggiate o degradate di elementi in calcestruzzo armato e per il contestuale trattamento dei ferri di armatura e rasatura protettiva. La malta è provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504 3, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥ 20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1) - per uno spessore medio di 10 mm.
Totale Prodotti Da Costruzione (PR)









Fornitura e posa in opera di malta minerale, tixotropica a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche per il ripristino monolitico localizzato o generalizzato di sezioni danneggiate o degradate di elementi in calcestruzzo armato e per il contestuale trattamento dei ferri di armatura e rasatura protettiva. La malta è provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504 3, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura, dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici e dalla EN 1504-6 per l’ancoraggio ad effetto espansivo di armatura in acciaio; nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥ 20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all’abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: preparazione della superficie, irruvidimento del calcestruzzo e spazzolatura delle barre di armatura; inserimento di eventuale armatura integrativa (da contabilizzare a parte) e bagnatura a rifiuto del supporto; applicazione di malta tixotropica minerale per riprofilare e ripristinare il copriferro. La quantificazione è espressa per metro quadro di sezione ricostruita, considerando uno spessore medio di 10 mm.
RU.M01.A04.004
Preparazione della superficie
Operaio edile - Tabelle ministeriali - media nazionale - IV livello
Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media nazionale - III livello
Spazzolatura delle barre RU.M01.A04.004
Operaio edile - Tabelle ministeriali - media nazionale - IV livello
Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media nazionale - III livello
Ricostruzione del calcestruzzo
edile - Tabelle ministeriali - media nazionale - IV livello
Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media nazionale - III livello
Risorse Umane (RU)
Parziale (AT + PR + RU) (A)
d’impresa (0.1 di A+B) (C)
Lavorazione (A+B+C) m

di incarichi
consulenza
Presupposti, requisiti, flow chart del processo
Dott.ssa Rosalisa Lancia 17 settembre 2025
16:00 - 18:00 | 2 ore
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ENTI PUBBLICI
Mepa/Mepal – INIZ2429 INFO E ISCRIZIONI

Nei complessi rapporti tra il diritto di accesso agli atti e il diritto alla tutela dei dati personali, risulta di sommo interesse una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. III – Sentenza n. 3828 del
06/05/2025) in tema di legittimazione a richiedere l’ostensione dei dati del segnalante. La pronuncia origina dal caso di un ente -sottoposto a vigilanza ministeriale- destinatario di esposti aventi ad oggetto
lo svolgimento delle elezioni dei propri organi statutari che, avendo richiesto di accedere a tali segnalazioni e di conoscere i nominativi dei firmatari, si era visto opporre il diniego dall’Amministrazione.
Il Consiglio di Stato, rigettando le motivazioni del diniego basato prevalentemente sulla tutela della riservatezza, ha riconosciuto il diritto del richiedente sia ad accedere alla copia integrale degli esposti e delle segnalazioni, sia ad accedere ai nominativi dei firmatari confermando il pieno diritto dell’ente a conoscere gli atti al fine di esercitare una migliore difesa.
Secondo il Consiglio di Stato, il diritto a conoscere di un soggetto sottoposto ad un procedimento di controllo o ispettivo è un diritto pieno e non può essere limitato per esigenze di tutela dei dati personali di chi ha azionato l’ispezione o la verifica.
Segnatamente il Consiglio di Stato ritiene che “il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha comunque un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall’Amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi quindi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione di tale potere, non ostandovi neppure il diritto alla riservatezza, che non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell’ambito di un procedimento ispettivo, giacché al predetto diritto alla riservatezza non può riconoscersi un’estensione tale da includere il diritto all’ano-
nimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l’ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all’anonimato”.
Tale riflessione è di somma utilità nel bilanciamento di interessi che ciascuna amministrazione è tenuta a svolgere prima di decidere sull’istanza di accesso agli atti, e mette in correlazione il diritto a difendersi con il diritto all’anonimato, stabilendo che anche la paternità dell’esposto è un elemento utile per verificare la legittimazione del segnalante ad avanzare l’esposto e pertanto a consentire una difesa più efficace al segnalato. In altri termini, argomentando quanto condivisibilmente indicato dal Consiglio di Stato, saranno messi in competizione non più il diritto alla riservatezza del segnalante e il diritto alla trasparenza del segnalato, quanto piuttosto la legittimazione a segnalare e la legittimazione a difendersi integralmente; solo mediante la conoscenza del segnalante, il segnalato potrà esercitare con maggiore consapevolezza il proprio diritto di difesa. Peraltro, continua il Consiglio di Stato, una volta che l’esposto sia stato inoltrato all’Amministrazione, questo diventa documento con rilievo procedimentale e il segnalante perde il controllo sulla propria segnalazione che diventa un elemento nella disponibilità della sola Amministrazione.
La sentenza del Consiglio di Stato va nella stessa direzione della pronuncia di primo grado del TAR Lazio (Sent. n. 21257/2024) che efficacemente aveva evidenziato che colui che ha subito un procedimento di controllo o ispettivo ha un “interesse qualificato a conoscere integralmente” tutti i documenti del procedimento amministrativo, ivi inclusi gli atti iniziali quali esposti, segnalazioni e denunce. Pertanto, continua il TAR citato, al di fuori di particolari ipotesi in cui il denunciante potrebbe essere esposto in ragione di particolari rapporti con l’esponente a ritorsioni, discriminazioni o indebite pressioni, la tutela della riservatezza non può essere estesa fino a ricomprendervi il diritto all’anonimato dell’esponente o del segnalante.
Secondo il TAR, infatti, in una situazione in cui la trasparenza è funzionale alla difesa dei propri diritti e non conduce a rischi per la persona, la trasparenza prevale sulla tutela dell’anonimato.
Scarica il testo del Consiglio di Stato, Sentenza n. 3828 del 6 maggio 2025.

DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ: LA SENTENZA N. 70/2025
Con la Sentenza n. 70 depositata in data 23 maggio u.s. la
Corte costituzionale, ponendo fine ad una questione sollevata nel luglio 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57 della L. 247/2012 (c.d. “Legge Professionale Forense”) che vieta all’avvocato di richiedere la cancellazione dall’albo in pendenza di un procedimento disciplinare a proprio carico. La questione di costituzionalità veniva sol-
levata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione chiamate a valutare il rigetto dell’istanza di cancellazione disposto da un Consiglio dell’Ordine nei confronti di un professionista gravemente malato e in particolare chiamata a valutare se la motivazione del diniego, consistente nella pendenza di più procedimenti disciplinari a carico del professionista, fosse legittima in punto di diritti costituzionalmente garantiti.
In esito alla trattazione, la Corte Costituzionale ha ritenuto l’illegittimità della norma dell’art. 57 della Legge Professionale Forense contenente il divieto di cancellazione dall’albo per la pendenza del procedimento disciplinare.In particolare la Corte ha rappresentato che “ (…), nella fattispecie in esame, il divieto si traduce in un vulnus alla libertà di autodeterminazione, in quanto l’appartenenza al gruppo professionale viene imposta nonostante sia venuto meno il consenso comunque prestato dall’avvocato all’adesione alla istituzione ordinistica per avere egli perso l’interesse a esercitare la professione ovvero per non avere più la possibilità di farlo”. La Consulta ha infatti ritenuto che, per quanto orientata a garantire l’efficacia dell’azione disciplinare, la norma dell’art. 57 della Legge forense è in contrasto con l’art. 2 e 4 della Costituzione e in particolare che comprima
in maniera eccessiva i diritti di rango costituzionale da questi garantiti.
La valutazione svolta dalla Corte ritiene che l’art. 57 della Legge Forense:
• limiti la libertà del professionista di scegliere se rimanere iscritto all’albo in presenza di condizioni personali che richiedano la cessazione dell’attività o la possibilità di accedere a prestazioni previdenziali o assistenziali;
• incida in misura sproporzionata sulla libertà di lavoro garantita dall’articolo 4 della Costituzione, di fatto compromettendo il diritto del professionista di scegliere se cessare l’attività professionale o intraprendere un diverso percorso lavorativo, soprattutto in considerazione della lunghezza del procedimento disciplinare che, come noto, non ha un termine predefinito e pertanto potrebbe condurre il professionista a sopportare il sacrificio di restare iscritto all’albo per un tempo incerto. A riguardo la Consulta segnala che “Il divieto in scrutinio contrasta anche con l’art. 4 Cost., in quanto incide in maniera sproporzionata sulla libertà di lavoro dell’avvocato che richieda di cancellarsi dall’albo avendo intenzione di cessare l’esercizio della professione, ed even-
tualmente intraprendere una diversa attività lavorativa al cui svolgimento sia di ostacolo l’appartenenza all’istituzione ordinistica” nonché, segnala che “Nel caso di specie, la libertà, anche negativa, di lavoro risulta esposta a un sacrificio la cui durata non è prevedibile, non essendo prescritto un termine per la conclusione del procedimento amministrativo davanti al consiglio distrettuale di disciplina, né, tanto meno, per la definizione della eventuale fase giurisdizionale davanti al CNF e alle sezioni unite della Corte di cassazione”. Inoltre, procedendo con una valutazione di proporzionalità ed adeguatezza relativamente ai diritti richiamati nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la finalità perseguita dall’art. 57 citato di garantire la prosecuzione dell’azione disciplinare, possa essere raggiunta con misure meno restrittive e pertanto, nel rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità sancito dall’articolo 3 della Costituzione.Proprio a tal riguardo la Consulta conclude che il vuoto normativo lasciato dall’eliminazione del divieto di cancellazione in costanza di giudizio disciplinare, nelle more delle valutazioni del Legislatore, può essere colmato con un meccanismo che salvaguardi allo stesso tempo l’efficacia dell’azione discipli-
nare e i diritti fondamentali dei professionisti coinvolti. La Consulta, fermo restando la necessità di intervento specifico del Legislatore sul punto, ha ritenuto che cancellazione volontaria in costanza di procedimento disciplinare troverebbe un suo controaltare nella possibile riapertura del procedimento disciplinare all’atto di una nuova iscrizione. In particolare, la Consulta fornisce i seguenti spunti per perseguire il bilanciamento dei diritti coinvolti:
• la rinuncia volontaria all’iscrizione all’albo comporta l’estinzione del procedimento disciplinare;
• conseguentemente, onde far salva l’azione disciplinare, gli organi competenti avranno la possibilità di riattivare l’azione sanzionatoria qualora il professionista chieda, in seguito, di essere nuovamente iscritto all’albo;
• la riattivazione del procedimento disciplinare può avvenire solo se il fatto contestato non sia prescritto
PRIMI RISCONTRI
APPLICATIVI
La pronuncia della Consulta pone diverse riflessioni sulla portata dell’incostituzionalità e sugli indubbi riverberi di natura pratica che coinvolgeranno la gestione degli iscritti agli albi professionali.Provando ad anticipare, si segnalano

le seguenti situazioni che meritano da subito di essere attenzionate e gestite.
1. In via preliminare, la possibilità di chiedere la cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare costituisce una significazione inversione di tendenza, con l’ovvia conseguenza che vi è necessità da subito di un’azione divulgativa dell’orientamento della Consulta e una conseguente pronta revisione delle policy e procedure regolanti il procedimento disciplinare interne a ciascun ente esponenziale; 2. sempre in via preliminare, posto che l’orientamento della Consulta è basato sulla compatibilità tra la norma dell’art. 57 e i diritti costituzionalmente garantiti (cfr. art. 2 e art. 4 Costituzione), ciò richiede un’estensione della sua applicazione a tutte le professioni ordinistiche e non soltanto a quella forense; a prescindere dalla circostanza che taluni ordinamenti professionali non dispongono di
una normativa analoga all’art. 57 della Legge Forense ma che applicano il divieto di cancellazione in pendenza di disciplinare sulla base di prassi o di regolamentazione interna o di interpretazioni giurisprudenziali, è necessario che tutti gli ordinamenti professionali rivedano le proprie procedure sia eliminando il divieto di cancellazione dall’albo in costanza di procedimento disciplinare sia sostituendolo con il meccanismo di controllo a posteriori e nel caso in cui il professionista intenda riscriversi all’albo; 3. nel merito, l’orientamento della Corte richiede un sostanziale incremento di controlli a carico dell’Ordine. Nel caso del professionista che proceda con una nuova istanza di iscrizione dopo essersi cancellato dall’albo, è necessario che l’Ordine organizzi un ulteriore controllo finalizzato a verificare la previa pendenza di procedimento disciplinare; tale controllo può
essere assolto con un’autocertificazione ma, almeno in via campionaria, l’Ordine deve verificare la veridicità della dichiarazione prima di disporre la nuova iscrizione; in aggiunta, all’atto dell’iscrizione l’Ordine dovrà con immediatezza portare all’attenzione dell’organo disciplinare la situazione dell’iscrivendo con l’ovvia conseguenza che il procedimento disciplinare si riattiverebbe pressoché contestualmente alla reiscrizione e che il principio dell’immediatezza dell’azione disciplinare risulterebbe compromesso; ancora in aggiunta è necessario creare un flusso informativo robusto tra l’organo direttivo e l’organo disciplinare disciplinando modalità e criteri per comunicare tempestivamente all’organo disciplinare le eventuali istanze di cancellazione prevenute;
4. Sempre nel merito, la situazione appena descritta risulterebbe amplificata nel caso in cui il professionista chieda la reiscrizione in albo di altro distretto, diverso da quello in cui si è celebrato il procedimento disciplinare e si è richiesta la cancellazione; in questo caso oltre alle cautele di controllo appena esposte vi sarebbe necessità di as-
sicurare un’informazione diffusa e capillare tra ordini che non sarebbe superata e risolta dalla presenza dell’Albo Unico ma che anzi, in talune circostanze, potrebbe anche confliggere con l’applicazione della tutela dei dati personali;
5. Infine, ma sempre nel merito, l’eliminazione del divieto di cancellazione dall’albo in costanza di procedimento disciplinare attenua la caratteristica dissuasiva dell’azione disciplinare posto che -in astratto- potrebbe essere caducata in qualsiasi momento dalla richiesta di cancellazione dall’albo. A riguardo si rammenta la ratio del procedimento disciplinare, replicando l’orientamento in più pronunce espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “Il procedimento disciplinare è, infatti, diretto a «prevenire, dissuadere e al contempo sanzionare, dall’interno, violazioni di regole e valori fondanti della professione», a tutela dell’onore e «degli interessi corporativistici e anticoncorrenziali» della stessa, ma assume rilevanza anche per i terzi che si avvalgono della attività professionale, i quali, dunque, sono, a loro volta destinatari, sia pure indiretti, delle norme deontologiche”. La preoccupazio-
ne della caducazione del procedimento disciplinare è anche della Consulta che, nella propria sentenza, indica testualmente “È dunque necessario che, nelle more dell’intervento legislativo, gli organi professionali competenti vigilino con il massimo rigore affinché non siano consentite pratiche abusive che determinino l’aggiramento del segnalato principio di conservazione dell’azione disciplinare”.
In conclusione, la pronuncia di incostituzionalità relativa alla possibilità di richiedere la cancellazione volontaria dall’albo pur in pendenza di un procedimento disciplinare richiede implementazioni organizzative significative che vanno nella direzione di una maggiore cooperazione tra l’organo amministrativo e l’organo disciplinare e di maggiori controlli ordinistici in fase di reiscrizione.
Attendiamo che la pratica quotidiana ci fornisca nuovi spunti e riflessioni e attendiamo che il Legislatore colmi ill vuoto normativo.

Con un recente provvedimento il Garante Privacy ha sanzionato un Ordine professionale per violazione della normativa sui dati personali connessa ad un data breach; il Garante ha infatti rilevato la vulnerabilità dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate e in particolare ha accertato che l’accesso non autorizzato ai sistemi informatici è avvenuto a causa di una vulnerabilità dell’infrastruttura dell’Ordine che ha consentito l’esfiltrazione (e la successiva pubblicazione on line) di circa 7 GB di dati particolari, inclusi documenti relativi a procedimenti disciplinari e dati per-
sonali di dipendenti, collaboratori e iscritti.
A seguito delle proprie attività ispettive, il Garante ha rilevato un trattamento dei dati in difformità dei principi di integrità e riservatezza (cfr. art. 5, par. 1, lett. f) e art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679) con particolare riferimento all’insufficienza delle misure tecniche e organizzative idonee predisposte che non hanno consentito all’Ordine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio sotteso. Specificatamente, il Garante
ha rilevato le seguenti inadempienze da parte dell’Ordine:
• Mancata adozione di misure idonee a rilevare tempestivamente la violazione dei dati personali: l’Ordine non ha rilevato tempestivamente l’attacco, nonostante vi fossero segnali anomali (accessi notturni via RDP, traffico in uscita, disattivazione processi); la violazione è stata scoperta solo dopo la ricezione di alcune segnalazioni da utenti esterni stante la carenza di strumenti e misure interne di monitoraggio
idonee a rilevare tempestivamente le violazioni dei dati personali. A nulla è valsa la difesa dell’Ordine fondata sulla natura sofisticata dell’attacco informatico, posto che i meccanismi automatici di rilevazione -se posti in essere- sono finalizzati proprio alla rilevazione di eventi che, per le particolari accortezze impiegate dagli attaccanti, possono sfuggire al controllo umano, mettendo in rilevo determinati eventi (es. traffico in orario notturno o in giorni festivi, in giorni in cui non sono previsti interventi di manutenzione programmati);
• Utilizzo di sistemi vulnerabili ed obsoleti: il sistema configurato dall’Ordine era basato su un sistema operativo obsoleto che non rispettava i criteri minimi di sicurezza; tale sistema, unitamente all’omesso aggiornamento, ha facilitato l’accesso da parte di soggetti esterni. In conformità all’art. 32 del GDPR l’Ordine avrebbe dovuto tarare i propri sistemi di sicurezza sulla base dei rischi derivanti dal trattamento dei dati quali perdita, distruzione, modifica, divulgazione e accesso non autorizzato delle informazioni ed in particolare conseguenze sulle relazioni economiche e
sociali degli interessati;
• Inadeguatezza del sistema di sicurezza rispetto al rischio effettivo: la circostanza che l’Ordine ha adottato misure di sicurezza in linea con la Circolare AgID conformandosi al livello standard non è sufficiente a garantire l’adeguatezza delle misure; le stesse devono essere aggiornate rispetto all’attuale contesto tecnologico, all’evoluzione del rischio e della natura dei dati trattati (dati disciplinari, sanitari, giudiziari, su minori). Conseguentemente, la mancata rivalutazione periodica delle misure ha reso queste ultime minimali ed obsolete rispetto alle esigenze e ai più gravi rischi attuali, anche alla luce dell’aumento significativo degli attacchi informatici. Infatti, l’obbligo del titolare del trattamento di adottare misure tecniche e organizzative idonee non si esaurisce con l’asserita conformità alle misure indicate nelle linee guida che invero costituiscono le misure minime di sicurezza, ma richiede revisioni e aggiornamenti;
• Mancata adozione dell’autenticazione a più fattori (MFA): l’Ordine non aveva implementato l’autenticazione a più fattori per gli accessi remoti (RDP), nonostante gestis-
se dati particolari; soltanto a seguito dell’attacco è stato previsto l’uso di autenticazione doppia con certificati e blocchi orari. La mancata adozione dell’autenticazione a più fattori ha facilitato l’attacco, avvenuto tramite brute force su RDP esposto pubblicamente. Il Garante sottolinea che il costo di attuazione di tali misure -evidenziato dall’Ordine- non può giustificare la mancata adozione di misure elementari ma efficaci posto che l’autenticazione a più fattori è considerata ormai una misura di base;
• Mancata protezione crittografica delle credenziali: l’Ordine non ha adottato misure idonee a garantire la protezione crittografica delle credenziali consentendo il recupero delle stesse, associate al dominio esterno, nel dark web che di fatto hanno facilitato l’accesso; Il Garante ha ritenuto, tra le altre cose, che i costi connessi alle implementazioni informatiche non costituiscono una giustificazione accoglibile e non rappresentano una scriminante per la responsabilità dell’Ordine. L’Ordine ha infatti invocato carenze di bilancio ed eccessivi costi a supporto della mancata adozione di misure di sicurezza più evolute ma il Garante ha ribadito che i titolari del trattamento devo-
no essere in grado di gestire i costi complessivi per poter attuare efficacemente tutti i principi e tutelare i diritti. I costi di attuazione delle misure costituiscono solo uno dei fattori da considerare ai fini della loro individuazione e non giustificano l’adozione di misure inadeguate o un motivo per astenersi dalla loro attuazione. Da tale riflessione discende che l’individuazione di misure tecniche e organizzative meno costose deve sempre garantire la protezione dai rischi a cui sono sottoposti i dati non autorizzando il titolare ad abbassare il livello di protezione. Peraltro, il Garante ha sottolineato che la circostanza che le stesse misure siano state adottate dopo l’attacco dimostra che queste non fossero inaccessibili economicamente, ma semplicemente che non fossero state valutate con sufficiente consapevolezza del rischio.
VALUTAZIONE DELLA SANZIONE
In considerazione di quanto ricostruito, il Garante ha concluso che la mancata adozione da parte dell’Ordine delle misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei sistemi di trattamento dei dati personali configura una violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32, par. 1, del Regolamento UE 2016/679.
L’Autorità ha considerato negligente la condotta dell’Ordine valutandola come viola-
zione grave ed ha comminato una sanzione pecuniaria nella misura di euro 30.000,00 tenuto conto che:
• l’Ordine, pur non avendo adottato sistemi di alert in tempo reale per l’identificazione tempestiva di eventuali anomalie, aveva implementato un firewall in grado di rilevare i log e i tentativi di connessione RDP dall’esterno, inclusi eventuali tentativi di accesso indebito alla rete, affidando a taluni propri dipendenti il controllo periodico degli stessi;
• l’esfiltrazione dei dati è avvenuta in maniera progressiva, ovvero generando quantità di traffico di dimensioni tali da non generare sospetti, in orario notturno e in giorni festivi, senza mai superare la soglia di traffico media;
• la violazione non ha compromesso la disponibilità e l’integrità dei dati personali trattati dall’Ordine; tuttavia, ha riguardato un elevato numero di dati personali (dati anagrafici, di contatto, di pagamento, relativi a documenti d’identità/riconoscimento, appartenenti a categorie particolari, relativi a condanne penali e reati, e coperti dal segreto professionale) che ha esposto i soggetti interessati, tra cui anche soggetti vulne-
rabili, a potenziali rischi di discriminazione, furto d’identità, frodi, rischi reputazionali e altri pregiudizi nella sfera economica e sociale;
• l’Ordine ha notificato al Garante la violazione dei dati personali ai sensi dell’art. 33 del GDPR ed ha offerto una buona cooperazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria e che non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento.
Tale provvedimento valorizza fortemente il principio di “accountability” ai sensi del quale il titolare del trattamento adotta politiche e attua misure adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme allo stesso GDPR; tale valutazione deve essere effettuata periodicamente per consentire un aggiornamento e adeguamento costante delle misure ai rischi attuali. Scarica il testo del Provvedimento
Appalti e contratti pubblici

Con Comunicato del Presidente del 18 giugno u.s. l’ANAC ha ulteriormente prorogato la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare la piattaforma PCP per gli affidamenti diretti di valore inferiore a € 5.000,00 e per le fattispecie escluse dall’applicazione del Codice appalti i cui alla Delibera n. 584 del 2023. Tale proroga ha lo scopo di supportare le stazioni appaltanti nelle riferite difficoltà di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD).
Questo nuovo intervento va soprattutto nella direzione delle piccole amministrazioni che -nonostante sia trascorso un lasso di tempo lungo
dall’entrata in vigore delle norme sulla digitalizzazionesegnalano difficoltà di adeguamento connesse soprattutto alla mancanza di risorse utili per affrontare il cambiamento in modo rapido.
La proroga -oramai giunta alla sua terza edizione- sintetizza la scelta dell’Autorità che, nel
bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e le necessità di supporto concreto alle amministrazioni, riconosce l’importanza di un accompagnamento graduale verso la piena digitalizzazione del settore senza compromettere la trasparenza e l’efficacia dell’intero sistema.
Scarica il testo del Comunicato del Presidente, 18 giugno 2025.
Tuttavia, vale la pena osservare che la deroga ha finora rappresentato la regola, invece che l’eccezione; riprova ne è il fatto che il Comunicato di ANAC non stabilisce un termine alla proroga, con ciò potendo intendersi che è sine die. Riprova ulteriore ne è che ANAC ribalta l’onere del rispetto della norma invitando “le PAD a porre in essere ogni misura idonea a favorire la semplificazione del procedimento digitale per l’affidamento dei sopra richiamati contratti, nel rispetto delle regole tecniche dell’art. 26 comma 1 del Codice e del relativo aggiornamento in corso” riservandosi di monitorare il buon esito di tale semplificazione onde stabilire la definitiva dismissione della scheda per gli affidamenti dalla PCP web.

Didattica aggiornata al c.d. “Correttivoˮ
I contratti sotto soglia dopo il Nuovo Codice dei contratti pubblici
Affidamento diretto e procedure negoziate senza bando
Avv. Francesco Russo
25 settembre 2025 09:30 - 13:30 | 4 ore
APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
Mepa/Mepal – INIZ2398 INFO E ISCRIZIONI


Vuoi contribuire ai nostri
“Quaderni”?
Invia il titolo della tua proposta di contributo con un breve abstract, gli obiettivi e i destinatari, insieme al tuo CV, a: redazione@legislazionetecnica.it
Un caso studio tra le Alpi che dimostra l’efficacia del BIM par la progettazione su infrastrutture esistenti. La scelta di sviluppare l’intero modello in ambiente tridimensionale ha rappresentato una svolta significativa rispetto ai metodi tradizionali.

Nel cuore della Svizzera, un progetto infrastrutturale ad alta complessità – il K2B – ha permesso di testare sul campo l’efficienza e l’affidabilità della progettazione con ALLPLAN. La scelta di sviluppare l’intero modello in ambiente tridimensionale ha rappresentato una svolta significativa rispetto ai metodi tradizionali, sia per la qualità del risultato finale che per i benefici ottenuti in termini di gestione delle risorse, controllo delle interferenze e riduzione degli errori progettuali. L’intero processo ha evidenziato quanto sia determinante poter

controllare il progetto in ogni sua componente già nelle fasi preliminari. In un contesto così complesso e articolato, anche piccoli errori di pianificazione avrebbero potuto comportare ripercussioni pesanti sia in termini economici sia temporali.
Il case study rappresenta un riassunto tecnico dell’intervento ed è arricchito con un pacchetto che comprende foto del cantiere, screenshot del progetto, e sezioni tecniche.
Mediante l’applicazione del metodo di calcolo dinamico proposto dalla norma UNI EN ISO 52016-1 è stato studiato l’andamento della temperatura operativa al variare dell’inerzia termica dell’involucro edilizio e dell’intermittenza dell’impianto nel caso di residenze unifamiliari.
di Di Perna C., Summa S., Remia G

Planimetrie Piano Terra e Primo Piano, Sezione A-A’.
CASO STUDIO
L’analisi è stata condotta su un’abitazione unifamiliare a due piani con un locale sottotetto non riscaldato, considerando tre differenti località e zone climatiche:
• Milano, zona climatica E
• Roma, zona climatica D
• Palermo, zona climatica B
Per ciascuna località sono state progettate due configurazioni di edificio, uno massivo e uno leggero con uguale trasmittanza termica ma differente massa superficiale
DESCRIZIONE EDIFICIO
L’edificio è composto da soggiorno, cucina e ba-

gno al piano terra e tre camere al primo piano. Le strutture opache sono state progettate con pari trasmittanza termica, per valutare l’effetto dell’inerzia termica. La parete massiva utilizza laterizio alleggerito in pasta, quella leggera invece pannelli di fibrogesso con struttura portante in acciaio.
I dati climatici su base oraria sono stati ricavati secondo le norme UNI 10349-1:2016 e includono temperatura esterna, umidità relativa, irradianza solare e velocità del vento.
Il periodo considerato è tra il 1° giugno e il 30 settembre.
Consorzio POROTON® Italia Via Franchetti, 4 - 37138 VERONA - Telefono 045.572697 - Fax 045.572430 www.poroton.it - info@poroton.it

Palermo, variazione della temperatura operativa in funzione della tipologia di struttura. I valori evidenziati in blu (struttura leggera) e in rosso (struttura massiva) indicano la potenza fornita dall’impianto per garantire la temperatura di set-point estivo
Roma presenta circa il doppio del carico salare delle altre due località.
PROFILI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Per l’inverno, sono stati testati due scenari: impianto a potenza infinita e impianto con potenza ridotta del 50%. Temperatura di setpoint 20°C.
Per il periodo estivo la temperatura di set-point è stata fissata a 26°C con configurazione di impianto a potenza infinita.
ANALISI RISULTATI
1 - Periodo Invernale, Potenza Infinita
Con impianto a potenza infinita, la temperatura di set-point (20°C) viene sempre raggiunta.
La struttura leggera mostra un maggiore decadimento termico durante lo spegnimento dell’impianto, richiedendo più energia al riavvio, specialmente nelle zone più fredde. La struttura massiva, grazie alla maggiore inerzia, garantisce maggiore stabilità termica.
2 - Periodo Invernale, Potenza Ridotta
Con potenza dimezzata, l’impianto impiega più tempo per raggiungere la temperatura di set. La struttura massiva mostra tempi di ripresa più rapidi, maggiore comfort e fabbisogno di potenza inferiore. Questi aspetti la rendono più adat-
ta in caso di impianti a pompa di calore.
3 - Periodo Estivo
In estate, a impianto spento, la struttura leggera mostra un aumento più marcato della temperatura operativa. Entrambe le strutture raggiungono i 26°C quando l’impianto si accende, ma la struttura leggera richiede più potenza, specialmente nella prima ora.
La struttura massiva limita meglio i picchi di calore, migliorando il comfort interno.
Tutti i dati e i grafici delle rilevazioni sono disponibili nell’articolo completo
CONCLUSIONI
I risultati ottenuti mostrano come la struttura massiva risulti avere un comportamento invernale ed estivo migliore rispetto a quello della struttura leggera, sia in termini di temperatura operativa sia di potenza fornita e rendimento.
NELL’ARTICOLO COMPLETO
Nell’articolo completo di Murature Oggi 142 vengono riportati tutti i dettagli della ricerca. L’articolo è tratto da “Costruire in Laterizio” n. 187, ottobre 2021.
Con l’arrivo dell’estate e delle elevate temperature, il suolo è sempre più soggetto a processi di essiccazione. Questi fenomeni climatici estremi inducono alterazioni nei terreni di fondazione, aumentando il rischio di cedimenti con formazione di crepe negli edifici. Analizziamo cosa accade nel sottosuolo in queste condizioni
Nei periodi di siccità prolungata, specie se associati a caldo intenso, l’umidità naturale del terreno si riduce drasticamente. Nei suoli argillosi, questo comporta un ritiro volumetrico: l’argilla si contrae, creando vuoti e provocando un detensionamento.
Tali effetti si concentrano nei primi metri dal piano campagna, dove la traspirazione del terreno e l’irraggiamento solare intensificano l’essiccazione. Se le fondazioni sono poco profonde (entro 1 metro), possono essere fortemente interessate: il volume interessato può arrivare a 2-3 metri, causando cedimenti localizzati.
Un fattore aggravante è la presenza di alberi ad alto fusto vicino agli edifici. Le loro radici penetrano nel suolo per captare acqua, specialmente nelle zone sotto gli edifici, che mantengono l’umidità più a lungo. Questo fenomeno accentua l’essiccazione del terreno sotto le fondazioni.
Ne derivano cedimenti differenziali, che interessano di solito il perimetro esterno dell’edificio, mentre l’interno è meno colpito. Tuttavia, anche l’adduzione d’acqua da pozzi nelle vici-

DIFECH SRL
nanze può alterare l’equilibrio idrico nei terreni, estendendo i danni anche alle parti interne delle strutture.
Oggi esistono soluzioni efficaci e poco invasive per intervenire sui cedimenti di fondazione provocati dalla siccità. Due tecnologie innovative sono:
1. ValveSystem, che sfrutta l’iniezione di resine espandenti nel terreno;
2. Micropali PushSystem, che impiega pali modulari in acciaio.
Entrambe offrono vantaggi significativi: tempi ridotti, risparmio nessuna rimozione di materiale e vibrazione, interventi mirati e monitoraggio in corso d’opera con strumenti di precisione. Gli interventi sono garantiti 10 anni e rientrano nelle agevolazioni fiscali fino al 50% per ristrutturazione.
VALVESYSTEM, INIEZIONE DI RESINE ESPANDENTI
ValveSystem è l’innovativo sistema di consolidamento fondazioni mediante iniezione di speciali formulati, sviluppato da DIFECH po-
Via Sandro Pertini, 16 43012 Fontanellato (PR) 0521.14.12.895
https://www.difech.com | info@difech.com

SCOPRI DI PIÙ SU VALVESYSTEM

nendosi i due seguenti obbiettivi:
• ottenere una distribuzione uniforme ed omogenea del materiale nel volume di terreno interessato dal bulbo tensionale indotto dalla fondazione;
• adottare in ogni condizione geotecnica il tipo di formulato più idoneo;
Il primo obbiettivo si è raggiunto attraverso l’impiego di canne di iniezione dotate di speciali valvole, mentre il secondo attraverso la selezione di differenti formulati specificatamente sviluppati per impiego geotecnico.
MICROPALI PUSHSYSTEM
I Micropali PushSystem sono una soluzione

SCOPRI DI PIÙ SUI MICROPALI PUSHSYSTEM

innovativa e poco invasiva per risolvere i cedimenti in fondazione. L’impiego dei Micropali PushSystem permette un appoggio di fondazione stabile e duraturo.
Sono dei pali di fondazione modulari in acciaio S355 di provenienza certificata con accoppiamento filettato.
I moduli standard impiegati hanno una lunghezza di 1m e un diametro e spessore a partire da 76 e 8 mm.
La fondamentale peculiarità del sistema PushSystem è la messa in opera di pali con portata certificata ed immediatamente attivi in virtù del precarico effettuato su ogni palo prima del collegamento finale alla struttura con conseguente annullamento del cedimento primario.
Il sistema Rainplus di Valsir, ideato per edifici di medie e grandi dimensioni, è la soluzione per gestire il drenaggio delle piogge la cui intensità, negli ultimi tempi, sta aumentando sempre di più creando problematiche in ogni zona d’Italia
Rainplus rappresenta un’importante innovazione per il drenaggio e il recupero delle acque meteoriche. Ideato per edifici di medie e grandi dimensioni, sfrutta l’altezza del fabbricato per massimizzare l’efficienza del deflusso, favorendo il recupero e il riutilizzo dell’acqua raccolta.
La differenza principale tra un sistema convenzionale e Rainplus risiede nei captatori di raccolta installati sulla copertura dell’edificio. Questi, collegati a tubazioni in polietilene ad alta densità, gestiscono portate elevate fino a 65 l/s. Sono dotati di un particolare piattello antivortice che impedisce l’ingresso dell’aria nel sistema, facendo lavorare le condotte a sezione piena durante le precipitazioni intense. Quando le tubazioni sono completamente riempite, grazie ad un fenomeno idraulico noto come “effetto sifone”, si genera una depressione che accelera il deflusso, permettendo l’uso di tubi di diametro ridotto e senza pendenze per le condotte orizzontali.
LE NOVITÀ
Valsir ha sviluppato due nuovi modelli di captatori, Rainplus 110-S, che si distingue per le

Valsir S.p.A.

elevate performance di drenaggio grazie a una superficie di captazione maggiore.
Questo captatore è disponibile in due versioni, quella con piastra da 320 mm per l’installazione in gronde metalliche e quella con piastra da 480 mm per coperture piane impermeabilizzate (bitume, PVC, ecc.). Entrambe sono disponibili con diverse lunghezze del tronchetto in HDPE, per collegare i captatori alle dell’impianto di drenaggio.
Anche Rainplus 56-S introduce un nuovo coperchio in materiale plastico, mantenendo invariata la struttura del captatore. Questa
Località Merlaro, 2 - 25078 Vestone (BS) Tel. +39 0365 877 397 | Fax +39 0365 81 268 email: valsir@valsir.it - WEB: www.valsir.it

modifica consente di aumentare le portate di drenaggio fino a 16 l/s.
I nuovi modelli ripropongono il “kit overflow”, un sistema di emergenza applicabile ai captatori in grado di gestire anche intensità di pioggia improvvise semplicemente regolandone l’altezza.
Sono stati introdotti due nuovi kit: il primo permette di gestire la continuità della barriera al vapore, utilizzato su coperture per tetti leggeri, in particolare nei Paesi dell’Europa centrale e settentrionale. Il secondo kit è un filtro per le “coperture verdi”, serve a mantenere sgombra da terriccio e detriti l’area di installazione del captatore.
L’ultima novità riguarda lo sviluppo del sistema di staffaggio, Valsir ha introdotto dei collari speciali che abbinati alla barra di supporto e ai relativi accessori di evitare gli spostamenti laterali del sistema stesso.
Rainplus è una soluzione innovativa per il drenaggio delle acque meteoriche, ideale per affrontare l’elevato aumento dell’intensità delle precipitazioni degli ultimi anni. Oggi si registrano intensità di pioggia anche 10 volte superiori a quelle che venivano utilizzate per dimensionare gli impianti pluviali fino a qualche anno fa. Rainplus offre una soluzione più efficiente, che permette di gestire questi eventi metereologici mantenendo limitati gli ingombri e costi. Adatto sia per nuove costruzioni che per le ristrutturazioni, poiché consente di migliorare le performance senza modificare radicalmente gli impianti esistenti o gli spazi, evitando interventi invasivi.

Geolite è la gamma di geomalte minerali per recuperare, rasare e proteggere in un’unica soluzione il calcestruzzo ammalorato. Una famiglia di prodotti che si arricchisce con una nuova geomalta-rasante per la ricostruzione e la rasatura del calcestruzzo.

Con Geolite, Kerakoll – partita nel 1968 come azienda produttrice di adesivi per piastrelle nel distretto ceramico di Sassuolo – ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’edilizia, portando tutta la conoscenza e l’innovazione matura-
ta nel campo dei materiali eco-sostenibili per costruire edifici sempre più sicuri e durevoli in cui vivere. Il termine “geo” è frutto del mix design formulativo nato dalle ricerche svol-
Kerakol Italia via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia - Tel. +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581 kerakoll.com - info@kerakoll.com
te nel Kerakoll GreenLab di Sassuolo. Grazie alla struttura cristallina inorganica minerale composta da una speciale selezione di leganti idraulici innovativi ottenuti da materie prime naturali e processi produttivi a ridotte emissioni, il geolegante Kerakoll permette di rendere le geomalte simili alle rocce naturali. La rivoluzione di Geolite
Dagli anni ’80, il ripristino stratificato prevede l’applicazione di diversi materiali a protezione dei ferri d’armatura e continua ad essere il punto debole dell’intervento sulla struttura in calcestruzzo. La stratigrafia dovrebbe compensare le carenze prestazionali dei singoli prodotti (tecniche e chimiche), ma nella realtà risulta limitante a causa delle diverse condizioni di cantiere che ne possono pregiudicare l’efficacia. Geolite invece passiva, ripristina, rasa e protegge in un’unica soluzione il calcestruzzo ammalorato, superando i limiti del ripristino stratificato. Con la linea Geolite, ad elevata e naturale stabilità dimensionale, si ottiene maggiore resistenza agli agenti chimici e migliori proprietà meccaniche in condizioni estreme e si garantisce un’elevata protezione dei ferri d’armatura per inglobamento.
TECNOLOGIA INNOVATIVA, SICURA ED ECOCOMPATIBILE
Geolite è oggi una gamma completa composta da 9 prodotti per il ripristino del calcestruzzo che si dividono in: geomalte tixotropiche tra cui anche la geomalta-rasante Geolite Silt, geomalte fluide e prodotti complementari, come geopittura decorativa e gel strutturale.
VANTAGGI
Le innovazioni principali della linea Geolite sono:
• Quattro marcature: Geolite è l’unica gamma al mondo ad aver ottenuto una quadrupla marcatura CE per i prodotti tixotropici Geolite, Geolite 10 e 40 rendendo le nostre geomalte sicure e naturalmente stabili. Geolite ha superato infatti tutti i requisiti previsti dalla EN 1504-7 (passivazione dei ferri d’armatura), dalla EN 1504-3 (ripristino
strutturale), dalla EN 1504-2 (protezione, nella versione tixotropica) e dalla EN 15046 (ancoraggi);
• Temperatura di applicazione sottozero: rispondendo ad un’esigenza di mercato, Geolite 10 e Geolite Magma 20 sono stati testati per avere una temperatura di applicazione a -10° C. Risultato raggiunto grazie all’elevata reattività del geolegante;
• Sigillatura dei sacchi: per Geolite 10 e Geolite 40, due dei prodotti più usati dai professionisti, è stata apportata la sigillatura ai sacchi. Ciò consente una maggiore pulizia e ordine dei luoghi di stoccaggio e di rivendita;
• Formati pratici e maneggevoli: è stato inserito sul mercato un nuovo formato da 15 kg per Geolite 10 e Geolite 40, che affiancherà il classico da 25 kg, con l’aggiunta di una pratica maniglia e una conseguente riduzione degli sprechi e una maggiore trasportabilità e ottimizzazione del prodotto anche per piccoli interventi;
• Accessibilità delle informazioni tecniche: gli imballaggi presentano un Qr Code che permette di accedere rapidamente alla scheda tecnica del prodotto, in tutte le lingue disponibili.
Per ulteriori informazioni sulla
Per ulteriori informazioni sulla gamma GEOLITE

Per scoprire le specifiche tecniche della gamma GEOLITE
dal 1933
EDITORIA FORMAZIONE CONSULENZA

IL NOSTRO NETWORK
ltshop.legislazionetecnica.it (e-commerce) legislazionetecnica.it (BLT online) areaformazione.legislazionetecnica.it (Area formazione) fad.legislazionetecnica.it (e-learning) regolaearte.com (Area tecnica)