
9 minute read
Direzioni creative in modalità shuffle: sui cambi pesano più i quarter finanziari che i trend di stagione
Alla base delle frequenti separazioni lampo tra griffe e designer c’è una questione di business: le case di moda, più che per cercare una nuova visione del proprio marchio, utilizzano i direttori creativi come strumento economico
Quanto ancora è destinato a durare il risiko dei divorzi tra maison e creative director? E soprattutto, l’andirivieni di stilisti nelle fila di marchi storici giova realmente al business? Gli interrogativi sono attuali, dopo mesi segnati da separazioni eclatanti nelle fila di marchi storici. Nomi come Jeremy Scott da Moschino, Bruno Sialelli da Lanvin, Rhuigi Villaseñor da Bally (prontamente sostituito da Simone Bellotti), Ludovic de Saint Sernin da Ann Demeulemeester (ora affidato a Stefano Gallici), Charles de Vilmorin da Rochas o il duo Gmbh da Trussardi. Una frenesia che rischia di trasformare gli stilisti in pure commodity usa e getta, escludendo naturalmente le case history di Jeremy Scott, al timone creativo di Moschino da ben dieci anni e di Sialelli, che in Lanvin era entrato quattro anni fa, sacrificato in nome di una nuova strategia creativa. Negli altri casi parliamo di astri nascenti della creatività internazionale, scelti per intercettare una clientela più giovane, assicurare buzz sui social e garantire l’effetto sorpresa che tanta eco ha sui media. Liaison consumate nel giro di uno o due anni (sei mesi addirittura per Ludovic de Saint Sernin da Demeulemeester), spesso a causa dell’inesperienza dei designer. Purtroppo il genio creativo da solo non basta per affrontare sfide complesse all’interno di maison blasonate, in cui entrano in ballo aspetti come la giusta sensibilità per interpretare il dna del brand, la conoscenza approfondita del mercato e la capacità di coglierne e addirittura anticiparne le esigenze. Ed è per questo che alchimie magiche, come quella creatasi tra Alessandro Michele e Gucci, non possono nascere con facilità. Miraggi spesso inseguiti dalle maison; le stesse che non fanno altro che parlare di sostenibilità, eppure imbarcate in giri di valzer infruttuosi. Nel dubbio, meglio forse affidarsi a progetti one shot, coinvolgendo il creativo di turno in esperimenti stagionali utili a tastare il terreno e capire da che parte tira l’aria. Perché alla fine, alla base di tutto e dietro al nome blasonato, ci devono essere team creativi consolidati e strutturati, in grado di garantire continuità e coerenza all’heritage dei marchi. E se poi il vero genio arriva davvero, guai a lasciarselo scappare.

Luca Lo Curzio
ALLA GUIDA DI JIL SANDER

Dopo circa due anni di gestione da parte di Ubaldo Minelli, il ruolo di a.d. di Jil Sander passa nelle mani di Luca Lo Curzio. Comincia dunque a delinearsi il nuovo corso della griffe, entrata nella galassia di Otb nel 2021 e finora guidata dal ceo del polo della moda veneta, che detiene anche i marchi Diesel, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf, oltre a controllare Staff International, Brave Kid e una partecipazione del marchio americano
Amiri. Dal 2016 in Ermenegildo Zegna Group, Lo Curzio ha in curriculum anche esperienze nel Gruppo Luxottica, Bain&Company, Danone e L’Oréal
Dopo 15 anni passati all’interno di Gucci con ruoli di responsabilità crescente, fino a quella di ceo della divisione Vault and Metaverse Ventures e senior executive president, corporate and brand strategy, Robert Triefus ha lasciato la griffe di Kering per approdare nel gruppo Moncler, dove dal primo giugno ha preso le redini di Sportswear Company, l’azienda che sviluppa, produce e distribuisce Stone Island. Avviandosi a conclusione la prima fase di sviluppo del brand, con il controllo diretto dei mercati in cui opera, il top manager avrà il compito di guidare la seconda fase, dedicata all’evoluzione strategica e alla


SLOWEAR APRE UN NUOVO
CAPITOLO CON PIERO BRAGA
Slowear, azienda attiva con i brand Incotex, Zanone, Montedoro e Glanshirt fondata da Roberto Compagno (scomparso nel 2021 a 62 anni), ha nominato Piero Braga amministratore delegato. Una carica che da maggio 2022 a oggi è stata detenuta ad interim dal cfo e coo Marco Bernardini. Braga ha alle spalle una carriera in Gucci, culminata nel ruolo di Evp Strategic Advisor & Board Member. Dopo un aumento di capitale da parte di Nuo Capital - che dal 2018 ha una quota di minoranza della società - l’assemblea dei soci ha confermato nel cda il presidente Paolo Ferrin, Giorgio Delpiano e Stefano Sassi. New entry, oltre a Braga, Monica Marsilli crescita della rilevanza internazionale del marchio. Con l’ingresso di Triefus si rafforza il team management di Stone Island (oltre 400 milioni di euro di fatturato nel 2022), che attualmente vede impegnati, tra gli altri, Romeo Ruffini (secondogenito di Remo) e Francesco Omodei Salè. L’uscita da Gucci del dirigente, che in passato ha lavorato anche per Giorgio Armani e Calvin Klein, arriva in un momento delicato per la griffe, che dopo le dimissioni di Alessandro Michele lo scorso novembre sta preparando il debutto in passerella del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno, che si è insediato in azienda lo scorso 18 maggio.






ETICHETTE AMBIENTALI
Verso una direttiva contro le affermazioni false La parola ai consulenti
L’Ue dichiara guerra al greenwashing: pericolo boomerang
In Europa si contano 230 diversi marchi di sostenibilità. Troppi per proteggere i consumatori dalle false affermazioni. La Commissione propone una direttiva ma senza chiarire come mettersi in regola
DI ELISABETTA FABBRI
“100% Eco”, “Ecofriendly”, “Packaging con il 30% di plastica riciclata”: slogan di questo tipo, in futuro, non dovrebbero più circolare con leggerezza insieme ai prodotti venduti in Unione europea. In marzo la Commissione europea ha pubblicato una proposta di Direttiva sui Green Claim (affermazioni o slogan ambientali), che punta a «impedire alle aziende di fare affermazioni fuorvianti sui meriti ambientali dei loro prodotti e servizi». Il presupposto è che per i consumatori è sempre più complesso dare un senso alle numerose etichette sulle prestazioni ambientali di prodotti (sia beni che servizi) e aziende. Solo in Europa si contano 230 marchi di sostenibilità con livelli di trasparenza molto diversi fra loro, alcune dichiarazioni ambientali non sono affidabili e «la fiducia dei consumatori - si legge - è estremamente bassa».
Chi acquista rischia di essere ingannato, mentre i produttori possono dare una falsa impressione dei loro impatti o benefici ambientali, pratica nota come greenwashing. La proposta di una nuova normativa sulle indicazioni ecologiche vuole quindi proteggere gli acquirenti e l’ambiente, ma ambisce anche ad accelerare la competitività delle imprese «che si sforzano di innalzare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti e delle loro attività».
Il documento prende in considerazione le dichiarazioni esplicite, «fatte su base volontaria dalle imprese nei confronti dei consumatori, che riguardano gli impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali di un prodotto o del commerciante stesso e che non sono attualmente coperte da altre norme dell’Ue». Al momento, come precisa la
Commissione Ue, le label già regolamentate sono Eu Ecolabel, marchio volontario ufficiale dell’Unione europea nato nel 1992, che identifica l’eccellenza ambientale dei prodotti, ed Emas-Eco-management and audit scheme, indicativo del sistema ufficiale di ecogestione e audit dell’Ue, per migliorare le prestazioni ambientali delle aziende. Entrambe, tuttavia, sono scarsamente utilizzate dalle aziende del tessile-abbigliamento.
Dopo la presentazione della proposta antigreenwashing, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo ne valuteranno l’adozione attraverso la procedura legislativa ordinaria e la bozza di testo potrà essere oggetto di ulteriori modifiche. Intanto c’è già chi auspica che, quanto meno, venga fatta chiarezza su alcuni aspetti, pensando ai possibili impatti sulla filiera della moda. «L’industria del tessilemoda è direttamente chiamata in causa, nelle relazioni sia B2B che B2C», afferma Aurora Magni, presidente e cofondatrice di Blumine, società di consulenza con la missione di creare valore nelle filiere della moda e del design, applicando i principi della sostenibilità. «Le aziendeaggiunge - devono usare materiali con una storia documentata di sostenibilità, privilegiando quelli ottenuti almeno in parte da riciclo, e pensare al loro fine vita, evitando di produrre scarti di processo. Inoltre i capi devono durare di più ed essere riparabili».

La comunicazione documentata delle caratteristiche tecniche del materiale diventa quindi un aspetto chiave, nonché il punto su cui si concentrano dubbi e perplessità.
«I claim ambientali - spiega Magni - sono solitamente certificazioni volontarie che l’azienda ottiene a fronte di test, audit o compilazioni di questionari, con lo scopo di descrivere e documentare aspetti specifici di un dato prodotto, come la sicurezza chimica, la percentuale di materia prima da riciclo, l’origine biologica delle fibre e così via. Sono anche utilizzate le asserzioni autodichiarate (che fanno riferimento alla iso 14021) e in alcuni casi le aziende ottengono, a seguito di una Lca-Life cycle assessment, la dichiarazione ambientale di prodotto Epd. La Commissione ha indicato due possibilità: utilizzare Ecolabel oppure procedere misurando l’impatto ambientale con non meglio precisati “metodi scientifici”». Potrebbe trattarsi della metodologia internazionale Lca, è meglio la Pef-Product environmental footprint o altro? «La Lca è una metodologia robusta, che misura l’impatto ambientale di un prodotto in base a confini di analisi definiti - risponde Magni -. Ma prima di determinare quanta CO2 equivalente pesa una camicia di cotone occorre decidere se considerare nel calcolo, oltre ai processi produttivi, fattori come la coltivazione della fibra, la logistica e il fine vita, che influiscono sul risultato finale e che l’azienda, di solito, non ha direttamente a disposizione». Le modalità di rilevamento e calcolo dei dati «andrebbero condivise, per consentire le comparazioni e servono data base affidabili a cui riferirsi, per colmare le possibili lacune nel flusso di informazioni». Tutto questo non è facile in un mercato complesso e globale come quello della moda, composto soprattutto da Pmi che realizzano prodotti non standardizzabili, diversi in ogni collezione, con molteplici varianti. Quanto alla Pef, nata nel 2013 per favorire la comparazione tra materiali e prodotti, si è dimostrata uno strumento più snello ma ha generato dubbi, specie tra i produttori di fibre naturali come lana e cotone, che si sono viste penalizzate dal confronto con quelle man made. «Forse è per questo - osserva Aurora Magni - che la Ue sembra un po’ sfuggente sulla Pef, mentre ribadisce la necessità di dare rilevanza scientifica alle etichette ambientali. Ma se dobbiamo misurare gli impatti, deve dirci come e aiutarci a farlo». La Green Claim Directive pone anche un secondo problema. «Si sta passando da un approccio volontaristico - spiega la fondatrice di Blumine - a un sistema normato attraverso le direttive Ue e gli interventi legislativi dei singoli Stati membri, che dovranno regolamentare la verifica e la penalizzazione del ‘greenwashing’, inteso non solo come pubblicità false ma anche come dichiarazioni non adeguatamente sostenute da prove scientifiche». Allo stato attuale risulta difficile immaginare come ciò potrà essere fatto, senza generare danni o panico tra le imprese. «Non sottovaluto il ruolo di indirizzo di un approccio normativo - prosegue Magni - ma preferisco pensare che il mercato sia in grado di regolare se stesso, premiando le imprese virtuose ed escludendo chi fa greenwashing o socialwashing».
I 10 anni trascorsi a ridurre la criticità dei prodotti chimici nella filiera tessile rappresentano, a suo avviso, una buona pratica a cui può essere utile fare riferimento. «Sotto la pressione di Ong e movimenti di opinione - ricorda - i brand ma anche le tessiture, le tintorie e le filature hanno iniziato a dare visibilità ai propri sforzi di controllo dei materiali, dei processi, dei risultati ottenuti e hanno chiesto ai fornitori, da contratto, garanzie sui prodotti chimici utilizzati. Questo ha spinto i produttori chimici a investire in ricerca, per eliminare le sostanze che, seppur ammesse dal regolamento Reach, rappresentavano criticità. Esperienze come Detox e Zdhc confermano la condivisione di obiettivi di un’intera filiera con risultati tangibili, benché restino dei problemi da risolvere». «Una politica troppo restrittiva e stringente - prefigura l’esperta - potrebbe indurre le imprese, specie i brand globali, a non comunicare i propri progressi in termini di sostenibilità, per evitare di subire attacchi e contestazioni lesivi della loro reputazione. Forse è una visione estrema, ma tra una governance che punta sulla regolazione, calando norme dall’alto, e un sistema industriale che, grazie al dialogo con gli stakeholder, controlla se stesso, preferisco di gran lunga il secondo».
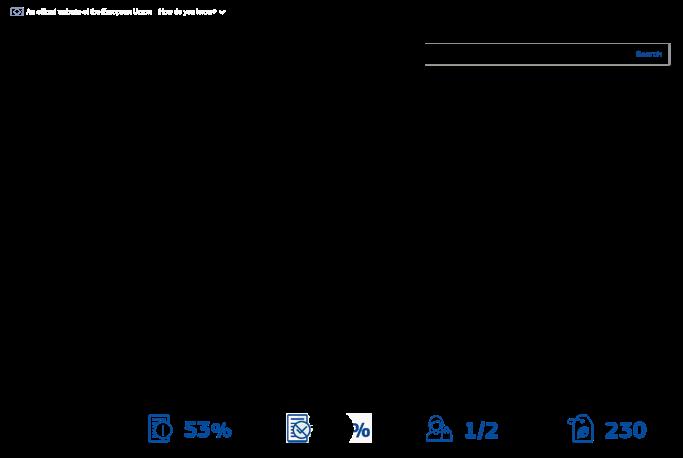
A sollevare dei dubbi è anche Giusy Bettoni, esperta di marketing e comunicazione nel tessile, che nel 2007 ha fondato l’ecohub C.L.A.S.S. (Creativity Lifestyle And Sustainable Synergy), con l’obiettivo di rivoluzionare la percezione della moda sostenibile. «Muoversi nella direzione anti-greenwashing è corretto ed è giusto mettere dei paletti, ma occorrono delle regole chiare - afferma -. Vorremmo capire chi detterà le definizioni, quali sono i parametri, chi si occuperà di controllare. Perché, viene poi da chiedersi, la direttiva considera solo l’ambiente e non l’etica, che invece dovrebbe occupare il primo posto?». «Anche generalizzare troppo - continua - è sbagliato. Se si parla di rispetto dell’ambiente, come pure di etica, entrano in gioco parametri molto diversi fra loro. Basti pensare alle fibre riciclate: si può trattare di rici- clo meccanico, chimico o di altro. Inoltre la ricerca nel tessile continua a sperimentare e, con il sostegno dei grandi brand, potrà fare anche molto di più. Si stanno sviluppando bio-materiali come la pelle ottenuta dai miceli e siamo già arrivati ai materiali bio-fabbricati, prodotti da cellule viventi e microrganismi come batteri e lieviti, con i quali si può persino “coltivare” un certo colore. Sul mercato sono presenti anche fibre sintetiche con polimeri degradabili nel fine vita o pensati già per avere un secondo utilizzo, dopo essere stati un capo di abbigliamento». Scrivere che le dichiarazioni green devono essere provate scientificamente è un buon inizio «ma non basta, bisogna entrare nel merito». «A monte - nota Bettoni - c’è un problema di comunicazione da parte
Le società europee rischiano di essere penalizzate due volte, se le regole non varranno anche per le imprese extra-Ue delle aziende, anche per quelle che stanno facendo molti progressi sul fronte della moda responsabile: devono essere più consapevoli che storytelling è diverso da storymaking. Speriamo che d’ora in avanti siano motivate da un discorso di reputazione, dal voler emergere come le migliori della classe». Non è nemmeno chiaro come saranno regolati i claim “verdi” delle aziende non europee. «Ci si aspetta che l’Ue prenda posizione in tal senso, perché - conclude la ceo di C.L.A.S.S. - se regolamenta in modo rigoroso le imprese europee, ma le regole non vengono estese alle società estere, le realtà domestiche rischiano di essere penalizzate due volte».


LA MATEMATICA NELL’UFFICIO STILE
Una questione di sensibilità
Parlano designer ed esperti di dati










