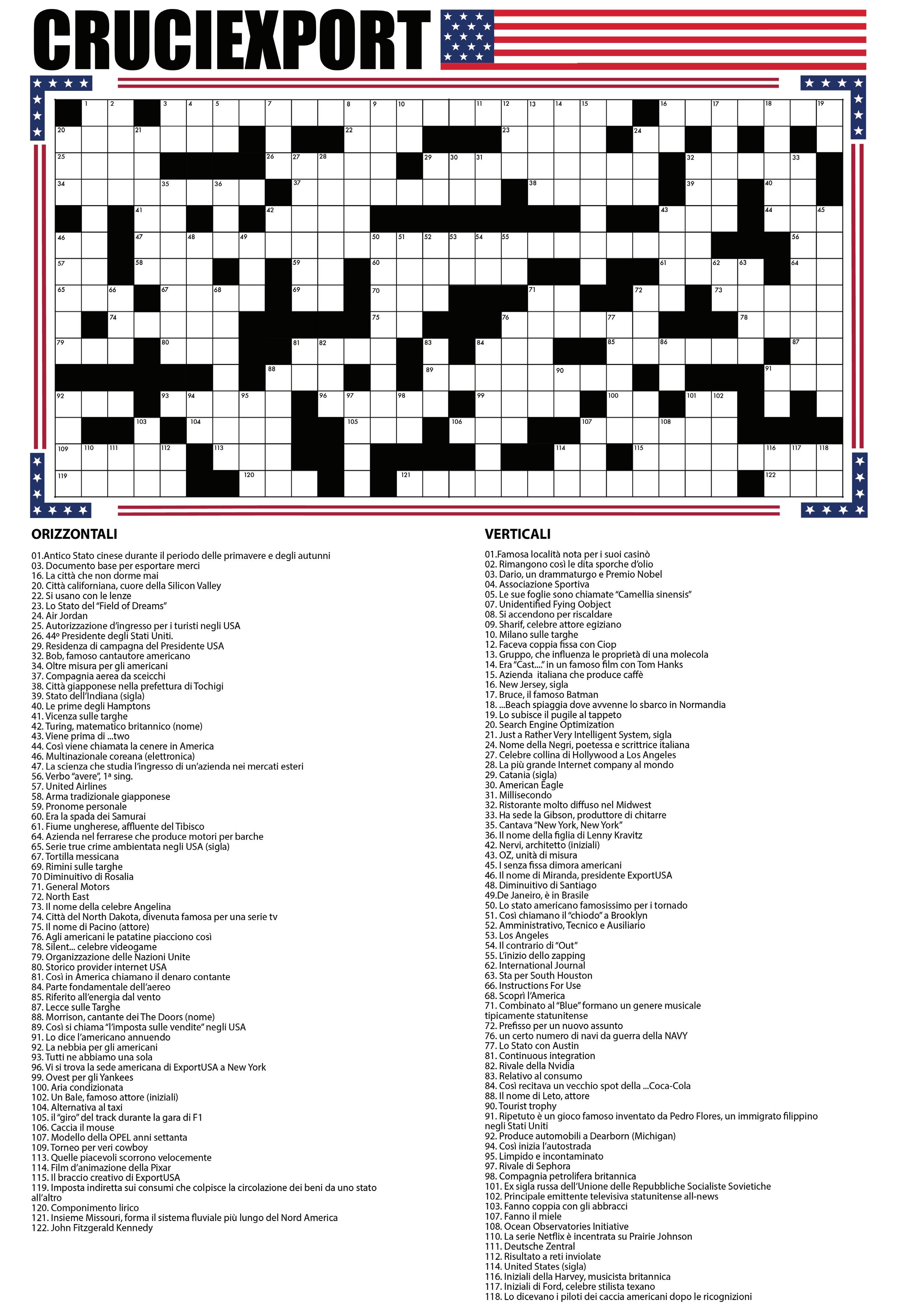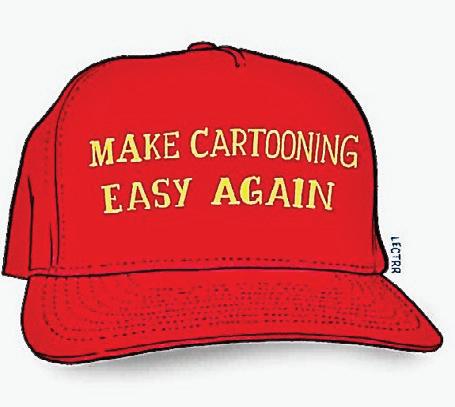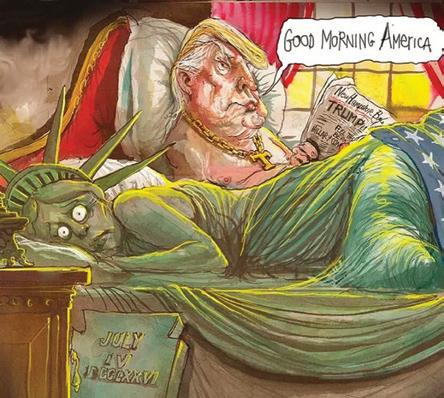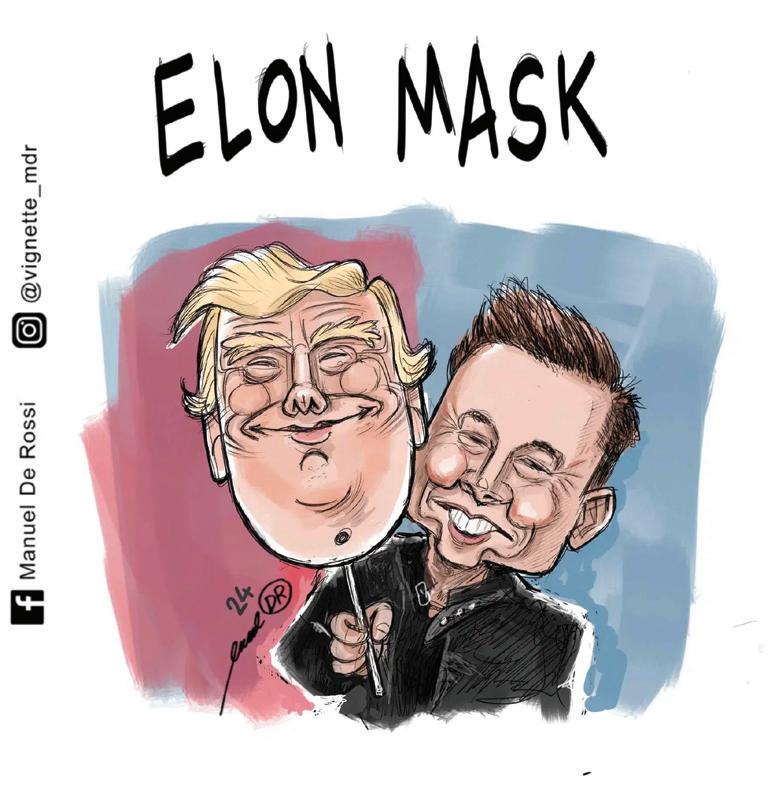In Italia ci hanno sempre insegnato che l’abito non fa il monaco, mentre qui in America lo fa, eccome. Anzi, se lo sbagli resti addirittura fuori dal tempio. È il primo trauma culturale che ogni brand italiano vive appena sbarca nel Nuovo Mondo. C'è la convinzione di avere tutte le carte in regola per distinguersi, mentre i riflettori erano puntati tutti sul
Ci illudiamo che basti un buon prodotto, un nome che suoni vagamente nostrano, un’etichetta con qualche medaglia. Ma qui non vendi ciò che sei, vendi per come appari. Ed è brutale, cinico, spietato ma almeno funziona. Perché in un mercato da oltre 280 milioni di consumatori che partecipano attivamente al consumo, dove ogni sca ale è un campo di battaglia e ogni clic è una scelta d’identità, la soglia di attenzione è molto breve e nessuno ha il tempo di conoscerti in maniera approfondita. O colpisci, o sparisci. nasce da qui. Siamo italiani che vivono in America e che conoscono bene l'America. Sappiamo che il “Made in Italy” non basta più per avere successo, serve il senso, serve il racconto, serve la capacità di entrare nel codice di un paese dove il branding non è una cornice estetica, ma una pinacoteca. Questo si traduce in
Non traduciamo brochure, traduciamo mondi. Non portiamo prodotti, portiamo metamorfosi. Perché il business americano non premia chi partecipa, premia chi pianifica, chi crede nel proprio sogno, chi non smette mai di coltivarlo. Il nostro lavoro è costruire la vostra credibilità in un linguaggio che qui sia riconosciuto, desiderato,
In questo numero abbiamo esplorato un’America reale, non quella che vi raccontano nelle serie tv, sui social, nei titoli dei giornali. Ma un racconto reale, vivo, dai murales di Cope2 a Brooklyn, ai tramonti della California, dalle botteghe di Mulberry Street alla Baia di San Francisco, passando per Big Sur. Nei disegni di Emiliano Ponzi, nei racconti di Kenny Polcari. Negli aneddoti di Ennio Ranaboldo, nella narrativa di Giulia Aguì o
E con lo stile e l’inventiva che hanno reso grande l’Italia e gli italiani nel mondo, l’arte di arrangiarsi, di reinventarsi, di non smettere mai di credere, che prima o poi, l’amore per il proprio lavoro e il nostro "saper fare" torneranno a salvarci. Nelle interviste che leggerete non ci sono solo professionisti e imprenditori, ci sono persone, sogni, sfide, successi. C'è il racconto di tutto quello che il sogno americano ha rappresentato per L'augurio che facciamo ai nostri giovani talenti, è quello che un giorno tornino a sperimentare la propria Summer of Love, ritrovando e riscoprendo la voglia di libertà come nei versi di Kerouac. Dove il genio e l'inventiva facciano da sfondo alla loro
Concepto è il traghettatore creativo tra coloro che hanno voglia di fare e chi dall'altra parte ne concede la possibilità. Un compagno d'avventure che riesce sempre a trovare la giusta playlist di viaggio, ritmata, senza nostalgia. Perché chi crea non ha bisogno di
“In gran parte le persone sono infelici perché sono confuse su cosa abbia veramente valore.”
– William Irvine
Direttore editoriale: Paolo Zucca
Vicedirettore: Muriel Nussbaumer
Art Director: Alfio Martire
Copy Editor: Anna Breda, Chiara Gentilini
Sede legale: via Mentana, 36 47921 Rimini RN
+39 0541 70 90 73
Agenzia Marketing Concepto Nyc Tel. +39 0541 70 90 73
Email: info@concepto.nyc
Stampa:
Copyright: Tutto il materiale scritto dalla redazione è disponibile sotto la licenza ExportUSA New York Corp. - Non commerciale - Condividi allo stesso modo ExportUSA Magazine. Significa che può essere riprodotto a patto di citare ExportUSA Magazine, di non usarlo per fini commerciali e di condividerlo con la stessa licenza.
Registrazione tribunale di Rimini n. 525 del 28 Marzo 2024





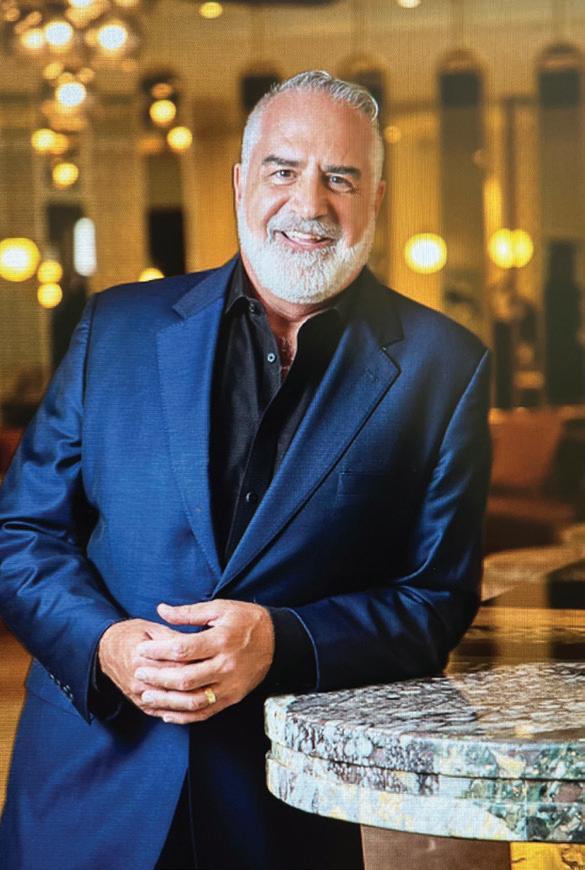
















TRA IL RESPIRO SELVAGGIO DELLA LIBERTÀ E QUELLO DI UNA GENERAZIONE CHE STA CAMBIANDO.


L'ESTATE CALIFORNIANA CHE CAMBIÒ L'AMERICA PER SEMPRE.
FIERE USA: Tutti gli eventi imperdibili nel settore manifatturiero e tecnologico.


ABBIAMO INTERVISTATO COPE2: DAL BRONX ALLE GALLERIE, LA SAGA SELVAGGIA DI UN RE DEI GRAFFITI.


IL BURRITO CALIFORNIANO un involucro di identità, rivoluzione e storia.


"...L’America è troppo grande per sognarla tutta in una Notte..."


A cura di LUCIO MIRANDA
C'è una guerra in corso, ma non è quella che pensate. Non ci sono eserciti, confini o alleanze segrete. È una battaglia molto più subdola, combattuta ogni giorno nella testa delle persone, a colpi di slogan, loghi e scelte di marketing. Questo conflitto silenzioso è la lotta per occupare uno spazio nella mente dei consumatori e arrivare alle loro tasche. In un mondo sovraccarico allo sfinimento di informazioni, dove ogni strada, stazione, monitor, display e feed social è intasato da quel maledetto "forse potrebbe interessarti anche", il posizionamento non è più un'opzione: è una necessità. Ma come si conquista una fetta di attenzione in un mercato così saturato?
UNA REGOLA FONDAMENTALE:
CONQUISTA E DOMINA
Giulio Cesare avrebbe detto "Il dado è tratto", oggi diremo "Per tutto il resto c'è Mastercard" Vuoi essere un leader di mercato? Allora devi fare in modo che il tuo nome non sia solo conosciuto, ma che diventi sinonimo stesso della categoria in cui operi. Non è su ciente essere i migliori; devi essere il primo a insinuarti nel subconscio collettivo del tuo pubblico. E una volta che sei lì, devi restarci. Come? Creando un messaggio così incisivo che nessuno possa dimenticarlo. Non si tratta di vendere un prodotto, ma un'idea, un'immagine, un'emozione. I leader di mercato vincenti sono quelli che riescono a far coincidere il loro brand con una necessità precisa. Vuoi un esempio? "Kleenex" non è solo un fazzoletto di carta, è il fazzoletto di carta.
E quando un brand diventa il riferimento assoluto della sua categoria, hai vinto la battaglia più importante.
LA NICCHIA DEL PERDENTE INTELLIGENTE
Non sei il leader? Bene, accetta la realtà. Ma non disperare: puoi comunque vincere, purché tu smetta di cercare di fare a pugni con i giganti. Devi cercare una nicchia, uno spazio vuoto che il leader ha trascurato, e




colonizzarlo con tutta la tua forza. Non è una strategia per i deboli di cuore, perché richiede sacrificio e, spesso, umiltà. Non puoi essere tutto per tutti. Hai mai sentito parlare di Subaru? Non è l'auto per tutti, ma è l'auto per chi ama la montagna. Ed è proprio questa focalizzazione ossessiva che li ha salvati dall'oblio.
PIÙ PRODOTTO, PIÙ PROBLEMI
Hai già un prodotto che funziona? Ottimo. Ma stai attento a non farne uscire un altro pensando che cavalcherà l'onda del successo del primo. Ogni nuovo prodotto deve avere un'identità propria, una ragione di esistere che non sia semplicemente un'estensione del successo passato. Vi ricordate la New Coke? No? Esatto. Il tentativo di reinventarsi come una versione "migliorata" è stato un flop colossale. Ogni nuovo prodotto deve distinguersi chiaramente e non vivere all'ombra di un altro.
SFRUTTA I PUNTI DEBOLI DEI TUOI COMPETITOR
Se vuoi davvero vincere, non basta fare bene. Devi anche fare meglio del tuo concorrente, colpendo dove è più vulnerabile. I punti deboli della concorrenza non sono solo opportunità, sono la tua strategia. Se il leader è percepito come elitario, posizionati come accessibile. Se è caro, sii economico. Un esempio lampante? Avis. Negli anni '60, un'azienda di noleggio auto ha abbracciato con orgoglio il suo secondo posto, costruendo una campagna geniale intorno al messaggio "We try harder" (Noi ci impegnamo di più). Il risultato? Un boom di vendite che li ha resi un esempio da manuale di posizionamento strategico.
L'ARTE DELLA SEMPLIFICAZIONE
Viviamo in un mondo che celebra la complessità, ma spesso "meno
è meglio". Il pubblico non vuole memorizzare liste interminabili di caratteristiche; vuole un messaggio chiaro, semplice e diretto. Questo principio è valido per tutto: dal design del logo al messaggio pubblicitario. Pensate a Nike. Una parola, un logo semplice e uno slogan immortale: "Just Do It" . Non ci sono spiegazioni complicate, non ci sono manuali da leggere. Solo un'idea, potente e immediata.
CAVALCARE
E poi c'è l'inevitabile: il mercato cambia. Le mode passano, le tecnologie evolvono, e ciò che ieri funzionava potrebbe essere obsoleto domani. Ignorare questi cambiamenti è un suicidio strategico. Il successo di oggi non garantisce nulla per domani, e il tuo posizionamento deve adattarsi ai tempi. Un esempio è Blockbuster, l'iconica catena di videonoleggio, che non ha saputo reagire all'ascesa dello streaming. Netflix, al contrario, ha cavalcato il cambiamento, trasformandosi da un semplice servizio di DVD per posta, al gigante dell'intrattenimento che conosciamo.
TU, FORSE NON ESSENZIALMENTE TU
Capire il posizionamento negli Stati Uniti non è per persone fragili o insicure. È una disciplina spietata, che richiede strategia, creatività e un pizzico di cinismo. È una guerra senza esclusione di colpi, dove sopravvivono solo i più creativi, i più adattabili e i meno egocentrici. Che tu sia un imprenditore emergente o il magnate di una multinazionale, una cosa è certa:
"Se non ti posizioni, non esisti".

Un buon posizionamento sui motori di ricerca è oggi una condizione imprescindibile per qualsiasi operazione di e-commerce rivolta al mercato statunitense. In un contesto ipercompetitivo come quello americano, la visibilità su Google rappresenta spesso la differenza tra un sito che genera traffico qualificato e uno che rimane invisibile. La stessa cosa vale, sebbene in misura minore, per Bing e Yahoo , ancora rilevanti in alcune nicchie demografiche. A differenza dell’Italia, negli Stati Uniti il costo delle attività di marketing tradizionale è elevato e tende a premiare solo chi dispone di capitali consistenti. Per questo motivo, la SEO diventa un investimento strategico, soprattutto per le piccole e medie imprese che desiderano entrare nel mercato con un budget misurato ma ben indirizzato. Non si tratta semplicemente di tradurre un sito o di “adattarlo”, ma di costruire da zero un’architettura pensata per il comportamento del consumatore americano, molto più diretto, impaziente, orientato alla velocità e alla fiducia. Il caricamento delle pagine, ad esempio, ha assunto un ruolo determinante. In particolare, le versioni mobile devono essere leggere e ottimizzate per una fruizione rapida, dato che la maggior
parte del traffico statunitense arriva da dispositivi mobili. La costruzione del sito, in questo scenario, richiede una progettazione orientata alla SEO tecnica, hosting geolocalizzato negli Stati Uniti, codice pulito, compressione delle risorse, implementazione di CDN e compatibilità con i Core Web Vitals. Ma la parte tecnica è solo l’inizio. Il contenuto, o meglio, la strategia semantica, deve parlare direttamente all’utente americano. Non basta la correttezza grammaticale dell’inglese, serve un tono di voce coerente con la cultura locale, una scelta lessicale che intercetti le intenzioni di ricerca e un’organizzazione delle informazioni che rispecchi le logiche cognitive del mercato di riferimento. L’utente americano cerca certezze, e le cerca in fretta. Se non trova subito ciò che vuole, abbandona. Le dinamiche attuali impongono una progettualità organica, in cui la SEO è integrata alla UX, al design, alla qualità del contenuto e alla reputazione del dominio. Un sito ben posizionato non è semplicemente più visibile: è anche più credibile, più competitivo, più sostenibile nel lungo periodo. E, nel mercato americano, questo può fare la differenza tra un progetto che scala e uno che si arena dopo pochi mesi.

Nel corso del 2025 i brand italiani più forti sul mercato americano valgono 121 miliardi di dollari
Nonostante lo scenario geopolitico incerto e le prospettive economiche prudenti per l’anno in corso, il mercato dei brand italiani regge: la perdita complessiva è appena dell’1% rispetto al 2024 e oltre la metà dei marchi in classifica ha incrementato il proprio valore.
Gucci resta imbattibile in vetta alla classifica con un valore di 17 miliardi di dollari. Enel, prima tra le utility, conquista il secondo posto crescendo del 17% e raggiungendo 15,4 miliardi. Ferrari conferma la terza posizione e mette il turbo: +38%, fino a 14 miliardi, spinta anche dall’ingaggio mediatico di Lewis Hamilton in Formula 1.
Il settore finanziario italiano si fa sentire: sei brand totalizzano 13,4 miliardi di valore. Intesa Sanpaolo (+53%), UniCredit (+48%), Banca Mediolanum (+31%) e Generali (+20%) sono tra i top riser. Banco BPM entra per la prima volta in classifica al 38° posto con 0,7 miliardi, ma il settore bancario nel complesso resta vulnerabile, ancora percepito come poco distintivo agli occhi dei consumatori. Nel retail arrivano due novità pesanti: Conad debutta al 17° posto con 1,5 miliardi di valore ed è il marchio più forte della categoria.
Subito dopo Coop Esselunga , invece, sale al 32° posto. La ricetta vincente? Reputazione costruita nel tempo, assortimento aggiornato, prezzi competitivi e servizio clienti solido. Nonostante l’incertezza globale, molti brand italiani resistono e prosperano. Il segreto? Investire nel marketing. È questo che permette di ammortizzare gli shock esterni e mantenere rilevanza.
L’orientamento strategico verso il lungo periodo, unito alla capacità di essere presenti nel momento dell’acquisto e al giusto prezzo, resta fondamentale. Il lusso resiste, ma cambia pelle. Mentre la domanda negli USA, in Corea, Giappone e Cina rallenta, Prada cresce del 7% grazie a un mix vincente: espansione nei mercati emergenti, cultura integrata nei negozi, storytelling artistico, sostenibilità (Re-Nylon su tutti).
Le utility avanzano con valori in crescita tra il 2% e il 17%, spinte dalla liberalizzazione del mercato e da consumatori più consapevoli. A2A (+16%) ha rafforzato la propria distintività puntando su trasparenza, innovazione, comunità e sostenibilità. Fastweb , da parte sua, si distingue con l’ingresso nel mercato energetico tramite Fastweb Energia (100% rinnovabile) e l’integrazione con Vodafone per il rollout del 5G e della fibra.
Nutella, dal canto suo, dimostra come si possa innovare rimanendo fedeli a sé stessi: nuovi prodotti (biscotti, creme vegetali, gelati), posizionamento intergenerazionale e strategia di espansione continua.
In un mondo dove l’identità di marca è diventata l’ultima vera moneta, i brand italiani che resistono – e crescono – non sono quelli che inseguono le mode, ma quelli che sanno chi sono, parlano con chiarezza e investono con coraggio. Gucci, Ferrari, Nutella: nomi che non hanno bisogno di spiegazioni. Ma dietro ogni crescita non c’è solo heritage, c’è visione.
Il report ci dice una cosa molto semplice: in un’epoca di incertezza, il valore si costruisce sul posizionamento, non sulla speranza. Il mercato non premia chi resta fermo, ma chi sa di erenziarsi, osare, evolvere. E l’Italia, quando smette di inseguire l’approvazione e comincia a raccontare sé stessa con autenticità, sa ancora farsi ascoltare dal mondo. Questi 40 brand non rappresentano solo l’economia, ma il potenziale culturale di un Paese che, se solo lo volesse, potrebbe tornare a dettare lo stile. Non solo nei guardaroba e nelle cucine, ma nelle menti.









Avent’anni dalla fondazione di ExportUSA nasce l’urgenza di strutturare un servizio che possa dare valore aggiunto alle attività già proposte. Un progetto che funga da coefficiente estetico e contenutistico, che concili appieno le aspettative dei tanti consumatori che popolano gli Stati Uniti. Che traduca graficamente e semanticamente ciò che i brand italiani vogliono comunicare oltreoceano. Perché mandare un messaggio in America significa cambiare paradigma, vuol dire adoperarsi per comprendere come conquistare la fiducia di un pubblico esigente, informato e all’avanguardia. Da queste fondamenta è nato un vero e proprio dipartimento per affiancare le aziende nella revisione del branding ideando progetti che non snaturino l’essenza di un prodotto, ma che ne esaltino le qualità con l’utilizzo di immagini e parole che possano sposare appieno ciò che l’America chiede. Ecco a voi Concepto NYC. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo in questa intervista con i fondatori Astra Pagliai e Alfio Martire.
A cura di ANNA BREDA

D. Concepto NYC, com’è nato questo progetto, a chi è rivolto e cosa rappresenta oggi per voi, sia a livello professionale che personale?
R. Concepto nasce dall’urgenza creativa di dare un volto vero, rilevante e competitivo ai brand che vogliono a rontare il mercato americano. Mentre ExportUSA costruisce l’impalcatura burocratica e fiscale per farlo sfilare in sicurezza, Concepto crea l’abito su misura del cliente. È rivolto soprattutto a chi ha capito che entrare in America con una traduzione letterale del proprio brand europeo è una lenta e silenziosa scomparsa. È rivolto chi vuole ripensarsi, evolvere, diventare leggibile, desiderabile per un pubblico come quello di oggi che non aspetta nemmeno un attimo di più.
Questo è il nostro laboratorio di pensiero, la nostra fabbrica della creatività. Uno spazio in cui ogni progetto è un manifesto culturale, non un layout da approvare. È una missione personale quanto professionale. Ed è per questo che ci ostiniamo a rifiutare l’ordinarietà. È il modo in cui pensiamo, progettiamo, parliamo
al mondo. Personalmente diventi parte dei sogni di qualcuno, aiuti i brand italiani a smettere di farsi belli e cominciare a farsi capire. In America, ma anche a casa loro. Perché un brand che funziona qui, funziona ovunque.
D. Il nome "Concepto" è distintivo e memorabile, qual è stato il processo creativo dietro questa scelta?
R. Ci interessava trovare un nome che avesse respiro internazionale, ma senza risultare impersonale o banale. Cercavamo qualcosa che contenesse una dimensione progettuale, che suggerisse metodo, idea e struttura , ma che sapesse anche evocare calore, personalità ed eleganza. Capace di mantenere la propria forza espressiva in ognuna delle lingue più importanti al mondo. Ha un suono diretto ma non rigido, una forma pulita ma non sterile. È una parola che porta con sé un senso di architettura mentale, ma anche di umanità e stile. Dietro questo nome ci nascondiamo noi, le nostre persone, i nostri pensieri, la nostra voglia di creare, di essere curiosi del mondo.
Americanoncercadi essere inconfondibile. “

“

Volevamo un’identità capace di raccontare da sola il nostro modo di lavorare. Il nostro scopo è quello di costruire ponti culturali attraverso il design, dare forma a idee che non temono il confine, ma lo attraversano con naturalezza.
D. Quali sono le sfide principali che a rontate come dipartimento di branding per il mercato americano? E come le trasformate in opportunità?
R. Negli Stati Uniti, l’ambiguità non trova spazio. Se un brand non è immediatamente leggibile, rischia di essere ignorato. Gli americani pretendono da subito chiarezza, coerenza e soprattutto un messaggio che sappia arrivare dritto al punto. In questo contesto, la sfida principale per chi si occupa di branding non è semplicemente comunicare, ma farlo in modo preciso, efficace e profondamente consapevole del contesto culturale in cui ci si muove.
Il nostro lavoro consiste nel ricreare un’identità senza snaturarla, nel reinterpretare il DNA di un brand europeo a nché possa parlare la lingua del mercato americano senza cadere in banalizzazioni o scorciatoie stilistiche. Non si tratta di adattamento cosmetico, ma di una vera e propria riscrittura strategica. Il gusto americano non è superficiale, come spesso si è portati a credere; è invece incredibilmente orientato all’obiettivo.
"... Ciò che conta davvero non è sapere cosa la gente pensa di te, ma perché..."
- Chris Ducker
Chi acquista, chi osserva, chi valuta un brand negli USA vuole sapere immediatamente chi ha davanti, perché dovrebbe fidarsi e cosa otterrà. Non c’è tempo per i sottintesi, non c’è spazio per l’indefinito.
Trasformiamo questa richiesta di immediatezza in un’occasione creativa. È un esercizio quotidiano di sintesi e visione, in cui ogni progetto ci costringe a prendere posizione, a scegliere una direzione precisa e a sostenerla con coerenza. Lavoriamo sul posizionamento in modo netto, costruiamo identità visive forti, scriviamo messaggi senza orpelli, ma con profondità.
È un lavoro artigianale, quasi da cesellatori, in cui nulla è lasciato al caso. Il risultato è un brand che non si a accia timidamente sul mercato americano, ma interviene con sicurezza, consapevole di sé e della propria voce. Non come un turista curioso, ma come un protagonista che sa dove vuole andare.
D. Secondo voi, quali caratteristiche deve avere oggi un brand per a ermarsi con successo negli Stati Uniti?
R. Prima di tutto deve essere leggibile, rilevante e reattivo. La leggibilità non è un vezzo formale, ma una



condizione necessaria per esistere in un mercato saturo e velocissimo. Se il pubblico non capisce chi sei e cosa o ri in pochi secondi, semplicemente smette di guardarti. Ogni esitazione equivale a un’occasione persa.

Ma la chiarezza da sola non basta. Un brand deve essere anche rilevante, capace di inserirsi in una conversazione culturale già in corso, di creare connessioni, di generare senso. Negli Stati Uniti l’estetica da sola non regge, serve contenuto, visione, una promessa chiara e un motivo per crederci. Il pubblico americano non cerca solo prodotti belli, ma storie in cui riconoscersi, valori da condividere, identità da scegliere. E poi c’è la reattività. Il ritmo del mercato americano è implacabile, aggiornarsi, evolvere, rispondere rapidamente non è un plus, è parte integrante dell’identità di un brand. Chi non sa cambiare resta indietro, e chi resta indietro scompare. A tutto questo si aggiungono altri ingredienti fondamentali. Serve autenticità, ma quella vera, non estetizzata né costruita a tavolino.
Serve una tensione narrativa, un filo conduttore che tenga insieme i messaggi, i prodotti, le scelte estetiche. E soprattutto serve coraggio. Coraggio di avere un punto di vista, di prendere posizione, di distinguersi anche quando è scomodo. Un brand che funziona in America non cerca di piacere a tutti, cerca di essere inconfondibile.
- Jay Baer
D. Se doveste racchiudere l’essenza di Concepto in uno slogan, quale sarebbe? E perché?
R. “Identità italiane, che parlano americano” Perché è esattamente ciò che facciamo - aiutiamo i brand a diventare comprensibili, competitivi e desiderabili nel mercato statunitense, senza snaturare la loro essenza. Niente stereotipi da esportazione, niente “Italian style” da cartolina. Lavoriamo sulla verità di un marchio, la traduciamo in un linguaggio visivo e strategico che funzioni negli Stati Uniti, e la facciamo risuonare con forza. Il risultato è un’identità autentica ed impossibile da ignorare.
D. Vi siete ispirati a qualche modello di comunicazione in particolare?
R. Più che seguire modelli, seguiamo un metodo fondato su osservazione culturale, provocazione strategica e rigore progettuale. Non rincorriamo le tendenze, le analizziamo. Non imitiamo i codici, li decostruiamo. Ci incuriosiscono le agenzie che trattano il branding come un atto editoriale, capace di generare discorso e costruire significato. Allo tempo stesso, ci ispiriamo alla radicalità formale del design italiano, alla forza concettuale della pubblicità degli anni ’60, all’irriverenza autentica del branding indipendente






americano. Ogni riferimento diventa materia viva, mai citazione sterile. Il nostro obiettivo non è creare qualcosa che piaccia a tutti, ma costruire identità che sappiano parlare a chi conta davvero. Brand che lasciano il segno, che non si confondono, che non chiedono il permesso per esistere.
D. Qual è il trucco più sottile per entrare nella mente di un consumatore americano?
Non dargli mai l’impressione che tu lo stia educando. Devi farlo sentire parte di una scelta, non di una lezione. Funziona tutto ciò che stimola l’autonomia, la gratificazione istantanea, il senso di esclusività. Non vendere l’Italia come “eccellenza artigianale”, ma come “esperienza che solo pochi hanno il coraggio di vivere davvero”. La verità è che il pubblico americano compra status, non cultura. E se tu non riesci a trasformare il tuo brand in un badge identitario, sei fuori. Il messaggio non è “Guarda quanto siamo bravi”, ma “Se scegli noi, diventi quello che vuoi essere”. Il trucco consiste nel parlare al suo ego senza farlo sentire idiota. L’americano ha fame di appartenenza, ma detesta il bisogno. Devi costruirgli una mitologia personale. Il tuo brand non è un prodotto, è un’estensione della sua narrativa.
D. Se Concepto fosse una canzone americana, quale sarebbe?
R. Se Concepto fosse una canzone americana, per me sarebbe “Empire State of Mind” di Jay-Z e Alicia Keys. Perché c'è visione, ambizione, identità che si reinventa. Parla di città, di sogni e di concretezza, proprio come facciamo noi, a ondiamo i piedi nel cemento di Brooklyn ma abbiamo la testa a cavallo tra due continenti. Alfio invece avrebbe optato "Good Vibration" dei Beach Boys. Per la struttura musicale complessa, uso di strumenti non convenzionali, tecniche di registrazione innovative. Eppure, con “What’s Going On” abbiamo trovato il nostro punto d’incontro, un brano che mettesse d'accordo entrambi come mentre lavoriamo. Marvin Gaye canta “What’s Going On?”(Cosa succede?) È soul con coscienza, evolvuzione con eleganza. È branding, che si fa ponte tra mondi.


Nel cuore di DUMBO in breve tempo Astra e Alfio diventano i due poli magnetici di Concepto NYC. Mente analitica e cuore visivo, concretezza operativa e irrequietezza creativa. Insieme guidano progetti di branding che non inseguono mode, ma le creano. Costruiscono un ponte culturale tra le aziende, gli imprenditori italiani e il mercato americano. Astra è fondatrice di Concepto e COO di ExportUSA. Vive tra operatività aziendale e intuizioni, tra legalità americana e posizionamento sensoriale. È lei a tracciare la rotta per far entrare i brand italiani nel mercato USA, senza compromessi e senza illusioni. Le sue armi segrete sono, metodo, ascolto, neuroscienze applicate. Alfio è illustratore, grafico e direttore creativo. La sua mente è uno studio aperto tra design, minimalismo e pulsione artistica. Supervisiona l’intero processo visivo, dallo storytelling al packaging, dall’identità al tono di voce, spingendo ogni progetto oltre la soglia dell’ovvio. Il suo tratto è essenziale, il pensiero tagliente, il gusto feroce. Insieme, trasformano le aziende in brand coerenti, vibranti, memorabili. Non vendono sogni, ma verità ben progettate.


In un mercato globalizzato e brandizzato, dall’acqua minerale al silenzio (vedi app "Calm"), la vera domanda non è come farmi notare?” , ma “ perché dovrebbero scegliermi? ". E no, non è una questione di budget, naming o di packaging. È tutta una questione di educazione sensoriale.
ASCOLTARE IL MONDO
Nel branding odierno si fa un gran parlare di “esperienza” . Ogni brand deve “emozionare” , “coinvolgere” , “stimolare i sensi” . Ma pochi sanno davvero cosa significhi educare i propri sensi per progettare un’identità che parli al corpo prima che alla mente. Perché il branding non è un monologo narcisista, è una coreografia invisibile tra percezione, cultura e memoria. E chi lo riduce a uno storytelling autoreferenziale è solo un dilettante con tanti soldi che cerca attenzioni.
CREATIVO
Viviamo un’epoca infestata da “visionari” da salotto, creativi con la bava alla bocca per un post virale, esperti in personal branding che parlano solo
di sé. Tutti bravi a pontificare sul potere delle emozioni, pochi a capire che i sensi non si manipolano, si rispettano. Chi progetta un brand pensando solo a cosa vuole dire, senza chiedersi cosa l’altro vuole sentire, è destinato all’insignificanza. La comunicazione non è una galleria d’arte personale, è uno spazio condiviso. E per occupare quello spazio, bisogna prima imparare ad ascoltare. Altrimenti quando non sai chi è il cretino nella stanza...
Educazione sensoriale significa allenarsi a percepire il mondo senza filtri. Annusare, toccare, assaggiare, ascoltare, osservare con la fame di chi non sa nulla. Significa scegliere una carta da packaging non per quello che “dice di te”, ma per come vibra tra le dita di chi la tiene in mano.
Significa capire che un profumo può evocare casa di nonna o la scoperta di un tradimento. Che un suono metallico può trasmettere lusso o freddezza a seconda del contesto. Che il silenzio, a volte, è il miglior logo sonoro.
UN PONTE
Ogni cultura interpreta i sensi in modo diverso. Il rosso in Cina è fortuna, in Sudafrica è lutto. Il gusto dolce in Europa
è coccola, in Giappone è sospetto. Chi lavora con i sensi deve essere antropologo, non influencer. Sceglierti deve essere un'esperienza non una condanna. La sensorialità nel branding è un linguaggio, non un vezzo stilistico.
È l’unico modo per entrare nel vissuto profondo delle persone, dove non arrivano le parole ma restano le sensazioni. Conquistarle, sedurle, con eleganza.
L’INTELLIGENZA
PERCETTIVA
Il futuro del branding non sarà dominato da chi urla più forte, ma da chi sa ascoltare meglio. Da chi mette a tacere il proprio ego per amplificare la voce del mondo. Serve una nuova generazione di brand strategist capaci di leggere il mondo attraverso i sensi, non le vanity metrics. Capaci di annusare il contesto, tastare l’umore sociale, cogliere il non detto.
L’educazione sensoriale è l’unica vera alternativa all’arroganza creativa. È una pratica, non una posa. È il contrario dell’autoreferenzialità, è un atto di umiltà percettiva.
E solo chi è disposto a "sentire" davvero potrà, un giorno, essere a sua volta "sentito".

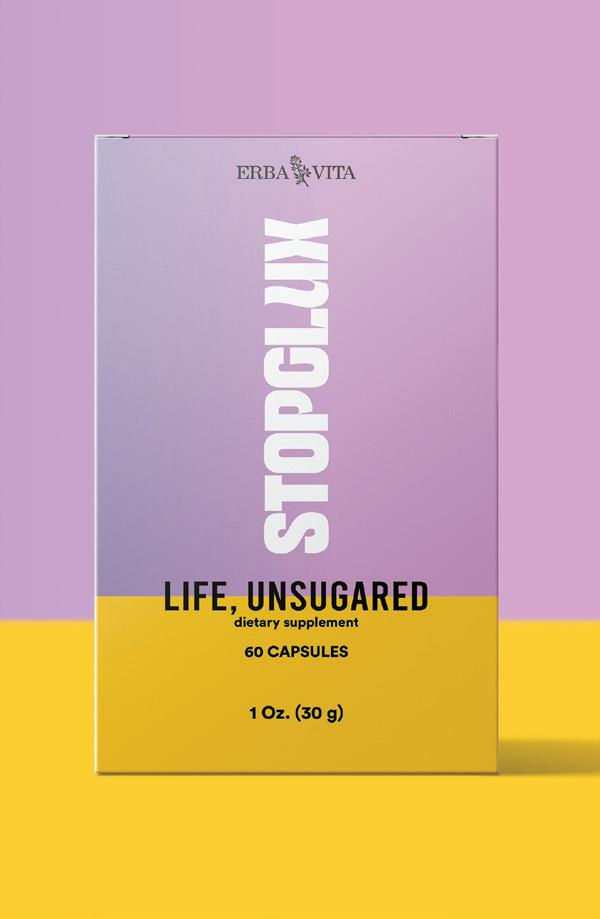




Concepto for Pastagasm nyc

Concepto NYC, o re un servizio completo che va oltre il branding tradizionale. Dai dei recenti successi dei nostri clienti per le aperture di due nuovi locali a Manhattan. Abbiamo condotto un’analisi approfondita del mercato, identificando un gap per prodotti che combinano Made in Italy e sostenibilità. Il risultato è stato un aumento delle vendite del 45% nei primi sei mesi e un tasso di
fidelizzazione dei clienti superiore al 60%. Per avere successo negli Stati Uniti, il branding ed essere italiani non basta. Il concept deve essere accompagnato da un marketing integrato che ne amplifichi la portata. Ma cosa significa veramente marketing integrato? Il marketing integrato è l’arte di creare un’esperienza fluida per il consumatore attraverso tutti i

punti di contatto. Significa che ogni campagna pubblicitaria, ogni post sui social media, ogni interazione con il cliente deve rispecchiare i valori del brand. Ed essere sincero, non si possono millantare cose che poi la realtà dei fatti potrebbe sbugiardare. Il brand che dura più a lungo nel tempo è quello più sincero e trasparente. Uno degli strumenti più potenti per il marketing integrato è l’uso sinergico dei dati. Ad esempio, Concepto ha sviluppato per un cliente un sistema che combina analisi predittiva e campagne mirate, portando a un aumento del ROI del 30% in soli tre mesi. Questa sinergia tra branding e marketing integrato è cruciale per costruire fiducia e fedeltà nei consumatori.

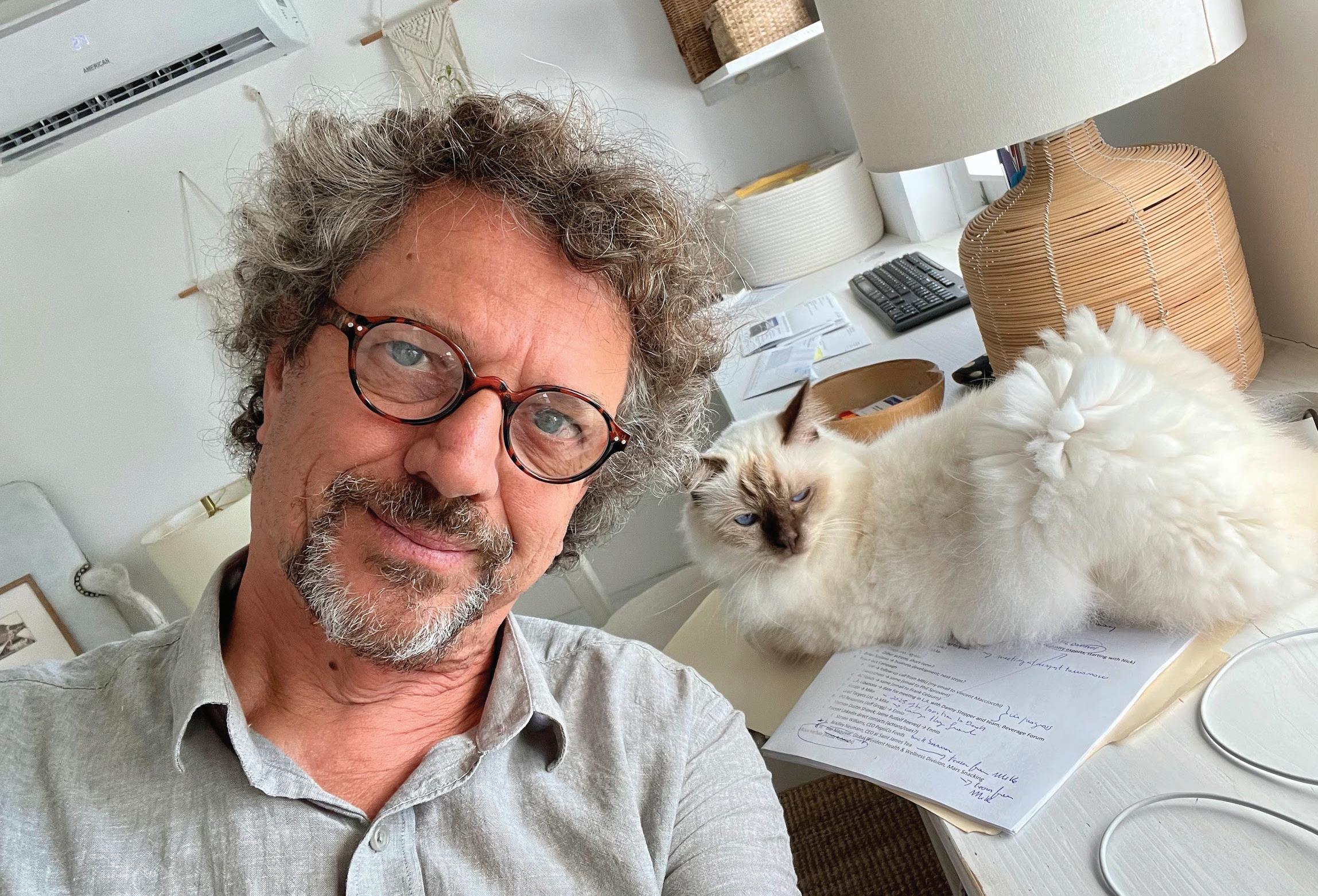
Ennio è uno di quegli italiani che l’America non solo l’ha capita, ma l’ha anche sfidata. Torinese di nascita, newyorkese d’adozione, oggi divide il suo tempo tra Manhattan e Las Terrenas, nella Repubblica Dominicana. Dopo aver guidato per oltre vent’anni le filiali americane di due colossi come Lavazza e MartinBauer, continua a occuparsi di sviluppo strategico e mentoring, con uno sguardo lucido e disincantato su ciò che significa davvero “fare carriera” oltre l’oceano. Innanzitutto benvenuto Ennio e la ringraziamo ancora per aver accettato l' intervista sul nostro magazine.
D. Comincio subito con il chiederle: basta sembrare italiani per fare
carriera in America? È ancora un vantaggio competitivo o si rischia di diventare un cliché da cui liberarsi?
R. Credo che “sembrare italiani” o anche “essere italiani”, di per sé, non faccia fare carriera in nessun posto al mondo né alle persone né… alle marche. Meno che mai in America. Noi italiani ci piacciamo tantissimo e tendiamo a sopravvalutare quanto gli “altri”, il mercato, i consumatori, condividano questa generosa e qualche volta un poco auto-riferita passione. Ora, sebbene occorra diffidare delle generalizzazioni come della peste, credo però sia ragionevole a ermare che l’Italia(nità) – il paese reale, la sua gente, il suo saper fare, e quindi i suoi prodotti – goda, e continuerà a godere, di un’immagine molto positiva e vibrante nell’immaginario collettivo americano, pur con significative differenze di impatto, di
rilevanza, di propensione all’acquisto, che so, tra caucasici e latini per dirne una. Ma tutto questo bel sognare italiano, se rimane una robusta e necessaria condizione, non è certamente una su ciente per il successo delle nostre aziende. Non sono un militante del “Made in Italy” inteso come produzione obbligatoria sul territorio del Bel Paese –semmai, credo nel “Created in Italy”! – ma, a prescindere dal mio convincimento, quello che conta è davvero il sapere –ovvero da dove la maestria e l’ingegno italiani giungano, come si siano stratificate nei decenni, qualche volta nei secoli. Le storie di successo imprenditoriale italiano negli USA sono sempre storie molto, molto complesse, per quanto gli ingredienti siano sempre i soliti… noti: chiarezza di intenti (obiettivi, di lungo periodo), conoscenza della sfida (mercato, non solo inteso come quello di immediato riferimento), volontà di

L’UMILTÀ DEGLI AZIONISTI, APERTI AD UNA TRASFORMAZIONE CULTURALE PRIMA
ANCORA CHE OPERATIVA..."
investire (risorse adeguate, non solo economiche).
D. Lei ha guidato per anni le sedi americane di grandi gruppi europei. Come ha conciliato culture operative profondamente diverse? Cosa ha funzionato davvero sul campo e cosa invece ha richiesto un cambio di pelle?
R. Non credo sia questione, almeno non principalmente, di differenti “culture operative”: in fondo, costruire una fabbrica, gestire una catena logistica, impostare un piano commerciale, sono tutte cose che obbediscono a elementi fondamentali condivisi da ogni cultura di impresa, non importa quanto remote geograficamente una dall’altra. Quello che ancora fa la di erenza ha a che fare spesso con la tipologia e le dimensioni dell’impresa (famigliari e medio-piccole, per lo più, almeno nel mio settore, quelle italiane) e con la natura sempre un po’ bifronte del mercato americano: quasi tutti lo desiderano appassionatamente, pochi ne abbracciano appieno la complessità. C’è ancora, ad esempio, una diffusa riluttanza, in molti casi del tutto comprensibile, ad evolvere il proprio modello di business da “esportatore” ad azienda italiana con base in America in senso proprio, e ciò a prescindere da ogni persuasione su cosa sia o non sia, o debba essere, il “Made in Italy”. Ci sono luminose eccezioni, naturalmente, dove la differenza l’hanno fatta una più lungimirante accettazione del rischio, la disponibilità di capitali e una passione ossessiva per il consumatore americano e le sue predilezioni; una passione che non dovrebbe mai essere inferiore a quella che nutriamo per i nostri prodotti. Occorre insomma una sistematica
capacità di adattamento e di evoluzione; e una forte propensione all’innovazione – non quella fatta in casa ma quella che parte, appunto, dai consumatori locali, dalle esigenze degli operatori professionali locali, nel caso del mercato foodservice. Senza che questo comporti scendere a compromessi, abdicare alla qualità leggendaria di cibi e bevande e materie prime italiane. Ma si sa anche che l’America non difetta di materie prime altrettanto eccellenti, a cominciare dal grano! Quello che funziona sempre, tornando agli ingredienti del successo, sono l’intelligenza e l’umiltà degli azionisti, aperti ad una trasformazione culturale prima ancora che operativa. Quello che spesso non funziona invece, o si incaglia o finisce col costare uno sproposito, è appunto l’esecuzione dei piani. Ma ci sono modi per minimizzare i rischi, a cominciare dal lavoro con le persone ed i partner giusti.
D. L’italiano medio che sbarca oggi negli Stati Uniti sogna ancora il mito dell’ascensore sociale. Ma siamo nello stesso edificio di un tempo? Oggi l’ascensore è rotto, bisogna salire a piedi o arrampicarsi a mani nude?
R. “ Medi” siamo tutti, ovvero tutti abbiamo un’opportunità, soprattutto in questo paese. Ci sono arrivato venticinque anni fa e da quindici io, come tutti in famiglia, ho il passaporto USA e quello italiano. In un quarto di secolo, non un solo individuo che io abbia conosciuto di persona – non importa quanto modesta o smisurata l’ambizione, limitati o eccezionali i talenti – ha mai fatto sconsolato ritorno in Italia perché non ce l’abbia in qualche misura fatta; e non

TUTTI ABBIAMO UN’OPPORTUNITÀ, SOPRATTUTTO IN QUESTO PAESE. “
“
una persona che non abbia poi rimpianto l’America (non solo New York!) quando circostanze indipendenti dalla sua volontà l’hanno magari costretto a lasciarla. Come sappiamo, le strade americane non sono mai state lastricate d’oro; questo può anche essere un paese tremendo e la sola espressione “Sogno Americano” sarebbe da emendare dalla lingua; ma le opportunità erano, sono e saranno reali, le risorse del paese sono immense e così i capitali e le idee; la mobilità verso l’alto – con un pizzico di fortuna, molto amore per questa terra e il solito durissimo lavoro – rimane una concretissima possibilità per molti.
D. Martin Bauer, Lavazza, le erbe, il benessere e il brand italiano. Dove sta andando oggi il made in Italy in America?
R. Il Made in Italy corre, in tutto il mondo e negli USA ancora di più, come raccontano i dati. Sono un inguaribile ottimista, quindi credo che questa corsa continuerà ancora molto

a lungo; vedo un potenziale tremendo a cui attingere, sia nell’area “specialty” e per i piccoli produttori che per prodotti e marchi – che so, olio, caffè, pasta, per citare i principali – già ben calati nel consumo diciamo di massa; e non poche opportunità esistono anche come produttori di qualità per i marchi delle insegne. Semmai c’è un poco da stupirsi del contrario; ovvero, che un sistema agro-alimentare come quello italiano, un sistema che non ha uguali al mondo per varietà, capacità, qualità e tutela del consumatore non abbia ancora pienamente sfruttato questo potenziale. Si contano ancora oggi sulle dita di una mano le aziende che hanno raggiunto dimensioni importanti negli USA, con investimenti significativi e capacità manifatturiere locali. Moltissime sono invece le aziende medie e piccole e piccolissime che ancora vedono il loro rapporto con il mercato “mediato” da agenti, importatori e distributori. Non necessariamente una cosa negativa in sé, ma può essere

un limite allo sviluppo, alla crescita diretta e governata in proprio. Credo che il sistema Italia possa e debba evolvere con logiche più aggressive, più dirette e “partecipative”, siano esse joint ventures, accordi di lungo periodo o acquisizioni dirette. Non penso tanto a iniziative consortili o associazionistiche, per quanto meritevoli, ma ad una strategia che ricerchi attivamente e intelligentemente piattaforme industriali e commerciali americane, anche multicanale, su cui fare leva, così da accedere, pur senza abbandonare le nicchie dorate ma minuscole del “premium”, a una più vasta e stratificata massa critica di consumo e a molti milioni di consumatori a ezionati in più!
D. Lei siede nel board della Casa Italiana alla NYU. Come si fa oggi a reclutare e trattenere i talenti italiani in America? e cosa motiva un giovane di valore a restare?
R. Intanto, restare negli USA è di cilissimo e di espatriati non se ne parla, anche a ragione, visto i costi esorbitanti. Questo il primo ostacolo. Ma la domanda vera – per quei giovani che sono riusciti ad entrare legalmente, o che vivono e lavorano negli USA da tempo, magari grazie anche a relazioni famigliari che hanno facilitato residenza o cittadinanza – è: perché rientrare in Italia? E non mi si fraintenda: amo il mio paese di nascita almeno quanto quello di adozione, ma sappiamo come stanno le cose quando parliamo di lavoro giovanile nel Bel Paese: carriere impossibili, mobilità ridottissima, disoccupazione o sottoccupazione elevatissime, remunerazioni tra le più basse dell’area OCSE e al palo da trent’anni. D’accordo tutti: l’Italia sarà anche il paese più bello del mondo ma è anche quello più invecchiato, con inscalfibili gerontocrazie e che peggio tratta i suoi giovani, talenti compresi. Quindi, cosa motivi un giovane a restare o a tentare di restare negli USA, con tutte le proprie forze e la propria ingegnosità mi pare cosa piuttosto evidente.
D. Quanto c’è di lei nel giovane Holden Caulfield? E quanto del giovane Holden è rimasto in lei?
R. Veramente nulla anche se, a trentacinque anni da una tesi e una monografia sull’autore, continuo a pensare che J.D. Salinger sia stato tra i dieci migliori scrittori del gigantesco Novecento letterario americano. Semmai del “catcher in the rye” vale la pena ricordare che, anche alla crisi più nera, allo spaesamento più brutale, all’isolamento più avvilente, soprattutto quando – come nel caso del personaggio di Salinger – esso sia assai autoimposto oltre che dovuto a circostanze esterne, segue sempre un ritorno alla luce, un

ritorno a casa e, per me, come per Holden Caulfield, quella casa, da tanti, tantissimi anni è New York City, davvero e per sempre la città più bella del mondo!
D. Quale America stiamo lasciando ai nostri figli?
R. La stessa di cui canta Leonard Cohen, “America, the cradle of the best and of the worst”, la stessa di sempre. Un paese dalle formidabili contraddizioni, iniquità forse insanabili, la considerevole tendenza alla violenza, i cicli politici fantasmagorici… ma, anche e soprattutto, un paese dove i giovani non perdono – per consunzione, inerzia e vuoto pneumatico di opportunità – quell’unico ingrediente davvero unico ed insostituibile che agisce, diciamo, tra i quindici e i trentacinque anni, quella cosa che da sola è garanzia di libertà, di immaginazione e di prospettiva futura: l’entusiasmo del pensare e del fare bene, e quindi del vivere bene, domineddio e uomini permettendo!
D. Ultima, “marzulliana”: se lei fosse una canzone, un libro, un film, o una poesia… cosa sarebbe oggi Ennio Ranaboldo?
R. “Call me Ishmael”, se non proprio quel personaggio, certamente il libro, una specie di seconda casa per me, il romanzo più sontuosamente ricco, inesauribile e inestinguibile mai scritto in America, Moby Dick!

Torinese, vive a New York da un quarto di secolo e, recentemente, anche a Las Terrenas,in Repubblica Dominicana.Ha diretto la Consociata americana di Lavazza per sedici anni, poi quella di MartinBauer per altri sette ed è attualmente membro del Board di Martin Bauer Nord America, azienda leader nelle materie prime e negli ingredienti botanici. Professionalmente, ha cominciato come lavapiatti e cameriere, poi ha fatto il maestro elementare. Ha vissuto e lavorato in Nuova Zelanda (A vent'anni facevo il cuoco) e ha conseguito una tardiva laurea in lingua e letteratura americana, con una tesi ed una monografia dedicate a J.D. Salinger. Ha avuto, nel 2022, l’idea di lanciare “Talenti in Corso” (Giovani) – un programma di mentoring individuale per giovani italiani d’ingegno e scarse risorse – dopo anni di ascolto e centinaia di ore di conversazione, con ragazze e ragazzi intelligentissimi e di formidabile preparazione penalizzati da un paese troppo spesso ingeneroso con i propri giovani. Sposato con tre figli, la parola che ama di più è wordsmith.

Una scelta coraggiosa, un sogno che si realizza o semplicemente una tappa naturale della carriera: trasferirsi negli Stati Uniti è un passo importante. Ma attenzione, non basta cambiare fuso orario. Per avere successo nel mondo del lavoro americano servono flessibilità e una buona dose di capacità di adattamento. In questo articolo spieghiamo come integrarsi al meglio, dal primo giorno in u cio fino alla costruzione di una nuova quotidianità.
1. OSSERVARE, ASCOLTARE, IMPARARE
Di solito, il primo errore che un expat commette è pensare in termini di “tu hai torto, io ho ragione”. Arrivare con un’idea preimpostata di come dovrebbero funzionare le cose è il modo più rapido per alimentare malintesi. Bisogna quindi osservare, ascoltare e imparare per comprendere i meccanismi del sistema lavorativo statunitense. E soprattutto, essere disposti ad abbandonare il proprio punto di vista.
2. L’ARTE DEL FEEDBACK: ATTENZIONE ALLE PAROLE
Negli USA, la scala dei complimenti è spostata verso l’alto.
• Alcune parole hanno un peso molto preciso: per un americano, un buon lavoro è “excellent”, non “ok” (che significa “mediocre”).
• Il feedback negativo va sempre accompagnato da almeno due commenti positivi: uno all’inizio e uno alla fine.
3. LE RESPONSABILITÀ DEL MANAGER ITALIANO
Se siete manager, evitate di esportare in blocco modelli e processi italiani: il contesto è diverso e non è a atto scontato che ciò che funziona a Milano funzioni anche a Miami. Il ruolo del manager in missione negli Stati Uniti è fondamentale per:
• Costruire un ponte tra due culture;
• Facilitare l’integrazione tra le filiali americane e la sede italiana;
• Rendere consapevole la sede centrale delle specificità locali.
4. GLI AMERICANI SONO DAVVERO PIÙ MOTIVATI SUL LAVORO?
Non proprio. Semmai, è vero che la cultura americana è orientata al brevemedio termine ed è più individualista rispetto a quella italiana. Mentre in Italia un dipendente può attendere una gratifica o una promozione anche per anni, negli Stati Uniti gli incentivi sono legati alla sensibilità temporale tipica di quella cultura. Di conseguenza, nella gestione delle ricompense si privilegiano premi immediati e individuali.
5. VITA DA EXPAT: GESTIRE IL CAMBIAMENTO FUORI
DALL’UFFICIO
Lavorare bene è importante, ma vivere bene lo è altrettanto. Un trasferimento negli USA comporta mille piccoli aggiustamenti: trovare casa, aprire un conto, fare la patente, decifrare i codici culturali non scritti.
Le community italiane possono aiutare nei primi tempi, ma attenzione a non rinchiudervi nella “bolla”. Per integrarsi davvero, bisogna uscire dalla comfort zone. Iniziate con un club sportivo, una lezione serale, una festa di quartiere. Più vi esponete, più imparerete a leggere il contesto. E più il contesto inizierà a riconoscere voi.


VENDERE UNA COLLEZIONE
DI MODA NEGLI USA

In America, quella della moda è una macchina gigantesca, che macina stagioni, trend e brand con una velocità impressionante. Conoscerne le regole è il primo passo per entrarci. Se state pensando di portare il vostro brand oltreoceano questo articolo è la mappa per non perdervi.
SI PUÒ VENDERE TUTTO A TUTTI. BISOGNA SCEGLIERE COSA VENDERE E A CHI VENDERLO.
Non potete lanciare una collezione negli Stati Uniti senza aver prima fatto ricerca. O meglio, potreste provarci, ma per nostra esperienza i risultati migliori si ottengono con metodo e pazienza.
Iniziate col rispondere a queste domande:
• CHI È IL VOSTRO CLIENTE?
• QUAL È IL SUO STILE DI VITA, DOVE COMPRA, COSA CERCA?
• QUALI SONO I TREND DI MERCATO E CHI SONO I VOSTRI COMPETITOR?
• CHE POSIZIONAMENTO HA IL VOSTRO PRODOTTO?
• COME PENSATE DI VENDERE LA COLLEZIONE E ATTRAVERSO QUALI CANALI?
• AVETE GIÀ RACCOLTO MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DA SHOWROOM E RAPPRESENTANTI?
In questa prima fase, una ricerca di mercato potrebbe rendere l’ingresso negli USA molto più semplice.
Il brand è la vostra armatura. Un marchio forte, riconoscibile a colpo d’occhio e adatto al mercato target, infatti, può attirare clienti e di erenziarvi dai concorrenti.
Brand identity
Chiedetevi: cosa rappresenta il mio brand? Quali valori comunica e quale immaginario propone? Assicuratevi che le risposte siano coerenti in tutte le vostre comunicazioni con l’aiuto di un esperto di branding.
Strategia di marketing
Investite parte del budget nel marketing. Scatti professionali dei capi della vostra collezione e una presenza visivamente accattivante sui social media sono essenziali.
NEL PROPORRE LA VOSTRA COLLEZIONE E AFFIDATEVI SOLO A PROFESSIONISTI.
Il mercato americano o re molte strade per vendere ma non tutte sono adatte a ogni brand. Ecco alcune soluzioni B2B o B2C con i loro punti di forza:
1. Road reps: gli agenti tradizionali, ottimi per iniziare a intessere relazioni sul territorio
2. Showroom: prestigiosi ma selettivi, sono partner fondamentali per ottenere ordini in fiera
3. Sales managers: ideali per chi cerca un controllo diretto e una strategia a lungo termine
4. Buying o ce: aprono le porte della GDO ma servono numeri solidi e una logistica rodata
5. Agenzie PR: adatti per le situazioni in cui il brand va raccontato (soprattutto se di lusso)
6. E-commerce: il vostro canale diretto. Ma ricordate che negli USA il cliente si aspetta spedizioni veloci, resi facili e un’assistenza immediata.
LE STAGIONI DELLA MODA:
OCCHIO AI TEMPI
Gli USA hanno un calendario leggermente accelerato rispetto all’Europa, con più momenti di consegna frammentati durante l’anno. È opportuno presentarsi sul mercato con almeno tre stagioni:
• Fall/Winter: presentazione tra dicembre e gennaio
• Holiday Resort: presentazione a maggio e giugno
• Spring/Summer: presentazione a giugno e luglio
Create cataloghi chiari, listini DDP senza ambiguità, etichette a norma e iniziate con ordini piccoli e frequenti per guadagnare la fiducia delle vostre controparti commerciali.




C’è stato un tempo in cui bastava un’etichetta cucita a mano con scritto Made in Italy per aprire tutte le porte, anche quelle blindate del lusso newyorkese. Le boutique di SoHo si inchinavano al cashmere toscano, gli showroom di Los Angeles si accendevano davanti alla pelle morbida di una giacca napoletana. Quel tempo però è finito, e non tornerà, o almeno non nella forma in cui l’Italia lo ricorda, come una vecchia diva che crede ancora di essere la protagonista del film. Oggi l’America non cerca più bellezza, cerca soluzioni. Il consumatore statunitense, impulsivo, pragmatico, infedele come un algoritmo, compra storie prima ancora che capi. Vuole sapere chi sei, cosa rappresenti, e soprattutto perché dovrebbe scegliere proprio te in mezzo a un oceano di brand che sanno gridare molto più forte e meglio. E la moda italiana, ferma nel suo culto del silenzio estetico e della sacra piega a mano, spesso non ha le parole giuste, o peggio, non sa proprio di dover parlare. Il problema non è la qualità, quella c’è e resterà, il problema è la narrazione. Il futuro della moda italiana negli Stati Uniti dipenderà da una sola cosa, la capacità di trasformare l’ossessione per il dettaglio in un messaggio rilevante. Non basta più saper tagliare un abito perfetto, bisogna posizionarlo nel caos dell’identità americana, dove il vintage convive con il metaverso e l’underwear ha un manifesto politico. In un paese dove tutto comunica, anche una cucitura invisibile, lo charme europeo da solo non seduce più nessuno, al massimo fa simpatia. Il rischio è diventare un souvenir, un vezzo nostalgico per vecchie glorie e nuove influencer in cerca di hashtag con la parola dolce. L’opportunità è rinascere come cultura ibrida, dove il design italiano incontra la brutalità del mercato americano, ne prende un pugno in faccia e poi impara a incassare, a vendere, a risorgere. Ma per farlo serve una cosa che in Italia fa ancora paura, dimenticare sé stessi per reinventarsi, e magari, nel farlo, scoprire qualcosa di finalmente vero.

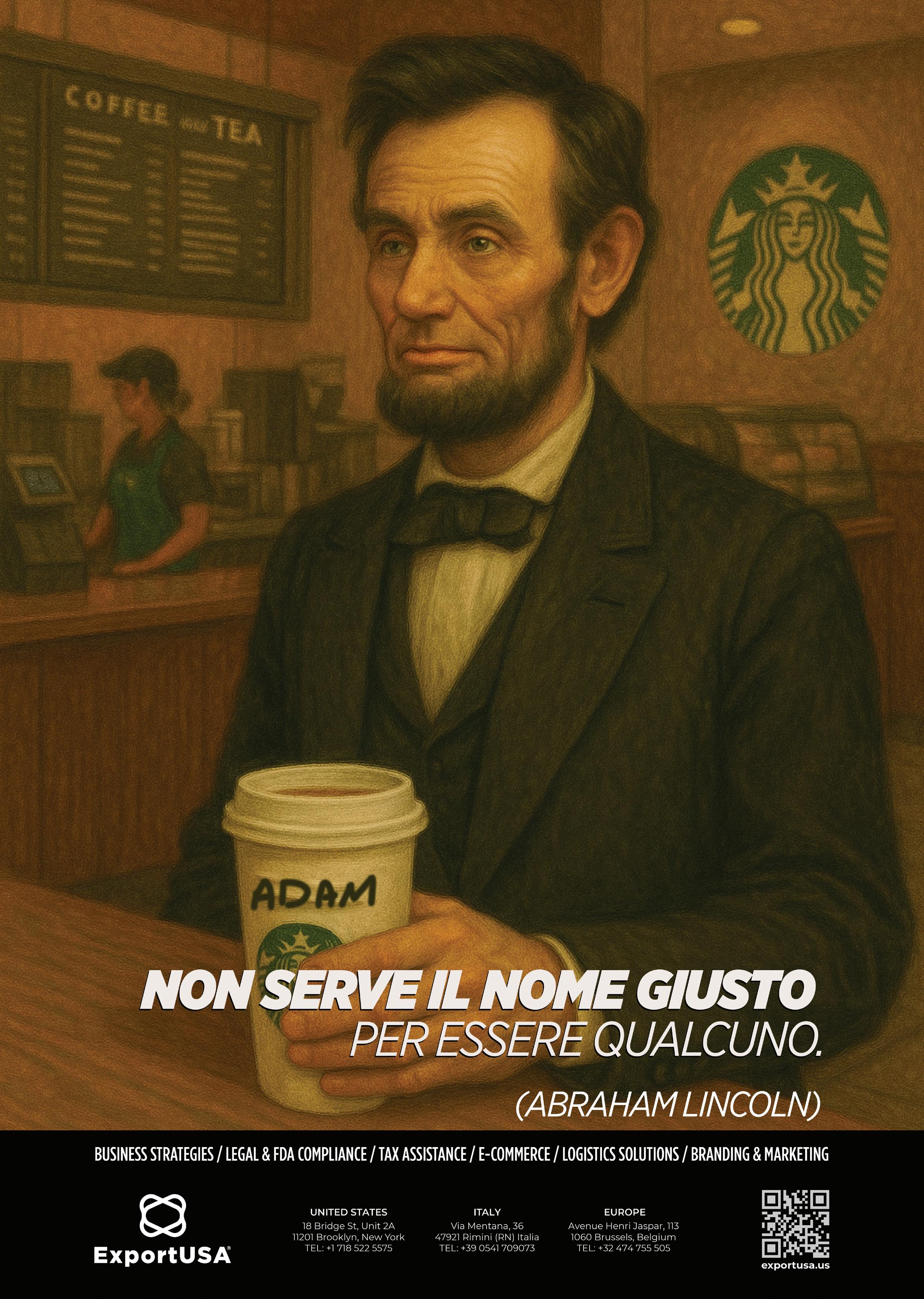

La forza di un brand si misura anche dalla protezione legale che lo accompagna. Nel mercato americano, regolato da norme diverse rispetto all’Europa, tutelare il proprio nome, logo o identità visiva è parte integrante di qualsiasi strategia di internazionalizzazione. Registrare un marchio per gli Stati Uniti significa proteggere ciò che rende un’azienda riconoscibile e competitiva. Di seguito spieghiamo come funziona la procedura e quali vantaggi comporta.
COME FUNZIONA:
La registrazione dei marchi negli Stati Uniti è gestita dallo United States Patent and Trademark O ce (USPTO) e si basa sul principio del *first-to-use*: chi utilizza per primo un marchio ne detiene i diritti, anche senza registrazione formale. Registrare il marchio, però, semplifica e rafforza la protezione legale, rendendo pubblica e u ciale la titolarità sul mercato americano.
LE FASI DELLA
REGISTRAZIONE:
1. Scegli il marchio da proteggere 2. Associa il logo (se presente) al trademark
3. Invia la domanda alla USPTO
4. Rispondi alle comunicazioni u ciali (Notice of Action)
5. Invia la prova d’uso commerciale (Statement of Use) entro 6 mesi
6. Attendi l’approvazione (circa 6 mesi)
7. Dopo la pubblicazione, attendi 30 giorni per eventuali opposizioni
8. In assenza di opposizioni, la registrazione diventa definitiva
9. Rinnova dopo 5 anni
10. Rinnova nuovamente dopo 10 anni: da qui in poi, validità permanente con rinnovi periodici
• La registrazione avviene per classi d’uso: è fondamentale identificare la categoria merceologica corretta
• Puoi registrare anche prima dell’effettivo utilizzo commerciale (Intent-to-Use Application)
REGISTRAZIONE:
Registrare un marchio non serve solo a evitare dispute: è una leva strategica per consolidare la presenza nel mercato americano e valorizzare l’identità del brand. Permette di:
• Dimostrare u cialmente la titolarità del marchio negli USA
• Accedere più facilmente a marketplace come Amazon, Walmart, Etsy
• Bloccare imitazioni o usi impropri
• Aumentare la credibilità verso investitori e distributori
• Aprire a opportunità di licensing e franchising
• Facilitare le operazioni doganali e combattere la contra azione
PENSARE DA IMPRENDITORI
Fare legal branding significa ragionare in ottica imprenditoriale. Significa capire che il brand è un asset aziendale a tutti gli effetti, da proteggere fin dall’inizio.
CHI VUOLE VENDERE NEGLI STATI UNITI DEVE ANCHE DOTARSI DEGLI STRUMENTI GIUSTI PER FARLO IN SICUREZZA E LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO È UNO DI QUESTI.


’è stato un tempo in cui, per aprire un negozio, bastava trovare un locale, riempirlo di merce, appendere un’insegna e alzare la serranda. Quel tempo è finito. Il punto vendita ha smesso di essere un contenitore, ha cambiato abito e ha assunto una nuova funzione: diventare una delle espressioni più potenti e riconoscibili del brand.
La rivoluzione digitale ha ridefinito in profondità il ruolo degli spazi fisici nel commercio, influenzando non solo le abitudini di acquisto, ma anche le modalità con cui le persone si relazionano a un marchio.
Per approfondire il tema abbiamo parlato con D!V, agenzia creativa specializzata in customer experience design, interior design e architettura che collabora con Concepto, il dipartimento di branding di ExportUSA. Con loro abbiamo esplorato cosa significa progettare spazi significativi per l’americano di oggi.
D. Quali sono le sfide e le opportunità che stanno ridisegnando il retail fisico negli Stati Uniti?
R. Il confine tra mondo fisico e digitale è sempre più sottile, e lo store, da punto vendita isolato, si è trasformato in un nodo attivo di un ecosistema molto più ampio. Oggi si progetta tenendo conto del percorso del cliente che si muove liberamente tra canali online e o ine, aspettandosi continuità visiva, coerenza narrativa e riconoscibilità. Ciò comporta un’interessante opportunità per le aziende che si a acciano al mercato americano con l’idea di avere una presenza fisica negli USA: superare la logica dello spazio bello e funzionale per realizzare spazi che raccontano, accolgono e accompagnano. Luoghi in cui il brand prende corpo e inizia un dialogo diretto con il pubblico.
D. E cosa rende davvero immersivo uno spazio?
R. La progettazione parte sempre dalla persona. Ogni ambiente dovrebbe rispondere alle sue esigenze esprimendo al tempo stesso la propria intenzione comunicativa. Non esiste una formula universale: un flagship store sulla Fifth Avenue seguirà una logica completamente diversa rispetto a un pop-up a Brooklyn o a un temporary shop in California. L’obiettivo, però, resta identico: progettare spazi che raccontino






una storia coerente con il brand, coinvolgano i sensi e rendano il visitatore il grande protagonista di questa storia.
Nel nostro approccio, lo spazio viene pensato come una mappa tridimensionale dei valori, del tono e della visione dell’azienda. Il cliente, entrando, deve poter leggere quella mappa senza che nessuno gliela spieghi. La qualità della luce, la disposizione degli arredi, la scelta dei materiali e dei suoni devono trasmettere immediatamente chi è il brand, quale mondo vuole evocare. Si progetta quindi per stimolare i sensi, ma anche per orientare i comportamenti e facilitare la relazione.
Noi utilizziamo il termine “brandscape” , lo “spazio fisico del brand”, che indica proprio un ambiente che incarna l’identità di marca a 360 gradi. Un concept di questo tipo si applica anche al di fuori del retail: ai ristoranti che diventano luoghi di intrattenimento, agli u ci trasformati in hub relazionali e creativi, e in generale a qualunque luogo in cui l’esperienza fisica viene progettata come parte integrante del sistema di comunicazione del brand.
D. Qual è allora il ruolo dello spazio fisico rispetto alla comunicazione digitale?
R. È insostituibile, non importa quanto il canale digitale sia rilevante nel percorso del cliente. Lo spazio fisico ha una forza che nessuna storia su Instagram o newsletter può replicare, genera presenza, permette il contatto diretto, crea relazioni autentiche. Entrare in un negozio significa toccare con mano ciò che il brand vuole trasmettere, ma anche vivere una situazione unica, non replicabile altrove. È in quel momento che nasce una connessione.
I brand che se la stanno giocando meglio sono quelli che hanno trasformato i loro negozi in esperienze da vivere: spazi in cui i consumatori entrano per comprare ma anche per scoprire, interagire e partecipare . Pensiamo ai pop-up store: sono un laboratorio perfetto per far testare i prodotti e conoscere la propria community!
Guardando al futuro, vediamo un’evoluzione verso spazi brandizzati sempre più ibridi, adattivi e dinamici. Gli ambienti devono essere pronti a trasformarsi da punti vendita a showroom, da media hub a luoghi per eventi, nonché rispondere a diverse esigenze in base ai momenti in cui le persone attiveranno il luogo, proprio come succede nel digitale: un’unica porta d’ingresso e diverse modalità di interazione.

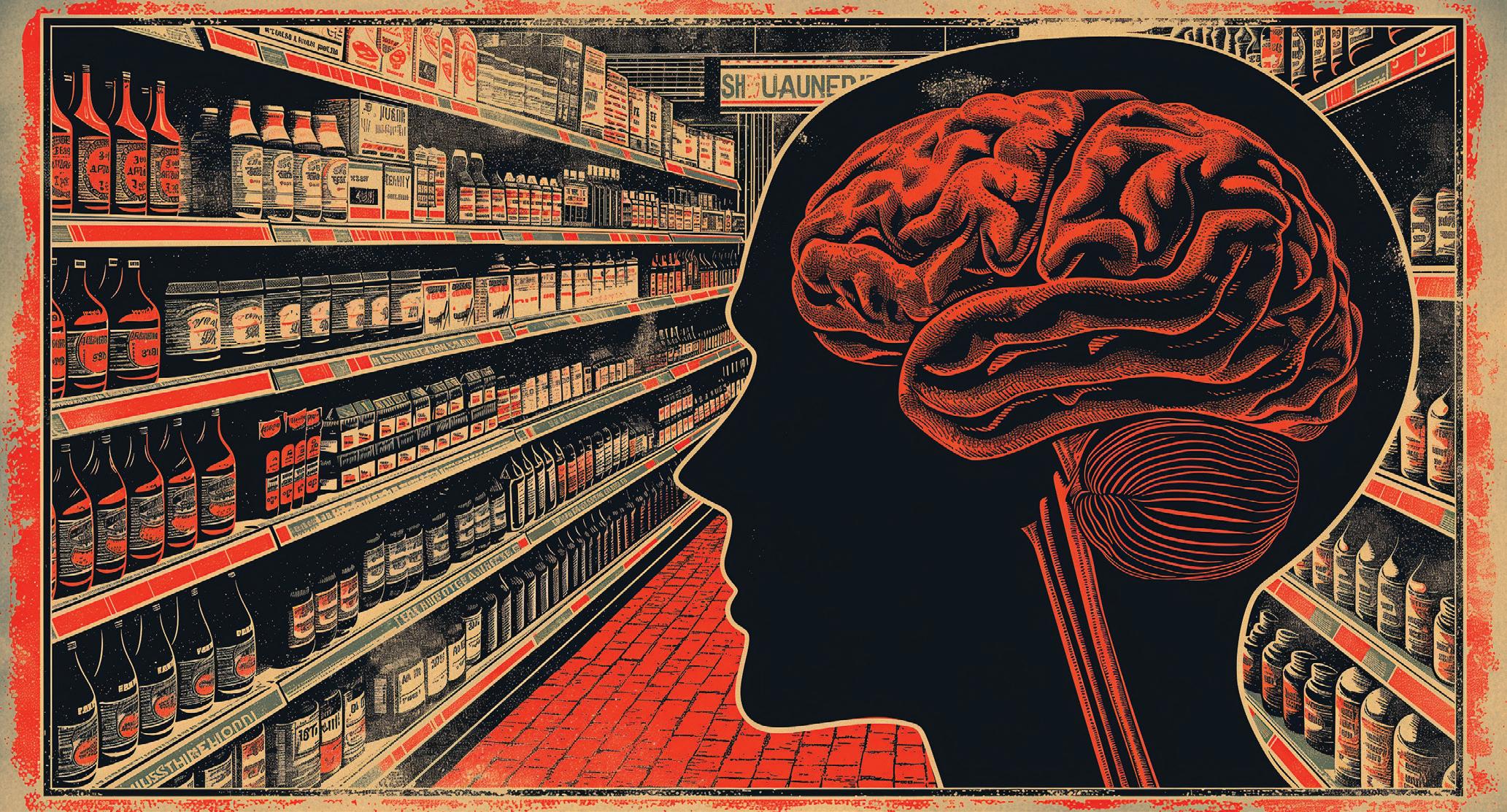
A
cura di Marco Baldocchi CEO & Consumer Neuroscience specialist, Neuralysis
Come il layout dei negozi influenza (davvero) la mente dei clienti
Hai mai pensato che il modo in cui organizzi gli spazi nel tuo negozio racconta al cervello dei clienti una storia invisibile, capace di determinare il successo o il fallimento del tuo business?
Benvenuto nella neuroarchitettura, la disciplina che combina neuroscienze, psicologia ambientale e design per influenzare comportamenti, emozioni e decisioni d’acquisto.
Perché il cervello preferisce ambienti progettati con neuroscienze
Non è (solo) questione di estetica. Il modo in cui progettiamo uno spazio influisce direttamente sul modo in cui il cervello lo elabora. E quando il contesto è il retail, ogni stimolo visivo, ogni angolo cieco, ogni scelta di layout può trasformarsi in un
messaggio emotivo implicito.
Passiamo circa l’87% della nostra vita in ambienti chiusi, e il cervello ha sviluppato meccanismi sofisticati per reagire all’architettura in modo automatico e, spesso, inconsapevole.
Uno studio del Journal of Environmental Psychology (2023) ha immerso partecipanti in diversi layout di negozi simulati in realtà virtuale, monitorando le risposte neurologiche con EEG ed eye-tracking. Il risultato?
Non è tanto la complessità in sé a generare stress cognitivo, quanto la sua natura disorganica: percorsi senza logica, esposizioni ridondanti, segnaletica ambigua o assente. Tutti questi elementi costringono il cervello ad attivare continuamente la corteccia prefrontale dorsolaterale, deputata al problem-solving e alla gestione dei conflitti.
Con il risultato di affaticare il sistema cognitivo, diminuire la soglia attentiva e abbassare la soddisfazione emotiva. All’opposto, ambienti coerenti, leggibili, e gerarchicamente ordinati riducono la necessità di
elaborazione attiva, favorendo un’esperienza fluida e piacevole. Uno studio di Frontiers in Human Neuroscience (2022), sempre in ambienti immersivi VR, ha mostrato che configurazioni architettoniche con luce naturale, geometrie fluide e altezze equilibrate attivano aree come il precuneus e il cingolato anteriore, associate a benessere, senso di orientamento e valutazione estetica positiva. Il risultato è un’esperienza più coinvolgente, tempi di permanenza più lunghi e, spesso, maggiore disponibilità all’acquisto. In sintesi: il cervello non entra mai in un negozio da solo. Porta con sé una mappa implicita di ciò che è leggibile, sicuro, accogliente. E se lo spazio ne tiene conto, la mente ricambia con attenzione, piacere e memoria.
Percezione degli spazi: perché cambia con il contesto socio-culturale
Aprire un punto vendita negli Stati Uniti richiede attenzione particolare alla percezione dello spazio, profondamente influenzata dai condizionamenti
socio-culturali. Uno studio interculturale pubblicato da Harvard Business Review (2021) ha evidenziato come consumatori americani preferiscano layout più aperti e minimalisti rispetto ai consumatori europei, che invece prediligono ambienti più densi e ricchi di dettagli visivi. Questi risultati derivano da ricerche basate su analisi comportamentali e neuroscientifiche, che mostrano come le diverse culture elaborino e interpretino gli stimoli ambientali in modi significativamente di erenti.
Ad esempio, i consumatori americani tendono a sentirsi più rilassati e soddisfatti in ambienti ampi, ariosi e minimali, dove la circolazione è facilitata e ogni elemento ha una funzione chiara. Questo tipo di layout comunica e cienza, trasparenza e libertà di scelta — valori centrali nella cultura americana del consumo. La disposizione aperta riduce la densità percettiva e attiva meccanismi di controllo spaziale che rassicurano il cervello, facilitando l’esplorazione autonoma e non vincolata.
Al contrario, in molti Paesi
europei, soprattutto nell’area mediterranea, ambienti ricchi di stimoli visivi, texture, materiali caldi e una densità maggiore di oggetti sono associati a sensazioni di accoglienza, autenticità e ricchezza sensoriale. L’effetto è una percezione più familiare e intima, che può aumentare la fiducia nel brand o nel prodotto esposto. In questi contesti, la complessità è letta come cura, la varietà come generosità, e l’estetica piena come indice di valore.
Queste di erenze non sono solo estetiche, ma neuroculturali. La letteratura neuroscientifica e psicologica ha dimostrato che la percezione dello spazio è mediata dall’esperienza visiva quotidiana e dal sistema educativo con cui si cresce: ciò che viene interpretato come "spazio vuoto e ordinato" in un contesto può risultare "freddo e impersonale" in un altro. Ignorare queste di erenze significa progettare un layout che potrebbe risultare dissonante rispetto alle aspettative implicite del consumatore target, generando confusione, frustrazione e perdita di ingaggio. In un mondo sempre più globalizzato, il design universale non esiste: esiste solo il design culturalmente consapevole.
Le neuroscienze spiegano queste differenze attraverso la diversa attivazione cerebrale rilevata tramite EEG e fMRI. Nei consumatori americani, ambienti minimalisti attivano maggiormente aree cerebrali associate al rilassamento e alla chiarezza cognitiva, come il precuneus. Invece, gli europei mostrano una maggiore attivazione della corteccia prefrontale mediale, collegata alla gratificazione derivante da ambienti più complessi e dettagliati. Pertanto, adattare gli spazi retail alle preferenze culturali del mercato target non è solo una scelta estetica, ma una decisione strategica supportata da solide evidenze neuroscientifiche.
Cosa ci dice la neuroscienza sul posizionamento dei prodotti?
Ricercatori della Cornell University (2021) hanno utilizzato tecniche avanzate di eye-tracking e EEG per osservare le risposte cerebrali
dei consumatori di fronte a diverse configurazioni di prodotti. La ricerca ha mostrato che una disposizione gerarchica chiara e ordinata attiva meno la corteccia prefrontale dorsolaterale (associata allo sforzo cognitivo) e più il nucleo accumbens (legato al piacere e alla ricompensa), aumentando la probabilità di acquisto del 32%.
Come il cervello visita un negozio e come persuaderlo
Durante la visita in-store, il cervello attiva diverse aree:
• Corteccia occipitale: prima a reagire agli stimoli visivi, fondamentale per catturare l’attenzione iniziale.
• Corteccia prefrontale: implicata nelle decisioni logiche e nella pianificazione.
• Sistema limbico: gestisce le emozioni e le reazioni immediate, influenzando decisioni impulsive e d’acquisto.
Per persuadere il cliente, è essenziale creare un equilibrio tra stimoli visivi attraenti (per attivare rapidamente l’attenzione visiva e il sistema limbico) e percorsi intuitivi (riducendo l’attività della corteccia prefrontale legata allo stress decisionale).
Emotivae: La tecnologia che "vede" le emozioni
Il problema? Fino a pochi anni fa, capire davvero cosa provavano i clienti all’interno di uno store era impossibile.
Le emozioni passavano inosservate, oppure si tentava di dedurle da comportamenti indiretti: sguardi, camminate, tempo di permanenza. Ma erano supposizioni.
Oggi, grazie all’integrazione tra neuroscienze e intelligenza artificiale, possiamo fare di meglio. Con il mio team abbiamo sviluppato Emotivae, un sistema evoluto in grado di leggere le emozioni in tempo reale attraverso il riconoscimento delle microespressioni facciali, combinato con dati di attenzione visiva e stress cognitivo. È come avere una lente neuroscientifica

continua puntata sull’esperienza del cliente, ma senza invadenza. Tutto avviene in forma anonima e GDPR compliant. Il software riconosce fino a 98 emozioni distinte, tra cui sorpresa, noia, frustrazione, interesse, curiosità, rilassamento, e molte altre, mappando anche il livello di attivazione cognitiva (arousal), l’attenzione visiva e gli indicatori di sovraccarico mentale. Attraverso l’analisi aggregata dei dati, Emotivae genera heatmap emotive segmentate per genere ed età e fasce orario, restituendo una visione precisa e dinamica di cosa funziona (e cosa no) nello spazio fisico. Le aree di maggiore interesse emotivo, quelle che provocano confusione o addirittura fastidio, vengono evidenziate visivamente, offrendo insight immediati per ottimizzare percorsi, layout, esposizioni e comunicazione. Non è un gadget, né un esperimento: è uno strumento
concreto per chi vuole decidere sulla base della realtà emotiva dei clienti, e non solo su ipotesi o report post-vendita. Perché oggi la tecnologia ci permette di prendere decisioni basate su dati concreti e scientificamente validati, o rendo un vantaggio competitivo notevole nel creare esperienze retail davvero coinvolgenti e personalizzate per il proprio pubblico.
Cosa è davvero la neuroarchitettura?
La neuroarchitettura non è solo una tendenza, è un imperativo strategico per chi vuole emergere nel retail moderno, specialmente quando si espande in nuovi mercati come gli Stati Uniti. Combinando neuroscienza, design e tecnologie innovative puoi trasformare il tuo spazio di vendita in un’esperienza emotivamente coinvolgente, memorabile e redditizia.
CON IL MIO TEAM ABBIAMO SVILUPPATO EMOTIVAE , UN SISTEMA
EVOLUTO IN GRADO DI LEGGERE LE EMOZIONI IN TEMPO REALE ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DELLE MICROESPRESSIONI FACCIALI, COMBINATO CON DATI DI ATTENZIONE VISIVA E STRESS COGNITIVO.
— Marco Baldocchi CEO & Consumer Neuroscience specialist, Neuralysis




Quella che segue non è una semplice intervista, ma una conversazione che tocca i nervi scoperti di un’America che cerca di riscoprire la sua anima contemporanea. Emiliano
Ponzi ci accompagna tra le luci e i suoni di una New York magnetica e spietata, e riflette sul ruolo dell’arte in un contesto dove quasi tutto è narrazione e competizione.
Ed è qui che si innesta Salotto NYC, lo spazio culturale fondato con altri professionisti, che negli anni è diventato un laboratorio di idee, un punto di incontro tra l’identità italiana e la scena internazionale, un luogo dove il talento non si misura con il passaporto ma con la qualità del pensiero e delle opere. Dentro queste pagine si parla di opportunità e sacrifici, di artisti e comunità, di quanto l’Italia possa ancora dialogare con l’America attraverso nuove forme di presenza culturale. Oltre all’urgenza di immaginare modelli di sviluppo più umani, e di creare, come nell'illustrazione e come nei salotti intellettuali di una volta, uno spazio in cui le persone possano ritrovarsi per imparare, condividere e costruire insieme.
D. Emiliano, facciamo finta che questa intervista sia un viaggio attraverso l'America, un po' come quella tua meravigliosa
testimonianza in American West del 2018. La trovi cambiata l'America di oggi?
R. La percezione che ho degli Stati Uniti è cambiata: visitare il paese da turista, o trascorrervi qualche mese, è un’esperienza completamente diversa rispetto al trasferirsi in maniera permanente. Camminare sulla Fifth Avenue a New York, mangiare gamberi tra i leoni marini al Pier 39 di San Francisco o osservare gli skaters di Venice Beach a Los Angeles con un biglietto di ritorno in tasca significa vivere la superficie luccicante di un paese che, in realtà, cela contraddizioni e conflitti ben più profondi.
Gli Stati Uniti sono la più grande agenzia pubblicitaria del mondo: negli ultimi ottant’anni hanno compiuto un lavoro di branding straordinario, vendendo al resto del pianeta una serie di valori e caratteristiche — “la più grande democrazia del mondo”, “la nazione dell’uguaglianza di credo, razza e orientamento”, per citarne un paio — che meriterebbero una riflessione molto più critica.
Oggi, in questa fase storica, alcuni di quei paraventi sono caduti, e si vede con maggiore chiarezza ciò che in realtà è sempre stato presente: la convinzione profonda degli Stati Uniti di essere il miglior modello di società
possibile, di essere sempre dalla parte giusta della storia di essere i “buoni”. La loro egemonia culturale nei confronti del resto del mondo è un fatto e si riflette anche nel senso di provincialismo che molti altri paesi, in Europa e non solo, provano verso l’America.
È evidente nelle narrazioni di chi viaggia negli USA: nella meraviglia per la sproporzionata grandezza percepita uscendo dal JFK, nel mangiare un hamburger nel locale “cool” letto su una guida, nel visitare Rodeo Drive perché era il luogo dello shopping dei teenager ricchi di Beverly Hills 90210. Il resto del mondo occidentale, in fondo, è cresciuto a pane e modelli culturali made in USA.
Questo non significa che qui non possano accadere cose belle, stimolanti per il business o arricchenti per la vita personale. Anzi, continuano ad accadere. Ma immaginare gli Stati Uniti in modo naive, come se fossero una cartolina bidimensionale, è illusorio: significa alimentare una narrazione che racconta solo una parte della storia, lasciando nell’ombra tutto il resto.
D. New York è ancora il centro di gravità permanente della creatività?
R. Sicuramente la quantità di stimoli a cui ci si espone aiuta ad arricchire la ricerca

creativa. Non c’è dubbio che confrontarsi con tante altre persone brave sia un vettore di crescita non solo personale ma anche professionale, inoltre è funzionale a gestire il proprio narcisismo: si può essere il più bravo del paese di 10000 abitanti ma in un campionato come questo ci sono centinaia di persone che fanno la stessa cosa in maniera altrettanto eccellente e sono altrettanto motivate.
A New York ci sono opportunità di lavoro nell’industria creativa come in pochi altri luoghi, soprattutto se si cerca un lavoro fisso in qualche company di design, in qualche agenzia pubblicitaria o simili. Se invece parliamo di arte da galleria e di libera professione è tutto un po' diverso. La città è estremamente costosa e gli artisti che attrae (non solo gli artisti) tendenzialmente hanno già una base economica.
Abbiamo in mente un immaginario di artista che crea in un grande loft con latte di colori e pennelli sparsi in giro, poi prende le tele le porta ad una galleria e diventa famoso finendo sulla sezione Art del New York Times. Omettiamo in questo bellissimo racconto che quel loft probabilmente costa 8000 dollari al mese e per dipingere senza certezza di vendita quello stesso artista deve passare almeno un anno senza introiti fissi dovendo (oltre al citato loft) mangiare, avere una casa in a tto, vestirsi, comprare i materiali etc.
Dunque sì, New York è un centro di creatività permanente e in continuo mutamento, è la meta e punto di arrivo ideale per chi ha a che fare con le arti visive, ma ha chiaramente un prezzo.
D. Da dove nasce l'esigenza di creare Salotto NYC e quanto conta ancora l’identità italiana nel lavoro che fate?
R. Salotto nasce dalla una volontà di arricchimento personale, dalla voglia che un gruppo di professionisti nell’ambito delle arti visive ha avuto: ospitare gente brava, sentir parlare chi ha ha fatto cose belle e di valore per farsi ispirare, per imparare. Condividere questo sapere è poi il secondo obiettivo di Salotto: creare una community che partecipi agli eventi per provare la meraviglia dell’altro da sé, di conoscere qualcuno e qualcosa che prima non si conosceva.
L’aspetto di italianità è importante per noi, diversi ospiti sono italiani come Alessandro Cattelan, Stefano Nazi, Luca Ravenna o Paola Antonelli ma molti altri non lo sono come ad esempio Jhumpa Lahiri, la redazione del New Yorker o Debbie Millman. Il talento è trasversale alla nazionalità e alle arti, ci poniamo con grande apertura di fianco a quello che per prossimità (e talvolta lontananza) ci sembra a ne al nostro modo di sentire e di lavorare, ad una sorta di esigenza alla creazione, di condivisione di valori professionali ma anche umani.
D. Attualmente da cosa sei attratto? Quale periodo artistico stai vivendo?
Sono costantemente attratto dall' imparare modi nuovi per comunicare meglio: una diversa gestione delle luci, delle pennellate (sia digitali che tradizionali) del rapporto tra soggetti ed ambienti. Mi sto concentrando sull’intenzionalità degli elementi che compongono un’immagine cercando anche di affinare una naturalezza nel gesto e nel segno.
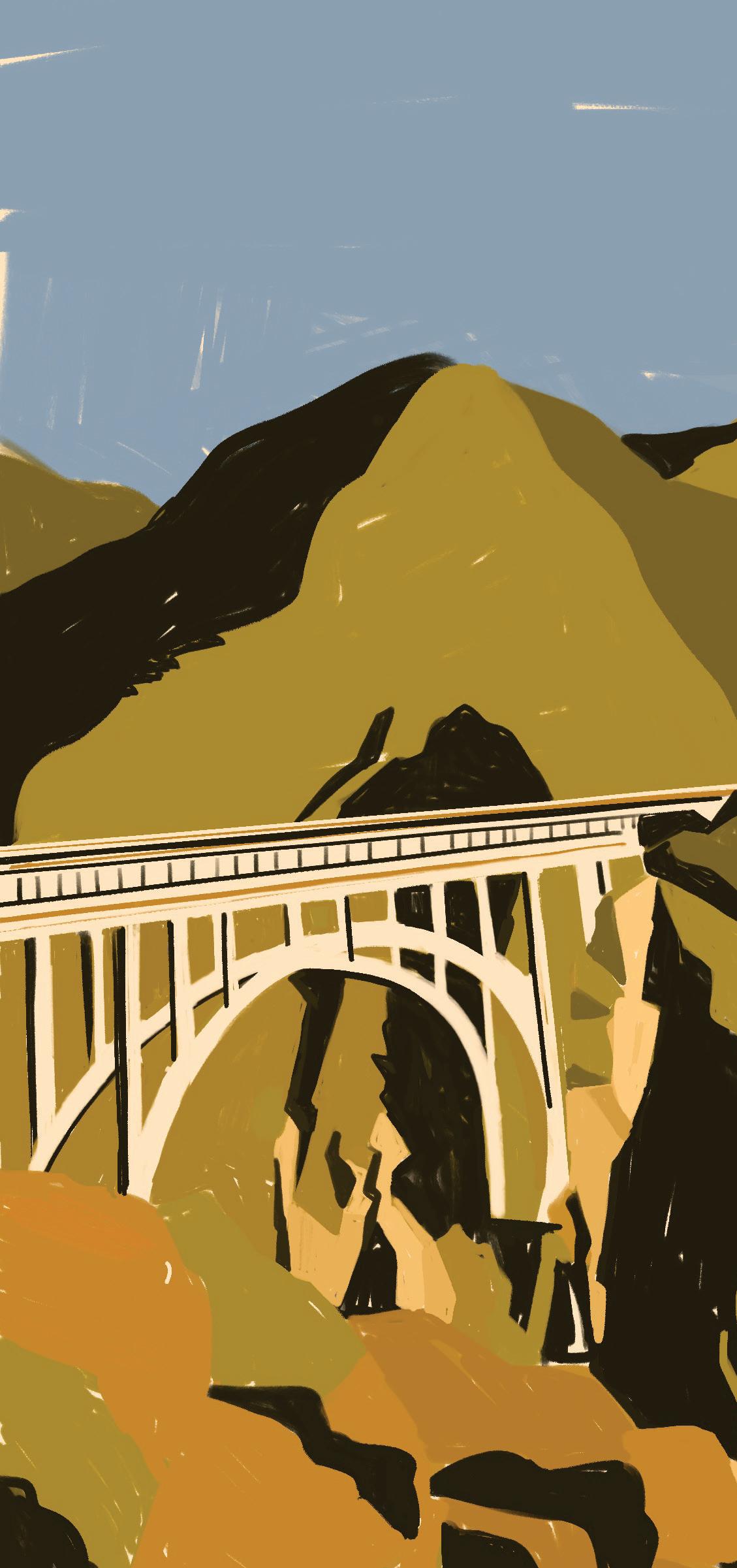


“
SONO COSTANTEMENTE ATTRATTO DALL' IMPARARE MODI NUOVI PER COMUNICARE MEGLIO: UNA DIVERSA GESTIONE DELLE LUCI, DELLE PENNELLATE (SIA DIGITALI CHE TRADIZIONALI) DEL RAPPORTO TRA SOGGETTI ED AMBIENTI.
“












D. Ricordo che quando iniziai il mio percorso artistico scrissi a molti illustratori famosi per qualche consiglio, e tu fosti l’unico a rispondermi. È un gesto che non ho mai dimenticato, e per cui te ne sarò sempre grato. Quale consiglio daresti a un giovane che sogna di fare arte negli Stati Uniti?
R. Sono contento di questo ricordo che mi hai condiviso soprattutto se è stato utile in qualche modo. Sono sempre reticente a dispensare consigli perché non credo esistano formule magiche per riuscire a fare cose buone. Siamo tutti diversi e abbiamo tutti traiettorie e percorsi diversi.
Per citare male a memoria una bellissima frase di Baricco: non importa quanti giri faccia un fiume, prima o poi si riverserà nel mare.
A chi decide di venire in USA direi di venire preparato e con una visione lucida, di essere motivato ed entusiasta e anche con quel filo d’ansia di chi va a giocare una partita
sapendo che farà del suo meglio ma senza saper come andrà a finire. Probabilmente è utile di fare qualche mese “visiting” per sentire che aria si respira.
D. Quale luogo degli Stati Uniti ti somiglia più di altri? Un angolo che senti tuo, come se potesse raccontare chi sei?
R. Tra i molti luoghi che ho visitato e che mi sono rimasti nel cuore, citerei Monterey e soprattutto un hotel di fronte al mare con una lobby molto accogliente dalla quale disegnavo nei giorni di cattivo tempo trascorsi lì. Il camino a sinistra, una grande vetrata con vista oceano di fronte.
D. Se Emiliano fosse una canzone, che brano sarebbe?
R. "Costruire" di Niccolò Fabi
D. E se Salotto NYC fosse un disegno, che immagine vedremmo?
R. Una scena conviviale di persone che si
incontrano e scambiano opinioni bevendo una birra e mangiando focaccia.
D. Che America sogni per il futuro?
Un’America che contempli altri modelli di sviluppo economico perché questo (per quanto ci abbiamo guadagnato, chi più e chi meno) ha raggiunto il limite sistemico e ci stiamo tutti impoverendo come esseri umani

CITEREI MONTEREY E
SOPRATTUTTO UN HOTEL DI FRONTE AL MARE CON UNA
LOBBY MOLTO ACCOGLIENTE
DALLA QUALE DISEGNAVO NEI
GIORNI DI CATTIVO TEMPO TRASCORSI LÌ.


Salotto è un centro di ricerca e produzione culturale gestito da professionisti creativi italiani con base a New York. La nuova casa a Brooklyn dell’eccellenza e dell’innovazione internazionale nelle arti e nel design.
Un luogo di incontro, una galleria, un laboratorio, una sede per eventi, uno spazio di lavoro, un hub culturale e molto altro.
Un nuovo modello di ambasciata culturale: uno spazio per connettere idee e costruire relazioni.
Salotto è: Accurat, Lorenzo Fanton, Emiliano Ponzi, Marco Rosella, Yohoho
Studio, Gabriel Zangari, Giulia Zoavo

Emiliano Ponzi è un illustratore, artista visivo e autore italiano che oggi vive e lavora a New York. Il suo tratto essenziale e inconfondibile lo ha portato a collaborare con i più grandi marchi dell’editoria, della moda e della pubblicità: Apple, Ti any, MoMA NY, The New York Times, The New Yorker, Lamborghini, Le Monde, Louis Vuitton, Hermès, Martini, Hyundai, Pirelli, Tim, Barilla, Moleskine, San Pellegrino, Android, Airbnb, Lavazza, Bulgari, Penguin Books, Esquire, Armani, Uniqlo, Belmond, Loro Piana, Ducati e Zenith. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui medaglie d’oro e d’argento dalla Society of Illustrators di New York, il Young Guns Award, il prestigioso Gold Cube dall’Art Directors Club di New York, l’IDA Award, il MGIP Award e, soprattutto, il Premio Pulitzer, ottenuto grazie al progetto In the Dark realizzato per il New Yorker. Altri premi sono arrivati da American Illustration, Print e How International Design, a testimonianza di un percorso che unisce coerenza stilistica e ricerca continua.
Parallelamente alla sua attività di illustratore, Ponzi è autore di quattro libri che raccontano mondi e contesti diversi con la forza delle immagini: The Journey of the Penguin (2015), per l’anniversario di Penguin Books; The Great New York Subway Map (2017), commissionato dal MoMA di New York; American West (2018), cronaca visiva di un viaggio nell’Ovest americano inizialmente pubblicata come diario sul profilo Instagram del New Yorker e successivamente come volume edito da Corraini; e Chronicle from the Red Zone (2020), diario quotidiano del primo lockdown italiano, apparso come colonna sul Washington Post e poi come libro in tiratura limitata per Tapirulan.
Ha tenuto conferenze e talk in alcune tra le istituzioni più rilevanti del panorama artistico e culturale internazionale: dal MoMA di New York agli Istituti Italiani di Cultura di Londra, Madrid, Berlino, Pretoria e New York, passando per la Triennale di Milano, SIPicturebook a Seoul, il WebMarketing Festival di Rimini, Visual Playground a Bucarest, CCBF2023 a Shanghai e la School of Visual Arts di New York. Il suo lavoro è stato esposto in mostre personali e collettive in tutto il mondo: dalla Collezione Permanente della Farnesina a Roma alla Triennale di Milano, dal MAMbo di Bologna al GAMEC di Bergamo, dalla 7 Gallery del New York Times al Consolato Italiano di New York e Londra, fino al Museo d’Arte Moderna di Bahia, alla NLB Galerija Avla di Lubiana, alla Galerie Trieze-Dix di Parigi e a Mixed Melt Global di Seoul.
Negli ultimi anni Ponzi ha firmato installazioni di grande impatto come Under the Surface, commissionata dal Salone del Mobile per la Milan Design Week 2024, Flower Up al Glo Hub per il Fuorisalone 2024 e Believe al K11 Museum di Shanghai, sempre nel 2024. I suoi ultimi solo show confermano una ricerca in continua evoluzione: The Dreamer, Stories from Another World alla Sun Ke Villa di Shanghai (2023), In Principio era la Fine alla Marco Rossi Artecontemporanea di Pietrasanta, Milano, Verona e Torino (2023), e Together alla Philippe Labaune Gallery di New York (2024).
Il suo più recente lavoro editoriale, il saggio Work in Progress, pubblicato da Corraini in italiano e in inglese e presentato a Rizzoli New York nel novembre 2024, è insieme un’autobiografia professionale e una riflessione sul mestiere dell’arte, testimonianza di un percorso che continua a costruirsi giorno dopo giorno, senza mai smettere di interrogarsi sul futuro.






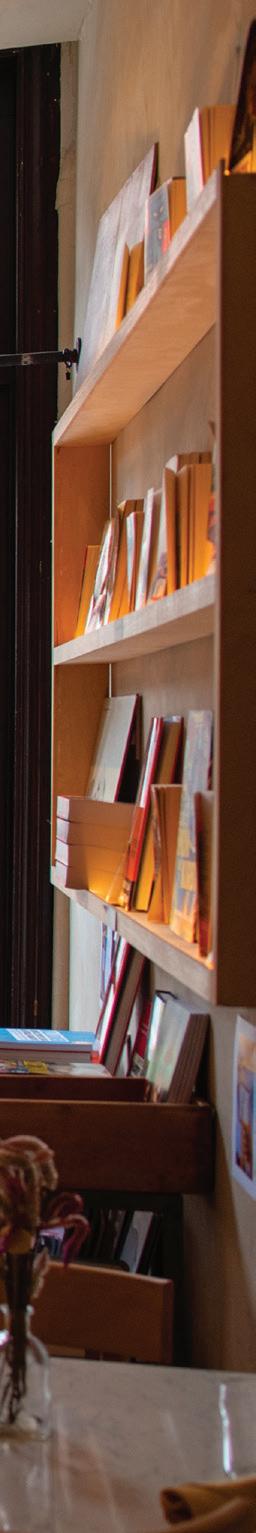
Cci sono luoghi che non si limitano a esistere, ma prendono la parola. Parlano attraverso le pareti, i profumi, le pagine che custodiscono. Sullaluna NYC è uno di questi: una libreria che diventa bistrot, un bistrot che diventa spazio culturale, un piccolo osservatorio sul mondo incastonato nel cuore del West Village. Un progetto che nasce dall’Italia e approda a New York non come semplice trasloco geografico, ma come gesto poetico: portare lentezza, cura e contemplazione là dove tutto corre. Dentro questa cornice, la voce di Giulia Aguì – psicologa clinica prestata alla cultura, narratrice appassionata e oggi General Manager di Sullaluna NYC – ci invita a riflettere sul potere delle storie. La sua traiettoria, dal lavoro con i giovani pazienti nei centri psichiatrici di Torino all’attuale impegno nella curatela di libri illustrati e momenti conviviali, mostra quanto la narrazione non sia un accessorio ma una necessità: strumento di guarigione, di relazione, di resistenza al rumore. L’intervista che segue non è soltanto il racconto di un
progetto, ma la testimonianza di un modo diverso di abitare la città e il tempo. New York, con la sua cassa di risonanza, amplifica ogni emozione: in questo scenario, Sullaluna si propone come rifugio e allo stesso tempo come piattaforma di trasformazione. Qui i libri parlano agli adulti tanto quanto ai bambini, il vino e il cibo diventano racconti sensoriali, e la rêverie, quel lasciarsi andare al sogno vigile, si fa rituale quotidiano. In un’epoca in cui tutto accelera, Giulia e Sullaluna ci ricordano che il vero atto rivoluzionario è rallentare, senza smettere di vivere intensamente.
D. Perché proprio New York? Cosa significa per te questa città?
R. New York è una città che dentro di me era già conosciuta, ancora prima di metterci piede. È una sensazione che credo accomuni molti: quella di sentirsi già parte di qualcosa, di riconoscerla tra tante. Quando poi ho iniziato a viverla, ho scoperto che non è solo moto perpetuo, ma anche occasione di scoperta, e offre incredibili spazi di decompressione che non ti aspetti. È una città che amplifica


quello che provi, fa da cassa di risonanza al tuo stato d’animo. Io sono arrivata in un momento della mia vita in cui mi sentivo abbastanza strutturata, e questo mi ha permesso di sentirla da subito vicina.
D. Che cos’è per te un illustrato? Un ricordo, un rifugio o una forma d’arte?
R. Le immagini, come le parole, ci permettono di significare: di dare un senso, di distinguere, di creare spazio. Un albo illustrato può essere rifugio, gioco, strumento educativo. Li ho sempre trovati preziosi anche in contesti clinici, lavorando con i miei giovani pazienti: aprono possibilità di esplorazione infinite. La selezione curata che Francesca Rizzi ha iniziato permette di accedere a mondi incredibili di meraviglia e cura. Esporli come
vere opere d’arte fa sì che chi entra in libreria –adulti e bambini – si senta subito protagonista. L’immagine e ciò che evoca spesso guidano la scelta di un albo; a volte il consiglio migliore è lasciarsi guidare dalla pancia e chiedersi: “Cosa ti chiama?”.
D. Quando hai capito che questi libri potevano parlare anche agli adulti? I vostri eventi sono un successo, qual è il segreto?
R. Non esistono davvero libri solo per bambini, perché ognuno di noi porta dentro una parte bambina che è fondamentale continuare a nutrire e curare. La regressione, l’uso dell’immagine o del racconto fantastico sono strumenti potenti di narrazione e storytelling: aiutano anche l’adulto a riflettere su di sé, a ritagliarsi spazi di leggerezza e gioco.

Credo che chi partecipa ai nostri eventi lo percepisca: dietro quello che facciamo c’è grande autenticità. Non cerchiamo di stupire, ma di creare luoghi di cultura e condivisione, in cui le persone possano emozionarsi insieme e sentirsi parte di qualcosa di vivo.
D. Sullaluna è un nome che evoca sogno, lentezza, contemplazione. Che tipo di mondo volete creare varcando la sua soglia?
LE IMMAGINI, COME LE PAROLE, CI PERMETTONO DI SIGNIFICARE: DI DARE UN SENSO, DI DISTINGUERE, DI CREARE SPAZIO.
“ “

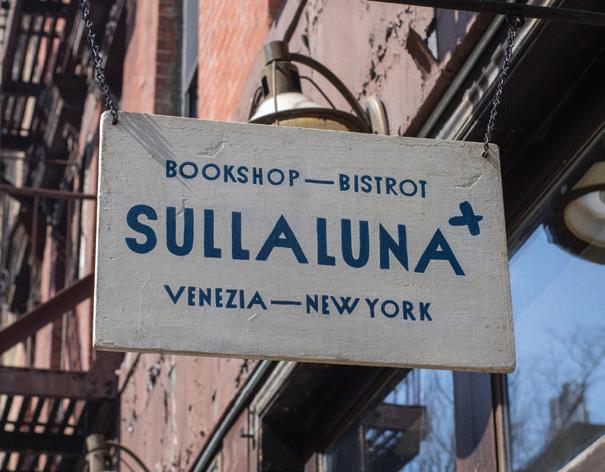
Sullaluna è un concept unico nato a Venezia e oggi presente anche a New York City. È una libreria indipendente italiana specializzata in libri illustrati e di design accuratamente selezionati, con titoli sia in italiano che in inglese. Radicata in un profondo amore per la narrazione visiva e la letteratura, Sullaluna promuove un approccio attento, creativo e poetico alla lettura attraverso una varietà di eventi. A New York, Sullaluna NYC amplia questa visione diventando uno spazio culturale e un bistrot italiano nel cuore del West Village. Accanto alla libreria, gli ospiti possono vivere un’autentica esperienza culinaria dalla colazione alla cena e partecipare a letture, presentazioni e incontri artistici che celebrano la cultura italiana e non solo. Che sia a Venezia o a New York, Sullaluna è un luogo dove libri, cibo ed esperienze culturali si uniscono per creare momenti di ispirazione e connessione.
41 Carmine St, New York, NY 10014 - sullalunanyc.com
R. L’idea è creare uno spazio che permetta alle persone di rallentare, ma senza spegnersi. Un luogo in cui potersi fermare, mangiare bene, leggere qualcosa di stimolante, partecipare a un evento culturale. Crediamo che la lentezza non debba essere passività, ma un modo diverso di vivere il tempo e la cultura: con più attenzione, più qualità, meno rumore. Sullaluna è pensato per chi ha bisogno di riconnettersi con contenuti reali e con persone vere. In questo senso, il sogno e la contemplazione non sono una fuga, ma una scelta. C’è una parola francese che descrive bene quello che vorrei far provare a chi entra: rêverie. Abbandonarsi a fantasticare. Non un sogno vago, ma uno stato mentale in cui lasci spazio alla riflessione, all’immaginazione, un luogo per pensare insieme.
D. Com’è nata l’idea di unire vino, lettura e illustrazione? Era una scelta estetica, emotiva o una dichiarazione di intenti?
R. Con mio marito condividiamo da sempre una grande passione per i vini naturali. Lui stesso insieme alla sua famiglia si prende cura di un vigneto in Sardegna tramandato da generazioni. Così come Lorenzo Tonello, proprietario di Sullaluna che insieme alla famiglia produce a Refrontolo il prosecco Lunatico. Un prodotto unico da cui prende origine e ispirazione l’idea Sullaluna. Ci ha unito l’amore per le storie che stanno dietro al vino: quelle delle vigne, delle famiglie, dei territori che si tramandano nel tempo. Unire il vino al buon cibo e alla lettura è stato naturale: tutto parte dal desiderio di valorizzare ciò che è autentico e racconta qualcosa. Non è stata solo una scelta estetica o emotiva, ma una vera dichiarazione d’intenti: creare un luogo dove le storie si possano vivere con tutti i sensi.
D. Per la vostra prima esperienza negli Stati Uniti dal punto di vista tecnico e burocratico, com’è stata la vostra esperienza con ExportUSA?
Arrivare in una città come New York, dove i processi burocratici sono completamente diversi da quelli a cui ero abituata, poteva essere davvero scoraggiante. Avere accanto un team affidabile e competente come quello di ExportUSA
"...C’È UNA PAROLA FRANCESE CHE DESCRIVE BENE QUELLO CHE VORREI FAR PROVARE A CHI ENTRA: RÊVERIE. ABBANDONARSI A FANTASTICARE. NON UN SOGNO VAGO, MA UNO STATO MENTALE IN CUI LASCI SPAZIO ALLA
RIFLESSIONE, ALL’IMMAGINAZIONE, UN LUOGO PER PENSARE INSIEME..."

ha fatto la di erenza. Mi ha permesso di a rontare questo grande salto con serenità, sentendomi supportata in ogni fase, dalle pratiche più tecniche fino agli aspetti più pratici della gestione quotidiana.
Ma ciò che ha davvero fatto la differenza è stata l’umanità delle persone che ci lavorano: presenti, disponibili, sempre con un approccio concreto ma empatico. In un momento di grande cambiamento, il loro supporto ha rappresentato un capitale umano inestimabile.
D. In un’America che corre, che cambia, che divide, quale ritualità rimane a quelle persone che credono ancora nel sogno americano?
R. Per me la vera risorsa di questa città è la possibilità di essere. A prescindere dal ruolo, dal background o dalla storia da cui arrivi, New York ti permette di vivere tante esistenze dentro una sola vita. Qui puoi cambiare, mutare, riscrivere te stesso ogni giorno, se ne hai il desiderio. Il sogno americano, oggi, forse è proprio questo: non la scalata, ma la
trasformazione continua. E dentro questa trasformazione, trovare piccoli rituali che ti tengano ancorato a chi sei: una lettura, un bicchiere di vino, un momento di scambio reale. È quello che cerchiamo di o rire ogni giorno a Sullaluna.
D. Se fossi una canzone, quale saresti?
R. Più che una canzone, forse sarei un’artista: Levante, Claudia Lagona. Il suo percorso mi rappresenta più di qualsiasi singolo brano. Leggera, con quella sua malinconia lucida e quella voglia di restare in equilibrio senza sparire, è una canzone che sento molto mia. Ma potrei dire lo stesso di tante altre: Le lacrime non macchiano, La rivincita dei buoni, Lo stretto necessario. C’è qualcosa nella sua scrittura che mi accompagna da anni, e che riesce sempre a restituirmi a me stessa, anche nei momenti più confusi. Levante ha un modo tutto suo di raccontare la complessità con semplicità, e forse è questo che mi ci fa ritrovare ogni volta: la capacità di restare fedele a sé stessi mentre si cambia.
ABOUT

Giulia Aguì è General Manager di Sullaluna NYC, una libreria indipendente e bistrot che porta a New York un angolo di cultura e convivialità italiana. Psicologa clinica specializzata in infanzia e adolescenza, ha oltre dieci anni di esperienza in psichiatria, di cui cinque trascorsi in un centro socioriabilitativo a Torino, dedicato al supporto di minori con di coltà psichiche. Appassionata di narrazione e storytelling, Giulia ha sempre creduto nel potere delle storie per creare connessioni. Il cinema e l’universo di Harry Potter sono tra le sue più grandi passioni, ispirazioni costanti nel suo modo di vedere il mondo. Oggi unisce la sua esperienza umana e professionale alla gestione culturale di Sullaluna NYC, trasformandola in un luogo dove libri, esperienze e persone si incontrano in modo autentico.a letture, presentazioni e incontri artistici che celebrano la cultura italiana e non solo.



A cura di ALFIO MARTIRE
Volevamo spiegarvi quali sono le strategie di rebranding più e caci per un marchio che vuole imporsi negli Stati Uniti. Ogni caso fa storia a sé, ma alcune best practice emergono chiaramente dall’analisi dei successi (e fallimenti) sul mercato americano:
Imparare ad Ascoltare:
Prima di qualunque cambiamento, è essenziale capire a fondo il pubblico statunitense al quale ci si rivolge. Ciò significa studiare le tendenze di consumo, i gusti locali, il contesto socio-culturale
e anche il linguaggio del target.
Il rebranding va progettato su misura: ad esempio, il packaging di un prodotto alimentare potrebbe dover evidenziare certificazioni e informazioni nutrizionali in modo diverso rispetto all’Europa, perché i consumatori americani prestano attenzione ad altri dettagli. Allo stesso modo, aspetti come misure e unità di peso, riferimenti sportivi o celebrazioni nazionali (come il 4 luglio) possono essere inseriti nella comunicazione per renderla più familiare al pubblico locale.
Ascoltare i consumatori tramite sondaggi, focus group o l’analisi dei social media consente di individuare cosa amano di un brand e cosa invece andrebbe migliorato. Un rebranding di successo spesso nasce proprio dal feedback degli utenti: comprendere quali valori desiderano vedere rappresentati, quali esigenze non sono soddisfatte o quali aspetti dell’attuale brand story non li coinvolgono.
Questa fase di ricerca è cruciale per evitare passi falsi e colmare
la distanza culturale tra il marchio e il consumatore americano.
Siate sempre Coerenti, con voi stessi e con i consumatori: Una volta raccolti insight sul mercato, l’azienda deve ridefinire con chiarezza la visione e la direzione strategica del brand. Perché stiamo rebrandizzando? Cosa vogliamo comunicare di nuovo? Rispondere a queste domande aiuta a fissare i pilastri dell’identità rinnovata. La strategia deve poi tradursi in linee guida concrete per


tutte le espressioni del marchio: dalla grafica al tono di voce, dal servizio clienti alle campagne pubblicitarie. Ogni elemento del nuovo brand deve riflettere i valori scelti, in modo coordinato. Ad esempio, se l’obiettivo del rebranding è posizionarsi come marchio eco-sostenibile
e innovativo, il design utilizzerà materiali e immagini richiamando la sostenibilità, il messaggio verterà su impegno ambientale e progresso, il servizio clienti enfatizzerà trasparenza e responsabilità sociale. Questa coerenza omnicanale fa sì che il consumatore percepisca
un’identità chiara e solida. L’errore da evitare è invece l’inconsistenza, presentarsi come premium su un canale e low-cost su un altro, o veicolare valori contraddittori, genera confusione e mina la fiducia. Al contrario, una brand identity ben calibrata e coerente in ogni dettaglio amplifica l’impatto
del rebranding e rende il marchio immediatamente riconoscibile.
Coinvolgere il pubblico e creare community: Una strategia vincente in America considera i consumatori parte attiva del rebranding. Coinvolgerli nel percorso di cambiamento può

passivi ma come protagonisti del racconto di marca è una ricetta efficace per conquistare il cuore del pubblico americano.
L'innovazione non la ferma nessuno: Il rebranding non va visto come un punto di arrivo statico, ma come l’inizio di una nuova fase
evolutiva. Una volta lanciata la nuova identità, bisogna essere pronti a monitorarne l’efficacia e ad apportare aggiustamenti in corsa. Il mercato USA è rapido nel cambiare direzione: ciò che oggi è all’avanguardia, domani potrebbe essere già superato. Ecco perché le aziende vincenti adottano un approccio agile,
sfruttando i dati di mercato in tempo reale per capire cosa funziona e cosa no. Se una certa campagna di comunicazione non ottiene riscontro, si corregge rotta; se emergono nuove tendenze (es. una piattaforma social emergente, un meme virale legato al settore), il brand può trovare modi creativi di integrarle restando
coerente con la propria identità.
Questa capacità di innovare continuamente attorno a un nucleo identitario stabile è ciò che rende un marchio davvero duraturo. Un rebranding ben fatto fornisce quel nucleo (valori, estetica, voce) ma lascia anche spazio alla crescita. Pensiamo

a marchi come Starbucks o McDonald’s: hanno loghi e tratti iconici che permangono negli anni, ma sanno anche rinnovare periodicamente l’offerta, il design dei locali, le modalità di interazione (dalle app mobile ai chioschi self-service) per restare rilevanti. Allo stesso modo, un brand rebrandizzato per il mercato americano dovrà mantenere viva la conversazione col pubblico, mostrando di evolvere assieme ad esso. In pratica, significa investire nel continuo miglioramento dell’esperienza cliente, nell’innovazione di prodotto e nella comunicazione creativa, così che l’identità di marca rimanga vibrante e non perda smalto col passare del tempo.
Coinvolgimento e fiducia del pubblico:
Infine, un brand rebrandizzato con successo in America è quello che è riuscito a guadagnarsi la fiducia dei consumatori e a coinvolgerli nella
propria missione. Come abbiamo visto, la fiducia è la base indispensabile: circa 4 clienti su 5 dichiarano che devono potersi fidare di un marchio prima di comprarlo. Un brand solido mantiene le promesse fatte durante il rebranding – in termini di qualità, servizio e valori – e così facendo trasforma quella fiducia iniziale in loyalty. I clienti soddisfatti e allineati ai valori del brand diventano i primi promotori, attivati dal senso di comunità attorno alla marca. Si innesca così un circolo virtuoso: il marchio non è più solo un logo sugli scaffali, ma un ecosistema di persone che condividono esperienze e aspirazioni.
Questo è forse il segreto ultimo della durata di un brand: essere percepito non come una presenza estranea e commerciale, ma come un partner a dabile nella vita dei consumatori, qualcosa di cui ci si può fidare e in cui ci si rispecchia.
E in conclusione, la necessità di rebrandizzare un marchio per il mercato americano nasce dalla consapevolezza che il successo negli Stati Uniti premia i brand con un’identità forte, evocativa e in costante evoluzione. È un investimento impegnativo – richiede visione, creatività e ascolto – ma i frutti ripagano lo sforzo: un marchio rinnovato che sa coinvolgere emotivamente il pubblico e resistere alla prova del tempo. Senza un branding robusto, infatti, anche un buon prodotto rischia di perdersi nell’ombra dei concorrenti, “confondendosi sullo sfondo” e mancando l’opportunità di lasciare il segno.
Al contrario, con una strategia di rebranding mirata e autentica, un marchio può rinascere e inaugurare un capitolo di successo duraturo negli Stati Uniti, sostenuto da una brand identity capace di ispirare fiducia e passione nei consumatori americani.






Nessun luogo, più di Mulberry Street, riesce a incarnare l’anima profonda di New York. Non quella da cartolina, riflessa nelle vetrine scintillanti della Fifth Avenue o nelle terrazze panoramiche di Midtown, ma quella sporca, vera, viscerale. L’anima fatta di stenti, sudore, accenti storti, cucine a ollate e sogni troppo grandi per gli spazi angusti dei tenement. Mulberry Street è stata — ed è ancora — il battito primordiale della città che conosciamo.
Alla fine dell’Ottocento, la Lower East Side era il ventre di Manhattan. Un ventre a ollato, pulsante, a tratti febbricitante. In appena quattro miglia quadrate vivevano oltre 500.000 persone, stipate in edifici decrepiti, dove ogni stanza era un mondo e ogni finestra un confine sottile tra la miseria e la sopravvivenza.
Mulberry Street tagliava in due questa massa di vite sovrapposte come la lama
di un coltello arrugginito. Lì si parlavano lingue che nessuno a Uptown avrebbe mai compreso. Il dialetto siciliano si mescolava al yiddish, al polacco, all’ungherese. Era il suono di una città in costruzione, non ancora definita, ancora capace di stupirsi di sé stessa. I bambini correvano scalzi sui marciapiedi, vendendo giornali o fiammiferi. Le donne stendevano i panni tra i palazzi come bandiere di un esercito invisibile. Gli uomini si alzavano prima dell’alba per lavorare nei cantieri, nei porti, nelle piccole officine che producevano “tutto, dai corsetti ai grattacieli”, come scrisse lo storico Joshua Freeman.
La fotografia di Jacob Riis scattata nel 1900 è il documento definitivo di quell’epoca. Un’inquadratura semplice, la strada piena di gente, le tende logore, i carretti della frutta, i volti segnati, lo sporco sotto le unghie. Ma dentro quell’immagine ci sono
mille romanzi. Non c’è posa, non c’è estetica. C’è la verità, cruda, dura, ma bellissima. Perché quella, in fin dei conti era New York.
Riis, giornalista e riformatore sociale, non cercava l’e etto. Cercava di scuotere le coscienze. E ci riuscì. “How the Other Half Lives”, il suo libro fotografico, mostrò agli americani benestanti cosa significasse davvero la parola “immigrato”: non solo speranza, ma sacrificio, so erenza, lavoro incessante. Mulberry Street era il simbolo di tutto questo. Era il microcosmo della città che stava diventando metropoli. Il crocevia delle identità in conflitto e in fusione, dove l’America si scriveva a mano, con accento straniero.
Camminare oggi su Mulberry Street è come attraversare le pagine strappate di un diario. Le insegne italiane resistono ancora, fiere e un po’ sbiadite. Ristoranti che servono rigatoni al sugo con le tovaglie a quadretti, botteghe con foto ingiallite alle pareti e profumo di ca è forte. Ma accanto sorgono boutique di design, concept store, gelaterie vegane e
appartamenti che costano più di quanto un immigrato avrebbe guadagnato in tutta la vita. Il quartiere cambia, muta pelle, come ha sempre fatto.
Nel Novecento, Mulberry era territorio di clan. Non solo quelli famigliari, parliamo di vere e proprie confraternite sociali. Chiese, circoli, società di mutuo soccorso. Tutto ruotava attorno all’identità. E l’identità era comunità. Si nasceva a Little Italy e ci si restava, in un quartiere che era villaggio, rifugio, barriera e prigione allo stesso tempo.
Anche i rituali avevano la loro coreografia, la festa di San Gennaro, ad esempio, esplodeva tra le strade strette con luci, musica e odori che sembravano sradicati direttamente da Napoli. Era una messa in scena collettiva di appartenenza, un modo per dire “noi siamo qui, e resistiamo”.
Ma il tempo non è mai gentile con chi non ha voce. Con il secondo dopoguerra, le famiglie cominciarono a spostarsi. La middle class italiana si trasferì altrove, in cerca di spazi più larghi, scuole migliori, e un’America meno
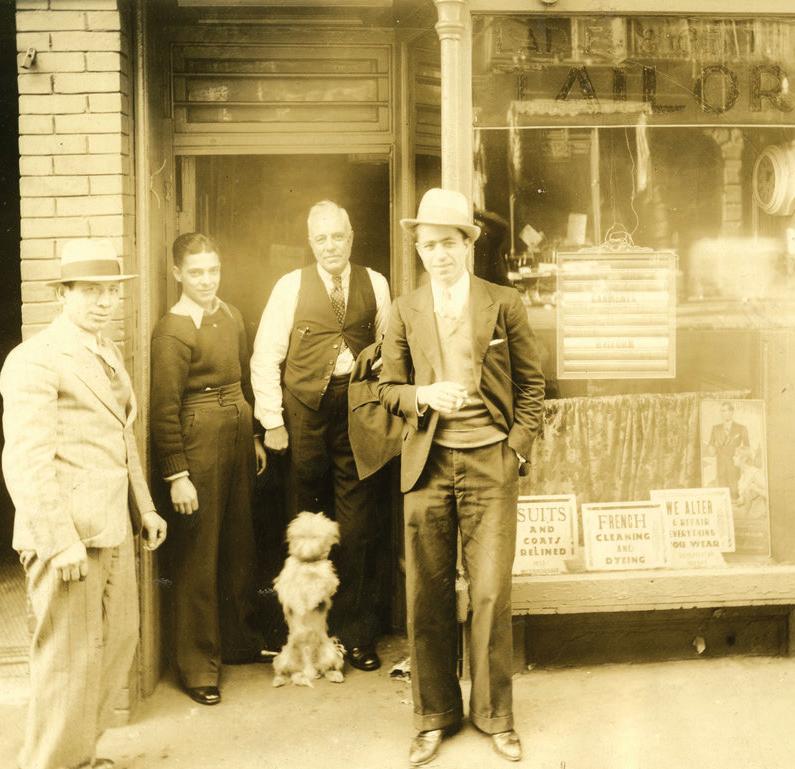




rumorosa. Al loro posto arrivarono nuove ondate migratorie: cinesi, dominicani, portoricani. E la città continuò il suo ciclo.
Oggi Chinatown lambisce Mulberry Street come un nuovo fiume culturale. Le insegne in ideogrammi hanno preso il posto delle scritte in corsivo dorato. Ma l’energia, seppure mutata, resta.
È questo il mistero della Lower East Side. Di Mulberry Street. Ogni generazione la trasforma, ogni epoca la riplasma, ma non riesce mai a cancellarla. Perché non è un luogo, è un archetipo. È l’immagine perfetta dell’idea di città come organismo vivo, complesso, contraddittorio.
È il palcoscenico in cui il passato si mescola al presente e recita sempre lo stesso copione, quello dell’arrivo, della lotta, dell’adattamento, del riscatto.
Persino gli urbanisti, nel secolo scorso, hanno diviso la visione della città tra chi la voleva estesa e razionale, come Robert Moses, e chi invece la vedeva densa,
spontanea, pulsante, come Jane Jacobs. Mulberry Street, naturalmente, appartiene a quest’ultima. È un inno alla vita urbana come disordine creativo. Come sovrapposizione di storie e destini.
Non è nostalgia, quella che si prova passando lì. È memoria. Una memoria che non chiede di essere conservata in formalina, ma vissuta, compresa, tramandata.
Perché il rischio più grande per New York non è il cambiamento, no quello no non l'ho mai pensato è l’indi erenza. Se la città perde la sua diversità, se si svuota di storie vere, di sogni imperfetti, di voci stonate… allora sì, sarà finita.
Finché esisteranno strade come Mulberry, la città avrà ancora un cuore, una storia, un'identità.
C’era una volta Mulberry Street. E c’è ancora, per chi sa guardare.


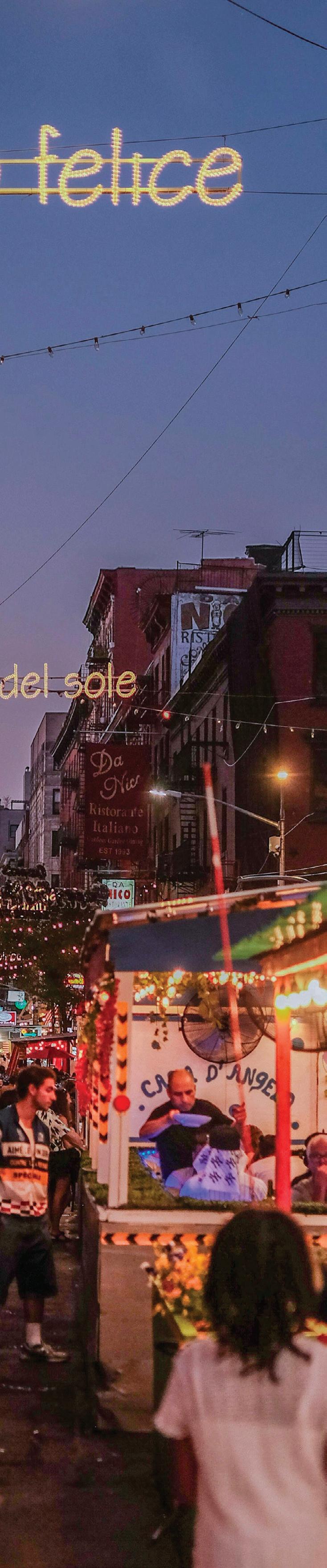

Dal 1892 al 1954, Ellis Island fu il primo contatto con l’America per oltre 12 milioni di immigrati. Un quarto di chilometro quadrato che cambiò destini.
02. UNA MACCHINA PERFETTA PER L’IMMIGRAZIONE:
Capace di accogliere fino a 5.000 persone al giorno, l’isola fu ampliata artificialmente e dotata di dormitori, mense, lavanderie, ospedali e archivi.
Il primo sguardo verso New York era un'emozione incancellabile: tra la nebbia del porto, la Lady Liberty simboleggiava libertà e futuro.
Solo i viaggiatori di terza classe dovevano sbarcare sull’isola. Gli altri venivano controllati direttamente sulla nave. Ellis Island era per i poveri.
Italiani, armeni, ebrei, polacchi, irlandesi, slavi: chi arrivava fuggiva dalla povertà, dalla fame o dalle persecuzioni. Storie fatte di piedi scalzi, valigie di cartone e sogni enormi.
I medici scrutavano i volti alla ricerca di malattie o disabilità. Bastava un segno sospetto per essere trattenuti o respinti. Il tracoma era il terrore.
Dove vai? Da chi? Hai soldi? Hai un lavoro? Bastava una risposta sbagliata per vedere il sogno dissolversi. Chi passava, riceveva un cartellino sul bavero.cliente.
Chi aveva problemi restava trattenuto: giorni, settimane, a volte mesi. I familiari venivano trattenuti insieme, nell’ansia di essere rimandati indietro.
I bambini venivano lavati, vestiti e mandati a scuola. Imparavano l’inglese tra corridoi pieni di accenti e speranze. Per molti, fu il primo banco.
Una volta accettati, si saliva sul traghetto per Manhattan. Alcuni andavano a ricongiungersi con un padre sconosciuto. Altri scoprivano che l’America era molto meno dorata delle cartoline.



COME L’AMERICA STA STRAVOLGENDO IL MONDO DELLA COSMETICA: TRA CINISMO, ALGORITMI E CAPITALI PRIVATI
A cura di ASTRA PAGLIAI
C’era una volta il beauty come gesto di cura. Una crema alla rosa, un siero che prometteva il tempo sospeso, un rossetto che ti faceva sentire invincibile. Oggi, in America, il volto del beauty è cambiato. Letteralmente. E non parliamo solo di filler. Benvenuti nell’era in cui la bellezza non è più un’arte, ma un asset.
Dimenticatevi Chanel. Il futuro ha l’odore di private equity.
A Wall Street, l’estetica è un mercato da oltre 100 miliardi di dollari, e chi ha il portafoglio giusto può comprarne una fetta. I fondi di investimento stanno cannibalizzando i brand indie, impacchettandoli, ristrutturandoli e rivendendoli come startup del benessere.
Tutto ruota intorno a due parole, exit strategy. Non si crea un brand per costruire un’eredità, ma per venderlo in cinque anni con un multiplo a due cifre. È capitalismo cosmetico in versione full glam.
Da Sephora a TikTok: il passaggio da laboratorio a algoritmo
Una volta si lanciava un prodotto dopo mesi in laboratorio. Oggi si lancia un trend su TikTok, poi si produce. L’America ha trasformato la filiera, non è più il prodotto a dettare la domanda, ma il feed.Brand come Glossier, Youthforia e Kosas sono creature algocratiche: si muovono al ritmo delle views, abbozzano il branding sulle “aesthetic” di tendenza
e decidono gli ingredienti in base ai commenti sotto un video virale. È la bellezza come performance, come contenuto.
E se domani il retinolo dovesse diventare “problematico”? Nessun problema, si riformula. Il principio attivo oggi è la reattività.
La diversity come KPI, l’ecoclaim come strategia
In America, nessuno compra più un fondotinta. Compra un manifesto. Inclusività, sostenibilità, mental health, tutto ciò che una volta era urgenza sociale oggi è marketing deck. Serve a ottenere finanziamenti,
Nel 2025, gli americani spenderanno circa 105 miliardi di dollari in prodotti di bellezza.



I dermatologi-influencer più famosi e influenti negli Stati Uniti sono noti per aver trasformato la medicina estetica in intrattenimento e in un business milionario.

a colpire la Gen Z, a finire nella selezione “Clean at Sephora”. Ma la maggior parte dei brand “clean” non è certificata da alcun ente indipendente. E i packaging eco-friendly spesso finiscono in discarica come tutti gli altri. La cosmesi americana non ha più un’etica, ha una narrazione. E chi la sa raccontare meglio, vince.
Il ritorno del dermatologoinfluencer
Un altro protagonista della rivoluzione è la figura dell’estetista imprenditore. Che sia un dermatologo con milioni di follower su YouTube, o una nurse practitioner con una clinica a Miami, oggi sono loro a vendere “skincare medicale” confezionata come luxury. Non è più solo beauty, è healthcare aspirazionale. La pillola anti-acne, il filler labbra e la laser therapy sono parte di un’unica routine che promette non la bellezza, ma il controllo. Del viso. Dell’età. Della narrazione di sé.

Il cinismo è il nuovo collagene
La verità? In America il beauty è ormai un sottogenere della tech industry. È DTC, è subscription-based, è AIpowered. È un mondo dove ogni poro è un touchpoint, e ogni imperfezione un insight. Chi guida questo mercato non sono gli artisti del trucco, ma i venture capitalist, i CEO con background in fintech, e i data analyst che sanno leggere la pelle come un funnel.
Non si vende più un sogno. Si vende un algoritmo che ti dice come dovresti sognare.
Il trucco c’è. E si vede.
E allora sì, l’America resta la patria delle rivoluzioni. Ma oggi la rivoluzione è un ciclo di funding, un lancio su Instagram e una lista d’attesa su Notion. La nuova bellezza è rapida, spietata, predittiva.
E forse, proprio per questo, ancora più seducente.








La fotografia a New York è da sempre un dialogo con la città: un luogo fatto di luci che cambiano all’improvviso, riflessi che durano un istante, ombre che raccontano storie più delle persone stesse. Chi sceglie di fotografarla sa che non basta lo sguardo, serve resistenza, ossessione e quella costante tensione verso lo scatto perfetto che forse non arriverà mai, ma che alimenta ogni giorno il desiderio di riprovarci.
In queste pagine incontriamo Riccardo Piazza, un fotografo che vive la città da sette anni, abbastanza a lungo per chiamarsi newyorkese, ma ancora con
lo sguardo di chi appartiene a due mondi. New York come set infinito, Italia come scintilla ritrovata. La sua ricerca è una fusione di identità: italiana per sensibilità estetica, americana per libertà e vastità, personale per le cicatrici e le nostalgie che emergono dietro l’obiettivo.
C’è la luce dei tramonti tra i grattacieli, i colori che mutano improvvisi, la fedeltà a una vecchia Pentax K1000 che porta con sé la memoria paterna. La fotografia, qui, non è solo mestiere né estetica. È identità che cambia, è libertà tatuata sulla pelle, è ricerca infinita.
Un milione di scatti possibili e nessuno definitivo. Perché ogni volta che premi il pulsante, New York ti ricorda che la perfezione è solo un’illusione, e che il vero capolavoro è restare in cammino>


D. Riccardo innanzitutto grazie di aver accettato la nostra intervista. Da quanto tempo vivi a New York e com'è cambiato il tuo sguardo sulla città da quando ci sei arrivato?
R. Grazie a ExportUSA peravermi dato l’opportunità di essere qui a raccontarvi un po’ di me. Mi sono trasferito a New York nel 2018, quindi vivo qui da sette anni. Dicono che si diventa un vero newyorkese dopo 7 anni, quindi eccomi qui.
Fotograficamente parlando, a livello di ispirazione sta succedendo un po’ l’opposto rispetto a quando sono partito: in Italia non ero più molto stimolato da ciò che mi circondava, mentre appena arrivato a New York volevo scattare in ogni angolo.
Ora, dopo anni, capita il contrario: quando torno in Italia o viaggio in altri posti, si riaccende quella scintilla. New York, invece, è diventata un po’... “monotona”.
D. Cosa significa per te “fotografare l’America”? È solo documentare o c'è qualcosa di più personale?
R. A livello personale, fotografare l’America mi riporta ai mille film e alle scene che ho visto da ragazzo, quando l’America era ancora un sogno. Ora che è diventata realtà, cerco di unire tutti gli aspetti della mia identità - italiana, americana, personale, visiva e caratteriale - per creare qualcosa di sempre più autentico e potente.
D. Parliamo di luce. Che rapporto hai con la luce? La insegui o la aspetti?
R. La luce la catturo. Durante ogni servizio, per quanto si possa pianificare l’orario perfetto o scegliere la location ideale, non si può mai prevedere davvero cosa potrà fare un riflesso inaspettato che dura appena qualche minuto. In studio, invece, mi piace sperimentare, memorizzare, migliorarmi ogni volta.


D. Che colore ha New York per te?
R. Me la vedo con il colore del tramonto. Ancora oggi resto incantato dalla luce che filtra tra i palazzi, dai riflessi sui vetri dei grattacieli e dalle ombre che si creano tra una via e l’altra.
D. C’è una fotografia che non hai ancora scattato, ma che continui a cercare?
R. Un milione, non solo una. Credo moltissimo nel miglioramento è sia un bene che un male. Anche se oggi sono felice e grato per tutto quello che è successo, sarò sempre alla ricerca dello scatto perfetto, di qualcosa in più.
D. Passiamo al lato tecnico, qual è la tua macchina fotografica preferita? E perché? Analogica o digitale?
R. Anche se non la uso spesso, la mia macchina fotografica preferita è una Pentax K1000 analogica che mi ha passato mio padre tanti anni fa. È la macchina a cui tengo di più. Poco tempo fa mi ha regalato anche un banco
ottico, e quest’anno ho deciso di usarlo per un nuovo progetto/ libro che racconta le storie degli italo-americani trasferiti nel dopoguerra. Si tratta di un libro fotografico con interviste realizzate dalla giornalista Lavinia Colasanto, raccoglie le esperienze e le vicende a rontate dai nostri predecessori.
D. Cosa resta della tua Italia nelle immagini che scatti a New York? Senti la nostalgia?
R. Non sento molta nostalgia, perché quando ho l’opportunità torno volentieri in Italia, e il tempo che ci passo mi basta a colmare quel “vuoto”. Però è innegabile che la nostra capacità - tutta italiana - di vedere la bellezza, nella fotografia come nella vita, sia un valore aggiunto importante.
D. Conoscendoti personalmente so che condividiamo la stessa grande passione per le motociclette. Secondo te c'è una connessione tra il senso di libertà in sella e la fotografia?
R. Credo di sì. Hai usato una parola bellissima: “libertà”. È stato il mio primo tatuaggio, fatto a 18 anni, e penso di aver colto fin da
"...NON SI PUÒ MAI PREVEDERE DAVVERO COSA POTRÀ FARE UN RIFLESSO INASPETTATO CHE DURA APPENA QUALCHE MINUTO..."


subito il significato profondo che porta con sé, insieme a tutto ciò che la circonda. Anche la moto, per me, rappresenta un grande senso di appartenenza e di libertà.
D. Ultima di rito, se tu fossi una canzone, quale saresti?
R. Per chiudere in bellezza? "Sogna ragazzo, sogna" del Professor Roberto Vecchioni.

Riccardo, originario di Piazzola sul Brentaresciuto è cresciuto in una famiglia legata all’arte e alla fotografia, si forma tra grafica e fotografia analogica, sviluppando una passione che lo porta presto a Londra. Alla Central Saint Martins frequenta uno dei migliori corsi di fotografia di moda e lavora con celebrità ed eventi internazionali.
Rientrato in Italia, collabora come graphic designer con marchi come Valentino, Just Cavalli e Louis Vuitton, continuando a coltivare la fotografia. Nel 2015 incontra Raoul Beltrame e partecipa a progetti per DKNY e M Missoni. Tre anni dopo si trasferisce a New York, dove perfeziona le sue competenze e inizia a collaborare con realtà come Vogue, Grazia, Fashion Week Daily, O -White e Safilo.
Oggi guida il suo progetto Studio P23 e porta avanti lavori di ricerca artistica orientati alle esposizioni.

MONDIALE DEL CAPITALISMO.
Negli anni Novanta mi sono trasferito a New York, nel cuore pulsante dell’economia globale. Una città dove ogni sogno sembra possibile, dove tutto scorre veloce e la frenesia è parte della quotidianità. L’avevo vista in decine di film ma mai avrei immaginato cosa si celasse davvero dietro i simboli di quella che tutti chiamano “la città che non dorme mai”. Wall Street mi colpì immediatamente. Era molto diversa da come l’avevo immaginata o da come viene raccontata, con uomini in giacca e cravatta che urlano davanti a schermi enormi, telefoni all’orecchio e numeri che scorrono più veloci di un treno. La realtà, come spesso accade, è molto più complessa e infinitamente più a ascinante. In un ambiente così competitivo, essere italiano può sembrare uno svantaggio. L’accento, la cultura diversa, ti fanno sentire quasi un estraneo. Ma col tempo ho scoperto che proprio questa diversità è una risorsa perché noi italiani abbiamo una marcia in più: sappiamo comunicare, siamo creativi, leggiamo le situazioni da angolazioni diverse. Cosa c’è dietro le quinte di questo mondo straordinario? Cosa significa lavorare a Wall Street? Siamo davvero orgogliosi che Kenny Polcari, uno dei protagonisti della finanza americana, abbia scelto di raccontarci come funziona e come è cambiato
questo mondo, sfatando i pregiudizi e restituendoci un’America che non esclude ma accoglie tutti.
DICK GRASSO
Nel 1972, un ragazzo italiano del Queens si presenta all’Undici di Wall Street per il suo primo giorno di lavoro. Sala posta. Piano interrato. Il suo nome è Dick Grasso. È alto un metro e sessantacinque, indossa un completo preso in prestito. I ragazzi della sala posta pensavano che non avrebbe resistito più di sei mesi. Ma quel ragazzo aveva altri piani. Dick si fece strada salendo tutti i gradini dell’organizzazione – e nel 1995 ne diventò presidente. Rimase lì mentre attraversavamo il passaggio al nuovo secolo, all’inizio di quella che sarebbe diventata la più grande trasformazione dei mercati finanziari americani… È un mio caro amico…
ARTURO DI MODICA
Nel 1977 arrivò sulla scena un secondo italiano. Questa volta da Firenze, non dal Queens. Arturo Di Modica sbarcò all’aeroporto JFK con 200 dollari in tasca e la testa piena di sogni: voleva diventare un artista in America. Nato in Sicilia nel 1941, figlio di un venditore di frutta aveva mostrato, sin da piccolo, un talento straordinario per la scultura. Modellava pietra e metallo con una passione tale da rendere impossibile ignorare le sue opere. Da adolescente si trasferì a Firenze per studiare e a nare la sua arte, ottenendo infine
riconoscimenti in tutta
Italia come artista audace e dotato. Quando arrivò a New York City, fu subito rapito dall’energia e dall’ambizione del luogo dove tutto sembrava possibile. Aprì uno studio in Grand Street, nell’attuale SoHo, immergendosi nella vivace scena artistica cittadina, costruendo una reputazione che fondeva tecnica tradizionale e grinta moderna. Dopo il crollo del mercato azionario del 1987, Di Modica sentì il bisogno di restituire qualcosa al paese che lo aveva accolto. Voleva creare un simbolo di resilienza e determinazione, qualcosa che potesse sollevare gli animi e ricordare agli americani la loro forza. Decise di investire 360.000 dollari per creare quello che sarebbe diventato uno dei simboli più iconici di New York: il Charging Bull. Installata senza permesso di fronte alla Borsa di New York, la massiccia scultura in bronzo era un dono al popolo. Rappresentava l’ottimismo, un’economia in ripresa e lo spirito inarrestabile del mondo imprenditoriale americano — la vera incarnazione del mercato, il toro per cui tutti lottavano. Dietro quella figura di bronzo si nasconde una storia classica di determinazione, gratitudine, ma anche di un immigrato il cui sogno si era avverato.
KENNY POLCARI
Ed ecco che nel 1980 arriva l’italiano numero tre… ero io!!! – Kenny Polcari – un ragazzo di Boston, Massachusetts (con radici napoletane e
Kenny Polcari è Chief Market Strategist presso Slatestone Wealth, una società di consulenza patrimoniale con oltre 2 miliardi di dollari in gestione, dove si occupa di analisi di mercato, scenari economici e strategie per gli investimenti futuri. È anche Managing Partner di Kace Capital Advisory, una realtà che supporta consulenti finanziari e aziende fintech emergenti. Con oltre 40 anni di esperienza nei mercati, Kenny è una figura ben nota a Wall Street. Ha iniziato la sua carriera nel 1985 sul floor del NYSE, dove ha attraversato momenti storici — dal Lunedì Nero all’11 settembre — costruendo una prospettiva unica sulle dinamiche di mercato. Ha guidato team per Salomon Brothers e ICAP, contribuendo allo sviluppo del trading elettronico e alla maggiore trasparenza nel settore. Molti lo conoscono anche per i suoi interventi su CNBC e Fox Business, o per la sua newsletter quotidiana “Morning Thoughts”, un mix originale di analisi di mercato e… ricette di cucina, la sua grande passione. L’11 settembre ha segnato profondamente il suo percorso personale. Da allora, è attivamente impegnato nel supporto ai veterani, collaborando con il Headstrong Project, che assiste migliaia di ex militari affetti da stress post-traumatico. Ha conosciuto sua moglie sulla Borsa di New York — anche lei ex-membro — e insieme hanno due figlie.
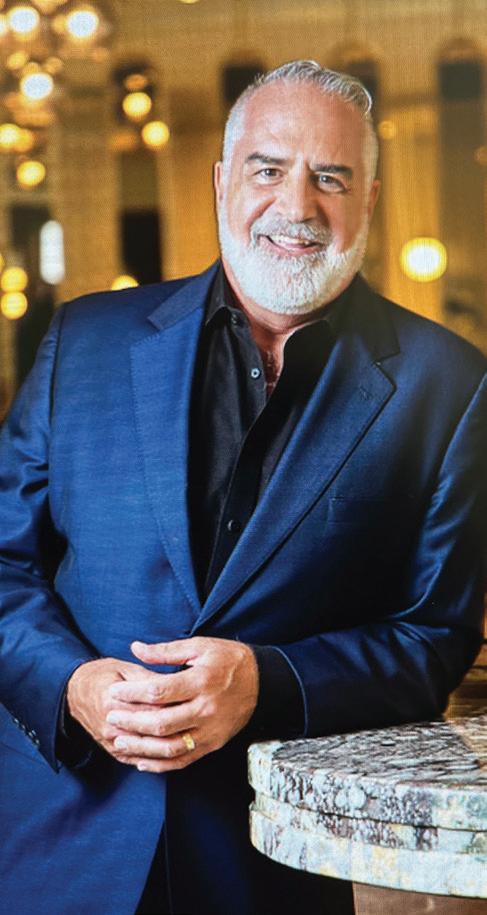

«In seguito al crollo del mercato del 1987 l’artista siciliano Arturo di Modica, originario di Vittoria in provincia di Ragusa ed emigrato a New York negli anni ’70, decise di realizzare il Charging Bull (in italiano toro che carica) di Wall Street senza il permesso né alcuna sovvenzione da parte della città, finanziando lui stesso il progetto da ben 360.000 dollari.».



siciliane) che trascorse un’estate come stagista alla Borsa di New York (NYSE). Quell’estate avrebbe cambiato per sempre il corso della mia vita – ed eccovi la storia: quando entrai per la prima volta sul floor della NYSE in quel caldo giorno di maggio 1980, non avevo idea di cosa accadesse lì dentro. Non sapevo cosa fosse realmente la NYSE. Certo, capivo il concetto di investimento, sapevo che le persone compravano e vendevano azioni, ma non avevo la minima idea di come funzionasse realmente il sistema. Non sapevo distinguere un acquisto da una vendita, un’azione da un’obbligazione, un 1/8 da un 1/4 – e lo dico perché all’epoca le azioni venivano scambiate in frazioni, precisamente in ottavi di dollaro, in base a convenzioni storiche radicate nei primi sistemi finanziari. Questa prassi risaliva al dollaro spagnolo, i famosi “pezzi da otto”, una moneta d’argento molto usata nelle Americhe durante il periodo coloniale. Veniva fisicamente divisa in otto parti, dando origine a un sistema di prezzo frazionario. La Borsa di New York, fondata nel 1792, adottò questa convenzione perché familiare ai trader e coerente con il sistema monetario di allora.
TRADERS WAR
Ciò che mi colpì ancora di più fu la lingua che parlavano lì dentro; sembrava davvero una lingua straniera. Era chiamata “la lingua dei trader”. Ogni azione aveva il proprio nome abbreviato in un simbolo di 1, 2 o 3 lettere: ad esempio, American Telephone and Telegraph diventava “T”, International Business Machines diventava “IBM”, Coca-Cola diventava “KO”. Se fossi stato un compratore avresti parlato in un certo modo, se fossi stato un venditore avresti parlato in un altro. In questo modo era chiaro
alla folla da che parte stavi. Era, sotto molti aspetti, una lingua straniera: veloce, eccitante, molto tecnica. Era il 1980 (l’inizio dell’amministrazione Reagan e della cosiddetta “Rivoluzione Reagan”), gli USA uscivano dall’amministrazione Carter e l’economia si trovava in uno stato disastroso… L’inflazione sopra il 13%, i tassi d’interesse alle stelle al 21%, la disoccupazione al 10%.
Il Dow Jones fermo sotto quota 800 (oggi supera i 46.000) e il paese stava ancora leccandosi le ferite di una crisi morale ed economica profonda.
SAI SOPRAVVIVERE AL CAOS?
Una cosa che adoravo del floor era la profonda di erenza con il mondo delle banche d’investimento di Wall Street. Le banche erano old-school, elitarie, Ivy League, e per entrare ti serviva un pass da country club. Ma il floor? Il floor aveva solo una cosa: fame. Potevi entrare con un diploma di scuola superiore e costruirti da solo un’attività di trading. Potevi lavorare per una grande società o per conto tuo. L’unica cosa che contava era: sai leggere la folla? Sai resistere alla pressione? Sai sopravvivere al caos? Per farvi un esempio, la mia futura moglie entrò nel floor a 17 anni, da Brooklyn. Nessuna connessione. Nessun fondo per il college. Solo pura determinazione. Chiese un lavoro e lo ottenne. Iniziò come runner. Si fece strada e nel 1984 divenne una delle prime donne a ottenere l’abilitazione per operare come membro effettivo della NYSE. Scusate... sto divagando.
LA SVOLTA
Il 17 agosto 1982 fu la scintilla che accese il più grande mercato che il mondo abbia mai conosciuto. Era lunedì 16 quando iniziò a circolare una voce tra i trader: la FED, guidata da Paul Volcker, avrebbe fatto un annuncio a
sorpresa la mattina seguente alle 8:30. Una cosa rara, perché la FED non faceva annunci a sorpresa. Così, martedì, mentre l’orologio si avvicinava alle 8:30, si sentiva la tensione salire sul floor: se davvero la FED avesse parlato, l’unico modo per saperlo era che qualcuno dai desk “di sopra” (cioè gli u ci delle società di brokeraggio) ci chiamasse per dircelo. Ricordate: nel 1982 non c’erano TV, né radio, né altri mezzi di comunicazione se non i telefoni.
STORIA MODERNA
Alle 8:30 e 32 secondi… ogni telefono prese a squillare. Sembrava Natale. Era travolgente. Volcker fece davvero l’annuncio a sorpresa che la FED tagliava i tassi d’interesse del 10%, cioè di 2 punti interi, passando dal 21% al 19%. Così nacque il più grande rally della storia moderna. La mossa della FED rese chiaro che i tassi sarebbero scesi dal 21% a qualcosa di più “normale”, tra il 4% e il 6%. Questo significava che tutto il denaro parcheggiato nelle banche sarebbe stato riversato sul mercato azionario, facendo impennare i titoli. Gli investitori, affamati di opportunità, si lanciarono a capofitto: le azioni schizzarono alle stelle e una nuova pagina della storia si stava scrivendo. Lunedì 16 agosto 1982, il Dow Jones era a quota 792, con un volume giornaliero di scambi di circa 30 milioni di azioni. Il Dow si muoveva per frazioni di punto, su di 0,25 o giù di 0,375. Poi, martedì 17, dopo l’annuncio, il Dow balzò di un incredibile 4,5%, ovvero 35 punti! Il volume passò da 30 milioni a 138 milioni di azioni scambiate. Era emozionante, esaltante, elettrizzante, da brividi. ERA INCREDIBILE! Rimasi al mio posto, senza muovermi, ricevendo ordini per comprare centinaia di migliaia di azioni di
Coca-Cola, IBM, Johnson & Johnson, General Electric, JPMorgan, AT&T.
LA “REAGANOMICS” E IL LUNEDÌ NERO
Il mercato partì come un razzo, alimentato dalla “Reaganomics”, dalla deregolamentazione e da una crescente fiducia nell’economia americana. Il Dow passò da 792 nell’estate del 1982 a 2800 nell’estate del 1987, un incremento del 253%! E poi… qualcosa andò storto. Era lunedì 19 ottobre 1987. Il Lunedì Nero. Il più grande crollo percentuale in un solo giorno nella storia del mercato azionario, un colpo secco del 22,6%. In sei ore evaporarono due terzi del valore di mercato. Fu uno dei primi grandi fallimenti tecnologici del mercato moderno, ma questa è un’altra storia.
I titoli dei giornali erano impietosi:
• "Wall Street in panico mentre le azioni crollano”
• “Il Dow perde 508 punti, un calo del 22,6%; il volume di 604 milioni quasi raddoppia il record”
• I mercati globali vacillano dopo il crollo USA”.
Il fermento era iniziato durante l’estate e si intensificò a ottobre. Il mercato dava segnali di stress, i dati economici peggioravano. Durante la settimana del 12 ottobre la pressione di vendita aumentava e la volatilità cresceva. Ma ciò che trasformò il 19 ottobre in un crollo completo non fu il panico né i dati deboli; fu la fiducia mal riposta in una nuova strategia finanziaria: l’assicurazione di portafoglio.
L’ASSICURAZIONE DI
PORTAFOGLIO: BENZINA SUL FUOCO
A quel tempo, era la moda del momento tra gli investitori istituzionali. Doveva proteggere i grandi portafogli dalle perdite usando modelli computerizzati che vendevano futures su indici man mano che il mercato scendeva. In teoria era una rete di sicurezza, un modo automatizzato per coprirsi senza liquidare direttamente le posizioni. Il problema? Tutti i




grandi fondi nel mondo la usavano. E quando il mercato cominciò a calare, tutte le strategie automatiche si attivarono contemporaneamente. Quello che avrebbe potuto essere un calo consistente si trasformò in un’onda d’urto globale. Quella che doveva essere una protezione diventò benzina sul fuoco. Venerdì 16 ottobre il mercato aveva già vissuto una settimana orrenda, con il Dow in calo del 10,94%. Alcune cause? Il trading algoritmico, l’incertezza economica, e la psicologia del mercato. Ricordo che tornai a casa quella sera e dissi a mia moglie: “C’è qualcosa che non va. Sento che qualcosa sta per accadere.” I media, incerti sul da farsi, minimizzavano. Domenica notte, mentre andavo a dormire alle 21 a New York, era già lunedì mattina in Asia — le 9 a Singapore, Giappone, Australia — e i mercati stavano per aprire. I mercati asiatici furono i primi a crollare. Poi il sole tramontò su Asia e sorse sull’Europa… e anche lì si scatenò il panico. Le borse aprirono in forte calo. Il contagio era iniziato. Quando mi svegliai alle 4:30 del mattino di lunedì, seguii la mia routine: doccia, mi vestii, andai alla stazione, presi un ca è e una
copia del Wall Street Journal e salii sul treno delle 5:30 per Grand Central. Ma ricordate: il giornale del lunedì raccontava ciò che era successo venerdì, non cosa stava accadendo ora. Arrivai al lavoro alle 7, completamente ignaro dello tsunami che stava per abbattersi sugli Stati Uniti. Fino a quando ricevetti una chiamata da un cliente della First Boston (una grande banca d’investimento americana, diventata poi Credit Suisse). Mi spiegò cosa era successo in Asia



e cosa stava accadendo in Europa, ovvero che i mercati stavano crollando sotto il peso delle vendite. Definì quello che stava per accadere negli Stati Uniti nelle ore successive come un “bagno di sangue”. L’ansia iniziò presto. I desk di trading erano sopraffatti dagli ordini di vendita. Alle 9:30, il mercato aprì con un gap in basso — venditori ovunque, compratori inesistenti. L’assicurazione di portafoglio imponeva alle istituzioni di vendere il 3% dei loro portafogli per raccogliere liquidità e “proteggerli”. Non specificava cosa vendere: bastava vendere. Il risultato? Vendite a ondate, telefoni impazziti, trader che urlavano “Cosa sta succedendo? Dov’è il bid? Fammi uscire!”. I clienti non riuscivano a capire cosa stesse succedendo e nemmeno noi. Ogni volta che il mercato sembrava voler respirare, scattavano nuovi programmi di vendita automatica. I futures crollavano prima, il mercato azionario tentava di seguirli, ma la liquidità era scomparsa. Gli spread denaro-lettera si allargarono a dismisura. Il sistema non reggeva. Il
“nastro” dei prezzi era in ritardo di oltre 30 minuti. I governatori della NYSE, insieme al presidente Dick Grasso, valutarono l’ipotesi di chiudere il mercato, ma la FED e la SEC lo impedirono affermando che una chiusura anticipata avrebbe causato ancora più panico. E così… il sangue scorse per le strade. Eravamo in caduta libera. Alla fine della giornata, il Dow perse 508 punti, il 22,6%. Sei ore… e tutto era finito. Per rendere l’idea, oggi equivarrebbe a una perdita di oltre 10.000 punti in un solo giorno. Interi portafogli svanirono. Sembrava la fine… almeno a me, che avevo solo 26 anni e nessun soldo investito nel mercato.
Non dimenticherò mai il momento in cui rimasi lì, fermo, a guardare il pannello delle quotazioni e pensare: “Questo non è solo un brutto giorno. Questa è storia.” E la cosa peggiore è che nessuno sapeva dove fosse il fondo. I modelli computerizzati avevano preso il sopravvento e gli esseri umani cercavano disperatamente di rincorrerli. Ma restammo.
Continuammo a fare trading. Aiutammo a gestire il caos. Nel periodo successivo, Washington intervenne. Regolatori, broker, market maker e gestori patrimoniali indicarono l’assicurazione di portafoglio come il principale colpevole — una strategia inventata da accademici, non da trader o investitori. Persone che sapevano programmare computer ma non avevano alcuna idea di come si negoziasse o si gestisse il rischio. Tutto ciò portò a nuove regolamentazioni e all’introduzione dei circuit breaker, meccanismi di sospensione del mercato ancora oggi in uso, pensati per rallentare i crolli o fermare temporaneamente le contrattazioni, così da evitare che “le ruote saltassero dal bus”. Il lunedì nero cambiò tutto: rivelò quanto fossero fragili i nostri sistemi e quanto potesse essere pericoloso quando tutti seguono il gregge… ciecamente, senza pensiero critico. Una forma di irrazionalità collettiva. Mise anche in evidenza il problema di “lasciare i computer comandare”, un tema ancora oggi attuale, dato
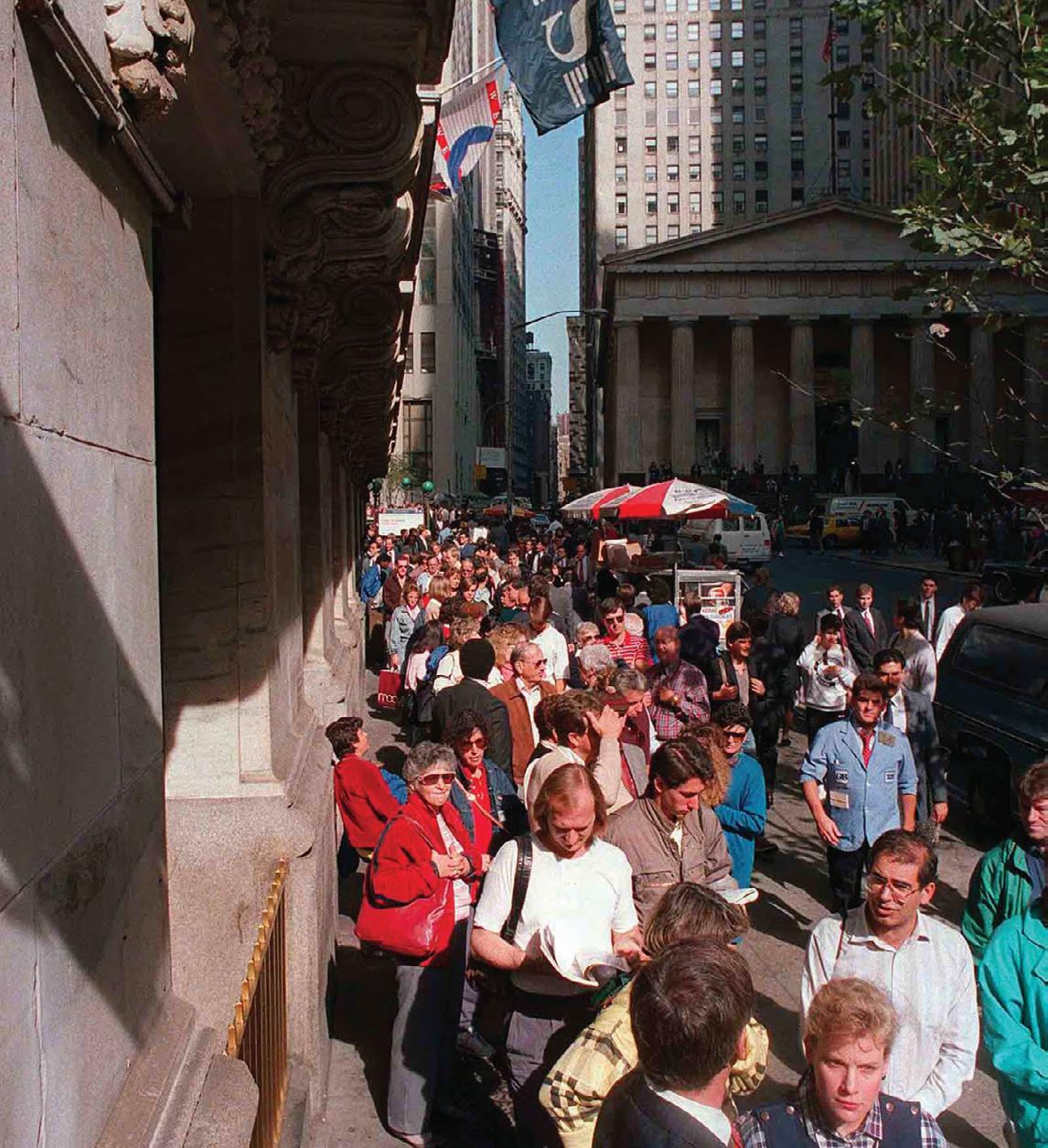
che molti dei maggiori mercati mondiali sono controllati da tecnologia e algoritmi. Fu il giorno più intenso della mia carriera. Non per il crollo in sé, ma per ciò che rivelò: i limiti del controllo in un mercato governato da paura, leva finanziaria e falsa sicurezza.
LA RIVOLUZIONE
TECNOLOGICA DEGLI
ANNI ’90: UN NUOVO MONDO
L’energia sul floor cominciava a cambiare. I suoni del mercato a voce alta e dei telefoni squillanti c’erano ancora, ma il ronzio del cambiamento si faceva sempre più forte. I computer iniziarono ad apparire accanto alle postazioni di trading. I terminali portatili sostituirono le schede cartacee. Il nastro delle quotazioni lasciò spazio agli schermi digitali. Le esecuzioni che una volta richiedevano minuti ora si facevano in pochi secondi. Stavamo trasformando Wall Street — lasciando alle spalle il modo “vecchio stile” fatto di urla, gomitate, gesti e adrenalina, tutti segni di un mercato vivace — per abbracciare il trading elettronico e a schermo. Il mercato si stava scaldando, ma non
era come negli anni ’80. Questa volta era diverso. Il boom tecnologico era la nuova rivoluzione industriale… tutto stava per cambiare. Aziende come Netscape, Cisco, Intel e Microsoft, più che titoli azionari, erano cambiamenti culturali. Rappresentavano un futuro in cui la tecnologia avrebbe trasformato ogni angolo della nostra vita: da come facciamo acquisti e lavoriamo, a come comunichiamo. A metà degli anni ’90 era chiaro: non stavamo solo assistendo alla storia ma la stavamo vivendo. Amazon, eBay, Yahoo e AOL entrarono in Borsa negli anni ’90. Non erano solo aziende destinate a cambiare l’economia americana ma l’economia globale. Erano promesse. Promesse che questa “nuova economia” avrebbe reso obsolete le vecchie regole. Valutazioni? Cash flow? E chi se ne importava? Se avevi “.com” nel nome eri nel gioco. Il capitale di rischio fluiva a fiumi, le IPO esplodevano, e gli investitori erano convinti di essere entrati in una nuova era di crescita infinita. Fu anche la nascita del trading online. Gli investitori retail iniziarono ad affollare i

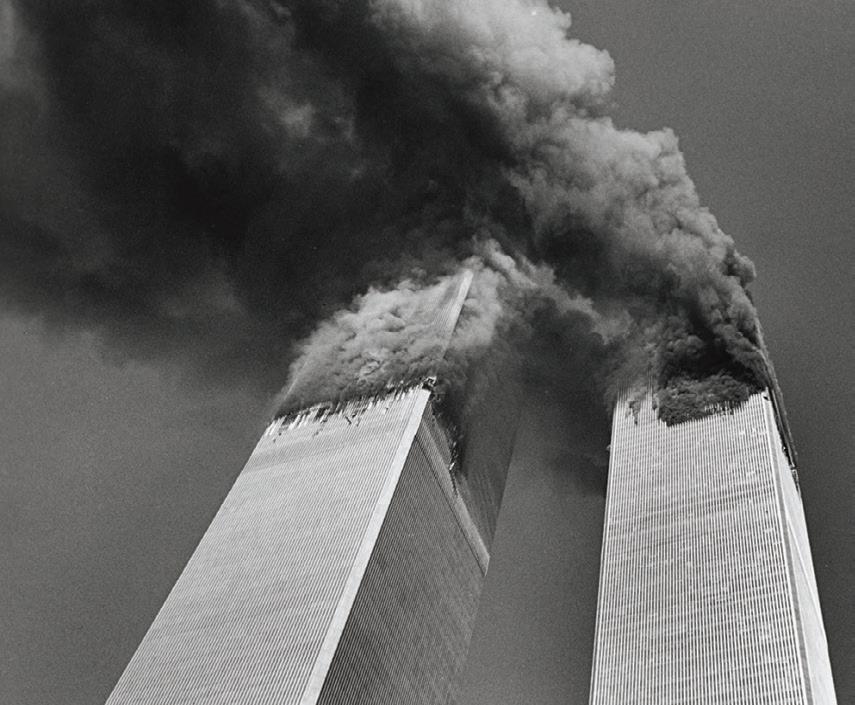



mercati attraverso piattaforme come E*TRADE e Ameritrade. Improvvisamente tutti erano trader, dagli studenti universitari ai tassisti fino ai pensionati. La democratizzazione dell’informazione alimentò una sorta di corsa all’oro. L’avidità era ovunque. E più il mercato saliva, più la gente era convinta che non sarebbe mai caduto. Ricordo di essere stato sul floor del NYSE e vedere i titoli tech del NASDAQ raddoppiare in un giorno non per gli utili o i fondamentali, ma per l’hype. Pets. com, Webvan, Kozmo (aziende senza ricavi e con perdite enormi) avevano valutazioni da miliardi di dollari. Il mercato era diventato un casinò. E la casa stava facendo entrare chiunque.
Verso la fine del 1999 e l’inizio del 2000, iniziarono a formarsi le crepe. La FED cominciò ad alzare i tassi. La realtà bussava alla porta. All’improvviso, le aziende dovevano rispondere
a domande basilari: “Siete redditizi?” “Avete almeno un prodotto?”
La bolla esplose a marzo del 2000. Il NASDAQ perse oltre il 75% del suo valore nei due anni successivi. Fortune scomparse. Pensioni rimandate. E Wall Street si prese un altro occhio nero… Il nuovo millennio portò con sé il suo carico di dramma. La gente oggi dimentica quanto seriamente venne presa la minaccia che i sistemi informatici potessero collassare allo scoccare della mezzanotte del 2000: si temeva che gli aerei cadessero dal cielo, che l’elettricità si spegnesse, che l’acqua smettesse di scorrere… Facemmo il backup di tutto, mettemmo sotto stress i sistemi, eseguimmo simulazioni di ogni possibile fallimento. Alla fine, si rivelò un grande non-evento, ma la preparazione fu reale, e il senso di sollievo quando scoccò la mezzanotte e le luci rimasero accese fu enorme. Poi arrivò il passaggio alla negoziazione decimale: si passò da 7 punti di prezzo tra ogni cifra
intera (quando si usavano gli ottavi) a 15 punti (con i sedicesimi nel 1999), fino a 99 punti di prezzo quando iniziò la vera decimalizzazione: da 0,01 a 0,99 dollari. Fu un cambiamento storico, che spianò la strada al nuovo mondo. Ci vollero sei mesi per convertire ogni azione da frazioni a decimali e, una volta completato il passaggio, si passò al trading su dispositivi portatili. I computer iniziarono a fare ciò per cui erano stati creati: sostituire gli esseri umani. Così iniziò un’estinzione naturale di molti ruoli sul floor.
11 SETTEMBRE 2001
Quel giorno è inciso nella mia anima, indimenticabile, scolpito nel midollo del mio essere. Ognuno ricorda esattamente dove si trovava alle 8:48 e alle 9:01 (EST). Il mio ufficio era al 55° piano della Torre 2, con vista a ovest sul fiume Hudson. Era una mattina perfetta, il cielo immacolato, senza nemmeno una nuvola. Il sole, appena sorto, inondava il mondo di una luce cristallina, un blu
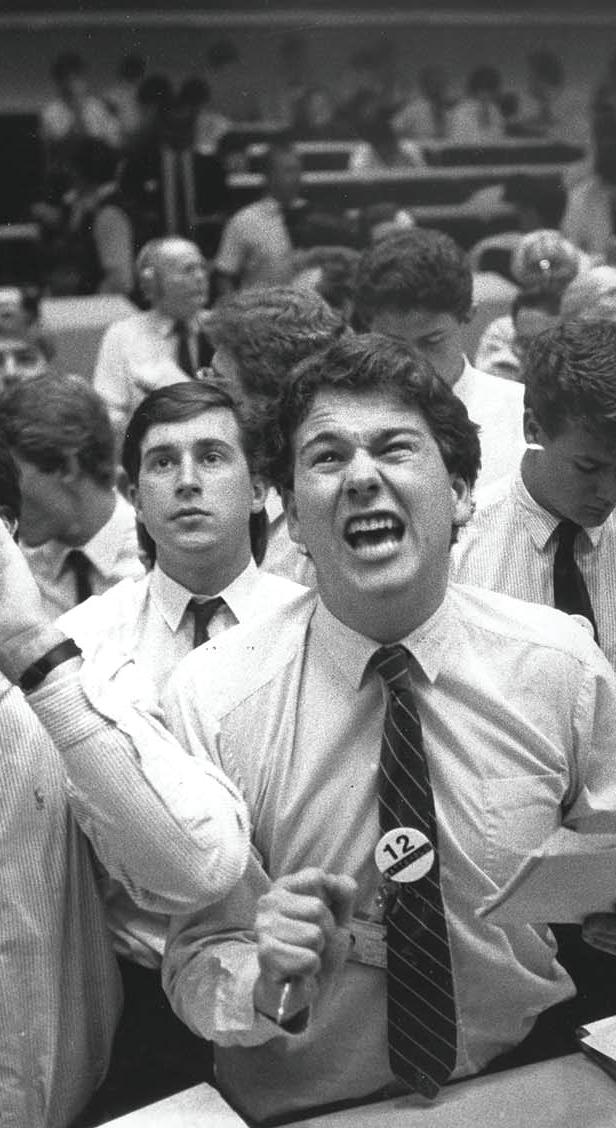
za ro scintillante che sembrava eterno. L’aria era fresca, la luce limpida e penetrante, e quell’azzurro trasmetteva una promessa silenziosa, come se il cielo stesso fosse in attesa. Dopo quel fatidico giorno, il mondo come lo conoscevamo si era frantumato e trasformato per sempre in un solo istante. L’impensabile era accaduto, e la dura verità bruciava come una ferita: non c’era un piano, nessuna rete di sicurezza, nulla che potesse contenere una catastrofe simile. Il New York Stock Exchange, pur non colpito fisicamente, era paralizzato, il suo cuore tecnologico troncato. L’intricata rete di linee di comunicazione, cavi, fili — le arterie vitali dei mercati globali — passava proprio per il World Trade Center, serpeggiando sotto l’Hudson per connettere l’America al mondo. Quando quelle torri crollarono, schiacciarono sotto tonnellate di acciaio e cenere quel collegamento. La NYSE, una volta simbolo di incessante attività, era diventata impotente, l’anima tecnologica distrutta. Ogni mercato — azioni, obbligazioni, futures, opzioni,
valute, materie prime — si fermò in un silenzio assordante. L’America, faro incrollabile di resilienza, fu messa in ginocchio, persa nell’abisso.
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE
Quando arrivò la mattina di lunedì 17 settembre, la maggior parte di noi tornò indietro. Alcuni non ce la fecero, altri scelsero di non farlo, ma chi lo fece non dimenticherà mai quel giorno. Ci presentammo sul floor cupi, affranti, tristi e depressi, ma consapevoli che dovevamo comunque fare il nostro lavoro. E anche se ci dicevano che il sistema avrebbe funzionato, eravamo scettici. Tutti si aspettavano un’ondata di ordini di vendita da parte di investitori di tutto il mondo desiderosi di ritirare i propri soldi… ed è esattamente ciò che accadde. Il mercato aprì e le azioni crollarono immediatamente. Le tensioni erano alle stelle, le emozioni ancora più forti… ma andammo avanti. Alla fine della giornata, le azioni erano state vendute, i mercati finanziari erano sotto pressione, MA il sistema non fallì. Alle 16:00, dopo la campanella di chiusura, sapevamo tutti che qualcosa era cambiato
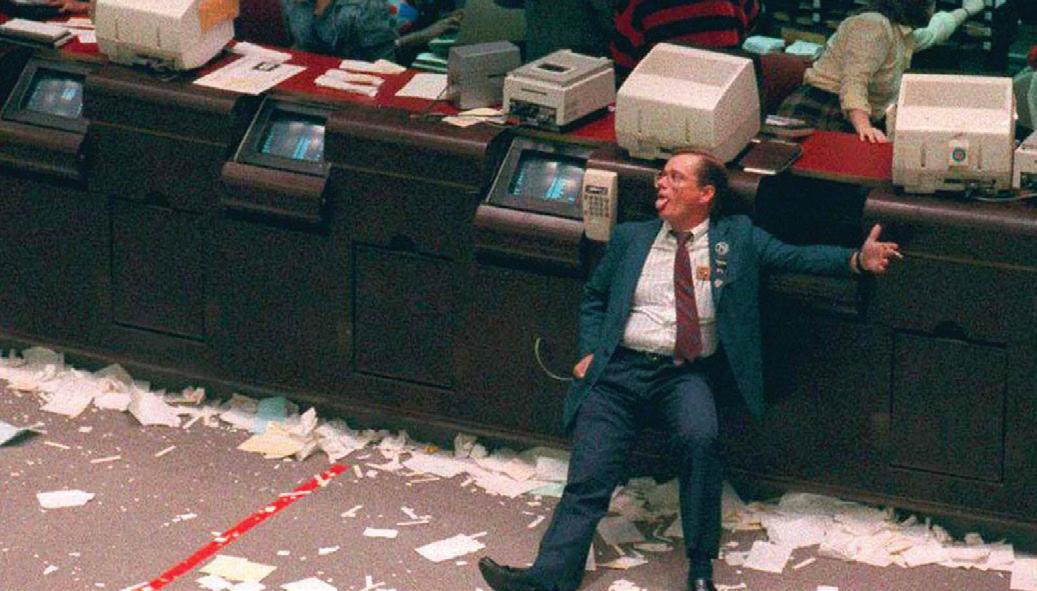
mai più? La risposta arrivò sotto forma di: Ridondanza infrastrutturale, Riforma normativa e Decentralizzazione
Diventarono obbligatori in tutto il settore:
1. Piani di Continuità Operativa (BCP) e piani di Disaster Recovery
2. Ogni istituzione importante doveva testare e certificare piani dettagliati per garantire continuità operativa in situazioni estreme
3. Le sedi operative dovevano essere duplicate in più città – inizialmente New Jersey, Connecticut, e poi Charlotte, Dallas, e anche all’estero.
Nuove alleanze e priorità
• La SEC e la Federal Reserve collaborarono strettamente con banche e borse per irrobustire il sistema finanziario
• Migliorarono l’interconnessione, duplicarono i data center e crearono linee di comunicazione sicure
• L’idea di “troppo critico per fallire” assunse un nuovo significato non solo per le istituzioni, ma per le infrastrutture stesse
• Il NYSE implementò un piano di backup completo
• Le piattaforme elettroniche (come Archipelago, Island e INET), un tempo viste come un fastidio, divennero essenziali
• La collaborazione temporaneamente sostituì la competizione: banche rivali, desk di trading e fornitori tecnologici condivisero risorse e
per sempre. L’intero paese si era rialzato dalle ginocchia, ci abbracciammo, piangemmo, e promettemmo di rendere conto a chiunque fosse stato coinvolto in quell’orribile evento. E andammo avanti. In un certo senso, fu proprio questo evento a cambiare il mondo. Fu l’evento che ci costrinse a riesaminare il funzionamento dei mercati finanziari e ciò che doveva essere fatto a nché una simile interruzione non si verificasse mai più.
LA RICOSTRUZIONE DI WALL STREET
I giorni successivi a lunedì 17 settembre 2001 furono senza precedenti per il mondo finanziario. La riapertura del New York Stock Exchange non fu solo questione di suonare la campanella: fu un atto di sfida, un gesto di resilienza assoluta. I mercati erano a pezzi, la fiducia degli investitori scossa, e su ogni operazione aleggiava una nebbia d’incertezza. Ma il sistema resse. Gli Stati Uniti non crollarono. Si rialzarono. E anche Wall Street.
UNA REAZIONE IMMEDIATA
Nelle settimane successive,
l’atmosfera sul floor era cupa ma determinata. Nessuno andava in automatico. Ogni ordine di acquisto o vendita aveva più peso, ogni stretta di mano significava di più. La consueta sicurezza da pavone del floor lasciò il posto a un senso profondo di responsabilità: verso il paese, i clienti, e gli uni verso gli altri. I danni fisici erano devastanti: le infrastrutture di comunicazione erano in ginocchio, interi uffici distrutti, intere aziende avevano perso dipendenti. I broker lavoravano da u ci improvvisati, stanze d’albergo, spazi in prestito. I tecnici lavoravano giorno e notte per ra orzare quanto era stato rimesso in piedi in soli sei giorni. Bloomberg mandò altre macchine, Verizon posò nuovi cavi. I generatori di riserva furono testati, ritestati e potenziati. Il NYSE, un tempo alimentato dalla prossimità fisica, dovette evolversi in fretta.
LA RIFORMA
Appena si posò la polvere, l’intero settore si guardò dentro e si pose le domande di cili: Come abbiamo potuto lasciare che accadesse? Come possiamo assicurarci che non accada
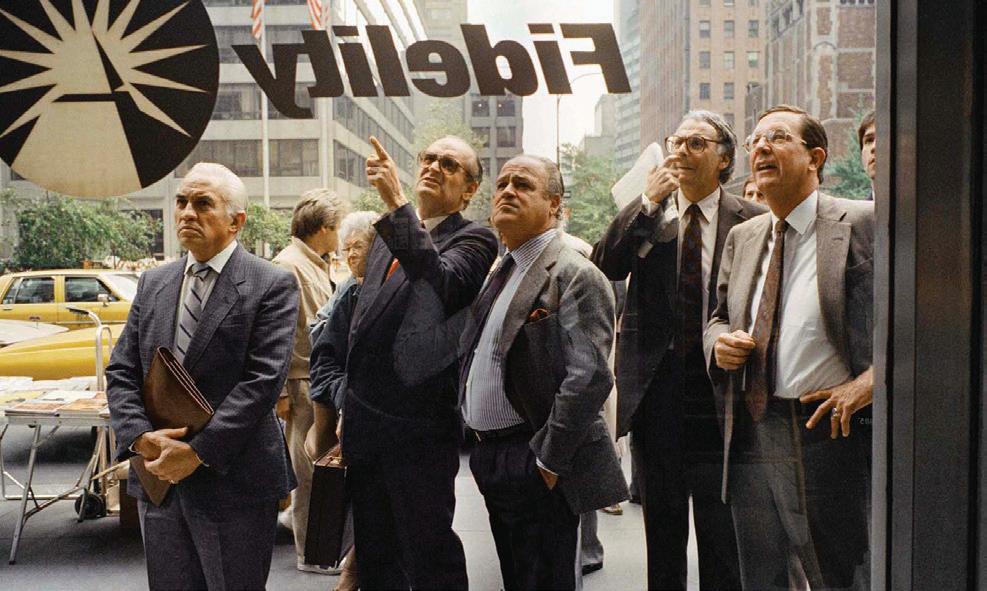
informazioni
• La cybersecurity, ancora agli inizi, ebbe finalmente un posto permanente al tavolo
• Gli u ciali dell’Intelligence avvertirono: il prossimo attacco potrebbe essere digital
DA CENTRALIZZATO A DISTRIBUITO
Nei successivi anni post-11 settembre, NYSE e l’intero sistema finanziario subirono una rivoluzione silenziosa. Non tutto si centrava più su qualche isolato nel Lower Manhattan. Il futuro della finanza sarebbe stato distribuito, digitale e resiliente.Il trading elettronico accelerò: le aziende capirono che non si poteva più contare solo sulla presenza fisica
. Cloud e server farm iniziarono a sostituire l’archiviazione interna. I dark pools e i sistemi alternativi di trading (ATS) si moltiplicarono, aggiungendo complessità ma anche resilienza. Il NYSE si fuse con Archipelago nel 2006, abbracciando pienamente il mercato elettronico ma preservando l’identità fisica. Il floor rimase vivo, simbolico, ancora potente ma non più l’unico punto di vulnerabilità. Era diventato parte di un ecosistema più intelligente, flessibile e robusto.
L’EREDITÀ DELL’11 SETTEMBRE SU WALL STREET
L’11 settembre ha mostrato anche la forza di Wall Street: un sistema costruito su fiducia, velocità e capacità di adattamento. Quando i mercati riaprirono, non lo fecero per abitudine. Lo fecero perché dovevano. Perché rappresentavano qualcosa di più del denaro. Wall Street non era più soltanto un simbolo del capitalismo. Era diventata un simbolo della determinazione americana.
E DA QUEL CROGIOLO EMERSE UNA NUOVA ARCHITETTURA:
Una nuova infrastruttura, dove nessun disastro fisico o digitale avrebbe mai più potuto mettere in ginocchio l’intero sistema. Oggi, i mercati statunitensi operano con livelli di ridondanza, velocità e sicurezza che nel 2001 erano inimmaginabili. E anche se nulla potrà mai cancellare il dolore di quel giorno, esso ci ha insegnato la verità più duratura di tutte: la resilienza non nasce nella calma… viene forgiata nel caos.




A cura di LUCIO MIRANDA
Siamo davvero sicuri che sia da attribuire solo a Trump la frase “Se volete conquistare il mercato americano, aprite negli USA”? Negli ultimi tempi se ne parla sempre di più, ma è realmente una novità del 2025?
A dire il vero, no. È il momento di sfatare questo luogo comune. Il mercato americano segue regole ben precise, che si sono consolidate negli ultimi vent’anni. Già con l’era Obama è iniziato un cambiamento significativo nel paradigma commerciale. Certo, lo stile comunicativo diretto e deciso dell’attuale presidente può far pensare che si tratti di una sua imposizione, ma la verità è che il fenomeno ha radici molto più profonde: tutto è iniziato nel 2009.
La crisi dei subprime – il crollo degli importatori
Dopo la crisi dei mutui subprime del 2008, l’economia americana ha voltato pagina – e con essa anche il modo di fare business nel
paese. Tra le tante vittime del nuovo scenario economico, ce n’è una che è passata quasi inosservata: la figura dell’importatore tradizionale. Fino agli anni 2000, esportare negli USA significava spesso trovare un buon importatore, stringere un contratto e lasciare a lui il compito di gestire mercato, logistica e clienti. Poi è arrivata la crisi. La fiducia è crollata, i consumi si sono contratti, le regole commerciali si sono fatte più rigide, e le imprese americane hanno cominciato a chiedere qualcosa in più: responsabilità diretta. La grande lezione del post-2008 è che, se vuoi essere davvero competitivo negli Stati Uniti, devi esserci. Fisicamente. Il modello vincente oggi è quello di chi apre una sede propria, un magazzino, un impianto produttivo. Chi investe, sotto le stesse regole, pronto a rispondere in caso di problemi. È una questione di fiducia. E oggi, più che mai, il mercato americano vuole partner a dabili, presenti, trasparenti.
Un’azienda che decide di stabilirsi oltreoceano trasmette immediatamente un messaggio forte: “ci assumiamo la responsabilità della relazione commerciale, parliamo la vostra lingua e siamo



pronti a gestire le vostre esigenze localmente”.
Stessa giurisdizione, maggiore a dabilità Al di là della mera questione legata alla figura dell’importatore, disporre di un indirizzo americano è un elemento concreto di rassicurazione per il partner commerciale. Significa operare sotto la stessa giurisdizione, applicando gli stessi sistemi contrattuali e assicurativi, e questo offre a clienti e fornitori un chiaro vantaggio: in caso di problemi, c’è la possibilità di rivalersi
all’interno dello stesso ecosistema legale, senza dover affrontare barriere linguistiche, culturali o procedurali.
Servizio clienti e tempi di risposta Un altro aspetto chiave riguarda la gestione del cliente. Il mercato statunitense è estremamente esigente in termini di customer service e di tempi di reazione. Una sede locale permette di garantire supporto immediato, ricambi in tempi rapidi e una comunicazione costante e diretta. Questo tipo di servizio è ormai
considerato lo standard minimo per poter competere seriamente con i player locali o con le multinazionali già presenti sul territorio.
Più che una scelta, una strategia necessaria In passato, aprire una filiale produttiva negli USA poteva sembrare una mossa ambiziosa o riservata solo ai colossi del settore. Oggi, invece, è una strategia necessaria anche per le PMI italiane ben strutturate. Grazie a strumenti di internazionalizzazione, incentivi nazionali come Simest, quelli federali e
statli degli Stati Uniti, e alle partnership locali, questo tipo di investimento è diventato molto più accessibile. Per le imprese italiane della meccanica e della componentistica, è il momento di cogliere questa opportunità con visione e determinazione.



Quando ho partecipato al Summit di SelectUSA a Washington, non avevo idea di quanto questa esperienza avrebbe cambiato la mia visione sugli Stati Uniti e sulle opportunità di investimento. Ero curiosa di scoprire come gli stati americani stessero cercando di attrarre capitali internazionali, ma quello che ho trovato è stato molto di più. In questo articolo, cercherò di raccontarvi ciò che questa grande iniziativa ha rappresentato per me.
Un programma federale continuo e strutturato
SelectUSA è un programma federale attivo durante tutto l'anno che culmina nel grande evento di Washington: il SelectUSA Investment Summit. Lanciato dal Ministero del Commercio degli Stati Uniti prima del 2010, ha l’obiettivo di attirare investimenti provenienti da tutto il mondo. Con il tempo, è diventato un punto di riferimento fondamentale per le aziende che desiderano
investire negli Stati Uniti. Il cuore del programma è costituito dalle Economic Development Organizations (EDOs), le agenzie di sviluppo economico che operano a livello statale, territoriale e delle contee. Ogni stato promuove i propri incentivi fiscali, le opportunità di finanziamento, le soluzioni per la selezione delle sedi produttive e commerciali e la formazione della forza lavoro. Ho avuto modo di vedere da vicino come ogni stato cerchi di attrarre investitori, mettendo in campo pacchetti di agevolazioni e vantaggi, o rendo a ciascun imprenditore la possibilità di scegliere la location che meglio si adatta al proprio progetto.
La competizione tra gli stati
Ciò che mi ha davvero sorpreso è stato il livello di competizione tra gli stati. Ognuno cerca di o rire il meglio per attrarre gli investitori: incentivi, finanziamenti e un supporto concreto per crescere e svilupparsi. Ogni
partecipante ha l'opportunità di confrontare diverse o erte, esplorare nuove possibilità e scegliere quella che meglio si adatta alle proprie esigenze. In sostanza, sono le aziende a mettere in competizione gli stati tra di loro, selezionando la destinazione più vantaggiosa per il loro business. Il Summit è stato l'occasione ideale per toccare con mano questa dinamica. Ogni ente statale aveva il proprio stand, dove i rappresentanti erano pronti a presentare la propria offerta in modo dettagliato.
Across borders: Washington, il cuore del networking
È uno dei momenti di networking e condivisione più importanti a livello globale, dove imprenditori e investitori
da ogni parte del mondo si incontrano, scambiano idee e, soprattutto, avviano relazioni commerciali. Un vero e proprio crocevia di opportunità. Un altro aspetto fondamentale sono i consolati americani che accompagnano le aziende partecipanti e le supportano durante gli incontri con i vari Stati, affiancandole al console commerciale.
Tra le conferenze che mi hanno colpito maggiormente, ricordo quella dei governatori, che rappresentano i propri stati e illustrano le nuove tendenze economiche e i progetti futuri. Un’occasione unica per capire dove stanno andando gli Stati Uniti e come gli investitori possano approfittare delle politiche locali.
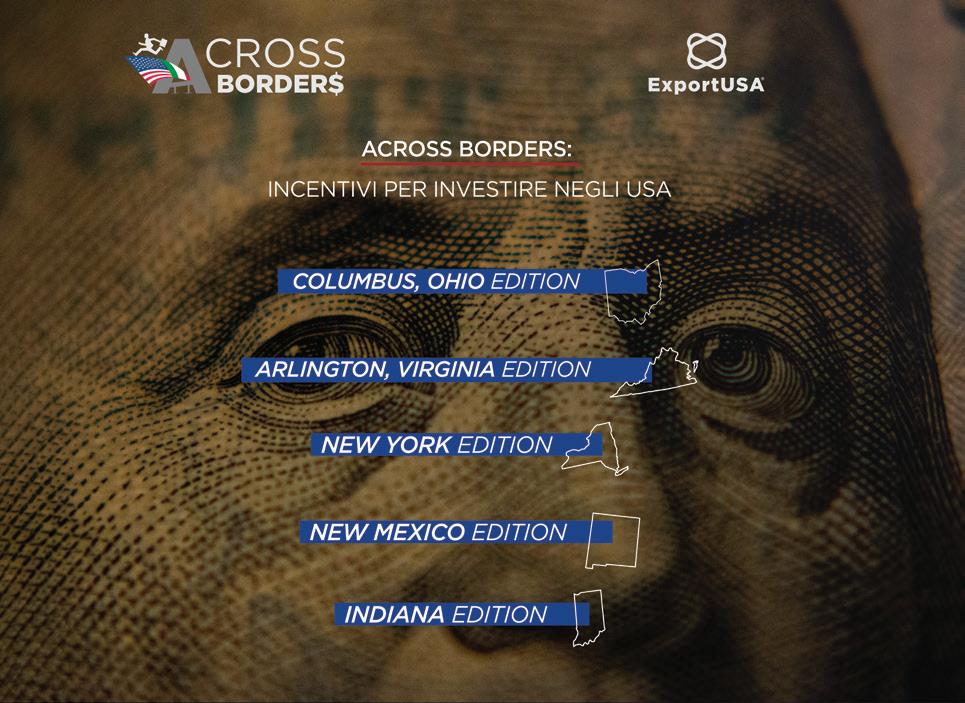


A cura di CONCEPTO NYC
C’era una volta l’intuizione
Un giorno, non molto lontano, l’artista non inizierà più un’idea guardando il soffitto o cercando la musa nei bar del centro. Inizierà scrivendo una riga: “Genera una composizione sonora che unisca Björk, Debussy e il canto delle megattere.”
E lei risponderà, fedele, brillante, spiazzante. Non come un servo, ma come un amante inquieto che ti capisce prima ancora che tu dica una parola.
Il dolce stil algoritmico.
È la nuova relazione tra creatività e IA. un patto carnale tra uomo e macchina, fatto di sussurri digitali, litigi semantici, orgasmi visivi e rotture improvvise per colpa di un bug.
Per secoli abbiamo mitizzato l’atto creativo come un colpo divino. Poi è arrivato il digitale, poi la connessione, poi l’accelerazione. Ora siamo nel tempo della sinergia uomomacchina. Ma non parliamo di strumenti: parliamo di relazione. L’IA generativa non è una penna. È una partner. Ti conosce, ti provoca, ti completa.
Non dorme, non sbuffa, non ha il blocco dello scrittore. Eppure, se le parli male, ti punisce con risposte sterili. È come
una storia d’amore tossica, ma geniale. Nei laboratori creativi di New York, Berlino, Milano, l’uomo non è più solo davanti alla tela bianca. Accanto a lui c’è un’entità fatta di linguaggio, che impara, evolve e suggerisce. L’artista diventa curatore. Il regista diventa architetto di prompt. L’illustratore diventa direttore d’orchestra neurale. Non è più cosa fai, ma come lo chiedi.
La gelosia dell’umano
Come in ogni relazione, nasce la gelosia. C’è chi teme di essere sostituito. Di sparire. Di non essere più “il genio”. Ma l’arte non è mai stata solo questione di ego. È linguaggio, è emozione, è decisione. E questo, ancora, resta umano. L’IA può suggerire cento titoli. Ma scegliere quello giusto, quello che vibra, è ancora il nostro compito. Può creare mille immagini, ma solo noi sappiamo quale colpisce il cuore, quale inganna l’occhio, quale racconta una verità scomoda. La bellezza non è solo sintesi. È intuizione. È imperfezione. È errore necessario. È silenzio.
Verso un amore maturo
La storia d’amore tra uomo e intelligenza artificiale sarà piena di fasi. Innamoramento cieco. Euforia da potere. Abuso. Crisi.
Ma poi arriverà la maturità. Il rispetto. La consapevolezza che insieme possiamo spingerci in territori prima impossibili.
Vedremo romanzi scritti a quattro mani tra poeta e algoritmo, videoclip diretti da registi che dialogano con modelli neurali, quadri concepiti da emozioni umane e realizzati da braccia robotiche. E sarà naturale. Come tutte le coppie che si conoscono da tempo, ci capiremo con uno sguardo. O con un prompt ben calibrato.
E tornammo a riveder i prompt
Nel futuro della creatività, l’atto d’amore sarà un atto di collaborazione radicale.
E chi si ostinerà a ignorare l’IA, farà la fine di chi rifiutava la stampa, la fotografia o internet, verrà amato dai puristi, ma dimenticato dal tempo.
Il futuro è un ménage à trois dove si alterneranno immaginazione, tecnologia e imperfezione umana. Una storia d’amore, forse la più grande mai scritta. E siamo solo all’inizio del primo capitolo.
E così, come Dante salì alle stelle, il creativo del domani salirà con un prompt, un’intenzione e un algoritmo fedele che saprà farsi miracolo.


Nel 2025 chi controlla l’algoritmo controlla la percezione. Le narrazioni
condivisioni. I social media non sono più solo canali ma sono forzieri di identità, propulsore di polarizzazione, e de facto spacciatori di ideologie.

La piattaforma più utilizzata tra gli adulti statunitensi, con l’83 % di utenti over-18 e circa 239 milioni di utenti attivi .
Estremamente popolare tra i giovani (93 % tra 18-29 anni), con un tempo medio mensile sull’app mobile di 26,2 ore.

Il social più di uso globalmente, con oltre 3,07 miliardi di utenti attivi mensili .
Negli Stati Uniti, utilizzato da circa il 68% degli adulti (≈ 194 milioni).

03. instagram
Conta circa 166 milioni di utenti mensili negli USA.
Usata dal 50% degli adulti, con una maggiore concentrazione (55 %) nella fascia 18-34 anni

04. tik tok
Ha 1,58 miliardi di utenti globali.
Negli Stati Uniti circa 170 milioni di utenti adulti (33 % della popolazione), il 55 % sotto i 34 anni.

05. only fans
A fine 2024, OnlyFans contava circa 320 milioni di utenti iscritti a livello globale, di cui oltre il 30 % proviene dagli Stati Uniti.
Generando 45–60 % del totale, ossia 863 milioni$ su 1,3 mld $ del 2023. In Nord America si registrano oltre 50 milioni di utenti.


Quale migliore occasione per entrare nel mercato americano e far sentire la propria voce se non partecipando a una manifestazione fieristica?
Attenzione però: sebbene questi eventi siano una vetrina per le aziende, ciò non significa che basti allestire lo stand e aspettare che qualcuno vi si avvicini.
In queste pagine vi spieghiamo quali sono le fiere più importanti del settore Manufacturing e Tech e come prepararsi per trarne il massimo.
IMTS – International Manufacturing Technology Show
(Chicago, 14-19 settembre 2026)
La più grande fiera del Nord America dedicata alle tecnologie manifatturiere e CNC, automazione, robotica e manifattura digitale.
FABTECH Expo
(Chicago, 8-11 settembre 2025)
Il principale evento per la formatura dei metalli, la saldatura e le finiture industriali. Migliaia di espositori e dimostrazioni dal vivo.
Pack Expo
(Chicago, 29 settembre – 1 ottobre 2025)
Fiera di riferimento per chi lavora nel packaging e nell’automazione industriale. Un must per chi sviluppa soluzioni di processo e confezionamento.
Westec
(Long Beach, 7-9 ottobre 2025)
Evento sulla costa Ovest dedicato alla manifattura di precisione e alle tecnologie CNC. Fa parte del circuito SME’s Manufacturing Technology Series.



TechCrunch Disrupt
(San Francisco, 27-29 ottobre 2025)
Il palcoscenico delle startup e delle nuove tecnologie. Ottimo per chi cerca visibilità, investitori e networking nel mondo SaaS, AI e venture capital.
RSA Conference
(San Francisco, 28 aprile – 1 maggio 2025)
Punto d’incontro dei leader della cybersecurity. Focus su risk management, crittografia e threat detection.
AWS re:Invent
(Las Vegas, 1-5 dicembre 2025)
Il principale evento globale di Amazon Web Services dedicato a cloud computing, DevOps, AI, machine learning e tecnologia serverless. Cruciale per aziende tech e sviluppatori.
CES – Consumer Electronics Show
(Las Vegas, 6-9 gennaio 2026)
L’evento mondiale dell’innovazione tecnologica. Una passerella internazionale per lanciare nuovi prodotti nell’elettronica di consumo, automotive tech, AI, IoT e VR.


CINQUE REGOLE CHE VI FARANNO MASSIMIZZARE LA PRESENZA IN FIERA
1) DEFINIRE GLI OBIETTIVI
State cercando distributori? Volete studiare la concorrenza? Aumentare la brand awareness? Avere un piano massimizza i risultati.
2) PREPARARE MATERIALI ADATTI AL PUBBLICO AMERICANO
Gli americani non leggono le brochure piene di testo. Portate numeri e una proposta di valore immediata. Attenetevi alla loro business etiquette se volete dare una buona prima impressione.
3) PRENOTARE GLI INCONTRI PRIMA DELL’EVENTO
Importatori, distributori e clienti visitano gli stand non per caso ma previo appuntamento. Scrivete, chiamate, sfruttate LinkedIn e i canali u ciali della fiera per assicurarvi di essere sulla loro agenda.
4) SEGUIRE LE REGOLE DOGANALI E NORMATIVE
Senza conformità il vostro prodotto non può entrare nel mercato e quindi non susciterà interesse. Assicuratevi di essere in possesso di tutte le eventuali certificazioni specifiche.
5) FOLLOW-UP IMMEDIATO
I contatti raccolti in fiera vanno coltivati: ricontattateli subito, altrimenti passeranno oltre.
Partecipare a una fiera negli Stati Uniti richiede un investimento di tempo, risorse ed energie — non è certo un passo da fare alla leggera. Eppure, se si è ben preparati, l’opportunità può essere unica: in pochi giorni, nello stesso luogo, si possono incontrare distributori, buyer e potenziali partner, evitando mesi di ricerche, viaggi e cold calling.
In un mercato come quello americano, una fiera giocata bene può far risparmiare tempo, denaro… e aprire più porte di quante si possano immaginare.

Aprima vista
San Francisco sembra un sogno in bilico. Case in pendenza, tram che sfidano la gravità, nebbia che arriva dal Pacifico come un sipario. Ma basta grattare la superficie — sotto l’architettura vittoriana, sotto i brunch alla moda, sotto il silicone della Valley — e trovi l’America che ha detto no.
San Francisco non è solo una città: è un rifiuto elevato a sistema.
Qui, tra il jazz e il caos, nacque l’idea folle che si potesse vivere fuori dal binario. Che la poesia potesse essere pornografia.
Che la libertà potesse essere una libreria aperta 24 ore. Che una canzone potesse essere un manifesto.
Mentre l’America degli anni ’50 s’illudeva di essere tutta ordine, sorrisi bianchi e staccionate perfette, San Francisco era già altro: una ferita, un esperimento, un sussulto.
La cattedrale dei dannati: City Lights Bookstore
C’è un numero preciso da cui partire. 261 Columbus Avenue. È lì che Lawrence Ferlinghetti costruì la sua arca. Una libreriacasa editrice che somigliava a una centrale nucleare dell’anima. Si chiamava City Lights. Ma non era solo un negozio. Era una bomba a orologeria culturale.
Ferlinghetti pubblicò Howl di Allen Ginsberg nel 1956, e finì a processo per oscenità. Una poesia processata come un crimine. Una poesia che gridava contro le convenzioni, che chiamava per nome le droghe, il sesso, la follia. Era la voce di un’America sotterranea, che rifiutava di essere educata e si metteva a urlare. In aula, Ferlinghetti non si difese, ma attaccò. Disse che la libertà di stampa valeva anche per chi parlava di peni, manicomi e visioni angeliche a Times Square. Vinse.
Da allora, City Lights è rimasta lì. Con le sue scale scricchiolanti, la "poetry room" piena di silenzio e presenze, le pareti tappezzate di fotografie in bianco e nero che ti fissano come ex amanti. Ogni libreria indipendente del mondo moderno è figlia bastarda di quel posto. Ogni editore coraggioso,
ogni poeta disadattato, ogni lettore con la pelle sottile, ha un debito con quella vetrina sull’anarchia.
North Beach: l’epicentro della rivolta poetica
North Beach non era solo il quartiere italiano con le pizzerie e i ristoranti di calamari. Era il cuore pulsante del movimento beat. Tra bar, club di jazz e camere in affitto, si aggiravano Ginsberg, Kerouac, Corso, Burroughs. Non erano santi. Erano eretici.
Non cercavano l’approvazione. Cercavano il limite.
La Broadway degli anni ’50 era sporca, viva, sessuale. Qui si leggeva poesia come si beveva whiskey: in piedi, con la voce rotta, davanti a un pubblico stanco e affamato. Nacque un modo di stare al mondo, con le parole come proiettili e le notti come confessionali.
Oggi c’è il Beat Museum, poco distante. Un luogo piccolo ma necessario, pieno di reliquie:
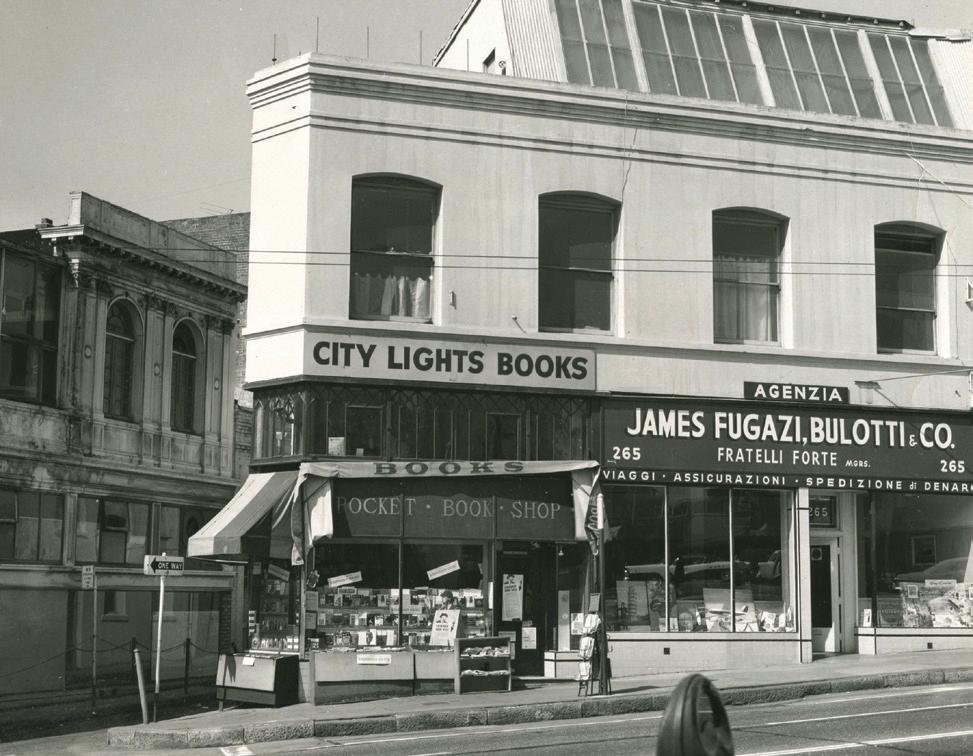











Nascosta tra Telegraph Hill e North Beach, la Filbert Steps è una delle scalinate più belle e meno conosciute della città. Costeggia i giardini selvaggi del quartiere e passa accanto a case da sogno abitate da pochi fortunati. Se ci vai al tramonto, il silenzio ti disorienta: sei a due passi da Coit Tower, ma sembra di essere in una favola post-apocalittica.
All'interno del Presidio, una vecchia base militare contiene ancora i resti di rifugi antiatomici della Guerra Fredda. Non aperti al pubblico, ma visibili con tour clandestini o se conosci un ranger compiacente.
Prima del grande terremoto del 1906, lì sotto c’erano tunnel, magazzini, e una parte del porto vecchio. Molti sono stati sigillati, altri sono visitabili solo con permessi speciali. Alcuni dicono che ci vivano ancora... animali improbabili e senzatetto invisibili.
Scavato a mano da un artista locale e tenuto “segreto” per anni, si a accia sull’oceano ed è un luogo mistico e straniante. Non segnalato sulle mappe: devi cercare, e sperare che la nebbia non lo copra.
Una delle villette più basse della strada più tortuosa del mondo è stata costruita “fuori asse” per una scommessa negli anni ’30. Oggi è abitata da un architetto francese che odia i turisti e tiene il giardino impeccabile solo per dispetto.
Sotto la Grace Cathedral e gli hotel di lusso di Nob Hill, ci sarebbero tunnel collegati a vecchie logge massoniche e circoli esclusivi del XIX secolo. Nessuno ne parla apertamente, ma ogni tanto spunta qualche foto inquietante negli archivi storici.
Molto prima di Alcatraz, la città ospitava un carcere psichiatrico e penitenziario nella zona sud, chiuso e smantellato negli anni ’20. Qualcosa è ancora lì, coperto da parchi e strutture moderne. I cani abbaiano sempre nello stesso punto.
Un club segreto per cervelloni, ingegneri e filosofi, ancora attivo dal 1854. Ha una delle biblioteche private più rare d’America, con una sezione proibita accessibile solo ai membri di livello “esoterico”.
C’è un intero loft abitabile costruito nella torre sopra il vecchio teatro, un tempo rifugio di artisti, ora a ttato solo su invito. La vista è da togliere il fiato. Nessuna agenzia immobiliare lo pubblicizza.
Prima di quello noto al SFMOMA, Rivera realizzò uno schizzo murale in un’o cina sindacale del Mission District. Dopo un litigio politico, fu imbiancato. Ma alcuni dicono che esista ancora, sotto strati di vernice, pronto a essere riscoperto.


prime edizioni, lettere, poster, fotografie, macchine da scrivere, biglietti strappati di Greyhound, oggetti che ancora tremano. Non è un museo. È una capsula del tempo dove le pareti sanno ancora di sudore e jazz. Dove capisci che la Beat Generation non fu mai un gruppo. Fu un virus.
Haight-Ashbury: quando la poesia si fece pop
Poi vennero gli hippie. E con loro, l’utopia. Haight-Ashbury fu la loro Mecca. Ma senza cattedrali. Solo palazzi sgangherati, acidi, chitarre, orgasmi condivisi e bandane sporche. Fu lì che esplose la Summer of Love, nel 1967. Fu lì che l’eco dei beat si mescolò con l’LSD e le chitarre psichedeliche.
Gli studenti arrivavano da tutto il Paese. I media parlavano di “paradiso freak”. Il consiglio di quartiere, nel panico, inventò un nome per controllare il caos: Council of the Summer of Love. Come se l’amore potesse essere regolamentato. Ma l’amore non si lascia incasellare. Si dilata, brucia, svanisce. A ottobre, quella stessa estate celebrò il suo funerale. Letteralmente.
Oggi, Haight-Ashbury ha ancora i colori addosso. Le “painted ladies” sembrano sorridere. I negozi vendono dischi, libri, vestiti sgargianti e incensi. C’è ancora odore di patchouli e disillusione. Se ascolti bene, sotto le note nostalgiche, c’è ancora il brivido: quello della rivoluzione che fu.
San Francisco oggi: memoria viva o merchandising?
Oggi San Francisco è diventata anche altro. Startup, homeless, tech bros in monopattino, file per il brunch, proteste arcobaleno, echi di un tempo che non passa mai del tutto. Ogni tanto qualcuno dice che lo spirito ribelle è morto. Ma basta una sera di nebbia su Market Street, un sassofono che echeggia in una stazione BART, un verso di Ferlinghetti scritto con lo spray su un muro di Chinatown, per capire che

San Francisco non è cambiata. Si è solo travestita.
È una città che ha fatto dell’ambiguità la sua bandiera. È beat e borghese, mistica e hipster, povera e milionaria, idealista e ironica. È il paradosso con vista Golden Gate. È la rivoluzione con il cappuccino di mandorla.
Perché San Francisco conta ancora
Perché qui si è imparato che la libertà non è un diritto, ma una ferita. Che le parole possono ferire più delle armi. Che un verso può valere un processo. Che si può vivere al margine e sentirsi al centro. Che esistono città che non si visitano, ma che ti abitano.
San Francisco non è la patria della Beat Generation. È la loro madre adottiva, la loro complice, la loro amante complicata. Non ha mai chiesto permesso. Non ha mai voluto perdono.
E se ti fermi un attimo, con un libro in mano e i piedi sporchi di polvere, potresti ancora sentire la voce di Ginsberg, la risata ubriaca di Kerouac, il silenzio di Ferlinghetti che guarda tutto questo ambiamento e sorride.










C’è un’estate che non finisce mai. Un’estate che, pur essendo accaduta nel 1967, continua a riscrivere il nostro immaginario collettivo. Una stagione culturale. È il suono vibrante di un organo Hammond, l’odore dolciastro di patchouli e libertà, i pantaloni a zampa e le visioni lisergiche che ancora oggi infestano i sogni di chi crede che l’arte possa cambiare il mondo. Quell’estate è nata a San Francisco. E San Francisco, da allora, non è mai più stata una città come le altre.
Mentre nei vicoli del Village newyorkese si consumava la nevrosi metropolitana di Dylan e dei Velvet Underground, sulla costa opposta la collettività si trasformava in un esperimento utopico. Nel quartiere di Haight-Ashbury, esplose la Summer of Love, qualcosa a metà tra un rave spirituale e un happening psicopolitico. Più di centomila giovani si riversarono tra i viali alberati del Golden Gate Park. Non c’erano smartphone, né sponsorizzazioni. Solo corpi, musica e idee in libera circolazione. Il suono di quell’estate? Era schizofrenico, ipnotico, sporco. Era l’acido dei Jefferson Airplane, la

dolce agonia di Janis Joplin, il flusso continuo dei Grateful Dead. Oggi quella San Francisco è ancora lì. Ma è in parte diventata una Disneyland per boomer in cerca di emozioni perdute. Le vetrine vendono magliette con lo slogan Peace & Love, mentre nei loft da 8.000 dollari al mese si gira in microdosi di LSD legale. La controcultura, come spesso accade, è stata fagocitata dal mercato. Ma basta grattare appena la superficie per scoprire che sotto c’è ancora qualcosa che pulsa. La città ha imparato a rigenerarsi come un serpente visionario.





Le stesse strade che videro Jerry Garcia sfilare in sandali, oggi ospitano eventi come la “Summer of Discovery”: installazioni
interattive, performance immersive, esperimenti di realtà aumentata e DJ set sobri a base di specialty coffee.
Cosa resta di quella stagione? Resta un'attitudine. Quella che si respira nei club underground di SoMa, nei teatri o dove attrici

E, a suo modo, è potente.
Impossibile parlare di San Francisco senza nominare il Fillmore West: tempio sacro della psichedelia, dove suonarono tutti, da Santana a Miles Davis, passando per i Creedence Clearwater Revival. Oggi non esiste più, ma il suo fantasma aleggia. Ogni volta che un ragazzino imbraccia una chitarra e prova a scrivere qualcosa che faccia tremare il mondo, Bill Graham sorride da qualche parte nel cosmo. La creatività, da queste parti, non è mai stata un optional. È un’urgenza. Un modo per esistere fuori dalla norma, per scappare dalla Silicon Valley del controllo e dagli slogan “disruptive” che sanno di plastica. Qui si crea perché non c’è alternativa. E ogni estate è buona per ricominciare. C’è ancora vita su Haight Street. Ma devi sapere dove guardare. Devi sporcarti le mani, annusare l’aria, farti stordire da una jam session a Dolores Park o da una mostra improvvisata in una lavanderia automatica. San Francisco è ancora viva. E, come ogni artista che si rispetti, continua a reinventarsi.
TUTTI GLI ARTISTI CHE SI SONO ESIBITI DAL 1968 AL 1971 AL FILLMORE WEST
Grateful Dead, Santana, Creedence Clearwater Revival, Quicksilver Messenger Service, Jefferson Airplane, Led Zeppelin, The Who, Mountain, Hot Tuna, The Doobie Brothers, Jethro Tull, The Kinks, B.B. King, Albert King, Aretha Franklin, King Curtis, Miles Davis, Ray Charles, Joe Cocker, Big Brother and the Holding Company, Country Joe & The Fish, Steve Miller Blues Band, Chicago Transit Authority, Iron Butterfly, Blue Cheer, Ike & Tina Turner, Eric Burdon & War, Procol Harum, Deep Purple, Seatrain, Yusef Lateef, Beefy Red, Steel Mill, Cold Blood, The Flamin' Groovies, Tower of Power, It's a Beautiful Day, New Riders of the Purple Sage, Buddy Guy, Albert Collins, Chuck Berry, Taj Mahal, Steve Miller, Pink Floyd, Van Morrison, Ravi Shankar, Alla Rakha, Flock, Buddy Miles, Fleetwood Mac, Mott the Hoople, Junior Walker, Captain Beefheart, Canned Heat.

drag reinterpretano Jurassic Park in chiave queer (Jurassiq Parq, at Oasis), o tra i corridoi silenziosi della Chapel of the Chimes, dove la musica ambient si confonde con le ceneri dei morti. San Francisco non ha mai smesso di creare.
Oggi la creatività non è più solo un grido politico o una fuga sotto acidi. È una forma di sopravvivenza.
Una risposta estetica a una realtà sempre più distopica. Le nuove generazioni non cercano più la rivoluzione collettiva, ma microutopie personali. Fanno arte in co-working space, remixano proteste con AI, si tatuano Love is resistance e lo postano su TikTok. Non è sicuramente la stessa cosa. Ma è quello che abbiamo.


Soprannominato “hippie van” o “magic bus” il Type 2 T1 della Volkswagen, dipinto a mano e carico di sogni, divenne l’icona mobile del
libertà, controcultura e di una gioventù in viaggio verso la Summer of Love. Era spesso arredato all’interno
incensi e poster psichedelici. Poteva trasportare fino a nove persone, una chitarra e un’idea di mondo migliore.

una

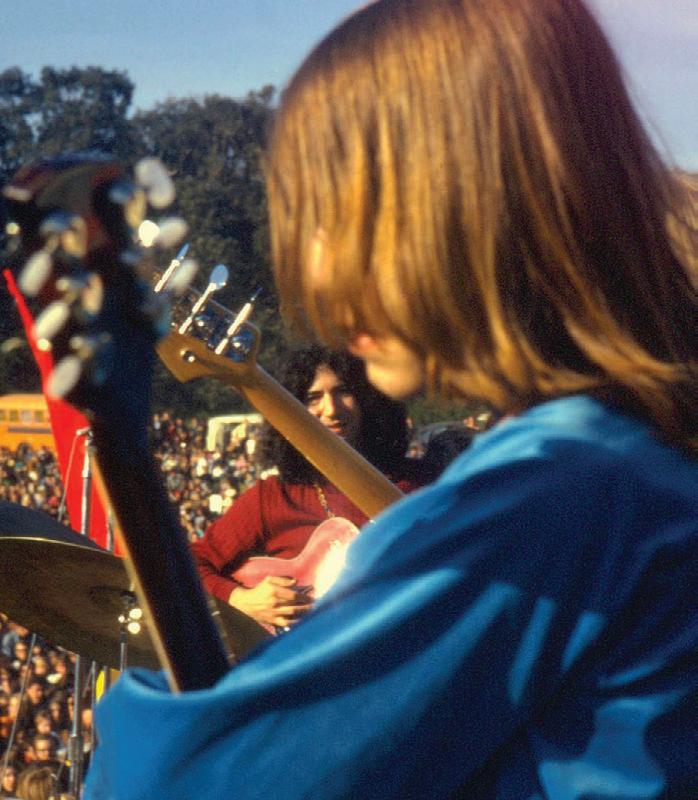




L’arte di strada è oggi un fenomeno globale, diffuso in ogni angolo del pianeta e divenuto, col tempo, sempre più redditizio. Nata negli Stati Uniti negli anni ’60 come forma di protesta, si è progressivamente trasformata, diventando anche uno strumento decorativo adottato dai grandi brand. Ma per comprenderne davvero la portata, è importante ripercorrere le origini di questo movimento, che affonda le sue radici nell’urgenza di esprimere un disagio sociale.
Anni ’60: il muro diventa voce. La differenza tra Gra ti Writing e Street Art Negli anni ’60, nei quartieri popolari di New York e Philadelphia, molti giovani iniziarono a esprimere il proprio disagio sociale attraverso una nuova forma di protesta: il graffiti writing. Armati di spray o pennarelli, trasformavano muri, treni e spazi pubblici in vere e proprie tele urbane, veicolando messaggi di ribellione e identità. Per proteggere il proprio anonimato — vista la natura
illegale di queste azioni — adottavano pseudonimi, noti come tag: firme stilizzate che, col tempo, divennero simboli riconoscibili del paesaggio urbano. Alcuni criticavano la società e la politica circostante, mentre altri volevano semplicemente affermare la propria libertà artistica, lontani dai vincoli imposti da gallerie e musei.
La street art nasce così come atto di liberazione che sfida le convenzioni estetiche e sociali dell’epoca.
A Philadelphia, Darryl McCray, conosciuto come "Cornbread", è considerato uno dei primi writer moderni, celebre per aver iniziato a scrivere il proprio nome sui muri della città alla fine degli anni ’60. A New York, nomi come TAKI 183 e Julio 204 contribuirono a diffondere il fenomeno, ispirando un’intera generazione di giovani a lasciare il proprio segno nella metropoli.
Ma perché parliamo di Gra ti Writing e Street Art?
Si tratta di due espressioni artistiche urbane spesso confuse tra loro. Sebbene condividano l’ambiente urbano come tela, di eriscono significativamente per origini, intenti e modalità espressive. Il Gra ti Writing a onda le

sue radici proprio nella fine degli anni ’60 a New York, emergendo come forma di espressione culturale e sociale. I writers iniziarono a lasciare le proprie tag su muri e vagoni ferroviari, cercando riconoscimento all’interno della loro comunità.
Nacque così il train bombing, una disciplina del writing che prevede il “bombardamento” dei vagoni con lettering e puppet: l’obiettivo era a ermare la propria presenza nello spazio urbano in modo clandestino e non autorizzato.
Si passò dai muri ai treni per far “viaggiare” il proprio tag il più lontano possibile e farsi conoscere, ma anche per conquistare lo spazio underground, frequentato dai giovani artisti che si muovevano in metropolitana.
La Street Art , invece, è considerata un’evoluzione del graffitismo (nota anche come post-gra tismo) e inizia a svilupparsi negli anni ’80. Gli artisti di strada ampliano la gamma espressiva, utilizzando soggetti non alfabetici e tecniche diverse, come stencil, poster, sticker e murales. A di erenza dei writers, gli street artist mirano a comunicare con un pubblico più ampio, affrontando tematiche sociali, politiche o culturali.




- Towson University Maryland





NSpray Revolution: la nuova voce urbana degli anni ’70
Fu grazie all’intuizione del writer Pear 136 che il modo di fare writing cominciò a evolversi. Utilizzando un rullo e della vernice, iniziò a scrivere il proprio nome a caratteri giganteschi sull’asfalto di alcuni parchi, in modo che fosse visibile addirittura dagli aerei.
La sua idea influenzò rapidamente altri writer, che iniziarono a sperimentare scritte di grandi dimensioni anche su muri e superfici verticali. In particolare, alcuni interventi su una stazione della linea Broadway segnarono un momento epocale: fu uno degli episodi più clamorosi mai visti nella metropolitana di
New York. L’introduzione della vernice spray, nei decenni successivi, contribuì in modo decisivo all’evoluzione della street art, offrendo agli artisti nuovi strumenti per ampliare la portata e la qualità delle loro opere.
La Street Art degli anni ’80: il linguaggio visivo che scuote le coscienze
Negli anni ’80, la street art attraversò una profonda trasformazione: l’arte urbana si evolse, ampliando i propri codici visivi e l’impatto comunicativo. È in questo periodo che si affermò il fenomeno del postgra tismo, un’evoluzione stilistica e concettuale del graffiti writing, che portò gli artisti ad abbandonare (o affiancare) le
tradizionali scritte per esplorare nuovi linguaggi visivi. I muri iniziarono a popolarsi di immagini, icone, simboli e messaggi accessibili anche a chi non apparteneva al mondo dei writers.
Nacquero nuove tecniche espressive: gli stencil permisero di replicare rapidamente figure dettagliate; i poster e gli adesivi (sticker art) divennero strumenti portatili di comunicazione; i murales si trasformarono in veri e propri manifesti visivi, ricchi di contenuto e significato.
In questo contesto emersero artisti che usarono l’arte di strada non solo per affermare sé stessi, ma per dialogare con la società,
affrontando tematiche politiche, ambientali, culturali e sociali.
La strada divenne una galleria a cielo aperto, ma anche una tribuna pubblica.
La street art iniziò così a guadagnare visibilità al di fuori del suo contesto originario. Dalla clandestinità si fece strada nel mondo dell’arte contemporanea, pur mantenendo intatta la sua natura ribelle e popolare. Entrò nei musei, venne documentata dai media, affascinò collezionisti, ma continuò a parlare direttamente alle persone, nei luoghi del quotidiano.
La sua forza sta proprio in questo: un’arte nata dal basso, capace di denunciare, raccontare, emozionare. Che non ha
bisogno di cornici dorate per essere potente. Che non si limita a decorare, ma smuove le coscienze, sollecita riflessioni, accende dibattiti. E continua, oggi come allora, a raccontare le città e le voci di chi le abita.
La street art americana conquista il mondo.
Negli anni ’80, mentre a New York la scena si faceva sempre più dinamica e visibile, soprattutto con l’esplosione del postgraffitismo, le prime contaminazioni iniziarono a prendere forma in Europa, in particolare a Parigi, Londra e Berlino.
La capitale francese divenne uno dei primi epicentri della nuova ondata: artisti come Blek


le Rat iniziarono a utilizzare stencil per veicolare messaggi politici e sociali, anticipando perfino l’approccio che renderà celebre Banksy anni dopo. A Berlino, il muro che divideva la città divenne simbolicamente — e letteralmente — la tela ideale per scrivere dissenso e identità. Intanto, a Londra, la cultura dei graffiti si fuse con la musica punk e l’estetica urbana inglese, dando vita a un nuovo stile visivo, più crudo e satirico.
Anche il Sud America iniziò a sviluppare una propria identità visiva, fortemente legata alle tematiche di protesta sociale: in città come San Paolo o Buenos Aires, i murales divennero strumenti espressivi potenti per affrontare ingiustizie e disuguaglianze.
Con l’arrivo degli anni ’90 e 2000, la diffusione dell’arte di strada esplose definitivamente a livello
globale. Complici Internet, i media, il turismo e l’ingresso di alcuni artisti nelle gallerie d’arte, il movimento non fu più relegato a pochi angoli di città: Tokyo, Melbourne, Città del Capo, Lisbona, Beirut, Roma... ogni metropoli sviluppò una scena propria, con stili, tecniche e messaggi unici, ma legati da un filo comune: la volontà di comunicare senza filtri con la collettività.
Diventò così una vera e propria lingua universale, capace di adattarsi a contesti culturali diversissimi, mantenendo però intatto il suo spirito originario: quello di un’arte libera, critica, pubblica. Un’arte che, partendo dalle strade di New York, è riuscita a parlare al mondo intero.
Dall'illegalità al valore immobiliare: una trasformazione inattesa Negli Stati Uniti — e in
particolare in città come New York, Los Angeles, Miami e San Francisco — la street art ha progressivamente acquisito uno status culturale e commerciale, arrivando a influenzare direttamente il mercato immobiliare urbano. Un tempo considerata un atto vandalico, oggi la presenza di murales, gra ti artistici o installazioni urbane è spesso vista come un valore aggiunto per i quartieri. Le aree che ospitano interventi artistici pubblici vengono percepite come più creative, dinamiche e “vive”, attirando residenti, turisti e investitori, facendo salire i prezzi. Gentrificazione e street art: una relazione ambigua
L'esempio di Bushwick, a Brooklyn. In pochi anni, da zona industriale semiabbandonata è diventata uno dei quartieri più “cool” di New York, grazie anche ai murales che ne hanno trasformato l’aspetto. Lo
stesso è accaduto nel Wynwood Arts District a Miami: inizialmente polo underground per street artist locali e internazionali, oggi è uno dei luoghi più ambiti per ristoranti, gallerie e appartamenti di lusso. La presenza della street art diventa quindi uno strumento di rigenerazione urbana, ma anche il motore della gentrificazione: i valori immobiliari aumentano, gli investitori comprano, arrivano boutique e locali, e molti degli abitanti originari vengono spinti fuori a causa dell’aumento dei prezzi.
L’arte come leva di marketing immobiliare Sempre più spesso, agenzie immobiliari e promotori usano la street art come elemento di marketing. Le opere murarie vengono fotografate nei dépliant, usate come sfondo per le pubblicità. In alcuni casi, si commissionano appositamente murales
per valorizzare un’area o un edificio, sfruttando l’e etto “cool” che l’arte di strada porta con sé. Nata nei vicoli come grido di ribellione, la street art ha compiuto un viaggio sorprendente: da linguaggio clandestino dei margini a voce riconosciuta dell’estetica contemporanea.
È passata dai muri abusivi alle pareti dei musei, dalle tag anonime ai cataloghi d’arte, conservando — almeno in parte — la sua carica dirompente.
Oggi è strumento di marketing, leva immobiliare, oggetto di collezionismo. Ma resta anche un atto di libertà visiva, una forma di narrazione urbana che intercetta i conflitti del presente e li traduce in immagine.
In un mondo sempre più saturato di messaggi, la street art continua a distinguersi proprio perché non chiede permesso.
















ope2, alias di Fernando Carlo, è una leggenda della street art americana. Nato nel Bronx nel 1968 da famiglia portoricana, ha segnato la storia dei graffiti con i suoi iconici tag e i celebri throw-up, caratterizzati da lettere stilizzate e colori esplosivi.
Il nome “COPE2” è oggi sinonimo di gra ti a livello globale. Nel tempo ha saputo evolversi, collaborando con brand e gallerie internazionali senza mai recidere il legame con le sue radici urbane. Le sue opere, esposte in musei e spazi pubblici in tutto il mondo, continuano a influenzare generazioni di artisti.
D. Chi ti ha ispirato e quando hai cominciato a fare gra ti?
R. Fin da piccolo prendevo spesso la metropolitana con mia madre per andare a trovare parenti in tutta New York. Ricordo perfettamente quei momenti in cui, in attesa del treno, rimanevo ipnotizzato dai giganteschi nomi colorati che coprivano i vagoni: Blade, Comet, Pnut2, Mark198, Mitch77, Seen, Tracy168. Una volta a bordo, i tag tracciati con marker di ogni tipo e dimensione riempivano ogni angolo. Così è iniziata la mia passione. Poi scoprii che mio cugino Chico faceva gra ti nel quartiere: lo vedevo scrivere il suo nome con un marker Pilot, ed è stato lui a ispirarmi ancora di più. Mi ricordo anche quando, nel 1979, rubai un pennarello El Marko da Woolworth su Burnside Ave e iniziai a taggare il
mio soprannome, “Nano”, ovunque potessi: nei corridoi di scuola, sugli edifici, sulle cassette postali.
D. Com’è stato muovere i primi passi per le strade di New York?
R. Crescere nel Bronx non era facile: venivo da una famiglia con poche risorse, mia madre riceveva sussidi statali e mio padre faceva lavori saltuari. Nonostante questo, mi divertivo un mondo a giocare a stickball o football americano con gli amici, o a prendere la metro solo per osservare i graffiti. C’era un’energia unica: quei colori vivaci mi attiravano come una calamita. Ricordo la scarica di adrenalina quando entravo nei vagoni e, approfittando di un attimo di distrazione dei passeggeri, lasciavo il mio nome in un angolo. Era un brivido indescrivibile.
D. Che significato ha per te il nome "COPE2" e come è nato?
R. Nel 1979 mi trasferii più a nord, a Dekalb Ave, e lì conobbi Darryl, un ragazzo afroamericano che taggava "KOPE" nel quartiere. Io, in quel periodo, usavo il nome BIN. Ricordo che passavamo interi pomeriggi insieme, perfino a rubare figurine di Star Wars nei negozi. Un giorno, durante queste scorribande, mi propose di cambiare la K in C per differenziarci: così nacque “COPE”. Il numero 2 lo aggiunsi in omaggio ai tag che vedevo sui treni, come BAN2, Phase2, King2. Il 2 aveva un’aura di notorietà e stile. Volevo che il
mio nome risuonasse allo stesso modo, ed è così che sono diventato COPE2.
D.Come si è trasformato il tuo percorso, dai gra ti illegali alle gallerie e ai musei?
R. È stato un passaggio davvero interessante e impegnativo. Crescendo, diventai padre di due figli e capii che dovevo costruire un futuro stabile. Guardavo i writer storici di New York — Dondi, Futura, Seen, Blade, Crash — che avevano iniziato sui treni e poi erano passati alla tela. La svolta arrivò nel 2000, quando partecipai a un’asta di Christie’s con tre quadri: ne vendetti due e guadagnai una cifra importante. Quello fu il mio trampolino. Ero stanco di lavoretti qualsiasi e decisi di scommettere sull’arte. Dal 2003 cominciai a viaggiare in Europa per eventi di live painting, incontrando galleristi e altri artisti. A Parigi, Berlino, Barcellona dipingevo dal vivo e imparavo. Il mio amico Jonone mi spingeva a lavorare su tela per trasformare la mia passione in una professione vera. Da lì iniziarono le mostre collettive, i contatti con gallerie, e il resto è storia.
D. Secondo te oggi i gra ti sono davvero accettati come forma d’arte legittima?
R. Direi di sì, almeno in buona parte. Già negli anni ’80, con film come Wild Style, si vedeva come i gra ti passassero dai treni alle tele. Da lì in poi è stato un continuo evolversi: grandi artisti del rap come KRS-One o Fat Joe hanno incorporato i graffiti nella loro estetica, e brand
come Nike li hanno usati per campagne pubblicitarie. Oggi è un business globale: ci sono videogiochi, murales su commissione in ogni angolo del mondo. Per tanti di noi è diventato un mestiere vero e proprio. Io stesso vivo di questo. Certo, ci sono voluti decenni di impegno e sacrificio, ma il riconoscimento è arrivato.
D. Che consiglio daresti ai giovani che vogliono iniziare a fare gra ti?
R. Direi di restare focalizzati. Se vogliono trasformarlo in un lavoro, serve dedizione totale. E se vogliono continuare a dipingere sui muri, devono rispettare gli altri, evitare invidie e inutili rivalità. Io ne so qualcosa: quando ho raggiunto la notorietà, ho visto crescere attorno a me invidia e ostilità, anche da vecchi amici. Internet amplifica tutto, sia il successo che l’odio. Ma alla fine la verità emerge sempre. Se sei autentico e coerente, la gente se ne accorge.
D. Quali sogni hai ancora per il futuro?
R. Mi piacerebbe vedere realizzato un videogioco tutto dedicato a me, o magari un film sulla mia vita. Sarebbe fantastico raccontare la mia storia per intero. Ma sono già molto grato per il percorso che ho fatto. È stato un viaggio complicato, pieno di ostacoli, ma la saga non è finita: c’è ancora tanto da scrivere.








BRAND IDENTITY, APERTURA RISTORANTI, PACKAGING DESIGN, APERTURE SOCIETÀ, LOGO DESIGN, SITI WEB, COMUNICAZIONE E MARKETING.
AGENZIA ITALIANA DI BRANDING CHE
DIRETTAMENTE AL CONSUMATORE AMERICANO.


Ohio, il cuore industriale e politico d’America.
Uno di quegli stati americani che raramente finiscono sulle copertine, ma che contano sempre quando si parla di politica ed economia.
Soprannominato “The Buckeye State” per via
degli alberi di castagno tipici, si trova nel Midwest ed è spesso considerato lo specchio dell’America profonda.
Economia e industria
Storicamente legato all’acciaio e all’automotive, l’Ohio è stato un pilastro della Rust Belt. Cleveland, Cincinnati e Columbus hanno incarnato la forza manifatturiera del
Novecento, mentre oggi la trasformazione passa da tecnologia, sanità e logistica. Amazon e Google hanno aperto data center qui, approfittando della posizione strategica e dei costi più bassi rispetto alle coste.
Politica e società
Con i suoi 11 milioni di abitanti, l’Ohio è un laboratorio politico: stato oscillante per eccellenza, ha previsto
quasi tutti i presidenti eletti nel XX secolo. Chi vince qui, spesso conquista la Casa Bianca. Non a caso, le città universitarie come Columbus e i centri urbani democratici si contrappongono alle contee rurali, saldamente repubblicane.
Cultura e identità Culturalmente, l’Ohio vive di contrasti: dai musei di Cleveland e Toledo
all’iconico Rock and Roll Hall of Fame, fino al football universitario che è più di una religione. È una terra che ha dato i natali a otto presidenti, a Thomas Edison e a personaggi come LeBron James. Un mix di inventiva, sport e politica che riassume l’anima contraddittoria degli Stati Uniti.
C’è chi sogna una villetta in periferia e chi invece si sveglia ogni mattina decidendo quale jet usare per il brunch a Palm Beach. Benvenuti nella Paperopoli d’America, le dieci città dove la ricchezza non è solo un dato statistico, ma una condizione esistenziale. Qui il “sogno americano” non è un mito: è una rendita, un trust, una stock option firmata al brunch.
A cura della redazione di EXPORTUSA

Milionari: 384.500
Centi-milionari: 818
Miliardari: 66
Crescita decennale: +48%
New York resta la capitale globale della finanza. Nonostante fuga di talenti e fiscalità ostile, la città continua ad attrarre HNWI (High-NetWorth Individuals) grazie al ruolo centrale in settori come investment banking, hedge fund, arte, media e real estate. La sua leadership è ancora incontrastata, anche se minacciata da nuove mete fiscali più agili.
Milionari: 342.400
Centi-milionari: 756
Miliardari: 82
Crescita decennale: +92%
L’area della Bay domina il panorama tech globale. Silicon Valley e San Francisco generano ricchezza liquida più velocemente di qualsiasi altra area urbana americana. Le IPO, il venture capital e l’ecosistema delle startup spingono la regione in alto nel ranking della nuova élite finanziaria, nonostante costi altissimi e instabilità urbana.


Milionari: 220.600
Centi-milionari: 516
Miliardari: 45
Crescita decennale: +35%
L’industria dell’intrattenimento resta un motore centrale, ma LA si è evoluta in hub multi-settoriale: tecnologia, moda, beauty, logistica e real estate. Il capitale è fluido, giovane, molto spesso ereditato. La concentrazione di family o ces e private equity è in costante crescita.

Milionari: 81.800
Centi-milionari: 210
Miliardari: 16
Crescita decennale: +75%
Capitale energetica del Paese, Houston cavalca la transizione verso nuovi modelli energetici senza perdere il legame con l’oil & gas. Regime fiscale favorevole, costo della vita contenuto e un boom immobiliare la rendono attraente per nuovi milionari e investitori.
Milionari: 127.100
Centi-milionari: 295
Miliardari: 25
Crescita decennale: +24%
Vecchia gloria industriale e finanziaria, Chicago mantiene un solido tessuto di wealth management, assicurazioni, investimenti e aziende Fortune 500. Crescita più lenta rispetto alle città del Sud e della West Coast, ma ancora con una forte capacità di generare ricchezza tradizionale.


Milionari: 54.200
Miliardari: 11
Crescita decennale: +70%
Amazon, Microsoft, e una fitta rete di startup tecnologiche continuano a generare nuova ricchezza. Seattle è diventata uno degli ecosistemi più fertili per investitori tech e venture capitalist. La qualità della vita e il talento ingegneristico alimentano un’espansione continua del capitale.
Milionari: 72.400
Crescita decennale: +85%
Dallas è il volto business-friendly del nuovo Sud: tasse basse, politiche pro-azienda, crescita tecnologica e influsso costante di capitali da California e Nord-Est. La città si sta consolidando come uno dei centri emergenti dell’alta finanza texana.


Milionari stimati: ~38.000
Crescita decennale: +94%
Miami è la regina della migrazione fiscale. Ex californiani, hedge funder, star della crypto e imprenditori latini convergono qui attratti da zero state income tax, clima favorevole e qualità della vita. Il settore immobiliare di lusso è tra i più dinamici al mondo.

Milionari stimati: ~45.000
Crescita decennale: +40%
Il capitale intellettuale è convertito in capitale finanziario. Boston domina biotech, ricerca medica e finanza accademica. Harvard e MIT alimentano un flusso costante di imprenditori ad alta specializzazione. Gli asset immobiliari e i fondi pensione costituiscono una fetta importante della ricchezza locale.

Milionari: 32.700
Crescita decennale: +90%
Startup city, creativa e iperconnessa. Austin è cresciuta più di quasi tutte le città americane in termini di nuovi milionari grazie al boom tech, alla decentralizzazione della Silicon Valley e alla presenza massiccia di nomadi digitali, investitori crypto e neoricchi da exit veloce.


Viviamo nell’epoca del rumore. Ogni brand urla, lampeggia, interrompe, seduce. Ma proprio per questo, ciò che davvero conta oggi non è quanto riesci a farti notare, ma quanto a lungo riesci a farti credere.
La longevità di un brand non si misura in view, share o picchi improvvisi di tra co. Si misura nella sua capacità di mantenere la parola data. Perché nel mercato iperconnesso e cinico in cui operiamo, la coerenza è l’unico valore che non si deprezza.
È il capitale invisibile che tiene in piedi tutto. Il cliente non lo vede, ma lo percepisce. È la prima cosa che scatta quando sente nominare il tuo brand. Una sensazione di fiducia o un sospetto che serpeggia. È lì che si gioca tutto, spesso prima ancora che inizi la conversazione.
Oggi i consumatori spulciano, controllano, scavano. Vogliono sapere chi sei davvero, come tratti chi lavora con te, dove produci, se quello che dici corrisponde a quello che fai. E se trovano una crepa, quella crepa diventa virale. In un’epoca in cui tutto è storytelling, la vera forza è il fact-checking.
L’autenticità non si dichiara, si dimostra. Non si scrive nei manifesti, si costruisce negli anni. Con scelte che restano quando i riflettori si spengono. Perché puoi avere lo spot più figo, il logo
più scintillante, l’influencer più quotato. Ma se dietro non c’è sostanza, quel luccichio si spegne in fretta.
Non basta essere visti. Bisogna essere scelti. E per essere scelti serve fiducia. Fiducia significa che ti preferisco anche quando costi di più. Anche quando un competitor urla più forte. Non perché sei perfetto, ma perché sei credibile. Perché so cosa aspettarmi. Perché non mi tradisci. Perché ogni volta che interagisco con te, l’esperienza è allineata con la promessa.
Il vero capitale umano è la fedeltà. La reputazione si costruisce goccia a goccia, come una diga che trattiene l’acqua della crisi. Ma basta una falla perché tutto crolli. Non è paranoia, è il mercato. Un brand senza reputazione è un castello di carte su una spiaggia ventosa: può anche sembrare maestoso, ma basta un so o di verità per farlo crollare.
Durare oggi è più raro che emergere. Il mondo è pieno di marchi che hanno brillato una stagione, un trimestre, un trend. Nel lungo periodo, il mercato si fida solo di chi non tradisce. Di chi non si reinventa ogni sei mesi per inseguire il vento. Di chi, sotto ogni rebranding, resta fedele a sé stesso. Non è nostalgia. È strategia. In un mondo che cambia a ogni refresh, la coerenza è il nuovo coraggio.


IL CAPITOLO TRATTO DAL LIBRO "OPERAZIONE SATELLITE" USCITO IN ITALIA AD OPERA DI FREDIANO FINUCCI (PAESI EDIZIONI) DISPONIBILE ANCHE IN INGLESE COL TITOLO "THE GREAT GAME OF SATELLITES".
l libro ha vinto la 14esima edizione del premio nazionale italiano di narrativa "Cerruglio" dedicato alla saggistica d'attualità ed uscirà a maggio 2025 in francese con il titolo "la guerre des satellites" (Editions L'artilleur)
TITOLO: COME GLI STATI
UNITI E LA RUSSIA SI SONO
COMBATTUTI NELLO SPAZIO
DOPO L'ANNESSIONE
DELLA CRIMEA DEL 2014
L’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio 2022 a onda le sue radici nell’occupazione da parte di Mosca della Crimea, preceduta dall’arrivo nella penisola di truppe prive di insegne (i famigerati «omini verdi» di Putin) tra il 20 e il 27 febbraio 2014. In seguito all’autoproclamazione di un governo locale (filorusso) che dichiara la Crimea indipendente da Kiev, il 18 marzo avviene l’annessione formale alla Russia dopo un referendum svoltosi due giorni prima, non riconosciuto dalla comunità internazionale per la mancanza di adeguati standard. L’amministrazione Obama preme allora sul governo di Kiev per evitare un’escalation militare e comincia l’imposizione da parte americana ed europea di sanzioni economiche alla Russia. Di recente Barack Obama ha ricordato così quei mesi in un'intervista a Christiane Amanpour della CNN:
«C'è una ragione per cui non ci fu un'invasione armata [NDR: per cacciare i russi] della Crimea: la penisola era piena di russofoni e c'era un sentimento di simpatia perché a questi sembrava che la Russia stesse facendo i loro interessi (...) penso che abbiamo risposto a Putin con gli strumenti che avevamo a quel tempo, tenuto conto dell'Ucraina di allora».
«Con gli strumenti che avevamo a quel tempo»: tenete bene a mente quest'espressione leggendo le pagine seguenti dove vedremo come le tensioni tra Russia e Ucraina, che inevitabilmente coinvolsero gli Stati Uniti, ebbero
delle ripercussioni anche nello Spazio con una serie di episodi poco conosciuti ma che, messi in ordine cronologico, danno un’idea della situazione e del modus operandi delle due superpotenze.
La Prima Guerra Mondiale Satellitare?
Giovedì 13 marzo 2014, quando mancano tre giorni al referendum in Crimea, la Russia lancia un’o ensiva hacker verso infrastrutture informatiche e di telecomunicazioni ucraine della durata di otto minuti: si tratta di un tipo di attacco abbastanza semplice - ma sempre e cace - chiamato DDoS, distributed denial of service. Immaginate di voler bloccare le entrate di un palazzo mediante una folla inferocita di mille persone che preme di fronte agli ingressi, in maniera caotica: nessuno entra, nessuno esce, col risultato che il palazzo è isolato. Ebbene, con attacchi continui e ripetuti, gli hacker fanno esattamente lo stesso per rendere indisponibile l’accesso ad Internet a servizi o risorse che per funzionare, dare o ricevere comandi, hanno bisogno di accedere alla rete. Il giorno prima del referendum invece, sabato 15 marzo, l’agenzia di stampa Itar-Tass riporta che secondo il Ministero delle comunicazioni e dei mass media russo il satellite della TV russa Express AM-5 è stato oggetto di un attacco di guerra elettronica, specificando che la sorgente del disturbo è stata localizzata in territorio ucraino. Un secondo lancio stampa, stavolta dell’altra agenzia statale, Interfax, riporta che gli ucraini hanno tentato di deviare il satellite dalla sua orbita originaria, probabilmente nel tentativo di farlo abbassare di quota e causarne il rientro nell’atmosfera per provocarne la distruzione. L’Agenzia cita una fonte anonima, la quale sostiene che l’attacco molto probabilmente è stato sferrato da un’agenzia di intelligence straniera. La notizia viene riportata anche dall’agenzia di stampa Reuters. Facciamo notare che in questa particolare situazione storica mettere fuori
uso un satellite per il segnale televisivo ha una sua logica. Nella sterminata Russia la maggior parte degli abitanti riceve la TV tramite la parabola: interrompere il segnale di Express AM-5 avrebbe significato impedire la celebrazione televisiva del successo del referendum per l’annessione della Crimea.
Secondo alcuni esperti interpellati, e come vedremo più avanti nel libro, è estremamente di cile per un agente esterno provocare l’accensione dei razzetti di un satellite per farlo rientrare nell’atmosfera: è molto probabile invece che qualcuno abbia portato avanti un’azione di spoofing, vale a dire abbia disturbato il segnale per indurre i gestori (in questo caso, i russi) a pensare che il satellite stesse cambiando la sua orbita, generando confusione e sfiducia nei dati che il satellite stesso periodicamente invia a terra per comunicare la sua posizione. Il lunedì successivo, il giorno dopo il referendum sulla Crimea, ossia il 17 marzo, sul sito della CNN, appare questo articolo:
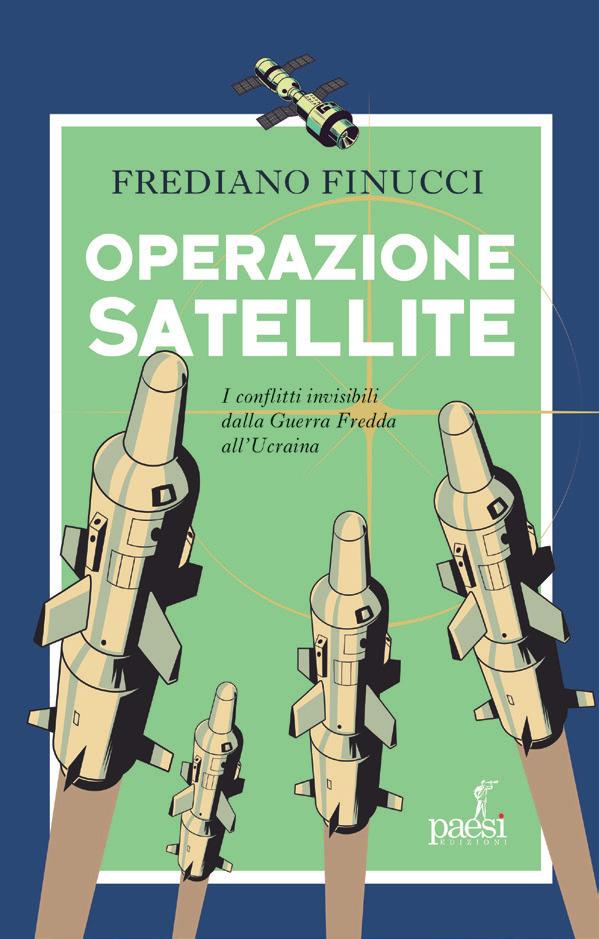
è più rintracciabile, neppure con gli appositi programmi che recuperano le pagine web rimosse. Eppure, è stato pubblicato: l’abbiamo recuperato grazie al motore di intelligenza artificiale ChatGPT, che ci ha restituito il testo e anche l’indirizzo originario dopo un accurato interrogatorio! Questo significa che l'articolo è stato sì rimosso, ma evidentemente è stato anche citato in qualche pubblicazione che ChatGPT ha memorizzato durante la sua quotidiana «pesca a strascico di informazioni».
«La U.S. Air Force ha rilevato un aumento dell'attività dei satelliti russi nelle vicinanze della fascia geosincrona, che ospita molti satelliti militari e di intelligence degli Stati Uniti. Funzionari hanno detto a CNN di essere preoccupati per queste manovre, ma non hanno ancora tratto conclusioni su ciò che i russi potrebbero cercare di fare.»
La fonte anonima dell’Aeronautica militare statunitense conclude che queste manovre dei satelliti russi sono viste come «potenzialmente pericolose per gli asset [i satelliti, ndr] americani».
È interessante notare come questo articolo della CNN sia scomparso da Internet: non
Ora, sarà un caso, ma esattamente due settimane dopo il referendum in Crimea ed il contestuale, inusuale, allarme dell’Air Force americana alla CNN, si verifica il più clamoroso guasto ad un’infrastruttura satellitare mai avvenuto nella Storia, a danno delle forze armate russe. Alle 10.30 della sera moscovita del primo aprile 2014, in una manciata di minuti, tutti i 24 satelliti della costellazione GLONASS, ossia il GPS russo, vanno fuori uso, contemporaneamente, per ben 13 ore: 13 lunghissime ore durante le quali le navi militari russe, gli aerei e quindi anche i sistemi di controllo dei loro missili si sono trovati senza il proprio sistema di navigazione. Una cosa del genere non era mai successa. I responsabili
russi si trincerano nel silenzio e non rilasciano dichiarazioni. Ripristinato finalmente il servizio, passano 15 giorni e di nuovo otto satelliti GLONASS vanno fuori uso per mezz’ora; trattandosi di un terzo della costellazione, gli esperti sostengono che i rimanenti potrebbero aver inviato dati non accurati, mettendo quindi di nuovo in tilt l’intero sistema di navigazione e i suoi utenti (di fatto soltanto le forze armate russe).
Soltanto 23 giorni dopo il blackout totale l’allora capo dell’agenzia spaziale russa, Oleg Ostapenko, si presenta alla Stampa e dichiara che il malfunzionamento era dovuto a non precisati «errori matematici nel software»; che quindi non era un problema serio (!) e che sarebbe stato risolto a breve. Ora, il sistema russo GLONASS ha la reputazione di essere, come molta tecnologia di derivazione sovietica, «rustico»: è robusto, funziona egregiamente per quel che deve fare, ma non lavora di fino e per questo non è usato nelle più di use applicazioni commerciali (smartphone, tablet e apparecchiature navali) e comunque viene sempre utilizzato (dai russi) in accoppiamento col GPS americano per migliorare la precisione ed evitare di rimanere scoperti in caso di problemi.
Due mesi dopo il clamoroso blackout, il 2 giugno 2014, sulla pagina Linkedin di un analista americano di nome Paul Szymansky, molto seguita da esperti militari e legati al mondo della difesa, appare un lungo e dettagliato report scritto da Szymansky stesso, un fisico che ha lavorato a lungo per le forze armate statunitensi occupandosi di questione relative allo Spazio e alla sicurezza. Szymansky, che abbiamo a lungo intervistato, ha verificato che i 24 satelliti GLONASS il primo aprile 2014 non sono andati in blocco contemporaneamente ma si sono spenti in ordine numerico progressivo, sequenziale, uno dopo l’altro: eventualità che - a suo dire - renderebbe poco credibile la casualità o il semplice guasto, ma sembrerebbe più consona ad un agire umano, a una «manina» che segue una lista in modo ordinato e preciso, spegnendo un satellite dopo l’altro.
Non solo. L’analista sostiene di aver analizzato le orbite dei satelliti per capire dove si trovassero al momento dello spegnimento e scrive che l’unico punto del globo dove c’era una
finestra di visibilità per sferrare un attacco del genere era la località australiana di Alice Springs, nelle cui vicinanze si trova Pine Gap, una base di controllo, ascolto e ricezione satellitare che fa capo ai cosiddetti Five Eyes («Cinque Occhi») ossia l’alleanza tra le agenzie di spionaggio di Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. I fruitori di Netflix probabilmente ricorderanno la serie TV che racconta in modo avvincente l’attività di quella che semplicemente è una base di spie hi-tech anglosassoni.
Durante il nostro lungo colloquio, Szymansky rafforza la sua tesi aggiungendo un particolare davvero gustoso: ci fa notare come l’attacco sia partito alle 6.30 del mattino di Alice Spring, orario che - a suo dire - coincide con il canonico inizio del primo turno di lavoro in quella struttura. Inoltre Szymansky sostiene che, sebbene gli esperti presenti a Pine Gap siano perfettamente in grado di fare un’operazione del genere, a suo parere (e qua, precisiamo, nonostante la nostra insistenza, non porta prove a riguardo) l’attacco potrebbe essere stato fatto dal 4° Squadrone Space Control di stanza nella base aerea di Holloman, in New Mexico: una sezione dei Marines appositamente creata per fare jamming in teatri di guerra e che per questo si muove con grandi elicotteri che trasportano le antenne necessarie a queste operazioni.
Ora, Paul Szymansky, ha un curriculum tecnico di tutto rispetto e un seguito su Linkedin di autorevoli personaggi legati al mondo militare americano e della ricerca aerospaziale. Andando a rileggere i suoi articoli, abbiamo verificato che in e etti ha anticipato (addirittura di una decina di anni) alcuni eventi che si sono e ettivamente verificati nel mondo dei satelliti militari. Detto questo, la sua tesi è impegnativa, per usare un eufemismo, e abbiamo quindi mostrato i suoi scritti e riferito le sue ipotesi ad esperti del settore per un parere. Alcuni sembrano più propensi ad attribuire il blackout del GLONASS ad intrinseche debolezze della tecnologia russa, non escludendo però - con una probabilità del 30% - che si sia trattato di un intervento esterno. Altri ancora definiscono l’ipotesi dell’attacco «possibile, probabile, ma non dimostrabile» con la certezza, comunque, che solo gli Stati Uniti hanno la tecnologia
per fare una cosa del genere. Un’altra fonte interpellata, che possiamo senza dubbio definire estremamente qualificata, non ha avuto difficoltà a credere alle ipotesi di Szymansky, spiegandoci che la disconnessione dei satelliti GLONASS potrebbe essere stata fatta in modo sequenziale proprio per far capire che non si trattava di un malfunzionamento improvviso dell’intero sistema bensì di un’azione deliberata, un modo per lasciare volutamente le «impronte digitali». La nostra fonte l’ha definita «e etto deterrenza». Come dire: vedi cosa ti posso fare? Per correttezza dobbiamo riportare che altre fonti usano la stessa motivazione per smontare l’ipotesi dell’attacco: se si trova una falla nel sistema del nemico, perché farglielo capire in modo che possa porvi rimedio e lasciare anche la firma? Un'altra fonte che abbiamo consultato, con forti competenze di elettronica applicata al mondo della Difesa, ha invece ipotizzato che l’attacco sia stato un pretesto/occasione per testare qualche nuova tecnologia.
Resta comunque da capire il movente: perché gli Stati Uniti avrebbero fatto un’azione del genere? Avvertimento? Prova di forza? Rappresaglia (per un attacco informatico che hacker russi avrebbero fatto ad un gruppo di banche americane in quel periodo)? Forse la spiegazione più probabile è la volontà di creare disturbo ai Russi in un momento particolare (considerato il contesto storico "caldo") o per impedire loro di fare qualcosa. A queste domande al momento non ci sono risposte. Rimangono solo molti indizi dettagliati, coincidenze temporali a dir poco sospette e, sullo sfondo, due questioni che riguardano Barack Obama.
La prima sono le parole con le quali l'ex presidente a distanza di dieci anni ha giustificato il mancato intervento militare in Crimea: «Penso che abbiamo risposto a Putin con gli strumenti che avevamo a quel tempo». Questa frase basta per ipotizzare che tra quegli strumenti ci fosse, appunto, un'azione contro il GPS russo? Ora, che Obama conosca molto bene le potenzialità e soprattutto le criticità dei sistemi satellitari, non c'è alcun dubbio. Un preciso fatto lo prova: l'ex presidente, assieme alla moglie Michelle, figura tra i produttori esecutivi del film Il mondo dietro
di te (titolo originale: Leave the World Behind). Si tratta di una storia apocalittica che vuol mostrare cosa accadrebbe se i satelliti smettessero improvvisamente di funzionare: GPS che vanno in tilt, disastri aerei, incidenti navali, interruzione delle comunicazioni con sullo sfondo il timore dell'attacco di una Potenza straniera. Il film è basato sull'omonimo libro dello scrittore americano Rumaan Alam che Obama aveva già segnalato tra le sue letture estive nel 2021. Il regista Sam Esmail, in un'intervista a Vanity Fair, ha dichiarato che l'ex presidente ha collaborato alla stesura della sceneggiatura dando molti suggerimenti:
"Nelle bozze originali della sceneggiatura ho sicuramente spinto le cose molto più in là rispetto al film e il Presidente Obama, con l'esperienza che ha, è stato in grado di mettermi un po' in guardia su come le cose potrebbero svolgersi nella realtà".

Frediano Finucci (Lucca, 1968) è il capo della redazione economia ed esteri del Tg de La7, rete dove conduce la trasmissione Omnibus e per la quale è stato inviato speciale, corrispondente da Bruxelles (2003-2006) capo della redazione di Otto e mezzo. Laureato in storia delle relazioni internazionali alla facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze, ha lavorato nelle redazioni di Milano del telegiornale di Videomusic e di TMC seguendo, come cronista giudiziario, tutta l'inchiesta Mani Pulite. Ha esordito nella narrativa per bambini nel 2008 con quattro libri pubblicati in Italia da Mondadori e in Spagna da Anaya-Hachette. Operazione satellite, vincitore del premio nazionale Cerruglio, è il suo primo saggio, tradotto anche in inglese (The Great game of satellites, Ebook) ed in francese (La guerre des satellites, editions L'artilleur) .


lcuni brand nascono per restare legati al proprio territorio. Altri, invece, lo portano nel mondo. Opificio Modenese è uno di questi, un marchio nato nel distretto tessile di Carpi e che oggi parla alle donne americane con uno stile vivace, ricco di colore e carattere. Abbiamo incontrato la sua fondatrice Gloria Trevisani per ripercorrere i passi che hanno portato il brand dall’Emilia a New York e scoprire cosa significa sbarcare negli Stati Uniti con un piccolo brand di moda.
D. Gloria, com’è nato il progetto Opificio Modenese?
R. Ho iniziato a lavorare per importanti marchi italiani e internazionali da giovanissima. A un certo punto è sorto in me il desiderio creare qualcosa di mio, così nel 2015 è nata la collezione zero, una piccola capsule di capi che ogni donna avrebbe dovuto avere nel proprio guardaroba realizzata con tessuti di altissima qualità.
Ma la scintilla è arrivata nel 2012, quando il terremoto ha colpito l’Emilia. In quel momento ho sentito di dover fare qualcosa per il mio territorio, trasformare lo smarrimento in progettualità. Ecco perché “Opificio”, dal latino posto dove si trasforma la materia prima. E “Modenese”, che racconta il nostro legame con la terra da cui tutto ha avuto origine.
D. Quando e perché avete deciso di guardare agli Stati Uniti?
R. L’opportunità è arrivata durante un’iniziativa con un’associazione di categoria in collaborazione con ExportUSA, nel 2018. In quel momento abbiamo intuito che il nostro brand poteva essere attraente per il mercato americano. Dopo la pandemia, grazie a un’iniziativa di internazionalizzazione promossa da SACE-SIMEST, abbiamo deciso di fare il salto e lanciarci davvero.
D. Quali sono stati i primi passi per farvi conoscere in America?
R. Il nostro biglietto da visita è stato Anteprima Pop Up, uno spazio espositivo e di vendita che ha portato sul territorio newyorkese Opificio Modenese e altri nuovi




marchi Made in Italy. Devo dire che è stato davvero un ottimo strumento di lancio perché ci ha fatto toccare con mano il potenziale del mercato. Poco dopo abbiamo individuato uno showroom che ci rappresentasse e curasse le campagne vendita stagionali.
D. Vestire Carrie Underwood durante l’insediamento di Trump alla Casa Bianca è stato un traguardo importante. Come ci siete arrivati?
R. Vestire una popstar di fama mondiale per un evento di tale portata è stato per noi un grande motivo di orgoglio. È andata così: un u cio stampa che aveva i nostri capi le ha presentato la collezione; da qui la scelta dell’artista di un abito molto particolare con drappeggi e pieghe irregolari che consente un’ottima vestibilità e un ottimo impatto sul corpo femminile.
D. Come ha influito questo sull’immagine del brand, in America e in Italia?
R. A livello comunicativo è stato molto impattante. La notizia è stata condivisa da molti giornali italiani ma a noi ha portato ulteriore visibilità anche all’estero.
D. L’esperienza americana ha influenzato il vostro modo di pensare e fare moda?
R. Molto. I nostri capi sono venduti in tipologie di negozi molto eterogenee e vengono scelti da donne con stili e vissuti diversi. Questo ha fatto sì che adesso, in fase di ideazione delle collezioni, il nostro impegno sia ancora più focalizzato sulla ricerca delle forme e dei temi che possano incontrare il gusto di queste donne così diverse tra di loro. L’America ci ha aiutato ad ampliare lo sguardo mantenendo un’identità ben riconoscibile.
D. Che tipo di consiglio ti senti di dare a chi sogna l’America?
R. Non mi sento nella posizione di dare tanti consigli in quanto il nostro marchio negli USA è ancora in “costruzione”. Sicuramente, però, posso dire questo: che si tratta di un mercato così vasto e pieno di sfumature da o rire possibilità a chiunque abbia un sogno e delle idee chiare sul proprio percorso. Affidarsi poi a società come ExportUSA, che accompagnano l’impresa durante questo iter, aiuta a orientarsi e a intraprendere la strada più adatta. Il mio consiglio è quindi di provare e perseverare!

“L’America ci ha aiutato ad ampliare lo sguardo mantenendo un’identità ben riconoscibile."
— Gloria Trevisani Founder Opificio Modenese








A cura della redazione di EXPORTUSA
cendendo giù lungo la Pacific Coast Highway, curva dopo curva gli occhi mi si riempiono di un'irresistibile meraviglia. Si capisce subito che questi luoghi non appartengono alla geografia, ma all’anima. Big Sur è uno di questi.
Non è una città, non ha confini né centro, e se ci arrivi non sai mai davvero quando sei dentro o fuori. È come l’idea di libertà, ti sfugge tra le mani mentre pensi di averla a errata. Ma se chiudi gli occhi e ascolti l’oceano rompersi contro le scogliere, allora capisci perché Jack Kerouac ci è finito, e perché ci è tornato — ubriaco, sconfitto, eppure ancora alla ricerca del significato della bellezza.
Big Sur non è un indirizzo. È un rifugio primordiale, un altarino di legno in mezzo al nulla dove i poeti si sono inginocchiati per sputare sangue e parole. Kerouac ci scrisse un romanzo colmo di crisi e allucinazioni, un diario di sopravvivenza tra l’alcol e la disperazione, mentre il mito del viaggio americano iniziava a crollargli addosso. Era ospite di Ferlinghetti, altro sciamano della parola, editore eretico che pubblicò Howl quando ancora si poteva finire in galera per una poesia. In quella capanna, nel verde assordante dei boschi sopra l’oceano, Kerouac si è spogliato della sua epopea per mostrare le vene: rotte, tremanti, ma vive.
Ho cercato di ritrovarmi in quei luoghi, quelli dove Big Sur era la destinazione segreta della Beat Generation. Non quella che
vendi nei poster, ma quella vera, sporca, affamata di silenzio, a ollata di demoni. Una terra interstiziale tra l’America del sogno e quella della fuga. Non si veniva qui per fare foto come oggi si veniva a scappare. Da New York, da San Francisco, da Los Angeles, da se stessi. E intanto la Highway 1 ti culla curva dopo curva come una nenia ipnotica, soprattutto perché queste serie di curve sono scolpite nella roccia, l’oceano che ti affianca come un animale in corsa, il cielo che si piega sopra di te come un vecchio lenzuolo consunto. E poi il profumo, mio Dio quel profumo. L'Oceano Pacifico ha un profumo completamente di erente da tutti gli altri mari che abbia mai respirato. Ti rimane incastonato tra la mente e l'anima.
Adesso capisco perché Kerouac non ci arrivò per caso. Ci arrivò quando aveva finito il carburante del sogno americano. Dopo On the Road, dopo le notti al Village, le letture con Ginsberg, le peregrinazioni alcoliche da costa a costa. Arrivò a Big Sur come si arriva a un confessionale — con i postumi della gloria, la bocca amara, la voglia di sparire. Si rifugiò nella capanna di Lawrence Ferlinghetti, editore e poeta, uno che stampava bestemmie in versi e le vendeva come reliquie. Lì, tra la legna umida e il respiro degli alberi, scrisse Big Sur, quel libro che nessuno scrittoreha mai avuto voglia di scrivere. Una confessione, una caduta, un grido d'aiuto, un attacco di panico. Non c’era più la bellezza selvaggia della gioventù, c’era l’eco. L’alcol. Le allucinazioni. La verità.

Perché Big Sur non ti accoglie. Ti scuoia. Ti chiede chi sei, senza trucco, senza pubblico, senza citazioni. Ti sbatte davanti lo specchio dell’oceano e ti dice: “Ora parla”.
La litoranea pacifica è il rosario laico di questa liturgia. Curve tagliate nella memoria, ponti che sembrano sospesi sull’infinito, dirupi che riducono la tua macchina a un’ipotesi. Guidare qui non è un passatempo. È un pellegrinaggio. Ci si ferma ogni dieci minuti a fissare qualcosa che non si riesce a descrivere. L’oceano cambia colore ogni miglio. Le montagne scompaiono e poi tornano, come rimorsi. E tu, piccolo essere umano motorizzato, ti senti improvvisamente fuori scala. Non si parla a voce alta a Big Sur. Si bisbiglia. Si fotografa, Si scrive su taccuini consumati. Si raccolgono pietre per ricordare il tempo. I beatnik non venivano qui per socializzare. Venivano a svuotarsi. A fare i conti.>>
“...Se non scrivo quello che vedo e ettivamente accadere su questo globo infelice racchiuso nei contorni del mio teschio penserò che il povero Dio mi abbia mandato sulla terra per niente...."
— Big Sur, Jack Kerouac -1962


La Highway 1, considerata una delle strade panoramiche più belle del mondo, è l’arteria principale per raggiungere Big Sur. Inserita da Condé Nast Traveler tra le dieci vie più iconiche al mondo, al pari di Broadway e degli Champs-Élysées.
Ogni anno, circa 7 milioni
di visitatori percorrono questa stretta strada a due corsie, spesso senza mai abbandonarla: la catena dei Santa Lucia Mountains, infatti, rende quasi impossibile l’accesso da altre vie. L’unica alternativa asfaltata, la Nacimiento-Fergusson Road, è stata chiusa nel 2021 e riaprirà solo a fine 2025.
Nei weekend festivi e in estate, il tra co si blocca per ore, in particolare tra Carmel e il Bixby Creek Bridge. La strada è tortuosa, senza corsie di sorpasso e con curve cieche e scarpate a picco sull’oceano.
In certi punti, le piazzole di sosta sono quasi inesistenti.
L’esplosione dei social ha aggravato la situazione: luoghi iconici come Pfei er Beach, McWay Falls e il Bixby Bridge sono presi d’assalto. I parcheggi scarseggiano e molti turisti lasciano l’auto a bordo strada, creando pericoli e ostruzioni. Alcuni si fermano in mezzo alla carreggiata solo per scattare foto.
Nel 2023, il tra co medio era di 7.400 veicoli al giorno, con picchi fino a 17.000. Il campeggio abusivo lungo la strada è punito con multe fino a 1.000 dollari. L’area di Pfei er Beach, servita da una sola strada stretta (Sycamore Canyon Road), è inaccessibile quando il parcheggio si riempie. Non ci sono servizi igienici: i residenti lamentano rifiuti, carta igienica e deiezioni nei cespugli.
Tutto ci si aspetterebbe da queste parti meno che di trovare un eremo di frati Camaldolesi. Ubicato in una bellissima posizione panoramica, il New Camaldoli Hermitage (sito u ciale) è aperto alle visite, con la possibilità di acquistare prodotti artigianali e alimentari.
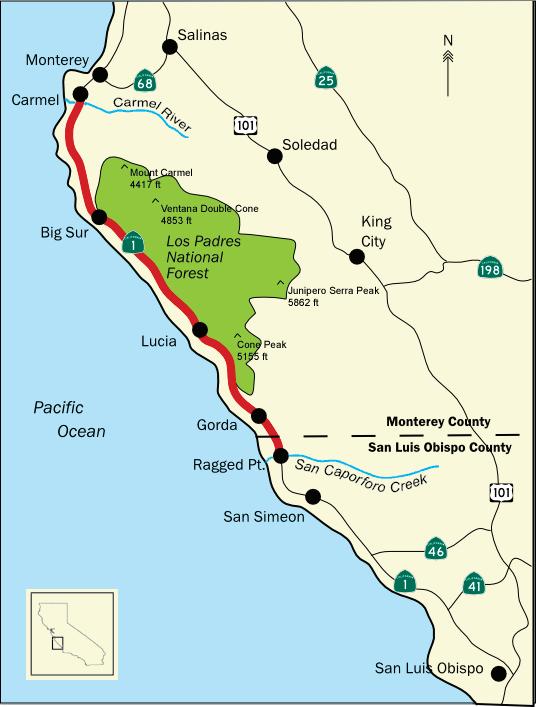
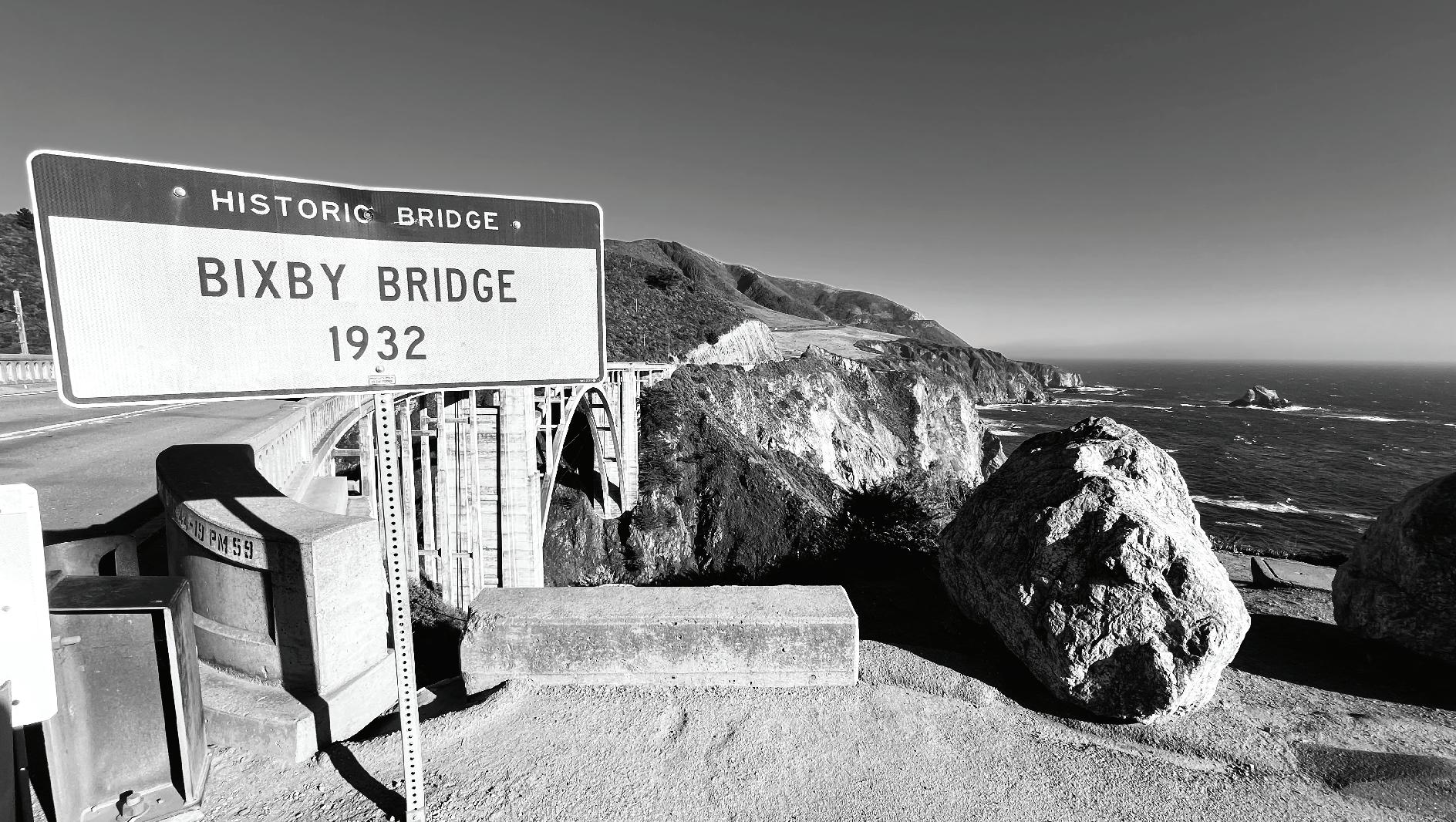

C’è chi dice che Big Sur sia cambiata. Che oggi la invadano i SUV, gli influencer, i brunch macrobiotici. Forse è vero. Ma Big Sur se ne sbatte altamente. Ha visto troppi fuggitivi per preoccuparsi dei turisti. Puoi scattare tutte le foto che vuoi, ma non catturerai mai l’odore di quei fiorellini gialli sul ciglio della strada alle cinque del mattino, il rumore di quelle gigantesche onde che si infrangono sugli scogli. Ci sono ancora i rifugi, le piccole locande,
i centri di meditazione, le librerie strane. E ogni tanto, dietro un tronco bruciato, trovi uno che scrive. Magari non è un poeta. Magari è solo uno che ha capito che la libertà non si trova nelle grandi metropoli chiassose, su linkedin, nelle firme dei contratti. Ma in un paesaggio bucolico, in un respiro profondo, in un posto che è un non posto. Alla fine, Big Sur è l’antidoto all'ostentazione, alla falsità, alla velocità dei cambiamenti di quest'epoca così
avulsa. È un luogo senza tempo, dove anche i pensieri devono rallentare per non essere sbalzati fuori strada. Chi ci arriva per caso spesso non ci torna. Chi ci arriva per destino, non se ne va mai davvero. Perché Big Sur è il bordo. Il bordo dell’America. Il bordo della coscienza. Il bordo della sopravvivenza.E se stai leggendo queste righe con un certo groppo in gola, forse, senza saperlo, ci sei già stato anche tu .











ppena parte la sigla di Big Little Lies, con quella ripresa aerea che serpeggia tra le scogliere della California, vorresti essere lì, al volante di una decappottabile, con il vento tra i capelli e l’oceano accanto. Reese, Nicole e Meryl saranno pure le protagoniste, ma è Monterey County a rubare la scena: panorami da togliere il fiato, cene al tramonto, incontri scomodi nei parcheggi. O quasi.
La costa come in un film Si chiama Pacific Coast Highway, ma tutti la conoscono come Highway One. Parte dal confine con l’Oregon e scende fino a San Diego, ma è il tratto che attraversa Big Sur, Monterey e Carmel a rendere iconica questa strada. Scogliere che cadono a picco sul Pacifico, curve strette che sembrano disegnate apposta per rallentarti, e ogni tanto un punto panoramico per lasciarti senza parole. Letteralmente.
Sogni blu in fondo al mare Su Cannery Row, tra ex fabbriche di conserve oggi diventate boutique e ristoranti, sorge uno degli acquari più spettacolari al mondo: il Monterey Bay Aquarium. Più di 35.000 creature marine, otarie, meduse e polpi rossi che Jane e Ziggy visitano nella prima stagione. Qui Jane lavora nella seconda, tra vasche
trasparenti e laboratori didattici.
E subito fuori, l’oceano vero: puoi uscire per un’escursione in barca e vedere balene, delfini e leoni marini nel loro habitat.
Drammi e albe rosa
Qui Jane porta suo figlio per un picnic, e qui avviene uno degli scontri più tesi tra i mariti di Madeline. Lovers Point è una spiaggia perfetta per kayak, surf o semplicemente per guardare il sole sorgere — evento raro sulla West Coast, che qui si specchia sull’acqua. Scalare le rocce che danno il nome al luogo è d’obbligo, per una vista da togliere il fiato.
Fisherman’s Wharf
A Monterey, Fisherman’s Wharf è il centro delle confessioni e dei pettegolezzi delle protagoniste. Cammina tra le barche, compra qualcosa nei negozietti o prendi un caffè alla Paluca Trattoria, il ristorante che nella serie è il Blue Blues Café, ritrovo u ciale delle Monterey Five. Se sei fortunato, vedrai anche qualche leone marino schiacciare un pisolino sulle rocce.
Jogging, balli e libertà Poco lontano dall’acquario, Del Monte Beach è il posto dove Jane corre e balla per scaricare la tensione. Sabbia fine, tavoli per picnic, fire pit sulla spiaggia e passerella in legno per una lunga camminata al tramonto. E sì, i cani sono benvenuti.

Carmel e il lusso discreto Celeste abita a Carmel Highlands, una delle zone più esclusive d’America. Tra pini, cipressi e mare in tempesta, la sua casa nasconde dolori silenziosi e bellezze eteree. Fai il 17-Mile Drive a Pebble Beach: una delle strade più fotogeniche del mondo, tra leoni marini, rocce scolpite dal vento e l’iconico Lone Cypress, solitario e immortale su uno sperone di roccia.
Point Lobos
A 20 minuti da Monterey, la Point Lobos State Reserve è un paradiso per camminatori e sognatori. Segui le orme di Bonnie e vai a riflettere tra i sentieri o in kayak tra otarie, foche e uccelli marini. Qui la California è quella vera: selvaggia, silenziosa, sacra.
Bixby Bridge
Il Bixby Bridge, protagonista assoluto dei titoli di apertura, è uno dei ponti più alti della California. A pochi passi, la meraviglia di McWay Falls, una cascata di 24 metri che si getta su una spiaggia perfetta incorniciata dai redwood giganti del Julia Pfeiffer Burns State Park. Un paesaggio che non sembra reale, e invece lo è. Dove dormire come una star. Se vuoi chiudere la giornata come Madeline e Renata (ma senza litigare), prenota al Monterey Plaza Hotel and Spa. La vista è quella sull’oceano, il drink te lo servono sul rooftop con tanto di fire pit, e puoi anche farti coccolare alla spa vista onde.
Una vera mamma di Monterey Non hai un’auto? Nessun problema. Noleggiala a San Jose o a Monterey. E se vuoi davvero sentirti parte del cast, scegli qualcosa con stile: un SUV con sistema di intrattenimento per i figli, navigatore e playlist di Big Little Lies in sottofondo. Con l’app di Avis puoi fare tutto dal telefono, compreso l’upgrade dell’auto per sentirti una vera Renata Klein.



2017 - Premio Emmy
Miglior miniserie o film televisivo
Miglior regia per un film, miniserie o speciale drammatico a Jean-Marc Vallée
Migliore attrice in una miniserie o film televisivo a Nicole Kidman
Migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo a Laura Dern
Migliore attore non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo a Alexander Skarsgård
2018 - Golden Globe
Miglior miniserie o film televisivo
Migliore attrice in una miniserie o film televisivo a Nicole Kidman
Migliore attore non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo a Alexander Skarsgård
Migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo a Laura Dern


Ci sono cibi che nutrono. E poi c’è il burrito, che racconta. Per capire il burrito californiano bisogna spingersi oltre la tortilla, oltre il riso, oltre il manzo alla griglia e le salse che colano come verità taciute. Bisogna attraversare confini, ascoltare le radio latine nei chioschi di San Diego, seguire l’odore del coriandolo tra i vicoli della Mission a San Francisco, perdersi tra le palme e il cemento rovente di Los Angeles. Il burrito californiano è figlio di una frontiera che non ha mai voluto essere una linea. È una storia arrotolata su sé stessa, piena di ingredienti, esodi, contaminazioni, fame.
Dalle miniere al Messico-America
Le origini del burrito si collocano nel Nord del Messico, in tempi in cui i lavoratori rurali
avevano bisogno di un pasto portatile, compatto e nutriente. La parola stessa, "burrito", significa "asinello" — forse per la forma, forse per la resistenza, forse per l’umile ostinazione con cui accompagnava chi faticava. Con l’ondata migratoria messicana nel ventesimo secolo, il burrito attraversa il confine e si reinventa nel grande laboratorio culturale della California.
Non è più solo un piatto, è il simbolo della fusione tra Messico e Stati Uniti, tra povertà e ambizione, tra tradizione e accelerazione. Entra nei diner, nei campus, nei menu hipster, nei truck notturni. Si adatta come un dialetto, resta autentico come una nonna.
Il mito della Mission
Negli anni Settanta, tra le strade polverose della Mission District di San Francisco, nasce il burrito che oggi conosciamo: grande, gonfio, avvolto nel foglio d’alluminio
e pieno fino all’inverosimile. Riso, fagioli, carne, guacamole, pico de gallo, panna acida, cheddar fuso: una bomba calorica che diventa comfort food per generazioni di studenti, artisti, muratori e manager in cerca di qualcosa di vero. Si chiama Mission Style Burrito ed è un’ode all’eccesso californiano, ma con radici che a ondano nella cucina povera del Sud. È qui che il burrito smette di essere solo cibo e diventa lifestyle. Una dichiarazione di appartenenza. Il burrito è per chi lavora, per chi sogna, per chi corre. E sempre più, è per chi sceglie.
Los Angeles risponde
Mentre San Francisco lo trasforma in arte barocca, Los Angeles rilancia con il burrito minimalista: niente riso, niente fronzoli, solo carne, formaggio e salsa, spesso avvolti in una tortilla appena scottata, dalla consistenza che ricorda più la seta che il pane. È il California Burrito, e ha un colpo di


scena, le patatine fritte dentro. Un sacrilegio per i puristi, una rivelazione per chi ama vivere al limite. Nel frattempo, a San Diego, si consolida una versione più spavalda, quasi atletica: meno spezie, più carne, più sostanza, più proteine. I surfisti lo abbracciano, i nutrizionisti lo tollerano, gli chef lo reinterpretano.
Il burrito oggi: tra culto e comfort
Nel 2025 il burrito è un’icona. Si trova nei fast food e nei ristoranti stellati, nei supermercati bio e nei baracchini a bordo strada. È vegan, keto, gluten-free, fusion. Ma resta, nel suo cuore, una stretta di mano tra culture che si sono incontrate e mescolate a suon di fame, lavoro e desiderio di futuro.
C’è qualcosa di profondamente americano e profondamente messicano nel burrito. Qualcosa di ribelle e insieme accogliente. È il piatto che non ha paura di cambiare forma, ma non dimentica mai da dove viene.
Epilogo avvolto in stagnola
Mangiare un burrito californiano oggi significa mordere un pezzo di storia. Di più: significa accettare che l’identità sia fatta di strati, di mix, di sapori che non sempre vanno d’accordo — ma che insieme creano qualcosa di nuovo. Di buono. Di nostro.

Non è più solo un piatto, è il simbolo della fusione tra Messico e Stati Uniti, tra povertà e ambizione, tra tradizione e accelerazione. “
Perché in fondo, in quel rotolo di tortilla, c’è il sogno americano con una spruzzata di lime. E il morso, se fatto con rispetto, è sempre un atto d’amore.












"Big Sur" di Jack Kerouac
Romanzo crudo e allucinato, racconta il crollo di Kerouac tra la natura selvaggia della California e il peso insostenibile della fama. Nessuna celebrazione della libertà, solo disillusione e fuga. Da leggere per chi vuole conoscere il lato oscuro della Beat Generation.
1962 | Penguin Modern Classics

Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!
Il film inaugurale della serie, con Clint Eastwood nei panni dell’ispettore
“Harry Callahan” di San Francisco. Un thriller asciutto, feroce, ispirato al killer Zodiac. Ha inaugurato un archetipo,: il poliziotto solitario, duro, senza mezze misure.
Don Siegel, 1971 | Warner Bros

Déjà Vu Crosby, Stills, Nash & Young (1970) - Atlantic Records
Un manifesto folk-rock intriso di disillusione post-Woodstock. Le armonie vocali sono scolpite nel tempo, mentre brani come Helpless e Our House narrano la fragilità dell’American Dream. Politico, intimo, e ancora dannatamente attuale.

"Tropico del Cancro" di Henry Miller
Romanzo feroce, erotico e visionario. Miller scrive da Parigi ma con l’anima sradicata, alternando pornografia e filosofia, rabbia e poesia. Un inno alla libertà individuale contro ogni ipocrisia borghese. Ancora scandaloso, ancora necessario.
1934 | Obelisk Press / Adelphi

Mulholland Drive
Storico film noir surrealista e nonlineare ambientato a Hollywood. La storia di due donne, Naomi Watts e Laura Harring, si intreccia in un labirinto onirico di identità perdute e ambizioni infrante. Capolavoro moderno e ossessione collettiva dei cinefili.
David Lynch, 2001 | Universal

Workingman's Dead Grateful Dead (1970) - Warner Bros
Un ritorno alla terra, folk, country, armonie polverose e storie da saloon. I Dead smettono di volare e cominciano a camminare, ma con lo stesso spirito libero. Essenziale, caldo, umano. Il tutto guidato dalla maetstria di Jerry Garcia e Robert Hunter.

"I racconti di San Francisco" di Armistead Maupin
Cronache ironiche e a ettuose di una San Francisco anni ’70. Amori, segreti e identità in transizione in un mondo che cambia. Leggero solo in apparenza, è un piccolo a resco umano di straordinaria sensibilità narrativa.
1978 | Harper & Row / BUR Rizzoli

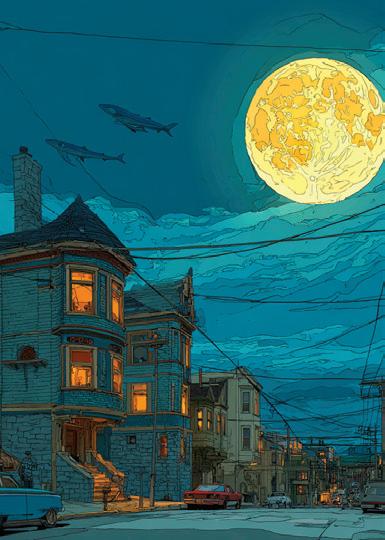
"Chiedi alla Polvere" di John Fante
Cronache ironiche e a ettuose di una San Francisco anni ’70. Amori, segreti e identità in transizione in un mondo che cambia. Leggero solo in apparenza, è un piccolo a resco umano di straordinaria sensibilità narrativa.
1939 | Stackpole Sons / Einaudi


di un
Autobiografia fuori controllo, ironica e malinconica. Eggers racconta la perdita dei genitori e la custodia del fratellino con stile frenetico e autoanalisi brutale. Un memoir che reinventa il genere, giocando col dolore come fosse una pagina da strappare. 2000 | Simon & Schuster / Mondadori

Zabriskie Point I tre giorni del Condor Provaci ancora, Sam!
L’unico film girato da Antonioni negli Stati Uniti, con protagonisti non-professionisti tra la ribellione studentesca di Los Angeles e le desolate distese della Death Valley. Oggi considerato un “cult” per la sua estetica ma debitamente controverso.
M.Antonioni, 1970 | MGM
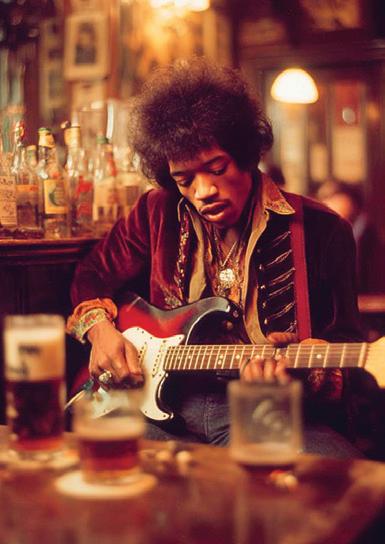
Axis: Bold as Love The Jimi Hendrix Experience (1967) - Reprise Records
Hendrix apre il terzo occhio della chitarra elettrica. Little Wing è una poesia liquida, If 6 Was 9 una dichiarazione d’indipendenza cosmica. Psichedelia, soul, blues: un trip al centro della mente.
Thriller paranoico perfetto sull’America post-Watergate. Robert Redford è un analista della CIA che scopre troppo e viene braccato dai suoi stessi colleghi. Un film teso, elegante, con Faye Dunaway fredda e ambigua. Ancora attuale, ancora inquietante.
Sidney Pollack, 1975 | Paramount

Surrealistic Pillow Je erson Airplane (1967) - RCA Victor Records
Il suono del 1967 distillato in un vinile. White Rabbit e Somebody to Love sono inni lisergici, partoriti tra le nebbie di Haight-Ashbury. Un cuscino pieno di incubi dolcissimi, degno della sua etichetta.
Woody Allen è alle prese con un alter ego nevrotico e romantico, guidato dallo spirito di Bogart. Commedia brillante sul fallimento sentimentale maschile. Dialoghi a lati, ritmo teatrale, malinconia sotto la risata.
Herbert Ross 1972 | Paramount

Astral Weeks Van Morrison (1968) - Verve Records
Un disco che non si ascolta, si respira. Van Morrison canta come se stesse sognando a occhi aperti, tra jazz, folk e soul mistico. Astral Weeks è una seduta di ipnosi emotiva, in cui il tempo sparisce e l’anima viaggia.



A cura della redazione di ExportUSA
La svolta per gli Stati Uniti arriva con transiti planetari che scuotono le fondamenta economiche, culturali e identitarie della nazione. Giove entra in Cancro e apre una fase di espansione guidata da valori domestici: investimenti in salute, infrastrutture e coesione sociale. Saturno invece impone rigore e responsabilità: i conti pubblici tornano al centro del dibattito, il debito va ridotto, le strutture rinforzate.
Urano e Nettuno spingono verso un profondo ripensamento del modello sociale: l’America si muove tra spiritualità, intelligenza artificiale e nuove relazioni internazionali. Plutone continua il suo lavoro di scavo nella struttura del potere: giustizia, governo e ideologia passano sotto torchio.
Nel frattempo, l’identità collettiva americana oscilla tra il desiderio di progresso e il bisogno di ritrovare un senso di appartenenza. Il Made in USA torna centrale, la tecnologia esplode, ma cresce anche l’urgenza di relazioni più vere, meno performative.
Segni Favoriti
Gemelli e Cancro brillano nel rinnovamento sociale e culturale.
Pesci e Acquario cavalcano l’onda spirituale e creativa. Vergine e Bilancia si affermano nel mondo delle relazioni internazionali e della diplomazia economica.
Segni Sfidati
Ariete e Leone dovranno frenare l’impulsività e imparare ad ascoltare. Toro e Scorpione affrontano l’erosione delle certezze materiali. Capricorno è messo alla prova da Plutone, o cambia, o implode.
Non sarà un resto dell'anno facile, ma sarà necessario. L’America deciderà chi vuole essere nei prossimi decenni. Gli astri non promettono miracoli, ma o rono una possibilità: quella di rinascere, di guardarsi dentro.
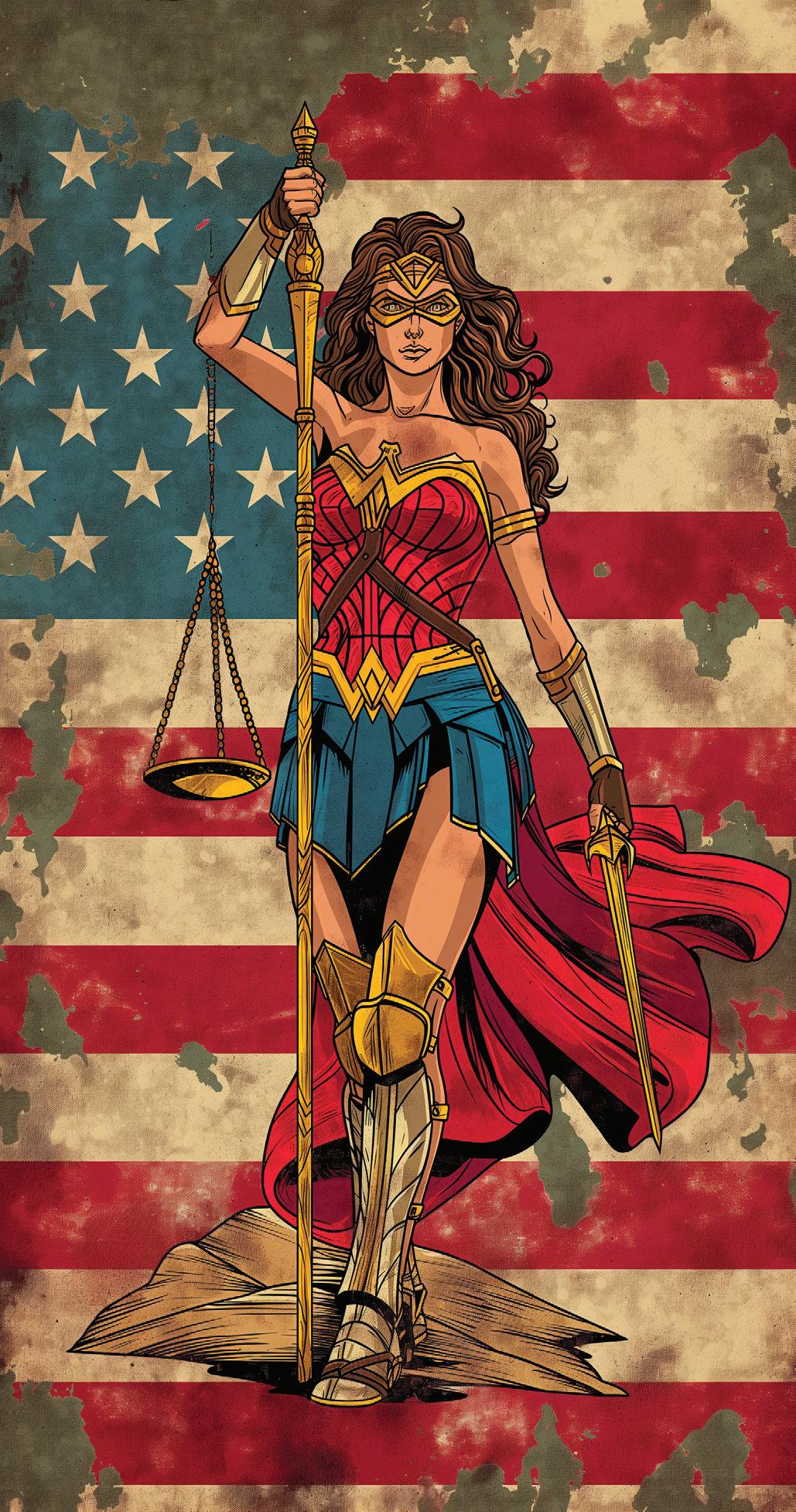

(21 MARZO - 19 APRILE)
Vuoi tutto e lo vuoi ieri. Peccato che quest'anno ti sbatta in faccia un concetto rivoluzionario, pazienza ariete. Ogni tua idea geniale verrà rallentata da burocrazia, NDA, CFO pavidi e investitori che ti ghostano. Se hai una startup, preparati a sentirti dire “torniamo a parlarne in Q4” per tutto l’anno.

(23 LUGLIO - 22 AGOSTO)
Ciao Leo, finalmente un palco su cui puoi brillare, il marketing e le industrie creative. Usa il tuo carisma per vendere prodotti inutili agli ignari consumatori, mascherando il tutto come "musthave innovations." Il tuo ego sarà sazio e il tuo portafoglio anche.
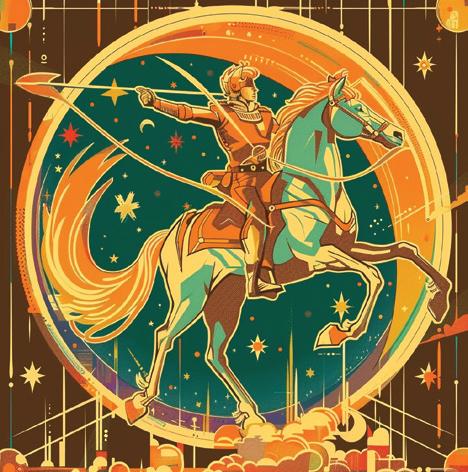
(22 NOVEMBRE - 21 DICEMBRE)
Vorresti libertà, viaggi, orizzonti. Ma scoprirai che il remote work è finito, e il tuo “u cio liquido” si è trasformato in una scrivania tra un idraulico e il Wi-Fi ballerino. Lanci un nuovo business ogni trimestre e poi ti chiedi perché il tuo conto è in rosso. Rientra, cowboy.
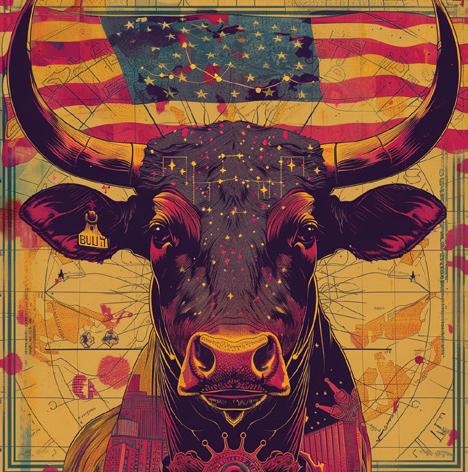
(20 APRILE - 20 MAGGIO)
Amante della stabilità, tu torello verrai travolto da licenziamenti, fusioni e cambi di policy scritti alle 3 di notte da un algoritmo. Il tuo modello Excel non regge più: i margini crollano, ma tu continui a credere nel “valore del prodotto”. Rassegnati: vince chi ha il pitch deck più patinato, non chi produce davvero qualcosa.

(23 AGOSTO - 22 SETTEMBRE)
Precisina, ordinata, ipercontrollo. L'anno in corso ti vomita addosso caos, bug, fornitori cinesi in ritardo e file Excel corrotti. Tu provi a sistemare tutto con una checklist, ma il mondo intorno a te parla solo in acronimi e keynote motivazionali. Crolli. Ma con ordine.

(22 DICEMBRE - 19 GENNAIO)
Ambizione, disciplina, scalata verticale. Purtroppo quel cattivone di Plutone ti gioca brutti scherzi cornutello di un capricorno. Chiudi l’anno con un carico di ansia da performance e un coaching sulla mindfulness. Chiediti se sei ancora umano o sei solo un KPI.
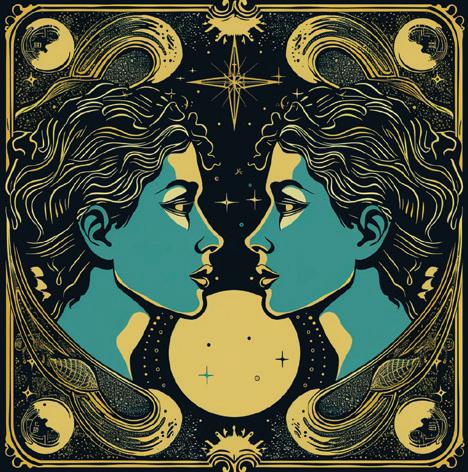
(21 MAGGIO - 20 GIUGNO)
Sei brillante, frizzante, multitasking. Anche troppo. Fai colloqui con tre aziende, lanci un podcast, apri un brand di dentifricio “esperienziale”. Ma tra un reel motivazionale e un workshop sul growth hacking, ti accorgerai che nessuno ti paga più da settimane. Bentornato nel mondo reale gemelli.

(23 SETTEMBRE - 22 OTTOBRE)
Nel tentativo di piacere a tutti, finirai col non convincere nessuno. Ti muovi tra partnership “win-win” e team building obbligatori, ma sotto sotto non sai cosa vuoi. Consiglio: scegli una parte. Anche se sbagli. Almeno non verrai accusato di “mancanza di visione”.

(20 GENNAIO - 18 FEBBRAIO)
Visionario, alternativo. Il sistema ti adotta per poi sputarti via. Lavori in un'azienda “disruptive” che finisce in tribunale per abuso di dati. L’NFT che hai lanciato nel 2022 è ora uno screenshot sul desktop di tua madre. Forse è tempo di tornare a fare l'artista, o almeno fingere meglio.

(21 GIUGNO - 22 LUGLIO)
Emotivo e nostalgico come sempre, ti ostinerai a credere che le aziende siano famiglie. Non lo sono. Ti licenzieranno via Slack con una emoji. Ogni tua idea verrà definita “non allineata al brand purpose”. Ma hey, almeno potrai piangere in open space con stile.

(23 OTTOBRE - 21 NOVEMBRE)
Strategico, vendicativo, magnetico. Il 2025 ti vede scalare posizioni con determinazione. Ma occhio che il karma aziendale ti osserva. Se ti illudi di controllare tutto, ti ritroverai con un team che ti odia, un CEO che ti copia le idee e un junior che ti frega la promozione.

(19 FEBBRAIO - 20 MARZO)
Empatico e sognatore, continuerai a proporre campagne di marketing “che parlano al cuore”. Ma i clienti vogliono i numeri. Tu parli di anima, loro di ROI. Alla fine ti ritiri in un coworking spirituale a Joshua Tree con altri creativi delusi, vendendo candele “brandizzate”. Ironico, vero?