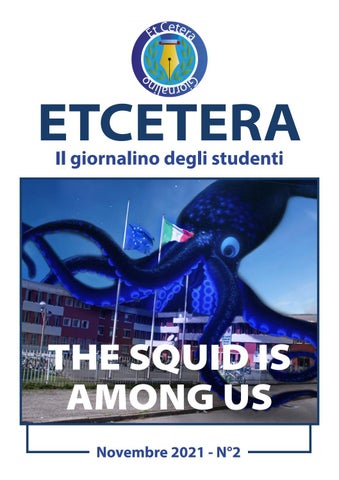6 minute read
Squid Game: bello, ma
STEFANO ROVERE, 4D
Squid Game è una serie di recente uscita che ha spopolato su… Suvvia, la conoscete tutti. Impossibile non averne sentito parlare, tantissimi l’hanno vista. Bella serie no? Beh, sì ma. “Sì ma” per molti motivi, che spaziano dalla regia al messaggio, valido ma nel contempo nullo. Ah, e questa recensione contiene spoiler.
Advertisement
Sulla regia:
Affrontando questa serie con un certo ottimismo, dovuto alla mia passata, umile ma buona, esperienza con la minuzia nei dettagli della regia orientale, derivata da registi come Kurosawa (I sette samurai o Rashomon), un più recente Kore’eda (Shoplifters) o un coreano Bong Joon-ho (Parasite), non nego di essermi chiesto il motivo di alcune scelte dubbie e di errori facilmente evitabili. Errori evidenti sono stati, ad esempio, quelli della figura dell’ombrello nella partita a “Caramello”, che a distanza di pochi secondi cambia forma tra un’inquadratura e l’altra, o del biglietto da visita alla stazione di polizia, prima in mano all’agente e subito dopo appoggiato sul tavolo,per poi ritornare ancora una volta in mano all’agente nel taglio successivo. Le scene di dialogo sono spesso molto confuse, con errori di raccordo abbastanza evidenti per tutte le persone un minimo interessate alla cinematografia. Per quanto riguarda la fotografia, essa è valida ma comunque inferiore ad altre opere presenti sulla piattaforma: mancano tutte quelle scene che hanno reso celebri, tra le altre, serie come Breaking Bad, o i quadri in movimento che accompagnano la narrazione della trama, raccontando le contraddizioni della società occidentale, ispirati ad American Beauty. Anche la scenografia non mi ha convinto: troppi i personaggi passivi e senza ruolo nella trama. E’ davvero possibile che i soldati fossero così obbedienti e che non avessero nessuna esitazione anche davanti alle richieste più assurde, ma che fossero privi di emozioni o di umanità? Troppe sono anche le contraddizioni e le falle nella narrazione: se i soldati sono così obbedienti e la sicu-
rezza è così serrata in ogni punto dell’isola, come si è potuta formare una rete di compravendita d’organi all’insaputa degli organizzatori, con tanto di barche per il ritiro della merce? O ancora, il concorrente 456, protagonista, non ha ricevuto un vantaggio nell’episodio 6 con la possibilità passare il gioco delle biglie senza competizione, andando contro le regole stesse del gioco? Mancano inoltre spiegazioni riguardanti il funzionamento del sistema: come sono arrivati i soldati a essere tali? Perché sono così preparati a uccidere ed essere uccisi? Qual è il motivo dietro la forzata anonimità?. Per non parlare del finale, che rovina l’opera intera: un colpo di scena estremamente prevedibile, non necessario e completamente senza senso, che distrugge la scena con più pathos di tutti e nove gli episodi: quella della morte del concorrente 1.
Finzione o realtà?
La serie vuole raccontare la vera storia del sistema di debiti della Corea che, negli ultimi decenni, è cresciuto passo passo fino a diventare un grande problema per la società della nazione. Si tratta di uno scenario simile a quello cinese, ancora più assurdo, di cui però non scriverò questa volta. Nei primi episodi si racconta di come 455(+1) persone decidano di partecipare a un gioco in cui si va incontro a morte certa pur di avere la possibilità di risanare i propri debiti con la cifra di 45,6 miliardi di Won, 33 milioni e mezzo di euro. In Corea del Sud chiedere un prestito è facilissimo e lo fa quasi chiunque: per comprare una casa, per lanciare un’azienda, per investire, per superare un periodo di crisi lavorativa. Dobbiamo parlare, almeno schematicamente, della guerra di Corea. Per farlo siamo costretti a tornare indietro di una settantina d’anni, ma tranquilli, sarò breve. A metà del 1950, a Guerra Fredda già iniziata, la Corea era divisa in due dal 38° parallelo da confini tra l’area Nord e Sud completamente arbitrari. Entrambe le parti erano controllate da dittature, ma, mentre il Sud vedeva l’Ovest come alleato, il Nord era rimasto con lo sguardo a est. La Corea del Nord decise quindi di schierare le proprie forze per un attacco diretto prima a Seoul, poi all’intera Corea del Sud, al fine di distruggerla ed eliminarla. L’ONU si schierò con il Sud, la Cina e la Russia invece col Nord. La guerra durò tre anni e fece quasi tre milioni di morti, stabilendo i confini che noi oggi conosciamo. Nel 1960 una rivolta studentesca rovesciò il corrotto governo della Corea del Sud, ma prese il potere il generale Park Chung-hee, il quale instaurò una dittatura de facto. Costringendo il Paese ad un forzato sviluppo economico, egli spinse per un capitalismo universale. Lo sviluppo crebbe in maniera esponenziale, fino ad arrivare all’affermazione di brand come Samsung, Hyundai e LG, ma gravò molto sulla società, poiché eliminò ogni freno alle disuguaglianze tra le classi. Questo ha portato, in anni recenti, alla creazione di enti privati che prestano soldi a interessi ridicolmente alti, come il 200%: nell’ultimo anno infatti l’indebitamento totale delle famiglie ha superato
la quota del PIL, come non avviene in nessun’altra nazione dell’est. Pare però che l’impegno di organi oggi non sia tra le modalità di risarcimento richieste dai creditori, come mostrato nella puntata 1 della serie, ma che in passato fosse comunque in uso. Più comuni sono le minacce alla famiglia del debitore accompagnate da persecuzione, una cosetta insomma. Di esempi ce ne sono tanti e prendo dal Los Angeles Times la storia di Park, quarantacinquenne che tre anni fa chiese dei prestiti per la sua caffetteria, allora in difficoltà. Con la pandemia di Covid19 non riuscì a rispettare i tempi del prestito al 210% e si ritrova ora a dover restituire circa 30.000 euro in due mesi, da aggiungere al suo già presente debito di più di 730.000 euro.
Ed eccoci giunti al problema della serie:
Per quanto la serie provi a denunciare questi problemi dovuti allo sfrenato capitalismo delle nazioni in via di sviluppo, come è stato il Giappone e come è oggi il Sud Corea, essa non fa altro che prendersi gioco di questo messaggio, consapevolmente o inconsapevolmente. Certamente ne è consapevole la piattaforma Netflix, che sfrutta una serie che vuole comunicare un messaggio, per quanto possa essere apprezzato o meno, unicamente per alimentare gli introiti della piattaforma. Non voglio fare un discorso anti-capitalista, sia chiaro, ma trovo perlomeno ironico che un’opera che si vuole schierare contro le ingiustizie di una società basata sul capitale non solo sia finanziata e prodotta da Netflix, a cui il capitalismo stesso ha permesso di avere il monopolio dello streaming, ma che sia anche uno dei maggiori motori della piattaforma: è stata promossa così tanto da essere diventata la serie più vista di sempre dell’azienda.
In conclusione, Squid Game è stata una discreta serie. Qui mi sono limitato a esporre le criticità dell’opera, ma non la ritengo una cattiva visione, specialmente nel catalogo attualmente proposto da Netflix. È anche vero, però, che non si avvicina alla perfezione e che il suo potenziale non sia stato sfruttato a pieno. Dal momento che questo articolo è stato mero frutto della mia personalissima opinione, invito chiunque lo voglia a scrivere la sua su questa o su altre serie, proprio su questo giornalino nel numero del mese prossimo. L’ingresso è libero a tutti, e non c’è opinione sbagliata.