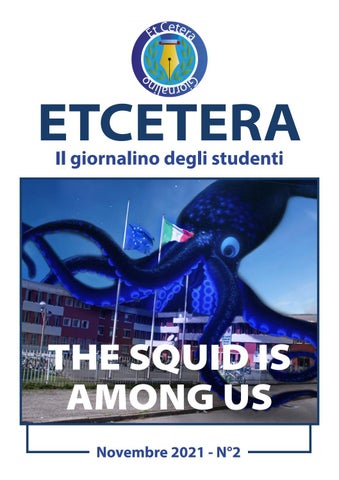7 minute read
Intervista a Tonazzo
SCUOLA INTERVISTA A TONAZZO
ANDREA ORSENIGO, 4F; STEFANO ROVERE, 4D
Advertisement
Abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata con Daniele Tonazzo, professore di Storia e Filosofia del Majorana, durante la quale abbiamo potuto conoscere aspetti e punti di vista professionali, oltre che personali esperienze.
Innanzitutto, vorremmo chiederle della sua personale esperienza da studente e di come essa possa esserci d’aiuto, ad esempio in vista dell’orientamento universitario.
La mia esperienza di studente è l’esperienza di una persona che già prima della conclusione della scuola aveva capito di avere una predilezione abbastanza netta per una certa disciplina. Il problema che mi posi all’epoca – un problema ancora attuale- era appunto nella scelta tra una facoltà come quella di filosofia, che già allora si diceva avrebbe portato difficilmente ad uno sbocco occupazionale soddisfacente, oppure in altre più sicure dal punto di vista dell’occupazione, come mi era stato consigliato dai genitori. La testimonianza che posso dare è quindi che la mia è stata una scelta vocazionale, di cui non mi sono mai pentito, perché quella mia passione mi ha aiutato ad andare avanti.
Come ha già detto lei giustamente, alcuni ragazzi si trovano in difficoltà a scegliere tra facoltà più sicure dal punto di vista economico (ingegneria, ad esempio) o altre che seguano la loro vocazione. Ha qualche consiglio da darci in merito a questa questione?
Certamente una scelta personale come quella universitaria non è qualcosa di cui si può dar senz’altro consiglio agli altri. I consigli che posso darvi sono sicuramente di non trascurare la dimensione della sicurezza economica e di escludere facoltà che non sfiorano lontanamente i vostri interessi. Se io dovessi scegliere tra una facoltà che mi offre più prospettive e una che viene più incontro alla mia vocazione, sceglierei la facoltà che mi offre più prospettive, ma solo a patto che si tratti di una disciplina a cui mi è capitato alme-
no una volta di pensare con interesse. Il consiglio è quindi di scegliere qualcosa che abbia qualche relazione con sé stessi, altrimenti poi sarà difficile sostenere lo sforzo universitario.
In merito al rapporto tra docente e materia, normalmente a causa della ripetizione giornaliera con cui si affrontano i temi della propria disciplina, si perde quella passione originale che si aveva da giovani o agli albori della propria carriera lavorativa. Qual è il suo rapporto con la filosofia? Continua ad avere un approccio “giovanile”, che influenza ancora più o meno concretamente la sua vita, oppure ha perso di valore?
Direi che convivono entrambe le cose. Non parlerei di una “routinizzazione” del mio rapporto con la filosofia, sarebbe da porre la questione in maniera diversa. Da quando faccio l’insegnante il mio rapporto con la filosofia è diventato duplice: da una parte io cerco di raggiungere un buon livello nella trasmissione di contenuti generali e imprescindibili della mia disciplina, venendo costretto a togliere piuttosto che ad aggiungere, cioè a semplificare; dall’altra parte è rimasta una dimensione che non è scomparsa e mai dovrebbe farlo. Mi riferisco alla predilezione per alcuni argomenti o autori piuttosto che per altri, che si continuano a coltivare personalmente nel tempo. Credo che questa dimensione difficilmente potrebbe sparire.
Rispetto alla dimensione personale con la disciplina, soprattutto in una materia come filosofia, crede che sia corretto lasciar trapelare il proprio pensiero, anche una semplice predilezione, all’interno della trasmissione dei contenuti?
No, non penso sia giusto trasmettere agli altri la propria disciplina secondo il proprio punto di vista, perché credo che l’insegnamento liceale debba soddisfare un livello formativo generale, cioè che debba toccare punti generali e imprescindibili. Però a questo non si esclude - anzi sarebbe nei limiti del possibile da aggiungere - il far percepire allo studente che si può avere un rapporto personale con alcune materie, che ci si può sentire toccati da certi argomenti più di altri, che ci può essere la dimensione della predilezione. Tuttavia bisogna evitare che lo studente legga la materia, nel mio caso la filosofia, sotto le mie lenti, perché la filosofia non è una mia esclusiva, bensì un qualcosa con cui io ho un rapporto e con cui vorrei che anche tu, studente, avessi un tuo personale rapporto.
Di recente, nell’era social, il tempo di attenzione medio della popolazione è pian piano diminuito. Le informazioni sono diventate più immediate e i messaggi trasmessi sono cambiati. Nel 2021 si legge meno rispetto a qualche anno fa, ma si tendono a guardare più contenuti sotto forma di immagini, come possono essere serie TV o video informativi. Noi conosciamo la sua passione verso l’opera Ken Il Guerriero, che estremizza le possibili conseguenze di una terra post-apocalittica a seguito dell’utilizzo di armi nucleari nella Se-
conda guerra mondiale. Ritiene che i nuovi mezzi di comunicazione possano essere validi quanto quelli più classici per narrare una storia, per far arrivare un messaggio a un vasto pubblico o per informare le persone?
Sì, penso che i nuovi mezzi di comunicazione non vadano demonizzati, come talvolta accade, perché la loro presenza si è innanzitutto imposta nella contemporaneità e secondariamente permette di far emergere degli aspetti di creatività delle persone che magari non possono emergere così facilmente in una civiltà esclusivamente caratterizzata dalle forme di comunicazione scritte e alfabetiche. Quindi, rispetto al fatto che possano essere strumenti utili per la narrazione, è indubbio. Resta il fatto però che, secondo me, è molto difficile che questi strumenti sostituiscano completamente le modalità di narrazione tradizionali. Per quanto riguarda la divulgazione online, secondo me il pericolo è che ci sia una certa superficialità. La persona, penso, dovrebbe essere in grado di praticare un canale di informazione tradizionale, saperlo abitare, avere una familiarità con le forme di comunicazione per voi magari più antiche, come potrebbero essere i giornali, per poi essere capace di vagliare quelle fonti multimediali di cui parlate e per voi più familiari. Il problema tra le generazioni non dipende da loro, ma è causato dal fatto che nascono in un mondo che è profondamente marcato dalla rivoluzione informatica, da quella che alcuni chiamano Terza rivoluzione industriale. Di conseguenza, le nuove generazioni non hanno più come riferimento quello che avevo io all’epoca in cui io avevo la vostra età, quando non esisteva lo smartphone, al limite il telefonino a tasti che usano i vostri nonni. Quindi, il fatto di essere nati con un mondo profondamente marcato da questa velocità e dal carattere multimediale della comunicazione rende per voi difficile adottare come riferimento il vecchio mondo della scrittura alfabetica chirografica. A questo punto si pone il problema se sia giusto proporvi questo standard come riferimento oppure se sia necessario adottare le vecchie forme di comunicazione. Io penso che l’ideale sarebbe far percepire il valore di entrambe, seguendo il tentativo che si fa a scuola, dove la forma scritta non multimediale rimane innegabilmente dominante. I vostri stessi libri, pur essendo cambiati nel corso della storia ed essendosi arricchiti di immagini e di contenuti, tuttavia hanno ancora come base quel tipo di comunicazione tradizionale, perché evidentemente si ritiene che, una volta acquisita, essa permetta di orientarsi anche in quell’altro tipo di comunicazione. Per concludere, ci sono dei pregi, secondo me, di queste nuove forme di trasmissione dei contenuti e delle informazioni, ma se dovessi valutare le cose dal mio personale punto di vista e a partire dal canale che io ritengo più complesso, penso che la scrittura alfabetica sia ancora fondamentale.
L’opinione pubblica italiana si è recentemente divisa sulla legalizzazione delle droghe leggere, vi è stato anche il refe-
rendum proposto da “radicali italiani”; qual è la sua posizione sulla possibile legalizzazione di queste e sulle droghe già attualmente legalizzate in Italia, come l’alcool e le sigarette?
La mia posizione risente della mia esperienza. Io ho lavorato per diversi anni in una comunità terapeutica, che ospitava ragazzi più o meno della vostra età, più piccoli e più grandi di voi, affetti da disturbi di personalità. Tra questi ragazzi c’erano i cosiddetti ragazzi con doppia diagnosi: essi da un lato hanno una diagnosi di disturbo della personalità, dall’altro una diagnosi di dipendenza. Mi è quindi capitato di parlare con questo tipo di ragazzi, numerosi, e ho riscontrato sistematicamente che il consumo intenso di stupefacenti importanti come la cocaina, l’hashish e le droghe sintetiche, comincia sistematicamente da un consumo di marijuana considerato generalmente normale. zione: quindi non è vero che una persona che consuma marijuana sistematicamente comincerà a consumare cocaina, ma vuol dire che nelle persone diventate consumatori di droghe pesanti si riscontra nella stragrande maggioranza dei casi un iniziale consumo di droghe leggere.
Ho visto che, anche informandomi su questo problema, molti descrivono le droghe leggere l’opposto di quello che ha detto lei, cioè come un’attività che non ha legami con il futuro uso di droghe a livello più pesante. La sua tesi è solamente relazionata all’esperienza o ha fondamenti scientifici?
No, è anche relazionata all’esame di psicologia dell’adolescenza, che dedica una parte allo studio degli stupefacenti con allegati dati statistici. Che ci sia una relazione tra il consumo di droga leggera e l’accesso a consumi di livello più importante è un dato scientifico risaputo. Non è un dato deterministico ma una correla-