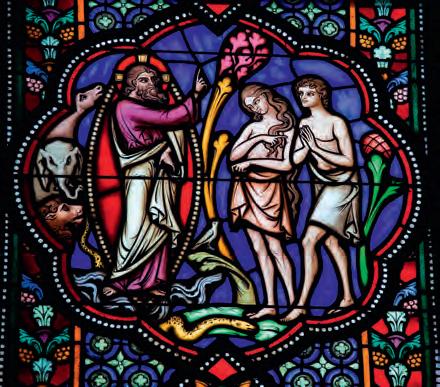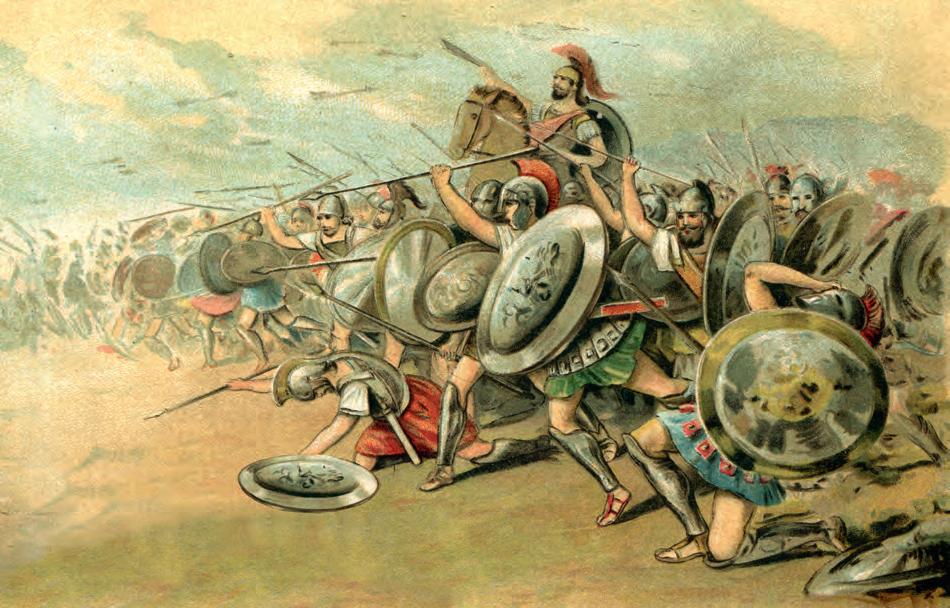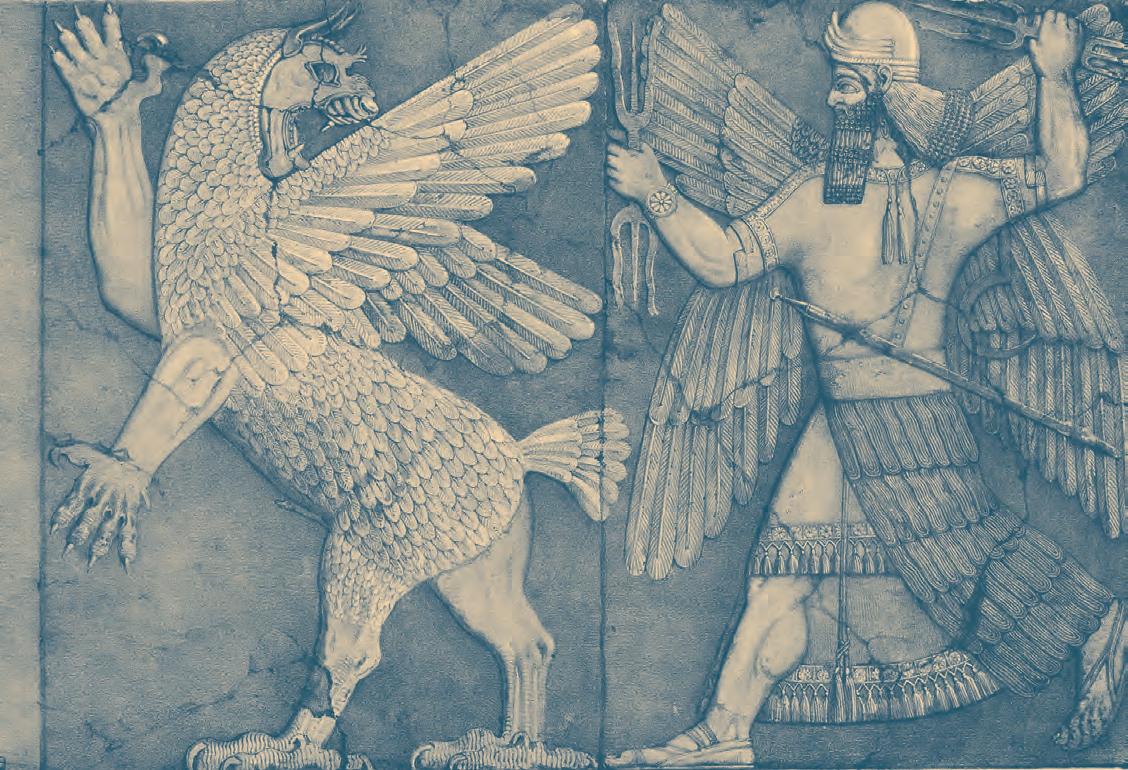Maria Zioni Elefteria Morosini Maria Belponer
Maria Zioni Elefteria Morosini Maria Belponer
INDICE Il piacere di apprendere Gruppo Editoriale ELi
Sentieri dell’immaginario EPICA E MITO
#PROGETTOPARITÀ equilibri Autori, opere Percorsi tematici Lettura espressiva di tutti i testi a cura della Scuola di teatro Paolo Grassi
Coordinamento redazionale: Marco Mauri
Redazione: Fabiana Anfuso per Studio Roveda Marelli, Milano, Manuela Capitani
Art direction: Enrica Bologni
Impaginazione: Marinella Carzaniga
Disegni: Marco Bregolato, Giorgio Bianchin
Illustrazione di copertina: Alida Massari
Contenuti digitali
Progettazione: Giovanna Moraglia
Realizzazione: BSmart Labs
Per la lettura espressiva dei testi si ringrazia la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi:
tutor: Manuel Renga
regia: Riccardo Vanetta, Matteo Finamore
voci: Giulia Rossoni, Eleonora Brioschi, Carola Invernizzi, Lorena Nacchia, Leonardo Moroni, Lorenzo Giovannetti, Lorenzo Prevosti, Vito Vicino
Referenze iconografiche
Shutterstock, Istock. Tutte le altre immagini provengono dall’Archivio Principato.
Per le riproduzioni di testi e immagini appartenenti a terzi, inserite in quest’opera, l’editore è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire, nonché per eventuali non volute omissioni e/o errori di attribuzione nei riferimenti.
ISBN 978-88-416-5175-9
Sentieri dell’immaginario Epica e mito
ISBN 978-88-6706-547-9
Sentieri dell’immaginario Epica e mito
eBook+
Prima edizione: gennaio 2023
Printed in Italy
© 2023 - Proprietà letteraria riservata.
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le riproduzioni per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi (Centro licenze e autorizzazioni per le riproduzioni editoriali), corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org
L’editore fornisce – per il tramite dei testi scolastici da esso pubblicati e attraverso i relativi supporti o nel sito www.principato.it e www.gruppoeli.it – materiali e link a siti di terze parti esclusivamente per fini didattici o perché indicati e consigliati da altri siti istituzionali. Pertanto l’editore non è responsabile, neppure indirettamente, del contenuto e delle immagini riprodotte su tali siti in data successiva a quella della pubblicazione, dopo aver controllato la correttezza degli indirizzi web ai quali si rimanda.
Casa Editrice G. Principato sito web: http://www.principato.it www.gruppoeli.it
Via G.B. Fauché 10 - 20154 Milano e-mail: info@principato.it
La casa editrice attua procedure idonee ad assicurare la qualità nel processo di progettazione, realizzazione e distribuzione dei prodotti editoriali. La realizzazione di un libro scolastico è infatti un’attività complessa che comporta controlli di varia natura. È pertanto possibile che, dopo la pubblicazione, siano riscontrabili errori e imprecisioni. La casa editrice ringrazia fin da ora chi vorrà segnalarli a: Servizio clienti Principato e-mail: info@principato.it
Stampa: Tecnostampa - Pigini Group Printing Division - Loreto - Trevi 22.85.198.0P
Percorrere i “Sentieri dell’immaginario”
I sentieri dell’immaginario sono imprevedibili e affascinanti anche nei vasti territori del mito e dell’epica. In questa antologia li percorreremo lungo tre direzioni principali: quella testuale, naturalmente, attraverso la lettura consapevole; quella visiva, attraverso immagini potenti, suggestive; quella uditiva, attraverso l’ascolto di tutti i brani proposti, interpretati con forza espressiva.
Gli strumenti
In questa sezione avrete a disposizione gli strumenti, appunto, per avvicinare la tradizione mitologica ed epica, per consolidare le vostre conoscenze e competenze di lettura, attraverso numerosi esempi.
I classici
In questa sezione affronterete i grandi testi classici, attraverso letture guidate e commentate, spesso accompagnati dalla rubrica “Nel cuore del testo”, che vi aiuterà a coglierne i tratti essenziali.
I percorsi tematici
In questi numerosi inserti potrete approfondire temi importanti della tradizione letteraria e dell’esistenza umana in generale, con riferimento a varie opere e a contesti più recenti.
la terra ferma si affida ad un elemento a lui estraneo, del quale non sempre può dominare la forza: la prima efficace rappresentazione della tempesta è nell’Odissea
Omero Odissea (V, vv. 278-453) La tempesta e la salvezza Quando Odisseo, dopo la lunga permanenza presso l’isola di Calipso, intraprende il viaggio di ritorno a Itaca, viene raggiunto dall’ira di Poseidone che vuole vendicarsi dell’offesa arrecata a suo figlio, il Ciclope Polifemo accecato dall’eroe. Il dio scatena contro Odisseo una terribile tempesta e l’eroe, giunto quasi a terra, dispera veramente di salvarsi. Diciassette giorni navigò, traversandolo, il mare, al diciottesimo apparvero monti ombrosi 280 della terra dei Feaci, la parte lui vicina: sembrava come uno scudo nel fosco mare. Ed ecco, tornando dagli Etiopi, lo Scuotiterra possente

280. la mitica popolazione presso cui Odisseo trova rifugio che fornisce l’aiuto definitivo per
da lontano lo vide, dai monti dei Solimi: gli apparve mentre navigava sul mare. Di più si sdegnò nel suo cuore, e scuotendo la testa parlò rivolto al suo animo: «Che malanno! Gli dei hanno dunque deciso altrimenti di Odisseo, mentre ero presso gli Etiopi: è già vicino alla terra dei Feaci, dove è destino che sfugga alla massa di guai che l’incalzano. 290 Ma penso di ricacciarlo a fondo nella sventura». Detto così, spinse insieme le nuvole, agitò il mare, levando con le mani il tridente: aizzò tutti i turbini d’ogni sorta di venti, con le nubi ravvolse e terra e mare. Dal cielo era sorta la notte. 295 Euro, Noto, Zefiro violento, Borea nato dall’etere s’avventarono insieme, voltolando gran flutto. Allora si sciolsero Odisseo le ginocchia e il cuore, e angosciato disse al suo cuore magnanimo: «Povero me, alla fine che mi accadrà? 300 Temo che la dea m’abbia detto la verità, dicendomi che avrei colmato sul mare le mie sofferenze prima di giungere in patria: e ora tutto si compie. Di che nuvole Zeus riempie fino all’orlo il vasto cielo: il mare ha sconvolto, incalzano raffiche 305 di venti diversi. La ripida morte per me ora è certa. Tre e quattro volte beati Danai che morirono nella vasta terra di Troia, arrecando gioia agli Atridi. Così fossi morto io pure e avessi subito il destino, il giorno che mi scagliarono in folla Troiani aste di bronzo intorno al Pelide morto. Avrei avuto onori funebri e dagli Achei la fama: ora mi tocca esser preda d’una misera morte». Mentre diceva così, l’investì un gran flutto, dall’alto, con impeto terrificante e fece ruotare la zattera. Lontano dalla zattera cadde, dalle mani lasciò andare il timone: l’albero glielo ruppe metà un turbine di venti diversi sopraggiunto terribile, vela e antenna caddero in mare, lontano. A lungo lo tenne sommerso; non poté 320 riemergere presto, per la furia del grande maroso: lo appesantivano panni che gli diede la chiara Calipso. Finalmente riemerse, dalla bocca sputò l’acre acqua salata che copiosa gli grondava dal capo. Ma neppure così, benché affranto, dimenticò la sua barca: 325 slanciatosi tra i flutti la prese, in mezzo vi si sedette, evitando la fine e la morte. Un grande maroso la portava con la corrente qua e là. Come quando per la pianura Borea d’autunno trascina
Durante il cammino troverete suggerimenti per altre letture interessanti e moderne, avrete occasione di esprimere le vostre riflessioni ed esperienze nella rubrica
A voi la parola, quindi, e buon viaggio!
3
TE LA PAROLA
A
Le voci dei grandi poeti epici i versi e le parole, gli eroi e le imprese dei poemi immortali che rappresentano le fondamenta del sapere nelle civiltà antiche. Classici 1. L’epopea di Gilgamesh Percorso tematico Il viaggio 2. Omero Iliade 2.1 Il primo autore epico: Omero 2.2 La questione omerica 2.3 Uno o due poeti? 2.4 Milman Parry e l’oralità 2.5 La redazione scritta dei poemi 2.6 Come inizia la guerra: l’antefatto 2.7 Il mondo omerico 2.8 Gli eroi e la civiltà della vergogna 2.9 temi dell’Iliade 2.10 Odisseo e gli altri eroi 2.11 Le figure femminili Percorsi tematici La guerra L’amicizia tra eroi • Il dolore dei genitori 3. Omero Odissea 3.1 L’Odissea 3.2 personaggi dell’Odissea 3.3 L’Odissea un poema epico? Percorsi tematici L’ospitalità Il riconoscimento nella tragedia 4. Virgilio Eneide 4.1 Prima di Virgilio 4.2 Virgilio e il suo tempo 4.3 L’Eneide 4.4 La trama 4.5 Un poema innovativo 4.6 Le novità della form Percorsi tematici Ritratti di donne La morte degli eroi 83 PERCORSO TEMATICO • Il viaggio Classici 82 Autori Il viaggio PERCORSO tematico 1. Andar per mare: la tempesta La tempesta è forse il pericolo più temuto dai naviganti e la rappresentazione più efficace dei rischi della navigazione:l’uomo che abbandona
T1
ritorno a Itaca. 282-283. Etiopi... Solimi secondo mito, Etiopi sono gli unici esseri umani presso quali Poseidone, qui definito con l’epiteto che ne sotconnessione con terremoti maremoti,trascorrevaalcuniperiodi; Solimisonouna popolazione dell’Asia Minore 295.Euro... ventichesoffianodadiverse direzioni, qui scatenati tutti insieme per creare la tempesta. 300. Calipso, ninfa che aveva predetto l’incombere nuove sofferenze. 309-310. giorno... morto ricorda la lotta cadavere Achille, episodio non narrato Iliade che si conclude con morte di Ettore. 318. vela antenna l’albero 1. Andar per mare: la tempesta T1 Omero Odissea V, vv. 278-453 T2 Esiodo Le opere giorni vv. 618-690 T3 Virgilio Eneide I, vv. 81-156 e 198-209 T4 Joseph Conrad Tifone 2. Il viaggio nell’altro mondo T5 Omero Odissea XI, vv. 1-43 T6 Omero Odissea XI, vv. 405-456 T7 Virgilio Eneide, VI, vv. 298-316 T8 Virgilio Eneide VI, vv. 640-723 e 756-901 LETTURA ESPRESSIVA Ti blaciet, omnimus temporibus videlia Le tecniche gli strumenti, le modalità della produzione epica per capire i racconti, le storie, le leggende del patrimonio mitico dell’umanità. Strumenti 1. Il mito 1.1 Che cos’è il mito 1.2 Il mito messo in scena 1.3 Il mito in forma di romanzo 1.4 La storia di Perceval Percorso tematico Le riletture di un mito: il sacrificio 2. Dal mito all’epos 2.1 La narrazione epica 2.2 Il Mahabharata, non solo mito 2.3 Il mito in forma di poema 2.4 Gilgamesh, il primo eroe epico Percorso tematico La protasi 3. Il cantore e la poesia epica 3.1 L’epica: origine di un nome 3.2 Il cantore-poeta 3.3 Gli strumenti del poeta epico Percorso tematico Il poeta
1 Il mito
3 Il cantore e la poesia epica

INDICE 4 Strumenti 6
8 1.1 Che cosa è il mito 8 1.2 Nuovi miti 10 T1 Esiodo, Teogonia Il mito delle origini 11 T2 Sacra Bibbia, Genesi La creazione nel racconto biblico 12 T3 Esiodo, Teogonia Il primo sacrificio: il mito di Prometeo 13 T4 Eschilo, Prometeo incatenato Altre voci: il Prometeo di Eschilo 15 T5 Platone, Protagora Epimeteo e il mito del progresso 17 T6 Erodoto, Storie Il mito e la storia 19 1.3 Il mito messo in scena 21 T7 Sofocle, Aiace La follia di Aiace 22 SCHEDA di approfondimento Il teatro tragico 24 T8 Sofocle, Aiace La risposta di Tecmessa 26 1.4 Il mito in forma di romanzo 28 1.5 La storia di Perceval 30 T9 Chrétien de Troyes, Perceval L’incontro con la damigella della tenda 32 Percorso tematico Le riletture di un mito: il sacrificio 35 T1 Eschilo, Agamennone Il sacrificio di Ifigenia 35 T2 Lucrezio, La natura L’Ifigenia di Lucrezio 37 T3 Ovidio, Metamorfosi La versione di Ovidio 38 T4 Sacra Bibbia, Genesi Il sacrificio di Isacco 38
Dal mito all’epos 40 2.1 La narrazione epica 40 2.2 Il Mahabharata, non solo mito 40 T1 Mahabharata Una prova straordinaria 42 T2 Ovidio, Metamorfosi Di forma in forma, continuamente 46 2.3 Il mito in forma di poema 48 2.4 Il primo eroe epico: Gilgamesh 48 T3 L’epopea di Gilgamesh Prologo: Gilgamesh, re di Uruk 51 Percorso tematico La protasi 53 1. Imprese di eroi invincibili, ma mortali 53 2. La funzione della protasi 54 3. La presentazione dell’eroe 56 4. L’eroe fondatore del futuro 57 T1 Omero, Iliade Un sentimento al centro della storia 59 T2 Omero, Odissea Un uomo al centro della storia 60 T3 Esiodo, Le opere e i giorni La giustizia oggetto del canto 61 T4 Virgilio, Eneide Un uomo, una guerra, un destino 62
2
64 3.1 L’epica: origine di un nome 64 3.2 Il cantore-poeta 64 3.3 Gli strumenti del poeta epico 67 Percorso tematico Il poeta 69 1. Orfeo, il poeta incantatore 69 T1 Virgilio, Georgiche Orfeo nel racconto di Virgilio 69 2. Una nuova identità poetica: Esiodo 72 T2 Esiodo, Teogonia L’ispirazione del poeta 72 3. Il poeta epico nel mondo romano 73 T3 Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici Un poeta silenzioso 74
1 L’epopea di Gilgamesh
2 Omero, Iliade
INDICE 5
78 T1 L’epopea di Gilgamesh Il viaggio nella foresta 78 Percorso tematico Il viaggio 82 1. Andar per mare: la tempesta 82 T1 Omero, Odissea La tempesta e la salvezza 82 T2 Esiodo, Le opere e i giorni Mettersi in mare per denaro 88 T3 Virgilio, Eneide Il naufragio di Enea 90 T4 Joseph Conrad, Tifone Il tifone 94 2. Il viaggio nell’altro mondo 98 T5 Omero, Odissea Odisseo nell’Ade 98 T6 Omero, Odissea L’incontro con Agamennone 100 T7 Virgilio, Eneide Enea, la profezia del futuro 103 T8 Virgilio, Eneide Enea incontra il padre 104
114 2.1 Il primo autore epico: Omero 114 2.2 La questione omerica 115 2.3 Uno o due poeti 116 2.4 Milman Parry e l’oralità 116 2.5 La redazione scritta dei poemi 117 2.6 Come inizia la guerra: l’antefatto 117 2.7 Il mondo omerico 118 SCHEDA l’opera La trama dell’Iliade: 51 giorni di guerra 120 2.8 Gli eroi e la civiltà della vergogna 121 2.9 I temi dell’Iliade 122 2.10 Odisseo e gli altri eroi 123 2.11 Le figure femminili 123 All’inizio di tutto, l’ira 124 T1 Lo scontro tra Achille e Agamennone 125 T2 Elena, una bellezza insostenibile 132 Percorso tematico Le mura 137 1. Le mura come difesa 137 Le mura di Ilio 137 Le mura di Tebe 138 La resa di Troia 140 Le mura di Atene 140 2. Il muro come separazione 141 Il Muro di Berlino 141 l muro come frontiera 142 Il muro fra Israele e Cisgiordania 143 Altri muri oggi 144 L’interno e l’esterno, il “dentro” e il “fuori” 146 Iliade a che punto è la storia Sul campo di battaglia 150 T3 Il duello mancato di Glauco e Diomede 150 T4 L’ultimo incontro di Ettore e Andromaca 155 Percorso tematico La guerra 159 1. L’ideale eroico in Achille ed Ettore 159 2. Enea e il destino di guerra 160 3. L’esaltazione della guerra nella Chanson de Roland 164 SCHEDA l’opera La trama della Chanson de Roland 165 4. La guerra negata 170 5. Il rifiuto dell’eroismo nel mondo contemporaneo 170 Percorso tematico L’amicizia tra eroi 176 1. Gilgamesh ed Enkidu 176 T1 L’epopea di Gilgamesh Il patto tra Gilgamesh ed Enkidu 176 T2 L’epopea di Gilgamesh Pianto di Gilgamesh per la morte di Enkidu 177 2. Achille e Patroclo 179 T3 Omero, Iliade L’estrema solitudine 179 3. Eurialo e Niso 181 T4 Virgilio, Eneide Un’impresa per due amici, Eurialo e Niso 181 4. Rolando e Oliviero 186 T5 Chanson de Roland Rolando suona l’olifante 186 5. Primo e Sandro 188 T6 Primo Levi, Il sistema periodico Condividere un’impresa 188 SCHEDA l’opera La trama dell’Iliade: la conclusione dell’ira 196 T5 Achille e Priamo 198 Percorso tematico Il dolore dei genitori 201 T1 Omero, Iliade Parole sofferte e vane 201 T2 Omero, Iliade Il dolore di Andromaca 202 T3 Omero, Odissea Anticlea e Laerte 204 T4 Omero, Iliade L’ultima preghiera 205 T5 Virgilio, Eneide La madre di Eurialo 206 T6 e T7 Euripide, Troiane La morte innocente 207 SCHEDA segnalibro Rachel Bespaloff, Teti, soprattutto una madre 210 SCHEDA segnalibro Madeline Miller, Un’altra Teti 211 Classici 76
INDICE 6
212 3.1 L’Odissea 212 3.2 I personaggi dell’Odissea 215 3.3 L’Odissea, un poema epico? 217 SCHEDA l’opera La trama dell’Odissea: Telemaco e Odisseo in viaggio 218 T1 E tu sii felice, comunque 220 SCHEDA segnalibro Roberto Calasso, Calipso, la Nasconditrice 223 SCHEDA l’opera La trama dell’Odissea: il canto di Nausicaa 225 T2 Nausicaa e Odisseo 225 T3 I consigli di Nausicaa 228 Percorso tematico L’ospitalità 232 1. Odisseo e Polifemo 232 T1 Omero, Odissea Polifemo, l’ospite feroce 234 T2 Omero, Odissea Odisseo a Itaca 238 2. Didone ed Enea 242 T3 Virgilio, Eneide Salvezza e accoglienza 242 3. Filemone e Bauci 246 T4 Ovidio, Metamorfosi Povertà ospitale 246 4. Donna Catìn e comare Giacoma 249 T5 Italo Calvino, L’ospitalità La grettezza beffata 249 SCHEDA l’opera La trama dell’Odissea: Odisseo alla corte dei Feaci 257 T4 L’astuzia e la violenza 258 SCHEDA l’opera La trama dell’Odissea: verso Itaca 265 T5 La cicatrice 269 Percorso tematico Il riconoscimento nella tragedia e nel romanzo 273 1. Il riconoscimento nella tragedia 273 T1 Sofocle, Elettra Il riconoscimento nell’Elettra di Sofocle 273 2. Lo scioglimento nel romanzo 275 T2 Longo Sofista, Dafni e Cloe Dafni e Cloe 276 3. Dopo il lager 278 T3 Primo Levi, La tregua Il ritorno a casa 278 SCHEDA segnalibro Daniel Mendelsohn rivive l’Odissea 281 SCHEDA l’opera La trama dell’Odissea: a Itaca, finalmente 282 T6 Dopo vent’anni 283 SCHEDA segnalibro Margaret Atwood, Una lettura dissacrante 288 4 Virgilio, Eneide 290 4.1 Prima di Virgilio 290 4.2 Virgilio e il suo tempo 291 4.3 L’Eneide 292 4.4 La trama 292 4.5 Un poema innovativo 293 4.6 Le novità della forma 295 SCHEDA l’opera La trama dell’Eneide: la caduta di Troia 296 T1 L’ultima notte: Ettore e il rogo di Troia 298 SCHEDA l’opera La trama dell’Eneide: i viaggi e la nuova partenza 302 T2 Il suicidio di Didone 304 Percorso tematico Ritratti di donne 308 1. Alcuni grandi ritratti femminili 308 T1 Esiodo, Le opere e i giorni Il malanno Pandora 309 T2 Omero, Odissea La sposa saggia 311 2. La donna innamorata e tradita 315 T3 Apollonio Rodio, Argonautiche Medea 315 3. La Medea euripidea 318 T4 Euripide, Medea La Medea di Euripide 318 4. Didone e Creusa in Virgilio 319 T5 Virgilio, Eneide Didone innamorata 320 T6 Virgilio, Eneide La veglia di Didone 321 T7 Virgilio, Eneide Creusa, la sposa sacrificata 322 5. La figura della donna nel romanzo cortese-cavalleresco 325 T8 Thomas, Tristano e Isotta La donna tormentata 325 SCHEDA segnalibro Giuseppe Ungaretti, Cori descrittivi di stati d’animo di Didone 333 SCHEDA l’opera La trama dell’Eneide: il viaggio e la guerra 334 T3 Il destino inesorabile 337 T4 L’eroe pietoso 341 SCHEDA l’opera La trama dell’Eneide: lo scontro decisivo 345 T5 L’ultimo eroe 346 Percorso tematico La morte degli eroi 356 1. Patroclo 356 T1 Omero, Iliade La vittima di Apollo 356 2. Ettore 359 T2 Omero, Iliade L’ultimo scontro 359 3. Rolando 366 T3 Chanson de Roland La morte del paladino 366 SCHEDA l’opera Il poema dei Nibelunghi 371 4. Sigfrido 373 T4 I Nibelunghi L’eroe tradito 373 SCHEDA segnalibro Eroi contemporanei, Lettera di Luigi Capriolo 382
3 Omero, Odissea
Strumenti
Le tecniche, gli strumenti, le modalità della produzione epica per capire i racconti, le storie, le leggende del patrimonio mitico dell’umanità.
1. Il mito
1.1 Che cosa è il mito
1.2 Nuovi miti
1.3 Il mito messo in scena
1.4 Il mito in forma di romanzo
1.5 La storia di Perceval
Percorso tematico
Le riletture di un mito: il sacrificio
2. Dal mito all’epos
2.1 La narrazione epica
2.2 Il Mahabharata, non solo mito
2.3 Il mito in forma di poema
2.4 Gilgamesh, il primo eroe epico
Percorso di genere
La protasi
3. Il cantore e la poesia epica
3.1 L’epica: origine di un nome
3.2 Il cantore-poeta
3.3 Gli strumenti del poeta epico
Percorso tematico
Il poeta
Il mito
1.1 Che cosa è il mito?
Il mito come spiegazione del mondo Quando usiamo la parola «mito» necessariamente ci riferiamo alla narrazione mitologica che ci è stata tramandata dalle opere letterarie, ma il mito, in origine, era racconto orale, che nasceva con diverse funzioni e in diversi ambiti, solo in parte rispecchiati dalle narrazioni che ancora oggi leggiamo. Il mito, infatti, nasce come spiegazione prelogica, precedente la riflessione della filosofia e della scienza, su alcuni problemi fondamentali, che l’uomo, fin dai tempi più antichi, si pone. Proprio perché esso è stato in un certo senso “raccolto” e riformulato in diverse modalità, nella poesia, nella storiografia, nel teatro, persino nel romanzo, se ne può seguire l’evoluzione e si possono individuare diverse varianti, che, tuttavia, rispondono all’esigenza originaria di spiegare la realtà, di motivare le scelte umane, di giustificare avvenimenti naturali razionalmente incomprensibili e, spesso, di concedersi il piacere della narrazione favolosa, che affianca quella razionale. Per questo motivo, rientra nel mito la narrazione esiodea delle origini del mondo dal caos, cui si affianca quella biblica che attribuisce la creazione all’intenzione divina. Il mito delle origini esiodeo, che vede il distinguersi della materia primigenia e la nascita degli dei, e la creazione divina narrata dalla Bibbia rappresentano una risposta alla domanda focale sulle origini del mondo e degli uomini, mentre si apre un’altra questione: quella del rapporto tra uomo e natura e quindi del progresso, cui Esiodo fornisce una risposta nella figura di Prometeo, ripresa nel racconto platonico, nel quale la spiegazione mitica si incastona nella riflessione filosofica, ma acquista l’autonomia di un meraviglioso racconto.

Strumenti 8
Strumenti
«Narrare miti, o ascoltarne, è come mettersi per mare».
1
Maurizio Bettini
Il rapporto tra umano e divino Nel momento in cui si affronta la spiegazione dell’origine del mondo, e quindi della separazione tra gli uomini e gli dei, o gli uomini e Dio, si apre il problema del rapporto tra questi due poli, umanità e divinità. La mediazione, il momento di confronto, è rappresentato dal rito del sacrificio, tanto più drammatico nella narrazione biblica, più giocato sull’astuzia nel mondo greco, ma comunque legato alla necessità di istituire un patto con il divino, una modalità di rapporto: nel sacrificio di Isacco, il traguardo è l’affermazione della fiducia piena dell’uomo in Dio; nel racconto esiodeo, invece, l’istituzione del rito del sacrificio segna una sorta di patto, che mette in luce un’ambiguità di rapporto tra Prometeo, che inganna Zeus, e Zeus stesso, che porta alle estreme conseguenze l’inganno e rappresenta un rapporto con la divinità mai risolto, nel mondo greco, in bilico tra fiducia e diffidenza, tra timore e sfida.
Mito e storiografia La narrazione mitica continua ad esercitare il suo fascino e a rivestire una funzione ancora nell’indagine storiografica, dove integra lo studio dei fatti e spesso li riconduce a eventi leggendari, perché, ancora una volta, il mito si pone come spiegazione dove la spiegazione puramente razionale è mancante, insoddisfacente. Per motivare una rivalità radicale come quella tra Greci e Persiani, Erodoto, lo storico che conosce bene l’Oriente, non può che fare ricorso a un antico passato mitico, perché, evidentemente, le spiegazioni puramente basate sui fatti, non gli sembrano convincenti: per lui, ma soprattutto

1 • Il mito 9
Itinerario visivo
per il pubblico cui sono destinati i suoi racconti. D’altra parte, anche la figura di Enea, che discende direttamente dal ciclo troiano, assume risvolti storici: egli è il protagonista di un poema epico, ma questo poema giustifica un evento storico, la fondazione di Roma e del suo impero. Ancora una volta assistiamo alla trasformazione del mito, che, senza perdere la sua natura di narrazione, assume una funzione diversa.
Il mito a teatro D’altra parte, il mito alimenta, con le sue figure e i suoi temi, il teatro, greco prima, e poi romano. Gli eroi che hanno animato la poesia epica si ripropongono sulla scena, incarnando problematiche e vicende che assumono nuovi risvolti e più profondi significati: Agamennone diviene la vittima del suo stesso potere, come Aiace lo è del suo eroismo. Ancora una volta il mito risponde a una domanda sugli esiti dei destini umani e, rappresentato sulla scena, di fronte agli spettatori, induce alla riflessione sulle vicende degli eroi, mentre dà voce alle figure femminili, che spesso dominano la tragedia, anche quando si tratta di una schiava, come avviene per Tecmessa, la compagna di Aiace. In questo caso, la modalità di riproduzione del mito, incarnato dagli attori che recitano di fronte al pubblico, comporta un ulteriore significato e produce un effetto di immedesimazione che, togliendo i protagonisti dalla lontananza della narrazione epica, che si colloca nel passato, li proietta nel presente e ne fa figure vere, attuali, vive sulla scena come nella percezione del pubblico, per il periodo della rappresentazione.
1.2 Nuovi miti
Infine, la riformulazione del mito nel romanzo comporta la creazione di nuovi miti “umani”, che sono rappresentati dai cavalieri medievali, uomini che, come gli antichi eroi, combattono per degli ideali, difendono il loro signore o una fanciulla debole, o sono paladini della fede nelle crociate, come Rolando nella Chanson de Roland. Questi eroi cavallereschi riproducono alcuni elementi del modello epico arcaico: compiono viaggi avventurosi, affrontano prove terribili, mettono a rischio la loro vita, spesso al servizio di un signore a cui sono fedeli fino alla fine, ma, rispetto al modello originario dell’eroe antico, sono tanto più “maturi”, in quanto conoscono l’amore per una donna, la fede cristiana, e seguono la loro ispirazione fino al sacrificio più alto.

Strumenti 10
San Giorgio e il drago, affresco, XV-XVI sec., Aarhus (Danimarca), Cattedtrale di San Clemente.
Esiodo, Teogonia (I, vv. 116-133)
Il mito delle origini
Ecco come il poeta greco Esiodo (viii-vii secolo a.C.) racconta un mito delle origini. Nel poema Teogonia (cioè la “nascita degli dei”) narra in versi esametri come dal caos che avvolgeva in principio il mondo siano nati gli dei e un ordine che trasforma il caos in cosmo, “mondo ordinato”.
116 Dunque, per primo fu Caos, e poi Gaia dall’ampio petto, sede sicura per sempre di tutti gli immor tali che tengono la vetta nevosa d’Olimpo, e Tartaro nebbioso nei recessi della terra dalle ampie strade,
120 poi Eros, il più bello fra gli immortali, che rompe le membra, e di tutti gli dei e di tutti gli uomini doma nel petto il cuore e il saggio consiglio. Da Caos nacquero Erebo e nera Notte. Da Notte provennero Etere e Giorno
125 che lei concepì a Erebo unita in amore.
Gaia per pr imo generò, simile a sé, Urano stellato, che l’avvolgesse tutta d’intorno, che fosse ai beati sede sicura per sempre. Generò i monti grandi, grato soggiorno alle dee
130 Ninfe, che hanno dimora sui monti ricchi d’anfratti; essa generò anche il mare infecondo, di gonfiore furente, Ponto, senza amore gradito; dopo, con Urano g iacendo, generò anche Oceano dai gorghi profondi…
(Esiodo, Teogonia, I, vv. 116-133, trad. di G. Arrighetti, BUR, Milano 1984)

nel cuore del testo
Per spiegare la nascita del cosmo*, Esiodo ricorre a un procedimento simile alla generazione degli esseri umani, illustrando la nascita di tutti gli elementi naturali, le divinità minori e gli eroi, da cui discenderanno gli esseri umani. In questo racconto egli dà forma poetica a un mito cosmogonico* antichissimo.
* cosmogonico: kósmos, ordine, mondo ordinato; ghénesis, nascita, origine
GUIDA alla lettura
Come è nato il mondo?
Il poeta Esiodo esprime, trasforma in racconto, una domanda fondamentale: come è nato il mondo che ci circonda? Spiegare l’origine del mondo è un’attività difficilissima, cui i Greci rispondono appunto con il mito, immaginando dapprima un nulla disordinato, il caos, una sorta di grande vuoto spalancato (il verbo chaino, in greco, significa «spalancarsi»: da questo verbo deriva appunto il termine caos), che viene successivamente distinto in parti diverse.
Gaia, o Gea, è la terra, Tartaro è il sottosuolo, oscuro, che sarà identificato con gli Inferi, Erebo, dimora dei morti, Notte, che insieme a Erebo dà vita all’aria e al giorno. La nascita di Erebo e Notte avviene per analogia, da Caos che è una realtà oscura, quella di Etere e Giorno per contrasto: etere è l’aria chiara che domina durante il giorno e scaturisce, per contrasto, dalla Notte. La terra è rappresentata nella sua funzione materna, poiché Gaia genera, insieme al cielo, Urano, i monti e due zone acquoree, Ponto e Oceano.
1 • Il mito 11
T1
LETTURA ESPRESSIVA
Sacra Bibbia, Genesi (1, 1-27)

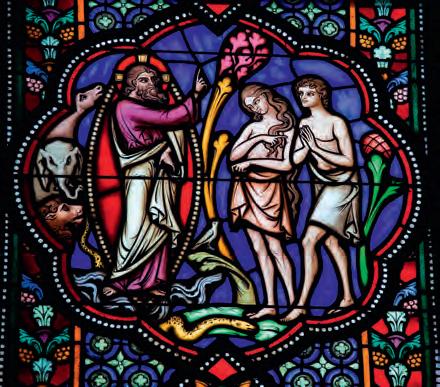
La creazione nel racconto biblico
La stessa domanda, «come è nato il mondo?», nella Bibbia, dà origine a una spiegazione diversa, che si esplica nel racconto della creazione
In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno. Dio disse: “Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque”. Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno. Dio disse: “Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l’asciutto”. E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: “La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie”. E così avvenne: la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno. Dio disse: “Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra”. E così avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno. Dio disse: “Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo”. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: “Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra”. E fu sera e fu mattina: quinto giorno. Dio disse: “La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie”. E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secon do la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra!”. Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li
Strumenti 12
creò.
T2 5 10 15 20 25 30 35 40
(Sacra Bibbia, Genesi, 1. 1-27)
Adamo ed Eva nel Giardino dell’Eden, vetrata, XVI sec., Bruxelles, Concattedrale dei Santi Michele e Gudula.
LETTURA ESPRESSIVA
Il primo sacrificio: il mito di Prometeo
Dalla Bibbia emerge un racconto dettagliato della creazione non solo del mondo, ma di tutti gli esseri viventi, ultimo di essi l’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio: nella mitologia greca, invece, non c’è un racconto unitario sull’origine dell’uomo; una tradizione ne attribuisce l’origine all’opera di Prometeo, il figlio del Titano Iapeto.
Alla figura di Prometeo sono legati altri miti, volti a illustrare altri aspetti della vita del mondo e del rapporto fra gli uomini e gli dei. Un mito particolare, che ha in Prometeo il protagonista, è quello che narra l’istituzione del sacrificio e viene narrato, ancora una volta, da Esiodo
535 Inf atti, quando la loro contesa dirimevano dèi e uomini mortali a Mecone, allora [Prometeo] un grande bue con animo consapevole, spar tì, dopo averlo diviso, volendo ingannare la mente di Zeus; da una par te infatti carni e interiora ricche di grasso pose in una pelle, nascostele nel ventre del bue, 540 dall’altra ossa bianche di bue, per perfido inganno con ar te disposte, nascose nel bianco grasso. E allora a lui disse il padre degli uomini e degli dèi: «O figlio di Iapeto, illustre fra tutti i signori, amico mio caro, con quanta ingiustizia facesti le parti».
545 Così disse Zeus beff ardo che sa eterni consigli, ma a lui r ispose Prometeo dai torti pensieri, r idendo sommesso, e non dimenticava le sue ingannevoli arti: «O Zeus nobilissimo, il più grande degli dèi sempre esistenti, di queste scegli quella che il cuore nel petto ti dice».
550 Così disse meditando inganni, ma Zeus che sa eterni consigli r iconobbe l’inganno, né gli sfuggì, e mali meditava dentro il suo cuore per gli uomini mor tali e a compierli si preparava. Con ambedue le mani il bianco g rasso raccolse; si adirò dentro l’animo e l’ira raggiunse il suo cuore, 555 come vide le ossa bianche del bue frutto del perfido inganno: è da allora che agli immor tali la stirpe degli uomini sulla terra br ucia ossa bianche sugli altari odorosi.
nel cuore del testo
Il racconto di Esiodo illustra un’usanza greca tipica, quella del sacrificio offerto agli dei, e nello stesso tempo descrive il personaggio di Prometeo, benefattore degli uomini. Questo racconto si può definire un mito eziologico*, in quanto illustra la causa, l’origine di un fenomeno, in questo caso un rito. Esso istituisce una precisa tradizione religiosa, un rito che dovrà sempre essere rispettato. Questo testo non è solo racconto, ma soprattutto istituisce una tradizione, inaugura un costume religioso che fa parte della cultura greca: il mito assume qui una funzione normativa.
* eziologico: da aitía, causa, lógos, discorso, spiegazione

13 1 • Il mito
Esiodo, Teogonia (I, vv. 535-557)
T3
(Esiodo, Teogonia, I, vv. 535-557, trad. di G. Arrighetti, BUR, Milano 1984)
LETTURA ESPRESSIVA
GUIDA alla lettura
Prometeo come mediatore tra uomini e dei Esiodo allude a una lite fra gli dei e gli uomini, cioè a un momento in cui essi non vivevano insieme in armonia, ma erano ormai in due mondi separati, caratterizzati dalla difficoltà di comunicare.
Il sacrificio, l’offerta di beni a Zeus, escogitato da Prometeo è proprio un modo per parlare con gli dei, per cercare di attirare la loro attenzione e la loro benevolenza. Prometeo quindi è un mediatore fra gli dei e gli uomini: è figlio di un Titano, Iapeto, ha aiutato Zeus quando gli altri Titani hanno cercato di sottrargli il potere, si assume il compito di suddividere le parti del bue che è stato ucciso e di indurre Zeus a scegliere la propria parte.
Tuttavia, in questo evento, che costituirà il primo sacrificio, Prometeo cerca di ingannare Zeus. Nasconde la parte migliore per gli uomini e mette in mostra quella peggiore per indurre la divinità a una scelta sbagliata. Zeus naturalmente comprende l’inganno, ma sceglie deliberatamente la parte più sfavorevole: avrà così un pretesto per punire gli uomini per l’inganno di Prometeo e il Titano stesso, che sarà inchiodato su
una rupe del Caucaso, esposto al freddo e al caldo, tormentato da un’aquila che gli divora il fegato, finché non sopraggiungerà Eracle a liberarlo.
Il mito fonda e spiega la realtà
Questo racconto è l’esempio molto efficace di un mito che vuole illustrare una verità, in questo caso il rapporto complesso tra gli dei e gli uomini, che si rivolgono ad essi con il sacrificio, seguendo un rituale istituito una volta per tutte in un’età antichissima. Esso è un racconto autorevole, veritiero, che illustra un contenuto ritenuto indiscutibile e fa luce su alcune conseguenze: per esempio, in questo caso, la difficoltà del rapporto tra gli dei e gli uomini, la tendenza di Zeus ad essere vendicativo, ma anche l’astuzia, indispensabile alla sopravvivenza, del Titano Prometeo. Non a caso egli induce Zeus a scegliere la parte non commestibile dell’animale ucciso, perché in una società povera come quella greca, e forse in qualsiasi società che fa un sereno calcolo economico, la parte commestibile dell’animale sacrificato è troppo preziosa per mandarla in fumo.
LABORATORIO delle competenze
COMPRENDERE
1. Chi sono i protagonisti dell’episodio?
a. gli dèi
b. gli uomini e Prometeo
c. Prometeo e Zeus
2. In che modo Prometeo separa le parti del bue sacrificato?
a. carne e interiora in una pelle
b. ossa e carne in una pelle
c. ossa nascoste nel grasso
3. Come si può giustificare la scelta di Prometeo?
a. per aiutare gli uomini
b. per favorire Zeus
c. per punire gli uomini
ANALIZZARE E INTERPRETARE
4. Perché questo mito si può definire un mito eziologico?
5. Come puoi definire le espressioni evidenziate nel passo? Che funzione hanno?

SCRIVERE
6. Questo mito ha la caratteristica tipica di ogni mito, cioè quella di raccontare una storia: quali altre funzioni assume? Per quale ragione?
Strumenti 14
La punizione di Prometeo, ceramica greca.
Eschilo, Prometeo incatenato (vv. 436-471, 476-506)
Altre voci: il Prometeo di Eschilo
Una caratteristica fondamentale del mito è quella di potere essere narrato in diverse versioni, arricchendosi ogni volta di dettagli o di significati, oppure di assumere un personaggio e un evento della sua vita per fargli incarnare altre funzioni espressive. Per esempio, nella formulazione di Eschilo, il tragico ateniese del v secolo a.C., la vicenda di Prometeo è legata a un evento successivo a quello del sacrificio di Mecone, al furto del fuoco, che egli sottrae a Zeus per donarlo agli uomini. Anche questo episodio è narrato da Esiodo, che racconta come Zeus per vendicarsi di questo furto inviò tra gli uomini Pandora, la prima donna, origine di tutti i mali. Eschilo, riprendendo il racconto esiodeo, concentra la sua narrazione sulla pena inflitta al Titano e trasforma Prometeo nell’eroe del progresso; egli infatti narra le conseguenze del dono del fuoco agli uomini in un passo assai affascinante.
Ascoltate invece le miserie dei mortali: erano come infanti prima, e io diedi loro coscienza e pensiero. Parlerò senza disprezzo alcuno per gli uomini, ma vi spiegherò quanto fu il mio amore per loro, quali i miei doni. Prima, avevano occhi e non vedevano, orecchie e non sentivano, ma come le immagini nei sogni vivevano confusamente una vita lunga, inconsapevole. Non sapevano costruire edifici, case all’aperto, non sapevano lavorare il legno: abitavano sottoterra come brulicanti formiche, in caverne profonde, senza la luce del sole. Non sapevano riconoscere i segnali dell’inverno, la primavera e i suoi fiori, l’estate e i suoi frutti. Facevano tutto senza coscienza finché io insegnai loro a distinguere il sorgere e il tramontare degli astri; e poi il numero, principio di ogni sapere, per loro inventai, e le lettere e la scrittura, memoria di tutto, madre feconda della poesia.
Per primo addomesticai le bestie selvatiche, le legai al giogo, così che sostituissero gli uomini nelle fatiche pesanti; domai i cavalli e li legai al carro, ché fossero il vanto di lussuoso sfarzo. Io e nessun altro inventai la nave, il cocchio marino dalle ali di lino. E io che per gli uomini ho escogitato tutte queste invenzioni, disgraziato non so trovare per me il mezzo per sfuggire a questa pena. [...]
Ancor di più ti stupirai ascoltando il resto: quali arti, quali espedienti ho inventato. Il più importante è questo: se uno si ammalava non aveva alcun rimedio, né cibo, né unguento o pozione. Si consumavano così, senza farmaci, finché io non insegnai loro a miscelare medicamenti curativi per scacciare tutte le malattie. Poi spiegai loro distintamente i diversi tipi di divinazione: per primo insegnai a discernere le visioni veridiche che vengono in sogno, e a riconoscere le voci confuse dei presagi, gli indizi da trarre dagli incontri. Da me impararono a distinguere il volo degli uccelli rapaci, il significato del volo da destra e del volo da sinistra; il comportamento di ciascun uccello, quali siano in contrasto fra loro, quali in accordo, quali convivano assieme. Le viscere degli animali poi insegnai a osservare, se sono lisce e quale colore hanno, se dalla bile risulta il favore degli dei, e le forme variabili del lobo del fegato. Insegnai a bruciare le parti più interne dell’intestino e lunghi lombi misi sul fuoco. Così guidai i mortali sulle vie imperscrutabili delle arti magiche: resi chiari per loro i segnali che prima erano oscuri. Questo è tutto quello che ho fatto. E quanto ai tesori nascosti nella terra, utili agli uomini – bronzo, ferro, argento e oro – chi prima di me potrebbe dire di averli scoperti? Nessuno, lo so bene, nessuno che non voglia vantarsi a vuoto.
In poche parole, insomma, sappilo: i mortali possiedono tutte le arti grazie a Prometeo.
(Eschilo, Prometeo incatenato, vv. 436-471, 476-506, trad. di M. Centanni, Mondadori, Milano 2003)

15 1 • Il mito
T4 5 10 15 20 25 30 35
LETTURA ESPRESSIVA
LABORATORIO delle competenze

COMPRENDERE
1. Come descrive Prometeo la condizione degli uomini prima del dono del fuoco?
a. erano come bambini incapaci di agire e pensare
b. erano privi di sensi
c. avevano ogni risorsa e ne sapevano usufruire
2. Quali sono, secondo Prometeo, le conseguenze legate all’uso del fuoco?
a. gli uomini imparano a consumare cibi cotti
b. gli uomini imparano a usare la luce del fuoco
c. grazie al fuoco gli uomini fanno progressi in ogni campo
3. Una parte importante del discorso di Prometeo è legata alla sfera religiosa: quali sono le conoscenze che, secondo lui, dipendono dal suo intervento?
a. l’interpretazione delle viscere degli animali
b. l’interpretazione delle viscere degli animali e del volo degli uccelli
c. l’interpretazione del volo degli uccelli
ANALIZZARE E INTERPRETARE
4. Alcune espressioni del discorso di Prometeo sono particolarmente significative, per esempio:
– il numero, principio di ogni sapere
– la scrittura, memoria di tutto, madre feconda della poesia
– la nave, il cocchio marino dalle ali di lino
Illustra il significato di queste espressioni, spiegando perché questi elementi sono definiti in questo modo.
5. Nel testo compaiono alcuni paragoni: individuali e spiega per quale motivo, a tuo parere, sono stati introdotti nel discorso.
SCRIVERE
6. «E io che per gli uomini ho escogitato tutte queste invenzioni, disgraziato non so trovare per me il mezzo per sfuggire a questa pena». Illustra lo stato d’animo di Prometeo, quale emerge da questa affermazione.
Strumenti 16
Platone, Protagora (320c-323a, 325d-e e 326c-e)

Epimeteo e il mito del progresso
Leggiamo il mito di Prometeo così come viene narrato da Platone, nel dialogo intitolato Protagora, dal nome del filosofo che dialoga con Socrate, a cui è attribuita la narrazione del mito, un’altra variante della vicenda di Prometeo e del furto del fuoco. Protagora – il narratore nel dialogo platonico – però lega la sua narrazione ad altri due temi: la nascita degli uomini e l’origine della democrazia.
Vi era un tempo in cui esistevano gli dèi, ma non ancora razze mortali. Quando anche per queste giunse il tempo destinato alla generazione, gli dèi le plasmarono all’interno della terra, mescolando terra, fuoco e gli elementi che si combinano col fuoco e con la terra. Immediatamente prima di portarle alla luce, incaricarono Prometeo ed Epimeteo di ordinarle e di distribuire ad ognuna le possibilità confacenti. Epimeteo pregò Prometeo di lasciargli il compito della distribuzione. «Dopo che avrò distribuito, disse, tu verrai a controllare.» Ottenuto il suo consenso, si mise all’opera. Nella distribuzione assegnò ad alcuni la forza senza la velocità; ad altri più deboli assegnò la velocità; dotò alcuni di mezzi di difesa e di offesa; per altri, che aveva provvisti di natura inerme, escogitò qualche altra possibilità di conservazione. Agli animali che foggiava piccoli concedeva ali per la fuga o un’abitazione sotterranea; a quelli che faceva grandi di corpo, dava modo di conservarsi con la loro grandezza. Così distribuì le altre doti in modo che si compensassero. Escogitandole, aveva la precauzione che nessuna razza si estinguesse. Distribuisce cibi e stabilisce l’equilibrio tra predatori e prede... Dopo che le ebbe dotate in modo che sfuggissero alla distruzione reciproca, elaborò espedienti di difesa contro le intemperie del cielo: rivestì le razze di fitto pelame e di dure pelli, sufficienti a proteggere dall’inverno, ma capaci anche di difendere dai calori estivi, e fece in modo che questi rivestimenti costituissero, quando andavano a dormire, coperte proprie e naturali. E calzò alcune di zoccoli, altre di pelli spesse e senza sangue. In seguito fornì ad ogni specie cibi diversi: ad alcune l’erba della terra, ad altre i frutti degli alberi, ad altre ancora le radici. E ve ne sono altre alle quali diede come cibo la carne di altri animali; a queste egli assegnò scarsa prolificità, alle loro prede, invece, grande prolificità, procurando così la conservazione della specie. Ma Epimeteo, che non era un gran sapiente, non si accorse di aver consumato le possibilità in favore degli animali senza ragione: il genere umano rimaneva ancora privo di ordine ed egli non sapeva che fare. Mentre era in difficoltà sopraggiunse Prometeo per esaminare la distribuzione e vide che gli altri animali erano forniti di ogni cosa in giusta proporzione, mentre l’uomo era nudo, scalzo, senza coperte e inerme. Ormai era imminente il giorno destinato in cui anche l’uomo doveva uscire dalla terra alla luce.
Preso dalla difficoltà di trovare una via di salvezza per l’uomo, Prometeo rubò l’abilità tecnica di Efesto e di Atena insieme col fuoco (perché acquisire o impiegare questa tecnica senza il fuoco era impossibile) e ne fece dono all’uomo. Con essa l’uomo ottenne la sapienza per la vita, ma non la sapienza politica. Questa si trovava presso Zeus e a Prometeo non era concesso di penetrare nell’Acropoli, abitazione di Zeus; inoltre le guardie di Zeus lo intimorivano. Si introdusse invece di nascosto nell’officina comune di Atena ed Efesto, ove essi lavoravano e insieme, rubò la tecnica di usare il fuoco, propria di Efesto, e l’altra, propria di Atena, e ne fece dono all’uomo. Da Prometeo quindi provenne all’uomo la risorsa necessaria per vivere; ma in seguito, a quel che si dice, a causa di Epimeteo, egli dovette scon-
17 1 • Il mito
T5 5 10 15 20 25 30 35 40 LETTURA
ESPRESSIVA
tare la pena del suo furto. Divenuto partecipe di una condizione divina, l’uomo fu, in primo luogo, a causa della sua parentela con la divinità, il solo tra gli animali a credere negli dèi e ad innalzare ad essi altari e statue; in secondo luogo, egli articolò ben presto con tecnica voce e parole, e inventò abitazioni, vesti, calzature, coperte e gli alimenti che nascono dalla terra. Pur essendo così forniti, in principio gli uomini vivevano dispersi e non esistevano città; perivano quindi uccisi dalle fiere, dato che erano in tutto più deboli di esse: la tecnica artigianale bastava per aiutarli a procacciarsi il cibo, ma era insufficiente nella lotta contro le fiere, perché essi non possedevano ancora la tecnica politica, di cui è parte la tecnica di guerra. Cercavano allora di riunirsi e di salvarsi fondando città; ma quando si erano riuniti, commettevano ingiustizie reciproche in quanto non possedevano la tecnica politica, sicché nuovamente si disperdevano e perivano. Zeus, temendo l’estinzione totale della nostra specie, inviò Ermes a portare agli uomini il rispetto e la giustizia, affinché costituissero l’ordine della città e fossero vincoli di solidarietà e di amicizia. Ermes chiese a Zeus in che modo dovesse dare la giustizia e il rispetto agli uomini: «Devo distribuirli come le altre tecniche? Queste sono distribuite in modo che un solo medico, per esempio, basta per molti profani; allo stesso modo gli altri artigiani. La giustizia e il rispetto devo stabilirli in questo modo tra gli uomini o devo distribuirli a tutti?». «A tutti, rispose Zeus, e tutti ne partecipino: non esisterebbero città, se, come avviene per le altre tecniche, soltanto pochi ne partecipassero. E stabilisci in mio nome una legge per la quale chi non può partecipare di rispetto e giustizia sia ucciso come peste della città». Per questo, Socrate, gli Ateniesi, come gli altri uomini, quando si discute sulla virtù costruttrice o su qualche altra tecnica artigianale, credono che sia compito di pochi dare consigli, e se qualcuno, estraneo a questi, si mette a darne, non lo tollerano, come tu dici, e a ragione, dico io. Quando invece si riuniscono a consiglio sulla virtù politica, che deve procedere interamente secondo giustizia e saggezza, è naturale che ammettano a parlare chiunque, poiché è proprio di ognuno partecipare di questa virtù; altrimenti non esisterebbero città.
(Platone, Protagora, 320c-323a, 325d-e e 326c-e, in Dialoghi filosofici, vol. I, a cura di G. Cambiano, Utet,Torino 1987, pp. 319-322, 324-326)
GUIDA alla lettura
Prometeo eroe culturale
A partire dalla lettura del passo di Eschilo che abbiamo visto ( T4 Altre voci: il Prometeo di Eschilo, p. 15), numerosi autori moderni e contemporanei hanno costruito diverse “storie” sulla figura di Prometeo, visto come eroe culturale, cioè colui che trasmette conoscenze e abilità sulle quali si fonda una cultura condivisa in una società, tanto che nella figura dello sfortunato Titano si è incarnato quello che si può definire il mito del progresso. In questo caso il termine mito non è più usato nel significato originario, ma in quello appunto contemporaneo di racconto straordinario, che comporta ammirazione e attenzione e coinvolge significati anche diversi da quello che in origine avevano la figura di Prometeo e le sue vicende; in questo senso si può dire che un mito originario, antichissimo, è diventato un mito letterario,
su cui autori diversi in tempi diversi hanno riflettuto e di cui hanno dato la loro interpretazione.
Il mito nel racconto platonico
Un autore antico che “usa” il mito in modo ancora diverso è il filosofo Platone: egli fa ricorso ai miti “tradizionali”, tra cui quello di Prometeo, oppure ne crea di nuovi, con nuove figure e nuovi significati: anche in questo caso il racconto platonico non è fantasia pura, non è solo una favola, ma è un racconto che aspira a illustrare una verità che si affianca alla filosofia: il mythos, per Platone, è affine, non opposto al lógos, la spiegazione filosofica più rigorosa.
In questo caso, il mito serve a illustrare la nascita di una città ben regolata, capace di garantire la convivenza dei suoi concittadini: è diventato una sorta di teoria politica.
Strumenti 18
45 50 55 60 65 70
Erodoto, Storie (I, 1-5)

Il mito e la storia
Il ricorso al mito in dimensione storica, come nella narrazione della guerra di Troia in Omero, è ancora fondamentale in un autore molto più tardo, Erodoto, che vive nel v secolo a.C., ed è considerato il padre della storia greca
All’esordio della sua opera, le Storie, egli fa risalire le ostilità fra i Greci e i Persiani, che sfociano nelle guerre persiane, a una vicenda mitica.
I dotti persiani affermano che i responsabili della rivalità furono i Fenici. Costoro giunsero in queste nostre acque provenienti dal mare detto Eritreo; insediatisi nella regione che abitano tuttora, subito, con lunghi viaggi di navigazione, presero a fare commercio in vari paesi di prodotti egiziani ed assiri, e si spinsero fino ad Argo. A quell’epoca Argo era da ogni punto di vista la città più importante fra quante sorgevano nel territorio oggi chiamato Grecia. I Fenici arrivarono ad Argo e vi misero in vendita le loro mercanzie. Quattro o cinque giorni dopo il loro arrivo, ormai quasi esaurite le merci, scesero sulla riva del mare diverse donne, tra le quali si trovava la figlia del re Inaco: si chiamava Io, anche i Greci concordano su questo punto. Secondo i dotti persiani, mentre le donne si trattenevano accanto alla poppa della nave, per acquistare i prodotti che più desideravano, i marinai si incoraggiarono a vicenda e si avventarono su di loro: molte riuscirono a fuggire, ma non Io, che fu catturata insieme con altre; risaliti sulle navi, i Fenici si allontanarono, facendo rotta verso l’Egitto.
Secondo i Persiani Io giunse in Egitto così e non come narrano i Greci; e questo episodio avrebbe segnato l’inizio dei misfatti. In seguito alcuni Greci (essi non sono in grado di precisarne la provenienza), spintisi fino a Tiro, in Fenicia, vi rapirono la figlia del re, Europa; è possibile che costoro fossero di Creta. E fino a qui la situazione era in perfetta parità, ma poi i Greci si resero responsabili di una seconda colpa: navigarono con una lunga nave fino ad Ea e alle rive del fiume Fasi, nella Colchide, e là, compiuta la missione per cui erano venuti, rapirono Medea, la figlia del re dei Colchi; questi mandò in Grecia un araldo a reclamare la restituzione della figlia e a chiedere giustizia del rapimento, ma i Greci risposero che i barbari non avevano dato soddisfazione del ratto dell’argiva Io e che quindi per parte loro avrebbero fatto altrettanto.
(Erodoto, Storie, I, 1-5, trad. di A. Izzo D’Accinni, Rizzoli, Milano 1984)
Altre funzioni del mito
Tra le funzioni del mito rientra anche quella di narrare la storia, in diverse modalità: la vicenda della guerra di Troia, che è narrata nell’Iliade come la grande spedizione degli Achei contro la città di Priamo per riportare Elena, la sposa di Menelao, in patria, dopo che ella ha abbandonato il marito ed è fuggita con Paride, è senz’altro una vicenda che cela uno sfondo storico. Gli studiosi moderni sono concordi nel ritenere che la
narrazione epica abbia come sfondo reale una vicenda storica, una spedizione a Oriente da parte dei Micenei, forse la loro ultima grande impresa. Come emerge dal racconto di Erodoto, una vicenda bellica contemporanea allo scrittore viene fatta risalire a un tempo antichissimo, prendendo a pretesto due figure femminili, Io e Medea, che saranno a loro volta protagoniste di altre narrazioni mitiche.
19 1 • Il mito
T6
GUIDA alla lettura 5 10 15 20 25
LETTURA ESPRESSIVA
LABORATORIO delle competenze

COMPRENDERE
1. In quali luoghi sono ambientati i rapimenti che narra Erodoto?
a. in Asia
b. in Grecia
c. in Asia e in Grecia
2. Quali popolazioni ne sono protagoniste?
a. i Greci e gli Argivi
b. i Greci e i Fenici
c. i Fenici e i Persiani
3. Chi rappresenta l’Occidente e chi l’Oriente?
4. Perché i Fenici si recano ad Argo?
5. Che cosa rispondono i Greci al re dei Colchi?
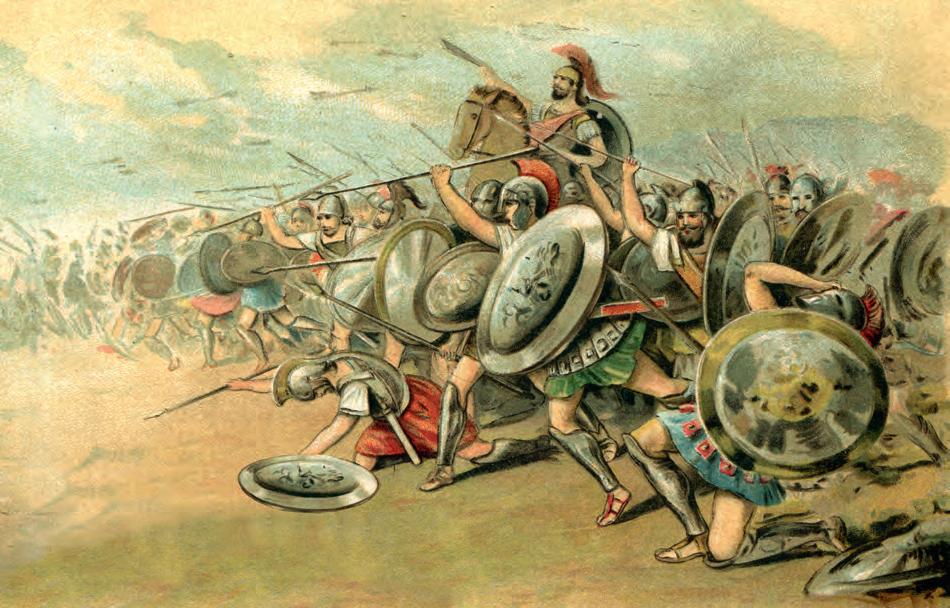
ANALIZZARE E INTERPRETARE
6. Ricostruisci la catena dei rapimenti: perché i Greci sostengono di essere in parità?
SCRIVERE
7. Cerca informazioni sulle figure di Io, di Europa e confronta la loro vicenda, indicando analogie e differenze nei miti tramandati su di loro. Puoi fare riferimento a questi link: http://www.treccani.it/enciclopedia/io_%28Enciclopedia-Italiana%29/ https://mediterraneoantico.it/articoli/archeologia-classica/il-mito-di-europa-e-il-toro/
Strumenti 20
L’esercito ateniese alla battaglia di Maratona del 490 a.C.
1.3 Il mito messo in scena
Mito e tragedia Il mito, che costituisce l’oggetto principale della narrazione epica, è ugualmente al centro di un’altra forma espressiva, la tragedia ( Scheda di approfondimento Il teatro tragico, p. 24). Si tratta di un fenomeno artistico di grandissima rilevanza, che nasce ad Atene, verso la fine del vi secolo a.C. e trova il suo sviluppo più importante nel corso del secolo successivo, quando viene anche esportato in Sicilia, a Siracusa, e in Macedonia, a Pella, alla corte del re Arcelao. Nella tragedia il mito diviene evento: l’eroe è protagonista di una vicenda che non viene narrata, ma messa in scena e vissuta nella forma del teatro. Il tempo in cui si svolge la vicenda non è il passato leggendario ed esemplare, ma il presente, il momento in cui la sua storia si svolge sulla scena; grazie alla convenzione per cui gli spettatori si illudono che i fatti si stiano svolgendo davanti ai loro occhi, l’eroe vive nella dimensione della recitazione, diventa vero e presente e la distanza temporale, che caratterizzava la narrazione epica, si azzera: sulla scena alla narrazione si sostituisce l’azione.
In questo modo, momenti e vicende esemplari prendono vita in un presente senza tempo, nel quale lo spettatore condivide la situazione del protagonista e dei personaggi che interagiscono con lui, e la sua esperienza diventa tanto più efficace e coinvolgente.
Eroi epici di fronte a scelte drammatiche La messa in scena del mito riguarda spesso personaggi che appartengono al mondo della poesia epica: Agamennone, Aiace, Odisseo. Si tratta di eroi caratteristici delle narrazioni del Ciclo epico, che nelle tragedie diventano protagonisti di eventi che riformulano il messaggio tradizionale. Mentre nella narrazione epica l’eroe era visto nella successione delle vicende che lo coinvolgevano insieme ai suoi compagni, nella tragedia egli è isolato in un momento cruciale, che, pur includendo e spesso travolgendo gli altri personaggi, lo vede al centro di scelte che deve operare in prima persona, quasi sempre senza avere una vera possibilità di salvezza. Quando gli eroi protagonisti della tragedia sono desunti dal mondo omerico, della loro vita si mettono in scena momenti diversi da quelli narrati da Omero: Agamennone è rappresentato nel suo funesto rientro in patria, Aiace nel momento in cui, dopo la morte di Achille, si vede negate le armi dell’eroe, cui aspirava, Odisseo è colto in momenti diversi, ma sempre prima di intraprendere il viaggio che lo riporterà a casa, quindi ancora sul campo troiano.
La crisi dell’eroe epico Il cuore della messa in scena è la crisi dell’eroe epico: mentre nella poesia omerica egli è rappresentato all’apice della gloria, anche se vinto, nella tragedia egli è in una condizione che lo mette in discussione, o, come nel caso di Agamennone e Aiace, lo porta a una morte ingloriosa, che rovescia completamente il ritratto che il poeta arcaico ne aveva dato. Nel momento in cui lo spettatore, cessata la rappresentazione, reagisce a ciò che ha visto, nasce in lui la riflessione sul destino tragico dell’eroe, sui limiti della sua azione e sul significato che essa assume: da questo punto di vista la tragedia utilizza il mito come forma educativa, che ricade sulla formazione del cittadino ateniese.
21 1 • Il mito
Sofocle, Aiace (vv. 430-484)

La follia di Aiace
Aiace, eroe omerico di grande valore, secondo solo ad Achille, può essere considerato un esempio efficace di questa operazione. Il poeta tragico Sofocle ne mette in scena la vicenda intorno al 440 a.C.; egli rappresenta l’eroe nel momento in cui, privato delle armi di Achille, a cui legittimamente aspirava dato il suo ruolo preminente nell’esercito, per decisione dell’assemblea degli Achei, è colto dall’ira e decide di vendicarsi dei compagni, che lo hanno disonorato. Per intervento della dea Atena, però, egli è colpito da follia e, scambiando le bestie dell’accampamento per i suoi compagni, ne fa strage. Ciò che comporta la salvezza dei compagni, è per l’eroe motivo di vergogna: egli ha fallito il bersaglio e non ha portato a termine la vendetta che riteneva suo dovere. Per questo motivo, dopo aver preso coscienza dell’accaduto, si suicida, gettandosi sulla spada di Ettore, che aveva avuto dall’avversario alla fine di un duello eroico: da un punto di vista simbolico, Aiace ottiene la morte dal suo avversario e riscatta così la sua sorte infelice, tornando ad essere, in un certo senso, l’eroe che la vergogna rischiava di cancellare.
In questo passo, Aiace, ormai consapevole di quanto è accaduto, ricorda la sua dignità di eroe, ormai perduta, e riflette sulla scelta che lo attende.
430 Ahi, ahi, Aiace! Chi avrebbe mai pensato che questo nome fosse così adatto alle mie sventure! Ora è il momento di g ridare per due, tre volte «Ahi, ahi, Aiace!», davanti a sciagure così grandi.
435 Da questa ter ra dell’Ida mio padre r itornò in patria riportando la gloria più g rande, il premio più bello dell’armata. Ed io, suo figlio, che in questa stessa terra sono venuto con forze non inferiori
440 e ho compiuto imprese di valore eguale, per isco tra il disprezzo degli Achei.
Ma c’è una cosa di cui sono cer to: se fosse stato vivo Achille, se fosse stato lui ad assegnare le sue armi come premio del valore,
445 io le avrei ottenute, nessun altro.
E invece gli Atridi, disprezzando la mia forza, le hanno destinate, con l’inganno, a un intrigante. Se la follia, che stravolge gli occhi e la mente, non mi avesse distolto dal mio piano,
450 mai più essi avrebbero potuto pronunciare contro nessuno, un simile giudizio.
431-432. Questo nome… sventure: Aiace allude al suono del suo nome in greco, Aiax, che riecheggia nel grido di dolore che pronuncia.
441. Disprezzo degli Achei: nella prospettiva di Aiace, gli Achei lo disprezzano perché non ha saputo portare a termine la sua vendetta: egli è completamente legato alla logica dell’onore aristocratico.
443-445. Se fosse stato… altro: nell’Iliade Aiace è sempre ricordato come secondo solo ad Achille, ed egli fa parte dell’ambasceria che nel libro IX si reca da Achille per cercare di convincerlo a rientrare in battaglia.
448-451. Se la follia… giudizio: la follia per Aiace è ciò che lo ha distolto da quella che per lui sarebbe stata un’azione giusta; nel sovrapporsi delle
posizioni, essa è un gesto provvidenziale di Atena che salva gli eroi greci dalla strage, ma un intervento rovinoso per l’eroe che, in preda alla follia, non sa distinguere i veri oggetti delle sue armi. Se Aiace non fosse stato sviato da Atena, avrebbe rivolto la sua ira innanzitutto contro gli Atridi, Agamennone e Menelao, che considera i primi responsabili della sottrazione delle armi.
Strumenti 22
T7
LETTURA ESPRESSIVA
Ma la figlia di Zeus, la dea indomabile, dallo sguardo di Gorgone, mentre già levavo il mio braccio su di loro,
455 ha scagliato contro di me la furia della follia, e così ho macchiato le mie mani col sangue di quelle bestie Ed essi, che sono riusciti a sfuggirmi mio malg rado, ridono di me; se un dio
460 vuol f are del male, anche il vile r iesce a sfuggire al valoroso. E ora, che devo fare? Mi odiano gli dei E tutti i Greci, la Troade intera E queste sue pianure. Devo forse lasciare
465 Questi por ti sicuri e gli Atridi e ritornare In patr ia attraverso il mare Egeo? E con che f accia mi presenterò a mio padre, a Telamone? Come potrà sopportare di vedermi, se gli appaio davanti nudo, senza i premi
470 del valore che furono la grande corona della sua glor ia? No, non è possibile. Allora me ne andrò verso le mura Di Troia, per piombare sui nemici, solo, e mor ire alla fine, con le armi in pugno?
475 Quale g ioia sarebbe per gli Atridi! No, non è possibile. Devo tuttavia Trovare il modo di mostrare a mio padre Che sono figlio suo, e non sono un vile. Non è bello voler vivere a lungo
480 Per chi non prevede mutamento ai suoi mali. Quale gioia può dare un g iorno che si succede all’altro, se non la mor te? Non è degno di stima l’uomo che si nutre di speranze vane.
485 Vivere bene o morire bene, questo è il dovere dell’uomo nobile. Ed è tutto.
23 1 • Il mito
(Sofocle, Aiace, vv. 430-484, trad. di M.G. Ciani, Marsilio,Venezia 2001)
453. Gorgone: lo sguardo della Gorgone, secondo il mito, impietriva coloro cui si rivolgeva.
459. Ridono di me: nella tragedia, il riso del nemico è il vero timore dell’eroe, perché rende vana non solo la
sua azione, ma la sua natura stessa: deridere un eroe significa diminuirlo e privarlo della sua identità.
SCHEDA di approfondimento
Il teatro tragico
La nascita della tragedia
Il teatro tragico nasce in Atene e in questa città trova la sua massima espressione, nonostante due degli autori tragici di cui ci sono pervenute le opere, Eschilo e Euripide, abbiano svolto la loro attività anche fuori dalla città d’origine, in Sicilia, a Siracusa, e in Macedonia.
La sua nascita risale all’inizio del v secolo a.C., ma la prima tragedia giunta fino a noi, i Persiani di Eschilo, è datata al 472, ed è l’unica che tratta un argomento storico, la sconfitta dei Persiani, ad opera degli Ateniesi, nella battaglia di Salamina, avvenuta nel 480 a.C., quindi solo pochi anni prima della rappresentazione.
L’occasione delle feste
Le tragedie venivano rappresentate durante le feste che la città dedicava al dio Dioniso, in primavera, e avevano carattere agonale: si trattava cioè di una vera e propria gara, della durata di quattro giorni (diventeranno tre durante la guerra del Peloponneso), durante la quale ognuno dei tre poeti ammessi all’agone tragico metteva in scena tre tragedie e un dramma satiresco, mentre nel quarto giorno venivano rappresentate le commedie.
La selezione per essere ammessi alla partecipazione durante le Dionisie era molto difficile: i poeti presentavano le opere a un collegio giudicante, che doveva valutarle, soprattutto in rapporto ai valori della città, perché la messa in scena avveniva attraverso un sistema di tassazione particolare, la liturgia. Infatti i cittadini più ricchi sostenevano le spese per l’allestimento tramite il versamento di molto denaro, che a tutti gli effetti veniva impiegato per una finalità pubblica.
Il significato della tragedia
La tragedia, quindi, non era sentita come uno spettacolo, un divertimento, ma un momento di partecipazione a una festa religiosa che metteva in scena personaggi e vicende volti a sollecitare una riflessione su temi importanti, spesso lasciando “aperta” l’interpretazione.
Le tematiche storiche, a parte l’esempio unico dei Persiani di Eschilo, non trovavano spazio, se non in una lettura in chiave contemporanea del mito, oggetto dominante delle messe in scena. In realtà per noi risulta molto difficile comprendere in quale misura i cittadini ateniesi individuassero riferimenti storici precisi nelle tragedie cui assistevano, ed è più probabile che vedessero negli eroi protagonisti delle figure esemplari, che incarnavano i grandi temi della riflessione filosofica e della poesia contemporanee.
Ciò che risulta evidente è che i personaggi del mito, che erano oggetto
di racconto nella tradizione epica, diventano nelle tragedie dei personaggi vivi, perché interpretati dagli attori, e quindi rendono possibili processi di immedesimazione tra il pubblico che assiste alla rappresentazione e i protagonisti delle opere di volta in volta rappresentate.
Il testo tragico
La struttura del testo tragico, che comprende parti dialogate estese, in cui inizialmente due attori, più tardi tre, si confrontano anche aspramente, rende evidente la differenza rispetto alla narrazione epica: gli attori che interpretano gli eroi sono “vivi” sulla scena, la distanza del tempo è annullata, il pubblico li vede dibattere come se l’evento rappresentato fosse veramente attuale.
L’aspetto dialogico del testo tragico è in gran parte dovuto allo sviluppo di una particolare attività ateniese, che è contemporanea alla nascita del teatro: l’arte retorica. Gli oratori dibattevano nella piazza della città, l’agorà, di temi politici, etici, religiosi, e i cittadini appartenenti ai ceti più ricchi, educati nell’arte retorica, discutevano nel Consiglio, la boulé, e nell’assemblea, l’ecclesìa, nelle quali si assumevano decisioni politiche fondamentali, soprattutto nelle ricorrenti circostanze della guerra.
La funzione del coro
Anche da questo punto di vista, la tragedia è uno specchio fedele della città. Un’ultima considerazione è indispensabile a proposito delle parti corali: nella tragedia attica le parti dialogate sono intervallate da cori, parti nelle quali recita un coro, formato dapprima da dodici, poi, grazie all’innovazione di Sofocle, da quindici coreuti, che intervengono come se fossero una voce sola, commentando l’accaduto, gli sviluppi del dialogo, o riportando gli eventi all’esempio mitico, inserendo elementi legati alla tradizione religiosa. Il coro rappresenta l’eredità più antica della poesia corale, appunto, che passa nella tragedia in questa forma, anche se è impossibile per noi comprendere in che modo l’antica poesia corale abbia influenzato la struttura e la natura del coro tragico. Quello che è certo è che i coreuti, che entrano in scena all’inizio della rappresentazione, permangono sulla scena per tutta la durata di essa: sono quindi testimoni di tutto lo svolgimento delle vicende, al contrario degli attori, che si succedono sulla scena. In questo senso il coro è un testimone privilegiato dell’evento tragico e ne ha una conoscenza che ne giustifica i commenti e le valutazioni, anche quando essi superano la conoscenza dei fatti che hanno gli stessi protagonisti.

Strumenti 24
Busto di Eschilo, Atene, Giardino nazionale.
L’impatto emotivo della messa in scena
Mettere in scena un evento come se stesse avvenendo veramente, attraverso gli scambi dialogici degli attori, e inserire il commento costante del coro, che nello stesso tempo è legato ai fatti rappresentati, ma tende ad astrarne un significato superiore, comporta un forte impatto emotivo, e questo è ciò che realizza la convenzione del teatro: lo spettatore assiste alla vicenda non attraverso il filtro del racconto, ma direttamente, come se ciò che è rappresentato avvenisse veramente davanti ai suoi occhi; nello stesso tempo è sollecitato a trarre, da ciò cui assiste, delle riflessioni. Quando l’attore sulla scena si spoglia della sua identità reale, per assumere quella fittizia del personaggio che incarna, mette in scena un evento, ed esso si imprime nell’emotività dello spettatore, suscitandone la partecipazione; quando il coro interviene, commenta o dialoga a sua volta con l’attore, sollecita nel pubblico un momento critico, di approfondimento. Inoltre, mentre il tempo del racconto epico è il passato, esemplare ma lontano, il tempo della tragedia è il presente dell’evento che si compie sulla scena. Per quanto l’episodio rappresentato sia lontano nel tempo, esso viene sentito come se avvenisse in quel momento, e quindi sollecita domande ben più forti in chi assiste alla rappresentazione.
La funzione dei miti
Dunque i grandi eroi del mito, Aiace, Odisseo, Edipo, Agamennone e molti altri vengono “isolati” in un momento specifico della loro vita, ed esso assume un valore esemplare e diventa oggetto di riflessione: la vicenda della follia di Aiace, di cui leggiamo un passaggio
( T7 La follia di Aiace, p. 22), induce a interrogarsi sulla grandezza dell’eroe, che può diventare ossessione e condurlo all’autodistruzione; essa può, allo stesso tempo, essere una
riflessione sulla necessità, per l’uomo inserito nella comunità, di adattarsi alle regole di quella comunità, ridimensionando le sue aspirazioni individuali. Può darsi che, nello spettatore ateniese del tempo, l’esempio di Aiace divenisse uno specifico ammonimento ad adeguarsi alle leggi della città democratica: un eroe individualista come Aiace, grandissimo ai tempi dell’antica aristocrazia narrata da Omero, sarebbe quindi distruttivo, per sé e per la città, nel tempo della democrazia.
Analogamente, altri miti, divenuti famosi, quali quello di Edipo o di Eracle, inducono alla riflessione sul significato dell’oracolo: la divinità comunica con l’uomo attraverso l’oracolo, ma l’uomo non può presumere di comprendere sempre esattamente le parole del dio: in tal senso, la vicenda di Edipo, come quella di Eracle, entrambe narrate da Sofocle, assumono il valore di una critica alla fiducia eccessiva nelle capacità di conoscere dell’uomo: la fiducia nelle proprie forze non deve mai portare all’eccesso, ma anzi, deve porre sempre come punto di riferimento il senso del limite.
L’esemplarità della figura eroica
Si comprende quindi come le figure eroiche, astratte dal contesto epico originale, diventino esemplari sulla scena della città, perché in grado di assumere altri significati, nel momento in cui incarnano eventi specifici, che portano in evidenza comportamenti e gesti isolati, ma per questo ben più forti; quegli stessi personaggi hanno, in un certo senso, attraversato i tempi, perché la tragedia attica, che si è spenta nel iv secolo, ha in realtà continuato a vivere altrove, sia nelle messe in scena dei testi originali, sia nelle riletture di essi, in forme diverse, con una grandissima vitalità, dovuta alla possibilità di leggere ogni volta le vicende rappresentate in luoghi e tempi diversi, ma sempre con la stessa forza espressiva.

1 • Il mito 25
Veduta panoramica del Teatro greco di Siracusa, V sec. a.C.
nel cuore del testo
Aiace è abbattuto nella sua
dimensione: nessuna parola lo potrà convincere, ancorato com’è al senso dell’onore, nemmeno quelle di Tecmessa, che fa appello agli affetti di compagno, di figlio, di padre. I due lunghi monologhi si contrappongono, e non ci sarà mediazione alcuna.
Sofocle, Aiace (vv. 485-524)
La risposta di Tecmessa
Al lungo monologo di Aiace segue la risposta di Tecmessa, la schiava di guerra divenuta sua compagna e madre di suo figlio Eurisace, che lo scongiura di non fare una scelta rovinosa per lei e per il figlio.
485 Mio signore, essere in balia della sorte è la disg razia peggiore per gli uomini. Io sono nata da un uomo libero, ricco e potente come nessun altro tra i Frigi, e ora sono schiava: vollero così gli dei
490 e la forza del tuo braccio. Ma da quando mi sono unita a te, è al tuo bene che penso. In nome di Zeus, protettore del nostro focolare, in nome di questo letto, che ci ha uniti, io ti supplico, non espormi ai dolorosi insulti
495 dei tuoi nemici, non abbandonarmi nelle loro mani. Se tu morirai e io resterò sola, in quello stesso giorno gli Argivi mi trascineranno a forza insieme con tuo figlio
500 a mang iare il pane degli schiavi. E qualcuno dei miei padroni mi rivolgerà parole crudeli, dirà: «Ecco la donna di Aiace, il guer riero più forte dell’ armata, tanto invidiata un tempo
505 e ora r idotta in schiavitù».
Questo diranno di me e questo sarà il mio destino, ma le parole suoneranno a biasimo di te e della tua stir pe. Abbi vergogna di abbandonare tuo padre
510 nella sua vecchiaia dolorosa, e tua madre, car ica d’anni, che innalza suppliche agli dei perché tu ritorni, vivo, a casa tua.
Abbi pietà, signore, di tuo figlio: quanto male infliggeresti a lui e a me con la tua morte,
515 se dovesse passare la sua infanzia solo e senza cure, con dei tutori malvagi! Io non ho altr i al mondo cui rivolgere lo sguardo, se non te. La tua lancia ha distr utto la mia patria; altro destino ha condotto
520 mia madre e mio padre nelle dimore di Ade.
Quale patr ia, quale ricchezza mi resta senza di te? Tu sei la mia salvezza.
Ricordati di me: un uomo non deve dimenticare la dolcezza che ha ricevuto.
525 Il bene genera il bene, sempre, e colui che non osser va il ricordo di quel bene non può essere definito un uomo nobile.
(Sofocle, Aiace, vv. 485-524, trad. di M.G. Ciani, Marsilio,Venezia 2001)

Strumenti 26
T8
LETTURA ESPRESSIVA
GUIDA alla lettura
Il codice d’onore dell’eroe omerico Aiace rappresenta pienamente l’aspetto dell’antico eroe omerico, legato al codice dell’onore. Come Achille, che si ritira dalla battaglia per vendicare l’offesa subita con la sottrazione di Briseide, così Aiace vorrebbe sterminare i suoi compagni per vendicarsi della sottrazione delle armi di Achille:inentrambiicasisitrattadell’onorenonriconosciuto. La condizione di Aiace è tanto più dolorosa perché egli vorrebbe farsi assassino dei compagni, e perché persiste nel suo desiderio di vendetta, anche dopo che la follia scaturita in lui da Atena lo salva da questo gesto. Ma nella sua ottica eroica, questa “salvezza” è in realtà una rovina, perché lo priva della soddisfazione che avrebbe voluto cogliere. Aiace è completamente solo, in preda alla frustrazione nei confronti del padre, che costituisce il modello eroico per eccellenza: come sempre, l’eroe deve essere all’altezza della sua stirpe. Inoltre egli diventerà
oggetto della derisione degli Atridi: essi, un tempo suoi compagni, ora sono i suoi nemici, e quindi la loro derisione comporterà la definitiva riduzione del suo ruolo eroico.
La figura di Tecmessa
Alle parole di Aiace risponde Tecmessa, il cui discorso ripercorre, con echi molto chiari, quello di Andromaca a Ettore nel vi libro dell’Iliade ( T4 L’ultimo incontro di Ettore e Andromaca, p. 155): come Andromaca, anche Tecmessa è ormai priva della sua famiglia, e prefigura un destino infelice di schiava per sé e una vita amara per il figlio. Inoltre Tecmessa rovescia la prospettiva di Aiace rispetto ai genitori: al contrario di quanto sostiene l’eroe, che non osa presentarsi al padre, essa sottolinea la tenerezza degli affetti dovuti agli anziani genitori, in una prospettiva squisitamente femminile, che, presente anche nel poema omerico, qui assume particolare rilievo.
LABORATORIO delle competenze

COMPRENDERE
1. Perché Aiace afferma che il suo nome è adatto alle sventure?
a. perché richiama il significato greco del nome
b. perché richiama il suono greco del nome
c. perché costituisce un soprannome
2. Perché Aiace teme di presentarsi al padre?
a. perché il padre si aspetta un bottino di guerra
b. perché non porta con sé Tecmessa come schiava di guerra
c. perché non è adeguato alla fama della sua famiglia
3. Perché Aiace è convinto che Achille avrebbe riservato a lui le sue armi?
a. perché egli è legato strettamente all’eroe per eroismo
b. perché lo avrebbe difeso davanti agli Achei
c. perché non avrebbe permesso che fossero date ad altri
4. Chi è la figlia di Zeus?
a. Afrodite
b. Atena
c. Era
ANALIZZARE E INTERPRETARE
5. Analizza e spiega questa affermazione di Aiace:
«Se la follia, che stravolge gli occhi e la mente, non mi avesse distolto dal mio piano, mai più essi avrebbero potuto pronunciare contro nessuno, un simile giudizio».
6. Individua nel discorso di Tecmessa le motivazioni con cui cerca di dissuadere Aiace da scelte funeste.
SCRIVERE
7. Leggi il discorso di Andromaca riportato alle pp. 155-157 e confrontalo con quello di Tecmessa, individuando le diverse condizioni delle due donne, ma soprattutto le analogie che legano i due discorsi.
27 1 • Il mito
1.4 Il mito in forma di romanzo
Il romanzo cortese-cavalleresco A partire dalla seconda metà del xii secolo, accanto all’epica carolingia delle canzoni di gesta – la cosiddetta “materia di Francia” – si sviluppa in Francia, e successivamente nell’area germanica, un’epica bretone o arturiana – la cosiddetta “materia di Bretagna” – che rielabora antiche leggende delle popolazioni celtiche della Francia settentrionale e della Britannia. Esse si incentravano sulla figura di re Artù, mitico re britannico (vissuto forse nel vi secolo d.C.) e di vari cavalieri, riuniti intorno al sovrano e alla sua Tavola Rotonda: Galeotto, Lancillotto, Perceval, Ivano, Galvano – per ricordare solo i più famosi – partivano dalla corte di Camelot in cerca di avventure per poi farvi ritorno periodicamente, in nome della fedeltà al re e agli ideali comuni.
La materia di Bretagna, unitamente alla cosiddetta “materia antica” – un ciclo di narrazioni ispirate a vicende e personaggi dell’antichità classica rivisitati in chiave tutta medievale – fornirà i contenuti di un nuovo genere della narrativa, il romanzo1 cortese-cavalleresco, fiorito nella Francia del Nord, attorno ad alcune corti di grande prestigio, come quella di Enrico II Plantageneto e di sua moglie Eleonora di Aquitania, o quella di una figlia di Eleonora, Maria, andata sposa a Enrico I di Champagne, che ospiterà e proteggerà uno dei più grandi autori di romanzi del tempo, Chrétien de Troyes, attivo fra il 1160 e il 1190, considerato il più grande poeta del Medioevo europeo dopo Dante.
I modelli della società cortese Il romanzo medievale è un genere letterario che propone modelli di vita e ideali propri della società cortese: il coraggio, l’amore, l’onore, la generosità, la raffinatezza. Il modello umano è un nuovo tipo di eroe, il cavaliere, che unisce alle virtù militari la nobiltà d’animo, la cortesia, la gentilezza, il senso innato della giustizia; gli ingredienti del romanzo sono il gusto per l’avventura e il sentimento d’amore, inteso come omaggio e servizio verso la donna, creatura perfetta, strumento di perfezionamento morale; gli scenari sono fantastici o meravigliosi.
1. Il termine roman (da romanz) significa inizialmente “lingua volgare neolatina” (cioè derivata dal latino); in un secondo momento designa genericamente un “testo scritto in volgare”, e poi un genere con precise caratteristiche, diverse nel tempo.
Strumenti 28
Scena cortese raffigurante il re inginocchiato in preghiera, damigelle di corte, soldati ed esponenti del clero.
Un nuovo genere letterario Il romanzo cortese-cavalleresco, scritto in lingua romanza, cioè volgare, nato per trasmettere al vasto pubblico, che ignorava il latino, le leggende antiche, divenne genere di intrattenimento per un pubblico colto con la diffusione di contenuti appassionanti e dilettevoli, come la materia di Bretagna e i suoi personaggi: Artù e la sua spada invincibile Excalibur, il mago Merlino, consigliere del re, Ginevra, sposa infedele di Artù, e poi Lancillotto, Ivano, Galvano, Tristano, Perceval, questi due ultimi, sopra tutti, incarnazioni di veri e propri miti letterari e umani.
Per gli elementi costitutivi indicati, il romanzo cortese-cavalleresco presenta analogie con il poema epico, pur sviluppando tematiche diverse e riformulando nella figura del cavaliere il modello del paladino e dell’eroe cristiano proposto nei poemi epici.
Contrariamente alle canzoni di gesta, il romanzo cortese-cavalleresco è destinato non alla recitazione, ma alla lettura, sia pubblica (nell’ambito della corte, davanti a un pubblico di dame e cavalieri), sia privata, individuale (in un romanzo di Chrétien de Troyes, Ivano, c’è una fanciulla che legge un libro ai suoi genitori: la scena rivela come la lettura fosse una pratica ormai diffusa, anche fra le donne, a sottolinearne il ruolo sociale e culturale). La diffusione e la fama di queste narrazioni si colgono anche nella ricca iconografia cortese: soprattutto miniature nei codici manoscritti, spesso di grande pregio e valore, fatte oggetto di doni fra i nobili e di scambi fra le diverse corti; affreschi e tavole dipinte che decoravano castelli e residenze nobiliari, con momenti della vita di corte o scene tratte dai romanzi.
L’eroe del romanzo cavalleresco Dal punto di vista contenutistico, come le canzoni di gesta e gli antichi poemi epici, così anche il romanzo ha il suo eroe, un protagonista che incarna doti straordinarie ed esemplari: il cavaliere. Egli, come l’eroe del poema epico, è un uomo coraggioso, bello, forte, generoso, pronto al sacrificio e, soprattutto, avventuroso. Alcune caratteristiche del cavaliere lo collegano ai modelli dell’epos classico, al gusto dell’avventura di Odisseo, ai suoi viaggi, e al ciclo dei nostoi, ritorni: anche nel romanzo cortese alcuni personaggi, come Tristano, Lancillotto, Perceval, conoscono l’esperienza del viaggio, che comporta l’abbandono di un luogo noto e sereno, il superamento di prove e, infine, il ritorno al luogo di partenza. Ciò che differenzia i personaggi medievali, ad esempio, dall’eroe greco per eccellenza, Odisseo, è lo scopo del viaggio e, in un certo senso, il contesto in cui esso è inserito: mentre per Odisseo il viaggio è finalizzato al ritorno e alla salvezza, per questi cavalieri viaggiare significa cercare le avventure, affrontare le prove che mettano in luce il loro valore, le loro qualità e ne esaltino la virtù cavalleresca. In un cammino di perfezionamento etico, l’avventura, l’aventure, la prova di capacità, si collega alla queste, la ricerca di cose e persone, mete e tappe significative in una prospettiva che abbraccia la vita dell’eroe nella sua interezza e che le dà un senso.
L’eroe antico combatte sia per dimostrare il suo coraggio in ossequio con il suo codice di comportamento, sia per corrispondere alle aspettative della società, cioè, in ultima analisi, per difendere la sua città. Nel cavaliere medievale queste prospettive sono in un certo senso “complicate”: ad esempio, Tristano supera prove e ostacoli – il duello con un drago e con un nemico crudele e possen-
29 1 • Il mito
te – non solo per difendere la sua patria, la Cornovaglia minacciata, ma anche perché questo è il suo compito di cavaliere, la sua dimensione. E le sue azioni, le sue gesta individuali sono mosse dall’amore per Isotta, con cui sarà legato da una infelice passione, che finirà tragicamente.
L’amore infelice del cavaliere Anche quest’ultimo è un tratto specifico del romanzo cortese: l’amore infelice per una fanciulla di cui il cavaliere è servo, ma che spesso egli non può legittimamente possedere e che adora nel suo cuore con segreta sofferenza. In questo senso il romanzo cortese fonde due componenti letterarie: la canzone di gesta, erede dell’epica antica, che fa del cavaliere un eroe bello e coraggioso, e la poesia provenzale, sviluppatasi nella Francia del Sud, il cui tema centrale era proprio la fin’amors, l’amore perfetto, spesso infelice e impossibile, in genere fuori del vincolo coniugale. Nei romanzi cortesi-cavallereschi le imprese ruotano attorno all’amore e all’avventura e sono spesso ambientate in luoghi leggendari e favolosi, nei quali si possono incontrare esseri meravigliosi, maghi e mostri; i cavalieri sono coinvolti in avventure che li portano in luoghi fantastici, lontani dalla corte, devono affrontare ostacoli e prove che mettono in luce le loro virtù, indipendentemente da motivazioni o finalità religiose, anche se i valori cristiani sono sempre in evidenza.
1.5 La storia di Perceval
Chrétien de Troyes La storia di Perceval, o Parzival (leggi “Parsifal”), è narrata per la prima volta da Chrétien de Troyes, nella sua ultima opera, incompiuta, databile dopo il 1185, dedicata a Filippo d’Alsazia, conte di Fiandra, che, in procinto di partire per la terza crociata, gli aveva richiesto un’opera che trattasse la vicenda del Graal. Nell’immaginario religioso medievale, il Graal era la coppa usata da Cristo nell’ultima Cena e poi servita a Giuseppe di Arimatea per raccogliere il sangue di Cristo crocefisso.
Il Graal divenne una reliquia religiosa e un simbolo di rigenerazione dagli straordinari poteri, che avrebbe potuto essere ritrovato solo da un gentiluomo ardimentoso e soprattutto puro di cuore; così, alla sua ricerca si muovono tutti i migliori cavalieri.
Chrétien parte da uno spunto e da un’ispirazione religiosa, affidata al titolo del romanzo – Perceval il Gallese o Il racconto del Graal – ma poi se ne distacca; il motivo religioso non è mai centrale nella narrazione e il nucleo sostanziale dell’opera è piuttosto la formazione del cavaliere, attraverso tre tappe: l’iniziazione alla cavalleria, all’amore e infine alla religione. Chrétien piuttosto sviluppa il motivo della queste, collegato come sempre al tema dell’avventura, ma con un’accentuazione della ricerca del significato dell’esistenza e del mondo. L’aspetto più significativo dell’opera di Chrétien è quello della formazione del cavaliere – formazione guerresca, sentimentale, spirituale secondo una prospettiva più complessa, insieme al ruolo che l’educazione può giocare su un giovane grezzo e incolto, che, all’inizio ignaro del mondo e delle sue regole, impara a cono scerlo e al quale, nel momento in cui sceglie di entrare nella cavalleria,

Strumenti 30
Il sacro calice dell’Eucaristia in un affresco bergamasco.
si schiude il cammino della maturazione e della perfezione. Attraverso la vicenda di Perceval si delinea l’ideale cortesia che ispira le azioni del buon cavaliere: la nerosità verso le fanciulle e gli inermi, che il cava liere deve soccorrere nel bisogno e difendere dai soprusi, la lealtà nel duello che comporta anche la pietà verso l’avversario sconfitto, la difesa del sovrano e della sua terra. La novità del Perceval rispetto alla tipologia del cavaliere medievale, e soprattutto dell’immagine ideale che ne viene tratteggiata nel romanzo cortese-cavalleresco, è il senso di una scoperta progressiva del mondo e la consapevolezza del cammino spirituale da percorrere. Quello che conta, nel profilo “eroico” del cavaliere medievale, è l’educazione, superiore a ogni privilegio di nascita, a ogni dato di natura.
La trama La trama è piuttosto complessa, ricca di visioni e immagini, di strani incontri e di rappresen tazioni simboliche. Una nobile vedova, che ha perduto il marito e due figli in un combattimento cavalleresco, cresce in solitudine nella foresta, isolato dal mondo circostante, il suo ultimogenito, Perceval; un giorno però il fanciullo incontra casualmente alcuni cavalieri di re Artù; affascinato li segue, e decide di entrare anch’egli nella cavalleria. La madre non può opporsi alla sua scelta, ma muore di dolore alla partenza del figlio, che si allontana da lei, ignaro della sventura che lo ha appena colpito. Procuratosi con un combattimento le armi di un cavaliere sconfitto, il Cavaliere Vermiglio, Perceval, grazie alle cure del vecchio Gorneman, diviene un perfetto cavaliere. Compiuta l’educazione militare, comincia quella sentimentale: innamorandosi di Biancofiore, la bella fanciulla che soccorre per sottrarla a un matrimonio forzato, Perceval corre di avventura in avventura, fino a quando giunge al meraviglioso castello del Re Pescatore, che giace paralizzato per una ferita riportata in combattimento. Lì assiste a una processione misteriosa, in cui appare il sacro Graal; ma il giovane cavaliere non osa chiedere il significato della visione che lo rivela. Quando, il giorno successivo, lascia il castello, non percepisce più alcun segno di vita provenire da esso. In seguito, da una damigella e da un eremita verrà a sapere che non ha avuto il coraggio di chiedere la spiegazione desiderata perché impedito dalla responsabilità della morte della madre e che, se avesse formulato la richiesta, avrebbe guarito il re ferito; inoltre apprende che la misteriosa persona alla quale veniva portato il Graal, il padre del Re Pescatore, viveva da quindici anni solo di un mistico cibo contenuto nella reliquia. L’episodio rappresenta l’avvio dell’iniziazione religiosa di Perceval. Un evento cruciale, sotto questo aspetto, è la rivelazione della verità della fede di Cristo, nel giorno del Venerdì santo, da parte dell’eremita e la confessione dei peccati; quindi, la narrazione della ricerca di Perceval si intreccia con la storia delle avventure di Galvano, un perfetto cavaliere. E qui l’opera si interrompe.

31 1 • Il mito
Chrétien de Troyes, Perceval L’incontro con la damigella della tenda
Nell’episodio intitolato L’incontro con la damigella della tenda, Perceval ritrova la fanciulla che aveva visto un giorno in una tenda e che ingenuamente aveva baciato, credendo di osservare così un insegnamento cavalleresco, che la madre gli aveva impartito ed egli aveva travisato. La fanciulla, dopo aver confessato al suo cavaliere protettore di essere stata baciata, è da lui maltrattata e continuamente offesa, perché egli non crede alla sua onestà e alla buona fede del cavaliere. Perceval ne conferma l’innocenza e punisce l’uomo insensibile, rozzo e violento.
Sopra vi andava una fanciulla1, la più miserabile del mondo. La si sarebbe detta molto bella, ma le vesti erano povere, e l’abito non aveva più d’un palmo di stoffa buona. Il resto era mal ricucito con grossi punti, e dappertutto tenuto con nodi che lasciavano tuttavia vedere i seni. La carne era ferita come da colpi di lancetta, bruciata, screpolata da caldo, grandine e gelo. Senza velo, i capelli spettinati, offriva agli occhi un viso devastato da tristi tracce di lacrime, che senza interruzione vi avevano scavato solchi fino al seno e sopra la veste erano scese fino alle ginocchia. Certo il cuore doveva soffrire se il corpo mostrava una tale disgrazia!
Appena Perceval la scorge, accorre lesto presso di lei. Ma vedendolo venire, ella si copre con i propri stracci. Se nasconde uno strappo, subito ne scopre cento altri! Perceval raggiunge la damigella così pallida e disfatta, per ascoltarla piangere la sua sventura: «Ah, Dio, che non ti piaccia lasciarmi in questo stato! È troppo tempo che trascino una vita tanto triste che non ho affatto meritata! Dio, te ne prego, manda presso di me qualcuno che mi tragga fuori da questa pena o mi liberi da colui che mi fa vivere così grand’onta! In lui non v’è alcuna pietà. Rifiuta anche di uccidermi, quando non posso sfuggirgli viva! Perché vorrebbe la compagnia di una miserabile, se non per il piacere della mia miseria e della mia onta? Se invero l’avessi ingannato e s’egli lo sapesse per certo, dovrebbe non di meno perdonarmi, che cara me l’ha fatta pagare. Ma come potrebbe amarmi, se mi fa condurre aspra vita senza che mai se ne commuova!»
«Amica, che Dio vi salvi!» dice Perceval che l’ha raggiunta.
Ed ella china il capo e dice a voce bassa:

«Signore che mi hai salutata, che il tuo cuore abbia quel che desidera. Ma l’augurartelo non è giusto.»
Perceval, che per vergogna muta colore, risponde: «In nome di Dio, damigella, perché? Non credo di avervi mai vista né fatto alcun torto.»
«Sì» risponde la fanciulla «ho tanta sofferenza e miseria che nessuno mi deve salutare. Che mi si guardi o che mi si fermi, la più grande angoscia mi prende.»
«Se mai v’ho fatto danno» dice Perceval «fu invero senza saperlo! Non voglio tormentarvi. Il mio cammino m’ha guidato da voi e da che vi ho vista sì desolata, sì povera e nuda, mai conoscerò gioia alcuna se non posso apprendere quale ventura vi ha condotta a tal pena e dolore.»
«Ah, signore, abbiate pietà! Tacete! Andate per la vostra strada e lasciatemi. Il peccato vi trattiene qui. Fuggite, fuggite, ché farete bene.» «Perché fuggire? Per quale paura? Da che parte verrebbe? Chi mi minaccia?»
«Ve lo dico, ché c’è ancora tempo. Fuggite! Senza oltre tardare sopraggiungerà l’Orgoglioso della Landa2, che non cerca che scontri e battaglie. Se qui vi vede, vi ucciderà sull’istante. Se mi si ferma o mi si parla, ne prova tal dispetto che nessuno può salvarsi la testa, se colto sul fatto.Vi dirò che ora non è molto3
Strumenti 32
T9
1. Sopra… fanciulla: la giovane appare sopra un “ben povero palafreno”, stremato dalla fame.
2. l’Orgoglioso della Landa: è un uomo arrogante e violento, che sospetta della lealtà della fanciulla e la tiene legata a sé sottoponendola a ingiurie e offese; costituisce l’opposto di Perceval e di ogni nobile e onesto cavaliere.
5 10 15 20 25 30 35 40
3. ora non è molto: poco tempo fa.
LETTURA ESPRESSIVA
4. padiglione: sontuosa tenda da campo, in genere destinata a personaggi di rango.
5. Per ventura: per caso.
6. un giovane Gallese: lo stesso Perceval.
7. mercede: ricompensa.
8. Re Pescatore: colui che lo aveva accolto nel castello ove Perceval aveva assistito alla misteriosa processione del Graal.
9. Cavaliere Vermiglio: si tratta del cavaliere ribelle ad Artù che Perceval incontra davanti alla reggia e che uccide in duello, per poi impadronirsi appunto delle sue armi.
un uomo fu messo a morte in tal modo. Ma egli non vuole uccidere senza prima narrare perché mi punisce d’un trattamento sì indegno e crudele.»
I due stanno ancora parlando quando, uscendo dal bosco, tra polvere e sabbia appare l’Orgoglioso della Landa che come folgore su di loro si scaglia minacciandoli: «Sventura a te che t’arrestasti presso la damigella! Ché se l’hai trattenuta, foss’anche per la lunghezza d’un passo, tanto basta perché tu muoia! Ma sappi che non t’ucciderò se non dopo averti narrato per qual cagione le imposi onta sì vile: un giorno ero andato nel bosco, lasciando in un padiglione4 costei che amavo più d’ogni cosa al mondo. Per ventura5, uscendo dal bosco, là capitò un giovane Gallese6; per qual cammino vi giunse io non lo so, ma quel che so per certo è che un bacio il ragazzo le prese di viva forza. Ella me lo confessò. Forse mi mentì. Non dico di no. L’altro ne trasse vantaggio: chi dunque glielo avrebbe impedito? E se egli la baciò suo malgrado, non prese dopo tutto il proprio piacere? Chi dunque potrebbe giurare che dopo quel bacio non vi sia stato altro? Chi lo crederebbe? Una cosa viene dopo l’altra. L’uomo che bacia una donna e non ne trae vantaggio quando sono soli, è perché non lo vuole. Ma la donna che concede la propria bocca, facilmente accorda di più, se l’uomo lo vuole davvero! Anche se la donna si difende, si sa ch’essa può vincerla in tutto tranne che in questa tenzone in cui prende l’uomo per la gola e lo graffia, lo morde, l’uccide augurandosi di soccombere. Ha tanta paura di darsi e vuole che la si prenda di forza, che non ne abbia riconoscenza. Ho ragione di credere ch’egli l’abbia presa. E di più, le ha rubato l’anello che le avevo dato e che portava al dito. Questo m’ha offeso. Aggiungo che dopo egli ha osato bere un vino forte e ha gustato buoni pasticci ch’erano stati conservati per me. La mia amica ne ha la sua mercede7, bella mercede come puoi vedere! Chi commette follia, ne abbia dolore! Mai più la commetterà. Quando conobbi la verità, ognuno poté vedere la mia collera sapendo che ne avevo il diritto. Le dissi che il suo palafreno non avrebbe mangiato avena, non sarebbe stato né ferrato né salassato; ch’ella più non avrebbe indossato nuovo mantello o tunica nuova finché non avessi ucciso colui che l’aveva violata e gli avessi poi mozzata la testa.»
Perceval l’ascolta. Risponde parola per parola:
«Amico, tenete per certo ch’ella ha scontato la sua penitenza. Sono io colui che le prese il bacio, e fu di forza. Sono io che rubai l’anello. Non feci altro, ma mangiai un pasticcio intero e un altro mezzo, e bevvi vino a sazietà, ma questo non fu sì sciocco.»
L’Orgoglioso della Landa dice:
«In fede mia, fa davvero meraviglia sentirti confessare tal cosa! Tu stesso convieni dunque d’avere meritato la morte!»
Ma Perceval lesto risponde:
«La morte non mi è vicina come credi.»
Senz’altra parola si avventano l’uno sull’altro. E tanto furiosamente si urtano che le lance volano in frantumi e tutti e due lasciano libero l’arcione. Caduti, subito si levano e si battono a colpi di spada. Perceval dapprima lo colpisce con la spada che gli era stata donata, ché voleva provarla. Sull’elmo d’acciaio assesta un fendente sì forte che in due pezzi spezza la buona spada del Re Pescatore8 . L’Orgoglioso non ha paura. Lo ripaga con un colpo sì grande da cancellare dall’elmo i fiori smaltati e le pietre incastonate. Perceval ha il cuore triste per la lama che l’ha tradito, ma subito sfodera quella che fu del Cavaliere Vermiglio9 . Raccoglie e mette nel fodero i pezzi dell’altra. Di nuovo si slanciano l’uno
33 1 • Il mito
45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
contro l’altro. Cominciano un’aspra battaglia che mai se ne vide di più crudele. Perché descriverla? È inutile pena.
Tanto combattono che l’Orgoglioso della Landa ha la peggio e invoca pietà. Il giovane cavaliere non dimentica quanto gli ordinò il valvassore10: mai uccidere uomo alla nostra mercé11 .
Allora dice:
«Cavaliere, in fede mia non ti farò grazia finché, davanti a me, tu non l’avrai concessa alla tua amica. Ella non ha meritato, te lo giuro, di essere trattata come tu hai fatto.»
L’Orgoglioso amava la fanciulla più della pupilla dei propri occhi. Risponde:
«Bel signore, mi trovate ben pronto a riparare. Sarà come voi volete. Ordinate e io v’obbedirò! Ho il cuore cupo e dolente per averla così tormentata.»
Il vincitore dice:
«Andrai dunque alla tua dimora più vicina. Farai bagnare e riposare la tua amica finché sarà ristabilita. Quando sarà adornata, vestita d’abiti belli, la porterai da re Artù. Lo saluterai da parte mia e ti porrai alla sua mercé, equipaggiato come sarai partendo da qui. Se ti domanda chi t’invia, risponderai: “È il ragazzo che avete fatto Cavaliere Vermiglio con l’approvazione e il consiglio di messer Keu, il siniscalco”. A re Artù racconterai la penitenza che hai voluto per la tua amica e la miseria in cui ella ha vissuto. E lo riferirai a voce alta davanti alla corte, ché tutti e tutte possano intendere, la regina e le sue damigelle. [...]»
(Chrétien de Troyes, Perceval, a cura di G. Agrati e M.L. Magini, Mondadori, Milano 1983)
LABORATORIO delle competenze

COMPRENDERE
1. Perché la fanciulla consiglia a Perceval di fuggire?
a. perché teme il ritorno del padre
b. perché pensa che sia un brigante
c. perché teme l’arrivo dell’Orgoglioso della Landa
2. Per quale motivo l’Orgoglioso della Landa punisce la fanciulla?
a. perché essa ha tentato di fuggire
b. perché ha baciato un giovane
c. perché gli ha sottratto il denaro che portava con sé
3. Che cosa confessa Perceval?
a. di avere rubato l’anello della fanciulla
b. di avere baciato la fanciulla
c. di avere baciato la fanciulla e di avere rubato l’anello
4. Che cosa chiede Perceval all’Orgoglioso della Landa per salvargli la vita?
a. di onorare la fanciulla e condurla a re Artù
b. di consegnare a lui la fanciulla
c. di liberare la fanciulla
ANALIZZARE E INTERPRETARE
5. Analizza la descrizione della fanciulla e individua le caratteristiche che l’autore sottolinea per rappresentarne la sorte.
SCRIVERE
6. Riassumi le fasi del duello tra Perceval e l’Orgoglioso della Landa, individuandone con esattezza le fasi e il significato della conclusione.
Modi 34
10. Il giovane… valvassore: Perceval sa che un buon cavaliere deve avere pietà dell’avversario sconfitto, come gli ha insegnato il valvassore, cioè il suo precettore Gorneman.
95 100 105 110
11. alla nostra mercé: nelle nostre mani.
Le riletture di un mito: il sacrificio
T1 Eschilo, Agamennone, vv. 223-247
T2 Lucrezio, La natura, I, vv. 87-101
T3 Ovidio, Metamorfosi, XII, vv. 24-38
T4 Sacra Bibbia, Genesi, 22, 1-18

T1
Eschilo, Agamennone (vv. 223-247)
Il sacrificio di Ifigenia
Abbiamo visto che Esiodo narra come viene istituito il rito del sacrificio; esso inaugura la modalità di comunicazione tra gli dei e l’uomo ed entra a far parte della cultura religiosa. Un mito legato al tema del sacrificio, e quindi al rapporto fra uomo e dio e ai suoi aspetti inquietanti, è quello del sacrificio di Ifigenia, la figlia di Agamennone, che viene sacrificata ad Artemide per propiziare la partenza della flotta greca alla volta di Ilio. Si narrava infatti che Agamennone, mentre l’esercito era fermo in Aulide in attesa dei venti propizi per salpare alla volta di Troia, muovere guerra ai Troiani e riportare in patria Elena, avesse ucciso una cerva sacra alla dea Artemide e se ne fosse vantato, tanto da suscitare l’ira della dea e la conseguente vendetta: la richiesta di avere in cambio, offerta in sacrificio, la vita di sua figlia, appunto la giovane Ifigenia.

Così narra il poeta tragico Eschilo (v secolo a.C.) la vicenda del sacrificio della giovane.
223 E tanto lui osò: si fece car nefice del sacrificio di sua figlia, per sostenere quella guer ra, per rivendicare una donna, per propiziare e far partire le navi.
228 Lei pregava e il padre chiamava per nome: ma a nulla valeva, neppure la sua età di fanciulla, per quei comandanti bramosi di guer ra. E il padre disse ai ministri del sacrificio che dopo la preghiera come una capra la sollevassero sull’altare.
233 Avvolta nelle vesti con decisione la presero. Lei stava prostrata, il muso a terra: le imbavagliarono la bella bocca
35 PERCORSO TEMATICO • Le riletture di un mito: il sacrificio
PERCORSO tematico
224. carnefice: colui che esegue una condanna a morte.
Andrea Mantegna, Il sacrificio di Isacco, 1490 circa, Vienna, Kunsthistorisches Museum. LETTURA
ESPRESSIVA
239. croco: color zafferano; le vesti di Ifigenia gettate a terra sono una macchia informe.
247. peana: un canto gioioso, spesso volto a celebrare una vittoria.
per impedire che imprecasse maledizioni contro la sua casa.
238 Violenta la forza di quel mor so che la ammutoliva. Le vesti erano già una macchia tinta di croco, sparse per terra, e lei lanciava a ciascuno dei sacerdoti occhiate, come pietose frecciate, vivida e bella
243 come un quadro dipinto; e voleva dire qualcosa lei che tante volte nelle stanze del padre per i suoi banchetti aveva cantato: voce pura, intatta, che celebrava l’amato padre nel terzo brindisi con un peana
248 di buon augurio, facendogli onore con tutto il suo amore. (Eschilo, Agamennone, vv. 223-247, trad. di M. Centanni, Mondadori, Milano 2003)
GUIDA alla lettura LABORATORIO
Il contrasto tra l’amore e il dovere Nel poeta tragico, la narrazione del mito mette a fuoco un tema fondamentale: il contrasto tra l’amore paterno di Agamennone, e il suo dovere di comandante, che ha giurato di operare per il bene dell’esercito e
per la realizzazione della guerra. Nella tragedia di Eschilo, e nel mito greco tradizionale, questa scelta di Agamennone dà inizio a una serie di eventi luttuosi, dai quali emergono le contraddizioni delle scelte umane e la sofferenza che ne consegue.
COMPRENDERE
1. Per quale motivo Agamennone accetta di sacrificare Ifigenia?
a. per soddisfare la richiesta di Era
b. per favorire la partenza dell’esercito
c. per garantire la vittoria degli Achei
2. Quali sono le reazioni di Ifigenia alla sua sorte?
a. accetta la sua sorte senza timore
b. è in preda al terrore
c. riesce a fuggire
3. Perché il poeta concentra la sua attenzione nello sguardo?
a. per sottolineare la crudeltà del gesto
b. per sottolineare la consapevolezza e l’accusa di Ifigenia
c. per impietosire il pubblico
ANALIZZARE E INTERPRETARE

4. Nel passo ripor tato Ifigenia è paragonata a una capra: perché? Quali altri elementi nel testo insistono su questo paragone?
5. In seguito il poeta paragona Ifigenia a un quadro dipinto: perché, secondo te, fa ricorso a questo paragone?
SCRIVERE
6. Prova a immedesimarti in Ifigenia e a rivolgerti ad Agamennone per convincerlo a desistere dalla sua scelta, utilizzando alcuni elementi della vita della ragazza a cui il poeta allude.
Strumenti 36
delle competenze
Lucrezio, La natura (I, vv. 87-101)
L’Ifigenia di Lucrezio
In un altro periodo storico, con finalità diverse, un altro poeta, Lucrezio (I secolo a.C.), racconta la stessa vicenda di Ifigenia, in un poema didascalico, che, attraverso la forma del poema epico, aspira a divulgare a Roma una filosofia: l’epicureismo. Nel suo racconto il sacrificio della giovane Ifigenia esprime il rifiuto proprio del rituale del sacrificio, perché è inammissibile che la divinità possa volere la morte di una giovane innocente. Nel testo di Lucrezio sono sottolineati alcuni aspetti importanti, che dimostrano come gli uomini si ingannino sulla volontà degli dei.
Quando la benda che le circondava le chiome verginali le fu fatta scivolare da entrambe le guance ad eguale altezza in parti uguali, ed ella si accorse che suo padre stava triste davanti agli altari, e che presso di lui i sacerdoti cercavano di nascondere il ferro, e che alla sua vista i concittadini scoppiavano in pianto, muta per il terrore, piegandosi sulle ginocchia, cadde a terra. E alla disgraziata non poteva essere di aiuto, in una simile circostanza, il fatto che per prima avesse fatto dono al re del nome di padre. Infatti, sollevata dalle mani degli uomini e tutta tremante, fu condotta agli altari, non per poter essere accompagnata dallo splendido Imeneo, una volta compiuto il solenne rito delle cerimonie, ma perché, (lei) pura, impuramente cadesse, proprio nel tempo delle nozze, (come) triste vittima, sotto il colpo del padre, perché fosse concessa una partenza felice e fortunata alla flotta.
A così grandi mali poté spingere la religione.
GUIDA alla lettura
Il rovesciamento del significato Ifigenia è stata ingannata dal padre, che l’ha convocata presso l’esercito illudendola con la promessa delle nozze con Achille: è dunque in una condizione tanto più misera, una fanciulla priva di qualsiasi difesa, illusa sulla sua sorte, che si trova di fronte ai guerrieri achei, condotta a morte invece che alle nozze, con un gesto che anziché rappresentare un sacrificio puro è un gesto
assolutamente impuro, un vero e proprio assassinio. Il sacrificio di Ifigenia assume un significato rovesciato, la crudeltà non è degli dei ma degli uomini, perché sono questi ultimi che si ingannano sul volere divino. Quindi, in questo caso, la riscrittura del mito serve a illustrare che la superstizione è falsa, e la ragione deve condurre gli uomini a una verità diversa sugli dei.
LABORATORIO delle competenze


COMPRENDERE
1. Perché Lucrezio introduce il mito di Ifigenia?
a. per imitare Eschilo
b. per darne una versione diversa
c. per illustrare un danno della religione
2. Quale elemento viene maggiormente sottolineato?
a. la bellezza di Ifigenia
b. la presenza dell’esercito
c. l’ingiustizia del sacrificio umano
37 PERCORSO TEMATICO • Le riletture di
il
un mito:
sacrificio
T2
(Lucrezio, La natura, I, vv. 87-101, trad. di M. Belponer)
5 10
LETTURA ESPRESSIVA
Ovidio, Metamorfosi (XII, vv. 24-38)
La versione di Ovidio
Un’altra narrazione, quella del poeta latino Ovidio (i secolo a.C.-i d.C.), conferisce al mito ancora un ulteriore sviluppo. Il poeta, raccogliendo una tradizione già presente nel mondo greco, cambia l’esito della vicenda e restituisce alla dea sentimenti di umanità e di compassione: anche per lui non è possibile pensare a una divinità malvagia.
Nereo continua a sconvolgere le acque dell’Aonia e a impedire il trasporto delle armate; tanto che alcuni cominciano a credere che Nettuno voglia salvare Troia, città di cui ha costruito le mura. Non però il figlio di Testore: lui non ignora, e non lo tiene per sé, che bisogna placare l’ira della vergine Diana con sangue di una vergine. Ma quando l’interesse pubblico finisce col prevalere sui sentimenti e il re col prevalere sul padre e Ifigenia si ritrova davanti all’altare, tra gli officianti in lacrime, e sta per versare il suo casto sangue, la dea cede, nasconde la scena con una nuvola, e nel momento culminante del rito, in mezzo alla calca, tra il vociare di gente che prega, sostituisce la fanciulla di Micene, si racconta, con una cerva. Così, quando Diana si è placata con una vittima che meglio a lei si confà, quando la sua ira si è spenta e con essa anche l’ira del mare, le mille navi salpano col vento in poppa, e dopo molte peripezie attraccano sulle spiagge della Frigia.
(Ovidio, Metamorfosi, XII, vv. 24-38, trad. di P. Bernardini Marzolla, Einaudi,Torino 1994)
Sacra Bibbia, Genesi (22, 1-18)
Il sacrificio di Isacco
Il racconto del sacrificio di Isacco, nella Bibbia, come quello del sacrificio di Ifigenia, mette un padre di fronte al dolore più lacerante: la perdita di un figlio Abramo affronta la necessità di dare la dimostrazione più radicale di fedeltà di fronte a Dio.
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va’ nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò». così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull’altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Poi l’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce».
(Sacra Bibbia, Genesi, 22, 1-18)


Strumenti 38
T3
T4 5 10 5 10 15 LETTURA ESPRESSIVA LETTURA ESPRESSIVA
GUIDA alla lettura
La fedeltà estrema di Abramo Anche in questo caso, come nel racconto di Ovidio, Dio salva il figlio, e la narrazione serve soprattutto a dimostrare la fedeltà estrema di Abramo, oltre che il premio di Dio, che, grazie a questa prova, riserverà alla discendenza di Isacco un futuro felice e prospero.
Dunque il racconto si conclude con una sorta di patto fra Dio e l’uomo, che ha saputo abbandonarsi alla volontà di Dio e perciò ha ottenuto un dono inestimabile, in una prospettiva di corrispondenza che supera, per la specifica natura religiosa di questo episodio, il racconto puramente mitologico.
LABORATORIO delle competenze

COMPRENDERE
1. Che cosa hanno in comune la narrazione di Ovidio e quella biblica?
a. la salvezza della persona destinata al sacrificio
b. la finalità del sacrificio
c. la reazione dei due padri
2. Perché Agamennone accetterebbe comunque di sacrificare Ifigenia, secondo Ovidio?
a. perché teme il giudizio dei sacerdoti
b. perché teme il giudizio dei soldati
c. perché il ruolo di re prevale su quello di padre
3. Perché Dio sceglie di risparmiare Isacco?
a. perché ha pietà del bambino
b. perché ha messo alla prova la fedeltà di Abramo
c. perché la prova sarebbe ingiusta
SCRIVERE
4. Confronta le tre versioni del mito di Ifigenia e redigi un breve testo in cui illustri:
- le diverse finalità delle narrazioni
- i diversi esiti della vicenda
- le caratteristiche della ragazza comuni a tutti i racconti
Alla fine del percorso
Ogni autore, nella sua versione del sacrificio di Ifigenia, ha cambiato qualche dettaglio: il mito, dunque, si presta ad essere narrato in modi diversi, si piega a significati diversi, pur conservando il suo nucleo originario: la storia di una ragazza indifesa messa a confronto con le necessità della guerra.
La stessa vicenda si moltiplica in tante storie, che si possono intrecciare tra loro. Inoltre, il racconto del sacrificio di Ifigenia, come quello di Isacco, si inserisce in un modello archetipico*, cioè in una narrazione che rappresenta un contenuto antichissimo, risalente alle origini e nello stesso tempo un racconto tipico, che si ritrova in altri contesti e civiltà: il sacrificio del figlio costituisce un momento cruciale, uno snodo che mette l’uomo di fronte alla prova più grande.
* archetipo: da arché, origine, inizio; týpos, impronta, segno, forma.
39 PERCORSO TEMATICO • Le riletture di un mito: il sacrificio
Classici
Le voci dei grandi poeti epici, i versi e le parole, gli eroi e le imprese dei poemi immortali che rappresentano le fondamenta del sapere nelle civiltà antiche.
2.
2.1 Il primo autore epico: Omero
2.2 La questione omerica
2.3 Uno o due poeti?
2.4 Milman Parry e l’oralità
2.5 La redazione scritta dei poemi
2.6 Come inizia la guerra: l’antefatto
2.7 Il mondo omerico
2.8 Gli eroi e la civiltà della vergogna
2.9 I temi dell’Iliade
2.10 Odisseo e gli altri eroi
2.11 Le figure femminili
Percorso tematico
• Il viaggio
Percorsi tematici
• La guerra
• L’amicizia tra eroi
• Il dolore dei genitori
1. L’epopea di Gilgamesh
Omero Iliade
3.1
3.2 I personaggi dell’Odissea
3.3 L’Odissea, un poema epico?
4.1
4.2
4.3 L’Eneide
4.4 La trama
4.5 Un poema innovativo
4.6 Le novità della forma
Percorsi tematici
• L’ospitalità
• Il riconoscimento nella tragedia e nel romanzo
Percorsi tematici
• Ritratti di donne
• La morte degli eroi
3. Omero Odissea
L’Odissea
4. Virgilio Eneide
Prima di Virgilio
Virgilio e il suo tempo
L’epopea di Gilgamesh
L’incontro di due eroi L’epopea di Gilgamesh ( T3 Prologo: Gilgamesh, re di Uruk, p. 51) ha un episodio centrale nella vicenda dell’incontro tra il protagonista, Gilgamesh, ed Enkidu, un uomo forte e selvaggio che giunge a Uruk e subito si scontra con il sovrano, divenendone in seguito l’amico inseparabile. La prima grande impresa che i due eroi condividono è il viaggio nella foresta: Enkidu racconta a Gilgamesh di una grande foresta, ricca di cedri, custodita da un mostruoso guardiano, Humbaba. Gilgamesh, desideroso di impadronirsi del prezioso legname e di conquistarsi altra gloria con una grande impresa, parte con l’amico alla volta della foresta.
L’epopea di Gilgamesh

Il viaggio nella foresta
Proponiamo la parte iniziale dell’episodio, che narra il progetto e mette in luce la diversità fra Gilgamesh ed Enkidu.
Enlil1 della montagna, padre degli dèi, aveva decretato il destino di Gilgamesh. Così Gilgamesh fece un sogno ed Enkidu disse: «Questo è il significato del sogno. Il padre degli dèi ti ha dato la sovranità, questo è il tuo destino; una vita che duri in eterno non è il tuo destino. Non essere triste in cuor tuo per questo, non essere afflitto né oppresso. Egli ti ha dato il potere di legare e di sciogliere, di essere tenebra e luce dell’umanità. Ti ha dato supremazia incomparabile sul popolo, vittoria nella battaglia da cui nessun fuggiasco scampa, nelle scorrerie e negli assalti da cui non si torna indietro. Ma di questo potere non abusare, agisci con giustizia verso i tuoi servi nel palazzo, davanti a Shamash2 agisci con giustizia».
Gli occhi di Enkidu erano pieni di lacrime, sgomento era il suo cuore. Sospirava amaramente; Gilgamesh incontrò il suo sguardo e disse: «Amico mio, perché sospiri così amaramente?». Enkidu aprì la bocca e rispose: «Sono debole, le mie braccia han perduto la forza, il grido della mestizia mi attanaglia la gola, sono oppresso dall’inerzia».
Fu allora che il signore Gilgamesh rivolse i pensieri al Paese del Vivente; sulla Terra dei
la
Classici 78
Classici
1
T1
1. Enlil: dio che nell’epopea è detto «padre degli dèi», signore della Terra, del Vento e dell’Aria universale; ha dato a Humbaba il compito di difendere
foresta, perciò l’impresa degli eroi sarà una trasgressione contro di lui e ne scatenerà l’ira.
2. Shamash: è il dio Sole e rappresenta la giusti-
5 10
zia; ha inoltre il dono della profezia, come Febo Apollo nella mitologia greca; il suo nome è spesso accompagnato dall’epiteto formulare “glorioso”.
LETTURA ESPRESSIVA
Cedri3 il signore Gilgamesh meditò. Disse al suo servo Enkidu: «Non ho stabilito il mio nome imprimendolo sui mattoni4 come decretava il mio destino; andrò quindi nel paese dove si abbatte il cedro. Innalzerò il mio nome dove si scrivono i nomi degli uomini famosi, e là dove non è stato ancora scritto il nome di nessun uomo eleverò un monumento agli dèi.5
A causa del male che c’è in questa terra, andremo nella foresta e distruggeremo il male; nella foresta infatti vive Humbaba il cui nome è “Enormità”, gigante feroce». Ma Enkidu sospirò amaramente e disse: «Scorrazzando per le lande con gli animali selvatici scoprii la foresta: la sua lunghezza è di diecimila leghe in ogni direzione. Enlil ha dato a Humbaba l’incarico di difenderla, e lo ha armato di settuplici terrori; terribile è Humbaba per ogni essere fatto di carne. Quando ruggisce è come lo scroscio della tempesta, il suo alito è come il fuoco, le sue fauci sono la morte stessa. Fa la guardia ai cedri così bene che quando una giovenca selvatica si muove nella foresta lui la ode anche a sessanta leghe di distanza. Chi è l’uomo che di sua volontà camminerebbe per quel paese e ne esplorerebbe i recessi? Ti dico: chiunque vi si avvicini è sopraffatto da debolezza: non è una pari tenzone combattere con Humbaba, egli è un grande guerriero, un ariete da assedio. O Gilgamesh, il guardiano della foresta non dorme mai».
Gilgamesh rispose:6 «Chi è l’uomo che può scalare il cielo? Soltanto gli dèi vi-
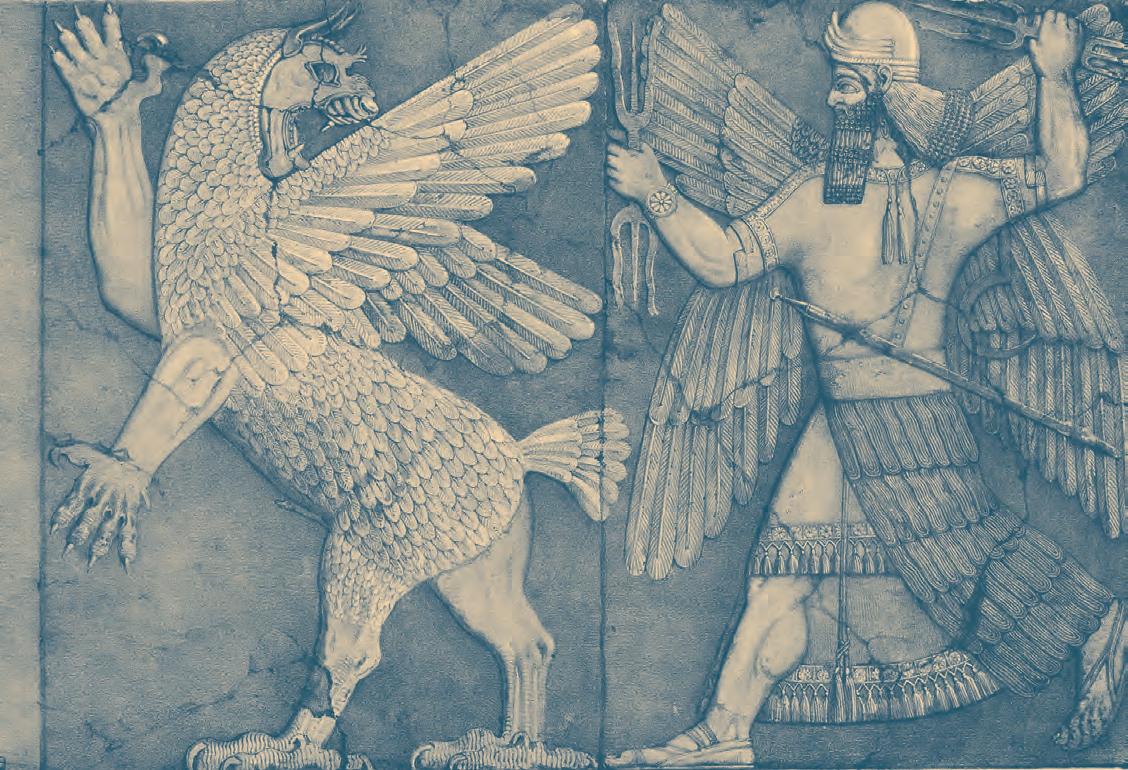
3. al Paese del Vivente; sulla Terra dei Cedri: sono denominazioni simboliche della foresta fatata, che Gilgamesh ed Enkidu si accingono ad attraversare.
4. Non ho... mattoni: allusione alla gloria, conquistata attraverso prove di abilità e di coraggio: imprimere il proprio nome sui mattoni equivale a “fissare” il riconoscimento della fama, rendendola eterna.
5. eleverò un monumento agli dèi: molteplici sono gli scopi dell’avventura: procurarsi legname per costruire templi agli dèi, liberare la foresta dal mostro, e quindi dal male, vivere un’avventura eroica in compagnia dell’amico inseparabile.
che rassicura il compagno, secondo un fortissimo legame di solidarietà e di amicizia, modello per successive coppie di eroi. La risposta di Gilgamesh allude chiaramente alla gloria, che è tanto più luminosa a fronte dell’asprezza del nemico, ritratto come un mostro terribile e favoloso.
79 • L’epopea di Gilgamesh
6. Gilgamesh rispose: di fronte a Enkidu, che è titubante e perplesso, si leva la forza di Gilgamesh, 15 20 25 30
vono per sempre con Shamash glorioso; invece noi uomini abbiamo i giorni contati, le nostre faccende sono un soffio di vento. Com’è che tu hai già paura? Benché io sia il tuo signore, andrò avanti per primo, e tu stando al sicuro potrai gridare: “Avanti, non c’è nulla da temere!”. Così, se cado, lascerò ai posteri un nome duraturo. Di me gli uomini diranno: “Gilgamesh è caduto nella lotta con Humbaba feroce”. Per molto tempo dopo la nascita del figlio nella mia casa lo diranno e si ricorderanno». Enkidu parlò ancora a Gilgamesh: «Signor mio, se tu entrerai in quel paese, va’ prima dall’eroe Shamash,7 informa il Dio Sole, perché la terra è sua. Il paese dove si taglia il cedro appartiene a Shamash».
Gilgamesh prese un capretto bianco immacolato; e assieme a esso un capretto bruno; se li strinse al petto e li portò alla presenza del sole. Prese in mano lo scettro d’argento, disse a Shamash glorioso: «In quel paese mi reco, o Shamash, mi reco; supplici sono le mie mani: fa’ dunque che ben ne incolga alla mia anima e riconducimi alla banchina di Uruk. Concedimi, ti prego, la tua protezione, e che il presagio sia buono». Shamash glorioso rispose: « Gilgamesh, tu sei forte; ma che cos’è per te il Paese del Vivente?».
«O Shamash, odimi; odimi, Shamash, che la mia voce sia udita. Qui in città l’uomo muore oppresso in cuor suo, perisce l’uomo con la disperazione nel cuore. Ho guardato sopra le mura e ho visto i cadaveri galleggiare nel fiume, e questa sorte anche a me toccherà. In verità so che è così, dal momento che il più alto degli uomini, chiunque egli sia, non può raggiungere i cieli e il più grande di essi non può abbracciare la terra. Per questo voglio entrare in quel paese: poiché non ho stabilito il mio nome imprimendolo su mattone come aveva decretato il mio destino, andrò nel paese dove si taglia il cedro. Innalzerò il mio nome dove si scrivono i nomi degli uomini famosi, e là dove non è stato scritto il nome di nessun uomo eleverò un monumento agli dèi». Scorrevano le lacrime sul suo viso, ed egli diceva: «Ahimè, lungo è il cammino che dovrò intraprendere verso la Terra di Humbaba. Se questa impresa non è da compiersi, perché, o Shamash, mi hai mosso con il desiderio irrequieto di realizzarla? Come posso riuscire se tu non mi aiuti? Se morirò in quel paese morirò senza rancore; ma se farò ritorno offrirò a Shamash un’offerta gloriosa di doni e di lode».
Così, Shamash accettò il sacrificio delle sue lacrime8; come l’uomo compassionevole gli mostrò pietà. Per Gilgamesh designò forti alleati, figli di una sola madre, e li appostò nelle caverne montane. I grandi venti designò, il vento del Nord, il turbine, la tempesta e il vento gelato, la bufera e il vento ardente. Come vipere, draghi, fuoco ardente, come un serpente che raggela il cuore, come una piena distruggitrice e la forca del fulmine: tali essi erano e Gilgamesh se ne rallegrava.
Andò alla forgia e disse: «Darò ordini agli armieri; essi forgeranno le nostre armi davanti ai nostri occhi». Diedero dunque ordini agli armieri e gli artefici si sedettero a consiglio. Si recarono nei boschi della pianura e tagliarono salice e bosso; per essi forgiarono scuri di nove ventine di libbre ciascuna; e grandi spade forgiarono con lame di sei ventine di libbre ciascuna, pomi ed else di trenta libbre. Per Gilgamesh forgiarono la scure «Possanza d’eroi» e l’arco di Ansan; e Gilgamesh era armato e anche Enkidu, e il peso delle armi che portavano era di trenta ventine di libbre.
(L’epopea di Gilgamesh, a cura di N. K. Sandars, Adelphi, Milano 1986)
7. va’ prima dall’eroe Shamash: l’impresa umana smisurata non può compiersi senza l’aiuto del dio Sole, che viene invocato ritualmente; tuttavia, lo scrupolo verso questa divinità non salverà gli eroi
dall’ira degli dèi, che coglierà Enkidu: prova di forza e trasgressione sono intimamente legate.
8. Shamash accettò il sacrificio delle sue lacrime: il dio accetta di aiutare l’eroe e schiera
insieme a lui favolosi alleati; quindi gli fa preparare delle armi straordinarie: questo motivo delle armi fatate e divine tornerà nell’Iliade (libro XVIII) e, per imitazione, nell’Eneide (libro VIII).
Classici 80
35 40 45 50 55 60 65 70 75
L’eroe lotta per liberare la foresta dal mostro, cioè dal male: le sue parole sono ispirate dal coraggio e dalla consapevolezza della missione, ma egli sa che non può compiere l’impresa senza l’aiuto degli dei: perciò l’eroe forte è anche pio, e ottiene per questo gli strumenti favolosi, i venti, che si fanno suoi alleati, e le armi invincibili, che gli consentono la vittoria. Ma da solo non potrebbe sopraffare il male: l’amico Enkidu, che vince la paura grazie all’incoraggiamento di Gilgamesh, è il compagno dell’avventura e della gloria.
GUIDA alla lettura
Un luogo di mistero
L’episodio è ambientato in un luogo che tradizionalmente rappresenta il mistero e la paura: la foresta, luogo inospitale, nel quale ci si può perdere e si possono incontrare ostacoli insormontabili, ideale quindi per mettere alla prova l’eroe. Esso, inoltre, contiene alcuni temi importanti: innanzitutto la conquista della sovranità da parte di Gilgamesh con questa impresa, grazie alla quale il suo destino – la morte – sarà in un certo senso
ricompensato dalla regalità; poi lo scontro con Humbaba, presentato come una prova per conquistare la fama e, nello stesso tempo, liberare la foresta dal male, incarnato dal gigante, che sarà ucciso. Tale prova non può essere portata a termine senza l’invocazione della divinità che, commossa dalla religiosità dell’eroe, decide di aiutarlo; essa è narrata con toni favolosi, in cui sono messe in luce le straordinarie doti dei protagonisti.
LABORATORIO delle competenze

COMPRENDERE
1. Quali doni ha avuto Gilgamesh dal padre degli dèi?
a. l’immortalità e la sovranità
b. la sovranità, ma non l’immortalità
c. l’immortalità, ma non la sovranità
2. Per quale motivo Gilgamesh decide di recarsi nella foresta?
a. per sconfiggere Humbaba, che rappresenta il male
b. per impadronirsi del territorio
c. per conquistare la Terra dei Cedri
3. Perché Gilgamesh decide di avanzare per primo nella foresta?
a. per fare coraggio a Enkidu
b. perché è più forte di Enkidu
c. perché conosce la strada per inoltrarsi nella foresta
4. Quali forze aiutano Gilgamesh nell’impresa?
a. le armi straordinarie forgiate per lui e i venti designati da Shamash
b. i venti designati da Shamash
c. vipere, draghi e fuochi ardenti
ANALIZZARE E INTERPRETARE
5. Che cosa significa l’espressione: «Non ho stabilito il mio nome imprimendolo sui mattoni come decretava il mio destino»?
6. Perché Enkidu piange prima di affrontare l’impresa?
7. Perché anche Gilgamesh piange prima di affrontare l’impresa?
8. Individua nel passo le similitudini che definiscono il mostro Humbaba
SCRIVERE
9. Confronta i due protagonisti, Gilgamesh ed Enkidu, e metti in evidenza i diversi sentimenti che li animano e le iniziative che prendono nella preparazione dell’impresa.
81 • L’epopea di Gilgamesh
nel cuore del testo
Il viaggio

1. Andar per mare: la tempesta
T1 Omero, Odissea, V, vv. 278-453
T2 Esiodo, Le opere e i giorni, vv. 618-690
T3 Virgilio, Eneide, I, vv. 81-156 e 198-209
T4 Joseph Conrad, Tifone

2. Il viaggio nell’altro mondo
T5 Omero, Odissea, XI, vv. 1-43
T6 Omero, Odissea, XI, vv. 405-456
T7 Virgilio, Eneide, VI, vv. 298-316
T8 Virgilio, Eneide, VI, vv. 640-723 e 756-901
1.
Andar per mare: la tempesta
La tempesta è forse il pericolo più temuto dai naviganti e la rappresentazione più efficace dei rischi della navigazione: l’uomo che abbandona la terra ferma si affida ad un elemento a lui estraneo, del quale non sempre può dominare la forza: la prima efficace rappresentazione della tempesta è nell’Odissea.
Omero, Odissea (V, vv. 278-453)
T1
La tempesta e la salvezza
Quando Odisseo, dopo la lunga permanenza presso l’isola di Calipso, intraprende il viaggio di ritorno a Itaca, viene raggiunto dall’ira di Poseidone, che vuole vendicarsi dell’offesa arrecata a suo figlio, il Ciclope Polifemo, accecato dall’eroe. Il dio scatena contro Odisseo una terribile tempesta e l’eroe, giunto quasi a terra, dispera veramente di salvarsi.
Diciassette g iorni navigò, traversandolo, il mare, al diciottesimo appar vero i monti ombrosi
280 della ter ra dei Feaci, la parte a lui vicina: sembrava come uno scudo nel fosco mare.
Ed ecco, tornando dagli Etiopi, lo Scuotiterra possente
282-283. Etiopi... Solimi: secondo il mito, gli Etiopi sono gli unici esseri umani presso i quali Poseidone, qui definito con l’epiteto che ne sot-
tolinea la connessione con i terremoti e i maremoti, trascorreva alcuni periodi; i Solimi sono una popolazione dell’Asia Minore.
Classici 82
PERCORSO tematico
280. Feaci: la mitica popolazione presso cui Odisseo trova rifugio e che gli fornisce l’aiuto definitivo per il ritorno a Itaca.
LETTURA ESPRESSIVA
da lontano lo vide, dai monti dei Solimi: gli apparve mentre navigava sul mare. Di più si sdegnò nel suo cuore,
285 e scuotendo la testa parlò r ivolto al suo animo: «Che malanno! Gli dei hanno dunque deciso altr imenti di Odisseo, mentre ero presso gli Etiopi: è g ià vicino alla terra dei Feaci, dove è destino che sfugga alla massa di guai che l’incalzano
290 Ma penso di r icacciarlo a fondo nella sventura». Detto così, spinse insieme le nuvole, agitò il mare, levando con le mani il tridente: aizzò tutti i turbini d’ogni sorta di venti, con le nubi ravvolse e ter ra e mare. Dal cielo era sorta la notte.
295 Euro, Noto, Zefiro violento, Borea nato dall’etere s’avventarono insieme, voltolando gran flutto. Allora si sciolsero a Odisseo le ginocchia e il cuore, e angosciato disse al suo cuore magnanimo: «Povero me, alla fine che mi accadrà?
300 Temo che la dea m’abbia detto la verità, dicendomi che avrei colmato sul mare le mie sofferenze pr ima di giungere in patria: e ora tutto si compie. Di che nuvole Zeus riempie fino all’orlo il vasto cielo: il mare ha sconvolto, incalzano raffiche
305 di venti diversi. La ripida morte per me ora è certa. Tre e quattro volte beati i Danai che morirono nella vasta terra di Troia, arrecando gioia agli Atridi. Così fossi mor to io pure e avessi subito il destino, il g iorno che mi scagliarono in folla i Troiani

310 aste di bronzo intorno al Pelide morto. Avrei avuto onori funebri e dagli Achei la fama: ora mi tocca esser preda d’una misera morte». Mentre diceva così, l’investì un gran flutto, dall’alto, con impeto ter rificante e fece ruotare la zattera.
315 Lontano dalla zattera cadde, dalle mani lasciò andare il timone: l’albero glielo ruppe a metà un turbine di venti diversi sopraggiunto terribile, vela e antenna caddero in mare, lontano. A lungo lo tenne sommer so; non poté
320 r iemergere presto, per la furia del grande maroso: lo appesantivano i panni che gli diede la chiara Calipso. Finalmente r iemerse, dalla bocca sputò l’acre acqua salata che copiosa gli g rondava dal capo. Ma neppure così, benché affranto, dimenticò la sua barca:
325 slanciatosi tra i flutti la prese, in mezzo vi si sedette, evitando la fine e la morte. Un g rande maroso la portava con la corrente qua e là. Come quando per la pianura Borea d’autunno trascina
a Odisseo l’incombere di nuove sofferenze. 309-310. il giorno... morto: Odisseo ricorda la lotta per il cadavere di Achille, episodio non narrato nell’Iliade, che si conclude con la morte
83 PERCORSO TEMATICO • Il viaggio
295. Euro... Borea: i venti che soffiano da diverse direzioni, qui scatenati tutti insieme per creare la tempesta.
300. la dea: Calipso, la ninfa che aveva predetto
di Ettore. 318. vela e antenna: la vela e l’albero che la reggeva.
Eduard Hildebrandt, Tempesta, 1852, Varsavia, Museo Nazionale.
i cardi, ed essi si tengono stretti ammucchiati, 330 così la por tavano i venti sul mare qua e là: ora Noto gettava la barca a Borea, che la spingesse, Ora Euro l’abbandonava a Zefiro, che l’inseguisse. Lo scor se la figlia di Cadmo, Ino dalle belle caviglie, Leucotea, che era mortale un tempo, con voce umana, 335 e ora tra i gorghi del mare ha in sorte onori divini. Ebbe pietà di Odisseo, che errava soffrendo dolori: come una procellaria emerse a volo dall’acqua, si posò sulla barca e gli disse: «Infelice, perché Poseidone che scuote la terra è irato 340 così tremendamente, da darti tante disgrazie?
Eppure non può rovinarti, anche se molto lo brama. Ma tu f a’ così — non mi sembri uno sciocco: togliti questi vestiti, abbandona ai venti la zattera, e cerca d’arrivare a braccia, nuotando,
345 nella ter ra dei Feaci, dove è destino che scampi. Ecco, stendi sotto il petto questo velo immor tale: non aver timore di soffrire o morire! Ma appena toccherai con le mani la ter ra, scioglilo e gettalo subito nel mare scuro come vino,
350 molto lontano da ter ra, e tu voltati via». Detto così, la dea gli diede un suo velo, e come una procellaria si immerse subito nel mare ondoso: la coprì l’onda scura. Ma egli esitò, il paziente chiaro Odisseo,
355 e angosciato disse al suo cuore magnanimo: «Ohimè, che non mi ordisca ancora un inganno qualche immor tale, esortandomi a lasciare la zattera. Ma non darò retta, perché ho visto con i miei occhi che è lontana la ter ra in cui disse sarei scampato.
360 Ma f arò piuttosto così, mi sembra la cosa migliore: finché i legni saranno confitti nelle loro giunture, resterò ancora qui e, pur soffrendo dolori, resisterò; quando poi l’onda mi sf ascerà del tutto la barca, nuoterò, poiché non c’è un piano migliore».
365 Mentre rifletteva così nella mente e nell’animo, Poseidone che scuote la terra suscitò una grande onda dolorosa e terribile, inarcata, contro di lui, e lo spinse. Come un vento impetuoso agita un mucchio di arida pula e la spar paglia qua e là,
370 così spar pagliò i lunghi legni. Allora Odisseo montò su un tronco, come guidando un corsiero, si spogliò delle vesti che gli diede la chiara Calipso, stese subito il velo sotto il suo petto, si tuffò prono in mare, allargando le mani,
333-334. Ino dalle belle caviglie, Leucotea: secondo il mito, Ino si gettò in mare con il figlio Melicerte, per sfuggire al marito Atamante, in preda
alla follia, ed è trasformata in divinità soccorritrice dei naviganti. 337. procellaria: uccello marino, che vola sfiorando le onde.
346-347. velo immortale: il velo offerto da Ino è una sorta di talismano, un elemento folklorico, destinato ad aiutare Odisseo.
Classici 84
375 dandosi con foga a nuotare. Lo vide lo Scuotiterra possente e muovendo la testa parlò rivolto al suo animo: «Er ra dunque così per il mare, dopo i molti mali sofferti, finché ar riverai tra uomini allevati da Zeus: ma penso che neanche così dirai piccola la tua sventura».
380 Detto così, frustò i cavalli dalla bella criniera, andò ad Aigai, dove sono le sue celebri case. Ma Atena, la figlia di Zeus, pensò un’altra cosa: impedì agli altr i venti il cammino, a tutti ordinò di cessare e placarsi,
385 e suscitò l’impetuoso Borea, ruppe innanzi le onde, finché g iungesse tra i Feaci che amano i remi il divino Odisseo, evitata la morte e il destino. Due notti e due g iorni vagò sull’onda dura, e spesso il suo cuore intravide la morte.
390 Ma quando Aurora dai riccioli belli portò il terzo giorno, finalmente il vento cessò e ci fu calma di vento: allora egli scorse vicino la terra, aguzzando la vista, sollevato da una grande onda. Come quando ai figli appare preziosa la vita
395 del padre, che giace ammalato soffrendo atroci dolori, a lungo languendo — un demone cattivo l’invase — e dopo tanto agognare gli dei lo sottrassero al male, così agognate apparvero a Odisseo la terra e la selva, e nuotava bramoso di calcare coi piedi la terra.
400 Ma appena distò quanto basta per sentire chi grida, allora udì tra gli scogli il rombo del mare: la g rande onda mugghiava contro la costa or ridamente ruggendo, tutto era avvolto dalla schiuma del mare. Perché non v’erano porti per accogliere navi, né rade,
405 ma v’erano coste sporgenti e scogli e punte rocciose. E allora ad Odisseo le g inocchia e il cuore si sciolsero, e angosciato disse al suo cuore magnanimo: «Ohimè, ora che Zeus m’ha concesso di vedere la terra insperata e ho attraversato questo abisso, solcandolo, 410 da nessun lato appare un’uscita dal mare canuto. Scogli aguzzi sporgono in fuori, l’onda mugghia fragorosa d’intorno, liscia s’eleva la roccia, il mare sottocosta è profondo e non si può stare ben saldi sui piedi e sfugg ire al pericolo.
415 Che un g rosso maroso mentre esco non mi sbatta su una roccia pietrosa: vano sarebbe il mio slancio. Se nuoto ancora, più avanti, per vedere se trovo spiagge lambite di fianco e por ti di mare, temo che la tempesta mi trascini di nuovo, 420 e mi por ti tra cupi gemiti sul mare pescoso, o che un dio mi susciti contro un gran mostro dal mare, come ne nutre tanti la gloriosa Anfitrite:
85 PERCORSO TEMATICO • Il viaggio
381. Aigai: città dell’Eolide.
so g ià che lo Scuotiterra glorioso m’ha in odio». Mentre rifletteva così nella mente e nell’animo,
425 un g rande maroso lo spinse sulla costa scogliosa.
E lì si sarebbe stracciata la pelle, fracassate le ossa, se non lo avesse ispirato la dea glaucopide Atena. Di slancio affer rò con le mani la roccia, vi si resse gemendo finché la grande onda passò.
430 E così la evitò: ma rifluendo di nuovo lo agg redì e colpì, lo gettò lontano nel mare. Come quando alle ventose di un polipo strappato dal covo restano attaccate fitte pietruzze, così fu stracciata sulla roccia la pelle
435 dalle sue mani audaci: una grande onda l’avvolse. L’infelice Odisseo sarebbe allora perito, ingiustamente, se non gli avesse dato giudizio la glaucopide Atena. Riemer so dall’onda che correva verso terra mugghiando, nuotò sottocosta, guardando la terra, per trovare
440 spiagge lambite di fianco e por ti di mare. Ma quando alla foce di un fiume dalla bella cor rente g iunse nuotando, là gli parve ottimo il luogo, sgombro di scogli, v’era anche un riparo dal vento; r iconobbe l’acqua del fiume e lo pregò nel suo animo:
445 «Ascolta, signore, chiunque tu sia! Giungo a te, che sei tanto invocato, fuggendo l’ira di Poseidone dal mare. Anche per gli dei immor tali è degno di compassione chi degli uomini ar rivi ramingo, come arrivo ora io al tuo cor so e alle tue ginocchia, dopo tanto soffrire.
450 Abbi pietà, signore: mi dichiaro tuo supplice». Disse così: ed egli subito smise di scorrere, trattenne l’onda, gli fece bonaccia davanti, lo portò in salvo nella foce del fiume. Egli piegò ambedue le ginocchia e le mani robuste: perché il suo cuore era vinto dal mare.
(Omero, Odissea, trad. di G.A. Privitera, Mondadori, Milano 1991)
tà
Classici 86
445. Ascolta, signore: in preda all’incertezza, Odisseo si rivolge alla divini-
del fiume, dando voce all’antica credenza secondo la quale gli elementi
naturali sono abitati da una natura divina.
Poseidone, il dio del mare, in un’immagine digitale.
Odisseo è messo alla prova per la prima volta e subito rivela quelle che saranno le sue caratteristiche in tutto il poema: egli è l’eroe prudente, anche nel momento della disperazione riflette e s’interroga, agisce con calma ed esamina attentamente anche i suggerimenti divini. La forza della saggezza, però, non gli basterebbe: all’ostilità di Poseidone si oppongono l’aiuto di Atena, la sua dea protettrice, e quello di Ino Leucotea, personaggio quasi favoloso, che gli fornisce un amuleto. Ma Odisseo è anche un uomo pio e sa che deve chiedere pietà alla divinità minore, il dio che abita il fiume, cui rivolge la preghiera del supplice, che spesso ripeterà nel corso del poema.
GUIDA alla lettura
Un eroe prudente
La furia della tempesta che travolge Odisseo è attribuita all’ira di Poseidone e la forza da lui scatenata è personificata nei diversi venti che, soffiando da direzioni opposte, suscitano una vera e propria contesa, in balìa della quale l’eroe si sente perduto e rimpiange di non aver avuto morte gloriosa in battaglia, durante la guerra di Troia e nella lotta per il cadavere di Achille: è un tema importante, perché la morte in guerra è destinata alla celebrazione eroica, alla memoria poetica, mentre morire in mare significa perdere il proprio valore e la propria identità di guerriero.
L’episodio, tuttavia, è significativo perché vediamo più volte Odisseo parlare tra sé e interrogarsi sulla scelta da fare: egli è diffidente anche nei confronti della divinità che gli dà aiuto, Ino, e, giunto in prossimità della terraferma, riflette su come approdare: già in questo passo egli si definisce per la sua caratteristica fondamentale: la prudenza, intesa come capacità di considerare diverse alternative e valutarne gli effetti. Rispetto agli eroi tradizionali, che agiscono nell’Iliade, egli non agisce d’impulso, ma con attenta riflessione, che il poeta esprime attraverso i monologhi che rivolge a sé stesso.
LABORATORIO delle competenze

COMPRENDERE
1. Perché Poseidone scatena la tempesta contro Odisseo?
a. perché vuole vendicarsi della conquista di Troia, di cui ha costruito le mura
b. perché vuole vendicarsi dell’accecamento di suo figlio, Polifemo
c. perché vuole vendicarsi dell’uccisione di suo figlio, Polifemo
2. Che cosa si augura Odisseo, in balìa della tempesta?
a. di morire subito
b. di salvarsi sulla terraferma
c. di essere morto a Troia, in battaglia
3. Quale divinità aiuta per prima Odisseo?
a. Atena b. Ino Leucotea c. Afrodite
4. Che cosa consiglia Ino a Odisseo?
a. di abbandonare la sua imbarcazione e di utilizzare un velo magico che gli fornisce
b. di abbandonare la sua imbarcazione
c. di utilizzare un velo magico che gli fornisce
5. A chi rivolge una preghiera alla fine dell’episodio?
a. a Ino Leucotea
b. ad Atena
c. al dio del fiume cui approda
ANALIZZARE E INTERPRETARE
6. Nel passo ricorrono alcune similitudini; individuale e indica qual è l’elemento paragonato di volta in volta e a cosa è paragonato.
7. Nel passo Odisseo rivolge a se stesso dei monologhi: indica in quali circostanze e con quale contenuto.
87 PERCORSO TEMATICO • Il viaggio
nel cuore del testo
1. Pleiadi: le sette figlie di Atlante e di Pleione, generate sul Monte Cillene in Arcadia; secondo un mito, morirono di dolore per le sventure del loro padre Atlante o, con le sorelle Iadi, dopo la morte del fratello Iante, e furono mutate nell’omonima costellazione. Secondo un’altra versione, le Pleiadi incontrarono il cacciatore Orione che, innamoratosi di loro, le inseguì per cinque anni finché furono mutate in colombe e poi in stelle, insieme con l’inseguitore e il suo cane; qui l’espressione indica la stagione invernale.
2. cavicchio: tappo collocato nel fondo della nave per permettere la fuoriuscita dell’acqua che si raccoglieva nella sentina.
3. le ali: le vele della nave.

4. Perse: è il fratello di Esiodo.
5. Eolia Cuma: la famiglia di Esiodo era originaria di questa città dell’Eolia, dalla quale emigrò dopo un dissesto finanziario.
Esiodo, Le opere e i giorni (vv. 618-690)
Mettersi in mare per denaro
Nel suo poema dedicato alle attività umane, Le opere e i giorni, il poeta Esiodo contrappone la vita operosa e severa del contadino, che si accontenta di poco ma non mette a rischio la sua vita standosene sulla terraferma, a quella del marinaio, che si affida all’acqua, un elemento estraneo, per guadagnare denaro, allettato dai commerci. Il mare consente certamente di diventare ricchi, se si sfugge ai suoi pericoli, ma deve essere affrontato con saggezza.
Se ti prende il desiderio della perigliosa navigazione, bada! quando le Pleiadi1 fuggono nel tenebroso mare l’impeto del possente Orione, infuriano i soffi di tutti i venti. Non tenere allora le tue navi nel fosco oceano, ma ricordati di lavorare la terra e fa’ quel che ti ho detto. Trarrai la nave al lido ponendovi intorno pietre, le quali reggano salde al soffiare degli umidi venti, e ne toglierai il cavicchio2 affinché la pioggia mandata da Zeus non imputridisca la nave. Riponi ordinatamente in casa tutti gli attrezzi, racconcia diligentemente le ali3 della nave che solca il mare, e appendi il timone ben costruito sul focolare: e tu attendi il tempo opportuno per navigare, finché esso giunga.
Allora spingerai al mare la nave veloce, e se a casa vuoi portare del guadagno, la riempirai con debita merce; così il padre mio, che è anche il tuo, o stoltissimo Perse4, navigava sulle navi, bramoso di una vita agiata, e giunse anche qui dopo aver varcato molto mare e dopo aver lasciato l’Eolia Cuma5 su una nera nave, non per fuggire prosperità, ricchezza e agi, ma la cattiva povertà che Zeus dà agli uomini. Prese dimora presso l’Elicona, in una misera borgata, ad Ascra, trista d’inverno, penosa d’estate e non mai piacevole.
Ricordati, o Perse, che ogni cosa deve essere fatta a suo tempo, e sopra tutto il navigare. Loda la piccola nave, ma affida la merce alla grande; maggiore il carico, maggiore il guadagno che si aggiunge al guadagno, se pure i venti tratterranno i loro soffi contrari.
Qualora, poi, tu volga l’animo imprudente al commerciare per sfuggire ai debiti e alla trista fame, allora ti mostrerò le leggi del tempestoso mare, pur non essendo io esperto di navigazione o di navi. [...] Delle ben ferrate navi questo soltanto conosco, ma, anche così, io ti rivelerò la mente dell’egioco Zeus, perché le Muse m’insegnarono a cantare un canto infinito.
Cinquanta giorni dopo il solstizio, quando giunge alla fine l’ora della faticosa estate, allora è tempo per i mortali di navigare: la nave non s’infrangerà né il mare inghiottirà gli uomini, se Poseidone, scotitor della terra, ciò non premediti, o Zeus, il re degli Immortali, non ti voglia far perire: sta in loro, infatti, la decisione parimenti del bene e del male. Allora i venti spirano propizi e il mare è sereno; sicuro allora, fidando nei venti, spingi nel mare la nave veloce e poni in essa tutto quanto il carico; ma affrettati quanto più puoi a tornare a casa, non aspettare il tempo del vin nuovo, la pioggia autunnale, l’inverno che sopraggiunge e il terribile imperversare di Noto, che sconvolge i flutti accompagnando la pioggia di Zeus, abbondante in autunno, e rende periglioso il mare.
Anche la primavera è propizia agli uomini per la navigazione. Appena le foglie in cima al fico appaiono all’uomo grandi come l’impronta che lascia la cornacchia camminando, allora è praticabile il mare. Tale è la navigazione di
Classici 88
T2
5 10 15 20 25 30 35 LETTURA
ESPRESSIVA
6. assale: l’asse che unisce le ruote del carro e le bilancia.
nel cuore del testo
primavera; ma io te la sconsiglio: non piace al mio animo: è da cogliersi al volo e difficilmente sfuggirai al male.
Tuttavia, anche questo gli uomini fanno a causa della loro mente sciocca: gli averi, infatti, sono la vita dei miseri mortali, ma terribile è morire in mezzo al mare. Tutte queste cose meditale in mente proprio come io te le dico, e non affidare alle concave navi tutti i tuoi beni, bensì lascia a casa il più e imbarca il meno.Terribile è incontrare sventura nelle onde del mare; ed è terribile se, per aver imposto sul carro un carico troppo pesante, tu infrangessi l’assale6 e la mercanzia andasse in rovina. Osserva la misura: l’opportunità è la cosa migliore in ogni occasione.
(Esiodo, Le opere e i giorni, trad. di L. Magugliani, BUR, Milano 1979)
Il vero consiglio è la misura: la nave troppo carica non è diversa dal carro oberato di peso. Con qualsiasi condizione meteorologica, il buon marinaio come il buon contadino non deve essere avido, ma prudente.
GUIDA alla lettura
La prudenza di Esiodo
Esiodo non rifiuta al fratello Perse (con il quale è in contesa per una questione ereditaria) i consigli per una buona navigazione, anzi, anche questo rientra nel compito che Zeus e le Muse gli hanno affidato in quanto poeta, ma gli ricorda di continuo i rischi del mare. La stagione migliore per navigare è l’estate,
perché l’inverno e l’autunno sono rischiosi, la primavera è imprevedibile; ma anche d’estate è indispensabile l’aiuto di Poseidone, dio delle acque, elemento infido ed estraneo all’uomo. E soprattutto, l’uomo saggio non deve affidare i suoi beni al mare, che diviene l’immagine stessa dell’instabilità.
LABORATORIO delle competenze

COMPRENDERE
1. Qual è la stagione adatta alla navigazione secondo Esiodo?
a. la primavera b. l’estate c. l’autunno
2. Perché il padre di Esiodo e di Perse navigava per mare?
a. per sfuggire la povertà
b. per visitare nuove terre
c. per desiderio di arricchirsi
3. Perché il padre di Esiodo e di Perse ha abbandonato Cuma?
a. per sfuggire la povertà
b. per trovare una nuova terra da coltivare
c. per sfuggire ai creditori
4. Perché Esiodo sconsiglia di restare a lungo in mare?
a. perché il tempo muta rapidamente
b. perché la stagione propizia alla navigazione è breve
c. perché la navigazione in autunno è pericolosa
ANALIZZARE E INTERPRETARE
5. Per quale motivo Esiodo sostiene che «l’opportunità è la cosa migliore in ogni occasione»?
89 PERCORSO TEMATICO • Il viaggio
40 45
81. Pronunciò... parole: il soggetto è Eolo, re dei venti, che obbedisce prontamente alla preghiera di Giunone, con atteggiamento servile.
85-86. Euro e Noto... Africo: Euro è vento che spira da Oriente, Noto da sudest, Africo dall’Africa, cioè

Virgilio, Eneide (I, vv. 81-156 e 198-209)
Il naufragio di Enea
All’inizio del poema che narra la fuga di Enea da Troia, l’Eneide, Virgilio narra l’approdo dell’eroe troiano e dei suoi compagni a Cartagine, in seguito a una terribile tempesta, nel corso della quale egli pensa di avere perso i suoi compagni e vive emozioni e sofferenze analoghe a quelle di Odisseo, in preda alla furia del mare. Infatti, Enea, in mare da molti anni, sta navigando dalla Sicilia alle coste d’Italia, quando Giunone, ancora adirata per il giudizio di Paride, che le aveva preferito Venere, decide di disperdere le navi dei Troiani, per tenerli lontani dall’Italia, dove sa che essi giungeranno per fondare quello che è destinato a diventare un potente regno.
La dea si reca da Eolo, dio dei venti, e, promettendogli in sposa una ninfa, lo convince a scatenare una tempesta. Il dio obbedisce a Giunone: Enea e i compagni sono travolti dal fortunale ma Nettuno, dal fondo del mare, irato contro i venti e il loro re, che hanno osato turbare il mare, suo dominio, ristabilisce la pace. Enea riesce ad approdare con sette delle venti navi con cui era partito dalla Sicilia; dopo una caccia che consente un ristoro, Enea nasconde angosce e preoccupazioni per fare un discorso d’incoraggiamento ai compagni.
Pronunciò queste parole e subito, rovesciata la lancia, il cavo monte colpì, sul lato: i venti, come una schiera, dove si apre un’uscita, si precipitano e sferzano la terra col turbine. Si abbattono sul mare e tutto dal profondo
85 lo stravolgono insieme Euro e Noto, e addensa tempeste
Afr ico: possenti si rovesciano i flutti al lido. Si leva un grido di uomini e uno stridìo di sàrtie. Improvvisamente le nubi strappano il cielo e la luce agli occhi dei Teucri; cupa notte incombe sul mare.
90 Tuona il cielo e riluce di fitti lampi l’aria: tutto minaccia mor te incalzante agli uomini. Ad Enea con un br ivido si sciolgono le membra; geme e tendendo al cielo le mani queste parole pronuncia: «Tre, quattro volte felici, 95 coloro che davanti agli occhi dei padri sotto le alte mura di Troia trovarono morte! O fortissimo, della stirpe dei Danai, Tidide! Non avrei anch’io potuto morire sul campo ad Ilio, finire questa vita sotto il colpo della tua mano, dove giace il fiero Ettore vinto dall’arma dell’Eacide, dove 100 il nobile Sar pedonte, dove il Simoenta, travolti nei flutti tanti scudi ed elmi e for ti corpi di eroi trascina!»
Mentre questo gridava, un turbine sibilante di Aquilone strappa la vela di fronte e gonfia alle stelle i flutti.
da sud-ovest (equivale al nostro libeccio). La diversa provenienza dei venti sottolinea lo sfrenarsi turbinoso della tempesta.
87. sàrtie: le funi che assicurano le vele all’albero della nave e fissano l’albero stesso.
89. Teucri: appellativo dei
Troiani, derivato da Teucro, primo sovrano della Troade.
94-96. Tre... morte: Nel momento in cui rischia la morte per mare, ingloriosa e oscura, Enea, come Odisseo, rimpiange la morte eroica degli uomini cui fu concesso di cadere com-
battendo, ricoprendosi così di gloria.
97. Tidide: Diomede, figlio di Tideo, guerriero greco.
99. Eacide: attributo di Achille, che discendeva da Eaco.
100. Sarpedonte: figlio di Zeus, re dei Lici, caduto in battaglia a Troia. – Simoe-
nta: fiume che scorre intorno a Troia.
102. Aquilone: vento del nord. Il lungo passo, che riecheggia la descrizione della tempesta nell’Odissea, crea una forte tensione e dà un ampio quadro di turbamento e di sconvolgimento.
Classici 90
T3
Si spezzano i remi; la prora si rovescia e offre
LETTURA ESPRESSIVA
109 rupi nascoste: scogli di difficile identificazione e collocazione, forse fra Sicilia e Sardegna.
114. Lici: popolazione proveniente dall’Asia Minore, alleata dei Troiani, guidata dal re Sarpedonte; dopo la morte di questo, Oronte ne divenne il capo.
119. Appaiono... ondate: il verso (divenuto proverbiale nella sua solennità: Apparent rari nantes in gurgite vasto), introduce quasi una pausa, uno sguardo dall’alto, dopo la convulsa descrizione della scena del fortunale.
121-122. Ilioneo... Alete: elenca alcuni fra i più illustri e autorevoli compagni di Enea, ciascuno dei quali comanda una nave e avrà ruoli importanti nelle vicende successive.
126. Nettuno: omologo del Poseidone greco, dio del mare. Il suo intervento ha funzione riequilibratrice: il dio ristabilisce la situazione, turbata per il malvagio intervento di Eolo, e si fa garante del Fato. La descrizione, solenne e pacata, contrasta con quella della tempesta e preannuncia lo scioglimento dell’evento favorevole ai Troiani.
132. Zefiro: vento che soffia da ovest.
133-142. Tanto... venti: Nettuno allude a una severa divisione delle prerogative e delle sfere di potere (i venti presumono troppo di sé, agendo nel regno marino di Nettuno); d’altra parte, pur attribuendo a Eolo la colpa dell’accaduto,
105 il fianco alle onde: una montagna d’acqua s’avventa precipite. Questi sono in bilico sulla cresta di un flutto, a questi l’onda si spalanca sotto e r ivela la terra fra i gorghi, infuria ribollente la sabbia. Tre navi afferra Noto e le schianta su rupi nascoste,
110 (r upi, celate fra le onde, che gli Italici chiamano Are, affioranti sull’ampio dor so del mare), tre Euro dall’alto mare in secca le spinge, fra le sabbie (terribile spettacolo) le avvinghia nel bassofondo, le serra in un argine di sabbia. Una, che portava i Lici ed il fedele Oronte,
115 un flutto possente, abbattendosi dall’alto, davanti ai suoi occhi colpisce a poppa: è sbalzato via il timoniere, a capofitto precipita, ma ancora tre volte il flutto lì la rovescia travolgendola e un vortice la divora rapido. Appaiono qua e là pochi scampati, fra le ampie ondate, 120 ar mi uomini tavole e le ricchezze troiane fra i flutti. Ora la nave robusta di Ilioneo, ora quella del forte Acate, e quella che por tava Abate e quella dell’anziano Alete, tutte travolge la tempesta; tutte dalle fiancate sconnesse imbarcano l’acqua ostile e si aprono per le falle. 125 Intanto sente r iecheggiare il rombo del mare sconvolto e la tempesta sfrenata Nettuno e nel profondo r imescolarsi le acque, turbato; e guardando in alto calmo uscì il suo capo dalla cresta dell’onda. Disper sa vede su tutta la vasta distesa del mare la flotta di Enea,
130 oppressi dai flutti i Troiani e dai rovesci del cielo. Non restarono ignoti al fratello le trame dell’irata Giunone. Richiama a sé Euro e Zefiro, e queste parole pronuncia: «Tanto smisurata fiducia avete nella vostra stirpe?
Or mai, o venti, il cielo, la terra osate sconvolgere
135 senza mio ordine, e scatenare tempesta tanto possente?
Io vi...! Ma ora bisogna prima placare i flutti agitati. Dopo la colpa commessa espierete con una pena inaudita. Fugg ite, presto, questo riferite al vostro re: non a lui il dominio del mare e il fiero tridente, 140 ma a me la sor te lo diede. Egli domina le rupi immani, vostre dimore, Euro; in quella reggia si vanti Eolo e regni nel chiuso carcere dei venti».
Così dice e più svelto delle parole placa le onde rigonfie, le nubi dense volge in fuga e riporta il sole.
145 Insieme Cimotoe e Tritone con sforzo liberano le navi dalla scogliera scoscesa; egli stesso col tridente le solleva, spalanca le ampie sabbie, mitiga la forza del mare scivolando a fior d’acqua col carro leggero.
il dio non ignora gli intrighi di Giunone.
139. tridente: forcone a tre denti, è lo scettro di Nettuno, simbolo del suo potere sul mare.
143. Così dice: formula
abituale per concludere il discorso, dopo il quale si sviluppa l’azione.
145. Cimotoe e Tritone: Cimotoe è una ninfa, Tritone è un mostro marino, in parte uomo e in parte
pesce, figlio di Nettuno, abitualmente rappresentato nell’atto di suonare la tromba.
148. scivolando a fior d’acqua: in contrasto con le immagini di pesantezza
e di violenza della tempesta, l’azione del dio è liberatrice, leggera; inoltre l’immagine si confà alla consueta rappresentazione di Nettuno che scivola sul mare a bordo di un cocchio.
91 PERCORSO TEMATICO • Il viaggio
E come spesso nella massa del popolo scoppia
150 una r ivolta ed il volgo senza nome furoreggia, e g ià volano tizzoni e sassi, il furore dà le armi: allora se per caso un uomo, insigne per pietà e meriti vedono, tacciono e stanno ad ascoltare attenti; egli tiene con le sue parole gli animi e placa le intenzioni:
155 così cadde il fragore su tutto il mare, dopo che il padre, guardando la distesa, attraverso il cielo aperto guida i cavalli e volando sul celere carro allenta le briglie.
Enea e i compagni, con sette navi, stremati dalla tempesta, approdano sul lido della Libia, che li accoglie in un porto tranquillo. Lì accendono fuochi e si riposano, mentre Enea, con una rapida e fortunata battuta di caccia, procura il cibo ai compagni, che consola con queste parole:
«O compagni (da tempo inf atti conosciamo dolore) g ià sofferenze più dure patimmo, ed anche a queste un dio porrà fine.
200 L’ira di Scilla e gli scogli che dal profondo r imbombano voi avete toccato, voi le rupi dei Ciclopi avete provato: fatevi forza, lasciate il cupo terrore; for se un giorno sarà bello ricordare questi dolori. Attraverso diverse avventure, attraverso tanti pericoli
205 siamo volti al Lazio, dove i Fati mostrano sedi serene e pacifiche; là il Fato vuole che Troia risorga. Resistete e conser vatevi per la buona sorte». Queste parole pronuncia e, pur angosciato da grandi timori, simula speranza in viso, nasconde nel profondo del cuore il dolore.
(Virgilio, Eneide, I, vv. 81-156 e 198-209, trad. di M. Belponer)
149-157. E come... briglie: similitudine famosa, attinta non al mondo animale o alle attività agricole, come avviene per lo più in Omero e in Virgilio stesso, ma all’esperienza della vita civile. La corrispondenza fra la tempesta sul mare e la rivolta popolare, cui è raffrontata, e quella fra Nettuno e l’uomo politico autorevole, alludono a una scena che fa parte dell’esperienza sociale e civile di un Romano e della tradizione storica; nello stesso tempo rimanda all’ideale della concordia e
nel cuore del testo
alla propaganda augustea, che condanna le tensioni civili in nome della pace.
198 e sgg. Il primo discorso di Enea ai compagni rivela le sue contraddizioni: in quanto capo di un popolo di fuggiaschi, egli è tenuto a infondere coraggio, facendo leva sulla speranza, in quanto personaggio che soffre in prima persona, può solo celare a fatica la sua angoscia.
200-201. L’ira... toccato: Enea allude a un momento del viaggio che da Tro-
ia li ha portati fino a Cartagine, citando un luogo omerico e un episodio che avrà poi più spazio nel libro iii 201-202. le rupi dei Ciclopi avete provato: seconda allusione a una tappa del viaggio sia di Odisseo che di Enea.
205-206. dove i Fati... risorga: per la prima volta Enea rivela consapevolezza circa il suo destino.
209. nasconde... dolore: solo nell’intimo del suo cuore Enea può concedersi la sofferenza e l’angoscia.
Enea compare qui per la prima volta nella sua veste di capo. Come Odisseo, nel passo precedente, egli rivela le sue caratteristiche fondamentali: soffrire per la sorte sua e dei compagni, ma infondere loro il coraggio indispensabile ad affrontare le vicende che il destino riserverà. Anche lui, come Odisseo, deve soffrire senza perdersi d’animo, ma, a differenza dell’eroe greco, egli ha la responsabilità di un gruppo di uomini, che deve portare in salvo.
Classici 92
GUIDA alla lettura
Il modello omerico
Il passo è profondamente influenzato dal modello omerico che abbiamo appena letto: le parole di Enea, che preferirebbe essere morto in battaglia piuttosto che morire nel naufragio, riecheggiano direttamente quelle di Odisseo e sono ispirate allo stesso modello eroico. Analogamente, la tempesta è scatenata dalla divinità, rappresentata come una battaglia di venti opposti, e sedata dall’intervento pacificatore di Nettuno, qui in veste opposta a quella che assume Poseidone nell’Odissea. La figura della divinità, paragonata a quella
di un oratore saggio che placa gli istinti della folla, è attinta alla realtà sociale romana. Nel passo, tuttavia, l’aspetto più importante è l’elenco degli uomini e delle navi che vengono travolte dalle onde, a ricordarci che Enea non è solo, ma è il capo di una spedizione, in cerca di salvezza per sé, ma soprattutto per i suoi compagni: una veste che egli assume, subito dopo, nel discorso di incoraggiamento che rivolge ai naufraghi e, in un certo senso, anche a se stesso, per riuscire a trovare il coraggio per continuare la sua missione.
LABORATORIO delle competenze

COMPRENDERE
1. Quale divinità scatena la tempesta?
a. Nettuno, su istigazione di Eolo
b. Eolo, su istigazione di Nettuno
c. Eolo, su istigazione di Giunone
2. Che cosa si augura Enea nel momento del pericolo?
a. di potere scampare al naufragio
b. di essere morto a Troia, come i migliori eroi
c. di portare in salvo i compagni
3. Per quale motivo Nettuno rimprovera i venti?
a. perché hanno scatenato la tempesta, obbedendo a Eolo, che non ha il potere sul mare
b. perché hanno scatenato la tempesta, obbedendo a Giunone, che non ha il potere sul mare
c. perché hanno trasgredito l’ordine di Eolo
4. Che cosa ricorda Enea ai suoi compagni per incoraggiarli a resistere?
a. ricorda le sventure già vissute
b. ricorda la promessa che si salveranno nel Lazio
c. ricorda le sventure già vissute e la promessa che si salveranno nel Lazio
ANALIZZARE E INTERPRETARE
5. Che cosa significa l’espressione: «Improvvisamente le nubi strappano il cielo e la luce agli occhi dei Teucri»?
6. «Appaiono qua e là pochi scampati, fra le ampie ondate,/armi uomini tavole e le ricchezze troiane fra i flutti». Che funzione ha questa osservazione?
7. Analizza la similitudine ai vv. 149-157: quali elementi emergono nel paragone tra l’uomo autorevole e Nettuno?
SCRIVERE
8. Confronta il passo dell’Odissea in cui è narrata la tempesta e questo passo, mettendo in evidenza il comportamento dei due eroi, gli elementi comuni delle descrizioni e il ruolo degli dèi.
93 PERCORSO TEMATICO • Il viaggio
Joseph Conrad, Tifone
Il tifone

Joseph Conrad (1857-1924) narra nel racconto Tifone la lotta tra la nave Nan-Shan e il suo equipaggio contro un violentissimo tifone tropicale; probabilmente l’autore si basa su una vicenda che realmente visse in quanto marinaio, come in altri suoi romanzi e racconti che traggono spunto dalle sue esperienze in mare. Nel racconto, il capitano Tom MacWhirr è al comando di una nave che imbarca coolies cinesi, lavoratori sfruttati e malpagati in lavori che gli occidentali rifiutavano di svolgere, diretti verso la terra natìa. A fianco del comandante si trova il primo ufficiale Jukes, giovane ma determinato, che, nel passo che segue, vediamo in preda alle incertezze e, nello stesso tempo, pronto a reagire coraggiosamente. Nonostante il capitano sembri inizialmente poco adatto al suo ruolo, la sua determinazione e la sua calma riusciranno a portare in salvo la nave e il suo carico umano.
Da quando aveva sentito sul viso la prima ventata, la tempesta sembrava avere accumulato la forza di una valanga. Enormi spruzzi avvolgevano la Nan-Shan da prua a poppa e improvvisamente la nave aveva abbandonato il rollio regolare e aveva cominciato a impennarsi e ripiombare giù, come se fosse impazzita di paura. Jukes pensò «Non è uno scherzo». Mentre scambiava grida di spiegazioni col comandante, le tenebre calarono improvvisamente nella notte come qualcosa di palpabile alla loro vista. Era come se le velate luci del mondo fossero state spente. Dentro di sé Jukes era contento di avere accanto il comandante. Ne provava sollievo come se quell’uomo, semplicemente arrivando sul ponte di comando, avesse preso la gran parte del peso della tempesta sulle sue spalle. Questo è il prestigio, il privilegio e la responsabilità del comando. Il capitano MacWhirr invece non si poteva aspettare quel tipo di conforto da nessuno al mondo. E quella è la solitudine del comando. Con quel modo attento che ha l’uomo di mare di guardare diritto negli occhi il vento come fosse un avversario, stava cercando di capirne le intenzioni nascoste e di indovinarne la direzione e la forza. Il forte vento si sprigionava da un’immensa oscurità; sentiva sotto i piedi il malessere della sua nave e non poteva neanche distinguerne l’ombra sull’acqua. Avrebbe voluto che non fosse così; e restò immobile, sentendosi come afflitto dal senso d’impotenza di un cieco. Stare in silenzio per lui era naturale, con la luce o col buio. Accanto a lui, Jukes si fece sentire gridando allegramente nelle raffiche: «Mi sa che c’è toccato subito il peggio, signore.» La luce leggera di un fulmine si propagò d’intorno, come si fosse scaricato in una caverna, in un’oscura e segreta camera marina, col pavimento di schiuma spumeggiante. Per un attimo sinistro e palpitante svelò una sfilacciata massa di nubi sospesa in basso, l’ondeggiare del lungo profilo della nave, le figure scure degli uomini bloccate sul ponte di comando, protesi in avanti, come pietrificati nell’atto di dare una testata. Le tenebre palpitavano tutt’intorno e alla fine il peggio arrivò. Fu qualcosa di tremendo e repentino, come la rottura improvvisa di una fiala di violenza. Sembrò esplodere intorno alla nave con un impeto e una massa d’acqua impressionante, come se un’immensa diga fosse saltata sopravento. Immediatamente gli uomini si persero di vista. Questo è il potere disintegrante di un forte vento: isola uno dall’altro. Il terremoto, una frana o una valanga piombano addosso all’uomo incidentalmente, come dire, senza determinazione. Una furiosa tempesta invece lo aggredisce come fosse un nemico personale, cerca di afferrargli le membra, s’impossessa della sua mente e cerca di strappargli l’anima. Jukes fu sospinto lontano dal comandante. Immaginò di essere trascinato a grande distanza nell’aria. Tutto scomparve, per un attimo an-
Classici 94
T4 5 10 15 20 25 30 35 LETTURA ESPRESSIVA
che la capacità di pensare; ma la sua mano aveva trovato uno dei candelieri della battagliola1. La sua angoscia non trovò il minimo sollievo dalla sua propensione a dubitare che quanto stava succedendo fosse vero. Pur essendo giovane, gli era già capitato di confrontarsi col maltempo e non aveva mai dubitato che potesse esserci qualcosa di peggio; ma questo era talmente al di là della sua capacità d’immaginazione che sembrava incompatibile con la resistenza di qualsiasi nave. E forse non avrebbe creduto neanche alla possibilità di sopravvivere lui stesso, se non fosse stato così assillato dalla necessità di esercitare uno sforzo titanico per contrastare una forza che cercava di strapparlo alla sua presa. Inoltre, l’idea di non essere ancora morto gli veniva dalla sensazione di essere semi affogato, brutalmente scosso e quasi soffocato. Gli sembrava di essere rimasto per molto, molto tempo aggrappato precariamente a quel candeliere. La pioggia cadeva, lo inondava, lo sommergeva a valanga. Respirava a fatica e l’acqua che inghiottiva a volte era dolce e a volte salata. La maggior parte del tempo restò con gli occhi chiusi, come se temesse che la forza degli elementi potesse accecarlo. Quando si azzardò ad aprirli per un attimo trasse conforto dalla luce verde del fanale di dritta2 che illuminava debolmente gli scrosci di pioggia e gli spruzzi. Lo stava per l’appunto guardando quando la sua luce illuminò un’ondata che lo spense. Vide la cresta dell’onda abbattersi, sommando il proprio rumore al tremendo frastuono che si scatenava intorno, e quasi nello stesso momento il candeliere fu strappato alla sua presa. Dopo un violento colpo alla schiena si sentì trascinato in alto da un’onda. Il primo irresistibile pensiero fu che tutto il Mar della Cina si fosse rovesciato sul ponte. Poi, più ragionevolmente, pensò di essere finito fuori bordo. Ogni volta che veniva sollevato, rovesciato e scagliato in quella massa d’acqua continuava a ripetere fra sé, con la massima apprensione: «Dio mio; Dio mio; Dio mio!»
A un certo punto, in un sussulto di angoscia e di disperazione, ebbe la folle idea di provare a uscirne. E cominciò ad agitare le braccia e le gambe. Ma, appena cominciata quella lotta disperata, si accorse di essere in qualche modo entrato in contatto con un viso, una cerata e con gli stivali di qualcuno. Afferrò rabbiosamente tutte quelle cose a turno, le perse, le ritrovò, le perse di nuovo e alla fine fu lui a essere agganciato dalla presa di due forti braccia. Ricambiò l’abbraccio di quel corpo solido e massiccio. Aveva trovato il suo comandante. Rotolarono più volte, abbracciandosi sempre più stretti.Alla fine l’acqua li scaraventò giù con uno schianto brutale e, atterrati contro il fianco della timoniera, senza fiato e tutti ammaccati, rimasero a barcollare in preda al vento, aggrappandosi dove potevano. Jukes ne uscì sconvolto, come fosse sfuggito a un inaudito oltraggio al suo orgoglio. Aveva perso la fiducia in se stesso. Cominciò a lanciare grida senza senso all’uomo che poteva sentire accanto in quelle tenebre demoniache. «È lei, signore? È lei, signore?» fino a che le tempie sembravano vicine a scoppiare. E sentì in risposta una voce, come un pianto lontano, un grido irritato da grande distanza, una sola parola: «Sì.» Altre ondate che si abbatterono sul ponte di comando lo colpirono in pieno proprio sulla testa scoperta, con le mani impegnate a reggersi. La nave si muoveva in modo strano. Sbandava come fosse in totale balìa delle acque: beccheggiava come se facesse un salto nel vuoto e ogni volta sembrava cozzare contro un muro. Quando rollava si coricava tutta su un lato e poi tornava indietro con un contraccolpo così violento che a Jukes sembrava come il barcollare di un uomo colpito alla testa prima di stramazzare al suolo. La gigantesca tempesta ululava e cozzava tutt’intorno nelle tenebre, come se tutto il mondo fosse un oscuro burrone. In certi momenti il vento colpiva la nave come se fosse risucchiato attraverso un tunnel che ne con-
95 PERCORSO TEMATICO • Il viaggio
1. candelieri della battagliola: i supporti del cavo che delimita la ringhiera del ponte della nave.
40 45 50 55 60 65 70 75 80
2. fanale di dritta: la luce verde che segnala il fianco destro della nave.
3. boccaporti: le aperture nel ponte della nave, chiuse con le cappe.
4. verricelli: macchine che movimentano pesi con funi metalliche o catene.
5. piede di un albero: il punto in cui l’albero della nave è fissato al ponte.
6. castello mediano: parte rialzata del ponte.
7. vele di cappa: le vele che avrebbero consentito un’andatura sicura.
8. gerli: cavi utilizzati per serrare le vele.
9. tendalini: tende che riparano dal sole, tese sul ponte della nave.
10. battagliole: ringhiere metalliche di protezione, disposte all’orlo dei ponti scoperti delle navi, costituite da paletti mobili tra i quali è tesa una catena o una corda.
11. bozzello: carrucola.
centrava e moltiplicava la violenza e l’impatto sembrava sollevarla dall’acqua e tenerla sospesa per un attimo, percorsa da cima a fondo da un tremito. Poi la nave riprendeva di nuovo le sue giravolte come fosse caduta in un calderone bollente. Jukes cercò di riordinare le idee e valutare la situazione a mente fredda. Il mare, schiacciato sotto le raffiche di vento più forte, tornava a sollevarsi e a sommergere la prua e la poppa della Nan-Shan con ondate bianche di schiuma, che si allargavano nella notte oltre le due fiancate. E in quell’abbagliante lenzuolo, steso sotto il nero delle nuvole ed emanante un riflesso azzurrino, il capitano MacWhirr riuscì a scorgere il desolante barlume di alcuni puntini neri come l’ebano, i portelli e le cappe sprangate dei boccaporti3, le teste dei verricelli4 o il piede di un albero5. Questo è ciò che poteva vedere della sua nave. Il castello mediano6 – col ponte di comando, dove erano lui e il secondo, e la cabina della timoniera, dove un uomo teneva la barra con la paura di venire spazzato fuori bordo con tutto il resto in un unico schianto – quella struttura centrale della nave era come uno scoglio semisommerso dalla marea vicino a una scogliera; come uno scoglio lontano, con l’acqua che ribolle e scorre via vorticando –come uno scoglio nella risacca, a cui si aggrappano i naufraghi prima di cedere – ma uno scoglio che affiorava, che s’immergeva e che oscillava in continuazione, senza pausa e senza riposo, come una roccia staccatasi miracolosamente dalla costa che se ne andasse beatamente alla deriva. La Nan-Shan era saccheggiata dalla tempesta con una furia insensata e devastante: le vele di cappa7 strappate via dai gerli8, le tende con doppi lacci volate via, il ponte spazzato dai marosi, i tendalini9 ridotti a pezzi, le battagliole10 contorte e i vetri dei fanali in frantumi; due delle scialuppe erano sparite. Se n’erano andate senza essere viste o sentite, confuse nel fragore e nel polverone della tempesta. Solo più tardi – quando su un bianco cavallone che si scagliava contro la nave ebbe la visione delle due gru delle scialuppe che emergevano nere e vuote dalle tenebre, con un tirante libero e un bozzello11 cerchiato di ferro che svolazzava per l’aria – solo allora Jukes si rese conto di cos’era successo solo tre metri dietro di lui. Sporse la testa in avanti, cercando l’orecchio del comandante. Le sue labbra lo toccarono, grande, carnoso e tutto bagnato. Gridò con tono agitato: «Le scialuppe se ne stanno andando, signore.» E di nuovo sentì quella voce, sforzata e debole, ma capace di indurre tranquillità in quell’enormità di rumori discordanti, come se fosse uscita da qualche remoto angolo di pace dietro le nere distese della tempesta. Di nuovo sentì una voce umana – il fragile e indomito suono capace di portare un’infinità di pensieri, risoluzioni e progetti, che sarà capace di pronunciare parole tranquillizzanti nell’ultimo giorno, quando crolla il cielo e si compie la giustizia – sentì di nuovo quella voce che gli gridava, come da molto lontano: «Va bene.» Pensava non avesse capito. «Le scialuppe… intendo dire le scialuppe… le scialuppe, signore! Ne abbiamo perse due!» La stessa voce, ad appena un passo da lui, eppure così lontana, gridò saggiamente: «Non ci possiamo fare niente.»
Il capitano MacWhirr non aveva mai girato la testa, ma Jukes riuscì a captare altre parole nel vento.
«Cosa possiamo… aspettarci… con questo… macello… Si deve per forza… lasciare indietro qualcosa… c’è poco da fare.»
Jukes rimase attentamente in ascolto. Ma non giunse altro. Questo era quanto MacWhirr aveva da dire; e Jukes poteva immaginare più che vedere davanti a sé la larga e corta schiena del comandante. Un’oscurità impenetrabile incombeva sullo spettrale bagliore del mare.
La cupa idea che non ci fosse niente da fare s’impossessò di Jukes.
(Joseph Conrad, Il tifone, trad. di A. Politzer, Mondadori, Milanno 1949)
Classici 96
85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Il contrasto tra l’uomo e il mare
Il passo proposto descrive una drammatica situazione in mare: come nei testi antichi, esso mette in scena il confronto tra l’uomo e un elemento naturale indomabile, e mette i protagonisti, il comandante MacWhirr e il suo secondo, Jukes, di fronte alle scelte più importanti e alle riflessioni decisive. In particolare, Jukes si sente attraversato da pensieri molteplici e assume atteggiamenti non diversi da quelli di Odisseo: cerca di affrontare la situazione, ma spesso cade in balìa della
disperazione, incerto se prendere l’iniziativa o affidarsi al comandante, che, però, appare piuttosto inerte. La scena, inoltre, è dominata dalla descrizione della tempesta, che suscita riflessioni di carattere psicologico molto sottili, a partire dal comportamento che si deve assumere di fronte ad essa, percepita come un nemico, per raggiungere la massima precisione descrittiva nella rappresentazione dei fenomeni naturali, venti, fulmini, ondate, e della nave stessa, paragonata a uno scoglio staccato dalla terra, in preda alla furia dei venti.
LABORATORIO delle competenze

COMPRENDERE
1. Perché Jukes è sollevato nel vedere MacWhirr?
a. perché il comandante ha la responsabilità del comando e quindi si aspetta che trovi una soluzione alla situazione
b. perché condividerà con lui le scelte
c. perché sa che è competente e sicuro
2. Che cosa caratterizza l’atmosfera allo scoppiare del tifone?
a. i venti
b. l’oscurità solcata dai fulmini
c. le ondate ricorrenti
3. Chi trova improvvisamente Jukes sul ponte della nave?
a. il nostromo
b. il suo secondo
c. il comandante della nave
4. Quando Jukes teme che non ci sia più nulla da fare?
a. quando si accorge che si è rotto il candeliere della battagliola
b. quando vede che hanno perso le scialuppe
c. quando vede che hanno perso due scialuppe
ANALIZZARE E INTERPRETARE
5. Che significato hanno queste parole, che esprimono le riflessioni di Jukes?
«Questo è il prestigio, il privilegio e la responsabilità del comando»; «E quella è la solitudine del comando».
6. Individua nel passo la personificazione del tifone e degli elementi naturali che lo caratterizzano.
7. Individua i sentimenti e le riflessioni del giovane Jukes, sottolineando come essi risultino contrastanti tra loro.
8. Individua nel passo una lunga similitudine dedicata alla rappresentazione della nave in balìa delle onde.
SCRIVERE
9. Confronta i tre protagonisti dei passi riportati (Odisseo, Enea e Jukes), mettendo in evidenza i loro sentimenti e le loro reazioni di fronte all’impossibilità di dominare la tempesta.
97 PERCORSO TEMATICO • Il viaggio
GUIDA alla lettura
2. Il viaggio nell’altro mondo
Omero, Odissea (XI, vv. 1-43)

Odisseo nell’Ade
L’episodio è raccontato da Odisseo stesso, che, giunto alla corte dei Feaci, narra le vicende straordinarie del suo viaggio. Nel viaggio verso Itaca, egli approda alla dimora della dea Circe, presso la quale si ferma a lungo, dopo avere sventato l’incantesimo con cui essa trasformava gli uomini in porci e avere quindi salvato i suoi compagni. Ormai deciso a ripartire verso la sua patria, ascolta il consiglio della maga di recarsi nell’oltretomba, per interrogare l’indovino Tiresia, che gli rivelerà il suo destino e gli darà suggerimenti preziosi per raggiungere sano e salvo Itaca. Il viaggio verso l’aldilà si presenta come una prova inevitabile ma terribile, che Odisseo e i compagni affrontano con angoscia e timore, come dimostrano il paesaggio inquietante che viene descritto e il rito scrupoloso con cui Odisseo si accinge a varcare la soglia dell’ignoto regno dei morti.
Quando giungemmo alla nave e al mare, anzitutto traemmo la nave nel mare lucente, mettemmo nella nera nave albero e vele, prendemmo. e imbarcammo le pecore e, tristi, 5 salimmo noi pure, versando pianto copioso.

Classici 98
T5
LETTURA ESPRESSIVA
Louis Jean Desprez, La tomba di Agamennone, disegno del 1787, New York, Metropolitan Museum of Art.
Poi, dietro la nave dalla prora turchina
Circe dai riccioli belli, dea tremenda con voce umana, ci inviò il vento propizio che gonfia la vela, valente compagno. Dopo che disponemmo i singoli attrezzi dentro la nave,
10 sedemmo; la governavano il vento e il pilota. Tutto il giorno restarono tese le vele, mentre correva sul mare. Il sole calò e tutte le strade s’ombravano: ed essa g iunse ai confini dell’Oceano profondo. Lagg iù sono il popolo e la città dei Cimmerii,
15 avvolti da nebbie e da nuvole: mai il Sole splendente li guarda con i suoi raggi, né quando sale nel ciclo stellato, né quando volge dal cielo al tramonto, ma sugli infelici mor tali si stende una notte funesta.
20 Lì ar rivati, approdammo e sbarcammo le bestie: poi andammo lungo il corso d’Oceano, finché fummo al luogo indicato da Circe. Perimede ed Euriloco fermarono in quel punto le vittime. Io, tratta l’aguzza lama lungo la coscia, 25 scavai una fossa di un cubito, in un senso e nell’altro, e versai intorno un’offerta per tutti i defunti pr ima di latte e di miele, dopo di dolce vino, poi una terza di acqua: la cosparsi di bianca farina di orzo. Feci voto con fervore alle teste senza forza dei morti,
30 di immolare, giunto ad Itaca, in casa, la migliore vacca sterile e colmare di doni opulenti la pira, e d’immolare a Tiresia, a lui solo, il montone tutto nero, che nelle mie greggi spicca di più. Dopo aver supplicato le stirpi dei morti con voti 35 e preghiere, afferrai e scannai sulla fossa le bestie: fosco come nube il sangue scorreva. Dall’Erebo si accalcarono le anime dei morti defunti. Donne, giovani, vecchi provati da molto dolore, tenere spose con acerbo strazio nell’animo, 40 molti squarciati da armi di bronzo, uomini uccisi in battaglia, con le armi lorde di sangue: s’agg iravano in folla attorno alla fossa, chi di qua chi di là, con strano g ridìo: mi prese una pallida angoscia.
14. Cimmerii: antica popolazione che abitava la penisola di Crimea; in realtà da questo racconto, come di norma nell’Odissea, non è possibile collocarli in un luogo definito: sono inseriti in un orizzonte favoloso, posto verosimil-
mente a nord, e avvolto dall’oscurità e dalla nebbia, come si addice a una collocazione necessariamente indefinita.
22. Oceano: indica genericamente il mare.
23. Perimede ed Euriloco: due com-
pagni di Odisseo.
25. cubito: unità di misura, corrispondente alla distanza tra il polso e il gomito.
36. Erebo: il regno dei morti.
99 PERCORSO TEMATICO • Il viaggio
(Omero, Odissea, XI, vv. 1-43, trad. di M. Belponer)
Omero, Odissea (XI, vv. 405-456)
L’incontro con Agamennone

Dopo l’incontro struggente con la madre Anticlea ( Percorso Il dolore dei genitori, p. 201), Odisseo continua la descrizione della sua discesa nell’Ade davanti ai Feaci sempre più incantati dal suo racconto. Incontra le ombre di famose eroine e poi quelle di illustri eroi della guerra di Troia. Fra di essi l’anima dell’Atride Agamennone, sollecitata dall’eroe, rievoca l’atroce fato suo e della sua casata.
405 «Laer tiade divino, Odisseo ricco di espedienti, né Poseidone mi vinse nelle navi, scatenando ter ribile vortice di venti funesti, né a ter ra mi uccisero i nemici, ma Eg isto dopo aver tramato morte e destino
410 con la mia sposa, rovinosa, mi uccise, chiamandomi nella casa, a banchetto, come si uccide un bue alla mangiatoia. La mor te più miserabile ho avuto: e intorno mi uccidevano i compagni, senza tregua, come porci dalle bianche zanne, nella casa di un uomo r icco e potente
415 per una festa nuziale o un pranzo o un lauto banchetto. E tu, che hai visto la strage di tanti uomini uccisi nel duello o nella lotta dur issima, molto di più avresti sofferto in cuore, vedendo come intor no ai crateri e alle mense imbandite
420 noi g iacevamo nella sala, e il suolo tutto fumava di sangue. Sentii il g rido miserevole della figlia di Priamo, Cassandra, Clitennestra dai perfidi inganni la uccise, sul mio cor po: ed io levando le mani, a terra le battei, spirando per il colpo: lei, occhio di cane,
425 se ne andò e non seppe, mentre io scendevo nell’Ade, con le sue mani chiuder mi gli occhi e la bocca.
Nulla è più vergognoso e sfrenato di una donna che escogiti in cuore tali azioni,
405. Laertiade divino: Agamennone saluta con onore Odisseo, che, da parte sua, è sorpreso e addolorato di vederlo in questo luogo.
406-408. né Poseidone… nemici: Odisseo ha chiesto ad Agamennone la causa della sua morte e ha ipotizzato che abbia fatto naufragio per una tempesta o che sia stato ucciso in un combattimento per la conquista di una città. Egli pensa comunque a una morte eroica; Agamennone invece racconta la sua triste sorte: non il dio del mare lo travolse in un naufragio, né i nemici lo uccisero in una battaglia terrestre.
409. Egisto: l’esecuzione materiale del delitto è attribuita all’amante della moglie Clitennestra, che è comunque colpevole di aver tradito il marito e di averne tramato la morte.
410-411. mi uccise… banchetto: la morte di Agamennone è miserevole e vergognosa. È ucciso a tradimento, mentre pensa di celebrare il banchetto per il ritorno, e non può difendersi in alcun modo
da questa sorte antieroica. L’uccisione dell’Atride, che comporta anche la profanazione della casa nel momento rituale del banchetto, è opposta alla vendetta di Odisseo alla fine del poema. In una situazione rovesciata l’eroe prudente riuscirà a uccidere durante il banchetto i pretendenti della moglie: gli elementi di salvezza sono perciò la fedeltà di Penelope, contrapposta al tradimento di Clitennestra, e la cautela di Odisseo, contrapposta all’eccessiva fiducia di Agamennone. Su entrambi questi elementi l’Atride insiste continuamente.
411. come si uccide… mangiatoia: il paragone, analogo a quello successivo riferito ai compagni (v. 413), vuole rappresentare il degrado della morte di Agamennone e dei compagni: gli eroi di ritorno da Troia, coperti di gloria per la loro impresa, hanno incontrato la morte propria di un animale. 416-420. E tu… sangue: sottolinea l’angoscia e lo sdegno per l’offesa arrecata agli eroi con quella morte indegna: solo la morte eroica, per l’eroe
dell’Iliade, poteva garantirne un ricordo glorioso. Con tali parole Agamennone rivela il suo attaccamento agli antichi ideali.
421. figlia di Priamo: è Cassandra, che Agamennone aveva portato con sé come concubina. Nella letteratura posteriore si tramanda che essa, amata da Apollo non mantenne fede alla promessa di sposarlo e fu dal dio condannata a profetizzare il vero senza essere creduta.
427-428. Nulla è… azioni: nonostante l’assassino in Omero sia Egisto, la vera colpa è della donna che è venuta meno al patto nuziale; le parole di Agamennone sono particolarmente pregnanti perché insistono sul tema della fedeltà e preparano la presentazione che l’Atride stesso farà di Penelope. Con queste parole, peraltro, Omero esprime quei sentimenti misogini, che avranno molta fortuna nella letteratura greca, e non solo in essa.
Classici 100
T6
LETTURA ESPRESSIVA
come questa tur pe azione che essa tramò, 430 di uccidere il suo legittimo sposo. Ed io pensavo che prezioso sarebbe stato per i figli ed i servi il mio r itorno a casa: ma quella, che perfettamente conosce ogni malvagità, su di sé e sulle donne che verranno ha riversato il disonore, anche su quelle oneste”.
435 Così disse ed io gli r isposi: “Ahimè, Zeus dalla voce che lungi risuona la stirpe di Atreo ter ribilmente detestò con trame di donne, fin dall’or igine: a causa di Elena in molti siamo morti, e a te, che tornavi di lontano, Clitennestra tese un inganno”.
440 Così dissi e subito egli mi r ispose: “Dunque, anche tu, non essere sincero con la tua sposa, e non dirle tutto ciò che conosci, ma dille qualcosa, qualcosa tienilo nascosto. Ma a te, Odisseo, non verrà morte dalla tua sposa:
445 è molto sagg ia e nutre pensieri sapienti la figlia di Icar io, Penelope. Era una g iovane sposa quando noi la lasciammo, andando alla guer ra: un bimbo teneva al seno, piccolo, che certo ora è un uomo,
450 e felice: infatti il padre lo vedrà, ritornando, ed egli abbraccerà il padre, come è giusto. Mia moglie, invece, non volle che i miei occhi si colmassero della gioia di r ivedere il figlio: prima mi uccise. Ma un’altra cosa ti dico, e tu serbala in cuore:
455 di nascosto, non apertamente, approda alla patria terra, g iacché mai nelle donne bisogna aver fiducia».
(Omero, Odissea, XI, vv. 405-456, trad. di M. Belponer)
433-434. su di sé… oneste: Clitennestra ha macchiato del suo errore le donne future: è una sorta di peccato d’origine nell’opinione di Agamennone.
436-439. Ahimè... inganno:Odisseo restringe l’affermazione di Agamennone, circoscrivendo a Clitennestra e a Elena, entrambe figlie di Leda, la colpa che l’Atride getta su tutte le donne. – la stirpe di Atreo: complemento diretto retto da detestò (v. 437).
441-443. anche tu… nascosto: Agamennone dà un prezioso consiglio a Odisseo: nonostante non nutra dubbi sulla fedeltà di Penelope, come dirà in seguito, la prudenza nei confronti di una donna è sempre consigliabile.
447-448. Era una giovane… guerra: all’evocazione della saggezza di Penelope, si lega il ricordo tenero della sua giovinezza, segnata dal dolore per la partenza degli eroi che Agamennone rievoca.
452-453. Mia moglie… uccise: anche il tema del figlio ritrovato è legato al tradimento di Clitennestra: il ricordo del piccolo Telemaco (vv. 448-451) porta nuovo strazio ad Agamennone, che muore senza rivedere il figlio Oreste (che, secondo il mito, vendicherà il padre uccidendo Egisto e la madre).
455-456. di nascosto… fiducia: il consiglio, legato all’opinione della scarsa affidabilità delle donne, è comunque adeguato anche a Odisseo, che infatti, aiutato da Atena, lo seguirà.
nel cuore del testo
Mistero e paura dominano i gesti rituali di Odisseo, che si accinge a varcare una soglia terribile, mentre Agamennone è caratterizzato da sentimenti opposti, sdegno e sofferenza: è l’eroe diminuito e azzerato, sconfitto da una donna, astuta e malvagia. Un’immagine resta impressa: uomini che avevano eroicamente combattuto scannati ferocemente.
101 PERCORSO TEMATICO • Il viaggio
Il viaggio nell’aldilà
Il viaggio di Odisseo nell’aldilà è una tappa obbligata per conoscere il suo futuro, ma anche per percorrere nuovamente il suo passato, incontrando gli eroi che hanno condiviso con lui la vicenda troiana; inoltre, è una prova fondamentale che contribuisce alla sua identità di eroe e lo accomuna a numerosi altri eroi che affronteranno una prova analoga come Eracle, Orfeo, Teseo. Nei poemi antichi, il viaggio nell’aldilà costituisce uno snodo fondamentale, che consente all’eroe di procedere nel suo percorso di ritorno, nel caso di Odisseo, o nella sua missione di fondatore della nuova città, nel caso di Enea. Per entrambi questi eroi, però, il confronto con il mondo dei morti è drammatico, perché comporta la consapevolezza della propria sorte e, in un
certo senso, la prova più ardua: il passaggio dal mondo in cui si è vivi a quello in cui si incontrano le anime in una sorta di rispecchiamento del proprio destino, per tornare tra i vivi, con una diversa percezione della propria sorte. Nel passo iniziale, il momento culminante della scena è l’affollarsi delle anime, in cui Odisseo vede giovani e anziani, donne ed eroi accomunati dalla stessa pietosa condizione, e viene quasi sopraffatto dall’angoscia. Viceversa, sono il rimpianto della propria condizione di eroe e lo sdegno verso la sposa traditrice che caratterizzano il lungo monologo di Agamennone: anche in questo caso, l’incontro con un compagno ormai morto serve a Odisseo per conoscere qualcosa del suo futuro, e soprattutto per avere rassicurazioni sulla sorte della sua famiglia, cui aspira a tornare.
LABORATORIO delle competenze
COMPRENDERE
1. Che cosa caratterizza l’ingresso nell’Ade?
a. l’oscurità
b. la luce abbagliante
c. l’area deserta
2. A chi offre il sacrificio Odisseo?
a. a Tiresia
b. ai morti
c. a Tiresia e ai morti
3. Perché Odisseo è in preda all’angoscia?
a. perché si trova in un luogo oscuro
b. perché attorno a lui si affollano le anime dei morti
c. perché è solo nell’oltretomba
4. Come è morto Agamennone?
a. travolto dalla tempesta al ritorno ad Argo
b. ucciso dai servi nella reggia
c. ucciso dalla moglie Clitennestra e dal suo amante Egisto
5. Che cosa consiglia Agamennone a Odisseo?

a. di essere prudente e di non svelarsi alla sposa
b. di consigliarsi con la sposa per fare vendetta sugli usurpatori
c. di consigliarsi con il figlio per fare vendetta sugli usurpatori
ANALIZZARE E INTERPRETARE
6. Quali elementi nel testo concorrono a descrivere il paesaggio del mondo dei Cimmerii?
7. Quali anime si presentano di fronte a Odisseo?
8. Quali elementi, nel racconto di Agamennone, evocano la morte sua e dei compagni paragonandola a quella di animali?
9. Quali aspetti ricorda Agamennone di Penelope, in contrasto con Clitennestra?
Classici 102
GUIDA alla lettura
298. fiume: l’Acheronte, fiume infernale.
299. Caronte: il traghettatore delle anime, ignoto a Omero e forse ripreso dalla divinità infernale etrusca Charun.
299-301. cui fluente… stretto in un nodo: l’immagine di Caronte, tetra e adeguata allo scenario infernale, influenzerà Dante per il suo Caron dimonio, con occhi di bragia (Inf. iii, v. 83 e 109); cfr. Percorsi 11. 302. pertica: più adatta dei remi ad acque poco profonde.
303. conca: scafo.
304. ormai… vecchiaia: la sua è una vecchiaia senza età (come la gioventù degli dèi); verde vale “salda, vigorosa”.
Virgilio, Eneide (VI, vv. 298-316)
Enea, la profezia del futuro
Anche Enea, come Odisseo, si trova ad affrontare la prova cruciale, la discesa nell’Ade, per conoscere il destino suo e della sua gente, incontrando il padre Anchise. Dunque egli dirige la flotta a Cuma. Si reca al tempio di Apollo, per interrogare la Sibilla, profetessa del dio, che pronuncia i suoi vaticini in un’enorme grotta, l’antro dalle cento porte. La profetessa annuncia a Enea che i pericoli per mare sono finiti, ma altri lo attendono in terra; ordina però a Enea di non cedere ai dolori e di continuare a lottare: il primo aiuto gli verrà da una città greca. Enea chiede quindi alla Sibilla come scendere ai Campi Elisi, per incontrare il padre, che dimora tra gli spiriti beati. La Sibilla gli prescrive di cercare il ramo d’oro nascosto nel bosco che può essere spiccato solo con il favore del Fato e deve essere offerto a Proserpina per favorire la discesa nell’Ade. Inoltre ordina a Enea di seppellire un compagno che è morto nel frattempo. Si tratta di Miseno, punito con la morte da Tritone, perché aveva gareggiato con gli dèi nel suonare la tromba di guerra. Dopo i riti funebri per lo sventurato Miseno accompagnato dalla Sibilla, si avvia a scendere nel regno dei morti: la Sibilla ordina a Enea di seguirlo da solo, pronto e audace, mentre gli altri devono stare lontani.
Nel vestibolo infernale appaiono il pianto, i rimorsi, le malattie, le personificazioni dei mali dell’umanità, e poi una serie di figure mostruose, fra cui i Centauri, la Chimera, le Gorgoni e le Arpie; quindi i due si dirigono verso la palude Stigia. Presso l’Acheronte incontrano Caronte, traghettatore delle anime, che vorrebbe impedire il passaggio di Enea, ma la Sibilla lo convince mostrando il ramo d’oro e spiegando che Enea varca il limite dell’oltretomba per vedere il padre morto, mosso quindi da una grande pietà.
Custodisce vig ile le acque del fiume, orrendo traghettatore, Caronte, d’atroce squallore, cui fluente dal mento

300 cade incolta la barba bianca, fissi sono gli occhi fiammeggianti, sordido pende dalle spalle un mantello, stretto in un nodo. Con una per tica sospinge la barca e dà vento alle vele, traspor ta sulla conca grigiastra i corpi, or mai vecchio, dio dalla dura e verde vecchiaia.
305 Lì tutta una folla, sparsa lungo le rive, accorreva, donne, uomini, corpi privi di vita di nobili eroi, fanciulli e fanciulle morte prima di giungere a nozze, g iovani posti sui roghi davanti agli occhi dei genitori: come le foglie, innumerevoli, nei boschi, al primo freddo d’autunno
310 cadono lievi o gli uccelli dai gorghi profondi del mare si ammassano a ter ra, quando la fredda stagione oltre il mare li spinge a fuggire e li invita a terre solatìe.
Lì stavano, pregando di compiere per primi il cammino, tendevano le mani, avidi di toccare la riva di fronte;
315 ma il duro barcaiolo ora questi ora quelli raccoglie, gli altr i respinge lontani, via dalla spiaggia. (Virgilio, Eneide,VI, vv. 298-316, trad.di M. Belponer)
305. tutta una folla : si tratta dei morti ancora insepolti, che non possono oltrepassare il fiume prima che siano passati cento anni dalla loro scomparsa. 307-308. fanciulli e fan-
ciulle… genitori: i versi celebrano i morti giovani, di cui poche parole sintetizzano l’atroce destino di una vita spezzata immaturamente (prima di giungere a nozze), in una morte che precede quella
dei genitori, ed è perciò innaturale.
309-312. Celeberrima similitudine, per la quale Virgilio raccoglie molteplici suggerimenti, fra cui la similitudine omerica del vi dell’Iliade (cfr. vv. 148-151);
oltre a questa, è possibile rintracciare l’eco del passo dell’Odissea riportato sopra, in particolare dei vv. 38-41, su cui il poeta opera “contaminando” gli spunti e componendo un’immagine dall’esito originale.
103 PERCORSO TEMATICO • Il viaggio
T7
LETTURA ESPRESSIVA
Convinto Caronte e oltrepassato l’Acheronte, all’ingresso del regno dei morti, la Sibilla getta focacce soporifere a Cerbero, mostro a tre teste che sta a guardia della palude Stigia. L’eroe e la profetessa incontrano quindi le anime dei morti anzitempo: bambini e fanciulli, suicidi, gli eroi morti in battaglia. Mentre attorno a Enea si accalcano gli antichi compagni troiani, di fronte a lui le schiere greche fuggono o lanciano grida. Fra gli eroi vede Deifobo, figlio di Priamo, che gli narra il tradimento di Elena, che lo aveva consegnato a Menelao, nella speranza di riconciliarsi con il primo marito.
Enea osserva le grandi mura del Tartaro circondate dal Flegetonte, dove sono i malvagi, responsabili di varie colpe, fra cui la slealtà, l’avarizia, l’infedeltà. I due visitatori volgono verso il palazzo di Dite, dove le anime dei beati, poeti, musici, eroi passano il loro tempo infinito in tranquille occupazioni: chi danza, chi canta, chi fa esercizi ginnici. In una valletta Enea incontra il padre Anchise, che gli illustra la teoria della metempsicosi: le anime, vivificate dallo Spirito Universale, entrano nei corpi e li animano, per tutta la vita; dopo la morte, esse si purificano e bevono l’acqua del Lete, che dà l’oblio della vita precedente, e tornano a incarnarsi. Quindi conduce Enea su un colle e di lì gli mostra i futuri Romani illustri, celebra le future doti civili e politiche di Roma e conclude con l’esaltazione di Marcello, nipote di Augusto, morto giovanissimo. Infine accompagna il figlio e la Sibilla fino alla porta d’avorio, da dove essi escono alla spiaggia.
Enea incontra il padre
640 Qui l’eter più aereo si diffonde e veste di luce purpurea i campi, un loro sole, loro stelle conoscono. Alcuni esercitano le membra in erbose palestre, si provano in giochi e lottano nella sabbia rosseggiante; altr i intrecciano ritmiche danze e intonano canti.
645 E il sacerdote tracio con lunga veste scandisce le sette note di suoni ed ora le vibra con le dita, ora con il plettro d’avorio. Qui l’antica stir pe di Teucro, splendida discendenza, g randi eroi, nati in anni più felici,
650 Ilio, Assaraco e Dardano, fondatore di Troia. Lontano Enea ammira le ar mi e i carri vuoti degli eroi. Stanno confitte a ter ra le aste e qui e là sparsi nel campo pascolano i cavalli. L’amore che ebbero per i carri e per le ar mi da vivi, l’amore per i cavalli
655 splendenti, li segue uguale, ormai sepolti dalla terra.
640-641. Qui l’eter… stelle conoscono: i Campi Elisi, ove sono accolti gli eroi e gli uomini giusti, sono immersi in un’atmosfera rarefatta (eter più aereo: cielo più puro) e illuminati da una luce splendente, che contrasta con l’atmosfera opprimente degli altri luoghi infernali.
642-644. Alcuni... canti: le anime continuano anche dopo la morte le attività che amarono in vita, in un’atmosfera di serenità. Nell’aldilà virgiliano, le anime colpevoli sono separate da quelle innocenti, che possono godere una felicità piena e purissima.
645. il sacerdote tracio: Orfeo, figlio di Eagro e della Musa Calliope, è poeta e musico ( Percorso Il poeta, p. 69), e rappresenta, come in seguito Museo, la poesia; a lui sono associate le credenze religiose e misteriche nella trascendenza e nella progressiva elevazione spirituale dell’uomo, destinato così a un aldilà di pace. Omero non è ricordato: nonostante la sua ammirazione, Virgilio non poteva includerlo in questa celebrazione, poiché avrebbe commesso un anacronismo, dal momento che il viaggio di Enea è immaginato subito dopo la caduta di Troia.
646-647. scandisce… avorio: Orfeo è rappre-

sentato nell’atto di suonare la cetra, facendo vibrare le corde nelle sette note.
648. Teucro: re di Troia, antenato di Priamo, da cui i Troiani sono spesso detti Teucri.
649. nati in anni più felici: la visione dei grandi eroi, che vissero nel tempo in cui Troia era potente, strappa al poeta un ricordo e un rimpianto del passato felice.
650. Ilo, Assaraco e Dardano: mitici capostipiti dei Troiani.
653-655. L’amore… terra: anche dopo la morte restano negli eroi le stesse caratteristiche che ebbero in vita.
Classici 104
Virgilio,Eneide (VI, vv. 640-723 e 756-901)
T8
LETTURA ESPRESSIVA
 Maria Zioni Elefteria Morosini Maria Belponer
Maria Zioni Elefteria Morosini Maria Belponer