GUIDA DIDATTICA
PROGRAMMAZIONE
UNITÀ DI APPRENDIMENTO
NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
IMPARIAMO CON I SANTI SCHEDE FOTOCOPIABILI



PROGRAMMAZIONE
UNITÀ DI APPRENDIMENTO
NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
IMPARIAMO CON I SANTI SCHEDE FOTOCOPIABILI


G razie alle espansioni digitali dei libri si potrà accedere a numerosi contenuti e st rumenti aggiuntivi, da utilizzare in classe oppure a casa , in mod o semplic e e autonomo.
Attivare e scaricare il libro digitale, collegandosi alla pagina www.gruppoeli.it/libridigitali e seguendo le istruzioni.
Il codice da inserire, quando richiesto, è:
Il libro digitale, sfogliabile e interattivo, presenta: espensioni con approfondimenti ; audio per l’ascolto; video e animazioni; giochi interattivi e didattici; libro liquido: versione accessibile ad alta leggibilità che consente di modificare il tipo di carattere e la sua dimensione, l’interlinea e il colore dello sfondo della pagina e attivare il sintetizzatore vocale.
Il libro digitale è utilizzabile sia o nline sia offline ed è disponibile per PC, Mac, Tablet, LIM e Monitor interattivi.
Inquadrare i QR code presenti nelle pagine del volume, che condurranno direttamente ai contenuti a udio e video di ogni u nità.
L’insegnante può accedere, inoltre, alle risorse online contenute nella sezione # altuofianco, all’indirizzo www.gruppoeli.it/altuofianco, e utilizzarle nel modo che riterrà più opportuno.
Per ricevere as sistenza, è possibile collegarsi all’indirizzo www.gruppoeli.it/assistenza/ e scegliere tra le opzioni proposte.
Seguic i anch e su
Gratis 52 numeri in versione digitale a scelta tra: Accesso gratis a:Corsi gratuiti: ELICERT-983219

oppure



«La scuola continua a essere il luogo in cui le persone possono essere riconosciute in quanto tali, possono sentirsi accolte e incoraggiate. Nonostante non si dovrà dimenticare l’importante dimensione di efficienza ed efficacia nella trasmissione delle conoscenze che permetteranno ai nostri giovani di trovare il proprio posto nella società, è fondamentale che siamo, prima di tutto, “maestri d’umanità”.
E questo può essere un contributo importantissimo offerto dall’educazione cattolica a una società che a tratti sembra avere rinunciato agli elementi che ne facevano una comunità: la solidarietà, il senso di giustizia, il rispetto per l’altro, in particolare per il più debole o più piccolo».
Papa Francesco in Disciplina e passione. Le sfide di oggi per chi deve educare
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
L’insegnamento della Religione cattolica è una disciplina curricolare che entra a pieno titolo nel piano dell’offerta formativa della scuola e che favorisce la crescita integrale degli alunni nella loro dimensione umana e spirituale. L’IRC si qualifica come laico, aperto a tutti i valori umani, come è citato nel testo dell’ACCORDO DI REVISIONE CONCORDATARIA:
«La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado». Questo insegnamento è impartito «nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola».
DPR 751/85 integr. dal DPR 202/90 all’art. 1.1
L’insegnamento della Religione cattolica si realizza inoltre in un rapporto di continuità con l’AZIONE EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE, di cui rispetta le scelte e gli orientamenti. Esso si svolge infine secondo criteri di continuità con l’IRC della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di I grado, in modo da stabilire negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri metodologici una progressione che corrisponda ai processi di MATURAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEGLI ALUNNI .

Presentazione del progetto
Il mio libro di Religione Nuovo Detto... fatto!
Il Corso IL MIO LIBRO DI RELIGIONE - NUOVO DETTO... FATTO! recepisce le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/2012) e le riferisce in modo organico al vissuto esperienziale degli alunni, al fine di stabilire un parallelo significativo tra le sfide poste dalla Rivelazione e dalla sapienza delle religioni e i “COMPITI EVOLUTIVI” DEGLI ALUNNI . Suddiviso in 4 volumi separati (testo ed eserciziario integrati), il corso presenta i contenuti scanditi/ritmati da una successione di "contenuti" (logo del libro) e pagine di "attività" (logo della matita). Tale metodologia, evidenziata dagli appositi loghi, si riconduce allo “stile” stesso di Dio che, fin dalla prima pagina della Bibbia, “dice” e quello che dice “avviene, si fa”: «Sia la luce! E la luce fu».
Gli ELEMENTI DIGITALI del testo sono evidenziati in ogni pagina, nella parte più in basso, da appositi loghi:
elementi video
elementi audio
notizie e curiosità
giochi e quiz
Il testo presenta i CONTENUTI DELLA FEDE CRISTIANA CATTOLICA in un’ottica di gradualità didattica, considerando la tenera età delle prime classi, lo sviluppo spesso precoce di molti studenti che si sentono già grandi e, infine, il contesto multietnico e multireligioso dell’epoca attuale, evidenziando il contributo che il Cristianesimo ha dato e dà al patrimonio umano, culturale e valoriale italiano ed europeo, con riferimenti anche alle varie discipline scolastiche, tra le quali in particolar l’arte, la cittadinanza, l’inglese, la storia, la matematica e le scienze.
All’alunno è proposto non solo di apprendere dei contenuti, ma di relazionarsi personalmente ai vari temi a partire dalle sue esperienze di vita quotidiana. Si dà di conseguenza spazio ai contenuti presentati dall’insegnante, al contesto, ovvero alle emozioni dell’alunno e alla metodologia, al “fare” in prima persona, a partire dai quali si innestano le finalità e i contenuti propri dell’insegnamento della Religione cattolica in quanto disciplina.
Il testo si struttura, come anticipato, in quattro volumi, in modo tale da poter graduare l’espressione lessicale ed il livello di difficoltà dei concetti proposti secondo l’età degli allievi, nel seguente modo:
VOLUME classe prima (testo/eserciziario pagg. 84)
VOLUME classi seconda e terza (testo/eserciziario pagg. 192)
VOLUME classe quarta (testo/eserciziario pagg. 120)
VOLUME classe quinta (testo/eserciziario pagg. 120)
Nei volumi sono offerti sia i contenuti del “testo”, con il logo del LIBRO, che del “quaderno operativo”, con il logo della MATITA, favorendo così l’immediata correlazione e fruizione tra i due componenti del corso, che sono presentati in modo immediato per ogni singolo argomento.
I contenuti di ciascuna classe sono articolati in 5 o 6 sezioni, ciascuna delle quali instaura un rapporto tra i contenuti IRC e le situazioni esperienziali che gli alunni si trovano a vivere nelle tappe della propria crescita. Queste le sezioni proposte che approfondiscono a “spirale” alcuni macro-nuclei tematici ricorrenti, ognuno caratterizzato dal medesimo colore ogni anno nell’impostazione grafica delle pagine:
Classe prima
Sezione 1 Primi giorni / A scuola per... settembre
Sezione 2 Una storia d’Amore ottobre - novembre
Sezione 3 È Natale! dicembre
Sezione 4 Ecco Gesù! gennaio - febbraio
Sezione 4 È Pasqua! marzo - aprile
Sezione 6 Ecco la Chiesa! maggio - giugno
Classe seconda
Sezione 1 Si ricomincia! settembre
Sezione 2 Una grande amicizia ottobre - novembre
Sezione 3 L’attesa di Gesù dicembre
Sezione 4 Gesù e i suoi amici gennaio - febbraio
Sezione 4 La luce di Pasqua marzo - aprile
Sezione 6 La Chiesa ieri e oggi maggio - giugno
Presentazione del progetto
Classe terza
Sezione 1 Si ricomincia! settembre
Sezione 2 Le grandi domande ottobre - novembre
Sezione 3 Un popolo eletto dicembre - gennaio - febbraio
Sezione 4 Una grande alleanza In una nuova terra marzo - aprile
Sezione 4 Nella pienezza dei tempi maggio - giugno
Classe quarta
Sezione 1 Per partire in quarta! settembre
Sezione 2 Viaggio nella storia ottobre
Sezione 3 Gli ebrei nella storia novembre
Sezione 4 Gesù, il Cristo dicembre - gennaio - febbraio
Sezione 4 La Pasqua cristiana marzo - aprile
Sezione 6 La Chiesa di Gesù maggio - giugno
Classe quinta
Sezione 1 Di nuovo in viaggio settembre
Sezione 2 I giganti dell’inizio ottobre
Sezione 3 La Chiesa delle origini novembre - dicembre
Sezione 4 La Chiesa nel tempo gennaio - febbraio
Sezione 4 La vita della Chiesa marzo - aprile
Sezione 6 Le grandi religioni maggio - giugno
Nelle diverse sezioni sono presenti delle pagine speciali, dedicate ai bambini con bisogni speciali (BES/DSA), alla MULTIDISCIPLINARITÀ, ai COMPITI DI REALTÀ, una MAPPA DI SINTESI che riassume e semplifica i contenuti proposti e una verifica per valutare l’apprendimento.
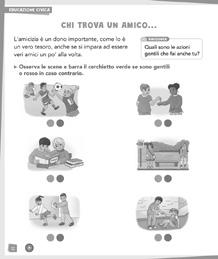



Una delle pagine “speciali” che caratterizzano il testo, è caratterizzata da un apposito logo posto nella parte alta della pagina. Presenta i temi più importanti che riguardano l’alunno in quanto “cittadino del domani”.
Caratterizzata da un apposito logo questa speciale pagina è proposta a conclusione di ogni sezione tematica affrontata. Le tematiche trattate in queste pagine si riferiscono ai contenuti della sezione in corso ma, in modo semplificato (“chiaro”) e con il testo ad alta leggibilità, particolarmente utile anche (ma non solo) per situazioni di BES/DSA.
Pagina dedicata in modo speciale espressamente all'Arte, in modo operativo e direttamente connesso alle tematiche delle sezioni in corso. Quando l'Arte... insegna!
Sintetizza e riassume i contenuti della sezione ed è caratterizzata dal colore azzurrino. Il testo delle mappe, corredato di immagini significative, è scritto per tutte e cinque le classi in stampato maiuscolo con font (carattere) certificato per la lettura facilitata.

“Impariamo con i Santi” è una serie di pagine speciali dedicata a numerosi Santi e Sante (dall'antichità ai giorni d'oggi) che rappresentano una significativa testimonianza dei valori non solo del Vangelo, ma anche della solidarietà, pace, dialogo e accoglienza.
Per ognuna delle 5 classi sono proposte figure inerenti le tematiche trattate e, in questa guida didattica, sempre in relazione ai medesimi Santi e Sante ci sono letture, laboratori e numerose schede operative aggiuntive.
Diversi box presenti all’interno del testo, ciascuno dei quali ha una sua caratteristica particolare e presentano le attività proposte in modi e tipologie differenti:
BOX ATTIVITÀ: propone dei piccoli esercizi o attività relative al testo letto;
BOX RACCONTA: suggerisce all’insegnante le domande utili per il confronto e la discussione in classe;
BOX LO SAPEVI CHE?: presenta delle curiosità o aspetti particolari dei vari argomenti trattati;
BOX PAROLE NUOVE: definisce parole nuove o difficili.

A inizio di ciascuna sezione tematica di ogni classe un Qrcode permette di accedere alle risorse digitali speciali inerenti le tematiche delle sezioni stesse.
Corso di religione CattoliCa per la sCuola primaria Presentazione del progetto
consistono, in primis, nel libro digitale sfogliabile in MODALITÀ INTERATTIVA, con numerose opzioni: lettura audio vocale del testo, possibilità di impaginazione fluida lineare per BES/DSA con font e fondini ad alta leggibilità, evidenziazione/esclusione di parti sulla pagina, annidamento di appunti (testo, immagini, link…) e molto altro.

Tra gli elementi digitali presenti per ogni sezione tematica, vi sono degli APPROFONDIMENTI DI CONTENUTO considerabili come "espansioni" del testo stesso degli alunni.
Queste le espansioni proposte.
Classe prima
Wow, che emozioni!
Costruire o creare
Quando arriva Natale
Case di un tempo
La Pasqua e i suoi segni
Classe terza
La Bibbia dei poveri
Il valore ospitalità
I nomi nella Bibbia
Un passaggio portentoso
Nel campo dei pastori
Classe seconda
Il dono di Madre Terra
L’Annunciazione nell’arte
Il rito del Battesimo
Gli ultimi giorni di Gesù
Nel mondo della preghiera
Classe quarta
Nelle grotte di Altamira
Una storia avvincente
Nel mondo dei Vangeli
Paesaggi palestinesi
I successori di Pietro
Classe quinta
Chiesa, Duomo, Cattedrale, Santuario L’Islamismo
Un Dio in tre Persone L’Induismo
Tra conventi e monasteri
Il Buddismo in Italia
L’arcipelago protestante Il Buddismo
La tradizione ebraica
Le religioni tradizionali africane
Corso di religione CattoliCa per la sCuola primaria
Presentazione del progetto
Il testo, nell’ottica di un approccio protagonista e creativo dei contenuti, propone per ogni unità didattica e per ciascuna classe, un COMPITO DI REALTÀ (oltre a quelli presenti nel cartaceo) dando istruzioni online e fornendo anche elementi per la valutazione mediante le “Competenze chiave” a valenza europea.
Questi i compiti di realtà proposti.
Classe prima
La mappa dei nomi
Viaggio nel passato
Tre doni speciali
Non sono mai solo
Coi 5 sensi in chiesa
Classe terza
Al quiz della Bibbia
Abramo all’anagrafe
Interpretatori di sogni
Una rassegna poetica
Le regole dell’amicizia
Classe quinta
Itinerari del territorio
In tribunale dinanzi ai cristiani
Giornalisti di cronaca bianca
Tutti in redazione
Un documento ecumenico
Classe seconda
Esploratori naturali
Io, presepista
Donne di ieri e di oggi
Intervista agli Apostoli
La prima comunità cristiana
Classe quarta
Indagine sul senso della vita
Le feste della luce
Maschi vs femmine
Con l’emozionometro
Il valore di un pasto insieme
Corso di religione CattoliCa per la sCuola primaria
Presentazione del progetto

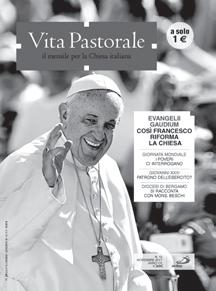

programmazione didaT TiCa annuale per unità di apprendimento
Periodo: settembre
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o o bie TT ivi formaT ivi
L’alunno
• riflette su Dio Creatore.
I valori etici e religiosi
• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.
Periodo: settembre-ottobre
L’alunno partecipa alla discussione del gruppo classe in modo adeguato e pertinente, rispettando il proprio turno di parola.
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o o bie TT ivi formaT ivi
L’alunno
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e come documento fondamentale della nostra cultura;
• conosce le divinità e le religiosità dei popoli antichi.
Dio e l’uomo
• Conoscere la religiosità dei popoli primitivi.
L’alunno comprende che nonostante diverse culture e scelte di vita, tutti gli uomini si rivolgono a un essere superiore.
T enu T i didaT T
T enu T i didaT T i C i
• Prerequisiti
• Ricordo giocando
• Stupore, meraviglie e amicizia
• Segni che vanno oltre
• Le fonti storiche
• Piccoli archeologi crescono
• Santa Elena Imperatrice
• Le prime grandi civiltà dei fiumi
• Buone azioni verso l’acqua
• Sumeri e Babilonesi
• La grande Torre di Babele
• Gli antichi egizi
• Dalla civiltà greca agli antichi romani
Periodo: ottobre-novembre
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze
L’alunno
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale della nostra cultura;
• conosce le caratteristiche principali dell’ambiente in cui è vissuto Gesù.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
La Bibbia e le altre fonti
• Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli.
I valori etici e religiosi
• Riflettere e individuare nella dimensione religiosa il bisogno di senso che accompagna da sempre l’umanità.
L’alunno
scopre gli spostamenti e la storia del popolo ebraico e, comprende appieno la formazione religiosa di Gesù di Nazaret; coglie la differenza tra la società di un tempo e quella attuale.
• Gli ebrei
• Un popolo con una grande storia
• La vita di Mosè

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Periodo: dicembre-gennaio-febbraio
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze
L’alunno
• riconosce nel Vangelo la fonte storico-religiosa privilegiata per la conoscenza di Gesù;
• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali dei suoi insegnamenti alle tradizioni dell’ambiente in cui vive;
• riconosce e sa spiegare il significato cristiano del Natale traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
Dio e l’uomo
• Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.
La Bibbia e le altre fonti
• Leggere direttamente pagine bibliche, saper riferire circa alcuni brani in particolare gli episodi chiave dei racconti evangelici.
Il linguaggio religioso
• Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.
• Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.
I valori etici e religiosi
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.
L’alunno
scopre che Gesù è realmente esistito e che le fonti storiche confermano ciò che viene riportato dai Vangeli; impara che la festa del Natale affonda le sue radici in una tradizione millenaria e che in ogni luogo ci sono modi diversi per ricordare la nascita di Gesù.
• Un Messia preannunciato
• Un uomo mandato da Dio
• L’annuncio del Messia
• La nascita di Gesù
• La magia del Natale
• Gesù, uomo nella storia
• I vangeli
• Una sola notizia, quattro evangelisti
• I vangeli sinottici
• La Palestina
• In pellegrinaggio a Gerusalemme
• San Cristoforo
• Una terra in tre regioni
• Gesù nella sua terra
• La vita in Palestina
• I mestieri in Palestina
• I villaggi al tempo di Gesù
• La condizione delle donne
• La Questione palestinese
• La speranza della Pace
• La Giornata mondiale della Pace
• La vita pubblica di Gesù
• La missione di Gesù
• Parole e gesti speciali
• La legge dell’amore
• Santa Faustina
• Il battesimo di Gesù
• Il battesimo nelle altre religioni
• La missione degli apostoli
• Parabole e miracoli
• Gli incontri di Gesù
• Le Beatitudini
Periodo: marzo-aprile
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze
L’alunno
• riconosce e sa spiegare il significato cristiano della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale;
• si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Dio e l’uomo
• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto, testimoniato dai cristiani.
Il linguaggio religioso
• Scoprire nella Pasqua il centro della fede cristiana.
• Conoscere i principali segni e i simboli pasquali e il loro significato.
L’alunno
coglie il valore salvifico della Pasqua e comprende che la morte di Gesù è stata un dono pet tutta l’umanità.
• Dalla Quaresima alla Pasqua
• Un cammino di conversione
• San Francesco di Paola
• L’ultima settimana di Gesù a Gerusalemme
• L’ultima cena
• Passione, morte e risurrezione di Gesù
• “Io sono la vita”
• Il “dopo vita” nelle religioni del mondo
• La settimana santa oggi
• I simboli della Pasqua
• Un’Italia ricca di riti e tradizioni
programmazione didaT TiCa annuale per unità di apprendimento
Periodo: maggio-giugno
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o
L’alunno
• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento.
Dio e l’uomo
• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.
L’alunno
riconosce che alla base di tutto c’è l’amore di Dio; apprende che Dio non lascia mai da soli gli uomini, ma si manifesta nei loro cuori attraverso il dono dello Spirito Santo.
• La Sacra Sindone
• Un telo a Torino
• Un velo a Napoli
• Credere o non credere?
• I discepoli di Emmaus
• Dall’Ascensione alla Pentecoste
• I simboli dello Spirito Santo

Obiettivi minimi
• Scoprire che Gesù è un personaggio realmente esistito.
• Conoscere la Palestina, il paese di Gesù.
• Conoscere i Vangeli.
• Conoscere gli evangelisti.
• Sapere che Gesù si esprime attraverso parabole e miracoli.
• Conoscere gli avvenimenti della Pasqua.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
TiCa annuale
• Sapere che la morale cristiana si basa sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo.
L’alunno…
• sa riferire gli eventi principali della vita di Gesù e, cogliendone il significato religioso, si rende conto dell’incidenza che ha nella vita sociale;
• riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi rispetto al modo in cui lui stesso percepisce vive tali festività;
• riconosce nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, anche per un personale progetto di vita.
programmazione didaT TiCa annuale per unità di apprendimento
Metodologia
• Lezione interattiva.
• Lavoro individuale.
• Lavoro di gruppo.
• Conversazioni guidate.
Materiali
• Libro di testo.
• Allegati al testo.
• Quaderni.
• Schede e immagini.
• Disegni.
• Materiale audiovisivo.
Spazi
• Aula.
• Aula informatica.
• Biblioteca.
• LIM.
Discipline coinvolte: Italiano, Arte e immagine, Inglese, Matematica, Musica, Storia
Verifica e valutazione (degli obiettivi e delle competenze)
• Compiti di realtà su obiettivi relativi a uno o più traguardi.
• La prova sarà valutata in base ai livelli definiti dalla rubrica valutativa del curricolo verticale
• Osservazione sistematica dei progressi nel processo di apprendimento.
• Per gli alunni alloglotti, con H, con DSA, con scheda BES, si fa riferimento ai documenti appositamente predisposti.
• La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi compiuti, nonché dell’impegno e del grado di maturazione.
Il percorso della classe quarta è scandito dalle sei unità di apprendimento che affrontano, in ordine, i seguenti argomenti:
1. Per partire in quarta, il rientro a scuola dopo le vacanze e l’inizio di un nuovo ciclo, quello che accompagna gli alunni alla scuola secondaria;
2. Viaggio nella storia, un percorso interdisciplinare che tocca in modo netto altre discipline, quali la storia, per conoscere, in modo ampio e generale, la nascita delle prime civiltà della storia;
3. Gli ebrei nella storia, inevitabilmente nella conoscenza delle civiltà antiche rientra la storia del popolo scelto da Dio per la sua Alleanza, il popolo ebraico;
4. Gesù, il Cristo, figlio del popolo ebraico e messia annunciato dai profeti, si approfondirà la conoscenza della figura di Gesù di Nazaret, l’ambiente sociale, geografico e storico-politico in cui visse e il suo messaggio evangelico attraverso parole (parabole) e gesti (miracoli);
5. La Pasqua cristiana, conoscere i luoghi dove si sono svolti gli ultimi eventi terreni della vita di Gesù e il nuovo volto che Lui stesso ha dato alla Pasqua, quella cristiana, per mezzo del suo grande gesto di amore: donare la propria
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
vita per gli altri; approfondire i segni e i significati di questa festa di vita, di pace e di gioia per tutti che sta al centro di tutto il messaggio di Gesù;
6. La Chiesa di Gesù, la Chiesa fatta di persone, la Chiesa intesa come comunità dove stare bene con gli altri, e quale luogo di preghiera dei cristiani, nata dal dono dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, e che ancora oggi continua la sua missione di testimonianza nel mondo.
Competenze in Chiave Europee
• Alfabetica funzionale.
• Personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
• Multilinguistica.
• Matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.
• Consapevolezza ed espressione culturali.
• Cittadinanza.
Metodologia, spazi e materiali
• Lezione interattiva.
• Lavoro individuale e di gruppo.
• Conversazioni guidate.
• Libro di testo e allegati.
• Quaderni.
• Schede, disegni e immagini.
• Materiale audiovisivo.
• Aula (classica, LIM, informatica).
Saranno coinvolte le seguenti discipline:
Verifica e valutazione
• Compiti di realtà su obiettivi relativi a uno o più traguardi.
• La prova sarà valutata in base ai livelli definiti dalla rubrica valutativa del curricolo verticale.
• Osservazione sistematica dei progressi nel processo di apprendimento.
• Per gli alunni alloglotti, con H, con DSA, con scheda BES, si fa riferimento ai documenti appositamente predisposti.
• La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi compiuti, nonché dell’impegno e del grado di maturazione.
Educazione Civica, Italiano, Arte e immagine, Inglese, Matematica, Musica, Storia.
programmazione didaT TiCa annuale per unità di apprendimento
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riflette su Dio Creatore;
• conosce le divinità e le religiosità dei popoli antichi;
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale della nostra cultura;
• conosce le caratteristiche principali dell’ambiente in cui è vissuto Gesù;
• riconosce nel Vangelo la fonte storico-religiosa privilegiata per la conoscenza di Gesù;
• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali dei suoi insegnamenti alle tradizioni dell’ambiente in cui vive;
• riconosce e sa spiegare il significato cristiano del Natale e della Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale;
• identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine bibliche a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza;
• si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo;
• coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani;
• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento.
Obiettivi di Apprendimento d io e l’uomo l a b ibbia e le alT re fon T i i l linguaggio religio S o
• Conoscere la religiosità dei popoli primitivi.
• Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.
• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto, testimoniato dai cristiani.
• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.
• Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei santi.
• Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli.
• Leggere direttamente pagine bibliche, saper riferire circa alcuni brani in particolare gli episodi chiave dei racconti evangelici.
• Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.
• Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.
• Scoprire nella Pasqua il centro della fede cristiana.
• Conoscere i principali segni e i simboli pasquali e il loro significato.
• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.
• Riflettere e individuare nella dimensione religiosa il bisogno di senso che accompagna da sempre l’umanità.
• Prerequisiti
• Ricordo giocando
• Stupore, meraviglie e amicizia
• Segni che vanno oltre
• Le fonti storiche
• Piccoli archeologi crescono
• Santa Elena Imperatrice
• Le prime grandi civiltà dei fiumi
• Buone azioni verso l’acqua
• Sumeri e Babilonesi
• La grande Torre di Babele
• Gli antichi egizi
• Dalla civiltà greca agli antichi romani
• Gli ebrei
• Un popolo con una grande storia
• La vita di Mosè
• Un Messia preannunciato
• Un uomo mandato da Dio
• L’annuncio del Messia
• La nascita di Gesù
• La magia del Natale
• Gesù, uomo nella storia
• I vangeli
• Una sola notizia, quattro evangelisti
• I vangeli sinottici
• La Palestina
• In pellegrinaggio a Gerusalemme
• San Cristoforo
• Una terra in tre regioni
• Gesù nella sua terra
• La vita in Palestina
• I mestieri in Palestina
• I villaggi al tempo di Gesù
• La condizione delle donne
• La Questione palestinese
• La speranza della Pace
• La Giornata mondiale della Pace
• La vita pubblica di Gesù
• La missione di Gesù
• Parole e gesti speciali
• La legge dell’amore
• Santa Faustina
• Il battesimo di Gesù
• Il battesimo nelle altre religioni
• La missione degli apostoli
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
• Conoscere gli episodi principali della predicazione di Gesù.
• Sapere che Gesù annuncia la Buona Notizia del Regno di Dio e che questo, anche oggi, è presente nella testimonianza di tante persone.
• Approfondire l’insegnamento di Gesù, in particolare analizzando il progetto di vita da lui proposto attraverso le Beatitudini.
• Conoscere e approfondire alcune parabole e miracoli narrati nei Vangeli, comprendendone il messaggio, gli elementi fondamentali e la struttura.
• Approfondire la conoscenza del contesto storico, politico e religioso al tempo di Gesù.
• Scoprire le caratteristiche principali dei Vangeli e degli evangelisti.
• Conoscere il contesto storico-culturale in cui sono nati i Vangeli e le relative tappe per la loro formazione.
• Scoprire i Vangeli apocrifi e il loro contenuto, considerato dalla Chiesa “non autentico”.
• Conoscere e approfondire la storia della nascita di Gesù raccontata in particolare nei Vangeli di Luca e Matteo.
• Conoscere i riti cristiani e i simboli pasquali della Settimana Santa, con uno sguardo alle tradizioni popolari di oggi.
• Conoscere i racconti evangelici delle apparizioni di Gesù risorto.
L’alunno…
• Sa decodificare il messaggio di alcuni episodi riferiti da Vangeli e sa riflettere sull’insegnamento che da esso emerge in riferimento alla propria esperienza di vita.
• Conosce, sa riferire e identifica le proprietà, gli elementi caratterizzanti e la struttura di alcune parabole e miracoli di Gesù.
• Riflette sul valore delle Beatitudini in riferimento a un personale progetto di vita.
• Conosce e sa riferire informazioni sul paese di Gesù, identificandone le analogie e le differenze col proprio vissuto e la specificità di usi e costumi dell’epoca.
• Conosce i Vangeli canonici, i suoi autori e sa collocarli cronologicamente in un contesto storico preciso, distinguendoli dai vangeli apocrifi.
• Sa riferire in modo adeguato i fatti relativi alla nascita di Gesù, in particolare narrati dai Vangeli di Luca e Matteo.
• Comprende il carattere universale della nascita, morte e risurrezione di Gesù, riconosciuti dai cristiani come eventi salvifici per l’umanità.
• Conosce il significato e il valore simbolico delle celebrazioni pasquali cristiane della Settimana Santa, ed è in grado di accostarsi ad esse con maggiore consapevolezza e rispetto.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Con T enu T i didaT T i C i o bie TT ivi annuali Compe T enze aTT e S e
• Parabole e miracoli
• Gli incontri di Gesù
• Le Beatitudini
• Dalla Quaresima alla Pasqua
• Un cammino di conversione
• San Francesco di Paola
• L’ultima settimana di Gesù a Gerusalemme
• L’ultima cena
• Passione, morte e risurrezione di Gesù
• “Io sono la vita”
• Il “dopo vita” nelle religioni del mondo
• La settimana santa oggi
• I simboli della Pasqua
• Un’Italia ricca di riti e tradizioni
• La Sacra Sindone
• Un telo a Torino
• Un velo a Napoli
• Credere o non credere?
• I discepoli di Emmaus
• Dall’Ascensione alla Pentecoste
• I simboli dello Spirito Santo
• Analizzare alcune opere d’arte che hanno raffigurato i vari momenti della vita di Gesù, dalla nascita alla morte e risurrezione.
• Scoprire la condizione delle donne al tempo di Gesù e confrontarla con quella delle donne di oggi.
L’alunno…
• Sa accostarsi ad un’opera d’arte, rilevandone le principali caratteristiche di colore ed espressività.
• Individua nell’arte una possibile forma di espressione religiosa.
• Comprende e sa riferire informazioni sulla festa cristiana di Pentecoste e sul suo significato.
ALFABETICA FUNZIONALE
PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
MULTILINGUISTICA
MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
CITTADINANZA
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Competenze in Chiave Europee
• Comprendere un testo scritto e rielaborarlo con linguaggi diversi.
• Rispondere a domande in forma scritta e orale.
• Esprimere la propria opinione sia a livello orale, sia scritto.
• Mettere in atto strategie e metodi di ricerca, personali o collettivi.
• Saper interagire in una discussione di gruppo in modo opportuno.
• Conoscere nuovi termini e vocaboli di lingue differenti.
• Utilizzare il pensiero matematico e applicare le conoscenze scientifiche e tecnologiche per risolvere problemi di vita quotidiana.
• Saper leggere e decifrare un’opera d’arte.
• Ascoltare e rispettare le opinioni degli altri, tentando di comprendere i diversi punti di vista.
• Provare a essere mediatore tra opinioni differenti.
• Collaborare con gli altri in modo proficuo.
raCCordo diSCiplinare Con: eduCazione CiviCa
L’educazione civica favorisce il riconoscimento di valori e comportamenti coerenti con la Costituzione attraverso il dialogo e il rispetto reciproco, volti a incoraggiare un pensiero critico personale, aperto e costruttivo, in un percorso formativo che, coinvolgendo la persona nella sua interezza e unitarietà.
Nucleo tematico: Costituzione diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 1
• Sviluppare atteggiamenti e adottare comportamenti fondati sul rispetto di ogni persona, sulla responsabilità individuale, sulla legalità, sulla consapevolezza della appartenenza ad una comunità, sulla partecipazione e sulla solidarietà, sostenuti dalla conoscenza della Carta costituzionale, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione Internazionale dei Diritti umani.
Obiettivi di Apprendimento
• Individuare i diritti e i doveri che interessano la vita quotidiana di tutti i cittadini, anche dei più piccoli. Condividere regole comunemente accettate. Sviluppare la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità locale, nazionale ed europea.
• Rispettare ogni persona, secondo il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione. Riconoscere, evitare e contrastare forme di violenza e bullismo presenti nella comunità scolastica.
• Curare gli ambienti, rispettare i beni pubblici e privati così come le forme di vita (piante, animali) che sono state affidate alla responsabilità delle classi.
• Aiutare, singolarmente e in gruppo, coloro che presentino qualche difficoltà per favorire la collaborazione tra pari e l’inclusione di tutti.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 2
• Interagire correttamente con le istituzioni nella vita quotidiana, nella partecipazione e nell’esercizio della cittadinanza attiva, a partire dalla conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni dello Stato, dell’Unione europea, degli organismi internazionali, delle Regioni e delle Autonomie locali. Essere consapevoli dell’appartenenza ad una comunità, locale e nazionale.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere il valore e il significato dell’appartenenza alla comunità nazionale.
• Conoscere il contenuto generale delle Dichiarazioni Internazionali dei diritti della persona e dell’infanzia. Individuare alcuni dei diritti previsti nell’ambito della propria esperienza concreta.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 3
• Rispettare le regole e le norme che governano la democrazia, la convivenza sociale e la vita quotidiana in famiglia, a scuola, nella comunità, al fine di comunicare e rapportarsi correttamente con gli altri, esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri per contribuire al bene comune e al rispetto dei diritti delle persone.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere ed applicare le regole vigenti in classe e nei vari ambienti della scuola (mensa, palestra, laboratori, cortili) e partecipare alla loro eventuale definizione o revisione. Conoscere il principio di uguaglianza nella consapevolezza che le differenze possono rappresentare un valore quando non si trasformano in discriminazioni.
• Conoscere i principali fattori di rischio dell’ambiente scolastico, adottare comportamenti idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza proprie e altrui e contribuire a definire comportamenti di prevenzione dei rischi. Traguardi per il raggiungimento delle competenze 4
• Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela della salute e del benessere psicofisico.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere e attuare le principali regole per la cura della salute, della sicurezza e del benessere proprio e altrui, a casa, a scuola, nella comunità, dal punto di vista igienico-sanitario, alimentare, motorio, comportamentale.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 9
• Maturare scelte e condotte di contrasto all’illegalità.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere le varie forme di criminalità, partendo dal rispetto delle regole che ogni comunità si dà per garantire la convivenza. Conoscere la storia dei vari fenomeni mafiosi, nonché riflettere sulle misure di contrasto. Conoscere il valore della legalità.
Nucleo tematico: Cittadinanza digitale comunicazione virtuale e sviluppo del pensiero critico
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 10
• Sviluppare la capacità di accedere alle informazioni, alle fonti, ai contenuti digitali, in modo critico, responsabile e consapevole.
Obiettivi di Apprendimento
• Ricercare in rete semplici informazioni, distinguendo dati veri e falsi.
• Riconoscere semplici fonti di informazioni digitali.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 11
• Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali consentite, individuando forme di comunicazione adeguate ai diversi contesti di relazione, adottando e rispettando le regole comportamentali proprie di ciascun contesto comunicativo.
Obiettivi di Apprendimento
• Interagire con strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare semplici regole per l’utilizzo corretto di strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare le principali regole di partecipazione alle classi virtuali e alle piattaforme didattiche.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 12
• Gestire l'identità digitale e i dati della rete, salvaguardando la propria e altrui sicurezza negli ambienti digitali, evitando minacce per la salute e il benessere fisico e psicologico di sé e degli altri.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere il significato di identità e di informazioni personali in semplici contesti digitali di uso quotidiano.
• Conoscere i rischi connessi con l’utilizzo degli strumenti digitali in termini di sicurezza personale.
• Riconoscere, evitare e contrastare le varie forme di bullismo e cyberbullismo.
L’alunno…
• riflette su Dio Creatore

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
Per partire in quarta
• Riepilogo delle attività svolte lo scorso anno.
• Conversazione guidata sugli argomenti del nuovo anno.
Da pag. 2 a pag. 3 I valori etici e religiosi
• Scoprire la bellezza dello
• stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.
All’inizio di questo nuovo anno scolastico, che dà il via al secondo ciclo della scuola primaria, coinvolgiamo gli alunni nel ricordo del ricco programma dell’anno precedente, con tutta la storia dell’ALLEANZA TRA DIO E il POPOLO EBRAICO, sottolineando principalmente le figure più importanti, ovvero quelle di Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe e Mosè.
Sarà fondamentale fissare i dati principali e gli eventi che hanno segnato la storia del popolo ebraico, che sarà protagonista anche all’inizio di questo nuovo anno, e che ci catapulterà nel ricco programma di quarta, incentrato sulla figura di GESÙ DI NAZARET, figlio di Maria e Giuseppe, ebreo anche lui.
È SEMPRE IMPORTANTE CREARE UN CLIMA SERENO E POSITIVO ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE , e soprattutto a inizio anno, dopo la pausa estiva, far riacquisire il ritmo studio a ciascun alunno, e questo può essere favorito grazie a schede semplificate di ripasso e attività ludiche.
UNA VITA IN RICERCA
INIZIA UNA NUOVA AVVENTURA. Prima di aprire la prima pagina del testo destiamo la curiosità degli alunni con una delle seguenti strategie.
Mettiamo una MUSICA DI SOTTOFONDO RILASSANTE e iniziamo a dire: «Bambini, ora chiudiamo gli occhi ed immaginiamo di addentrarci in una buia caverna. In mano abbiamo una lampada e ai piedi dei sicuri scarponi che ci impediscono di scivolare. Sulla parete della caverna intravvediamo delle figure, le illuminiamo con la nostra lampada e vediamo raffigurati dei monumenti del passato! Ah, è nel passato che siamo finiti! Cosa ci serve andare nel passato? Cosa scopriremo e visiteremo? A cosa servivano questi monumenti e come si chiamano? Lasciatevi guidare dalla vostra fantasia: cosa vedete ancora addentrandovi nella caverna? Cosa vi aspettate da questa avventura? Cosa volete scoprire? Chi vi piacerebbe incontrare?».
Lasciamo gli alunni in silenzio ad occhi chiusi con la sola musica che li guida. Poi sollecitiamoli a RACCONTARE COSA HANNO “VISTO” CON GLI OCCHI DELLA LORO FANTASIA .
Infine facciamoli esprimere liberamente nel disegno.
Oppure…
Mettiamo sulla cattedra una bussola, degli scarponi da viaggio e il testo di religione. Chiediamo agli alunni perché sono presenti questi tre oggetti. Raccolte tutte le risposte, anche le più fantasiose, procediamo a illustrare il percorso da compiere durante l’anno scolastico elencando le varie unità di apprendimento. Infine facciamo disegnare agli alunni le tappe del percorso scolastico sul proprio quaderno, quasi come fosse una copertina per l’inizio di questo biennio.
In questa prima unità dell’anno scolastico inizia possiamo presentare alcuni brani tratti dal libro “IL PICCOLO PRINCIPE”.
Dalle tematiche di questo celebre libro faremo scaturire riflessioni e attività extra prima sul TEMA DELL’AMICIZIA, poi su quello del DONO DI SÉ.
Ma, prima, approfondiamo la conoscenza dell’autore e del libro che presentiamo ai ragazzi.
A Lione, il 29 giugno del 1900, in una famiglia aristocratica, nasce Antoine de SaintExupéry. Anche se rimane prematuramente orfano di padre, trascorre un’infanzia felice grazie alle cure amorevoli della madre. Da adulto si dedica alla scrittura e diventa aviatore militare: numerose sono le missioni che compie, non senza incidenti. È proprio durante una di queste che alla giovane età di 44 anni scompare misteriosamente. Il suo libro più noto, che affascina grandi e piccoli ancora oggi, è Il Piccolo Principe. Il Piccolo Principe è uno dei libri più tradotti al mondo. Uscito per la prima volta negli Stati Uniti, racconta la storia di un aviatore, l’autore stesso del libro, che precipita con il suo aereo in avaria nel deserto del Sahara. Qui incontra un bambino, appunto il Piccolo Principe, che gli chiede di disegnargli una pecora e non si accontenta fintantoché l’aviatore gli propone una scatola all’interno della quale il Principe possa immaginare la sua. L’aviatore viene a conoscenza del fatto che il Piccolo Principe proviene dall’asteroide B612 in cui vive con tre vulcani, di cui solo uno attivo, e una bellissima rosa. Il motivo della sua partenza è proprio questa rosa, che con il suo atteggiamento scorbutico l’ha rattristato. Durante il viaggio racconta di aver incontrato dei personaggi particolari: un vecchio, un uomo vanitoso, un ubriacone, un uomo d’affari, un lampionaio e un geografo che gli consiglia di dirigersi verso la Terra dove potrà trovare la pecora che possa divorare i baobab che crescono sull’asteroide.
Sulla Terra il Piccolo Principe fa tre incontri simbolici: un serpente, un piccolo fiore con un roseto e una volpe.
Terminato il suo racconto, i due vanno alla ricerca di acqua e trovato un pozzo si separano, dandosi appuntamento per la sera dopo.
Quando l’aviatore arriva, trova il Piccolo Principe in compagnia del serpente: egli grazie a lui è pronto a ritornare a casa, sul suo asteroide. Il pilota da quel giorno osservando il cielo stellato penserà a lui: è stato “addomesticato”, come avvenuto con la volpe.
Progetto lettura: "Di pianeta in pianeta con..."
Introduciamo Il Piccolo Principe con la visione del noto film di animazione. Si possono poi affrontare le diverse tematiche leggendo dei brani del libro durante
l’anno scolastico. È un’esperienza che aiuterà i bambini a crescere e maturare determinati atteggiamenti proprio perché i temi trattati nel testo sono molteplici e tutti di grande profondità. Ecco alcune frasi famose che permettono di entrare nel vivo del libro.
“Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”.
“Amare è donare tutto se stesso senza nulla chiedere amare è non dire mai... mi devi”.
“È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante”.
“Diventi responsabile per sempre di ciò che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa”.
La frase più famosa del testo è: «Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi». Essa aiuta a far capire all’individuo che la cosa fondamentale è “vedere” con il cuore e lasciarsi stupire da tutto ciò che va ben al di là delle semplici apparenze.
«È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante». Il protagonista nell’asteroide cura una semplice rosa con grande dedizione e amore. Lei, tuttavia, lo ricambia non sempre in modo amorevole, anzi in alcuni momenti diventa scorbutica e piena di esigenze.
Quando è lontano, tuttavia, il Piccolo Principe capisce che lui ha un profondo amore nei suoi confronti, perché si sono presi cura l’uno dell’altro, tanto da farsi mordere dal serpente velenoso per tornare da lei.
Questo gesto così estremo induce a capire che non è l’apparenza e l’esteriorità la cosa importante, ma l’io profondo di ognuno. Gli adulti non dovrebbero mai dimenticare il bambino che c’è dentro di loro e non dovrebbero farsi prendere dal materialismo e dalle apparenze del mondo che li circonda. Questo “bambino addormentato” dentro ciascuno va svegliato.
Confronto con la Bibbia
Il libro Il Piccolo Principe si presta molto bene ad un confronto con molte delle tematiche presenti nella Bibbia, sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento, come la fedeltà e l’amore che ben stanno insieme perché l’una non esclude l’altra. Difatti lo stesso evangelista Giovanni riferisce le parole di Gesù: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici» (Gv 15,13).
Gesù inoltre durante la sua vita terrena si prende cura delle persone svantaggiate o in difficoltà, così come il protagonista del libro si prende cura della sua rosa.
Proponiamo due schede su quanto affrontato con Il Piccolo Principe: la scheda n. xx qui a pagina xxx con giochi e quiz e la scheda xx a pagina xxx con la richiesta di esprimersi sul concetto di amicizia. Circa questa tematica abbiamo a disposizione il compito di realtà di questa unità “Le Regole dell’amicizia”.
Facciamo leggere la pagina xx del testo “La festa delle feste”, con la scheda operativa “La festa di Pasqua” a pagina 161. Entriamo così nelle tematiche pasquali, ma facciamolo con l’aiuto della musica, presentando una delle opere più celebri di Johann Sebastian Bach, compositore tedesco del XVIII secolo, peraltro molto religioso.
Inserisci le parole dopo aver risposto a ciascuna domanda.
Il fiore che il Piccolo Principe ama.
Precipita con il suo aereo in avaria.
Gli consiglia di andare sulla Terra.
Lo aiuta a ritornare dalla rosa.
Gli spiega cosa vuol dire amare qualcuno.
Spiega con parole tue una delle frasi più significative del libro: «ECCO IL MIO SEGRETO. È MOLTO SEMPLICE: NON SI VEDE BENE CHE COL CUORE. L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI».
E tu? Come dimostri la tua amicizia?
E Gesù? Cosa ha fatto per gli uomini, che chiamava “amici”?
Disegna nel pianeta un tuo amico o amica e descrivi in basso le caratteristiche del vostro rapporto di amicizia.
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e come documento fondamentale della nostra cultura;
• conosce le divinità e le religiosità dei popoli antichi.
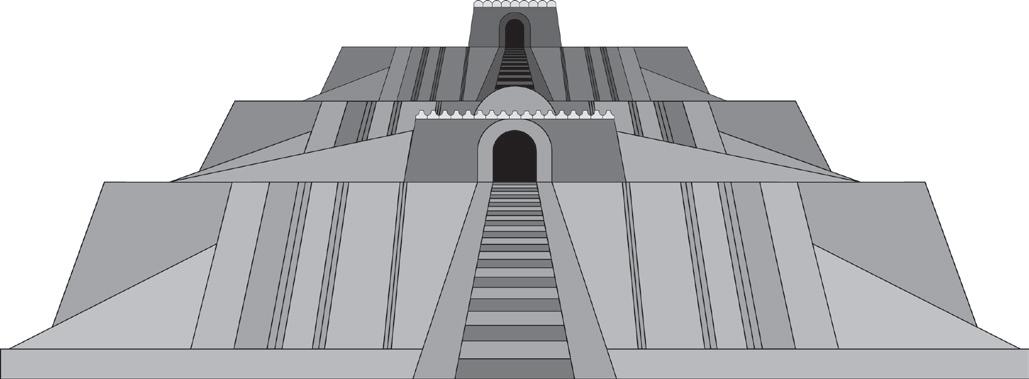
u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
Viaggio nella storia Segni e fonti storiche.
Le prime civiltà della storia:
• i sumeri e i babilonesi;
• gli antichi egizi;
• greci e i romani
Da pag. 4 a pag. 18 Dio e l’uomo
• Conoscere la religiosità dei popoli primitivi.
Questa nuova avventura si apre all’insegna dei “SEGNI” DEL PASSATO DA CONOSCERE ED ESPLORARE (la religiosità dell’umanità primitiva, le prime civiltà della storia e il popolo ebreo in viaggio, fino alle tracce di Gesù in Palestina). Gli alunni della classe quarta, che hanno già studiato la preistoria, avranno modo di notare le differenze tra le prime forme di religiosità, tipiche dei popoli primitivi, e le antiche religioni che presentano i tratti di un pensiero già organizzato con precetti e nuclei di fede fondati e ricchi di spiritualità.
In questo percorso l’insegnante accompagnerà gli alunni ad approfondire le loro conoscenze storiche sulle popolazioni dell’antichità (sumeri, babilonesi, egizi, greci e romani) e sul loro rapporto con gli dèi, e sul destino dell’uomo dopo la morte.
Per ben contestualizzare quanto in questo primo percorso stiamo per approfondire è utile mostrare ed eventualmente far costruire agli alunni una MAPPA SINTETICA TEMPORALE DELLE PRINCIPALI RELIGIONI DELL’ANTICHITÀ , dall’epoca primitiva a quella greco-romana.
CIVILTÀ
MESOPOTAMICHE
Sumeri
Babilonesi
POPOLI PRIMITIVI
Assiri
CIVILTÀ EGIZIA
CIVILTÀ GRECA
CIVILTÀ ROMANA
La MESOPOTAMIA è una zona compresa tra il fiume Tigri e il fiume Eufrate, il suo nome viene dal greco e significa TERRA TRA DUE FIUMI. Oggi questa regione appartiene quasi interamente all’Iraq. Il suo territorio è quasi completamente desertico, ma ricco di petrolio. Quasi 10.000 anni fa questa zona era coperta di paludi. Poi, intorno al 5000 a.C. molti territori diventarono deserti e steppe a causa del clima sempre secco. Fu allora che scesero a valle alcune popolazioni che iniziarono a vivere lungo i fiumi.
Intorno al 4000 a.C. la Mesopotamia era una delle zone più fertili del mondo. Vi si ottenevano anche tre raccolti all’anno di cereali, frutta e verdura.
Secondo alcuni studiosi il Tigri e l’Eufrate straripavano regolarmente come il fiume Nilo, lasciando sul suolo un limo fecondo che rendeva particolarmente fertile il terreno. Oggi, questo fenomeno, sarebbe cessato in maniera del tutto naturale.
La Mesopotamia divenne importante per gli scambi commerciali tra l’India e Nella mezzaluna fertile
i Paesi del Mediterraneo, rendendola una regione ricca. Le merci provenienti dall’Oriente arrivavano in Mesopotamia, lungo il Golfo Persico, attraverso i fiumi Tigri ed Eufrate, dove venivano scambiate con quelle che arrivavano dall’Occidente attraverso le carovane. In Mesopotamia vissero diverse popolazioni: i
SUMERI, i BABILONESI, gli ASSIRI.
La coppia di fiumi più famosa del mondo: il Tigri e l'Eufrate
Sono fiumi che PORTANO ENORMI QUANTITÀ D’ACQUA, attraversando regioni aridissime e popolose. Entrambi i fiumi sono lunghi e ricchi di acqua, hanno perciò una grande importanza per la vita delle popolazioni di quell’area. Ma la loro importanza storica è più generale: in Mesopotamia sono state trovate le più antiche tracce di coltivazione volontaria dell’uomo – cioè dell’agricoltura – e qui si sono costituite, in conseguenza, le più antiche città e si sono formati i più antichi Stati della storia.
Sono tutti eventi fondamentali per l’intera civiltà umana, resi possibili proprio dalla presenza dei due fiumi.
Il suo corso misura 2.760 km e il suo bacino copre un’estensione di 765.000 km2. Ha una portata irregolare – come anche il Tigri – e piene che un tempo erano imponenti: il medio e basso corso di entrambi i fiumi sono protetti da argini e corrono rialzati rispetto ai campi che attraversano.
I due rami da cui nasce l’Eufrate vengono da una regione della Turchia non lontana dall’Ararat, il monte che, secondo la tradizione biblica, fu la prima cima a emerge re dopo il Diluvio universale proprio dove si sarebbe fermata l’arca di Noè. L’Eufrate scorre dapprima verso ovest, poi attraversa le strette gole dell’Antitauro, fino a sfociare sull’altopiano siriano. Qui, con un percorso sempre più pianeggiante verso sud-est, scende in territorio iracheno. Costituisce allora il bordo orientale di quella grande fascia stepposa che in arabo è detta al-Jazira «l’isola» (corrispondente quindi a Mesopotamia).
Nel suo lento tragitto l’Eufrate si divide allora in più bracci, fino a congiungersi con il Tigri.
Il nome del Tigri, 1.950 km e 375.000 km2 di bacino, in arabo significa «freccia» per via della sua velocità – anche la parola tigre ha la stessa origine –, anche se il corso del fiume in pianura è lento e sinuoso.
Il Tigri nasce sul Tauro Armeno e scorre verso sud-est, in territorio turco, per più di 500 km. Attraversa la Mesopotamia settentrionale (l’antica Assiria, ora parte delle terre curde), entrando in Iran. Bagna la città di Mossul e costeggia al-Jazira da est. Scende e riceve gli affluenti da sinistra, tra i quali il Grande e il Piccolo Zab e il Diala.
Compie poi un’ampia curva verso ovest, arrivando a sfiorare l’Eufrate, attraversa Baghdad ed entra nella Mesopotamia meridionale, costituita da terreni per lo più paludosi.
Il Tigri ha una pendenza minima e acque molto ricche di sedimenti. Si unisce quindi con l’Eufrate. Con il nome di Shatt al’Arab, i due fiumi proseguono per 150 km, bagnano Bassora, fanno da confine tra Iraq e Iran e sfociano nel Golfo Persico. In età antica la costa era più arretrata e i due fiumi giungevano al mare con foci distinte.
I Sumeri
I Sumeri erano politeisti, cioè adoravano più dèi, li immaginavano con un aspetto simile agli uomini e con un carattere e dei sentimenti come quelli umani. Tutti gli dèi adorati erano immortali. Gli dèi che questo popolo adorava erano circa cinquanta, di cui ve ne erano alcuni considerati più importanti di altri. Il destino degli uomini era stabilito dagli dèi. Essi erano visti come dei nemici: per conquistarsi i loro favori venivano offerti dei sacrifici di animali, vino, olio e cerali.
Secondo i Sumeri, inizialmente esistevano solamente le acque.
Da queste furono generati gli dèi che crearono gli uomini con argilla e sangue. I sacerdoti avevano l’importante compito di parlare con gli dèi ed interrogarli per conoscere la loro volontà.
Tiamat, etimologicamente, è da collegarsi alle parole TI (Vita) e AMA (Madre). Tiamat trae origine dalla più antica divinità sumera Nammu, la dea della creazione, della quale prende la quasi totalità degli attributi. Si accoppiò con Apsû con il fine di creare gli dèi più giovani.
Nell’Enûma Eliš, si oppose ad Apsû quando decise di sterminare le giovani divinità, avvisando il più potente tra loro, Enki-Ea, il quale riuscì ad addormentare Apsû con un incantesimo per poi ucciderlo.
Dal corpo di Tiāmat si sarebbe formato il mondo, la terra e il mare.
Gli dèi rappresentavano elementi della natura, come:
• Enki, il dio dell’acqua;
• Ki, il dio della terra;
• An, il dio del cielo;
• Ishtar, il dio della luna e dell’amore;
• Inanna, la dea della fertilità;
• Dumuzi, marito di Inanna e protettore delle mandrie;
• Enil, il dio del vento.
STRUTTURA DELLE ZIGGURAT
Il tempio presente nella ziggurat era dedicato al dio protettore della propria città.
I Sumeri credevano nella vita dopo la morte. Per questa ragione seppellivano i loro capi insieme ad oggetti come armi e gioielli. Con il capo venivano seppelliti anche i suoi diretti collaboratori e amici i quali si offrivano volontariamente alla morte in onore del defunto.
I Sumeri credevano nella vita dopo la morte. Per questa ragione seppellivano i loro capi insieme ad oggetti come armi e gioielli. Con il capo venivano seppelliti anche i suoi diretti collaboratori e amici i quali si offrivano volontariamente alla morte in onore del defunto. Per rendere meno gravoso il cammino verso il mondo dei morti, i Sumeri erano soliti “regalare” al defunto diversi oggetti, posti nella bara a lato del cadavere che, spesso, veniva sepolto in maniera raggomitolata, una posizione che ricorda quella del feto. Come a voler indicare che l’uomo, morendo, torna ad inserirsi nel ciclo vitale della natura: ovvero, vita e morte sono sempre indissolubilmente legate. I Sumeri e Babilonesi avevano una visione triste dell’Aldilà, in cui le anime avrebbero vagato rimpiangendo i momenti felici della vita terrena. Questo pessimismo dava solo alla persona giovane, sana, fortunata negli affetti una parvenza di felicità, destinata a svanire con la vecchiaia e la morte.
Babilonia
Situata sull’Eufrate e attraversata da due canali, l’Arakhtu e il Libil Khegalla, da una doppia cinta di mura costruite in mattoni: il muro esterno (dūru), chiamato Imgur-Bel, era largo 6,5 m ed aveva ogni 18 m una torre, una grande alternata con una piccola; il muro interno (shalkhū), chiamato Nimitti-Bel, era largo quasi 4 m, e davanti ad esso era scavato un fossato pieno d’acqua; la distanza tra le due mura era di 7,20. La città aveva 8 grandi porte (abullu), ognuna delle quali era dedicata a una divinità; la più famosa è la porta di Ishtar, la cui descrizione dà un’idea anche delle altre. Era una porta doppia, in quanto attraversava due mura, fiancheggiata da due torri avanzate e da vani che si aprivano nell’interno delle mura stesse e che servivano da corpo di guardia; la porta principale era fiancheggiata da due porte minori, che servivano da entrate secondarie, ed era decorata con draghi e tori smaltati. La città era divisa in almeno quattro quartieri. Si distingueva la città vecchia, interna (libbi āli), dalla nuova che giaceva a destra dell’Eufrate.
Le strade principali erano 24 e vi erano inoltre due strade militari (girru). Nelle strade si trovavano numerosi piedistalli e pedane per le statue o i simboli degli dèi: a Babilonia si contavano 180 altari per la dea Ishtar, 180 per gli dèi Nergal e Adad, oltre ai 53 templi degli dèi maggiori e alle 900 cappelle per gli dèi minori (Igigi e Anunnaki).
Le comunicazioni con la sponda destra dell’Eufrate erano assicurate da un ponte, costruito anch’esso in mattoni con travi di legno in rinforzo, i cui piloni erano lunghi 21 m nel senso della corrente, con uno spessore di 9 m; su di esso passava la famosa strada processionale tra l’Etemenanki, il tempio Esagil e il Bīt Akītu. Questa strada, larga 22 m e lunga 300, era fiancheggiata da due mura di 7 m di spessore, ornate con 60 leoni per lato. Il tempio più importante della città era quello dedicato a Marduk e chiamato Esagil, che significa “tempio dall’alto tetto”; era situato sulla sponda dell’Eufrate e constava di due parti principali: una più antica, con la Porta Santa e la torre, l’altra, più recente, che era il tempio Esagil stesso; era di pianta quadrata con la cella del dio (che conteneva la sua statua, seduta in trono, di certo simile a quella che si vede riprodotta in alcuni sigilli cilindrici, e inoltre, il letto, il carro, e la barca del dio).
Come in genere tutti i templi mesopotamici, anche l’Esagil era ricco di cortili. La torre (ziqqurat) chiamata Etemenanki, che significa “casa del fondamento del
cielo e della terra”, si ergeva su una base quadrata di 90 m di lato, e constava di 7 piani, per un’altezza totale di 90 m; il settimo piano era rivestito di mattoni smaltati in azzurro e portava un tempietto (gigunu).
Altro tempio famoso era il bīt akītu edificato fuori della cinta di mura, al quale conduceva la strada processionale Aīburshābū che passava sotto la porta di Ishtar; ivi si svolgeva principalmente, ogni primavera, la festa del capodanno babilonese, l’akītu, che era la festa più importante dell’anno e durava dodici giorni. C’erano poi i famosi giardini pensili, celebrati come la settima meraviglia del mondo antico; gli scavi hanno riportato alla luce, presso la porta di Ishtar, una terrazza sulla quale venivano piantati alberi e che si levava su una serie di 14 camere a volta che le facevano da sottostruttura; tali resti, piuttosto scarsi, dànno un fondamento concreto alla tradizione, che aveva ampliato fantasticamente un dato di fatto più inconsueto che meraviglioso.
La porta di Ishtar (dea della fertilità) risale al 575 a.C. Voluta da Nabucodonosor era l’entrata principale di Babilonia e collegava la Strada delle Processioni, il Tempio di Marduk alla Casa delle Feste.
La porta era totalmente rivestita di mattonelle smaltate blu decorate con 575 figure di animali.
MARDUK
Marduk, dio di Babilonia, in una immagine proveniente da un sigillo cilindrico in lapislazzuli risalente al IX secolo a.C., e dedicato al dio dal re babilonese Mardukzâkir-šumi (regno: circa 854-819 a.C.).
Fu rinvenuto nei resti di una casa di un artigiano di monili del periodo partico. Marduk è qui accompagnato dal serpente-drago con corna Mušhuššu (lett. “serpente terribile”). Con la mano sinistra regge il listello e la corda, strumenti della giustizia. Il suo corpo è adornato da simboli astrali.
Gli Egizi credevano nell’aldilà (immaginato simile all’esistenza terrena), nel giudizio dell’anima, nella reincarnazione.
Praticavano l’imbalsamazione. Il libro dei morti è una raccolta di formule magiche
e preghiere che secondo gli Egizi guidavano e proteggevano l’anima del defunto nel suo viaggio nell’oltretomba.
Pensavano che la conoscenza di questi testi permettesse all’anima di scacciare i demoni che ostacolavano il cammino e di superare le prove poste da quarantadue giudici del tribunale di Osiride.
Con il termine psicostasia si vuole indicare la cerimonia cui, secondo il Libro dei morti nel capitolo 125 dell’antica religione egiziana, veniva sottoposto il defunto prima di poter accedere all’aldilà. Più usualmente, la psicostasia era nota come “pesatura del cuore”, o “dell’anima”. Il dio della saggezza, Thot, prendeva nota dell’esito della pesatura: se, infatti, il cuore, come depositario di tutte le azioni, buone o malvagie, compiute durante la vita, bilanciava la piuma, allora il defunto era dichiarato “giusto”, o “giustificato”, ed ammesso al regno dei morti. In caso contrario, il cuore veniva dato in pasto a Ammit, “colei che ingoia il defunto”, rappresentata da un mostro composito ai piedi della bilancia, che somma in sé gli animali più pericolosi dell’Egitto: il coccodrillo, il leone e l’ippopotamo.
Il paese che oggi corrisponde all’IRAQ si chiamava nell’antichità MESOPOTAMIA (terra tra i fiumi). Qui, a partire dal neolitico, si stanziarono nel corso di tremila anni molti popoli: SUMERI, ASSIRI e BABILONESI
Grazie alle tavolette, ritrovate dagli archeologi durante gli scavi, conosciamo la loro religione: le divinità che veneravano, i riti, le preghiere e le loro leggi. Inizialmente le divinità era personificazioni di fenomeni naturali, le più importanti erano: ANU, ENLIL, EA
• Anu era il dio del cielo che sorvegliava l’operato degli dei e degli uomini.
• Enlil, suo figlio, che comandava e fissava il destino degli uomini.
• Ea era colui che conosceva tutto, il dio della sapienza che abitava nell’Apsu, la grande massa d’acqua che, secondo la cosmologia mesopotamica, circondava il cosmo.
Essi garantivano l’ordine del cosmo e il controllo degli elementi che la compongono. Gli dèi mesopotamici erano numerosissimi, anche perché ogni città aveva un dio locale e, quando una regione ne vinceva o conquistava un’altra, gli sconfitti erano costretti a onorare, oltre alle proprie, anche le divinità dei vincitori. Così,
quando nel corso del II millennio a.C. i Babilonesi ebbero il sopravvento sui Sumeri, il dio di Babele, MARDUK ebbe il potere supremo sulle altre divinità, spontaneamente cedutogli da Anu ed Enlil.
In onore delle divinità venivano edificate delle costruzioni templari chiamate
ZIGGURAT, la cui forma ricorda quella di una piramide a gradoni. Esse erano una sorta di montagna sacra, templi a torre, costruiti con mattoni, calce e canne. La torre veniva realizzata attraverso la sovrapposizione di tronchi di piramide, che consentivano all’uomo di avvicinarsi al cielo, sede della divinità. Si credeva che su queste torri il dio scendesse durante le feste in suo onore. La sommità della ziggurat era considerata la sede del dio, dove si officiavano le cerimonie, e l’accesso era consentito solo ai sacerdoti.
Essi avevano un potere enorme in quanto erano gli unici che potevano rivolgersi alle divinità e conoscere i loro ordini. Inoltre avevano il compito di lavare, profumare, rivestire e ornare le statue degli dei.

I SACERDOTI si dividevano in gradi gerarchici, il loro ufficio era spesso ereditario e legato a condizioni speciali (assenza di difetti fisici, conoscenza della scrittura…). I più importanti erano gli INDOVINI che predicevano il futuro osservando le stelle, interpretando i sogni, la forma delle viscere degli animali sacrificati.
A capo di tutti erano il SOMMO SACERDOTE, l’unico a poter entrare direttamente nella cella del dio, recitare le preghiere durante le feste solenni, stabilire i tempi e le forme del culto, garantire la continuità della tradizione. Durante le celebrazioni egli declamava anche alcuni poemi sacri di tipo mitologico: il POEMA DELLA CREAZIONE, che ricordava a tutti come la vita nascesse dalla volontà degli dei e l’epopea di GILGAMESH, in cui si esalta il valore, l’amicizia e si affronta l’interrogativo se l’uomo possa sfuggire alla morte per proprio volere.
Gilgamesh è un famoso eroe dei popoli della Mesopotamia le cui gesta sono arrivate fino ai nostri giorni. Infatti nel poema a lui intitolato si racconta che fosse più un dio che un uomo. Era il re di Uruk ed era un uomo potente e ricco, ma anche spietato.
È proprio per la sua crudeltà che i suoi sudditi chiedono aiuto alla dea Ishtar. Quest’ultima però, innamorata di lui e da lui allontanata, si vendica creando con il fango Enkidu, un essere dalla forza invincibile di cui Gilgamesh diventa però amico.
I due compiono grandi imprese insieme come eliminare un toro creato da Ishtar per distruggere
Gilgamesh e la sua città.
La loro amicizia si rafforza sempre di più fino a quando Ishtar colpisce Enkidu con una malattia mortale.

Gilgamesh sperimenta così il sentimento della perdita e piange per giorni e giorni. Si rende anche conto che anche lui è mortale come tutti gli uomini e decide di partire per un lungo viaggio per cercare l’uomo a cui era stata concessa l’immortalità: Utnapishtim, sopravvissuto al diluvio. Grazie a lui Gilgamesh scopre l’esistenza della pianta dell’immortalità e la trova nei pericolosi fondali marini secondo le sue indicazioni, ma dopo averla presa non riesce né a mangiarla né a darla ai suoi amici perché un serpente sentendone la dolcezza la ingoia, diviene giovane e scappa via.
È così che Gilgamesh e gli uomini sono costretti a rimanere mortali. Gilgamesh esprime allora il desiderio di vedere un’ultima volta il caro Enkidu: una fessura si apre e i due possono finalmente riabbracciarsi e parlare a lungo.
Enkidu racconta la vita nell’Aldilà dicendo che si tratta di un mondo buio, scuro, tetro, dove manca la luce e di come il corpo venga mangiato dai vermi. Anche Gilgamesh, dopo un lungo regno, muore come ogni comune essere umano.
RIFLETTIAMO
• Chi sono i protagonisti del mito?
• Chi è l’antagonista?
• Come diventano amici?
• Descrivi la loro amicizia.
• Cosa vuole spiegare questo antico mito mesopotamico?
• Immagina di essere Gilgamesh: descrivi quali emozioni ha provato alla perdita del suo più caro amico.
• Come immaginavano i popoli della Mesopotamia l’Aldilà?
La torre di Babele
Gli ebrei nel 586 a.C. furono deportati in BABILONIA dove vi rimasero fino al 538 a.C. quando Ciro il Grande, re di Persia sconfisse i Babilonesi.
Nella città di Babilonia c’era un edificio imponente e impressionante: LA TORRE, innalzata per una divinità dei Babilonesi, che corrisponde dal punto di vista archeologico alla ziggurat. Quando i bambini degli Israeliti chiedevano ai loro padri: «Che cos’è questa torre?» questi raccontavano la seguente storia.
Tanto, tanto tempo fa, gli uomini lasciarono i loro rifugi in montagna e decisero di stabilirsi in pianura. E dissero tra loro: «Avanti! Costruiamoci una nostra montagna, alta fino alle nuvole, con in cima un’abitazione per il nostro Dio». Altri aggiunsero: «Ottima idea! Questo ci renderà famosi e inoltre sarà più facile per noi rimanere uniti se abitiamo tutti quanti intorno alla torre del nostro Dio. Sarà un po’ come nei nostri vecchi villaggi in montagna. E così ci sentiremo anche più sicuri.» E si misero subito al lavoro.
Il capo architetto aveva disegnato un grande progetto e delimitava sul terreno un quadrato di cento metri per cento metri come base della costruzione. I mattoni, seccati al sole, venivano trasportati su piccoli carri trainati da muli, messi in cesti, sollevati in alto e legati con bitume.

E così procedevano, da un gradino all’altro, installando anche delle impalcature per accelerare i lavori. Tutti dovevano fare il loro dovere: c’erano degli operai per sollevare i pesi, altri per trasportare i mattoni, altri ancora addetti alla costruzione; le donne si occupavano dei pasti e delle bevande: ognuno doveva dare il suo contributo all’impresa comune. Il capo architetto saliva più in alto di tutti e ammoniva a lavorare di più e più velocemente; lo si riconosceva anche da lontano dal suo berretto rosso.
«La torre deve diventare una Scala!» esclamò, «una scala che ci porta dritto, dritto fino a Dio!» Dio, comunque, non si era neppure accorto di quella torre in quella strana città, finché un giorno, per puro caso, non vide quella minuscola torretta di cui gli uomini si vantavano tanto.
E pensò: «Perché gli uomini non fanno ciò che dovrebbero fare: costruire case in cui abitare e curarsi l’uno dell’altro? Perché vogliono costruire un edificio così particolare? Mica penseranno per davvero che io mi ci metterò ad abitare! Non crederanno sul serio che questo sia il modo migliore per rimanere vicini l’uno all’altro! Un’impresa così non può che fallire!». Gli uomini, infatti, durante tutti quegli anni si erano talmente concentrati sulla costruzione di quella torre che avevano dimenticato di parlare tra di loro. I portatori di mattoni non conversavano più con i costruttori, né con gli addetti ai trasporti.
Il capo architetto era diventato vecchio e affidò tutto ai suoi rappresentanti. E poiché i pochi rapporti rimasti erano quelli all’interno del proprio gruppo, ciascun gruppo aveva sviluppato il suo modo particolare di parlare. Per esempio,
un giorno, un vice architetto fece calare dall’alto una trave annunciando: «Richiedesi attenzione! Annuncio del capo reparto: materiale, destinato ad essere calato, con eventuale rischio per l’addetto in posizione A» o qualcosa di simile… Ma il portatore di mattoni non capiva che in posizione A c’era proprio lui e neppure il resto di ciò che il caporeparto aveva detto e, naturalmente, con grande precisione la trave gli cadde sulla testa!
Certamente, la sua risposta non poteva che essere: «Imbecille!» o qualcosa del genere, perché nel suo linguaggio questa era una parolaccia adatta alla situazione. Però questa ultima parola era incomprensibile per il capo reparto in alto e così cominciarono a litigare. E queste cose si ripetevano sempre più frequentemente, anzi, le cose peggioravano di giorno in giorno e sempre più gente si arrabbiò e se ne andò.
La torre non fu mai finita e quando la pioggia e il caldo provocarono le prime crepe, nessuno si adoperò neppure ad aggiustarle.
Dopo pochi anni tra i mattoni cominciò a crescere l’erba e tutto ciò che rimase del grandioso progetto fu un enorme mucchio di mattoni.
K. Eykmann – B. Boumann
Al termine della storia leggiamo agli alunni il testo biblico della torre di Babele (Genesi 11,1-9) e spieghiamo loro che questo edificio simboleggia il tentativo dell’umanità di ieri e di oggi di fare a meno di Dio.
Questo progetto però non va in porto perché quando l’uomo ignora Dio e le sue leggi, non riesce più a capirsi nemmeno con i suoi simili
• Che cosa vogliono fare gli uomini?
• Perché?
• Che cosa significa l’immagine della torre alta fino al cielo?
• Che cosa vogliono dimostrare gli uomini a Dio?
• Quali risultati hanno i loro sforzi?
Il pantheon egizio è vario e variegato, presenta divinità dalle forme umane (antropomorfe), animali (zoomorfe) e ibridi, e prospetta un forte orientamento all’aldilà.
In origine ogni divinità egizia era legata strettamente al distretto di origine (l’Egitto era diviso infatti in 42 distretti), in cui si trovava il suo centro di culto.
Con il tempo e l’unificazione del Paese, ALCUNE DIVINITÀ
GLI EGIZIANI.






Nato dalla fusione del dio Ra di Eliopoli e del dio Amon, la principale divinità di Tebe, fu riconosciuto come il re di tutti gli dei del pantheon egizio. L’animale a lui sacro è l’ariete.






NUT E GEB
Divinità rispettivamente del cielo (principio femminile) e della terra (principio maschile). Sono molto innamorati l’uno dell’altra. Sono i genitori di Osiride e di Seth. Nut è raffigurata come una donna dalla pelle giallastra con un vaso di acqua sulla testa. Geb è rappresentato come un uomo barbuto con l’emblema di un’oca sulla testa che simboleggia il geroglifico del suo nome.
Dio della morte e della vita e soprattutto dio dell’agricoltura e vegetazione Fu ucciso e smembrato dal suo malvagio fratello Seth e ricomposto e riportato in vita da Iside. Venne in seguito imbalsamato da Anubi, andando così a regnare nel mondo dei morti.





Dea delle madri, dei bambini e dea della luna, in seguito, dopo aver riportato in vita Osiride, dea della medicina. Sposa e sorella di Osiride e madre del dio-falco Horus. Figlia di Nut e di Geb. Nel mito di Osiride ella è colei che salva la vita ad Osiride. L’amore che Iside prova per Osiride non può finire. Iside ha un copricapo a forma di trono o delle corna sulla testa con una luna ed è spesso rappresentata con le ali spiegate.
Malvagio dio dei deserti della sventura e del male
In generale fratello di Osiride nonché suo uccisore. Viene raffigurato come un uomo con la testa di animale talvolta identificato con lo sciacallo o con la capra.







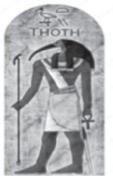
HORUS
Dio del cielo, della luce e della bontà. Viene rappresentato con la testa di falco ma anche come un bambino con un dito sulle labbra. Il faraone è ritenuto la sua incarnazione.
THOT
Dio della saggezza, messaggero degli dei, dio della scrittura, della scienza e delle arti magiche. Viene rappresentato in un primo tempo con la testa di babbuino, in seguito con quella di ibis.









HATHOR
Dea dell’amore e della gioia, patrona della musica e della danza. Quando viene rappresentata con le sembianze di vacca, è protettrice dell’abbondanza e propiziatrice di fertilità.
ANUBI
È il dio con la testa di sciacallo. Insieme con Horus e Thot assiste alla pesatura del cuore dei defunti. Per questo è considerato il protettore delle necropoli e del mondo dei morti
SOBEK
Dio con la testa di coccodrillo, gli antichi egizi credevano fosse il creatore del mondo







BASTET
La dea originariamente dalla forma di leone era raffigurata come gatta. Divinità protettrice della vita, della felicità e della maturità







IL FARAONE
Era considerato l’incarnazione del dio, sua immagine in terra, dio egli stesso. La sua autorità era indiscussa e illimitata. Con la forza magica che derivava dalla sua natura divina, il faraone assicurava fertilità alla terra, prosperità ai sudditi, forza agli eserciti. È raffigurato con la barba intrecciata, con un copricapo, il bastone ricurvo del pastore, la frusta per mietere il grano.
Il libro dei morti
L’aldilà egizio è pensato a SPECCHIO DELL’ALDIQUA.
Per arrivarci sono ritenute necessarie tre condizioni:
• Una vita morale corretta
• La conservazione del corpo
• L’esito favorevole del processo tenuto dal dio dell’oltretomba
Osiride soppesa il cuore dei morti: su un piatto della bilancia pone il cuore, sull’altro una piuma (simbolo di giustizia e verità).
Se il cuore non si è appesantito con atti malvagi, il piatto della bilancia rimane in pareggio e l’oltretomba è assicurato. Il temuto processo finale, però, può essere pilotato con preghiere e formule magiche (da recitare in vita e portare con sé da morti, nel sarcofago).
Ne presentiamo un brano agli alunni che può essere fotocopiato per svolgere un’attività.
Discorso sulla soglia dal Libro dei morti:
Sia lode a te, grande dio, signore delle due verità. Sono giunto a te, mio Signore, per contemplare la tua bellezza […] Giungo a te, e reco la verità, e scaccio i peccati. Non ho commesso peccati contro gli uomini. Non ho fatto nulla di ciò che gli dei aborriscono. Non ho parlato male di alcuno presso i miei superiori. Non ho fatto patire la fame. Non ho fatto piangere. Non ho ammazzato. Non ho dato ordine di ammazzare. Non ho causato pena ad alcuno. Non ho ridotto gli alimenti ai templi. Non ho diminuito il pane agli dei. Non ho rubato le vivande dei glorificati. Non ho commesso nulla di turpe nella pura sede del mio dio patrio. Non ho ridotto la misura del grano. Non ho ridotto la misura del braccio. Non ho falsificato la misura del terreno. Non ho appesantito i pesi sulla bilancia. Non ho rubato il latte dalla bocca del bambino. Non ho derubato il gregge del suo pascolo. Non ho catturato gli uccelli degli dei. Non ho pescato i pesci dei loro mari. Non ho ostacolato l’acqua dell’inondazione nella sua stagione. Non ho opposto dighe all’acqua corrente. Non ho arrecato danno agli armenti che appartengono al patrimonio dei templi. Non ho ostacolato gli dei ne i loro introiti […] Sia lode a voi, o dei. Vi conosco e conosco i vostri nomi. Non cado dinanzi alla vostra spada. Voi non riferite a questo dio (Osiride), al cui seguito siete, nulla di male al mio riguardo; non avete da occuparvi di me.
A conclusione della preghiera, tutta incentrata sulla vita morale, facciamo notare agli alunni che essa inizia con una lode cui seguono, immediatamente due dichiarazioni di innocenza nei confronti degli uomini e degli dei.
Facciamo sottolineare con tre colori diversi i tre momenti della preghiera.
Inoltre facciamo loro elencare alcuni reati che è possibile desumere dal brano (esempio: reati contro il Nilo...).
Nelle terre bagnate dal MAR EGEO, ebbe origine una tra le più famose e importanti civiltà antiche: quella ELLENICA o GRECA. I Greci credevano in moltissimi dei, che rappresentavano i vari elementi dell’universo e i fenomeni della natura. Avevano forme umane, ma potevano trasformarsi in pioggia, acqua o qualsiasi animale.
Essi amavano, odiavano, mangiavano, bevevano e dormivano, esattamente come gli uomini, ma erano belli ed eternamente giovani.
Eppure il loro potere non era illimitato, infatti esisteva una volontà superiore a quella degli dei, il Fato, cioè il destino di fronte al quale si piegava anche il volere di ZEUS, PADRE E RE DI TUTTI GLI DEI.
L’abitazione delle divinità era il TEMPIO che sorgeva sull’acropoli, la parte più alta della città. In origine era in legno, poi fu costruito in marmo e in pietra.
L’antica struttura tuttavia rimase: le colonne che sostenevano il tetto ricordavano i tronchi degli alberi.
All’interno del tempio, in una stanza chiamata NAOS (cella) era collocata la statua della divinità. Questa grande scultura era realizzata con materiali preziosi e solo ai sacerdoti era consentito di apparire al suo cospetto.
I riti collettivi invece si svolgevano all’aperto presso l’altare per i sacrifici.
L’esterno del tempio era decorato da rilievi e

da sculture, a volte dipinte con colori vivaci.
I rilievi ornavano sia il frontone (elemento triangolare posto a coronamento della facciata di un edificio), sia il fregio (motivo pittorico decorativo posto, in genere, sopra l’architrave).
I Greci credevano esistesse un REGNO SOTTERRANEO DEI MORTI , chiamato ADE, in cui le ombre dei defunti vegetavano e rimpiangevano di non vivere più sulla terra. Le anime dei morti venivano trasportate da CARONTE, un vecchio dagli occhi fiammeggianti, su una nave che le conduceva all’altra riva.
Oltrepassato il fiume, i morti percorrevano un lungo viale ed arrivavano ad una grandissima porta sorvegliata da Cerbero, un mostruoso cane a tre teste. Dietro la porta c’erano tre aree dove risiedevano i morti:
• la Prateria degli Asfodeli, dove finivano coloro che nella vita terrena non erano stati né buoni né cattivi
• il Tartaro destinato a chi nella vita si era macchiato di colpe verso gli dei e gli uomini;
• i Campi Elisi riservati agli eletti dove essi vivevano dilettati tra musiche, danze e banchetti.

Quando i Romani erano ancora un piccolo popolo, la loro religione consisteva nel culto di divinità protettrici del benessere familiare e sociale. Le divinità romane primitive erano i MANI, i LARI e i PENATI. La loro devozione fu intensa e duratura.
• I Mani erano gli spiriti dei morti e ad essi venivano dedicate feste, chiamate parentalia, in cui ogni famiglia onorava la tomba degli antenati con fiori e cibi, per ottenere protezione.
• I Lari proteggevano i territori abitati. Essi venivano onorati in apposite nicchie (larari), addossate ai muri esterni delle case o ai confini delle proprietà.
• I Penati proteggevano il benessere familiare e in modo particolare le provviste di cibo.
Le loro statuette dovevano essere custodite in una nicchia presso il focolare domestico con accanto una fiammella sempre accesa e venivano trasmesse in eredità. Solo più tardi con la conquista di altri paesi, i romani adottarono anche le divinità di questi popoli. L’influenza etrusca e greca arricchì il pantheon romano di divinità con caratteristiche specifiche. ZEUS-GIOVE divenne il sommo tra gli dei.
Tutti gli altri dei dell’Olimpo furono accolti e venerati. Mentre il CAPO FAMIGLIA presiedeva le cerimonie domestiche, presso gli altari che ciascuna abitazione possedeva, i riti pubblici erano celebrati dai SACERDOTI che erano divisi in gruppi o collegi a seconda dei compiti.
• I più importanti erano i pontefici, con a capo il pontefice Massimo.
Essi istruivano il popolo circa il tempo e il modo con cui celebrare gli atti di culto e furono gli ideatori del calendario.
• I flamini si occupavano del culto di singole divinità: di Giove, Marte e Quirino.
• Gli àuguri, attraverso l’esame e l’interpretazione di alcuni fenomeni naturali, avevano il compito di comprendere quale fosse la volontà degli dei.
• Infine gli aruspici cercavano di interpretare la volontà degli dei dalle viscere di animali appena uccisi.
Anche i Romani credevano nella vita dopo la morte (INFERI).
La loro idea dell’aldilà non si differenziava dall’Ade. Si temeva che i morti potessero ritornare sulla terra e si cercava di propiziarseli con un sacrificio offerto nove giorni dopo la sepoltura; inoltre, in determinate festività si compivano riti particolari per convincere i morti a lasciare in pace i vivi.
Gli Inferi erano divisi in:
• Campi Lugentes, per coloro che erano morti giovani
• Tartaro, per i malvagi
• Campi Elisi per i giusti Attraverso gli scritti greci e romani pervenuti fino a noi possiamo conoscere il nome che era stato dato alle divinità, il simbolo che le rappresentava e le principali funzioni, cioè le cose o le persone sulle quali esercitavano il loro potere.
Attraverso la seguente tabella l’insegnante guiderà gli alunni a memorizzare e confrontare, in un solo colpo d’occhio, il mondo degli dei.
Nome greco
Nome romano
ZEUS GIOVE
ERA GIUNONE
FEBO APOLLO APOLLO
PALLADE ATENA MINERVA
ARES MARTE
AFRODITE VENERE
Simbolo Principali funzioni
Fulmine
Corno dell’abbondanza
Sole
Civetta
Lancia
Conchiglia
ERMES MERCURIO Calzari alati
EFESTO VULCANO
ESTIA VESTA
DEMETRA CERERE
POSEIDONE NETTUNO
ARTEMIDE DIANA
Capo degli dei, dio del cielo e del tuono.
Moglie di Zeus, dea della terra e protettrice dei matrimoni.
Dio della luce, della poesia.
Dea della giusta guerra e della sapienza.
Dio della guerra violenta.
Dea dell’amore e della bellezza.
Messaggero degli dei, protettore del gregge.
Martello Dio del fuoco.
Torcia Dea del focolare domestico.
Falce
Tridente
Cervo
ADE PLUTONE Cane a tre teste
Dea della fecondità e dell’agricoltura.
Dio del mare e protettore dei marinai.
Dea della caccia.
Dio degli inferi.
Nel Cantico delle Creature l’invito alla lode passa dai corpi celesti incorruttibili (sole, luna e stelle) ai quattro elementi del mondo sublunare (aria, acqua, fuoco e terra), ognuno dei quali “porta un significato” del suo Creatore e svolge un compito particolare nei confronti delle creature “sorelle”, come appare anche dalla strofa di “sorella Acqua”: «Laudato si, mi Signore, per sor Acqua, la quale è multo utile et humile et preziosa et casta» (vv. 15-16). La grande utilità dell’acqua sta nel fatto che essa è indispensabile per la sopravvivenza degli esseri viventi, ma frate Francesco mette in evidenza diversi aspetti: è umile, sempre disposta ad abbassarsi, come il Figlio di Dio che si è umiliato in mezzo a noi; è preziosa e casta, che Cristo Signore ha usato per il segno del Battesimo, nel quale la grazia dello Spirito Santo scende ad arricchire e purificare le persone dei credenti. Questo annuncio del Cantico dà risalto a tutti gli elementi del creato che concorrono ad illuminare le creature viventi. Questo è un messaggio profetico e straordinariamente attuale per il nostro tempo: per poter salvare questa terra che è la sua casa, l’uomo deve passare dalla logica dello sfruttamento e del consumo sfrenato, all’etica del rispetto, del servizio, addirittura dell’«obbedienza» amorosa a quel progetto di vita che Dio ha inscritto sul volto e nel cuore della sua creazione.
“Laudato si, mi Signore”, cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: “Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba”.
L’acqua potabile e pulita rappresenta una questione di primaria importanza, perché è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici. Le fonti di acqua dolce riforniscono i settori sanitari, agropastorali e industriali. La disponibilità di acqua è rimasta relativamente costante per lungo tempo, ma ora in molti luoghi la domanda supera l’offerta sostenibile, con gravi conseguenze a breve e lungo termine.
Grandi città, dipendenti da importanti riserve idriche, soffrono periodi di carenza della risorsa, che nei momenti critici non viene amministrata sempre con una adeguata gestione e con imparzialità. La povertà di acqua pubblica si ha specialmente in Africa, dove grandi settori della popolazione non accedono all’acqua potabile sicura,
o subiscono siccità che rendono difficile la produzione di cibo. In alcuni Paesi ci sono regioni con abbondanza di acqua, mentre altre patiscono una grave carenza. Un problema particolarmente serio è quello della qualità dell’acqua disponibile per i poveri, che provoca molte morti ogni giorno.
Fra i poveri sono frequenti le malattie legate all’acqua, incluse quelle causate da microorganismi e da sostanze chimiche. La dissenteria e il colera, dovuti a servizi igienici e riserve di acqua inadeguati, sono un fattore significativo di sofferenza e di mortalità infantile.
Le falde acquifere in molti luoghi sono minacciate dall’inquinamento che producono alcune attività estrattive, agricole e industriali, soprattutto in Paesi dove mancano una regolamentazione e dei controlli sufficienti. Non pensiamo solamente ai rifiuti delle fabbriche. I detergenti e i prodotti chimici che la popolazione utilizza in molti luoghi del mondo continuano a riversarsi in fiumi, laghi e mari.
Mentre la qualità dell’acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato.
In realtà, l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani.
Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non hanno accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita radicato nella loro inalienabile dignità.
Questo debito si salda in parte con maggiori contributi economici per fornire acqua pulita e servizi di depurazione tra le popolazioni più povere. Però si riscontra uno spreco di acqua non solo nei Paesi sviluppati, ma anche in quelli in via di sviluppo che possiedono grandi riserve. Ciò evidenzia che il problema dell’acqua è in parte una questione educativa e culturale, perché non vi è consapevolezza della gravità di tali comportamenti in un contesto di grande iniquità.
Una maggiore scarsità di acqua provocherà l’aumento del costo degli alimenti e di vari prodotti che dipendono dal suo uso. Alcuni studi hanno segnalato il rischio di subire un’acuta scarsità di acqua entro pochi decenni se non si agisce con urgenza.
Gli impatti ambientali potrebbero colpire miliardi di persone, e d’altra parte è prevedibile che il controllo dell’acqua da parte di grandi imprese mondiali si trasformi in una delle principali fonti di conflitto di questo secolo.
La ziggurat
La ziggurat è un argomento storico affascinante che si presta ad una varietà di idee per lavorare in classe. Suggeriamo la realizzazione di un modello di ziggurat per migliorare le abilità manuali.
Nella parte anteriore delle scatole creare con le forbici dei piccoli ingressi.
Pitturare le scatole con la tempera marrone.
Una volta asciugata la tempera sistemare le scatole con un po’ di vinavil una sull’altra, per formare i vari livelli della ziggurat.
Piegare fittamente delle strisce di cartoncino per formare le scale e poi incollarle nella parte più alta della ziggurat a destra e a sinistra.
Disegnare i personaggi, ritagliarli e metterli al loro posto sulla ziggurat. 1 3 5 2 4
• Quattro scatole di varia grandezza
• Cartoncino marrone chiaro
• Cartoncino bianco
• Colori
• Vinavil
• Forbici
• Tempera marrone chiaro

OCCORRENTE
• Un righello • Cartoncino giallo • Colla • Matita • Forbici

1
Su un cartoncino colorato disegna una griglia con 9 quadrati da 8x8cm.


4
3
2

Segna il punto a metà dei 4 quadrati centrali, come in foto.
Ritaglia la figura che hai disegnato.

7
Traccia quella che sarà la struttura della piramide, come da illustrazione.
Ricorda di lasciare le striscioline al lato di ogni triangolo: sono i punti in cui andrà messa la colla.
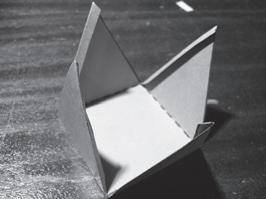
5
Piega tutte le linee tracciate.

Metti la colla nelle striscioline che fungono da giuntura tra i vari lati della piramide. 6
Unisci tutte le facce della piramide tramite le striscioline con la colla, facendo attenzione che aderiscano bene. Ecco completata la tua piramide!
Tra i fiumi Tigri ed Eufrate, tanto tempo fa, sono nate grandi civiltà.
Sumeri, Assiri, Babilonesi, regnarono per anni in questi paesi.
Oltre alla scrittura, grande invenzione, idearono anche la prima legislazione. Famose per le loro costruzioni erano quelle popolazioni: le torri alte e i giardini di Babilonia resteranno sempre nella memoria.
Esse adoravano tanti dei, circa mille e sei, poco gentili e superbi, trattavano gli uomini come servi.
Nel tempio, in cima alla città, si pensava abitassero le divinità.
Tra tutte quante la più potente era Marduk, il combattente.
Una volta l’anno, il legittimo sovrano, la sua statua prendeva per mano, un gesto davvero importante, poiché era il suo rappresentante.
Tra riti e preghiere, musiche e canti, i sacerdoti andavano avanti, per ricordare nella processione, quanto fosse importante la devozione.
Ed ora che queste cose vi abbiamo narrato, sappiate che il tutto andrà poi studiato…
C. Bugiolacchi – A. Del Monte
Sul monte Olimpo, in Grecia si sa, vivevano tante divinità.
Dei e dee assai capricciose, abitavano in regge molto lussuose. Sempre belli ed immortali avevano dei poteri speciali.
Di nettare e ambrosia si nutrivano e con una tunica si vestivano.
Di tutti Zeus era il capo, anche lui sottomesso al fato. Insieme a Ade e Poseidone del mondo era il padrone.
Per dimostrare la sua potenza i fulmini scagliava con irruenza. Quando in terra era chiamato sostava in un tempio a lui dedicato.
In suo onore giochi e gare ogni quattr’anni si dovevan fare.
I vincitori d’alloro adornati nell’ultimo giorno venivan premiati. Con una statua la loro gloria rimaneva sempre nella memoria.
C. Bugiolacchi – A. Del Monte
Fin dall’antichità tutti i popoli, anche se molto lontani e diversi tra loro, hanno sperimentato sentimenti a volte di paura e altre volte di ammirazione verso forze misteriose, ritenute “superiori” e in grado di decidere il destino degli uomini. Queste forze furono considerate divinità e assunsero nomi diversi presso i vari popoli, anche se spesso le loro caratteristiche erano molto simili.
Illustra o incolla nel riquadro vuoto l’immagine di un luogo sacro legato alle antiche religioni.
Metti con una linea nella tomba insieme al corpo solo gli oggetti che gli sono appartenuti. Spiega il perché della tua scelta.
Ritaglia ogni gradone della ziggurat e incolla in ordine crescente lasciando all’ultimo piano il tempio vero e proprio, dimora terrena della divinità protettrice della città.
Colora e ritaglia le immagini.
Costruisci il pop-up della battaglia di Marduk contro Tiamat sul tuo quaderno.
Incolla il drago, mentre il carro scorre su un binario (taglio sulla pagina) a cui è attaccato con un anello di carta.
Crea lo sfondo cielo dove avvenne la battaglia.
Colora e ritaglia le immagini; costruisci il pop-up sul quaderno come nel modello mostrato dall’insegnante. Crea lo sfondo a piacere e scrivi una didascalia riassuntiva.
Colora e ritaglia le immagini.
Costruisci il popup sul quaderno come mostrato dall’insegnante.
Colora e ritaglia le immagini.
Costruisci il popup sul quaderno come mostrato dall’insegnante.
Scrivi al posto giusto i nomi delle principali parti di un tempio greco.
BASAMENTO - COLONNA - ARCHITRAVE - CELLA/NAOS - RAMPA D'ACCESSO
PORTICO - TIMPANO - FRONTONE - VESTIBOLO - FREGIO
Colora la scena, scrivi poi sotto quanto ricordi della vicenda di questi personaggi.
Colora la scena, scrivi poi sotto quanto ricordi della vicenda di questi personaggi.
Ogni cosa ha una sua storia; anche le religioni hanno radici lontane. La religione è nata con l’uomo. Gli uomini delle antiche civiltà (della Mesopotamia, dell’Egitto, della Grecia, di Roma, …) erano politeisti, cioè adoravano tanti dèi.
Collega con una freccia i luoghi di culto alla frase corrispondente.
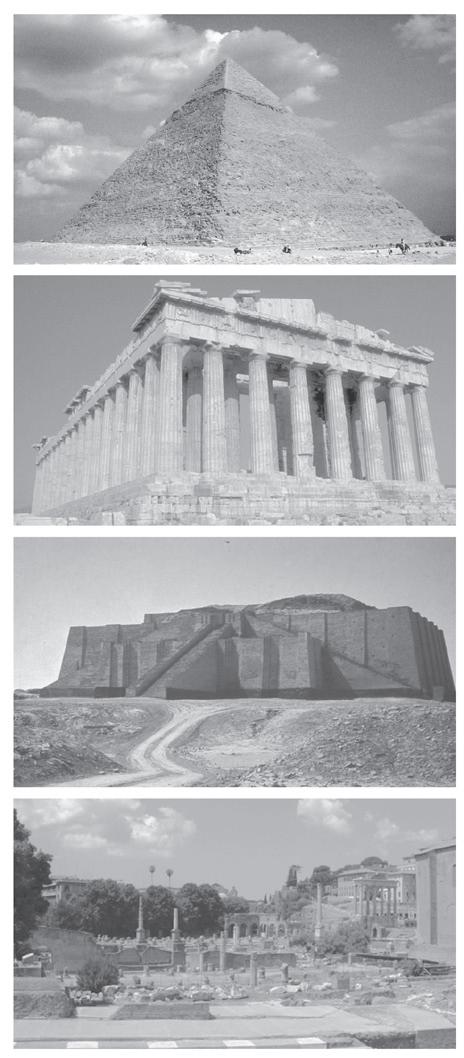
I Romani adoravano dèi simili a quelli dei Greci; il più importante tra essi era Giove.
Gli antichi Egizi adoravano tanti dèi, il più importante era Rha, il dio del Sole.
Il dio supremo degli antichi Greci era Zeus, che abitava sul monte Olimpo.
Gli abitanti della Mesopotamia (Sumeri, Assiri, Babilonesi) credevano in tante divinità; Marduk era il loro dio supremo.
Secondo la mitologia greca, gli dèi avevano sede sul monte Olimpo ed erano protettori delle attività umane. Molte fra le divinità greche vennero in seguito accoIte presso i romani, anche se con nomi diversi.
Osserva i disegni e collega ogni divinità al rispettivo ruolo.
Nome greco: ATENA
Nome romano: MINERVA
Nome greco: ERMETE
Nome romano: MERCURIO
Nome greco: ERA
Nome romano: GIUNONE
Nome greco: AFRODITE
Nome romano: VENERE
dea della sapienza dea della caccia dio del mare dio della guerra padre degli dèi madre degli dèi dio del commercio dea della bellezza dea dell’agricoltura
Nome greco: DEMETRE
Nome romano: CERERE
Nome greco: ZEUS
Nome romano: GIOVE
Nome greco: POSEIDONE
Nome romano: NETTUNO
Nome greco: ARTEMIDE
Nome romano: DIANA
Nome greco: ARES Nome romano: MARTE
L’alunno…
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale della nostra cultura;
• conosce le caratteristiche principali dell’ambiente in cui è vissuto Gesù.

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
Gli ebrei nella storia
• La storia degli ebrei.
• Da Abramo a Mosè, i principali fatti ed eventi del popolo ebraico.
Da pag. 19 a pag. 25 La Bibbia e le altre fonti
• Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli.
I valori etici e religiosi
• Riflettere e individuare nella dimensione religiosa il bisogno di senso che accompagna da sempre l’umanità.
Dal politeismo delle prime civiltà, nate nella zona cosiddetta della “MEZZALUNA FERTILE”, gli alunni approfondiranno la storia del popolo ebraico, cioè la prima grande RELIGIONE MONOTEISTA, nata sempre in questo vasto territorio e conosciuta già in classe terza, e che troverà il suo pieno compimento (per i cristiani) nella rivelazione definitiva di Dio attraverso la figura di Gesù di Nazaret.
L’insegnante riproporrà le figure dei patriarchi degli ebrei al solo scopo di approfondire i significati delle loro storie e del loro intervento in relazione alla Storia della Salvezza. Partendo da Abramo, Isacco e Giacobbe, passando per
Giuseppe e fino a Mosè, verrà sottolineato come l’intervento di Dio sia stato fondamentale per la nascita del popolo ebraico.
Proprio le vicende di Mosè narrate nell’Antico Testamento, e approfondite attraverso un’opera d’arte, faranno da ponte al Nuovo Testamento e alla conoscenza e approfondimento della storia di Gesù.
LA RELIGIONE EBRAICA
L’ebraismo è la religione del popolo ebraico. Secondo la legge ebraica, chiunque sia figlio di madre ebrea è considerato ebreo, anche se non è religioso.
L’ebraismo è la più antica delle religioni monoteiste (cioè che venerano un solo Dio). Nacque circa 3.500 anni fa in Palestina, nella regione che oggi corrisponde più o meno allo stato di Israele. Oggi nel mondo ci sono circa 18 milioni di ebrei, che vivono soprattutto negli Stati Uniti, in Europa e in Israele. Esistono molti gruppi differenti di ebrei, con modi diversi di praticare la fede. I gruppi principali sono gli ebrei ortodossi, i riformati e i conservatori.

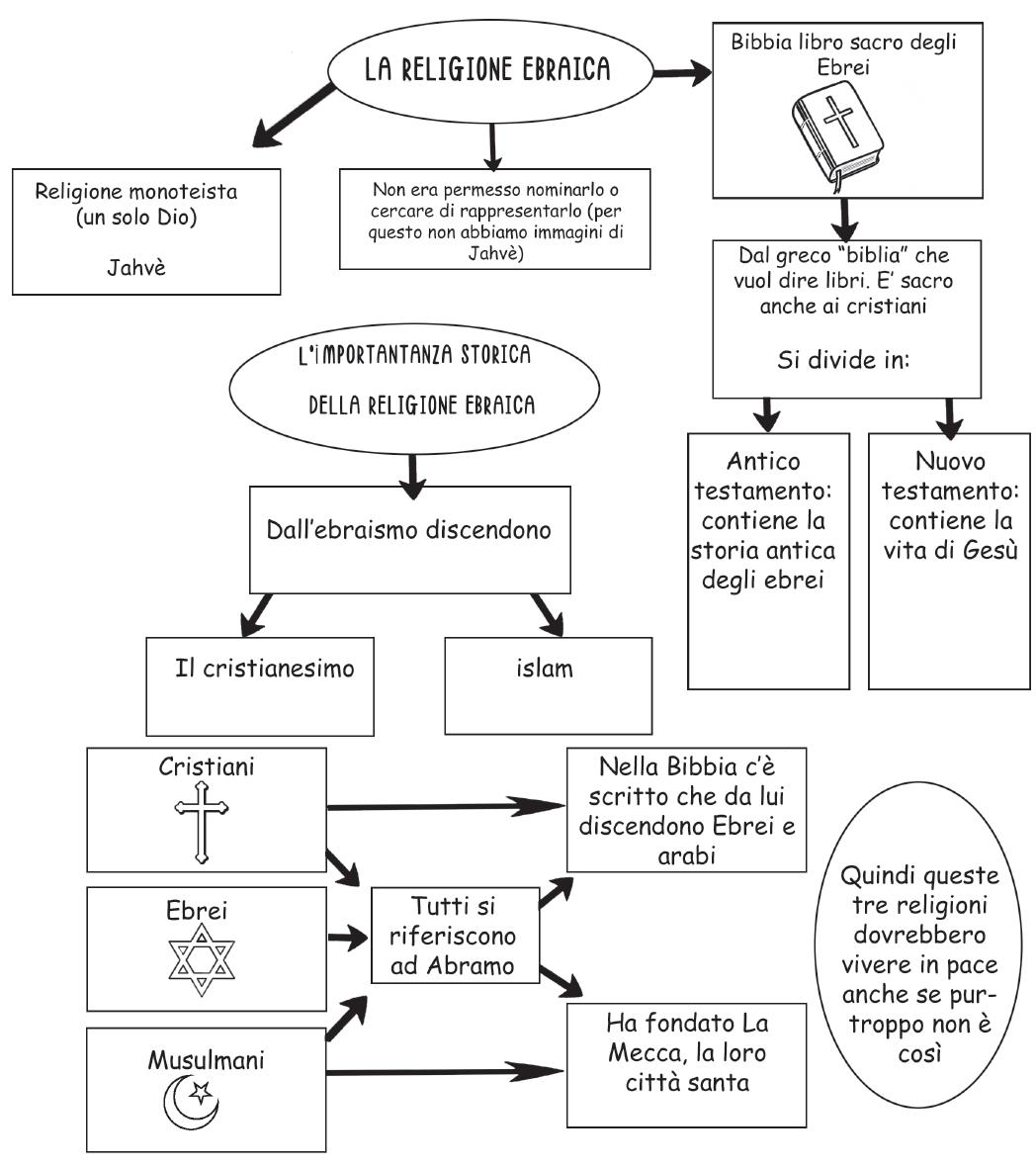
Un'attesa di liberazione
In questo percorso l’insegnante affronterà il delicato argomento della SCHIAVITÙ ripercorrendo la storia degli EBREI IN EGITTO e della loro liberazione. Nelle pagine di approfondimento si faranno dei confronti con la storia moderna e contemporanea.
La liberazione del popolo Ebraico dalla schiavitù in Egitto è l’evento principale raccontato nel Libro dell’Esodo (Antico Testamento).
Gli Ebrei vissero in Egitto per 430 anni, da Giuseppe a Mosè. Il Libro dell’Esodo narra che il faraone Ramses II, vedendo che gli Ebrei erano diventati molto numerosi e potenti, impose loro dei sovrintendenti per farli lavorare forzatamente nella costruzione di due città-deposito: PITOM E RAMSES.

«Ecco che il popolo dei figli d’Israele è più numeroso e più forte di noi. Prendiamo provvedimenti nei suoi riguardi per impedire che aumenti, altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese» (Esodo 1, 8-22).
Queste parole sembrano anticipare le persecuzioni che il popolo ebreo subì nella sua storia, anche in tempi più recenti.

Dichiarazione universale dei diritti umani
Il 10 dicembre 1948 l’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE ha proclamato la Dichiarazione universale dei diritti umani. Con questo documento si proclama che TUTTE LE PERSONE DEL MONDO, senza alcuna distinzione, HANNO DEI DIRITTI PER LA SOLA RAGIONE DI ESISTERE
L’Organizzazione delle Nazioni Unite, spesso abbreviata in NAZIONI UNITE oppure in ONU, è una organizzazione intergovernativa a carattere internazionale.
L’organizzazione è nata il 24 ottobre 1945 con l’entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite, vi aderiscono 193 Stati del mondo su un totale di 205.
L’articolo 1 e 2 dello Statuto delle Nazioni Unite riassumono gli SCOPI E i PRINCIPI che questa organizzazione internazionale si è prefissata:
1. mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
2. promuovere la soluzione delle controversie internazionali e risolvere pacificamente le situazioni che potrebbero portare a una rottura della pace;
3. sviluppare le relazioni amichevoli tra le nazioni sulla base del rispetto del principio di uguaglianza tra gli Stati e l’autodeterminazione dei popoli;
4. promuovere la cooperazione economica e sociale;
5. promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali a vantaggio di tutti gli individui;
6. promuovere il disarmo e la disciplina degli armamenti ;
7. promuovere il rispetto per il diritto internazionale e incoraggiarne lo sviluppo progressivo e la sua codificazione.

La schiavitù parte dall’idea che un essere umano possa avere dei diritti, possedere e decidere sul destino di un altro essere umano. Purtroppo ancora oggi esiste questa forma di dominio e prevaricazione, nonostante nel 1956 l’ONU abbia promulgato una seconda convenzione che condanna definitivamente lo schiavismo e tutte le pratiche simili allo schiavismo: i bambini prigionieri di guerra, il lavoro coatto, la vendita delle donne ed anche forme molto più sottili e diffuse in tutto il mondo come l’usura, il prestito su pegno e la speculazione del traffico delle persone che vogliono scappare dalla loro patria.
PRATICHE
DONNE CHE NON RICEVONO UN’ADEGUATA DIFESA
DEI LORO DIRITTI in molti paesi del mondo. Inoltre, in molte aree di conflitto armato (guerra tra stati oppure molto spesso guerra civile tra fazioni dello stesso paese) i prigionieri vengono considerati e venduti come schiavi. Purtroppo, in molti paesi che hanno un’economia sviluppata e che non soffrono per la guerra lo sfruttamento del lavoro minorile è ugualmente praticato senza scrupoli: questo è il dramma umanitario e sociale del nostro tempo che minaccia la crescita e la formazione di una buona parte delle future generazioni.

A partire dai dati raccolti da numerose ORGANIZZAZIONI UMANITARIE, si calcola che a tutt’oggi 21 milioni di persone nel mondo vivono una situazione di schiavitù.

Mosè salvato dalle acque
Introduciamo questo importante personaggio biblico a partire dal suo nome e dalla sua vicenda personale: il nome Mosè (dall’ebraico: salvato dalle acque) indica il suo ritrovamento nelle acque del Nilo.
Vediamo con gli alunni alcune rappresentazioni artistiche di Mosè: dalla scultura di Michelangelo a questo dipinto del Tintoretto.

Mosè salvato dalle acque, dipinto di Jacopo Robusti detto il Tintoretto (olio su tela, 1555), Museo del Prado di Madrid.
Mentre in Egitto il faraone aveva legiferato la morte di tutti i maschi Ebrei, che altrimenti sarebbero diventati più numerosi di loro, nasceva Mosè. La madre cercando di salvarlo lo mise nelle acque del Nilo in una cesta.
La figlia del faraone lo trovò e lo crebbe come un figlio, chiamandolo Mosè (come già anticipato sopra: salvato dalle acque. In seguito, divenuto adulto, Dio gli rivela chi è veramente e gli annuncia che lui dovrà salvare il suo popolo dalla schiavitù.
Mosè farà attraversare agli Ebrei il Mar Rosso in modo da fuggire dall’Egitto, alla ricerca della “terra promessa”.
Possiamo approfondire la narrazione biblica della storia di Mosè, illustrando le varie fasi della sua vita e le sue imprese ispirate da Dio e realizzate per liberare il suo popolo dalla schiavitù.
Il popolo degli israeliti (o ebrei = il popolo scelto da Dio) in quel tempo si trovava in Egitto. Gli israeliti erano molto numerosi e stavano diventando anche potenti, tanto che gli egiziani cominciarono a temerli. Salì al trono un faraone molto crudele che decise di far schiavi tutti gli ebrei e metterli ai lavori forzati, inoltre mandò i suoi soldati a uccidere tutti i neonati maschi degli ebrei.
In una famiglia ebrea un giorno nacque un bel bambino, la sua mamma per salvarlo dai soldati del faraone lo mise in una cesta e la depose sul fiume Nilo. Proprio lì vicino faceva il bagno la figlia del faraone con le sue serve, vedendo il bambino ne ebbe compassione e decise di tenerlo come se fosse suo figlio. Il bambino venne chiamato MOSÈ che significa “salvato dalle acque”.
Mosè crebbe sano e felice e divenne una persona importante fra gli egiziani. Crescendo scoprì le sue vere origini e un giorno vedendo come venivano trattati male i suoi fratelli ebrei si arrabbiò così tanto che uccise un soldato del faraone. La sua vita era in pericolo e fu costretto a fuggire nel deserto.
Un giorno Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, un sacerdote di Madian che lo aveva accolto nella sua famiglia, e condusse il bestiame vicino a un monte chiamato Sinai. Qui gli apparve l’angelo del Signore in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma non si consumava. Mosè si avvicinò per vedere meglio e Dio lo chiamò: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. Ora va’! Io ti mando dal faraone, fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e per far uscire dall’Egitto gli Israeliti? Non mi crederanno!». Dio rispose: «Non temere, io sarò con te!» Mosè si fidò di Dio e insieme a suo fratello Aronne si recò dal faraone per chie-
dergli di liberare il loro popolo.
Il faraone ovviamente non ne voleva sapere e cacciò via Mosè. Allora Dio fece accadere delle cose terribili (chiamate le 10 piaghe): prima le acque del fiume Nilo si trasformarono in sangue, poi ci fu un’invasione di rane, poi di mosche e zanzare e infine di cavallette.
Visto che il faraone ancora non cedeva Dio fece calare il buio su tutto l’Egitto per 3 giorni. Il faraone ancora non liberava gli schiavi così Dio scatenò l’ultima piaga, la peggiore di tutte: durante la notte passò per le strade dell’Egitto l’angelo della morte e tutti i figli primogeniti degli egiziani morirono, compreso il figlio del faraone. Furono risparmiati i figli degli ebrei perché Dio aveva raccomandato loro di segnare gli stipiti delle loro porte con del sangue di agnello. Il faraone scosso dal dolore finalmente lasciò libero il popolo israelita. Mosè allora guidò il popolo fuori dall’Egitto seguendo le indicazioni che gli dava il Signore.
Il faraone però non si era ancora arreso e con i suoi soldati partì all’inseguimento degli ebrei.
A un certo punto questi si trovarono di fronte al Mar Rosso mentre dietro di loro stavano i soldati egiziani, allora Mosè alzo le braccia ed ecco che improvvisamente le acque del mare si divisero così che gli ebrei poterono camminare in mezzo senza nemmeno bagnarsi.
Quando furono passati tutti Dio fece chiudere le acque così i soldati del faraone ne rimasero sommersi e annegarono.
Gli ebrei vagarono per 40 anni nel deserto prima di raggiungere la terra a loro promessa da Dio. Divennero sempre più comuni litigi, lotte e questioni di ogni genere, inoltre in molti persero la fiducia in Dio e cominciarono ad adorare altri idoli.
Allora Mosè salì sul monte Sinai e chiese aiuto a Dio.
Come risposta Dio gli disse di scrivere su due tavole di pietra queste leggi: sono i 10 COMANDAMENTI che il popolo doveva seguire per vivere da figli e fratelli e conservare l’amicizia con Dio: IO SONO IL SIGNORE TUO DIO, CHE TI HA FATTO USCIRE DALLA SCHIAVITÙ IN EGITTO.
1. NON AVRAI ALTRI DÈI DAVANTI A ME.
2. NON USERAI IL NOME DI DIO INVANO.
3. RICORDATI DEL GIORNO DI SABATO PER SANTIFICARLO.
4. ONORERAI TUO PADRE E TUA MADRE.
5. NON UCCIDERAI.
6. NON COMMETTERAI ADULTERIO.
7. NON RUBERAI.
8. NON FARAI FALSA TESTIMONIANZA CONTRO IL TUO PROSSIMO.
9. NON DESIDERERAI LA CASA DEL TUO PROSSIMO
10. NON DESIDERERAI LA MOGLIE DEL TUO PROSSIMO, NÉ COSA ALCUNA CHE SIA
DEL TUO PROSSIMO.
C’era una volta un’anziana signora che passava in pia preghiera molte ore della giornata. Un giorno sentì la voce di Dio che le diceva: “Oggi verrò a farti visita”.
Figuratevi la gioia e l’orgoglio della vecchietta. Cominciò a pulire e a lucidare, a impastare e a infornare dolci. Poi indossò il vestito più bello e si mise ad aspettare l’arrivo di Dio. Dopo un po’, qualcuno bussò alla porta. La vecchietta corse ad aprire. Ma era solo la vicina di casa che le chiedeva in prestito un pizzico di sale.
La vecchietta la spinse via: “Per amor di Dio, vattene subito, non ho proprio tempo per queste stupidaggini! Sto aspettando Dio, nella mia casa! Via via!” e sbatté la porta in faccia alla mortificata vicina. Qualche tempo dopo, bussarono di nuovo. La vecchietta si guardò allo specchio, si rassettò e corse ad aprire. Ma chi c’era? Un ragazzo infagottato in una giacca troppo larga, che vendeva bottoni e saponette da quattro soldi. La vecchietta sbottò: “Io sto aspettando il buon Dio. Non ho proprio tempo. Torna un’altra volta!”.
E chiuse la porta sul naso del povero ragazzo. Poco dopo bussarono nuovamente alla porta. La vecchietta aprì e si trovò davanti un vecchio cencioso. “Un pezzo di pane, gentile signora, anche raffermo … e se potesse lasciarmi riposare un momento qui sugli scalini della sua casa” implorò il povero. “Ah, no! Lasciatemi
in pace! Io sto aspettando Dio! E stia lontano dai miei scalini!” disse la vecchietta stizzita. Il povero se ne partì zoppicando e la vecchietta si dispose di nuovo ad aspettare Dio. La giornata passò, ora dopo ora.
Venne la sera e Dio non si era fatto vedere. La vecchietta era profondamente delusa. Alla fine si decise ad andare a letto. Stranamente si addormentò subito e cominciò a sognare. Le apparve in sogno il buon Dio che le disse: “Oggi, per tre volte sono venuto a visitarti e per tre volte non mi hai ricevuto!”.
(Bruno Ferrero, Altre Storie, Elledici-Leumann, Torino
L'arca dell'alleanza
Era una cassa di legno d’acacia rivestita d’oro, a forma di parallelepipedo con un coperchio d’oro zecchino sovrastato da due cherubini anch’essi d’oro. Ai lati c’erano due sostegni di legno per trasportarla. Nella cassa erano contenute le ”Tavole della legge”. Quando l’Arca fu trasportata a Gerusalemme era ricoperta da un telo di pelle di tasso con un aggiuntivo telo color turchino. Quando i portatori si fermavano la cassa veniva posta sotto una tenda chiamata: “Tenda del Signore”.

Dopo Mosè
Narra ancora la Bibbia che Giosuè, dopo la morte di Mosè, divenne il capo delle 12 tribù di Ebrei che giunsero in Palestina dopo essere rimasti 40 anni nel deserto. Giosuè morì all’età di 110 anni dopo aver chiesto al popolo ebraico di rimanere fedele a Dio. Da quel momento iniziò il periodo dei Giudici. Questi furono capi militari o responsabili amministrativi e legislativi ispirati da Dio che governarono le tribù, fino all’elezione del primo re d’Israele: Saul.
Costruiamo un Tamburello
Praticare, con il punteruolo, 4-5 buchi in torno al piatto distanziati regolarmente.
Sempre con il punteruolo, bucare nel centro i tappi a corona ed inserirli a due a due in pezzi di spago da infilare e legare nei buchi del piatto.
Disegnare e ritagliare sulla carta colorata delle forme e poi incollarle sul tamburello come decorazioni.
Muovendo il piatto, i tappi produrranno il suono.
Il popolo della promessa
Ad un certo punto nell’antichità vi fu un popolo con una novità.
Mentre tutti quanti adoravano tanti dei un solo Dio pregavano gli ebrei.
Il primo a seguirlo fu Abramo, un pastore col bastone in mano.
Un giorno fu da Dio chiamato mentre ammirava il cielo stellato.
Dio gli donò il figlio tanto atteso e Abramo di questo fu sorpreso.
Dopo un po’ di tempo chiamò Mosè attraverso il roveto più strano che c’è.
OCCORRENTE
• piatti di cartone o di plastica
• tappi a corona
• spago da cucina
• carta colorata
• colla vinilica
• punteruolo
• forbice
• matita
Gli disse: «Il mio popolo devi andare a liberare così il faraone non lo potrà più sfruttare».
Il faraone dal cuore indurito di Mosè non ascoltò l’invito.
Allora Mosè disse al faraone: «Degli ebrei non sei tu il padrone».
Quando finalmente il popolo partì del Mar Rosso Dio le acque aprì.
In quarant’anni di cammino Dio restò loro sempre vicino.
Ormai giunti a destinazione Dio rese grande la loro nazione.
A tutto il popolo promise che sarebbe nato un grande re.
La sua promessa si realizzò quando suo Figlio al mondo mostrò.
C. Bugiolacchi – A. Del Monte
Questa canzone ispirata al salmo 121, attribuito al re Davide, offre l’occasione per parlare di Gerusalemme e del suo Tempio santo. Gerusalemme era considerata dagli Ebrei come il centro dell’unità religiosa e del governo civile. Dopo la distruzione compiuta nel 586 a.C., dall’esercito babilonese, la città viene ricostruita dagli esuli rimpatriati e dai loro discendenti. Essa è vista quale luogo di pace, gioia e vanto d’Israele. Ecco la canzone.
Rit. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è ricostruita come città salda e compatta. Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, secondo la Legge di Israele, per lodare il nome del Signore.
(Rit.)
Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. (Rit.)
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: Su di te sia pace! Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene.
(Rit.)

Osserva e descrivi l’immagine: di cosa si tratta? Poi colora.
RISOLVI IL CRUCIVERBA
Oggetto sacro per gli ebrei.
L’Arca è una…
Legno utilizzato per costruire l’Arca.
Materiale prezioso che riveste l’Arca.
Decorano il coperchio.
Lo è quella del Convegno.
Nell’Arca sono in dieci.
Il padrone del bastone dentro l’Arca.
Casa di pietra per l’Arca.
L’arca è considerata una…
Osserva e descrivi le immagini, ricordando il più possibile quanto hai appreso dell’Arca dell’Alleanza e della parte centrale del Tempio.
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riconosce nel Vangelo la fonte storico-religiosa privilegiata per la conoscenza di Gesù;
• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali dei suoi insegnamenti alle tradizioni dell’ambiente in cui vive;
• riconosce e sa spiegare il significato cristiano del Natale traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
Gesù, il Cristo
• I profeti annunciano la nascita di Gesù.
• La nascita di Gesù raccontata nei Vangeli.
• Il Natale cristiano.
• Gesù nelle fonti non cristiane.
• Gesù nelle fonti cristiane: i Vangeli.
• Segni e simboli dei quattro evangelisti.
• I Vangeli sinottici.
• La terra di Gesù: la Palestina (aspetti storici, geografici, sociali e religiosi).
• Il valore della Pace.
La vita pubblica di Gesù:
• il battesimo
• le parabole
• i miracoli
• gli incontri
• le Beatitudini
Da pag. 26 a pag. 90
Dio e l’uomo
• Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.
La Bibbia e le altre fonti
• Leggere direttamente pagine bibliche, saper riferire circa alcuni brani in particolare gli episodi chiave dei racconti evangelici.
Il linguaggio religioso
• Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.
• Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.
I valori etici e religiosi
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.
In questa unità l’insegnante guiderà gli alunni alla SCOPERTA DEI VANGELI, da come sono stati pensati e poi nati, dalla lingua e lo stile utilizzato, dai mittenti ai destinatari, fino alla loro diffusione.
Nelle classi precedenti è già stato già affrontato il tema del Natale e quindi gli alunni ne conoscono il valore religioso e anche gli aspetti più esteriori.
In questo percorso, attraverso i brani del NUOVO TESTAMENTO e le immagini artistiche, lo scopo sarà far riflettere gli alunni sul SIGNIFICATO VERO DEL NATALE , che spesso contrasta con quanto viene proposto dai media e dall’ambiente circostante, ormai completamente pervasi dal consumismo.
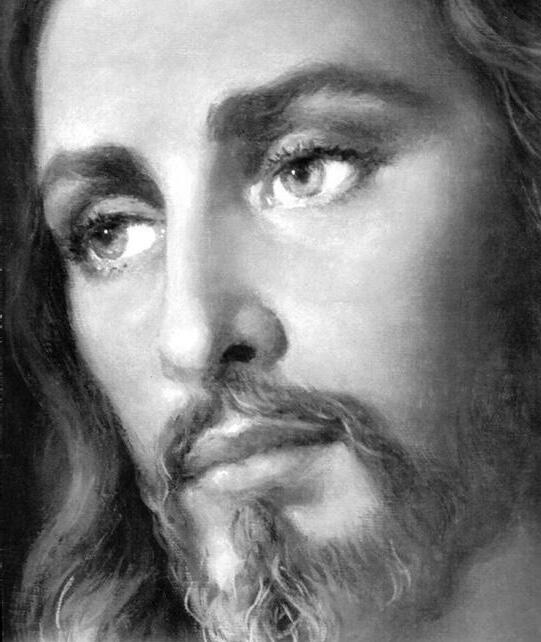
Dalla narrazione della nascita di Gesù, emergerà in primo luogo che egli è un personaggio storico la cui esistenza è documentata non solo nei Vangeli canonici, ma anche nei testi e negli scritti non cristiani. Verrà approfondita la situazione sociale, storica, geografica, politica e religiosa della Palestina al tempo di Gesù, premessa necessaria alla scoperta della sua persona, con una riflessione sull’attuale situazione in Terra Santa, dove sono presenti oggi le tre grandi religioni monoteiste, e all’esemplificazione di alcune iniziative che mirano a costruire la pace in una zona in cui tante divisioni e violenze sono ancora presenti. La rivelazione, preparata nell’ANTICO TESTAMENTO attraverso la storia del popolo d’Israele ora si compie nell’incarnazione del Verbo, in cui Dio comunica sé stesso e il suo progetto di salvezza per gli uomini. Per i cristiani, il Gesù narrato nei Vangeli, è il compimento delle promesse messianiche preparate nell’Antico Testamento, è l’incarnazione del Verbo, in cui Dio comunica sé stesso, è quel Dio che cammina con gli uomini.
Le STRADE DELLA PALESTINA faranno da sfondo a questa grande storia, cioè l’incontro tra l’uomo e Dio per mezzo di Gesù Cristo. In questo scenario avvengono i racconti (le parabole), i gesti straordinari (i miracoli), gli incontri con i peccatori (Zaccheo e la Samaritana) e gli annunci del Regno di Dio (le Beatitudini).
Proponiamo un racconto che affronta la tematica del Natale. Questa festa dell’amore e della semplicità si è trasformata nella celebrazione del consumismo. I negozi e gli spot pubblicitari invitano all’acquisto di oggetti lussuosi, giocattoli, pacchetti viaggio...
I protagonisti del racconto ritrovano il vero significato del Natale che è anche una festa da vivere in famiglia, recuperando ed esaltando tutti quei valori che ad essa sono collegati.
Facciamo riflettere gli alunni su questo aspetto, attraverso la lettura del brano che segue anche attraverso la scheda operativa n. X dal titolo Noi.
C’era, qualche anno fa, un bambino che...
Attenzione, questa non è una fiaba. Alcuni anni fa c’era un bambino di nome Peter: aveva sei anni ed era un torrente di vivacità e di fantasia. Desiderava da tanto un certo giocattolo e se lo aspettava come dono di Natale. Ma proprio quell’anno, per varie spiacevoli circostanze, non avrebbe potuto averlo. Mamma e papà erano dispiaciutissimi, ma non potevano farci niente.
Lo dissero a Peter e lui, che era un ragazzino intelligente, capì e non fece storie. «Un alberello però possiamo preparartelo.» disse la mamma.
E il papà aggiunse: «Useremo le decorazioni dello scorso anno, lo faremo bello. Vedrai, Peter, vedrai...» «E come, se non sono rimasti che pochi nastri argentati e una grossa stella d’oro?» sospirò la mamma. Ma il papà non era tipo da buttarsi giù per tanto poco. «Aggiungeremo qualcosa che possa servire da mettere sotto i denti e risolveremo nel migliore dei modi. Disporremo tanti cioccolatini e caramelle, eh?»
L’alberello venne su in un momento: era piccolo e miserello, però dai suoi rami pendevano innumerevoli fili sottili con cioccolatini, canditi, persino chicchi di pop-corn. E così appariva davvero bello, perlomeno insolito, non vi pare? Tanto che Peter, appena lo vide, batté le mani, contento, ed esclamò: «È meraviglioso! Nessuno ha un albero di Natale come il mio!» «Però è un albero triste, perché non offre alcun dono...» ricordò la mamma. Peter non disse nulla, ma era evidente che ci soffriva.
«Una cosa possiamo sempre farla...» propose il babbo (evidentemente era un uomo ottimista e pieno di iniziativa). «Giacché siamo stati capaci di realizzare un alberello natalizio unico al mondo, possiamo fare un’altra cosa unica al mondo. Noi... ecco, Peter, noi vedremo i nostri doni. Ma sì, lasciatemi spiegare! Disegneremo i regali che vorremmo scambiarci tra noi. Che ne dite?» «Mi sembra una cosa divertente, papà. Ci sto!» rispose Peter.
Nei giorni seguenti, la casa fu totalmente ingombra di giornali, carte lucenti, barattoli di colla, gomitoli di fili colorati...; E un gran lavorare di matite e di forbici. La mattina di Natale, l’albero di Peter era un capolavoro di bizzarria. Che cosa c’era, che cosa c’era tra ramo e ramo?
C’era una grandissima macchina nera, un aeroplano azzurro, un motoscafo rosso per il babbo; un vestito blu, una pelliccia di castoro, un braccialetto rilucente di brillanti per la mamma...; Per Peter, poi, ecco lì, a portata di occhi, i giocattoli più belli e moderni che si potessero sognare. Solo che il tutto era ritagliato dalle riviste oppure disegnato da Peter e dal suo papà. «Strano...» diceva il ragazzino, sorridendo «È quasi come se tutte queste cose fossero vere e proprio nostre. Sapete, nemmeno li desidero più, i doni di Natale!»
E sembrava davvero contentissimo: bastava guardare i suoi occhi: gli occhi non sanno mentire. Tuttavia, i genitori credevano che Peter fingesse per far contenti loro e avevano il cuore stretto stretto.
Peter, invece, era felice davvero. Soprattutto perché aveva in serbo un suo dono segreto e non vedeva l’ora di esporlo. E adesso era il momento adatto. «Eccolo!» gridò il ragazzo, mostrando un foglio gigante. «Ecco il mio regalo natalizio, signori genitori! Un regalo per voi e per me!» e lo teneva sbandierato, a braccia larghe, con l’ansia di vedere l’effetto sulle facce stupite di mamma e papà.
Era un disegno eseguito a regola d’arte e con splendidi colori: il meglio che si potesse sperare da una mano di un bimbo, anche se bravissimo in disegno. Era un quadretto assolutamente meraviglioso. Soprattutto per il significato. Tre persone sorridenti, strettamente allacciate, quasi a formare un’unica persona.
E sotto il disegno Peter aveva scritto una sola parola: noi.
AA.VV., Tante storie di Natale, Mondadori
RIFLETTIAMO
• Che cosa era accaduto nella famiglia di Peter?
• Quale soluzione propone suo padre?
• Come reagisce il bambino?
• Quale regalo natalizio prepara per i suoi genitori?
• È più importante l’amore di una famiglia o la bellezza di un regalo?
• Quali sono i vostri desideri più grandi per questo Natale?
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato!
Ah! Quanto ti costò l’avermi amato.
Ah! Quanto ti costò l’avermi amato.
A te, che sei del mondo il Creatore, mancano i panni e il fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà più mi innamora, giacché ti fece amor povero ancora. Giacché ti fece amor povero ancora.
Tu lasci del tuo Padre il divin seno, per venire a tremar su questo fieno; per venire a tremar su questo fieno. Caro eletto del mio petto, dove amor ti trasporto!
O Gesù mio, perché tanto patir, per amor mio…
Questo antichissimo brano è stato scritto più di trecento anni fa da un santo napoletano, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, nato a Marianella di Napoli nel 1696 e morto nel 1787.
Spieghiamo ai bambini che egli era un uomo buono e un prete saggio che divenne Vescovo. Aveva studiato molto bene le grandi verità della fede e le trasmetteva agli altri con tanto amore. Egli seppe usare anche la musica per insegnare il catechismo in modo efficace e divertente. Aveva capito che, quando si canta, le parole giungono nella mente e soprattutto arrivano dirette al cuore. Egli ha scritto parole bellissime per raccontare di Gesù e le faceva cantare a tutti, piccoli e grandi.
L’arcivescovo di Milano, Dionigi Tettamanzi, in una lettera indirizzata ai bambini della sua città, ha voluto condividere con loro l’incanto del Natale e comprenderne una parte dei suoi più profondi significati, partendo proprio dal canto Tu scendi dalle stelle.
Per la sua straordinaria profondità, riportiamo alcuni passaggi salienti di questa riflessione che potranno essere utilizzati dall’insegnante per aiutare gli alunni a cogliere il messaggio della canzone.
Nella lettera egli racconta di alcune esperienze e incontri personali: parla di un grande uomo d’affari molto famoso, che non riesce a trattenere le lacrime quando arriva alle parole: Ah! Quanto ti costò l’avermi amato. L’uomo disse all’arcivescovo che non riusciva proprio a capire come mai il Re del cielo, che poteva comandare tutto da lassù, aveva scelto di farsi così piccolo e povero. Quell’uomo, secondo Tettamanzi, è arrivato a comprendere il punto più importante: l’amore di Gesù Bambino ci innamora con la sua povertà.
Egli continua affermando che non è una cosa normale che ciò accada nel nostro mondo così attratto da ricchezze e comodità. Infatti, QUELLO CHE HA FATTO GESÙ NON È NORMALE: È DIVINO! In questo modo DIO HA SCELTO DI AMARCI TUTTI, senza differenze.
Gesù è la manifestazione del vero Amore, è l’apparire tra noi di Dio-Amore.
Ed è l’amore che lo fece povero ancora.
La riflessione continua soffermandosi sulle parole Il Re del cielo è sceso dalle stelle, è venuto qui a tremar, al freddo e al gelo senza panni e fuoco che esprimono una cosa bellissima anche se un po’ difficile da capire: LA VERA FELICITÀ È
Dio Padre, infatti, donando all’umanità Gesù povero, capace di amare senza ricchezze, ha fatto il regalo più prezioso e importante.
Gesù è diventato un bambino e gli uomini possono conoscerlo proprio perché è venuto ad abitare in mezzo a noi. Da quel giorno essi sanno cosa serve per essere felici e per donare l’amore: il sorriso, le parole buone, l’affetto del cuore, i gesti di bene, le preghiere, la fiducia verso gli altri... insomma ciò che caratterizza ogni bambino. Il cardinale prosegue affermando che anche oggi Gesù Bambino continua a tremare. Lo fa attraverso il corpo e l’anima sofferente di tantissime persone denutrite, senza acqua, malate, sole, tristi, oppresse, in fuga, offese,
umiliate, dimenticate. Egli invita a riconoscere la presenza di Gesù nei poveri di oggi. È questo il modo per incontrarlo di persona, senza doversi accontentare di contemplare la statuina del presepe. Tutti i bambini possono trasformarsi in asini e buoi di quel presepe che sono oggi le nostre città, i paesi dove si vive, la nostra nazione e il mondo intero, anzitutto informandosi bene sulle miserie e sulle ingiustizie, di cui sono vittime tantissime persone e, in modo particolare, molti bambini e poi cercando di non lasciare sole le persone che soffrono. Se smettessimo infatti di rivolgere loro il nostro affetto e il nostro pensiero, sarebbe come se l’asino e il bue smettessero di soffiare su Gesù Bambino.
Negli auguri conclusivi della lettera egli svela una formula preziosa anche per gli adulti che consentirà a chi la mette in pratica di essere felice.
È la FORMULA DELLE CINQUE
Eccole:
• Ridurre le cose che si comprano, badando solo a quelle davvero essenziali.
• Riciclare gli oggetti finché si possono usare (vestiti e giochi di un fratello o di un cugino più grande…) e ciò che può essere rigenerato (attraverso, ad esempio, la raccolta differenziata dei rifiuti).
• Riparare gli oggetti anziché buttarli al primo danno.
• Rispettare, trattare bene le cose, gli ambienti e soprattutto le persone che li hanno realizzati con il loro lavoro.
• Regalare con gioia e generosità qualcosa dei nostri risparmi a chi ora è nel bisogno.
Con Papa Francesco
Per cogliere il vero senso del Natale cristiano leggiamo ai bambini questa breve omelia di PAPA FRANCESCO
Nel suo primo Natale da Papa, egli ha richiamato tutti a vivere l’essenzialità del Vangelo e ha ricordato che i primi a ricevere l’annuncio sono stati proprio i pastori perché erano tra gli ultimi, gli emarginati.
In questa celebrazione ha voluto introdurre una novità: ha portato lui stesso la statua di Gesù Bambino nella mangiatoia e alla fine è stato accompagnato da una decina di bambini di tutti i continenti, portando il Bambinello in processione fino al presepe in fondo alla basilica di San Pietro.
«Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce.» (Is 9,1)
Questa profezia di Isaia non finisce mai di commuoverci, specialmente quando la ascoltiamo nella Liturgia della notte di Natale. E non è solo un fatto emotivo, sentimentale; ci commuove perché dice la realtà profonda di ciò che siamo: siamo popolo in cammino, e intorno a noi – e anche dentro di noi – ci sono tenebre e luce. E in questa notte, mentre lo spirito delle tenebre avvolge il mondo, si rinnova l’avvenimento che sempre ci stupisce e ci sorprende: il popolo in cammino vede una grande luce. Una luce che ci fa riflettere su questo mistero: mistero del camminare e del vedere. Camminare. Questo verbo ci fa pensare al corso della storia, a quel lungo cammino che è la storia della salvezza, a cominciare da Abramo, nostro padre nella fede, che il Signore chiamò un giorno a partire, ad uscire dal suo paese per andare verso la terra che Lui gli avrebbe indicato. Da allora, la nostra identità di credenti è quella di gente pellegrina verso la terra promessa. Questa storia è sempre accompagnata dal Signore! Egli è sempre fedele al suo patto e alle sue promesse.
«Dio è luce, e in lui non c’è tenebra alcuna» (1Gv 1,5). Da parte del popolo, invece, si alternano momenti di luce e di tenebra, fedeltà e infedeltà, obbedienza e ribellione; momenti di popolo pellegrino e di popolo errante.
Anche nella nostra storia personale si alternano momenti luminosi e oscuri, luci e ombre. Se amiamo Dio e i fratelli, camminiamo nella luce, ma se il nostro cuore si chiude, se prevalgono in noi l’orgoglio, la menzogna, la ricerca del proprio interesse, allora scendono le tenebre dentro di noi e intorno a noi.
«Chi odia suo fratello – scrive l’apostolo Giovanni – è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi» (1Gv 2,11).
In questa notte, come un fascio di luce chiarissima, risuona l’annuncio dell’Apostolo: «È apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini» (Tt 2,11). La grazia che è apparsa nel mondo è Gesù, nato dalla Vergine Maria, vero uomo e vero Dio. Egli è venuto nella nostra storia, ha condiviso il nostro cammino. È venuto per liberarci dalle tenebre e donarci la luce. In Lui è apparsa la grazia, la misericordia, la tenerezza del Padre: Gesù è l’Amore fattosi carne. Non è soltanto un maestro di sapienza, non è un ideale a cui tendiamo e dal quale sappiamo di essere inesorabilmente lontani, è il senso della vita e della storia che ha posto la sua tenda in mezzo a noi.
I pastori sono stati i primi a vedere questa tenda, a ricevere l’annuncio della nascita di Gesù. Sono stati i primi perché erano tra gli ultimi, gli emarginati. E sono stati i primi perché vegliavano nella notte, facendo la guardia al loro gregge.
Con loro ci fermiamo davanti al Bambino, ci fermiamo in silenzio.
Con loro ringraziamo il Signore di averci donato Gesù, e con loro lasciamo salire dal profondo del cuore la lode della sua fedeltà: Ti benediciamo, Signore Dio Altissimo, che ti sei abbassato per noi. Tu sei immenso, e ti sei fatto piccolo; sei ricco, e ti sei fatto povero; sei l’onnipotente, e ti sei fatto debole.
In questa Notte condividiamo la gioia del Vangelo: Dio ci ama, ci ama tanto che ha donato il suo Figlio come nostro fratello, come luce nelle nostre tenebre.
Il Signore ci ripete: «Non temete» (Lc 2,10).
E anch’io vi ripeto: Non temete! Il nostro Padre è paziente, ci ama, ci dona Gesù per guidarci nel cammino verso la terra promessa. Egli è la luce che rischiara le tenebre. Egli è la nostra pace. Amen.
Molti artisti hanno cercato di far rivivere l’ATMOSFERA DEL NATALE, tra questi Giotto con l’affresco della natività di Gesù, databile dal 1303 al 1305 e conservato nella Cappella degli Scrovegni a Padova.
Osserviamo l’immagine e focalizziamo l’attenzione su alcuni particolari.
Al centro della scena la nostra attenzione è catturata da MARIA, sdraiata sotto una tettoia di legno che accenna al rifugio di fortuna in cui lei e Giuseppe si sono dovuti riparare.
La Madonna è raffigurata nell’atto in cui sta deponendo il piccolo Gesù nella mangiatoia, avvolto in fasce aiutata da una levatrice, personaggio presente nei Vangeli apocrifi, da cui Giotto trasse ispirazione. Il manto di Maria, un tempo azzurro, è andato in larga parte perduto, scoprendo la stesura sottostante della veste rossa.
Il bue fissa intensamente l’evento e vigila accanto al teso asinello. In primo piano, un po’ distante, GIUSEPPE sta accovacciato, con mesti occhi socchiusi, non avendo
potuto trovare un luogo più accogliente per la nascita del Figlio di Dio. Il suo stare in disparte sottolinea anche, come è tipico dell’iconografia, il suo ruolo non attivo nella procreazione.
A destra di Giuseppe troviamo un gruppo di PECORE, strette strette l’una accanto all’altra mentre dormono, ma una veglia teneramente sul proprio agnellino. Vicino a loro in piedi, ci sono due PASTORI che, voltati di spalle e ritratti con indumenti quotidiani, le calzature e le bisacce, guardano verso il cielo: lì è apparsa una schiera di angeli che volano e rivolgono gesti di preghiera al fanciullo nato da poco e a Dio che è nei cieli. Tra questi, ce né uno che si china verso i pastori per dare loro il lieto annuncio.
Un PAESAGGIO ROCCIOSO E MONTAGNOSO fa da sfondo alla scena della natività.

Nella sua opera L’INFANZIA DI GESÙ, Benedetto XVI cerca di interpretare ciò che Matteo e Luca raccontano all’inizio dei loro Vangeli. Nel CAPITOLO TERZO, il papa emerito offre un quadro storico e teologico della narrazione della nascita di Gesù. La lettura di queste riflessioni può offrire all’insegnante ulteriori spunti per affrontare con gli alunni la storicità di Gesù di Nazaret e la problematicità della data e del luogo della sua nascita.
“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra” (Lc 2,1).
Con queste parole Luca introduce il suo racconto sulla nascita di Gesù e spiega perché essa è avvenuta a Betlemme: un censimento con lo scopo di determinare e poi riscuotere le imposte è la ragione per cui Giuseppe con Maria, sua sposa, che è incinta, vanno da Nazaret a Betlemme. La nascita di Gesù nella città di Davide si colloca nel quadro della grande storia universale, anche se l’imperatore non sa nulla del fatto che questa gente semplice, a causa sua, è in viaggio in un momento difficile e così, apparentemente per caso, il bambino Gesù nascerà nel luogo della promessa.
Per Luca il CONTESTO STORICO-UNIVERSALE è importante. Per la prima volta viene registrata tutta la terra, l’ecumene nel suo insieme. Per la prima volta esiste un governo e un regno che abbraccia l’orbe. Per la prima volta esiste una grande area pacificata, in cui i beni di tutti possono essere registrati e messi al servizio della comunità.
Solo in questo momento, in cui esiste una comunione di diritti e di beni su larga scala e una lingua universale permette ad una comunità culturale l’intesa nel pensiero e nell’agire, un messaggio universale di salvezza, un universale portatore di salvezza può entrare nel mondo: è, difatti, la pienezza dei tempi.
[…] Siamo nuovamente giunti al fatto della registrazione di tutti gli abitanti del regno, che collega la nascita di Gesù di Nazaret con l’IMPERATORE AUGUSTO. Su questa riscossione delle imposte (il censimento) esiste un’ampia disputa tra i dotti, nei cui particolari non dobbiamo qui entrare.
Un primo problema è ancora abbastanza facile da chiarire: il censimento avven-
ne ai tempi del re Erode il Grande che, però, morì già nell’anno 4 a.C. L’inizio del nostro computo del tempo – la determinazione della nascita di Gesù – risale al monaco Dionigi il Piccolo (morto ca. nel 550), che nei suoi calcoli evidentemente sbagliò di alcuni anni. La data storica della nascita di Gesù è quindi da fissare qualche anno prima.
Grandi controversie sono causate da altre due date. Secondo Giuseppe Flavio, a cui soprattutto dobbiamo le nostre conoscenze della storia giudaica ai tempi di Gesù, il censimento avvenne nell’anno 6 D.C., sotto il GOVERNATORE QUIRINIO e –poiché, in ultima analisi, si trattava di denaro – portò all’insurrezione di Giuda il Galileo. Inoltre, Quirinio sarebbe stato attivo nell’ambiente siriaco-giudaico solo in quel periodo e non prima.
Questi fatti, però, per parte loro, sono di nuovo incerti; in ogni caso, esistono indizi secondo cui Quirinio, su incarico dell’imperatore, già all’incirca nell’anno 9 a.C. operava in Siria. Così sono certamente convincenti le indicazioni di diversi studiosi, secondo le quali il censimento nelle circostanze di allora si svolgeva in modo stentato e si protraeva per alcuni anni. Del resto, esso si realizzava in due tappe: innanzitutto nella registrazione dell’intera proprietà terriera ed immobiliare e poi – come secondo momento – nella determinazione delle imposte da pagare di fatto.
La prima tappa avvenne quindi al tempo della nascita di Gesù; la seconda, che per il popolo era più urtante, suscitò l’insurrezione.
Infine, è stato anche obiettato che per un tale rilevamento non sarebbe stato necessario un viaggio di ciascuno nella propria città (Lc 2,3). Sappiamo però, da diverse fonti, che gli interessati dovevano presentarsi là dove avevano proprietà terriere. Possiamo supporre che Giuseppe della casa di Davide disponesse di una proprietà terriera a Betlemme così che, per la riscossione delle imposte, doveva recarsi lì.
[…] Torniamo al grande contesto del MOMENTO
DI GESÙ. Con il riferimento all’imperatore Augusto e all’intera ecumene Luca ha creato consapevolmente un quadro insieme storico e teologico per gli avvenimenti da raccontare.
Gesù è nato in un’epoca determinabile con precisione.
All’inizio dell’attività pubblica di Gesù, Luca offre ancora una volta una datazione dettagliata ed accurata di quel momento storico: è il quindicesimo anno dell’im-
pero di Tiberio Cesare; vengono inoltre menzionati il governatore romano di quell’anno e i tetrarchi della Galilea, dell’Iturea e della Traconitide, come anche dell’Abilene, e poi i capi dei sacerdoti (Lc 3,1 s.).
Gesù non è nato e comparso in pubblico nell’imprecisato una volta del mito. Egli appartiene ad un tempo esattamente databile e ad un ambiente geografico esattamente indicato: l’universale e il concreto si toccano a vicenda.
In Lui, il LOGOS, la RAGIONE CREATRICE DI TUTTE LE COSE , è entrato nel mondo. Il Logos eterno si è fatto uomo, e di questo fa parte il contesto di luogo e tempo.
[…] È importante ancora un altro elemento. Il decreto di Augusto per la registrazione fiscale di tutti i cittadini dell’ecumene porta Giuseppe, insieme con la sua sposa Maria, a Betlemme, nella città di Davide, e serve così all’adempimento della promessa del PROFETA MICHEA, secondo cui il Pastore d’Israele sarebbe nato in quella città.
[…] Autorevoli rappresentanti dell’esegesi moderna sono dell’opinione che la notizia dei due evangelisti Matteo e Luca, secondo cui Gesù nacque a Betlemme, sarebbe un’affermazione teologica, non storica. In realtà, Gesù sarebbe nato a Nazaret. Con le narrazioni della nascita di Gesù a Betlemme, la storia sarebbe stata teologicamente rielaborata secondo le promesse, per poter così – in base al luogo della nascita – indicare Gesù come l’atteso Pastore d’Israele.
Io non vedo come si possano addurre vere fonti a sostegno di tale teoria. Di fatto, sulla nascita di Gesù non abbiamo altre fonti che quelle dei racconti dell’infanzia in Matteo e in Luca. I due dipendono con evidenza da rappresentanti di tradizioni molto diverse. Sono influenzati da visioni teologiche differenti come anche le loro notizie storiche in parte divergono.
A Matteo, chiaramente, non era noto che tanto Giuseppe quanto Maria abitavano inizialmente a Nazaret. Per questo, ritornando dall’Egitto, Giuseppe vuole dapprima andare a Betlemme, e solo la notizia che in Giudea regna un figlio di Erode lo induce a deviare verso la Galilea. Per Luca, invece, è fin dall’inizio chiaro che la Santa Famiglia, dopo gli avvenimenti della nascita, ritor nò a Nazaret. Le due differenti linee di tradizione concordano nella notizia che il luogo della nascita di Gesù era Betlemme.
SE CI ATTENIAMO ALLE FONTI, RIMANE CHIARO CHE GESÙ È NATO A BETLEMME ED È CRESCIUTO A NAZARET.
Il terzo percorso inizia affrontando il tema dei VANGELI e della Buona Notizia. Il Vangelo è Gesù di Nazaret, morto e risorto per la salvezza dell’uomo. Gli autori degli scritti chiamati Vangeli, hanno presentato in quattro forme la Buona Notizia annunciata e proclamata da Gesù. I Vangeli secondo MATTEO, MARCO, LUCA e GIOVANNI rappresentano la documentazione più ampia e più antica su Gesù e i suoi insegnamenti.
MATTEO
È il PRIMO VANGELO NEL CANONE.
Fu uno degli apostoli ed ebbe due nomi: LEVI (Mc 2,1317; Lc 5,27-32) e MATTEO (Mt 9,9; 10,3; Mc 3,18; Lc 6,15; At 1,13), ma dopo la conversione venne preferito il nome Matteo.

Quando Gesù lo invitò a seguirlo svolgeva le mansioni del pubblicano di Cafarnao. Il suo Vangelo, che inizia con la genealogia di Gesù, è stato scritto per comunità di origine ebraica stanziate in Palestina: Matteo si accostò alla vita e all’insegnamento di Gesù con una prospettiva che VEDE NEL CRISTO IL PERFETTO COMPIMENTO DELLA STORIA E DELLE SPERANZE D’ISRAELE .

L’evangelista è talvolta raffigurato con la borsa e la bilancia per ricordare la sua origine di pubblicano e altre volte con la lancia, simbolo del martirio. Nell’iconografia cristiana Matteo è presentato come evangelista assistito dall’angelo che lo ispira mentre scrive.
MARCO
È il PIÙ BREVE DEI VANGELI, ma anche il PIÙ ANTICO.
Fu un collaboratore di Paolo (At 13,5) e cooperò con l’apostolo Pietro, infatti è da lui chiamato: mio figlio (1Pt 5,13).



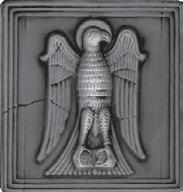
Marco è dunque una FIGURA DI MEDIAZIONE TRA PIETRO (mondo giudaico) E PAOLO (mondo ellenistico). Il suo Vangelo fu scritto per i cristiani non ebrei: perché costoro potessero meglio comprendere l’ambiente di Gesù, fornì loro indicazioni geografiche per una localizzazione dei luoghi, spiegazioni delle usanze e delle tradizioni dei giudei, infine traduzione delle parole aramaiche, cioè della lingua parlata da Gesù. Per Marco Gesù è il

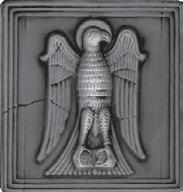

Cristo, il Figlio di Dio, due espressioni che ritroviamo nella proclamazione di fede di Pietro e nell’esclamazione del centurione romano ai piedi della croce. Nell’arte Marco è rappresentato con la tunica e il pallio, mentre scrive il Vangelo. Il suo simbolo è il leone alato, segno della fervente predicazione del Battista nel deserto.
È il VANGELO PIÙ ACCURATO con una preoccupazione di informazione e di ordine (Lc 1,3). Probabilmente fu un medico, collaborò con Paolo e lo seguì nei suoi viaggi.



Scrisse anche gli Atti degli Apostoli. Dai suoi scritti appare come un UOMO DOTATO DI UNA NOTEVOLE CULTURA e di una eccellente padronanza della lingua greca. Il destinatario del terzo Vangelo è Teofilo, nome greco che simboleggia la Chiesa proveniente dai pagani. IL GESÙ DI LUCA È UN MESSIA MISERICORDIOSO CHE PREDILIGE I BAMBINI, I POVERI, LE DONNE
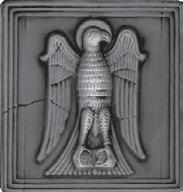
E I PECCATORI PENTITI. Una leggenda lo propone come il pittore che ha realizzato il primo ritratto della Madre di Gesù. I suoi simboli sono il libro e il bue, a lui abbinati perché il suo Vangelo comincia con il sacrificio di Zaccaria.


È il VANGELO PIÙ RECENTE. Giovanni scrisse inoltre l’Apocalisse e tre Epistole. Fu uno degli apostoli prediletti di Gesù (Mt 17,1), figlio di Zebedeo e fratello di Giacomo il Maggiore. Quando Gesù lo chiamò lui e suo fratello stavano riassettando le reti, erano infatti pescatori (Mt 4,21-22). Alla morte di Gesù ebbe il compito di sostituirlo nei doveri di figlio verso Maria. Morì quasi centenario e pare sia stato l’unico dei discepoli a salvarsi dal martirio. Il suo Vangelo fu rivolto alle comunità cristiane dell’Asia minore ed era animato da una PARTICOLARE ATTENZIONE PER L’OPERA DI GESÙ IN GIUDEA . Per Giovanni Gesù è il Verbo che era fin da principio ed è Colui che dà il potere di diventare figli di Dio. Il santo compare come giovane nelle rappresentazioni dell’Ultima Cena e in quelle della crocifissione, accanto alla Vergine Maria. Il suo simbolo è l’aquila.
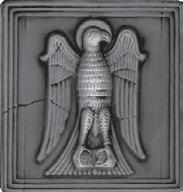
PASTORI
I pastori si distinguevano in proprietari del gregge o garzoni. Essi erano nomadi e vivevano all’aperto sulle colline.
PESCATORI
I pescatori lavorano tutto il giorno con fatica pescando nel lago di Galilea. È un’attività lavorativa che impiegava non solo loro, ma anche chi si dedicava all’essiccazione del pesce, alla vendita, alla riparazione di reti e barche.
CONTADINI
Tutte le mattine aspettavano di essere chiamati al lavoro dei campi. Erano spesso poveri e avevano una famiglia numerosa da mantenere.
PUBBLICANI
Erano gli esattori delle tasse, le riscuotevano per l’autorità romana a cui veniva data la maggior parte del denaro raccolto. La rimanente la tenevano per sé. Per questo erano mal visti dal popolo, oltre che per la collaborazione che avevano con gli stranieri.
ARTIGIANI
Lavoravano nella loro bottega che spesso era anche la loro abitazione. Essi erano ad esempio vasai, falegnami, fabbri, tessitori, panettieri.
POVERI E AMMALATI
Erano ai margini della società, riconosciuti per la loro condizione come castigati da Dio. Vivevano di elemosina.
RICCHI PROPRIETARI
Amministravano le loro ricchezze e davano lavoro ai braccianti che controllavano nell’attività lavorativa.
Per COMPRENDERE GLI INSEGNAMENTI DI GESÙ possiamo leggere alcune parabole: esse ci aiutano a capire i significati più profondi del suo messaggio d’amore. A tale scopo, la seguente tabella aiuterà l’insegnante a mettere a confronto i brani dei vari evangelisti, coglierne uguaglianze e differenze, comprenderne gli intenti morali e religiosi. Le parabole dette da Gesù sono moltissime. Noi ne proponiamo alcune.
Parabole di Gesù Vangelo di Matteo Vangelo di Marco Vangelo di Luca LA LUCERNA SOTTO IL MOGGIO
LA
I
I
L’ULTIMO POSTO ALLA FESTA 14,7-14
LA
Leggiamo agli alunni questa versione moderna della parabola del Buon Samaritano Ci servirà per far meglio comprendere quanto sia ancora attuale l’insegnamento di Gesù. L’autore è Don Tonino Bello (così amava farsi chiamare anche se era vescovo), tanto amato dalle persone semplici e dai ragazzi che andava a incontrare nelle scuole e ai quali raccontava le sue parabole, come quella proposta di seguito.
Ecco: un uomo scendeva da Palestrina a Roma con la sua Cinquecento. Percorreva quel tratto di strada ogni giorno alle otto. Un giorno trovò un incidente: una macchina cappottata. Scese dall’auto e vide un uomo ferito, che perdeva sangue. Fasciò le lacerazioni, ma visto che perdeva ancora molto sangue, lo caricò sulla Cinquecento, lo portò in ospedale e lo salvò.
Due giorni dopo, un altro incidente stradale! Insomma, un giorno sì e uno no, incrociava un incidente, e sempre nello stesso posto.
Allora chiamò il parroco e gli disse: «Riuniamo il consiglio pastorale e quelli della Caritas per comunicare che ogni giorno, sempre alla stessa ora, trovo un incidente su quella strada. Possiamo acquistare un’ambulanza per soccorrere le persone, facciamo una sottoscrizione!» Al consiglio pastorale se ne discusse, finché uno tra i presenti prese la parola e disse: «Voi non mi conoscete perché vivo qui da poco tempo. Sono però un cattolico fervente: il parroco mi ha visto in chiesa e mi ha invitato. Io ho accettato volentieri. Grazie a Dio che mi ha dato una buona fortuna penso di potervi liberare dal peso di una sottoscrizione.»
Tutti applaudirono.
Nel pomeriggio arrivò un’ambulanza nuovissima, fiammante. Quando si dice la carità! Le cose andavano bene perché gli incidenti accadevano sempre nello stesso posto ma bastava una telefonata, arrivava l’ambulanza e via!
Un giorno, l’operaio che per primo aveva effettuato il soccorso, partì prima del solito per il lavoro, arrivò alla famosa curva e... meno male che conosceva bene quella strada, perché si vide avvolto in un nebbione incredibile! Non avendo scorto il muricciolo, andò a sbattere con la sua Cinquecento contro la fiancata del ponte. Di lì intravide una vallata, in fondo alla quale c’erano delle fabbriche le cui ciminiere cacciavano smog: era fumo, non nebbia!
E capì perché accadevano gli incidenti. Aveva trovato la causa! Volle andare a parlare subito col responsabile: scese precipitosamente a valle ma lo bloccarono ai cancelli della fabbrica.
Dopo un’ora riuscì però a colloquiare col responsabile: era il signore che aveva regalato l’ambulanza!
L’operaio gli disse: «Sono contento che sia proprio lei il proprietario, così possiamo subito porre rimedio! Vede, gli incidenti accadevano non perché la strada fosse pericolosa, non per via della nebbia, ma unicamente per il fumo di queste ciminiere. Perciò, se adottiamo i parametri contemplati dalla legge, si può risolvere il problema alla radice.» L’altro rispose: «Io sono in grado di pagare dieci ambulanze, ma qui non si tocca niente!»
I miracoli di Gesù
Il brano seguente offre l’occasione di presentare la figura di MARTA DI BETANIA, e di introdurre anche il discorso sui miracoli di Gesù, in quanto si fa riferimento alla resurrezione di Lazzaro.
Nelle parole che Gesù rivolge a Marta guidiamo gli alunni a cogliere un invito per tutti, sia grandi che piccoli, a trovare nella vita indaffarata di tutti i giorni un momento per riflettere e aprire il proprio cuore a Gesù e al prossimo.
Betania è un piccolo villaggio della Giudea, poco distante da Gerusalemme, arrampicato sulle colline. Marta si è sposata. Abita con il marito e i figli in una casetta bianca nel cuore del villaggio. Davanti al cortile c’è una bellissima pianta di fico e i figli di Marta giocano ad arrampicarsi. Una ragazzina un po’ più grande tiene in braccio l’ultimo nato, ancora in fasce. Marta è indaffarata, ogni tanto controlla la zuppa di legumi che sobbolle sul focolare, e intanto sbriga le faccende di casa. Si muove rapida, sicura, con gesti eleganti e veloci. Non sta ferma un attimo, alacre e sorridente. Ha una casa semplice e accogliente dove tutto è al suo posto, tutto è lindo e in ordine. «Shalom, Marta.» «Shalom, benvenuta. Che cosa posso fare per te?» «Vorrei parlarti, se possibile, farti qualche domanda, ma vedo che hai molto da fare.» «Beh, da fare in una casa ce n’è sempre. Ma posso continuare più tardi.
Vieni, sediamoci a parlare.» Prende una cesta con la lana e, mentre parla, si mette a filare. «Spero che non ti dispiaccia se lavoro, mentre parliamo. Sai, non sono capace di stare con le mani in mano...» mi dice. «Sei proprio una donna eccezionale» «Oh, non credo proprio. Non faccio né più e né meno di quello che fa qualunque altra donna.» “ «Non ne sono convinta. Guardandoti lavorare in casa mi vengono in mente quelle parole dei Proverbi: com’è difficile trovare una donna di carattere: vale molto di più delle perle di corallo. Lavora con grande energia, le sue braccia non sono mai stanche...» «Così mi fai arrossire. Sono solo una donna come tante, che fa del suo meglio per prendersi cura della sua casa e della sua famiglia.» «Oh no, non tutte le donne hanno la stessa dedizione e la capacità di usare bene le mani come te. Ho sentito dire che ti capitava di lamentarti con tua sorella Maria, quando ancora vivevate insieme, perché ti aiutava poco...» «Sai, a Maria piace ascoltare le persone, non vuole mai perdersi una parola di tutto quello che viene detto, così quando c’erano ospiti, invece di aiutarmi a preparare la cena e a servire, lei se ne stava accoccolata ad ascoltare la conversazione.» «E tra i vostri ospiti c’era spesso il maestro Gesù con i suoi discepoli.» «Era di lui che volevi parlare, vero?» «Sì, è così. Sei una donna perspicace.» «Basta saper ascoltare, e tu hai messo nel tono della voce un’enfasi speciale, quando hai detto il suo nome.»
«Vedo che sei un’ascoltatrice attenta, anche se tieni gli occhi e le mani occupate a fare altro.» «Sai, una volta Gesù era da noi, quasi mi sgridò perché io avevo chiesto a mia sorella di aiutarmi: lui sapeva bene che io non mi perdevo una parola anche se ero affaccendata, mentre Maria, che era poco più che una ragazzina, non ci sarebbe riuscita. Allora mi ha detto: Marta, Marta, tu ti affanni e ti preoccupi di troppe cose! Una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore e nessuno gliela porterà via.»
«Ti è dispiaciuto molto che ti rimproverasse davanti a tutti?»
«In realtà non mi ha rimproverato: le sue parole erano piene di amicizia e di affetto. Ma ha approfittato di quel piccolo episodio domestico per impartire un insegnamento più grande a chi era presente.» «Vale a dire?»
«In quel modo Gesù insegnò che non solo gli uomini, ma anche le donne hanno il diritto di ascoltare e riflettere e partecipare a una conversazione pubblica. Sai, lui non trattava le donne come esseri inferiori, ma si intratteneva a parlare con loro e teneva in gran conto i loro pensieri e le loro opinioni.» «Tu lo conoscevi bene?» «Gesù era molto amico di mio fratello Lazzaro, tutti noi lo amavamo e gli
volevamo bene, quando arrivava a casa nostra era una festa. Con Maria aveva un rapporto speciale: quando lui arrivava, lei gli si sedeva vicino e non perdeva una parola.» «Era così affascinante starlo a sentire?» «Non ho mai sentito nessuno parlare come lui. Usava parole semplici per spiegare la Torah, faceva esempi tratti dalla vita di tutti i giorni per insegnare che cosa è giusto e che cosa è sbagliato agli occhi del Signore.» «Dicono che, oltre a parlare, facesse molti miracoli..» «Penso che abbia fatto più miracoli lui dei profeti Elia ed Eliseo messi insieme. Il Santo, sia egli benedetto, lo aveva mandato per trasformare i nostri cuori, così lui usava i segni, oltre alle parole, perché le persone credessero e cambiassero vita.» «Ho sentito dire che proprio con tuo fratello Lazzaro abbia compiuto uno dei suoi miracoli più straordinari: tuo fratello si era ammalato e voi avevate mandato a chiamare Gesù, che però giunse troppo tardi, dopo che Lazzaro era già stato seppellito da quattro giorni, ma quando Gesù arrivò e vide piangere te e Maria si commosse e pregò per Lazzaro, che uscì dalla tomba e ricominciò a muoversi e a stare bene come se non fosse successo nulla...» «Sono in molti a raccontare questa storia, ciascuno con particolari diversi. Alcuni dicono che non fosse mai morto, che era solo malato e che sarebbe guarito comunque, altri che era morto da una o due settimane... Per quel che mi riguarda, ho deciso di serbare nel mio cuore quello che ho visto accadere e non parlarne affatto: sono già venuti in tanti, in troppi a interrogarmi e a farmi domande su queste cose, ma fin da subito ho capito che ciascuno crede soltanto a quello a cui vuole credere. Così preferisco tacere.» «E tu in che cosa credi?» «Credo che Gesù fosse il Messia che stavamo aspettando.»
Da: L’ora di religione, Elledici
• Chi è Marta?
• Perché conosce così bene Gesù?
• Chi è sua sorella? Che rapporto aveva con Gesù?
• Come considerava le donne Gesù?
RIFLETTIAMO
• Che cosa vuol dire Gesù a Marta con queste parole: «Marta, Marta tu ti affanni…»?
• Marta chi crede che sia Gesù?
Per dimostrare l’amore di Dio verso gli uomini Gesù compì molti MIRACOLI, di cui il primo nella città di Cana, grazie all’intervento di sua Madre. Fece miracoli con i quali guarì ammalati, resuscitò morti e dimostrò il suo potere sulle forze della natura. Leggiamoli nei Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, mettendo a confronto i diversi testi. Possiamo classificarli in tre tipi:
1. Miracoli di guarigione
2. Miracoli di risurrezione
3. Miracoli di potere sulle forze della natura
Prima di accostarsi alle narrazioni dei miracoli del Vecchio e del Nuovo Testamento , suggeriamo di leggere ai bambini la favola seguente in cui la protagonista, alla ricerca della bellezza esteriore, non trovandola si indebolisce e si ammala. Quando riuscirà a trovare in se stessa la vera bellezza, quella interiore, allora guarirà e la sua gioia sarà infinita.
I miracoli più grandi dunque avvengono dentro di noi quando riusciamo a vedere le cose belle che sono dentro e attorno a noi.
In mezzo alle montagne coperte di neve c’era una verde vallata con giardini, campi fertili, casette di artigiani. Sulla collina più alta c’era un castello dove abitava il vecchio principe con l’unica figlia, di nome Anima. Il principe e la principessa erano tutti e due buoni e la gente della valle li amava. Però tutti diventarono tristi quando si sparse la notizia che la principessa Anima era gravemente ammalata e non poteva uscire dal castello. Molti diedero consigli e portarono erbe medicinali. I medici arrivarono da paesi lontani. Ma nessun rimedio servì a niente. La principessa Anima peggiorava di giorno in giorno e la gente era sempre più triste. Un giorno arrivò alla porta del castello una vecchietta sconosciuta. La presero per una mendicante e le diedero del pane in elemosina. Ma la vecchietta disse che voleva vedere la principessa malata. I servi non volevano lasciarla entrare e stavano a discutere con lei sul portone del castello, finché il vecchio principe fu attirato dalle voci e uscì a vedere la strana vecchietta. Gli sembrò una buona donna e non trovò nessun motivo per non farla salire nella camera dove la figlia giaceva malata. «Dio mio, quanto è dimagrita e com’è triste!» sospirò la vecchietta. «Purtroppo – gemette il principe – sembra che non vi sia più speranza.» «Vi lamentate inutilmente – gli sussurrò all’orecchio la vecchietta – la principessa guarirà. Ha una malattia particolare. Non è nel corpo, è nell’anima. Per guarire ha bisogno di vedere il volto più bello che esista sulla terra.»
Detto questo la vecchietta improvvisamente sparì. Al principe sembrava assai strano questo consiglio. Ma quando l’uomo è nella miseria si attacca a tutto. Così invitò pubblicamente tutte le più belle ragazze e i più bei giovani della sua terra a venire al castello. Il bel viso che guarirà la prin-
cipessa, diceva il bando del principe, riceverà una lauta ricompensa.
Se si tratterà di un giovane, Anima diventerà sua moglie, nel caso di una ragazza, riceverà in dote la metà dell’eredità.
Appena il bando fu pubblicato, tutta la più bella gioventù accorse al castello.
I giovani sono tutti belli, e ognuno cerca di persuadersi di essere più bello degli altri. Ma tutto fu inutile.
Anima peggiorava di giorno in giorno e diventava l’ombra di se stessa.
Il principe piangeva, e nessuno riusciva a consolarlo. Un pomeriggio la vecchietta sconosciuta comparve di nuovo al portone del castello. Di nuovo i servi non volevano lasciarla entrare e la prendevano in giro chiedendole se per caso credesse d’essere lei la più bella del mondo. Ma il principe anche stavolta fu attirato dal trambusto. Accorse all’ingresso e condusse subito la vecchietta al capezzale della principessa.
«Dio mio, quanto è dimagrita e com’è debole!» esclamò la vecchietta.
Il principe scoppiò a piangere. Ma la vecchietta aggiunse: «È un bene che sia qui, sta morendo.»
Tutto il castello si riempì del pianto disperato del principe, a cui si unì quello di tutti i servi e di tutte le guardie.
Ma la vecchietta non badò affatto alla gran confusione che le sue parole avevano provocato.
Corse al muro della stanza, tolse lo specchio che vi era appeso, si avvicinò al letto e mise lo specchio davanti al volto agonizzante della principessa Anima.
Successe il miracolo. La principessa vide il più bel volto del mondo: era lei la più bella giovane della terra. Lo sguardo su se stessa la guarì all’istante e il pianto del castello si trasformò in grida di esultanza e di gioia.
Da T. Spidlik, Il professore Ulispirus e altre storie, Lipa
RIFLETTIAMO
• Che cosa rappresenta la principessa Anima?
• Perché non riesce ad essere felice?
• Chi l’aiuterà a ritrovare la vera felicità?
• Ti è mai capitato di essere aiutato da qualcuno a ritrovare la gioia che avevi perduto?
I miracoli nell'Antico Testamento
Affrontando il tema dei miracoli l’insegnante potrà operare dei collegamenti con l’Antico Testamento. Proponiamo tre racconti sugli interventi prodigiosi di Dio che il docente potrà raccontare ai bambini. In questi racconti gli alunni potranno riflettere sull’intervento di Dio a favore del suo popolo nel deserto, ma anche degli stranieri, come Naaman, e per mezzo di un profeta, scelto per manifestare la volontà di Dio.
Dopo l’uscita dalla terra d’Egitto, tutta la comunità degli Israeliti arrivò nel deserto di Sin. Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine.»
Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che avranno raccolto ogni altro giorno.» Mosè ed Aronne riferirono agli
Israeliti che la sera stessa avrebbero saputo che era il Signore che li aveva fatti uscire dalla terra d’Egitto e che il mattino seguente avrebbero visto la sua gloria e che Dio aveva udito le loro mormorazioni.
La sera le quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al mattino c’era uno strato di rugiada intorno all’accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, sulla superficie del deserto c’era una cosa fine e granulosa, minuta come la brina.
Gli Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro: «Che cos’è?»
Mosè disse loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo.»
Ecco che cosa comanda il Signore: «Raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il numero delle persone che sono con voi nella tenda.» Venuto il sesto giorno, essi raccolsero il doppio di quel pane anche perché il sabato, giorno consacrato al Signore. Il popolo dunque nel settimo giorno riposò. La casa d’Israele chiamò quel pane manna.
Era simile al seme del coriandolo e bianco, aveva il sapore di una focaccia con miele. Gli Israeliti mangiarono la manna per 40 anni, fino al loro arrivo in una terra abitata.
Naaman, capo dell’esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore e stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la vittoria agli Aramei. Ma questo uomo prode era lebbroso.
Ora bande aramee in una razzia avevano rapito dal paese di Israele una giovinetta, che era finita al servizio della moglie di Naaman. Essa disse alla padrona: «Se il mio signore si rivolgesse al profeta che è in Samaria, certo lo libererebbe dalla lebbra.» Naaman andò a riferire al suo signore: «La giovane che proviene dal paese di Israele ha detto così e così».
Il re di Aram gli disse: «Vacci! Io invierò una lettera al re di Israele.» Partì dunque, prendendo con sé dieci talenti d’argento, seimila sicli d’oro e dieci vestiti. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: «Ebbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo curi dalla lebbra.» Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi mandi un lebbroso da guarire? Sì, ora potete constatare chiaramente che egli cerca pretesti contro di me.» Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re si era stracciate le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciate le vesti? Quell’uomo venga da me e saprà che c’è un profeta in Israele».
Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: «Va’, bagnati sette volte nel Giordano: la tua carne tornerà sana e tu sarai guarito.» Naaman si sdegnò e se ne andò protestando: «Ecco, io pensavo: Certo, verrà fuori, si fermerà, invocherà il nome del Signore suo Dio, toccando con la mano la parte malata e sparirà la lebbra. Forse l’Abana e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per essere guarito?» Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Se il profeta ti avesse ingiunto una cosa gravosa, non l’avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: Bagnati e sarai guarito.» Egli, allora, scese e si lavò nel Giordano sette
volte, secondo la parola dell’uomo di Dio, e la sua carne ridivenne come la carne di un giovinetto; egli era guarito.
Tornò con tutto il seguito dall’uomo di Dio; entrò e si presentò a lui dicendo: «Ebbene, ora so che non c’è Dio su tutta la terra se non in Israele.»
Volle Dario costituire nel suo regno centoventi funzionari e ripartirli per tutte le province. A capo di essi mise tre governatori, di cui uno fu Daniele, ai quali i funzionari dovevano render conto.
Ora Daniele era superiore agli altri governatori e ai funzionari, perché possedeva uno spirito eccezionale, tanto che il re pensava di metterlo a capo di tutto il suo regno.
Perciò tanto i governatori che i funzionari cercavano il modo di trovar qualche pretesto contro Daniele nell’amministrazione del regno. Ma non potendo trovare nessun motivo di accusa né colpa, perché egli era fedele e non aveva niente da farsi rimproverare, quegli uomini allora pensarono: «Non possiamo trovare altro pretesto per accusare Daniele, se non nella legge del suo Dio».
Perciò quei governatori e i funzionari si radunarono presso il re e gli dissero: «Re Dario, vivi per sempre! Tutti i governatori del regno, i magistrati, i funzionari, i consiglieri e i capi sono del parere che venga pubblicato un severo decreto del re secondo il quale chiunque, da ora a trenta giorni, rivolga supplica alcuna a qualsiasi dio o uomo all’infuori di te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, emana il decreto e fallo mettere per iscritto, perché sia irrevocabile, come sono le leggi di Media e di Persia, che non si possono mutare.» Allora il re Dario fece scrivere il decreto Daniele, quando venne a sapere del decreto del re, si ritirò in casa.
Le finestre della sua stanza si aprivano verso Gerusalemme e tre volte al giorno si metteva in ginocchio a pregare e lodava il suo Dio, come era solito fare anche prima. Allora quegli uomini accorsero e trovarono Daniele che stava pregando e supplicando il suo Dio.
Subito si recarono dal re e gli dissero riguardo al divieto: «Non hai tu scritto un decreto che chiunque, da ora a trenta giorni, rivolga supplica a qualsiasi dio o uomo, all’infuori di te, re, sia gettato nella fossa dei leoni?».
Il re rispose: «Sì. Il decreto è irrevocabile come lo sono le leggi dei Medi e dei Persiani.» «Ebbene - replicarono al re - Daniele, quel deportato dalla Giudea, non ha alcun rispetto né di te, né del tuo decreto: tre volte al giorno fa le sue preghiere.» Il re, all’udir queste parole, ne fu molto addolorato e si mise in animo di salvare Daniele e fino al tramonto del sole fece ogni sforzo per liberarlo. Ma quegli uomini si riunirono di nuovo presso il re e gli dissero: «Sappi, che i Medi e i Persiani hanno per legge che qualunque decreto firmato dal re è irrevocabile.»
Allora il re ordinò che si prendesse Daniele e si gettasse nella fossa dei leoni. Il re, rivolto a Daniele, gli disse: «Quel Dio, che tu servi con perseveranza, ti possa salvare!» Poi fu portata una pietra e fu posta sopra la bocca della fossa: il re la sigillò con il suo anello e con l’anello dei suoi grandi, perché niente fosse mutato sulla sorte di Daniele. Quindi il re ritornò alla reggia, passò la notte digiuno, non gli fu introdotta alcuna donna e anche il sonno lo abbandonò. La mattina dopo il re si alzò di buon’ora e sullo spuntar del giorno andò in fretta alla fossa dei leoni. Quando fu vicino, chiamò: «Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ti ha potuto salvare dai leoni?» Daniele rispose: «Re, vivi per sempre. Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso le fauci dei leoni ed essi non mi hanno fatto alcun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui; ma neppure contro di te, o re, ho commesso alcun male.» Il re fu pieno di gioia e comandò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Appena uscito, non si riscontrò in lui lesione alcuna, poiché egli aveva confidato nel suo Dio.
Quindi, per ordine del re, fatti venire quegli uomini che avevano accusato Daniele, furono gettati nella fossa dei leoni insieme con i figli e le mogli. Non erano ancor giunti al fondo della fossa, che i leoni furono loro addosso e stritolarono tutte le loro ossa.
Allora il re Dario scrisse a tutti i popoli, nazioni e lingue, che abitano tutta la terra: «Pace e prosperità. Per mio comando viene promulgato questo decreto: In tutto l’impero a me soggetto si onori e si tema il Dio di Daniele, perché egli è il Dio vivente, che dura in eterno. Il suo regno è tale che non sarà mai distrutto e il suo dominio non conosce fine. Egli salva e libera, fa prodigi e miracoli in cielo e in terra: egli ha liberato Daniele dalle fauci dei leoni.» Questo Daniele prosperò durante il regno di Dario e il regno di Ciro il Persiano.
Il concetto di malattia nella Bibbia
Nella teologia veterotestamentaria si assiste, dinanzi al fatto della malattia, alla convinzione (quasi “dogma”) della RETRIBUZIONE DIVINA come spiegazione della sofferenza nell’uomo. OGNI SOFFERENZA E MALATTIA SONO, in questa logica, IL FRUTTO
DEL PECCATO, del limite e della fragilità umana.
Nel libro di Giobbe tale concetto è bene espresso nel dialogo con i quattro amici di Giobbe, ma il libro stesso è scritto per smontare questa tesi, dato che Giobbe è sì malato, ma è “giusto”, mentre molti malvagi stanno bene.
Queste idee erano comunque ancora presenti al tempo di Gesù. Nel Nuovo Testamento, infatti, tale concetto viene ripreso con l’episodio del cieco nato (Gv 9,1-41) dove Gesù dice a chiare lettere che né lui, né i suoi genitori hanno peccato.
L’amore donato può trasfigurare la malattia e la sofferenza, trasformandola in dono di se stessi come strumenti nelle mani di Dio, capaci di operare salvezza in ogni creatura. Questo fece Gesù morendo sulla croce. Ecco allora il mandato di Cristo alla sua Chiesa: annunciare con l’accoglienza e la carità la vicinanza del Regno di Dio e delle sue opere prodigiose ad ogni povero e sofferente.
Con le ali delle Beatitudini
In questo percorso iniziale l’insegnante riprenderà “Il discorso della montagna” pronunciato da Gesù, per spiegare agli alunni il messaggio delle Beatitudini.
In questo discorso emergono sentimenti come la misericordia e la purezza di cuore, indispensabili ai cristiani per vivere una vita coerente con gli insegnamenti di Gesù, affrontare le difficoltà della vita terrena e aspettare fiduciosi la ricompensa della vita eterna nel regno dei cieli.
La misericordia è il sentimento che caratterizza Gesù nei racconti del Vangelo: tanti sono gli esempi di compassione di Gesù verso le situazioni dolorose della condizione umana. Eccone alcuni esempi.
La guarigione del lebbroso (Mc 1,41):
Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi guarirmi!». Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci!». Subito la lebbra scomparve ed egli guarì.
Osserviamo il dipinto di Minniti (allievo di Caravaggio) e leggiamo insieme l’episodio della vedova che accompagna il figlio morto (Lc 7,13):
In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Naim e facevano la strada con lui i discepoli e una grande folla.

Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova; e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere!»
E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Giovinetto, dico a te, alzati! ». Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare.
Ed egli lo diede alla madre.

Per comprendere cosa significa essere operatori di pace, dobbiamo rileggere il discorso/testamento in occasione dell’ultima cena quando Gesù dice: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo io la do a voi.»
La pace secondo Gesù è la disponibilità al servizio, non la semplice mancanza di conflitto.
L’insegnante può proporre agli alunni un collage di parole-chiave che richiamano la parola PACE.
Quante le strade che un uomo farà e quando fermarsi potrà?
Quanti mari un gabbiano dovrà attraversar per giungere a riposar?
Quando tutta la gente del mondo riavrà per sempre la sua libertà…
Risposta non c’è o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà.
Risposta non c’è o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà.
Quando dal mare un’onda verrà che i monti lavare potrà?
Quante volte un uomo dovrà litigar sapendo che è inutile odiar?
E poi quante persone dovranno morir perché siano troppe a morir?…
Risposta non c’è o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà.
Risposta non c’è o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà.
Quanti cannoni dovranno sparar e quando la pace verrà?
Quanti bimbi innocenti dovranno morir. (…)
Versione italiana di Blowing in the Wind, Bob Dylan
“I
have a dream: that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.”
“Io ho un sogno: che un giorno questa nazione si alzerà e vivrà apertamente il vero senso delle sue convinzioni. Noi riteniamo che questa verità sia ovvia, che tutti gli uomini sono creati uguali”.
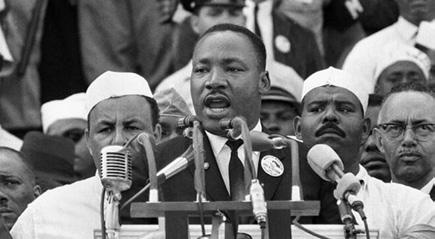

Questo è il nucleo del suo famoso discorso tenuto a Washington nel 1963, ormai conosciuto e citato in tutto il mondo.
GIUSEPPE IMPASTATO, meglio noto come PEPPINO (Cinisi, 1948-1978).
È stato un giornalista, attivista e poeta italiano, noto per le sue denunce contro le attività della mafia a seguito delle quali fu assassinato, vittima di un attentato il 9 maggio 1978.
Bandiera internazionale della pace, nei colori dell’arcobaleno, secondo la tradizione pacifista del ‘900 e il messaggio biblico della Genesi.
«Io pongo il mio arcobaleno nella nuvola, e servirà di segno del patto fra me e la terra». (Genesi 9,13)

Dio dichiara beati coloro che cercano e creano giustizia. Nel mondo attuale, esistono molte situazioni in cui gli alunni possono ritrovare situazioni di conflitto e sopraffazione. Il caso più vicino a loro è quello dei ragazzi che si mostrano forti e superiori e tormentano i più fragili. Denominati “bulli” rappresentano un grave problema tra i più giovani, perché spesso le “vittime“ non dichiarano cosa sta accadendo e, per questo, non è facile mettere fine ai loro ricatti.
La derisione avviene sempre da parte di un gruppo, il bullo non agisce mai solo, la vittima deve cercare il coraggio di denunciare cosa sta accadendo.
In questa storia, i personaggi sentono delle mancanze che chiedono al Mago di Oz di colmare. In particolare il “LEONE CODARDO” vorrebbe il coraggio per affrontare le situazioni di difficoltà e poter finalmente VINCERE LE PAURE
Ma durante l’incontro con il Mago, lui gli rivela che questo dono è già dentro di lui e lo deve semplicemente dimostrare. Da quel momento il leone diventa sicuro di sé e coraggioso, come la sua natura di animale selvaggio impone.
Quanto a te, mio caro amico, tu sei vittima di un ragionamento sballato: ti sei fatto l’errata opinione che solo perché rifuggi dai pericoli tu non hai coraggio. Tu confondi il coraggio con la saggezza. Nel Paese da cui provengo ci sono degli uomini che sono chiamati eroi: una volta all’anno tolgono il loro coraggio dalla naftalina e lo portano in parata per le vie della città. E quelli non hanno più coraggio di te. Ma loro hanno una cosa che tu non hai: una medaglia.
Disse poi una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio». (Lc 12,16/21)
In questa opera Charles Dickens racconta la metamorfosi di Scrooge, uomo di affari senza alcuna sensibilità. Durante la notte, il suo socio Marlowe gli ha mostrato il suo passato, il suo presente e il suo futuro, facendolo ravvedere. Il coraggio del rinnovamento lo porterà ad essere felice.
Scrooge chiede al fantasma perché si trova lì e Marlowe spiega che il suo spirito sta vagando da quando è morto, in giro per il mondo, come un prigioniero in catene e senza pace, come punizione per aver speso la sua vita pensando esclusivamente agli affari e mai al suo prossimo, mentre era ancora vivo.
Scrooge è sinceramente pentito della sua condotta ed è desideroso di riscattarsi.
In fondo, era un uomo buono, indurito dalle vicissitudini della vita. Scrooge si sveglia nella sua camera da letto e gioiosamente affronta il nuovo giorno, con l’intento di mettere da subito in pratica i suoi nuovi, buoni, propositi. Corre festoso attorno alla sua casa, ed anche fuori, dove le campane stanno suonando a festa. Un ragazzo gli dice che oggi è il giorno di Natale, quindi capisce che i tre spiriti sono venuti tutti durante la stessa notte. Compra subito un tacchino e lo manda alla casa di Bob. Scrooge indossa i suoi migliori vestiti e cammina sorridente in mezzo alla gente, incontra il gentiluomo che il giorno prima aveva chiesto una donazione, e gli dona una ingente somma di denaro. Continua quindi a camminare per la città, e gentilmente parla con le persone che incontra. Visita la casa di Fred e si unisce alla festa, trascorrendo così un meraviglioso natale. Il giorno successivo, al negozio, dove Bob arriva in ritardo, Scrooge finge di rimproverarlo, quindi gli comunica che ha appena ricevuto un aumento, e che ha intenzione di fare anche altre cose per lui e per il piccolo Tim. Il futuro adesso è cambiato, il piccolo Tim non morirà e lo stesso Scrooge alla sua morte sarà pianto dalle persone che lo hanno conosciuto. Scrooge non vedrà più spiriti in vita sua, ma porterà sempre nel cuore i tre spiriti che ha avuto la fortuna di incontrare.

Palla di Natale
Costruiamo insieme agli alunni una DECORAZIONE NATALIZIA che possiamo usare come addobbo per la classe o come lavoretto di Natale da portare a casa.
Tamponare il colore a tempera con la spugnetta all’interno di una metà della sfera e lasciare asciugare.
Inserire il tovagliolo con il disegno rivolto verso l’esterno nell’altra metà della sfera.
Fissare con il pennello e con la colla (tre parti di colla e una di acqua) il tovagliolo alla sfera partendo dal centro.
Stendere eventuali pieghe del tovagliolo con il tampone.
Ritagliare le parti del tovagliolo che fuoriescono dal bordo e lasciar asciugare.
Unire le due metà della sfera.
Fissare con la colla a caldo o con la colla il nastro dell’altezza di 1 cm lungo la circonferenza.
Formare un fiocco con il nastro dell’altezza di 4 cm e fissarlo sulla sommità della sfera.
Far passare il cordoncino nei due buchi della sfera, fare un nodo alla base e un nodo in alto per poter appendere la palla di Natale. 1 3 5 7 9 2 4 6 8
• Una sfera apribile di plastica (10 cm di diametro)
• Tovagliolo per decoupage con disegni del presepe
• Colla vinilica
• Pennello
• Tampone
• Tempera azzurra
• Spugnetta
• 30 cm di nastrino (altezza 1 cm)
• 30 cm di nastro (altezza 4 cm)
• Cordoncino
Il mio segna-vangelo
Proponiamo la realizzazione di un segna-vangelo che potrà essere utilizzato dagli alunni nella RICERCA DEI BRANI BIBLICI , come segnalibro, o anche come regalo per un amico dopo averlo magari plastificato per renderlo più resistente.
REALIZZAZIONE
1 3
2 4
Colorare i disegni e ritagliarli.
Incollare i disegni sul cartoncino.
Perforare l’estremità.
Infilare il nastro di raso nel foro e annodarlo.
Parabole da raccontare
OCCORRENTE
• Foglio bianco
• Foglio di carta da lucido
• Nastro adesivo
• Pennarelli
• Cartoncino
OCCORRENTE
• Fotocopia della scheda numero 2
• Colori
• Cartoncino o foglio da disegno ruvido (24x33 cm)
• Perforatrice
• Pennarelli colorati
• Forbici
• Colla
• Quattro nastrini di raso di colori diversi
Facciamo realizzare delle rappresentazioni grafiche di alcune brevi parabole da raccontare in due tempi: la prima parte della parabola viene raffigurata in un foglio bianco e la seconda in un foglio di carta da lucido che verrà sovrapposto al primo.
I due fogli saranno fissati con del nastro adesivo. Una prima parabola, ad esempio quella del GRANELLINO DI SENAPA, potrebbe essere realizzata dall’insegnante e poi mostrata in classe.
NEL PRIMO FOGLIO bianco verrà scritta la seguente frase: Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma… Sotto a questa citazione l’insegnante disegnerà un prato con qualche fiore e un granellino nel terreno.
NEL SECONDO FOGLIO (lucido) prima illustrare un albero grande con degli uccellini sui rami e sotto scrivere: …una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi
e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami. In seguito i bambini saranno invitati a realizzare loro stessi anche altre parabole. Alla fine la classe avrà diversi testi illustrati in due tempi che potranno essere raccolti in una busta fatta con un foglio di cartoncino.
È nato! Alleluia!
È nato il sovrano Bambino, è nato, Alleluia! Alleluia!
La notte che già fu ‘sì buia risplende di un astro divino.
Umberto Saba
Orsù, cornamuse più gaie suonate squillate campane! Venite, pastori e massaie, o genti vicine e lontane!
Non sete, non molli tappeti, ma come nei libri hanno detto da quattromill’anni i profeti, un poco di paglia ha per letto.
Da quattromil’anni s’attese a quest’ora su tutte le ore.
È nato, è nato il Signore!
È nato nel nostro paese. Risplende d’un astro divino la notte che già fu si buia.
È nato il sovrano Bambino, è nato Alleluia! Alleluia!
Guido Gozzano
NON AMI
Puoi decidere le strade che farai puoi scalare le montagne oltre i limiti che hai potrai essere qualcuno se ti va ma se non ami, se non ami non hai un vero motivo per vivere se non ami non ti ami e non ci sei se non ami non ha senso tutto quello che fai.
Puoi creare un grande impero intorno a te costruire grattaceli e contare un po’ di più puoi comprare tutto quello che vuoi tu ma se non ami, se non ami non hai un vero motivo per vivere se non ami non ti ami e non ci sei se non ami, se non ami non hai il senso delle cose più piccole le certezze che non trovi e che non dai...
Nek
Tacciano i venti
Tacciano i venti tutti, del mar si arrestino le acque, Gesù, Gesù già nacque, già nacque il Redentor. Il Sommo Nume Eterno scese dall’alto cielo, il misterioso velo già ruppe il Salvator.
Nascesti alfin nascesti, pacifico Signore, al mondo apportatore d’alma felicità.
L’empia, funesta colpa, giacque da te fiaccata, gioisci, o avventurata, felice umanità.
Sorgi, e solleva il capo dal sonno tuo profondo; il Redentor del mondo ormai ti liberò.
No, più non senti il giogo di servitù pesante, son le catene infrante da lui che ti salvò.
Gloria sia dunque al sommo, Onnipossente Iddio, guerra per sempre al rio d’Averno abitator.
Dia lode e Cielo, e Terra, al Redentor divino, al sommo Re Bambino di pace alto Signor.
Giacomo Leopardi
Ama la vita così com’è.
Amala pienamente, senza pretese; amala quando ti amano o quando ti odiano, amala quando nessuno ti capisce, o quando tutti ti comprendono.
Amala quando tutti ti abbandonano, o quando ti esaltano come un re.
Amala quando ti rubano tutto, o quando te lo regalano.
Amala quando ha senso o quando sembra non averlo nemmeno un po’.
Amala nella piena felicità, o nella solitudine assoluta.
Amala quando sei forte, o quando ti senti debole.
Amala quando hai paura, o quando hai una montagna di coraggio. Amala non soltanto per i grandi piaceri e le enormi soddisfazioni; amala anche per le piccolissime gioie.
Amala seppure non ti dia ciò che potrebbe, amala anche se non è come la vorresti. Amala ogni volta che nasci ed ogni volta che stai per morire.
Ma non amare mai senza amore.
Non vivere mai senza vita!
Santa Teresa di Calcutta
Compila l’identikit della tua mamma e realizza sotto il suo ritratto.
Osserva il dipinto qui e alla LIM, descrivilo poi colora la copia sotto.

Dopo aver ascoltato la lettura del racconto Noi riordina la storia e scrivi una breve didascalia accanto ad ogni immagine.
Come dovrebbe essere il Natale secondo te? Scrivi la tua opinione.
1)Il profeta che annuncia il Messia si chiama…
Isaia
Giovanni Samuele
2)L’imperatore che ordinò il censimento si chiama:
Nerone
Cesare Augusto
Aurelio
3)Maria e Giuseppe vanno a:
Nazaret
Betlemme
Gerico
4)La nascita di Gesù è scritta: in tutti i Vangeli in tre Vangeli in due Vangeli
5)Maria e Giuseppe trovano posto: in un albergo in una stalla in un palazzo
6)Gesù nasce a:
Nazaret
Betlemme
Roma
7)I primi a ricevere l’annuncio della nascita furono: i Magi i pastori gli angeli
8)L’angelo dice ai pastori: …ehc iuloc ottedeneB
Osanna al re d’Israele ùip len oiD a airolG alto dei cieli…
Prova a realizzare anche tu l’affresco di Giotto: la natività di Gesù. Utilizza la tecnica che preferisci. Completa il testo in basso.
TITOLO DELL’OPERA ...........................................................................................
AUTORE: ..............................................................................................................
PERSONAGGI RAPPRESENTATI: .........................................................................
QUEST’OPERA M’ISPIRA SENTIMENTI DI ..........................................................
CLASSE ...................................
Segna con una x la risposta che ritieni più giusta, poi completa l’ultima domanda.


Sono nato nudo, dice Dio, perché tu sappia spogliarti di te stesso.
Sono nato povero perché tu possa considerarmi l’unica ricchezza.
Sono nato in una stalla perché tu impari a santificare ogni ambiente.
Sono nato debole perché tu non dubiti mai del mio amore.
Sono nato di notte perché tu creda che posso illuminare qualsiasi realtà.
Sono nato persona perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso.
Sono nato creatura perché tu possa diventare figlio di Dio.
Sono nato nella semplicità perché tu smetta di essere complicato.

Sono nato nella tua vita, dice Dio, per portare tutti alla casa del Padre.
L. Noben

• Dio è nato povero perché...:
l’uomo lo consideri come vera ricchezza
l’uomo desideri di essere ricco
• Dio parla di...:
umiltà, semplicità e coraggio vergogna, arroganza e paura
• Dio nasce di notte...: per nascondersi per illuminare l’umanità
• Il poeta afferma che:
Dio è nato per conquistare il mondo
Dio è nato per portare tutti alla casa del Padre
• Sei d’accordo con il significato della poesia? Perché?
Leggi il Vangelo di Matteo 2,1-12 e ricomponi nel giusto ordine le sequenze di questo brano.

Essi entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
Allora Erode, chiamati in segreto i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: “Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo”.
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: “Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”.
All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”.
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.
Colora le immagini e collegale rispettivamente al libro dell’Antico e del Nuovo Testamento.



Colora e ritaglia i segna-vangelo. Scrivi una frase su ognuno che rappresenta la caratteristica dell’evangelista.
Colora, ritaglia e monta il cubo degli evangelisti con i loro simboli.
Gioca con i tuoi compagni lanciando il dado e spiegando il simbolo dell’evangelista che compare.
Ritaglia a pagina XX, poi incolla al posto giusto i simboli degli evangelisti. Colora.
Il suo Vangelo è chiamato il
Vangelo dei Giudei, perché Matteo cerca di dimostrare ai suoi fratelli ebrei come Gesù sia davvero il Messia annunciato dai profeti, discendente dal re Davide. È il Vangelo più lungo, con 28 capitoli.
Il suo Vangelo è chiamato il Vangelo per i Romani o del catecumeno, perché contiene l’annuncio ai popoli pagani convertiti. Il Gesù presentato da Marco è un Messia nascosto, che si rivela Figlio di Dio con parole e opere. È il Vangelo più breve: solo 16 capitoli.
Il suo Vangelo è chiamato il
Vangelo per i Greci, perché presenta Gesù nella sua grande umanità e bontà nei riguardi degli ultimi, dei più piccoli e degli stranieri. È con Matteo uno dei due Vangeli dell’infanzia.
Il suo Vangelo ha 24 capitoli.
GIOVANNI
Il suo è un Vangelo diverso dagli altri, dove Giovanni sembra interpretare molti fatti e discorsi di Gesù, dopo averli a lungo meditati, con molta fede. Il Vangelo di Giovanni ha 21 capitoli.



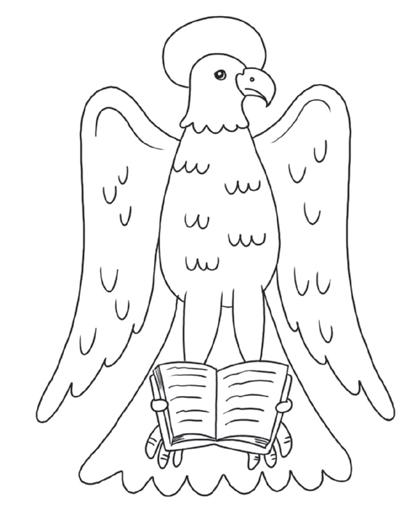
La parola Vangelo deriva dal greco eu anghellion, che significa buona notizia, lieto evento. La parola fu in seguito trascritta in latino con il termine Evangelus, che in italiano divenne poi Vangelo. La predicazione di Gesù si svolse soprattutto in Palestina, territorio che ai nostri giorni corrisponde a una parte dello stato d’Israele. La Palestina è costituita da territori con caratteristiche fisiche diverse: dalla costa alla pianura, dalla zona collinare al deserto e alla fertile valle del Giordano. La parte costiera è formata da pianure, mentre la parte a sud è desertica. Le montagne si trovano a est (Altopiano orientale), a ovest (Montagne centrali) e sud-ovest (Montagne di Giuda). Due sono i laghi principali: il Lago di Galilea (detto anche di Tiberiade o Mare di Galilea) e il Mar Morto.
Leggi le caratteristiche della Palestina e, con l’aiuto dell’atlante, colora il territorio dove visse Gesù. Prova poi a indicare dove si trovano alcuni luoghi frequentati da Gesù.
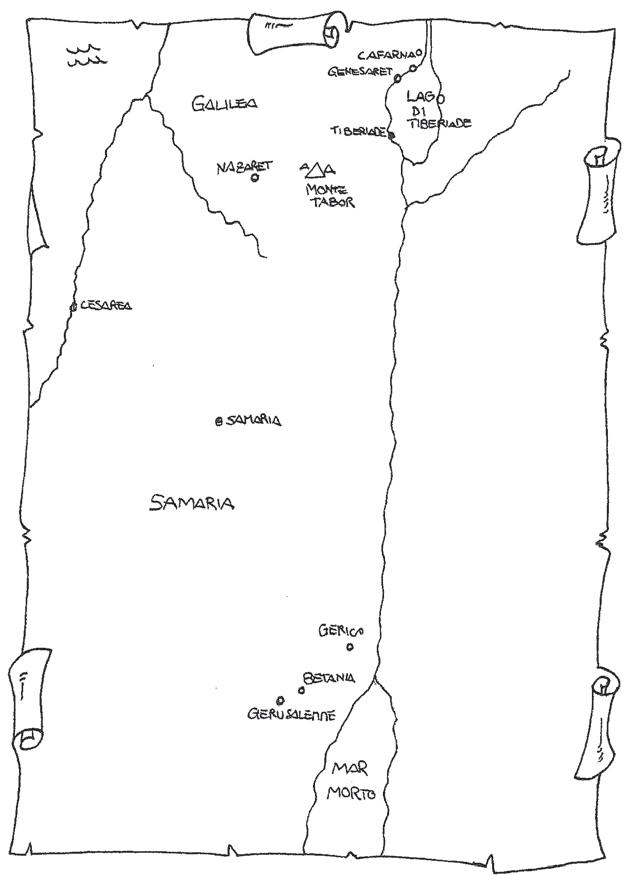
Scrivi accanto ai fumetti il gruppo politico e religioso a cui fa riferimento. In basso individuane altri tre tu.
La mia spada caccerà i romani!
Io raccolgo le tasse per i romani! Interpreto le Sacre Scritture!
Guido le sacre celebrazioni al Tempio!
Io osservo la Torah!
Io vado al tempio sul monte Garizim!
Individua i luoghi più importanti della vita di Gesù. Cerca i brani indicati e trascrivi i nomi delle località.
• Gesù nasce a (Lc 2,4)
• Con la sua famiglia vive a ....
...................... (Lc 4,16)
• Riceve il Battesimo lungo le rive del ......................................................... (Mt 3,5)
• Chiama i discepoli lungo il ...................................................................... (Mt 4,18-22)
• Guarisce il cieco e incontra Zaccheo nella città di .............................(Lc 18,35; 19,1)
• Si trasfigura davanti ai suoi tre discepoli sul .............................. Tabor (Mt 17,1-13)
• Incontra una donna samaritana presso la città di ..................................... (Gv 4,5-7)
• Compie il suo primo miracolo a ........................................................... (Gv 2,1-5)
• Resuscita il suo amico Lazzaro a ........................................................... (Gv 11,1)
• Viene arrestato in un .......................................................................... (Mc 14,32)
• Viene crocifisso al luogo del ........................................................... (Mc 15,22-23)
• Risorge nella città di ..................................................................... (Mc 15,40,41)
• Appare a due discepoli sulla strada di ............................................... (Lc 24,13-15)
CLASSE
Scrivi la corretta citazione evangelica sopra alla relativa immagine nella lanterna, scegliendola tra quelle proposte nel riquadro. Poi colora e monta la lanterna come mostrato nel modellino.
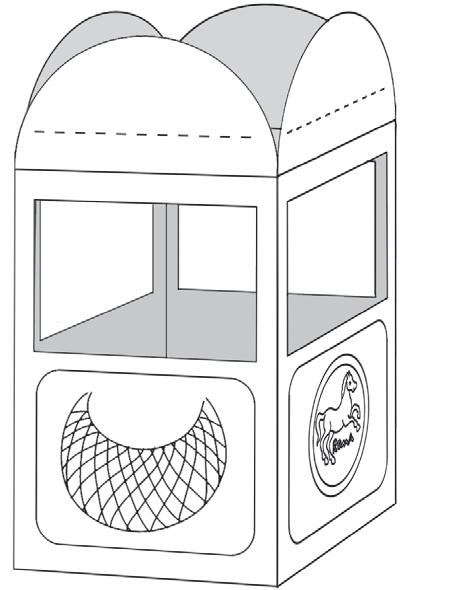
• Mt 13,47-50
• Mt 5,14-16
• Mt 25,14-30
• Mt 18,12-14
Riordina la sequenza della parabola del Padre misericordioso e scrivi sotto ogni disegno una breve didascalia.



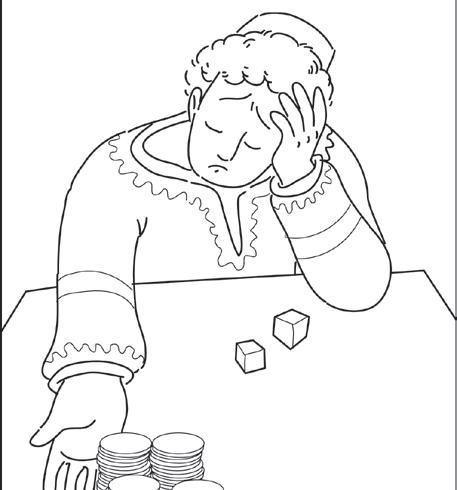
Scrivi la corretta citazione evangelica sopra alla relativa immagine nella lanterna, scegliendola tra quelle proposte nel riquadro. Poi colora e monta la lanterna come mostrato nel modellino.
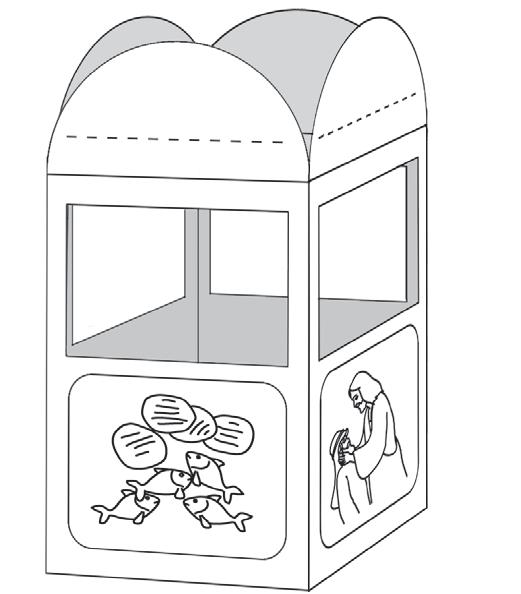
• Mt 14,13-21
• Mc 8,22-26
• Gv 11,1-44
• Mc 7,31-37
Riordina, numerandole, le vignette e per ognuna scrivi una breve didascalia.
Completa il fumetto: cosa chiesero i lebbrosi? Completa il cruciverba.
Gesù è in viaggio verso…
Gesù è in viaggio verso…
Durante il tragitto incontra dieci…
Durante il tragitto incontra dieci…
Essi chiedono a Gesù di avere….
Essi chiedono a Gesù di avere….
Gesù li manda dai…
Gesù li manda dai…
Solo … torna da Gesù.
Solo … torna da Gesù. ESEGUI UN RICERCA SU COSA ERA LA LEBBRA
UN
Un giorno era accorsa tanta gente ad ascoltare Gesù, che fece un discorso nuovo e molto bello, nel quale pronunciò spesso una parola. Vuoi scoprire quale?
Completa il cruciverba e la parola apparirà nelle caselle evidenziate.
1. Il colore delle candele che si usano in chiesa.
2. Il nome della sposa di Assuero.
3. Il nome del primo uomo.
4. Dio ha creato il cielo e la...
5. Dio ha cambiato il nome di Giacobbe in...
Colora il disegno.
Ricordi il Discorso della montagna in cui Gesù espone il suo annuncio di felicità?
Abbina le due parti di ogni frase per ottenere le Beatitudini.
Beati i perseguitati per la giustizia
Beati i miti perché
perché troveranno misericordia..
perché saranno consolati.
Beati i misericordiosi
Beati gli afflitti perché
perché di essi è il regno dei cieli.
erediteranno la terra.
Ricordi il Discorso della montagna in cui Gesù espone il suo annuncio di felicità?
Abbina le due parti di ogni frase per ottenere le Beatitudini.
Beati gli operatori di pace
perché saranno saziati.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia
perché vedranno Dio.
Beati i puri di cuore
Beati i poveri di spirito
perché di essi è il regno dei cieli.
perché saranno chiamati figli di Dio.
Rileggi le Beatitudini proclamate da Gesù e scrivi a fianco di ciascuna quale potrebbe essere l’esempio di una loro attualizzazione ai nostri tempi.
Beati quelli che
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati quelli che
Beati quelli che
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati quelli che
Beati quelli che
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riconosce e sa spiegare il significato cristiano della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale;
• si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo.

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale
La Pasqua cristiana
• Un tempo di preparazione alla Pasqua: la Quaresima.
• Gli eventi della Settimana Santa.
• La Pasqua di Gesù.
• La Settimana Santa oggi, tra riti e tradizioni in Italia.
• I simboli della Pasqua cristiana.
r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
Da pag. 91 a pag. 106
Dio e l’uomo
• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto, testimoniato dai cristiani..
Il linguaggio religioso
• Scoprire nella Pasqua il centro della fede cristiana.
• Conoscere i principali segni e i simboli pasquali e il loro significato.
In questa unità, viene affrontata LA PASQUA non come un avvenimento isolato dagli altri, ma proprio NEL CONTESTO DELLE ULTIME AZIONI CHE GESÙ HA COMPIUTO PRIMA DELLA SUA PASSIONE, MORTE E RISURREZIONE.
Come premessa a questo percorso, l’insegnante presenterà la QUARESIMA dei cristiani, come periodo di preparazione e attesa (come l’Avvento per il Natale) a un evento centrale e fondamentale per la fede cristiana. Verranno poi presentati i luoghi in cui si sono svolti gli ultimi giorni della vicenda terrena di Gesù, che,
insieme ai segni e ai simboli cristiani, offrono l’opportunità di comprendere più adeguatamente il MISTERO PASQUALE. Parallelamente gli alunni verranno guidati in un salto temporale e guidati alla conoscenza di diversi riti e tradizioni presenti ancora oggi in Italia, e nati propri dalla memoria degli eventi dell’ultima Settimana di vita di Gesù. Inoltre, l’insegnante guiderà gli alunni alla riflessione e al confronto su come le altre religioni vivono la morte e quello che viene dopo secondo le diverse credenze popolari.

L’avvenimento della risurrezione sfugge al bisogno di concretezza dei bambini, pertanto è apparso opportuno soffermarsi sul CONTESTO STORICO-GEOGRAFICO di tale evento, centrale per la fede cristiana. La presentazione del processo a Gesù e dei luoghi in cui si sono svolti gli ultimi giorni della sua vicenda terrena offrono l’opportunità di comprendere più adeguatamente il mistero pasquale. L’ultima parte dell’itinerario riguarda le apparizioni di GESÙ RISORTO, in particolare si fa riferimento all’incontro tra Gesù e Tommaso in cui l’apostolo incredulo, dopo aver fatto ESPERIENZA DIRETTA DELLA RISURREZIONE , diventa credente.
Con Oscar Wild
La fiaba-parabola di OSCAR WILDE richiama e allude al mistero della Pasqua. Essa si articola in due parti:
• La prima è a sfondo etico ed insegna che chi vive da egoista si condanna alla tristezza, chi invece apre il suo cuore agli altri vive nella gioia e nella luce
• La seconda è a sfondo religioso: il bambino con le ferite sulle mani e sui piedi è manifestazione di Gesù colpito e crocifisso nella passione
Ogni pomeriggio, al ritorno dalla scuola, i bambini andavano a giocare nel giardino del gigante. Era un grande e delizioso giardino, pieno di erbetta soffice e verde, bellissimi fiori e alberi di pesco. Gli uccellini cantavano così dolcemente che i bambini lasciavano i loro giochi per poterli ascoltare. «Come siamo felici!» gridavano allegramente.
Ma un bel giorno il gigante ritornò dopo sette lunghi anni. Quando giunse nella sua casa, vide tutti i bambini che giocavano nel suo giardino. «Che cosa fate qui? Questo giardino è solo mio e non permetterò più a nessuno di venirci a giocare.»
gridò con il suo vocione il gigante.
E i bambini scapparono via. L’omone costruì un alto muro di cinta e vi attaccò un grande cartello con questa scritta: Vietato l’ingresso. I disubbidienti saranno puniti.
I poveri bambini non sapevano più dove andare a giocare e gironzolavano sempre intorno all’alto muro, parlando del bel giardino ormai chiuso.
Finalmente giunse la primavera e in tutta la campagna c’erano boccioli e uccellini: solo nel giardino del gigante egoista regnava ancora l’inverno. Gli uccellini non cantavano più e gli alberi si erano dimenticati di fiorire. Gli unici abitanti di quel parco erano la neve e il ghiaccio.
«Non capisco come la primavera tardi tanto ad arrivare...» disse il gigante, stando seduto davanti alla finestra e guardando le sue aiuole bianche e fredde, «Spero proprio che il tempo si decida a cambiare.»
Ma la primavera non venne e nemmeno l’estate. L’autunno portò i suoi frutti in tutti i giardini, meno che in quello del gigante.
Un bel mattino, mentre già sveglio se ne stava disteso sul letto, il gigante udì una musica deliziosa.
Risuonava così dolcemente alle sue orecchie che egli dapprima credette che i suonatori del re stessero passando di lì.
In realtà si trattava soltanto di un piccolo fringuello che cantava fuori dalla sua finestra. In quel momento la neve smise di cadere e il vento smise di brontolare mentre un meraviglioso profumo giungeva sino al gigante attraverso la finestra aperta.
«Credo che la primavera sia giunta, finalmente!» disse l’omone. E saltò giù dal
letto per guardare fuori. Ma che cosa vide mai?
Ai suoi occhi apparve un’incantevole visione: attraverso un piccolo buco nel muro, i bambini erano scivolati dentro e si erano seduti sui rami degli alberi. Su ogni pianta c’era un bambino, e le piante erano tanto felici che si erano subito ricoperte di boccioli e agitavano dolcemente i loro rami sulle testoline dei fanciulli.
Gli uccelli volavano cinguettando allegramente e i fiori occhieggiavano ridendo fra l’erba verde.
Era una scena deliziosa. Ma in un angolo del giardino era ancora inverno. Era il punto più lontano e lì, vicino a un albero, se ne stava un bimbetto così piccolo che non riusciva a raggiungere i rami e vi girava intorno piangendo sconsolatamente. L’albero era ancora coperto di ghiaccio e di neve e il vento soffiava scuotendolo.
Il cuore del gigante si sciolse a quella vista. «Come sono stato egoista!» esclamò. «Adesso capisco perché la primavera non arrivava mai. Metterò quel povero bambino sulla cima dell’albero e abbatterò il muro di cinta, in modo che il mio giardino sia aperto per sempre ai giochi dei fanciulli.» Era veramente pentito di quello che aveva fatto e subito scese e aprì dolcemente la porta d’ingresso per uscire. Ma quando i bambini lo videro, si spaventarono tanto che scapparono via, e nel giardino ritornò l’inverno. Solo il bambino più piccolo non fuggì, poiché, avendo gli occhi pieni di lacrime, non aveva visto il gigante. Questi gli apparve davanti e sollevandolo gentilmente con la mano, lo mise sull’albero. Subito questo fiorì, mentre gli uccellini venivano a cantare tra i suoi rami e il bimbo tese le sue braccia e le strinse al collo del gigante baciandolo. Quando gli altri bambini videro che egli non era più cattivo, ritornarono correndo e con loro ritornò la primavera. Preso un grosso palo, il gigante abbatté il muro e ogni giorno giocava con i bambini nel suo giardino che era diventato il più bello del mondo. Ma il bambino che aveva messo sull’albero se ne era andato.
Ogni pomeriggio, dopo la scuola, i bimbi andavano a giocare nel giardino. Il gigante era molto gentile con loro, ma aveva tanta nostalgia del suo piccolo amico e spesso parlava di lui.
«Quanto vorrei rivederlo!» era solito dire.
Gli anni passarono e il gigante divenne vecchio e stanco. Non poteva più giocare e se ne stava sempre seduto in un’enorme poltrona, guardando i bimbi che giocavano e ammirando il suo bel parco. «Posseggo tanti bei fiori, ma i bambini sono i più bei fiori che esistano!» mormorava.
In una mattina d’inverno, egli guardava fuori dalla finestra. Ora non odiava più quella stagione, perché sapeva che essa era soltanto la primavera addormentata e che i fiori stavano riposando. All’improvviso spalancò gli occhi, sbalordito, e guardò più attentamente il meraviglioso spettacolo. Nell’angolo più lontano del giardino c’era un albero tutto fiorito di bianco. I suoi rami erano d’oro e carichi di frutti d’argento e sotto di esso c’era il piccolo bambino tanto amato. Il gigante si precipitò giù pieno di gioia e corse. Si affrettò fra la neve e si avvicinò al bimbetto. Ma quando gli giunse vicino, si fece rosso di rabbia. «Chi ha osato ferirti?» chiese.
Sui palmi delle manine del bambino c’erano infatti le ferite rosse di due chiodi e altre due ferite di chiodi erano sui piedi. «Chi ha osato ferirti?» ripeté il gigante «Dimmi il suo nome e io lo ucciderò con la mia spada!»
«Nessuno.» rispose il bimbo «Queste sono soltanto le ferite dell’amore.» «Chi sei dunque?» chiese il gigante.
Uno strano timore si impadronì di lui ed egli si inginocchiò davanti al piccino che gli sorrise e gli disse: «Oggi tu verrai con me nel mio giardino, che si chiama Paradiso.»
Da: Oscar Wilde, Il gigante egoista.
RIFLETTIAMO
• Dopo che il gigante caccia i bambini, come diventa?
• Com’è ora il suo giardino?
• Dopo l’incontro con il bambino misterioso, che cosa accade?
• Perché entra la primavera nel suo giardino?
• A quale altra storia ti fa pensare questa fiaba?
• Le ferite e le parole del bambino quale altro personaggio ti ricordano?
Gli EBREI sostenevano in un primo momento l’ESISTENZA DELLO SHEOL, un mondo sotterraneo dove andranno tutti, giusti e non giusti. Successivamente, in un’epoca più tardiva, si arrivò a dire che Dio, grazie alla sua bontà avrebbe dato ai giusti la vita eterna in una sorta di paradiso, mentre i malvagi avrebbero avuto una punizione. Il defunto viene deposto in terra consacrata. Sulla sua tomba si è soliti posare dei sassolini bianchi.
Nel CORANO si parla invece di come i meritevoli entreranno nel GAN EDEN, cioè in un luogo in cui i fedeli possono trovare cose materiali come miele, carne, frutta ma anche le urì cioè delle vergini. È un PARADISO DIVISO IN SETTE DIMORE , mentre i non meritevoli andranno all’inferno. Il corpo del defunto viene avvolto in un sudario e sepolto con il volto in direzione della Kaaba.
La RELIGIONE BUDDHISTA crede nella reincarnazione o TRASMIGRAZIONE DELLE ANIME . Ognuno rinasce in un’altra forma umana o animale sulla base delle azioni compiute nella vita precedente. Per i buddhisti è importante uscire dal ciclo di nascita, morte, reincarnazione per poter smettere di soffrire e raggiungere quello stato che chiamano NIRVANA, cioè la FELICITÀ ETERNA. Tutto ciò è possibile grazie alla meditazione.

Le uova decorate
REALIZZAZIONE
Ritagliare tante strisce larghe pochi millimetri e leggermente più lunghe dell’uovo.
Con un pennello distribuire la colla diluita con acqua sulla parte posteriore delle strisce.
Posizionare la prima striscia su tutta la lunghezza dell’uovo (svuotato e lavato) e incollarne una identica in posizione diametralmente opposta.
Incollare le strisce successive ricoprendo completamente il guscio, badando che non si formino pieghe o grinze: margini sollevati o bolle d’aria comprometterebbero il risultato finale.
Far asciugare molto bene (almeno 24 ore) l’uovo e procedere alla finitura dando più mani di flatting o di vernice poliuretanica trasparente, rispettando attentamente i tempi di asciugatura.
• Uovo di gallina lavato e svuotato secondo le indicazioni suggerite
• Carta da regalo
• Colla vinilica e pennello
• Flatting o vernice poliuretanica
• Forbici

Come svuotare le uova
Lavare l’uovo con una spazzolina o con una spugna lievemente abrasiva e del sapone neutro.
Con una matita fare un segno in corrispondenza dei poli opposti dell’uovo, verificando che siano effettivamente centrati.
Con un oggetto appuntito (per esempio ago di lana) bucare l’uovo nei punti segnati. Allargarli poi leggermente con l’aiuto di una lima.
Soffiare con forza in uno dei due fori: tuorlo e albume usciranno dalla parte opposta.
Sciacquare molto bene l’uovo tenendolo immerso in una soluzione di acqua tiepida e aceto (un bicchiere circa per litro d’acqua): ciò impedirà la formazione di muffe.
Lasciare asciugare per qualche ora: l’uovo sarà pronto per essere decorato. 1 3 5
• Sapone neutro
• Spazzolina morbida
• Spugna da cucina
• Matita
• Gomma
• Ago da lana
• Aceto
• Ciotole

REALIZZAZIONE
• Un palloncino
Gonfiare un palloncino, fare un nodo all’imboccatura e attaccare un cordino al nodo. Avvolgere tutt’attorno al palloncino tre strati di strisce di carta di giornale dopo averle immerse nella colla, facendo attenzione a non coprire il nodo al palloncino e il cordino. (Per fare la colla, mescolare acqua e farina di grano e impastare fino ad ottenere una crema un po’ liquida).
Quando la cartapesta è asciutta, sgonfiare il palloncino bucandolo ed estrarlo dal guscio tirando il cordino.
Tagliare il guscio a metà altezza e utilizzare la parte inferiore come cestino. Da un pezzo di carta colorata tagliare una striscia di circa 7x25 cm e incollare assieme le due estremità. (Questa è la base del cestino).
Tagliare un’altra striscia di carta di circa 3x30 cm e incollare le estremità su due lati opposti del bordo interno superiore del cestino. (Questo sarà il manico).
Pitturare il cestino con vernice per cartelloni.
Riempire il cestino di erba artificiale, poi aggiungere uova di plastica, cartoline di Pasqua, oggetti di peluche, bandierine e fiocchi o coccarde colorate. 1 3 5 2 4 6
• Cordino
• Carta di giornale
• Colla (acqua e farina)
• Carta colorata
• Vernice per cartelloni
• Erba artificiale
• Uova di plastica
• Cartoline di Pasqua
• Bandierine
• Fiocchi o coccarde colorate
• Piccoli peluche (pulcini o coniglietti).


Inno alla croce gloriosa
O croce gloriosa del Signore risorto, albero della mia salvezza!
Di esso mi nutro, di esso mi diletto, nelle sue radici cresco, nei suoi rami mi distendo. La sua rugiada mi rallegra, la sua brezza mi feconda, alla sua ombra ho posto la mia tenda. Nella fame l’alimento, nella sete la fontana, nella nudità il vestimento. Angusto sentiero, mia strada stretta, scala di Giacobbe, letto d’amore dove ci ha sposato il Signore. Nel timore la difesa, nell’inciampo il sostegno, nella vittoria la corona, nella lotta tu sei premio. Albero di vita eterna, sostegno dell’universo, ossatura della terra, la tua cima tocca il cielo e nelle tue braccia aperte brilla l’amore di Dio.
Da un antico inno di San Clemente Romano
Buona Pasqua
Nei miei sogni ho immaginato un grande uovo colorato.
Per chi era?
Per la gente dall’Oriente all’Occidente: pieno di sorprese destinate ad ogni paese. C’era dentro la saggezza e poi tanta tenerezza, l’altruismo, la bontà, gioia in grande quantità.
Tanta pace, tanto amore da riempire ogni cuore.
È Pasqua, è Pasqua! dice allegro il sole mentre gioca con i fiori delle aiuole. È Pasqua, è Pasqua! risponde il vento mentre insegue le nubi nel firmamento. È Pasqua, è Pasqua! canta allegro il cuore. In questo giorno è risorto il Signore!
La data di Pasqua non è sempre uguale, come succede ad esempio a Natale. Per calcolarla vi insegno un trucco (già lo prevedo, rimarrete di stucco!).
Appena trascorso di marzo il 21 guardare in cielo sarebbe opportuno non al mattino ma piuttosto di sera (che buon profumino, è già primavera!).
Quando vedrete la luna piena potrete al cielo voltare la schiena perché a quel punto la soluzione non chiede più somma né sottrazione: lasciate il cielo e tornate in poltrona, la prima domenica sarà quella buona!
L’esperimento con me ha funzionato ma poi sentite cosa mi è capitato. Il giorno di Pasqua ero fuori a passeggio, e inebriato da un dolce gorgheggio (credo di merli, almeno un migliaio), sono passato vicino ad un pollaio.
Ora, lo so, non mi crederete, ma io vi giuro che dietro la rete
E Gesù rivedeva, oltre il Giordano campagne sotto il mietitor rimorte: il suo giorno non molto era lontano. E stettero le donne in sulle porte delle case, dicendo: Ave, Profeta!
Egli pensava al giorno di sua morte. Egli si assise all’ombra d’una meta di grano, e disse: Se non è chi celi sotterra il seme, non sarà chi mieta .
Egli parlava di granai ne’ Cieli: e voi, fanciulli, intorno lui correste con nelle teste brune aridi steli.
c’era un pulcino sporco d’albume che pigolava a tutto volume, ma quel che mi è parso davvero strano è che pigolando... parlava italiano: «Rompendo il mio guscio, picchiando sul fondo, nel giorno di Pasqua son venuto al mondo. Nel giorno di Pasqua fioriscon le aiuole e l’Uovo del mondo è dischiuso dal sole. Nel giorno di Pasqua dalla sua tomba, come oggi ricorda la bianca colomba, è risuscitato il Figlio di Dio (ma io adesso torno a fare pio pio)» ù
Nelle parole del saggio pulcino (forse ispirato da un lume divino) sembra nascondersi tutta l’essenza di questa magnifica ricorrenza.
Nel Santo giorno di Resurrezione quel che rinasce è l’intera creazione: è la natura che si rinnova…
In questo grande trionfo di uova!
Mario Sala Gallini
Egli stringeva al seno quelle teste brune; e Cefa parlò: Se costì siedi, temo per l’inconsutile tua veste. Egli abbracciava i suoi piccoli eredi; il figlio – Giuda bisbigliò veloce d’un ladro, o Rabbi, t’è costì tra’ piedi: Barabba ha nome il padre suo, che in Croce morirà.
Ma il Profeta, alzando gli occhi, “No” mormorò con l’ombra nella voce; e prese il bimbo sopra i suoi ginocchi.
Giovanni Pascoli
Leggi i seguenti brani biblici (Matteo 27,35; Matteo 27,29; Giovanni 19,34; Luca 23,33; Giovanni 19,19; Matteo 27,48; Matteo 27,59; Luca 23,56; Giovanni 19,2) e scrivi sotto ogni oggetto la citazione biblica corrispondente. Colora.




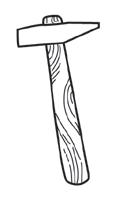


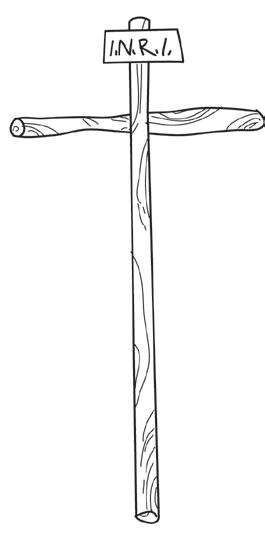

Dopo aver letto le pagine dei Vangeli riguardanti la Passione, la morte e la Risurrezione di Gesù, prova a rispondere alle seguenti domande:
•Da chi era stata annunciata l’entrata di Gesù a Gerusalemme?
•Quale festa della liturgia ricorda questo evento?
•Gli Apostoli sono stati capaci di restare vicini a Gesù negli ultimi momenti?
•Perché Gesù lava i piedi agli Apostoli?
•Durante l’ultima Cena quale ricorrenza stavano festeggiando Gesù e gli Apostoli?
•Quale sacramento cristiano viene istituito in quell’occasione?
•Quali parole pronuncia Gesù?
•Quando Gesù viene arrestato dove vanno gli Apostoli?
•Chi rimane vicino a Gesù quando è Crocifisso?
•Chi va a visitare la tomba trovandola vuota?
•Che cosa viene detto a chi era andato alla tomba?
•Per noi, cristiani di oggi, è facile capire che cosa è la Risurrezione?
CLASSE

L’alunno…
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze
• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento.

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
La Chiesa di Gesù
• Dalla Sacra Sindone al Cristo Velato.
• I discepoli di Emmaus.
• Dall’Ascensione alla Pentecoste.
• I simboli dello Spirito Santo.
Da pag. 107 a pag. 120
Dio e l’uomo
• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.
In quest’ultima parte gli alunni saranno accompagnati a un ITINERARIO DI “FEDE” che i cristiani oggi vivono, dalla Sacra Sindone a Torino, il telo che la tradizione attribuisce allo stesso telo che avvolse Gesù dopo la sua morte, al Cristo velato a Napoli, ovvero come l’arte abbia raffigurato in modo quasi realistico la morte di Gesù, quasi da toccare con mano quell’evento tragico. L’insegnante poi presenterà gli eventi successivi alla morte e risurrezione di Gesù, in particolare facendo riferimento all’incontro tra Gesù e Tommaso in cui l’apostolo incredulo, dopo aver fatto esperienza diretta della risurrezione, diventa credente.
L’ultimo argomento di questo anno scolastico vede come protagonista lo SPIRITO SANTO, che dopo la salita al cielo di Gesù (Festa dell’Ascensione) scenderà sugli apostoli dando VITA ALLA CHIESA voluta da Cristo (giorno di Pentecoste).
Gli alunni verranno guidati alla conoscenza dei simboli presenti nella bibbia e che da sempre rappresentano la forza e l’efficacia della terza persona della Trinità cristiana.
Sia che riusciamo ad organizzare una breve visita a una chiesa del quartiere per vedere direttamente il luogo di riunione dei cristiani, sia che non prevediamo questa uscita didattica, possiamo proporre la lettura del brano che segue.
Il racconto è come una visita vera e propria in cui i bambini, come i personaggi del libro di testo, si trovano a identificarsi con la protagonista.
Con San Tommaso
Per approfondire il tema della Risurrezione l’insegnante aiuterà gli alunni a leggere l’opera d’arte del Caravaggio, fornendo alcune notizie e facendo emergere che cosa rappresenta la composizione e il suo messaggio.
L’INCREDULITÀ DI SAN TOMMASO (CARAVAGGIO)
È un dipinto ad olio su tela realizzato tra il 1600-1601.
È conservato alla Bildergalerie nel parco di Sanssouci a Postdam.
IL QUADRO RAFFIGURA L’APOSTOLO SAN TOMMASO MENTRE INFILA UN DITO NELLA FERITA DEL COSTATO DI GESÙ, con altri due apostoli che osservano la scena. È Gesù stesso che guida con la sua mano quella dell’apostolo, egli scosta il sudario con cui è avvolto, per consentire al dito di Tommaso di entrare nella piaga.
Il dito dell’apostolo non si limita a toccare la ferita, ma vi entra dentro come a voler frugare ogni ombra di dubbio.
Le figure sono disposte in modo da formare un’elementare croce, o una spirale, con le tre teste degli apostoli, perfettamente incastrate l’una all’altra.
L’artista veste i protagonisti della vicenda con abiti contemporanei alla sua epoca, mentre lascia CRISTO CON UN MANTELLO.
Questo gli serve per dare una verità ancora più diretta e comprensibile all’episodio raccontato: il fatto accade quel giorno di tanti secoli prima in Palestina, ma proprio perché realmente accaduto può essere riscontrabile, toccabile con mano, anche oggi, e in qualunque altro tempo.
I personaggi non sono più inquadrati a distanza (tradizionale iconografia del tema), nella sala, teatro dell’episodio. Essi sono a portata di sguardo, anzi di mano.
Per di più sono ad altezza dell’osservatore, per cui, chiunque sia di fronte a quella
tela, diventa il quinto personaggio della scena: anche lui si trova a chinare lo sguardo, incredulo e stupito, sul centro dell’evento illuminato da una luce che, in uno sfondo buio e spoglio, irrompe da sinistra per risvegliare l’incredulità di Tommaso.
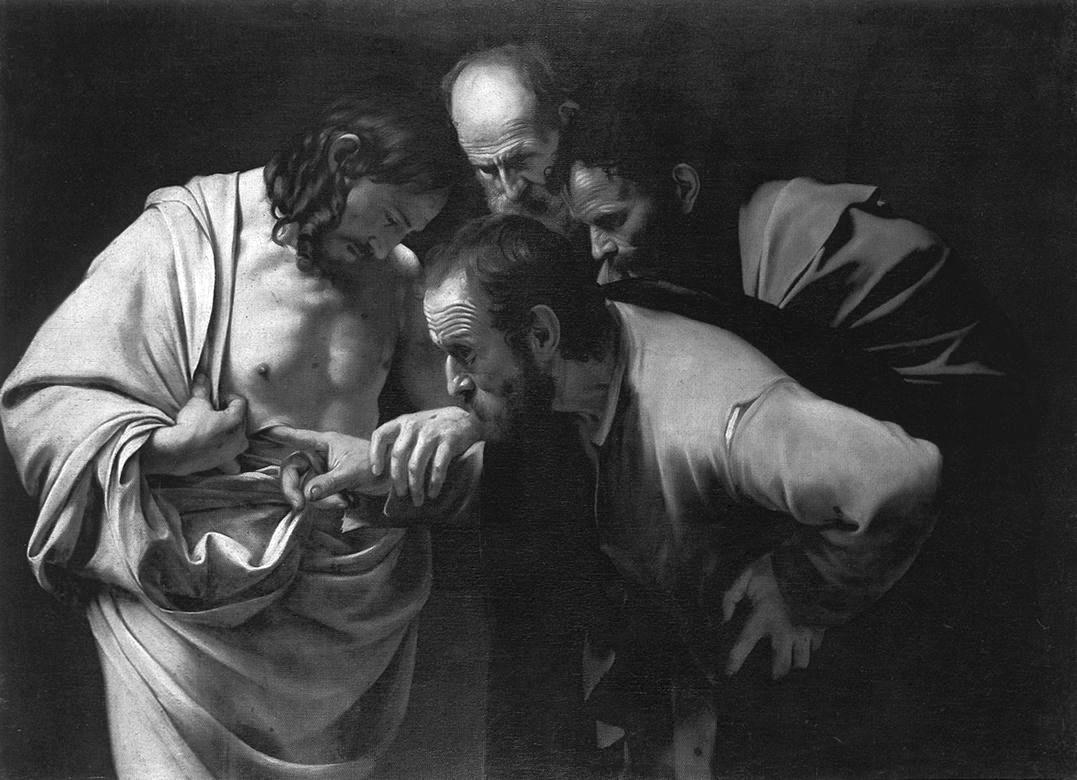
Il dibattito sull’autenticità della Sindone, non si è mai interrotto neppure dopo il 13 ottobre 1988, quando il cardinale BALLESTRERO, vescovo di Torino, in seguito ai risultati ottenuti dai laboratori di Tucson, Zurigo e Oxford che analizzarono alcuni frammenti sindonici con il metodo 14C, annunciò che la Sindone risultava medioevale e risalente a un’epoca dal 1260 al 1390 d.C.
I dubbi che i radiocarbonisti abbiano eseguito le loro analisi correttamente e che abbiano messo la Chiesa in condizioni di non opporsi ai loro risultati però rimangono e oggi la datazione medioevale non viene accettata da moltissimi sindonologi.
A questo punto, se la Sindone non è il vero lenzuolo funebre di Gesù ma è un falso medioevale, si apre un’altra questione: come è stato prodotto e chi ne è l’autore? In altri termini, come si è formata l’immagine visibile sulla Sindone?
Sul telo appare un CORPO MASCHILE DI FRONTE E DI SCHIENA (perché il cadavere è stato posto in posizione supina e il telo gli venne piegato sopra).
L’impronta riguarda solo lo strato più superficiale del telo e resiste al calore, agli agenti chimici e all’acqua. Per vederla, poiché i contorni sono molto sfumati, bisogna essere distanti come minimo due metri.

• SI È IPOTIZZATO CHE FOSSE UN DIPINTO, ma gli esami effettuati non hanno mostrato tracce né di pigmenti, né della direzione delle pennellate. Il falsario dunque avrebbe dovuto essere capace di dipingere senza vedere che cosa stesse facendo, di rappresentare su una tela una figura che è un negativo fotografico con caratteristiche tridimensionali (e quindi essere al corrente della tecnica della fotografia). Inoltre avrebbe dovuto essere in grado di macchiare il telo con sangue di un vivo e di un morto e di spargervi pollini delle piante di Palestina, Francia e Italia, distinguendoli prima al microscopio. Se fosse stato capace di fare tutto questo, avrebbe saputo anche come invecchiare il lino su cui dipingeva.
• Per lo studio particolareggiato dei dettagli anatomici, LA SINDONE È STATA PERSINO ATTRIBUITA A LEONARDO, ma Leonardo nasce 100 anni dopo che la Sindone è apparsa a Lirey (Francia)!
Per ammettere che si tratta di un dipinto, chi l’ha realizzato dovrebbe essere un assassino che ha appositamente sottoposto a tortura e poi ucciso un uomo.
• Altri studiosi hanno ipotizzato una REAZIONE CHIMICA TRA IL LENZUOLO E IL CORPO con il quale è venuto a contatto diretto, altri un’azione dei gas che si sarebbero sviluppati tra lino e cadavere (ma non vi sono segni che dicano che il corpo sia rimasto avvolto nel lenzuolo abbastanza a lungo perché si formassero gas e avesse inizio la putrefazione).
• Si è anche pensato all’ESPOSIZIONE AL SOLE DI UNA PITTURA SU VETRO appoggiata al telo (ma l’immagine arriverebbe più in profondità) o a un bassorilievo riscaldato e messo a contatto con il lenzuolo (ma allora la Sindone dovrebbe presentare la fluorescenza verdastra anche dove c’è l’immagine e si dovrebbe avere traccia dell’esistenza di questo bassorilievo).
• Un’altra ipotesi è quella del cosiddetto EFFETTO CORONA: un terremoto avrebbe provocato una compressione degli strati di quarzo del sottosuolo, dando origine a un CAMPO ELETTRICO CON SCARICHE che avrebbero provocato un’INTERAZIONE TRA TELO E CADAVERE; questo sarebbe coerente con la menzione della scossa di terremoto che si trova nei Vangeli.
• Un’ultima idea che è stata formulata dagli scienziati è quella di una RADIAZIONE LUMINOSA PROVENIENTE DALL’INTERNO DEL CORPO STESSO .
In mezzo a tutte queste possibili ipotesi di spiegazione la verità è una sola: NESSUNO È IN GRADO DI DIRE COME SI SIA FORMATA L’IMPRONTA DELLA SINDONE né tantomeno di riprodurla, neppure con le tecniche più sofisticate di cui siamo a conoscenza attualmente.

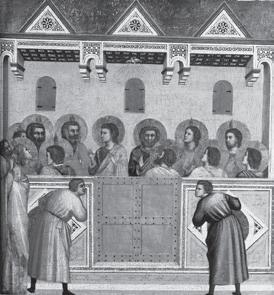
Questa opera di Giotto raffigurante la Pentecoste è una tempera e oro su tavola che si trova a Londra alla National Gallery. Essa mostra una stanza priva della parte superiore per permettere all’osservatore di ammirare la scena. Due persone curiose rappresentate in modo simmetrico osservano l’accaduto.
CHI SONO I PERSONAGGI RAPPRESENTATI NELL’OPERA?
2. RICONOSCI LA PRESENZA DELLO SPIRITO SANTO? DA CHE COSA?
Ecco ora una scena dal ciclo pittorico nella Cappella degli Scrovegni a Padova (1303-1305), opera di Giotto. La Pentecoste è l’ultima delle storie della Passione di Gesù, dipinte nella parete sinistra.

1. DOVE SONO SEDUTI GLI APOSTOLI? DOVE È COLLOCATA MARIA?
2. COME È RAPPRESENTATO LO SPIRITO SANTO?
Colora il disegno, poi costruisci il popup seguendo le istruzioni dell’insegnante.
Colora il disegno, poi costruisci il popup seguendo le istruzioni dell’insegnante.
Scrivi una frase per ciascuna scena della prima comunità cristiana descritta negli Atti degli Apostoli. Sottolinea poi i verbi che specificano il loro modo di vivere. Riordina infine le vignette seguendo l’ordine del testo biblico.

Drepamim (Bitinia), III sec. – ? † 330 ca. Di famiglia plebea, Elena venne ripudiata dal marito, il tribuno militare Costanzo Cloro, per ordine dell’imperatore Diocleziano. Quando il figlio Costantino, sconfiggendo il rivale Massenzio, divenne padrone assoluto dell’impero, Elena, il cui onore venne riabilitato, ebbe il titolo più alto cui una donna potesse aspirare, quello di «Augusta». Fu l’inizio di un’epoca nuova per il cristianesimo: l’imperatore Costantino, dopo la vittoria attribuita alla protezione di Cristo, concesse ai cristiani la libertà di culto. Un ruolo fondamentale ebbe la madre Elena: forse è stata lei a contribuire alla conversione, poco prima di morire, del figlio. Elena testimoniò un grande fervore religioso, compiendo opere di bene e costruendo le celebri basiliche sui luoghi santi. Ritrovò la tomba di Cristo scavata nella roccia e poco dopo la croce del Signore e quelle dei due ladroni. Il ritrovamento della croce, avvenuta nel 326 sotto gli occhi della pia Elena, produsse grande emozione in tutta la cristianità. A queste scoperte seguì la costruzione di molte basiliche. Morì probabilmente intorno al 330. Il suo corpo riposa in un altare laterale della Basilica dell’Ara Coeli in Roma. Una sua grande statua campeggia nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, in prossimità dell’altare della confessione. La Chiesa latina la ricorda il 18 agosto, data in cui è stata inserita nel Martirologio Romano ed in cui è presente la sua Messa propria nella forma extraordinaria del rito romano “per alcuni luoghi”. In Oriente, invece, cattolici e ortodossi la venerano insieme al figlio San Costantino imperatore in data 21 maggio, ed insieme sono spesso raffigurati nelle sacre icone.
Etimologia: Elena = la splendente, fiaccola, dal greco
Martirologio Romano: A Roma sulla via Labicana, santa Elena, madre dell’imperatore Costantino, che si adoperò con singolare impegno nell’assistenza ai poveri; piamente entrava in chiesa mescolandosi alle folle e in un pellegrinaggio a Gerusalemme alla ricerca dei luoghi della Natività, della Passione e della Risurrezione di Cristo onorò il presepe e la croce del Signore costruendo venerande basiliche.
Nell’iconografia, specie orientale, sant’Elena è raffigurata spesso insieme al figlio l’imperatore Costantino e ambedue posti ai lati della Croce. Perché il grande merito di Elena fu il ritrovamento della Vera Croce e di Costantino il merito di aver data libertà di culto ai cristiani, che per trecento anni erano stati perseguitati ed uccisi a causa della loro fede.
Di Elena i dati biografici sono scarsi, nacque verso la metà del III secolo forse a Drepamim in Bitinia, cittadina a cui fu dato il nome di Elenopoli da parte di Costantino, in onore della madre. Elena discendeva da umile famiglia e secondo s. Ambrogio, esercitava l’ufficio di ‘stabularia’ cioè locandiera con stalla per gli animali e qui conobbe Costanzo Cloro ufficiale romano, che la sposò nonostante lei fosse di grado sociale inferiore, diventando così moglie ‘morganatica’. Nel 280 ca. a Naisso in Serbia, partorì Costantino che allevò con amore; ma nel 293 il marito Costanzo divenne ‘cesare’ e per ragioni di Stato dovette sposare Teodora, figliastra dell’imperatore Massimiano Erculeo; Elena Flavia fu allontanata dalla corte e umilmente rimase nell’ombra. Il figlio Costantino venne allevato alla corte di Diocleziano (243-313) per essere educato ad un
futuro di prestigio; in virtù del nuovo sistema politico della tetrarchia, nel 305 Costanzo Cloro divenne imperatore e Costantino lo seguì in Britannia nella campagna di guerra contro i Pitti; nel 306 alla morte del padre, acclamato dai soldati ne assunse il titolo e il comando. Divenuto imperatore, Costantino richiamò presso di sé Elena sua madre, dandole il titolo di ‘Augusta’, la ricoprì di onori, dandole libero accesso al tesoro imperiale, facendo incidere il suo nome e la sua immagine sulle monete. Di queste prerogative Elena Flavia Augusta ne fece buon uso, beneficò generosamente persone di ogni ceto e intere città, la sua bontà arrivava in soccorso dei poveri con vesti e denaro; fece liberare molti condannati dalle carceri o dalle miniere e anche dall’esilio. Fu donna di splendida fede e quanto abbia influito sul figlio, nell’emanazione nel 313 dell’editto di Milano che riconosceva libertà di culto al cristianesimo, non ci è dato sapere. Ci sono due ipotesi storiche, una di Eusebio che affermava che Elena sia stata convertita al cristianesimo dal figlio Costantino e l’altra di s. Ambrogio che affermava il contrario; certamente deve essere stato così, perché Costantino ricevé il battesimo solo in punto di morte nel 337. Ad ogni modo Elena visse esemplarmente la sua fede, nell’attuare le virtù cristiane e nel praticare le buone opere; partecipava umilmente alle funzioni religiose, a volte mischiandosi in abiti modesti tra la folla dei fedeli; spesso invitava i poveri a pranzo nel suo palazzo, servendoli con le proprie mani.
Tenne un atteggiamento prudente, quando ci fu la tragedia familiare di Costantino, il quale nel 326 fece uccidere il figlio Crispo avuto da Minervina, su istigazione della matrigna Fausta e poi la stessa sua moglie Fausta, sospettata di attentare al suo onore. E forse proprio per questi foschi episodi che coinvolgevano il figlio Costantino, a 78 anni nel 326, Elena intraprese un pellegrinaggio penitenziale ai Luoghi Santi di Palestina. Qui si adoperò per la costruzione delle Basiliche della Natività a Betlemme e dell’Ascensione sul Monte degli Ulivi, che Costantino poi ornò splendidamente. La tradizione narra che Elena, salita sul Golgota per purificare quel sacro luogo dagli edifici pagani fatti costruire dai romani, scoprì la vera Croce di Cristo, perché il cadavere di un uomo messo a giacere su di essa ritornò miracolosamente in vita. Questo episodio leggendario è stato raffigurato da tanti artisti, ma i più noti sono i dipinti nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme di Roma e nel famoso ciclo di S. Francesco ad Arezzo di Piero della Francesca. Insieme alla Croce furono ritrovati anche tre chiodi, i quali furono donati al figlio Costantino, forgiandone uno nel morso del suo cavallo e un altro incastonato all’interno della famosa Corona Ferrea, conservata nel duomo di Monza. L’intento di Elena era quello di consigliare al figlio la moderazione ed indicargli che non c’è sovrano terreno che non sia sottoposto a Cristo; inoltre avrebbe indotto Costantino a costruire la Basilica dell’Anastasis, cioè della Resurrezione. Elena morì a circa 80 anni, assistita dal figlio, verso il 329 in un luogo non identificato; il suo corpo fu però trasportato a Roma e sepolto sulla via Labicana “ai due lauri”, oggi Torpignattara; posto in un sarcofago di porfido, collocato in uno splendido mausoleo a forma circolare con cupola. Fu da subito considerata una santa e con questo titolo fu conosciuta nei secoli successivi; i pellegrini che arrivavano a Roma non omettevano di visitare anche il sepolcro di s. Elena, situato tangente al portico d’ingresso della Basilica dei Santi Marcellino e Pietro. Il grandioso sarcofago di porfido fu trasportato nell’XI secolo al Laterano e oggi è conservato nei
Musei Vaticani. Il suo culto si diffuse largamente in Oriente e in Occidente, l’agiografo Usuardo per primo ne inserì il nome nel suo ‘Martirologio’ al 18 agosto e da lì passò nel Martirologio Romano alla stessa data; in Oriente è venerata il 21 maggio insieme al figlio s. Costantino imperatore. Gli strumenti della Passione da lei ritrovati, furono custoditi e venerati nella Basilica romana di S. Croce in Gerusalemme, da lei fatta costruire per tale scopo, le sue reliquie hanno avuto una storia a parte, già dopo due anni dalla sepoltura a Roma, il corpo fu trasferito a Costantinopoli e posto nel mausoleo che l’imperatore aveva preparato per sé. Poi le notizie discordano, una prima tradizione dice che nell’840 il presbitero Teogisio dell’abbazia di Hauvilliers (Reims) trasferì le reliquie in Francia; una seconda tradizione afferma che verso il 1140 papa Innocenzo II le trasferì nella Basilica romana dell’Aracoeli e infine una terza tradizione dice che il canonico Aicardo le portò a Venezia nel 1212. È probabile che il percorso sia stato Roma - via Labicana, poi Reims e dopo la Rivoluzione Francese le reliquie siano state definitivamente collocate nella Cappella della Confraternita di S. Croce nella chiesa di Saint Leu di Parigi; qualche reliquia deve essere giunta negli altri luoghi dell’Aracoeli a Roma e a Venezia. S. Elena è venerata con culto speciale anche in Germania, a Colonia, Treviri, Bonn e in Francia ad Elna, che in origine si chiamava “Castrum Helenae”. Inoltre è considerata la protettrice dei fabbricanti di chiodi e di aghi; è invocata da chi cerca gli oggetti smarriti; in Russia si semina il lino nel giorno della sua festa, affinché cresca lungo come i suoi capelli. Nel più grande tempio della cristianità, S. Pietro in Vaticano, s. Elena è ricordata con una colossale statua in marmo, posta come quelle di s. Andrea, la Veronica, s. Longino, alla base dei quattro enormi pilastri che sorreggono la cupola di Michelangelo e fanno da corona all’altare della Confessione, sotto il quale c’è la tomba dell’apostolo Pietro.
Autore: Antonio Borrelli
m. 250 circa
San Cristoforo, martire in Licia nel 250, durante la persecuzione dell’imperatore Decio, fu uno dei «quattordici santi ausiliatori», colui che avrebbe portato sulle spalle un bambino, che poi si rivelò Gesù. Il testo più antico dei suoi Atti risale all’VIII secolo. In un’iscrizione del 452 si cita una basilica dedicata a Cristoforo in Bitinia. Cristoforo fu tra i santi più venerati nel Medioevo; il suo culto fu diffuso soprattutto in Austria, in Dalmazia e in Spagna. Chiese e monasteri si costruirono in suo onore sia in Oriente che in Occidente. (Avvenire)
Patronato: Pellegrini, Motoristi, Viaggiatori, Ferrovieri, Tranvieri, Automobilisti, S
Etimologia: Cristoforo = portatore di Cristo, dal greco
Emblema: Palma
Martirologio Romano: In Licia nell’odierna Turchia, san Cristoforo, martire.
Protettore dei viaggiatori
L’immagine più frequente di San Cristoforo raffigura un gigante barbuto che porta su una spalla Gesù Bambino, aiutandolo ad attraversare le acque di un fiume; Gesù Bambino regge sulla punta delle dita il mondo, come se giocasse con una palla. Questa immagine risale ad una delle leggende agiografiche più note relative al Santo martirizzato il 25 luglio a Samo, in Licia. Secondo questa tradizione, il suo vero nome era Reprobo, ed era un gigante che desiderava mettersi al servizio del re più forte del mondo. Giunto alla corte di un re che si riteneva invincibile, si mise al suo servizio, ma un giorno si accorse che il re, mentre ascoltava un menestrello che cantava una canzone che parlava del diavolo, si faceva il segno della croce. Gli chiese come mai, e il re gli rispose che aveva paura del diavolo, e che ogni volta che lo sentiva nominare si faceva il segno della croce per cercare protezione. Il gigante si mise allora alla ricerca del diavolo, che giudicava più potente del suo re. Non gli ci volle molto per trovarlo, e si mise a servirlo e a seguirlo. Ma un giorno, passando per una via dove c’era una croce, il diavolo cambiò strada. Reprobo gli chiese per quale motivo l’avesse fatto, e il diavolo fu costretto ad ammettere che su una croce era morto Cristo e che lui davanti alla croce era costretto a fuggire spaventato. Reprobo allora lo abbandonò e si mise alla ricerca di Gesù Cristo. Un eremita gli suggerì di costruirsi una capanna vicino ad un fiume dalle acque pericolose e di aiutare, grazie alla sua forza e alla sua statura gigantesca, i viandanti ad attraversarlo; certo Cristo ne sarebbe stato felice e forse un giorno si sarebbe manifestato a lui. Un giorno il gigante buono udì una voce infantile che gli chiedeva aiuto: era un bambino che desiderava passare sull’altra riva. Il gigante se lo caricò sulle spalle e cominciò ad attraversare le acque tumultuose; ma più si inoltrava nel fiume, più il peso di quell’esile fanciullo aumentava, tanto che solo con molta fatica il gigante riuscì a raggiungere la riva opposta. Lì il bambino rivelò la propria identità: era Gesù, e il peso che il gigante aveva sostenuto era quello del mondo intero, salvato dal sangue di Cristo. Questa leggenda, oltre ad ispirare l’iconografia occidentale, ha fatto sì che San Cristoforo fosse invocato patrono dei barcaioli, dei pellegrini e dei viandanti.
In Oriente San Cristoforo è in genere raffigurato con testa di cane, come è testimoniato da molte icone conservate a San Pietroburgo e Sofia. L’iconografia del santo cinocefalo secondo alcuni dimostrerebbe che si tratta di un culto nato in ambito ellenistico-egizio, con un chiaro riferimento al culto del dio Anubis; più plausibile e complessa sarebbe invece un’altra ipotesi: Reprobo si sarebbe arruolato nell’esercito romano e si sarebbe convertito al cristianesimo col nome di Cristoforo. Denunziato per la sua attività di apostolato tra i commilitoni, e condotto davanti al giudice, avrebbe resistito ad ogni tentativo di farlo abiurare e sarebbe stato infine decapitato. Cristoforo, dunque, avrebbe “portato Cristo” nel suo cuore fino al martirio, come l’asinello portò Cristo a Gerusalemme il giorno delle Palme. Per questa ragione in Oriente si sarebbe inizialmente diffusa l’abitudine di raffigurare Cristoforo con una testa d’asino, che si sarebbe poi mutata in una testa di cane. Si tratterebbe perciò di una iconografia interna al cristianesimo, senza alcun rapporto con culti pagani.
Il protettore degli occhi
Secondo la Leggenda Aurea, il martirio di Cristoforo avvenne a Samo, in Licia. Il Santo resistette alle torture inflittegli con verghe di ferro e metallo rovente. Persino le frecce che gli furono scagliate contro rimasero sospese a mezz’aria, e una di esse tornò indietro e trafisse l’occhio del sovrano che aveva ordinato il supplizio. Il re diede allora ordine di decapitare Cristoforo, e il Santo, prima di morire, gli disse: “Bagnati l’occhio col mio sangue, e sarai risanato.” Il re riacquistò la vista e si convertì, e da allora San Cristoforo viene invocato per guarire dalle malattie della vista. (Vatican News)
Il testo più antico dei suoi Atti, in edizione latina, risale oltre il sec. VIII. Esso contiene narrazioni intessute di episodi talmente fantastici, da spingere qualche critico a dubitare della reale esistenza di questo martire. Ma in un’iscrizione del 452, scoperta ad Haidar-Pacha in Nicomedia, .si parla di una basilica dedicata a Cristoforo nella Bitinia: ciò non comporta necessariamente che il santo sia originario di questa regione. Il Martirologio Geronimiano al 25 luglio pone la festa di Cristoforo in Licia, nella città di Samon: ma sul problema della localizzazione di questa Samon, i critici non sono pienamente concordi. Un’altra testimonianza è del 536: tra i firmatari del concilio di Costantinopoli ci fu un certo Fotino del monastero di S. Cristoforo non meglio identificato. S. Gregorio Magno, infine, parla di un monastero in onore di questo martire a Taormina in Sicilia. Si tratta, è vero, di testimonianze sommarie, ma per sé sufficienti a dimostrare l’esistenza storica del martire orientale, ucciso, secondo il Geronimiano, nel 250, durante la persecuzione di Decio. Cristoforo fu uno dei santi più venerati nel Medioevo: chiese e monasteri si costruirono in suo onore sia in Oriente sia in Occidente; particolarmente, in Austria, in Dalmazia e in Spagna il suo culto fu diffusissimo. Nella Spagna, poi, si venerano molte sue reliquie. Cristoforo godeva speciale venerazione presso i pellegrini e proprio per questo sorsero in suo onore istituzioni e congregazioni aventi lo scopo di aiutare i viaggiatori che dovevano superare difficoltà naturali di vario genere. Questo intenso culto determinò il sorgere di una letteratura copiosa e stra-
ordinaria, caratterizzata da leggende e narrazioni favolose dove, indipendentemente dall’obbiettività storica, è degna di ammirazione la ricca fantasia dei compilatori. Si nota, tuttavia, come le leggende orientali differiscano, in parte, da quelle occidentali. Secondo i sinassari, Cristoforo era un guerriero appartenente a una rozza tribù di antropofagi; si chiamava Reprobo e nell’aspetto “dalla testa di cane” (come lo definiscono gli Atti) dimostrava vigoria e forza. Il particolare della cinocefalia ha indotto qualche critico moderno a vedere nelle leggende l’influsso di elementi della religione egiziana, presi specialmente dal mito del dio Anubis, o anche di Ermete ed Eracle. Narra ancora la leggenda che, entrato nell’esercito imperiale, Cristoforo si convertì al Cristianesimo e iniziò con successo fra i suoi commilitoni un’intensa propaganda. Denunziato, fu condotto davanti al giudice che lo sottopose a svariati supplizi. Due donne, Niceta e Aquilina, incaricate di corromperlo, furono da lui convertite e trasformate in apostole (nel Martirologio Romano sono menzionate come martiri al 24 luglio). Cristoforo prima fu battuto con verghe, in seguito colpito con frecce, poi gettato nel fuoco e, infine, decapitato. Jacopo da Varagine (sec. XIII), con la sua Legenda Aurea, fu l’autore che in Occidente rese celebre Cristoforo Secondo questo testo, egli era un giovane gigante che si era proposto di servire il signore più potente. Per questo fu successivamente al servizio di un re, di un imperatore, poi del demonio, dal quale apprese che Cristo era il più forte di tutti: di qui nacque il desiderio della conversione. Da un pio eremita fu istruito sui precetti della carità: volendo esercitarsi in tale virtù e prepararsi al battesimo, scelse un’abitazione nelle vicinanze di un fiume, con lo scopo di aiutare i viaggiatori a passare da una riva all’altra. Una notte fu svegliato da un grazioso fanciullo che lo pregò di traghettarlo; il santo se lo caricò sulle spalle, ma più s’inoltrava nell’acqua, più il peso del fanciullo aumentava e a stento, aiutandosi col grosso e lungo bastone, riuscì a guadagnare l’altra riva. Qui il bambino si rivelò come Cristo e gli profetizzò il martirio a breve scadenza. Dopo aver ricevuto il battesimo, Cristoforo si recò in Licia a predicare e qui subì il martirio. Come questa leggenda sia sorta è ancora oggi un problema insoluto. Si sono formulate alcune ipotesi: chi ritiene che il nome Cristoforo (= portatore di Cristo) abbia potuto suggerire la leggenda; chi suppone che l’iconografia (Cristoforo con Gesù sulle spalle) sia anteriore alla narrazione di Jacopo da Varagine, per cui la rappresentazione iconografica avrebbe ispirato il motivo leggendario. La festa di Cristoforo in Occidente è celebrata il 25 luglio, in Oriente il 9 maggio. Per quanto riguarda il folklore, è da notare come esso non sia diminuito nei tempi recenti, sebbene abbia subito, ovviamente, degli adattamenti. Se nel Medioevo Cristoforo era venerato come protettore dei viandanti e dei pellegrini prima di intraprendere itinerari difficili e pericolosi, oggi il santo è divenuto il protettore degli automobilisti, che lo invocano contro gli incidenti e le disgrazie stradali. Varie altre categorie si affidano alla sua tutela: i portalettere, gli atleti, i facchini, gli scaricatori e, in genere, coloro che esercitano un lavoro pesante ed esposto a vari rischi. La leggenda del bastone fiorito, dopo il trasporto di Gesù, ha contribuito a dichiararlo protettore dei fruttivendoli. Fu anche uno dei quattordici santi ausiliatori, di quei santi, cioè, invocati in occasione di gravi calamità naturali. Questa devozione sorse nel sec. XII e si sviluppò nel sec. XIV. Il patrocinio di Cristoforo era specialmente invocato contro la peste. La leggenda, inoltre, ispirò in Italia e in Francia poemetti e sacre rappresentazioni.
Autore: Gian Domenico Gordini
Glogowiec, Polonia, 25 agosto 1905 - Cracovia, Polonia, 5 ottobre 1938
Helena Kowalska nacque il 25 agosto 1905 nel villaggio di Głogowiec in Polonia, terza dei dieci figli di una coppia di contadini. Lasciata la casa paterna a 16 anni, lavorò come donna di servizio in alcune famiglie finché, nell’agosto 1925, non entrò nella Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia a Varsavia; con la vestizione religiosa, assunse il nome di suor Maria Faustina. Impegnata nei più umili servizi in varie case della sua Congregazione, non lasciava trasparire nulla delle straordinarie comunicazioni divine che andava registrando nei suoi diari, cercando invece di vivere strettamente unita alla volontà di Dio e confidando nella sua misericordia. Malata di tubercolosi, morì il 5 ottobre 1938 nel convento di Cracovia-Łagiewniki, a 33 anni. Il culto alla Divina Misericordia, di cui si è fatta portavoce, si è ben presto diffuso in Polonia e non solo. Beatificata da san Giovanni Paolo II il 18 aprile 1993, è stata da lui canonizzata il 30 aprile 2000. I suoi resti sono venerati nel Santuario della Divina Misericordia a Cracovia-Łagiewniki.
Etimologia: Faustina (come Fausta) = propizia, favorevole, dal latino
Martirologio Romano: Santa Faustina Kowalska, vergine, delle Suore della beata Maria Vergine della Misericordia, fu sollecita nella propagazione del mistero della divina misericordia. Morì santamente nel Signore a Cracovia, in Polonia.
Suor Faustina, terzogenita di dieci figli, nacque il 25 agosto 1905 da una povera famiglia di contadini, che abitava nel villaggio di Glogowiec in Polonia. Nel battesimo, ricevuto nella Chiesa parrocchiale di Swinice Warckie, presso Lódz, le venne posto il nome di Elena. La famiglia Kowalski viveva di un piccolo podere agricolo e dell’attività di falegname del padre Stanislao, un uomo religioso, molto laborioso ma nello stesso tempo severo, il quale dimostrava un forte senso di responsabilità nell’adempimento dei suoi doveri professionali e familiari ed esigeva lo stesso dai figli, richiamandoli anche nelle loro più piccole trasgressioni.
La madre, Marianna Babel, era invece una persona sensibile, affettuosa, tollerante, laboriosa e tenace; insegnava alla piccola Elena e ai suoi fratelli le verità della fede e gli stessi principi di condotta cristiana professati dal padre. Vivendo in questo ambiente i bambini crescevano con un profondo senso della disciplina e dell’obbedienza maturando una grande stima per le cose sante. Inoltre fin da piccoli essi venivano educati alla laboriosità, al senso di responsabilità ed alla collaborazione familiare.
Nella famiglia Kowalski la fede costituiva l’elemento essenziale della vita: Dio era sempre al primo posto e ogni giorno la preghiera si univa armoniosamente al lavoro. Infatti il padre stesso, fin dal primo mattino, cantava il tradizionale inno dell’alba: Kiedy ranne wstajq zorze e le Piccole Ore della Beata Vergine Maria; mentre durante la Quaresima tutti insieme cantavano Amari Lamenti e osservavano scrupolosamente il digiuno e l’astinenza. Anche se la famiglia viveva poveramente del duro lavoro, tuttavia riusciva a trovare sia il denaro per comprare i libri religiosi sia il tempo per la lettura fatta in comune. Sono state proprio queste letture a far nascere la disposizione alla vita religiosa nell’animo della piccola Elena che fin dall’infanzia voleva vivere per Dio come i protagonisti di questi libri. Ella ne ricordava bene il contenuto e
lo raccontava ai suoi coetanei durante il pascolo del bestiame o mentre giocavano insieme. Il clima religioso della famiglia favoriva in lei il formarsi di una viva e personale unione con Dio, che si è rivelata molto presto, fin dall’età di sette anni, come ella stessa scrisse nel Diario: « O Gesù nascosto, in Te c’è tutta la mia forza. Fin dai più teneri anni Gesù nel Santissimo Sacramento mi ha attirata a Sé. All’età di sette anni, mentre ero ai vespri e Gesù era esposto nell’ostensorio fu allora che mi venne trasmesso per la prima volta l’amore di Dio che riempì il mio piccolo cuore, ed il Signore mi fece comprendere le cose divine... Tutta la forza della mia anima proviene dal Santissimo Sacramento ».
A nove anni, come si usava allora, fece la sua prima confessione e si accostò alla Santa Comunione. Tornando dalla chiesa sentiva vivamente la presenza del Divino Ospite nella sua anima. « Perché non vai insieme alle tue amiche? - le domandò la vicina di casa -. Io vado con il Signore Gesù », rispose seriamente. La sua amica in quel giorno era felice perché aveva un bel vestito, mentre Elena era contenta perché aveva ricevuto Gesù. Istruita sui doveri religiosi, non soltanto cercava di adempirli da sola, ma desiderava anche che gli altri li adempissero. Il suo primo impegno era la Santa Messa domenicale. Quando non aveva un vestito decoroso per andare in chiesa, si rifugiava nell’orto con il libro delle preghiere, unendosi spiritualmente al sacerdote e ai fedeli che partecipavano alla Santa Messa; non rispondeva neppure alle chiamate della madre e solo dopo la celebrazione dell’Eucaristia andava da lei e baciandole la mano diceva: « Mammina, non ti arrabbiare, Gesù si sarebbe rattristato più di te se non mi fossi raccolta in preghiera ». Tra i suoi fratelli si distingueva non soltanto per la devozione e l’amore per la preghiera, ma anche per la laboriosità, l’obbedienza e la serena accettazione della povertà. Grazie ad un profondo senso di responsabilità aiutava molto volentieri i genitori rinunciando anche ai giochi; voleva essere obbediente ed evitare di dar loro dei dispiaceri. Fin da bambina era molto sensibile alle privazioni ed alla miseria della gente e cercava in ogni modo di aiutarla. Un giorno, per esempio, vestita da mendicante, si mise a girare per le case e, recitando preghiere, chiedeva l’elemosina per i poveri. Un’altra volta invece organizzò una lotteria, e i soldi raccolti li diede al parroco, destinandoli ai bisognosi. Frequentò la scuola di Swinice aperta nel 1917 solo per tre anni. La cominciò all’età di 12 anni e sebbene fosse una brava scolara, dovette rinunciare agli studi per far posto ai bambini più piccoli. Elena lasciò la casa natale quando aveva 16 anni portando con sé il tesoro della fede, l’amore per la preghiera, i sani principi della morale cristiana, nonché le virtù della laboriosità, dell’obbedienza e un forte senso di responsabilità. Prima andò ad Aleksandrów, vicino a Lódz dove lavorò come domestica dalla Signora Leokadia Bryszewska, proprietaria di un panificio. In quel periodo ebbe la misteriosa visione del « chiarore ». Dopo tale evento tornò a casa per chiedere il permesso di entrare in un convento. I genitori, pur essendo persone molto religiose, non volevano perdere la figlia migliore e giustificarono il rifiuto del permesso con la mancanza di denaro per la dote.
Ma Elena non si perse d’animo e decise di tornare a lavorare come domestica a Lódz. Prima trovò lavoro presso le Terziarie Francescane e dopo, presso Marcjanna Sadowska, proprietaria di un negozio di alimentari, la quale le affidò il compito di occuparsi della casa e dei bambini. « Era una persona allegra e alla mano - ricordava la sua padrona -. La sera quando si sedeva
sullo sgabello, era subito circondata dai miei tre figli. Le volevano bene perché raccontava loro le fiabe... Quando dovevo partire non ero mai preoccupata, perché lei sapeva fare tutto meglio di me... Era gentile, educata, laboriosa. Non posso dire niente di male di lei perché era fin troppo buona. Così buona che mi mancano le parole di esprimermi ». Suor Faustina KowalskaMancandole il consenso dei genitori, Elena cercava di soffocare la voce della chiamata di Dio che - come scrive nel Diario -sentiva nella sua anima fin dall’età di sette anni. Un giorno andò con la sorella maggiore e con un’amica a una festa. Durante il ballo vide Cristo martoriato, il quale le diceva con rimprovero: «Quanto tempo ancora ti dovrò sopportare? Fino a quando mi ingannerai?». Sconvolta da questa visione lasciò la compagnia ed entrò nella chiesa più vicina, la cattedrale di Lódz. Prostrata davanti al Santissimo Sacramento chiese a Gesù cosa dovesse fare. Gesù le disse: «Parti immediatamente per Varsavia; là entrerai in convento». Informò la sorella della sua decisione, le chiese di salutare i genitori e partì per la capitale. Non conoscendo la città la prima cosa che fece fu di entrare nella chiesa di San Giacomo, nel quartiere di Ochota. Dal parroco ricevette l’indirizzo di una famiglia, presso la quale avrebbe potuto fermarsi finché non fosse stata accolta in un convento. « In quel tempo - annotò nel Diario - cominciai a cercare un convento, ma a qualsiasi porta ove bussai, incontrai un netto rifiuto. Il dolore attanagliava il mio cuore e dissi a Gesù: «Aiutami. Non lasciarmi sola»». Finalmente bussò alla porta della casa della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia che si trova a Varsavia in via Zytnia. Dopo un breve colloquio, la superiora della casa, Madre Michaela Moraczewska, le suggerì di chiedere al Padrone della casa se l’avrebbe accolta. Elena comprese che doveva andare nella cappella a interpellare il Signore, e in risposta alla sua domanda sentì: «Ti accolgo; sei nel mio cuore». Quando riferì tali parole alla superi ora, questa le disse: «Se ti ha accettata il Signore, t’accetterò anch’io». Prima però di entrare Elena lavorò ancora per un anno come domestica presso Aldona Lipszyc a Ostrówek, per guadagnarsi una modesta dote. Il 1° agosto 1925 Elena varcava la soglia della clausura nella casa della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia a Varsavia. Nel suo Diario confessa: « Mi sentivo infinitamente felice; mi pareva di essere entrata nella vita del paradiso. Dal mio cuore erompeva, unica, la preghiera della gratitudine ». Dopo alcune settimane sentì una forte tentazione di trasferirsi in un altro convento dove avrebbe potuto trovare più tempo per la preghiera. Allora Gesù, mostrandole il suo volto ferito e addolorato, le disse: «Tu mi causerai un simile dolore, se uscirai da questo ordine. È qui che t’ho chiamata e non altrove e ho preparato per te molte grazie». Alla Congregazione alla quale Cristo chiamò Elena Kowalska appartenevano le cosiddette « Case della Misericordia » il cui scopo era la cura e l’educazione delle ragazze e delle donne bisognose di un profondo rinnovamento spirituale. Le Suore che svolgevano le funzioni di educatrici costituivano il cosiddetto primo coro. Al secondo coro appartenevano le suore che svolgevano i lavori (le mansioni) ausiliari. Ma ogni suora, indipendentemente dal tipo di lavoro a lei affidato, partecipava attivamente all’opera di salvare per l’eternità le anime che sembravano perdute. Elena fu accettata come suora del secondo coro, cioè fra le suore coadiutrici. A Varsavia Elena trascorse i primi mesi della vita religiosa chiamati postulandato. In seguito si recò nella casa della Congregazione a Cracovia per compiere il noviziato. Durante la ce-
rimonia della vestizione ricevette il nome di Suor Maria Faustina. Finito il noviziato emise i primi voti di castità, povertà ed obbedienza che rinnovò per 5 anni consecutivi fino alla professione perpetua emessa il 1° maggio 1933 a Cracovia. « Sono in Lui ed Egli in me - annotò in quell’occasione nel Diario. Nel momento in cui il Vescovo mi ha messo l’anello, Iddio è penetrato in tutto il mio essere... Dopo i voti perpetui la mia intima unione con Dio è tanto forte, quanto non è stata mai in precedenza. Sento che amo Dio e sento che Egli ama me. La mia anima dopo aver gustato Iddio, non saprebbe vivere senza di Lui». Suor Faustina, come professa, visse in diverse case della Congregazione, più a lungo a Cracovia, poi a Plock, quindi a Wilno, adempiendo principalmente le mansioni di cuoca, giardiniera e portinaia. Esteriormente nulla tradiva la straordinaria ricchezza della sua vita mistica. Con zelo eseguiva i doveri che le venivano affidati, osservando fedelmente e scrupolosamente le regole della comunità: così le suore ricordavano Suor Faustina alcuni anni dopo la sua morte. Ella, pur conducendo uno stile di vita semplice, spontaneo ed allegro, tuttavia si distingueva per una intensa vita contemplativa. Nei rapporti con il prossimo manifestava sensibilità e benevolenza, evidenziando continuamente il suo grande amore per ogni persona. Soltanto il Diario ha svelato la profondità della sua vita spirituale nota solo ai confessori ed in parte alle superiore. Da un’attenta lettura di questi appunti si può comprendere quanto misticamente profonda fosse l’unione della sua anima con Dio e quanto Dio fosse presente nella sua anima, come pure le lotte e le difficoltà incontrate nel cammino verso la perfezione cristiana. «Gesù mio, - ha rivelato nel Diario - Tu sai che fin dai miei primissimi anni ho desiderato diventare una grande santa, cioè ho desiderato amarti con un amore tanto grande, quale finora nessun’anima ha avuto verso di Te». Il Signore premiava generosamente il suo impegno spirituale concedendole il dono della contemplazione e della profonda conoscenza del mistero della Misericordia Divina. Gesù la onorava con grazie straordinarie come le visioni, le rivelazioni, le stimmate nascoste, l’unione mistica con Dio, il dono del discernimento dei cuori e della profezia, ecc. Ella, arricchita da queste grazie, ha scritto: « Né le grazie, né le rivelazioni, né le estasi, né alcun altro dono elargito alla mia anima la rendono perfetta, ma l’unione intima del mio spirito con Dio. Questi doni sono soltanto un ornamento dell’anima, ma non ne costituiscono la sostanza né la perfezione. La mia santità e perfezione consistono in una stretta unione della mia volontà con la volontà di Dio ».
Nella vita spirituale di Suor Faustina Gesù ha scolpito due tratti caratteristici per i quali si distingueva quale apostola della Divina Misericordia: l’illimitata fiducia, la totale dedizione a Dio e l’attivo amore verso il prossimo che giungeva fino all’eroismo. « Figlia mia, - le disse Gesù - se per tuo mezzo esigo dagli uomini il culto della mia misericordia, tu devi essere la prima a distinguerti per la fiducia nella mia misericordia. Esigo da te atti di misericordia, che debbono derivare dall’amore verso di me. Devi mostrare sempre e dovunque la misericordia verso il prossimo: non puoi esimerti da questo, né rifiutarti né giustificarti».
Suor Faustina era cosciente dell’azione di Dio nella sua anima e generosamente collaborava con la sua grazia. « O mio Gesù, - pregava - ognuno dei tuoi santi rispecchia in sé una delle tue virtù; io desidero rispecchiare il tuo Cuore compassionevole e pie-
no di misericordia... La tua misericordia, o Gesù, sia impressa nel mio cuore e nella mia anima come un sigillo, e ciò sarà il mio segno distintivo in questa e nell’altra vita». La via dell’unione con Dio passa sempre attraverso la croce. La sofferenza purifica l’anima rendendola capace della più intensa partecipazione alla vita divina e all’opera redentrice di Gesù Cristo. Suor Faustina cercava di impararlo fin da bambina decidendo: « Nelle sofferenze conservare la serenità e l’equilibrio. Nei momenti difficili rifugiarsi nelle Piaghe di Gesù... Nelle prove procurerò di vedere l’amorevole mano di Dio ». Ha capito che «tanto più il nostro amore diventa puro, tanto meno il fuoco delle sofferenze avrà da distruggere in noi e la sofferenza per noi cesserà di essere sofferenza: diventerà per noi una delizia. Con la grazia di Dio ora ho ottenuto questa disposizione del cuore, - annotava - cioè non sono mai tanto felice, come quando soffro per Gesù che amo con ogni palpito del cuore». L’austerità della vita e i digiuni estenuanti ai quali si sottoponeva ancora prima di entrare nella Congregazione avevano indebolito il suo organismo e già durante il postulandato fu mandata a Skolimów, vicino a Varsavia, per curarsi. Dopo l’anno di noviziato ebbe le prime dolorose esperienze mistiche della « notte oscura dell’anima » e le sofferenze spirituali legate alla realizzazione della missione ricevuta da Gesù Cristo. Il Giovedì Santo del 1934 si offrì come vittima di espiazione per i peccatori e ciò le comportò, in seguito, una serie di varie sofferenze per la salvezza delle anime. « Ho bisogno delle tue sofferenze per la salvezza delle anime », le ha insegnato Gesù. « Sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano, silenzioso martirio nella totale sottomissione alla mia volontà, conduce molte anime in paradiso, e quando ti sembra che la sofferenza oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe... La meditazione sulla mia passione ti aiuta a sollevarti al di sopra di tutto ». Negli ultimi anni della sua vita si intensificarono le sofferenze interiori della « notte passiva dello spirito » e le sofferenze fisiche: si aggravò la tubercolosi attaccando i polmoni e l’apparato digerente. Per questo Suor Faustina dovette ricoverarsi due volte per qualche mese nell’ospedale di Pradnik a Cracovia, dove ricevette il sacramento degli infer mi.
Da quell’ospedale, nell’agosto del 1938, scriveva alla superiora generale Madre Michaela Moraczewska: «Carissima Madre, mi pare che questo sia il nostro ultimo colloquio sulla terra. Mi sento molto debole e scrivo con la mano tremante. Soffro ai limiti della sopportazione. Gesù non ci fa soffrire oltre le nostre forze. Se il dolore è grande, la grazia divina è immensa. Mi abbandono totalmente a Dio e alla Sua santa volontà. Sento sempre più intensa la nostalgia di Dio. La morte non mi fa paura, la mia anima è inondata da una grande calma ». Con questa lettera ringraziava per tutto il bene che aveva ricevuto nella Congregazione dal momento dell’ingresso, si scusava per tutte le infedeltà alla regola e chiedeva la benedizione per l’ora della morte. Alla fine scriveva: «Arrivederci, Carissima Madre, ci vedremo in ciclo ai piedi del Trono Divino». Qualche giorno prima della morte Suor Faustina tornò nel convento di Lagiewniki a Cracovia. Prima di uscire dall’ospedale, il dott. A. Silberg le chiese l’immaginetta di Santa Teresa di Gesù Bambino che stava sul suo comodino e che lui voleva appendere vicino al letto di suo figlio. E quando l’infermiera espresse la sua preoccupazione per il pericolo di contagio, il medico la tranquillizzò dicendo: «I santi non contagiano». Nell’ospedale le fece visita don Michele Sopocko, suo direttore spirituale di Wilno assegna-
tele da Dio per la realizzazione della missione della Misericordia. In quell’occasione Suor Faustina gli comunicò il giorno della propria morte. «Sembrava un essere divino - ha scritto di lei in seguito don Michele. - Allora non ho avuto più alcun dubbio che quello che era scritto nel suo Diario riguardo la Santa Comunione concessale dall’Angelo, fosse vero ». Nel convento, come richiedeva la regola, Suor Faustina invitò nella sua cella le consorelle per salutarle, per ringraziarle per tutti i favori ottenuti e per chiedere scusa per le eventuali trasgressioni commesse. Con il suo comportamento, la sua serenità, la sua pazienza, la sottomissione amorosa alla volontà di Dio, fu edificante per tutte. Alla Superiora, Suor Irene Krzyzanowska, disse di non preoccuparsi per il culto della Misericordia Divina; personalmente desiderava che si adempisse solo la volontà di Dio al riguardo. Oltre a ciò aggiunse ancora: « Gesù vuole esaltarmi e la Congregazione per merito della mia persona potrà trarre molti benefici ». Si percepiva la sua intensa unione con Dio e una « quiete interiore - ricordava la superiora -che qualche volta non volevo turbare con le parole ». Il 5 ottobre 1938 venne a visitarla P. Giuseppe Andrasz, S.I., e Suor Faustina si confessò per l’ultima volta. La sera tardi, vicino al suo letto, si radunarono le consorelle che insieme al cappellano recitarono le preghiere per i moribondi. Suor Faustina partecipava alle loro preghiere, consapevole di essere giunta agli ultimi momenti della sua vita terrestre. Alle 22.45 si avviava silenziosamente verso la casa del Padre per cantare eternamente l’inno alla Misericordia Divina. Consumata nel corpo e misticamente unita a Dio, morì in concetto di santità all’età di 33 anni, dopo 13 anni di vita religiosa. Nel Diario ha scritto: « Non mi dimenticherò di te, povera terra, sebbene senta che m’immergerò immediatamente tutta in Dio, come in un oceano di felicità, ma ciò non mi potrà impedire di tornare sulla terra a dare coraggio alle anime ed esortarle alla fiducia nella divina misericordia. Anzi, quell’immersione in Dio mi darà una possibilità d’azione illimitata ». Il funerale ebbe luogo il 7 ottobre, il giorno della festa della Madonna del Rosario e primo venerdì del mese. Dei suoi parenti non venne nessuno perché Suor Faustina, considerando il costo del viaggio, aveva chiesto di non informarli. Dopo la Santa Messa, nel corteo funebre presieduto dai sacerdoti, le suore e le educande portarono a spalla la bara nel cimitero del convento e lì, dopo la cerimonia di commiato, venne deposta nella tomba. Durante la seconda guerra mondiale si è diffusa velocemente nel mondo la devozione alla Misericordia Divina. A seguito di questo don Sopocko ha ritenuto opportuno rivelare chi era la sua promotrice, la cui fama di santità cresceva di anno in anno. Così si sono realizzate le sue parole profetiche scritte nel Diario: « Avverto bene che la mia missione non finirà con la mia morte, ma incomincerà ». Prima della sua morte, poche persone erano a conoscenza della sua profonda vita mistica e della missione che doveva compiere; oggi il messaggio della Misericordia a lei rivelato da Gesù è noto in tutti i continenti e si diffonde rapidamente tra il clero e tra i fedeli. Al Santuario della Misericordia Divina di Lagiewniki a Cracovia, dove si trova l’immagine di Gesù Misericordioso, fonte di grazia e di salvezza, e dove dal 1966 riposano i resti mortali di Suor Faustina, giungono pellegrini da tutta la Polonia e da molti paesi del mondo per chiedere l’intercessione dell’umile Apo-stola della Misericordia Divina. Le numerose testimonianze di riconoscenza per le grazie e i benefici concessi, costituiscono la prova dell’efficacia della sua mediazione.
Fonte: www.divinamisericordia.it
Paola, Cosenza, 27 marzo 1416 - Plessis-les-Tours, Francia, 2 aprile 1507
La sua vita fu avvolta in un’aura di soprannaturale dalla nascita alla morte. Nacque a Paola (Cosenza) nel 1416 da genitori in età avanzata devoti di san Francesco, che proprio all’intercessione del santo di Assisi attribuirono la nascita del loro bambino. Di qui il nome e la decisione di indirizzarlo alla vita religiosa nell’ordine francescano. Dopo un anno di prova, tuttavia, il giovane lasciò il convento e proseguì la sua ricerca vocazionale con viaggi e pellegrinaggi. Scelse infine la vita eremitica e si ritirò a Paola in un territorio di proprietà della famiglia. Qui si dedicò alla contemplazione e alle mortificazioni corporali, suscitando stupore e ammirazione tra i concittadini. Ben presto iniziarono ad affluire al suo eremo molte persone desiderose di porsi sotto la sua guida spirituale. Seguirono la fondazione di numerosi eremi e la nascita della congregazione eremitica paolana detta anche Ordine dei Minimi. La sua approvazione fu agevolata dalla grande fama di taumaturgo di Francesco che operava prodigi a favore di tutti, in particolare dei poveri e degli oppressi. Lo stupore per i miracoli giunse fino in Francia, alla corte di Luigi XI, allora infermo. Il re chiese al papa Sisto IV di far arrivare l’eremita paolano al suo capezzale. L’obbedienza prestata dal solitario costretto ad abbandonare l’eremo per trasferirsi a corte fu gravosa ma feconda. Luigi XI non ottenne la guarigione, Francesco fu tuttavia ben voluto ed avviò un periodo di rapporti favorevoli tra il papato e la corte francese. Nei 25 anni che restò in Francia egli rimase un uomo di Dio, un riformatore della vita religiosa. Morì nei pressi di Tours il 2 aprile 1507.
Patronato: Calabria, Naviganti, pescatori.
Etimologia: Francesco = libero, dall’antico tedesco
Martirologio Romano: San Francesco da Paola, eremita: fondò l’Ordine dei Minimi in Calabria, prescrivendo ai suoi discepoli di vivere di elemosine, senza possedere nulla di proprio né mai toccare denaro, e di mangiare sempre soltanto cibi quaresimali; chiamato in Francia dal re Luigi XI, gli fu vicino nel momento della morte; morì a Plessy presso Tours, celebre per la sua austerità di vita.
La sua vita fu uno stupore continuo sin dalla nascita, infatti Francesco nacque il 27 marzo 1416 da una coppia di genitori già avanti negli anni, il padre Giacomo Alessio detto “Martolilla” e la madre Vienna di Fuscaldo, durante i quindici anni di matrimonio già trascorsi, avevano atteso invano la nascita di un figlio, per questo pregavano s. Francesco, il ‘Poverello’ di Assisi, di intercedere per loro e inaspettatamente alla fine il figlio arrivò. Riconoscenti i giubilanti genitori lo chiamarono Francesco; il santo di Assisi intervenne ancora nella vita di quel bimbo nato a Paola, cittadina calabrese sul Mar Tirreno in provincia di Cosenza; dopo appena un mese si scoprì che era affetto da un ascesso all’occhio sinistro che si estese fino alla cornea, i medici disperavano di salvare l’occhio. La madre fece un voto a s. Francesco, di tenere il figlio in un convento di Frati Minori per un intero anno, vestendolo dell’abito proprio dei Francescani, il voto dell’abito è usanza ancora esistente nell’Italia Meridionale. Dopo qualche giorno l’ascesso scomparve completamente. Fu allevato senza agi, ma non mancò mai il necessario;
imparò a leggere e scrivere verso i 13 anni, quando i genitori volendo esaudire il voto fatto a s. Francesco, lo portarono al convento dei Francescani di San Marco Argentano, a nord di Cosenza. In quell’anno l’adolescente rivelò subito doti eccezionali, stupiva i frati dormendo per terra, con continui digiuni e preghiera intensa e già si cominciava a raccontare di prodigi straordinari, come quando assorto in preghiera in chiesa, si era dimenticato di accendere il fuoco sotto la pentola dei legumi per il pranzo dei frati, allora tutto confuso corse in cucina, dove con un segno di croce accese il fuoco di legna e dopo pochi istanti i legumi furono subito cotti. Un’altra volta dimenticò di mettere le carbonelle accese nel turibolo dell’incenso, alle rimostranze del sacrestano andò a prenderle ma senza un recipiente adatto, allora le depose nel lembo della tonaca senza che la stoffa si bruciasse. Trascorso l’anno del voto, Francesco volle tornare a Paola fra il dispiacere dei frati e d’accordo con i genitori intrapresero insieme un pellegrinaggio ad Assisi alla tomba di s. Francesco, era convinto che quel viaggio gli avrebbe permesso d’individuare la strada da seguire nel futuro.
Fecero tappe a Loreto, Montecassino, Monteluco e Roma, nella ‘Città eterna’ mentre camminava per una strada, incrociò una sfarzosa carrozza che trasportava un cardinale pomposamente vestito, il giovanetto non esitò e avvicinatosi rimproverò il cardinale dello sfarzo ostentato; il porporato stupito cercò di spiegare che era necessario per conservare la stima e il prestigio della Chiesa agli occhi degli uomini.
Nella tappa di Monteluco, Francesco poté conoscere in quell’eremo fondato nel 528 da S. Isacco, un monaco siriano fuggito in Occidente, gli eremiti che occupavano le celle sparse per la montagna; fu molto colpito dal loro stile di vita, al punto che tornato a Paola, appena tredicenne e in netta opposizione al dire del cardinale romano, si ritirò a vita eremitica in un campo che apparteneva al padre, a quasi un chilometro dal paese, era il 1429.
Si riparò prima in una capanna di frasche e poi spostandosi in altro luogo in una grotta, che egli stesso allargò scavando il tufo con una zappa; detta grotta è oggi conservata all’interno del Santuario di Paola; in questo luogo visse altri cinque anni in penitenza e contemplazione. La fama del giovane eremita si sparse nella zona e tanti cominciarono a raggiungerlo per chiedere consigli e conforto; lo spazio era poco per questo via vai, per cui Francesco si spostò di nuovo più a valle costruendo una cella su un terreno del padre; dopo poco tempo alcuni giovani dopo più visite, gli chiesero di poter vivere come lui nella preghiera e solitudine. Così nel 1436, con una cappella e tre celle, si costituì il primo nucleo del futuro Ordine dei Minimi; la piccola Comunità si chiamò “Eremiti di frate Francesco”.
Prima di accoglierli, Francesco chiese il permesso al suo vescovo di Cosenza mons. Bernardino Caracciolo, il quale avendo conosciuto il carisma del giovane eremita acconsentì; per qualche anno il gruppo visse alimentandosi con un cibo di tipo quaresimale, pane, legumi, erbe e qualche pesce, offerti come elemosine dai fedeli; non erano ancora una vera comunità ma pregavano insieme nella cappella a determinate ore. Fu in seguito necessario allargare gli edifici e nel 1452 Francesco cominciò a costruire la seconda chiesa e un piccolo convento intorno ad un chiostro, tuttora conservati nel complesso del Santuario.
Durante i lavori di costruzione Francesco operò altri prodigi, un grosso masso che stava rotolando sugli edifici venne fermato con un gesto del santo e ancora oggi esiste sotto la strada del
Santuario; entrò nella fornace per la calce a ripararne il tetto, passando fra le fiamme e rimanendo illeso; inoltre fece sgorgare una fonte con un tocco del bastone, per dissetare gli operai, oggi è chiamata “l’acqua della cucchiarella”, perché i pellegrini usano attingerne con un cucchiaio. Ormai la fama di taumaturgo si estendeva sempre più e il papa Paolo II (14641471), inviò nel 1470 un prelato a verificare; giunto a Paola fu accolto da Francesco che aveva fatto portare un braciere per scaldare l’ambiente; il prelato lo rimproverò per l’eccessivo rigore che professava insieme ai suoi seguaci e allora Francesco prese dal braciere con le mani nude, i carboni accesi senza scottarsi, volendo così significare se con l’aiuto di Dio si poteva fare ciò, tanto più si poteva accettare il rigore di vita.
La morte improvvisa del papa nel 1471, impedì il riconoscimento pontificio della Comunità, che intanto era stata approvata dal vescovo di Cosenza Pirro Caracciolo; il consenso pontificio arrivò comunque tre anni più tardi ad opera del nuovo papa Sisto IV (1471-1484). Secondo la tradizione, uno Spirito celeste, forse l’arcangelo Michele, gli apparve mentre pregava, tenendo fra le mani uno scudo luminoso su cui si leggeva la parola “Charitas” e porgendoglielo disse: “Questo sarà lo stemma del tuo Ordine”. La fama di questo monaco dalla grossa corporatura, con barba e capelli lunghi che non tagliava mai, si diffondeva in tutto il Sud, per cui fu costretto a muoversi da Paola per fondare altri conventi in varie località della Calabria. Gli fu chiesto di avviare una comunità anche a Milazzo in Sicilia, pertanto con due confratelli si accinse ad attraversare lo Stretto di Messina, qui chiese ad un pescatore se per amor di Dio l’avesse traghettato all’altra sponda, ma questi rifiutò visto che non potevano pagarlo; senza scomporsi Francesco legò un bordo del mantello al bastone, vi salì sopra con i due frati e attraversò lo Stretto con quella barca a vela improvvisata. Il miracolo fra i più clamorosi di quelli operati da Francesco, fu in seguito confermato da testimoni oculari, compreso il pescatore Pietro Colosa di Catona, piccolo porto della costa calabra, che si rammaricava e non si dava pace per il suo rifiuto. Risanava gli infermi, aiutava i bisognosi, ‘risuscitò’ il suo nipote Nicola, giovane figlio della sorella Brigida, anche suo padre Giacomo Alessio, rimasto vedovo entrò a far parte degli eremiti, diventando discepolo di suo figlio fino alla morte. Francesco alzava spesso la voce contro i potenti in favore degli oppressi, le sue prediche e invettive erano violente, per cui fu ritenuto pericoloso e sovversivo dal re di Napoli Ferdinando I (detto Ferrante) d’Aragona, che mandò i suoi soldati per farlo zittire, ma essi non poterono fare niente, perché il santo eremita si rendeva invisibile ai loro occhi; il re alla fine si calmò, diede disposizione che Francesco poteva aprire quanti conventi volesse, anzi lo invitò ad aprirne uno a Napoli (un altro era stato già aperto nel 1480 a Castellammare di Stabia. A Napoli giunsero due fraticelli che si sistemarono in una cappella campestre, là dove poi nel 1846 venne costruita la grande, scenografica, reale Basilica di S. Francesco da Paola, nella celebre Piazza del Plebiscito. Intanto si approssimava una grande, imprevista, né desiderata svolta della sua vita; nel 1482 un mercante italiano, di passaggio a Plessis-les-Tours in Francia, dove risiedeva in quel periodo il re Luigi XI (1423-1482), gravemente ammalato, ne parlò ad uno scudiero reale, che informò il sovrano. Il re inviò subito un suo maggiordomo in Calabria ad invitare il santo eremita, affinché si recasse in Francia per aiutarlo, ma Francesco rifiutò, nonostante che anche il re di Napoli Ferrante appoggiasse la richiesta.
Allora il re francese si rivolse al papa Sisto IV, il quale per motivi politici ed economici, non voleva scontentare il sovrano e allora ordinò all’eremita di partire per la Francia, con grande sgomento e dolore di Francesco, costretto a lasciare la sua terra e i suoi eremiti ad un’età avanzata, aveva 67 anni e malandato in salute. Nella sua tappa a Napoli, fu ricevuto con tutti gli onori da re Ferrante I, incuriosito di conoscere quel frate che aveva osato opporsi a lui; il sovrano assisté non visto ad una levitazione da terra di Francesco, assorto in preghiera nella sua stanza; poi cercò di conquistarne l’amicizia offrendogli un piatto di monete d’oro, da utilizzare per la costruzione di un convento a Napoli. Si narra che Francesco presone una la spezzò e ne uscì del sangue e rivolto al re disse: “Sire questo è il sangue dei tuoi sudditi che opprimi e che grida vendetta al cospetto di Dio”, predicendogli anche la fine della monarchia aragonese, che avvenne puntualmente nei primi anni del 1500. Sempre vestito del suo consunto saio e con in mano il rustico bastone, fu ripreso di nascosto da un pittore, incaricato dal re di fargli un ritratto, che è conservato nella Chiesa dell’Annunziata a Napoli, mentre una copia è nella Chiesa di S. Francesco da Paola ai Monti in Roma; si ritiene che sia il dipinto più somigliante quando Francesco aveva 67 anni. Passando per Roma andò a visitare il pontefice Sisto IV (1471-1484), che lo accolse cordialmente; nel maggio 1489 arrivò al castello di Plessis-du-Parc, dov’era ammalato il re Luigi XI, nel suo passaggio in terra francese liberò Bormes e Frejus da un’epidemia. A Corte fu accolto con grande rispetto, col re ebbe numerosi colloqui, per lo più miranti a far accettare al sovrano l’ineluttabilità della condizione umana, uguale per tutti e per quante insistenze facesse il re di fare qualcosa per guarirlo, Francesco rimase coerentemente sulla sua posizione, giungendo alla fine a convincerlo ad accettare la morte imminente, che avvenne nel 1482, dopo aver risolto le divergenze in corso con la Chiesa. Dopo la morte di Luigi XI, il frate che viveva in una misera cella, chiese di poter ritornare in Calabria, ma la reggente Anna di Beaujeu e poi anche il re Carlo VIII (1470-1498) si opposero; considerandolo loro consigliere e direttore spirituale.
Giocoforza dovette accettare quest’ultimo sacrificio di vivere il resto della sua vita in Francia, qui promosse la diffusione del suo Ordine, perfezionò la Regola dei suoi frati “Minimi”, approvata definitivamente nel 1496 da papa Alessandro VI, fondò il Secondo Ordine e il Terzo riservato ai laici, iniziò la devozione dei Tredici Venerdì consecutivi.
Francesco morì il 2 aprile 1507 a Plessis-les-Tours, vicino Tours dove fu sepolto, era un Venerdì Santo ed aveva 91 anni e sei giorni.
Già sei anni dopo papa Leone X nel 1513 lo proclamò beato e nel 1519 lo canonizzò; la sua tomba diventò meta di pellegrinaggi, finché nel 1562 fu profanata dagli Ugonotti che bruciarono il corpo; rimasero solo le ceneri e qualche pezzo d’osso
Queste reliquie subirono oltraggi anche durante la Rivoluzione Francese; nel 1803 fu ripristinato il culto. Dopo altre ripartizioni in varie chiese e conventi, esse furono riunite e dal 1935 e 1955 si trovano nel Santuario di Paola; dopo quasi cinque secoli il santo eremita ritornò nella sua Calabria di cui è patrono, come lo è di Paola e Cosenza. Nel 1943 papa Pio XII, in memoria della traversata dello Stretto, lo nominò protettore della gente di mare italiana. Quasi subito dopo la sua canonizzazione, furono erette in suo onore
basiliche reali a Parigi, Torino, Palermo e Napoli e il suo culto si diffuse rapidamente nell’Italia Meridionale, ne è testimonianza l’afflusso continuo di pellegrini al suo Santuario, eretto fra i monti della costa calabra che sovrastano Paola, sui primi angusti e suggestivi ambienti in cui visse e dove si sviluppò il suo Ordine dei ‘Minimi’.
Autore: Antonio Borrelli
San Francesco di Paola compie tanti miracoli ed è molto venerato in Calabria. Nasce a Paola (Cosenza) nel 1416 in una povera famiglia. La coppia anziana desidera un figlio e prega San Francesco d’Assisi perché compia il prodigio. Così avviene. Dopo quindici anni di matrimonio, nasce un bel maschietto che viene chiamato come il Poverello d’Assisi, Francesco. Subito dopo, un occhio del piccolo si ammala. I genitori promettono di tenere il bambino per un anno in convento e pregano San Francesco. L’implorazione viene ascoltata: il bambino guarisce e la promessa viene mantenuta. Quando entra in convento Francesco è un ragazzino, ma già desidera vivere come umile frate: dorme per terra, si ciba poco, prega sempre. Sente, poi, di volersi dedicare completamente a Dio e si ritira in una grotta sul mare, vicino a Paola, dove, per cinque anni, vive in solitudine mangiando solo erba. Compie tanti miracoli e diventa famosissimo. In convento accende la pentola con i legumi con il segno della croce. Guarisce lebbrosi, ciechi e paralitici. Moltiplica il pane e il vino. Libera città da epidemie. Il miracolo più conosciuto è quello della traversata dello Stretto di Messina sul suo mantello, poiché il santo non ha denaro per pagare il barcaiolo che dovrebbe traghettarlo. Lo stesso barcaiolo, testimone del prodigio, si pente di aver negato il suo aiuto e chiede perdono al frate. Attorno a Francesco convergono molti discepoli. Nasce così l’Ordine degli Eremiti (o dei Minimi) di San Francesco d’Assisi. Il santo si reca pellegrino ad Assisi, Montecassino, Loreto e Roma. A Roma, Francesco rimane turbato dalla vita sfarzosa condotta da un cardinale, tanto da redarguirlo ricordandogli la semplicità evangelica. I potenti dell’epoca vogliono conoscerlo, essere da lui consigliati, guariti, come il re di Francia Luigi XI molto ammalato. Il frate si reca in Francia. Non guarisce il re ma gli dà tanta serenità. La corte lo ama e lo stima, tanto da farlo restare in Francia per venticinque anni, tempo che Francesco utilizza per far nascere tanti altri conventi. L’umile francescano rimane per tutta la vita povero, semplice, difende i poveri e si scaglia contro i potenti che conducono vita agiata e mondana e tartassano ingiustamente il popolo. Francesco di Paola muore nel 1507, a 91 anni, a Tours (Francia). Protettore di eremiti, marinai, viaggiatori e pescivendoli, viene invocato da coppie sterili per avere un figlio. È patrono della Calabria.
Autore: Mariella Lentini
Di famiglia plebea (umile), Elena venne ripudiata dal marito. Quando il figlio Costantino divenne imperatore, Elena riacquistò il suo onore e ottenne il titolo di «Augusta».
Questo segnò una nuova epoca per il cristianesimo, poiché Costantino concesse la libertà di culto ai cristiani. Elena ebbe un ruolo fondamentale nella conversione del figlio e compì opere di bene, costruendo basiliche sui luoghi santi. Scoprì la tomba di Cristo e la croce del Signore nel 326. Sant’Elena è venerata sia nella Chiesa latina che in quella ortodossa, spesso raffigurata con suo figlio Costantino.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri quale patronato spetta a Sant’Elena.
Soluzione:
Attività 1

Cima da Conegliano, Sant'Elena Imperatrice, 1495, National Gallery of Art, Washington.
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Nell'opera manca una parte del paesaggio, quale? Scoprila con l'aiuto dell'insegnante e poi prova a disegnarla.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.
L’immagine più comune di San Cristoforo mostra un gigante barbuto che trasporta Gesù Bambino su una spalla, aiutandolo a attraversare un fiume. Gesù Bambino tiene il mondo tra le dita, come se fosse un gioco. Questa rappresentazione deriva da una leggenda sul Santo, martirizzato il 25 luglio a Samo, in Licia. Si narra che il suo vero nome fosse Reprobo, un gigante che desiderava servire il re più potente. Dopo aver scoperto che il suo re temeva il diavolo, Reprobo lo cercò e divenne suo servitore. Tuttavia, quando il diavolo scappò davanti a una croce, Reprobo decise di abbandonarlo e cercare Gesù Cristo. Un eremita gli suggerì di aiutare i viandanti ad attraversare un fiume pericoloso. Un giorno, sentì un bambino chiedere aiuto e, trasportandolo, sentì un peso crescente. Alla fine, il bambino rivelò di essere Gesù, e il peso rappresentava il mondo intero, salvato dal sangue di Cristo.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri quale patronato spetta a San Cristoforo.
Attività 1

Orazio Borgianni, San Cristoforo, secolo XVI, Museo del Prado, Madrid.
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Nell’opera il mantello di Cristoforo è senza colore. Scopri qual è il colore e il suo significato con l’aiuto dell’insegnante. Poi colora.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.
Helena Kowalska era la terza di dieci figli di una famiglia di contadini. A 16 anni lasciò la casa e lavorò come donna di servizio. Poi decise di diventare suora e prese il nome di Maria Faustina.
Suor Maria Faustina è una figura importante nella spiritualità cristiana, poiché ha dato inizio al culto alla Divina Misericordia.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri la parola chiave di Suor Faustina.
Soluzione:
Attività 1
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Nell’opera i raggi che emana Gesù da suo cuore non sono colorati.
Scopri con l’aiuto dell’insegnante il colore e il loro significato. Poi completa.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.

Eugeniusz Kazimirowski, Gesù Misericordioso, ispirato alla visione di Santa Faustina Kowalska.
Francesco nacque a Paola in Calabria da genitori molto devoti di san Francesco d’Assisi, e il suo nome e la sua vita religiosa furono influenzati da questo. Uomo dotato di una grande spiritualità, Francesco iniziò la sua vita religiosa nell’ordine francescano, ma lasciò il convento dopo un anno.
Da allora cercò la sua vocazione con viaggi e pellegrinaggi, scegliendo infine la vita eremitica a Paola. Qui, attirò seguaci e fondò eremi e diede vita alla congregazione eremitica conosciuta come Ordine dei Minimi. È stato un grande taumaturgo, e i suoi miracoli raggiunsero la corte di Luigi XI in Francia, che lo volle alla sua corte restandoci per ben 25 anni.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri la parola chiave di Francesco di Paola.
Soluzione:
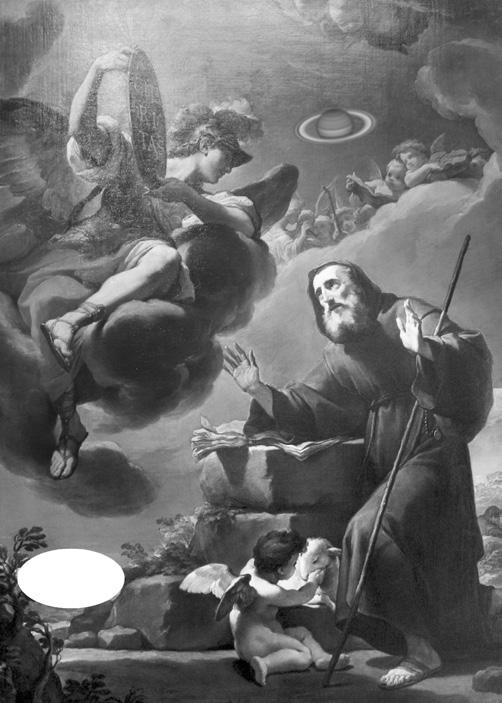
Attività 1
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Sullo sfondo dell’opera c’è un panorama di una città. Scopri con l’aiuto dell’insegnante di quale città si tratta. Poi prova tu a ridisegnarla.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Periodo: settembre
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T
L’alunno
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi;
• riflette su Dio Creatore e Padre.
I valori etici e religiosi
• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.
Periodo: ottobre-novembre
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze
L’alunno
• sa cogliere, attraverso alcune pagine degli Atti degli Apostoli, la vita della Chiesa delle origini.
L’alunno
Partecipa alla discussione del gruppo classe in modo adeguato e pertinente, rispettando il proprio turno di parola.
• Prerequisiti
• Ricordo giocando
• Una zuppa “speciale”
• La zuppa dell’amicizia
• Un talento per tutti
• E tu, che talento hai?
Dio e l’uomo
• Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della chiesa cattolica sin dalle origini.
L’alunno
conosce i fondatori del cristianesimo e le loro storie.
• Maria, madre della Chiesa
• Una donna da festeggiare
• Da Simone a Pietro
• Il papa oggi
• Gli stemmi papali
• Da Saulo a Paolo
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Periodo: novembre-dicembre
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT
L’alunno
• individua i tratti essenziali del cristianesimo, della Chiesa e della sua missione. Dio e l’uomo
• Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo.
Periodo: gennaio-febbraio
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze
L’alunno
• conosce le caratteristiche fondamentali delle principali confessioni cristiane.
• riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
L’alunno
scopre il modo in cui vivevano i primi cristiani; apprende, attraverso lo studio delle persecuzioni, che la fede e l’amore sono più forti dell’odio.
• La vita delle prime comunità
• Il diacono Stefano
• Una diffusione contrastata
• Santa Lucia
• Da Costantino a Teodosio
• Due leggi a confronto
• La Domus Ecclesiae
• Dentro le catacombe
• I primi simboli cristiani
• Chiesa e chiese
• Chiese… con stile
• I principi della fede cristiana
Il linguaggio religioso
• Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalla vita della Chiesa.
• Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.
I valori etici e religiosi
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore.
• Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con sé stessi, con l’altro e con Dio.
L’alunno
impara che ci possono essere diversi modi per manifestare la propria fede; scopre che l’arte ha avuto un peso notevole per la divulgazione del pensiero cristiano.
• La nascita del monachesimo
• Il monachesimo in occidente
• Sant’Antonio abate e San Benedetto
• Dentro al monastero
• Un cammino non sempre facile
• La Chiesa d’oriente
• Il culto delle icone
• Gli ordini mendicanti
• Il francescanesimo
• San Giuseppe da Copertino
• Martin Lutero e la riforma
• I principi della chiesa riformata
• Cattolici, ortodossi e riformati
• La controriforma cattolica
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Periodo: marzo-aprile
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze
L’alunno
• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento;
• coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.
La Bibbia e le altre fonti
• Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei santi.
Il linguaggio religioso
• Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo.
L’alunno
coglie la presenza di Dio in ogni tempo e in ogni luogo; scopre che, nonostante le divergenze di pensiero, i cristiani sono tutti fratelli; scopre che solo attraverso la condivisione e l’accettazione reciproca, i cristiani possono diventare testimoni concreti della fede in Cristo.
• Il Concilio Vaticano II
• La nascita dell’ecumenismo
• Voi siete il corpo di Gesù
• L’anno liturgico
• I sacramenti della Chiesa
• Segni e simboli
• La santa messa
• Una famiglia in festa
• Testimoni della Chiesa
• A servizio di Dio e della vita
• Carlo Acutis
Periodo: maggio-giugno
Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze
L’alunno
• sa distinguere il testo biblico da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;
• conosce le caratteristiche principali delle grandi religioni del mondo;
• matura atteggiamenti di rispetto e apprezzamento nei confronti delle diverse religioni e comprende l’importanza del dialogo interreligioso.
La Bibbia e le altre fonti
• Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. Il linguaggio religioso
• Conoscere le origini e lo sviluppo delle grandi religioni del mondo, individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.
L’alunno
scopre gli aspetti fondamentali delle religioni più diffuse al mondo; impara che sono molteplici i modi per rapportarsi ad un essere superiore.
• Tante religioni
• L’ebraismo
• Gli ebrei nella storia
• Il giorno della memoria
• L’islam
• L’induismo
• Il buddismo
• Confucianesimo, taoismo, shintoismo, sikhismo, animismo
• Il dialogo interreligioso
• Un mondo migliore
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Obiettivi minimi
• Conoscere le figure di Maria, San Pietro e San Paolo.
• Conoscere le principali confessioni cristiane.
• Conoscere le persone che formano la Chiesa.
• Sapere che la Chiesa è la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo.
• Conoscere i sacramenti.
• Conoscere i tratti essenziali delle principali religioni del mondo.
• Riconoscere che ogni religione ha i suoi modi di pregare.
Competenze finali
L’alunno…
• acquisisce la consapevolezza della presenza, nel proprio ambiente sociale, di elementi legati al Cristianesimo;
• riconosce e rispetta le altre realtà religiose presenti nella società, individuandone i tratti salienti più evidenti;
• riconosce avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica;
• individua nei sacramenti e nelle celebrazioni liturgiche i segni della salvezza di Gesù e l’agire dello Spirito Santo nella Chiesa fin dalle sue origini;
• scopre la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e sa confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane.
Metodologia
• Lezione interattiva.
• Lavoro individuale.
• Lavoro di gruppo.
• Conversazioni guidate.
Materiali
• Libro di testo.
• Allegati al testo.
• Quaderni.
• Schede e immagini.
• Disegni.
• Materiale audiovisivo.
Spazi
• Aula.
• Aula informatica.
• Biblioteca.
• LIM.
Discipline coinvolte: Italiano, Arte e immagine, Inglese, Matematica, Musica, Storia
Verifica e valutazione (degli obiettivi e delle competenze)
• Compiti di realtà su obiettivi relativi a uno o più traguardi.
• La prova sarà valutata in base ai livelli definiti dalla rubrica valutativa del curricolo verticale.
• Osservazione sistematica dei progressi nel processo di apprendimento.
• Per gli alunni alloglotti, con H, con DSA, con scheda BES, si fa riferimento ai documenti appositamente predisposti.
• La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi compiuti, nonché dell’impegno e del grado di maturazione.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Il percorso della classe quinta è scandito dalle sei unità di apprendimento che affrontano, in ordine, i seguenti argomenti:
1. Di nuovo in viaggio, comincia l’ultimo anno della scuola primaria, un passo fondamentale prima del passaggio alla scuola secondaria;
2. I giganti dell’inizio, conoscenza e approfondimento dei principali personaggi che hanno segnato la nascita e lo sviluppo del cristianesimo: Maria (la mamma di Gesù), Pietro (primo apostolo e papa) e Paolo (l’apostolo delle genti);
3. La Chiesa delle origini, le vicende delle prime comunità cristiane narrate negli Atti degli Apostoli, a partire dalla conoscenza del diacono Stefano, primo martire della chiesa, lo studio dei simboli paleocristiani e dei primi luoghi di preghiera (domus ecclesiae, catacombe, basiliche) fino allo sviluppo delle chiese e i suoi stili architettonici nel corso dei secoli;
4. La Chiesa nel tempo, lo sviluppo del cristianesimo e dei principali protagonisti: dal monachesimo con San Benedetto da Norcia, al francescanesimo con San Francesco d’Assisi, dalle divisioni all’interno della chiesa (scisma d’Oriente e Occidente) fino al Concilio di Trento (Controriforma cattolica);
5. La vita della Chiesa , la storia della Chiesa dal Concilio Vaticano II a oggi attraverso le figure e i momenti principali della Chiesa cattolica, mostrando come all'interno della comunità cristiana esistano vocazioni e carismi diversi, presentati dalle esperienze di alcuni testimoni, persone o associazioni che svolgono un compito a servizio degli altri a seconda dei propri talenti e delle proprie capacità.
6. Le grandi religioni, conoscenza e approfondimento delle principali religioni del mondo, a partire da ciò che le unisce: la regola aurea; un percorso che si chiude sottolineando l’importanza del rispetto reciproco e del dialogo costruttivo.
Competenze in Chiave Europee
• Alfabetica funzionale.
• Personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
• Multilinguistica.
• Matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.
• Consapevolezza ed espressione culturali.
• Cittadinanza.
Metodologia, spazi e materiali
• Lezione interattiva.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
• Lavoro individuale e di gruppo.
• Conversazioni guidate.
• Libro di testo e allegati.
• Quaderni.
• Schede, disegni e immagini.
• Materiale audiovisivo.
• Aula (classica, LIM, informatica).
Saranno coinvolte le seguenti discipline:
Verifica e valutazione
• Compiti di realtà su obiettivi relativi a uno o più traguardi.
• La prova sarà valutata in base ai livelli definiti dalla rubrica valutativa del curricolo verticale.
• Osservazione sistematica dei progressi nel processo di apprendimento.
• Per gli alunni alloglotti, con H, con DSA, con scheda BES, si fa riferimento ai documenti appositamente predisposti.
• La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi compiuti, nonché dell’impegno e del grado di maturazione.
Educazione Civica, Italiano, Arte e immagine, Inglese, Matematica, Musica, Storia.
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi;
• riflette su Dio Creatore e Padre;
• sa cogliere, attraverso alcune pagine degli Atti degli Apostoli, la vita della Chiesa delle origini;
• individua i tratti essenziali del cristianesimo, della Chiesa e della sua missione;
• conosce le caratteristiche fondamentali delle principali confessioni cristiane;
• riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale;
• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento;
• coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani;
• sa distinguere il testo biblico da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;
• conosce le caratteristiche principali delle grandi religioni del mondo;
• matura atteggiamenti di rispetto e apprezzamento nei confronti delle diverse religioni e comprende l’importanza del dialogo interreligioso.
per unità di apprendimento
Obiettivi di Apprendimento d io e l’uomo l a b ibbia e le alT re fon T i i l linguaggio religio S o i valori e T i C i e religio S i
• Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della chiesa cattolica sin dalle origini.
• Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo.
• Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo.
• Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.
• Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalla vita della Chiesa.
• Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.
• Cogliere il significato dei Sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo.
• Conoscere le origini e lo sviluppo delle grandi religioni del mondo, individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.
• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore.
• Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con sé stessi, con l’altro e con Dio.
Con T enu T i didaT T i C i o bie TT ivi annuali
• Prerequisiti
• Ricordo giocando
• Una zuppa “speciale”
• La zuppa dell’amicizia
• Un talento per tutti
• E tu, che talento hai?
• Maria, madre della Chiesa
• Una donna da festeggiare
• Da Simone a Pietro
• Il papa oggi
• Gli stemmi papali
• Da Saulo a Paolo
• La vita delle prime comunità
• Il diacono Stefano
• Una diffusione contrastata
• Santa Lucia
• Da Costantino a Teodosio
• Due leggi a confronto
• La Domus Ecclesiae
• Dentro le catacombe
• I primi simboli cristiani
• Chiesa e chiese
• Chiese… con stile
• I principi della fede cristiana
• La nascita del monachesimo
• Il monachesimo in occidente
• Sant’Antonio abate e San Benedetto
• Dentro al monastero
• Un cammino non sempre facile
• La Chiesa d’oriente
• Il culto delle icone
• Gli ordini mendicanti
• Il francescanesimo
• San Giuseppe da Copertino
• Martin Lutero e la riforma
• I principi della chiesa riformata
• Cattolici, ortodossi e riformati
• La controriforma cattolica
• Il Concilio Vaticano II
programmazione didaT TiCa annuale per unità di apprendimento
• Rilevare le principali caratteristiche di Maria, scoprirne le peculiarità rispetto alle donne al tempo di Gesù, che le conferiscono un carattere unico, per la quale, la Chiesa, ancora oggi le riconosce una grande venerazione.
• Conoscere lo sviluppo del cristianesimo nelle prime tappe del suo cammino storico.
• Conoscere le difficoltà nel cammino di sviluppo del cristianesimo e del suo riconoscimento come religione.
• Conoscere alcune figure fondamentali che hanno contribuito alla diffusione del cristianesimo nel tempo.
• Conoscere i simboli e i luoghi di preghiera delle prime comunità cristiane.
• Conoscere il significato del Simbolo Apostolico (Credo).
• Approfondire la conoscenza dei sacramenti cristiani e il loro valore nella vita di ogni credente.
• Conoscere le varie tappe e le suddivisioni esistenti all’interno del cristianesimo, e i relativi motivi di separazione.
• Scoprire l’ecumenismo religioso.
• Conoscere la struttura e la gerarchia della Chiesa cristiana, individuando i differenti ruoli presenti all’interno di una comunità.
• Scoprire l’operato di tante persone che hanno vissuto, e che ancora oggi vivono in modo significativo i valori morali universali.
• Conoscere l’originalità dell’esperienza monastica nella cultura medievale e moderna.
L’alunno…
T enze aTT e S e
• Approfondisce le conoscenze sulla figura di Maria, ne comprende l’importanza e la specificità quale madre di Gesù e sa riferirne alcune caratteristiche peculiari.
• Sa individuare le principali feste cristiane dedicate alla figura di Maria.
• Conosce lo stile di vita delle prime comunità cristiane nate a Gerusalemme.
• Matura coscienza sul fenomeno delle persecuzioni e dei pregiudizi, che ancora oggi, segnano l’esistenza umana.
• Comprende l’importanza della lotta per la difesa dei valori in cui l’individuo crede.
• È consapevole dei diversi ruoli all’interno della struttura della Chiesa.
• Sa distinguere i sacramenti e percepisce la loro importanza nella vita dei cristiani.
• Conosce le diverse confessioni presenti all’interno del cristianesimo e sa riferire le cause della loro origine e le caratteristiche fondamentali.
• Comprende il concetto di ecumenismo e rileva come il dialogo costruttivo favorisca la conoscenza e il rispetto dell’altro.
• Percepisce il valore dell’impegno missionario della Chiesa, comunità di credenti a servizio di tutti.
• Conosce alcune figure e gli elementi principali del monachesimo.
• Sa apprezzare il valore delle feste religiose come espressione di identità e di appartenenza.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
• La nascita dell’ecumenismo
• Voi siete il corpo di Gesù
• L’anno liturgico
• I sacramenti della Chiesa
• Segni e simboli
• La santa messa
• Una famiglia in festa
• Testimoni della Chiesa
• A servizio di Dio e della vita
• Carlo Acutis
• Tante religioni
• L’ebraismo
• Gli ebrei nella storia
• Il giorno della memoria
• L’islam
• L’induismo
• Il buddismo
• Confucianesimo, taoismo, shintoismo, sikhismo, animismo
• Il dialogo interreligioso
• Un mondo migliore
• Scoprire la ciclicità delle feste religiose cristiane scandite dal calendario liturgico.
• Conoscere gli elementi fondamentali delle grandi religioni del mondo.
• Scoprire il dialogo come strumento di conoscenza reciproca e di convivenza pacifica nel contesto attuale di pluralismo religioso.
L’alunno…
• Individua nell’arte una possibile forma di espressione di fede religiosa ed è in grado di saper “leggere” un’opera d’arte.
• Sa che nel mondo esistono diverse religioni, e che ciascuna di esse è degna di rispetto.
• È in grado di cogliere nelle diverse religioni valori umani comuni e universali.
• Impara che la conoscenza di sé e dell’altro passa attraverso il dialogo e il confronto, che permette di apprezzare e valorizzare la diversità come ricchezza.
• Matura atteggiamenti di rispetto e tolleranza verso culture e religioni diverse dalla propria.
ALFABETICA FUNZIONALE
PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
MULTILINGUISTICA
MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
CITTADINANZA
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Competenze in Chiave Europee
• Comprendere un testo scritto e rielaborarlo con linguaggi diversi.
• Rispondere a domande in forma scritta e orale.
• Esprimere la propria opinione sia a livello orale, sia scritto.
• Mettere in atto strategie e metodi di ricerca, personali o collettivi;
• Saper interagire in una discussione di gruppo in modo opportuno.
• Conoscere nuovi termini e vocaboli di lingue differenti.
• Utilizzare il pensiero matematico e applicare le conoscenze scientifiche e tecnologiche per risolvere problemi di vita quotidiana.
• Saper leggere e decifrare un’opera d’arte.
• Ascoltare e rispettare le opinioni di tutti, e comprenderne i diversi punti di vista.
• Mediare tra le opinioni di tutti.
• Collaborare con gli altri in modo proficuo.
raCCordo diSCiplinare Con: eduCazione CiviCa
L’educazione civica favorisce il riconoscimento di valori e comportamenti coerenti con la Costituzione attraverso il dialogo e il rispetto reciproco, volti a incoraggiare un pensiero critico personale, aperto e costruttivo, in un percorso formativo che, coinvolgendo la persona nella sua interezza e unitarietà.
Nucleo tematico: Costituzione diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 1
• Sviluppare atteggiamenti e adottare comportamenti fondati sul rispetto di ogni persona, sulla responsabilità individuale, sulla legalità, sulla consapevolezza della appartenenza ad una comunità, sulla partecipazione e sulla solidarietà, sostenuti dalla conoscenza della Carta costituzionale, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione Internazionale dei Diritti umani.
Obiettivi di Apprendimento
• Individuare i diritti e i doveri che interessano la vita quotidiana di tutti i cittadini, anche dei più piccoli. Condividere regole comunemente accettate. Sviluppare la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità locale, nazionale ed europea.
• Rispettare ogni persona, secondo il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione. Riconoscere, evitare e contrastare forme di violenza e bullismo presenti nella comunità scolastica.
• Curare gli ambienti, rispettare i beni pubblici e privati così come le forme di vita (piante, animali) che sono state affidate alla responsabilità delle classi.
• Aiutare, singolarmente e in gruppo, coloro che presentino qualche difficoltà per favorire la collaborazione tra pari e l’inclusione di tutti.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 2
• Interagire correttamente con le istituzioni nella vita quotidiana, nella partecipazione e nell’esercizio della cittadinanza attiva, a partire dalla conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni dello Stato, dell’Unione europea, degli organismi internazionali, delle Regioni e delle Autonomie locali. Essere consapevoli dell’appartenenza ad una comunità, locale e nazionale.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere il valore e il significato dell’appartenenza alla comunità nazionale.
• Conoscere il contenuto generale delle Dichiarazioni Internazionali dei diritti della persona e dell’infanzia. Individuare alcuni dei diritti previsti nell’ambito della propria esperienza concreta.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 3
• Rispettare le regole e le norme che governano la democrazia, la convivenza sociale e la vita quotidiana in famiglia, a scuola, nella comunità, al fine di comunicare e rapportarsi correttamente con gli altri, esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri per contribuire al bene comune e al rispetto dei diritti delle persone.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere ed applicare le regole vigenti in classe e nei vari ambienti della scuola (mensa, palestra, laboratori, cortili) e partecipare alla loro eventuale definizione o revisione. Conoscere il principio di uguaglianza nella consapevolezza che le differenze possono rappresentare un valore quando non si trasformano in discriminazioni.
• Conoscere i principali fattori di rischio dell’ambiente scolastico, adottare comportamenti idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza proprie e altrui e contribuire a definire comportamenti di prevenzione dei rischi.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 4
• Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela della salute e del benessere psicofisico.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere e attuare le principali regole per la cura della salute, della sicurezza e del benessere proprio e altrui, a casa, a scuola, nella comunità, dal punto di vista igienico-sanitario, alimentare, motorio, comportamentale.
Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 9
• Maturare scelte e condotte di contrasto all’illegalità.
Obiettivi di Apprendimento
• Conoscere le varie forme di criminalità, partendo dal rispetto delle regole che ogni comunità si dà per garantire la convivenza. Conoscere la storia dei vari fenomeni mafiosi, nonché riflettere sulle misure di contrasto. Conoscere il valore della legalità.
Nucleo tematico: Cittadinanza digitale comunicazione virtuale e sviluppo del pensiero critico
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 10
• Sviluppare la capacità di accedere alle informazioni, alle fonti, ai contenuti digitali, in modo critico, responsabile e consapevole.
Obiettivi di Apprendimento
• Ricercare in rete semplici informazioni, distinguendo dati veri e falsi.
• Riconoscere semplici fonti di informazioni digitali.
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 11
• Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali consentite, individuando forme di comunicazione adeguate ai diversi contesti di relazione, adottando e rispettando le regole comportamentali proprie di ciascun contesto comunicativo.
Obiettivi di Apprendimento
• Interagire con strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare semplici regole per l’utilizzo corretto di strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare le principali regole di partecipazione alle classi virtuali e alle piattaforme didattiche.
programmazione didaT TiCa annuale per unità di apprendimento
Traguardi per il raggiungimento delle competenze 12
• Gestire l'identità digitale e i dati della rete, salvaguardando la propria e altrui sicurezza negli ambienti digitali, evitando minacce per la salute e il benessere fisico e psicologico di sé e degli altri.
• Conoscere il significato di identità e di informazioni personali in semplici contesti digitali di uso quotidiano.
• Conoscere i rischi connessi con l’utilizzo degli strumenti digitali in termini di sicurezza personale.
• Riconoscere, evitare e contrastare le varie forme di bullismo e cyberbullismo.
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi;
• riflette su Dio Creatore e Padre.
Di nuovo in viaggio
• Riepilogo delle attività svolte lo scorso anno.
• Conversazione guidata sugli argomenti del nuovo anno.
Da pag. 2 a pag. 7 I valori etici e religiosi
• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.
Siamo all’inizio dell’ultimo anno della scuola primaria, e oltre a ricordare i principali argomenti dello scorso anno, che hanno visto come protagonista assoluto Gesù di Nazaret, la sua vita raccontata nei Vangeli, sarà importante coinvolgere tutti gli alunni per creare un clima sereno e positivo all’interno del gruppo classe, soprattutto in questo periodo dove molti di loro si sentono già grandi, in attesa del passaggio alla scuola secondaria.
Dopo la pausa estiva, facciamo riacquisire il RITMO STUDIO in modo quasi autonomo, attraverso schede semplificate di ripasso e attività ludiche.
Il cammino di questo ultimo anno ci porterà DALLE PORTE DELLA PROPRIA CASA E NAZIONE (il Cristianesimo) FINO A GIUNGERE AI CONFINI DEL MONDO (le grandi religioni). Così come la Chiesa, una famiglia che cammina nel tempo e nello spazio, giungendo ad annunciare la Buona Novella a tutti i popoli del mondo e si confrontando con essi con l’intenzione di trovare dei punti in comune nell’orizzonte del Bene di tutti.
Con la sua predicazione Gesù propose a tutti un progetto davvero speciale che riguarda la nascita di un Regno. Di certo non si tratta però di un “regno” come quelli presenti nelle fiabe, ma di qualcosa di tutt’altro genere.
Traccia nel labirinto la via giusta per raggiungere il Regno di Dio. Lungo il percorso scrivi nei cartellini gli atteggiamenti giusti che secondo te aiutano ad entrare a far parte di questo Regno. Nella pergamena più grande alla fine scrivi quanto puoi leggere in Matteo 4,17.
Per entrare a far parte del Regno di Dio, tutti sono invitati da Gesù a far fruttare i talenti che Dio ha loro donato.
Completa lo schema indicando, per ogni persona, il nome e i talenti che possiede.
ENOSREP
MAMMA
PAPÀ AMICO
NONNO INSEGNANTE IO
ITNELAT
Illustra nel riquadro ciò che ritieni essere il tuo principale talento o incolla una foto che bene lo rappresenti.
L’alunno…
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze
• sa cogliere, attraverso alcune pagine degli Atti degli Apostoli, la vita della Chiesa delle origini.
u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
I giganti dell’inizio
• Maria, la mamma di Gesù:
• i modi, i luoghi e le date per far festa con lei
• Pietro, il primo apostolo e Papa della Chiesa
• Paolo, l’apostolo delle genti
Da pag. 8 a pag. 21 Dio e l’uomo
• Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della chiesa cattolica sin dalle origini.
In questa prima parte del percorso sarà affrontato il CAMMINO DELLA CHIESA nascente, in particolare attraverso alcune figure fondamentali, che possiamo anche definire “I GIGANTI” DELLA FEDE: MARIA, PIETRO e PAOLO. In primis gli alunni conosceranno alcuni aspetti della mamma di Gesù, chiamata anche madre della Chiesa, le date e i luoghi che ancora oggi rendono Maria una donna speciale ed esempio per tutti i credenti. Poi, attraverso la lettura di alcuni brani degli Atti degli Apostoli, l’insegnante presenterà le fasi di sviluppo della Chiesa che da Gerusalemme, punto di partenza, è arrivata fino a Roma, centro del mondo di quel tempo, e che ha come protagonisti i santi Pietro e Paolo. Il primo, capo degli apostoli e guida della Chiesa, il secondo, che, pur non appartenendo al gruppo dei dodici, diviene apostolo e testimone del Vangelo.
L’insegnante guiderà gli alunni alla CONOSCENZA DI MARIA di cui si parla nel Nuovo Testamento, in particolare nel VANGELO DI LUCA. Diverse tradizioni hanno analizzato questa grande figura umana, compreso il Corano che ne racconta alcuni episodi dedicandole una “sura” dal titolo: Myriam.
Con questa preghiera l’insegnante introdurrà il personaggio evangelico di Maria, madre di Gesù, leggendo le parole che lei pronuncia nell’incontro con Elisabetta sua cugina.
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
L’insegnante approfondirà l’argomento facendo osservare questo dipinto di forma circolare, dove Maria ha il Bambino sulle ginocchia e sta scrivendo il verso iniziale del cantico
COME PREGARE
L’insegnante può mostrare agli alunni un rosario (ne esistono di molto colorati per bambini e ragazzi) e con l’aiuto di questo schema può spiegare agli alunni l’utilizzo della corona del rosario.



Sandro Botticelli, Madonna del Magnificat,
Se gli alunni mostrano interesse, si può entrare nella descrizione dettagliata di un rosario.
I misteri del rosario sono 20:
• 5 misteri gaudiosi, che ricordano la vita di Maria e Gesù fino all’inizio della sua vita pubblica (l’Annunciazione, la Visitazione, la nascita di Gesù, la Presentazione di Gesù al tempio, il Ritrovamento di Gesù).
• 5 misteri luminosi che ricordano la vita pubblica di Gesù (il Battesimo, le Nozze di Cana, l’Annuncio del Regno di Dio, la Trasfigurazione e l’Eucaristia).
• 5 misteri dolorosi che ricordano la passione di Gesù (Gesù nel Getzemani, la Flagellazione, la Corona di spine, la Salita al calvario, la Crocifissione e Morte).
• 5 misteri gloriosi (la Risurrezione di Gesù, l’Ascensione di Gesù, la Pentecoste, l'Assunzione e l’Incoronazione di Maria).
Presentiamo gli EVENTI PIÙ IMPORTANTI DELLA VICENDA UMANA DI MARIA, che sono rivelatori del suo mistero, vale a dire del suo significato nella storia della salvezza. Lo facciamo attraverso una serie di immagini e la lettura dei brani evangelici in cui è possibile ricostruire il suo CAMMINO PREZIOSO ACCANTO A GESÙ
Gli episodi principali della vita di Maria
ANNUNCIAZIONE (Luca 1,26-38)
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe.
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te.» A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo.
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine.» Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio.» Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola.» E l’angelo si allontanò da lei.

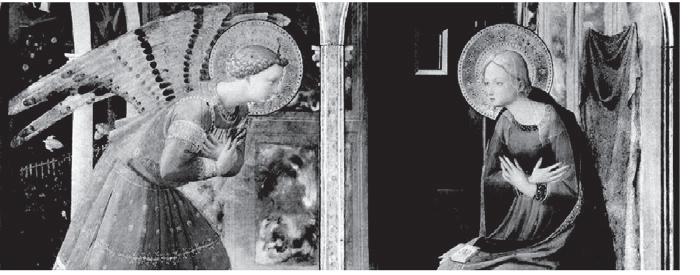
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «

tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!
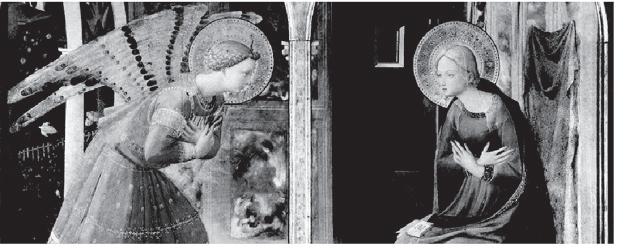
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio
E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto.
VIAGGIO A BETLEMME (Luca 2,1-5)



In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!

A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto.»


NASCITA DI GESÙ (Luca 2,6-7)
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primo genito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
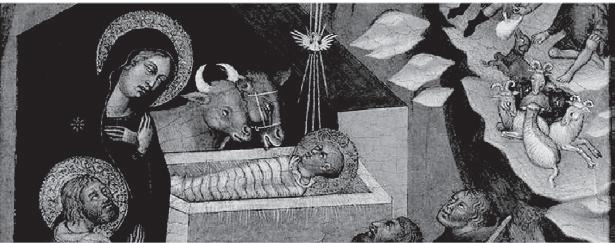

FUGA IN EGITTO (Matteo 2,13-15)

Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo.»
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall’Egitto ho chiamato mio figlio.


2,22-28)
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu mes so nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.
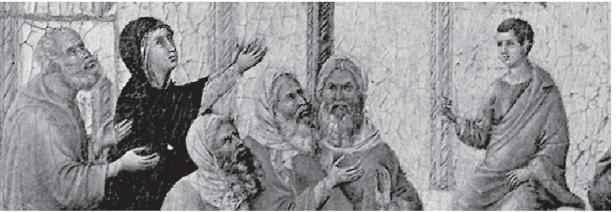
Quando furono compiuti i giorni del la loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signo re:
al Signore

coppia di tortore e due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui.

Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.


2,41-50)

I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù

(Giovanni 2,1-12)
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino.» E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora.» Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela.» Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le anfore”; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto.» Ed essi gliene portarono.
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto –

il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora.» Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli cedettero in lui. Dopo questo fatto scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni.


Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: figlio!» dre!» E da quell’ora il discepolo l’accolse con se.


Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino per messo in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riu nirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Gia como e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda fi glio di Giacomo.
(Atti 1,11-14; 2,1-4)

Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Ecco una proposta per l’utilizzo delle immagini e dei brani evangelici:
• Si possono ingrandire le immagini e costruire con esse un grande cartellone.
• Si possono ritagliare le figure, incollarle su un cartoncino, metterle insieme come un mazzo di carte, rimescolarle e distribuirle. Poi, mentre un ragazzo legge in ordine cronologico i brani evangelici, ciascuno è invitato a posare in successione (come nel gioco del domino), le diverse carte fino a ricostruire la vita di Maria in sequenza temporale sul cartellone.
La devozione per Maria è molto viva tra i fedeli, lo testimoniano le feste, le processioni e i santuari, a lei dedicati.
Attraverso la lettura di questi tre racconti i ragazzi saranno guidati ad accostarsi alla figura di Maria, venerata dai cristiani come Madre di Dio e della Chiesa
Il padre Auriemma racconta che una povera pastorella che guardava gli armenti amava tanto Maria, che la sua gioia più grande era di andare in una cappelletta di nostra Signora, su una montagna, e di restare là mentre le pecorelle pascolavano, per parlare con la sua cara Madre e renderle omaggio.
Vedendo che quella modesta statua era disadorna, si mise a confezionarle un manto con le sue mani.
Un giorno colse alcuni fiori nei campi e ne fece una ghirlanda; poi, salita sull’altare di quella cappelletta, la pose sul capo dell’immagine dicendo: «Madre mia,
vorrei porre sulla tua fronte una corona d’oro e di gemme, ma poiché sono povera, ricevi da me questa povera corona di fiori e accettala come segno del mio amore per te.»
Così e con altri omaggi la devota pastorella cercava di servire e di onorare la sua amata Signora. Vediamo ora come la nostra buona Madre ricompensò le visite e l’affetto di questa sua figlia. La ragazza si ammalò e stava per morire. Due religiosi, passando da quelle parti, stanchi per il viaggio, si misero a riposare sotto un albero. L’uno dormiva, l’altro vegliava, ma ebbero la stessa visione.
Videro un gruppo di bellissime fanciulle e fra queste ve n’era una che le superava tutte in bellezza e maestà. Uno di loro le domandò: «Signora, chi sei?» «Io sono, rispose, la Madre di Dio e con queste fanciulle vado a visitare nel vicino villaggio una pastorella moribonda che ha fatto tante visite a me.» Dopo queste parole, la visione scomparve. Allora i due buoni servi di Dio si dissero l’un l’altro: «Andiamo anche noi a vedere la pastorella.» Si avviarono e, trovata l’abitazione della ragazza, entrarono in un piccolo tugurio. Lì, sopra un po’ di paglia, giaceva la giovane moribonda. La salutarono ed ella disse loro: «Fratelli, pregate Dio di farvi vedere chi è venuto ad assistermi.»
S’inginocchiarono subito e videro Maria che stava accanto all’agonizzante con una corona in mano e la consolava. Le altre vergini cominciarono a cantare e a quel dolce canto l’anima benedetta della pastorella si sciolse dal corpo. Maria le pose in capo la corona e prendendosi l’anima la portò con sé nel paradiso.
Secondo un racconto del Belluacense (Vincenzo di Beauvais), nella città di Ridolfo in Inghilterra, nell’anno 1430, viveva un giovane nobile chiamato Ernesto. Dopo aver distribuito tutto il suo patrimonio ai poveri, entrò in un monastero in cui conduceva una vita così perfetta, che i superiori lo stimavano grandemente, soprattutto per la sua speciale devozione alla santa Vergine.
In quella città scoppiò la peste e gli abitanti ricorsero al monastero chiedendo preghiere.
L’abate ordinò a Ernesto di andare a pregare davanti all’altare di Maria e di non allontanarsi finché la Madonna non gli avesse risposto.
Il giovane rimase lì tre giorni e finalmente Maria gli rispose indicando alcune
preghiere che si dovevano recitare. Così fu fatto e la peste cessò.
Ma in seguito il giovane cominciò a trascurare sempre più la devozione a Maria. Il demonio lo assalì con mille tentazioni, specialmente contro la purezza e contro la sua vocazione. Non essendosi raccomandato a Maria, lo sventurato arrivò a prendere la decisione di fuggire calandosi da un muro del monastero.
Ma mentre passava davanti a un’immagine di Maria che stava nel corridoio, la Madre di Dio gli disse: «Figlio mio, perché mi abbandoni?» Stordito e colto da rimorsi, Ernesto cadde in ginocchio e rispose: «Signora, non vedi che non posso resistere? Perché non mi aiuti?» La Madonna replicò: «E tu perché non mi hai invocata? Se ti fossi raccomandato a me, non ti saresti ridotto a questo. Da oggi in poi, raccomandati a me e non dubitare.»
Ernesto tornò nella sua cella. Ma tornarono le tentazioni. Egli non invocò l’aiuto di Maria e finì col fuggire dal monastero.
Da allora si abbandonò a una vita sciagurata passando di peccato in peccato e infine si ridusse a fare l’assassino.
Prese in affitto un’osteria dove la notte uccideva i poveri viaggiatori per depredarli. Così fra gli altri uccise il cugino del governatore di quel luogo il quale in base agli indizi raccolti nel corso del processo lo condannò alla forca. Mentre lo scellerato era ancora in libertà, ecco che capita nella locanda un giovane cavaliere.
Volendo attuare di nuovo i suoi orribili disegni, l’oste entra di notte nella sua stanza per assassinarlo, ma sul letto, invece del cavaliere, vede un Crocifisso coperto di piaghe che guardandolo con compassione gli dice: «Non ti basta, ingrato, che io sia morto per te una volta? Vuoi uccidermi di nuovo? Su presto, alza il braccio e uccidimi.»
Allora il povero Ernesto, tutto confuso, cominciò a piangere e disse: «Signore, eccomi, poiché mi tratti con tanta misericordia, voglio tornare a te.»
Subito lasciò la locanda dirigendosi verso il suo monastero per farvi penitenza, ma per strada fu raggiunto dai rappresentanti della giustizia e portato davanti al giudice, al quale confessò tutti i delitti commessi. Perciò fu condannato a morire impiccato, senza dargli neppure il tempo di confessarsi. Allora egli si raccomandò a Maria e quando fu buttato già dalla forca, la Vergine fece sì che non morisse.
Ella stessa lo sciolse dal laccio e gli disse: «Torna al monastero, fa’ penitenza e quando verrò a portarti la sentenza di perdono dei tuoi peccati, allora ti prepa-
rerai a morire.»
Ernesto tornò al monastero, raccontò tutto all’abate e fece gran penitenza. Dopo molti anni, vide apparire Maria che aveva in mano la sentenza del suo perdono. Subito si preparò alla morte e santamente morì.
Il padre Bovio racconta che una donna di malaffare, chiamata Elena, entrata in una chiesa, udì per caso una predica sul rosario. Uscì e ne comprò uno, ma lo portava nascosto per non farlo vedere. Cominciò poi a recitarlo, dapprima senza devozione. La santa Vergine le fece tuttavia gustare tali consolazioni e tali dolcezze in questa pratica, che non si stancava mai di dire il rosario. Così arrivò a concepire un tale orrore per la sua cattiva condotta che, non trovando pace, fu come costretta ad andare a confessarsi, e lo fece con tale contrizione, che il confessore ne fu stupito.
Fatta la confessione, andò a inginocchiarsi davanti a un altare di Maria per ringraziare la sua avvocata e, mentre recitava il rosario, udì la voce della divina Madre che da quell’immagine le diceva: «Elena, hai molto offeso Dio e me. Da oggi in poi cambia vita e ti concederò in abbondanza la mia grazia.»
Tutta confusa, la povera peccatrice rispose: «Vergine santa, è vero che finora sono stata una sciagurata, ma tu che tutto puoi, aiutami. Io mi dono a te e voglio impiegare il resto dei miei giorni a far penitenza dei miei peccati.» Aiutata da Maria, Elena distribuì tutti i suoi averi ai poveri e si diede a una vita di rigorosa penitenza.
Era tormentata da terribili tentazioni, ma si raccomandava incessantemente alla Madre di Dio e così ne usciva sempre vittoriosa. Arrivò ad avere molte grazie anche soprannaturali, visioni, rivelazioni, profezie.
Infine, dopo averla avvertita qualche giorno prima della sua morte ormai prossima, la Vergine con suo Figlio venne a visitarla e, quando la peccatrice morì, fu vista la sua anima volare verso il cielo in forma di bellissima colomba.
Da: Le glorie di Maria di S.Alfonso Maria de Liguori
Nel corso della storia sono stati molti i modi con cui i cristiani si sono rivolti a Maria. A lei hanno attribuito i nomi più belli legati alle Sacre Scritture e alla tradizione della Chiesa
SPECCHIO DI GIUSTIZIA
Quando si guarda in uno specchio si fa meno caso allo specchio e a ciò che esso riflette. Se guardiamo Maria, essa ci riflette la giustizia. Questa parola nella Bibbia significa la BONTÀ DI DIO, la sua fedeltà, e anche la santità dell’uomo. Allora con Specchio di giustizia vogliamo dire: MARIA È L’IMMAGINE PIÙ BELLA DELLA SANTITÀ .
SEDE DELLA SAPIENZA
Nel libro della sapienza si dice che la SAPIENZA, rappresentata come una persona, ha il suo trono vicino a Dio. Noi chiamiamo Gesù anche SAPIENZA ETERNA e diciamo che Maria è il suo trono. Vediamo Gesù raffigurato seduto sul grembo della madre: in molti quadri è seduto sulle ginocchia di Maria, come un re sul suo trono. Con la parola sede pensiamo anche all’espressione SEDE DEL GOVERNO. Governare significa dirigere e guidare. Maria, come sede della Sapienza, ha questo significato: se andiamo da lei, troveremo la sapienza che ci conduce a una vita di fede più viva.
Durante il viaggio nel deserto gli Israeliti costruirono un prezioso cofano di legno d’acacia. Era riccamente adornato. In questa cassa posero i SEGNI DELL’ALLEANZA, le TAVOLE DELLA LEGGE che Mosè ricevette da Dio sul monte Sinai. L’arca dell’alleanza accompagnò il popolo d’Israele fin quando fu collocata nel locale più sacro del tempio di Gerusalemme. Noi cristiani viviamo nella nuova alleanza e chiamiamo Maria arca dell’alleanza, perché in lei prese carne il mediatore dell’alleanza: Gesù, il Figlio di Dio.
Gesù è lo strumento della nuova alleanza, fondata non più su tavole di pietra, ma su un uomo vivo. Così anche l’arca dell’alleanza non è più un cofano di legno, ma una persona viva: Maria.
In molti canti MARIA VIENE PARAGONATA A UNA ROSA. Questo è infatti un titolo delle
Litanie lauretane.
La rosa è il più bello di tutti i fiori. Il suo profumo rallegra gli uomini. La rosa è anche il fiore dell’amore. L’umanità non ha niente di meglio da donare a Dio che Maria, la rosa mistica. Fiorisce sempre e non appassisce mai. Non ci si stanca di guardarla.
LE TORRI SONO EDIFICI ALTI. Da una torre elevata si può vedere il paesaggio circostante. Quindi MARIA È UN SEGNO DI RICONOSCIMENTO PER LA CHIESA . Nei tempi antichi le torri erano luoghi militarmente ben difesi, un rifugio quando infuriava la guerra. Questo è Maria per i cristiani. Nel Cantico dei Cantici la sposa viene paragonata, per la sua bellezza, alla torre di Davide. Questa immagine della Bibbia la attribuiamo a Maria. Inoltre affermiamo che Maria è il frutto più bello della gloriosa stirpe del re Davide.
Nelle antiche chiese troviamo a volte dei tabernacoli costruiti a forma di torre riccamente adornata. Come una simile torre porta il Santissimo, così Maria porta Gesù.
Dopo che Adamo ed Eva furono cacciati dal Paradiso terrestre, la porta fu chiusa. Dio pose davanti ad esso un angelo con la spada fiammeggiante, per impedirne l’accesso fino al momento in cui il Figlio di Dio fosse venuto sulla terra. Possiamo immaginarci che la porta del cielo si è aperta.
MARIA È LA PORTA ATTRAVERSO LA QUALE GESÙ È VENUTO NEL NOSTRO MONDO. Egli ha così aperto la porta del cielo. Se la parola di Gesù si diffonde nel mondo per nostro merito, anche noi siamo un poco Porta del cielo.
STELLA DEL MATTINO – STELLA DEL MARE
Prima di tutto è Gesù che viene chiamato Stella del mattino: questo è poi un altro modo per indicare il sole. Ma chiamiamo stella del mattino anche una stella luminosa, ben visibile prima del sorgere del sole. Noi paragoniamo MARIA a questa
STELLA. BRILLÒ NELL’OSCURITÀ DELLA NOTTE COME PREANNUNCIO DEL MATTINO . Infatti la chiamiamo anche
AURORA DELLA SALVEZZA
Definendo Maria Stella del mare, pensiamo ad una stella che dà l’orientamento
al marinaio durante la notte. Anche se tutto intorno a noi è tenebra, guardando Maria riusciamo a trovare la via giusta.
REGINA
PARAGONIAMO SOVENTE MARIA A UNA REGINA . È facilissimo capirne il motivo. I pittori hanno sempre rappresentato Maria come una regina, anche se non ha mai posseduto vestiti preziosi. Ma Dio ha reso la povera ragazza di Nazaret più grande di tutti gli esseri umani e perciò hanno ragione i pittori. Le Litanie lauretane ripetono dodici volte il titolo di “Regina” rivolto a Maria: Regina degli angeli, dei patriarchi, dei profeti... Inoltre l’ultimo mistero glorioso del Rosario contempla Maria incoronata Regina del cielo.
RIFUGIO DEI PECCATORI
MARIA CALPESTA UN SERPENTE: la vediamo spesso rappresentata così. Il serpente è il simbolo del peccato e della seduzione. Maria, l’Immacolata, ha sconfitto il serpente con la forza della grazia che le viene dal Figlio. Così essa infonde in noi la speranza di poter a nostra volta vincere il male per mezzo della vittoria di Gesù.
QUANDO CADIAMO NEL MALE, CI DÀ LA SPERANZA DI OTTENERE LA VITTORIA SUL PECCATO GRAZIE
AL PERDONO DI GESÙ. Ecco perché chiamiamo Maria rifugio dei peccatori.
Da: J. Seuffert, Segni di vita, piccola raccolta di simboli cristiani, Paoline

La straordinaria storia della Sacra Cintola, la preziosa reliquia della Madonna, conservata nella Cattedrale di Prato, è un affascinante intreccio di verità e credenze popolari.
Secondo la tradizione, San Tommaso contemplò la Vergine Maria mentre veniva assunta in cielo, che lasciò in dono all’apostolo la sua Cintola.
Altri dicono che, incredulo dell'assunzione in cielo della Madonna, Tommaso volle aprirne il sepolcro ma vi trovò solo la cintura del suo abito, lasciata da Maria per confortare la sua fede.
Ad ogni modo, questo evento, nel corso dei secoli, ha sempre incuriosito e ispirato molti artisti, tanto da essere rappresentato simbolicamente in moltissime pale d'altare e opere dedicate a San Tommaso, mostrando la Madonna che sale al cielo e la cintura che pende verso l’apostolo, scena che vuole anche simboleggiare il legame fra gli uomini e la Vergine.
Consegnata ad un sacerdote di Gerusalemme, la Cintola è stata conservata per secoli dai suoi discendenti. Intorno al 1100, un mercante pratese di nome Michele, in viaggio nella città Santa, si innamorò di una ragazza di nome Maria, figlia di un sacerdote orientale. Si narra che i due si sposarono in segreto contro il volere del padre di lei.
Michele successivamente tornò a Prato intorno al 1141, da solo senza Maria, infatti, la donna non riuscì ad affrontare il lungo viaggio, poiché cagionevole di salute, morì durante il tragitto. Il mercante pratese portò con sé la sua unica dote, la Cintola appartenuta alla Madonna. Michele tenne nascosta gelosamente la Cintola, e non parlò a nessuno del dono ricevuto. Una leggenda narra che la notte si addormentasse sulla panca custodiva la reliquia, e che durante la notte due angeli lo tenevano sollevato dalla stessa, perché non era degno di dormire su un oggetto così sacro.
In punto di morte, nel 1173, Michele donò la Cintola al preposto della Pieve di Santo Stefano a Prato, per poi essere riposta all'interno dell'altare maggiore del Duomo. Dopo un tentativo di furto, subito nel 1312, venne costruita una Cappella apposita sul fianco sinistro, all’interno del Duomo, che in seguito a tale evento subì una serie di trasformazioni e ampliamenti fino a raggiungere l'aspetto di oggi.
La Sacra Cintola, chiamata anche “sacro cingolo”, nel tempo è diventata meta di pellegrinaggi ed oggetto molto venerato dai pratesi e non solo. Tra i tanti
fedeli accorsi a Prato per pregare, o anche solo per curiosità, si possono citare San Francesco d’Assisi (nel 1212), fino ad arrivare ai giorni nostri con le visite di Papa Giovanni Paolo II nel 1986 e Papa Francesco nel 2015.
La leggenda narra che nel 1312, un tale Giovanni di ser Landetto, detto "Musciattino", tentò di rubare la Sacra Cintola, per portarla nella vicina Pistoia. Quando però uscì dalla Chiesa, una folta nebbia avvolgeva la città, tanto da far perdere l’orientamento all’uomo, che senza rendersene conto, tornò al punto di partenza.
Credendo di essere giunto a Pistoia, gridò alle porte della città: "Aprite, aprite Pistoiesi: ho la Cintola de' Pratesi!".
Alcuni documenti conservati nell’Archivio comunale di Prato, riportano i fatti successivi a tale furto: il ladro fu catturato, processato e poi condannato nella pubblica piazza al taglio della mano destra e, legato alla coda di un asino, fu successivamente trascinato sulle rive del fiume Bisenzio, dove venne arso vivo e i suoi resti buttati nelle acque del fiume.
Inoltre, la tradizione popolare narra che, dopo che gli fu mozzata la mano, la folla inferocita abbia scagliato l'arto tagliato verso la chiesa, lasciando un segno indelebile su una pietra del Duomo, ovvero una macchia color sangue a forma di mano, che ancora oggi è visibile. Visitando il centro di Prato si può trovare il segno di questa leggenda sulla pietra di marmo dell'angolo in alto a sinistra dello stipite della porta laterale, quella più vicina al campanile sul fianco destro del Duomo.
L'Ostensione
La parola OSTENSIONE significa “MOSTRATA PUBBLICAMENTE”.
Riconosciuta dalla Chiesa, la Sacra Cintola viene mostrata ai fedeli dal Pulpito, commissionato e fatto costruire appositamente a Donatello, posto sull'angolo destro della facciata del Duomo di Prato.
La pubblica ostensione è citata per la prima volta in uno statuto del Comune di Prato del 1276-1279 in occasione della Natività di Maria (8 Settembre). La sacra reliquia ancora oggi viene mostrata pubblicamente (Ostensione) cinque volte
all'anno, queste le date:
• 8 settembre, Natività di Maria (è la più importante e sentita particolarmente dai pratesi);
• In occasione della Santa Pasqua (tra il 22 marzo ed il 25 aprile);
• 25 dicembre, nel giorno del Santo Natale;
• 1º maggio, che segna l’inizio del mese dedicato al culto di Maria
• 15 agosto, giorno della solennità dell’Assunzione al cielo di Maria.

La Cintola è una SOTTILE STRISCIA DI LANA FINISSIMA , BROCCATA IN FILI D'ORO, custodita in un reliquiario chiuso da 3 chiavi (due di proprietà del Comune ed una della Diocesi) che solo se usate congiuntamente aprono lo scrigno. Il “SACRO CINGOLO” è considerato il TESORO PIÙ PREZIOSO DELLA CITTÀ , divenendo, nel tempo, un suo elemento identificativo.
La Sacra Cintola dal 1395 fu collocata nella Cappella fatta costruire sulla sinistra dell'ingresso principale della Basilica Cattedrale di Santo Stefano, affrescata poi da Agnolo Gaddi con Storie della Vergine e della Cintola (1392-95). La Cappella fu poi racchiusa da una splendida cancellata rinascimentale in bronzo, opera di Maso di Bartolomeo. Sull'altare è posta una preziosa statua della Madonna col Bambino, capolavoro del primo Trecento di Giovanni Pisano.
CON PIETRO E PAOLO
Presentiamo due interviste e commenti di due opere d’arte del Caravaggio, al fine di consolidare e arricchire le informazioni relative agli apostoli PIETRO e PAOLO.
Intervista a Pietro

• Dove hai iniziato a predicare?
«La predicazione del Vangelo, come aveva raccomandato Gesù, si è rivolta dapprima agli Ebrei. Nella primavera dell’anno 30, per celebrare la festa della Pentecoste, erano giunti a Gerusalemme molti pellegrini. A loro ho raccontato come Gesù era risorto: non solo mi hanno ascoltato con interesse, ma molti si sono fatti battezzare. Non so quanti ne ho battezzati quel giorno, sicuramente alcune migliaia.»
• Perché avevi paura di farti vedere con i gentili, i cristiani provenienti dal paganesimo?
«Ti riferisci all’episodio di Antiochia? Guarda che io sono stato uno dei primi a credere nella necessità di annunciare il Vangelo di Gesù non solo agli Ebrei, ma anche ai pagani. Sono stato io ad assistere alla conversione del primo pagano, quel centurione romano che si chiamava Cornelio.
Ecco cosa è accaduto ad Antiochia: per rispetto nei confronti di un gruppo di Ebrei cristiani che, secondo la legge ebraica, consideravano sconveniente e peccaminoso mangiare insieme con i non-Ebrei, evitavi di frequentare la mensa dei gentilo-cristiani, che ad Antiochia erano numerosi. Per questo mio atteggiamento c’è stato uno scontro tra me e Paolo. Ma poi tutto si è chiarito. Ti posso dire che è stato un incidente molto utile, perché ha fatto discutere contribuendo a far crollare steccati e barriere che dividevano Ebrei e Gentili.»
• Perché tu, capo degli apostoli, hai deciso di trasferirti a Roma?
«La capitale dell’Impero era un crocevia di gente, di razze, di commerci, di eserciti e di divinità. Nonostante la sua vocazione a comandare il mondo, si lasciava
facilmente “catturare” dalla cultura di altri popoli. Questa città aveva tutte le caratteristiche necessarie per poter accogliere il messaggio di Gesù. Inoltre i Romani erano particolarmente sensibili e tolleranti in fatto di religione. Molti Romani, mercanti, soldati e viaggiatori, venuti a contatto con le comunità di Antiochia, Corinto ed Efeso, si erano fatti cristiani con entusiasmo.»
• Che cosa hai trovato a Roma?
«C’era una numerosa comunità di Ebrei. Molti di essi si erano già fatti cristiani. I cristiani provenienti dal paganesimo (pochi rispetto al milione di abitanti di Roma) si erano organizzati e si riunivano in case private per pregare. Anche se la Roma imperiale concedeva la massima libertà di culto, i primi cristiani cercavano di non dare troppo nell’occhio. Aderivano con entusiasmo alla nuova religione soprattutto le donne, i poveri e gli schiavi.
Non mancavano però le persone colte, gli intellettuali.»
• In che cosa credevano i Romani?
«In quegli anni - siamo intorno al 60 d.C. - la religione romana tradizionale, basata sul culto degli antenati e su tre divinità principali, JUPITER (GIOVE), GIUNONE e MINERVA, era un po’ in decadimento.
In pratica a Roma c’era spazio per ogni divinità cara ai popoli dominati dai Romani, mentre il fervore religioso in generale si era assai intiepidito. Gli imperatori, con la loro personalità avevano finito per essere il vero punto di riferimento religioso e spesso richiedevano dai sudditi atti di vera adorazione.»
• Mi parli delle persecuzioni?
«Prima dei Romani, sono stati gli Ebrei a perseguitarci: il diacono Stefano e alcuni discepoli sono caduti vittime del loro fanatismo. Poi c’è stata la prima grande persecuzione, quella del folle e crudele Nerone. Il numero dei martiri cristiani è in seguito cresciuto di anno in anno.»
• E tu come sei morto?
«Fra i cristiani che Nerone ha fatto massacrare nell’anno 64, come responsabili dell’incendio di Roma. Anch’io sono stato condannato alla crocefissione: sono stato inchiodato ai legni con la testa in giù.»
• Perché Nerone ha ordinato la morte dei cristiani?
«Nel luglio del 64 a Roma è scoppiato un violento incendio. Forse non è stato Nerone a farlo appiccare, ma il fatto che la voce del popolo lo ha accusato subito dimostra che aveva fama di grande crudeltà.
Da vero capo di un regime totalitario, prima ancora di riparare il disastro, ha cercato qualcuno cui addebitarlo. È uno storico romano a confermarlo, Tacito: Nerone ha deciso di scaricare la colpa su una setta religiosa formatasi in quei tempi.
Nerone non sapeva niente di noi. Ha fatto arrestare tutti quelli che gli sono capitati a tiro e li ha fatti condannare alla tortura dopo un processo sommario. Alcuni sono stati dati alle belve, altri crocifissi, altri spalmati di resina e trasformati in torce. Prima di questo crudele episodio, Roma non si era accorta di noi. Dopo, invece, la gente ha cominciato a guardare i cristiani con una certa curiosità.»
• Dove sei stato giustiziato?
«A Roma, la dove sorge la basilica che porta il mio nome. I carnefici non sono stati nemmeno sfiorati dal dubbio che sulla mia tomba sarebbe sorto un altro impero, spirituale, destinato a sotterrare quello secolare e pagano, che aveva pronunciato il verdetto.»
Da M. Giordano - E. Ciocetti: I personaggi
del Vangelo, Paoline
La crocifissione di San Pietro
La crocifissione di San Pietro è un dipinto del Caravaggio. Questa opera è conservata a Roma nel transetto sinistro della chiesa di Santa Maria del Popolo. Essa è stata realizzata tra il 1600 e 1601. È un dipinto estremamente innovativo per il suo carattere anti ieratico e anti aulico. La scena ritrae il momento della crocifissione di San Pietro, il quale si fa crocifiggere a testa in giù per umiltà nei confronti di Cristo. L’immagine è compressa in un angolo visivo talmente ristretto che non riesce a contenere neppure tutta la croce.
Tutte le figure rappresentate concorrono a formare una X con le assi della croce e dei corpi degli aguzzini, quest’ultimi sono accomunati col santo dal senso della fatica. In primo piano è posto un carnefice inginocchiato che sta aiutando gli
altri due a issare la croce per completare il martirio.
Ciò che colpisce è la modalità con la quale sono stati rappresentati i carnefici, non aguzzini ma manovali che svolgono il loro compito come se fosse un lavoro assolutamente ordinario, assegnatogli per quel giorno come una qualsiasi altra commissione.
L’artista nasconde i loro volti mentre si vede molto bene quello di San Pietro, che ci appare non sofferente, ma incredulo davanti al suo martirio.

Egli ha un corpo ancora scolpito e tonico che gli permette di sollevare il busto e la testa per osservare la mano appena inchiodata al legno.
La sua morte si avvicina e finalmente potrà perdersi nell’abbraccio col suo Dio. In quest’opera la luce è come un riflettore che avvolge la croce e il Santo, entrambi simboli della fondazione della Chiesa, e fa emergere alcuni particolari: le venature del legno della croce, il piede nero dell’aguzzino chino, le rughe sulla fronte dell’aguzzino di sinistra, le unghie del Santo e dell’aguzzino che tende la corda. Il contrasto tra il chiaro e lo scuro è simbolo della grazia salvifica e delle tenebre del peccato. Il messaggio consiste nell’invito ad abbandonare le vie oscure del male e a restare nella zona illuminata dalle virtù che conducono alla salvezza divina.
Intervista a Paolo
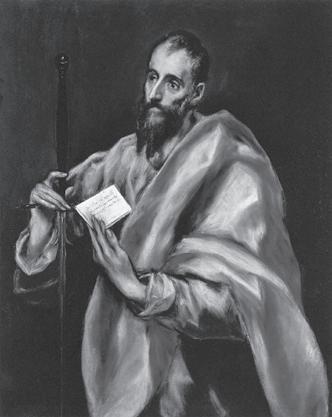
• Vuoi presentarti?
«Ebreo di razza, greco di formazione e cittadino romano. Sono nato a Tarso, in Cilicia, che era una provincia romana.
Mio padre era un fariseo benestante, e quindi di origine borghese, e mi ha trasmesso il più prezioso di tutti i beni, almeno per quei tempi: la cittadinanza romana.»
• Hai conosciuto personalmente Gesù?
«Avevamo più o meno la stessa età, ma non l’ho mai incontrato mentre era vivo e predicava.
L’ho conosciuto in modo straordinario sulla via che portava a Damasco.»
• Eri un persecutore dei cristiani?
«Si, ero un acerrimo nemico della nuova religione che per me, rigido fariseo, era una grave minaccia alla religione di Mosè. I capi del Sinedrio a Gerusalemme mi avevano affidato l’incarico di annientare i cristiani a Damasco.»
• E cosa è accaduto?
«Ho visto Gesù, vivo, risorto. Mi ha accecato e sono caduto da cavallo. Poi ha pronunciato quella frase che ha cambiato la mia vita: Perché mi perseguiti? Io perseguitavo i cristiani, non lui. Allora ho capito che egli era presente in ogni cristiano.»
• Tu non sei uno dei dodici: perché ti hanno attribuito il titolo di apostolo?
«Per la vastità e l’importanza della mia opera di evangelizzazione. Anche al mio amico Barnaba è stato dato, giustamente il titolo di apostolo.
• Su una carta geografica si possono vedere i complicati itinerari dei tuoi viaggi e avere un’ idea della grandiosità della tua impresa missionaria. Quanti chilometri hai percorso?
«Una quantità enorme. Ho solcato mari, ho valicato monti, ho attraversato luoghi impervi, hanno cercato di lapidarmi, sono stato scambiato per Ermes: il dio greco; da Damasco sono fuggito facendomi calare in una cesta dalle mura della città. Ho incontrato diffidenze e ostilità.
A Filippi sono stato bastonato e imprigionato; a Corinto sono stato trascinato in tribunale davanti al proconsole Gallione, fratello del filosofo Seneca. Ad Atene mi hanno deriso. Ovunque però ho costituito comunità cristiane».
• A Roma sei arrivato in condizione di prigioniero. Come ti hanno trattato?
«Mi hanno ascoltato con pazienza, ma non hanno capito nulla delle questioni che esponevo.
L’unica cosa che avevano compreso era che la politica non c’entrava. Mi hanno trattato bene, limitandosi a mettere un soldato di guardia alla porta di casa. Ma mi avevano lasciato scegliere l’abitazione. Qui venivano a trovarmi esponenti della colonia ebraica ed ebrei-cristiani che ancora respingevano con orrore l’idea che il battesimo fosse più importante della circoncisione.»
• Le tue lettere costituiscono ancora oggi la base della teologia. Quante ne hai scritte?
«Quattordici: le ho scritte un po’ a tutti gli amici di Corinto, di Tessalonica, di Efeso, di Filippi…».
• Perché non hai fatto nulla per salvarti dalla persecuzione di Nerone?
«Non ho cercato il martirio, ma l’ho accettato. Sono morto decapitato come Giovanni Battista.»
Da M. Giordano - E. Ciocetti: I personaggi del Vangelo, Paoline
La conversione di San Paolo
Anche la conversione di S. Paolo è un DIPINTO DEL CARAVAGGIO.
L’anno di realizzazione è il 1601 e si trova a Roma nella chiesa di Santa Maria del Popolo.
L’opera ritrae il MOMENTO TOPICO DELLA CONVERSIONE DEL SANTO.
La scena si svolge in una semplice stalla, una postazione poco prima della città in cui Saulo era diretto.
Testimoni della vicenda soprannaturale sono:
• Il cavallo, dal cui dorso sono caduti i finimenti e la sella, occupa più della metà del dipinto e grazie all’intervento divino alza lo zoccolo per non calpestare Paolo.
• Un anziano palafreniere si intravede dietro il muscoloso collo del destriero, mentre sta calmando il cavallo.
• Paolo riverso a terra, è rappresentato nell’istante successivo a quella luce del cielo che lo folgorò abbattendolo al suolo.
La LUCE è la protagonista principale del teatro della vicenda. Dall’alto proviene
una sorte di FOLGORE DIVINA che squarcia la tenebra del persecutore.
Tutto si impressiona di quella luce: il mantello porpora del Santo, il mantello pezzato del cavallo, i piedi nudi dell’anziano scudiero.
Paolo, con le braccia allargate, è disposto ormai ad ACCETTARE LA VOLONTÀ DIVINA anche se non è ancora capace di vedere con gli occhi della fede.
Egli ponendosi nella stessa direzione di chi osserva l’immagine, invita lo spettatore a lasciarsi illuminare dalla luce, la grazie divina che irrompe nella vita degli uomini per vivificarla.

Il canto XXXII del Paradiso
Le più belle opere della letteratura italiana hanno spesso un’ispirazione religiosa, come ad esempio la Divina Commedia di Dante Alighieri. Di seguito presentiamo la parafrasi della preghiera che San Bernardo rivolge alla Madonna nel Paradiso dantesco. Il canto XXXII del Paradiso infatti si apre con la preghiera che San Bernardo rivolge alla Vergine Maria. Egli viene scelto da Dante non a caso, proprio perché fu il più importante esponente del pensiero mistico del XII secolo, e soprattutto fu colui che più di ogni altro contribuì all’affermazione del culto di Maria Vergine: il Santo aveva esaltato la sua funzione mediatrice tra Dio e l’umanità, valorizzata dall’esperienza della maternità. Questa preghiera è legata all’attività proposta nella scheda fotocopiabile numero 8 dal titolo Vergine Madre.

Vergine Madre - Parafrasi
Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e grande fra tutte le creature, oggetto della volontà eterna di Dio; Tu sei colei che nobilitasti tanto la natura umana a tal punto che il suo Creatore non disdegnò di farsi propria creatura. Nel tuo grembo si riaccese l’amore di Dio per gli uomini grazie al quale nel Paradiso è fiorita questa rosa dei beati. Qui sei per noi fiaccola ardente di carità, e giù in terra inesauribile sorgente di speranza. O Signora, sei tanto grande e potente, che se qualcuno vuole ottenere una grazia senza rivolgersi a te, è come colui che vuole volare senza ali. La tua bontà non solo soccorre chi prega, ma molte volte spontaneamente previene la richiesta. In te si concentra tutto ciò che di buono vi è nei mortali, misericordia, pietà, magnificenza e ogni virtù.
La Divina Commedia, una delle più famose opere della letteratura italiana, è stata scritta da Dante Alighieri nel XIV secolo. Il poeta racconta il viaggio immaginario che fa attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Nell’ultimo canto del Paradiso, Dante incontra San Bernardo il quale rivolge a Maria, la Madre di Gesù, questa splendida preghiera.

ergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d’etterno consiglio; Tu se’ colei che l’umana natura nobilitasti si’, che ‘l suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l’amore per lo cui caldo nell’etterna pace così è germinato questo fiore. Qui se’ a noi meridiana face di caritate, e giuso, intra i mortali, se’ di speranza fontana vivace. Donna, se’ tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia ed a te non ricorre, sua distanza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s’aduna quantunque in creatura è di bontate. Dante Alighieri
Con l’aiuto dell’insegnante prova a riscrivere nell’italiano di oggi i versetti della preghiera di Dante Alighieri. Colora.
Esegui una ricerca sui santuari mariani che vedi nella cartina e rispondi alle domande.

• Maria, quando ricevette il messaggio divino portato dall’angelo, si trovava a...
BETLEMME NAZARET GERUSALEMME
• Come si chiamava l’angelo che apparve a Maria?
MICHELE RAFFAELE GABRIELE
• Maria viene implorata Regina della...
LUCE PACE TERRA
• Chi disse a Maria: “... il dolore ti colpirà come colpisce una spada?
SIMEONE GIOVANNI PIETRO
• Con quale altro nome viene chiamata, in genere, la Vergine Maria?
DONNA CELESTE MADRE SACERDOTESSA

Il testo sacro dei musulmani, il Corano, parla di Maria nei capitoli delle Sure 3, 5 e 19. In particolare, il Corano tramanda cinque fatti inerenti alla figura di Maria:
1 La sua nascita (Sura 3,5-19)
2 Il suo ritiro presso il tempio di Gerusalemme (Sura 3,37.42-44)
3 L’annuncio dell’angelo che le spiega che sarebbe diventata madre di Gesù (Sura 3,45-49)
4 Il momento della nascita di Gesù (Sura 19,22-26)
5 La difesa della sua innocenza da parte di Gesù bambino (Sura 19,27-33)
In quanto madre di Gesù, l’Islam esprime una profonda ammirazione per Maria Gesù, però è considerato un grande profeta ma non il Figlio di Dio. Conseguentemente, Maria per i musulmani non è considerata la Madre di Dio. Per ogni fedele, comunque, Maria è un modello da imitare soprattutto per la sua obbedienza e accettazione della volontà di Dio.
Numera le immagini secondo l’argomento evidenziato nei capitoli della Sura. Colora.
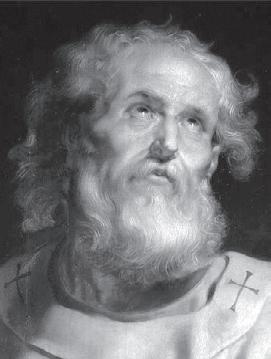
Nome or ig inar io ( Mc 1, 16)
N om e attribuito g li d a Ge sù (G v 1 ,40 -4 2) che si g nifi ca
Vivev a a
Pro fess io ne ( pri m a e dop o l a chia ma t a)
Pro fess io ne di fede ( Mt 16 , 13 - 19)
Rinn ega ment o d i G e sù (M c 14 , 30 - 31 . 66-72)
In iz io de ll a p re di c az i on e ( At 2 , 14 - 41)
Docum ent i p r od o tt
Lu og o e data d i mo rte
Si mb olo
Con l’aiuto del tuo insegnante e di un atlante biblico traccia su questa cartina, usando quattro colori diversi, il percorso di ciascun viaggio missionario dell’apostolo Paolo.

PRIMO VIAGGIO MISSIONARIO (rosso)
Da Antiochia di Siria all’isola di Cipro, poi a Perge, poi ad Antiochia di Pisidia, poi ad Iconio, poi a Listri, infine a Derbe.
SECONDO VIAGGIO MISSIONARIO (blu)
Da Antiochia di Siria a Tarso, poi a Derbe, poi a Listri, poi ad Iconio, poi a Triade, poi a Nespoli, poi a Tessalonica, poi a Berea, poi ad Atene, poi a Corinto, poi per mare ad Efeso, poi a Cnido, poi per mare a Cesarea, poi a Gerusalemme.
TERZO VIAGGIO MISSIONARIO (verde)
Da Antiochia di Siria a Tarso, poi attraverso la Galazia fino ad Antiochia di Pisidia, poi ad Efeso, poi a Triade, poi a Filippi, poi a Corinto, poi a Nespoli, poi di nuovo a Triade, poi ad Asso, poi a Mitilene, poi per mare a Patara, poi sempre per mare a Tiro, poi a Tolemaide, poi a Cesarea.
QUARTO VIAGGIO MISSIONARIO (arancio)
Viene arrestato a Gerusalemme, trasferito a Cesarea, poi a Sidone, poi per mare a Cnido, poi all’isola di Creta, poi subisce un naufragio andando all’isoletta di Caudas, da qui va all’isola di Malta, poi a Siracusa, poi a Reggio Calabria, poi a Pozzuoli e infine a Roma, dove muore martire.
CLASSE
Costruisci il “diario di bordo” dei quattro viaggi di San Paolo.
I santi Pietro e Paolo sono indissolubilmente uniti nella loro opera evangelizzatrice, tanto che sono festeggiati assieme nel calendario il 29 giugno.
Chiediamo agli alunni di distinguere in questa immagine l'uno dall'altro, spiegare perché tengono in mano questi oggetti e colorare.

Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• individua i tratti essenziali del cristianesimo, della Chiesa e della sua missione.
Verifica LA CHIESA DELLE ORIGINI
Compito di realtà LE CHIESE DELLA TUA CITTÀ
u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
La Chiesa delle origini
• Il diacono Stefano, primo martire della Chiesa.
• Da Costantino a Teodosio, il cristianesimo si diffonde. Dalla domus ecclesiae alle catacombe.
• I simboli paleocristiani.
• Gli stili delle chiese nel tempo.
Da pag. 22 a pag. 46
Dio e l’uomo
• Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo.
Con questa unità, l’insegnante porterà a conoscenza degli alunni lo SVILUPPO
DEL CRISTIANESIMO subito DOPO LA MORTE E RESURREZIONE DI GESÙ, con la nascita delle prime comunità chiamate a portare avanti il suo annuncio di amore.
All’inizio il cammino della Chiesa fu duro e difficile con persecuzioni e uccisio-
ni nel mondo ebraico e romano. Grazie al coraggio della testimonianza degli apostoli e dei martiri, la diffusione del cristianesimo non si arrestò, trovando, al contrario, maggiore forza e sviluppo.
Con l’imperatore Costantino nel 313 d.C. terminarono le persecuzioni e i cristiani poterono liberamente professare la propria fede e cominciarono a costruire i propri luoghi di culto, fino alla nascita delle chiese. Inoltre, verranno approfonditi i vari simboli paleocristiani comparsi nelle prime catacombe: sono segni che nascondevano il messaggio d’amore di Gesù, ma che, nello stesso tempo, potevano essere capiti da tutti, anche da chi non sapeva né leggere né scrivere, aiutando così lo sviluppo della fede cristiana durante il periodo delle persecuzioni.
Gli alunni scopriranno che LA PAROLA CHIESA PORTA IN SÉ UN DUPLICE SIGNIFICATO , intesa come COMUNITÀ CHE VIVE E ANNUNCIA IL VANGELO e come LUOGO DI CULTO DEI
CRISTIANI, affrontando un ipotetico viaggio nel tempo che li porterà a conoscere lo sviluppo dei diversi stili architettonici nel corso dei secoli.
Ultima tappa di questa unità sarà la conoscenza del Credo cristiano, ovvero una vera e propria carta d’identità dei cristiani, nata dall’esigenza di contrastare le eresie di quel periodo e messo per iscritto dai vescovi di tutto il mondo riuniti nei primi concili della storia (Nicea e Calcedonia).
Erano assidui nell’ascoltare l’INSEGNAMENTO DEGLI APOSTOLI e nell’unione fraterna, nella frazione del PANE e nelle PREGHIERE. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli.
Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo.
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. (At 2,42-48)
Quando si viaggia si fa sempre un’esperienza interessante ma, non raramente, si incontrano delle difficoltà. Questa constatazione è il filo conduttore in filigrana di questa unità di lavoro, in riferimento ai momenti difficili affrontati dai primi cristiani, soprattutto le persecuzioni.
Un riferimento “forte” a momenti difficili vissuti dai nostri alunni è costituito da quanto proponiamo ora sul tema del bullismo, davvero un “incidente di viaggio” pesante per chi vi incappa, purtroppo non raramente.
Leggiamo ai ragazzi la seguente lettera, relativa a un fatto di cronaca reale raccontato da Famiglia Cristiana nel settembre del 2017.
«A tutti voi che nel corso della mia vita vi siete solo impegnati a “divertirvi” con le mie emozioni, sottolineando i miei difetti anche più nascosti, distruggendomi interiormente senza rendervene conto, voglio dire grazie.
Grazie per avermi lasciata sola a raccogliere i pezzi rotti di me stessa e fatto in modo che li rimontassi a mio piacimento così da sembrare più forte; grazie perché adesso il mio fisico è cambiato.
Non so se è migliorato perché ho perso quei pochi chili che avevo in più di cui mi vergognavo, dopo tutte le vostre critiche poco costruttive ma pesanti, perché eravate in tanti se non troppi a farle.
Voglio solo dire un altro grazie a tutti quelli privi di cuore nei miei confronti. Sapete perché vi ringrazio? Perché, nonostante tutto, la vostra ignoranza mi ha resa più forte e ho sempre mantenuto il sorriso davanti a voi, non lasciandovela vinta».
Dopo la lettura della lettera, che potrebbe fare una nostra alunna, poniamo le seguenti domande per stimolare la conversazione con gli alunni.
RIFLETTIAMO
• Cosa è successo a questa studentessa?
• Chi vuole ringraziare?
• Perché vuole ringraziare?
• Ciò che gli è successo cosa ha provocato in lei?
• È accaduto anche a te un episodio simile?
• Come ti sei sentito?
• Cosa hai fatto?
• Come si è risolto?
Se lo riteniamo opportuno possiamo proporre un breve cammino progettuale sul bullismo (e cyberbullismo), tantopiù che questa tematica è indicata dal Ministero come da affrontare assolutamente nel corso della Scuola Primaria e noi, come docenti di Religione, ne siamo investiti in pieno per la portata umana della cosa.
Tutti nella loro vita, poco o tanto, hanno preso in giro o sono stati derisi. A volte tra amici prendersi in giro con degli scherzi è bello, è anche un modo per iniziare un’amicizia bella e importante.
Quando però il deridere diventa una prepotenza che continua nel tempo e soprattutto è intenzionale non è più un semplice scherzo. Si crea una differenza tra i ragazzi coinvolti in cui “il più forte” colpisce “il più debole” che si sente solo e non sempre ha il coraggio di raccontare quanto gli sta accadendo. Ecco allora che si parla di bullismo.
Questo fenomeno che è in ampia diffusione tra i ragazzi può essere di più tipi. Può colpire la vittima da un punto di vista fisico, verbale, psicologico e purtroppo anche elettronico. Si parla perciò di cyberbullismo.
tipi questi cristiani
I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale.
La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli altri.
Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale.
Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati.
Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi.
Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti, e vengono condannati. Sono uccisi, e riprendono a vivere. Sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbondano. Sono disprezzati, e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed onorano.
Facendo del bene vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell’odio.
(Dalla Lettera a Diogneto, II secolo d.C.)
L'editto di Costantino
Nel 313 d.C. Costantino proclamò l’editto di Milano, riconoscendo piena libertà di culto alle comunità cristiane e ordinando la restituzione di tutti i loro beni confiscati. I cristiani potevano acquistare proprietà, aprire e frequentare luoghi di culto in pubblico ed avere i propri cimiteri. Successivamente Costantino concesse l’immunità ai sacerdoti e la possibilità di ereditare ed accettare donazioni, accumulando ricchezze per attività di assistenza sociale e caritativa. La domenica fu proclamato giorno festivo.
Il martirio di Santo Stefano
Il luogo dove Stefano fu martirizzato si trova a Gerusalemme, fuori dalla porta di Damasco. Egli è definito protomartire (primo martire), fu il primo cristiano ad essere ucciso perché testimoniava il Vangelo e la propria fede in Gesù Cristo. Stefano applicava totalmente la regola della carità fraterna, infatti tutti i discepoli condividevano i beni e ad ognuno di loro veniva distribuito a seconda dei bisogni. Stefano all’interno della comunità aveva il ruolo di amministratore ma anche di predicatore verso i non cristiani. Fu arrestato e morì lapidato.
Il giorno in cui si ricorda il suo martirio è il 26 dicembre. Di lui s’ignora il luogo di provenienza, fu il primo diacono di Gerusalemme (somministrava i sacramenti) e fu tra i primi giudei a convertirsi al cristianesimo.
Con i martiri
Dal II al IV secolo le comunità cristiane si estendono in tutto il bacino del Mediterraneo e in Oriente. Il cristianesimo si diffonde nell’intero Impero Romano. Sono iniziate, le grandi persecuzioni, che finiranno nel 313 con l’Editto di Milano, emanato dall’Imperatore Costantino, con il quale si concede libertà di culto. Innumerevoli sono i santi martiri, vittime delle persecuzioni.
Per approfondire ulteriormente l’argomento legato alle persecuzioni leggiamo agli alunni il seguente racconto sul martirio di S. POLICARPO e poi una cronaca medioevale del martirio di CIPRIANO, vescovo di Cartagine.
Fu condotto allo stadio, dove regnava un tale chiasso che nessuno avrebbe potuto farsi intendere. Mentre Policarpo entrava nello stadio si udì una voce dal cielo: «Sii forte o Policarpo, e comportati da valoroso.» Nessuno vide chi aveva parlato, ma quelli dei nostri che erano presenti udirono la voce. Quando finalmente fu introdotto, la notizia del suo arresto suscitò un tumulto enorme.
Tradotto dunque innanzi al proconsole, questi lo interrogò se egli fosse Policarpo. Rispondendo egli affermativamente, il proconsole cercò di indurlo a rinnegare Cristo dicendogli: «Abbi riguardo alla tua età e a tutte le altre cose che sogliono far seguire, cioè: giura per il genio di Cesare; ravvediti e dì: Abbasso agli atei!.»
Allora Policarpo gettando uno sguardo severo sulla turba dei traviati pagani che gremivano lo stadio, e accennando a loro con un gesto della mano: «Sì, certamente, non più atei!» E volse gli occhi al cielo, traendo un profondo sospiro.
Il proconsole insisteva, dicendo: «Giura e ti rilascio; insulta il Cristo.» «Sono ottantasei anni che lo servo e non m’ha mai fatto torto alcuno; come potrei quindi bestemmiare il mio Re e Salvatore?» rispose Policarpo. Il proconsole insistette di nuovo dicendo: «Giura per il genio di Cesare.» «Se ti illudi di farmi giurare per il genio di Cesare, come tu dici, riprese Policarpo, e fingi di ignorare chi sono io, ascolta, te lo dirò francamente: io sono cristiano. Se poi tu vuoi imparare che cosa sia il cristianesimo, dammi un giorno di tempo e ascoltami.» «Persuadi il popolo.» disse il proconsole. «Te io ho stimato degno di udire le mie ragioni; poiché ci fu insegnato di rendere onori ai poteri e alle magistrature ordinate da Dio, nel modo che a loro si conviene, purché non sia a noi di danno. Quanto a quelli lì, io non li stimo degni di udire la mia difesa...» Fu più presto fatto che detto: in un baleno la folla si diede a raccogliere legna e sarmenti dalle officine e dai bagni; e, come al solito, i più zelanti in questa opera furono i Giudei. Quando il rogo fu pronto cominciò egli stesso a deporre i vestiti e, sciolta la cintura, prese a levarsi da sé i calzari, cosa che prima non soleva fare, perché ciascuno dei fedeli andava a gara nell’essergli più pronto a rendergli quel servigio, per poter toccare il suo corpo; talmente era venerato, anche prima del martirio per la santità della sua vita.
Fu tosto collocato in mezzo all’apparecchio, che serviva per fissare il paziente al rogo e stavano per inchiodarvelo; ma egli disse: «Lasciatemi così. Colui che mi da la forza di sopportare il fuoco mi darà anche quella di rimanere immobile
sul rogo, senza la precauzione dei vostri chiodi.» Poiché ebbe detto amen, appena terminata la preghiera, gli uomini addetti al rogo vi appiccarono il fuoco. E mentre, grande lampeggiava la fiamma, apparve un portento a noi, cui fu dato di vederlo, e che fummo riservati per narrare agli altri questi avvenimenti.
Il fuoco infatti, curvandosi a guisa di volta, come vela di nave gonfiata dal vento, circondò il corpo del martire; sicché egli stava nel mezzo non già come carne che brucia, ma come pane che vien cotto, o come oro e argento che si purifica nella fornace. E a noi giunse un profumo delizioso, come quello che esala dall’incenso o da altro aroma prezioso.
Alla fine gli empi, vedendo che le fiamme non riuscivano a consumare il suo corpo, diedero ordine a un confector che gli si avvicinasse e lo trafiggesse con un pugnale.
Appena gli ebbe eseguito l’ordine uscì fuori una colomba e tanta copia di sangue che spense il fuoco; e la folla rimase piena di meraviglia al vedere quanta differenza passa tra gli infedeli e gli eletti. Nel numero di costoro è certamente il meraviglioso martire Policarpo, che, ai tempi nostri, fu un maestro apostolico e profeta, vescovo della Chiesa cattolica di Smirne.
Da: G. Bosio, Iniziazione ai Padri, SEI
E così il giorno seguente, ottavo avanti le calende di ottobre, una gran folla si radunò alla villa di Sesto secondo l’ordine del proconsole Galerio Massimo. E così il medesimo proconsole Galerio Massimo in quello stesso giorno ordinò che gli fosse presentato, mentre egli sedeva nell’atrio Sauciolo, Cipriano. E quando gli fu presentato, il proconsole Galerio Massimo, disse a Cipriano: «Tu sei Tascio Cipriano?» Il vescovo Cipriano: «Sono io.» rispose.
Il proconsole Galerio Massimo disse: «Tu ti sei comportato come gran sacerdote di gente sacrilega?» Il vescovo Cipriano rispose: «Io.»
Il proconsole Galerio Massimo disse: «I sacratissimi imperatori ti ordinano di far sacrificio secondo la cerimonia romana.» Il vescovo Cipriano disse: «Non lo faccio.» Il proconsole Galerio Massimo disse: «Rifletti ai casi tuoi.»
Il vescovo Cipriano rispose: «Fa’ quanto ti è imposto. In cosa tanto giusta non
occorre riflettere.»
Galerio Massimo, dopo aver consultato il tribunale, pronunziò a stento e malvolentieri la sentenza con queste parole: «Sei vissuto a lungo facendo professione d’empietà e hai raccolto intorno a te moltissimi individui d’una pericolosa setta, ti sei dichiarato nemico degli dei romani e delle cerimonie religiose, né i sacratissimi principi Valeriano e Gallieno Augusti e Valeriano nobilissimo Cesare poterono indurti ad aderire alla pratica della loro religione: pertanto essendo tu autore e istigatore confesso di tale colpe, servirai di esempio a quanti hai coinvolti nel tuo delitto; col tuo sangue sarà affermato il vigore delle leggi.»
Dette queste parole, lesse sulla tavoletta la condanna a morte: «Ordino che Tascio Cipriano sia decapitato.» Il vescovo Cipriano disse: «Grazie a Dio.» Dopo questa sentenza la folla dei fratelli diceva: «Anche noi vogliamo essere decapitati con lui.» Ne sorse tra i fratelli un tumulto e una gran folla lo seguì. E così il medesimo Cipriano fu condotto nella campagna di Sesto, e ivi si spogliò della sopravveste e piegò a terra il ginocchio e si prostrò in orazione al Signore.
Ed essendosi spogliato della dalmatica, che consegnò ai diaconi, rimase con la tunica di lino e cominciò ad attendere il carnefice.
Venuto poi il carnefice, ordinò ai suoi che dessero al carnefice stesso venticinque monete d’oro. Dai fratelli venivano gettati davanti pannolini e fazzoletti.
Poi il beato Cipriano si bendò di propria mano gli occhi; e non potendo legarsi le fasce ai polsi, il presbitero Giuliano e il suddiacono gliele legarono.
Così il beato Cipriano sofferse il martirio, e il corpo di lui fu deposto in luogo vicino per sottrarlo alla curiosità dei gentili.
Acta Proconsularia Cypriani, III, I, Patrologia latina accurante J.B. Migne, III, 1497
RIFLETTIAMO
• Per quale motivo Policarpo e Cipriano vengono condannati?
• I proconsoli che cosa vogliono che facciano i cristiani?
• Che cosa rispondono i cristiani?
• Secondo te, su che cosa i cristiani fondano la loro speranza?
Approfondimento
I primi cristiani consideravano la sepoltura un dovere. Inizialmente le prime tombe erano intagliate nella roccia, secondo la consuetudine ebraica, oppure erano costituite da una camera sotterranea, sul tipo degli ipogei etruschi, ma molto più semplici. Le tombe divennero presto luoghi di ritrovo, specie se in esse era stato deposto un martire.
Per l’aumentato numero dei cristiani e per il diffuso desiderio di essere seppelliti il più vicino possibile ai martiri, divenne necessario predisporre un’area per la sepoltura.
Le CATACOMBE furono i cimiteri sotterranei usati dalle prime comunità cristiane per seppellire i propri morti, al contrario dei pagani che li bruciavano. Collocate al di fuori delle città, le catacombe, erano costituite da una rete di corridoi e gallerie strette e buie scavate nel tufo, spesso su più piani. Il tipo di tomba più frequente era quella a loculi, composta da vani scavati orizzontalmente nelle pareti delle gallerie, poi chiusi con lastre di marmo o con mattoni sigillati da calce. Sulle superfici imbiancate veniva inciso il nome del defunto.
I LOCULI rappresentavano il sistema sepolcrale più umile. Oltre ai loculi vi erano numerose camere tombali per intere famiglie detti CUBICOLA
In questo caso i loculi erano intagliati nelle pareti della stanza o sul pavimento e corredati di affreschi o ampie iscrizioni.
TOMBE ancora più elaborate erano gli
ARCOSOLIA, cavità a forma di sarcofago sormontate da nicchie a forma di arco. Talvolta venivano utilizzati sarcofagi di marmo o terracotta, a seconda delle possibilità del defunto.

I primi nuclei sotterranei delle catacombe sorsero nel II secolo e furono ampliati nel III secolo grazie al lavoro di professionisti chiamati FOSSORES o scavatori. Le gallerie delle catacombe romane formarono una rete sotterranea di oltre 200 m. In esse possiamo rinvenire le prime testimonianze di arte cristiana, un’arte di tipo simbolico: in alcuni dipinti e incisioni vengono rappresentati con semplicità alcuni concetti difficili da esprimere.
Oltre ai simboli più comuni come il PESCE, il MONOGRAMMA DI CRISTO, la FENICE, il BUON PASTORE, la NAVE, l’ALFA e l’OMEGA ve ne sono altri. Tra questi:
L’ALBERO
Rappresenta la vita che dalla terra si sviluppa verso il cielo con foglie, frutti, fiori, quali segni della sua vitalità. Sono questi simboli della vita terrena che tende alla vita del cielo, alla resurrezione.
L’AGNELLO
Rappresenta Gesù crocifisso, trafitto da un colpo di lancia. Gesù è presentato come Agnello di Dio che si offre per la salvezza dell’uomo.
L’AGNELLO
Rappresenta Gesù crocifisso, trafitto da un colpo di lancia. Gesù è presentato come Agnello di Dio che si offre per la salvezza dell’uomo.
IL PAVONE
È simbolo della resurrezione della carne in relazione a una credenza che riteneva le sue carni incorruttibili.
LA COLOMBA
Simboleggia, secondo il contesto: l’intervento salvifico di Dio; lo Spirito Santo; l’anima del defunto; la pace.
L’ORANTE
Simboleggia l’anima in possesso della beatitudine celeste che intercede per coloro che restano in vita ed anche il desiderio di raggiungere il cielo.
L’ANCORA
È strumento che tiene ferma la nave quando il mare è agitato, perché non vada alla deriva. Essa simboleggia: la speranza fiduciosa nella salvezza; la croce che è l’albero maestro della nave, cioè della Chiesa.
Le catacombe
In riferimento alle prime comunità, si farà riferimento alle catacombe (CIMITERI
SOTTERRANEI), scavate nel tufo, con scale che conducono alle gallerie in cui sono sistemati i loculi nel senso della lunghezza chiusi da mattoni o lastre di mar mo.
Questo sistema voleva essere umile e ugualitario, proprio nel rispetto delle regole comunitarie che animavano i primi cristiani. La maggior parte delle catacombe si trovano a ROMA (circa una sessantina) e altrettante nel Lazio.
Nelle pareti si sviluppano pitture e mosaici che raccontano le storie della Bibbia e mostrano alcuni simboli del Cristianesimo:
GESÙ = PESCE
PARADISO = COLOMBA
FEDE = ÀNCORA
Sulle lastre veniva spesso rappresentato un attrezzo che indicava il mestiere svolto dal defunto.

Costruiamo una basilica
REALIZZAZIONE
1 3 2
Prendere 7 scatole delle misure riportate nel modello.
Seguendo lo schema disegnato prendi ogni singolo elemento contrassegnato da una lettera dell’alfabeto e decoralo con archi, finestre, tetto...
Una volta asciugati, assembla i vari elementi con colla vinilica sempre seguendo lo schema disegnato.
OCCORRENTE
• Scatole di cartone di diverse misure
• Colla vinilica
• Forbici
• Colori a tempera
• Pennelli
Tutti a scuola han paura di un bullo
Cammina tra noi come fosse un rullo, Quando va in giro il bullo, io scappo
Lui mi rincorre e mi dice: “Ora ti acchiappo!”
Tutti lo temono se si avvicina
A tanta arroganza qualcuno si inchina,
Lui prende in giro il resto del mondo
E dà del cicciopalla a chi è grasso
e un po’ tondo!
Del bullo han paura
Sia belli, che brutti, Grandi e piccini…
Insomma un po’ tutti,
Ma io questa volta li ho messi a cantare
La rima che il bullo ha dovuto ascoltare
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo, Se fosse a Firenze sarebbe anche grullo, Vivrebbe anche lui in un mondo più bello,
Se usasse col cuore anche il cervello!
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo, Un pollo convinto di essere un gallo, Sconfiggere il bullo anche tu ora puoi
Unisciti al coro e canta con noi!
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo, Se fosse a Firenze sarebbe anche grullo, Vivrebbe anche lui in un mondo più bello,
Se usasse col cuore anche il cervello!
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo, Un pollo convinto di essere un gallo, Sconfiggere il bullo anche tu ora puoi
Unisciti al coro e canta con noi!
Ora ogni giorno è più sorridente,
Tutto è più allegro e più divertente.
Il bullo ci ha visti uniti e sicuri
E adesso va strisciando contro tutti i muri.
Se la lezione
L’abbiamo capita È un grande tesoro
Per tutta la vita,
Il bullo è tornato e mi ha detto: “Se vuoi, Potrei unirmi anch’io a cantare con voi?”
A cantare con noi?
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo, Se fosse a Firenze sarebbe anche grullo, Vivrebbe anche lui in un mondo più bello, Se usasse col cuore anche il cervello!
Si crede perfetto ma il bullo è citrullo, Un pollo convinto di essere un gallo , Sconfiggere il bullo anche tu ora puoi
Unisciti al coro e canta con noi!
Zecchino d’Oro
Di bulli come te ce ne sono tanti, fai volare insulti pesanti, parole buone non sai pronunciare, gran spettacolo vuoi sempre dare.
Sei come una bolla di sapone, gonfio d’aria e senza ragione avanzi sempre tante pretese solo verso persone indifese.
Questo vile comportamento spesso viene fuori nel momento
In cui ti trovi in compagnia di chi ti sostiene con ipocrisia.
Credi di essere forte e fiero, Ma sei solo un prigioniero ella tua grande debolezza che annienta ogni dolcezza.
Forse tu non hai capito, debole non è chi hai avvilito, In difetto sei tu soltanto giacché il tuo cuore vive affranto.
Ma questo lo realizzerai quando in solitudine resterai, Non si può vivere senza amore, che della vita è il motore.
Caro bullo, tu forse non lo sai, ma segni profondi lascerai, Cicatrici che nel cuore portano solo tanto dolore.
Ci vorrà molto, chi lo sa. Non so quando si rialzerà Chi hai ferito con le tue sfide e adesso più non sorride.
Ma adesso sai cosa facciamo?
Da oggi in poi ci teniamo la mano, sconfiggendo con saggezza ogni violenza perché la forza è l’amicizia.

Accogli, o Padre Santo, Dio eterno e onnipotente. Accogli questo Anno che oggi incominciamo. Sin dal primo giorno, sin dalle prime ore desideriamo offrire a Te, che sei senza inizio, questo nuovo inizio. Questa data ci accompagnerà nel corso di molte ore, giorni, settimane e mesi. Giorno dopo giorno apparirà davanti a ciascuno di noi come un nuovo frammento del futuro, che subito dopo cadrà nel passato così come del passato fa ora parte l’intero anno trascorso. L’anno Nuovo appare davanti a noi, come una grande incognita, come uno spazio che dovremo riempire con un contenuto, come una prospettiva di avvenimenti sconosciuti e di decisioni da prendere. Come una nuova tappa e un nuovo spazio della lotta di ogni essere umano e insieme a livello della famiglia, della società, delle nazioni: dell’umanità intera.
Papa Giovanni Paolo II

All’inizio del nuovo anno prego il Signore di concedere la pace, la concordia, la tranquillità nell’ordine e nel rispetto dei diritti di ogni persona umana, senza cui il mondo non può avanzare verso traguardi di progresso e di civiltà.
Papa Giovanni Paolo II
Il testo della canzone servirà alla classe per riflettere sul tema così importante della costruzione di un mondo di pace , senza discriminazioni razziali , più giusto, senza guerre e soprattutto con la speranza che non ci sia più indifferenza ma amore.
Quante volte ci ho pensato su, Il mio mondo sta cadendo giù
Dentro un mare pieno di follie, Ipocrisie.
Quante volte avrei voluto anch’io Aiutare questo mondo mio,
Per tutti quelli che stanno soffrendo
Come te
Il mondo che vorrei
Avrebbe mille cuori,
Per battere di più avrebbe mille amori.
Il mondo che vorrei
Avrebbe mille mani
E mille braccia per i bimbi del domani,
Che coi loro occhi
chiedono di più
Salvali anche tu.
Per chi crede
nello stesso sole
Non c’è razza non c’è mai colore
Perché il cuore
di chi ha un altro Dio
è uguale al mio.
Per chi spera ancora in un sorriso,
Perché il suo domani l’ha deciso
Ed è convinto che il suo domani
È insieme a te.
Il mondo che vorrei
Ci sparerebbe i fiori, Non sentiremo più Il suono dei cannoni.
Il mondo che vorrei,
Farebbe più giustizia
Per tutti quelli che La guerra l’hanno vista,
E coi loro occhi
chiedono di più
Salvali anche tu.
Come si fa a rimanere qui,
Immobili così
Indifferenti ormai
A tutti i bimbi che Non cresceranno mai
Ma che senso ha ascoltare
e non cambiare
Regaliamo al mondo
quella pace
Che non può aspettare più
Nel mondo che vorrei uh uh uh
Nel mondo che vorrei
Avremo tutti un cuore.
Il mondo che vorrei
Si chiamerebbe amore.
Stringi forte le mie mani
E sentirai il mondo che vorrei
Uh uh uh i l mondo che vorrei.
Laura Pausini
Ascolta dall’insegnante l’articolo circa la ragazza presa in giro ed evidenzia le parole che più ti colpiscono, riportandole nei rettangoli qui sotto. Poi metti la crocetta accanto alle frasi che corrispondono all’episodio di cronaca.
La ragazza ricorda con tristezza i compagni che l’anno presa in giro e che l’hanno fatta soffrire anziché dare il loro aiuto e la loro amicizia.
La ragazza ringrazia i suoi compagni che l’hanno aiutata a crescere forte con le loro parole d’incoraggiamento.
La studentessa ringrazia i suoi compagni per le belle emozioni che ha provato con loro.
La studentessa ringrazia i compagni perché dalle loro cattiverie ha tratto la forza di resistere e di sorridere sempre.
La ragazza è rimasta ferita nel cuore, ma ha anche saputo superare e rafforzare la stima di sé.
La ragazza è rimasta ferita nel cuore e non riuscirà più a risanare i pezzi feriti di se stessa.
Scrivi nella pergamena una breve descrizione di te stesso, delle tue emozioni e del tuo modo di comportarti. Hai mai vissuto situazioni di bullismo? Se sì, racconta.
Descrivi ciascun comportamento e analizza se, in un qualche modo, ti appartiene o meno. Trova le motivazioni di tali comportamenti e analizza anche queste.
Immagina di essere un giornalista del tempo che intervista i protagonisti del fatto, redigi poi un articolo più dettagliato.
“Nel giorno di Calende di Quintilis Nerone sottopone a supplizio Liberto, fedele ad una superstizione nuova e malefica chiamata Cristianesimo.”
Gaio Svetonio
PROTAGONISTI
LIBERTO, NERONE, GAIO SVETONIO, CRISTIANI, ROMANI
INTERVISTA
• Nerone, perché hai ordinato il supplizio di Liberto?
• Liberto, chi ti ha accusato e perché?
• Gaio Svetonio, perché consideri il Cristianesimo una superstizione malefica?
• Cristiani, in che cosa credete e perché?
• Romani, che idea vi siete fatti dei cristiani?
NOME
CLASSE
Ricerca gli articoli della Costituzione italiana che trattano della libertà di religione. Confrontali con l’Editto di Milano e di Tessalonica e poi rispondi alle domande.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
ART. 3 DELLA COSTITUZIONE
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
ART. 8 DELLA COSTITUZIONE
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
ART. 19 DELLA COSTITUZIONE
• Quale dei due Editti assomiglia alle indicazioni della Costituzione? Perché?
• Se tu fossi un Imperatore come ti comporteresti a riguardo?
L’agnello, caratterizzato dalla docilità e dal dipendere in tutto dal suo pastore, rappresenta un’immagine del rapporto tra l’uomo e Dio. Leggi il versetto che trovi in Giovanni 10,14 e ricopialo qui sotto.

L’agnello, caratterizzato dalla docilità e dal dipendere in tutto dal suo pastore, rappresenta un’immagine del rapporto tra l’uomo e Dio. Leggi il versetto che trovi in Giovanni 10,14 e ricopialo qui sotto.
Osserva l’immagine riportata qui sotto. Si tratta di un antico simbolo cristiano. A che cosa assomiglia? Un suggerimento: si tratta della stilizzazione di un comune animale.
Quale? Rispondi:
Quale? Rispondi:
Il nome di questo animale in greco si scrive nel seguente modo:
Il nome di questo animale in greco si scrive nel seguente modo:


Ogni lettera è l’iniziale di una parola che compone la seguente frase:
Ogni lettera è l’iniziale di una parola che compone la seguente frase:
7-5-17-19 3-16-9-17-18-13 6-9-7-10-9-13 4-9 4-9-13 17-1-10-20-1-18-13-16-5
In epoca di persecuzioni da parte dei Romani, i cristiani non avrebbero mai potuto scrivere una cosa simile. Ecco il perché dell’invenzione di questo misterioso anagramma.
Scopri che cosa significa la frase usando il codice.
In epoca di persecuzioni da parte dei Romani, i cristiani non avrebbero mai potuto scrivere una cosa simile. Ecco il perché dell’invenzione di questo misterioso anagramma. 1 8 15 2 9 16 3 10 17 4 11 18 5 12 19 6 13 20 7 14 21
Osserva l’immagine che raffigura un noto santo francescano diffusore del cosiddetto monogramma di Cristo, cioè delle tre lettere IHS, abbreviazione della parola greca che designa GESÙ. Probabilmente nel tuo paese o città esiste qualche raffigurazione del monogramma di Cristo o in una chiesa, o in qualche edicola religiosa o anche vicino alle porte delle case. Prova a scoprire se ne trovi qualcuno e fotografalo.
Scopri chi è questo santo usando il codice.
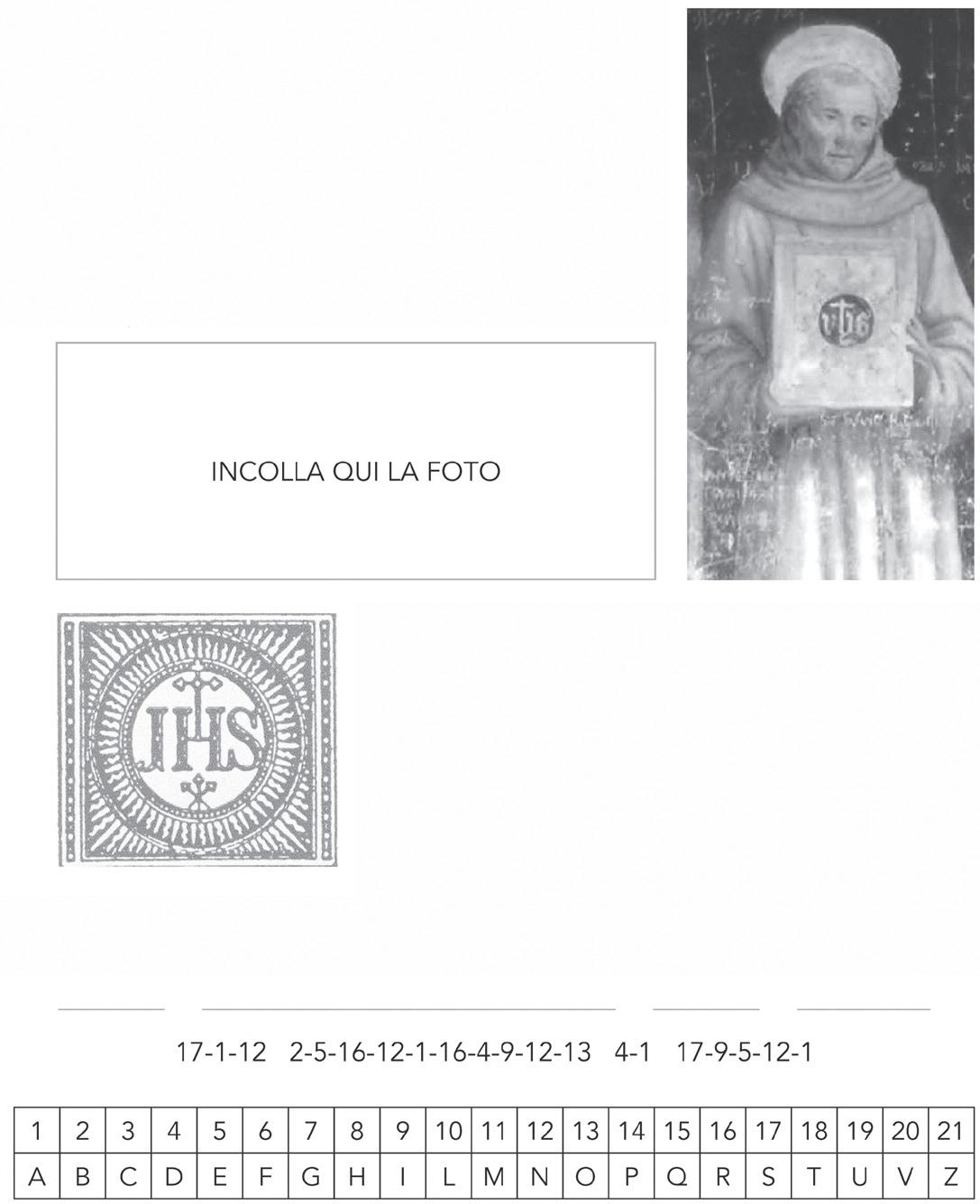
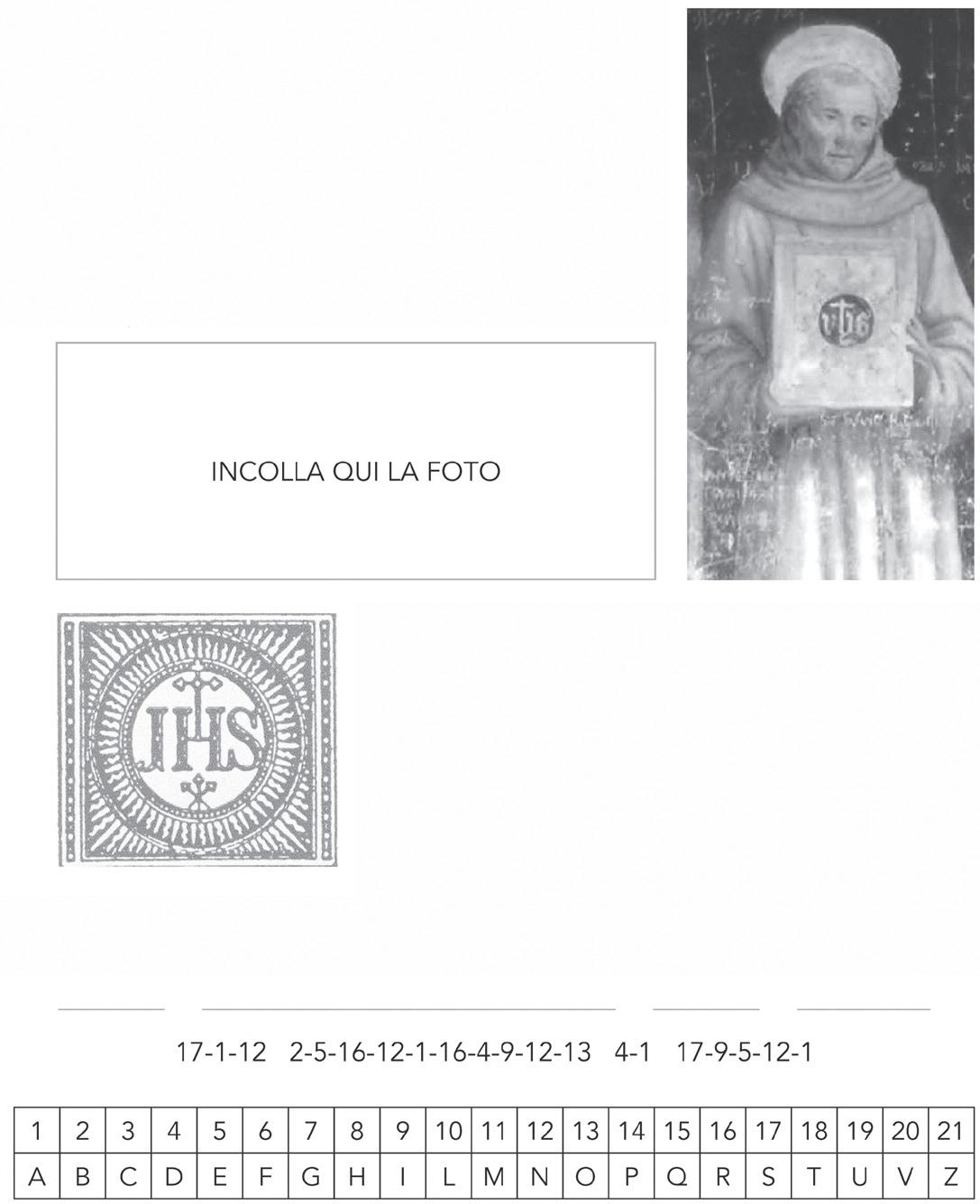
Si ritiene che grazie alla sua predicazione il IHS o JHS (Jesus hominum Salvator = Gesù salvatore degli uomini) sia entrato nell’uso iconografico comune e sia divenuto familiare alla gente. Infatti, venivano fatte baciare ai fedeli che ascoltavano le sue prediche delle tavolette di legno incise con il monogramma sormontato da una croce e attorniato da un sole.
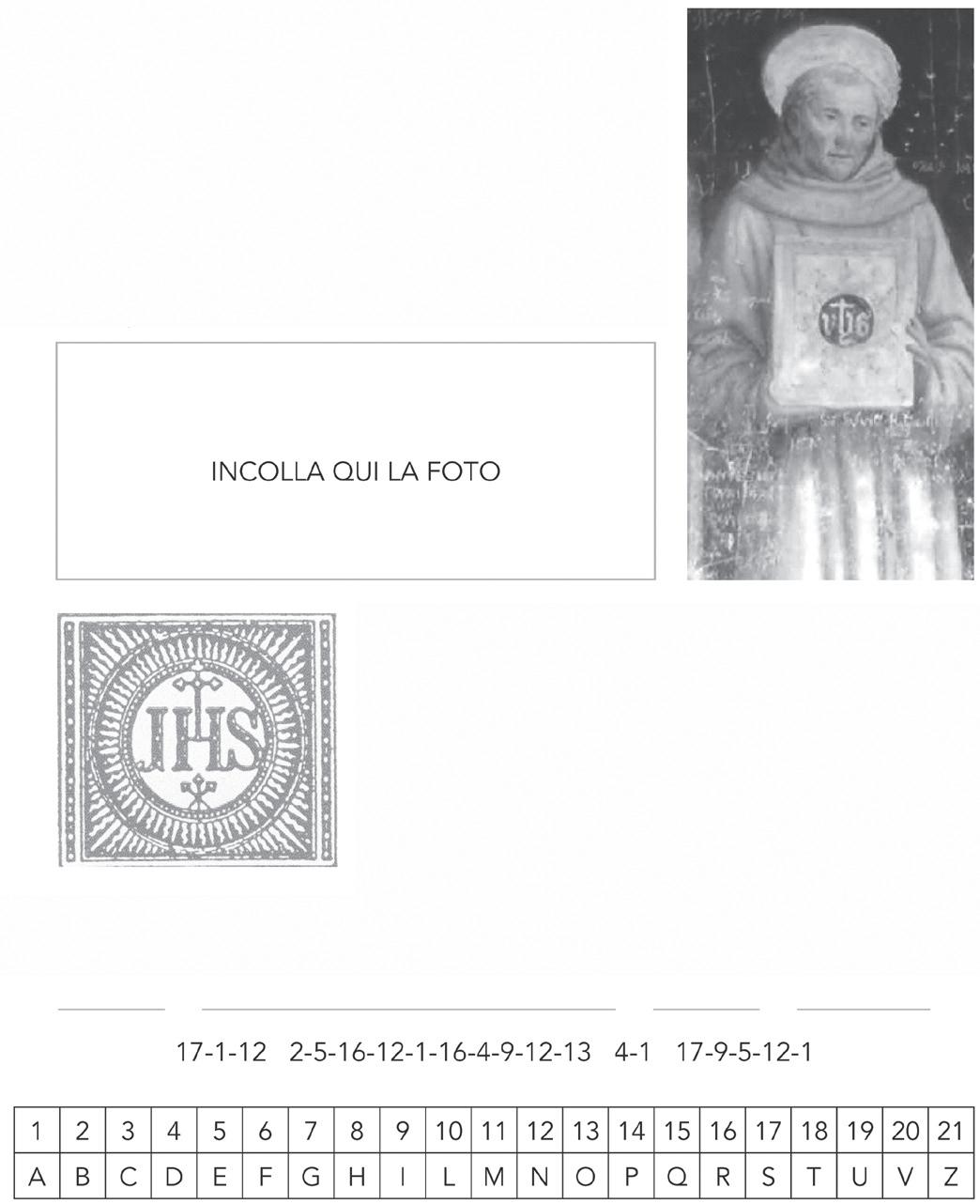
Immagina di essere un abile archeologo che deve ricostruire l’interezza delle seguenti antiche iscrizioni cristiane in una catacomba. Il tempo le ha rovinate, completa tu i disegni e da’ a ciascuno un nome.
Con l’editto di Milano (313 d.C.), l’Imperatore Costantino permise la costruzione di luoghi di culto. I primi edifici sacri furono le basiliche. Nel corso dei secoli lo stile architettonico delle chiese cambiò a seconda dei gusti e delle correnti artistiche, mantenendo però, sempre, la sua importante funzione di esprimere i contenuti della fede.
Analizza con l’aiuto dell’insegnante queste immagini e completa con quanto viene richiesto.

Periodo storico:
Stile architettonico:

Periodo storico:
Stile architettonico:

Periodo storico:
Stile architettonico:

Periodo storico:
Stile architettonico:

Periodo storico:
Stile architettonico:
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• conosce le caratteristiche fondamentali delle principali confessioni cristiane.
• riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
La Chiesa nel tempo
• Il monachesimo.
• Lo Scisma d’Oriente: cattolici e ortodossi.
• Lo Scisma d’Occidente: i riformati.
• Gli ordini mendicanti e il francescanesimo.
Da pag. 47 a pag. 64 Il linguaggio religioso
• Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalla vita della Chiesa.
• Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.
I valori etici e religiosi
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore.
• Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con sé stessi, con l’altro e con Dio.
In questa unità l’insegnante approfondirà la conoscenza del MONACHESIMO, fenomeno nato intorno al III e IV secolo d.C. in Europa, e che vede alcuni cristiani VIVERE LA FEDE IN GESÙ IN MODO RADICALE, lasciando la vita agiata alla ricerca di luoghi e ambienti dove poter SPERIMENTARE IL SILENZIO, LA SOLITUDINE, LA PREGHIERA e LA POVERTÀ come stile di vita sull’esempio di Cristo.
Due i principali personaggi del monachesimo: Sant’Antonio Abate in Egitto e poi San Benedetto da Norcia in Italia.
Quest’ultimo protagonista e artefice dello sviluppo del monachesimo cenobitico, che ha permesso la diffusione e la conservazione della cultura in Europa, grazie al lavoro degli amanuensi nei diversi monasteri sorti in quel periodo. La parte centrale di questa unità guiderà gli alunni alla conoscenza delle divisioni avvenute all’interno della Chiesa cristiana, a causa dei due grandi scismi d’oriente (1056 d.C.) e d’occidente (1517 d.C.). Il percorso continua con la NASCITA DEGLI ORDINI MENDICANTI che cercarono di diffondere il Vangelo vivendo con le elemosine dei fedeli.
Due i protagonisti fra tutti: SAN FRANCESCO D’ASSISI (l’ordine francescano) e SAN DOMENICO DI GUZMAN (l’ordine domenicano).
La vita di Sant'Antonio Abate
Antonio nacque a Coma, in Egitto nel 250 d. C., da una ricca famiglia contadina, EDUCATO SECONDO I PRINCIPI EVANGELICI e, rimasto orfano giovane, vendette le sue proprietà e si dedicò alla vita ascetica. VISSE COME EREMITA IN PREGHIERA , povertà e castità, non senza essere attaccato da durissime prove e tentazioni che superò con la sua grande tenacia e fede. Molti cristiani si recavano al suo eremo per consiglio e conforto spirituale. Per due volte nella sua vita lasciò l’eremo, una nel 311 quando si recò ad Alessandria d’Egitto per sostenere i cristiani perseguitati dall’imperatore romano Massimino Daia ed un’altra volta per sostenere il suo amico Sant’Atanasio, vescovo di Alessandria, contro l’eresia ariana. Visse nel deserto della Tebaide per una lunghissima vita ultracentenaria dove FU D’ESEMPIO PER MOLTI CHE DESIDERAVANO VIVERE UNA FEDE PIÙ PROFONDA FONDATA SULLA PREGHIERA E SULLA CONTEMPLAZIONE.
Quando nel 561 fu scoperto il suo luogo di sepoltura, cominciarono a circolare in vari paesi e città le sue reliquie.
IN FRANCIA FU PERFINO COSTRUITA UNA CHIESA IN SUO ONORE , dove vi si recavano ad onorare le reliquie del Santo molti ammalati di herpes zoster, chiamato anche “fuoco di Sant’Antonio”, in quanto una confraternita di religiosi, gli “Antoniani”, avevano costruito un ospedale per ospitare questi malati e curarli con il grasso dei maiali da loro allevati.
Per questo motivo nell’iconografia cristiana il Santo veniva ritratto con accanto il maialino, che poi la pietà popolare ha esteso a tutti gli animali domestici e alla stalla divenendone il loro protettore e patrono, tanto che il 17 gennaio, giorno della sua scomparsa terrena, nelle campagne si usa benedire la stalla e gli animali.
Nell’iconografia è ritratto anche con il bastone dell’eremita a forma di T.
San Benedetto da Norcia

Benedetto nacque a Norcia nel 480 d.C. da una famiglia nobile, A DICIASSETTE ANNI FUGGÌ DA ROMA , dove si era recato per gli studi giuridici, SCONVOLTO DAL DEGRADO SOCIALE andò a vivere a sessanta chilometri da Roma cercando la solitudine e dedicandosi alla vita religiosa. Si spostò poi a Subiaco dove incontrò il monaco Romano che lo condusse in una caverna dove Benedetto volle vivere una vita ascetica. Romano lo alimentò, lo rivestì con l’abito religioso e per tre anni mantenne il segreto sulla sua vita solitaria. Successivamente Benedetto abbandonò la vita ascetica per dedicarsi all’insegnamento fondando dodici piccoli monasteri e mantenendo la direzione del monastero dedicato alla formazione dei suoi discepoli. Purtroppo verso di lui si creò gelosia, tanto da rischiare di essere ucciso. Così Benedetto decise di trasferirsi a Cassino dove era ancora diffuso il paganesimo: decise di far abbattere gli altari pagani, rase al suolo il bosco dedicato ad Apollo e adattò i vecchi edifici rendendoli dimora dei monaci. Fu architetto e ingegnere del monastero di Montecassino, dove scrisse la sua Regola e morì il 21 marzo del 547 d.C.
Ora et labora
La Regola consiste in un programma preciso dell’organizzazione di una comunità monastica, basata sulla preghiera e sul lavoro (Ora et labora = Prega e lavora). Nel monastero vive un gruppo di CONFRATELLI guidati dalla direzione di un ABATE. Essi devono rinunciare totalmente ad ogni proprietà personale, prendere i VOTI e rispettare le regole della comunità dove rimarranno fino alla morte.
L’insegnante può introdurre il significato delle parole evidenziate sul testo e chiedere agli alunni di dare la loro interpretazione.
Gli amanuensi
Prima dell’invenzione della stampa erano gli schiavi che ricopiavano i manoscritti commissionati dai privati o dal potere pubblico. Con la diffusone del cristianesimo, i manoscritti venivano ricopiati soprattutto nelle abazie dei benedettini. San Benedetto stabilì l’obbligo di avere all’interno del monastero lo SCRIPTORIUM, un ambiente destinato alla copiatura dei testi.
L’insegnante può proporre in classe la lettura di alcuni brani del romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco (1980) e la visione di alcune scene del film omonimo di Jean Jacques Annaud (1986), in cui si trasmette in modo efficace l’ atmosfera degli antichi monasteri medievali.
I codici e le miniature
I codici erano LIBRI COPIATI DAGLI AMANUENSI , FORMATI DA FOGLI CUCITI . I primi testi furono copiati SU PAPIRI ARROTOLATI, in seguito vennero incisi su TAVOLETTE CERATE con uno strumento a punta. Dal V al XII secolo venne utilizzata una pergamena fatta con la pelle trattata degli animali (vitello, capra, montone), con il rasoio raschiavano le pergamene e marcavano la distanza tra le righe con il compasso. Utilizzavano un INCHIOSTRO NERO, ROSSO PER LE MAIUSCOLE E I TITOLI , VERDE E AZZURRO PER LE INIZIALI, ORO E ARGENTO PER I CODICI LUSSUOSI. Il lavoro del miniatore cominciava al termine di quello del copista, decorando e illustrando le lettere in argento e oro.
L'origine del canto gregoriano
Il canto gregoriano trae l’origine del nome dal grande PAPA BENEDETTINO GREGORIO MAGNO, UOMO DOTTO ED ERUDITA, che ha saputo riunire i CANTI SACRI LITURGICI in un libro detto “Antifonario”, dal quale attingere le melodie latine adatte alla contemplazione.
Il canto gregoriano viene interpretato da un CORO DI VOCI MASCHILI e dal solista cantore senza accompagnamento strumentale. Si tratta di una musica recitativa che permette l’INTERIORIZZAZIONE DELLA PAROLA DI DIO.

Gli ordini mendicanti
Intorno al secolo XI ci furono UOMINI E DONNE SENSIBILI AGLI IDEALI DI POVERTÀ EVANGELICA: nascono in questo periodo frati che diffondevano forme di culto più vicine alla spiritualità del Vangelo, vivendo solo delle elemosine elargite dai fedeli per questo motivo essi erano definiti “frati mendicanti”.
Erano specializzati nell’ARTE ORATORIA della predicazione pubblica, con sermoni che ebbero grande successo nelle piazze cittadine. Oltre a san Francesco di Assisi che fondò l’ordine dei Francescani, vi fu Domenico di Guzman, vissuto tra il 1170 e il 1221, che fondò l’ordine dei domenicani, dediti alla predicazione evangelica contro le eresie, in particolare quella catara della Francia meridionale. Infatti i catari erano considerati una setta eretica contraria alla Chiesa cristiana. Fecero parte di questo ordine molti agenti dell’Inquisizione (una istituzione fondata da papa Gregorio IX, per giudicare gli eretici secondo un tribunale ecclesiastico) e un grande intellettuale quale Tommaso d’Acquino, autore della Summa Teologica.
L’ordine dei carmelitani nasce dalla riunione di tutti gli eremiti del monte Carmelo ad Haifa, in Palestina, l’odierna Israele.
La Compagnia di Gesù, fondata da Sant’Ignazio di Loyola nel 1534, i cui membri sono chiamati gesuiti, ha come voto la totale obbedienza al papa e l’impegno nelle missioni e nell’educazione. L’emblema dell’ordine è un disco raggiante
con al centro il MONOGRAMMA
Le confraternite sono delle associazioni che nascono con lo scopo di accogliere, curare e confortare gli ammalati e gli infermi. Sono i primi centri ospedalieri.
San Giovanni di Dio fu il fondatore dell’ordine “FATEBENEFRATELLI”, i suoi seguaci hanno fondato ospedali che ancora oggi portano questo nome.
San Filippo Neri
Filippo Neri, soprannominato dalla sorella
“PIPPO IL BUONO” per il suo carattere altruista e allegro, nasce a Firenze nel luglio del 1515 in una famiglia di notai. Della sua infanzia si hanno poche informazioni.
A 18 anni lascia la sua città natale per recarsi in Campania.
Ben presto però parte per Roma e conosce una città corrotta nel pieno del Rinascimento. Qui fa il precettore, STUDIA TEOLOGIA E FILOSOFIA, visita i luoghi frequentati dai primi cristiani come le catacombe.
Nasce in lui un sentimento spirituale profondo che lo porterà ad essere consacrato sacerdote nel 1551.
Si impegna soprattutto con quella parte della popolazione povera, in difficoltà economiche, avvicinando i ragazzi di strada per introdurli nell’oratorio e accostarli alle scritture.
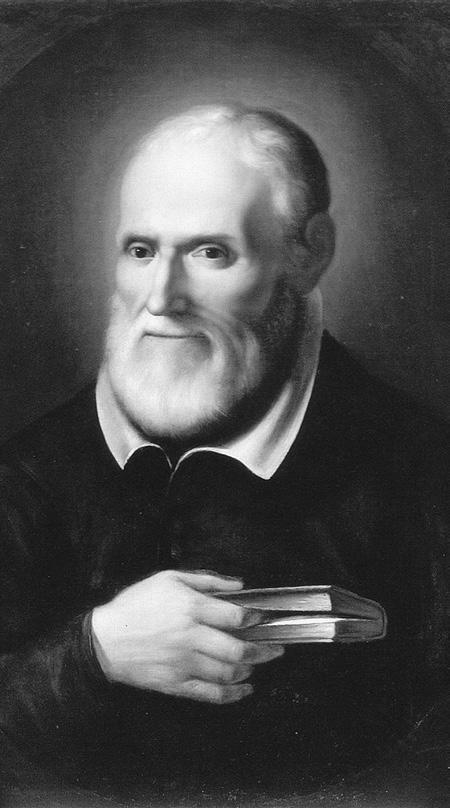
Qui i giovani sfortunati di Roma hanno la possibilità di nutrirsi, giocare e avere un’istruzione.
L’oratorio diventa il luogo a cui tutti possono accedere, in cui creare legami di amicizia e praticare la carità. A lui e ai suoi compagni fu affidata la cura di Santa Maria in Vallicella. PER IL SUO CARATTERE ALLEGRO E MITE È CHIAMATO IL “GIULLARE DI DIO”. Muore nel maggio del 1595.
San Giovanni Bosco

Fratelli cristiani
Giovanni Bosco è un UOMO DI GRANDE SEMPLICITÀ, INTELLIGENZA E UMANITÀ
Nasce a Castelnuovo d’Asti nel 1815 in una famiglia contadina molto povera. La sua vocazione è molto profonda e diventa sacerdote nel 1841. Quando arriva a Torino rimane molto colpito dalle condizioni di precarietà dei giovani che non hanno lavoro, ideali e girovagano per le strade. Si fa dunque PROMOTORE DELLA NASCITA DELL’ORATORIO per poter dare loro un’opportunità di vita migliore. Li aiuta nel trovare lavoro e nell’istruzione, il suo è un impegno a tempo pieno. Da qui la necessità di trovare finanziamenti che gli permettano di attuare il suo progetto. Osservandolo con attenzione alcuni giovani desiderano essere come lui: ecco che nasce la “SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES” e quindi l’ORDINE DEI SALESIANI. Nel gennaio del 1888 muore a Torino.
Per semplificare l’argomento relativo ai cristiani separati, si suggerisce di leggere il brano che segue.
Anche se l’esempio riportato è preso da un’esperienza fatta a catechismo, ci pare renda ugualmente bene l’idea che vogliamo esprimere: quella della RICERCA
DELL’UNITÀ DEI CRISTIANi.
Il brano inoltre si presta anche a una drammatizzazione sullo stesso tema.

Siamo nell’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani. La catechista ha cercato di presentare ai fanciulli il significato dell’iniziativa di preghiera e si è avventurata a spiegare chi sono i protestanti, gli ortodossi, e i cattolici.
Naturalmente i fanciulli non hanno compreso granché. Ebbene, quel giorno i fanciulli, che erano arrivati in anticipo e che di solito aiutavano la catechista a sistemare la sala, avevano preparato tre vasi di fiori differenti: uno di margherite, uno di garofani e uno di mimose. A partire da questi tre vasi di fiori veniva costruita una storia o una favola, presentata poi dai fanciulli alla Messa della domenica seguente, nella quale la comunità pregava per l’unità dei cristiani.
La drammatizzazione, inventata con la collaborazione di tutti, raccontava la storia di un re che aveva ordinato un mazzetto di fiori.
Arrivava un primo gruppo di fanciulli che diceva ad alta voce: «Un mazzo di margherite! Il re vuole le margherite!»
Dall’altra parte si faceva avanti un altro gruppo che gridava: «Non è vero! Il re ama solo i garofani!» e naturalmente si faceva un po’ di confusione.
A questo punto entrava in scena un terzo gruppo che diceva: «Tutte storie! Noi siamo andati a leggere nel libro del re. Al re piacciono tutti i fiori eccetto le margherite e i garofani!»
E ricominciava la baraonda, fino a quando tutti i gruppi dicevano: «Così non va: bisogna trovare una soluzione.» L’unica soluzione era quella di offrire al re tre mazzetti differenti, mettendo davanti a lui tre vasi. Furono portati i tre vasi e furono deposti sull’altare, separati e distanti fra di loro.
A questo punto il re diceva: «Non avete capito niente! Io amo tutti i fiori, è vero. Ma mi sarebbe piaciuto vederli tutti insieme in un unico mazzo.»
E tuttavia furono lasciati i tre mazzetti separati, per mostrare che c’era da fare una cosa sola, quella di unire i tre mazzetti in un solo mazzo; ma per il momento la cosa non era ancora possibile... C’era ancora un cammino da fare.
L’ora di Religione n. 5, anno IV, Elledici
• Che cosa rappresentano i tre mazzolini di fiori?
• Che cosa rappresenta il re?
• Qual è l’insegnamento di questo racconto?
• Hai mai sentito parlare di iniziative a favore dell’unità dei cristiani?
• Secondo te, quali cose possono essere ancora fatte per ristabilire l’unità tra tutti i credenti in Gesù?
ORTODOSSO. Le icone ortodosse
Presentiamo agli alunni le icone, termine che di solito si associa al CRISTIANESIMO
L’icona è la tradizionale RAPPRESENTAZIONE DI CRISTO, DELLA VERGINE MARIA E DEI SANTI. Essa nasce e si diffonde a partire dal IV secolo, in Oriente, al tempo in cui la Chiesa Orientale era ancora unita alla Chiesa Occidentale. Essa è una TAVOLA DI LEGNO STAGIONATA (tiglio, betulla) su cui si stende una tela che viene poi ricoperta con vari strati di gesso.
Il disegno viene inciso sulla tavola così preparata, e in seguito vengono stesi vari strati di colori, dal più scuro al più chiaro, secondo una tecnica chiamata “illuminazione”. La Santa Vergine, ad eccezione del Salvatore, è il soggetto più raffigurato nell’iconografia cristiana. Osservando le icone della Madre di Dio si può notare la ROTONDITÀ DEL CAPO DELLA VERGINE , che indica la PERFEZIONE DELLA
CREATURA SCELTA DA DIO per la realizzazione del suo disegno salvifico sull’uomo. Anche le mani, nella loro stessa forma mobile e allungata e nella gestualità maestosa e misurata, rivelano profondi significati teologici. Le icone di Maria più frequenti appartengono a due tipi: “L’Eleousa” e “L’Hodighitria”, che, secondo la tradizione, risalgono al primo iconografo, S. Luca apostolo.
LA VERGINE ELEOUSA (della Tenerezza)
In questa icona LA VERGINE RECA IL BAMBINO SUL BRACCIO SINISTRO, E CHINA IL CAPO VERSO DI LUI IN SEGNO DI AFFETTO. Il Bambino le si stringe ed è volto verso sua Madre. Il
nome dunque fa riferimento al rapporto tra Madre e Figlio pieno di tenerezza. La Madre di Dio è anche simbolo della Chiesa di Cristo, e l’icona ci mostra tutta la pienezza dell’amore tra Dio e l’uomo – pienezza che è possibile soltanto nel grembo della Madre – Chiesa.
L’amore unisce in questa icona quello che è celeste e quello che è terrestre, il divino e l’umano: l’unione è espressa dai volti che si toccano e dalle aureole congiunte. La Madre di Dio spesso è pensierosa, mentre stringe a sè il Figlio: prevede il cammino della croce e le sofferenze che lo aspettano.
Di queste icone la più venerata in Russia è la Madonna di Vladimir.
LA VERGINE HODIGHITRIA (che mostra la via)
L’icona è caratterizzata dal GESTO DELLA MANO DELLA VERGINE CHE INDICA IL BAMBINO GESÙ, via di salvezza eterna. La Madre di Dio sostiene il Bambino con il braccio sinistro e lo indica con la mano destra, lo sguardo di entrambi è rivolto verso il fedele. Le immagini sono severe, dirette, le teste di Cristo e della Vergine non si toccano. Il Bimbo è già cresciuto, col volto più da adulto, vestito come i saggi filosofi greci e tiene tra le mani un cartiglio oppure è benedicente. Nella Russia le più famose icone di questo modello sono: Madonna di Smolensk, Madonna di Tichvin, Madonna di Iver.
I COLORI

L’ORO È IL COLORE DELLO SFONDO DI OGNI ICONA. Lo sfondo è unico come unico è lo sfondo su cui tutto esiste ed avviene: è Dio, perché in Lui viviamo, e ci muoviamo. LO SFONDO RAPPRESENTA
UNA PROFESSIONE DI FEDE; tutti gli altri colori infatti acquistano significato proprio in relazione all’oro. IL ROSSO RAPPRESENTA
LA DIVINITÀ, ma può anche essere la vita, perché è il colore del sangue. IL BLU È L’UMANITÀ. Nelle raffigurazioni di Cristo, questi ha la veste di sotto rossa e di sopra blu per raffigurare che Dio si è rivestito d’umanità. Al contrario la Madonna ha la prima veste blu e la seconda rossa.
IL VERDE RAPPRESENTA IL COSMO, il creato. IL BIANCO È IL COLORE DELLO SPIRITO SANTO, ed è spesso associato al verde. IL NERO RAPPRESENTA LA MANCANZA DI VITA, dunque LA MORTE. Il marrone simboleggia ciò che è terrestre e nella sua natura più umile e povero.
Prima di analizzare i principi della fede protestante approfondiamo la conoscenza della figura di MARTIN LUTERO, fondatore.
MARTIN LUTERO
Martin Lutero NACQUE A EISLEBEN IN GERMANIA IL 10 NOVEMBRE 1483 da una famiglia di origine contadina. Ricevette un’EDUCAZIONE MOLTO RIGIDA, impregnata dall’idea di un Dio giudice e severo. A 22 anni si era già laureato in filosofia all’Università di Erfurt, e avrebbe proseguito negli studi giuridici secondo la volontà del padre, quando scampò a un fulmine. L’amico che passeggiava con lui rimase ucciso.
Il giovane fece un voto a S. Anna. Poi, ispirato dalla madre, una donna molto pia, e ossessionato da tempo dal problema della salvezza dell’anima, entrò nel convento dei frati agostiniani, sempre a Erfurt.
Dopo due anni fu ordinato sacerdote e nel 1510 compì un viaggio a Roma come pellegrino dove non trovò nessun confessore che potesse mettere fine alle sue inquietudini interiori. Nel 1511 venne trasferito nel convento di Wittemberg, qui in preda a forti tentazioni, egli si immerse nella penitenza, nella preghiera, nella ricerca teologica, cercando di raggiungere la propria salvezza attraverso la verità. In questo periodo iniziò un intenso studio sui Salmi e sulla Lettera ai Romani di Paolo, che prese come fonte ispiratrice delle sue idee riformatrici.
Nel 1512 divenne DOTTORE IN TEOLOGIA A WITTEMBERG , fece GIURAMENTO DI FEDELTÀ E OBBEDIENZA ALLA CHIESA DI ROMA e ottenne la cattedra di Sacra Scrittura.
Egli aveva un sogno: quello di riportare la Chiesa alla semplicità delle origini. Proprio mentre Lutero elaborava la sua visione teologica, si presentò l’occasione della rottura.
Nel 1515 papa Leone X affidò all’arcivescovo di Magonza la concessione delle indulgenze per ricavare fondi per la costruzione della basilica di San Pietro. L’arcivescovo a sua volta delegò un frate domenicano, un certo Tetzel a predicare le indulgenze che era solito usare quest’espressione per convincere i fedeli: «Non appena il denaro tintinna nella cassetta, l’anima esce dal fuoco.» Lutero indignato nel 1517 indirizzò alcune lettere di protesta all’arcivescovo e al suo vescovo diocesano deplorando il modo in cui si predicavano le indulgenze. Non ricevendo risposta, decise di scrivere le 95 tesi contro le indulgenze che secondo la tradizione furono affisse il 31 ottobre 1517 sulla porta della chiesa di tutti i santi del castello di Wittemberg. Inizialmente a Roma la cosa non destò
preoccupazione.
Solo il 7 agosto 1518 venne convocato con l’ACCUSA DI ERESIA, ottenne di essere interrogato dal cardinale Caetano ad Augsburg, ove si manifestò chiaramente la rottura protestante. Lutero non ritrattò e insistette nella discussione. Nel 1519, nella disputa di Lipsia con Johann Eck, Lutero affermò apertamente che il concilio può errare e che il primato pontificio non è d’istituzione divina. Con la bolla papale Exsurge Domine del 15 giugno 1520 Leone X invitò Lutero alla ritrattazione delle tesi entro 60 giorni, pena la scomunica.
Egli rispose bruciando la bolla papale per cui la scomunica lo colpì nel 1521. Il 26 maggio del 1521 Carlo V firmò l’editto di Worms mettendo al bando il riformatore e i suoi sostenitori; ma grazie alla complicità di Federico di Sassonia, Lutero si rifugiò per sedici mesi nel Castello di Wartburg, ove si dedicò alla traduzione in tedesco del Nuovo Testamento. Nel 1522 torna a Wittemberg e nel 1525 sposa una ex monaca, Katharina Von Bora da cui avrà sei figli. Nel 1530 fu convocata la dieta di Augusta, in cui si definirono le posizioni dottrinali protestanti attraverso i 28 articoli della Confessio Augustana redatta da Melantone, il suo braccio destro. Dal 1541 Lutero si ritirò a Wittemberg ormai malato. Morì a Eisleben il 18 febbraio 1546, all’età di 63 anni.

La Rosa di Lutero, o Stemma di Lutero, è il simbolo riconosciuto del luteranesimo. In una lettera del 1516, Martin Lutero spiegò il significato della rosa:
«Prima dev’esserci una croce: nera nel cuore, che ha il suo colore naturale, affinché io mi ricordi che la fede nel Crocifisso ci rende beati. Poiché il giusto vivrà per fede, per la fede nel Crocifisso. Ma il cuore deve trovarsi al centro di una rosa bianca, per indicare che la fede dà gioia, consolazione e pace; perciò la rosa dev’essere bianca e non rossa, perché il bianco è il colore degli spiriti e di tutti gli angeli. La rosa è in campo celeste, che sta per la gioia futura. Il campo è circondato da un anello d’oro, per indicare che tale beatitudine in cielo è eterna e che non ha fine e che è anche più eccellente di tutte le gioie e i beni, così come l’oro è il minerale più pregiato, nobile ed eccellente.»
Presentiamo agli alunni una griglia sinottica delle tre confessioni cristiane per poter cogliere gli elementi comuni e le differenze inoltre essa potrà essere d’aiuto per completare la scheda numero 5.
Argomento
MINISTRI DEL CULTO:
I loro ministri del culto si chiamano sacerdoti. Sono obbligati al celibato.
AUTORITÀ RELIGIOSE: Il capo della loro Chiesa è il Papa.
BIBBIA:
SACRAMENTI:
SANTI E MARIA:
NATALE:
MESSA:
CHIESA:
CROCE:
Interpretano la Bibbia con la guida del Magistero della Chiesa.
I loro sacramenti sono sette: comunicano la grazia divina.
Celebrano molte festività in onore di Maria e dei Santi
Viene festeggiato il 25 dicembre.
Alla Domenica si riuniscono per celebrare l’Eucaristia, nella Santa Messa.
È semplice o riccamente adornata a seconda dello stile architettonico.
Rappresenta il sacrificio di Gesù, e di conseguenza la Risurrezione.
I loro ministri del culto si chiamano pope. Possono sposarsi ed avere figli.
I capi delle loro chiese sono i Patriarchi.
Seguono la Bibbia alla luce della Tradizione.
I loro sacramenti sono sette.
Celebrano molte festività in onore di Maria (non riconoscono l’Immacolata concezione) e dei Santi.
Viene festeggiato il 7 gennaio.
Alla Domenica si riuniscono per celebrare l’Eucaristia in modo solenne.
È ricca di pietre, materiali preziosi e icone.
Ha in più un braccio obliquo, come una bilancia: significa che i peccati saranno pesati.
I loro ministri del culto si chiamano pastori. Possono sposarsi ed avere figli.
Non vi è alcuna gerarchia. L’unica autorità religiosa è Dio.
Interpretano personalmente la Sacra Scrittura.
I loro sacramenti sono solo due: il Battesimo e la Cena del Signore.
Non venerano né Maria, né i Santi.
Viene festeggiato il 25 dicembre.
Alla Domenica si riuniscono per leggere la Bibbia, pregare e cantare.
È molto semplice e piuttosto spoglia: non ci sono immagini, né statue.
Non presenta Gesù, volendo mostrare la Risurrezione più che la morte.
Con San Francesco d'Assisi
Francesco d’Assisi (1182-1226), santo patrono d’Italia, è l’uomo più conosciuto ed amato, da persone di ogni ceto sociale e credo religioso. Milioni di credenti e non credenti si recano ogni anno a visitare i luoghi dell’uomo che assomigliò più di tutti a Cristo. Entrando nella basilica di San Francesco, si può ammirare il ciclo di affreschi, realizzato da GIOTTO, che ha fermato nel tempo gli episodi più importanti della vita del santo.
Aiutati da queste immagini e dai racconti dei primi biografi di Francesco, andiamo alla scoperta di quest’uomo convertitosi dalla vanità del mondo alla vita nuova in Cristo.

Viveva ad Assisi, nella valle spoletana, un uomo di nome Francesco. Nacque durante un’assenza del padre, e la madre gli mise nome Giovanni; ma, tornato il padre dal suo viaggio in Francia, cominciò a chiamare suo figlio Francesco. Dai genitori ricevette una cattiva educazione, ispirata alle vanità del mondo. Imitando i loro esempi, egli stesso divenne ancor più leggero e vanitoso. Sciupò miseramente il tempo, dall’infanzia fin quasi al suo venticinquesimo anno. Anzi, precedendo in queste vanità tutti i suoi coetanei, si era fatto promotore di mali e di stoltezze. Oggetto di meraviglia per tutti, cercava di eccellere sugli altri ovunque e con smisurata ambizione: nei giochi, nelle raffinatezze, nei bei motti, nei canti, nelle vesti sfarzose e morbide. Allegro e spensierato, gli piaceva godersela e cantare, andando a zonzo per Assisi giorno e notte con una brigata di amici, spendendo in festini e divertimenti tutto il denaro che guadagnava o di cui poteva impossessarsi. Non era spendaccione soltanto in pranzi e divertimenti, ma passava ogni limite anche nel vestirsi. Si faceva confezionare abiti sontuosi e, nella ricerca dell’originalità, arrivava a cucire insieme nello stesso indumento stoffe preziose e panni grossolani. (FF 1395ss; 320ss)
Un nobile assisano, desideroso di soldi e di gloria, organizzò una spedizione per andare a combattere in Puglia. Venuto a sapere la cosa, Francesco fu preso dalla sete di avventura e dal desiderio di diventare cavaliere e s’impegnò per realizzare il suo progetto.
Ma una notte gli apparve uno che, chiamatolo per nome, lo condusse in un grande palazzo, in cui spiccavano, appese alle pareti, armature da cavalieri, splendenti scudi e simili oggetti di guerra. Francesco, incantato, pieno di felicità e di stupore, domandò a chi appartenessero quelle armi e quel palazzo meraviglioso. Gli fu risposto che tutto quel che vedeva, insieme al palazzo, era proprietà sua e dei suoi cavalieri. Svegliatosi, s’alzò quel mattino pieno di entusiasmo.
Interpretando il sogno secondo criteri mondani, fantasticava che sarebbe diventato un gran principe. Messosi dunque in cammino, giunse fino a Spoleto e qui cominciò a non sentirsi bene. Mentre riposava, nel dormiveglia intese una voce interrogarlo dove fosse diretto. Francesco gli espose il suo ambizioso progetto. E quello: «Chi può esserti più utile: il padrone o il servo?».
Rispose: «Il padrone.» Quello riprese: «Perché dunque abbandoni il padrone per seguire il suo servo, e il principe per il suddito?» Allora Francesco interrogò: «Signore, che vuoi che io faccia?» Concluse la voce: «Ritorna nella tua città e là ti sarà detto cosa devi fare; poiché la visione che ti è apparsa devi interpretarla in tutt’altro senso.» Risvegliatosi, egli si mise a riflettere attentamente su questa rivelazione. Pensava e ripensava così intensamente al messaggio ricevuto, che quella notte non riuscì più a chiudere occhio. Spuntato il mattino, in gran fretta dirottò il cavallo verso Assisi, lieto ed esultante. (FF 1399ss)
Era del tutto mutato nel cuore quando, un giorno, passò accanto alla chiesa di San Damiano, quasi in rovina e abbandonata da tutti. Condotto dallo Spirito, entrò a pregare, si prostrò devoto davanti al crocifisso e, toccato in modo straordinario dalla grazia divina, si ritrovò totalmente cambiato.
Mentre egli era così profondamente commosso, improvvisamente l’immagine di Cristo crocifisso dal dipinto gli parlò, muovendo le labbra: «Francesco – gli disse chiamandolo per nome – va’, ripara la mia casa che, come
vedi, è tutta in rovina.»
Francesco pieno di stupore, quasi perdette i sensi a queste parole, ma subito si dispose ad obbedire e si concentrò tutto su questo invito.
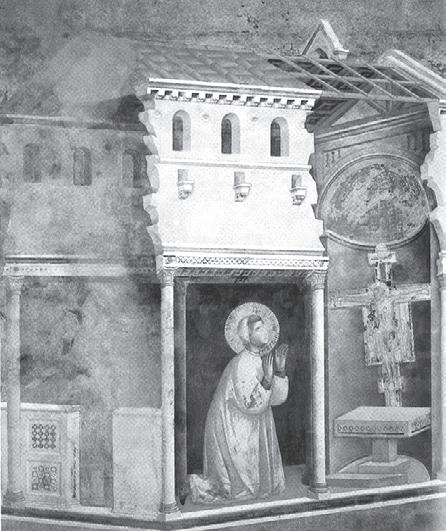
Si prese cura di quella sacra immagine e offrì denaro al sacerdote che viveva in quella chiesetta, perché non rimanesse priva, neppure per un istante, dell’onore doveroso di un lume. Poi si dedicò con impegno al resto, lavorando con intenso zelo a riparare la chiesa. Perché, benché il comando del Signore si riferisse al restauro della Chiesa acquistata da Cristo col proprio sangue, egli naturalmente non capì subito la cosa, ma concretamente si impegnò come manovale a restaurare quella piccola chiesetta in cui il Signore gli aveva parlato. Da quel giorno in poi si fissò nella sua anima santa la compassione del crocifisso e, come si può più devotamente ritenere, le venerabili stigmate della passione gli si impressero profondamente nel cuore. Da allora, non riuscì più a trattenere le lacrime ogni volta che il suo pensiero andava a contemplare la passione di Cristo. (FF 593; 1413)

Dopo aver ascoltato le parole del crocifisso, Francesco, salì a cavallo e si recò verso la città di Foligno portando un carico di stoffe di diversi colori.
Qui vendette cavallo e merce e tornò subito a San Damiano, dove trasferì la sua dimora. Suo padre, preoccupato, andava cercando dove mai fosse finito il figlio.
Venne a sapere che, completamente trasformato, abitava presso quella chiesa. L’uomo chiamò amici e vicini e in tutta furia si precipitò
a San Damiano. Francesco, per schivare la violenta ira paterna, andò a rifugiarsi in una caverna segreta, e vi restò nascosto un mese intero. Un giorno, ritrovato il coraggio, armato di fiducia in Cristo, decise di tornare in paese. Subito al vederlo, quelli che lo conoscevano com’era prima, presero ad insultarlo, gridando che era un pazzo e un insensato, gettandogli fango e sassi. Si diffuse per le piazze e le vie della città la notizia di quanto succedeva, finché venne agli orecchi del padre. Pietro andò di corsa al palazzo del comune a protestare contro il figlio davanti ai consoli, chiedendo il loro intervento per obbligare Francesco a restituire il denaro preso in casa. Di fronte al vescovo e ai consoli e a tutta la città accorsa per vedere questo avvenimento, Francesco esclamò: «Non soltanto restituirò a mio padre il denaro ricavato vendendo la sua roba, ma gli restituirò di tutto cuore anche i vestiti.»
Entrò in una camera, si spogliò completamente, depose sui vestiti il gruzzolo, e uscendo nudo alla presenza di tutti, disse: «Ascoltate tutti e cercate di capirmi. Finora ho chiamato Pietro di Bernardone padre mio. Ma dal momento che ho deciso di servire Dio, gli rendo il denaro che tanto lo tormenta e tutti gli indumenti avuti da lui. D’ora in poi voglio dire: Padre nostro, che sei nei cieli...»
Addolorato e infuriato, Pietro si alzò, prese denari e vestiti, e se li portò a casa. Il vescovo, considerando attentamente l’uomo santo e ammirando il suo coraggio, aprì le braccia e lo coprì con il mantello.
(FF 1415ss)
Restaurata San Damiano, Francesco si trasferì nella località chiamata Porziuncola, dove c’era un’antica chiesa in onore della Beata Vergine Madre di Dio, ormai abbandonata. Vedendola in quel misero stato, mosso a compassione, anche perché aveva grande devozione per la Madre di ogni bontà, il Santo vi stabilì la sua dimora e terminò di ripararla nel terzo anno della sua conversione.
Vedendo Francesco che il Signore aveva iniziato a dargli dei compagni che dietro il suo esempio

volevano seguire il Signore – erano ormai in dodici perfettamente concordi nello stesso ideale – si rivolse a loro dicendo: «Fratelli, vedo che il Signore misericordioso vuole aumentare la nostra comunità. Andiamo dunque dalla nostra madre, la santa Chiesa romana, e comunichiamo al papa ciò che il Signore ha cominciato a fare per mezzo di noi, al fine di continuare la nostra missione secondo il suo volere e le sue disposizioni.» Camminavano tutti giulivi, parlando delle cose di Dio e abbandonandosi a Lui nella preghiera.
Si affrettavano per presentarsi al più presto al cospetto del Sommo Pontefice, papa Innocenzo III.
Ma li prevenne, nella sua clemenza, Cristo potenza e sapienza di Dio, che, per mezzo di una visione, ammonì il suo vicario a prestare ascolto e ad acconsentire con benevolenza alle suppliche di quel poverello. Difatti il Pontefice romano vide in sogno la Basilica Lateranense che stava ormai per crollare e un uomo povero, piccolo e spregevole, che la sorreggeva, mettendovi sotto le proprie spalle, perché non cadesse.
Il saggio Pontefice, contemplando in quel servo di Dio la povertà e lo zelo per la salvezza della anime, esclamò: «Veramente questi è colui che con l’opera e la dottrina sorreggerà la Chiesa di Cristo.» Perciò, acconsentendo in tutto alle sue richieste, approvò la Regola.
(FF 354ss; 1455ss; 1064)
Nel tredicesimo anno della sua conversione, partì per la Siria, e mentre infuriavano aspre battaglie tra cristiani e musulmani, preso con sé un compagno, non esitò a presentarsi al cospetto del Sultano.
Prima di giungere dinanzi a lui, furono catturati dai suoi soldati che li trattarono malamente, ma essi non temettero nulla: né minacce, né torture, né morte. Alla fine furono portati alla presenza del Sultano, che li accolse con grande onore.
Chi potrebbe descrivere la sicurezza e il
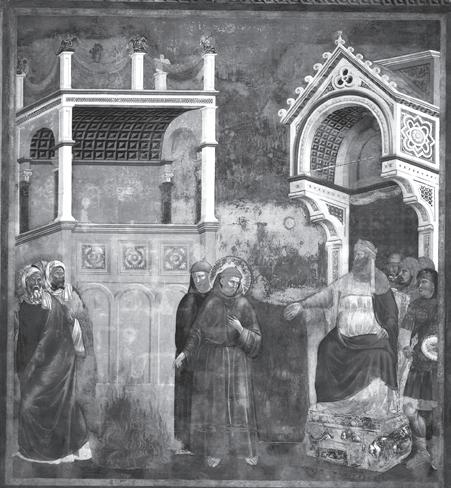
coraggio con cui gli stava davanti e gli parlava, e la decisione e l’eloquenza con cui rispondeva a quelli che ingiuriavano la legge cristiana?
Il Sultano offrendogli molti doni, tentava di convertirlo alle ricchezze del mondo; ma vedendolo disprezzare tutto risolutamente come spazzatura, ne rimase profondamente stupito, e lo guardò come un uomo diverso da tutti gli altri. Era molto commosso dalle sue parole e lo ascoltò volentieri. (FF 422)
FERITO D’AMORE
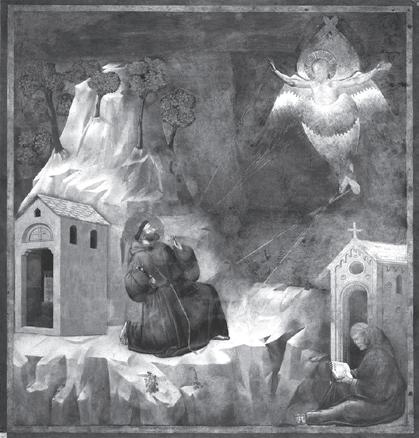
Mentre dimorava nel romitorio di La Verna, due anni prima della sua morte, Francesco ebbe da Dio una visione. Gli apparve un uomo, in forma di Serafino, con le ali, librato sopra di lui, con le mani distese ed i piedi uniti, confitto ad una croce.
Due ali si prolungavano sopra il capo, due si dispiegavano per volare e due coprivano tutto il corpo. A quell’apparizione il beato servo dell’Altissimo si sentì invaso da viva gioia e sovrabbondante allegrezza per lo sguardo bellissimo e dolce col quale il Serafino lo guardava, ma era contemporaneamente atterrito nel vederlo confitto in croce nell’acerbo dolore della passione.
Mentre era in questo stato di smarrimento, ecco: nelle sue mani e nei piedi cominciarono a comparire gli stessi segni dei chiodi che aveva appena visto in quel misterioso uomo crocifisso. Le sue mani e i piedi apparvero trafitti nel centro da chiodi, le cui teste erano visibili nel palmo delle mani e sul dorso dei piedi, mentre le punte sporgevano dalla parte opposta.
Anche il lato destro era trafitto come da un colpo di lancia.
(FF 484ss)
SORELLA MORTE
Erano ormai trascorsi vent’anni dalla sua conversione e, come gli era stato comunicato per divina rivelazione, la sua ultima ora stava per scadere.

Sentendo che la morte era ormai imminente, chiamò a sé due suoi frati, perché a piena voce cantassero le Lodi al Signore con animo gioioso per l’approssimarsi della morte, anzi della vera vita.
Egli poi, come poté, intonò il salmo: «Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore.» Uno dei frati che lo assistevano, molto caro al Santo, vedendo questo e conoscendo che la fine era vicina, gli disse: «Padre amato, già i tuoi figli stanno per rimanere orfani e privi della luce dei loro occhi! Ricordati dei figli che lasci orfani, perdona tutte le loro colpe e dona ai presenti e agli assenti il conforto della tua benedizione.»
E Francesco: «Ecco, Dio mi chiama, figlio. Ai miei frati presenti e assenti, perdono tutte le offese e i peccati e tutti li assolvo, per quanto posso, e tu, annunciando questo, benedicili da parte mia.»
Poi si fece portare il libro dei Vangeli, pregando che gli fosse letto il brano del Vangelo secondo Giovanni, che inizia con le parole: «Sei giorni prima della Pasqua, sapendo Gesù ch’era giunta l’ora di passare da questo mondo al Padre.»
Questo stesso passo si era proposto di leggergli il ministro, e lo stesso si presentò alla prima apertura del libro.
E dato che presto sarebbe diventato terra e cenere, volle che gli si mettesse indosso il cilicio e venisse cosparso di cenere.
E mentre molti frati, di cui era padre e guida, erano lì raccolti con riverenza e attendevano il beato transito, quell’anima santissima si sciolse dalla carne, per salire nell’eterna luce, e il corpo s’addormentò nel Signore. (FF 508ss)
Il Tau
Il Tau è l’ULTIMA LETTERA DELL’ALFABETO EBRAICO . Esso venne adoperato con valore simbolico sin dall’Antico Testamento; se ne parla già nel libro di Ezechiele: “Il Signore disse: Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme e segna un Tau
sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono...” (Ez 9,4)
ESSO È IL SEGNO CHE POSTO SULLA FRONTE DEI POVERI DI ISRAELE, LI SALVA DALLO STERMINIO. Ma soprattutto i cristiani adottarono il Tau, perché la sua forma ricordava ad essi la croce, sulla quale Cristo si immolò per la salvezza del mondo. San Francesco d’Assisi, per questi stessi motivi, faceva riferimento di tutto al Cristo, all’Ultimo: per la somiglianza che il Tau ha con la croce, ebbe carissimo questo segno, tanto che esso occupò un posto rilevante nella sua vita come pure nei gesti. In lui il vecchio segno profetico si attualizza, si ricolora, riacquista la sua forza salvatrice ed ESPRIME LA BEATITUDINE DELLA POVERTÀ , elemento sostanziale della forma di vita francescana.
I luoghi della santità di Francesco
SAN DAMIANO
È un UMILE ORATORIO già esistente nell’undicesimo secolo, di STILE ROMANICO, rustico, con interno a una navata.
L’edificio è una TESTIMONIANZA DELLA POVERTÀ E DELLA SEMPLICITÀ CHE TANTO AMAVA FRANCESCO.
Secondo la tradizione fu qui che egli nel 1206 udì la voce del crocifisso (ora conservato nella Basilica di Santa Chiara) che lo esortava a riparare la sua chiesa.
Questo episodio segnò l’inizio della sua vita ascetica.
Francesco si mise a ricostruire le parti distrutte di questa chiesetta, che sorgeva tra cipressi e ulivi, a poca distanza da Assisi.
Ancora oggi nei muri sono conservate pietre che vi collocò il santo con le sue mani. A san Damiano poi Francesco accolse nel 1212 Chiara e le sue prime compagne che vi si stabilirono dando vita al secondo ordine francescano, le Clarisse.
Al piano superiore si trova ancora il dormitorio dove
Chiara morì; anche il refettorio è dell’epoca di Chiara e oggi una croce indica il posto che la santa occupava abitualmente.

RIVOTORTO
Oggi il TUGURIO DI RIVOTORTO, di somma humilitate, com’era chiamato ai tempi di Francesco, si trova all’interno di una grande basilica dedicata a S.
Maria degli Angeli, NON LONTANO DA ASSISI.
Al tempo di Francesco, questa catapecchia si trovava in aperta campagna; la notte vi sostavano buoi e asini e nel 1209, al suo ritorno da Roma, Francesco vi si sistemò insieme ai suoi primi compagni, dormendo sulla paglia. Non lontano dal tugurio sorgeva un lebbrosario dove Francesco si recava abitualmente per portare cure e conforto agli ammalati.
IL LUOGO ERA ESTREMAMENTE ANGUSTO E DI UNA POVERTÀ ASSOLUTA. Sulle pareti il santo scrisse i nomi dei confratelli così che ognuno potesse individuare subito, anche di notte, il metro quadrato che era stato assegnato a ciascuno. Questa prima comunità si sosteneva con la prestazione di lavoro agricolo per i vicini coloni o, in mancanza di lavoro, con la questua. Fu qui che Francesco scrisse la Regola dei frati minori forse durò due anni il soggiorno dei primi frati a Rivotorto, finché nel 1212 si trasferirono alla cappella della Porziuncola. Rivotorto rappresenta quindi il momento iniziale, forse il più difficile ed eroico della vita francescana.
LA CAPPELLA DELLA PORZIUNCOLA
È un SEMPLICE ORATORIO RETTANGOLARE CON UNA CUSPIDE, in pietra del Subasio e una sola finestrella. Fu tra i luoghi più cari a San Francesco. Il nome Porziuncola si riferisce alle sue DIMENSIONI così MINUSCOLE; e probabilmente anche per questo Francesco amava ritirarvisi periodicamente fino a quando, nel 1211, lasciato Rivotorto, lo scelse come sede prediletta. Qui venne accolta Chiara, la notte del 19 marzo 1212, dopo essere fuggita dalla casa paterna per iniziare la sua vita ascetica. Qui Francesco le tagliò i lunghi capelli a suggello della sua consacrazione. Come nel caso di Rivotorto, oggi questa chiesetta si trova all’interno di una grande basilica costruita per proteggerla dalle intemperie.
L’EREMO DELLE CARCERI
Si tratta di un LUOGO NON DISTANTE DA ASSISI, sulle pendici del monte Subasio e, lo spirito francescano conserva qui tutta la sua originaria semplicità. Era il carcere, ritiro di Francesco e dei suoi compagni. LUOGO SOLITARIO E ANNIDATO nel cuore di una selva, aveva attirato Francesco sin dagli anni della sua ricerca
giovanile e il santo amava rifugiarsi in una grotta dove fece esperienza di vita eremitica. Rimase anche in seguito, quando la comunità si ingrandì accogliendo nuovi membri, un luogo preferito da Francesco, ideale per periodici ritiri dedicati esclusivamente alla contemplazione.
Ancora oggi si conserva qui il giaciglio di sasso usato normalmente dal santo.
BASILICA DI SAN FRANCESCO
È un edificio che costituisce un’elaborazione tutta italiana del gotico francese. Qui si trova il corpo di san Francesco che morì nel 1226 e dopo solo due anni fu santificato.
A riconoscimento della sua santità da parte della Chiesa di Roma corrisponde la decisione di costruire la basilica deliberata dall’ordine mendicante da lui fondato. Iniziata nel 1228 per volontà di Gregorio IX, la basilica venne consacrata nel 1253 e conclusa nel 1280, ma già dal 1230 il corpo di Francesco vi era stato traslato.
La basilica, che sorge in posizione elevata, alle falde del monte Subasio, appare oggi come un edificio composto da due chiese sovrapposte: quella inferiore e quella superiore.
La chiesa inferiore, a cui si accede attraverso un portale gotico del 200, è bassa, austera e scarsamente illuminata, tanto da sembrare una grande cripta. Nel 1818, in seguito agli scavi sotto l’altare, furono riportate alla luce e, dopo un attento esame ufficialmente riconosciute, le spoglie del santo.
La chiesa superiore, pur ripetendo lo schema di quella sottostante, si mostra come il regno della luce che proviene da ampie finestre. Destinata prevalentemente alla predicazione, è una grande aula affrescata con il ciclo la vita del santo di Giotto e con le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento della scuola del Cimabue.
La facciata, ancora legata al romanico umbro, è divisa in tre parti. Quella superiore è costituita dal timpano, quella mediana ha come unico elemento decorativo un rosone, mentre l’inferiore accoglie un ampio portale strombato e bipartito.
L’edificio, colpito dal sisma del 26 settembre 1997, è stato danneggiato e recentemente restaurato. In particolare furono distrutte la Volta dei Dottori con la Vela di san Girolamo e la Volta degli Evangelisti con la Vela di San Matteo.
Immaginiamo ora di ambientarci in alcuni momenti nella giornata del monaco in particolar modo in quelli dedicati ai pasti e all’assistenza dei malati attraverso giochi e laboratori.
I monaci si radunavano due volte al giorno nel refettorio per consumare i loro pasti. Ogni pasto comprendeva due pietanze cotte. La base dell’alimentazione era costituita da verdure, formaggi, focacce. La carne era riservata ai malati o a chi era molto debole. A tavola si usavano cucchiai, piatti, bicchieri che erano considerati proprietà comune di tutti i monaci e dovevano quindi essere utilizzati e conservati con estrema cura. Per san Benedetto il momento del pasto non era solo il momento in cui si soddisfaceva il BISOGNO DI CIBO, ma anche il MOMENTO IN CUI SI STAVA INSIEME A TAVOLA e quindi di conseguenza si doveva mantenere un ordine e un comportamento dignitoso.
La Regola stabiliva che si mangiasse in silenzio e che durante i pasti si ascoltasse la lettura di brani delle Sacre Scritture.
Il cibo veniva distribuito in quantità prestabilite, né troppo scarse, né troppo abbondanti.
Giochiamo insieme: I pasti del monaco
Giocatori: quanti si vuole, divisi in squadre condotte da un capitano. Luogo: all’aperto o in palestra.
Materiale: tanti cartoncini quadrati di 4-5 centimetri di lato quanti sono i giocatori moltiplicati per due. Quattro pennarelli di altrettanti colori. Due cucchiai e un piatto per ogni squadra.
1
2
Su ogni cartoncino viene disegnato un numero di cibi del pasto (esempio latte, formaggio, focaccia, marmellata...) facendo in modo che alla fine ci sia lo stesso numero di cibi su ogni cartoncino.
Fatto questo, i cartoncini vengono piegati in quattro, chiusi con un punto di pinzatrice e sparsi per l’area di gioco.
Le squadre si schierano una accanto all’altra, ognuna con i propri giocatori disposti in fila indiana, a un’estremità del campo.
Di fronte a ogni squadra, all’estremità opposta del campo, viene posato un piatto.
Al Via! il primo giocatore di ogni squadra parte, raccoglie un cartoncino servendosi unicamente dei cucchiai (senza aiutarsi con le mani), lo porta nel piatto della propria squadra, torna indietro, consegna i due cucchiai al compagno successivo, che parte a sua volta e così via.
Quando anche l’ultimo cartoncino è finito in uno dei piatti, il gioco termina.
Il capitano di ogni squadra apre i propri cartoncini e conta quanti cibi ha guadagnato (ogni cibo ha un punteggio diverso, il latte 6 punti, il formaggio 5, la focaccia 1, la marmellata 3…).
Il primo giocatore di ogni squadra riceve due cucchiai e il gioco può avere inizio. 1 3 3 5 2 4 4
Vince la squadra che è riuscita ad ottenere il maggior punteggio.
L'assistenza ai malati
Nella Regola di San Benedetto era scritto: LA CURA DEGLI INFERMI SIA AVANTI TUTTO E SOPRA TUTTO. Ogni monastero per assolvere a questo compito disponeva di una piccola farmacia di cui aveva cura un monaco medico e ciò non solo per la salute della comunità ma anche per i pellegrini e i bisognosi che chiedevano assistenza.
I medicamenti venivano preparati all’interno dei monasteri e prevaleva il ricorso alle piante medicinali, coltivate direttamente dai monaci ovvero nell’orto dei semplici.
Per i monaci che si ammalavano, l’abazia disponeva anche di una infer meria.
Ai malati erano riservati alcuni privilegi: l’infermeria era una delle poche parti riscaldate dal monastero, lì si era esonerati dalla preghiera e dal lavoro, si poteva mangiare carne più spesso e quindi a volte capitava anche che qualcuno si fingesse malato per farsi ricoverare.
Giochiamo insieme: L’assistenza ai malati
Giocatori: i partecipanti vengono suddivisi in squadre. Il numero delle squadre è ininfluente l’importante è che non siano eccessivamente numerose.
Luogo: spazio delimitato e sufficientemente ampio.
Materiale: foulard o strisce di stoffa per bendare gli occhi di metà dei partecipanti, lenzuola o teli resistenti (uno per squadra), strisce di stoffa alte 15/20 cm. o carta igienica in quantità sufficiente per bendare un terzo dei partecipanti. Al termine di ogni prova viene assegnato un punteggio a seconda della velocità con cui è stata eseguita (e tenendo conto delle eventuali penalità date se qualche regola viene trasgredita).
1
Guidare un non vedente.
2
Ogni squadra dovrà eseguire tre prove.
Il monaco infermiere deve guidare un non vedente fino all’abbazia. I partecipanti si dividono in coppie: uno viene bendato, l’altro funge da guida. Ogni coppia deve svolgere un percorso con semplici ostacoli da aggirare o scavalcare. Il non vedente deve procedere guidato dalle indicazioni verbali del compagno. Al Via! parte la prima coppia seguita, a distanza di qualche secondo, dalla successiva. Se nel gioco qualche regola viene trasgredita (ad esempio il non vedente viene guidato e aiutato attraverso il contatto fisico…) vengono assegnate alla squadra delle penalità. Il Via! ad ogni prova viene dato contemporaneamente a tutte le squadre.
Trasportare un ferito all’infermeria.
I partecipanti si dividono a gruppi di cinque. Un telo viene disposto a terra. Al centro si siede un concorrente. Al Via! gli altri quattro afferrano i lati del telo e trasportano il ferito fino alla zona indicata come infermeria. Quando il primo ferito è arrivato a destinazione, i monaci infermieri riportano di corsa il telo al secondo gruppo che effettuerà il proprio trasporto. Se si lascia cadere il ferito, vengono assegnate delle penalità.
3
Bendare il proprio ferito.
I partecipanti si dividono a gruppi di tre. Un componente ha il ruolo di ferito, gli altri due di soccorritori. Al Via! ogni terna deve arrotolare intorno al proprio ferito che rimane in piedi, un bendaggio di carta igienica o stoffa a strisce in modo da coprirlo interamente.
Se un corpo non è bendato completamente, vengono assegnate delle penalità.
Realizziamo un'icona
Prendendo spunto dalle icone ortodosse proviamo a realizzare un’icona con gli alunni.
REALIZZAZIONE
Con la carta vetro, lisciamo il nostro pezzo di legno.
Ricopriamo la tavoletta con l’impregnante; se occorre, ripetere l’operazione una volta asciutto. La tavoletta dovrebbe risultare molto scura.
Lasciare asciugare bene, levigare e stendere la missione facendo attenzione a non coprire completamente la tavoletta, ma lasciando libero il legno nei punti dove, presumibilmente, la tavola dovrebbe essere più consumata.
Attendere i tempi necessari e applicare la foglia oro sulla missione, togliendo l’eccedenza con un pennello piatto asciutto.
Incollare l’immagine e ricoprire di colla tutto il lavoro; livellare lo spessore della carta con diversi strati di vernice all’acqua.
Strofinare sulla tavola una patina invecchiante scura e passare la cera con lana d’acciaio per lucidare.
OCCORRENTE
• Tavoletta di legno
• Carta vetro
• Impregnante ad alcol color legno scuro
• Pennelli piatti
• Missione all’acqua
• Foglia oro
• Immagini sacre ispirate alle icone bizantine e russe
• Colla
• Patina invecchiante
• Cera
• Lana d’acciaio
Voi non ci crederete, adesso ve lo canto, intorno al 500 nasceva un santo, dai forza su vediamo cosa in vita ha fatto. Ed ora ve lo presento lui è san Benedetto! Deluso un po’ dal mondo e dalla fine dell’Impero volendo stare solo in una grotta andò davvero. Scordando le ricchezze che aveva abbandonato scoprì una nuova vita vivendo da eremita.
Finita l’esperienza la “Regola” lui scrisse e insieme ad altri amici in monastero visse obbedendo all’abate obbedisco a Gesù. Restando in silenzio dico anche di più. Cantando, pregando ma anche lavorando se poi non mi vanto divento quasi santo. Copiando libri interi senza il PC riempiva biblioteche del sapere di quel dì.
Dalle erbe ricavava medicamenti sanando i corpi ed anche le menti. Lavorava la terra gli animali allevava facendo ogni cosa pregava, pregava. Ora che conoscete come lui ha vissuto dai forza fate vostro ciò che ci ha donato; è stato un grande uomo santo giusto e retto abbiamo un nuovo amico lui è san Benedetto.


Era pieno Autunno, la vecchia strada costeggiata da lampioni che emanavano una fioca luce arancione conduceva ad una locanda.
Qui pernottavano due amici d'infanzia, si conoscevano da anni, erano in viaggio da molto tempo. Fuori il cielo era velato e nuvoloso, uno stormo di corvi, sicuramente di passaggio, gracchiava, in lontananza.
Al piano terra della Locanda, dietro al bancone un oste intratteneva ridente altri viandanti, intenti a mangiare e bere; in quell'atmosfera il ristoro era assicurato, molti viaggiatori si incontravano per poi mai più rivedersi. Il mattino seguente la melodia del suono delle campane svegliò i due amici all' alba.
Era ora di riprendere il cammino nella tenue luce del mattino.
La loro meta era l'Antica Cattedrale gotica, ornata di rosoni ed ampie vetrate colorate; lì avrebbero terminato il loro viaggio.
Andrea Galimberti
Fratello sole, sorella luna
Dolce è sentire
come nel mio cuore
Ora umilmente
Sta nascendo amore
Dolce è capire
Che non son più solo
Ma che son parte di una immensa vita
Che generosa
Risplende intorno a me
Dono di lui
Del suo immenso amore
Ci ha dato il cielo
E le chiare stelle
Fratello sole
E sorella luna
La madre terra
Con frutti, prati e fiori
Il fuoco, il vento
L’aria e l’acqua pura
Fonte di vita
Per le sue creature
Dono di lui
Del suo immenso amore
Dono di Lui
Del suo immenso amore.
Dal film Fratello sole, sorella luna di F. Zeffirelli
1. L’ozio è il nemico dell’anima.
2. Parla poco, ascolta molto.
3. Tutti dobbiamo cucinare e tenere puliti gli utensili.
4. Ci bastano una semplice tunica, un paio di sandali.
5. Il nostro motto è: “Ora et labora”.
6. Al suono della campana dobbiamo alzarci nel mezzo della notte.
Osserva le immagini, leggi le frasi e scrivi nel fumetto giusto il numero corrispondente ad ogni immagine. Colora.
1 Che cos’è il monachesimo?
2 Come è fatto il monastero?
3 Chi è a capo del monastero?
4 Qual è la Regola di San Benedetto?
5 Spiega brevemente la giornata di un monaco benedettino.
6 Cosa sono le miniature e chi le faceva?
7 Dove i manoscritti venivano ricopiati? Da chi?
Collega ciascun monaco alla parte del monastero che ritieni più consona al suo ruolo.
Diventa un monaco amanuense e colora con cura i capolettera proposti, disegnando dentro ciascuno una miniatura a tema religioso a tua scelta. (vedi esempi sotto).



Il termine icona viene dal greco eikon e significa immagine. Questa espressione viene utilizzata in contesti diversi, anche attualmente, pensa ad esempio alle icone sul desktop di un computer, ma il significato più antico fa riferimento a una pittura a carattere religioso realizzata su pannello di legno. Esistono vari stili pittorici riconoscibili in un’icona, ad esempio quello greco, russo o bizantino. Ma un’icona, per i cristiani, non è un semplice dipinto: soprattutto per il mondo degli ortodossi essa ha un valore di fede che quasi evoca la presenza di quanto l’immagine propone. Le figure più presenti nelle icone sono quelle di Cristo, la Vergine Maria e i Santi. Tali figure ci possono a volte sembrare un po’ strane, ma ciò è dovuto sempre a dei profondi significati: un collo particolarmente gonfio, ad esempio, è segno della presenza del soffio dello Spirito Santo; i giochi di luci ed ombre sul viso dipinti al contrario, per fare un altro esempio, sono segno che la luce non colpisce da fuori il soggetto, ma esce dal personaggio stesso. In ogni icona, in definitiva, si intende trasmettere una parte del mistero di Dio. È per questo motivo che si usa dire che un’icona si legge.
Osserva quanto raffigurato nell’icona e prova a riprodurlo nella cornice accanto.

Ognuna delle Chiese sorelle ha approfondito nei secoli un aspetto particolare della vita cristiana che è comune a tutte, ma che la contraddistingue in maniera singolare. Questo può diventare un ulteriore dono per le altre Chiese.
Qual è, secondo te, l’importanza di ciascuno di questi elementi?
CHIESA
CATTOLICA
PROTESTANTE
ASPETTO SOTTOLINEATO
La Comunità e i Sacramenti
La Parola di Dio
ORTODOSSA
La Santa Liturgia e le Icone

In c ontri parti col ari:
Residenz a:
Stat o c i vi l e:
Pro fessi o ne:
Cara tt eri sti che:
Lu o gh i fran c es c ani :
Se gn i partic ol ar i:
M ort o ne l:
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento;
• coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.
u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
La vita della Chiesa Il Concilio Vaticano II:
• l’ecumenismo;
• il calendario liturgico;
• la santa Messa;
• i sacramenti.
Testimoni della Chiesa:
• i santi di oggi.
Da pag. 65 a pag. 83
La Bibbia e le altre fonti
• Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei santi.
Il linguaggio religioso
• Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo.
In questa unità l’insegnante presenterà la CHIESA come una REALTÀ VARIEGATA che esprime la propria fede e il proprio servizio al mondo mediante vocazioni e ministeri differenti.
A partire dai documenti del Concilio Vaticano II, il percorso guiderà gli alunni alla CONOSCENZA DEI VARI MINISTERI E DELLE FIGURE PRESENTI ALL’INTERNO DELLA CHIESA : papa, vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, laiche e laici. A seguire
viene mostrato come all’interno della Chiesa esistano vocazioni e carismi diversi, presentati attraverso il racconto di esperienze di testimoni, persone o associazioni. L’insegnante spiegherà come OGNI CRISTIANO SEGUE UNA VOCAZIONE, cioè un compito, quasi una missione pensata da Dio per lui, a servizio della comunità e per il mondo, a seconda dei propri talenti e delle proprie capacità, prendendo spunto dalle figure di alcuni GRANDI SANTI DI OGGI (Giovanni Paolo II, Gianna Beretta Molla, Carlo Acutis e Madre Teresa di Calcutta) e ponendoli come esempio da seguire per ciascun credente.
Il Concilio Vaticano II fu annunciato da papa Giovanni XXIII il 25 gennaio del 1959 e iniziò l’11 ottobre 1962. Terminò l’8 dicembre 1965, presieduto da papa Paolo VI, dopo 4 sessioni e 168 assemblee generali dei 2400 vescovi partecipanti.
I documenti prodotti sono 16, così suddivisi:
• 4 costituzioni (documenti che affrontano i principi di maggiore importanza ed efficacia generale riguardanti la dottrina cattolica)
• 9 decreti (documenti che contengono le norme necessarie per applicare i principi generali espressi dalle costituzioni del concilio)
• 3 dichiarazioni (documenti con cui viene affrontato, a scopo di chiarimento o spiegazione, un aspetto di un problema o di una dottrina)
Ogni documento viene identificato con un titolo, desunto dalle prime parole del testo originale latino. Riportiamo brevemente il contenuto di ciascun documento:
Sacrosanctum Concilium, costituzione su La Sacra Liturgia
È il primo documento approvato che ha introdotto delle novità nella riforma liturgica come:
• Riforma del rito della messa;
• Maggiore partecipazione dei fedeli alla liturgia;
• Utilizzo della lingua volgare nelle celebrazioni;
• Adattamento della liturgia all’indole e alle tradizioni dei vari popoli.
Lumen Gentium, costituzione dogmatica su La Chiesa È il primo documento dogmatico relativo:
• Al mistero della Chiesa
• Alla Chiesa come popolo di Dio
• Alla gerarchia, ai laici, ai religiosi
• A Maria nel mistero della Chiesa
Dei Verbum, costituzione dogmatica su La Divina Rivelazione La seconda costituzione dogmatica si riferisce:
• Alla natura, origine e fine della Rivelazione cristiana e la sua trasmissione
• All’interpretazione della Sacra Scrittura
• All’importanza della Sacra Scrittura nella vita della Chiesa
Gaudium et Spes, costituzione pastorale su La Chiesa nel mondo contemporaneo È una costituzione pastorale, ossia relativa all’attualizzazione del Vangelo nella vita pratica e all’impegno etico della Chiesa nel mondo contemporaneo. Il documento:
• Procede da un’analisi della situazione attuale dell’uomo e delle sue problematiche
• Riflette sull’attività umana nell’universo, il rapporto fede-cultura, la vita economica-sociale
• Promuove la missione della chiesa nel mondo contemporaneo
Optatam totius, decreto su La formazione sacerdotale Il decreto afferma l’importanza della formazione sacerdotale e ne delinea alcuni principi fondamentali.
Presbyterorum ordinis , decreto su Il ministero e la vita sacerdotale Tratta del ministero dei presbiteri nella vita della Chiesa per i quali si ribadisce il celibato.
Christus Dominus, decreto su L’ufficio pastorale dei vescovi Analizza il compito di guida che hanno i vescovi come successori degli apostoli.
Perfectae caritatis, decreto su Il rinnovamento della vita religiosa Si occupa della vita e della disciplina degli istituti religiosi.
Apostolicam actuositatem, decreto su L’apostolato dei laici Il documento definisce la natura, l’indole e la varietà dell’apostolato dei laici; la vocazione e i fini, nonché la formazione dei laici all’apostolato.
Ad gentes, decreto su L’attività missionaria della Chiesa Illustra i principi dottrinali dell’evangelizzazione contemporanea e l’organizzazione dell’attività missionaria.
Unitatis redintegratio, decreto su L’ecumenismo Da voce all’intenzione ecumenica di tutto il concilio, che è quella di denunciare la contraddizione della divisione tra i cristiani e mostrare il desiderio d’unione. Illustra i principi cattolici dell’ecumenismo ed evidenzia i punti in comune con i non cattolici.
Orientalium ecclesiarum, decreto su Le Chiese orientali cattoliche Il decreto esprime la stima per le Chiese orientali e il desiderio di conservare il loro patrimonio spirituale.
Inter mirifica, decreto su Gli strumenti di comunicazione sociale È un documento che manifesta la consapevolezza della Chiesa sull’uso improprio a cui le trasformazioni tecnologiche, e in particolare i mezzi di comunicazione sociale, possono indurre coloro che li gestiscono.
Gravissimum educationis , dichiarazione su L’educazione cristiana Riflette sull’importanza e il diritto all’educazione cristiana dei fanciulli e dei giovani e sui fini formativi della scuola cattolica.
Dignitatis humanae, dichiarazione su La libertà religiosa È una dichiarazione sulla dignità della persona e il diritto alla libertà religiosa.
Nostra Aetate, dichiarazione su La relazione della Chiesa con le religioni non cristiane Esprime il pensiero della Chiesa cattolica sulle religioni non cristiane, in particolare l’ebraismo, l’islam, il buddismo, l’induismo. L’intento è quello di evidenziare gli aspetti positivi delle religioni e di condannare ogni forma di discriminazione.
Da S. Pasquali – A. Panizzoli, Terzo millennio cristiano, La
Scuola
il Piccolo Principe verso i sacramenti
Si suggerisce di utilizzare il racconto IL PICCOLO PRINCIPE per introdurre l’argomento dei sacramenti, segni della presenza e dell’azione di Cristo in mezzo agli uomini, partendo da segni e gesti semplici e comuni dell’esperienza umana.
In questo modo i sacramenti appariranno non come qualcosa di magico, ma come testimonianza della presenza di Dio, che assume i modi umani di comunicare e di porsi in relazione con gli uomini.
Il piccolo principe era sempre vissuto sul suo pianeta: un pianeta così piccolo che non c’era posto per un’altra persona, così che egli non aveva nessuno con cui comunicare. Ora è disceso sulla Terra e cerca di imparare il linguaggio dei terrestri per comunicare con loro. Comprende subito che i suoni che essi emettono con la bocca hanno ciascuno un significato differente. Essi esprimono quello che i terrestri pensano dentro la loro testa. Non sono semplici suoni: sono parole, vogliono dire qualcosa. Quando, per esempio, uno dice: «Ho fame», subito gli viene dato qualcosa da mangiare… Se dice «Ho sonno», tutti comprendono che è stanco e che desidera andare a riposare. In questo modo, a poco a poco, egli comprende il miracolo della parola.
Presto si accorge che essi non comunicano solo con i suoni, ma anche con i gesti della mano e del volto. Quando uno sorride vuol dire che è contento; quando piange vuol dire che è triste o sta male... Si rende conto, anzi, che i sentimenti e i messaggi più profondi e più importanti sono spesso manifestati con un gesto e con una parola. Un abbraccio, un bacio, una carezza indicano: amore, affetto, tenerezza...
Una stretta di mano significa: amicizia o desiderio di fare la pace… Uno schiaffo, una minaccia con la mano vogliono dire odio, cattiveria, inimicizia…
Un giorno, mentre passeggia per le vie di una grande città, vede uno strano albero di ferro con le luci appese: luci verdi, luci rosse, luci gialle… Si ferma a guardare incuriosito, e presto nota una cosa: quando quello strano albero emette una luce verde, la gente passa dall’altra parte della strada; quando invece la luce diventa rossa, la gente si ferma ed anche le auto rallentano e si bloccano.
Il piccolo principe si domanda: «Perché col rosso la gente si ferma, e col verde passa?» Dopo un po’ di riflessione egli comprende: i terrestri per comunicare tra loro non adoperano soltanto le parole o i gesti, essi adoperano anche i colori ed altri segnali. Una cosa, però, non riesce a comprendere: che legame c’è tra il colore rosso e il fatto che la gente si ferma, e tra il colore verde e il fatto che la gente si muove?
La risposta è semplice.
Gli abitanti del pianeta terra per comunicare delle cose utilizzano segni diversi: parole, gesti, disegni, colori, segnali geometrici e luminosi.
Essi si sono accordati, per esempio, che quando il semaforo segna rosso, vuol dire stop e bisogna fermarsi; quando indica verde si può passare senza pericolo. Il nostro piccolo principe ha compreso una cosa importante: i segni (parole, gesti, segnali...) sono stati fissati dagli uomini per dire delle cose fra di loro, per comunicare.
Ogni gruppo umano si mette d’accordo per fissare (più o meno arbitrariamente) un certo numero di segni ai quali hanno attribuito un particolare significato. Ogni segno ha un suo significato ed un suo messaggio da comunicare.
Andando avanti nella sua esplorazione, il nostro piccolo principe si rende conto che le diverse popolazioni e gruppi di persone per dire la stessa realtà utilizzano gesti o segni differenti.
Per esempio per indicare l’edificio dove gli uomini abitano, in italiano si dice casa, in francese si dice maison, in inglese si dice house.
In Italia e nei paesi d’Europa il nero è il colore del lutto e della morte, in Cina il colore del lutto è il bianco.
Così, per augurare il buongiorno o per salutare delle persone il nostro piccolo principe si accorge che in Europa ci si stringe la mano, mentre nel paese degli esquimesi, per esprimere la stessa cosa, la gente si strofina il naso a vicenda.
Il piccolo principe comprende sempre meglio il linguaggio del pianeta terra: ma ci sono ancora molte cose che gli sfuggono. Egli ha notato, per esempio, che oltre alle parole, ai gesti, ai segni, ci sono anche certi oggetti (ad esempio un pezzo di pane, una croce, un fiore, un drappo colorato, una bandiera...) che sembrano esprimere qualcosa che li unisce profondamente. Una mattina assiste molto meravigliato e incuriosito alla cerimonia dell’alzabandiera in un campeggio di lupetti: rimane molto meravigliata dal silenzio, dal rispetto e dal canto (inno nazionale) che accompagna il gesto dell’alzabandiera.
Un lupetto gli dice che la bandiera è il simbolo della Patria.
A questo punto il piccolo principe non ce la fa a capire tutto quello che vede. Incontra un uomo che gli spiega. «Il simbolo – dice costui – è qualcosa come una relazione, un legame tra due persone, qualcosa che si riferisce ad una esperienza nel corso della quale due persone si sono incontrate.» Allora questo oggetto assume un significato nuovo che è compreso da quelli che hanno vissuto quella esperienza. Per esempio: un giovane offre alla sua fidanzata una viola. Essa la fa seccare e la conserva dentro le pagine di un libro.
Questo fiore per quella ragazza non è più soltanto un fiore. Esso rappresenta il suo fidanzato, l’amore che lega le due persone. Esso rende presente la persona amata, rende presente il momento e l’esperienza nella quale questo fiore è stato offerto.
Gli uomini utilizzano spesso di questi simboli quando stringono un’amicizia fra loro, quando fanno un’alleanza. I segni servono anche per comunicare con Dio. L’avventura del piccolo principe non è ancora finita. Tante scoperte gli rimangono ancora da fare.
Un giorno vede molta gente (uomini, donne, bambini) entrare in un grande edificio diverso dalle case comuni. Entra anche lui con un giovane amico che gli dice: “E’ domenica; la gente va in chiesa per la Messa”. Sono tante le cose che lo colpiscono: un uomo in croce appeso al soffitto, un grande tavolo di marmo
con sopra pane e vino, un libro grande e bello sopra un leggio, un uomo vestito diversamente dagli altri che legge e parla, la gente che siede, si alza, canta, si stringe la mano… Una cosa però l’ha colpito più di tutto: ad un certo punto la gente si mette in fila e va verso quel signore vestito diversamente e tutti ricevono da lui un pezzetto di pane. Sembra un pezzo di pane comune, ma il piccolo principe subito si rende conto che è un pane speciale: è contenuto in un piatto d’oro; la gente lo riceve in mano o in bocca con un atteggiamento di grande rispetto; appena ricevuto ciascuno va al proprio posto e si ferma in silenzio e in grande concentrazione.
Il piccolo principe domanda allora al suo amico di che cosa si tratta… Il suo amico gli fa cenno di aver pazienza e per un po’ di tempo sta anche lui in silenzio, in grande concentrazione, addirittura con gli occhi chiusi e con la testa fra le mani. Quando escono gli spiega: «Quello che hai visto non era un semplice pezzo di pane; per i cristiani è il corpo stesso del Signore Gesù! Quel pane è il segno della presenza di Gesù in mezzo a loro. Quel pane ricorda loro un gesto che Gesù fece prima di morire, quando prese un pezzo di pane, lo diede loro e disse: Questo è il mio corpo, offerto per voi!»
Il pane è cibo che nutre e fa crescere: il pane che i cristiani mangiano durante la Messa nutre la loro anima e fa crescere la comunità dei cristiani. Il piccolo principe comprende che i gesti e i segni non servono solo per comunicare tra gli uomini, ma anche con Dio.
Anzi si accorge che i segni sono il linguaggio privilegiato di Dio con gli uomini. Per parlare agli uomini Dio si serve spesso di segni e di oggetti.
Il suo amico è un ragazzo che ha studiato molto bene il catechismo e che frequenta l’ora di Religione nella scuola e quindi è davvero una buona guida per far conoscere al piccolo principe i segni della comunità cristiana. Lo conduce di nuovo dentro la chiesa, che ora è vuota perché la Messa è finita. Entrando fa il segno di croce, poi fa una genuflessione rivolto verso una piccola casetta dorata che si chiama tabernacolo, accanto alla quale sta una lampada accesa.
Gli mostra l’altare, il crocifisso, l’ambone con sopra il libro della Bibbia…
Nella comunità cristiana, dice la guida al piccolo principe, ci sono dei segni speciali. Essi non soltanto dicono una cosa, o ricordano un avvenimento passato, ma hanno il potere di renderla veramente presente qui, adesso. Per esempio i cristiani credono fermamente che quando il sacerdote nella Messa ripete le parole e i gesti di Gesù nell’ultima Cena, egli non ha soltanto il ricordo di una cosa accaduta tanti secoli fa, ma attraverso le sue parole, Gesù si fa veramente presente come duemila anni fa nel segno del pane e del vino. Per questo i cristiani dicono che, dopo le parole del sacerdote, il pane e il vino sono diventati corpo e sangue del Signore Gesù. E quando essi mangiano il pane consacrato e bevono il vino, sono sicuri che Gesù è presente in loro. Per questo si inginocchiano davanti al tabernacolo che contiene il pane consacrato. Questi segni speciali i cristiani li chiamano sacramenti. Il sacramento del pane e del vino consacrato si chiama Eucaristia.
M. Filippi-B. Bartolini, Il mio libro di religione
• Una volta disceso sulla Terra cosa cerca di imparare il piccolo Principe?
• Di che cosa si accorge?
• Il piccolo Principe riesce sempre a capire tutto ciò che vede?
• Quale edificio scopre?
• Quali sono i segni speciali della comunità cristiana?

CON JOHN BAPTIST ONAMA
MILIONI DI BAMBINI NEL MONDO VIVONO IN CONDIZIONE DI SFRUTTAMENTO, spesso vengono usati dagli adulti come oggetti da sfruttare a proprio piacimento.
A questi bambini i diritti sono ignorati, l’adolescenza negata. Grave piaga è la realtà dei bambini soldato che vengono sfruttati nelle ostilità o in ruoli di supporto (vedette, messaggeri, spie...). Riportiamo la testimonianza di JOHN BAPTIST ONAMA, oggi docente presso l’Università di Padova che ha vissuto la dolorosa esperienza di bambino soldato. Spinto dall’esigenza di dare voce a chi ancora oggi sta subendo violenze è riuscito a trovare la forza di raccontare.
Intervista a John Baptist Onama, bambino-soldato

Quando sono stato arruolato nell’esercito avevo appena compiuto quattordici anni: era il 1980 e mi sono trovato in un contesto di guerra: per salvarmi la vita ho dovuto accettare l’arruolamento e combattere. In una situazione del genere, un bambino di quattordici anni subisce la volontà di chi comanda, non ci sono spazi per ragionare, pensare o trovare una via d’uscita. Si segue quello che succede, in una situazione in cui si massacra e il bambino diviene un assassino.
[…] La motivazione che c’è dietro è la povertà e la fame, la mancanza di una famiglia e di figure di riferimento. I bambini hanno bisogno di un’educazione. Quindi ci sono bambini che si arruolano volontariamente, poi ci sono bambini che vengono rapiti e costretti a combattere. Questo è diverso. Il primo bambino va volontariamente, magari senza consapevolezza e senza immaginare quello a cui va incontro, ma una volta là accetta la situazione.
Quello è il prezzo che deve pagare per sopravvivere, avere qualcosa da mangiare, essere rispettato e considerato, ma ci sono anche bambini che vengono presi, trasformati attraverso una serie di atrocità – bastonate, minacce, costretti a uccidere un parente o i genitori e in tal caso un bambino non torna più indietro.
[…] Il mio reclutamento è avvenuto così, ci hanno catturato e ci hanno detto: «Dobbiamo fucilarvi!» Non ci hanno picchiati. Hanno usato la pressione psico-
logica. Eravamo io e mio fratello di un paio d’anni più di me. Io i miei genitori li ho lasciati nel Sudan. Non avevamo degli adulti che potessero tutelarci.
[…] La giornata tipo: si partiva alla mattina presto, quindi vuol dire sveglia molto, molto presto anche perché i ribelli molto spesso attaccavano alla mattina. Il loro attacchi coincidevano con il suono delle campane. Allora si partiva prima, si seguiva quello che riuscivamo a captare, si pattugliava il perimetro, si girava nell’aerea boscosa o in quella di montagna e si andava avanti fino all’ora di pranzo, poi c’era una piccola pausa pranzo, un piccolo riposo al pomeriggio, poi si ripartiva fino a sera. Prima del tramonto del sole si trovava un posto per dormire. C’era i turni di guardia, qualche volta con un amico, in due. La cosa strana è che eravamo veramente adorati dai nostri compagni. Qualche volta ci capitava anche di perdere qualcuno dei nostri.
[…] Sono rimasto in Uganda fino al 1989. Sono arrivato in Italia attraverso un missionario che ho conosciuto in un’azione di guerra in Kenya. Questi ha capito che ero da solo, che facevo fatica ad andare avanti, che ero interessato a studiare.
Quando è tornato a casa in vacanza, ha parlato di me nella sua parrocchia, nel veronese. Una famiglia si è fatta avanti offrendosi di darmi una mano all’inizio. Ho fatto la maturità e poi mi hanno invitato per vedere se riuscivo a fare l’Università.
[…] Adesso sono docente a contratto dell’Università. Questa esperienza forse mi ha reso molto sensibile alla sofferenza. […] Penso che per risolvere le situazioni che oggi nel mondo creano difficoltà bisogna essere lucidi. Ciò che mi spaventa prima di tutto è l’indifferenza. La gente non si accorge che siamo molto vulnerabili tutti quanti. Le cose che nella vita valgono sono le cose più semplici. Le cose più preziose che abbiamo nella vita sono le relazioni. Se vedi uno che soffre non è possibile girarsi da un’altra parte, quindi se posso dare un messaggio, il mio messaggio è questo: impegniamoci un po’ di più in questo mondo.
Quando una persona soffre, anche un sorriso, anche una pacca sulla spalla, basta quella per far sentire quella persona un essere umano e non abbandonato a se stesso. Io sono riemerso dalle mie ferite, perché ho riscoperto, ho ritrovato la fiducia nelle persone.
La vita ha delle grandi sfide, non va vissuta superficialmente. Siamo esseri uma-
ni, possiamo soffrire, ma non è mai detta l’ultima parola, se vogliamo possiamo sempre superare e imparare dai drammi della vita.
Parafrasando le parole di Albert Einstein: «Il mondo non è cattivo solo a causa di chi fa del male, ma anche a causa di chi guarda e non fa niente per impedirlo.»
RIFLETTIAMO
• Di quale sofferenza è vittima John Baptist Onama?
• Che cosa significa essere bambino soldato?
• Chi sono i responsabili di questa condizione?
• Qual è la cosa che a John B. spaventa di più?
• Qual è il messaggio finale di questa testimonianza?

Tonino Bello, VESCOVO DI MOLFETTA dà testimonianza veramente eroica di una vita spesa in particolar modo per i sofferenti: gli ultimi. Egli è sempre in prima linea nei momenti più difficili, non presenta mai segni di sfiducia o abbattimento, ma sempre trova rifugio e forza in Dio per continuare la sua missione ed esortare anche gli altri.
Fratello marocchino, perdonami se ti chiamo così, anche se col Marocco non hai nulla da spartire. Ma tu sai che qui da noi, verniciandolo di disprezzo, diamo il nome di marocchino a tutti gli infelici come te, che vanno in giro per le strade, coperti di stuoie e di tappeti, lanciando ogni tanto quel grido, non si sa bene se di richiamo o di sofferenza: tapis! La gente non conosce nulla della tua terra. Poco le importa se sei della Somalia o dell’Eritrea, dell’Etiopia o di Capo Verde. A che serve? Per il teatro delle sue marionette ha già ritagliato una maschera su misura per te. Con tanto di nome: marocchino. E con tutti i colori del palcoscenico tragico della vita. Un berretto variopinto sul volto di spugna. I pendagli di cento bretelle cadenti dal braccio. L’immancabile coperta orientale sulla spalla ricurva. E quel grido di dolore soffocato dalla paura: tapis!
Il mondo ti è indifferente. Ma forse non ne ha colpa. Perché se, passandoti accanto, ti vede dormire sul marciapiede, è convinto che lì, sulle stuoie invendute, giaccia ri-
versa solo la tua maschera. Come quella di Arlecchino o di Stenterello, dopo lo spettacolo. Ma non la tua persona. Quella è altrove. Forse è volata su uno dei tanti tappeti che nessuno ha voluto comprare da te, nonostante l’implorante sussurro: tapis! Dimmi, marocchino. Ma sotto quella pelle scura hai un’anima pure tu? Quando rannicchiato nella tua macchina consumi un pasto veloce, qualche volta versi anche tu lacrime amare nella scodella? Conti anche tu i soldi la sera come facevano un tempo i nostri emigranti? E a fine mese mandi a casa pure tu i poveri risparmi, immaginandoti la gioia di chi lì riceverà? È viva tua madre? La sera dice anche lei le orazioni per il figlio lontano e invoca Allah, guardando i minareti del villaggio addormentato? Scrivi anche tu lettere d’amore? Dici anche tu alla tua donna che sei stanco, ma che un giorno tornerai e le costruirai un tukul tutto per lei, ai margini del deserto o a ridosso della brughiera? Mio caro fratello, perdonaci. Anche a nome di tutti gli emigrati clandestini come te, che sono penetrati in Italia, con le astuzie della disperazione, e ora sopravvivono adattandosi ai lavori più umili. Sfruttati, sottopagati, ricattati, sono costretti al silenzio sotto la minaccia continua di improvvise denunce, che farebbero immediatamente scattare il “foglio di via” obbligatorio. Perdonaci, fratello marocchino, se, pur appartenendo a un popolo che ha sperimentato l’amarezza dell’emigrazione, non abbiamo usato misericordia verso di te. Anzi ripetiamo su di te, con le rivalse di una squallida nemesi storica, le violenze che hanno umiliato e offeso i nostri padri in terra straniera.
Perdonaci, se non abbiamo saputo levare coraggiosamente la voce per forzare la mano dei nostri legislatori. Ci manca ancora l’audacia di gridare che le norme vigenti in Italia, a proposito di clandestini come te, hanno sapore poliziesco, non tutelano i più elementari diritti umani, e sono indegne di un popolo libero come il nostro. Perdonaci, fratello marocchino, se noi cristiani non ti diamo neppure l’ospitalità della soglia. Se nei giorni di festa, non ti abbiamo braccato per condurti a mensa con noi. Se a mezzogiorno ti abbiamo lasciato sulla piazza, deserta dopo la fiera, a mangiare in solitudine le olive nere della tua miseria.
Perdona soprattutto me, vescovo di questa città, che non ti ho mai fermato per chiederti come stai. Se leggi fedelmente il Corano. Se osservi scrupolosamente le norme di Maometto. Se hai bisogno di un luogo, fosse anche una chiesetta, dove poter riassaporare, con i tuoi fratelli di fede e di sventura, i silenzi misteriosi della tua moschea.
Perdonaci fratello marocchino. Un giorno, quando nel cielo incontreremo il nostro Dio, questo infaticabile viandante sulle strade della terra, ci accorgeremo con sorpresa che egli ha... il colore della tua pelle.
P.S. Se passi da casa mia, fermati.
Invitiamo gli alunni a sottolineare di verde le frasi di Don Tonino che maggiormente li hanno fatto pensare, e di rosso quelle che non condividono.
FILIPPO NEVIANI, in arte Nek, conta oggi su vent’anni di carriera, oltre 8 milioni di dischi venduti nel mondo e un’OTTIMA POPOLARITÀ anche all’estero. Pochi sanno però del suo cammino più intimo, della sua FEDE CATTOLICA RINATA nell’inverno del 2005 durante un viaggio a Medjugorje, invitato da Chiara Amirante, la fondatrice di Nuovi Orizzonti. «In quel posto ci sono stato ben tre volte e le assicuro, senza con questo cadere nella sterile ed inutile retorica, che la mia fede prima era molto, ma molto più tiepida, poi si è riscaldata e mi sono infervorato», ha raccontato recentemente. «Indubbiamente devo fare ancora molta strada, ma sono sulla via giusta. Vedo una Chiesa attiva, concreta, vicina alle esigenze di chi soffre». Grazie all’incontro con Nuovi Orizzonti, Nek ha trovato una “seconda famiglia”, come ha spiegato, «perché mi avete fatto capire, mi avete fatto vedere quanto Dio sia vicino, quanto Dio non sia astratto, divinità, ma quanto Dio sia simile a ognuno di noi e quanto opera attraverso la nostra piena disponibilità».

Introdotto in questa grande amicizia, ha collaborato attivamente alla realizzazione del villaggio di “Cittadella Cielo”, per aiutare concretamente quanti desiderano emergere dal buio nel quale sono precipitati.
«Oggi sento tutto questo come la mia casa, in cui vengo accolto per ciò che realmente sono», ha raccontato. «Posso dire che Medjugorje è un luogo che io consiglio di visitare innanzitutto agli scettici, affinché si rendano conto che lì non c’è nulla di esoterico o di magico.
C’è la presenza della Madonna e di Dio, che sono disponibili a entrare in te, se lo vuoi, in punta di piedi, per spalancarti l’anima a cose meravigliose.
Anche chi avrà fatto questo viaggio per pura curiosità, tornando a casa si renderà conto di essersi arricchito di qualcosa di importante che, se coltivato con amore, porterà frutto».
Su Youtube sono disponibili diverse sue testimonianze molto interessanti.
Hey Dio, avrei da chiederti anch’io, cos’è quest’onda di rabbia, che poi diventa follia, che c’è da stare nascosti, per evitare la scia, di questo tempo che ormai, è il risultato di noi...
Hey Dio, vorrei sapere anche io, se questo mondo malato, può ancora essere mio, e se il domani che arriva, è molto peggio anche di così, ma in fondo sai cosa c’è, hai ragione sempre te...
Che c’è bisogno d’amore, è tutto quello che so, per un futuro migliore, per tutto quello che ho, per cominciare da capo e ritrovare una coscienza, per fare a pezzi con le parole questa indifferenza...
Hey Dio, permettimi di dire che qui, è solo l’odio che fa notizia, in ogni maledetto tg,
non c’è più l’ombra di quel rispetto, il fatto è che sembra andar bene così, ma in fondo sai cosa c’è, hai ragione sempre te...
Che c’è bisogno d’amore, è tutto quello che so, per un futuro migliore, per tutto quello che ho, per cominciare da capo e ritrovare una coscienza, per fare a pezzi con le parole questa indifferenza... E dopotutto sai, che sono quello di sempre, che non potrei stare fermo mai, d’avanti a un mucchio di niente...
In qualche angolo c’è, chi la pensa come me... Che c’è bisogno d’amore, è tutto quello che so, per un futuro migliore, per ogni cosa che ho, e per sentirmi più vivo, io voglio cominciare da qui, l’amore è il vero motivo, per essere più liberi.
Filippo Neviani, Marco Baroni
Eccoci, Signore, davanti a te dopo aver tanto camminato lungo quest’anno. Forse mai, come in questo crepuscolo dell’anno, sentiamo nostre le parole di Pietro: «Abbiamo faticato tutta la notte, e non abbiamo preso nulla». Ad ogni modo, vogliamo ringraziarti ugualmente.
Perché, facendoci contemplare la povertà del raccolto, ci aiuti a capire che senza di te non possiamo far nulla. Ci agitiamo soltanto.
Grazie, Signore, perché se ci fai sperimentare la povertà della mietitura e ci fai vivere con dolore il tempo delle vacche magre, tu dimostri di volerci veramente bene, poiché ci distogli dalle nostre presunzioni corrose dal tarlo dell’efficientismo, raffreni i nostri desideri di onnipotenza, e non ci esponi al ridicolo di fronte alla storia: anzi di fronte alla cronaca.
Marina Duccillo
Ci sono cose che non si possono comprare, né vendere, a volte neanche regalare.
Spesso è una conquista la vera felicità, la salute è un tesoro, e beato chi ce l’ha.
I figli, la famiglia, l’amore degli sposi, tutti beni impagabili, più dell’oro preziosi.
Qualcosa in più distingue l’umanità che crede: è un dono straordinario, il dono della fede. Unita alla speranza e al sempiterno amore, è il regalo più grande che può darti il Signore.
La fede, quando è autentica, sai? ti cambia la vita, e sposta le montagne con potenza infinita.
Ne basta poca, non la devi neppur misurare: quanto un granello di senape sembrerebbe pesare.
Eppure non immagini la forza che sprigiona nel corpo, nello spirito, nel cuore d’ogni persona. È quella marcia in più, la spinta soprannaturale che aiuta nel combattere con più carica il tuo male.
Ti svela sulla terra i tanti misteri divini, agli altri e al Creatore a poco a poco ti avvicini: sono tutti tuoi fratelli, non esistono nemici, appaiono migliori anche i giorni infelici.
Ti auguro di averla, mio fedele lettore, e se ancora ti manca ascolta e prega il tuo Signore.
Don Tonino Bello
Leggi il seguente testo e prova a rispondere.

Un obbligo, qualsiasi cosa diamo a questi uomini non è beneficenza, ma la riparazione di un torto commesso.
Per ognuno di quelli che hanno recato offesa qualcuno di noi dovrebbe andare a offrire aiuto.
Albert Schweizer
Chi sono coloro che secondo te devono impegnarsi concretamente per aiutare i bisognosi?
• Il Sindaco perché
• Il Governo perché
• Gli enti di assistenza perché
• Quelli che hanno tanti soldi perché
• La Chiesa perché
• Tutti gli uomini perché
• Io stesso perché
I cristiani cercano di mettere in pratica le parole di Gesù aiutando gli altri. Alcuni di essi, in particolare, vanno incontro ai fratelli di ogni parte del mondo, senza fare distinzione di lingua, razza e religione: sono i missionari.
Completa la frase e colora, commentando i disegni.
Secondo me la parola “solidarietà” significa:
Assieme a un tuo compagno o compagna di scuola, sfogliate alcuni giornali e riviste cercando notizie riguardanti personaggi o realtà che hanno contribuito a diffondere qualcosa del messaggio di Gesù.
Incollate qui la foto e scrivete un breve articolo al riguardo.
Colora e ritaglia le parti, poi fissa la prima sopra alla seconda con un fermacampione; fa’ girare la parte sopra e scopri gli abbinamenti dei colori ai tempi forti e feste principali dell’anno liturgico cristiano.
ROSSO BIANCO BIANCO ROSSO BIANCO VERDE
ROSSO BIANCO BIANCO ROSSO BIANCO VERDE
VIOLA
VIOLA
VIOLA
VIOLA
VIOLA
VIOLA
VIOLA
DOMENICA DELLE PALME PASQUA GIOVEDÌ SANTO LECENERI
PENTECOSTE NATALE ASCENSIONE TEMPO ORDINARIO EPIFANIA AVVENTO QUARESIMA VENERDÌSANTO
CRISTO RE V I OL A ONCAIB BIANCO VIOLA
CRISTO RE V I OL A ONCAIB BIANCO
PENTECOSTE NATALE ASCENSIONE TEMPO ORDINARIO EPIFANIA AVVENTO QUARESIMA VENERDÌSANTO
DOMENICA DELLE PALME PASQUA GIOVEDÌ SANTO LECENERI
L’anno solare è scandito dai giorni, dalle settimane e dai mesi. L’anno liturgico è scandito dalle festività della comunità cristiana. Inizia con la festa di Cristo Re, che cade nell’ultima domenica prima dell’Avvento, e si sviluppa fino alla stessa festa dell’anno successivo. Si suddivide in tempi come segue:
AVVENTO
Tempo di attesa della nascita di Gesù.
NATALE
Festa che ricorda la nascita di Gesù.
QUARESIMA
Tempo di attesa della Passione, morte e Risurrezione di Gesù.
SETTIMANA SANTA
Settimana di Passione e morte di Gesù.
Nel corso di questi tempi liturgici in Chiesa, nei paramenti sacri, sono dominanti colori diversi:
BIANCO per le feste di Natale e Pasqua VERDE per il tempo ordinario. VIOLA nei tempi dell’attesa di Natale e Pasqua ROSSO nella Settimana Santa
TEMPO ORDINARIO Senza festività particolari.
PASQUA
Festa della Risurrezione di Gesù.
Colora i riquadri dei tempi dell’Anno liturgico con i colori dei paramenti sacri.
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…
• sa distinguere il testo biblico da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;
• conosce le caratteristiche principali delle grandi religioni del mondo;
• matura atteggiamenti di rispetto e apprezzamento nei confronti delle diverse religioni e comprende l’importanza del dialogo interreligioso.
u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o
Le grandi religioni Le grandi religioni del mondo:
• Ebraismo;
• Islam;
• Induismo;
• Buddismo;
• Confucianesimo, Taoismo e Shintoismo;
• Sikhismo e Animismo. Il dialogo interreligioso.
Da pag. 84 a pag. 120
La Bibbia e le altre fonti
• Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.
Il linguaggio religioso
• Conoscere le origini e lo sviluppo delle grandi religioni del mondo, individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.
In questa unità l’insegnante ha lo scopo di introdurre la CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI
RELIGIONI PRESENTI NEL MONDO, delle loro credenze, riti, luoghi e strutture, a partire dalla loro risposta nei confronti del male e della violenza: cioè l’AMORE e la PACE, quali VALORI COMUNI UNIVERSALI. Verranno trattate tutte le religioni più diffuse nel mondo: presentando gli elementi principali e più caratteristici per ciascuna:
EBRAISMO, ISLAM, BUDDISMO, INDUISMO, TAOISMO, SHINTOISMO, ANIMISMO, CONFUCIANESIMO e SIKHISMO.
Il percorso si chiuderà affrontando il tema del DIALOGO INTERRELIGIOSO a partire dalla conoscenza della riunione tenuta ad Assisi tra i grandi leader delle diverse religioni mondiali, conosciuta come “Spirito di Assisi” che ha dato vita e una forte spinta verso il confronto e la ricerca di ciò che può unire le diverse religioni, alla ricerca del bene comune.
Feste ebraiche
Il CALENDARIO FESTIVO EBRAICO (ricordiamo che il primo degli anni ebraici corrisponde al 3760 a.C., anno in cui colloca la creazione della Terra) è LUNI-SOLARE, cioè si basa sulle fasi lunari (mesi) e sul cielo solare (anni). Tutte le feste cominciano la sera del giorno precedente e continuano sino alla sera successiva.
La giornata sacra per eccellenza è il sabato: SHABBATH, che RICORDA IL GIORNO IN CUI IL SIGNORE CONCLUSE LA CREAZIONE .
In questo giorno nelle case si consuma un pasto, come rito religioso in cui il capo famiglia benedice il pane e il vino e la moglie accende due candele. Nel corso di questa giornata tutte le occupazioni dei giorni lavorativi devono essere evitate per dedicarsi alla preghiera, allo studio e al riposo. Nelle funzioni del sabato ha un posto molto importante la lettura della Torah.
Il calendario ebraico è costellato da numerose celebrazioni festive che si possono suddividere in tre principali gruppi.
Il primo gruppo comprende le tre feste bibliche considerate maggiori, note come feste di pellegrinaggio, hanno in comune il tema della gioia di fronte alla presenza di Dio:
Si celebra in marzo-aprile, per RICORDARE L’ESODO DALL’EGITTO. In questa occasione la famiglia si riunisce per la cena rituale della notte di Pasqua in cui si mangiano pane azzimo, marmellata di frutta, erbe amare intinte nell’aceto, agnello arrostito, in memoria della vita di stenti durante la schiavitù egiziana.
C’è anche l’obbligo di bere quattro bicchieri di vino legati alle quattro promesse contenute in Esodo 6,6-7: E io vi farò uscire e vi libererò e vi redimerò e vi prenderò per me.
Siccome molti ebrei si attendono che la sera di Pasqua il profeta Elia annunci la venuta del Messia, lasciano aperta per lui la porta di casa e pongono sulla tavola un bicchiere di vino in più.
Si celebra in maggio-giugno, 50 giorni dopo la Pasqua, per esprimere la riconoscenza per il raccolto e ricordare l’anniversario della rivelazione sul Sinai. Originariamente era la
FESTA DELLA SPIGOLATURA, legata alla figura di Ruth, la moabita, nonna di re Davide, che rimase vedova in giovane età. Un giorno, mentre andava a spigolare conobbe Booz, il padrone del campo, che si innamorò di lei, la convertì e poi la sposò, facendola entrare nella storia d’Israele. Successivamente si passò a commemorare la consegna dei dieci comandamenti a Mosé che infatti gli furono consegnati da Dio proprio sette settimane dopo l’uscita dall’Egitto. In questo giorno le case vengono addobbate con fiori e ceste di grano.
SUKKOTH (FESTA DELLE CAPANNE)
Si celebra in settembre-ottobre IN MEMORIA DELL’ESODO NEL DESERTO, quando gli ebrei vissero in capanne fatte di fogliame. Le famiglie ebree alzano una capanna o una tenda, sul balcone di casa se non c’è altro posto all’aperto, lasciando un’apertura in alto per vedere il cielo, così come gli antenati, accampati nel deserto, non avevano altro tetto che il cielo. Per una settimana vi sostano un po’ di tempo ogni giorno, RECITANO L’HALLEL (Alleluia) TENENDO IN MANO RAMETTI DI PALMA (lulavi), SALICE PIANGENTE (aravot), MIRTO (hadas) e CEDRO (etrog).
Il secondo gruppo comprende le feste penitenziali:
Si celebra in autunno tra settembre-ottobre e rievoca la creazione del mondo da parte di Dio. Inoltre il Capodanno è il giorno del ricordo e il giorno del giudizio poiché Dio, ricordandosi le azioni degli uomini durante l’anno, giudica l’uomo e questi deve giudicare se stesso pentendosi delle sue colpe. Per gli ebrei è un
GIORNO DI SILENZIO E DI RITIRO. Simbolo di questo rinnovamento è la testa di agnello o di pesce che si porta in tavola: un incitamento ad essere sempre come la testa e mai come la coda. Durante la funzione vengono letti brani della Genesi e, verso la fine della lettura, si suona il corno d’ariete, lo SHOFAR, in ricordo del sacrificio di Isacco e dell’ariete che Abramo sacrificò al posto del figlio. All’uscita dalla sinagoga la gente mormora: «Che l’anno nuovo ti sia dolce come il miele.» all’inizio del nuovo anno questo augurio ha un sapore di dolcezza come uno dei cibi tradizionali che vengono consumati in questo giorno, le mele intinte nel miele.
Ricorre a settembre-ottobre, dieci giorni dopo il Capodanno ebraico e celebra il GIORNO DELL’ESPIAZIONE e della riconciliazione con Dio. L’origine di questa festa è rintracciabile nel testo del Levitico 16,29-34. In questo giorno è prescritto il DIGIUNO COMPLETO PER TUTTI, come momento di sforzo nei confronti delle proprie debolezze e di occasione di meditazione e di preghiera. Un capro, su cui sono trasferite simbolicamente tutte le colpe del popolo, viene spinto nel deserto.
Il terzo gruppo comprende le feste minori:
Ricorre in novembre-dicembre, in coincidenza con il SOLSTIZIO INVERNALE, celebra la vittoria dei Maccabei su Antioco IV di Siria. Simbolo di questa festa è il candelabro ad otto bracci che si accende per ricordare il miracolo dell’olio. Infatti quando la dinastia degli Asmonei sconfisse i Greci, gli ebrei cercarono l’olio puro per la menorah del Tempio, ma ne trovarono solamente un piccolo vasetto, sufficiente per un solo giorno. Miracolosamente, quell’olio bastò per otto giorni.
Ricorre in febbraio-marzo, commemora il tempo in cui la regina Ester, moglie ebrea del re Assuero di Persia, salvò il popolo ebraico dalla distruzione ordita dal perfido consigliere Aman. Il nome della festa allude ai dadi lanciati da Aman per fissare la data del massacro degli ebrei.
È una specie di CARNEVALE, ma CON UN SIGNIFICATO PRETTAMENTE BIBLICO RELIGIOSO : i travestimenti e i giochi dei bambini, indicano la gioia per la salvezza degli ebrei. In questo giorno è prescritta la lettura del rotolo di Ester, alla mattina e alla sera.
I cinque pilastri dell'Islam
I pilastri della fede islamica, cioè gli OBBLIGHI FONDAMENTALI PER I CREDENTI MUSULMANI, sono cinque.
PROCLAMA L’UNICITÀ DI ALLAH E LA MISSIONE PROFETICA DI MAOMETTO , espressa nella formula Rendo testimonianza che non vi è dio all’infuori di Allah; rendo testimonianza che Muhammad è il suo profeta. Questa formula apre tutte le preghiere e accompagna il credente per tutta la sua esistenza.
Può essere recitata nei momenti solenni e importanti della vita e quando si intraprendono azioni o relazioni che mettono in pericolo l’appartenenza alla Ummah (comunità dei fedeli musulmani). La morte per la causa della fede ne è la più evidente attestazione e in quel caso si è martiri, sahid.
Deve essere recitata CINQUE VOLTE AL GIORNO: all’alba, a mezzogiorno, prima del tramonto, subito dopo il tramonto, quando si fa buio. Le preghiere devono essere fatte in stato di purità rituale e quindi sono precedute da abluzioni in cui il volto, le mani, i polsi, i piedi e le gambe sono lavati nei modi prescritti dalla tradizione: le mani fino ai polsi vanno lavati per tre volte, la bocca va sciacquata per tre volte e le narici vanno pulite con le dite bagnate; il viso va lavato dall’attaccatura dei capelli fino al mento, passando per le orecchie per tre volte. Il musulmano, quando prega, si rivolge alla Mecca e recita cosi: In nome di Allah il Compassionevole, il Misericordioso. La lode [appartiene] ad Allah, Signore del mondo, il Compassionevole, il Misericordioso, Re del Giorno del Giudizio.
Te noi adoriamo ed a Te chiediamo aiuto. Guidaci sulla retta via, la via di coloro che hai colmato di grazia, non di coloro che [sono incorsi] nella [Tua] ira, né degli sviati. Amen. La recita delle preghiere è accompagnata da un certo numero di genuflessioni alternate con prostazioni. Il credente può fare la sua preghiera dovunque si trovi, delimitando uno spazio sacro stendendo a terra un tappetino (per simboleggiare il distacco dal mondo), solo il venerdì, GIORNO DEL RADUNO, ha l’obbligo di recarsi nella moschea, per recitare, sotto la guida dell’imam, la preghiera in comune.
È un segno di misericordia verso i poveri prescritto dal Corano: Non fu comandato loro se non servire Dio offrendo a Lui un culto sincero […], di osservare la preghiera e fare l’elemosina, perché tale è la vera religione. (Corano 98,4)
Oggi, in molti Paesi dell’Islam, la Zakkat è sostituita con il pagamento delle tasse, raccolte e utilizzate dallo Stato per il bene pubblico. Resta comunque il fatto che il credente ha l’obbligo morale dell’elemosina.
Si osserva dall’alba al tramonto, durante il mese di RAMADAN, il nono mese dell’anno, in cui fu fatto scendere dal cielo il Corano, affinché Maometto lo riscrivesse in arabo per tutti gli uomini. Ogni musulmano deve astenersi da qualunque cibo, bevanda, fumo e rapporti sessuali, nell’arco del tempo che va dall’alba al calar del sole. Esso oltre a rappresentare una forma di devozione verso Dio, è un esercizio, un allenamento in cui si provano le virtù dell’uomo come la pazienza, la sopportazione, il coraggio...
IL PELLEGRINAGGIO (HAJJ)
Alla Mecca deve essere compiuto almeno una volta nella vita da ogni musulmano che abbia superato l’età della pubertà. I pellegrini convengono nella città santa dall’8 al 12 dell’ULTIMO MESE DELL’ANNO SOLARE ISLAMICO. Si considerano membri della stessa famiglia, indossano una veste bianca senza cuciture e fanno sette volte il giro della Kaaba, un edificio sacro a forma di cubo che conserva la pietra nera.
Essi ENTRANO E BACIANO LA PIETRA NERA, poi bevono al pozzo prima di recarsi sul colle antistante, chiamato Arafat, per stare eretti di fronte a Dio da mezzogiorno al tramonto e invocare il perdono di Dio per sé e per gli altri.
In riferimento alla pag. XX, l’insegnante spiegherà l’importanza di Medina e La Mecca per l’Islam.
Maometto a Medina predicò per circa otto anni, redigendo la COSTITUZIONE DI MEDINA che venne accettata dalle città-oasi e diede vita alla Umma (la prima comunità politica di credenti).
Nel 630 Maometto marciò sulla Mecca e la conquistò, ma tornò a vivere a Medina da dove conduceva tutta la sua azione politica e religiosa. E proprio in questa città morì 9 anni dopo, lasciando nove vedove e la figlia Fatima che, dopo la sua morte, divenne una delle figure più venerate della religione islamica.
L’insegnante parlerà agli alunni della moschea e del muezzin come elementi fondamentali nel culto dell’Islam



Il tappeto viene usato dai musulmani durante la preghiera giornaliera perché venga assicurata la pulizia, visto che il fedele deve inginocchiarsi a terra, ma deve pregare in un luogo pulito. Il rosario o Tasbih.
L’insegnante parlerà agli alunni della moschea e del muezzin come elementi fondamentali nel culto dell’Islam


Nonostante la Costituzione dell’UNIONE INDIANA (proclamata Repubblica federale nel 1950) abbia abolito le caste, esse perdurano a tutt’oggi, sebbene con minor rigidità.

Per l’induismo la casta non è solo un fatto economico e sociale, è la CONSEGUENZA DEL KARMA, del destino, cioè della reincarnazione.
Le ineguaglianze tra gli uomini non dipendono dagli dei, ma dalle azioni dell’uomo. Si nasce in questa vita, nella casta superiore o inferiore, o addirittura in forma non umana, come si è vissuti in un’esistenza passata; si rinascerà in una vita futura secondo la condotta della vita presente.
La struttura dell’induismo prevede da sempre una GRADUATORIA DI CASTE. Nei VEDA, libri sacri, viene motivata la divisione nelle quattro classi, chiamate VARNA
Esse rappresenterebbero le varie parti del PURUSHA, il mostro primordiale dalla cui uccisione e smembramento sono nati gli uomini:
• Dal suo capo sono nati i brahmini (sacerdoti)
• Dalle sue braccia i guerrieri
• Dalle sue gambe i contadini e gli operai
• Dai suoi piedi i servi
AD OGNI CASTA CORRISPONDE UN COLORE : a quella dei brahmini, cioè dei sacerdoti, corrisponde il bianco, a quella dei guerrieri il rosso, a quella del popolo il giallo e infine a quella dei servitori il nero.
Ogni casta, nel tempo, si è suddivisa in sottogruppi e il passaggio da una casta all’altra è estremamente difficile perché l’individuo eredita la sua casta di nascita.
OGNI CASTA HA LE SUE REGOLE E LE SUE TRADIZIONI , regimi alimentari, professioni e mestieri riservati.
Fuori dal sistema delle caste ci sono circa 135 milioni di persone definiti gli intoccabili (i paria), ritenuti impuri perché praticano mestieri che contaminano, come la pulizia delle strade, delle latrine, o la rimozione delle persone e degli animali morti; chi li sfiora anche solo accidentalmente, deve andare immediatamente a purificarsi.
Anche se la Costituzione Indiana afferma che i cittadini sono tutti uguali di fronte alla legge, la loro situazione resta piuttosto discriminata, MOLTI
ANCORA OGGI SONO ESCLUSI DALLA ALFABETIZZAZIONE e non possono svolgere importanti incarichi sociali e politici.
Oggi ci si domanda se lo sviluppo industriale dell’India, che richiede una certa mobilità della forza lavoro e sta abbattendo le corporazioni degli antichi mestieri, non finirà per distruggere finalmente il sistema delle caste.
Le verità del Buddismo

L’insegnante spiegherà il significato delle quattro nobili verità del Buddismo:
1. La sofferenza e la sua accettazione.
2. Le cause della sofferenza che dimorano dentro di noi.
3. Il raggiungimento di uno stato di pace mentale e di un benessere duraturo.
4. L’addestramento mentale a trasformare anche le situazioni più difficili in situazioni di pace e felicità.
«Perdona gli altri, non perché essi meritano il perdono, ma perché tu meriti la pace.» Buddha
Questa citazione dai discorsi del Buddha può aiutare in una breve riflessione con gli alunni su un approccio diverso da quello cristiano sul perdono ma con lo stesso risultato, cioè una buona relazione con gli altri esseri umani.
I simboli del Buddismo

L’insegnante può parlare del simbolo più conosciuto del Buddismo, il MANTRA, e mostrare la sua rappresentazione grafica. Il mantra è uno STRUMENTO PER PENSARE IN MODO NON RAZIONALE, è un mezzo per concentrare le forze già esistenti in noi e che consentono al credente di entrare nello spazio mistico. IL MANTRA PIÙ FAMOSO È OM.
L'idea di reincarnazione
IL BUDDISMO CREDE NELLA REINCARNAZIONE
, pensando alla vita terrena come ad una specie di punizione in modo da purificarci per tornare ad essere spirito. I meriti che un essere umano conquista durante la vita terrena lo avvicinano alla perfezione e alla spiritualità.
La meditazione
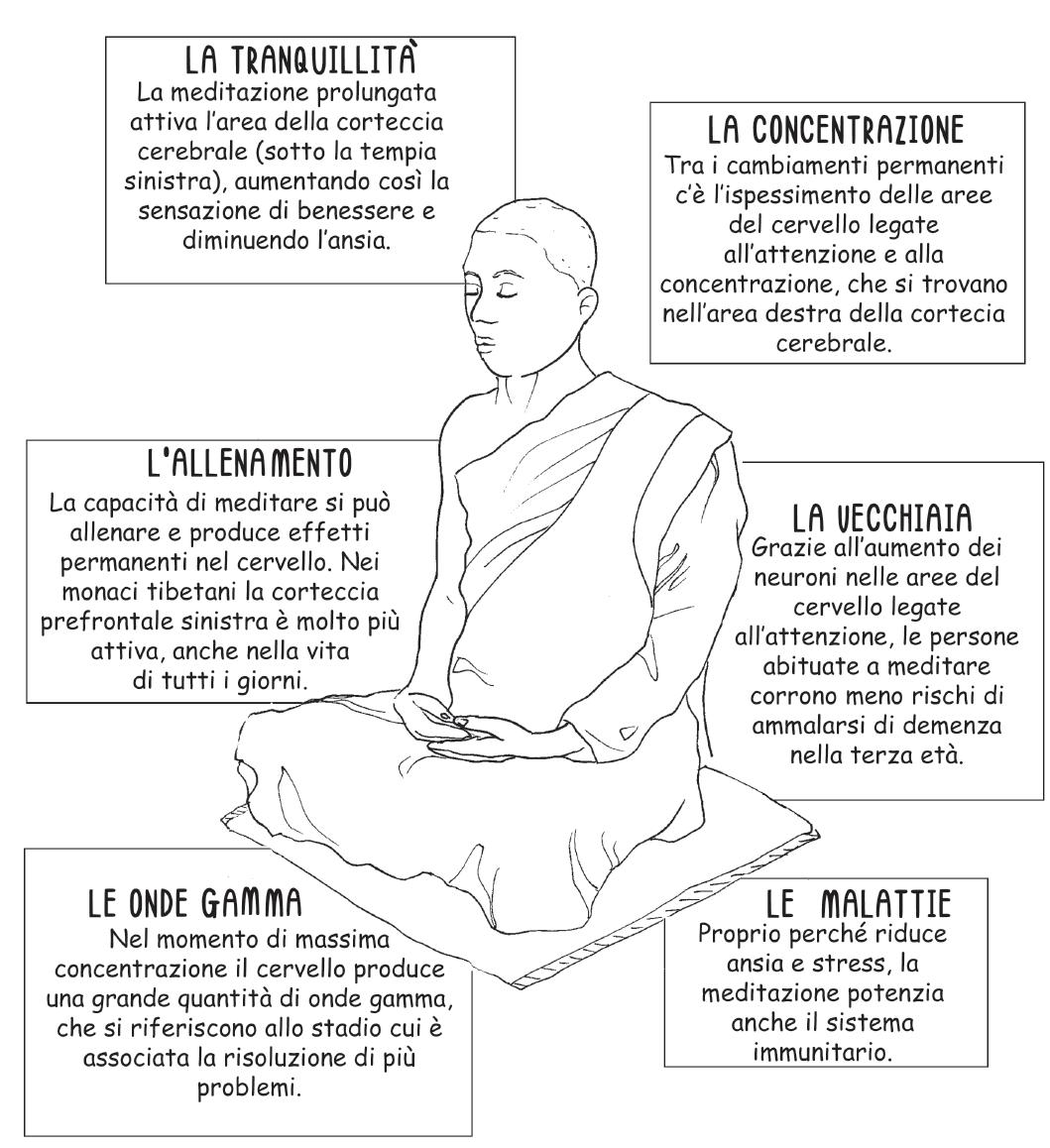
SIDDHARTA GAUTAMA
Siddharta Gautama nacque all’incirca nel 563 a.C. nella repubblica dei Sakya (i potenti), nel nord est dell’India, tra il Gange e l’Himalaya (presso l’attuale confine indo-nepalese). Secondo la tradizione Siddharta era di origini principesche.
La leggenda racconta che appena riuscì a camminare fece sette passi nella direzione dei quattro punti cardinali, e sette fiori di loto spuntarono per sostenere il suo movimento. Il padre lo presentò al tempio e in quella circostanza le statue degli dei discesero dai loro piedistalli per adorarlo in ginocchio. Vedendo questi segni i saggi compresero che il bambino sarebbe diventato un Buddha.
Reso sgomento dal futuro religioso predettogli, il padre lo fece sposare che aveva appena sedici anni con una bellissima principessa da cui ebbe un figlio. Egli visse una vita dedita ai piaceri, al lusso, alle gioie materialistiche fino al ventinovesimo anno, quando desideroso di conoscere la vita, uscì dal palazzo reale. Fuori dalla corte ebbe quattro incontri: con un vecchio, con un malato, con un corteo funebre e con un asceta mendicante. Questi aspetti della realtà lo portarono a riflettere sulle miserie della vita umana, a porsi il problema dell’identità dell’Io, dell’esistenza del male e di che cosa sopravvive alla morte. La sera stessa si allontanò definitivamente dal sontuoso palazzo, per due anni visse con i maestri di yoga e, deluso da essi, si ritirò poi per sei anni in solitudine tra gli asceti della foresta, nutrendosi di semi, d’erba e perfino di letame. Dopo essersi sottoposto a penitenze estenuanti, ad un certo punto capì che occorreva ricercare il giusto mezzo tra le ricchezze e le estreme mortificazioni.
A trentacinque anni, ai piedi di un fico sacro decise di non muoversi finché non avesse raggiunto l’illuminazione suprema e trovato il modo di liberare l’uomo da se stesso. Il demone del male, prese a tentarlo con le visioni di tutte le ricchezze e le vanità del mondo, ma lui sprofondò sempre più nella meditazione. Alla fine, in una grande estasi mistica che durò quarantanove giorni raggiunse l’Illuminazione, divenendo così il Buddha, il Risvegliato.
Da questo momento ebbe inizio la seconda parte della sua vita, dopo una scelta di isolamento, si recò nella città di Benares, sul Gange, ove pronunciò un celebre discorso per rivelare i suoi insegnamenti con parole molto semplici ma affascinanti. A poco a poco Buddha convertì migliaia di persone. Alcune abbandonarono tutto per seguirlo nella predicazione e condividere la sua vita, altre, invece, rimanendo nella vita secolare, si assunsero l’onere di fornire al loro maestro e ai suoi seguaci il poco cibo di cui avevano bisogno. Nacque così la comunità dei monaci mendicanti alla quale Buddha dettò le istruzioni e le leggi. Dopo quarantacinque anni di predicazione, Buddha, vecchio e malato, morì presso la cittadina di Kusinara, nel Bengala, pervenendo alla estinzione completa. Le ceneri, raccolte sul posto della sua cremazione, sarebbe state divise tra le schiere dei suoi fedeli i quali, dopo averle portate come preziosi talismani nei rispettivi luoghi di origine, avrebbero innalzato tumuli funerari sopra le urne. Dopo la sua morte la dottrina del Buddha si diffuse in tutta l’India grazie ai suoi discepoli che formarono ben presto delle scuole per trasmettere i suoi insegnamenti.
Attraverso questa MAPPA CONCETTUALE gli alunni potranno identificare facilmente i PUNTI FONDAMENTALI DEL BUDDISMO.

Uno dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, approvato nel 1965, si intitola “Le relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane”. Esso approfondisce i rapporti tra i cattolici e gli appartenenti alle religioni non cristiane, ebrei, musulmani, induisti e buddhisti.
“Nell’induismo gli uomini scrutano il mistero divino e lo esprimono con la inesauribile fecondità dei miti e con i penetranti tentativi della filosofia; essi cercano la liberazione dalle angosce della nostra condizione sia attraverso forme di vita ascetica, sia nella meditazione profonda, sia nel rifugio in Dio con amore e confidenza”.
“Nel buddhismo secondo le sue varie scuole, viene riconosciuta la radicale insufficienza di questo mondo mutevole e si insegna una via per la quale gli uomini, con cuore devoto e confidente, siano capaci di acquistare lo stato di liberazione perfetta o di pervenire allo stato di illuminazione suprema per mezzo dei propri sforzi e con l’aiuto venuto dall’alto”. La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella Verità che illumina tutti gli uomini. (Nostra aetate, n. 2)
“La Chiesa guarda con stima i musulmani che adorano l’unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti di Dio anche nascosti, come si è sottomesso anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce.
Benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano tuttavia come profeta; essi onorano la sua Madre Vergine, Maria, e talvolta pure la invocano con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati. Così pure essi hanno in stima la vita morale e rendono culto a Dio soprattutto con la preghiera, le elemosine e il digiuno. Se, nel corso dei secoli, non pochi dissensi e inimicizie sono sorti tra cristiani e musulmani, il Sacrosanto Concilio esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme, per tutti gli uomini, la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà”. (Nostra aetate, n. 3)
“La Chiesa di Cristo riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei Patriarchi, Mosè e i Profeti… Essa ha ricevuto la rivelazione dell’Antico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è degnato di stringere l’Antica Alleanza… La Chiesa crede che Cristo, nostra pace, ha riconciliato gli Ebrei e i Gentili per mezzo della sua Croce e dei due ha fatto una sola cosa in Se stesso… Essa ricorda anche che dal popolo ebraico sono nati gli Apostoli, fondamenta e colonne della Chiesa, e così quei moltissimi primi discepoli che hanno annunciato al mondo il Vangelo di Cristo… Essendo perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune a Cristiani e ad Ebrei, questo Sacro Concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto dagli studi biblici e teologici e da un fraterno dialogo. E se autorità ebraiche con i propri seguaci si sono adoperate per la morte di Cristo, tuttavia quanto è stato commesso durante la sua passione, non può essere imputato né indistintamente a tutti gli Ebrei allora viventi, né agli Ebrei del nostro tempo. E se è vero che la Chiesa è il nuovo popolo di Dio, gli Ebrei non devono essere presentati come rigettati da Dio, né come maledetti, quasi che ciò scaturisse dalla Sacra Scrittura… La Chiesa inoltre, che esecra tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, memore del patrimonio che essa ha in comune con gli Ebrei, e spinta non da motivi politici, ma da religiosa carità evangelica, deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell’antisemitismo dirette contro gli Ebrei in ogni tempo e da chiunque. (Nostra aetate, n. 4)
Per volontà di Giovanni Paolo II, nel 1986, nel 1993 e nel 2002 (in seguito agli attentati di New York), ad Assisi si sono riuniti i rappresentanti delle principali religioni allo scopo di riaffermare il loro impegno per la pace
1. Ci impegniamo a proclamare la nostra ferma convinzione che la violenza e il terrorismo si oppongono al vero spirito religioso e, condannando qualsiasi ricorso alla violenza e alla guerra in nome di Dio o della religione, ci impegniamo a fare tutto il possibile per sradicare le cause del terrorismo
2. Ci impegniamo a educare le persone al rispetto e alla stima reciproci, affinché si possa giungere a una coesistenza pacifica e solidale fra i membri di etnie, di culture e di religioni diverse.
3. Ci impegniamo a promuovere la cultura del dialogo, affinché si sviluppino la comprensione e la fiducia reciproche fra gli individui e fra i popoli, poiché tali sono le condizioni di una pace autentica.
4. Ci impegniamo a difendere il diritto di ogni persona umana a condurre un’esistenza degna, conforme alla sua identità culturale, e a fondare liberamente una propria famiglia.
5. Ci impegniamo a dialogare con sincerità e pazienza, non considerando ciò che ci separa come un muro insormontabile, ma, al contrario, riconoscendo che il confronto con la diversità degli altri può diventare un’occasione di maggiore comprensione reciproca.
6. Ci impegniamo a perdonarci reciprocamente gli errori e i pregiudizi del passato e del presente, e a sostenerci nello sforzo comune per vincere l’egoismo e l’abuso, l’odio e la violenza, e per imparare dal passato che la pace senza la giustizia non è una vera pace.
7. Ci impegniamo a stare accanto a quanti soffrono per la miseria e l’abbandono, facendoci voce di quanti non hanno voce e operando concretamente per superare simili situazioni, convinti che nessuno possa essere felice da solo.
8. Ci impegniamo a fare nostro il grido di quanti non si rassegnano alla violenza e al male, e desideriamo contribuire con tutte le nostre forze a dare all’umanità del nostro tempo una reale speranza di giustizia e di pace
9. Ci impegniamo a incoraggiare qualsiasi iniziativa che promuova l’amicizia fra i popoli, convinti che, se manca un’intesa solida fra i popoli, il progresso tecnologico espone il mondo a crescenti rischi di distruzione e di morte.
10. Ci impegniamo a chiedere ai responsabili delle nazioni di compiere tutti gli sforzi possibili affinché, a livello nazionale e a livello internazionale, sia edificato e consolidato un mondo di solidarietà e di pace fondato sulla giustizia.

Grazie alla seguente attività, gli alunni potranno riflettere e scoprire insieme quali possono essere le parole e gli atteggiamenti che favoriscono il dialogo e il rispetto tra gli uomini.
A come Amore La pace è segno dell’amore verso Dio e verso il prossimo.
B come Bontà Da un cuore pieno di bontà nasce la pace.
C come Collaborazione La pace è frutto della collaborazione di tutti i popoli della terra.
D come Dialogo Il dialogo tra le culture porta a una civiltà dell’amore e della pace.
E come Esempio Tante persone con il loro esempio testimoniano che la pace è possibile.
F come Fiducia La pace è superare le diffidenze ed avere fiducia nel prossimo.
G come Giustizia Dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti.
H come Handicap E’ necessario eliminare gli ostacoli che rendono un uomo inferiore all’altro.
I come Istruzione L’istruzione deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia e la pace tra gli uomini.
L come Luce Dopo l’oscurità delle guerre, la pace è la luce che tutti aspettano.
M come Medicina La pace è assicurare a tutti l’assistenza medica necessaria.
N come Non-violenza Con le armi della non-violenza si ottiene la pace.
O come Ospitalità La pace è essere ospitali con chi ne ha bisogno.
P come Perdono Offrendo il perdono si riceve la pace.
Q come Qualità Migliorare i rapporti tra le persone valorizzando le qualità.
R come Rispetto Nel rispetto dei diritti umani è il segreto della pace vera.
S come Solidarietà Solidarietà e sviluppo sono le due chiavi per la pace.
T come Trattative La pace si realizza attraverso trattative per venire ad un accordo.
U come Uguaglianza Per costruire la pace occorre affermare il principio d’uguaglianza fra gli uomini.
V come Vita La pace è diffondere una cultura della vita.
Z come Zelo Ognuno deve farsi carico di un impegno instancabile per le sorti future dell’umanità.
Realizziamo la
Preparare la base del candelabro a forma di cerchio con sei metà (rivolti verso il basso) dei contenitori sorpresa degli ovetti.
Incollare al centro una fila centrale di quattro contenitori (interi).
Dalla fila centrale saltare un contenitore e iniziare ad incollarne altri due uno a destra e l’altro a sinistra, proseguire aumentando di una unità sia a destra che a sinistra i contenitori.
Giunti alla terza fila, incollare nove metà dei contenitori (verso l’alto), quello centrale deve contenerne un altro ancora (cioè una metà sopra l’altra rivolte verso l’alto). Il primo contenitore del braccio sinistro e il primo del braccio destro debbono avere una base sottostante di una metà di contenitore rivolta verso l’alto.
Incollare i nove colori e applicare sulla punta delle fiammelle realizzate con la carta dorata. 1 3 5 2 4
• Contenitori di plastica che contengono le sorprese degli ovetti kinder
• Otto pennarelli vecchi di diversi colori
• Carta dorata
• Colla a caldo

Lo Shemah Israel (Ascolta Israele) è una delle preghiere fondamentali della liturgia ebraica e racchiude la PROFESSIONE DI FEDE SULL’ETERNITÀ E UNICITÀ DI DIO . Essa viene recitata ogni giorno al mattino e alla sera. Leggiamo ai bambini le fonti tratte da alcuni brani della Bibbia.
Ascolta Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti siano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.
Ora, se obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi do, amando il Signore, vostro Dio, e servendolo con tutto il cuore e con tutta l’anima, io darò alla vostra terra la pioggia al suo tempo: la pioggia d’autunno e la pioggia di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo frumento, il tuo vino e il tuo olio. Darò anche erba al tuo campo per il tuo bestiame. Tu mangerai e ti sazierai.
State in guardia perché il vostro cuore non si lasci sedurre e voi vi allontaniate, servendo dei stranieri e prostrandovi, davanti a loro. Allora si accenderebbe contro di voi l’ira del Signore ed egli chiuderebbe il cielo, non vi sarebbe più pioggia, il suolo non darebbe più i suoi prodotti e voi perireste ben presto, scomparendo dalla buona terra che il Signore sta per darvi. Porrete dunque nel cuore e nell’anima queste mie parole, ve le legherete alla mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi. Le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte, perché siano numerosi i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, come i giorni del cielo sopra la terra, nel paese che il Signore ha giurato ai vostri padri di dare loro.
Il Signore parlò a Mosè e disse: “Parla agli Israeliti dicendo loro che si facciano, di generazione in generazione, una frangia ai lembi delle loro vesti e che mettano sulla frangia del lembo un cordone di porpora viola. Avrete tali frange e, quando le guarderete, vi ricorderete di tutti i comandi del Signore e li eseguirete; non andrete vagando dentro il vostro cuore e i vostri occhi, seguendo i quali vi prostituireste. Così vi ricorderete di tutti i miei comandi, li metterete in pratica e sarete santi per il vostro Dio. Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto per essere il vostro Dio.
Io sono il Signore, vostro Dio.
Deuteronomio 6,4-9; 11,13-21; Numeri 15,37-41
Se tu credi che è più importante il dialogo che lo scontro, se tu credi che un sorriso è più potente di un’arma, s e tu credi alla forza di una mano aperta, se tu credi che essere differenti è una ricchezza e non un danno, se tu sai guardare un altro con un lampo d’amore, se tu sai preferire la speranza al pessimismo, se tu pensi che tocca a te fare il primo passo verso l’altro, se lo sguardo di un bambino riesce ancora a disarmare il tuo cuore, se tu sei capace di rallegrarti per la gioia del tuo vicino, se l’ingiustizia che colpisce gli altri ti indigna come quella subita da te, se per te lo straniero è un fratello che ti è stato donato, se tu sai offrire gratuitamente un po’ del tuo tempo per amore, se tu credi che un perdono vale più di una vendetta, se tu sei convinto che l’amore è la sola forza di persuasione, se tu credi che la pace è possibile …allora la pace verrà!.
Padre Eugenio Vittorio Di Giamberardi
prendi un sorriso
Prendi un sorriso, regalalo a chi non l’ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte. Scopri una sorgente, fa bagnare chi vive nel fango.
Prendi una lacrima, posala sul volto di chi non ha pianto.
Prendi il coraggio, mettilo nell’animo di chi non sa lottare.
Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla. Prendi la speranza, e vivi nella sua luce.
Prendi la bontà, e donala a chi non sa donare.
Scopri l’amore, e fallo conoscere al mondo.
Ciascuna grande religione del mondo è portatrice di valori universali che anche le altre confessioni di fede riconoscono.
Così, è possibile rivolgere tutti lo sguardo verso un unico grande orizzonte e collaborare per il bene dell’umanità anche se si appartiene a religioni diverse.
Osserva le fotografie e descrivi il valore che è rappresentato in ognuna di esse.


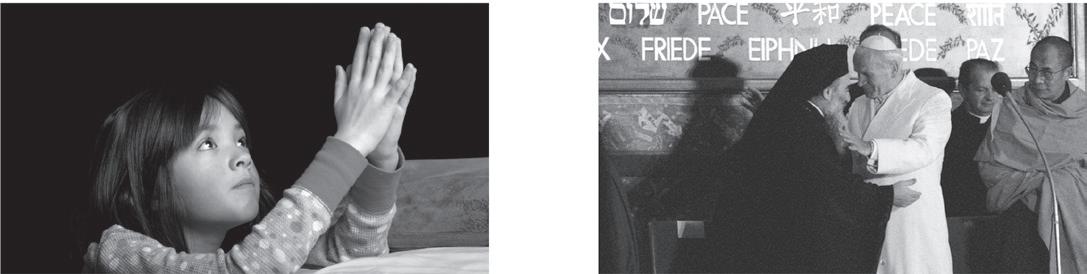
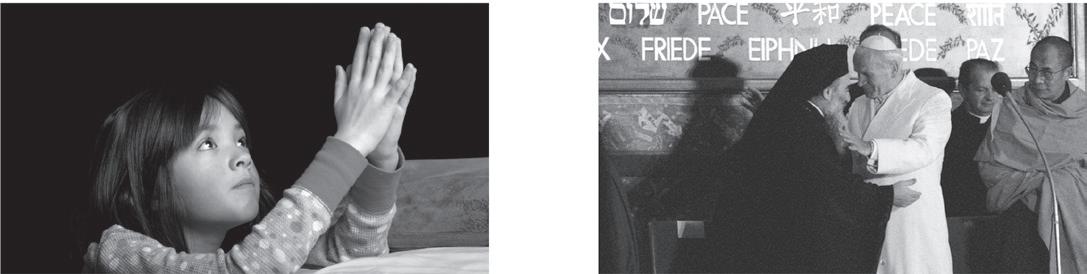
In tutte le religioni del mondo troviamo la cosiddetta “regola aurea”, cioè l’affermazione dell’importanza di una stessa realtà. Osserva questa immagine e leggi le scritte tratte dai testi di diverse religioni.
CRISTIANESIMO
INDIANI D’AMERICA
Non c’è nessuno che non sia mio amico.
Ama il prossimo tuo come te stesso.
CONFUCIANESIMO
Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te.
Aiutarsi a vicenda è la legge più importante di tutta la vita.
Ciò che procura dolore a te stesso non farlo al tuo fratello.
INDUISMO
Non fare agli altri ciò che causa dolore a te stesso. Augura al fratello quello che auguri a te stesso.
Ora, se dovessi scrivere tu questa “regola aurea” riassumendo quanto hai appena letto, cosa scriveresti?
Collega ogni elemento (simbolo e luogo di culto) alla religione a cui appartiene, utilizzando per ciascuna un colore diverso.





EBRAISMO
EBRAISMO
EBRAISMO
CRISTIANESIMO
CRISTIANESIMO
CRISTIANESIMO
ISLAMISMO
ISLAMISMO
ISLAMISMO
INDUISMO
INDUISMO
INDUISMO
BUDDHISMO
BUDDHISMO
BUDDHISMO

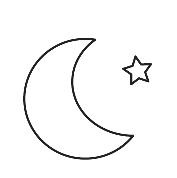


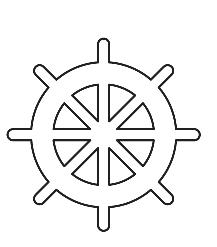
Ogni religione comprende una serie di precetti o di riti numericamente diversi l’uno dall’altro. Sai dire a quali numeri si riferiscono le domande del cruciverba? Se non conosci qualche risposta, puoi documentarti.
1. Il numero della Trinità.
2. Il numero dei nomi con i quali i musulmani pregano Allah.
3. Il numero delle vie buddhiste.
4. Il numero degli dèi che gli ebrei adorano oltre a Javhè.
5. Il numero dei precetti cristiani.
6. Il numero della stella di Davide, simbolo della religione ebraica.
7. Il numero inglese delle beatitudini.
8. Il numero dei comandamenti consegnati a Mosè.
9. Il numero degli anni durante i quali il popolo ebreo vagò nel deserto.
Completato il cruciverba, unisci le lettere che appaiono nelle caselle evidenziate e potrai leggere il cognome di un Papa. Scrivilo qui sotto.
Le religioni posseggono spesso simboli che rappresentano in sintesi il nucleo centrale della propria fede.
In questo gioco vi sono i simboli relativi alla religione cristiana (la croce), islamica (la mezzaluna), ebrea (la stella di Davide) e buddhista (l’ottuplice ruota).
Completa il sudoku con questi quattro simboli delle religioni. Fa’ in modo che in verticale, in orizzontale e all’interno dei quattro quadrati limitati dal segno grosso lo stesso simbolo compaia una sola volta.
Ritaglia le carte in duplice copia e gioca al memory con i simboli delle religioni del mondo.
Collega con una freccia il nome delle seguenti feste ebraiche alla relativa descrizione:
PASQUA - PENTECOSTE - ROSH HASHANAH - SUKKOTH
La festa nella quale si festeggia il primo giorno dell’anno.
La festa nella quale si mangia l’agnello.
La festa nella quale si festeggia il dono della Legge.
La festa nella quale si costruiscono capanne.
Sottolinea nei brani riportati il riferimento allo Sheol, poi commentali a parole tue.
SALMO 6
Pietà di me, Signore, sono sfinito; guariscimi, Signore: tremano le mie ossa. Trema tutta l’anima mia.
Ma tu, Signore, fino a quando?
Ritorna, Signore, libera la mia vita, salvami per la tua misericordia. Nessuno tra i morti ti ricorda.
Chi negli inferi canta le tue lodi?
Sono stremato dai miei lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, bagno di lacrime il mio letto.
I miei occhi nel dolore si consumano, invecchiano fra tante mie afflizioni.
Via da me, voi tutti che fate il male: il Signore ascolta la voce del mio pianto.
Il Signore ascolta la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera.
Si vergognino e tremino molto tutti i miei nemici, tornino indietro e si vergognino all’istante.
GIOBBE 17
I miei giorni passano, i miei piani e i miei sogni svaniscono. Gli uomini scambiano la notte con il giorno, dicono che la luce è più vicina delle tenebre.
Anche se spero, la mia dimora è nel mondo dei morti, là sarò disteso nell’oscurità.
Alla fossa ho detto:
“Tu sei mio padre!”, al verme ho detto:
“Tu mi sei madre e sorella”. Dove sei, ora, mia speranza?
Chi ti vedrà più?
Scenderai con me nel mondo dei morti, assieme finiremo nella polvere.
Osserva l’immagine della sinagoga ebrea e scrivi al posto giusto i nomi degli elementi che sono al suo interno:
Israele e la Palestina sono purtroppo spesso in lotta tra di loro. Colora le loro bandiere e scrivi nel mezzo il tuo messaggio di pace alle loro popolazioni.
Abbina ogni domanda alla risposta giusta colorando le caselle con il medesimo colore.
Il nome della divinità della religione musulmana è…
Il Corano è diviso in…
Maometto è stato portato al cospetto di Allah dall’…
La parola musulmano significa…
Colui che chiama i fedeli alla preghiera si chiama…
La persona che guida il culto è …
Maometto secondo l’Islam è…
I musulmani pregano ogni….
Il luogo sacro dell’ Islam è la… sottomissione. venerdì. l’imam. l’ultimo dei profeti. Allah. arcangelo Gabriele. 114 Sure. moschea. muezzin.
• Riassumi brevemente chi era Maometto.
• Descrivi il luogo di culto dei musulmani.
Riporta nei pilastri i cinque precetti dell’Islam con anche il nome in arabo.
Partendo da ciascuna espressione araba che definisce i cosiddetti “pilastri dell’Islam”, scopri di cosa si tratta seguendo le linee tracciate.
Quale tra i 5 pilastri ti sembra il più importante?
Illustralo qui accanto nel riquadro.




Osserva l’immagine dell’interno della moschea e scrivi al posto giusto i nomi degli elementi che sono al suo interno:
SALA DELLA PREGHIERA - LIBRO DEL CORANO - ABSIDE VERSO LA MECCA
PULPITO DELL’IMAM - TAPPETI - SCRITTA ESPOSTA DEL CORANO
Il TAPPETO è un oggetto rituale, spesso decorato, garantisce pulizia e delimita lo spazio durante le preghiere giornaliere (salat). Trova le 10 differenze tra questi due.
L’ ARABESCO è lo stile ornamentale ammesso dal Corano, mentre le immagini sacre sono vietate. Guarda questo esempio e inventane uno tu.
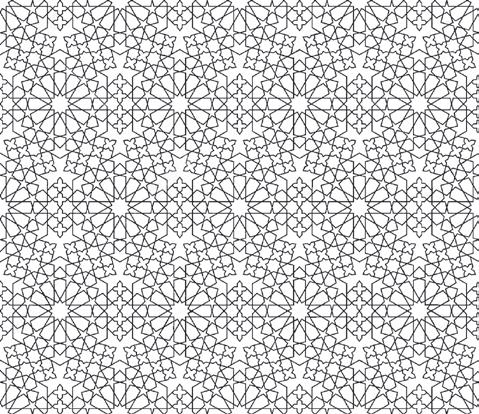
1 Chi ha dato origine all’Induismo?
I Greci I Romani Gli Arii
2 Come si chiama il Grande Essere induista?
Shiva Brahman Vishnu
3 Quali sono i testi sacri dell’Induismo?
Veda e Upanishad Corano Tripitaka
4 Come si chiama il tempio induista?
Moschea Pagoda Mandir
5 Chi è il ministro del culto?
Bramino Monaco Imam

Leggi le domande e colora il cartellino esatto.
• Descrivi il luogo di culto qui raffigurato.
• Che cos’è la reincarnazione?
Così Buddha spiega ai suoi monaci in cosa consiste l’ottuplice sentiero: «E cosa è mai, o monaci, questo sentiero di mezzo realizzato dal Perfettamente risvegliato che produce la visione e la gnosi, e che guida alla calma, alla perfetta conoscenza, al perfetto risveglio? Esso è il nobile ottuplice sentiero, ovvero la retta visione, la retta intenzione, la retta parola, la retta azione, il retto modo di vivere, il retto sforzo, la retta presenza mentale, la retta concentrazione».
Scrivi attorno all’immagine-simbolo dell’ottuplice sentiero le otto vie da praticare, individuandole nello scritto di Buddha che hai appena letto.
Secondo la tradizione il “nobile ottuplice sentiero” fu spiegato da Buddha all’età di 35 anni nel suo primo sermone tenuto al Parco delle gazzelle, vicino a Varanasi. A quale discorso di Gesù potrebbe essere paragonato e messo in confronto questo sermone, secondo te?
Così Buddha parlò ai suoi monaci delle cosiddette “quattro nobili verità”, elemento cardine della dottrina buddhista:
«O monaci, il Venerabile, il Perfettamente risvegliato, ha messo in moto presso Varanasi, nel Parco delle gazzelle, l’incomparabile ruota della Legge, che non può essere ostacolata da alcun asceta né da chiunque altro al mondo, la ruota della Legge, cioè l’annunciazione, l’esposizione, la dichiarazione, la manifestazione, la determinazione, la chiarificazione, l’esposizione dettagliata delle quattro nobili verità. E di quali quattro? Della nobile verità del dolore, della nobile verità dell’origine del dolore, della nobile verità della cessazione del dolore, della nobile verità della via che porta alla cessazione del dolore».
Attorno a quale termine ruotano tutte e quattro le verità? descrizione:
Perché, secondo te? Ripensa alla vita del giovane Siddharta, quando per la prima volta uscì dal suo palazzo.
Inserisci le seguenti parole mancanti nelle spiegazioni delle quattro nobili verità:
ELIMINARE - DESIDERIO - SENTIERO - UMANA
PRIMA VERITÀ: l’esistenza ............................ è caratterizzata dal dolore.
SECONDA VERITÀ: la sofferenza nasce dal ............................ .
TERZA VERITÀ: per sconfiggere la sofferenza bisogna ............................ ogni desiderio.
QUARTA VERITÀ: per eliminare ogni desiderio bisogna seguire l’ottuplice ............................ .
Per un confronto, in quale modo si parla del dolore in relazione a Gesù Cristo?
La città di Varanasi è collocata lungo il fiume Gange, in India, ed è considerata Città Sacra dagli induisti. Mediante 5 differenti scalinate di accesso al fiume, la gente compie le sue abluzioni fin dall’alba del giorno. Nel corso dei secoli milioni di induisti sono venuti a morire lungo la riva occidentale del Gange a Varanasi, poiché secondo l’induismo questo è l’unico posto della terra in cui gli dèi permettono agli uomini di sfuggire al “samsara”, cioè all’eterno ciclo di morte e rinascita

Scopri come sono chiamati questi accessi al fiume Gange mettendo nell’ordine indicato le seguenti lettere.
Spiega con parole tue analogie e differenze tra l’uso dell’acqua nelle seguenti tre differenti situazioni.
Molte famiglie indù conservano un flaconcino di acqua del sacro fiume nella propria casa. Conosci qualche pratica cristiana simile a questa?
Trova la risposta corretta alle domande qui elencate collegandola al riquadro corrispondente con una linea. Attento che vi sono anche delle risposte intruse.
Siddharta nasce a La Mecca.
Siddharta nasce a La Mecca.
Siddharta nasce a La Mecca.
Fuori dal palazzo incontra un viandante, uno straniero, un soldato e un monaco.
Fuori dal palazzo incontra un viandante, uno straniero, un soldato e un monaco.
Fuori dal palazzo incontra un viandante, uno straniero, un soldato e un monaco.
La vita è sofferenza, la causa della sofferenza è il desiderio, per eliminare la sofferenza basta non desiderare, il desiderio si elimina seguendo le otto regole (Ottuplice Sentiero).
La vita è sofferenza, la causa della sofferenza è il desiderio, per eliminare la sofferenza basta non desiderare, il desiderio si elimina seguendo le otto regole (Ottuplice Sentiero).
La vita è sofferenza, la causa della sofferenza è il desiderio, per eliminare la sofferenza basta non desiderare, il desiderio si elimina seguendo le otto regole (Ottuplice Sentiero).
• Chi era Siddharta Gautama?
• Chi era Siddharta Gautama?
Egli nacque nella località di Lumbini.
Egli nacque nella località di Lumbini.
Egli nacque nella località di Lumbini.
Siddharta capisce che esiste un solo e unico Dio.
Siddharta capisce che esiste un solo e unico Dio.
Siddharta capisce che esiste un solo e unico Dio.
Gli incontri cambiarono la visione della vita di Siddharta: il suo viaggio poi di meditazione lo portò alla scoperta del senso del vivere e delle quattro nobili verità.
Gli incontri cambiarono la visione della vita di Siddharta: il suo viaggio poi di meditazione lo portò alla scoperta del senso del vivere e delle quattro nobili verità.
Gli incontri cambiarono la visione della vita di Siddharta: il suo viaggio poi di meditazione lo portò alla scoperta del senso del vivere e delle quattro nobili verità.
• Cosa capì Siddharta dopo gli incontri?
• Cosa capì Siddharta dopo gli incontri?
• Chi era Siddharta Gautama?
• In quale città nacque?
• In quale città nacque?
• In quale città nacque?
• Quale fu la premonizione fatta alla famiglia?
• Quale fu la premonizione fatta alla famiglia?
• Quale fu la premonizione fatta alla famiglia?
• Quando a 29 anni esce dal palazzo chi incontra?
• Quando a 29 anni esce dal palazzo chi incontra?
• Quando a 29 anni esce dal palazzo chi incontra?
Dopo aver meditato a lungo Siddharta ha raggiunto l’illuminazione. È conosciuto con il nome di Buddha. Al padre fu predetto che la sua vita avrebbe potuto cambiare incredibilmente e diventare o un grande sovrano o un grande asceta.
Dopo aver meditato a lungo Siddharta ha raggiunto l’illuminazione. È conosciuto con il nome di Buddha. Al padre fu predetto che la sua vita avrebbe potuto cambiare incredibilmente e diventare o un grande sovrano o un grande asceta.
Dopo aver meditato a lungo Siddharta ha raggiunto l’illuminazione. È conosciuto con il nome di Buddha. Al padre fu predetto che la sua vita avrebbe potuto cambiare incredibilmente e diventare o un grande sovrano o un grande asceta.
• Cosa capì Siddharta dopo gli incontri?
• Quali sono le quattro nobili Verità?
• Quali sono le quattro nobili Verità?
• Quali sono le quattro nobili Verità?
• Come viene chiamato?
• Come viene chiamato?
• Come viene chiamato?
Nacque in una famiglia benestante: Siddharta era un principe.
Nacque in una famiglia benestante: Siddharta era un principe.
Nacque in una famiglia benestante: Siddharta era un principe.
La dottrina di Buddha si basa sui cinque pilastri.
La dottrina di Buddha si basa sui cinque pilastri.
La dottrina di Buddha si basa sui cinque pilastri.
Siddharta uscito dal palazzo incontrò un vecchio, un malato, un morto e un monaco.
Siddharta uscito dal palazzo incontrò un vecchio, un malato, un morto e un monaco.
Siddharta uscito dal palazzo incontrò un vecchio, un malato, un morto e un monaco.
Collega la risposta dei bambini alla domanda.
In quale luogo di culto si recano gli ebrei?
Dove si recano in pellegrinaggio gli induisti?
Come si chiama il libro sacro dei buddhisti?
Chi è il fondatore della religione cristiana?
Qual’è il luogo di pellegrinaggio per i musulmani?

Siracusa, III secolo - Siracusa, 13 dicembre 304
La vergine e martire Lucia è una delle figure più care alla devozione cristiana. Come ricorda il Messale Romano è una delle sette donne menzionate nel Canone Romano. Vissuta a Siracusa, sarebbe morta martire sotto la persecuzione di Diocleziano (intorno all’anno 304). Gli atti del suo martirio raccontano di torture atroci inflittele dal prefetto Pascasio, che non voleva piegarsi ai segni straordinari che attraverso di lei Dio stava mostrando. Proprio nelle catacombe di Siracusa, le più estese al mondo dopo quelle di Roma, è stata ritrovata un’epigrafe marmorea del IV secolo che è la testimonianza più antica del culto di Lucia. Una devozione diffusasi molto rapidamente: già nel 384 sant’Orso le dedicava una chiesa a Ravenna, papa
Onorio I poco dopo un’altra a Roma. Oggi in tutto il mondo si trovano reliquie di Lucia e opere d’arte a lei ispirate.
Patronato: Siracusa, ciechi, oculisti, elettricisti, contro le malattie degli occhi
Etimologia: Lucia = luminosa, splendente, dal latino
Emblema: Occhi su un piatto, Giglio, Palma, Libro del Vangelo
Martirologio Romano: Memoria di santa Lucia, vergine e martire, che custodì, finché visse, la lampada accesa per andare incontro allo Sposo e, a Siracusa in Sicilia condotta alla morte per Cristo, meritò di accedere con lui alle nozze del cielo e di possedere la luce che non conosce tramonto.
Le fonti più antiche e attendibili su Santa Lucia sono gli atti greci e latini degli inizi del V secolo: in particolare, la ricerca scientifica più recente in campo agiografico ha riabilitato l’autenticità della “Passio” latina, analizzandone con puntualità il testo e riscontrandone l’esattezza terminologica del linguaggio giuridico e la congruenza dei dati storici. Lucia nacque a Siracusa verso la fine del III secolo, da una nobile famiglia cristiana. Sin da fanciulla, si consacrò segretamente a Dio con voto di perpetua verginità, ma – secondo le consuetudini dell’epoca – venne promessa in sposa a un pretendente, invaghito per la sua straordinaria bellezza. Un giorno Lucia propose alla madre, di nome Eutichia, di recarsi insieme a lei in pellegrinaggio nella vicina città di Catania, presso il sepolcro dell’illustre vergine martire Sant’Agata, per domandare a Dio la grazia della guarigione della stessa Eutichia, da molto tempo gravemente ammalata. Giunte in quel luogo il 5 febbraio dell’anno 301, pregarono intensamente fino alle lacrime implorando il miracolo. Lucia consigliò alla madre di toccare con fede la tomba della santa patrona di Catania, confidando nella sua sicura intercessione presso il Signore. Ed ecco, Sant’Agata apparve in visione a Lucia dicendole: “Sorella mia Lucia, vergine consacrata a Dio, perché chiedi a me ciò che tu stessa puoi ottenere per tua madre? Ecco che, per la tua fede, ella è già guarita! E come per me è beneficata la città di Catania, così per te sarà onorata la città di Siracusa”. Subito dopo la visione, Eutichia constatò l’effettiva avvenuta guarigione miracolosa, e Lucia decise di rivelare alla madre il proprio desiderio di donare tutta la propria vita a Dio, rinunciando a uno sposo terreno ed elargendo tutte le proprie ricchezze ai poveri, per amore di Cristo.
Così Lucia da ricca che era si fece povera, e per circa tre anni si dedicò senza interruzione alle opere di misericordia d’ogni genere, a vantaggio dei poveri, degli orfani, delle vedove, degli infermi e dei ministri della Chiesa di Dio.
Ma colui che l’aveva pretesa come sposa, si vendicò del rifiuto denunciando Lucia al locale tribunale dell’impero romano, con l’accusa che ella fosse “cristianissima” (sic), poiché infieriva la crudele persecuzione anti-cristiana dell’imperatore Diocleziano. Arrestata, rifiutò con coraggiosa fermezza di sacrificare agli dèi pagani, e quindi venne processata dal magistrato Pascasio. Ella rispose senza timore, quasi esclusivamente citando la Sacra Scrittura. Il testo dell’interrogatorio è un vero capolavoro di ricorso alla parola biblica. Per giustificare la propria obiezione di coscienza contro l’ordine di sacrificare agli dèi, Lucia citò l’epistola dell’apostolo Giacomo: “Sacrificio puro presso Dio è soccorrere i poveri, gli orfani e le vedove. Per tre anni ho offerto tutto al mio Dio. Ora non ho più nulla, e offro me stessa”. Per testimoniare la sua serena fortezza dinanzi al magistrato, citò l’evangelista Matteo: “Sono la serva del Dio eterno, il quale ha detto: quando sarete trascinati dai giudici, non preoccupatevi di cosa dire, perché non sarete voi a parlare, ma parlerà in voi lo Spirito Santo”. Per confermare il sostegno da lei trovato nello Spirito Santo, citò la seconda lettera di Paolo ai corinzi: “Coloro che vivono in santità e castità sono tempio di Dio e lo Spirito Santo abita in essi”. Per affermare che era la potenza di Dio a proteggerla dalle minacce di violenza che la circondavano, citò il salmista: “Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire”. Rimasta miracolosamente illesa da crudeli supplizi, profetizzò l’imminente fine delle persecuzioni di Diocleziano e la pace per la Chiesa, dopo di che morì con un colpo di spada in gola e venne devotamente sepolta nelle grandi catacombe cristiane della sua Siracusa. Era il 13 dicembre dell’anno 304. Da allora, il suo culto si diffuse ben presto in tutta la Chiesa, e ancora oggi Santa Lucia è certamente tra i santi più popolari, più amati e più venerati nel mondo.
Autore: Carlo Fatuzzo
Gli atti del martirio di Lucia di Siracusa sono stati rinvenuti in due antiche e diverse redazioni: l’una in lingua greca il cui testo più antico risale al sec. V (allo stato attuale delle ricerche); l’altra, in quella latina, riconducibile alla fine del sec. V o agli inizi del sec. VI ma comunque anteriore al sec. VII e che di quella greca pare essere una traduzione. La più antica redazione greca del martirio contiene una leggenda agiografica edificante, rielaborata da un anonimo agiografo due secoli dopo il martirio sulla tradizione orale e dalla quale è ardua impresa sceverare dati storici. Infatti, il documento letterario vetustiore che ne tramanda la memoria è proprio un racconto del quale alcuni hanno messo addirittura in discussione l’attendibilità. Si è giunti così, a due opposti risultati: l’uno è quello di chi l’ha strenuamente difesa, rivalutando sia la storicità del martirio sia la legittimità del culto; l’altro è quello di chi l’ha del tutto biasimata, reputando la narrazione una pura escogitazione fantasiosa dell’agiografo ma non per questo mettendo in discussione la stessa esistenza storica della Santa, come sembrano comprovare le numerose attestazioni devozionali, cultuali e culturali in suo onore.
Sia la redazione in greco sia quella in latino degli atti del martirio hanno avuto da sempre ampia e ben articolata diffusione, inoltre entrambe si possono considerare degli archetipi di due differenti ‘rami’ della tradizione: infatti, dal testo in greco sembrano derivare numerose rielaborazioni in lingua greca, quali le Passiones più tardive, gli Inni, i Menei, ecc.; da quello in latino sembrano, invece, mutuare le Passiones metriche, i Resumé contenuti nei Martirologi storici, gli Antifonari, le Epitomi comprese in più vaste opere, come ad es. nello Speculum historiale di Vincenzo da Beauvais o nella Legenda aurea di Iacopo da Varazze. I documenti rinvenuti sulla Vita e sul martirio sono vicini al genere delle passioni epiche in quanto i dati attendibili sono costituiti solo dal luogo e dal dies natalis. Infatti, negli atti greci del martirio si riscontrano elementi che appartengono a tutta una serie di composizioni agiografiche martiriali, come ad es. l’esaltazione delle qualità sovrumane della martire e l’assenza di ogni cura per l’esattezza storica. Tuttavia, tali difetti, tipici delle passioni agiografiche, nel testo greco di Lucia sono temperate e non spinte all’eccesso né degenerate nell’abuso. Proprio questi particolari accostano gli atti greci del martirio al genere delle passioni epiche. Sul piano espositivo l’andamento è suggestivo ed avvincente, non mancando di trasmettere al lettore emozioni e resoconti agiografici inconsueti attraverso un racconto che si snoda su un tessuto narrativo piuttosto ricco di temi e motivi di particolare rilievo: il pellegrinaggio alla tomba di Agata (con il conseguente accostamento Agata/Lucia e Catania/Siracusa); il sogno, la visione, la profezia e il miracolo; il motivo storico; l’integrità del patrimonio familiare; la lettura del Vangelo sull’emorroissa; la vendita dei beni materiali, il Carnale mercimonium e la condanna alla prostituzione. Infatti è stretta la connessione tra la dissipazione del patrimonio familiare e la prostituzione per cui la condanna al postrìbolo rappresenta una legge di contrappasso sicché la giovane donna che ha dilapidato il patrimonio familiare è ora condannata a disperdere pure l’altro patrimonio materiale, rappresentato dal proprio corpo attraverso un’infamante condanna, direttamente commisurata alla colpa commessa; infine, la morte. Il martirio incomincia con la visita di Lucia assieme alla madre Eutichia, al sepolcro di Agata a Catania, per impetrare la guarigione dalla malattia da cui era affetta la madre: un inarrestabile flusso di sangue dal quale non era riuscita a guarire neppure con le dispendiose cure mediche, alle quali si era sottoposta. Lucia ed Eutichia partecipano alla celebrazione eucaristica durante la quale ascoltano proprio la lettura evangelica sulla guarigione di un’emorroissa. Lucia, quindi, incita la madre ad avvicinarsi al sepolcro di Agata e a toccarlo con assoluta fede e cieca fiducia nella guarigione miracolosa per intercessione della potente forza dispensatrice della vergine martire. Lucia, a questo punto, è presa da un profondo sonno che la conduce ad una visione onirica nel corso della quale le appare Agata che, mentre la informa dell’avvenuta guarigione della madre le predice pure il suo futuro martirio, che sarà la gloria di Siracusa così come quello di Agata era stato la gloria di Catania. Al ritorno dal pellegrinaggio, proprio sulla via che le riconduce a Siracusa, Lucia comunica alla madre la sua decisione vocazionale: consacrarsi a Cristo! A tale fine le chiede pure di potere disporre del proprio patrimonio per devolverlo in beneficenza. Eutichia, però, non vuole concederle i beni paterni ereditati alla morte del marito, avendo avuto cura non solo di conservarli orgogliosamente intatti e integri ma di accrescerli pure in modo considerevole. Le rispon-
de, quindi, che li avrebbe ereditati alla sua morte e che solo allora avrebbe potuto disporne a suo piacimento. Tuttavia, proprio durante tale viaggio di ritorno, Lucia riesce, con le sue insistenze, a convincere la madre, la quale finalmente le dà il consenso di devolvere il patrimonio paterno in beneficenza, cosa che la vergine avvia appena arrivata a Siracusa. Però, la notizia dell’alienazione dei beni paterni arriva subito a conoscenza del promesso sposo della vergine, che se ne accerta proprio con Eutichia alla quale chiede anche i motivi di tale imprevista quanto improvvisa vendita patrimoniale. La donna gli fa credere che la decisione era legata ad un investimento alquanto redditizio, essendo la vergine in procinto di acquistare un vasto possedimento destinato ad assumere un alto valore rispetto a quello attuale al momento dell’acquisto e tale da spingerlo a collaborare alla vendita patrimoniale di Lucia. In seguito il fidanzato di Lucia, forse esacerbato dai continui rinvii del matrimonio, decide di denunciare al governatore Pascasio la scelta cristiana della promessa sposa, la quale, condotta al suo cospetto è sottoposta al processo e al conseguente interrogatorio. Durante l’agone della santa e vittoriosa martire di Cristo Lucia, emerge la sua dichiarata e orgogliosa professione di fede nonché il disprezzo della morte, che hanno la caratteristica di essere arricchiti sia di riflessioni dottrinarie sia di particolari sempre più cruenti, man mano che si accrescono i supplizi inflitti al fine di esorcizzare la vergine e martire dalla possessione dello Spirito Santo. Dopo un interrogatorio assai fitto di scambi di battute che la vergine riesce a controbattere con la forza e la sicurezza di chi è ispirato da Cristo, il governatore Pascasio le infligge la pena del postrìbolo proprio al fine di operare in Lucia una sorta di esorcismo inverso allontanandone lo Spirito Santo. Mossa dalla forza di Cristo, la vergine Lucia reagisce con risposte provocatorie, che incitano Pascasio ad attuare subito il suo tristo proponimento. La vergine, infatti, energicamente gli dice che, dal momento che la sua mente non cederà alla concupiscenza della carne, quale che sia la violenza che potrà subire il suo corpo contro la sua volontà, ella resterà comunque casta, pura e incontaminata nello spirito e nella mente. A questo punto si assiste ad un prodigioso evento: la vergine diventa inamovibile e salda sicché, nessun tentativo riesce a trasportarla al lupanare, nemmeno i maghi appositamente convocati dallo spietato Pascasio. Esasperato da tale straordinario evento, il cruento governatore ordina che sia bruciata, eppure neanche il fuoco riesce a scalfirla e Lucia perisce per spada! Sicché, piegate le ginocchia, la vergine attende il colpo di grazia e, dopo avere profetizzato la caduta di Diocleziano e Massimiano, è decapitata. Pare che Lucia abbia patito il martirio nel 304 sotto Diocleziano ma vi sono studiosi che propendono per altre datazioni: 303, 307 e 310. Esse sono motivate dal fatto che la profezia di Lucia contiene elementi cronologici divergenti che spesso non collimano fra loro: per la pace della chiesa tale profezia si dovrebbe riferire al primo editto di tolleranza nei riguardi del cristianesimo e quindi sarebbe da ascrivere al 311, collegabile, cioè, all’editto di Costantino del 313; l’abdicazione di Diocleziano avvenne intorno al 305; la morte di Massimiano avvenne nel 310. È, invece, accettata dalla maggioranza delle fonti la data relativa al suo dies natalis: 13 dicembre. Eppure, il Martirologio Geronimiano ricorda Lucia di Siracusa in due date differenti: il 6 febbraio e il 13 dicembre. L’ultima data ricorre in tutti i successivi testi liturgici bizantini e occidentali, tranne nel calendario mozarabico, che la celebra, invece, il 12 dicembre. Nel
misterioso calendario latino del Sinai il dies natalis di Lucia cade l’8 febbraio: esso fu redatto nell’Africa settentrionale e vi è presente un antico documento della liturgia locale nel complesso autonoma sia dalla Chiesa di Costantinopoli che da quella di Roma, pur rivelando fonti comuni al calendario geronimiano.
Assai diffusa è a tutt’oggi la celebrazione del culto di Lucia quale santa patrona degli occhi. Ciò sembra suffragato anche dalla vasta rappresentazione iconografica, che, tuttavia, è assai variegata, in quanto nel corso dei secoli e nei vari luoghi si è arricchita di nuovi simboli e di varie valenze. Ma è stato sempre così? Quando nasce in effetti questo patronato e perché? Dal Medioevo si va sempre più consolidando la taumaturgia di Lucia quale santa patrona della vista e dai secc. XIV-XV si fa largo spazio un’innovazione nell’iconografia: la raffigurazione con in mano un piattino (o una coppa) dove sono riposti i suoi stessi occhi. Come si spiega questo tema? È, forse, passato dal testo orale all’iconografia? Oppure dall’iconografia all’elaborazione orale? Quale l’origine di un tale patronato? Esso è probabilmente da ricercare nella connessione etimologica e/o paretimologica di Lucia a lux, molto diffusa soprattutto in testi agiografici bizantini e del Medioevo Occidentale. Ma, quali i limiti della documentazione e quali le cause del proliferare della tradizione relativa all’iconografia di Lucia, protettrice della vista? Si può parlare di dilatazione dell’atto di lettura nell’immaginario iconografico, così come in quello letterario? E tale dilatazione nei fenomeni religiosi è un atto di devozione e fede? È pure vero che la semantica esoterica data al nome della santa di Siracusa è la caratteristica che riveste, accendendola di intensa poesia, la figura e il culto di Lucia, la quale diventa, nel corso dei secoli e nei vari luoghi una promessa di luce, sia materiale che spirituale. E proprio a tale fine l’iconografia, già a partire dal sec. XIV, si fa interprete e divulgatrice di questa leggenda, raffigurando la santa con simboli specifici e al tempo stesso connotativi: gli occhi, che Lucia tiene in mano (o su un piatto o su un vassoio), che si accompagnano sovente alla palma, alla lampada (che è anche uno dei simboli evangelici più diffuso e più bello, forse derivato dall’arte sepolcrale) e, meno frequenti, anche ad altri elementi del suo martirio, come ad es. il libro, il calice, la spada, il pugnale e le fiamme. È anche vero che le immagini religiose possono essere intese sia come ritratti che come imitazione ma non bisogna dimenticare che prima dell’età moderna sono mancati riferimenti ai suoi dati fisiognomici, per cui gli artisti erano soliti ricorrere alla letteratura agiografica il cui esempio per eccellenza è proprio la Legenda Aurea di Iacopo da Varazze, che rappresenta il testo di riferimento e la fonte di gran parte dell’iconografia religiosa. In tale opera il dossier agiografico di Lucia -che si presenta come un testo di circa tre pagine di lunghezza- è preceduto da un preambolo sulle varie valenze etimologiche e semantiche relative all’accostamento Lucia/luce: Lucia è un derivato di luce esteso anche al valore simbolico di Via Lucis, cioè “cammino di luce”. I genitori di Lucia, essendo cristiani, avrebbero scelto per la figlia un nome evocatore della luce, ispirandosi ai molti passi neotestamentari sulla luce. Tuttavia, il nome Lucia in sé non è prerogativa cristiana, ma è anche il femminile di un nome latino comune e ricorrente tra i pagani. Se poi Lucia significhi solo «luce» oppure più precisamente riguarda i «nati al sorger della luce (cioè all’alba)», rivelando nel contempo anche un dettaglio sull’ora di nascita della santa, è a tutt’oggi, un problema aperto. Forse la questione è destinata a restare insoluta? Il
problema si complica se poi si lega il nome di Lucia non al giorno della nascita ma a quello della morte (= dies natalis): il 13 dicembre era, effettivamente, la giornata dell’anno percentualmente più buia. Per di più, intorno a quella data, il paganesimo romano festeggiava già una dea di nome Lucina. Queste situazioni hanno contribuito ad alimentare varie ipotesi riconducibili, tuttavia, a due filoni: da un lato quello dei sostenitori della teoria, secondo la quale tutte le festività cristiane sarebbero state istituite in luogo di preesistenti culti pagani, vorrebbero architettata in tale modo anche la festa di Lucia (come già quella di Agata). Per i non credenti tale discorso può anche essere suggestivo e accattivante, trovando terreno fertile. Da qui a trasformare la persona stessa di Lucia in personaggio immaginifico, mitologico, leggendario e non realmente esistito, inventato dalla Chiesa come calco cristiano di una preesistente divinità pagana, il passo è breve (persino più breve delle stesse già brevi e pallide ore di luce di dicembre!). Dall’altro lato quello dei credenti, secondo i quali, invece, antichi e accertati sono sia l’esistenza sia il culto di Lucia di Siracusa, che rappresenta così una persona storicamente esistita, morta nel giorno più corto dell’anno e che riflette altresì il modello femminile di una giovane donna cristiana, chiamata da Dio alla verginità, alla povertà e al martirio, che tenacemente affronta tra efferati supplizi.
Nel Breviario Romano Tridentino, riformato da papa Pio X (ed. 1914), che prima di salire al soglio pontificio era patriarca di Venezia, è menzionata la traslazione delle reliquie di Lucia alla fine della lettura agiografica, così come ha evidenziato Andreas Heinz nel suo recente contributo.
A Siracusa un’inveterata tradizione popolare vuole che, dopo avere esalato l’ultimo respiro, il corpo di Lucia sia stato devotamente tumulato nello stesso luogo del martirio. Infatti, secondo la pia devozione dei suoi concittadini, il corpo della santa fu riposto in un arcosolio, cioè in una nicchia ad arco scavata nel tufo delle catacombe e usata come sepolcro. Fu così che le catacombe di Siracusa, che ricevettero le sacre spoglie della Santa, presero da lei anche il nome e ben presto attorno al suo sepolcro si sviluppò una serie numerosa di altre tombe, perché tutti i cristiani volevano essere tumulati accanto all’amatissima Lucia. Ma, nell’878 Siracusa fu invasa dai Saraceni per cui i cittadini tolsero il suo corpo da lì e lo nascosero in un luogo segreto per sottrarlo alla furia degli invasori. Ma, fino a quando le reliquie di Lucia rimasero a Siracusa prima di essere doppiamente traslate (da Siracusa a Costantinopoli e da Costantinopoli a Venezia)? Fino al 718 o fino al 1039? È certo che a Venezia il suo culto era già attestato dal Kalendarium Venetum del sec. XI, nei Messali locali del sec. XV, nel Memoriale Franco e Barbaresco dell’inizio del 1500, dove era considerata festa di palazzo, cioè festività civile. Durante la crociata del 1204 i Veneziani lo trasportarono nel monastero di San Giorgio a Venezia ed elessero santa Lucia compatrona della città. In seguito le dedicarono pure una grande chiesa, dove il corpo fu conservato fino al 1863, quando questa fu demolita per la costruzione della stazione ferroviaria (che per questo si chiama Santa Lucia); il corpo fu trasferito nella chiesa dei SS. Geremia e Lucia, dove è conservato tutt’oggi.
La duplice traslazione delle reliquie di Lucia è attestata da due differenti tradizioni. La prima tradizione risale al sec. X ed è costituita da una relazione, coeva ai fatti, che Sige-
berto di Gembloux († 1112) inserì nella biografia di Teodorico, vescovo di Metz. Tale relazione tramanda che il vescovo Teodorico, giungendo in Italia insieme all’imperatore Ottone II, abbia trafugato molte reliquie di santi –fra cui anche quella della nostra Lucia- che allora erano nell’Abruzzo e precisamente a Péntima (già Corfinium). La traslazione a Metz delle reliquie di Lucia pare suffragata dagli Annali della città dell’anno 970 d.C. Ma alcuni dubbi sembrano non avere risposte attendibili: Come e perché Faroaldo ripose le reliquie o le spoglie di Lucia a Corfinium? Furono traslate le reliquie o tutto il corpo della martire? Il vescovo locale si prestò ad un inganno (pio e devoto?) o diceva il vero? Se è ravvisabile un fondo di verità nel racconto del vescovo, allora si potrebbe desumere che le reliquie o il corpo della martire furono traslate da Siracusa nel 718 (quindi fino al 718 sarebbero rimaste a Siracusa?). Cosa succedeva allora nella città siciliana? Sergio, governatore della Sicilia, si era ribellato all’imperatore Leone III l’Isaurico e pertanto era stato costretto a fuggire da Siracusa e a rifugiarsi da Romualdo II, duca longobardo di Benevento. Se questa tradizione è attendibile, si può forse pensare che il vescovo di Corfinium (o piuttosto Sigeberto? Oppure altresì la sua fonte?) abbia confuso Romualdo (che proprio in quel periodo era duca di Spoleto e che, come tale, godeva di una fama maggiore) con Faroaldo? E ancora, lo stesso Sigeberto di Gembloux riferisce che Teoderico nel 972 abbia innalzato un altare in onore di Lucia e che nel 1042 un braccio della Santa sia stato donato al monastero di Luitbourg. Quindi, antichi documenti attestano che di fatto vi fu una traslazione delle reliquie di Lucia dall’Italia centrale a Metz, sulla frontiera linguistica romano-germanica, nella provincia di Treviri. Situata fra Germania e Francia, questa regione è anche il paese d’origine della dinastia carolingia. È una casualità? Come andarono effettivamente le cose? Secondo Sigeberto di Gembloux l’imperatore Ottone II sostò in Italia nel 970, avendo tra la sua scorta il vescovo Teodorico di Metz, il quale, durante il suo soggiorno, acquistava preziose reliquie, allo scopo di accrescere la fama della sua città vescovile. Pare che uno dei suoi preti, di nome Wigerich, che era anche cantore nella cattedrale di Metz, abbia rinvenuto le reliquie di Lucia di Siracusa, a Corfinium, poi identificata con Péntima in Abruzzo. Si dice che tali reliquie erano state prelevate dai Longobardi e trasportate da Siracusa al ducato di Spoleto. Ma perché questo spostamento? In un primo tempo le reliquie di Lucia, dopo essere state acquistate dal vescovo Teodorico di Metz, il quale aveva portato dall’Italia anche il corpo del martire Vincenzo, furono tumulate assieme alle reliquie di quest’ultimo al quale il vescovo aveva fatto erigere un’abbazia sull’isola della Mosella, dove nel 972 uno dei due altari della chiesa dell’abbazia, fu dedicato proprio a Lucia, come patrona. Sigeberto ricorda pure che Teodorico di Metz, in presenza di due vescovi di Treviri e precisamente di Gerard di Toul e di Winofid di Verdun, abbia dedicato a Lucia un oratorio nello stesso anno. Non solo, ma tanta e tale era dunque la devozione di Teodorico di Metz per la Santa di Siracusa che fece tumulare il conte Everardo, suo giovane nipote, prematuramente scomparso alla tenera età di soli dieci anni, proprio innanzi all’altare di Lucia. Per tutto il tempo in cui le spoglie di Lucia rimasero nella chiesa dell’abbazia di S. Vincenzo nella Mosella, la Santa di Siracusa fu implorata durante i giorni delle Regazioni, con una grande processione della cittadinanza di Metz che si fermò proprio nell’abbazia di S. Vincenzo. Così Metz divenne il fulcro da cui si irradiò ben presto il culto di Lucia tanto che già nel 1042 l’im-
peratore Enrico III reclamò alcune reliquie della Santa di Siracusa per il convento nuovamente fatto erigere dalla sua famiglia nella diocesi di Speyer e precisamente a Lindeburch/Limburg.
La seconda tradizione è, invece, tramandata da Leone Marsicano e dal cronista Andrea Dandolo di Venezia. Leone Marsicano racconta che nel 1038 il corpo di Lucia, vergine e martire, fu trafugato da Giorgio Maniace e traslato a Costantinopoli in una teca d’argento. Andrea Dandolo, esponendo la conquista di Costantinopoli del 1204 da parte dei Crociati, tra i quali militava anche Enrico Dandolo, un suo illustre antenato e doge di Venezia, informa che i corpi di Lucia e Agata erano stati traslati dalla Sicilia a Costantinopoli ma che quello di Lucia fu poi nuovamente traslato da Costantinopoli a Venezia, dove pare che di fatto giunse il 18 gennaio 1205. Quindi, la traslazione delle reliquie di Lucia a Venezia da Costantinopoli sembra legata agli eventi della Quarta Crociata (quella riconducibile al periodo che va dal 1202 al 1204), quando i cavalieri dell’Occidente latino, piuttosto che liberare la Terrasanta, spogliarono la metropoli dell’Oriente cristiano. Infatti, nel 1204, in seguito alla profanazione e al saccheggio dei crociati nelle basiliche di Bisanzio, neanche la chiesa in cui riposava il corpo di Lucia fu risparmiata da questa oltraggiosa strage tanto che furono pure rimosse le sue spoglie e contese le sue reliquie, molto venerate nell’Oriente ortodosso. Pare che proprio in tale occasione Venezia, che aveva condotto la Quarta Crociata presso il Santo Sepolcro, si impadronì delle reliquie di Lucia, le quali si dice giungessero nella laguna, nella chiesa di S. Giorgio Maggiore, il 18 gennaio 1205 - ancora prima della costruzione della basilica del Palladio e dell’attuale Palazzo Ducale. Il corpo di Lucia fu riposto nel monastero benedettino, dove aveva soggiornato il monaco Gerardo (o Sagredo?). Sembra che il tragico evento del 13 dicembre del 1279 (cioè una bufera scatenatasi all’improvviso, che provocò molte vittime) sia stato la causa di una nuova traslazione del corpo di Lucia dalla chiesa di S. Giorgio Maggiore a Venezia (eccetto, pare, un pollice - non un braccio, come vuole la communis opinio - che sarebbe rimasto in San Giorgio). Dopo tale tragedia, infatti, le autorità decisero di traslare il corpo di Lucia in città, ponendolo in una chiesa parrocchiale a lei intitolata e ciò allo scopo di agevolare a piedi il pellegrinaggio alle sue sacre spoglie in terraferma senza dovere ricorrere ad imbarcazioni. Quindi, nel mese seguente alla sciagura e precisamente il 18 gennaio del 1280 (lo stesso giorno della memoria dell’arrivo delle sacre spoglie di Lucia da Costantinopoli), il suo corpo fu traslato nella chiesa dedicatale, che si trovava nello stesso luogo in cui era ubicata la stazione ferroviaria che, ancora oggi ne conserva la memoria nel nome e precisamente sulle fondamenta prospicienti il Canal Grande e cioè all’inizio del sestiere di Cannareggio. Tale chiesa fu poi riedificata nel 1313 e fu assegnata dal papa Eugenio IV nel 1444 in commenda alle suore domenicane, che avevano aperto il loro convento intitolato al Corpus Domini, un cinquantennio prima sempre a Cannareggio. Nel 1476, dopo circa un trentennio di contese, si raggiunse un accordo tra le monache domenicane del convento del Corpus Domini e quelle agostiniane del monastero dell’Annunziata proprio per il possesso del corpo di Lucia: papa Sisto IV nel 1478 stabilì, con un solenne diploma, che il corpo della santa rimanesse nella chiesa a lei intestata sotto la giurisdizione delle agostiniane del monastero dell’Annunziata (che da allora prese il nome di monastero di S. Lucia), le quali ogni anno avrebbero
offerto la somma di 50 ducati alle monache domenicane del convento del Corpus Domini. Nel 1579 passando per il Dominio veneto l’imperatrice Maria d’Austria, il Senato volle farle omaggio di una reliquia di s. Lucia pertanto, con l’assistenza del patriarca Giovanni Trevisan fu asportata una piccola porzione di carne dal lato sinistro del corpo della Santa, Il 28 luglio del 1806 per decreto vicereale il monastero di Santa Lucia fu soppresso e le monache agostiniane costrette a trasferirsi al di là del Canal Grande e precisamente nel monastero di S. Andrea della Girada, dove portarono pure il corpo di Lucia. Nel 1807 il governo vicereale concesse alle agostiniane di S. Lucia di far ritorno nel loro antico convento, che, tuttavia, trovarono occupato dalle agostiniane di Santa Maria Maddalena, le quali si fusero con quelle di S. Lucia, assumendone anche il titolo. Nel 1810 Napoleone Bonaparte decretò la chiusura di tutti i monasteri e conventi, compreso quello di S. Lucia, le cui monache furono pure obbligate a deporre l’abito monastico e a rientrare nella propria famiglia di appartenenza. Il corpo di Lucia rimase nella sua chiesa, che fu così inserita nella circoscrizione della parrocchia di S. Geremia. Nel 1813 il convento di S. Lucia era donato dall’imperatore d’Austria alla b. Maddalena di Canossa, che vi abitò fino al 1846, quando iniziarono i lavori per la stazione ferroviaria e per la demolizione del convento. Fra il 1844 e il 1860 il governo austriaco realizzò la costruzione del ponte ferroviario, che doveva giungere fino alle fondamenta di Cannareggio e cioè proprio là dove da secoli allogavano i monasteri delle domenicane del Corpus Domini e delle agostiniane di Santa Lucia, poi abbattuti. Il corpo di Lucia l’11 luglio 1860 subì, quindi, una nuova traslazione nella parrocchia di S. Geremia, per volere del patriarca Angelo Ramazzotti: il sacro corpo rimase sette giorni sull’altar maggiore, poi fu posto su un altare laterale in attesa di costruire la nuova cappella. Tre anni dopo, l’11 luglio 1863, fu inaugurata: essa era stata costruita con il materiale del presbiterio della demolita chiesa di S. Lucia su gusti palladiani. Per la generosità di monsignor Sambo, parroco di quella Chiesa (che nel frattempo assunse la denominazione SS. Geremia e Lucia) su disegno dell’architetto Gaetano Rossi fu allestito un altare più degno in broccatello di Verona con fregi di bronzo dorato. Quindi, dal 1860 Pio IX l’avrebbe fatto trasferire nella chiesa dei Santi Geremia e Lucia, dove si venera a tutt’oggi. Qui, la cappella del corpo di santa Lucia è assai bella e artistica proprio come tutte le chiese di Venezia, adorna di marmi e di bronzi, ed è sempre stata oggetto di particolari cure ed elevata devozione di fedeli sempre più numerosi. Il sacro corpo, elevato sopra l’altare, è conservato in una elegante urna di marmi preziosi, superbamente abbellita da pregiate decorazioni e sormontata dalla stupenda statua della vergine. Sulla parete di sfondo si leggono due iscrizioni, che raccontano le vicende della traslazione e delle principali solenni festività. Il 15 giugno del 1930 il patriarca Pietro La Fontaine lo consacrava e collocava il corpo incorrotto di Lucia nella nuova urna in marmo giallo ambrato. Nel 1955 il patriarca Angelo Roncalli -divenuto poi papa con il nome di Giovanni XXIII- volendo che fosse conferita più importanza alle sacre reliquie di Lucia, suggerì che le sacre spoglie fossero ricoperte di una maschera d’argento, curata dal parroco Aldo Da Villa. Nel 1968, per iniziativa del parroco Aldo Fiorin fu portato a compimento un completo restauro della Cappella e dell’Urna della martire. Ancor oggi le sacre reliquie riposano nel tempio di Venezia e nella bianca curva absidale si legge un inciso propiziatorio: Vergine di Siracusa martire di Cristo in questo tempio riposa all’Italia al
mondo implori luce e pace. Ma, il 4 aprile 1867 le spoglie di Lucia furono disgraziatamente profanate dai ladri (subito arrestati), che furtivamente si erano introdotti nella chiesa di S. Geremia, per impadronirsi degli ornamenti votivi. Da allora seguirono altre profanazioni e spoliazioni: nel 1949, quando alla martire fu sottratta la corona (anche in questo caso il ladro fu arrestato) e nel 1969, quando due ladri infransero il cristallo dell’urna. Nel 1975 papa Giovanni Paolo I concesse che il corpo della martire fosse portato ed esposto alla venerazione dei fedeli nella diocesi di Pesaro per una settimana. Il 7 novembre 1981 due aggressori spezzarono l’urna della martire estraendovi il corpo e lasciandovi il capo e la maschera argentea. Anche questa volta il corpo fu recuperato proprio il 12 dicembre del 1981, giorno della vigilia della commemorazione della santa.
Esiste una variante sulla traslazione del corpo di Lucia a Venezia, documentata da un codice del Seicento, o Cronaca Veniera, conservato nella Biblioteca Marciana di Venezia: esso sarebbe stato portato a Venezia, assieme a quello di S. Agata, nel 1026, sotto il dogado di Pietro Centranico. Non conosciamo l’origine della notizia nè se derivi da una fonte anteriore. È diffuso, invece, il fondato sospetto di un errore meccanico di amanuense, che avrebbe letto 1026 invece di 1206, cioè gli anni dell’effettiva translatio. E nella Cronaca Veniera lo si accettò, legando il fatto al doge dell’epoca. La presenza del corpo di Lucia a Venezia sin dal 1026 è una notizia che va accolta con prudenza? Tra il 1167 e il 1182 a Venezia esisteva già una chiesa dedicata alla martire, come attestato da documenti locali. Una delle più antiche tradizioni veronesi racconta che le spoglie della santa siracusana passarono da Verona durante il loro viaggio verso la Germania intorno al sec. X, fatto che spiegherebbe anche la diffusione del culto della santa sia a Verona che nel nord Europa. Secondo un’altra tradizione, il culto di santa Lucia a Verona risalirebbe al periodo di dominio della Serenissima su Verona. Secondo la communis opinio, Venezia infatti, già nel 1204, avrebbe trasportato le spoglie della santa nella città lagunare.
Autore: Maria Stelladoro Ricca, bella, coraggiosa, Lucia, nata a Siracusa verso la fine del III secolo, è una fanciulla stupenda ma anche amorevole e di buon cuore. Soprattutto i suoi occhi splendidi attirano sguardi ammirati. La sua famiglia è nobile e agiata. La leggenda narra che rimasta orfana di padre in tenera età, Lucia (il cui nome significa “luce”, dal latino lux) viene promessa sposa a un giovane pagano siracusano, destinata quindi a diventare moglie e madre di famiglia, come si usava a quei tempi, anche se la ragazza desidera seguire Gesù e il Vangelo. La madre Eutichia, ammalata, è afflitta da una continua emorragia contro la quale non si riesce a trovare rimedio. Lucia, affranta, con fede si reca in pellegrinaggio con la madre a Catania presso la tomba di Sant’Agata, patrona della città, per chiedere la grazia di una guarigione. Lucia, mentre fiduciosa prega, sente una voce che le dice: «Lucia perché mi chiedi quello che tu stessa sei in grado di fare accadere? La tua grande fede ha salvato tua madre». È la voce di Sant’Agata. Mamma Eutichia guarisce mentre Lucia decide di fare voto di castità e povertà. La ragazza intende dedicare la sua vita al Signore, mettendo in pratica le parole di Gesù. Ri-
nuncia al matrimonio, elargisce la sua cospicua dote ai poveri di Siracusa e inizia ad assistere con dedizione e spirito caritatevole i bisognosi, gli orfani e le vedove. Il fidanzato, lasciato da Lucia, non si rassegna a perdere la bellissima e agiata fanciulla, forse interessato, più che altro, alle ricchezze della sua illustre famiglia. In preda all’ira, medita vendetta e così denuncia Lucia allo spietato console Pascasio che intende fare rispettare severamente la persecuzione dei cristiani, ordinata dall’imperatore romano Diocleziano. La ragazza viene arrestata e di fronte al suo rifiuto di rinnegare la propria fede, Pascasio la condanna a essere esposta tra le prostitute, ma la tradizione narra che Lucia sia diventata talmente pesante da non poter essere spostata nemmeno da decine di uomini, e perfino da due buoi. Allora i romani cercano di bruciarla, ma miracolosamente il fuoco non tocca la fanciulla. Infine un soldato la uccide con la sua spada il 13 dicembre del 304. La tradizione narra che a Lucia siano stati strappati gli occhi proprio perché stupendi, dei quali si era innamorato anche il suo fidanzato, ma che siano tornati miracolosamente al proprio posto. Ecco perché Lucia viene rappresentata con in mano un piccolo vassoio che porta i suoi occhi. Il culto di Santa Lucia si diffonde quasi subito da Siracusa in tutta la Sicilia e poi nel Nord Italia (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige). Patrona di Siracusa e di Venezia insieme a San Marco, generazioni di bambini hanno imparato ad amarla perché ogni 13 dicembre, secondo un’antica tradizione, la stupenda e dolce fanciulla, coperta da un candido velo, porta loro caramelle, dolci e giocattoli, accompagnata da un asinello e dal suono di una campanella. I bimbi scrivono una lettera a Lucia chiedendo i doni che desiderano ricevere e, prima di andare a dormire, la lasciano vicino alla finestra, con un po’ di biada per l’asinello e biscotti per la santa siciliana. Al mattino, appena svegli, i bimbi trovano sotto la finestra i doni portati dalla bella e buona Lucia. Secondo la tradizione popolare, intorno al XIII secolo, a Verona una grave malattia agli occhi colpisce i bambini della città. Per chiedere la grazia della guarigione a Santa Lucia, i genitori decidono di recarsi in pellegrinaggio, senza mantello e a piedi nudi, presso la Chiesa di Sant’Agnese, dedicata anche alla martire siracusana, dove oggi sorge il Palazzo Comunale. Il freddo pungente non invoglia i fanciulli a lasciare il calduccio delle abitazioni, così i genitori, per indurre i figli ad uscire di casa, promettono che al loro ritorno avrebbero trovato dei doni lasciati da Santa Lucia. I piccoli accettano con entusiasmo, partecipano al pellegrinaggio e la malattia sparisce. Così da quel giorno, ogni 13 dicembre, i bambini aspettano Santa Lucia che con il suo asinello porta i doni. In Sicilia in questo giorno si usa mangiare un dolce tipico: la “cuccìa”, grano intero bollito e condito con ricotta e cioccolato, a ricordo di un miracolo compiuto dalla santa nel 1646: durante una carestia approda una nave carica di grano che, per fame, il popolo mangia così com’è, senza macinarlo. Le spoglie della santa oggi si trovano a Venezia, presso la Chiesa dei Santi Geremia e Lucia, sul Canal Grande, non lontano dalla stazione ferroviaria, meta di moltitudini di fedeli provenienti da tutto il mondo. Santa Lucia, festeggiata anche nel Nord Europa (Russia, Polonia, Finlandia, Danimarca e Svezia), protegge la vista, considerata il bene più prezioso e viene invocata contro cecità, malattie degli occhi, dissenteria ed emorragie. È patrona di ciechi, oculisti, ottici ed elettricisti. A lei si chiede la “luce”, non solo per illuminare gli occhi, ma anche la mente e il cuore.
Autore: Mariella Lentini
Copertino (Lecce), 17 giugno 1603 – Osimo (Ancona), 18 settembre 1663
Giuseppe Maria Desa nacque il 17 giugno 1603 a Copertino (Lecce) in una stalla del paese. Il padre fabbricava carri. Rifiutato da alcuni Ordini per «la sua poca letteratura» (aveva dovuto abbandonare la scuola per povertà e malattia), venne accettato dai Cappuccini e dimesso per “inettitudine” dopo un anno. Accolto come Terziario e inserviente nel conventino della Grotella, riuscì ad essere ordinato sacerdote. Aveva manifestazioni mistiche che continuarono per tutta la vita e che, unite alle preghiere e alla penitenza, diffusero la sua fama di santità. Giuseppe levitava da terra per le continue estasi. Così, per decisione del Sant’Uffizio venne trasferito di convento in convento fino a quello di San Francesco in Osimo. Giuseppe da Copertino ebbe il dono della scienza infusa, per cui gli chiedevano pareri perfino i teologi e seppe accettare la sofferenza con estrema semplicità. Morì il 18 settembre 1663 a 60 anni; fu beatificato il 24 febbraio 1753 da papa Benedetto XIV e proclamato santo il 16 luglio 1767 da papa Clemente XIII.
Patronato: Aviatori, Passeggeri di aerei, Astronauti
Etimologia: Giuseppe = aggiunto (in famiglia), dall’ebraico
Martirologio Romano: A Osimo nelle Marche, san Giuseppe da Copertino, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, che, nonostante le difficoltà affrontate durante la sua vita, rifulse per povertà, umiltà e carità verso i bisognosi di Dio.
Come il francescano spagnolo s. Salvatore da Horta (1520-1567) che creava molti problemi ai suoi confratelli per i continui prodigi che operava, così anche s. Giuseppe da Copertino, li creava con il suo levitare da terra e per le continue estasi.
Giuseppe Maria Desa, figlio di Felice Desa e di Franceschina, nacque il 17 giugno 1603 a Copertino (Lecce) in una stalla del paese.
Il padre, maestro nella fabbricazione dei carri, era persona di fiducia dei signori locali, che a Copertino possedevano un castello; aveva sposato Franceschina di famiglia benestante, industriosa e pia, che aveva portato una discreta dote in ducati; insomma le condizioni economiche erano soddisfacenti.
Poi il padre Felice, per fare un favore ad un amico, fece da garante per un affare di mille ducati; a seguito del fallimento dell’amico, Felice fu denunziato e perse la causa, dovette vendere la casa e perse il lavoro, finendo in miseria con tutta la famiglia.
Proprio quando stava per nascere il sesto figlio Giuseppe, andarono ad abitare in una stalla dove vide la luce il nascituro.
Dopo poco tempo il padre morì per il dispiacere e la vedova rimase sola con i sei figli senza l’aiuto di nessuno; d’altronde la miseria era grande in tutto il Salentino, i poveri contadini erano gravati dei più assurdi balzelli come per esempio, cinque grana per ogni albero, a causa dell’ombra che faceva sulla terra.
La povera vedova e i figli, vissero anni durissimi, Giuseppe Desa, incapace d’imparare il mestiere del carpentiere o dello scarparo, faceva il garzone in un negozio, dove si trova-
va meglio che a casa, anzi specifichiamo nella piccola stalla adattata ad abitazione umana. In paese lo chiamavano “Boccaperta” per la sua abituale distrazione; in aggiunta, il creditore del padre ottenne dal Supremo Tribunale di Napoli, che Giuseppe unico figlio maschio di Felice e Franceschina, una volta raggiunta la maggiore età, fosse obbligato a lavorare senza paga, fino a saldare il debito del defunto genitore.
In pratica gli si prospettava una vita senza speranza, da considerare una vera e propria schiavitù; l’unico modo per sfuggire a questa desolante prospettiva era farsi sacerdote o frate. Sacerdote non era possibile, in quanto Giuseppe non sapeva niente di lettere e istruzione, forse frate andava bene, perché occorrevano braccia per lavorare e su questo non c’era difetto. La scuola che aveva cominciato a frequentare, la dovette lasciare quasi subito, a causa di un’ulcera cancrenosa che lo tormentò per cinque anni e di cui guarì grazie ad un eremita di passaggio che la massaggiò con dell’olio.
A quasi 17 anni, lasciò la madre e bussò alla porta dei Frati Francescani Conventuali, convento detto della ‘Grottella’ a due passi da Copertino, dove un suo zio era stato padre Guardiano, ma dopo un periodo di prova fu mandato via, per la sua poca letteratura, per semplicità ed ignoranza”. Passò allora dai Francescani Riformati, ma anche questi dopo un po’ lo rifiutarono, si diresse allora dai Cappuccini di Martina Franca, era il 15 agosto 1620, allora erano esigenti in fatto di cultura, vi restò otto mesi, ma per la sua inettitudine procurava continui disastri, aggravati da improvvise estasi durante le quali lasciava cadere piatti e scodelle, i cui cocci venivano attaccati alle sue vesti in segno di penitenza.
Nel marzo 1621 fu rimandato a casa, sostenendo che non era adatto alla vita spirituale né ai lavori manuali. Aveva una incapacità naturale e una preoccupazione soprannaturale, ma mentre la prima era evidente, la seconda sfuggiva a tutti.
Uscito dal convento rivestito con pochi stracci, perché aveva perso una parte del suo abito da laico, fu scambiato per un poco di buono, assalito dai cani di una vicina stalla e quasi bastonato dai pastori; fu respinto dallo zio paterno e persino la madre lo maltrattò, rimproverandogli di essersi fatto cacciare dal convento e che per lui non c’era posto. Grazie all’interessamento dello zio materno, Giovanni Donato Caputo, riuscì dopo molte insistenze a farsi accettare di nuovo dai Conventuali della “Grottella”, esponendo il suo caso per sfuggire alla condanna del Tribunale; i frati presero a cuore la situazione e lo ammisero nella comunità, prima come oblato, poi come terziario e finalmente come fratello laico, aveva 22 anni e si era nel 1625. Addetto ai lavori pesanti e alla cura della mula del convento, Giuseppe ben presto espresse il desiderio di diventare sacerdote, sapeva appena leggere e scrivere, ma intraprese gli studi con volontà e difficoltà; quando dovette superare l’esame per il diaconato davanti al vescovo, accadde che a Giuseppe, il quale non era mai riuscito a spiegare il Vangelo dell’anno liturgico tranne un brano, il vescovo aprendo a caso il libro domandò il commento delle frase: “Benedetto il grembo che ti ha portato”, era proprio l’unico brano che egli era riuscito a spiegare. Quando trascorsi i tre anni di preparazione al sacerdozio, bisognava superare l’ultimo e più difficile esame, i postulanti conoscevano il programma alla perfezione, tranne Giuseppe; il vescovo ascoltò i primi che risposero brillantemente all’interrogazione e convinto che anche gli altri fossero altrettanto
preparati, li ammise tutti in massa, era il 4 marzo 1628. Per la seconda volta fra Giuseppe, superò l’ostacolo degli esami in modo stupefacente e fu ordinato sacerdote per volere di Dio. Si definiva fratel Asino, per la sua mancanza di diplomazia nel trattare gli altri uomini, per la sua incapacità di svolgere un ragionamento coerente, per il non sapere maneggiare gli oggetti, ciò nonostante nel corso della sua vita ebbe tanti incontri con persone di elevata cultura, con le quali parlava e rispondeva con una teologia semplice ed efficace. Un professore dell’Università francescana di S. Bonaventura di Roma, disse: “L’ho sentito parlare così profondamente dei misteri di teologia, che non lo potrebbero fare i migliori teologi del mondo”. Ad un grande teologo francescano che chiedeva come conciliare gli studi con la semplicità del francescanesimo, rispose: “Quando ti metti a studiare o a scrivere ripeti: Signor, tu lo Spirito sei / et io la tromba. / Ma senza il fiato tuo / nulla rimbomba”. Possedeva il dono della scienza infusa, nonostante che si definisse “il frate più ignorante dell’Ordine Francescano”; amava i poveri, alzava la voce contro gli abusi dei potenti, ai compiti propri del sacerdote, univa i lavori manuali, aiutava il cuoco, faceva le pulizie del convento, coltivava l’orto e usciva umilmente per la questua. Amabile, sapeva essere sapiente nel dare consigli ed era molto ricercato dentro e fuori del suo Ordine. Dopo due anni di terribile aridità spirituale, che per tutti i mistici è la prova più difficile a superare, a frate Giuseppe si accentuarono i fenomeni delle estasi con levitazioni; dava improvvisamente un grido e si elevava da terra quando si pronunciavano i nomi di Gesù o di Maria, nel contemplare un quadro della Madonna, mentre pregava davanti al Tabernacolo; una volta volando andò a posarsi in ginocchio in cima ad un olivo, rimanendovi per una mezz’ora finché durò l’estasi. In effetti volava nell’aria come un uccello, fenomeni che ancora oggi gli studiosi cercano di capire se erano di natura parapsicologica o mistica; il fatto storico è che questi fenomeni sono avvenuti e in presenza di tanta gente stupefatta, che s. Giuseppe da Copertino non era un ciarlatano né un mago, ma semplicemente un uomo di Dio, il quale opera prodigi e si rivela ai più umili e semplici. Comunque frate Giuseppe costituì un problema per i suoi Superiori, che lo mandarono in vari conventi dell’Italia Centrale, per distogliere da lui l’attenzione del popolo, che sempre più numeroso accorreva a vedere il santo francescano.
Di lui si interessò l’Inquisizione di Napoli, che lo convocò per capire di che si trattasse e nel monastero napoletano di S. Gregorio Armeno, davanti ai giudici, Giuseppe ebbe un’estasi; la Congregazione romana del Santo Uffizio alla presenza del papa Urbano VIII, lo assolse dall’accusa di abuso della credulità popolare e lo confinò in un luogo isolato, lontano da Copertino e sotto sorveglianza del tribunale.
Fu sballottolato da un convento all’altro, a Roma, Assisi, Pietrarubbia, Fossombrone e infine ad Osimo (Ancona).
Aveva familiarità con gli animali, con cui conversava e come si era identificato in fratel Asino, così identificava gli altri uomini nelle sembianze dell’animale che meglio simboleggiava le sue caratteristiche di vita.
Nel 1656 papa Alessandro VII mise fine al suo peregrinare da un convento all’altro, destinandolo ad Osimo dove rimase per sette anni fino alla morte, continuando ad avere estasi, a sollevarsi da terra e ad operare prodigi miracolosi.
Morì il 18 settembre 1663 a 60 anni; fu beatificato il 24 febbraio 1753 da papa Benedetto XIV e proclamato santo il 16 luglio 1767 da papa Clemente XIII. Riposa nella chiesa a lui dedicata ad Osimo; festa liturgica il 18 settembre.
Autore: Antonio Borrelli
Giuseppe Maria Desa nasce a Copertino, in provincia di Lecce, nel 1603. Illetterato, dalle umili origini, ancora bambino abbandona gli studi per motivi di salute. Semplice e puro di cuore, Giuseppe desidera entrare in convento. Rifiutato più volte a causa della sua ignoranza, viene infine accolto dai frati di Grottella, vicino a Copertino. Accetta le mansioni disdegnate dai più: accudisce gli animali come inserviente di stalla tanto da essere soprannominato “Fratel Asino”, anche per la sua lentezza nel comprendere le cose. Giuseppe vorrebbe diventare sacerdote. Sembra impossibile per uno come lui che a stento sa leggere e scrivere, ma presentandosi all’esame finale, il vescovo, dopo avere ascoltato i primi quattro, promuove, senza interrogarli, tutti. Questo è per Giuseppe un segno della “Divina Provvidenza” che ha accolto le sue preghiere. La sua fama di frate umile e buono, dal sorriso gentile, si diffonde tra i fedeli che accorrono a lui per un consiglio e per la soave pace che da lui si espande. Grazie alla sua opera di evangelizzazione si assiste a numerose conversioni. Fra Giuseppe insegna a cantare agli uccelli, capisce gli animali, guarisce le malattie ed ha una parola di conforto per tutti. Il prodigio per il quale passa alla storia è “la levitazione” (vale a dire essere sollevati da terra). Infatti quando viene pronunciato il nome di Gesù o di sua Madre Maria, “il Santo che vola”, così viene chiamato da tutti, inizia a levitare rimanendo sospeso in aria, mentre dal suo corpo emana un profumo che infonde nei presenti una gioiosa serenità. A causa di questo evento viene osteggiato dai suoi superiori che nel 1639 lo trasferiscono ad Assisi (Perugia) e per Fra Giuseppe iniziano disagiate peregrinazioni da un convento all’altro. Lui sopporta i sacrifici, in pace con se stesso e con gli altri, sorretto dalla sua fede e dagli angeli che sente aleggiare attorno a sé. Nel 1656 papa Alessandro VII dispone il suo definitivo trasferimento nelle Marche, presso i cappuccini di Osimo (Ancona) dove Fra Giuseppe si spegne il 18 settembre 1663. È patrono di chi viaggia in aereo, dei piloti, degli astronauti, anche di scolari e studenti, soprattutto gli esaminandi. Viene invocato da chi soffre di vertigini.
Autore: Mariella Lentini
Breslavia, Polonia, 12 ottobre 1891 - Auschwitz, Polonia, 9 agosto 1942
Edith Stein nasce a Breslavia, capitale della Slesia prussiana, il 12 ottobre 1891, da una famiglia ebrea di ceppo tedesco. Allevata nei valori della religione israelitica, a 14 anni abbandona la fede dei padri divenendo agnostica. Studia filosofia a Gottinga, diventando discepola di Edmund Husserl, il fondatore della scuola fenomenologica. Ha fama di brillante filosofa. Nel 1921 si converte al cattolicesimo, ricevendo il Battesimo nel 1922. Insegna per otto anni a Speyer (dal 1923 al 1931). Nel 1932 viene chiamata a insegnare all’Istituto pedagogico di Münster, in Westfalia, ma la sua attività viene sospesa dopo circa un anno a causa delle leggi razziali. Nel 1933, assecondando un desiderio lungamente accarezzato, entra come postulante al Carmelo di Colonia. Assume il nome di suor Teresa Benedetta della Croce. Il 2 agosto 1942 viene prelevata dalla Gestapo e deportata nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau dove il 9 agosto muore nella camera a gas. Nel 1987 viene proclamata Beata, è canonizzata da Giovanni Paolo II l’11 ottobre 1998. Nel 1999 viene dichiarata, con S. Brigida di Svezia e S. Caterina da Siena, Compatrona dell’Europa.
Patronato: Europa (Giovanni Paolo II, 1/10/99)
Emblema: Palma
Martirologio Romano: Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith) Stein, vergine dell’Ordine delle Carmelitane Scalze e martire, che, nata ed educata nella religione ebraica, dopo avere per alcuni anni tra grandi difficoltà insegnato filosofia, intraprese con il battesimo una vita nuova in Cristo, proseguendola sotto il velo delle vergini consacrate, finché sotto un empio regime contrario alla dignità umana e cristiana fu gettata in carcere lontana dalla sua terra e nel campo di sterminio di Auschwitz vicino a Cracovia in Polonia fu uccisa in una camera a gas.
Un pugnetto di cenere e di terra scura passata al fuoco dei forni crematori di Auschwitz: è ciò che oggi rimane di S. Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein; ma in maniera simbolica, perché di lei effettivamente non c’è più nulla. Un ricordo di tutti quegli innocenti sterminati, e furono milioni, nei lager nazisti. Questo piccolo pugno di polvere si trova sotto il pavimento della chiesa parrocchiale di San Michele, a nord di Breslavia, oggi Wroclaw, a pochi passi da quel grigio palazzetto anonimo, in ulica (via) San Michele 38, che fu per tanti anni la casa della famiglia Stein. I luoghi della tormentata giovinezza di Edith, del suo dolore e del suo distacco. Sulla parete chiara della chiesa, ricostruita dopo la guerra e affidata ai salesiani, c’è un arco in cui vi è inciso il suo nome. Nella cappella, all’inizio della navata sinistra, si alzano due blocchi di marmo bianco: uno ha la forma di un grande libro aperto, a simboleggiare i suoi studi di filosofia; l’altro riproduce un grosso numero di fogli ammucchiati l’uno sopra l’altro, a ricordare i suoi scritti, la sua produzione teologica. Ma cosa resta veramente della religiosa carmelitana morta ad Auschwitz in una camera a gas nell’agosto del 1942? Certamente, ben più di un simbolico pugnetto di polvere o di un ricordo inciso nel marmo. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, la sua vicenda è balzata via via all’attenzione
della comunità internazionale, rivelando la sua grande statura, non solo filosofica ma anche religiosa, e il suo originale cammino di santità: era stata una filosofa della scuola fenomenologica di Husserl, una femminista ante litteram, teologa e mistica, autrice di opere di profonda spiritualità, ebrea e agnostica, monaca e martire; “una personalità – ha detto di lei Giovanni Paolo II – che porta nella sua intensa vita una sintesi drammatica del nostro secolo”. Elevata all’onore degli altari l’11 ottobre 1998, la sua santità non può comprendersi se non alla luce di Maria, modello di ogni anima consacrata, suscitatrice e plasmatrice dei più grandi santi nella storia della Chiesa. Beatificata in maggio (del 1987), dichiarata santa in ottobre, entrambi mesi di Maria: si è trattato soltanto di una felice quanto fortuita coincidenza? C’è in realtà un “filo mariano” che si dipana in tutta l’esperienza umana e spirituale di questa martire carmelitana. A cominciare da una data precisa, il 1917. In Italia è l’anno della disfatta di Caporetto, in Russia della rivoluzione bolscevica. Per Edith il 1917 è invece l’anno chiave del suo processo di conversione. L’anno del passo lento di Dio. Mentre lei, ebrea agnostica e intellettuale in crisi, brancola nel buio, non risolvendosi ancora a “decidere per Dio”, a molti chilometri dall’università di Friburgo dov’è assistente alla cattedra di Husserl, nella Città Eterna, il francescano polacco Massimiliano Kolbe con un manipolo di confratelli fondava la Milizia dell’Immacolata, un movimento spirituale che nel suo forte impulso missionario, sotto il vessillo di Maria, avrebbe raggiunto negli anni a venire il mondo intero per consacrare all’Immacolata il maggior numero possibile di anime. Del resto – e come dimenticarlo? – quello stesso 1917 è pure l’anno delle apparizioni della Madonna ai pastorelli di Fatima. Un filo mariano intreccia misteriosamente le vite dei singoli esseri umani stendendo la sua trama segreta sul mondo. Decisiva per la conversione della Stein al cattolicesimo fu la vita di santa Teresa d’Avila letta in una notte d’estate. Era il 1921, Edith era sola nella casa di campagna di alcuni amici, i coniugi Conrad-Martius, che si erano assentati brevemente lasciandole le chiavi della biblioteca. Era già notte inoltrata, ma lei non riusciva a dormire. Racconta: “Presi casualmente un libro dalla biblioteca; portava il titolo “Vita di santa Teresa narrata da lei stessa”. Cominciai a leggere e non potei più lasciarlo finché non ebbi finito. Quando lo richiusi, mi dissi: questa è la verità”. Aveva cercato a lungo la verità e l’aveva trovata nel mistero della Croce; aveva scoperto che la verità non è un’idea, un concetto, ma una persona, anzi la Persona per eccellenza. Così la giovane filosofa ebrea, la brillante assistente di Husserl, nel gennaio del 1922 riceveva il Battesimo nella Chiesa cattolica. Edith poi, una volta convertita al cattolicesimo, è attratta fin da subito dal Carmelo, un Ordine contemplativo sorto nel XII secolo in Palestina, vero “giardino” di vita cristiana (la parola karmel significa difatti “giardino”) tutto orientato verso la devozione specifica a Maria, come segno di obbedienza assoluta a Dio. Particolare non trascurabile – un’altra coincidenza? – il giorno in cui la Stein ottiene la risposta di accettazione da parte del convento di Lindenthal, per cui aveva tanto trepidato nel timore di essere rifiutata, è il 16 luglio del 1933, solennità della Regina del Carmelo. Così Edith offrirà a lei, alla Mamma Celeste, quale omaggio al suo provvidenziale intervento, i grandi mazzi di rose che riceve dai colleghi insegnanti e dalle sue allieve del collegio “Marianum” il giorno della partenza per l’agognato Carmelo di Colonia. Il 21 aprile 1938 suor Teresa Benedetta della Croce emette la professione perpetua. Fino al
1938 gli ebrei potevano ancora espatriare, in America perlopiù o in Palestina, poi invece –dopo l’incendio di tutte le sinagoghe nelle città tedesche nella notte fra il 9 e il 10 novembre, passata alla storia come “la notte dei cristalli” – occorrevano inviti, permessi, tutte le carte in regola; era molto difficile andare via. In Germania era già cominciata la caccia aperta al giudeo. La presenza di Edith al Carmelo di Colonia rappresenta un pericolo per l’intera comunità: nei libri della famigerata polizia hitleriana, infatti, suor Teresa Benedetta è registrata come “non ariana”. Le sue superiori decidono allora di farla espatriare in Olanda, a Echt, dove le carmelitane hanno un convento.
Prima di lasciare precipitosamente la Germania, il 31 dicembre del 1938, nel cuore della notte, suor Teresa chiede di fermarsi qualche minuto nella chiesa “Maria della Pace”, per inginocchiarsi ai piedi della Vergine e domandare la sua materna protezione nell’avventurosa fuga verso il Carmelo di Echt. “Ella – aveva detto – può formare a propria immagine coloro che le appartengono”. “E chi sta sotto la protezione di Maria – lei concludeva –, è ben custodito.” L’anno 1942 segnò l’inizio delle deportazioni di massa verso l’est, attuate in modo sistematico per dare compimento a quella che era stata definita come la Endlösung, ovvero la “soluzione finale” del problema ebraico. Neppure l’Olanda è più sicura per Edith. Il pomeriggio del 2 agosto due agenti della Gestapo bussarono al portone del Carmelo di Echt per prelevare suor Stein insieme alla sorella Rosa. Destinazione: il campo di smistamento di Westerbork, nel nord dell’Olanda. Da qui, il 7 agosto venne trasferita con altri prigionieri nel campo di sterminio di Auschwitz- Birkenau. Il 9 agosto, con gli altri deportati, fra cui anche la sorella Rosa, varcò la soglia della camera a gas, suggellando la propria vita col martirio: non aveva ancora compiuto cinquantuno anni.
Autore: Maria Di Lorenzo
Londra, Inghilterra, 3 maggio 1991 - Monza, Monza e Brianza, 12 ottobre 2006
Figlio primogenito di Andrea Acutis e Antonia Salzano, Carlo nacque a Londra, dove i genitori si trovavano per motivi di lavoro del padre, il 3 maggio 1991. Trascorse l’infanzia a Milano, circondato dall’affetto dei suoi cari e imparando da subito ad amare il Signore, tanto da essere ammesso alla Prima Comunione ad appena sette anni. Frequentatore assiduo della parrocchia di Santa Maria Segreta a Milano, allievo delle Suore Marcelline alle elementari e alle medie, poi dei padri Gesuiti al liceo, s’impegnò a vivere l’amicizia con Gesù e l’amore filiale alla Vergine Maria, ma fu anche attento ai problemi delle persone che gli stavano accanto, anche usando da esperto, seppur autodidatta, le nuove tecnologie. Colpito da una forma di leucemia fulminante, la visse come prova da offrire per il Papa e per la Chiesa. Lasciò questo mondo il 12 ottobre 2006, nell’ospedale San Gerardo di Monza, a quindici anni compiuti. Fu beatificato il 10 ottobre 2020, nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, sotto il pontificato di papa Francesco. Lo stesso Pontefice, il 23 maggio 2024, autorizzò la promulgazione del decreto relativo al secondo miracolo preso in esame per la canonizzazione, che sarà celebrata a Roma il 27 aprile 2025. I resti mortali di Carlo riposano dal 6 aprile 2019 ad Assisi, nella chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione, mentre la sua memoria liturgica ricorre il 12 ottobre, giorno della sua nascita al Cielo.
È sempre più vicino il giorno in cui avremo un Santo, regolarmente canonizzato, come patrono di internet e protettore di tutti i cybernauti. Già comunque adesso abbiamo un valido intercessore in Carlo Acutis, un ragazzo di 15 anni, “patito” di internet come i suoi coetanei, ma a differenza di tanti di loro, convinto che debba diventare “veicolo di evangelizzazione e di catechesi”. Sul web è ancora presente (www.miracolieucaristici.org), la mostra virtuale progettata e realizzata da lui a 14 anni, che sta facendo il giro del mondo e che testimonia come davvero per Carlo l’Eucaristia è stata la sua “autostrada per il cielo”. Già, perché Carlo continua ad essere un mistero: con i suoi 15 anni limpidi e solari, con la sua voglia di vivere e la sua prorompente allegria, ma soprattutto con la sua fede che scomoda ed interpella quella di noi adulti. Nasce il 3 maggio 1991 a Londra, dove i suoi genitori si trovano per esigenze di lavoro. Cresce a Milano, come tutti gli altri, differenziandosi solo per una particolare inclinazione per le pratiche religiose che a 12 anni lo porta alla messa ed alla comunione quotidiana. E non è tutto: di pari passo con l’adolescenza arriva anche il rosario quotidiano e l’adorazione eucaristica, convinto com’è che quando “ci si mette di fronte al sole ci si abbronza... ma quando ci si mette dinnanzi a Gesù Eucaristia si diventa santi”.
Già, la santità: è il suo chiodo fisso, il suo obiettivo, la molla che lo fa stare in modo “diverso” sui banchi di scuola, in pizzeria con gli amici o in piazzetta per la partita di pallone. Non è geloso del suo “kit per diventare santi”, che regala generosamente a tutti e che, molto semplicemente, contiene: un desidero grande di santità, Messa, Comunione e Rosario quotidiano, una razione giornaliera di Bibbia, un po’ di adorazione eucaristica, la confessione settimanale, la disponibilità a rinunciare a qualcosa per gli altri.
Per lui, che così tanto desidera la santità, è normale cercare amici in cielo; così nel suo sito internet c’è la sezione “scopri quanti amici ho in cielo”, dove compaiono i santi “giovani”, quelli che hanno raggiunto la santità in fretta. Anche lui è convinto di non invecchiare; “Morirò giovane”, ripete, ma intanto riempie la sua giornata di vorticosa attività: con i ragazzi del catechismo, con i poveri alla mensa Caritas, con i bambini dell’oratorio.
Tra un impegno e l’altro trova ancora il tempo per suonare il sassofono, giocare a pallone, progettare programmi al computer, divertirsi con i videogiochi, guardare gli adorati film polizieschi, girare filmini con i suoi cani e gatti. Oltre a studiare, naturalmente, perché frequenta con profitto (pur senza essere il primo della classe) il liceo milanese “Leone XIII”. Dagli amici è amato, per la ventata di allegria che sa portare nella compagnia, anche se lui non cerca lo sballo come gli altri, sempre misurato e padrone dei suoi sentimenti e dei suoi slanci. Così, anche chi lo avversa e lo deride, finisce per subirne il fascino e per lasciarsi attrarre da lui.
Poi, improvvisa come un fulmine a ciel sereno, arriva la leucemia, quella acuta che non lascia scampo, e che lui accoglie con un sorriso, offrendo la sua vita per il Papa e per la Chiesa. Cerca la guarigione perché ama la vita, ma sorride alla morte come all’incontro con l’Amato e perché sa che oltre ad essa non c’è il nulla.
Muore il 12 ottobre 2006 e lo seppelliscono nella nuda terra ad Assisi, la città di san Francesco, che più di altre ha amato e nella quale tornava così volentieri per ritemprare lo spirito. Proprio nel cimitero cittadino di Assisi viene sepolto, ma nel gennaio 2019 i suoi resti mortali sono stati riesumati, per essere traslati, il 6 aprile dello stesso anno, nella chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione, nella stessa città. «Tutti nasciamo come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie», amava dire, citando il filosofo inglese Edward Young. Un destino a cui egli evidentemente è sfuggito se, appena trascorsi i cinque anni previsti dalle norme canoniche, la diocesi di Milano, nel cui territorio si trova Monza, ha dato inizio alle fasi preliminari del suo processo di beatificazione. Dopo che, il 13 maggio 2013, la Santa Sede concesse il nulla osta per l’avvio della sua causa di beatificazione, è stato aperto il processo diocesano. La prima sessione si svolse il 15 febbraio 2013, l’ultima il 24 novembre 2016. Il 5 luglio 2018 papa Francesco autorizzò la promulgazione del decreto con cui Carlo veniva dichiarato Venerabile. Intanto, in Italia e all’estero, crescevano sempre più la fama e la stima per questo ragazzo che ha cercato la santità in modo straordinario, pur nell’ordinarietà della sua vita. Il 14 novembre 2019 la Consulta Medica della Congregazione delle Cause dei Santi espresse parere positivo circa un presunto miracolo, avvenuto nel 2013. Si trattava, come riferisce il sito della Congregazione delle Cause dei Santi, della guarigione di un bambino brasiliano affetto da importanti disturbi all’apparato digerente, con rara anomalia anatomica congenita del pancreas. I genitori del bambino e l’intera comunità parrocchiale cui appartenevano si unirono nella preghiera, chiedendo espressamente l’intercessione di Carlo. Il 21 febbraio 2020, ricevendo in udienza il cardinal Giovanni Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto con cui la guarigione era ritenuta miracolosa e ottenuta per intercessione di Carlo.
La sua beatificazione si svolse il 10 ottobre 2020, nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi. La Messa e il Rito della Beatificazione furono presiedute dal cardinal Agostino Vallini, Legato Pontificio per le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli, come rappresentante del Papa. La memoria liturgica del Beato Carlo venne fissata al 12 ottobre, giorno esatto della sua nascita al Cielo. Dopo la beatificazione, la venerazione per lui ha superato i confini a cui era vincolata, ovvero la diocesi di Milano, in cui è morto, e quella di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, che ne conserva le spoglie. I suoi genitori, particolarmente sua madre, sono stati invitati in ogni parte del mondo a tenere testimonianze, mentre molte località hanno ricevuto in dono sue reliquie. Tra le numerose attestazioni di presunte guarigioni a lui attribuite, la Postulazione ha preso in esame il caso di Valeria Valverde, studentessa nativa del Costarica, condotta all’Ospedale Careggi di Firenze (città dove viveva dal 2018 per motivi di studio) il 2 luglio 2022, dopo una caduta in bicicletta avvenuta intorno alle 4 del mattino. A causa di un trauma cranico molto grave, fu sottoposta a craniotomia d’urgenza con asportazione dell’osso occipitale destro del cranio per diminuire la pressione intracranica: rischiava di morire da un momento all’altro. L’8 luglio 2022 ritornò in respirazione spontanea: lo stesso giorno sua madre Liliana si era recata ad Assisi, pregando davanti alla tomba del Beato Carlo e lasciando una lettera scritta. Nei giorni seguenti, Valeria si riprese gradualmente: anche la terapia riabilitativa a cui fu sottoposta dall’11 agosto, nella struttura ospedaliera Don Gnocchi di Firenze, durò appena una settimana. Il 2 settembre, ormai completamente guarita, andò con la madre ad Assisi, in segno di ringraziamento. Il 23 maggio 2024, ricevendo in udienza il cardinal Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, papa Francesco (il quale ha più volte mostrato di apprezzare la testimonianza di Carlo, specie in testi e incontri rivolti ai ragazzi e ai giovani) autorizzò la promulgazione del decreto sul miracolo, aprendo la via alla canonizzazione.
Autore: Gianpiero Pettiti ed Emilia Flocchini
Il 3 maggio 1991, a Londra, dove i suoi illustri genitori, Andrea e Antonia, si trovano in quel momento per motivi di lavoro, nasce Carlo Acutis. Nel settembre dello stesso anno, rientrano tutti e tre a Milano, la loro città. Molto presto, Carlo si rivela un bambino di straordinaria intelligenza, quindi di una geniale capacità di utilizzare i computer e i programmi informatici. È affettuoso, vuole molto bene ai suoi genitori, trascorre del tempo con i nonni. Frequenta le scuole elementari e medie presso le Suore Marcelline di Milano, poi passa al Liceo Classico Leone XIII retto dai Padri Gesuiti. Ama il mare, i viaggi, le conversazioni, fa amicizia con i domestici di casa, è aperto a tutti e a tutti rivolge saluto e parola. Ha un temperamento solare, senza alcuna difficoltà a parlare con i nobili o con i mendicanti che incontra per strada. Nessuno è mai escluso dal suo cuore davvero buono.
Tutto per Gesù
Ma che cosa distingue Carlo da tanti suoi coetanei? Nel corso della sua esistenza, molto
presto ha scoperto una Persona singolare: Gesù Cristo, e di Lui, crescendo, si innamora perdutamente. Fin, da piccolo, l’incontro con Gesù sconvolge la sua vita. Carlo trova in Lui l’Amico, il Maestro, il Salvatore, la Ragione stessa della sua esistenza. Senza Gesù nel suo vivere quotidiano, non si comprende nulla della sua vita, in tutto simile a quella dei suoi amici, ma che custodisce in sé questo invincibile Segreto.
Cresce in un ambiente profondamente cristiano, in cui la fede è vissuta e testimoniata con le opere, ma è lui che sceglie liberamente di seguire Gesù con grande entusiasmo. In un mondo basato sull’effimero e sulla volgarità, testimonia Gesù e il suo Vangelo, che i più hanno smarrito o dimenticato, che molti combattono. Non ha paura di presentarsi come un’eccezione al mondo (ebbene, lo sia!) e di andare contro-corrente, contro la mentalità imperante oggi. Sa che per seguire Gesù, occorrono una grande umiltà e un gran sacrificio. I suoi modelli sono i Pastorelli di Fatima, Giacinta e Francesco Marto, S. Domenico Savio e S. Luigi Gonzaga, e poi S. Tarcisio martire per l’Eucaristia. Carlo, con continua coerenza e non in modo passeggero, si inserisce in questo stuolo di piccoli che con la loro esistenza narrano la gloria di Gesù. Si impegna fino al sacrificio per vivere continuamente nell’amicizia e nella grazia con Gesù. Trova, assai presto per la sua vita, due colonne fondamentali: l’Eucaristia e la Madonna.
L’Ostia lo trasforma
La sua vita è interamente eucaristica: non solo ama e adora profondamente il Corpo e il Sangue di Gesù, ma ne accoglie in sé l’aspetto oblativo e sacrificale. Già innanzi la sua 1a Comunione, ricevuta a soli 7 anni nel monastero delle Romite di S. Ambrogio ad Nemus, di Perego, poi sempre di più, alimenta una grande devozione al SS. Sacramento dell’altare, in cui sa e crede che Gesù è realmente presente accanto alle sue creature, come Dio e l’Amico più grande che esista. Partecipa alla Messa e alla Comunione – incredibile, ma vero anche per un ragazzo d’oggi – tutti i giorni. Dedica molto tempo alla preghiera silenziosa di adorazione davanti al Tabernacolo, dove sembra rapito dall’amore. Proprio così: dal Mistero eucaristico, impara a comprendere l’infinito amore di Gesù per ogni uomo.
Tutto questo è una continua “scuola” di dedizione così che non gli basta essere onesto e buono, ma sente che deve donarsi a Dio e servire i fratelli: tendere alla santità, essere santo! Nasce di lì, il suo zelo per la salvezza delle anime. Non si limita a pregare, ciò che è già grande cosa, ma parla spesso di Gesù, della Madonna, dei Novissimi (=le ultime cose: morte, giudizio di Dio, inferno, paradiso) e del rischio di potersi perdere con il peccato mortale nella dannazione eterna.
Carlo cerca di aiutare soprattutto coloro che vivono lontani da Gesù immersi nell’indifferenza per Lui e nel peccato. Spesso si offre, prega e ripara i peccati e le offese compiute contro l’Amore divino, contro il Cuore di Gesù, che sente vivo e palpitante nell’Ostia consacrata. Come S. Margherita Maria Alacoque, anche lui alimenta dentro di sé il desiderio di condurre le anime al Cuore di Gesù, nel quale confida e si abbandona ogni giorno. In particolare, si comunica tutti i primi venerdì del mese per riparare i peccati e meritarsi il Paradiso, secondo la “grande promessa” di Gesù, nel 1675, a S. Margherita Maria. Tra i suoi scritti, le sue “note d’anima”, forse l’affermazione più bella è proprio questa: “L’Eucaristia? È la mia autostrada per il Cielo!”.
Questa sua assidua e quotidiana abitudine di accostarsi all’Eucaristia, vivifica e rinnova il suo ardore verso Gesù e fa di lui un suo intimo amico, come confermano i sacerdoti che lo hanno conosciuto da vicino e anche i suoi compagni. Gesù gli fa bruciare le tappe nel suo cammino di ascesa. Ora ne conosciamo il perché: la sua esistenza sarebbe stata breve e la via della perfezione doveva essere percorsa da lui in poco tempo. Carlo non si sottrae e non si tira indietro e, pur sapendo di essere così diverso dalla società che lo circonda, sa anche che la santità è in realtà la norma della vita: si lascia condurre per mano, sicuro che Gesù ha scelto per lui “la parte migliore”, che non gli verrà tolta. Prova dentro di sé la certezza di essere amato da Dio e tanto gli basta per essere a sua volta apostolo della Verità e dell’amore, che è Gesù stesso.
Annunciatore di Gesù
È apprezzato e stimato dai suoi compagni di scuola, che lui aiuta sempre, anche se talvolta viene canzonato per la sua fede vivissima. Non è mai un alieno, ma è solo consapevole di aver incontrato Gesù e, per essergli fedele, è pronto anche a sfidare la maggioranza, “che ha solo ragione quando è nella Verità, mai perché è maggioranza”. Quindi non teme le critiche e le derisioni, ma sa che sono ineluttabili per conquistare alla causa di Gesù compagni e amici. Sì, Carlo intende conquistare anime e ci sono dei non-cristiani, uomini di altre religioni, che per averlo conosciuto e parlato con lui, hanno chiesto il Battesimo nella Chiesa Cattolica. È un genio del computer, nonostante e suoi versi anni, e un campione dello spirito, per la sua fede salda e operosa. I suoi compagni lo cercano per farsi insegnare a usare al meglio il computer, e Carlo, mentre spiega programmi e comandi, dirige il discorso verso le Verità eterne, verso Dio. Mobilitato e posseduto da Gesù Eucaristico, non perde occasione per evangelizzare e catechizzare. Il suo esempio trascina, la sua parola suadente spiega i Misteri della salvezza. Emana un fascino singolare, ha un ascendente straordinario, diremmo, un’autorevolezza che non è della sua età anagrafica. I suoi compagni sono ora concordi nel dire che Carlo è stato un vero testimone di Gesù e annunciatore del suo Vangelo. Ha capito che è indispensabile un grande sforzo missionario per annunciare il Vangelo a tutti. Apprezza l’intuizione del Beato Giacomo Alberione (1884-+1971) a usare i mass-media a servizio del Vangelo. Il suo obiettivo è quello dei missionari più veri: giungere a quante più persone possibili per far loro conoscere la bellezza e la gioia dell’amicizia con Gesù. In questa visione della realtà, prende come modello S. Paolo, l’apostolo delle genti, che impegna tutto se stesso per portare il Vangelo a ogni creatura, fino al sacrificio della vita. È un vero figlio della Chiesa, Carlo Acutis: per la Chiesa, prega e offre sacrifici. Il suo pensiero continuo è rivolto al Papa, nel quale, Giovanni Paolo II o Benedetto XVI che sia, crede e vede il Vicario di Cristo: per il Papa offre penitenze e preghiere. Si appassiona a ascoltare il Magistero del Papa e a seguirlo. Matura così una conoscenza della Fede, fuori dal comune, tanto più se si considera la sua età: comprende e illustra concetti di fede con parole semplici e comprensibili, che neppure un teologo potrebbe utilizzare meglio. Meraviglia e incanta sia il suo parroco sia i religiosi e le persone che incontra e lo ascoltano. Chi lo avvicina, se ne va con una certezza di fondo: che Gesù è davvero l’unico Salvatore atteso dall’umanità anche oggi e il solo che sa riempire a pieno il cuore dell’uomo.
Consacrato alla Madonna
L’altra colonna fondamentale su cui costruisce la sua vita è la Madonna: a Lei consacra più volte tutta la sua vita; a Lei ricorre nei momenti della necessità, certo che Maria SS. ma nulla rifiuta. È impossibile parlare di Carlo, senza considerare la sua forte devozione alla Madonna. È affascinato dalle sue apparizioni a Lourdes e a Fatima e ne vive il messaggio di conversione, penitenza e preghiera. Da Fatima, impara a amare il Cuore Immacolato di Maria, a pregare e a offrire sacrifici per riparare le offese che molti le arrecano. Maria SS.ma è la sua Avvocata, la sua Mamma: è fedele, per amor suo, alla recita quotidiana del Rosario, diffonde la devozione mariana tra i conoscenti, visita i suoi santuari, Lourdes e Fatima compresi. Tra i “suoi” santi, predilige S. Bernardette Soubirous e i Beati Pastorelli di Fatima e parla di loro assai volentieri, per invitare molti a vivere i messaggi della Madonna. È impressionato dal racconto della visione dell’inferno, come riferito da suor Lucia di Fatima, e pertanto decide di aiutare più persone che può a salvarsi l’anima. Sembra impossibile per un ragazzo, eppure Carlo legge il Trattato del Purgatorio di S. Caterina Fieschi da Genova (1447-1510), in cui la santa descrive le pene delle anime in Purgatorio. Carlo offre preghiere, penitenze e Comunioni in loro suffragio. In un mondo chiuso alla grande Verità della fede, Carlo scuote le coscienze e invita a guardare spesso all’”Aldilà”, che non tramonta. In famiglia, nella scuola, in mezzo alla società, diventa testimone dell’Eternità. Vive puro come un angelo, affidando la sua purezza alla Madonna e chiedendo preghiere per la sua purezza alle monache di clausura che frequenta, interessatissimo alla loro vita di preghiera. Difende la santità della famiglia contro il divorzio, e la sacralità della vita contro aborto e eutanasia, nei dibattiti in cui si trova coinvolto. Non conosce compromessi. È umile e ardente. Contagioso nella fede, come un fuoco che si appicca dovunque e incendia di Verità e di amore a Cristo.
“Voglio subito il Paradiso”
Non possiamo scriverne di più, tanto è affascinante. La sua storia bellissima è narrata nel libro di Nicola Gori, Eucaristia, la mia autostrada per il Cielo. Biografia di Carlo Acutis, S. Paolo, Milano, 2007. Questo angelo in carne, all’inizio d’ottobre 2006, è colpito da una gravissima forma di leucemia, incurabile. È ricoverato in ospedale. Non si spaventa, ma dice: “Offro tutte le sofferenze che dovrò patire, al Signore, per il Papa e per la Chiesa, per non fare il Purgatorio e andare dritto in Paradiso”. Si Confessa molto sovente, ma ora è Gesù che lo accoglie nel suo abbraccio. Riceve l’Unzione degli infermi, Gesù-Ostia come Viatico per la vita eterna. Sorride a tutti con uno sguardo bellissimo, con un coraggio senza pari. Alle 6,45 del 12 ottobre 2006, Carlo Acutis, di appena 15 anni, contempla per sempre Iddio. Piccolo grande meraviglioso intimo amico e apostolo di Gesù Cristo. Solo il divino Redentore e la sua Chiesa possono formare ragazzi così, segno che “anche oggi, come scrisse Montalembert, Colui che pende dalla croce continua ad attirare a Sé la gioventù e l’amore.
Autore: Paolo Risso
Lucia sperava che toccando la tomba di Sant’Agata, la madre si sarebbe guarita come la donna della Bibbia. Secondo la leggenda, il 5 febbraio del 304, Lucia si sentì stanca e si addormentò sognando proprio Sant’Agata, che le profetizzò la sua futura santità e le disse che aveva già pregato per la guarigione della madre. Dopo essersi svegliata e confermato la guarigione della madre, Lucia decise di consacrarsi a Cristo. Tornò a Siracusa e convinse la madre a rinunciare ai progetti matrimoniali, distribuendo i beni della famiglia ai poveri, e aiutò i cristiani nascosti nelle catacombe a causa delle persecuzioni di Diocleziano. Per avere le mani libere, portava una lampada accesa sulla testa. Quando il suo promesso sposo scoprì la sua scelta, la denunciò al Prefetto Pascasio per cristianesimo, il che significava una condanna a morte Lucia venne arrestata e durante il processo si rifiutò di sacrificare agli idoli, rispondendo con fermezza a tutte le accuse. Il Prefetto, stanco della sua resistenza, la condannò alla prostituzione, ma Lucia rimase immobile come una roccia. Dopo molti supplizi, fu decapitata e sepolta a Siracusa, dove oggi sorge il Santuario di Santa Lucia al Sepolcro, e il 13 Dicembre è il giorno a lei dedicato.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri di chi e cosa è la protettrice Santa Lucia.
Soluzione:
Attività 1
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Sullo sfondo dell’opera c’è un panorama di una città.
Scopri con l’aiuto dell’insegnante di quale città si tratta. Poi prova tu a ridisegnarla.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.

Giuseppe Maria Desa, ultimo di sei figli di Franceschina Panaca e Felice Desa (fabbricante di carri), nacque il 17 giugno 1603 a Copertino in Puglia. La sua infanzia fu difficile, segnata da malattie, ma si riprese grazie a un frate cappuccino. I suoi genitori lo affidarono allo zio francescano per l’educazione, ma Giuseppe fu considerato poco adatto e rifiutato da alcuni ordini religiosi fino a essere rimandato a casa. Dopo una serie di tentativi per trovare la sua strada religiosa, e dopo aver ricevuto ripetuti rifiuti, scappò per rifugiarsi nella chiesa della Grottella, dove pregò intensamente. Dopo sei mesi di vita nascosta, fu accettato come fratello oblato e indossò l’abito francescano. Finalmente Giuseppe nel 1628 fu ordinato sacerdote. La capacità di volare, con mente e corpo, fu la particolarità di San Giuseppe da Copertino. Nonostante le difficoltà negli studi, infatti, riceve il dono della scienza infusa e vive momenti di estasi con delle levitazioni.
La prima durante una processione il giorno di san Francesco d’Assisi, il 4 ottobre 1630. Dopo aver girato diversi conventi arriva a Osimo vicino Ancona (nelle Marche), e qui vi rimarrà ininterrottamente fino alla morte, all’età di 60 anni, sempre conducendo una vita umile al servizio del prossimo, e in colloquio con Dio nel culmine della celebrazione eucaristica.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri di chi e cosa è il protettore San Giuseppe da Copertino.
A S S I S I V I
A P U G L I A G
G R I F I U T I
O R D I N A T O
I E U M I L E S
T C A S A U D E
I N F A N Z I A
N T I O S I M O
Soluzione:
Attività 1
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Sullo sfondo dell’opera c’è un panorama di una città.
Scopri con l’aiuto dell’insegnante di quale città si tratta. Poi prova tu a ridisegnarla.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.

Edith Stein nasce a Breslavia il 12 ottobre 1891 da una famiglia ebrea. A 14 anni Edith, che era una bambina molto decisa sin da piccola, diventa agnostica e si dedica allo studio della filosofia a Gottinga, seguendo Edmund Husserl, un noto filosofo austro-tedesco del tempo.
Si convertì al cattolicesimo nel 1921 per trasferirsi a Münster nel 1932, dove insegnerà. Ma la sua carriera si fermerà ben presto a causa delle leggi razziali. Entra nel Convento del Carmelo di Colonia nel 1933 come suor Teresa Benedetta della Croce.
Fu tra le tante donne ebree che furono deportate ad Auschwitz nel 1942, dove morì il 9 agosto dello stesso anno. Edith Stein è riconosciuta dalla Chiesa come Compatrona dell’Europa dal 1999.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri di cosa è la protettrice Santa Teresa Benedetta della Croce.
Soluzione:

Attività 1
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Sullo sfondo dell’opera ci sono dei particolari. Di cosa si tratta? Scopri con l’aiuto dell’insegnante il loro significato. Poi prova tu a ridisegnarli.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.
Figlio primogenito di Andrea Acutis e Antonia Salzano, Carlo nacque a Londra il 3 maggio 1991 e trascorse l’infanzia a Milano. Fin da piccolo, si caratterizzò per una grande fede e un amore quasi incondizionato verso Dio. Questa sua spiritualità lo portò fare la Prima Comunione a soli sette anni. Carlo in Italia frequentò la parrocchia di Santa Maria Segreta e studiò con le Suore Marcelline e i padri Gesuiti
All’Eucaristia, che Carlo chiamava «La mia autostrada per il Cielo», era rivolta la sua fervente devozione, che lo portava quotidianamente a Messa. Aveva una grande passione, quella per l’informatica, della quale si serviva per divulgare e testimoniare la fede attraverso la realizzazione di siti web.
A soli 15 anni fu colpito da leucemia fulminante e offrì la sua sofferenza per il Papa e la Chiesa. Morì il 12 ottobre 2006 e fu beatificato il 10 ottobre 2020. La sua canonizzazione sarà celebrata a Roma il 27 aprile 2025. La sua memoria liturgica è il 12 ottobre.
Nel testo sono evidenziate delle parole. Cercale nella tabella sotto e con le lettere che restano scopri di cosa viene definito il protettore Carlo Acutis.
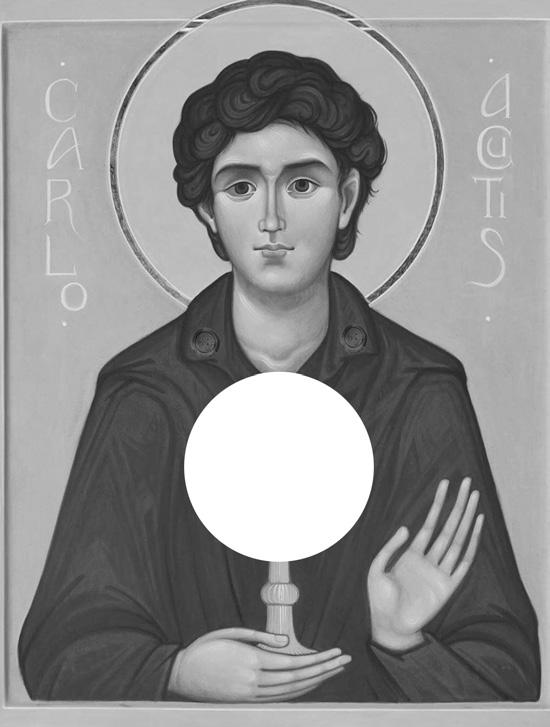
Attività 1
Nell’opera ci sono degli intrusi, cercali e mettici una X sopra.
Attività 2
Al centro dell’opera manca un particolare. Di cosa si tratta? Sai come si chiama? Scopri con l’aiuto dell’insegnante come si chiama e il suo significato. Poi prova tu a ridisegnarlo.
Attività 3
Dopo aver ascoltato la storia del santo e/o visto un video a lui dedicato, racconta quale è stato l’episodio che ti ha colpito di più, poi prova a disegnarlo tu.

Verifiche aggiuntive .....................................
Indicazioni nazionali per l’IRC ......................
La valutazione dell'IRC .................................
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile .... Le 8 competenze chiave europee ..................
Linee guida per l'educazione civica ................
Atlante biblico ............................................. pag. 408 pag. 420 pag. 434 pag. 439 pag. 453 pag. 456 pag. 478
Classe quarta
SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA
1. Perché è importante studiare le interazioni tra gli ebrei e altre civiltà antiche?
□ Per capire come vincere alle antiche gare di gioco.
□ Aiuta a comprendere come scambi e conflitti hanno plasmato la storia e la cultura.
□ Serve per imparare a costruire piramidi.
□ È utile per chi vuole diventare archeologo.
2. Come gli ebrei hanno influenzato le civiltà con cui sono entrati in contatto?
□ Insegnando loro a fare il pane azzimo.
□ Condividendo conoscenze, tradizioni religiose e pratiche commerciali.
□ Mostrando come giocare a scacchi.
□ Insegnando loro a parlare in ebraico.
3. Quali civiltà sono note per essere entrate in contatto e aver avuto scambi con gli ebrei nell'antichità?
□ Cinesi e indiani.
□ Egizi e babilonesi.
□ I popoli dell’Antartide.
□ Gli abitanti di Atlantide.
VERO O FALSO?
1. Gli ebrei hanno vissuto isolati e non hanno avuto contatti con altre civiltà.
□ VERO □ FALSO
2. Le interazioni tra gli ebrei e altre civiltà hanno sempre portato a conflitti.
□ VERO □ FALSO
3. Lo studio delle relazioni tra gli ebrei e altre civiltà antiche può insegnarci l'importanza del dialogo interculturale.
□ VERO □ FALSO
SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA
1. Perché è importante studiare le interazioni tra gli ebrei e altre civiltà antiche?
□ Per capire come vincere alle antiche gare di gioco.
♥ Aiuta a comprendere come scambi e conflitti hanno plasmato la storia e la cultura.
□ Serve per imparare a costruire piramidi.
□ È utile per chi vuole diventare archeologo.
2. Come gli ebrei hanno influenzato le civiltà con cui sono entrati in contatto?
□ Insegnando loro a fare il pane azzimo.
♥ Condividendo conoscenze, tradizioni religiose e pratiche commerciali.
□ Mostrando come giocare a scacchi.
□ Insegnando loro a parlare in ebraico.
3. Quali civiltà sono note per essere entrate in contatto e aver avuto scambi con gli ebrei nell'antichità?
□ Cinesi e indiani.
♥ Egizi e babilonesi.
□ I popoli dell’Antartide.
□ Gli abitanti di Atlantide.
VERO O FALSO?
1. Gli ebrei hanno vissuto isolati e non hanno avuto contatti con altre civiltà.
FALSO. Gli ebrei hanno avuto numerosi contatti e scambi con altre civiltà nel corso della storia, influenzando e venendo influenzati culturalmente e socialmente.
2. Le interazioni tra gli ebrei e altre civiltà hanno sempre portato a conflitti.
FALSO . Sebbene ci siano stati conflitti, ci sono stati anche periodi di scambi pacifici e cooperazione che hanno arricchito entrambe le parti.
3. Lo studio delle relazioni tra ebrei e altri può insegnarci il dialogo interculturale.
VERO. Comprendere queste interazioni storiche può promuovere l'apprezzamento della diversità culturale e l'importanza del dialogo e della comprensione reciproca.
DELLA CLASSE
Classe quarta
SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA
1. Perché i miracoli di Gesù sono importanti?
□ Mostrano che era bravo a fare magie.
□ Sono esempi del suo potere e del suo amore, dimostrando come si prendesse cura delle persone.
□ Servivano soprattutto a stupire la gente.
□ Gesù li faceva per farsi conoscere da tutti.
2. Cosa insegnano i miracoli di Gesù sul modo di trattare gli altri?
□ Che bisogna ignorare chi ha bisogno di aiuto.
□ Che l'amore e la cura verso gli altri sono fondamentali.
□ Che i miracoli sono l'unico modo per aiutare le persone.
□ Che dovremmo fare miracoli ogni giorno.
3. Qual è uno dei miracoli più noti compiuti da Gesù?
□ Ha vinto una gara di corsa.
□ Ha camminato sull'acqua.
□ Ha costruito un razzo spaziale.
□ Ha inventato il telefono.
VERO O FALSO?
1. I miracoli di Gesù erano solo grandi spettacoli per attirare l'attenzione.
□ VERO □ FALSO
2. Gesù ha compiuto miracoli solo per coloro che credevano in lui.
□ VERO □ FALSO
3. Oggi possiamo imparare dai miracoli di Gesù su come vivere e trattare gli altri.
□ VERO □ FALSO
SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA
1. Perché i miracoli di Gesù sono importanti?
□ Mostrano che era bravo a fare magie.
♥ Sono esempi del suo potere e del suo amore, dimostrando come si prendesse cura delle persone.
□ Servivano soprattutto a stupire la gente.
□ Gesù li faceva per farsi conoscere da tutti.
2. Cosa insegnano i miracoli di Gesù sul modo di trattare gli altri?
□ Che bisogna ignorare chi ha bisogno di aiuto.
♥ Che l'amore e la cura verso gli altri sono fondamentali.
□ Che i miracoli sono l'unico modo per aiutare le persone.
□ Che dovremmo fare miracoli ogni giorno.
3. Qual è uno dei miracoli più noti compiuti da Gesù?
□ Ha vinto una gara di corsa.
♥ Ha camminato sull'acqua.
□ Ha costruito un razzo spaziale.
□ Ha inventato il telefono.
VERO O FALSO?
1. I miracoli di Gesù erano solo grandi spettacoli per attirare l'attenzione.
FALSO. I miracoli di Gesù avevano lo scopo di dimostrare il suo amore e la sua cura per le persone, oltre che la sua autorità spirituale.
2. Gesù ha compiuto miracoli solo per coloro che credevano in lui.
FALSO. Gesù ha compiuto miracoli per tutti, mostrando amore e compassione a volte anche indipendentemente dalla loro fede.
3. Oggi possiamo imparare dai miracoli di Gesù su come vivere e trattare gli altri.
VERO. I miracoli di Gesù insegnano valori universali di amore, cura e compassione che sono applicabili nella vita quotidiana di ciascuno.
Classe quarta
SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA
1. Cosa fanno le persone che credono in Gesù per aiutare gli altri nel mondo di oggi?
□ Creano tante opere d'arte su Gesù.
□ Aiutano le persone bisognose e lavorano per rendere il mondo un posto più giusto.
□ Organizzano soprattutto feste in chiesa.
□ Parlano solo di preghiera.
2. Cosa significa fare un'azione di solidarietà nella comunità cristiana?
□ Costruire più chiese.
□ Andare a messa ogni giorno.
□ Aiutare le persone bisognose e lottare perché tutti siano trattati in modo giusto.
□ Scrivere libri sulla religione.
3. Come possono i ragazzi diventare messaggeri dell'amore nel mondo di oggi?
□ Discutendo su internet e valorizzando l’intelligenza artificiale.
□ Aiutando gli altri e partecipando a progetti che migliorano la vita delle persone.
□ Leggendo solamente la Bibbia.
□ Stando soprattutto con amici che pensano come loro.
VERO O FALSO?
1. I cristiani aiutano gli altri solo pregando per loro.
□ VERO □ FALSO
2. I ragazzi possono mostrare l'amore di Gesù solo parlando di religione.
□ VERO □ FALSO
3. Il volontariato è un modo per i cristiani di condividere le idee di Gesù.
□ VERO □ FALSO
SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA
1. Cosa fanno le persone che credono in Gesù per aiutare gli altri nel mondo di oggi?
□ Creano tante opere d'arte su Gesù.
♥ Aiutano le persone bisognose e lavorano per rendere il mondo un posto più giusto.
□ Organizzano soprattutto feste in chiesa.
□ Parlano solo di preghiera.
2. Cosa significa fare un'azione di solidarietà nella comunità cristiana?
□ Costruire più chiese.
□ Andare a messa ogni giorno.
♥ Aiutare le persone bisognose e lottare perché tutti siano trattati in modo giusto.
□ Scrivere libri sulla religione.
3. Come possono i ragazzi diventare messaggeri dell'amore nel mondo di oggi?
□ Discutendo su internet e valorizzando l’intelligenza artificiale.
♥ Aiutando gli altri e partecipando a progetti che migliorano la vita delle persone.
□ Leggendo solamente la Bibbia.
□ Stando soprattutto con amici che pensano come loro.
VERO O FALSO?
1. I cristiani aiutano gli altri solo pregando per loro.
FALSO. I cristiani aiutano gli altri anche con azioni concrete, come il volontariato e progetti che portano amore e giustizia.
2. I ragazzi possono mostrare l'amore di Gesù solo parlando di religione.
FALSO . I ragazzi possono mostrare l'amore di Gesù attraverso le loro azioni, aiutando chi ha bisogno e stando vicino a chi si sente solo.
3. Il volontariato è un modo per i cristiani di condividere le idee di Gesù.
VERO. Fare volontariato e aiutare gli altri sono modi importanti per i cristiani di vivere e condividere l'amore e i valori insegnati da Gesù.
SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA
1. Perché San Paolo è considerato un grande comunicatore?
□ Perché viaggiava sempre in prima classe.
□ Perché usava le sue lettere per diffondere il messaggio di Gesù.
□ Perché era un bravo cuoco.
□ Perché aveva molti follower su Instagram.
2. Come riusciva San Paolo a comunicare efficacemente con persone di culture diverse?
□ Parlando solo in latino.
□ Usando complesse formule matematiche.
□ Adattando il suo messaggio alle diverse culture e utilizzando esempi concreti.
□ Mandando cartoline illustrate.
3. Qual è un modo con cui seguire l'esempio di comunicazione di San Paolo oggi?
□ Scrivendo lettere a mano e spedendole per posta.
□ Parlando in modo chiaro e rispettoso, cercando di capire le persone che ci ascoltano.
□ Usando solo il telegrafo.
□ Ignorando le differenze culturali.
VERO O FALSO?
1. San Paolo ha scritto tutte le sue lettere in greco antico.
□ VERO
□ FALSO
2. San Paolo ha viaggiato in tutto il mondo conosciuto per predicare il Cristianesimo.
□ VERO
□ FALSO
3. Le lettere di San Paolo sono considerate importanti solo per i cristiani.
□ VERO
□ FALSO
SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA
1. Perché San Paolo è considerato un grande comunicatore?
□ Perché viaggiava sempre in prima classe.
♥ Perché usava le sue lettere per diffondere il messaggio di Gesù.
□ Perché era un bravo cuoco.
□ Perché aveva molti follower su Instagram.
2. Come riusciva San Paolo a comunicare efficacemente con persone di culture diverse?
□ Parlando solo in latino.
□ Usando complesse formule matematiche.
♥ Adattando il suo messaggio alle diverse culture e utilizzando esempi concreti.
□ Mandando cartoline illustrate.
3. Qual è un modo con cui seguire l'esempio di comunicazione di San Paolo oggi?
□ Scrivendo lettere a mano e spedendole per posta.
♥ Parlando in modo chiaro e rispettoso, cercando di capire le persone che ci ascoltano.
□ Usando solo il telegrafo.
□ Ignorando le differenze culturali.
VERO O FALSO?
1. San Paolo ha scritto tutte le sue lettere in greco antico.
VERO. Anche se San Paolo conosceva probabilmente più lingue, le sue lettere che ci sono pervenute sono scritte in greco, la lingua del Mediterraneo orientale al suo tempo.
2. San Paolo ha viaggiato in tutto il mondo conosciuto per predicare il Cristianesimo.
FALSO . Anche se San Paolo ha viaggiato tantissimo, i suoi viaggi si sono concentrati principalmente nell'area del Mediterraneo orientale.
3. Le lettere di San Paolo sono considerate importanti solo per i cristiani.
FALSO. Le lettere di San Paolo non solo hanno un significato religioso per i cristiani, ma sono anche studiate per il loro valore storico, letterario e culturale.
SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA
1. Cosa fanno i monaci benedettini durante la giornata?
□ Rimangono nella propria cella senza mai uscire.
□ Pregano, lavorano e studiano.
□ Pregano tutto il giorno.
□ Lavorano cinque volte al giorno.
2. Perché è importante il lavoro manuale per i monaci?
□ Perché vogliono vincere un premio.
□ Perché così possono comprarsi cibi golosi.
□ È un modo per guadagnarsi il necessario e contribuire alla comunità.
□ Solo per tenersi occupati.
3. Che cosa hanno contribuito i monaci benedettini alla società?
□ Hanno inventato le olimpiadi.
□ Hanno scritto e copiato libri, insegnato l'agricoltura e aiutato i poveri.
□ Hanno scoperto come viaggiare nello spazio.
□ Hanno inventato Internet.
VERO O FALSO?
1. I monaci trascorrono tutto il loro tempo in silenzio.
□ VERO □ FALSO
2. La vita in monastero è sempre stata la stessa fin dalle origini del monachesimo.
□ VERO □ FALSO
3. Imparare dalla vita dei monaci è importante per l’equilibrio tra lavoro e riflessione.
□ VERO □ FALSO
SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA
1. Cosa fanno i monaci benedettini durante la giornata?
□ Rimangono nella propria cella senza mai uscire.
♥ Pregano, lavorano e studiano.
□ Pregano tutto il giorno.
□ Lavorano cinque volte al giorno.
2. Perché è importante il lavoro manuale per i monaci?
□ Perché vogliono vincere un premio.
□ Perché così possono comprarsi cibi golosi.
♥ È un modo per guadagnarsi il necessario e contribuire alla comunità.
□ Solo per tenersi occupati.
3. Che cosa hanno contribuito i monaci benedettini alla società?
□ Hanno inventato le olimpiadi.
♥ Hanno scritto e copiato libri, insegnato l'agricoltura e aiutato i poveri.
□ Hanno scoperto come viaggiare nello spazio.
□ Hanno inventato Internet.
VERO O FALSO?
1. I monaci trascorrono tutto il loro tempo in silenzio.
FALSO. Anche se il silenzio è una parte importante della vita monastica, i monaci dedicano tempo alla preghiera comune, al lavoro e allo studio.
2. La vita in monastero è sempre stata la stessa fin dalle origini del monachesimo.
FALSO . La vita monastica si è adattata nel corso dei secoli, anche se molti dei principi fondamentali sono rimasti invariati.
3. Imparare dalla vita dei monaci è importante per l’equilibrio tra lavoro e riflessione.
VERO. La regola di "Ora et labora" dei monaci benedettini offre un modello per equilibrare lavoro, studio e “spiritualità” nella vita quotidiana.
SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA
1. Perché è importante conoscere le religioni del mondo?
□ Perché così possiamo vincere a tutti i giochi a quiz.
□ Per imparare date e nomi che altrimenti sono difficili.
□ Perché tutte le religioni insegnano le stesse identiche cose.
□ Per capire meglio le persone che incontriamo e rispettare le loro credenze.
2. Cosa possiamo imparare dal buddismo?
□ Che è importante avere sempre ragione.
□ Che dobbiamo spesso viaggiare.
□ L'importanza della pace interiore e di essere gentili con gli altri.
□ Che esistono infinite divinità.
3. Che insegnamento ci viene dall'islam?
□ Che dovremmo viaggiare nel deserto.
□ L'importanza della preghiera e di essere generosi.
□ Che bisogna mangiare spesso cibo piccante.
□ Che si deve parlare arabo per essere perfetti.
VERO O FALSO?
1. Tutte le religioni del mondo pregano nello stesso modo.
□ VERO □ FALSO
2. Imparare delle altre religioni ci può aiutare a essere più amici.
□ VERO □ FALSO
3. Il taoismo e il confucianesimo insegnano l'importanza di vivere in armonia.
□ VERO □ FALSO
SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA
1. Perché è importante conoscere le religioni del mondo?
□ Perché così possiamo vincere a tutti i giochi a quiz.
□ Per imparare date e nomi che altrimenti sono difficili.
□ Perché tutte le religioni insegnano le stesse identiche cose.
♥ Per capire meglio le persone che incontriamo e rispettare le loro credenze.
2. Cosa possiamo imparare dal buddismo?
□ Che è importante avere sempre ragione.
□ Che dobbiamo spesso viaggiare.
♥ L'importanza della pace interiore e di essere gentili con gli altri.
□ Che esistono infinite divinità.
3. Che insegnamento ci viene dall'islam?
□ Che dovremmo viaggiare nel deserto.
♥ L'importanza della preghiera e di essere generosi.
□ Che bisogna mangiare spesso cibo piccante.
□ Che si deve parlare arabo per essere perfetti.
VERO O FALSO?
1. Tutte le religioni del mondo pregano nello stesso modo.
FALSO. Ogni religione ha il suo modo unico di pregare e di praticare la propria fede.
2. Imparare delle altre religioni ci può aiutare a essere più amici.
VERO. Conoscere e capire le credenze degli altri promuove il rispetto e l'amicizia tra persone di diverse culture.
3. Il taoismo e il confucianesimo insegnano l'importanza di vivere in armonia.
VERO. Entrambi sottolineano l'armonia e il rispetto per la natura e le relazioni umane.
indiCazioni nazionali per l’irC
D.P.R. dell’11/02/2010
Traguardi per lo sviluppo delle competenze e Obiettivi di Apprendimento dell’insegnamento della Religione Cattolica per il primo ciclo d’istruzione.
Primo ciclo d’istruzione
L’insegnamento della religione cattolica fa sì che gli alunni riflettano e si interroghino sul SENSO DELLA LORO ESPERIENZA per elaborare ed esprimere un PROGETTO DI VITA, che si integri nel mondo reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo. Vista la ripartizione delle discipline d’insegnamento in tre distinte aree disciplinari, l’insegnamento della religione cattolica si colloca nell’area linguisticoartistico-espressiva in cui, a partire dal confronto interculturale e interreligioso, l’alunno si interroga sulla propria identità e sugli orizzonti di senso verso cui può aprirsi, affrontando anche le essenziali DOMANDE RELIGIOSE e misurandosi con i codici simbolici in cui esse hanno trovato e trovano espressione. In tale contesto si collocano gli strumenti per cogliere, interpretare e gustare le espressioni culturali e artistiche offerte dalle diverse tradizioni religiose e l’insegnamento della religione cattolica, impartito secondo gli accordi concordatari e le successive intese.
Religione cattolica
Nel quadro delle diverse discipline appartenenti a ciascuna area, l’insegnamento della religione cattolica si presenta nel modo seguente. Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’ESPERIENZA UMANA svolge un ruolo insostituibile per la piena formazione della persona. Esso permette, infatti, l’acquisizione e l’uso appropriato di strumenti culturali che, portando al massimo sviluppo il processo di simbolizzazione che la scuola stimola e promuove in tutte le discipline, consente la COMUNICAZIONE anche su realtà altrimenti indicibili e inconoscibili. Il confronto, poi, con la forma storica della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la CONVIVENZA CIVILE, in quanto permette di cogliere importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i RAPPORTI TRA PERSONE DI CULTURE E RELIGIONI DIFFERENTI .
La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio storico, culturale ed umano della società italiana; per questo, secondo le indicazioni dell’Accordo di
indiCazioni nazionali per l’irC
D.P.R. dell’11/02/2010
revisione del Concordato, la Scuola Italiana si avvale della collaborazione della Chiesa cattolica per far conoscere i principi del cattolicesimo a tutti gli studenti che vogliano avvalersi di questa opportunità. L’insegnamento della religione cattolica (Irc), mentre offre una prima conoscenza dei dati storico-positivi della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di tutti gli altri aspetti della persona, mediante l’approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla vita. Per tale motivo, come espressione della laicità dello Stato, l’Irc è offerto a tutti in quanto OPPORTUNITÀ PREZIOSA PER LA CONOSCENZA DEL CRISTIANESIMO, come radice di tanta parte della cultura italiana ed europea. Stanti le disposizioni concordatarie, nel rispetto della libertà di coscienza, è data agli studenti la possibilità di avvalersi o meno dell’Irc.
La proposta educativa dell’Irc consente la riflessione sui grandi interrogativi posti dalla condizione umana (ricerca identitaria, vita di relazione, complessità del reale, bene e male, scelte di valore, origine e fine della vita, radicali domande di senso…) e sollecita il confronto con la risposta maturata nella tradizione cristiana nel rispetto del processo di crescita della persona e con modalità differenziate a seconda della specifica fascia d’età, approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e valoriali, e promuovendo un confronto mediante il quale la persona, nell’esercizio della propria libertà, riflette e si orienta per la scelta di un responsabile progetto di vita.
Emerge così un ulteriore contributo dell’Irc alla formazione di persone capaci di dialogo e di rispetto delle differenze, di comportamenti di reciproca comprensione, in un contesto di pluralismo culturale e religioso.
In tal senso l’Irc – al di là di una sua collocazione nell’area linguistico-artistico-espressiva si offre anche come preziosa opportunità per l’elaborazione di attività interdisciplinari, per proporre percorsi di sintesi che, da una peculiare angolatura, aiutino gli alunni a costruire mappe culturali in grado di ricomporre nella loro mente una comprensione unitaria della realtà.
I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono formulati in modo da esprimere la tensione verso tale prospettiva e collocare le differenti conoscenze e abilità in un orizzonte di senso che ne espliciti per ciascun alunno la portata esistenziale.
IndIcazIonI nazIonalI per l’Irc
D.P.R. dell’11/02/2010
Gli obiettivi di apprendimento per ogni fascia d’età sono articolati in quattro ambiti tematici, tenendo conto della centralità della persona di Gesù Cristo:
Obiettivi di Apprendimento d io e l’uomo l a b ibbia e le alT re fon T i i l linguaggio religio S o i valori e T i C i e religio S i
• con i principali riferimenti storici e dottrinali del Cristianesimo.
• per offrire una base documentale alla conoscenza.
• nelle sue declinazioni verbali e non verbali.
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze
• per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile, responsabile e solidale.
L’alunno…
• riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.
• riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni.
• identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
• si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo.
• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento.
• coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.
dell’11/02/2010
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria d io e l’uomo l a b ibbia e le alT re fon T i i l linguaggio religio S o i valori e T i C i e religio S i
• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani.
• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.
• Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del «Padre Nostro».
• Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli.
• Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà e nella tradizione popolare.
• Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc.).
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo, come insegnato da Gesù.
• Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la giustizia e la carità.
nazIonalI per l’Irc
D.P.R. dell’11/02/2010
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria d io e l’uomo l a b ibbia e le alT re fon T i i l linguaggio religio S o i valori e T i C i e religio S i
• Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.
• Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.
• Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo.
• Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico.
• Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.
• Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio principale.
• Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli.
• Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.
• Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.
• Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù.
• Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.
• Riconoscere il valore del silenzio come «luogo» di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio.
• Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.
• Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo.
• Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane.
• Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita.
“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità di istituto”.
Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012
Il curricolo è uno strumento disciplinare e metodologico di organizzazione dell’apprendimento, frutto di un lavoro collettivo, interno alla scuola, di “traduzione” delle Indicazioni Nazionali, che pongono lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. Il curricolo verticale viene anche chiamato “curricolo d’istituto”, perché richiama l’insieme delle attività didattiche che rientrano nell’offerta formativa di ogni singolo istituto.
Con la sempre più frequente presenza di istituti cosiddetti “comprensivi”, ovvero che comprendono sia scuola primaria che secondaria inferiore (elementari e medie), il curricolo verticale si “spalma” su entrambi i cicli di istruzione (che a volte salgono addirittura a tre, in quegli istituti che comprendono anche la scuola dell’infanzia). In questi casi è ancor più sentita l’esigenza di PREDISPORRE DEI PIANI FORMATIVI che si basino su elementi di sviluppo graduale e progressivo delle conoscenze dell’allievo, con obiettivi trasversali e interconnessi (l’uno propedeutico all’altro).
Progettare insieme un Curricolo Verticale significa progettare un percorso unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di consolidare l’apprendimento e al tempo stesso di EVOLVERE VERSO NUOVE COMPETENZE.
IndIcazIonI nazIonalI per l’Irc
D.P.R. dell’11/02/2010
Campo di e S perienza
i l S e e l’alT ro
Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale l ivello b a S e l ivello in T ermedio l ivello avanzaT o
L’alunno scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la casa di chi crede in Lui.
Se stimolato, costruisce un’idea positiva di sé come persona e come creatura di Dio.
Si intuisce come persona e creatura di Dio.
il C orpo e il movimen T o
L’alunno riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni.
L’alunno riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti.
Conosce gli spazi scolastici e vi si orienta.
Conosce gli organi di senso e le loro funzioni.
Conosce e distingue i concetti di suono, rumore, silenzio e fonte sonora.
Conosce forme e figure, sagome, tracce, segni e linee.
Sperimenta schemi posturali e motori e li applica ai giochi di gruppo.
Utilizza i sensi per conoscere la realtà.
Coglie sé stesso e il mondo come donato da Dio e perciò da amare e custodire.
Apprezza sé stesso e il mondo come donato da Dio e perciò da amare e custodire.
Distingue i suoni dai rumori associandoli ai vari contesti.
Rappresenta graficamente in modo spontaneo, guidato e creativo.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Si orienta e si muove con disinvoltura, con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.
Conosce vari strumenti e generi musicali.
Memorizza canti e li esegue in coro.
Conosce l’uso del colore per esprimere sentimenti ed emozioni.
conosce il proprio ruolo in un’attività musicale.
Utilizza in modo appropriato e creativo il colore.
Legge semplici immagini e le descrive.
Campo di e S perienza
i di SC or S i e le parole
Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale l ivello b
L’alunno impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione anche in ambito religioso.
Riconosce alcuni simboli relativi alle principali feste cristiane.
Riconosce i simboli relativi alle principali feste cristiane ed alcuni termini specifici del linguaggio cristiano.
D.P.R. dell’11/02/2010
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano. Ascolta semplici racconti biblici.
Ascolta semplici racconti biblici e riesce a narrare i contenuti.
l a C ono SC enza del mondo
L’alunno osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.
Si orienta nel tempo della vita quotidiana.
Osserva i fenomeni naturali con curiosità.
Conosce la sequenza temporale.
Osserva i fenomeni naturali con attenzione.
Coglie semplici relazioni di causa / effetto.
Denomina i giorni della settimana.
Esplora ambienti naturali e artificiali.
Pone domande, discute, confronta ipotesi e soluzioni.
Riferisce eventi del passato recente ed è consapevole della loro collocazione temporale. Risolve semplici problemi e chiarisce soluzioni attraverso domande.
IndIcazIonI nazIonalI per l’Irc
D.P.R. dell’11/02/2010
Al termine della classe terza della scuola primaria o bie TT ivi di apprendimen T o
Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale l ivello b a S e l ivello in T ermedio l ivello avanzaT o
d io e l’uomo
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali dell’insegnament o alle tradizioni del suo ambiente.
Riconosce in Dio il creatore del mondo.
Conosce alcune caratteristiche di Gesù.
Conosce il linguaggio specifico relativo agli argomenti trattati.
Conosce e comprende in modo appropriato il lessico specifico relativo agli argomenti trattati.
Conosce, comprende, applica e padroneggia in modo appropriato il lessico specifico relativo agli argomenti trattati.
l a b ibbia e le alT re fon T i
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico.
Conosce alcuni semplici passi biblici, come il racconto della Genesi e i fatti principali della vita di Gesù.
Conosce il linguaggio specifico relativo agli argomenti trattati.
Comprende e utilizza il lessico specifico relativo agli argomenti trattati.
Comprende e utilizza in modo sempre appropriato il lessico specifico relativo agli argomenti trattati.
i l linguaggio religio S o
Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
Conosce le principali feste cristiane e alcuni simboli ad esse collegati.
Conosce il linguaggio simbolico legato alle principali feste cristiane.
Conosce e comprende il linguaggio simbolico legato alle principali feste cristiane.
Sa argomentare circa il valore simbolico legato alle principali feste cristiane.
D.P.R. dell’11/02/2010
Al termine della classe terza della scuola primaria o bie TT ivi di apprendimen T o Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale l ivello b a S e l ivello in T ermedio l ivello avanzaT o
i valori e T i C i e religio S i
LSi confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo.
Riconosce nella figura di Gesù un buon esempio di vita.
Riconosce nel messaggio di Gesù una proposta di vita per “crescere bene” nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.
Riconosce i valori di cui è portatore il messaggio evangelico e sviluppa atteggiamenti di rispetto verso gli altri e l’ambiente.
Riconosce i valori incarnati da Gesù e coglie in essi una proposta di vita fondata sul rispetto degli altri e dell’ambiente.
IndIcazIonI nazIonalI per l’Irc
D.P.R. dell’11/02/2010
Al termine della scuola primaria o bie TT ivi di apprendimen T o Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale l ivello b a S e l ivello in T ermedio l ivello avanzaT o
d io e l’uomo
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.
Conosce i principali argomenti trattati ed è in grado di esporli in modo accettabile.
È in grado di rielaborare i contenuti posti in un contesto semplificato.
Conosce gli argomenti trattati ed è in grado di esporli in modo corretto.
È in grado di rielaborare i contenuti e di proporre analisi e sintesi adeguate alle richieste.
Conosce in modo completo gli argomenti trattati ed è in grado di esporli in modo organico, con buona proprietà di linguaggio.
È in grado di rielaborare i contenuti in modo appropriato.
Conosce in modo approfondito gli argomenti trattati ed è in grado di esporli in modo organico, con un’ottima proprietà di linguaggio e apporti personali.
È in grado di rielaborare i contenuti in modo autonomo.
l a b ibbia e le alT re fon T i
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi.
Conosce il lessico relativo agli argomenti trattati in modo accettabile.
Conosce e utilizza il lessico specifico relativo agli argomenti trattati.
Conosce, comprende e utilizza in modo organico il lessico specifico relativo agli argomenti trattati.
Conosce, comprende e utilizza in modo sempre appropriato il lessico specifico relativo agli argomenti trattati.
o bie TT ivi di apprendimen T o
i l linguaggio religio S o
Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze
Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
i valori e T i C i e religio S i
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù.
D.P.R. dell’11/02/2010
l ivello iniziale l ivello b a S e l ivello in T ermedio
Conosce e comprende alcuni aspetti del linguaggio simbolico legato alle principali feste cristiane.
Conosce, comprende ed è in grado di verbalizzare, in modo accettabile, il significato essenziale di segni e simboli sacri.
Conosce il senso religioso delle feste di Natale e Pasqua per l’uomo di oggi.
Conosce la risposta della religione cristiana alla domanda di senso dell’uomo.
Conosce la risposta della religione cristiana alla domanda di senso dell’uomo e quella delle grandi religioni del mondo.
Conosce, comprende ed è in grado di verbalizzare, in modo corretto, il significato essenziale di segni e simboli sacri.
Conosce e comprende il senso religioso delle feste di Natale e Pasqua per l’uomo di oggi.
Conosce la risposta della religione cristiana alla domanda di senso dell’uomo e sa operare un confronto con le risposte fornite dalle grandi religioni del mondo.
l ivello avanzaT o
Conosce, comprende ed è in grado di verbalizzare, in modo organico e critico, il significato essenziale di segni e simboli sacri.
Comprende e sa argomentare circa il valore delle feste di Natale e Pasqua per l’uomo di oggi.
Sviluppa riflessioni e sa rielaborare la risposta della religione cristiana alla domanda di senso dell’uomo.
Mette in relazione la proposta biblica con quella delle grandi religioni del mondo.
IndIcazIonI nazIonalI per l’Irc
D.P.R. dell’11/02/2010
Scuola secondaria di secondo grado o bie TT ivi di apprendimen T o Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale l ivello b a S e l ivello in T ermedio l ivello avanzaT o
L’alunno è aperto alla ricerca della verità e sa porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.
d io e l’uomo
l a b ibbia e le alT re fon T i
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.
L’alunno individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del Cristianesimo delle origini.
Comprende, conosce e confronta in modo semplice.
Pone alcune domande sul senso della vita ed instaura relazioni essenziali con i compagni.
Comprende, conosce e confronta in modo adeguato.
Elabora domande di senso e instaura relazioni positive con i compagni e le figure di riferimento.
Comprende, conosce e confronta in modo completo.
Elabora domande di senso per le quali ricerca risposte proprie
Si rapporta efficacemente con pari e adulti.
Comprende, conosce e confronta in modo approfondito e personale.
Si pone domande sul senso della vita con senso critico, si rapporta con gli altri in modo autentico, dimostrando piena capacità di accoglienza.
Utilizza il testo biblico e individua gli elementi specifici dei documenti in modo semplice.
Riconosce alcuni elementi essenziali della storia della Chiesa.
Utilizza il testo biblico e individua gli elementi specifici dei documenti in modo adeguato.
Riconosce e confronta gli elementi fondamentali della storia della Chiesa.
Utilizza il testo biblico e individua gli elementi specifici dei documenti in modo completo.
Ricostruisce e confronta le tappe della storia della Chiesa.
Utilizza il testo biblico e individua gli elementi specifici dei documenti in modo approfondito e personale.
Ricostruisce, rielabora e interpreta le tappe della storia della Chiesa.
o bie TT ivi di apprendimen T o
l a b ibbia e le alT re fon T i
Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale l ivello b a S e
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa, li confronta con le vicende della storia civile passata e recente.
i l linguaggio religio S o
Lo studente riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.
Comprende, riconosce e utilizza il linguaggio specifico in modo molto semplice, anche a partire dal contesto in cui vive.
Conosce i principali riti, feste, simboli.
Comprende, riconosce e utilizza il linguaggio specifico in modo adeguato a partire dal contesto in cui vive.
Conosce riti, feste, simboli e ne apprezza il loro valore.
Comprende, riconosce e utilizza il linguaggio specifico in modo appropriato a partire sia dal contesto familiare che da quello sociale.
Conosce feste, riti, simboli e ne riconosce il significato.
Comprende, riconosce e utilizza il linguaggio specifico in modo approfondito e personale, sia a partire dal proprio contesto che da altri contesti.
Conosce feste, riti, simboli, ne coglie il valore spirituale e l’intreccio con gli ambiti artistici e culturali.
i valori e T i C i e religio S i
Lo studente coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita responsabili.
Comprende e riconosce in modo semplice i valori proposti dal Cristianesimo.
Comprende, coglie e riconosce in modo adeguato i valori proposti dal Cristianesimo e dalle altre religioni.
Comprende, coglie e riconosce in modo appropriato i valori proposti dal Cristianesimo e dalle altre religioni.
Comprende, coglie e riconosce in modo approfondito e personale i valori proposti dal Cristianesimo e dalle altre religioni.
IndIcazIonI nazIonalI per l’Irc
D.P.R. dell’11/02/2010
o bie TT ivi di apprendimen T o Traguardi per lo S viluppo delle Compe T enze l ivello iniziale
i valori e T i C i e religio S i
Lo studente coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita responsabili.
Riflette sulle proprie scelte di vita in modo essenziale, intuisce l’importanza del proprio comportament o nel rapporto con gli altri.
l ivello b a S e l ivello in T ermedio
Riflette sulle proprie scelte e sul proprio comportamento.
Riflette sulle proprie scelte di vita e sul proprio comportamento in modo consapevole.
l ivello avanzaT o
Riflette sulle proprie scelte di vita sul proprio comportamento in modo consapevole e maturo.
La valutazione dell’IRC nella scuola primaria
Il Ministero dell’Istruzione, in data 4 dicembre 2020, ha pubblicato l’ordinanza sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella SCUOLA PRIMARIA, con le rispettive linee guida e una nota contenente le indicazioni operative.
Da tale documentazione si evince che, almeno per il momento, NON È PREVISTA PER L’IRC LA FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO DESCRITTIVO come valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria, MA È RIBADITO L’IMPIEGO DI UN GIUDIZIO SINTETICO, che resta disciplinato dall’art. 2, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017; dunque, “RIMANGONO INVARIATE LE MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ”, che è comunque resa su una nota distinta, con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
Facendo riferimento alle circolari ministeriali n. 20/1964 e n. 491/1996 e tenendo conto, nel contempo, delle mutate esigenze di carattere pedagogico-didattico, si propone di seguito uno schema dei diversi livelli di competenza e una tabella, che ha il solo scopo esemplificativo, di possibili GIUDIZI SINTETICI PER LA VALUTAZIONE
PERIODICA E FINALE DELL’IRC:
avanzaT o
in T ermedio
ba S e
iniziale
Livelli di competenza
Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Porta a termine in modo autonomo i compiti assegnati. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. È in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove e di proporre soluzioni originali.
Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare in modo adeguato le conoscenze e le abilità acquisite. Porta a termine in modo autonomo i compiti assegnati.
Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. Porta a termine in modo abbastanza autonomo i compiti assegnati.
L’alunno, se guidato, svolge compiti semplici in situazioni note. Non ha ancora la padronanza adeguata delle conoscenze e delle abilità. Porta a termine in modo non autonomo i compiti assegnati.
avanzaT o e CC ellen T e 10
avanzaT o o TT imo 9
in T ermedio di ST in T o 8
Esempio di Tabella di Valutazione
Spiccato interesse per le tutte le attività svolte. Acquisizione piena dei contenuti proposti e capacità di utilizzarli costruttivamente in contesti nuovi e complessi.
Vivace interesse per tutte le attività svolte. Acquisizione dei contenuti proposti e capacità di utilizzarli costruttivamente anche in altri contesti.
Vivace interesse per le attività svolte. Acquisizione dei contenuti proposti e capacità di utilizzarli costruttivamente.
in T ermedio buono 7 Interesse per le attività svolte. Acquisizione dei contenuti proposti.
ba S e S uffi C ien T e 6
Interesse per alcune attività svolte. Acquisizione dei contenuti di base.
iniziale non S uffi C ien T e 5 Poco interesse per le attività svolte. Informazioni di base non acquisite.
valuTazione dell'irC
La valutazione scolastica riguarda l’apprendimento e il comportamento degli studenti e i docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le INDICAZIONI NAZIONALI e le LINEE GUIDA SPECIFICHE per i diversi livelli. Il decreto legislativo 62/2017 attuativo della Legge 107/2015 ha modificato il modello di valutazione della scuola del primo ciclo, senza stravolgimenti bensì nell’ottica di apportare i miglioramenti di cui, negli anni, la comunità pedagogica ha condiviso l’opportunità.
La valutazione nel primo ciclo di istruzione
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il GIUDIZIO DESCRITTIVO PER CIASCUNA DELLE DISCIPLINE previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a QUATTRO DIFFERENTI
Avanzato:
l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio:
l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base:
l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
Iniziale (in via di prima acquisizione): l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Riferimenti normativi
• Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione.
• Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze.
• DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado.
• DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. - Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
• Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 , Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.
• Linee guida valutazione scuola primaria, La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria.
www.miur.gov.it/valutazione
g iudizio di profi TT o (in riferimen T o a C ono SC enze, abili Ta , C ompe T enze di SC iplinari) l ivello di profi TT o
• Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite e senza errori;
• ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione dei concetti;
• esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con l’uso di una terminologia corretta e varia, un linguaggio specifico appropriato, una sicurezza nell’esposizione;
• autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite;
• capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni.
• Conoscenze ampie, complete e approfondite;
• apprezzabile capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione dei concetti;
• esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata con l’uso di una terminologia corretta e varia, un linguaggio specifico appropriato, una sicurezza nell’esposizione;
• autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite; capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni.
• Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale;
• buona capacità di comprensione e di analisi, idonea applicazione dei concetti;
• esposizione chiara e articolata con l’uso di una terminologia corretta e varia, un linguaggio specifico appropriato;
• autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici talvolta originali.
• Conoscenze generalmente sicure e complete;
• adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta applicazione dei concetti;
• esposizione chiara e sostanzialmente corretta con l’uso di una terminologia appropriata e discretamente varia ma con qualche carenza nel linguaggio specifico;
• parziale autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite.
• Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi;
• elementare, ma pertinente, capacità di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione dei concetti;
• esposizione semplificata e sostanzialmente corretta con qualche errore a livello linguistico, lessico povero ma appropriato;
10 avanzaT o
9
8 in T ermedio
7
6 ba S e

AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile
Cos’è l’Agenda 2030?
Dal 2015 l’ONU (l’Organizzazione delle Nazioni Unite) ha dato il via ad AGENDA 2030, che è un piano per realizzare, entro il 2030, alcuni MIGLIORAMENTI SIGNIFICATIVI
PER LA VITA del Pianeta Terra e di tutti i suoi abitanti (più di 7 miliardi e mezzo di persone, ma che nel 2030 potrebbero arrivare a 9 miliardi).
Non tutti, purtroppo, vivono una VITA DIGNITOSA e non hanno buone condizioni di vita, anzi sono tante le DISUGUAGLIANZE tra i più ricchi e i più poveri. Sono infatti più di un miliardo le persone che vivono situazioni di POVERTÀ: scarsa qualità (se non mancanza) del cibo, abitazioni precarie, servizi a favore dei cittadini insufficienti, cure mediche insufficienti.
Sono ancora troppi i paesi dove le DONNE subiscono ingiustizie e non godono delle stesse possibilità a livello lavorativo, e non solo, degli uomini. Moltissimi BAMBINI non possono andare a scuola e vengono sfruttati (catapultati nel mondo del lavoro nero) per aiutare la famiglia. Inoltre, anche il pianeta terra non viene rispettato e protetto come dovrebbe, subisce continui attacchi all’ AMBIENTE , dall’INQUINAMENTO al RISCALDAMENTO DEL CLIMA , cause queste che possono portare a un peggioramento delle condizioni di vita delle generazioni future.
I Paesi dell’ONU si sono seduti intorno a un tavolo e si sono confrontati su quali sono le possibili soluzioni da adottare, a partire da quelle cose più importanti e urgenti da fare, individuando 17 OBIETTIVI da raggiungere, chiamati OBIETTIVI GLOBALI
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE.
Perché si chiamano globali?
Globali perché sono obiettivi UNIVERSALI, cioè validi (e quindi da raggiungere) per tutti gli abitanti della terra (bambini, giovani, donne, anziani, disabili), in ogni tempo e ogni luogo. Non a caso, uno degli slogan dell’Agenda 2030 è “Nessuno escluso”, in quanto nessuno deve essere lasciato indietro in questo cammino da fare insieme.
Cos’è sviluppo sostenibile?
Lo sviluppo sostenibile è quel PROGRESSO ECONOMICO che permette di migliorare le condizioni di vita di tutti gli abitanti della terra, senza andare a toccare e rovinare le risorse per le generazioni future.
AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile
Quindi, l’obiettivo è rispettare e proteggere l’ambiente dove essi vivono, senza recare alcun danno a nessuno dei suoi elementi (paesaggi, aria, acqua, piante, animali) che sono alla base della vita sulla Terra.
17 Obiettivi/Target/Goals
Lo sviluppo sostenibile è quel PROGRESSO ECONOMICO che permette di migliorare le condizioni di vita di tutti gli abitanti della terra, senza andare a toccare e rovinare le risorse per le generazioni future.
Obiettivo 1. Eliminare la povertà dal mondo.
Essere poveri non significa solo avere poco denaro, ma è anche la MANCANZA TOTALE (o quasi) DI SERVIZI che permettono una condizione di vita serena. Per povera si intende quella persona che non può soddisfare bene i propri bisogni primari, come l’acqua pulita, il cibo, la casa, l’abbigliamento. Si è stabilito che la soglia minima di povertà è di 1,90 dollari al giorno: cioè, è considerata povera una famiglia dove si vive con meno di 1 dollaro e 90 centesimi (circa 1 euro e mezzo) per persona. Povero, purtroppo, è anche CHI NON PUÒ FREQUENTARE LA SCUOLA, CHI MANGIA CIBO DI SCARSA QUALITÀ, CHI VIVE IN UNA CASA SENZA RISCALDAMENTO O ELETTRICITÀ , CHI NON PUÒ
USUFRUIRE DI UN’ASSISTENZA MEDICA E ADEGUATE CURE.
Quindi NON È UN PROBLEMA SOLO DI TIPO ECONOMICO, ma riguarda tutti gli ambiti della vita di ogni individuo, in modo che vengano garantiti i servizi di base, in modo che, anche chi dispone di poco denaro, può vivere in modo dignitoso e adeguato. Circa un miliardo di persone nel mondo vive in povertà, e questo numero aumenta laddove le persone vengono colpite da situazioni di emergenza: la guerra, le catastrofi naturali, i cambiamenti climatici, le crisi economiche. In questo prospetto, le prime vittime sono sicuramente i bambini e le bambine che vivono situazioni di povertà estrema, ed è quest’ultimi che vanno indirizzati i maggiori sforzi e i programmi nazionali per la riduzione della povertà e il miglioramento delle società del futuro. Non è un caso se l’Obiettivo numero 1 dell’Agenda 2030 è quello di sconfiggere la povertà, quindi il più importante e il primo da raggiungere.
AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile
Obiettivo 2. Sconfiggere la fame nel mondo.
Ogni giorno ci sono uomini e donne che in tutte le parti del mondo non riescono a sfamare i propri figli con un pasto nutriente. Nonostante il nostro pianeta produce cibo a sufficienza per sfamare l’intera popolazione mondiale, CI SONO ANCORA TROPPE PERSONE CHE VANNO A
DORMIRE AFFAMATE OGNI NOTTE, e inoltre, c’è un dato relativo ai più piccoli preoccupante: UN BAMBINO SU TRE È SOTTOPESO. Una cattiva alimentazione, purtroppo, genera molti problemi alla salute degli adulti e, conseguentemente, alla crescita dei più piccoli.
Una delle cause di questa situazione è collegata alla produzione agricola, che risulta insufficiente laddove ci sono guerre e conflitti tra popoli, nelle zone colpite da disastri naturali, nei paesi dove le multinazionali sfruttano i terreni locali, i mercati finanziari, che decidono i prezzi del cibo.
La questione però non è solo la fame, ma anche la MALNUTRIZIONE, cioè non avere nel proprio cibo le proteine (contenute in carne, pesce, uova, latte, legumi) e le vitamine (contenute in frutta e verdura) sufficienti che favoriscano la crescita e una vita sana.
Quindi, eliminare la fame e la malnutrizione, è una delle grandi sfide dell’Agenda 2030, che ha come obiettivo quello di aumentare la produzione agricola, aiutare i piccoli agricoltori, favorire le coltivazioni biologiche, sostenere le popolazioni colpite da guerre, disastri naturali o emergenze sanitarie, nutrire i bambini in modo adeguato ed evitare lo spreco alimentare.
Obiettivo 3. Cure e benessere per tutti.
Per vivere bene, e quindi, avere una buona qualità della vita, è importante e necessario avere una BUONA SALUTE. L’Obiettivo 3 ha come scopo quello di GARANTIRE IL BENESSERE DI TUTTI GLI ABITANTI DELLA TERRA, DI TUTTE LE ETÀ (bambini, giovani, adulti, anziani).
In questi ultimi anni sono stati già fatti molti passi in avanti in campo sanitario: la mortalità è diminuita, così come molte persone hanno la possibilità di vaccinarsi contro le malattie contagiose. Ma la strada è ancora lunga, perché è ancora troppo grande il divario tra i Paesi ricchi e quelli meno sviluppati, dove chi abita lontano dalle grandi città è costretto a fare dei veri e propri salti mortali per
AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile
ricevere un’adeguata assistenza medica.
Quindi, tra i traguardi da ottenere dall’Agenda 2030 ci sono:
• un’ASSISTENZA MEDICA (gratuita o a basso costo) di qualità per tutti;
• EVITARE LA DIFFUSIONE DI EPIDEMIE DI GRAVI MALATTIE ;
• PREVENIRE LA MORTALITÀ INFANTILE E QUELLA DELLE MAMME PARTORIENTI;
• RIDURRE IL NUMERO DELLE MORTI per malattie provocate dall’inquinamento ambientale e naturale;
• DIFFONDERE MAGGIORMENTE UNA BUONA EDUCAZIONE ALIMENTARE (evitando l’uso di alcol, fumo e droghe).
Inoltre, l’auspicio è quello che tutti i Paesi del mondo possano avere una maggiore somma di denaro da investire nella sanità e all’istruzione del personale sanitario. Infatti, l’istruzione e l’educazione, oltre a una buona informazione, sono fondamentali per raggiungere l’obiettivo di una vita sana per tutti e a tutte le età.
Obiettivo 4. Una scuola di qualità per tutti.
Per migliorare la qualità della vita delle persone è necessario un BUON LIVELLO DI ISTRUZIONE.
Fortunatamente, negli ultimi anni, è diminuito il numero di bambini e bambine che non vanno a scuola, anche se, in molte parti del mondo, per diverse ragioni, c’è chi non ha la possibilità di frequentare la scuola dell’obbligo, o che non riuscirà a portare al termine il ciclo di studi. Questi bambini e queste bambine, purtroppo, cresceranno senza saper leggere, scrivere e contare. Sono i figli delle famiglie povere che vivono in zone di emarginate, periferiche e spesso abbandonate, sono bambini e bambine malati o con qualche problema di mobilità, che vivono in zone di guerra o nei campi profughi. Ma l’istruzione non è solo una questione che riguarda l’età scolare, infatti, NEL MONDO CI SONO MOLTI ADULTI, UOMINI E SOPRATTUTTO DONNE, CHE NON SANNO NÉ LEGGERE NÉ SCRIVERE.
L’Obiettivo 4, perciò, si propone di GARANTIRE A TUTTI, BAMBINI E BAMBINE, UOMINI E DONNE, UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ , cioè un buon livello di istruzione che permetta loro di diventare dei cittadini liberi che possano e sappiano costruirsi un futuro. Quindi, l’invito dell’Agenda 2030 a tutta la comunità internazionale è quello di organizzare scuole sempre più efficienti per i più piccoli, anche nelle zone emar-
AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile
ginate, per evitare l’aumento dell’abbandono scolastico e di aiutare i giovani e gli adulti a sviluppare le proprie capacità per diventare cittadini in grado di fare delle scelte e migliorare le proprie condizioni di vita.
Obiettivo 5. Uguali diritti per donne e uomini.
Purtroppo, ancora oggi, nel mondo esistono troppe DISUGUAGLIANZE, e tra queste quella tra uomini e donne.
Anche nei Paesi cosiddetti sviluppati, dove molte leggi garantiscono pari diritti a uomini e donne, LA POPOLAZIONE FEMMINILE HA MENO OPPORTUNITÀ
IN AMBITO PROFESSIONALE, POLITICO E SOCIALE. Inoltre, quasi sempre, in una famiglia è la donna che si fa carico dei figli, rinunciando anche a possibilità lavorative.
Addirittura, IN ALCUNI PAESI DEL MONDO, LE DONNE SONO SOTTOMESSE AGLI UOMINI , e non hanno la possibilità di decidere autonomamente della loro vita e del loro futuro.
I dati riportano questa situazione:
- IL 70% DEI POVERI DEL MONDO SONO DONNE;
- LE DONNE GUADAGNANO MENO DEGLI UOMINI (anche a condizioni lavorative uguali);
- LE DONNE SI OCCUPANO DELLA CASA E DELLA FAMIGLIA offrendo in pratica servizi e un lavoro che non ha retribuzione;
- a livello politico e manageriale, SONO IN MINORANZA LE DONNE CHE OCCUPANO I RUOLI DI LEADERSHIP.
L’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 è quello di garantire i diritti delle donne in ogni angolo del mondo, perché solo l’uguaglianza tra uomini e donne può portare un miglioramento e un progresso reale di tutta la società.
Per raggiungere tale obiettivo, la comunità internazionale dovrà impegnarsi a:
• METTERE FINE A TUTTI TIPI DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE E CONTRO LE BAMBINE ;
• DARE UN MAGGIOR VALORE AL LAVORO SVOLTO IN CASA DALLE DONNE ;
• FAVORIRE E INCORAGGIARE LE DONNE NELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICA ED ECONOMICA.
• PROTEGGERE E GARANTIRE LA BUONA SALUTE DELLE DONNE ;
• PROMUOVERE LEGGI CHE GARANTISCANO LA PARITÀ TRA UOMINI E DONNE IN OGNI AMBITO DELLA VITA.
AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile
Obiettivo 6. A tutti acqua per bere e per lavarsi. Purtroppo, seppur sembra una cosa naturale aprire il rubinetto e veder scendere l’acqua potabile per bere e cucinare, questo diritto per moltissime persone nel mondo è oggi ancora un obiettivo da raggiungere.
IN MOLTE PARTI DEL MONDO CI SONO PROBLEMI DI SCARSITÀ D’ACQUA , molte persone non hanno accesso ai servizi igienici, e cosa ancor più grave, è che troppe persone, in gran parte bambini, muoiono per malattie causate da una scarsa igiene personale e per la mancanza di acqua potabile. Nonostante il pianeta Terra avrebbe sufficiente acqua potabile per dissetare tutti i suoi abitanti, LA DISPONIBILITÀ MEDIA CONTINUA A DIMINUIRE . Questo fatto è legato a diverse cause, quali il CONTINUO AUMENTO DELLA POPOLAZIONE MONDIALE , l’UTILIZZO DI ACQUA PER LA CRESCITA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE , la SCARSA MANUTENZIONE , e quindi efficienza, DI ACQUEDOTTI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE , il riscaldamento globale causato dall’effetto serra.
L’Obiettivo 6 dell’Agenda 2030 si pone i seguenti traguardi:
- GARANTIRE A TUTTI ACQUA POTABILE ;
- MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ACQUA diminuendo l’inquinamento ambientale;
- PROTEGGERE GLI ECOSISTEMI LEGATI ALL’ACQUA (montagne, foreste, paludi, fiumi, laghi)
- EVITARE SPRECHI D’ACQUA e, laddove è possibile, riciclarla;
- INFORMARE E INSEGNARE ALLE COMUNITÀ A UNA BUONA GESTIONE DELL’ACQUA A DISPOSIZIONE.
Obiettivo 7. Energia pulita per tutti.
OGNI ATTIVITÀ UMANA HA BISOGNO DI ENERGIA , e se questa è pulita può
AIUTARE A CONSERVARE MEGLIO IL PIANETA . Per energia pulita, si intende quell’ENERGIA RINNOVABILE, cioè quel tipo di energia che non deve esaurirsi, ma continuamente riformarsi; è pulita, cioè efficiente, perché il suo utilizzo deve essere basato sul risparmio, evitando sprechi, e non deve inquinare l’aria, l’acqua o il suolo.
Al contrario, oggi la produzione di energia è la principale causa del riscaldamento del pianeta, dovuto all’utilizzo di materiali (carbone e petrolio) che emettono i gas serra, cioè quei gas che trattengono il calore sulla superficie terrestre. Pur-
AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile
troppo, anche l’ambiente marino viene spesso inquinato dagli scarichi delle petroliere. Un’energia pulita, perciò deve avere come primo obiettivo la PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE. L’Obiettivo 7 dell’Agenda 2030 è la protezione dell’ambiente, e per raggiungere tale obiettivo ha definito diversi traguardi:
- la POSSIBILITÀ DI OTTENERE ENERGIA IN MODO COMODO , sicuro e conveniente a tutta la popolazione mondiale;
- l’impegno della comunità internazionale ad AUMENTARE L’USO DI ENERGIA PULITA, investendo nella ricerca, nelle nuove tecnologie e nel miglioramento delle reti e degli impianti.
Obiettivo 8. Sviluppo economico e lavoro per tutti.
Nel mondo, MOLTI LAVORATORI SONO PAGATI TROPPO POCO e, spesso, sono sfruttati. Inoltre, in alcuni casi, il lavoro è saltuario, e questo non garantisce una paga sufficiente per poter sopravvivere. Poi ci sono i disoccupati, cioè quelle persone che vorrebbero lavorare, ma che non trovano nessun tipo di impiego.
L’Obiettivo 8 dell’Agenda 2030 si propone proprio di aumentare i posti di lavoro, ma questo potrebbe non bastare. Infatti, non basta avere un lavoro per avere un’adeguata condizione di vita. Bisogna che questo tipo di impiego rispetti alcune importanti condizioni:
- DEVE ESSERE UN LAVORO DIGNITOSO, cioè che rispetti l’individuo e la sua libertà; - DEVE ESSERE UN LAVORO PAGATO GIUSTAMENTE , in relazione al costo della vita;
- DEVE RISPETTARE LA SALUTE DEI LAVORATORI e non deve danneggiare l’ambiente.
Inoltre, tra i traguardi si parla di favorire la creatività delle persone, l’imprenditorialità e il turismo sostenibile (che promuova la cultura e i prodotti locali), cercando di dare particolare attenzione all’inserimento delle donne, dei giovani e dei disabili, garantendo a tutti una paga equa e giusta per un lavoro di uguale valore.
AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile
Obiettivo 9. Nuove tecnologie per l'industria. Per lavorare una fabbrica necessita di ENERGIA ELETTRICA (produzione), di Internet (informazione), di mezzi di trasporto (vendita) ben organizzati.
Quindi oggi, per raggiungere un buon livello di sviluppo per tutti i suoi abitanti, deve investire, nelle infrastrutture più moderne ed efficienti in ogni campo. Purtroppo, ancora oggi, molti paesi non dispongono di energia elettrica in modo continuativo, o in qualche caso addirittura, manca totalmente. L’Obiettivo 9 dell’Agenda 2030 ha come traguardo quello di SVILUPPARE E DIFFONDERE NUOVE SCOPERTE DELLA TECNOLOGIA a favore dello sviluppo di tutti i paesi.
In particolare, sarà importante:
- FAR OTTENERE NUOVI FINANZIAMENTI ALLE PICCOLE IMPRESE , per rinnovare i propri macchinari e i propri strumenti;
- GARANTIRE A TUTTI, soprattutto ai paesi più poveri, L’ACCESSO A INTERNET e alle nuove tecnologie;
- FAVORIRE LA RICERCA PER LA CREAZIONE DI NUOVI PRODOTTI TECNOLOGICI che rispondano ai bisogni di ciascun Paese;
- PRENDERSI CURA DELL’AMBIENTE, creando prodotti sani e durevoli che non danneggino né la salute delle persone né l’ambiente.
Obiettivo 10. Diminuire le differenze tra poveri e ricchi.
Nel mondo ci sono persone ricche e persone povere. Questa differenza, se nei paesi ben governati, viene quasi neutralizzata, in alcuni Paesi risulta essere enorme. Si tratta dei paesi dove i ricchi possiedono immense fortune e troppe sono le famiglie povere che fanno fatica a sopravvivere, con l’assenza dei servizi di base.
Le differenze esistono tra diverse zone di uno stesso Paese (ci sono regioni più ricche e regioni più povere), così come ci sono differenze anche tra città e campagna.
Uno degli ostacoli più duri da buttare giù sono i “muri” che vengono costruiti per difendere le aree più ricche dall’immigrazione. Questi muri dividono e crea-
AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile
no distanze a volte incolmabili, con cittadini ricchi di serie A e cittadini poveri di serie B (se non C). Ridurre le disuguaglianze è importante e fondamentale per realizzare una società più giusta.
Tra i traguardi dell’Obiettivo 10 troviamo:
- FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE di un paese senza distinzione di reddito, età, sesso, religione e origine geografica;
- GARANTIRE A TUTTI LA POSSIBILITÀ DI STUDIARE E DI LAVORARE .
- CREARE UN REGIME FISCALE DOVE LE TASSE SIANO PAGATE IN BASE AL PROPRIO REDDITO .
Obiettivo 11. Città vivibili e sicure.
L’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 si occupa della CRESCITA DELLE CITTÀ e indica quali sono i traguardi da raggiungere perché questa crescita avvenga in modo sostenibile.
Le città, ingrandendosi, e quindi ospitando più persone, non devono certo andare a peggiorare l’ambiente e i servizi offerti, anzi, dovrebbero migliorarli.
Tra i traguardi dell’obiettivo 11 possiamo sottolinearne alcuni:
- la REALIZZAZIONE DI CASE SICURE, comode e ben attrezzate per tutti; - la creazione di un SISTEMA DI TRASPORTI CONVENIENTE e diffuso;
- la progettazione e la realizzazione di SPAZI VERDI E di SPAZI SOCIALI, dove le persone possano stare bene insieme;
- la garanzia, attraverso reti e strutture, di SERVIZI PER TUTTI, e soprattutto per chi ha più esigenze o problemi (bambini, disabili, anziani).
Obiettivo 12. Consumare prodotti sostenibili.
Sul pianeta Terra, oggi, SI SPRECA UNA QUANTITÀ ENORME DI CIBO (circa un terzo di quello prodotto). Tutto questo cibo finisce nella spazzatura dei consumatori, dei ristoranti e dei commercianti, oppure va a male durante il trasporto e nei magazzini.
Lo spreco di cibo, dovuto a una cattiva alimentazione o gestione, comporta lo spreco anche di risorse quali l’energia elettrica, l’acqua, ecc. Ma è solo una questione di cibo. Sono troppi gli oggetti (abbigliamento, libri, elettronica, ecc.) che
AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile
non vengono utilizzati e quindi, spesso, buttati nella spazzatura. È importante allungare la vita di cibo e oggetti il più possibile, e per far ciò, sarà utile servirsi della strategia delle 3R:
• RIDURRE: diminuire la quantità di materiali consumati;
• RACCOGLIERE: rivendere, scambiare, regalare oggetti che non si usano più;
• RICICLARE: realizzare nuovi oggetti utilizzando questi materiali, senza consumare nuove materie prime.
L’Obiettivo 12 si occupa proprio di questo, del CONSUMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE, al fine di ridurre ogni tipo di spreco, utilizzando al meglio ogni tipo di risorsa.
Tra i traguardi dell’Obiettivo 12 ci sono infatti:
- DIMINUIRE LO SPRECO ALIMENTARE almeno della metà;
- RIDURRE LA PRODUZIONE ATTRAVERSO IL RICICLO ;
- FAVORIRE L’USO DI METODI SOSTENIBILI nella fase di produzione di oggetti.
Obiettivo 13. Fermare il riscaldamento globale. L’atmosfera che circonda la Terra sta aumentando la sua temperatura, provocando fenomeni meteorologici che determinano il CAMBIAMENTO CLIMATICO. Ci sono paesi dove l’avanzata del deserto (desertificazione) sembra inarrestabile, a dei lunghi periodi di siccità; in altri paesi, invece, si verificano casi di piogge violentissime, alluvioni e uragani. Questi fenomeni, dovuti dal RISCALDAMENTO CLIMATICO e aggravati da altri fattori (disboscamento, sfruttamento di terreni e riserve d’acqua) rappresentano una grave minaccia per l’agricoltura e quindi sulla quantità di risorse alimentari a disposizione, oltre a un conseguente aumento dei prezzi di questi prodotti. Sono diverse le possibili soluzioni per fermare l’aumento della temperatura sulla Terra, ma vanno fatte presto e tutte insieme. Tra le cose da fare c’è la REALIZZAZIONE DI NUOVE FORESTE, così come sui nostri comportamenti alimentari.
Per combattere il cambiamento climatico e limitarne le conseguenze, diverse le proposte da attuare per raggiungere i traguardi dell’Obiettivo 13: - mettere in atto tutte le misure possibili per FERMARE L’AUMENTO DELLE TEMPERATURE ; - INFORMARE LE PERSONE SUI RISCHI che comporta il cambiamento climatico;
AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile
- SOSTENERE con importanti finanziamenti I PAESI PIÙ POVERI per trovare soluzioni alle conseguenze del cambiamento climatico.
Obiettivo 14. Conservare il mare e le sue risorse. Le acque del mare, che coprono circa il 70% della superficie terrestre, sono come un grande sistema respiratorio per tutto il pianeta, producendo OSSIGENO PER L’ATMOSFERA, assorbendo anidride carbonica e riciclando i rifiuti organici nella catena alimentare. Inoltre, LE ACQUE DEL MARE E DEGLI OCEANI REGOLANO IL CLIMA , assorbendo calore d’estate e restituendolo d’inverno. Quindi, LA SALUTE DELLE ACQUE MARINE È INDISPENSABILE PER IL FUTURO DELLA TERRA. Le enormi masse d’acqua degli oceani sono da considerarsi una risorsa infinita e inesauribile, che purtroppo, l’essere umano, con le sue attività, sta danneggiando, creando sempre più problemi.
Il primo pericolo è l’eccessivo riscaldamento dell’atmosfera che, provocato dall’inquinamento terrestre, è stato assorbito soprattutto dagli oceani, aumentando così la temperatura delle acque marine con gravi conseguenze per gli ecosistemi e la fauna acquatica. Inoltre, l’aumento della temperatura dell’acqua provoca più uragani, a volte con effetti distruttivi.
Un altro grosso pericolo è dato dalla PESCA ECCESSIVA, che rischia di esaurire la fauna marina, soprattutto perché, pescando anche i pesci più piccoli, non si dà il tempo necessario per la riproduzione.
Altro problema, forse il più pericoloso, è dato dall’inquinamento delle acque marine con miliardi di oggetti di plastica dispersi nel mare, che ingeriti dalle diverse specie marine, entrano direttamente nella catena alimentare, e quindi fin sulle nostre tavole.
L’obiettivo 14 dell’Agenda 2030 ha perciò stabilito tra i diversi traguardi da raggiungere i seguenti:
- RIDURRE L’INQUINAMENTO MARINO;
- REGOLARE LA PESCA, fermando soprattutto quella illegale;
- FAVORIRE LE ATTIVITÀ DEI PICCOLI PESCATORI LOCALI ;
- SOSTENERE LA RICERCA SCIENTIFICA SUI PROBLEMI DEL MARE ;
- CREARE AREE MARINE PROTETTE.
AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile
Obiettivo 15. Conservare la biodiversità. Per biodiversità si intende la varietà di specie vegetali e animali che ci vivono sulla terra.
Purtroppo sono tantissime le azioni dell’uomo che riducono la biodiversità, tra i quali il più pericoloso è l’abbattimento di alberi (soprattutto quelli delle foreste equatoriali).
I traguardi dell’Obiettivo 15 dell’Agenda 2030 da raggiungere sono:
- ARRESTARE LA DEFORESTAZIONE e aumentare il rimboschimento
- PROTEGGERE LE SPECIE A RISCHIO DI ESTINZIONE
- METTERE FINE ALLA CACCIA ILLEGALE E AL COMMERCIO DEL LEGNAME PROTETTO ;
- GARANTIRE, da parte dei governi nazionali, L’ATTUAZIONE DI LEGGI A FAVORE DELLA
BIODIVERSITÀ;
- AIUTARE I PAESI PIÙ POVERI A CONSERVARE LE PROPRIE FORESTE .
Obiettivo 16. Creare delle società pacifiche e giuste.
Raggiungere gli scopi dell’Obiettivo 16 significa abolire ogni tipo di guerra, ma non solo, significa anche COMBATTERE OGNI FORMA DI VIOLENZA: dalla criminalità organizzata allo sfruttamento di donne e bambini, dalla corruzione al traffico di armi. Purtroppo, nel mondo ci sono troppe situazioni di guerra o di forte tensione che produce conflitti armati.
Tutti sono però d’accordo nel dire che la pace è indispensabile per costruire non solo delle società giuste, ma anche per raggiungere uno sviluppo economico.
La guerra, si sa, causa inevitabilmente la PERDITA DI MOLTE VITE UMANE, ma porta anche GRAVI CONSEGUENZE SULL’ECONOMIA DI UN PAESE .
Inoltre, ragazzi e ragazze hanno difficoltà o non possono frequentare la scuola, quindi un ulteriore ostacolo alla costruzione del futuro di una società.
Negli Stati democratici, i governi hanno il compito di garantire ai cittadini servizi adeguati, ma soprattutto i diritti umani (proclamati nel 1948 dall’Assemblea Generale dell’ONU, all’interno della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani), che spesso, purtroppo, vengono violati.
I traguardi dell’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 hanno stabilito che, per la realiz-
AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile
zazione di un mondo dove regni la pace e vengano rispettati i diritti umani, tutti i Paesi devono:
- RIDURRE (sarebbe meglio eliminare) OGNI FORMA DI VIOLENZA;
- ABOLIRE LO SFRUTTAMENTO DEI PIÙ DEBOLI , soprattutto di donne e bambini;
- RIDURRE IL TRAFFICO DI ARMI e impegnarsi contro ogni forma di criminalità organizzata;
- RIDURRE LA CORRUZIONE;
- FAR PARTECIPARE ANCHE I PAESI MENO AVANZATI A TUTTE LE DECISIONI CHE RIGUARDANO IL PIANETA.
- DIFENDERE LE LIBERTÀ FONDAMENTALI ;
- promuovere e GARANTIRE LEGGI CONTRO IL RAZZISMO e ogni tipo di discriminazione.
Obiettivo 17. Far collaborare Paesi e organizzazioni.
L’ultimo obiettivo dell’Agenda 20230, il numero 17, è più un invito a sviluppare tutti i mezzi necessari per il raggiungimento degli altri Obiettivi dell’Agenda 2030, attraverso la COLLABORAZIONE FRA PAESI, a livello sia politico che economico, e con le organizzazioni internazionali. In sintesi, questo obiettivo sottolinea il fatto che nessun Paese può raggiungere lo sviluppo sostenibile da solo, se non è collegato ad altri. Al fine di ridurre le disuguaglianze presenti tra i vari paesi del mondo, sarà indispensabile AIUTARE QUELLI MENO AVANZATI a raggiungere tutti gli obiettivi dell’Agenda 2030. Il primo strumento utile per equilibrare le varie differenze è il COMMERCIO INTERNAZIONALE, fissando regole giuste, che non favoriscano soltanto i Paesi più ricchi, ma che, al contrario, faciliti il commercio dei prodotti dei paesi più poveri. Un altro strumento utile per ridurre le disuguaglianze tra Paesi è la CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE PIÙ AVANZATE E SOSTENIBILI , in modo da dare la possibilità di migliorare la qualità della vita delle persone.
Sarà quindi necessario, per raggiungere questo obiettivo, che i paesi più sviluppati investano enormi somme di denaro e finanziamenti che aiutino lo sviluppo dei paesi meno sviluppati.
CompeTenze CHiave europee
Le competenze Chiave europee:
Le competenze chiave europee sono le otto Raccomandazioni adottate dal Consiglio dell’Unione Europea (22 maggio 2018) che fanno emergere la crescente necessità di competenze imprenditoriali, sociali e civiche, indispensabili per garantire la capacità di adattarsi ai cambiamenti da parte di ciascun alunno/a.
Non sono ordinate in modo gerarchico, ma sono da considerarsi tutte di pari importanza:
Competenza alfabetica funzionale
Si concretizza nella piena capacità di comunicare, sia in forma orale che scritta, nella propria lingua, adattando il proprio registro ai contesti e alle situazioni. Fanno parte di questa competenza anche il pensiero critico e la capacità di valutazione della realtà.
Competenza multilinguistica
Prevede la conoscenza del vocabolario di lingue diverse dalla propria, con conseguente abilità nel comunicare sia oralmente che in forma scritta. Infine, fa parte di questa competenza anche l’abilità di inserirsi in contesti socio-culturali diversi dal proprio.
Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie
Le competenze matematiche considerate indispensabili sono quelle che permettono di risolvere i problemi legati alla quotidianità. Quelle in campo scientifica e tecnologico, invece, si risolvono nella capacità di comprendere le leggi naturali di base che regolano la vita sulla terra.
Competenza digitale
È la competenza propria di chi sa utilizzare con dimestichezza le nuove tecnologie, con finalità di istruzione, formazione e lavoro. A titolo esemplificativo, fanno parte di questa competenza: l’alfabetizzazione informatica, la sicurezza online, la creazione di contenuti digitali.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
È la capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il proprio percorso di formazione e carriera. Vi rientra, però, anche la spinta a inserire il proprio contributo nei contesti in cui si è chiamati ad intervenire, così come l’abilità di riflettere su sé stessi e di autoregolamentarsi.
Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza
Ognuno deve possedere le skill che gli consentono di agire da cittadino consapevole e responsabile, partecipando appieno alla vita sociale e politica del proprio paese.
Competenza imprenditoriale
La competenza imprenditoriale si traduce nella capacità creativa di chi sa analizzare la realtà e trovare soluzioni per problemi complessi, utilizzando l’immaginazione, il pensiero strategico, la riflessione critica.
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
In questa particolare competenza rientrano sia la conoscenza del patrimonio culturale (a diversi livelli) sia la capacità di mettere in connessione i singoli elementi che lo compongono, rintracciando le influenze reciproche.
Nuove linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica
Il quadro di riferimento nazionale ed internazionale
La Legge 20 agosto 2019, n. 92 (d’ora in avanti, Legge) ha istituito l’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica e ha previsto che con decreto del Ministro siano definite le Linee guida per tale insegnamento che individuano, “ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti” . Secondo quanto previsto dalle Linee guida adottate in via di prima applicazione con decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35, le Istituzioni scolastiche sono state chiamate ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di progettazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Inoltre, in questo primo quadriennio di attuazione della Legge, le scuole del primo ciclo hanno individuato propri traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento, mentre quelle del secondo ciclo di istruzione hanno individuato propri risultati di apprendimento al fine di integrare il curricolo di istituto con riferimento all’Educazione Civica.
A seguito delle attività realizzate dalle scuole e tenendo conto delle novità normative intervenute, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, i curricoli di Educazione Civica si riferiscono a traguardi e obiettivi di apprendimento definiti a livello nazionale, come individuati dalle presenti Linee guida che sostituiscono le precedenti.
Tra le tematiche recentemente richiamate dalla normativa nazionale si sottolinea una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, alla educazione stradale4 e alla promozione dell’educazione finanziaria. Le Linee guida si configurano come strumento di supporto e sostegno ai docenti anche di fronte ad alcune gravi emergenze educative e sociali del nostro tempo quali, ad esempio, l’aumento di atti di bullismo, di cyberbullismo e di violenza contro le donne, la dipendenza
dal digitale, il drammatico incremento dell’incidentalità stradale – che impone di avviare azioni sinergiche, sistematiche e preventive in tema di educazione e sicurezza stradale – nonché di altre tematiche, quali il contrasto all’uso delle sostanze stupefacenti, l’educazione alimentare, alla salute, al benessere della persona e allo sport.
Le Linee guida, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 della Legge, mirano innanzitutto a favorire e sviluppare nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana – riconoscendola non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come riferimento prioritario per identificare valori, diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese – nonché delle istituzioni dell’Unione Europea.
La conoscenza della Costituzione – nelle sue dimensioni storiche, giuridiche, valoriali – rappresenta il fondamento del curricolo di Educazione Civica.
In questo senso va sottolineato il carattere personalistico della nostra Costituzione. Ne discende la necessità di sottolineare la centralità della persona umana, soggetto fondamentale della storia, al cui servizio si pone lo Stato.
Da qui nasce l’importanza di valorizzare i talenti di ogni studente e la cultura del rispetto verso ogni essere umano. Da qui il carattere fondamentale dei valori di solidarietà, di libertà, di eguaglianza nel godimento dei diritti inviolabili e nell’adempimento dei doveri inderogabili. Da qui il concetto stesso di democrazia che la nostra Costituzione collega non casualmente alla sovranità popolare e che, per essere autentica, presuppone lo Stato di diritto. Da qui anche la funzionalità della società allo sviluppo di ogni individuo (e non viceversa) ed il primato dell’essere umano su ogni concezione ideologica.
Le nuove Linee guida, in piena coerenza con il dettato costituzionale, sottolineano non solo la centralità dei diritti, ma anche dei doveri verso la collettività, che l’articolo 2 della nostra Carta costituzionale definisce come “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. L’importanza di sviluppare anche una cultura dei doveri rende necessario insegnare il rispetto verso le regole che sono
poste per una società ordinata al fine di favorire la convivenza civile, per far prevalere il diritto e non l’arbitrio. Da qui l’importanza fondamentale della responsabilità individuale che non può essere sostituita dalla responsabilità sociale. Pienamente coerente con la Costituzione è anche la necessità di valorizzare la cultura del lavoro come concetto fondamentale della nostra società da insegnare già a scuola fin dal primo ciclo di istruzione. La scuola, unitamente alla famiglia e alle altre istituzioni del territorio, ha la responsabilità di supportare gli studenti nel percorso che li porta a diventare cittadini responsabili, autonomi, consapevoli e impegnati in una società sempre più complessa e in costante mutamento. In questo contesto è fondamentale l’alleanza educativa fra famiglia e scuola. La scuola “costituzionale” che ispira l’educazione alla cittadinanza, proprio perché dà centralità alla persona dello studente, deve sempre favorire l’inclusione, a iniziare dagli studenti con disabilità, dal recupero di chi manifesta lacune negli apprendimenti, dal potenziamento delle competenze di chi non ha eguali opportunità formative e di chi non utilizza pienamente l’italiano come lingua veicolare. Insomma, la scuola costituzionale è quella che stimola e valorizza ogni talento.
In questa prospettiva, l’Educazione Civica favorisce il riconoscimento di valori e comportamenti coerenti con la Costituzione attraverso il dialogo e il rispetto reciproco, volti a incoraggiare un pensiero critico personale, aperto e costruttivo, in un percorso formativo che, coinvolgendo la persona nella sua interezza e unitarietà, inizia dall’infanzia e prosegue lungo tutto l’arco della vita.
L’Educazione Civica deve contribuire ad una formazione volta a favorire l’inclusione degli alunni stranieri nella scuola italiana. L’insegnamento dell’Educazione Civica può supportare gli insegnanti nel lavoro dell’integrazione, producendo nei suoi esiti coesione civica e senso della comunità, evitando che anche in Italia si verifichino fenomeni di ghettizzazione urbana e sociale.
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica offrono una cornice efficace entro la quale poter inquadrare temi e obiettivi di apprendimento coerenti con quel sentimento di appartenenza che deriva dall’esperienza umana e sociale del nascere, crescere e convivere in un Paese chiamato Italia. È in tale realtà geografica ed esperienziale insieme che il bambino comincia a rappresentare se stesso e se stesso in relazione al mondo. Per questa ragione il ruolo della scuola diventa fondamentale anche al fine di svelare il significato del ricchissimo patrimonio culturale e ambientale dell’Italia, dei suoi territori e delle sue comunità. L’Edu-
cazione Civica può proficuamente contribuire a formare gli studenti al significato e al valore dell’appartenenza alla comunità nazionale che è comunemente definita Patria, concetto che è espressamente richiamato e valorizzato dalla Costituzione . Rafforzare il nesso tra il senso civico e l’idea di appartenenza alla comunità nazionale potrà restituire importanza, fra l’altro, al sentimento dei doveri verso la collettività, come prescritto dall’articolo 2 della Costituzione, nonché alla coscienza di una comune identità italiana come parte, peraltro, della civiltà europea ed occidentale e della sua storia, consapevolezza che favorisce un’autentica integrazione. Inoltre, l’insegnamento dell’Educazione Civica aiuta gli studenti a capire la storia intera del Paese, riconoscendola nella ricchezza delle diversità dei singoli territori e valorizzando le varie eccellenze produttive che costituiscono il “Made in Italy”. Dovrebbe far comprendere che la cittadinanza si costruisce attraverso l’identificazione con i valori costituzionali, l’esercizio responsabile delle virtù civiche, la valorizzazione dei territori che costituiscono la Repubblica, con le loro tipicità e tradizioni. In questo contesto l’appartenenza alla Unione Europea appare coerente con lo spirito originario del trattato fondativo volto a favorire la collaborazione tra Paesi che hanno valori ed interessi generali comuni. Importante risulta anche educare a riconoscere la sussidiarietà orizzontale quale principio costituzionale che promuove l’iniziativa autonoma dei cittadini, sia come “singoli” che in “forma associata”. Spirito di iniziativa e di imprenditorialità sono, inoltre, competenze sempre più richieste per affrontare le sfide e le trasformazioni sociali attuali oltre che espressione di un sentimento di autodeterminazione. Parallelamente alla valorizzazione della iniziativa economica privata si evidenzia l’importanza della proprietà privata, tutelata dall’articolo 42 della Costituzione e che, come ben definisce la Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, è un elemento essenziale della libertà individuale e che va dunque rispettata e incoraggiata. In tali direzioni, le Linee guida propongono un approccio sistematico e trasversale per la progettazione, valutazione e promozione dei valori e delle competenze di Educazione Civica.
Il richiamo al principio della trasversalità dell’insegnamento dell’Educazione Civica si rende necessario anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una singola disciplina e neppure ad ambiti disciplinari delimitati.
La scelta italiana di individuare l’Educazione Civica come insegnamento trasversale e ambito di apprendimento interdisciplinare è coerente con i documenti europei e internazionali in materia di educazione alla cittadinanza. Inoltre, accanto al principio della trasversalità, è opportuno fare riferimento anche a quello dell’apprendimento esperienziale, con l’obiettivo, sotto il profilo metodologico-didattico, di valorizzare attività di carattere laboratoriale, casi di studio, seminari dialogici a partire da fatti ed eventi di attualità, così come esperienze di cittadinanza attiva vissute dagli studenti in ambito extra-scolastico e che concorrono a comporre il curricolo di Educazione Civica, grazie anche ad una loro rilettura critico-riflessiva e alla loro discussione sotto la guida del docente e nel confronto reciproco tra pari, ovvero nel confronto esperienziale fra studenti. Le Linee guida, infine, riconoscendo e valorizzando il principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, mirano a favorire e incoraggiare un più agevole raccordo fra le discipline, nella consapevolezza che ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascuno studente. Al fine di favorire l’unitarietà del curricolo e in considerazione della contitolarità dell’insegnamento tra tutti i docenti di classe o del consiglio di classe, le Linee guida sono impostate secondo i nuclei concettuali di cui all’articolo 3 della Legge che, per loro natura interdisciplinari, attraversano il curricolo e possono essere considerati in ogni argomento che tutti i docenti trattano quotidianamente.
La conoscenza del dettato costituzionale, della sua storia, delle scelte compiute nel dibattito in Assemblea costituente e la riflessione sul suo significato rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni normative devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale nel nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono innanzitutto i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento e delle funzioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’Unione Europea e le Nazioni Unite, così come la conoscenza approfondita di alcuni articoli della Costituzione, in particolare di quelli contenuti nei principi generali quali gli artt. dall’1 al 12. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e del-
le regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio, il codice della strada, i regolamenti scolastici) rientrano in questo primo nucleo concettuale, come pure la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale, come forme di appartenenza ad una Nazione, la conoscenza dell’Inno e della Bandiera europei come appartenenza ad una civiltà comune con i popoli europei, la conoscenza della Bandiera della regione e dello Stemma del comune, come appartenenza ad una comunità e ad un territorio che contribuiscono a formare la Repubblica.
In particolare, nello studio delle leggi (dalla Costituzione alle leggi ordinarie) occorre evidenziare che esse non sono prescrizioni etico/morali, ma strumenti giuridici; che sono fatte per le Persone e non le Persone per loro; che sono rivolte all’interesse comune di tutti i cittadini e servono allo scopo di regolare il rapporto autorità/libertà tra i cittadini e lo Stato. Educazione alla legalità, quindi, significa favorire la consapevolezza della necessità del rispetto delle norme per il benessere di tutti i cittadini. Rientra in questo nucleo anche l’educazione contro ogni forma di discriminazione e contro ogni forma di bullismo intesa come violenza contro la persona. Di grande importanza appare il contrasto ad ogni forma di criminalità e illegalità e in particolare la criminalità contro la persona, contro i beni pubblici e privati.
La tematica potrà essere opportunamente affrontata analizzando la diffusione territoriale della criminalità organizzata, i fattori storici e di contesto che hanno favorito la nascita e la crescita delle mafie e i suoi effetti economici e sociali, identificando comportamenti privati che possano contribuire a contrastare ogni forma di criminalità. Analogamente, trova collocazione l’educazione stradale –intesa anche come sicurezza stradale – finalizzata all’acquisizione da parte degli studenti di comportamenti responsabili quali utenti della strada, abituando i giovani al rispetto della vita propria e altrui e delle regole del codice della strada. Infine, in questo primo ambito, rientra anche l’esplicitazione della dimensione dei diritti e dei doveri che conseguono alla partecipazione alla vita della comunità nazionale ed europea e che sono spesso intrecciati fra loro, come insegna l’esempio del lavoro, inteso non solo come diritto (articolo 4, comma 1, della Costituzione) ma anche come dovere civico (articolo 4, comma 2, della Costituzione), e in più valore sul quale si fonda la nostra Repubblica (articolo 1, comma 1, della Costituzione).
È importante educare i giovani ai concetti di sviluppo e di crescita. Per questo, la valorizzazione del lavoro, come principio cardine della nostra società, e dell’iniziativa economica privata è parte fondamentale di una educazione alla cittadinanza. La diffusione della cultura di impresa consente alle studentesse e agli studenti di potenziare attitudini e conoscenze relative al mondo del lavoro e all’autoimprenditorialità. Ovviamente, lo sviluppo economico deve essere coerente con la tutela della sicurezza, della salute, della dignità e della qualità della vita delle persone, della natura, anche con riguardo alle specie animali e alla biodiversità, e più in generale con la protezione dell’ambiente. In questa prospettiva, che trova un particolare riferimento in diversi articoli della Costituzione, possono rientrare tematiche riguardanti l’educazione alla salute, alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi, alla bioeconomia, anche nell’interesse delle future generazioni (così come previsto dall’articolo 9 della Costituzione recentemente riformulato). In questo quadro si inserisce pure la cultura della protezione civile per accrescere la sensibilità sui temi di autoprotezione e tutela del territorio.
Analogamente trovano collocazione nel presente nucleo concettuale il rispetto per i beni pubblici, a partire dalle strutture scolastiche, la tutela del decoro urbano nonché la conoscenza e valorizzazione del ricchissimo patrimonio culturale, artistico e monumentale dell’Italia.
Sempre nell’ottica di tutelare la salute e il benessere collettivo e individuale si inseriscono nell’Educazione Civica sia l’educazione alimentare per la realizzazione del corretto rapporto tra alimentazione, attività sportiva e benessere psicofisico, sia i percorsi educativi per il contrasto alle dipendenze derivanti da droghe, fumo, alcool, doping, uso patologico del web, gaming e gioco d’azzardo. Conoscere i rischi e gli effetti dannosi del consumo di ogni tipologia di droghe, comprese le droghe sintetiche, e di altre sostanze psicoattive, nonché dei rischi derivanti dalla loro dipendenza, anche attraverso l’informazione delle evidenze scientifiche circa i loro effetti per la salute è essenziale per prevenire ogni tossicodipendenza e promuovere strategie di salute e benessere psicofisico, anche conoscendo le forme di criminalità legata al traffico di stupefacenti e le azioni di contrasto esercitate dallo Stato. Rientra in questo nucleo pure l’educazione finanziaria e assicurativa e la pianificazione previdenziale, anche con riferimento
all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro. In tale nucleo dovrà essere evidenziata l’importanza della tutela del risparmio. L’educazione finanziaria va intesa inoltre come momento per valorizzare e tutelare il patrimonio privato.
Alla “Cittadinanza digitale”, da intendersi come la capacità di un individuo di interagire consapevolmente e responsabilmente con gli sviluppi tecnologici in campo digitale, è dedicato l’intero articolo 5 della Legge che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.
Lo sviluppo impetuoso delle tecnologie digitali ha portato importanti e inedite possibilità di progresso e di benessere, ma ha anche trasformato, con incredibile velocità e con effetti difficilmente prevedibili, l’organizzazione sociale del nostro tempo. La dimensione “fisica”, tangibile, della vita si è ridotta: la maggior parte delle attività si svolge nello spazio digitale, dando luogo ad una produzione massiccia di dati che circolano, in modo incessante, attraverso la rete.
I più giovani, proprio perché più vulnerabili ed esposti, sono le “vittime” elettive quando si verifica un uso lesivo della rete, perché non sempre hanno gli strumenti per capire in modo adeguato i rischi a cui si espongono. Fondamentale, pertanto, e in linea con quanto indicato dall’articolo 5, comma 2 della Legge, è l’attività di responsabilizzazione e promozione di una reale cultura della “cittadinanza digitale”, attraverso cui insegnare agli studenti a valutare con attenzione ciò che di sé consegnano agli altri in rete.
Non si tratta però solamente di una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe. Utile strumento di lavoro può essere il Quadro delle Competenze Digitali per i Cittadini – DigComp2.2 – recentemente tradotto in italiano, che fornisce esempi di conoscenze, abilità e atteggiamenti nel campo del digitale, anche con riferimento all’intelligenza artificiale, che può essere d’altro canto un utilissimo strumento per favorire la personalizzazione della didattica e degli apprendimenti. Particolare attenzione potrà essere riposta nell’aiutare gli studenti a valutare
criticamente dati e notizie in rete, individuando fonti attendibili e modalità di ricerca adeguate; allo stesso modo, potranno essere previsti approfondimenti in tema di privacy e tutela dei propri dati e identità personale, oltre ad adeguati focus che mirino a prevenire e contrastare attività di cyberbullismo. Infine, la rapida evoluzione tecnologica nel campo dell’Intelligenza Artificiale, riguardante tutti gli ambiti e temi finora menzionati, suggerisce adeguati approfondimenti in merito.
Sviluppare la cittadinanza digitale a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. Pertanto, l’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare dal primo ciclo di istruzione con opportune e diversificate strategie. Insomma, l’educazione all’uso responsabile dei dispositivi elettronici va di pari passo con la consapevolezza che l’utilizzo corretto delle tecnologie è quello che potenzia l’esercizio delle competenze individuali, non quello che lo sostituisce. In conformità con gli indirizzi ministeriali, occorre evitare l’utilizzo di smartphone e tablet nella scuola dell’infanzia e dello smartphone nella scuola primaria e secondaria di I grado; nelle scuole del primo ciclo di istruzione il tablet può essere utilizzato per finalità didattiche e inclusive.
I nuclei concettuali dell’insegnamento dell’Educazione Civica sono già impliciti nelle discipline previste nei curricoli dei diversi percorsi scolastici. Per fare solo alcuni esempi, “l’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari” trovano una naturale interconnessione, tra le altre, con le Scienze naturali e con la Geografia; l’educazione alla legalità e al contrasto alle mafie si nutre non solo della conoscenza del dettato e dei valori costituzionali, ma anche della consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino, del loro progredire storico, del dibattito filosofico e letterario. Le tematiche connesse alla cittadinanza digitale afferiscono alle competenze digitali e a tutte le
discipline, in particolare l’italiano, la matematica, la tecnologia e l’informatica. Si tratta dunque di far emergere all’interno dei curricoli di istituto elementi già presenti negli attuali ordinamenti e di rendere più consapevole ed esplicita la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.
La trasversalità dell’insegnamento si esprime, quindi, nella capacità di dare senso e significato a ogni contenuto disciplinare. I saperi hanno lo scopo di fornire agli allievi strumenti per sviluppare conoscenze, abilità e competenze per essere persone e cittadini autonomi e responsabili, rispettosi di sé, degli altri e del bene comune. Il Collegio dei Docenti e le sue articolazioni, nonché i team docenti e i consigli di classe, nella predisposizione del curricolo e nella sua pianificazione organizzativa, individuano le conoscenze e le abilità necessarie a perseguire i traguardi di competenza fissati dalle Linee Guida, attingendo anche dagli obiettivi specifici in esse contenuti. Possono, in sede di pianificazione, essere individuati percorsi didattici, problemi, situazioni, esperienze anche laboratoriali idonei ad aggregare più insegnamenti/discipline e che richiedano la specifica trattazione di argomenti propri dell’Educazione Civica. È fondamentale che le tematiche trattate siano sempre coerenti e integrate nel curricolo e siano funzionali allo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze previste nei traguardi per lo sviluppo delle competenze dalle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, dalle Linee Guida degli Istituti tecnici e professionali e dalle Indicazioni per i Licei.
La trattazione interdisciplinare deve in ogni caso salvaguardare, con l’opportuna progressività connessa all’età degli allievi, la conoscenza della Costituzione, degli ordinamenti dello Stato e dell’Unione Europea, dell’organizzazione amministrativa decentrata e delle autonomie territoriali e locali.
Riveste particolare importanza nell’insegnamento dell’Educazione Civica l’approccio metodologico, al fine di consentire agli allievi di sviluppare autentiche competenze civiche, capacità di partecipazione, cittadinanza attiva, rispetto delle regole condivise e del bene comune, attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse, pensiero critico e capacità di preservare salute, benessere e sicurezza nel mondo fisico e in quello virtuale. Il tema della Costituzione, pri-
mario e fondante, non può esaurirsi nel proporre la lettura e la memorizzazione di una serie di articoli e neanche nella conoscenza, pure necessaria e imprescindibile, dell’ordinamento e dell’organizzazione dello Stato, degli Organismi territoriali, delle Organizzazioni sovranazionali e internazionali.
L’etica nell’uso del digitale non è legata solo alle abilità tecniche e alla conoscenza dei potenziali rischi nell’utilizzo dei dispositivi e della rete.
Lo sviluppo di autentiche e stabili abilità e competenze civiche si consegue in un ambiente di apprendimento dove prima di tutto gli adulti sono modelli coerenti di comportamento, dove l’organizzazione dei tempi, degli spazi e delle attività consente la discussione, il confronto reciproco, la collaborazione, la cooperazione e l’esperienza diretta.
Occasioni di esercizio della corretta convivenza e della democrazia devono essere presenti fin dai primi anni nella quotidianità della vita scolastica, attraverso l’abitudine al corretto uso degli spazi e delle attrezzature comuni, l’osservanza di comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza propria e altrui, la cura di relazioni improntate al rispetto verso il prossimo, verso gli adulti, e verso i coetanei, l’assunzione di responsabilità verso i propri impegni scolastici, la cura di altri compagni, di cose e animali, la partecipazione alla definizione di regole nel gioco, nello sport, nella vita di classe e di scuola, l’assunzione di ruoli di rappresentanza. L’attitudine alla convivenza democratica si sviluppa, infatti, in ambienti che consentono l’esercizio di comportamenti autonomi e responsabili. Le conoscenze e le abilità connesse all’Educazione Civica trovano stabilità e concretezza in modalità laboratoriali, di ricerca, in gruppi di lavoro collaborativi, nell’applicazione in compiti che trovano riscontro nell’esperienza, nella vita quotidiana, nella cronaca.
Il laboratorio, la ricerca, il gruppo collaborativo, la riflessione, la discussione, il dibattito intorno a temi significativi, le testimonianze autorevoli, le visite e le uscite sul territorio, le attività di cura e di responsabilità come il service learning, i progetti orientati al servizio nella comunità, alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse, alla cura del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, gli approcci sperimentali nelle scienze sono tutte attività concrete, da inserire organicamente nel curricolo, che possono permettere agli studenti non solo di “applicare” conoscenze e abilità, ma anche di costruirne di nuove e di sviluppare competenze.
In un ambiente di apprendimento così organizzato, anche l’utilizzo responsabile e consapevole dei dispositivi digitali riveste importanza primaria per la ricerca, l’assunzione critica, la condivisione e lo scambio di informazioni attendibili da fonti autorevoli, con l’attenzione alla sicurezza dei dati, alla riservatezza e al rispetto delle persone.
L’affidamento agli studenti di occasioni di costruzione attiva e autonoma di apprendimento, in contesti di collaborazione, costituisce la modalità necessaria per il conseguimento di conoscenze e abilità stabili e consolidate e di competenze culturali, metodologiche, sociali, relazionali e di cittadinanza.
La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività
La Legge prevede che all’insegnamento dell’Educazione Civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico.
Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento è affidato, in contitolarità, a docenti della classe/del consiglio di classe, tra i quali è individuato un coordinatore. Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti delle discipline giuridiche ed economiche, se disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia. In caso contrario, in analogia a quanto previsto per il primo ciclo, l’insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti del consiglio di classe. In ogni caso, anche laddove la titolarità dell’insegnamento venga attribuita a un insegnante di materie giuridiche ed economiche, gli obiettivi di apprendimento vanno perseguiti attraverso la più ampia collaborazione tra tutti i docenti, valorizzando la trasversalità del curricolo.
Nell’arco delle 33 ore annuali i docenti potranno proporre attività che sviluppino con sistematicità conoscenze, abilità e competenze relative all’educazione alla cittadinanza, all’educazione alla salute e al benessere psicofisico e al contrasto delle dipendenze, all’educazione ambientale, all’educazione finanziaria, all’educazione stradale, all’educazione digitale e all’educazione al rispetto e ai nuclei fondamentali che saranno oggetto di ulteriore approfondimento, di riflessione e ricerca in unità didattiche di singoli docenti e in unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Si potranno così offrire agli allievi gli strumenti indispensabili per affrontare le questioni e i problemi in modo trasversale al curricolo, favorendo un dialogo interdisciplinare e realizzando la prospettiva educativa che rappresenta l’autentica sfida dell’insegnamento dell’Educazione Civica.
Inoltre, le Linee guida offrono l’opportunità di leggere e interpretare tutto il curricolo della scuola con riferimento ai principi e ai nuclei fondanti previsti per l’insegnamento dell’Educazione Civica, dal momento che ogni sapere potrà essere orientato ad azioni finalizzate all’esercizio di diritti e doveri, al bene comune, all’ulteriore sviluppo della conoscenza e alla salvaguardia dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. Tale prospettiva richiede la messa a punto di percorsi didattici che, per tutte le discipline, prevedano l’aspetto civico degli argomenti trattati.
La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione di tale insegnamento.
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe, formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione.
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curricolo dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il consiglio di classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, finalizzati ad accertare il conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’Educazione Civica.
Anche per l’Educazione Civica il Collegio dei docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, esplicita a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Per gli alunni della scuola primaria, la valutazione avverrà in base alla normativa in vigore nell’anno scolastico di riferimento.
L’Educazione Civica per il primo e per il secondo ciclo di istruzione: traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
Le Linee guida individuano traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento dell’Educazione Civica, da perseguire progressivamente a partire dalla scuola primaria e da conseguire entro il termine del secondo ciclo di istruzione.
I traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento delineano i risultati attesi in termini di competenze rispetto alle finalità e alle previsioni della Legge e sono raggruppati tenendo a riferimento i tre nuclei concettuali: Costituzione, Sviluppo economico e sostenibilità, Cittadinanza digitale.
Per il primo ciclo di istruzione, gli obiettivi di apprendimento rappresentano la declinazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e sono distinti per la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Per il secondo ciclo, le competenze sono declinate in obiettivi di apprendimento che possono ulteriormente essere graduati dai consigli di classe per anno di corso e possono essere realizzati attraverso una didattica per moduli, unità di apprendimento, sillabi coerenti con l’età degli studenti, il curricolo specifico del corso e la sua progressione nelle diverse annualità.
Nei corsi di istruzione per gli adulti di primo e secondo livello istituiti a norma del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, i traguardi, le competenze e gli obiettivi sono perseguiti attraverso percorsi che tengono conto delle Linee Guida di cui al D.M. 12 marzo 2015 e dei patti formativi individuali sottoscritti con gli studenti. Gli obiettivi comprendono conoscenze e abilità ritenute funzionali allo sviluppo dei traguardi e delle competenze e concorrono a sviluppare gradualmente le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Primo ciclo di istruzione
Nucleo concettuale: COSTITUZIONE
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 1
Sviluppare atteggiamenti e adottare comportamenti fondati sul rispetto di ogni persona, sulla responsabilità individuale, sulla legalità, sulla consapevolezza della appartenenza ad una comunità, sulla partecipazione e sulla solidarietà, sostenuti dalla conoscenza della Carta costituzionale, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione Internazionale dei Diritti umani.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e saperne individuare le implicazioni nella vita quotidiana e nelle relazioni con gli altri.
• Individuare i diritti e i doveri che interessano la vita quotidiana di tutti i cittadini, anche dei più piccoli.
• Condividere regole comunemente accettate.
• Sviluppare la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità locale, nazionale ed europea.
• Rispettare ogni persona, secondo il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione.
• Riconoscere, evitare e contrastare forme di violenza e bullismo presenti nella comunità scolastica.
• Curare gli ambienti, rispettare i beni pubblici e privati così come le forme di vita (piante, animali) che sono state affidate alla responsabilità delle classi.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 2
Interagire correttamente con le istituzioni nella vita quotidiana, nella partecipazione e nell’esercizio della cittadinanza attiva, a partire dalla conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni dello Stato, dell’Unione europea, degli organismi internazionali, delle Regioni e delle Autonomie locali. Essere consapevoli dell’appartenenza ad una comunità, locale e nazionale. Obiettivi di apprendimento
• Conoscere l’ubicazione della sede comunale, gli organi e i servizi principali del Comune, le principali funzioni del Sindaco e della Giunta comunale, i principali servizi pubblici del proprio territorio e le loro funzioni essenziali.
• Conoscere gli Organi principali dello Stato (Presidente della Repubblica, Camera dei deputati e Senato della Repubblica e loro Presidenti, Governo, Magistratura) e le funzioni essenziali.
• Conoscere la storia della comunità locale, nazionale ed europea a partire dagli stemmi, dalle bandiere e dagli inni.
• Conoscere il valore e il significato dell’appartenenza alla comunità nazionale.
• Conoscere il significato di Patria.
• Conoscere l’Unione Europea e l’ONU.
• Conoscere il contenuto generale delle Dichiarazioni Internazionali dei diritti della persona e dell’infanzia.
• Individuare alcuni dei diritti previsti nell’ambito della propria esperienza concreta.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 3
Rispettare le regole e le norme che governano la democrazia, la convivenza sociale e la vita quotidiana in famiglia, a scuola, nella comunità, al fine di comunicare e rapportarsi correttamente con gli altri, esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri per contribuire al bene comune e al rispetto dei diritti delle persone.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere ed applicare le regole vigenti in classe e nei vari ambienti della scuola (mensa, palestra, laboratori, cortili) e partecipare alla loro eventuale definizione o revisione.
• Conoscere il principio di uguaglianza nella consapevolezza che le differenze possono rappresentare un valore quando non si trasformano in discriminazioni.
• Conoscere i principali fattori di rischio dell’ambiente scolastico, adottare comportamenti idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza proprie e altrui e contribuire a definire comportamenti di prevenzione dei rischi.
• Conoscere e applicare le principali norme di circolazione stradale.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 4
Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela della salute e del benessere psicofisico.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere e attuare le principali regole per la cura della salute, della sicurezza e del benessere proprio e altrui, a casa, a scuola, nella comunità, dal punto di vista igienico-sanitario, alimentare, motorio, comportamentale.
• Conoscere i rischi e gli effetti dannosi delle droghe.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 5
Comprendere l’importanza della crescita economica e del lavoro. Conoscere le cause dello sviluppo economico e sociale in Italia ed in Europa, le diverse attività economiche. Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela dell’ambiente, del decoro urbano, degli ecosistemi e delle risorse naturali per una crescita economica rispettosa dell’ambiente e per la tutela della qualità della vita.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere le condizioni della crescita economica. Comprenderne l’importanza per il miglioramento della qualità della vita e ai fini della lotta alla povertà.
• Individuare, con riferimento alla propria esperienza, ruoli, funzioni e aspetti essenziali che riguardano il lavoro delle persone con cui si entra in relazione, nella comunità scolastica e nella vita privata.
• Riconoscere il valore del lavoro.
• Conoscere, attraverso semplici ricerche, alcuni elementi dello sviluppo economico in Italia ed in Europa.
• Riconoscere, a partire dagli ecosistemi del proprio territorio, le trasformazioni ambientali ed urbane dovute alle azioni dell’uomo; mettere in atto comportamenti alla propria portata che riducano l’impatto negativo delle attività quotidiane sull’ambiente e sul decoro urbano.
• Individuare nel proprio territorio le strutture che tutelano i beni artistici, culturali e ambientali e proteggono gli animali, e conoscerne i principali servizi.
• Analizzare, attraverso l’esplorazione e la ricerca all’interno del proprio comune, la qualità degli spazi verdi, e dei trasporti, il ciclo dei rifiuti, la salubrità dei luoghi pubblici.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n 6
Comprendere le cause dei cambiamenti climatici, gli effetti sull’ambiente e i rischi legati all’azione dell’uomo sul territorio. Comprendere l’azione della Protezione civile nella prevenzione dei rischi ambientali.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere ed attuare i comportamenti adeguati a varie condizioni di rischio (sismico, vulcanico, idrogeologico, climatico, …) anche in collaborazione con la Protezione civile.
• Individuare alcune trasformazioni ambientali e gli effetti del cambiamento climatico.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 7
Maturare scelte e condotte di tutela dei beni materiali e immateriali.
Obiettivi di apprendimento
• Identificare nel proprio ambiente di vita gli elementi che costituiscono il patrimonio artistico e culturale, materiale e immateriale, anche con riferimento alle tradizioni locali, ipotizzando semplici azioni per la salvaguardia e la valorizzazione.
• Riconoscere, con riferimento all’esperienza, che alcune risorse naturali (acqua, alimenti…) sono limitate e ipotizzare comportamenti di uso responsabile, mettendo in atto quelli alla propria portata.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 8
Maturare scelte e condotte di tutela del risparmio e assicurativa nonché di pianificazione di percorsi previdenziali e di utilizzo responsabile delle risorse finanziarie.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere e spiegare il valore, la funzione e le semplici regole di uso del denaro nella vita quotidiana. Gestire e amministrare piccole disponibilità economiche, ideando semplici piani di spesa e di risparmio, individuando alcune forme di pagamento e di accantonamento.
• Individuare e applicare nell’esperienza e in contesti quotidiani, i concetti economici di spesa, guadagno, ricavo, risparmio.
• Riconoscere l’importanza e la funzione del denaro.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 9
Maturare scelte e condotte di contrasto all’illegalità.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere le varie forme di criminalità, partendo dal rispetto delle regole che ogni comunità si dà per garantire la convivenza. Conoscere la storia dei vari fenomeni mafiosi, nonché riflettere sulle misure di contrasto.
• Conoscere il valore della legalità.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 5
Comprendere l’importanza della crescita economica e del lavoro. Conoscere le cause dello sviluppo economico e sociale in Italia ed in Europa, le diverse attività economiche. Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela dell’ambiente, del decoro urbano, degli ecosistemi e delle risorse naturali per una crescita economica rispettosa dell’ambiente e per la tutela della qualità della vita.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere le condizioni della crescita economica. Comprenderne l’importanza per il miglioramento della qualità della vita e ai fini della lotta alla povertà.
• Individuare, con riferimento alla propria esperienza, ruoli, funzioni e aspetti essenziali che riguardano il lavoro delle persone con cui si entra in relazione, nella comunità scolastica e nella vita privata.
• Riconoscere il valore del lavoro.
• Conoscere, attraverso semplici ricerche, alcuni elementi dello sviluppo economico in Italia ed in Europa.
• Riconoscere, a partire dagli ecosistemi del proprio territorio, le trasformazioni ambientali ed urbane dovute alle azioni dell’uomo; mettere in atto comportamenti alla propria portata che riducano l’impatto negativo delle attività quotidiane sull’ambiente e sul decoro urbano.
• Individuare nel proprio territorio le strutture che tutelano i beni artistici, culturali e ambientali e proteggono gli animali, e conoscerne i principali servizi.
• Analizzare, attraverso l’esplorazione e la ricerca all’interno del proprio comune, la qualità degli spazi verdi, e dei trasporti, il ciclo dei rifiuti, la salubrità dei luoghi pubblici.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n 6
Comprendere le cause dei cambiamenti climatici, gli effetti sull’ambiente e i rischi legati all’azione dell’uomo sul territorio. Comprendere l’azione della Protezione civile nella prevenzione dei rischi ambientali.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere ed attuare i comportamenti adeguati a varie condizioni di rischio (sismico, vulcanico, idrogeologico, climatico, …) anche in collaborazione con la Protezione civile.
• Individuare alcune trasformazioni ambientali e gli effetti del cambiamento climatico.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 7
Maturare scelte e condotte di tutela dei beni materiali e immateriali.
Obiettivi di apprendimento
• Identificare nel proprio ambiente di vita gli elementi che costituiscono il patrimonio artistico e culturale, materiale e immateriale, anche con riferimento alle tradizioni locali, ipotizzando semplici azioni per la salvaguardia e la valorizzazione.
• Riconoscere, con riferimento all’esperienza, che alcune risorse naturali (acqua, alimenti…) sono limitate e ipotizzare comportamenti di uso responsabile, mettendo in atto quelli alla propria portata.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 8
Maturare scelte e condotte di tutela del risparmio e assicurativa nonché di pianificazione di percorsi previdenziali e di utilizzo responsabile delle risorse finanziarie.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere e spiegare il valore, la funzione e le semplici regole di uso del denaro nella vita quotidiana. Gestire e amministrare piccole disponibilità economiche, ideando semplici piani di spesa e di risparmio, individuando alcune forme di pagamento e di accantonamento.
• Individuare e applicare nell’esperienza e in contesti quotidiani, i concetti economici di spesa, guadagno, ricavo, risparmio.
• Riconoscere l’importanza e la funzione del denaro.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 9
Maturare scelte e condotte di contrasto all’illegalità.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere le varie forme di criminalità, partendo dal rispetto delle regole che ogni comunità si dà per garantire la convivenza. Conoscere la storia dei vari fenomeni mafiosi, nonché riflettere sulle misure di contrasto.
• Conoscere il valore della legalità.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 10
Sviluppare la capacità di accedere alle informazioni, alle fonti, ai contenuti digitali, in modo critico, responsabile e consapevole.
Obiettivi di apprendimento
• Ricercare in rete semplici informazioni, distinguendo dati veri e falsi.
• Utilizzare le tecnologie per elaborare semplici prodotti digitali.
• Riconoscere semplici fonti di informazioni digitali.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 11
Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali consentite, individuando forme di comunicazione adeguate ai diversi contesti di relazione, adottando e rispettando le regole comportamentali proprie di ciascun contesto comunicativo.
Obiettivi di apprendimento
• Interagire con strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare semplici regole per l’utilizzo corretto di strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
• Conoscere e applicare le principali regole di partecipazione alle classi virtuali e alle piattaforme didattiche.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 12
Gestire l’identità digitale e i dati della rete, salvaguardando la propria e altrui sicurezza negli ambienti digitali, evitando minacce per la salute e il benessere fisico e psicologico di sé e degli altri.
Obiettivi di apprendimento
• Conoscere il significato di identità e di informazioni personali in semplici contesti digitali di uso quotidiano.
• Conoscere i rischi connessi con l’utilizzo degli strumenti digitali in termini di sicurezza personale.
• Conoscere semplici modalità per evitare rischi per la salute e minacce al benessere psico-fisico quando si utilizzano le tecnologie digitali. Riconoscere, evitare e contrastare le varie forme di bullismo e cyberbullismo.


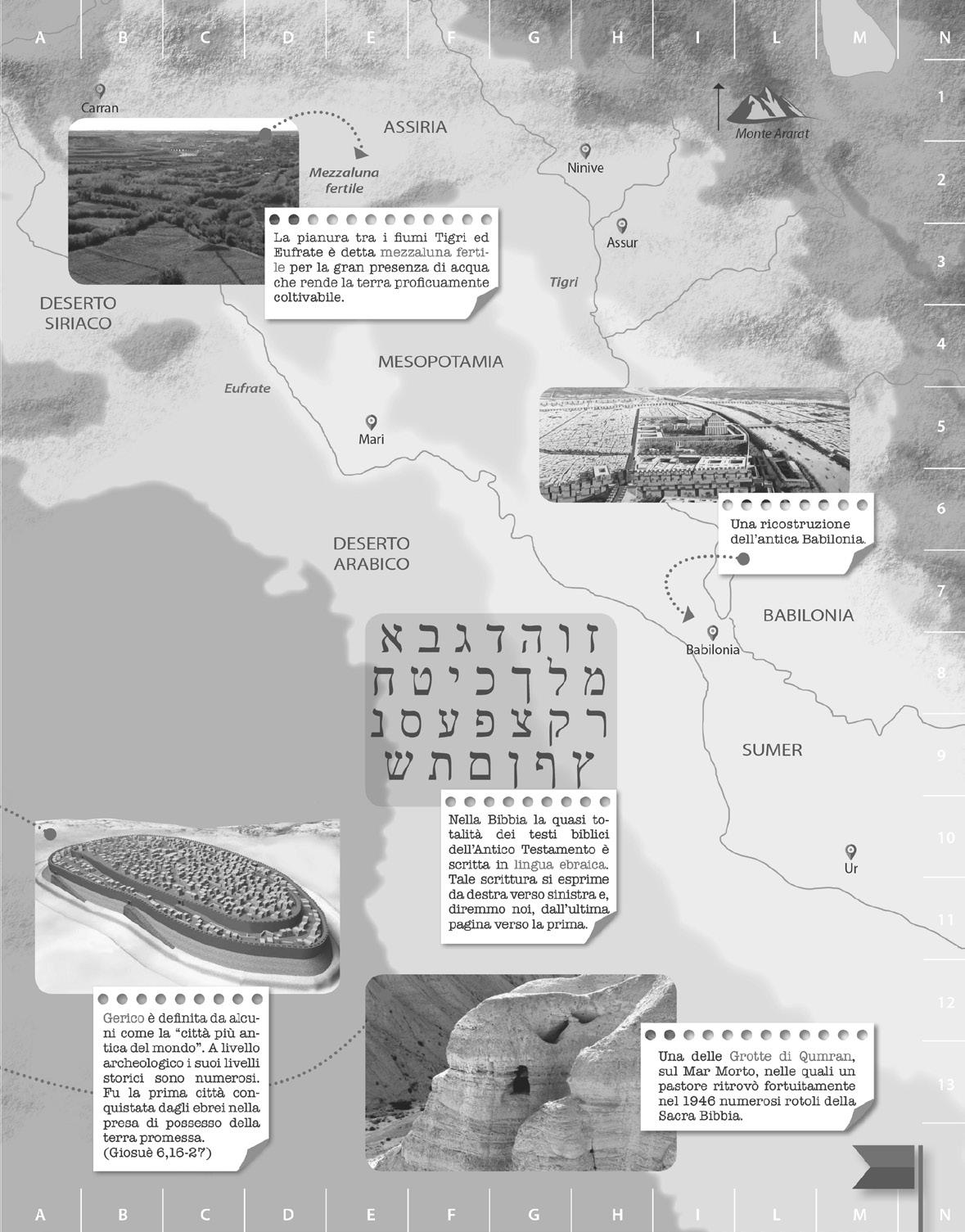
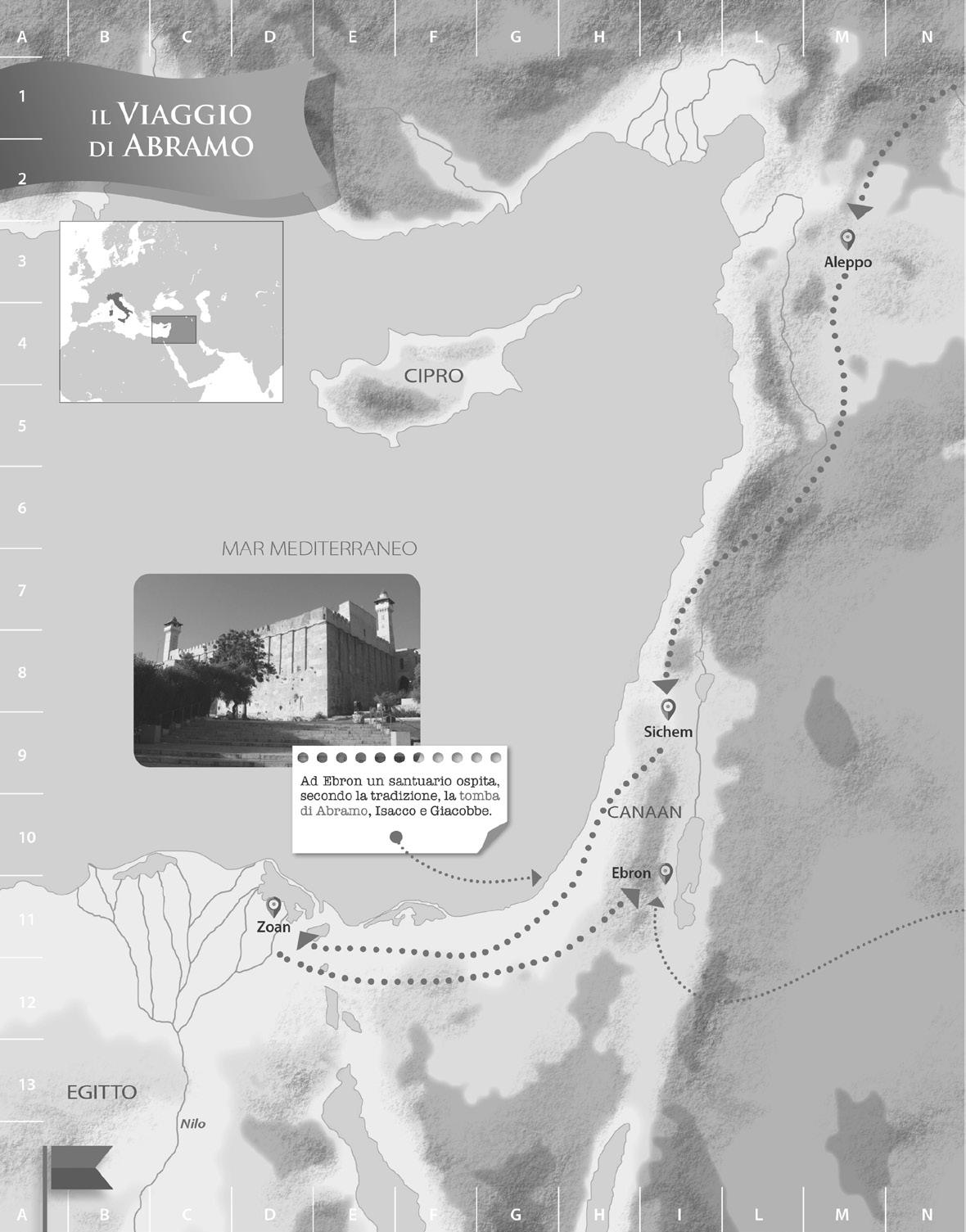
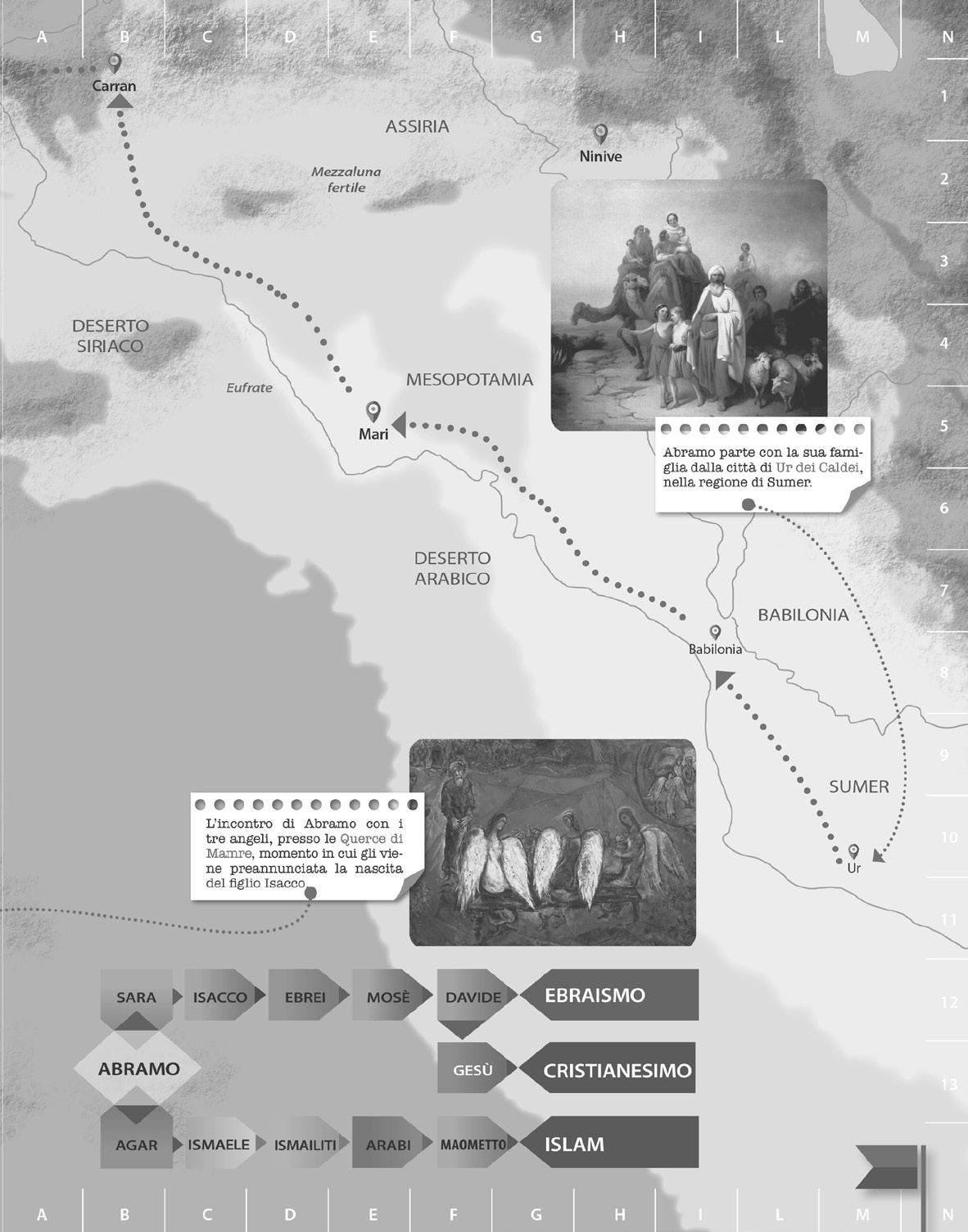



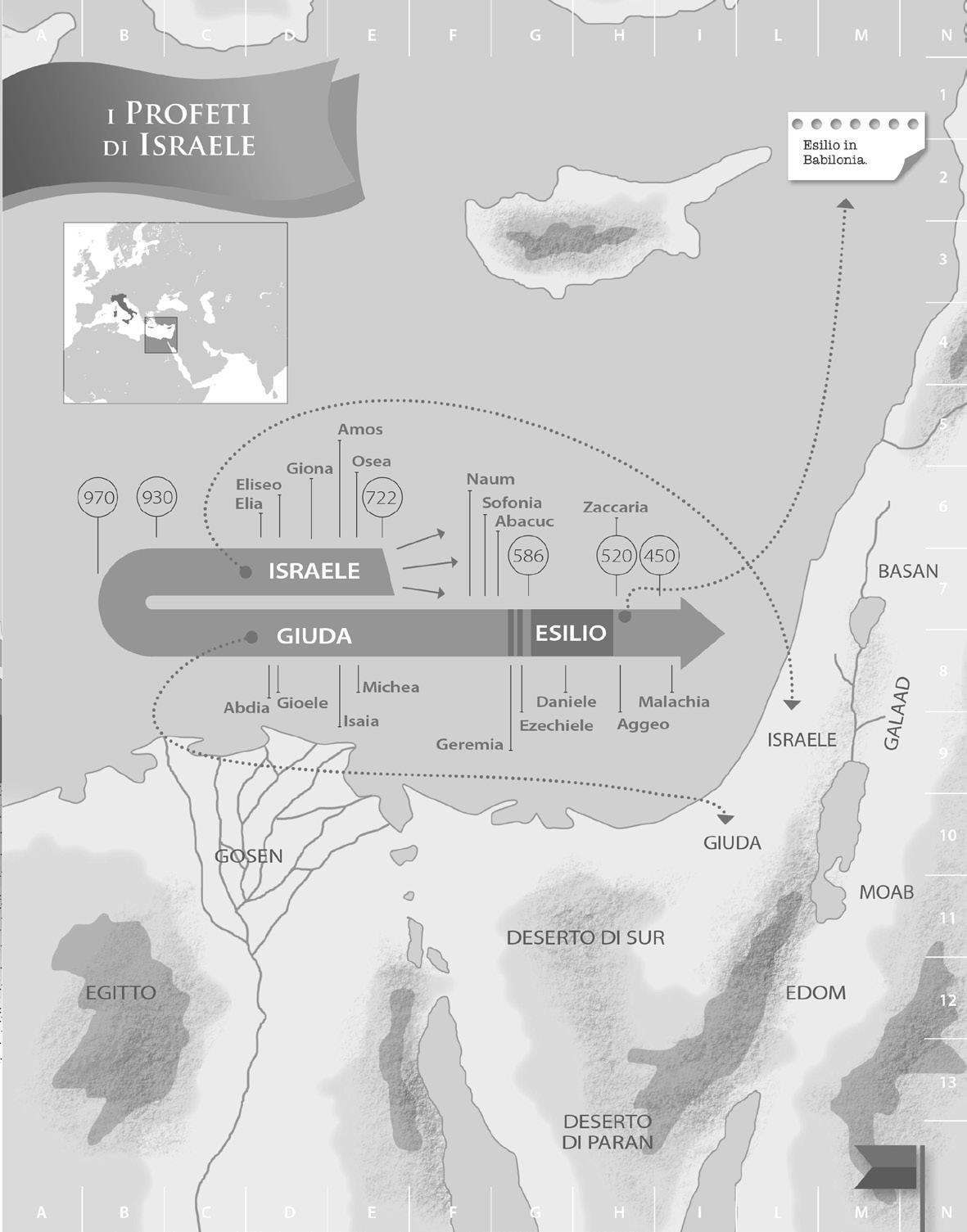

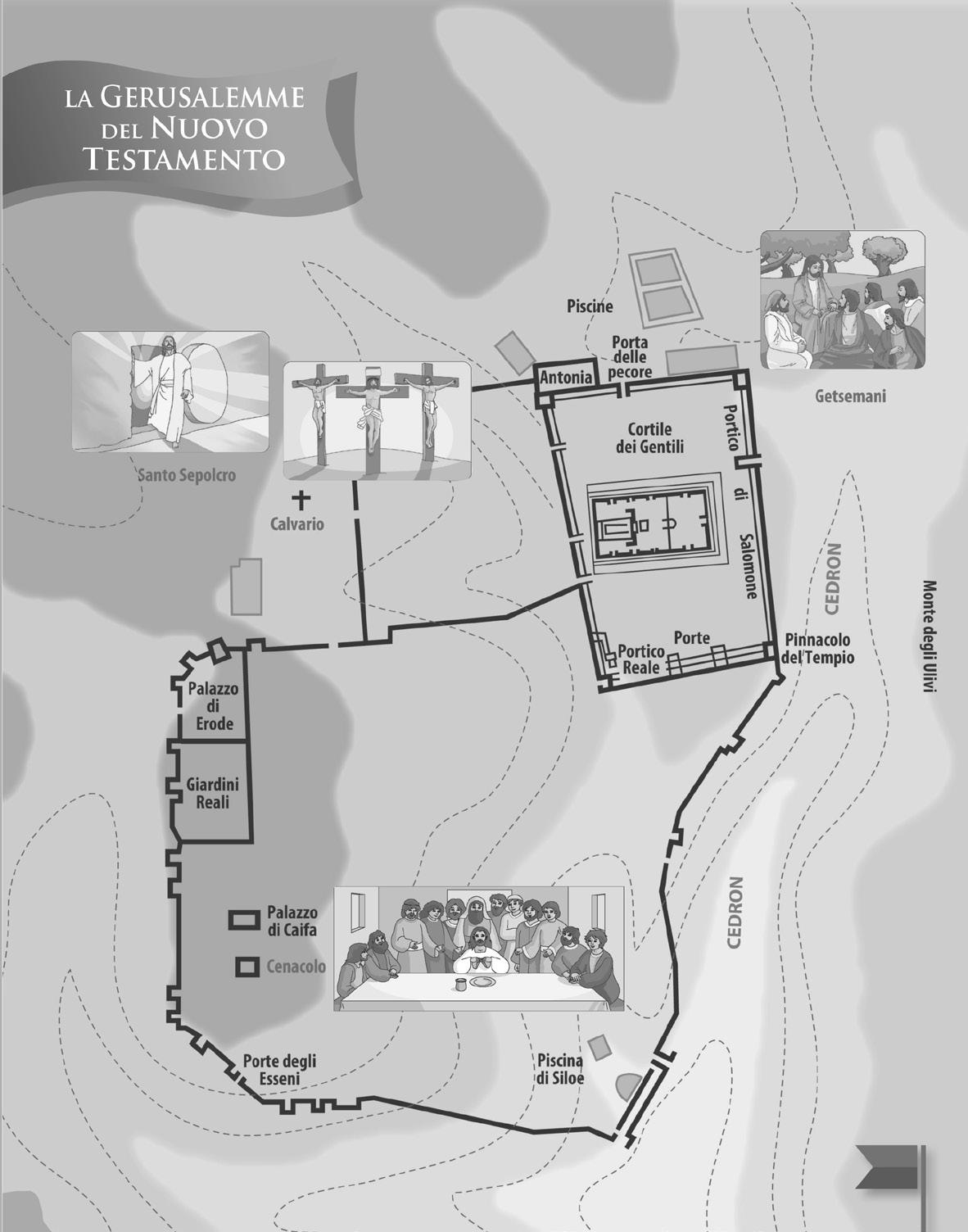
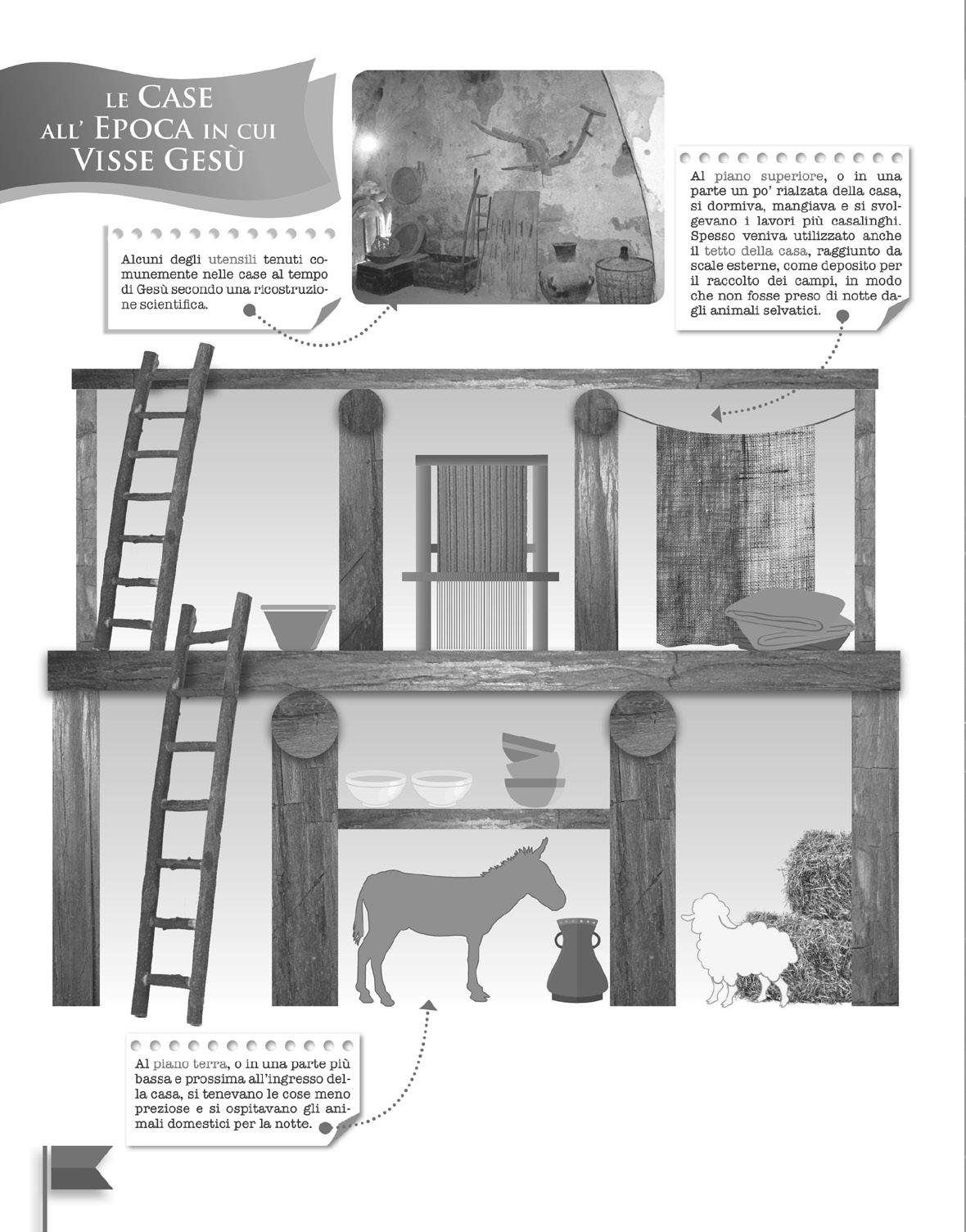

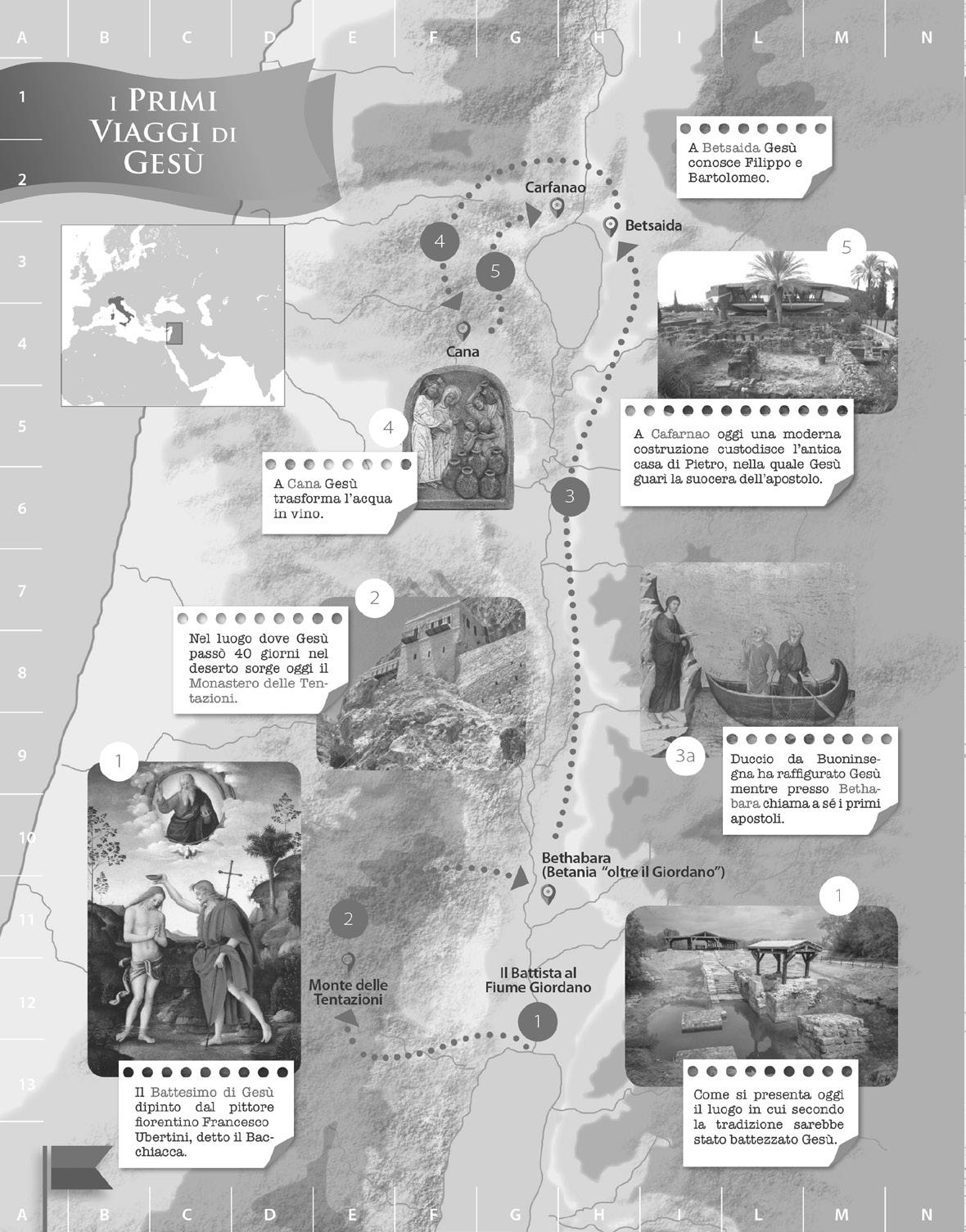
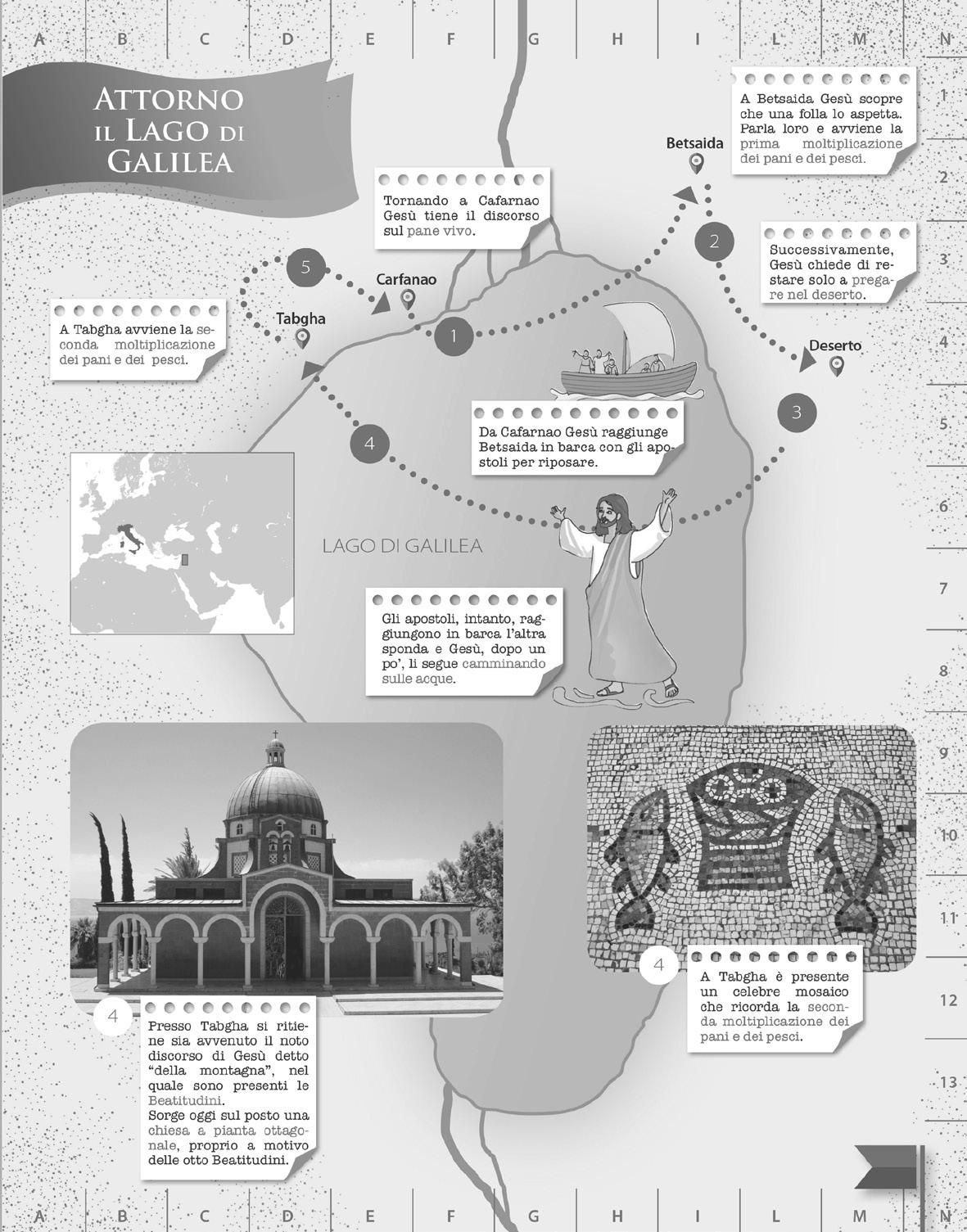

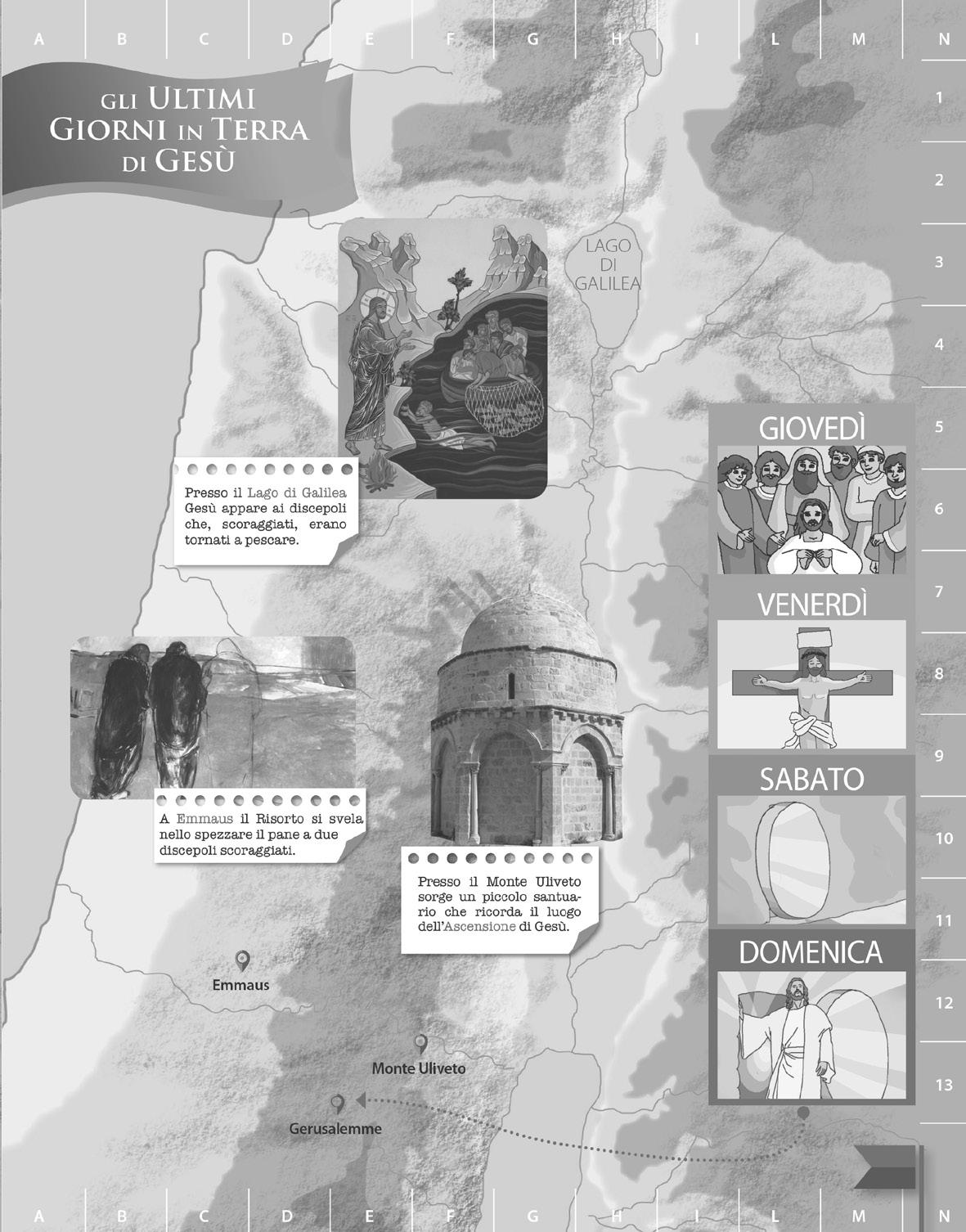
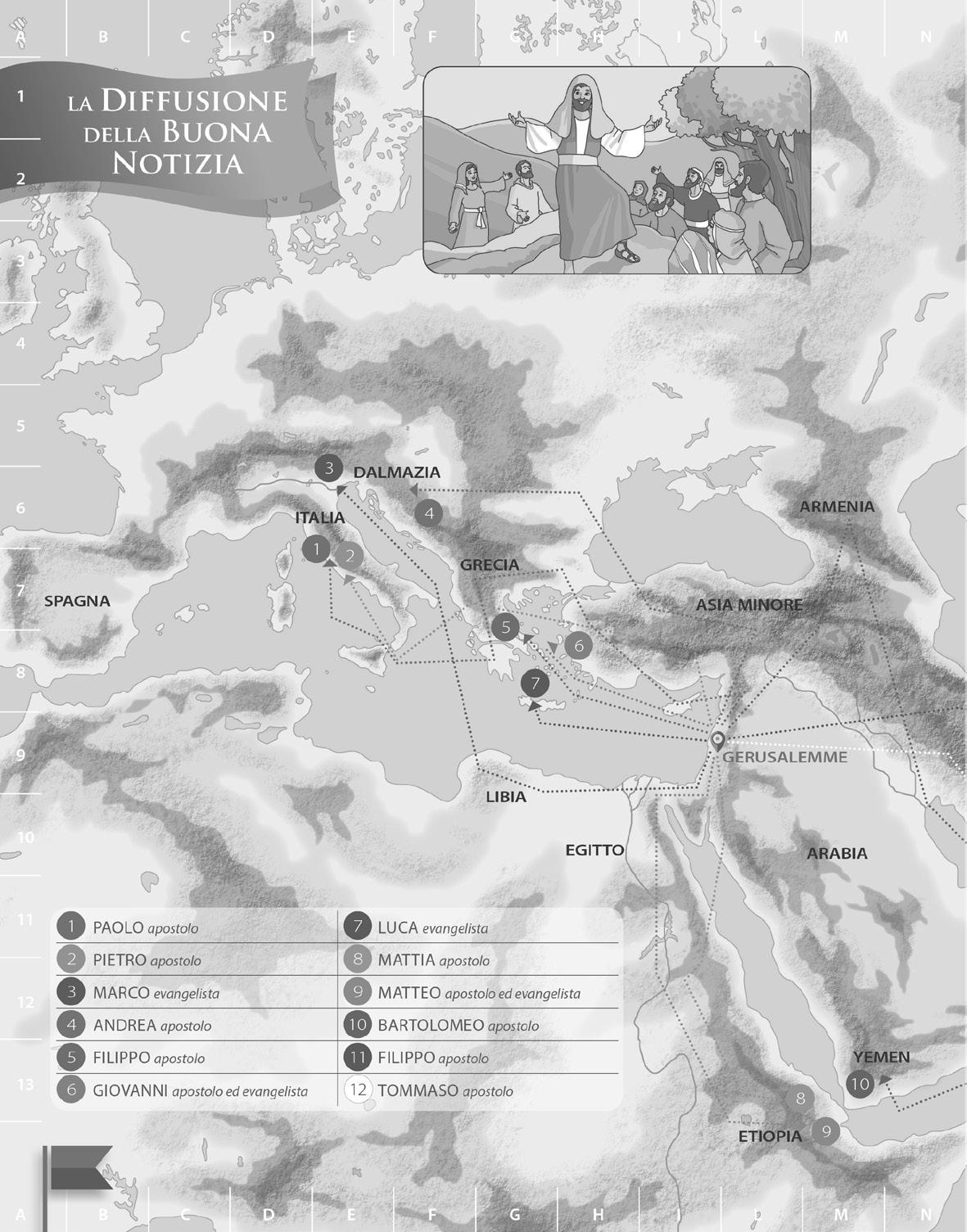

Presentazione ..............................................
Il mio libro di Religione .................................
CLASSE QUARTA
Programmazione didattica
Sezione 1: Per partire in quarta! ...................
Sezione 2: Viaggio nella storia ....................
Sezione 3: Gli Ebrei nella storia ....................
Sezione 4: Gesù, il Cristo ...............................
Sezione 5: La Pasqua cristiana
Sezione 6: La Chiesa di Gesù .........................
Impariamo dai Santi ....................................
CLASSE QUINTA
Programmazione didattica ..........................
Sezione 1: Di nuovo in viaggio .......................
Sezione 2: I giganti dell'inizio .....................
Sezione 3: La Chiesa delle origini
Sezione 4: La Chiesa nel tempo .....................
Sezione 5: La vita della Chiesa ......................
Sezione 6: Le grandi religioni
Impariamo dai Santi ....................................
APPENDICE
Verifiche aggiuntive .....................................
Indicazioni Nazionali per l'IRC
La valutazione dell'IRC ..................................
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ........
Le 8 competenze chiave europee ...................
Linee guida per l'educazione civica ...............
Atlante biblico
di Carmine Picariello
ISBN per l ’a dozione : 978-88-468-4529-0
Coordinamento e redazione: Diego Mecenero
Consulenza editoriale: Natale Benazzi
Progetto grafico e impaginazione: Elisa Panzieri
Copertina: Diletta Brutti
Illustrazioni: Stefania Bellucci, Maria Alejandra Ardila, Be Orange Ricerca iconografica: Diego Mecenero
Responsabile di produzione: Francesco Capitano
Stampa: Tecnostampa – Pigini Group Printing Division Loreto – Trevi 25.83.096.0
Nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana Prot. n. 63/2022
Roma, 25 gennaio 2022 + card. Gualtiero Bassetti
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
Imprimatur della Diocesi di Prato
Prot. n. SV-2022-0042
Prato, 2 febbraio 2022 + mons. Giovanni Nerbini
Vescovo di Prato
Parere positivo di Conformità della Conferenza Episcopale Italiana Prot. n. 4029/2024
Roma, 16 dicembre 2024
È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo testo, così come la trasmissione sotto qualsiasi forma o con qualunque mezzo, senza l’autorizzazione delle Case Editrici. Produrre un testo scolastico comporta diversi e ripetuti controlli a ogni livello, soprattutto relativamente alla correttezza dei contenuti. Ciononostante, a pubblicazione avvenuta, è possibile che errori, refusi, imprecisioni permangano. Ce ne scusiamo fin da ora e vi saremo grati se vorrete segnalarceli al seguente indirizzo: redazione@elionline.com
© 2025 | La Spiga, Gruppo Editoriale ELI info@gruppoeli.it www.gruppoeli.it
© 2025 | San Paolo Edizioni sanpaoloedizioni@stpaulus.it www.edizionisanpaolo.it
EquiLibri • Progetto Parità è un percorso del Gruppo Editoriale ELi in collaborazione con l’Università di Macerata per promuovere una cultura delle pari opportunità rispettosa delle differenze di genere, della multiculturalità e dell’inclusione, in armonia con il Magistero della Chiesa cattolica per quanto riguarda i testi di Religione cattolica.
Educability è un evento per docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, erogato dal Gruppo Editoriale ELi e riconosciuto dal MIM. Offre a docenti e dirigenti corsi di formazione sulle competenze non cognitive, grazie ai più importanti esperti in Italia di pedagogia, di psicologia e delle scienze comportamentali. Visita il sito internet: www.educability.it
classi 4 5
“il mio libro di Religione - Nuovo Detto... Fatto!” è un corso di Religione cattolica caratterizzato da forte operatività proposta in modo chiaro, semplice e lineare. A ogni pagina di contenuti corrisponde, immediatamente di seguito, l’offerta di esercizi e attività che continuano anche negli allegati ai testi degli alunni. La presente Guida didattica segue passo passo il percorso e offre inoltre altri numerosi materiali aggiuntivi.
Per lo studente




Per il docente
Codice per l’adozione classi 1a- 2a- 3a 978-88-468-4528-3
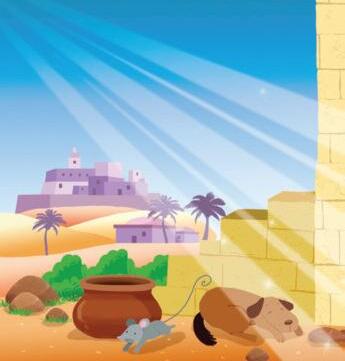
Codice per l’adozione classi 4a- 5a 978-88-468-4529-0 +