


























Editore
Massimiliano Monti

S.r.l.
via XX Settembre, 41/3


Tel. +39 010 5532701 amministrazione@edizioniliguri.it
Ufficio pubblicità
via XX Settembre, 41/3
Tel. +39 010 5532701 redazione@edizioniguri.it
Direttore Responsabile
Matteo Cantile
Produzione
Massimiliano Lussana
Direzione artistica & Impaginazione
Rolando Cassinari
Stampato da Giuseppe Lang – Arti Grafiche
Via Romairone, 66 - 16163 Genova
Foto copertina: Cristina Maioglio


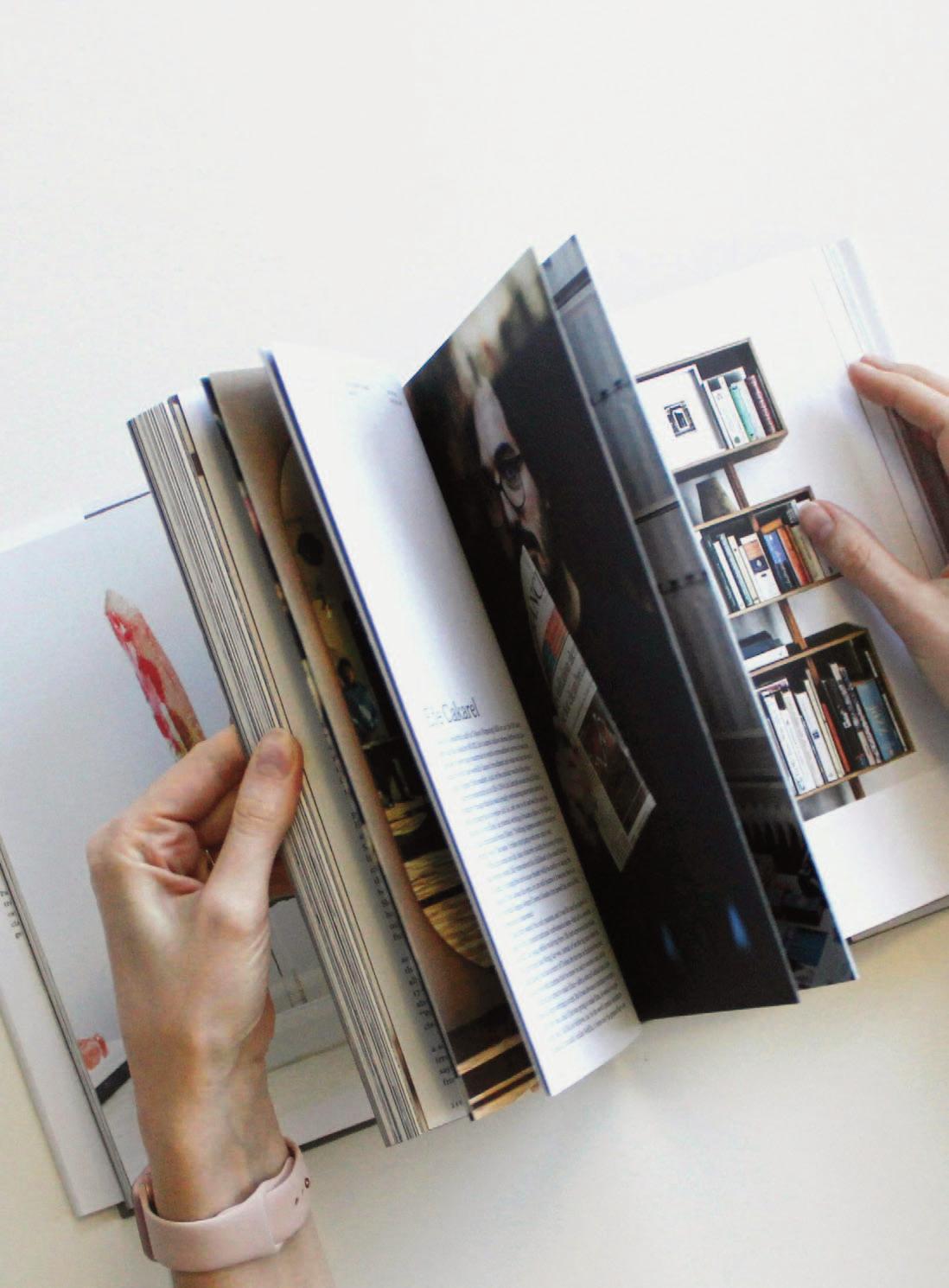
Editoriale
Pietro Piciocchi, la follia di amministrare ascoltando i cittadini
Salpare per il mondo con i Musei del Mare: Galata, Lanterna e MEI
EuroFlora 2025. Fiori e piante da tutto il mondo
Laura Sansebastiano, il "lato dolce" di Bucci
La città verticale
Genova, il piacere di salire verso il Paradiso
Dal Zeugo do Semenajo al lotto
Tutto nasce a Genova
Begato. Un quartiere rinato.
Dal Diamante nascono i fiori
Alfa. Il filo rosso dell'amore per Genova
Waterfront.
A green revolution between sky and sea.
Un investimento per il futuro
Welcome PatrickVieira
Palazzo Pallavicino, con gli incontri di Telenord il set più bello del mondo
Tullio Solenghi, non "fa" Govi, ma "diventa" Govi
Charles Dickens, "il genovese"
Alice e Asia al volteggio.
Alle Olimpiadi come nella vita
Dove i boschi raccontano storie. Una gita a Fontanigorda
Lucarda. Vestivamo alla marinara. Quando il mare è (letteralmente) di moda
















è un’espressione che vale per il passato, ma soprattutto per il presente e ancor più per il futuro. E non è solo il titolo di questo nostro viaggio attraverso le eccellenze della città, ma proprio una bussola per orientarsi attraverso tutto ciò che offre e offrirà Genova in ogni settore.
Dopo l’era di Marco Bucci finalmente si inizia a vedere compiutamente il lavoro dell’ex sindaco e della sua squadra, a partire dall’attuale facente funzione Pietro Piciocchi, con le grandi opere che disegnano il nuovo volto della città.
Un elenco di lavori la cui importanza sarà chiara a tutti col passare del tempo, un modello di città con una visione, parola chiave per comprendere il lavoro degli ultimi anni. In una parola, la città meravigliosa che i genovesi e i turisti meritano.
“Visione” significa progetti, realizzazioni che portano cambiamenti nello skyline di una città che per quasi trent’anni è rimasta immobile, con un nuovo utilizzo degli spazi e un imponente progetto di rigenerazione urbana che sta riscrivendo completamente il futuro di Genova.
Quindi va dato atto a Bucci di tutto questo lavoro e della straordinaria eredità che lascerà al sindaco che verrà e dovrà continuare a progettare e realizzare tutto ciò che serve per garantire una Genova che sia davvero meravigliosa.
L’unicità di tutto questo ci permette di raccontare sulle nostre pagine la Genova, splendida, che è stata Superba del passato e che è rinata negli ultimi anni, con un boom di turisti, di opere pubbliche e di investimenti che hanno riportato la città al centro dell’interesse del mondo non solo imprenditoriale, ma anche culturale, turistico e di attenzione in Italia e all’estero.
Ma ciò che più ci interessa e ci piace è il racconto della Genova del futuro e di come questa possa essere davvero anche una città per giovani, non più “costretti” ad emigrare e ad andare a studiare in altre città italiane o all’estero, ma che possono rimanere qui o rientrare, con un “ritorno dei cervelli”.
Di più, Genova è diventata una città attrattiva anche per molti giovani che vivevano in altre città.
Noi saremo sempre al loro fianco, perché il futuro è qui.
Qui, nella Genova meravigliosa.

Massimiliano Monti





Di Massimiliano Lussana
Dal giorno in cui è diventato sindaco facente funzione di Genova, Pietro Piciocchi ha inaugurato una sorta di dolce stil novo della gestione del Comune, andando ovunque ad ascoltare i cittadini, viaggiando da un lato all’altro della città, con giunte itineranti e intere giornate sul territorio dedicate a conoscere tutte le problematiche delle varie zone, con un’attenzione particolare alle manutenzioni e alla pulizia della città. E poi la ripresa delle colazioni col sindaco e il rinnovo della giunta, con il ritorno di un assessore alla Cultura, Lorenza Rosso, e due nuovi ingressi: Enrico Costa ai servizi sociali e Ferdinando De Fornari ai Lavori Pubblici.
A Genova Meravigliosa Piciocchi però racconta anche la sua vita privata, la sua famiglia, la sua storia, a partire dall’ultima notizia: "Sono diventato nonno". Un nonno baby, visto che ha solo 47 anni.
Al sindaco facente funzione si illuminano gli occhi quando gli chiediamo della sua famiglia e quasi si commuove: “Sono orgoglioso di loro”.
E poi racconta la sua vita, a partire dalle nozze, “eravamo giovanissimi”.
E ricordando sua moglie Emma, il giorno in cui subentrò a Marco Bucci eletto in Regione e quindi decaduto da primo cittadino, si è commosso nella Sala Rossa del Consiglio comunale di Palazzo Tursi, omaggiandola pubblicamente in quello che era il suo discorso di insediamento: “Consentitemi infine una nota personale in un giorno così importante per me: desidero ringraziare con tutto l’affetto di cui sono capace mia moglie Emma che, nonostante il notevole carico familiare, con generosità mi ha sempre sostenuto in questo mio assorbente lavoro pubblico”.

I primi tempi di Pietro ed Emma non furono certo ricchi: sua moglie aveva studiato fisarmonica e clarinetto e andò ad allietare gli anziani in una residenza protetta delle suore di don Guanella, per 700mila lire dell’epoca al mese, 350 euro di oggi. E oggi la famiglia è cresciuta: i figli sono sei più due in affido, più ovviamente la nipotina Elisa, ultima arrivata nella "tribù" dei Piciocchi.
di governo del sindaco facente funzione: “Credo che anche per amministrare serva follia, occorra gettare il cuore oltre l’ostacolo, dare fiducia. E la follia contagiosa fa il bene della comunità”. Parole che in qualche modo fanno il paio con la conclusione del suo discorso con cui ha iniziato la responsabilità da sindaco: “Personalmente ho deciso di trarre la mia ispirazione per il lavoro che mi attende dal

“La nostra è una famiglia aperta, proiettata all’esterno, con un valore sociale, i ragazzi si appoggiano reciprocamente”.
Ovviamente, è inevitabile, quando incontrano Pietro ed Emma amici e conoscenti dicono: “Ma voi siete matti!”. E qui arriva la risposta che è quasi un manifesto del Piciocchi-pensiero: “I matti fanno la differenza”.
Una ricetta che è anche parte del programma
gesto della lavanda dei piedi che mi ammonisce e mi richiama al senso di un servizio radicale, estremo, senza riserve, per la nostra città nella consapevolezza che chi ha ricevuto deve dare e che tanto più alta è la responsabilità alla quale siamo chiamati, tanto più bisogna darsi da fare, senza aspettarsi niente in cambio, mettersi all’ultimo posto, restare fermamente in quella posizione e da lì adoperarsi per gli altri”.
Discorsi che tornano ogni giorno nell’amministrazione quotidiana, “ma che hanno sempre ispirato il mio lavoro nei vari momenti, a partire da quando iniziai a lavorare con Victor Uckmar, una delle persone che mi hanno dato di più. E poi devo dire grazie a Sonia Viale, che conobbi iniziando a lavorare al Comune di Bordighera. Da lì, apprezzando il mio lavoro da amministrativista, iniziarono a chiamarmi tanti piccoli Comuni, oggettivamente allettati dal fatto che praticassi tariffe basse. Poi, sempre con Sonia andai alla segreteria tecnica di Roberto Maroni al ministero degli Interni, fino all’impegno genovese da commissario dell’Istituto Brignole all’Albergo dei Poveri, dove facemmo un bellissimo lavoro”.
elezioni, per la prima volta dal momento in cui era cambiata la legge elettorale con l’elezione diretta del sindaco, arrivò la corsa per il consi-

Nel 2017, con la candidatura di Marco Bucci e la vittoria del civismo e del centrodestra alle
glio comunale, con Piciocchi che si candidò da indipendente in “Vince Genova”, la lista di Marco Bucci, risultando il primo degli eletti di

tutto il centrodestra e diventando quindi assessore con una raffica di deleghe. Risultato bissato cinque anni dopo, in occasione della seconda elezione di Bucci: “In alcuni settori trovammo una situazione drammatica, ma si è instaurato un buon clima di lavoro, in cui si chiede tanto, si è esigenti, ma si lavora bene,

anche con la grande collaborazione degli uffici comunali. Personalmente, ho imparato moltissimo in questi anni”.
L’esperienza anche da padre aiuta Piciocchi ad affrontare uno dei temi che più gli sta a cuore, l’attenzione ai giovani: “Sento parlare di grande fuga, ma occorre considerare che il mondo oggi è caratterizzato dalla mobilità, quindi occorre analizzare il tema in modo serio. Ad esempio, quando sento dire che “questa città non offre nulla” non mi ritrovo affatto in questa definizione, mi pare una brutta narrazione, perché anzi penso che Genova sia ricca di opportunità per i giovani e il mio obiettivo è proprio quello di moltiplicare queste opportunità. E volare alto”.
Per Piciocchi tutto questo si declina anche e

soprattutto nell’individuazione di spazi che possano diventare punti di aggregazione per i giovani: “Penso ai teatri, come la riapertura del Verdi a Sestri Ponente, che ritengo un’operazione importantissima, di cui siamo orgogliosi, ma anche a ciò che abbiamo realizzato al Blue District al Molo, con la possibilità di studiare e lavorare in spazi pubblici, o alla riapertura di

biblioteche, come abbiamo fatto al CEP. I giovani non sono un mondo irraggiungibile, serve qualcuno che voglia arrivare a loro e parli apertamente. E dall’altra parte c’è volontà di ascolto, purché sentano che chi si rivolge a loro voglia loro bene, non considerandoli semplicemente prodotti commerciali da sfruttare e manipolare, ma persone a cui dare attenzione
e impegno”. Il modello, ovviamente visto con gli occhi “laici”, “è quello delle Giornate Mondiali della Gioventù”, che non erano raduni di pericolosi integralisti, ma semplicemente di giovani che avevano dei valori.
E’ tecnicamente un matto, questo Pietro Piciocchi.
Un matto erasmiano però, matto da slegare.

l Mu.MA, acronimo che sta per “Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni”, diventa grande. In ogni senso: diventa grande perché nel 2025 compie vent’anni, che per un sistema culturale significa praticamente quello che per un ragazzo è il raggiungimento della maggiore età, ma diventa anche grande perché il disegno che c’è alla base del suo sviluppo ora è sempre più chiaro ed
Di Manuela Litro
ha fatto il definitivo salto di qualità. La chiave per capire tutto questo ha anche un nome, un cognome e un volto, quelli di Mauro Iguera, che è una sorta di benefattore di Genova con la sua Cambiaso Risso, visto che la sede del gruppo è in centro a Genova, ma i clienti sono nel mondo. E che, anche ora che è stato chiamato a presiedere il Mu.MA, ha risposto nel solito modo: “Obbedisco!”.

Insieme a Iguera, c’è una squadra al femminile e vederli tutti e tre all’opera è un piacere perché luccicano loro gli occhi: Anna Dentoni è segretario generale dei Promotori dei Musei del mare, Laura Malavolta è una dipendente dell’azienda di Iguera appositamente distaccata sul lavoro dei musei.
E ci vuole, ci vuole tutto. Perchè stiamo parlando di un vero e proprio sistema museale, a partire dal Galata Museo del Mare, che è la declinazione in
terra di tutto ciò che è navigazione, il primo tassello di questa storia iniziata nel 2004. Che si è arricchito un po’ alla volta della sala Coeclerici, che racconta il piacere di navigare nell’arte, della mostra permanente sull’Andrea Doria e infine dell’archivio fotografico Leoni, tre milioni di immagini che raccontano non solo Genova, ma proprio l’evoluzione del mondo nel Novecento.
E poi, nel 2010, nello specchio d’acqua che sta davanti al Galata, in Darsena è arrivato il sottomarino Nazario Sauro, che attrae sempre più visitatori, come un’installazione, ma vivente. Ed è proprio qui che arriva la svolta anche nel numero di visitatori: 75mila, 90mila, 120mila, 150mila, 170mila, la crescita è continua.
E poi nel 2022, il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, trasferito da Roma, guidato da Paolo Masini, ospitato nella Commenda di Prè che è quasi una definizione, anche geografica e architettonica, della fusione fra culture. Con anche un’attenzione particolare all’interazione dei visi-


tatori che si trovano di fronte a un museo molto digital, con emigrazione e immigrazione raccontate in modo quasi speculare e anche momenti molto commoventi, come il memoriale dei naufragi in mare ospitato su quella che un tempo era una sorta di terrazza abbandonata. Su, su fino alla Lanterna, entrato nell’orbita Mu.MA nel 2018 e appena premiato la scorsa estate come Faro dell’Anno, una sorta di premio Nobel o Oscar per i fari di tutto il mondo, la certificazione assoluta dell’importanza della luce che illumina il porto di Genova.

Insomma, tutto questo, un tempo procedeva in ordine sparso. Ma ora, per volontà del Comune di Genova è al centro della nuova missione che

riunisce tutte queste realtà ed ha in Iguera e nella sua squadra anche la declinazione organizzativa di tutto questo.
“Il nostro scopo – racconta Iguera – è quello di integrare tre diverse realtà museali, ma anche di integrare pubblico e privato, con importanti investimenti da parte dei Promotori, benefattori che hanno a cuore la cultura del mare”.
Insomma, siamo di fronte alla definizione del perfetto connubio fra pubblico e privato che poi tocca anche quelle che sono battaglie sociali in senso lato: dal ricordo di Marcinelle e del dramma dei minatori italiani, fino al gemellaggio fra la Lanterna e la Statua della Libertà e i rispettivi musei.
La parola magica di Iguera è “progettazione” e il
suo racconto spazia dal parco urbano della Lanterna alla gioia di “costruire un sistema”.
E in tutto questo c’è anche la storia di Genova, della Liguria e d’Italia, con le partenze dal porto in direzione Lamerica, scritto proprio così, tutto attaccato, come i sogni, e l’arrivo a Ellis Island, il cui museo è perfettamente speculare a quelli del Mu.MA, con l’occhio ai cambiamenti di Genova: “Andiamo verso l’anniversario dei 900 anni della Lanterna e anche tutto ciò che sta succedendo dal punto di vista infrastrutturale in quella parte di città aiuterà a fruire ancora di più dell’area di quello che è il quinto faro più alto del mondo, che siamo orgogliosi sia diventato il faro dell’anno proprio nel 2024, valorizzando moltissimo il parco urbano attorno”.


Una storia, quella raccontata dal presidente dell’Istituzione Musei del Mare e della Navigazione, che in qualche modo è testimoniata persino dal punto di vista logistico dalla navetta che, in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune di Genova che ha finanziato l’iniziativa, ha messo a disposizione di turisti e visitatori un’apposita linea circolare fra tutte le sedi, dalla Darsena alla Lanterna, un autobus pronto a navigare sul mare o, almeno, visto che siamo sulla terraferma, sui suoi musei.
“E il futuro guarda sempre più all’integrazione fra i tre musei, il Galata con il Museo del Mare, la Commenda di Prè con il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana e la Lanterna” spiega Iguera. Che è come se tracciasse un piano aziendale,
pronto a distribuire i dividendi della cultura a tutti i visitatori che arriveranno e spiega all’unisono con Anna Dentoni: “L’unione fra questi musei permette ai visitatori di seguire un percorso che non è solo geografico, ma anche simbolico. Ogni sede rappresenta la tessera di un mosaico che parla di navigazioni e migrazioni, di approdi e partenze, di apertura al mondo”.
Partendo dalla Lanterna, che è quasi la custode del porto e dei marinai, si passa attraverso il Gala-


ta e la nascita delle traversate transoceaniche, in un viaggio che è anche quello dell’innovazione e delle scoperte tecnologiche che accompagnano i viaggi in mare, per poi arrivare alla Commenda, all’incontro e allo scambio fra i popoli.
E le loro culture.
Ma il viaggio può partire anche dalla Commenda e quindi dal racconto delle migrazioni dall’Italia verso il mondo e viceversa, per poi passare dal Galata e dalla storia epica della navigazione, per poi salpare (o approdare) alla Lanterna, simbolo della partenza da Genova e dell’arrivo a Genova.
Approdare e salpare.
Mai metafora più azzeccata.


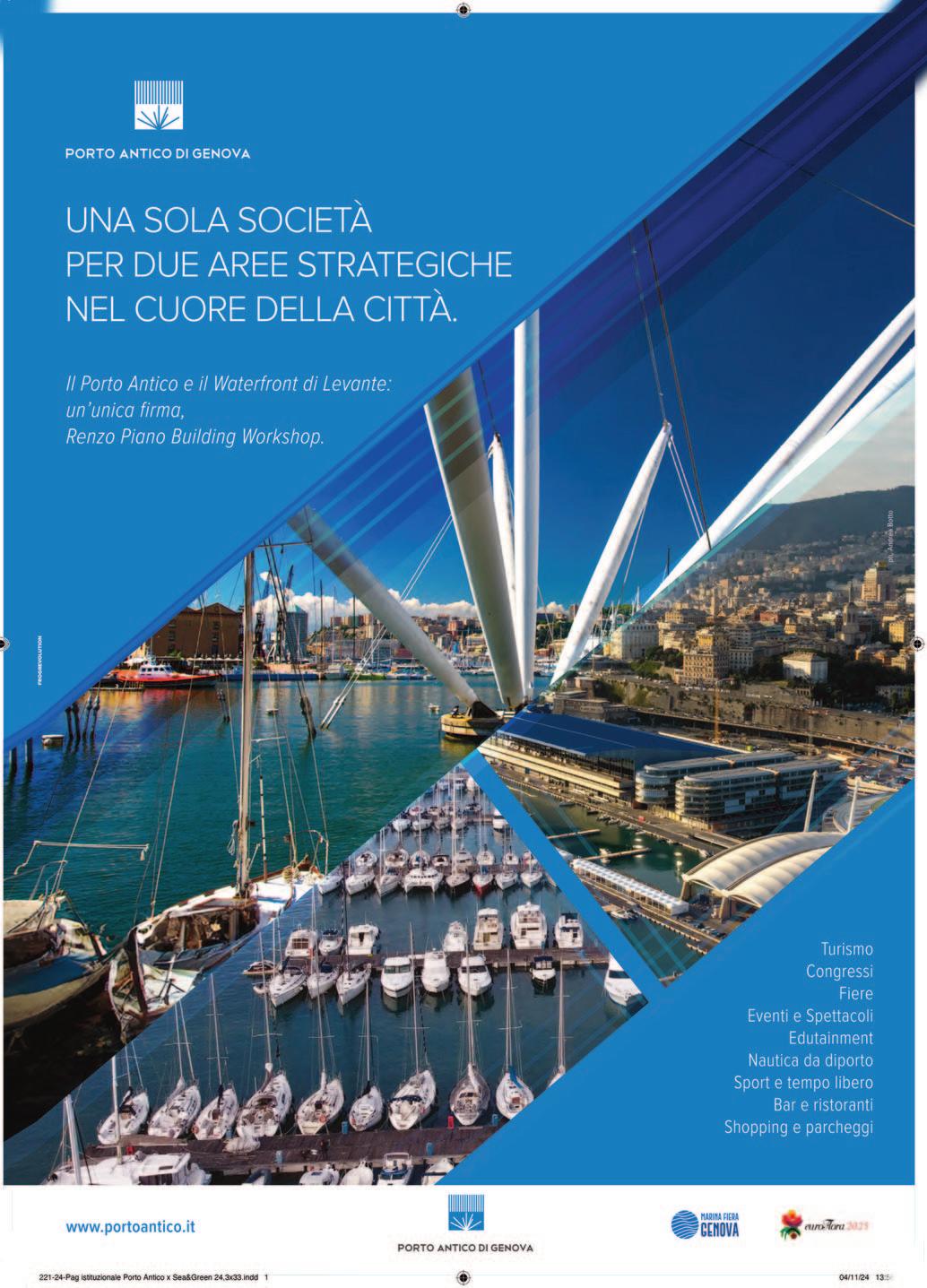


Di Manuela Litro
In principio, c’era l’Euroflora storica, quella che si svolgeva ogni cinque anni e che richiamava visitatori da tutto il mondo alla Fiera di Genova. Voluta dallo storico presidente della Fiera di Genova Carlo Pastorino - che fu anche ministro del Turismo e dello Spettacolo nel quarto governo di Giulio Andreotti e poi in una seconda vita l’inventore dell’intermediazione mobiliare in Borsa, tanto che il 9 per cento di tutto il volume di Piazza Affari passava attraverso il suo studio – fu un’intuizione geniale. E da qui occorre partire, perché il recupero delle radici e degli inizi delle storie aiuta a comprendere meglio anche il seguito. Insomma, Pastorino nel 1965 ebbe modo di visitare una “floralie”, le grandi esposizioni riconosciute da un’apposita associazione, con i fiori nel Dna, contemporaneamente cifra stilistica e ragione sociale, e se ne innamorò.

Quindi, di ritorno dal Belgio alzò il telefono e, con una delle sue intuizioni che ne hanno fatto un uomo di grandi visioni, chiamò l’associazione florivivaisti liguri e chiese: “Mi piacerebbe fare qualcosa di simile anche a Genova”.
Detto, fatto. E nel 1966 la prima Euroflora in Fiera fu una realtà, con una cadenza quinquennale e un successo crescente di edizione in edizione, tanto che in dieci edizioni svoltesi nei padiglioni di piazzale Kennedy si sono registrati oltre cinque milioni di visitatori, con il record del 1986 e 730mila paganti. Insomma, un trionfo, che andò avanti fino al-
l’edizione 2011. Poi, l’edizione prevista per il 2016 è stata rinviata all’anno successivo e poi all’anno dopo ancora, finché un altro uomo di visione, Marco Bucci, decise che Euroflora doveva tornare, che un marchio così di valore e così prestigioso non poteva essere disperso e che, anche se la Fiera era rimasta un cimitero di capannoni abbandonati di cemento armato in preda ai topi (il Waterfront di Levante era di là da venire), Euroflora ci sarebbe stata comunque.
A un certo punto, Bucci chiamò il miglior tecnico dell’Ente Fiera, Rino Surace, e gli chiese di allestire una nuova Euroflora. Ma in pochis-
simo tempo. “Tre anni” penso in qualche modo l’efficiente Surace. “Tre mesi!”, lo fulminò più o meno Bucci.
E, non immediatamente, ma dopo un po’, Surace e Bucci realizzarono che avevano fatto il militare insieme. “Ma tu sei “quel” Bucci?”. “Ma tu sei “quel” Surace?”.
E l’organizzazione fu simile a quella di una parata militare: severissima, perfetta, ai limiti dell’impossibile.
Quando l’allora sindaco di Genova lo raccontava a tutte le altre istituzioni, tutti lo guardavano un po’ strano, quasi a chiedersi: “Ma Bucci ci è o ci fa?” e gli dicevano, per loro stessa ammissione: “Vai avanti, bella idea”, as-
secondandolo un po’ come si faceva con coloro che si professavano Napoleone. E invece.
Bucci portò davvero a casa il risultato, in cui non credeva nessuno, e Surace, insieme alla sua squadra a cui esprime ancor oggi eterna gratitudine, fece il miracolo in poche settimane, con il ritorno di Euroflora a Nervi. L’edizione del 2018 fu memorabile, con numeri record di visitatori, anche solo per vedere l’effetto che faceva e una gestione che fu perfetta anche dal punto di vista della mobilità, con la zona attorno ai Parchi praticamente blindata e una rete di treni e navette per arrivare dal resto della città e del resto del mondo. Insomma,



andò benissimo e, superati gli anni del Covid, i Parchi di Nervi furono usati anche come location dell’edizione 2022, meno improvvisata e “miracolosa” e più organica, con una grande integrazione fra il verde storico dei Parchi e le installazioni di fiori ed alberi della manifestazione.
tiere del turismo sostenibile, sempre con il riconoscimento di essere l’unico appuntamento italiano tra le floralies europee riconosciute da AIPH, acronimo che sta per International Association of Horticultural Producers, una sorta di denominazione di origine controllata delle manifestazioni floreali internazionali.

Una storia che arriva ad oggi, con la stessa squadra vincente della Porto Antico e di Mauro Ferrando in cui Giusi Feleppa, storica comunicatrice della Fiera è una delle protagoniste, con uno slogan da film: “Euroflora 2025, ritorno al futuro”.
Funziona così: dal 24 aprile al 4 maggio Euroflora – giunta all’edizione numero 13 - torna a casa, in quella che era la Fiera e oggi è il nuovo Waterfront di Levante, proponendo una sfida tra le eccellenze del florovivaismo nel segno dell’arte e della sostenibilità, le nuove tendenze nell’architettura del paesaggio e le nuove fron-
Proprio la scelta del Waterfront di Levante offrirà a Euroflora la possibilità di svilupparsi su una molteplicità di spazi davanti al mare in grado di ospitare ogni tipologia di produzione, dalle piante da vivaio a quelle fiorite, dai fiori recisi alle composizioni floreali, dalle collezioni di bonsai alle realizzazioni originali di molteplici progettisti, avanguardie dei giardini del futuro con soluzioni tecniche improntate al risparmio idrico e alla scelta di piante consone agli ambienti in cui i giardini sono inseriti. Senza dimenticare una caratteristica che richiama a Euroflora migliaia e migliaia di visi-
tatori: lo spettacolo che alberi, fiori e arbusti possono regalare, anche semplicemente con gli allestimenti. Che saranno declinati in tutta l’area: dal nuovo parco urbano di trentamila metri quadrati che sta sorgendo in Piazzale Kennedy per entrare nel nuovo Palasport, proseguendo poi negli spazi sul mare, per poi approdare su un percorso galleggiante realizzato sui pontili delle darsene e infine terminare nel grande padiglione “blu” firmato da Jean Nouvel, per una superficie complessiva pari a quasi 14 (quattordici!) campi di calcio. Il progetto architettonico della manifestazione, firmato dall’architetto Matteo Fraschini per URGES – Gruppo Valagussa, vuole essere una narrazione che si dipana attraverso un dialogo con l’arte e il coinvolgimento di tutti i sensi, con un richiamo continuo alla sostenibilità, dall’uso di materiali totalmente riciclabili in ogni settore, fino – esattamente come era stato a Nervi - all’impiego prioritario di mezzi di trasporto pubblico, con posti auto riservati ai soli mezzi di servizio e ai disabili.
E poi – fior da fiore, e mai metafora è stata più azzeccata - ci saranno i classici appuntamenti di ogni Euroflora: i concorsi, la parte più com-
merciale, per il pubblico e gli operatori, momenti di intrattenimento e approfondimento con incontri, convegni, spettacoli, con speciali aperture serali, oltre a “Euroflora Young”, il ruolo didattico di Euroflora, con momenti studiati soprattutto per le scuole, dalla piantumazione di un vasetto a quella di una piccola aiuola scolastica.
Per conoscere tutti i particolari e le novità in continua evoluzione la guida obbligata è il sito www.euroflora.genova.it. La rassegna sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19. Il biglietto intero costerà 25 euro, in vendita direttamente sul sito o sul portale www.ticketone.it.
Per fare tutto, ci vuole un fiore. E un’Euroflora.




Di Massimiliano Lussana e Manuela Litro

Se dovessimo trovare due parole per raccontare Laura Sansebastiano, moglie di Marco Bucci, le parole sarebbero certamente semplicità e serenità.
Perchè, quarant’anni dopo, per Laura, “il Bucci” rimane sempre e comunque “il Bucci”. Esattamente come quel giorno in cui andavano all’università – “credo fossimo al terzo o quarto anno” – ed erano entrambi iscritti alla facoltà di Chimica e tecnologie farmaceutiche.
“Quel tipo mi attraeva anche per la sua testa geniale, che già si intravedeva, ma galeotta fu la formula chimica del cloralio idrato, che proprio non riuscivo a capire. E allora, eccolo lì, spunta su lui, “il Bucci” che mi ha spiegato tutto con parole semplici, risolvendo ciò che mi sembrava impossibile”.
In questa occasione è nata una bella amicizia, che nel tempo si è trasformata in una relazione speciale.
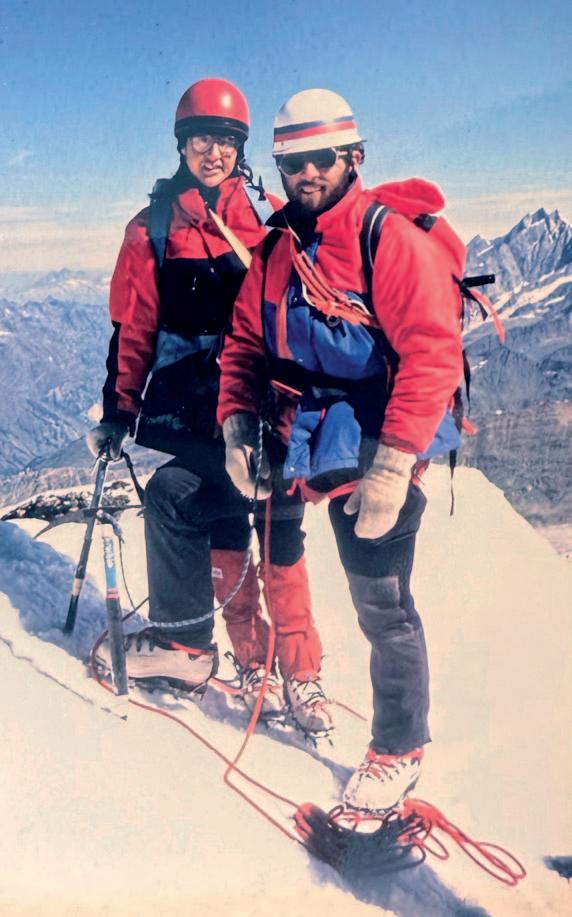
Laura, in verità, conosceva un altro Bucci, non “il Bucci”, ma suo fratello “che avevo incontrato agli scout. Lui, invece, non lo associavo, era un po’ più vecchio di noi, perché aveva fatto il militare in Marina e non seguiva tutte le lezioni, veniva solo alla mattina e nelle altre ore lavorava come magazziniere”.
Eppure, le mamme dei due promessi sposi frequentavano la stessa zona, quella della Passeggiata Anita Garibaldi di Nervi. All’altezza del
castello, “il Bucci” bambino per gioco lanciava i cocchetti, i frutti del pitosforo, alle malcapitate bambine, fra cui ovviamente c’era anche la piccola Laura.
Insomma, fra un piccolo frutto arrivato dolcemente sulla nuca di Laura bambina e la terribile formula chimica, i due iniziarono a frequentarsi, guidati anche dalla comune passione per la montagna che culminò in una storica arrampicata fino al monte Antoroto, al confine fra Liguria e Piemonte, fra Ormea e Garessio. Formula dopo formula e arrampicata dopo arrampicata, i due si innamorarono sempre più, finché un giorno “il Bucci” arrivò a casa Sansebasatiano e, arguendo che portare il dolce in dono per il fine pasto non era necessario visto che la famiglia di Laura ge-

stisce una storica pasticceria a Carignano, si presentò invece con una macedonia di frutta. E lì, fra un tassello d’ananas, un tocchetto di mela, rondelle di banane, spicchi d’arancia e
acini d’uva bianca, Marco trasformò per un attimo il suo sguardo determinato e fermo in un concentrato di occhi teneri – non precisamente la sua caratteristica principale – e si lasciò andare alla proposta di matrimonio.
Con questo gesto si inaugurò una tradizione di casa Bucci. Anche sua figlia Francesca, quando arrivò in casa per annunciare le nozze col suo fidanzato, si presentò a tavola con la macedonia.
A quel punto Laura e Marco si scambiarono uno sguardo e capirono immediatamente che
casa dicendomi: “Sai che c’è di nuovo? Domani partiamo per l’America. Ci siamo rimasti quattro anni, la prima volta in Minnesota, a Minneapolis-Saint Paul, quindi siamo tornati in Italia e poi siamo ripartiti per gli States, stavolta nello Stato di New York, a Rochester, per la precisione casa nostra era a Pittsford”. Nel frattempo, con fusioni e acquisizioni, cambiavano i nomi dell’azienda: 3M, Kodak e infine Carestream, di cui Bucci diventò il principale manager, fino alla decisione di aprire una sede a Genova.
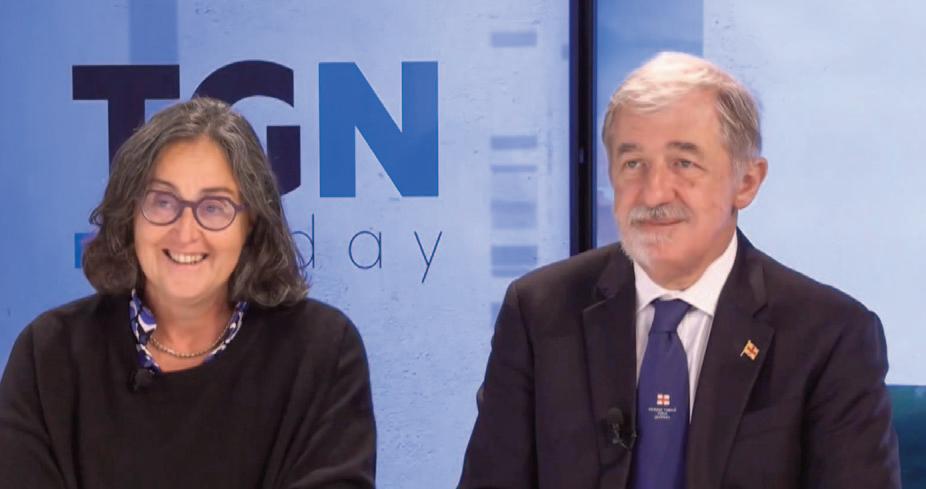
i due volevano sposarsi. E infatti Francesca si sposerà poco dopo nella chiesa di Sant’Anna a Castelletto, dove ogni giorno nascono imperdibili alchimie erboristiche e vocali ed è impossibile non innamorarsi.
Dal matrimonio di Marco e Laura nacquero due figli, Matteo e per l’appunto Francesca, “che hanno ventidue mesi di differenza. Matteo è dolce e più simile a me come carattere, Franci è una Bucci in gonnella, determinata e impossibile da arginare quando si mette in testa qualcosa”.
Insieme, tutti e quattro, hanno attraversato l’Oceano: “Un giorno “il Bucci” si presentò a
Laura interpreta il ruolo di first scignua in modo molto discreto in perfetto understatement tipico genovese. “Sarò andata solo un paio di volte in ufficio da lui a Palazzo Tursi, la seconda per portare i vassoi con i dolci per festeggiare l’elezione a presidente della Regione: “Il giorno del suo insediamento a sindaco, il capo del cerimoniale del Comune di Genova mi disse: “Signora, scambiamoci i recapiti, perché ci sentiremo spessissimo, ma in realtà non ci siamo mai più sentiti”.
Il cambio di passo, “anche per vigilare sulla salute del Bucci” è avvenuto con la campagna elettorale per le regionali, dove Laura ha soste-
nuto e seguito il marito in giro per la regione (“ho scoperto o riscoperto tanti paesi dove non ero mai stata o che avevo solo sfiorato”) e addirittura la sera della chiusura della campagna a Telenord è apparsa per la prima volta ufficialmente davanti alle telecamere. Anche in questo caso tutto iniziò una sera in
la sentii di darglielo subito e lo misi nella libreria di casa di mia mamma, che è attigua al nostro appartamento. Il Bucci, poi, andò a prenderselo…”. In fondo in fondo ha un cuore dolce anche lui.
E il rapporto fra Marco e Laura è proprio così: un equilibrio in bilico fra la ruvidezza connatu-

cui l’allora sindaco di Genova si presentò a casa dicendo: “La Meloni mi ha chiesto di candidarmi a presidente della Regione, cosa ne pensate?”. Tutti espressero parere negativo per scoraggiare il marito e il papà. E ovviamente “il Bucci” la mattina dopo chiamò al telefono la presidente del Consiglio dicendole: “Giorgia, ci sto”.
“Il Bucci” fa “il Bucci” anche a casa: un po’ burbero, dimentica regolarmente anniversari e compleanni o, almeno finge di farlo, figuriamoci San Valentino: “Un giorno, il 14 febbraio, gli regalai un libro su cui feci una dedica, ma intimidita dalla sua possibile reazione non me
rata, con tratti di tenerezza ben nascosta che lei riesce a cogliere, e ironia e autoironia che sono la chiave della signora Sansebastiano per vivere ogni giorno con un consorte così ingombrante. Anzi, in qualche modo, Laura riesce nel miracolo quotidiano di umanizzare Marco, avendo una propria individualità e personalità del tutto autonoma rispetto a quella del marito. Caratteristiche che le permettono di lavorare, ma contemporaneamente di tenere unita la famiglia dove lui trova conforto.
“Non vivo di luce riflessa, ma sono stata, sono e sarò sempre al suo fianco, per qualsiasi cosa. Da quasi quarant’anni lo scelgo ogni giorno”.


Le origini dell’Accademia risalgono al periodo della Repubblica Ligure, con la fondazione nel 1798 dell’Istituto Nazionale Ligure. Nel 1805, quando Genova entrò a far parte dell’Impero francese, venne fondata l’Accademia Imperiale delle Scienze e Belle Arti di Genova che successivamente prese varie denominazioni.
L’Accademia fu eretta in ente morale nel 1928 e nel 1951 entrò in vigore il primo statuto che prevedeva la suddivisione dell’attività in due classi: la Classe di Scienze (scienze fisiche, naturali, matematiche e mediche) e la Classe di Lettere (letteratura, scienze morali, storia).

La presenza delle due Classi ha reso possibile un proficuo contatto tra Accademici appartenenti ad aree culturali diverse favorendo iniziative di confronto e di dibattito. Inoltre, l’ampio spettro di interessi culturali dell’Accademia ha contribuito ad avvicinare al mondo della cultura un pubblico sempre più numeroso e consapevole, e allo stesso tempo ad aprire orizzonti di ricerca scientifica e di avanguardia anche ai
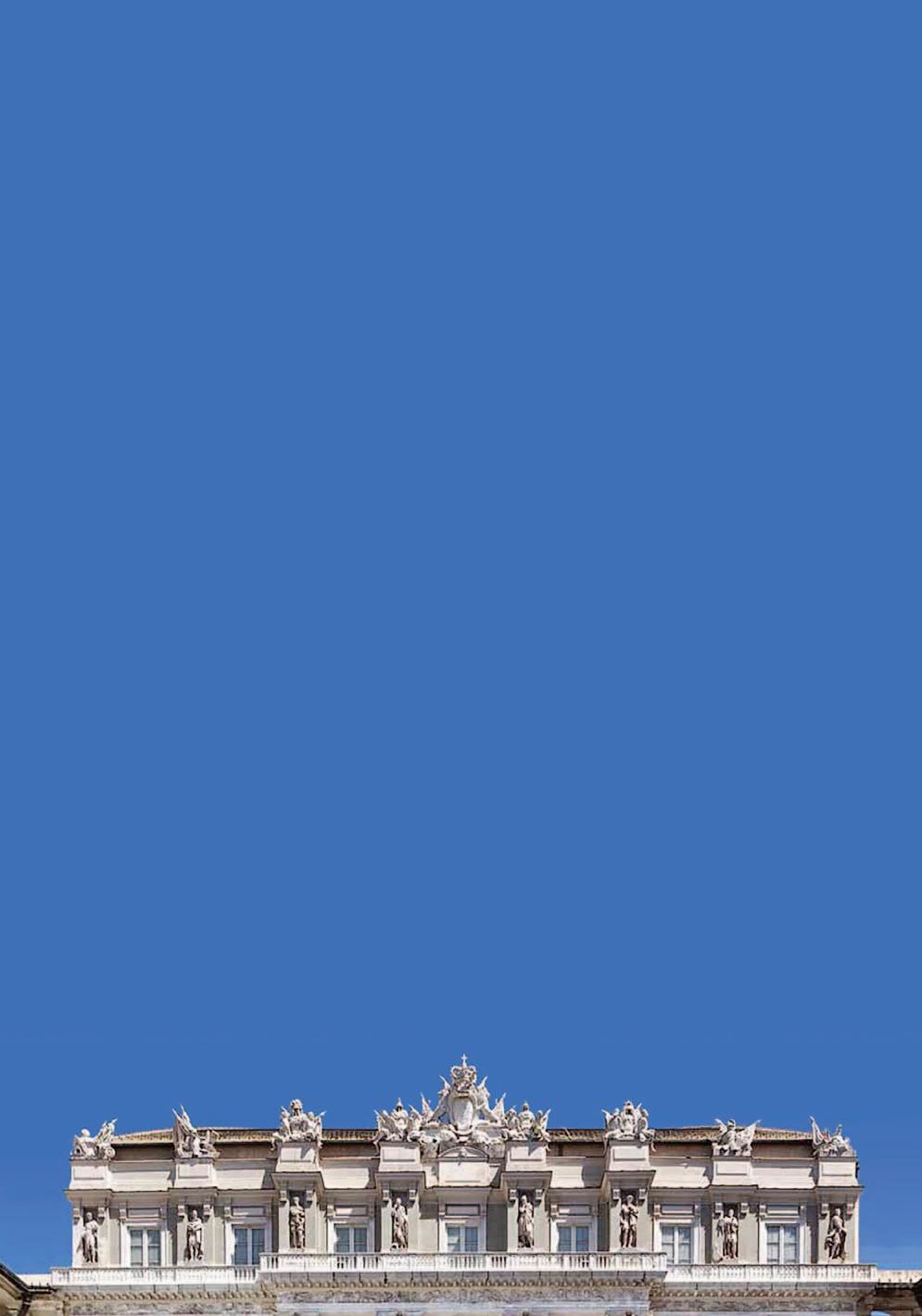


Scopri i prossimi appuntamenti scannerizzando il QR code con il tuo smartphone! Oppure cercaci sui nostri social come: @alsl_1798
giovani che operano all’interno delle università o in settori produttivi esterni avanzati. Un’altra attività importante dell'Accademia risiede nella trasmissione della cultura e delle conoscenze via via acquisite, attuata non solo con incontri pubblici (conferenze, tavole rotonde, convegni, aggiornamento della didattica ecc.) ma anche con la disponibilità di rendere fruibile con continuità il ricco patrimonio documentario, costituito da circa 60.000 unità bibliografiche. A questo proposito, merita ricordare che l’importanza della Biblioteca dell’Accademia risiede principalmente nella specificità delle proprie raccolte, che non ha uguale in campo regionale, e si colloca in un circuito nazionale ed internazionale di biblioteche delle Accademie scientifico-letterarie.

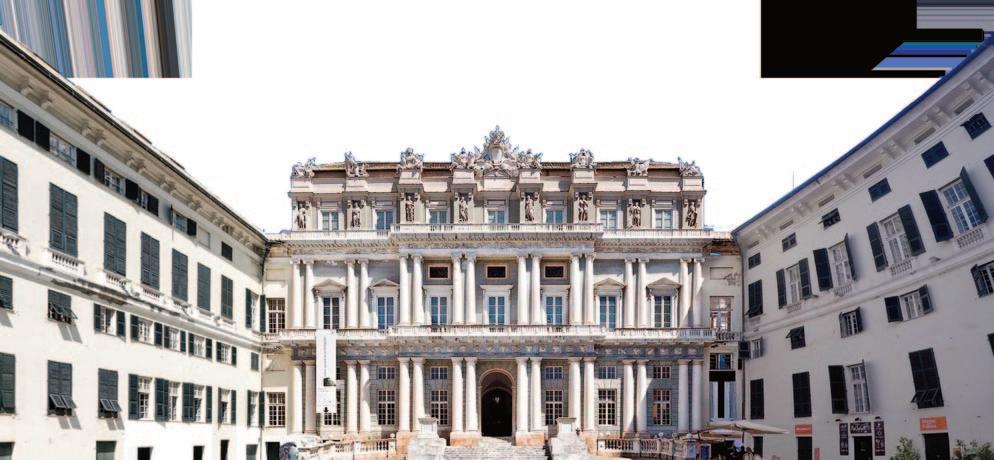


Di Anna Podestà
Genova è una città che sfida la gravità. Tra il mare e i monti si snodano antichi percorsi di pietra che sembrano arrampicarsi verso il cielo, mentre ascensori e funicolari raccontano un’innovazione che ha trasformato il bisogno in opportunità. Questo viaggio ci conduce attraverso una città verticale, dove ogni salita svela panorami mozzafiato e storie che intrecciano passato e presente.
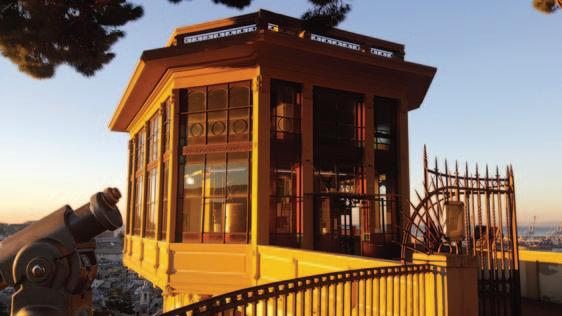
Per visitare la città verticale da angoli di visuale insoliti è necessario abbandonare le ampie strade nuove, Via XXV Aprile e Via Garibaldi, e raggiungere la più trafficata Piazza Portello. Da qui, a distanza di pochi metri, si ha accesso a due impianti di risalita: l'ascensore di Castelletto Levante e la funicolare di Sant'Anna.

Il primo è senza dubbio l'impianto verticale più amato da genovesi e turisti. Co struito nel 1909, insieme al suo gemello di Castelletto Ponente, collega la piazza alla fascinosa “Spianata Castelletto", formalmente Belvedere Luigi Montaldo. Superata la porta sempre dondolante, mollemente abbandonata dai passeggeri che si apprestano a scendere in centro, dopo aver attraversato una lunga galleria, si accede ad un’antica cabina completamente rivestita in legno e si attende trepidanti l’aprirsi delle porte.


luce abbagliante. Simbolo dell'art decò, la terrazza dell'ascensore crea coloratissimi giochi luminosi, che conservano il fascino liberty dell’epoca in cui venne realizzata. Non a caso, spicca la targa che ricorda i celebri versi del poeta Giorgio Caproni: "Quando mi sarò deciso d’andarci, in paradiso / ci andrò con l’ascensore di Castelletto”.
Non tutti sanno che un tempo la terrazza era un bar, e in pieno stile genovese, l'accesso alla vetrata era consentito solo dopo una consumazione. Anche oggi “Spianata”, come la chiamano in gergo i suoi residenti, è il luogo ideale per chi vuole godersi un panorama mozzafiato, concedendosi al

contempo un buon gelato. Da qui si possono ammirare i tetti delle vecchie case in ardesia, torri medievali e cupole barocche; in lontananza il mare animato da navi moderne e da memorie antiche. Proseguendo per le pittoresche creuze, in circa dieci minuti di cammino, si raggiunge piazza Sant’Anna: qui è possibile visitare l’antica farmacia che dal 1600 consiglia e vende rimedi naturali realizzati dai suoi eccentrici frati. La funicolare di Sant'Anna, costruita nel 1891, nasce come un innovativo impianto azionato ad acqua, inizialmente grazie ad un rivo che scorreva nei suoi pressi, in seguitoseppur con costi maggiori - per mezzo dell'acquedotto cittadino. A partire dal 1978 si è deciso di optare per un'alimentazione energetica in grado di sostentare tuttora la funicolare, che ogni anno trasporta oltre un milione di persone.
In Corso Magenta, a pochi passi dalla stazione di arrivo della funicolare, si trova l’uscita dell’ascensore Magenta-Crocco. Raggiungibile tramite una galleria pedonale, l’impianto congiunge Corso Magenta con Via Antonio Crocco, consentendo, tramite il binomio ascensore-funicolare, una rapida risalita sulle alture del quartiere di Castelletto. Tornati in centro storico, si procede in direzione di Piazza della Meridiana, dove si staglia la funicolare Zecca-Righi. Costruita tra il 1895 e il 1897, è una
delle più trafficate, anche per gli straordinari paesaggi che consente di ammirare dalle sue cabine. Raggiunto il capolinea del Righi, ci si trova davanti al Parco delle Mura e all’osservatorio astronomico cittadino. Scelta dagli amanti dell’escursionismo, la Zecca-Righi consacra Genova come capitale del trekking urbano, permettendo di intraprendere svariati sentieri che raggiungono i Forti della città, costruiti a scopo difensivo tra il XVIII e il XIX secolo. Il tragitto è percorso da molti ciclisti che vogliono cimentarsi nel downhill, ovvero la discesa tra il terreno scosceso delle alture e le ripide mulattiere. Riprendendo la funicolare in declivio fino alla stazione di Corso Carbonara e camminando per soli dieci minuti, si arriva in Corso Dogali, dove si trova l'ascensore Montegalletto - Castello d’Albertis, uno dei più innovativi al mondo ed unico in Europa: percorre 250 metri in orizzontale come una funi-

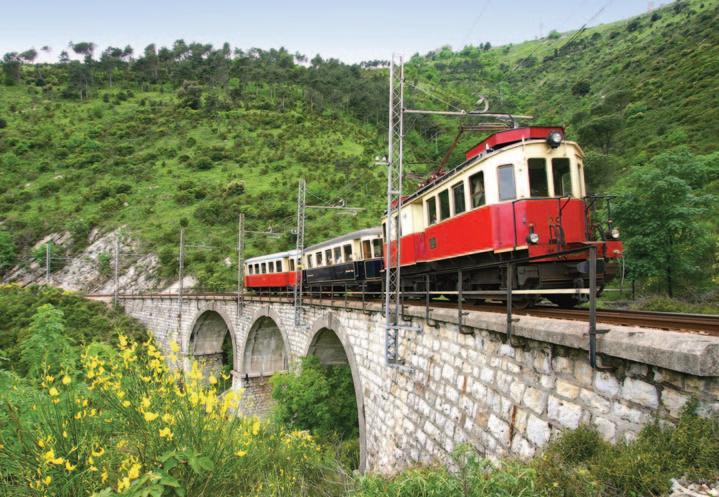
colare per poi salire, come un più tradizionale ascensore, un dislivello di 100 metri.
La fermata nei pressi di Castello d’Albertis - castello neo-gotico in cui viene ospitato il Museo delle cul-
ture del mondo - consente di raggiungere Via Balbi, a pochi metri di distanza dalla stazione di Principe, dove è situato il capolinea della Cremagliera di Granarolo. Originariamente in funzione 122 anni fa, ma nuovamente operativo da circa un decennio, l’impianto è una ferrovia che collega Principe a Granarolo tramite un sistema a cremagliera unico nel suo genere: un meccanismo di rotaia a dentiera, utile per aumentare l’aderenza.
La Cremagliera ha infatti un dislivello di 194 metri e una pendenza che sfiora il 21,4%, dati che possono essere testati in prima persona se si decide di


scendere ad una stazione intermedia: si notano immediatamente le ripide scalinate. Superate le 9 fermate che compongono la corsa, si giunge a Granarolo, un antico borgo che offre un panorama pittoresco sul porto anche grazie alle sue torri ottocentesche.
Ultimo mezzo iconico di cui è dotato il servizio pubblico cittadino è il Trenino di Casella. Rosso fiammante e amato da grandi e piccini, è la ferrovia storica, ancora funzionante, meglio conservata d’Italia. Attivo dal 1929, mette in collegamento ancora oggi Piazza Manin con Casella, passando per ben tre vallate: Valbisagno, Valpolcevera e Valle Scrivia, per un totale di 17 soste e 24 chilometri. La morfologia del territorio genovese rese difficoltosa la costruzione della ferrovia, rendendo necessario l’impiego di diversi ponti e gallerie.
Al termine di questo tour atipico della città verticale appare lampante che l'attaccamento dei genovesi ai loro impianti di risalita sia da ricercare nella doppia anima della loro funzione: utilizzati per svago da chi vuole godersi il verde dell’entroterra e per necessità da chi ne fa un uso giornaliero per raggiungere il centro città.
Diventati oggi, per il loro valore storico e per la suggestiva esperienza di viaggio che offrono a tutti i passeggeri, parte integrante dell’esperienza turistica, gli impianti di risalita rappresentano un modo veloce ecologico e diverso di muoversi: per questo il Comune di Genova ha esteso la gratuità di ascensori, funicolari e cremagliera per tutti i residenti nella città metropolitana, tutti i giorni della settimana e a tutte le ore, con l'obiettivo di incentivare il trasporto pubblico e di conseguenza ridurre traffico e inquinamento. Genova, con la sua conformazione urbana stretta tra mare e monti, incarna una sfida trasformata in opportunità. Le ripide salite e le antiche creuze si intrecciano con una rete di impianti di risalita che, nati dalla necessità, sono diventati un simbolo di ingegno e resilienza. Oggi, questi percorsi verticali non solo facilitano la vita quotidiana dei residenti, ma raccontano una storia di adattamento e innovazione, offrendo a chi visita la città una prospettiva unica su un luogo che sa trasformare le sue difficoltà in punti di forza.



Una pubblicazione che nell’ultimo periodo, grazie all’intuizione del presidente Carlo Bagnasco e del direttore Raffaele Ferriello,ha attraversato una profonda evoluzione trasformandosi da house organ dell’Automobile Club genovese in un vero e proprio “giornale della mobilità” al servizio di tutti gli automobilisti, degli utenti dei mezzi pubblici, dei ciclisti e dei pedoni. Il Magazine informa puntualmente non solo i soci, ma anche il grande pubblico riguardo le modifiche al Codice della strada, le norme di sicurezza, gli eventi più importanti, i progetti e i cantieri suscettibili di avere un impatto sulla viabilità, le autoscuole e i servizi dell’Aci e dell’Amt (con la quale è stata avviata una collaborazione per la distribuzione gratuita del periodico).
L’ Automobile Club Genova ha compiuto 120 anni e dagli anni ‘20 informa i soci, ma anche tutti gli utenti della strada della provincia attraverso il suo giornale: “Automobilismo ligure”.
L’ Automobile Club di Genova è stato ufficialmente costituito il 12 febbraio del 1904 e già l’anno dopo la costituzione del Club una sua delegazione poteva partecipare alla riunione di Torino in cui fu fondata l’associazione degli Automobile Club Italiani, (ACI), che pochi anni dopo assumeva la denominazione di RACI, cioè Reale Automobile Club Italiano. L’attività degli appassionati di automobili di Genova, però era iniziata già nel 1900 quando in Italia circolavano soltanto 190 autovetture, 40 delle quali proprio nel capoluogo ligure, che pagavano una tassa, il primo bollo, di 20 lire. Nel 1901 il gruppo di pionieri dell’automotive genovese organizzò riunioni automobi-
listiche alle quali parteciparono le prime Panhard e anche vetture a vapore. Da queste feste nacque la sfida chiamata “Gran Match Italiano”, con il Duca Degli Abruzzi e il cavaliere Garibaldi Coltelletti che si sfidarono per dimostrare se fossero superiori le auto costruite in Francia o quelle in Italia. Un percorso di 335 chilometri con partenza a Torino e arrivo a Bologna. Il Duca degli Abruzzi pilotava una Fiat 4 cilindri, a bordo della quale c’erano come passeggeri Giovanni Agnelli e Vincenzo lancia. Per la cronaca, vinse Coltelletti dopo una corsa sul filo dei 50 km/h.
Per informare i soci delle varie iniziative e di tutte queste attività anche sportive, nel 1927 l’AC Genova diede il via alla pubblicazione di un proprio giornale: “Automobilismo Ligure”. Oggi il periodico, diretto dal giornalista Alberto Pastanella e avvalendosi di una schiera di qualificati collaboratori, affronta ad ogni numero le tematiche più importanti della viabilità di Genova e provincia. Non mancano gli approfondimenti sui cantieri che verranno aperti lungo le principali direttrici, sul Tunnel sotto al porto, la Sopraelevata, gli “assi di Forza” che nei progetti del Comune rivoluzioneranno il trasporto pubblico locale, le nuove zone a traffico limitato, le aree pedonali, la carenza di parcheggi, le difficoltà del nodo autostradale, le norme del codice della strada che sono in continua evoluzione, le manifestazioni spettacolari che coinvolgono le auto storiche e le principali
gare automobilistiche. Importante anche la rubrica fissa di consigli legali tenuta dal vice presidente dell’AC Genova Alberto Campanella che, da avvocato, spiega ai lettori come districarsi nella normativa riguardo, ad esempio, agli autovelox non omologati, alla disciplina per il trasporto degli animali domestici o ai ricorsi contro le contravvenzioni.


Un giornale di servizio, quindi, che punta a svilupparsi sempre di più. Distribuito gratuitamente e reperibile nelle biglietterie Amt, nelle delegazioni dell’Aci e sul Web, attraverso il sito dell’Automobile Club Genova www.genova.aci.it .


Di Anna Podestà
estrazione del lotto, uno dei giochi d'azardo più amati e diffusi in Italia, ha radici profonde che affondano nella Genova del Cinquecento. Questa pratica, nata quasi per caso, è diventata una delle tradizioni più consolidate del nostro Paese, influenzando la cultura popolare e il linguaggio quotidiano. Non è pacifica l’origine del termine “lotto”. Infatti c’è che chi lo fa derivare dal tedesco hleut o dal francese lot, legati al concetto di sorte, eredità. Altri invece lo associano
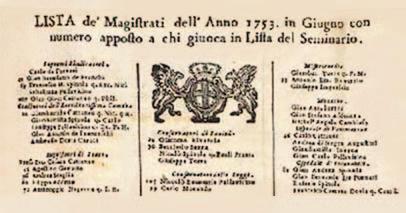
all’inglese “to lot”, ovvero assegnare qualcosa in base ad un sorteggio.
La nascita del lotto, o meglio gioco del Seminario, o meglio zeugo do Semenajo, risale al 1576, quando Genova era una delle Repubbliche marinare più potenti del Mediterraneo.

In quel periodo, la città era governata da un'oligarchia di nobili e il gioco del lotto si sviluppò come uno strumento per alimentare le finanze dello Stato. Il meccanismo era semplice: i cittadini scommet-
tevano su cinque nomi tra i 120 membri del Serenissimo Consiglio che sarebbero stati estratti a sorte per nuove nomine. I nomi dei 120 senatori venivano posti in bussolotti e riversati nella ruota della fortuna, quella che, per capirci, usavano in TV a mezzogiorno, per poi essere estratti davanti al pubblico. Con il tempo il numero dei senatori candidati si ridusse di trenta e dalla scommessa sul nome si passò a scommettere un numero associato ad ogni patrizio e, ancora oggi, i numeri che si possono giocare sono 90. Presto il montepremi formatosi con gli importi delle scommesse diventò cospicuo, portando lo Stato a fare del gioco un monopolio e il governo della Repubblica Genovese ad istituire il primo Banco del Lotto. Molti associano all’invenzione del gioco del lotto la figura del celebre ammiraglio e personaggio politico Andrea Doria, ma si tratta di un falso storico: infatti nel 1576 il Principe era morto da 16 anni! Il refuso è dovuto alla promulgazione da parte di Gian Andrea Doria, nipote di Andrea, delle “leges novae” che segnavano una forma embrionale di normativa sul gioco del lotto nel medesimo anno. Con il passare degli anni, il lotto si evolse, abbandonando la sua funzione originale per diventare un vero e proprio gioco d'azzardo. Questa trasformazione fu accompagnata da un crescente interesse popolare, che portò il
gioco a diffondersi oltre i confini di Genova. La possibilità di vincere somme considerevoli con una piccola scommessa attirava persone di ogni ceto sociale, creando un fenomeno di massa capace di travalicare le barriere economiche e sociali.
Il lotto divenne presto parte integrante della cultura popolare genovese e italiana. Numerose leggende e credenze legate ai numeri e alla
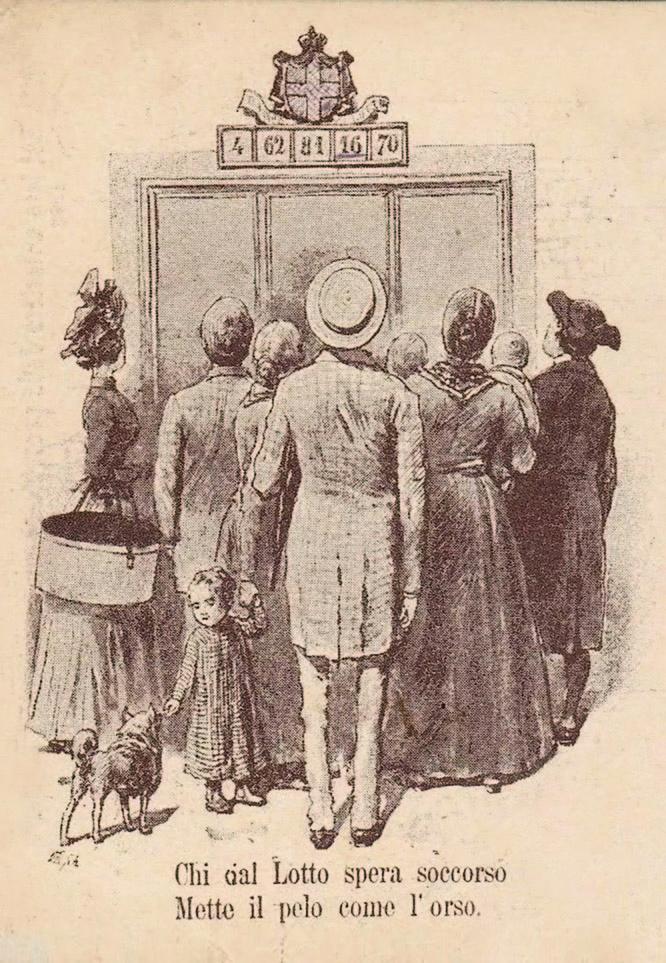
fortuna si svilupparono intorno al gioco, influenzando il folklore e il linguaggio quotidiano. Ancora oggi, espressioni come "fare un terno" o "giocarsi il numero" testimoniano questa lunga tradizione.
Un episodio emblematico della passione genovese per il lotto si verificò nel 1899, quando una serie di vincite significative scatenò una vera e propria febbre del gioco.
In quell’anno il banchiere Quartara conduceva un carro trainato da due cavalli giù per i bastioni dell’Acquasola quando la vettura deragliò e precipitò. I curiosi si radunarono sentendo i nitriti degli animali feriti e presto si creò una folla di persone. I più anziani della città ricondussero questo incidente alla numerologia: 2, i cavalli e poi 50, il numero di cadute e poi ancora 90, la paura. La voce si sparse e tutti i genovesi, di ogni classe e ceto sociale si precipitarono nelle ricevitorie per terminare i bollettini giocabili in poche ore. Alla prima estrazione a Torino accadde l’impensabile: uscirono i tre numeri.
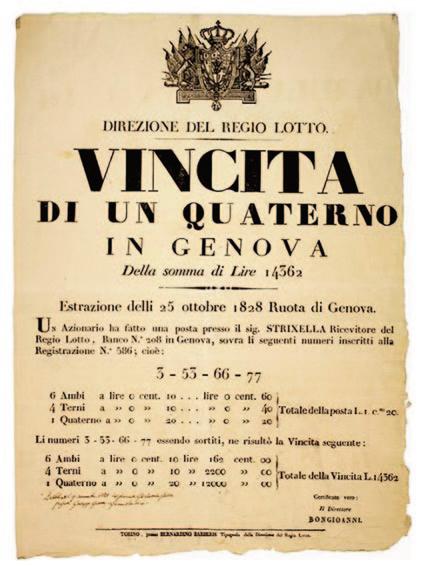
La città fu presa d'assalto da una folla di vincitori, ora divenuti ricchi, che festeggiava per le strade, creando un clima di euforia collettiva. La sezione del Lotto di Genova sborsò due milioni

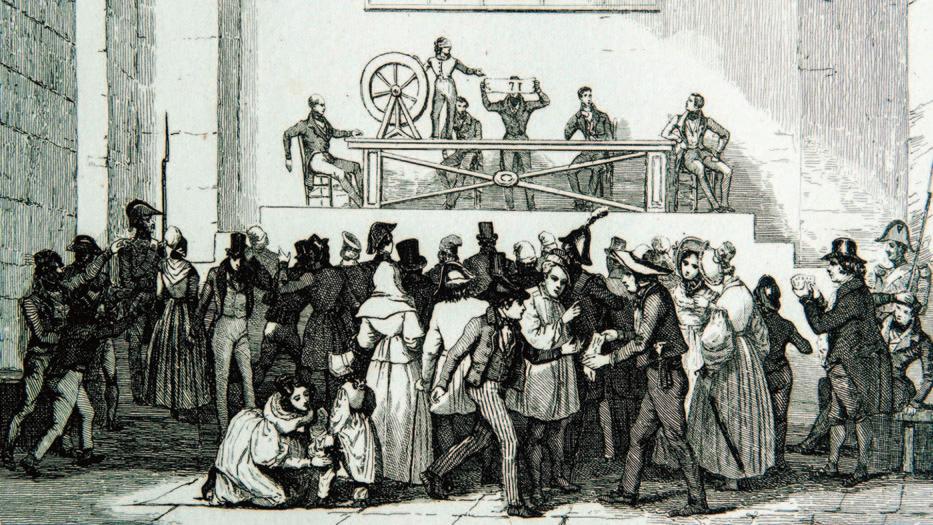
e mezzo di lire per pagare tutti i vincitori, che vinsero singolarmente fino a 120 mila lire. Questo episodio, descritto con dovizia di particolari dai cronisti dell'epoca, dimostra quanto il lotto fosse radicato nella vita quotidiana dei genovesi e quanto potesse influenzare l'umore e la vita sociale della città.
Oggi, il lotto è regolamentato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ne garantisce la trasparenza e la legalità. Nonostante l'evoluzione tecnologica e l'introduzione di nuovi giochi d'azzardo, il lotto rimane una delle forme di gioco più amate e praticate dagli italiani. Ogni settimana, per quattro volte, milioni di persone attendono con trepidazione l'estrazione dei numeri, sperando di vedere realizzati i propri sogni di fortuna. Genova, con la sua antica tradizione marinara e commerciale, continua a rivestire un ruolo simbolico nella storia del lotto. La città rappre-

senta il punto di partenza di un viaggio che ha attraversato secoli e generazioni. Le testimonianze storiche e culturali legate al lotto sono preservate in vari musei e biblioteche, tra cui la Biblioteca Titta Bernardini, che custodisce preziosi documenti sulla storia del gioco e sulla sua evoluzione.
La storia del lotto è la storia di un'Italia che cambia, si evolve e si adatta ai tempi. Dalla Genova del Cinquecento ai giorni nostri, il lotto ha accompagnato le vicende del nostro Paese, diventando un elemento imprescindibile della nostra cultura popolare. In ogni estrazione, in ogni scommessa, si riflette un pezzo di questa storia millenaria, fatta di sogni, speranze e, talvolta, delusioni.
Ma soprattutto, il lotto è il simbolo di una tradizione che, nonostante le trasformazioni della società, continua a mantenere vivo il legame con le nostre radici.


«Comune, Regione e Camera di Commercio hanno ampliato l’intesa per la tutela delle attività di pregio a 14 zone genovesi, nel quadro del piano strategico volto a valorizzare il nostro patrimonio commerciale. Siamo tra i pochi Comuni italiani ad aver adottato questi strumenti di pianificazione e siamo i primi a condividerli anche con le Prefetture» spiega l’assessore al Commercio Paola Bordilli. La delibera vieta l’insediamento di attività considerate potenzialmente degradanti, come H24 e giochi d’azzardo e impone restrizioni su negozi di vendita di prodotti alimentari che non rispettano determinati requisiti. XX Settembre, San Vincenzo, Colombo, Galata, Castelletto, Cornigliano, San Fruttuoso, Borgo Incrociati, Marassi, Molassana, Rivarolo, Certosa, Bolzaneto, Pontedecimo, Sestri Ponente, Pegli, Pra’, Voltri, Boccadasse, corso Buenos Aires, Tommaseo, via Albaro e Pisa, Quinto, Nervi sono le nuove aree selezionate come siti di valore archeologico, storico e artistico, in base a studi approfonditi e all’uso della tecnologia GIS, che ha permesso di visualizzare i dati delle attività commerciali su mappe aggiornate.

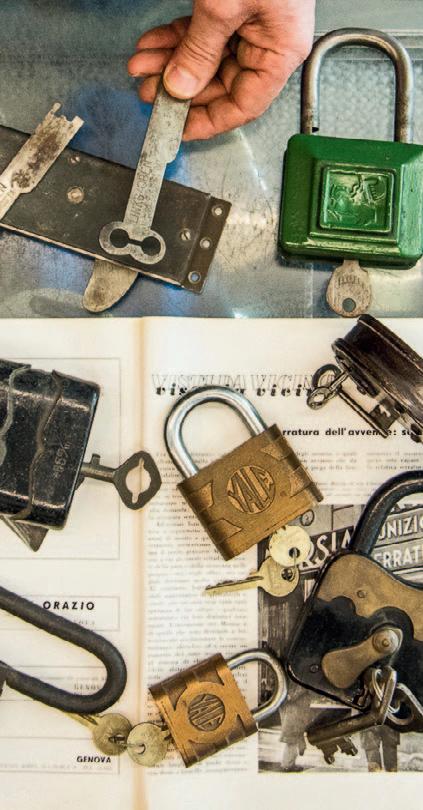
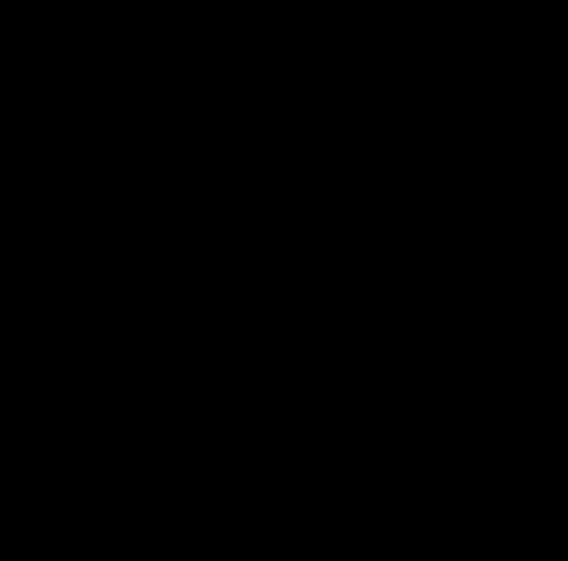









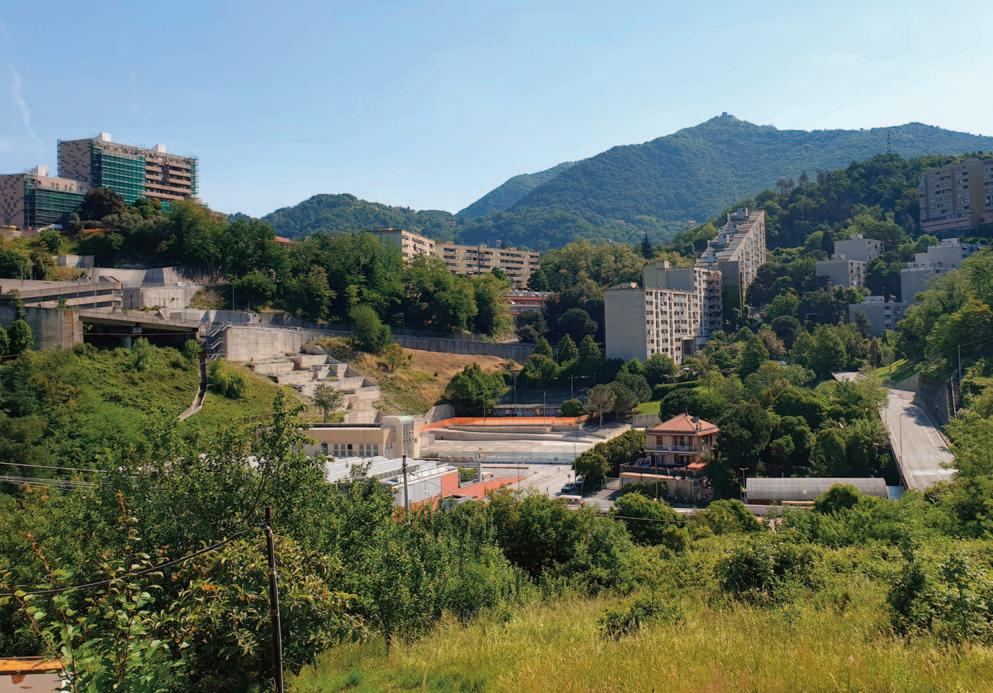
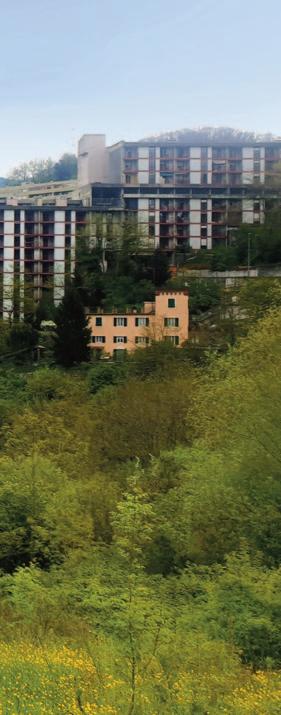

Di Anna Podestà
Nel cuore di Genova, dove le colline di Bolzaneto e Rivarolo abbracciano il cielo, un quartiere si prepara a riscrivere la propria storia. Begato, un tempo presieduto dalle sue imponenti Dighe, rinasce, diventando il simbolo di una profonda trasformazione urbanistica e sociale.
Sospeso tra alture e orizzonti, il quartiere Diamante è stato concepito come un modello innovativo di edilizia popolare, un’idea di accoglienza che, nel corso degli anni, si è trasformata in una sfida complessa per l’inclusione e il recupero sociale. Oggi, grazie all’operatività di Arte Genova e all’impegno di Regione Liguria e Comune di Genova, quella sfida si sta convertendo in opportunità: un percorso di rigenerazione urbana che mira a far splendere il quartiere di una nuova luce.
Dal 2018, è stato avviato un processo di ascolto e partecipazione con la comunità locale, un dialogo profondo capace di dare finalmente voce ai suoi abitanti. Solo attraverso questo scambio si è potuto rivitalizzare il quartiere, trasformando il cemento in speranza e l’isolamento in condivisione. Questo cammino, tanto lungo quanto delicato, ha raggiunto una svolta significativa nel 2020, con il ricollocamento di 374 nuclei familiari in 630 alloggi sfitti recuperati in tutta la città, grazie a un investimento pubblico di 12,7 milioni di euro. Un passaggio reso possibile anche dal lavoro costante delle associazioni territoriali, che hanno accompagnato le famiglie con sensibilità e attenzione.


Solo grazie a questo impegno condiviso, tra il 2020 e il 2022, per Begato si è chiuso un lungo e difficile capitolo: la demolizione della Diga Rossa e della gran parte della Diga Bianca, infatti, ha segnato l’inizio di nuova era per la zona. Progettati negli anni Ottanta dall’architetto Pietro Gambacciani, questi edifici – la Diga Rossa con 276 appartamenti e la Diga Bianca con 245 – costituivano un tentativo ambizioso di rispondere alle necessità abitative della città, con soluzioni strutturali e impiantistiche innovative. Tuttavia, l’esperimento si è scontrato con numerose difficoltà sociali e politiche, diventando oggetto di un progressivo degrado.
L'abbattimento dei 175.000 metri cubi di edifici, realizzato con un escavatore cingolato di 60 metri (lo stesso impiegato per le "Vele" di Scampia), ha aperto la strada a "Restart Begato", un progetto
di rigenerazione urbana che non si limita a ripensare gli spazi, ma punta a ridisegnare l’identità stessa del quartiere, intrecciando architettura, socialità ed economia in una visione di rinascita e futuro.
Il masterplan del progetto, curato dall’architetto Roberto Burlando, combina la costruzione di nuovi edifici di dimensioni ridotte e perfettamente integrate nel paesaggio, con interventi mirati di riqualificazione su un’area di 250.000 mq.
La rigenerazione del quartiere Diamante non si propone solo come un intervento edilizio, ma come un progetto orientato alla sostenibilità e all'inclusione. Infatti, grazie al “Programma innovativo nazionale sulla qualità dell’abitare” (PINQuA) e all’esperienza consolidata di Arte Genova, entro la fine del 2025, la parte superstite della Diga Bianca, situata all’11 di Via Cechov, verrà trasformata in 55 unità abitative ad alta efficienza energetica, con impianti


fotovoltaici e minieolici a segnare un nuovo equilibrio tra abitare e natura. Oltre a ciò, tre nuove palazzine NZEB, che accoglieranno 60 alloggi – 40 di edilizia residenziale pubblica e 20 sociale – sorgeranno con i più avanzati standard di efficientamento energetico, dando concretezza all’idea di un’area ecologica e all'avanguardia. Il progetto, tuttavia, non si ferma alla sostenibilità ambientale, ma abbraccia il tema dell’inclusività elevandolo ad elemento fondamentale.
In tale ottica, verranno realizzati otto appartamenti, accompagnati dai relativi parcheggi, appositamente progettati per garantire l’accessibilità alle persone diversamente abili.
Il nuovo assetto urbano sarà valorizzato da spazi pubblici di qualità, con numerose aree dedicate all’aggregazione. Un sistema di percorsi verdi unirà le diverse zone del quartiere, creando continuità tra aree pubbliche e private. Tra le nuove realizzazioni spicca Piazza Diamante, destinata a diventare
il cuore pulsante del quartiere, con panchine, giochi per bambini, fontanelle, spazi verdi e aree per eventi e mercatini.
L’intervento, però, non si limiterà a nuove costruzioni: è previsto anche il recupero delle storiche creuze e la creazione di percorsi immersi nel verde, pensati per le famiglie. Sulle fondamenta della vecchia Diga Rossa sorgerà inoltre un teatro all’aperto, concepito per ospitare concerti, spettacoli teatrali e cinematografici, rispondendo così alla crescente esigenza di luoghi dedicati alla socialità e alla cultura.
Un altro pilastro del progetto sarà la Casa della Cultura, ideata come centro di aggregazione inclusivo e ricco di opportunità. A completare l’intervento, verrà realizzata una nuova stazione dei Carabinieri con alloggi per il personale, rafforzando così la sicurezza e la presenza istituzionale nel quartiere.

«Dietro al cantiere di riqualificazione di Begato ci sono grande soddisfazione e orgoglio perché stiamo dando, giorno dopo giorno, forma a un progetto straordinario che cambierà totalmente il volto di un intero quartiere. Ridaremo dignità a un luogo per troppi anni dimenticato dalla politica, con centinaia di persone costrette a vivere in maniera inadeguata. Come amministrazione regionale abbiamo creduto fin da subito in un'operazione complessiva coraggiosa, mettendo al primo posto la cura e il rispetto delle persone, soprattutto quelle maggiormente in difficoltà. Un intervento simbolo di una nuova idea di edilizia residenziale che non sia sinonimo di emarginazione, ma di inclusione e miglioramento. 15 milioni

di euro per realizzare tre palazzine moderne che si andranno ad aggiungere agli alloggi di via Cechov. Entro la fine del 2025 avremo un quartiere rinnovato, sicuro, con alloggi confortevoli e all'avanguardia sotto tutti i punti di vista e con un inserimento urbano completamente differente rispetto allo stato in cui quest’area versava prima dei lavori».
Così commenta l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola, che, insieme al Vice Sindaco di Genova Pietro Piciocchi e all’amministratore unico di Arte Paolo Gallo, era presente a rappresentare le istituzioni alla posa della prima pietra del cantiere lo scorso 20 maggio.
La rigenerazione di Begato supera il mero intervento urbanistico, diventando un progetto che trasforma profondamente la vita della comunità. Grazie alla sinergia tra le istituzioni e a un approccio che unisce sostenibilità, innovazione e inclusività, il quartiere sta tornando a essere un esempio di come la riqualificazione urbana possa creare spazi di vita e socialità accessibili a tutti.

«Mi preme sottolineare con soddisfazione il grande "lavoro di squadra" tra istituzioni pubbliche» –afferma Paolo Gallo, amministratore unico di Arte – «che ha garantito, anche attraverso la professionalità e la sensibilità dei propri funzionari, il raggiungimento degli obiettivi condivisi e prefissati dalle Amministrazioni stesse».
Lontano da quella vecchia immagine di emarginazione, Begato si prepara ad accogliere nuove opportunità, riscoprendo il valore della memoria storica e aprendo le porte a un futuro all’insegna della coesione sociale e del benessere collettivo.



Di Gessi Adamoli
Umberto Bindi, Gino Paoli, Bruno Lauzi, Luigi Tenco e Fabrizio De Andrè: sembra ieri, ma sono passati più di sessant’anni da quando la scuola dei cantautori genovesi si affacciò alla ribalta. Ora tocca a Alfa, Bresh e Olly.
Giovani, bravi ed ispirati. Ed anche tifosissimi (Alfa e Bresh genoani, Olly sampdoriano) e questo è un ulteriore punto di contatto con i loro coetanei.
Travolto da improvviso, ma meritato successo, dopo il duetto con Roberto Vecchioni sul palco dell’Arison a Sanremo, Andrea De Filippi, in arte Alfa, è rimasto il ragazzo acqua e sapone che arrossisce per un complimento e smentisce il luogo comune che per sfondare i rapper devono essere sporchi, brutti e cattivi. “Sogna ragazzo sogna” è stata probabilmente la cover più riuscita degli ultimi anni a Sanremo. "Andrea mi ha dato tantissimo, m’ha fatto conoscere a uno sterminato numero di persone che non mi conosceva. Tutti i suoi fan hanno forse anche compreso una cosa e cioè che la musica di oggi deve moltissimo alla canzone di 15, 20, 30 anni fa. Cosa ho insegnato io ad Alfa? Ad avere tantissima fiducia in se stessi. Gli ho detto stai calmo,
Andrea, stai calmo", aveva confidato Roberto Vecchioni dopo il boom di consensi raccolto dall’inedita coppia nella loro esibizione sanremese.
Il successo arriva nel 2019 con “Cin Cin”, che conquista tre dischi di platino. “Un sogno che si avverava, ero partito scrivendo canzoni nella mia cameretta. Avevo trasformato una grande passione in un lavoro. Anche se continuo a divertirmi e forse lavoro non è il termine più giusto. Quello che voglio dire è che non sono mai entrato in dinamiche di ansia o di agitazione. Prendere il disco di platino è una soddisfazione, ma non diventa un’ossessione. A otto anni avevo iniziato a prendere lezioni di pianoforte e chitarra, la musica per me continua a restare un’esigenza”.
“Bellissimissima” era stato uno dei tormentoni dell’estate 2023. “Un pezzo autobiografico e ironico. L’ho dedicato ad una ragazza splendida, ma anche un po’ stronza che non mi si filava per niente e a un certo punto nemmeno più mi rispondeva ai messaggi”.


Per promuovere “Vai”, che a Sanremo si è piazzato al decimo posto, ha fatto un video lanciandosi col paracadute. “Buttarsi da 4mila metri è stata una bella botta di adrenalina, un’esperienza forte ma che non rifarei mai più. Quando me l’hanno proposto ho accettato subito, del resto col video di Bellissimissima avevo vinto la paura delle montagne russe. E in crescendo è arrivato il paracadute, ma dal prossimo disco si torna ai promo tradizionali. Cantare a Sanremo insieme a Vecchioni nella serata delle cover è stata un’emozione, ma soprattutto un grande onore, uno dei pilastri che hanno fatto la storia dei cantautori in Italia ha accettato di esibirsi con un ragazzo che conosceva a mala

pena. Gli ho mandato il testo così come lo avevo rivisitato, lo ha letto e ha deciso di fidarsi. Perché ho scelto proprio Vecchioni? È il cantante preferito di papà, in casa nostra è un mito”.
Ora va fortissimo “Il filo rosso” e per promuoverlo niente lanci col paracadute ma un video semplice, ma bellissimo, girato alla stazione Centrale di Milano. Il tema è l’amore a distanza e c’è un passo in cui è citata anche Genova: “Dimmi perché/ Io, quando piove forte, non mi calmo/ Sai, mi ricorda Genova quell'anno/Che abbiamo fatto gli angeli del fango, lì nel fango…” Il successo un po’ lo spaventa: “Se non hai la saggezza ogni tanto di fermarti rischi di finire in un ingranaggio che ti può stritolare. Non bisogna vivere col terrore che tutto possa finire da un momento all’altro, non puoi farti intossicare da traguardi come gli ascolti, le classifiche e i dischi d’oro. Le case discografiche mettono sotto contratto 800 ragazzini l’anno, li spremono e li buttano via. Io mi devo ritene-
re fortunato“.
Ha un’unica debolezza: i mini tatuaggi. “Ne ho 110. Il primo è stata la lettera Alfa, naturalmente non manca il Grifone e dopo Sanremo ho trovato uno spazio per il maestro Peppe Vessicchio ed i suoi mitici baffoni”.
Si è diplomato a pieni voti al D’Oria, il liceo classico che sforna manager, avvocati e letterati ma anche artisti, vedi Paolo Villaggio e per ultimo appunto Alfa che ha scelto questo nome d’arte proprio in omaggio ai suoi studi di greco. Alfa è la prima lettera dell’alfabeto e significa “inizio, principio”. La mamma voleva che si laureasse in medicina continuando la tradizione di famiglia. Lo hanno chiamato Andrea come il nonno, il professor Arata, che è stato a lungo un punto di riferimento per la psichiatria a Genova, portando avanti la battaglia per la chiusura dei manicomi. Primario a Cogoleto, Quarto e infine al Galliera aveva raccolto le esperienze di una vita professionale in un libro interessantissimo dal titolo “Cento…Ottanta”, facendo appunto riferi-

mento alla legge che impose la chiusura dei manicomi e regolamento il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale pubblici. Psichiatra era la nonna, Piera Bevilacqua, e psichiatra è anche la mamma Antonella che in pensione collabora comunque attivamente al centro di cura per anoressia e bulimia di Quarto.
Si era iscritto al corso di economia delle arti e dei beni culturali dell'Università Bocconi e la decisione di ritirarsi perché aveva compreso che la sua strada era un’altra lo portò, come confidò in un’intervista, ad un duro scontro con la madre. “L’università l’ho mollata per la
musica, ma anche perché era talmente competitiva che c’era chi passava gli appunti sbagliati apposta. Con mia madre ci fu un litigio importante, ma al mio primo grande concerto al “Fabrique” di Milano, abbiamo fatto pace. Il mestiere del cantautore è appeso a un filo, capisco che un genitore pensi a un percorso più sicuro”.
Il padre Marino, che ai tempi di Spinelli era il responsabile del settore giovanile del Genoa, in realtà lo avrebbe voluto calciatore. “Da bambino – ricorda Alfa - giocavo nel campetto a sette del G. Mora in via Prasca. Difensore con i piedi buoni, al punto che mi facevano battere le punizioni. Ma ero lento e quando il campo si è ingrandito ho capito che non era roba per me”.
Ma è rimasto l’amore per il Genoa. La prima partita l’ho vista a sei anni: Genoa –Pescara 3 a 0. Milanetto e doppietta di Adailton, una tappa fondamentale verso la promozione in serie A. Da bambino andavo nei Distinti con papà, poi è venuto il tempo della Nord con gli amici. E ora allo stadio sono tornato ad andarci con mio padre. Qual era il mio idolo? Sarebbe scontato rispondere Milito, il Principe. Ma io stravedevo per Marco Rossi, una bandiera. E conservo gelosamente la sua maglia”.
De Andrè confessò: "Al Genoa scriverei una canzone, ma non posso perché sono troppo coinvolto". Bresh al Genoa una canzone l’ha dedicata ma non citandolo mai nel testo. Alfa però si smarca: “Bresh ha regalato ai tifosi del Genoa qualcosa di indelebile. Ed era logico che lo facesse lui che è sempre nella Nord e segue

la squadra anche in trasferta. Non sarebbe carino nei suoi confronti se scrivessi qualcosa anch’io e non sarebbe giusto in assoluto. I tifosi genoani sono straordinari, tifare per il Grifone è qualcosa di incredibilmente romantico che affascina adulti e ragazzi. Nei momenti di maggiore difficoltà viene fuori l’orgoglio rossoblù. Dopo la retrocessione la risposta dei tifosi è stata stadio sempre pieno e tantissimi giovani al Ferraris. E una bella spinta è venuta proprio anche dalla canzone di Bresh. Che emozione tutto lo stadio che a luci spente canta Guasto d’amore!”.
Però lo scorso anno al Porto Antico ha presentato la terza maglia, quella oro. Ed è stato un bagno di folla. “Ho anche portato fortuna al mio Genoa. In maglia gialla non ha mai perso e contro avversari del calibro di Inter, Juventus e Napoli: cinque partite e cinque pareggi. Il giallo del resto è il colore che mi rappresenta. Mi rimanda alla leggenda di
Van Gogh che mangiava la tempera gialla convinto che portasse fortuna e felicità”.
Ora si è trasferito a Milano, ma tempo fa aveva dichiarato: “Genova è casa mia, ho scritto quasi tutte le mie canzoni qui. Non so se è una questione di tradizione, ma in questa città si respira musica. Stare vicino al mare mi stimola”. Il tour, che si intitolava “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, partito lo scorso 5 aprile da Padova è stato un grande successo. Ora è pronto a ripartire. A Genova sarà il 22 novembre e con largo anticipo c’è già il tutto esaurito, i 5.500 posti dello Stadium (il palazzetto dello sport alla Fiumara) sono stati polverizzati in un giorno e mezzo. Il ragazzo cicciottello, timido e anche un po’ preso in giro dai compagni, ora è una star. “Una rivincita su chi mi bullizzava. Ogni tanto rivedo le foto di classe e mai più avrei immaginato che soltanto qualche anno dopo avrei riempito i palazzetti”.

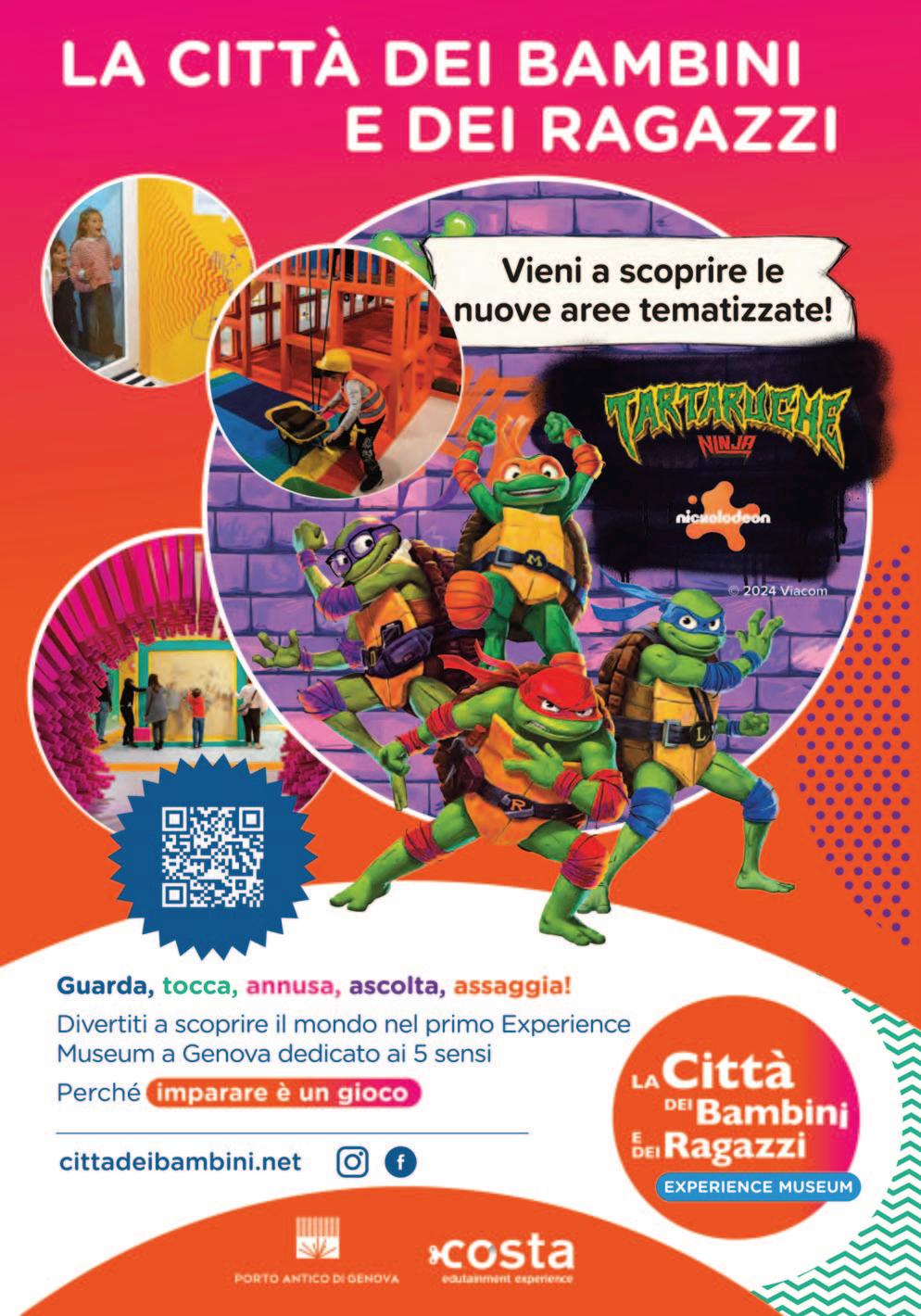
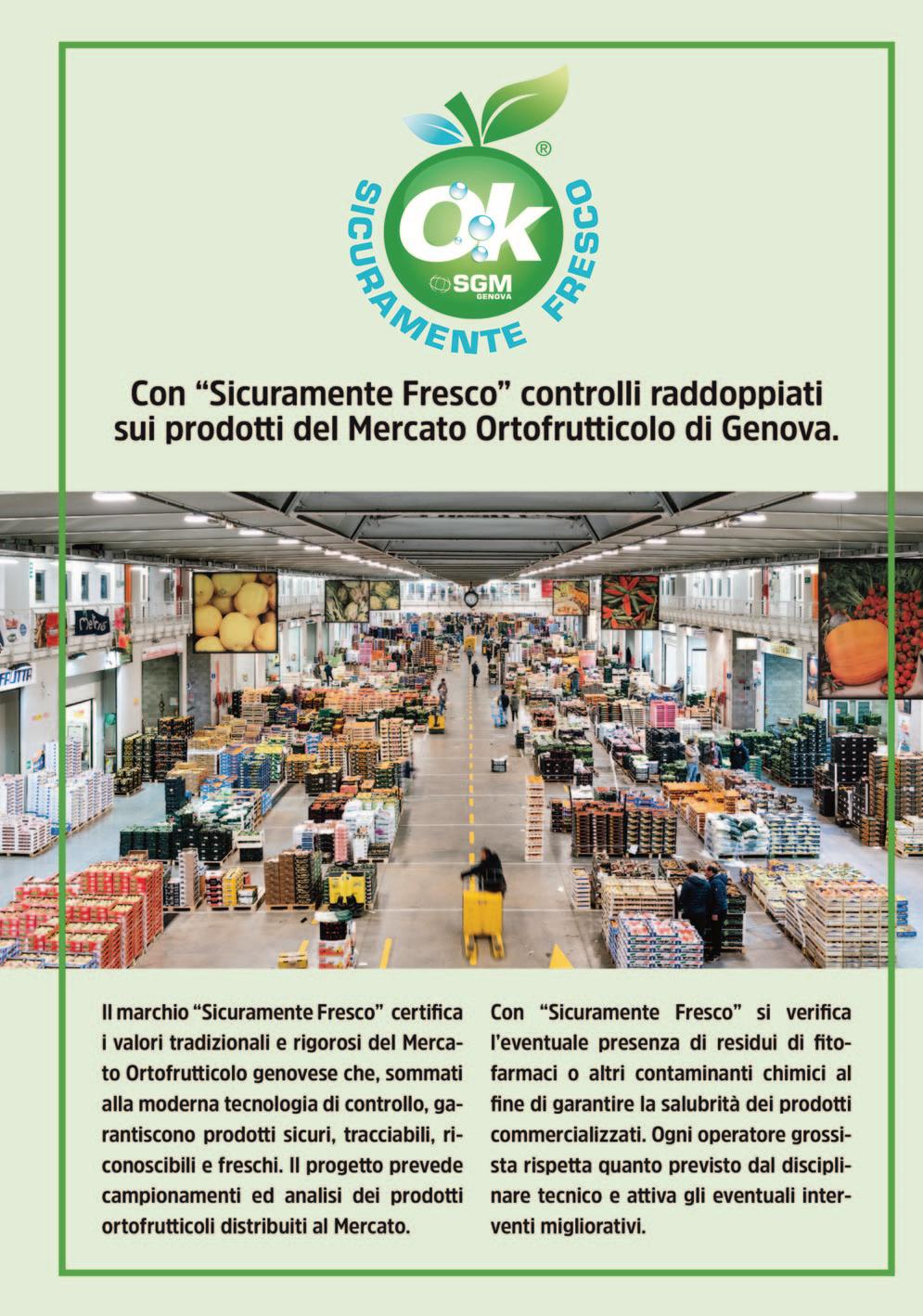




WA cura di Martina Re aterfront di Levante, a Genova, è un innovativo progetto residenziale che unisce modernità, bellezza e sostenibilità. Sviluppato da Orion European Real Estate Fund V e CDS Holding, progettato da Renzo Piano Building Workshop in collaborazione con Studio OBR e realizzato da CDS Costruzioni S.p.A., rappresenta una nuova visione dell'abitare urbano.

Questo complesso, affacciato sul mare, non è solo un luogo dove vivere, ma un'esperienza unica che promuove benessere e comfort.
Gli attici di Waterfront di Levante sono il fiore all'occhiello del progetto, con ampi spazi, vetrate panoramiche e materiali di alta qualità, pensati per integrarsi armoniosamente con il paesaggio ligure. Le residenze offrono la prelazione sui posti barca e sono immerse in un parco verde pedonale di 13.000 mq, creando un’isola abitativa naturale e tranquilla.


Le ampie terrazze panoramiche offrono magnifiche viste sul mare e veri living all'aperto, dove la luce naturale regna sovrana. Il progetto è costruito secondo criteri di sostenibilità avanzati, ottenendo certificazioni LEED Gold e NZEB, garantendo elevati standard energetici e un ridotto impatto ambientale. Ogni residenza è personalizzabile grazie a MARTINA RE, azienda specializzata nell’Asset & Development Management nel Luxury Real Estate, che offre un servizio di Interior Design "chiavi in mano" e gestisce in esclusiva il Sales Management degli attici.




I residenti possono usufruire di servizi esclusivi, tra cui concierge 24/7, palestra, area coworking, sale relax e spazi per eventi. Grazie alla posizione privilegiata, questi attici rappresentano una delle soluzioni più esclusive di Genova, offrendo privacy e accesso diretto alla città. Un'opportunità esclusiva per chi desidera vivere il futuro oggi, nel cuore di una Genova che guarda al domani.
Per scoprire gli esclusivi attici ancora disponibili: www.waterfrontdilevante.com

Di Gessi Adamoli
Gilardino esonerato, al suo posto Vieira. Una notizia così clamorosa al punto che nessuno ci voleva credere. Un pesce d’aprile? Ma se eravamo al 20 novembre.
Invece era tutto vero, nonostante i 4 punti ottenuti nelle partite con Parma e Como. “Se resta lui rischiamo di retrocedere”, era stato l’allarme lanciato da Andres Blasquez, di fatto plenipotenziario del club rossoblù in quella fase di transizione societaria.
Via allora l’allenatore della promozione e dell’undicesimo posto in serie A che è valso il miglior piazzamento da neopromossa nei cinque campionati europei più importanti. A bocciare Gilardino ed una squadra che giocava col cuore, nonostante le partenze eccellenti (Martinez, Gudmundsson, Retegui e già a gennaio Dragusin) e gli infortuni, è stato un freddo algoritmo. Possesso palla, passaggi nelle metà campo avversaria e gli ormai famigerati expected gol (aspettative di gol in base alla posizione della palla) erano tutti dati in rosso.
bandonando il 3-5-2 per il 4-3-3 ma anche inventando un ruolo per Zanoli. Ed è strano che nessuno prima di lui abbia pensato di utilizzare come ala il calciatore che è probabilmente il più veloce della serie A. Nessuno dei tre allenatori che aveva avuto lo scorso anno a Salerno (Inzaghi, Liverani e Colantuono) dove era addirittura finito a fare panchina nella squadra ultima in classifica e nemmeno Stankovic alla Sampdoria.
Ma al di là del modulo è cambiato poco, praticamente nulla, per quanto riguarda la qualità del gioco. Non era spettacolare quello di Gilardino e non è calcio champagne nemmeno quello di Vieria. Anzi, se possibile, è ancora più sparagnino e speculativo.

Patrick Vieira, che ricorda Michael Clarke Duncan de “Il miglio verde”, è un gigante all’apparenza buono (la sensazione è però che sia meglio non farlo arrabbiare) che trasmette sicurezza. Una squadra che gioca con la forza dei nervi distesi è stato il segreto della partenza eccellente (quanto meno in termini di risultati) del Genoa affidato al tecnico franco-senegalese.
Ma Vieira non ha unicamente trasmesso serenità, è anche intervenuto a livello tattico. Non solo ab-
Ma, ricordando Indro Montanelli che aveva invitato i suoi lettori “a turarsi il naso e a votare Dc” non è il caso di andare troppo per il sottile. Non perdiamo infatti di vista che il quart’ultimo posto è il traguardo da raggiungere. In una stagione costellata da cessioni e infortuni per quanto riguarda l’aspetto tecnico e, prima dell’arrivo di Sucu, da una grande incertezza societaria, l’obiettivo non può che essere la salvezza. Tutto ciò che verrà in più, va considerato un optional.
Conta solo conservare la categoria e Vieira si è subito calato nella parte. Come quei grandi chef che adattano il menù del loro ristorante a quello che in quel momento trovano in frigorifero. Si avvale della collaborazione dello spagnolo Antor Unzué, giovane match analist che ha collaborato a lungo con Luis Enrique, e dell’inglese Kristian Wilson che è da sempre il suo vice. Sono rimasti Murgita, il preparatore atletico Pilati e gli allenatori dei por-
tieri Scarpi e Raggio Garibaldi che erano nello staff di Gilardino, ma come dipendenti Genoa (discorso diverso per Caridi e Dainelli).
Da giocatore (Cannes, Milan, Arsenal, Juventus, Inter e Manchester City) aveva vinto tutto, compreso un Mondiale ed un Europeo al golden gol contro l’Italia che però, sempre con Patrick in campo, si era poi presa rivincita vincendo ai rigori il Mondiale 2006.
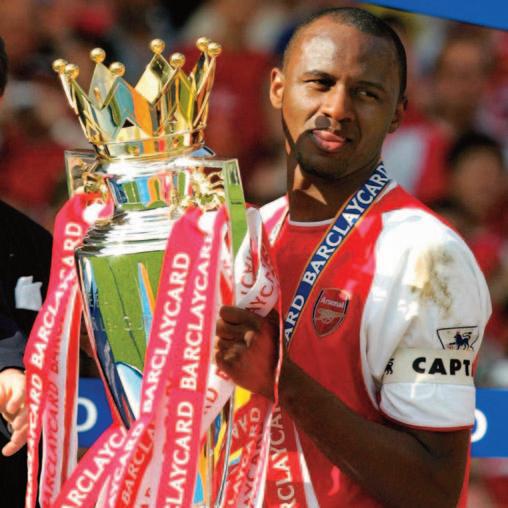
Era il mix perfetto tra forza fisica e tecnica. Univa estetica ed efficacia, forma e contenuto. In Francia l'avevano soprannominato "la piovra" per l’abilità di sradicare il pallone dal piede dell’avversario. Era duro e se occorreva cattivo, nel mitico Arsenal di Wenger riuscì a farsi espellere due volte nel giro di quattro giorni. Ed era un leader, nel Cannes aveva esordito a 17 anni e a 19 era già il capitano. Confidò in un’intervista Arsene Wenger: “La prima volta che l'ho visto, giocò 45 minuti col Cannes contro il mio Monaco. Dominò il centrocampo e subito mi sono detto che avrebbe fatto una grande carriera. Quando dopo l’esperienza in Giappone firmai per l’Arsenal, pensai subito a lui che nel frattempo era passato al Milan”.
La carriera da allenatore l’ha iniziata al Manchester City dove aveva finito quella da calciatore, fa-


cendo la gavetta partendo dalle giovanili con il titolo di Executive Development Football e come ambasciatore del club nel Regno Unito e all'estero. Proprio al City si era imbattuto in Balotelli e non era stato amore a prima vista. Si erano ritrovati al Nizza, dove Patrick era approdato dopo aver allenato il New York. Ed erano state scintille: “Balotelli non è mentalmente adatto a praticare uno sport di squadra”. Con queste premesse la scelta di puntare su Vieira, nemmeno un mese dopo aver

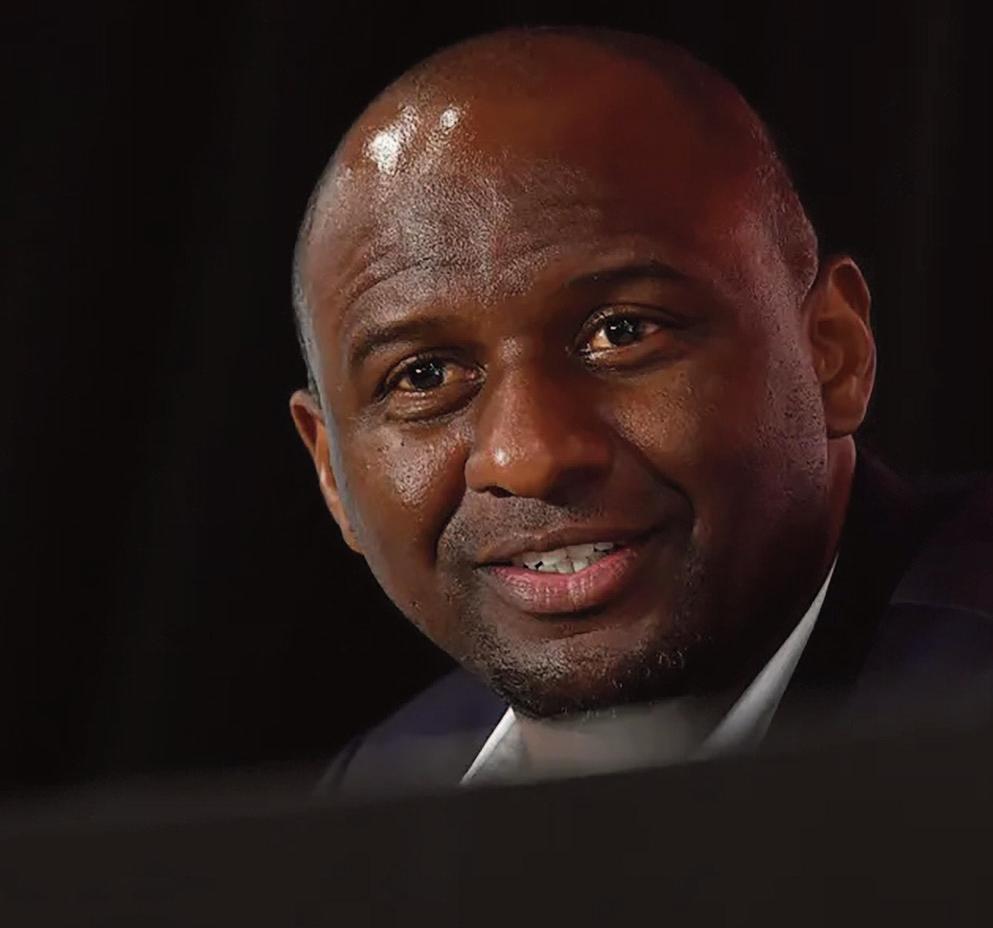
messo sotto contratto SuperMario, non poteva non spiazzare tutti, compreso Balotelli che era approdato a Genova pieno di buoni propositi.
Quel minuto contro il Cagliari, la prima volta di Vieira sulla panchina del Genoa, è stato il preludio di un rapporto che, viste le premesse, non poteva non es-

sere estremamente complicato. Se ha bruciato Balotelli, a Vieira va però dato merito di aver sdoganato Masini che ha dimostrato di essere un soldatino estremamente affidabile. Anche in un’ottica proiettata alle prossime stagioni perché nella lista dei 25 da consegnare alla Federazione quattro giocatori de-

vono essere prodotti del proprio settore giovanile. Ma anche se i numeri, soprattutto inizialmente, sono tutti dalla sua parte, c’è chi storce il naso: “Il Genoa non gioca bene. Anzi, gioca proprio male!”. Per proporre un calcio di qualità servono però interpreti di qualità. Ma Badelj ha 36 anni e non gli si può chiedere di cantare e portare la croce, Gudmundsson è stato venduto alla Fiorentina, Malinowskyi si è rotto il perone e Messias è più fragile di una porcellana di Capodimonte.
Così, anche se la cosa al “Derby del Lunedì” fa inorridire un fautore della palla a terra come Stefano Eranio, uno dei più positivi è sempre Thorsby. Come quando Rivera se ne uscì con lo storico “se il migliore in campo è stato Sogliano, vuol dire che abbiamo giocato proprio male”.
Eppure la Genova rossoblù aveva eletto come suo idolo indiscusso Ballardini, detto “lo zio” per la saggezza, per l’appunto da vecchio zio, con la quale gestiva le situazioni più delicate riuscendo sempre a condurre in porto la navicella rossoblù. Si era persino tirato in ballo Niccolò Machiavelli ed “il fine giustifica i mezzi” teorizzato ne
“Il Principe”. Ma se ai tempi di Ballardini era “la ragion di stato” ad autorizzare il pullman davanti alla porta, spesso compiacendosene anche, perché fare tanto gli schizzinosi con Viera al quale oggettivamente è stata affidata una rosa mediocre?
“Tutto cambi affinché nulla cambi”: è la politica adottata dal potente di turno sin dai tempi del Gattopardo. E rispetto a Gilardino non è praticamente cambiato nulla.

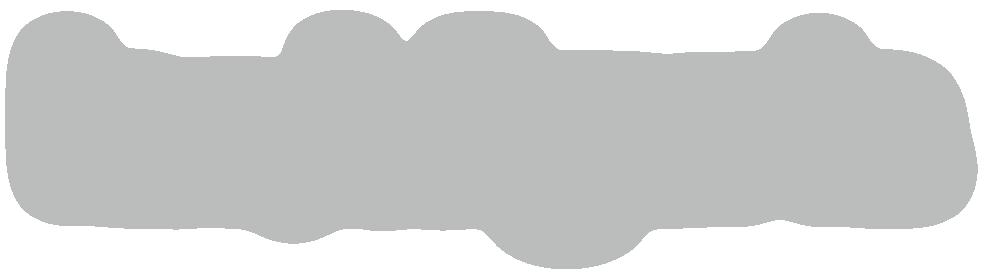


Di Manuela Litro

era una volta Palazzo Pallavicino, uno splendido palazzo storico di piazza Fontane Marose, a un metro da via Garibaldi, in mezzo al sistema dei Rolli, patrimonio dell’Umanità Unesco, che era chiuso al pubblico e quasi nascondeva la bellezza, come una splendida signora ritrosa.
Poi la decisione del principe Domenico Pallavicino e di Claudio Senzioni, che è l’anima operativa della Fondazione Pallavicino, di aprirlo al mondo e, in qualche modo, di “regalare” alla città i suoi splendidi spazi.
Prima le visite guidate e le “experience” organizzate insieme al Comune di Genova, con cui il palazzo è tornato esattamente come era un

tempo, il concetto che era alla base del sistema dei Rolli, i più antichi alberghi diffusi al mondo, accoglienti e ospitali. E quindi la possibilità per genovesi e turisti di vivere davvero un’esperienza
fra queste splendide sale. Poi, l’ulteriore salto di qualità, con la scelta del Principe, di Senzioni e dell’editore di Telenord Massimiliano Monti di trasformare Palazzo Pallavicino Interiano in un incredibile set per incontri aperti gratuitamente alla cittadinanza, facendo degli splendidi saloni e del giardino verticale un luogo, inedito e meraviglioso, per incontrare protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica, dell’imprenditoria, del giornalismo e delle professioni, praticamente la nuova sede culturale e di dibattito per eccellenza della città.
Soprattutto, il valore aggiunto di questa iniziativa firmata da TN Events&Media è stato proprio quello di aprire il palazzo alla città, nel senso più letterale della parola, non per una semplice fruizione “visiva” e in qualche modo museale – comunque notevole e importante, visto che stiamo parlando di un gioiellino architettonico – ma di farlo “vivere”, trasformandolo in soggetto e non semplicemente complemento oggetto di questa storia.
Così è nato il primo ciclo, “Incontri d’estate” che è stato quasi un “numero zero” di una storia poi cresciuta in continuazione: “La nostra è un'iniziativa ambiziosa che mira a creare una















rassegna d’incontri di respiro nazionale nel magnifico scenario del Palazzo Pallavicino Interiano a Genova – introdusse il primo ciclo l’editore Massimiliano Monti -. Questi cicli di incontri sono un'occasione unica per riunire ospiti di spicco. Il nostro obiettivo è quello di creare una rassegna annuale di grande risonanza nazionale, che celebri non solo la storia e la bellezza di Palazzo Pallavicino, ma anche promuova il dialogo e lo scambio di idee tra personalità di spicco provenienti da diverse sfere della società italiana”.
L’obiettivo fu immediatamente raggiunto, tanto che – racconta Senzioni – “iniziarono a chiamarmi amici da ogni parte d’Italia e persino da Roma, dove certo non si può dire che la vita culturale non sia effervescente, a complimentarsi e a dirmi che avevano letto sulla stampa nazionale delle interviste di Palazzo Pallavicino”.
Del resto, la lista degli ospiti della prima edizione era davvero un kolossal e ancora non si sapeva che sarebbe stato superato da quelle successive: Vittorio Sgarbi, Alberto Zangrillo, Giuseppe Cruciani, Paolo Masini e il Museo dell’Emigrazione Italiana, Federico Buffa, la presidente della film commission ligure Cristi-
na Bolla a presentare la meravigliosa storia di Amadeo Peter Giannini, il più straordinario banchiere della storia, partita da Favale di Malvaro nell’entroterra della Fontanabuona, e arrivata negli States, raccontati qui benissimo da Federico Rampini, e poi Enzo Paci, Matteo Bassetti, Giuseppe De Bellis e Stefania Aloia. Insomma, andò benissimo, tanto che l’appuntamento, anziché essere rinviato all’anno successivo, venne spostato solamente a pochi mesi dopo, con addirittura due cicli. Il primo “Incontri Liguria Italia” presentò le future regionali liguri con protagonisti della politica nazionale e locale che dibattevano in studio, con il rinforzo di opinionisti e editorialisti nazionali, in quello che è stato il programma televisivo che ha in qualche modo segnato le elezioni regionali in Liguria, dando spazio a tutti, non soltanto con il bilancino della par condicio, ma anche con la capacità di essere irriverenti e di fare le domande più scomode con il sorriso sulle labbra e senza mai rinunciare alle proprie opinioni. Insomma, puro stile Telenord, dove il titolo della notizia arriva dopo che si è fatta la trasmissione e l’intervista e non prima come trop-





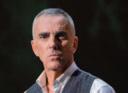






zo Pallavicino, con regole d’ingaggio molto stringenti, che divenne il più significativo fra i faccia a faccia fra tutti i candidati, sia per i contenuti, sia per la location che lo ospitò, davvero unica.
Ma, anche in questo caso, il clou, cioè il confronto fra i nove candidati presidenti della Regione Liguria, avvenne nel giardino di Palaz-
A questo punto, molto prima di quanto fosse previsto inizialmente, a grande richiesta, è arrivato il tris. Cioè la versione autunnale degli po spesso accade nel giornalismo italiano. E l’ironia e lo stile del direttore Matteo Cantile, insieme alla perfidia programmatica di Massimiliano Lussana, è stata la cifra stilistica dell’intero ciclo.

“Incontri a Palazzo”, perché squadra che vince non si cambia e anche formula che vince non si cambia. E quindi sempre a Palazzo Pallavicino, sempre con ingresso gratuito e sold out per ogni appuntamento, con la possibilità per il pubblico di avere la copia del libro firmata direttamente dagli autori o di fermarsi a conoscerli durante l’aperitivo dopo le intervi-
ste, e sempre con grandi nomi: Nicola Porro, il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, la prima vera uscita pubblica del neoeletto presidente della Regione Liguria Marco Bucci, Diego Fusaro, la ricerca del turismo delle radici con Paolo Masini e il Museo dell’Emigrazione Italiana, i fratelli Francesco e Silio Bozzi, che nella vita fanno rispettivamen-

te il capo degli autori di Fiorello e il dirigente della Criminalpol, consulente di Andrea Camilleri e di Carlo Lucarelli per i loro racconti di delitti, e qui erano in vesti di autori.
E ancora il ritorno di Vittorio Sgarbi, che ha richiamato ancora un pubblico numerosissimo, Francesco Baccini, l’Ordine dei Medici, i testimonial di Synlab e tutte le ultime novità
sul Waterfront di Levante. Cicli poi trasmessi più volte su Telenord e ancora disponibili in streaming su Telenord.it di cui i telespettatori, che magari ci si sono imbattuti per caso, hanno chiesto in continuazione repliche, facendo registrare ascolti e interazioni record.
Con, in più, Palazzo Pallavicino riaperto al pubblico, che ha iniziato ad amarlo e a fruirne.
Con uno sguardo sulla città.
Ma anche sul mondo.



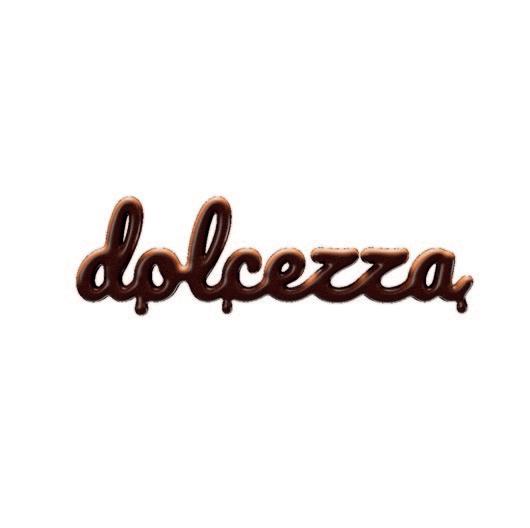
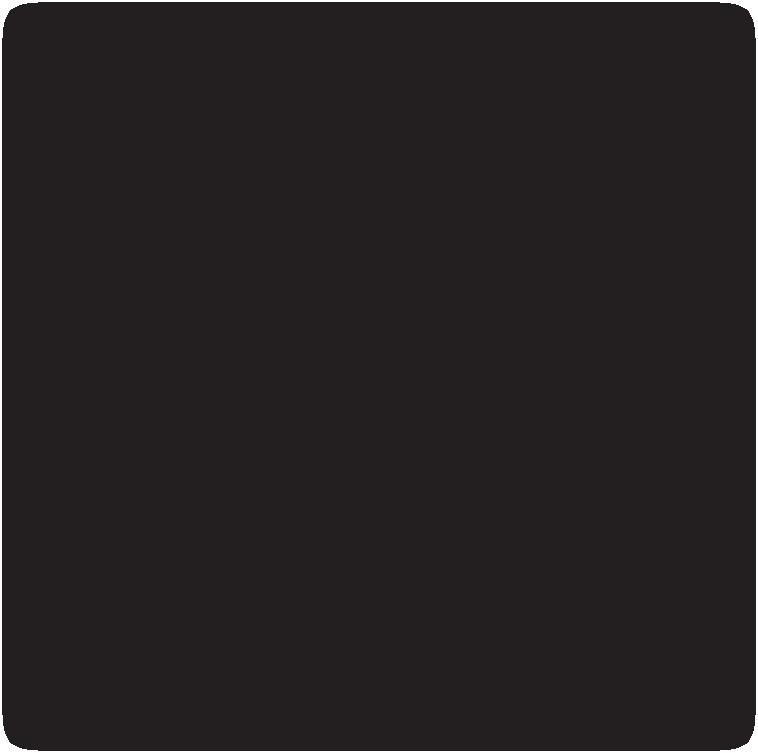

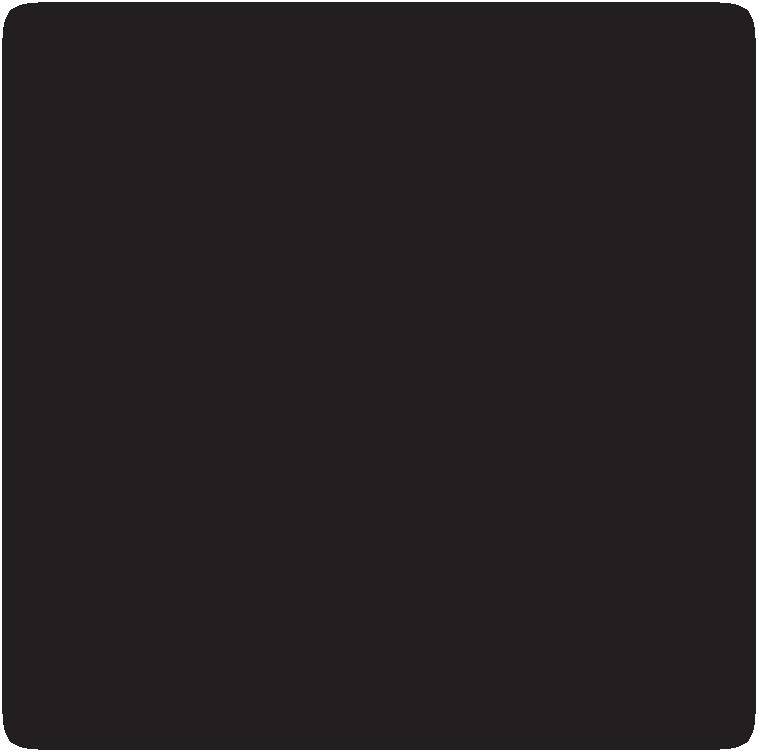

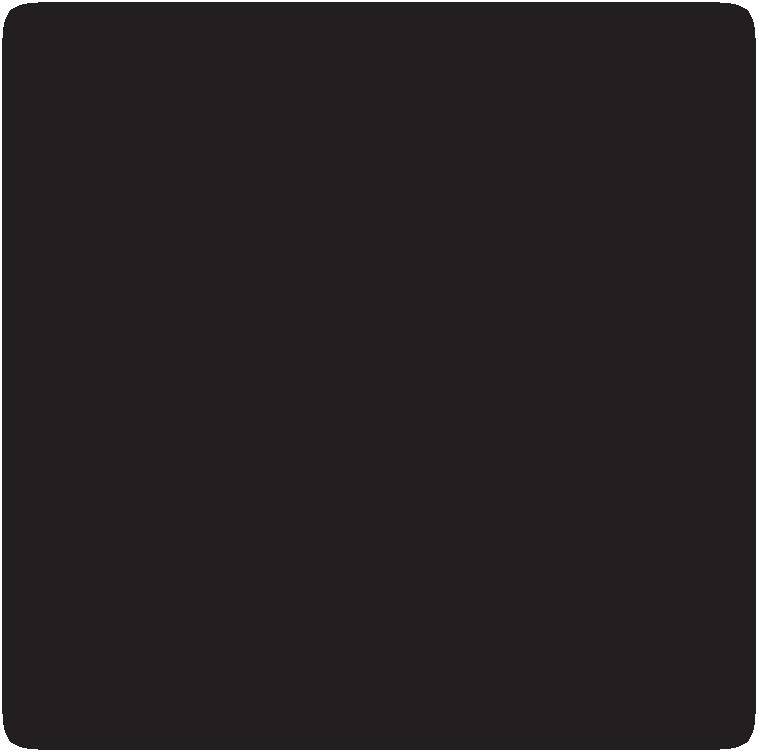


Offriamo servizi di amministrazione condominiale, revisione contabile condominiale, consulenza in tema di fiscalità e tributi con l’ausilio di professionisti qualificati per le materie riservate.
Garantiamo serietà, competenza, ampia disponibilità, trasparenza dei conti e sicurezza dei fabbricati, il tutto nel rispetto ed applicazione delle vigenti normative
Siamo dotati di un sistema di gestione condominiale online innovativo che mi permette di controllare i rapporti sia con i condomini che con i fornitori, avendo così un unico canale sicuro di comunicazione.


Piazza Ragazzi del '99, 8/n 16147 Genova Sturla
Tel: 010 3071636 - Tel/Fax : 010 3774487
mail: info@studioilcondominio.com https://studioilcondominio.webnode.it/
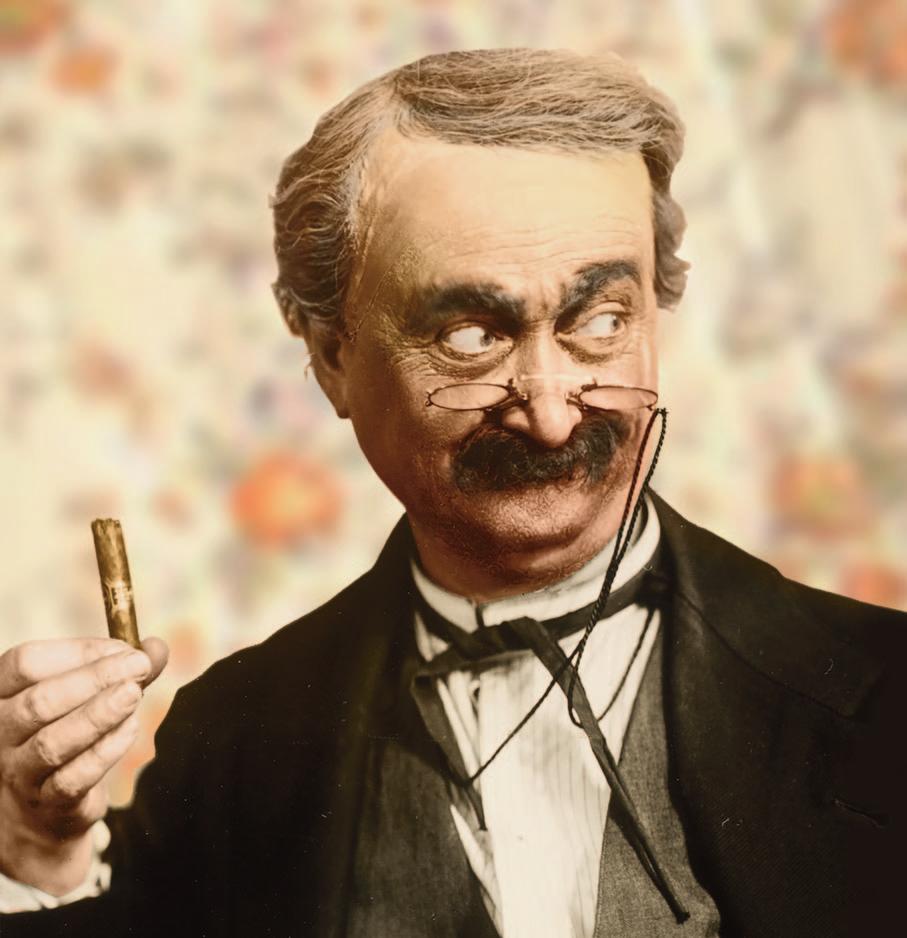

Di Gessi Adamoli
a siamo sicuri che davvero sia Solenghi? Per me è Govi. Uguale in tutto e per tutto. Per come si muove, per come parla, per la cadenza e per le smorfie, perfino per i tic”.
Chi il mito del teatro dialettale genovese l’aveva visto recitare dal vivo o comunque ha avuto la possibilità di vedere in televisione una delle sue commedie, non ha potuto fare a meno di notare come il grande attore, cresciuto alla scuola del teatro Stabile di Genova e poi affermatosi a livello nazionale insieme ad Anna Marchesini e a Massimo Lopez, sia a tutti gli effetti un clone perfetto di quella che è diventata la maschera di Genova un po’ come lo sono Arlecchino a Venezia, il dottor Balanzone a Bologna, Gianduia a Torino e Pulcinella a Napoli.

Quella di Solenghi è stata una scelta precisa: non interpretare Govi ma “essere” Govi. “Non lo ripropongo identico all’originale perché ho poca fantasia: lo faccio così perché è l’unico modo”, ha confidato.
E ha aggiunto: “Una scelta che mi ha permesso di trasmettere al pubblico di oggi le stesse emozioni che Gilberto Govi dava ai nostri genitori e nonni. Infatti in questi anni altre messe in scena sono passate sotto silenzio: nessuno se le ricorda più. Le commedie non le ha scritte lui: i Maneggi è di Felice Pastorino, Pignasecca è di Emerico Valentinetti. Ma Govi le ha trasformate in qualcosa
di suo, unico e irripetibile, filtrandole attraverso la sua sensibilità. Govi senza Govi non si può fare. Per questo ho deciso di farlo il più possibile simile all’originale, riproducendo le mimiche, la parlata, l’accento, le smorfie, le pause: tutto. In questo mi ha aiutato il fatto che io ho iniziato la carriera facendo molte cose, tra cui l’imitatore”.
E, anche grazie all’aiuto fondamentale di Bruna Calvaresi, per quanto riguarda trucco e parrucco, è sicuramente stata una scelta azzeccata come confermato dai “tutto esaurito” e dalla continua richiesta di repliche. “I testi di un grande come De Filippo – spiega Solenghi - sono straordinari,

ma possono essere messi in scena anche senza Eduardo. Ma per Govi non è possibile. Per Govi ci vuole la sua maschera, i suoi tic, le sue smorfie, la sua voce. Fare
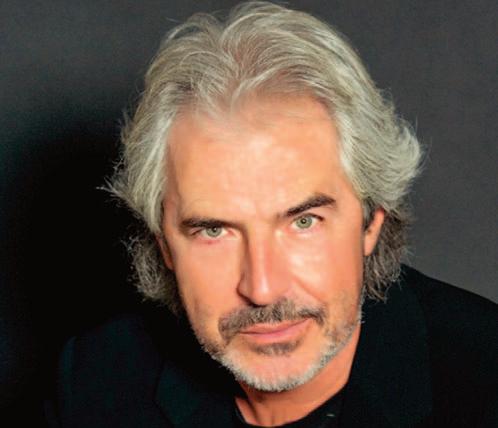
Govi senza Govi sarebbe come tradirlo”.
Confessa di essersi imbattuto in Govi quasi per caso, insieme a Maurizio Lastrico, lui pure cresciuto alla scuola del Teatro Stabile di Genova e col quale nel 2011 mise in scena un indimenticabile Moscheta del Ruzante per la regia di Marco Sciaccaluga. “Fu Margherita Rubino – ricorda - a coinvolgerci nella lettura di alcuni passi che facevano parte del repertorio di Govi. Non ci eravamo nemmeno preparati, pensavamo di leggere qualche pagina con un po’ di dialetto genovese. Invece ci siamo trovati davanti a duemila persone entusiaste. Era un segnale tangibile che alla gente mancava Govi e ci siamo messi al lavoro”. I meriti sono da suddividersi fra molti, a cominciare da Giuseppe Acquaviva, sovrintendente del Teatro Sociale di Camogli, che un progetto che inizialmente poteva sembrare velleitario l’ha ideato e prodotto insieme al Teatro Nazionale di Genova.
In principio furono i “Manezzi per maja na figgia” (regia dello stesso Solenghi, la scena e i costumi di Davide Livermore che giocando con il bianco e nero ha omaggiato le commedie goviane trasmesse in tv negli anni Sessanta): “Per me quella di Govi è una ‘maschera’ senza tempo ed è con grande rispetto e dedizione che ho voluto interpretarlo”. Straordinario il Govi/Solenghi o, se preferite, il Solenghi/Govi, ma impagabile anche l’interpretazione di Elisabetta Pozzi, genovese, pure lei formatasi alla scuola dello Stabile. Da anni ormai non vive più a Genova e calca i palcoscenici più importanti in Italia, ma ha accettato con entusiasmo e con la sua eccezionale professionalità di cimentarsi nel teatro dialettale nel ruolo di Giggia, la moglie, che era stato di Rina Govi. Ed è leggenda la battuta: “Giggia hai una faccia che se dai una facciata per terra
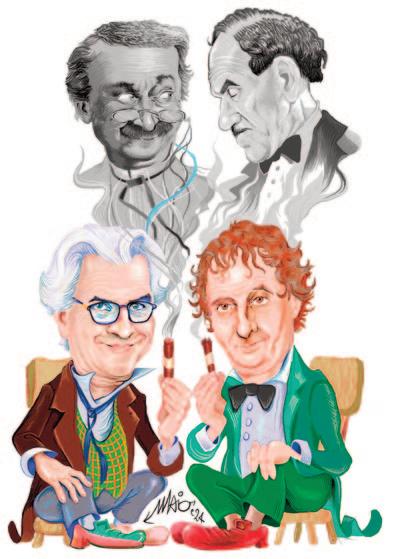


renza della precedente, nasconde, tra gli immancabili spunti di grande comicità, lati umani oscuri e intriganti da indagare e rappresentare. Questo nuovo personaggio goviano rappresenta, infatti, l’eterno archetipo dell’avaro attorno al quale ruotano personaggi e situazioni che vanno a comporre, nell’attenta osservazione della realtà, quel microcosmo di stampo ligure che si manifesta in una sorta di preziosa foto d’epoca. In Pignasecca e Pignaverde la maschera si fa più autentica, con una maggiore profondità narrativa: una nuova sfida per me, per la mia messa in scena e per la compagnia che mi ha affiancato, professionalmente ineccepibile in ogni ruolo, perché l’empatia del gruppo è sempre stata una delle risorse essenziali del teatro di Gilo lastrego sanguina”. Al pari di quella “Gassetta e pomello” in “Manezzi per maja na figgia”. Dopo l’imprevisto, ma straordinario successo dei Manezzi, Solenghi non poteva non concedere il bis. «Ho così lasciato i panni del remissivo Steva per calarmi con lo stesso entusiasmo in quelli del più arcigno Felice, una maschera che, a diffe-
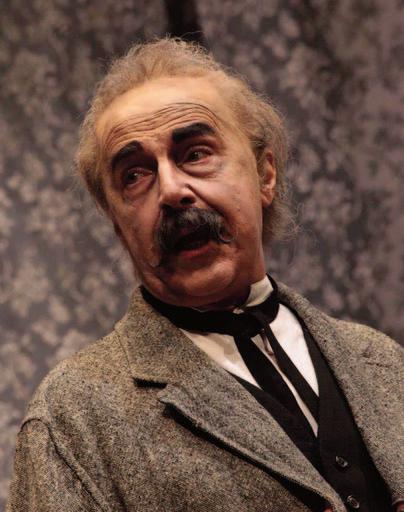
berto Govi”.
Nella sua squadra Solenghi, che anche in questo caso è il regista dello spettacolo, ha voluto Mauro Pirovano che con Maurizio Crozza, Ugo Dighero, Marcello Cesena e Carla Signoris alla fine degli anni Ottanta aveva fondato i Broncoviz). “Il percorso iniziato con l’elaborazione e la rappresentazione dei Maneggi mi ha arricchito
molto come attore – ha spiegato Solenghi – In Pignasecca il protagonista ha dei lati oscuri: come una negatività totale nei confronti della figlia. Pignasecca è l’avaro in salsa genovese. Ha a che fare con il concetto di parsimonia che è nel Dna ligure: e quindi non è arida e basta. Infatti invece di scegliere la soluzione più comoda, sceglie quella che privilegia la famiglia: e lo dice chiaramente. Non vuole che la figlia vada in Sud America sposando un marito argentino: vuole che i suoi nipoti restino con lui, e vuole lasciare a loro il suo patrimonio quando morirà. Anche qui ci sono molti spunti comici, ma sono disposti ad arte”.
Alla fine dello spettacolo, Tullio Solenghi esce a salutare il pubblico che non smetteva di applaudire: “Volevo ringraziarvi perché qui ogni sera va in scena un miracolo. Lo era già quando abbiamo fatto “I Maneggi”, ma questo, se possibile, è un altro miracolo”.
Ma siamo tutti noi che ringraziamo lui per averci fatto rivivere il grande Gilberto Govi. Nome d’arte di Amerigo Armando, padre di origini mantovane e madre bolognese. Unica, vera e straordinaria maschera genovese.

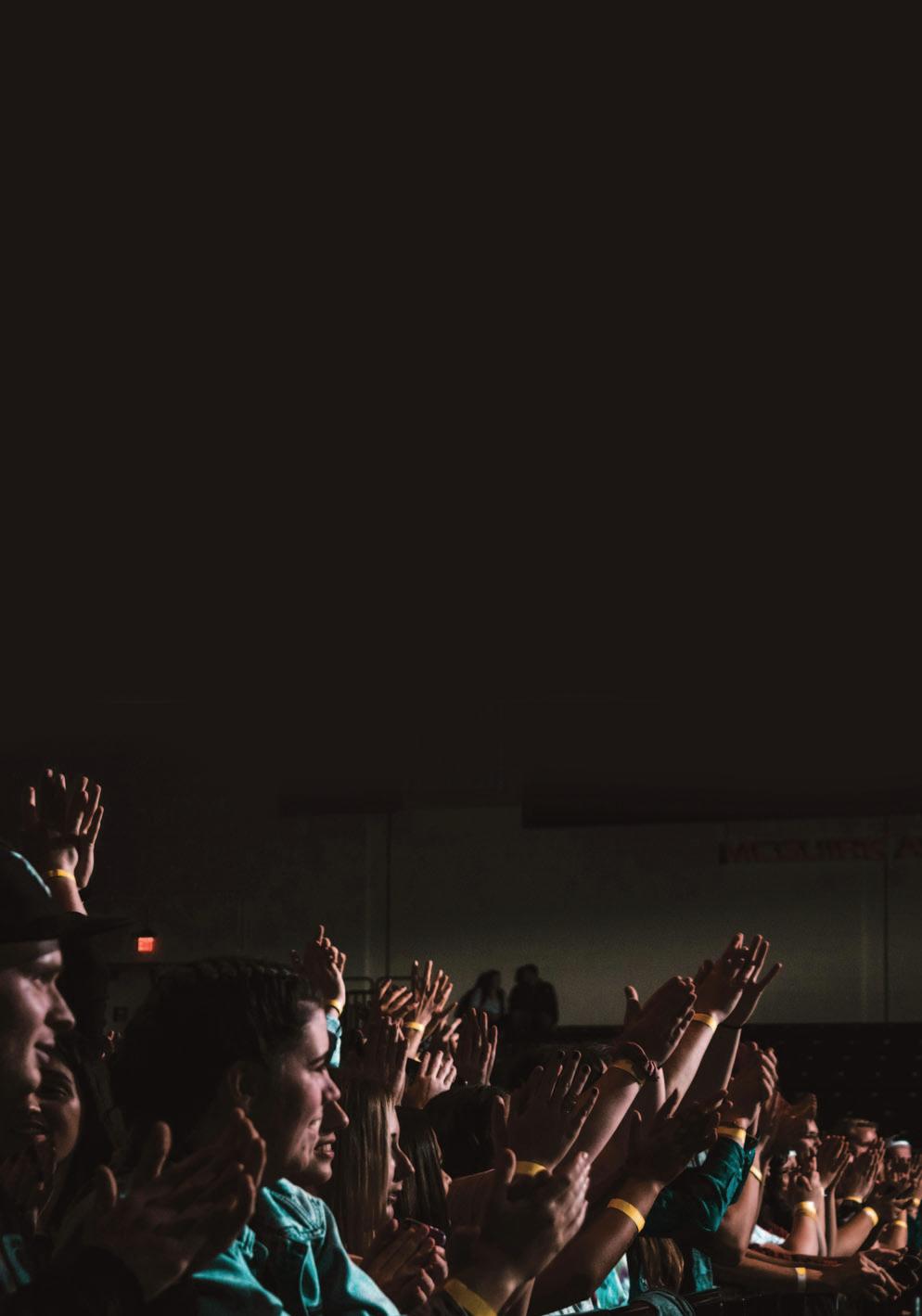

«Salutato il 2024 con il Tricapodanno - che ha trasformato la città in un palcoscenico di musica, spettacolo e divertimento, con artisti di fama nazionale e talenti locali - Genova ha iniziato il 2025 con un calendario ricco di eventi» racconta Federica Cavalleri, consigliera del Comune di Genova delegata ai Grandi eventi. «Un lungo viaggio, iniziato con i Rolli Days dedicati al Giubileo, che hanno celebrato il profondo legame tra Genova e Roma attraverso i nobili palazzi e le chiese gentilizie della città, e che sono stati l’occasione per approfondire la storia e l’arte che hanno contraddistinto Genova nel Rinascimento e nel Barocco» spiega Cavalleri che, passando dagli eventi culturali a quelli di puro divertimento, sottolinea anche il grande successo del Carnevale, con migliaia di cittadini, fa miglie e giovani uniti in una due giorni di gioia e spensieratezza. «Da tre anni, il Comune lavora per valorizzare la tradizione del Carnevale genovese, coinvolgendo anche le scuole per far conoscere ai più piccoli le caratteristiche maschere genovesi – prosegue Federica Cavalleri – Prossima tappa i Rolli Days di primavera: due appuntamenti, 26-27 aprile e 3-4 maggio, dedicati a Euroflora».



auto nuove, usate e km 0 oltre ad auto elettriche e veicoli commerciali delle migliori marche a prezzi competitivi e scooter elettrici a marchio Supersoco.. Che tu stia cercando un'auto nuova, un'auto usata o un'auto Km 0, da Velauto troverai quello che cerchi. Il nostro personale esperto è sempre a disposizione per aiutarti a trovare l'auto perfetta per le tue esigenze.





Via Giuseppe Colano, 36 a/r 16162 Genova (GE) commerciale@velauto.it +39 010 4554301

Di Anna Podestà
Se ci si ferma in un angolo silenzioso di Genova, si può ancora percepire, in lontananza, il rintocco delle campane. Un suono lieve, quasi sospeso, capace di evocare antiche emozioni, ormai soffocate dall’incessante frastuono della vita moderna. Eppure, c’è stato un tempo in cui Genova si risvegliava ogni giorno accompagnata da quel canto metallico:
un richiamo solenne che, riverberando tra i caruggi e i palazzi, dettava il ritmo della città, intrecciando il sacro e il profano in un’armonia senza tempo.
Seduto all’ombra del lussureggiante giardino di Palazzo delle Peschiere, Charles Dickens ascoltava quei suoni con un misto di meraviglia e riflessione. Era il 1844 quando lo scrittore
inglese giunse per la prima volta a Genova, prima tappa di un viaggio in Italia destinato a durare mesi.
sue esigenze. Qui, tra i giardini profumati di agrumi e le sale adorne di affreschi, trovò un’oasi di tranquillità che contrastava con il frastuono della città.

Osservando la città con l’occhio critico di un viaggiatore straniero, Dickens fu inizialmente colpito dal caos e dal calore opprimente dell’estate ligure. Albaro, con la sua Villa Bagnarello, divenne la sua dimora temporanea: un rifugio colorato, ma non privo di disagi.
L’incolto cortile, i continui battibecchi tra la servitù locale e quella inglese e un’invasione di pulci fecero guadagnare all’attuale Villa Barabino il soprannome di “Prigione rosa”. Eppure, giorno dopo giorno, la vista del mare che si stendeva all’orizzonte e il rumore delle onde che s'infrangevano sugli scogli gli restituivano una calma inaspettata. Per questa ragione l’autore inglese decise di prolungare il suo soggiorno nel Palazzo delle Peschiere, dimora più idonea alle
Quella che oggi è la celebre Villa Pallavicino divenne per lui un punto di osservazione privilegiato: da lì
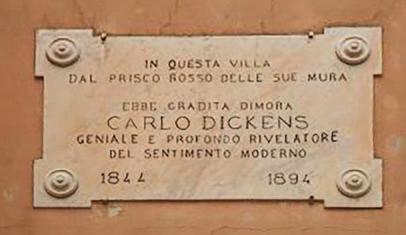
poteva abbracciare con la vista l'intera città, un intreccio di vicoli e piazze che si estendeva fino alle colline circostanti. Spinto dal desiderio di conoscere
la vera essenza del capoluogo ligure, Dickens dedicò molto tempo alla sua esplorazione carpendone i più reconditi segreti e bellezze.
Da sempre interessato all’osservazione del popolo e delle sue abitudini, l’autore trovò in Genova un microcosmo dell'umanità: un intreccio di luci e ombre che continuò a nutrire la sua creatività anche dopo il ritorno in Inghilterra. La Superba lo conquistò lentamente, insinuandosi nei suoi pensieri con il fascino di un mistero da svelare.
“Genova abbonda dei più strani contrasti; cose pittoresche, brutte, meschine, magnifiche, deliziose e offensive irrompono nella vista a ogni angolo”, scriveva appassionato in una lettera all’amico John Forster. Bellezza e degrado, opulenza e povertà, ordine e caos si intrecciavano costantemente negli scorci della vita quotidiana genovese. Da un lato, i vicoli sprigionavano odori intensi di spezie e il vociare incessante di mercanti, marinai e popolani; dall’altro, le maestose “Strade dei Palazzi” sfoggiavano un lusso sfarzoso, testimone di un passato ricco di fasti nobiliari.
Ma non erano solo i paesaggi a catturare l’immaginazione di Dickens. Tra i vicoli intricati, la vita pulsava con una vitalità sfrenata: marinai intenti a

contrattare merci esotiche, artigiani che lavoravano instancabilmente nelle loro botteghe, venditori ambulanti che richiamavano i passanti con voci cariche di storie e dialetti. I bambini correvano tra i vicoli, giocando sotto lo sguardo vigile delle loro madri, mentre l’aria vibrava di vita e racconti non detti. Ogni suono, ogni dettaglio sembrava custodire un frammento di umanità, e Dickens, con il suo sguardo attento, non poteva fare a meno di fissare su carta quelle immagini pulsanti di vita.

Tra i simboli più rappresentativi della ricchezza genovese spiccavano la Basilica della Santissima Annunziata del Vastato e il Teatro Carlo Felice. La prima, con i suoi affreschi straordinari e i dettagli dorati, appariva agli occhi dell’autore del “Canto di Natale” come un emblema della vanità delle grandi famiglie genovesi, ma anche come una prova tangibile della profonda devozione religiosa della città. Il Teatro Carlo Felice non era soltanto un impor-
grandioso e l’umile, si mescolavano in un’incessante danza di storie e suoni. Spesso lo scrittore inglese si concedeva lunghe passeggiate a cavallo lungo le mura cittadine, per ammirare una prospettiva unica sulla città. Dalle alture, le mura fortificate si estendevano come una piccola versione della Grande Muraglia, offrendo vedute mozzafiato che cambiavano continuamente: da un lato il porto, con il suo movimento incessante, dall’altro

tante centro culturale, ma anche un punto di ritrovo privilegiato per la fami glia dello scrittore e l’élite cittadina, dove si respirava un’atmosfera unica, capa ce di unire raffinatezza artistica e vivace mondanità.
Genova, con la sua vitalità, non era solo un luogo da osservare, ma un palcoscenico vivo, in cui il sacro e il profano, il

le valli dei fiumi Polcevera e Bisagno, che si snodavano tra le colline, creando un panorama tanto vario quanto affascinante. Immerso nella quiete della campagna, lo scrittore inglese traduceva su carta le infinite suggestioni offerte dall’anfiteatro genovese, trasformando persino i dettagli più insoliti in
preziose fonti d’ispirazione. Anche il fastidioso rintocco delle campane di Genova, che a suo dire emettevano “il rumore più insopportabile”, trovava un angolo nella sua immaginazione, diventando il cuore di uno dei suoi racconti più simbolici, intitolato, non a caso, Le Campane. “Avere trovato il titolo - disse - e sapere come sfruttare lo spunto delle campane è una gran cosa. Che mi assordino pure da tutte le chiese e conventi di Genova, ormai: non vedo altro che la cella campanaria di Londra in cui le ho collocate."
Nel suo secondo racconto di Natale, i rintocchi delle campane non sono più semplici suoni, ma si trasformano in storie intrecciate al destino di Trotty Veck, un povero usciere oppresso dalla miseria e dai giudizi altrui. Guidato dagli spiriti delle campane, il protagonista scopre che anche nei momenti più oscuri si può trovare speranza e riscatto.


Quei rintocchi, infatti, non si limitano a segnare il passare del tempo, ma diventano un messaggio profondo sull’umanità e sulla possibilità di redenzione. Genova, con il suo intricato equilibrio di ordine e caos, ha offerto a Dickens uno specchio attraverso cui riflettere sulle dinamiche sociali e sull’individuo. Nei suoi caruggi e piazze, tra mercati affollati e strade nobiliari, lo scrittore ha trovato un’umanità che continua a vivere nelle sue opere, testimonianza di un legame indissolubile tra la città e la sua narrativa. Ripercorrere i luoghi vissuti e descritti da Dickens significa immergersi in un mondo dove ogni suono, colore e contrasto diventa una chiave per esplorare le profondità dell’animo umano. Nei rintocchi delle campane che ancora oggi risuonano tra i vicoli si avverte la forza di quel fascino che tanto colpì uno dei più grandi narratori della storia.
È un suono lieve ma carico di significato, che continua a raccontare storie di speranza, redenzione e inesauribile meraviglia.
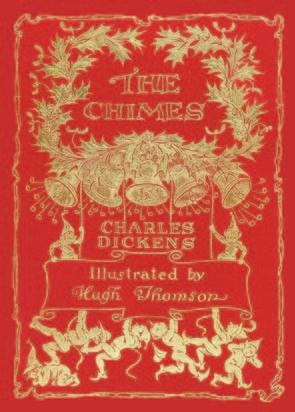


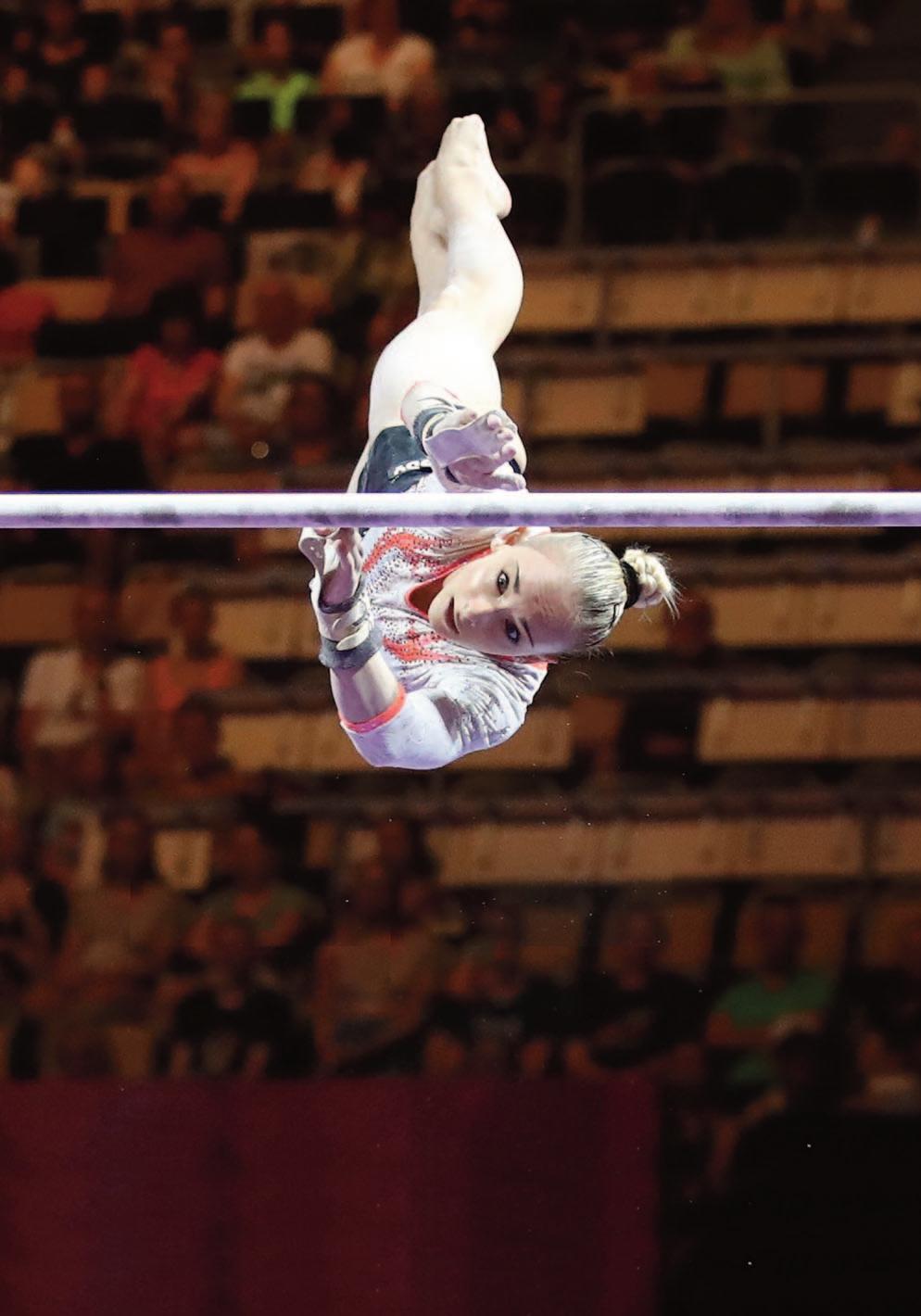
Alice e Asia ce l’hanno fatta. Le due ginnaste genovesi, partite dalla palestrina della scuola elementare di Sant’Eusebio, passando poi attraverso quella dell’Andrea Doria in viale Aspromonte, plasmate con amore dalla
lificati è più che un impegno nell’anno in cui la Liguria è stata insignita del titolo di Regione Europea dello Sport 2025, rilevando idealmente il testimone da Genova che era stata Capitale Europea dello Sport 2024.

loro istruttrice Valentina Pezzali, sono arrivate a vincere medaglie ai Mondiali e agli Europei e persino un oro alle Olimpiadi. Dare la possibilità al maggior numero possibile di ragazze e ragazzi di fare sport in strutture moderne e idonee quanto a sicurezza e igiene, con le attrezzature adeguate ed istruttori qua-
Lo scopo primario ovviamente non è costruire campioni ma consentire ai nostri ragazzi di godere di un diritto, quello allo sport. Se poi c’è chi ha il dna dei fuoriclasse tanto meglio. Potessero appuntarsi sul petto tutte le medaglie vinte, Alice e Asia D’Amato, 21 anni, “le fate azzurre” così come sono da tempo
soprannominate, sembrerebbero uno di quei generali dell’Unione Sovietica sul palco che veniva allestito al Cremlino in occasione della sfilata per celebrare la Rivoluzione d’Ottobre. Il loro, infatti, è un palmares sterminato. Per rendersene conto basta fare un blitz su Wikipedia, senza impantanarsi nello stucchevole “chi è più brava tra Alice ed Asia”? Una domanda che purtroppo si sente spesso ed è fastidiosa quasi quanto il “mai vuoi più bene alla mamma o al papà?”.

Alice, premiata lo scorso dicembre da “La Gazzetta dello Sport”, mediante i Gazzetta Sports Awards, come donna dell'anno, in questo suo favoloso 2024, è stata campionessa olimpica alla trave e vice-campionessa olimpica a squadre a Parigi 2024, vincitrice della medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali del 2019 e vincitrice di dieci medaglie ai

Campionati Europei. Specialista alle parallele asimmetriche, su questo attrezzo ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati europei nel 2019, prima italiana a riuscirci, cui ha fatto seguito l'argento nel 2022, l'oro nel 2023 e un secondo oro nel 2024.
Nonostante le parallele siano il suo attrezzo di punta è anche una buona all-arounder, testi-
moniato dall'argento conquistato agli Europei del 2024 e dal quarto posto ottenuto alle Olimpiadi di Parigi, miglior risultato di sempre per un'italiana in una finale all-around olimpica. È inoltre, insieme a Nastia Liukin, Simone Biles e Rebeca Andrade, l'unica ginnasta ad aver conquistato cinque finali in un'Olimpiade dall'introduzione del nuovo Codice dei Punteggi.
Asia è stata campionessa europea all-around nel 2022 a Monaco e vincitrice della medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali del 2019 a Stoccarda. Nel volteggio si è laureata vice-campionessa del mondo nel 2021 a Kitakyushu e due volte vicecampionessa europea nel 2022 e 2023.
Coppa del Mondo individuale, durante la finale al volteggio, si è rotta il legamento crociato anteriore ed il menisco.
Ma sacrificio e lavoro sono nel dna di chi ha scelto di praticare uno sport come la ginnasti-

La scorsa estate a Parigi non c’era perché la sfortuna si è accanita contro di lei. Nella primavera del 2023 al Cairo, in occasione della
ca artistica che non ti regala niente e non lascia spazio all’improvvisazione. Asia così ha recuperato a tempo di record e a fine febbraio

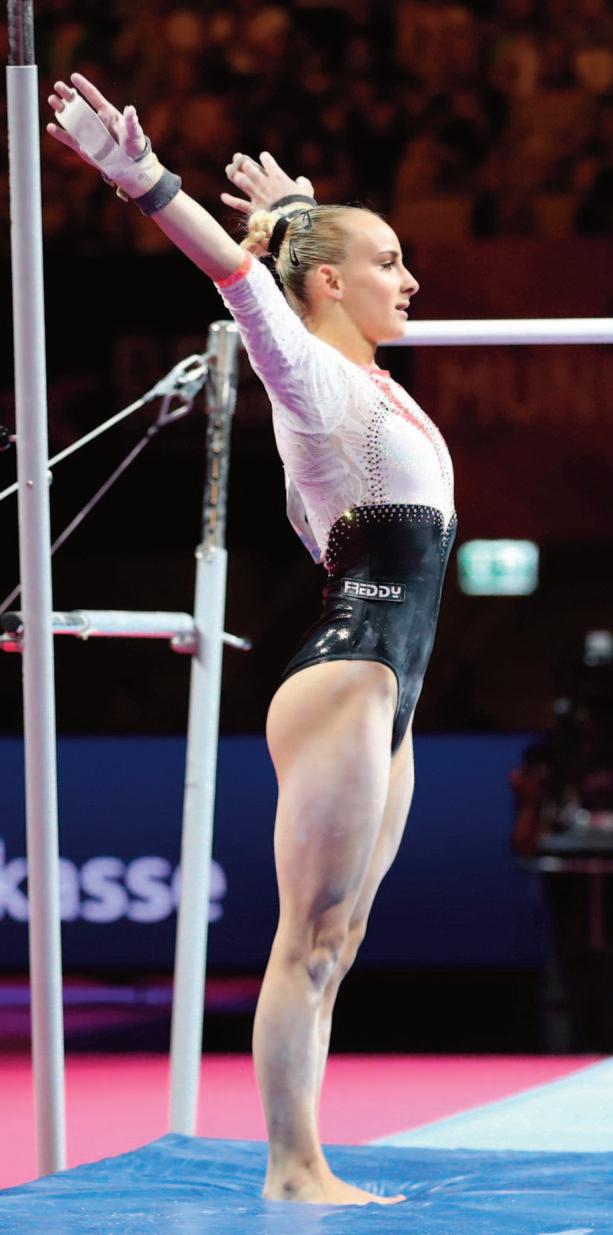
2024 era già in pedana vincendo al Trofeo città di Jesolo l'oro con la squadra, il bronzo nell'all-around e alla trave. Convocata ai Campionati Europei di Rimini per gareggiare su tutti gli attrezzi, si è però infortunata nuovamente, lesionandosi il legamento crociato già operato. Addio Olimpiadi.
Ma a Parigi è come se avesse vinto anche lei: “Dopo tutto quello che abbiamo passato ce lo meritavamo. Sono super fiera di te”, ha immediatamente postato sui social dopo il trionfo della sorella.
Ma anche nelle favole più belle c’è sempre un momento di commozione. La medaglia d’oro Alice l’ha dedicata al padre, Massimo, vigile del fuoco che è mancato due anni fa per un infarto. “Era lui che le accompagna alle gare, io dovevo pensare a mandare avanti la mia attività. Ci siamo separati che Alice e Asia erano ancora piccoline, ma il nostro rapporto è rimasto molto buono”, racconta mamma Elena che ha un negozio di hair stilist in via Piave ad Albaro. E parla con fierezza di una famiglia tutta al femminile: “Io le ragazze e mia mamma Carla che ha 85 anni e non si perde una gara delle nipoti. Sono stata una madre severa, ma io non sopporto i bambini capricciosi e maleducati. Come diciamo a Genova, le ho desbelinate che erano ancora piccoline. Un esempio? Se prendevano un bel voto a scuola e chiedevano un regalo, io rispondevo che non avevano fatto niente di più che il loro dovere.
Nemmeno a parlarne poi di giustificazioni perché non avevano potuto studiare avendo fatto tardi in palestra. E quando c’era una festicciola dicevo che toccava a loro scegliere: o gli amichetti o l’allenamento. Manco a dirlo hanno sempre scelto la ginnastica”.
A 11 anni le gemelle lasciano Genova e l’Andrea Doria, destinazione il Centro Federale di Brescia. Sono anni di sacrifici e disciplina. Il talento non basta se non è accompagnato da un lavoro costante, giorno dopo giorno. Fatica, sudore, abnegazione e tante rinunce. Vietate le serate in discoteca, anche una semplice pizza diventa un evento perché con la bilancia non si scherza e non puoi sgarrare neanche di qualche etto. Fondamentale nell’affermazione delle due gemelline di Sant’Eusebio è l’incontro con Enrico Carella. Strano ma vero, proviene da uno degli sport più rudi: il rugby. Si rivela invece determinante in una disciplina dove grazia e armonia sono indispensabili. “Ero sicuro che Alice avrebbe fatto una grande Olimpiade – ha confidato -La sera prima della finale le ho parlato: sei fortissima, devi solo avere più fiducia in te stessa”.
a vincere una medaglia d’oro. In assoluto (oro, argento a squadre e quinto posto nelle parallele asimmetriche), a parte Franco Menichelli (Roma 60 e Tokyo 64), ha fatto meglio anche di Yuri Chechi. La libellula di Sant’Eusebio è

Alice D’Amato è dunque entrata nella storia, prima donna della ginnastica artistica italiana
stata elogiata da Simone Biles (quinta a causa di una caduta) ovvero una leggenda della ginnastica al pari di Olga Korbut e Nadia Comaneci: “Ha fatto una gara eccezionale. Sono orgogliosa per lei!”. E i complimenti che arrivano dalla numero 1 sono sempre i più graditi.



Sarà una primavera ricca di appuntamenti e ci aspettiamo che continui il trend positivo di presenze registrato nella nostra città che continua a consolidare il suo posizionamento come meta turistica apprezzata dai turisti di tutto il mondo.
Ad aprile torna Euroflora al Waterfront di Levante la sua storica location, e Genova è pronta a regalare a cittadini e visitatori un’esperienza unica. In tutta la città si respirerà l’atmosfera floreale attraverso allestimenti ed installazioni a tema per un’esperienza diffusa da Ponente a Levante anche attraverso il nostro meraviglioso patrimonio culturale di musei, parchi e ville storiche. Torneranno, per un doppio weekend, i Rolli Days anche per la prima volta in versione “by night”.
A metà aprile avremo la Mezza di Genova con runners da tutto il mondo, grande classico del nostro calendario sportivo ma che quest’anno abbiamo deciso insieme agli organizzatori di svolgere su 2 giorni (sabato family run e gare domenica) proprio per incrementare ulteriormente il volano turistico di questo evento. La nostra offerta turistica inoltre propone una grande scelta di percorsi e sentieri, da quelli urbani a quelli della strada dei forti recentemente riqualificati con grandi investimenti, passando per l'acquedotto storico o per il Cammino dei Santuari del mare senza dimenticare l'esperienza unica dei nostri collegamenti verticali come ascensori, funicolari e cremagliere.




NNel cuore della Val Trebbia, si nasconde una località dove il passato si fonde con il presente, le antiche tradizioni con la capacità di metamorfosi dei suoi abitanti. Fontanigorda, piccolo borgo di 233 anime, non è vanitosa: protetta dai tortuosi tornanti che caratterizzano la Statale 45, accoglie gli avventori con riservata quiete. Eppure, passeggiando per le intricate viuzze del suo centro si viene pervasi da una pluralità di rumori: le risate dei bambini - liberi di sfrecciare in bicicletta in un centro quasi completamente pedonale - si mescolano con il chiacchiericcio sommesso degli anziani, infrangendo l’apparente silenzio.


Nomen omen, Fontanigorda, dal latino “Fontis Ingurdis”, è nota come il paese delle fonti: grazie alla presenza di numerose fontanelle - se ne possono contare ben tredici - tutte ornate da una piccola immagine della Vergine. Anima del paese, l’acqua gelida rappresenta la più importante attrazione turistica.
Non a caso nel passato erano molti i pellegrini che vi si recavano nella certezza di trovare un’acqua salutare, quasi miracolosa.
Una volta arrivati, vi consigliamo di lasciare l’auto nell’ampio parcheggio di piazza Roma e di proseguire a piedi: lo spirito di Fontanigorda si può percepire solo camminando tra le sue intricate viuzze. L'assenza di auto e il silenzio, interrotto solo dai passi, dai saluti tra vicini e dal rintocco delle campane della chiesa parrocchiale, creano un'atmosfera che sembra appartenere a un quadro d'epoca. Ma non fatevi ingannare, se consideriamo il tasso di innovazione rapportato al numero degli abitanti, Fontanigorda è da premio Nobel: fino agli anni Venti del secolo scorso il borgo si sostentava grazie ad un’industria, tanto rara quanto complessa: la lavorazione del fungo dell’esca. Nota anche nei grandi mercati esteri, la fabbrica dell’esca di Fontanigorda fu il centro di produzione e lavorazione di un particolare tipo di fungo parassita per tutto l’Ottocento e fino alla Seconda Guerra Mondiale. Qui, il fungo dell’esca veniva essiccato, immerso in acqua, battuto con apposite mazze di legno e, infine, ridotto a sfoglia di tessuto finalizzato principalmente all’uso chirurgico come emostatico.


Un’industria che ha poche analogie al mondo anche per via della rarità del materiale: la chiusura della fabbrica si pensa infatti sia dovuta alla scomparsa del fungo.
Se è vero che in Liguria lo scambio di merci, così come di pensieri e parole, è parte del DNA e dell’identità dei luoghi, Fontanigorda incarna perfettamente l’idea di una terra che non è mai uguale a se stessa e dove ogni angolo ha influenze diverse.
Non è un caso, infatti se nei mesi estivi, si senta parlare francese tra le vie del paese. Successivamente alla chiusura della fabbrica, buona parte della popolazione del borgo si trasferì a Saint Maime, nelle Alpi dell’Alta Provenza, attratta dalla possibilità di lavoro nelle miniere di lignite situate nelle vicinanze.
Tra le due comunità si sono instaurati legami di parentela e di amicizia e ancora oggi c’è chi a Saint Maime comprende il dialetto ligure. A testimonianza di questo rapporto fraterno, i due Comuni si sono gemellati dedicando una piazza al paese gemello.
Continuando a passeggiare lungo le strette vie del borgo, con il rumore dell’acqua che vi ac-
Foto: Cosmin Latan
compagna e sembra indicare la giusta direzione, ben presto raggiungerete l’antica chiesa parrocchiale, custodisce numerose opere di artisti locali, e il Comune di Fontanigorda che conserva al suo interno gli strumenti della fabbrica dell’esca, esposti insieme ad alcune fotografie d’epoca.
Superata la chiesa, ben presto raggiungerete Piazza Brignole, antica Aia di Brigneri, dove una lastra rievoca la memoria di un vivace ballo campestre, ricordato dagli abitanti come la realizzazione tangibile di quello spirito di comunità che pervade il paese.
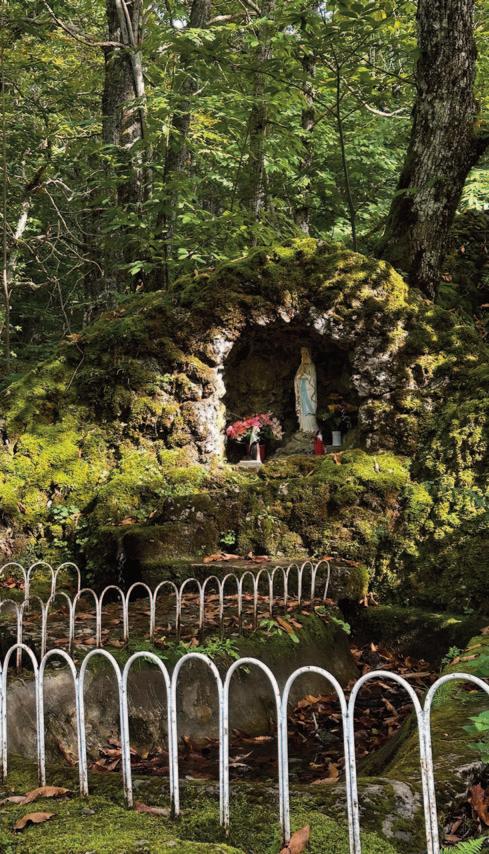
Quella leggendaria serata del 20 settembre 1936 è rimasta cristallizzata nell’immaginario comune per aver ispirato al poeta Giorgio Caproni la famosa poesia «Ballo a Fontanigorda», dell’omonima raccolta.
L’affetto che Caproni ha dimostrato nei confronti della Val Trebbia, dove ha vissuto per molti anni, è stato ricambiato dai cittadini del borgo che hanno creato un pittoresco percorso poetico con l’obiettivo di celebrare i versi che il poeta ha dedicato alla vallata.
Partendo sempre da Piazza Roma, si percorre un sentiero nel bosco, particolarmente suggestivo perché si snoda in un contesto naturale che sembra provenire da un libro di fiabe: il ce-
lebre Bosco delle Fate. Caratterizzato da enormi macigni ricoperti da muschio e felci, castagni secolari e scalini in pietra, questo bosco è un simbolo di Fontanigorda per la magia che evoca e per la storia che ricorda. Passeggiando è possibile leggere alcune tra le più belle poesie di Caproni, incise su imponenti lastre di ardesia.
Il fiabesco sentiero vi condurrà ad una pianura dove sorgono la Pro Loco, un campo da bocce -teatro di appassionanti sfide tra gli anziani signori del posto -, un’area giochi dove far tappa se siete con i vostri figli.
Ma non è finita qui: non abbiate paura di esplorare il bosco che cela, tra i suoi massi e



alberi, una spada nella roccia da fare invidia al celebre cartone animato. Se siete amanti del trekking potete proseguire fino a trovare la sua gemella, posta in alto, sulla vetta del monte Gifarco. D’altronde come suggeriva Caproni « L’ultima mia proposta è questa:/ se volete trovarvi,/ perdetevi nella foresta ».
All’interno del Bosco delle Fate si può percepire davvero come l’uomo si sia adattato al paesaggio e ingegnato per ottimizzarlo in una terra difficile: i suoi alberi secolari sono infatti testimoni viventi dell’importanza del castagno come risorsa economica per la popolazione locale. Dal legname per riscaldare i casolari, fornire tannino, ricavare tavolame e attrezzi di uso quotidiano, fino al fogliame usato come lettiera per il bestiame. Poi, ovviamente, le castagne che hanno rappresentato l’unica alternativa possibile ai cereali in virtù della facile reperibilità e conservabilità.
Nella lotta quotidiana per la sopravvivenza, gli abitanti utilizzavano le castagne nei più svariati modi: arrostite o bollite in acqua o latte sostituivano il pane; essiccate e macinate, erano impiegate al posto delle più costose farine di cereali nella preparazione di polente, focacce, zuppe. Tradizioni ancora vive e autentiche che si riverberano anche sulle ricette locali, tramandate dalle botteghe e trattorie che resistono allo spopolamento dell’entroterra. Queste attività sono lo specchio di una comunità che ha saputo fare




dei limiti un punto di forza per superare ogni genere di avversità.
È proprio questa perseveranza che ha permesso, da alcuni anni, di impiantare a Fontanigorda un meleto razionale. Nel frutteto si coltivano varietà moderne e cultivar storiche come la Mantovana, la Renetta in ogni sua variante (dalla rugginosa, alla champagne) e la de Luigiotto, così chiamata probabilmente dal nome di colui che la diffuse. Il meleto di Fontanigorda non è solo un simbolo della valle, ma anche un significativo esempio di concreta valorizzazione della tradizione agricola locale. Puntando su una produzione più attenta alla qualità che alla quantità, i produttori di Fontanigorda riescono a ottenere frutti pregevoli, adatti sia al consumo diretto sia alla trasformazione in cucina. La capacità di sfruttare le risorse territoriali che da sempre ha contraddistinto gli abitanti della valle ha permesso a Fontanigorda di usufruire di LIFE, uno strumento finanziario europeo per la tutela della biodiversità. Il paese è infatti diventato protagonista del progetto Life CLAW: un’iniziativa volta al ripopolamento del gambero fluviale promossa, tra gli altri, dall’Acquario di Genova e dal Parco dell’Antola. In particolare, il Centro Ittico di Fontanigorda ha riportato in vita vasche utilizzate nel dopoguerra per la riproduzione delle trote. Ora, queste vasche ospitano l'allevamento del gambero di fiume e delle trote fario, contribuendo alla preservazione della fauna e dell'ecosistema locali.
Risalendo in auto e lasciandosi Fontanigorda alle spalle, ci si rende conto della particolare energia che emana. Il tempo qui sembra scorrere diversamente, come se la fluidità delle acque potesse connettere epoche diverse, e si prova un velato senso di nostalgia.
Tutto è simbolo di una comunità unita: dalla distesa di tetti rossi, l’uno vicino all’altro, quasi a volersi sostenere durante i freddi mesi invernali, alla capacità di unirsi per tutelare e mettere a frutto le risorse naturali.
La tradizione si fonde con l’innovazione e finalmente si coglie il significato di alcuni versi di Caproni: « Viviamo di poco / Al fuoco / Lasciateci qua. Contenti.»

Quando il mare è (letteralmente) di moda

Vestire alla marinara i figli era un vezzo delle famiglie ricche, lo ha raccontato magnificamente Susanna Agnelli in un libro autobiografico che ha venduto quasi 300 mila copie. Lo stile dell'abito da marinaio era seguito in particolare nel corpetto e nel colletto, per bambine e ragazze era d’obbligo indossare una camicetta con, per l’appunto, il colletto alla marinara che è chiamata middy, derivando da "midshipman" (tradotto letteralmente mezzomarinaio) che nella Royal Navy inglese e nella Marina degli Stati Uniti rappresenta il grado più basso degli aspiranti ufficiali.
Dai middy delle ricche famiglie borghesi alle magliette a strisce orizzontali dei portuali genovesi che il 30 giugno 1960 occuparono De Ferrari per impedire che la città medaglia d’oro della Resistenza ospitasse il congresso del Movimento Sociale Italiano.
Come i jeans, altro capo di lavoro made in Genova e diventati un cult per quanto riguarda l’abbigliamento, quelle magliette simbolo della rivolta divennero di gran moda tra i giovani all’inizio degli anni Sessanta e si potevano acquistare solo a Genova, in un negozio, anzi è meglio dire in una bottega, situato sotto i portici medievali della “Ripa Maris” a Sottoripa, proprio di fronte alla Darsena e al Porto Antico. Lucarda , che giustamente si fregia dell’onorificenza assegnata dal Comune e dalla Camera di Commercio di bottega storica come Romanengo, Viganotti e la drogheria Torielli, è una sorta di museo dell’abbigliamento della gente di mare. Non a caso arrivano quotidianamente frotte di turisti, alcuni “fai da te” e altri appositamente
accompagnati dalle guide.
C’è chi ovviamente acquista la maglietta a strisce, chi la mitica pidocchiera (maglia col collo a lupetto e maniche lunghe) rigorosamente di lana ruvida

da vero lupo di mare, chi il “camugin”, cappello di lana blu col pon pon rosso dei marinai di Camogli, e chi il “caban”, il classico cappotto blu tipico dei marittimi della Bretagna. Vecchi poster della Michelangelo o dell’Atlantic dei
Fratelli Cosulich alle pareti e sui manichini autentici cimeli come un cappotto della marina olandese o un cappello da marinaio semplice ormai ingiallito dal tempo. Ci sono le magliette dei marittimi delle “Linee Espresso”, quelle bianche in puro cotone con la scritta blu del personale di bordo dell’Italia Navigazione e la tuta Lucarda in puro cotone, una casacca da lavoro coloro kaki indossata dagli operatori del porto dagli anni Sessanta sino a quelli Ottanta.
Per tutto il Novecento Lucarda è stato un punto di riferimento per il porto e le compagnie di navigazione. Vestiva tutti: dai camalli ai pescatori, dagli equipaggi ai figli degli armatori. E Genova sobria, taccagna e fieramente in simbiosi col mare, rappresenta meglio di tutte le altre città portuali lo stile marinaio italiano che è basilare ed essenziale. Lucarda è definita “la Bottega della Gente di Mare”, ma è anche un punto di riferimento fondamentale per un certo tipo di abbigliamento, quasi una pietra miliare che ha segnato la storia della città e che ha plasmato la moda e le tendenze dei genovesi per quasi un secolo.
È stato il primo negozio a vendere jeans in città e le famose “Boxer”, le camicie che si ispiravano



a quelle dei carcerati americani, che Giorgio Lucarda, il creativo della famiglia, aveva portato da Genova alle Galeries Lafayette di Parigi. E a Portofino era d’obbligo scendere in Piazzetta con il maglione dolce vita blu di Lucarda. Michelangelo Antonioni era stato uno dei primi e presto si adeguarono in molti: Rossella Falk, Renzo e Nora Ricci, Alberto Squarzina, Joe Sentieri e Moni-

ca Vitti. Anche Fabrizio De Andrè e Paolo Villaggio erano clienti abituali.
Quanto a Gilberto Govi passava interi pomeriggi da Lucarda a prendere spunto per i personaggi delle sue commedie come aveva raccontato il genero, Andrea Barbieri, in un’intervista.
Lucarda, che fu inaugurato nel 1920, conserva il fascino e i ricordi di una antica tradizione marinara, mantiene saldi i legami con il passato e la sua storia. Il negozio è infatti rimasto quello delle origini: vecchi scaffali, muri a strisce bianche e nere secondo la tradizione genovese e, salite le scale dell’antico palazzo, un vero e proprio scagno con le pareti in legno ancora del precedente negozio. Qui si sono vestite generazioni di giovani genovesi che, prima che nasces-


sero i negozi specializzati in abiti casual, venivano dai quartieri bene della città a comprare in un’atmosfera di suk arabo con gli scaffali colmi all’inverosimile. Ma soprattutto Lucarda era punto di riferimento per il porto e le compagnie di navigazione negli anni ’50, ’60, ’70 e ‘80: Traghetti del Mediterraneo, Linee Canguro, Linee Espresso, la Società Italia, Lloyd Triestino, Tirrenia sono solo alcune delle

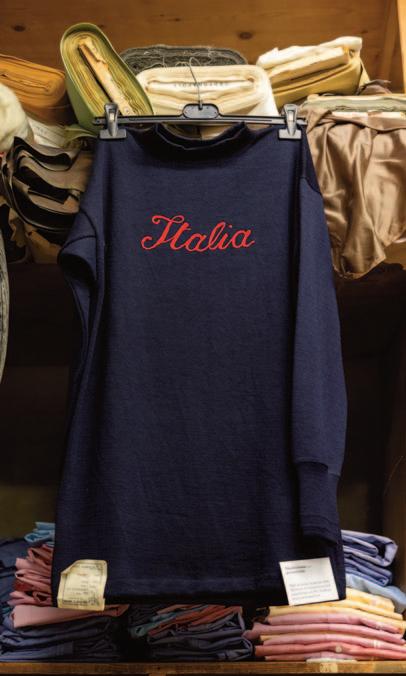
compagnie operanti in quel periodo che si servivano nel negozio per le forniture di abbigliamento per i marittimi, dagli ufficiali di macchina a quelli di coperta.
Ricorda con orgoglio Nanà, napoletana dei Quartieri Spagnoli, che del negozio di Sottoripa è un’istituzione avendo iniziato a lavorarci nel 1969: “Vestivamo interi equipaggi. I marittimi venivano col buono e ritiravamo il pacco dove dentro c’era tutto, dai mutandoni di lana al cappotto. Era un via vai continuo, c’erano quindici commessi che lavoravano gomito a gomito. Nel vicolo dietro il negozio c’era il laboratorio che era il regno di Nele, la camiciaia, e dove Siria tagliava la stoffa per le tute da lavoro. E poi c’erano tante sartine che lavoravano da casa. Cristiano Maglioglio la sua prima camicia, vistosa e con la grandi maniche larghe, è venuto a farsela apposta da noi”.
Siamo alla quinta generazione dei Lucarda. Tutto ebbe inizio con Giuseppe, un veneto con
antenati polacchi, che arrivò a Genova da Schio e aprì in via XX Settembre un negozio di tessuti, un “bottegone” che avendo sette ingressi veniva detto “da-e sette porte”. Il figlio che si chiamava pure lui Giuseppe, imparata l’arte in bottega, di ritorno dalla guerra, aprì in Sottoripa, nel 1920, un “negozietto” di abbigliamento da lavoro per portuali e marinai. Giuseppe, detto o scio Mimmo è morto a 94 anni nel 1989, ma da tempo i tre figli lo avevano affiancato nella gestione. Sergio passava le giornate in porto ad occuparsi delle ordinazioni e a prendere le misure, Mirella era dietro il banco e Giorgio gestiva fornitori e personale. Il testimone è poi passato a Michela, la figlia di Sergio, affiancata dalla figlia Elena, studi a Londra, laurea in antropologia e responsabile in Marocco per un’organizzazione che si occupa di difesa di diritti umani. E siccome bisogna stare al passo con i tempi si è inventata social manager creando uno sito internet, una pagina Facebook ed una su Instagram.


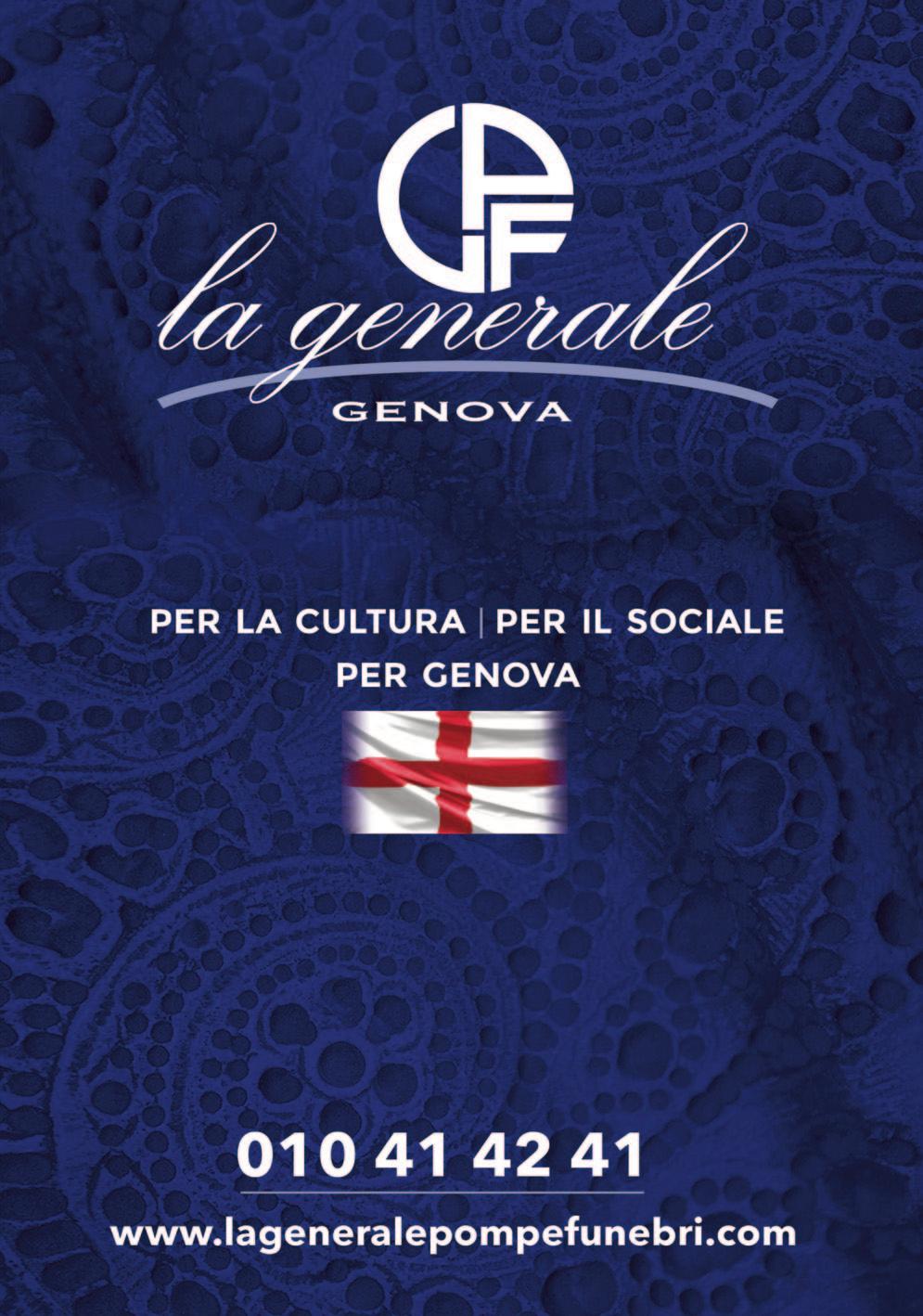











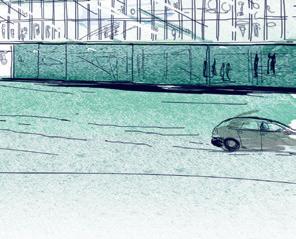



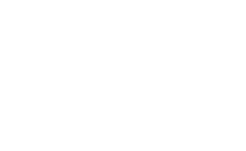
ESSELUNGA Genova San Benigno, Via di Francia
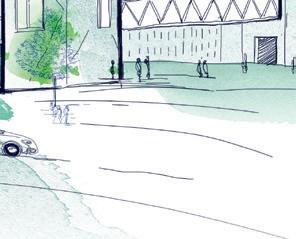











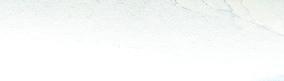
ESSELUNGA Genova, Via Piave








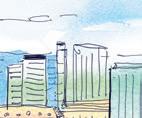
















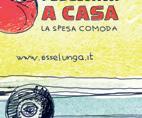









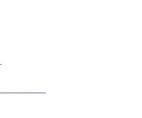



Online su esselunga.it




Scopri il mondo Esselunga. Ogni giorno lavoriamo per darti qualità, convenienza, eccellenza e innovazione. Ricerchiamo e selezioniamo i migliori prodotti da portare in tavola e offriamo tantissimi servizi per tutte le esigenze. Vieni a trovarci nei nostri negozi e online su esselunga.it

Scopri il negozio più vicino a te