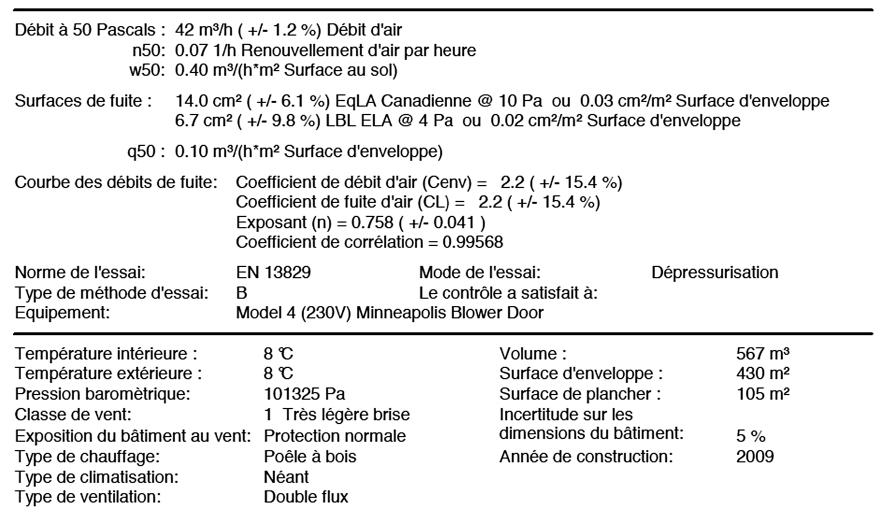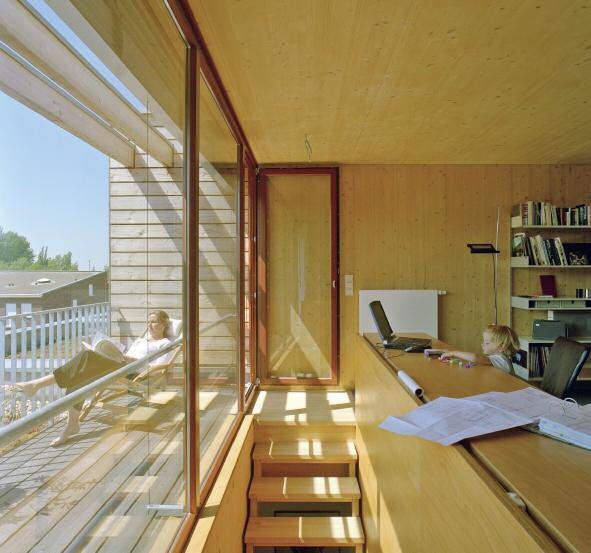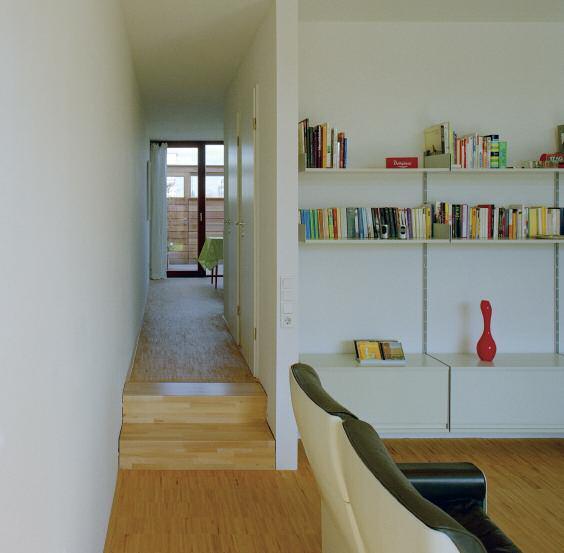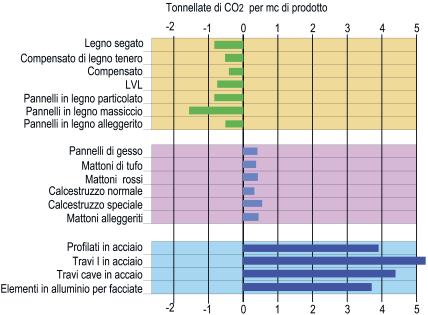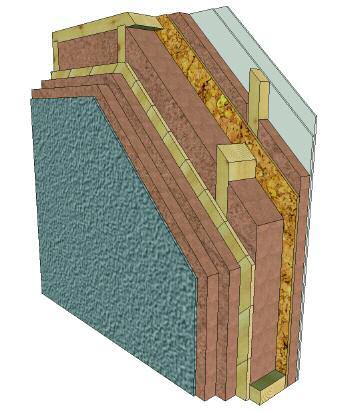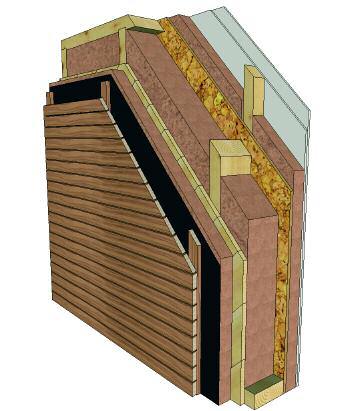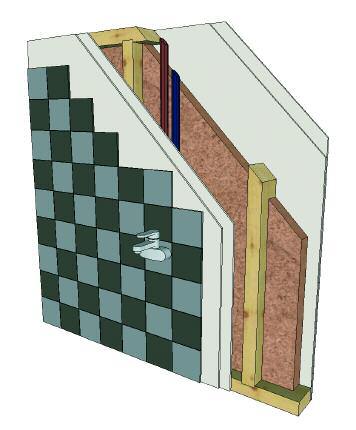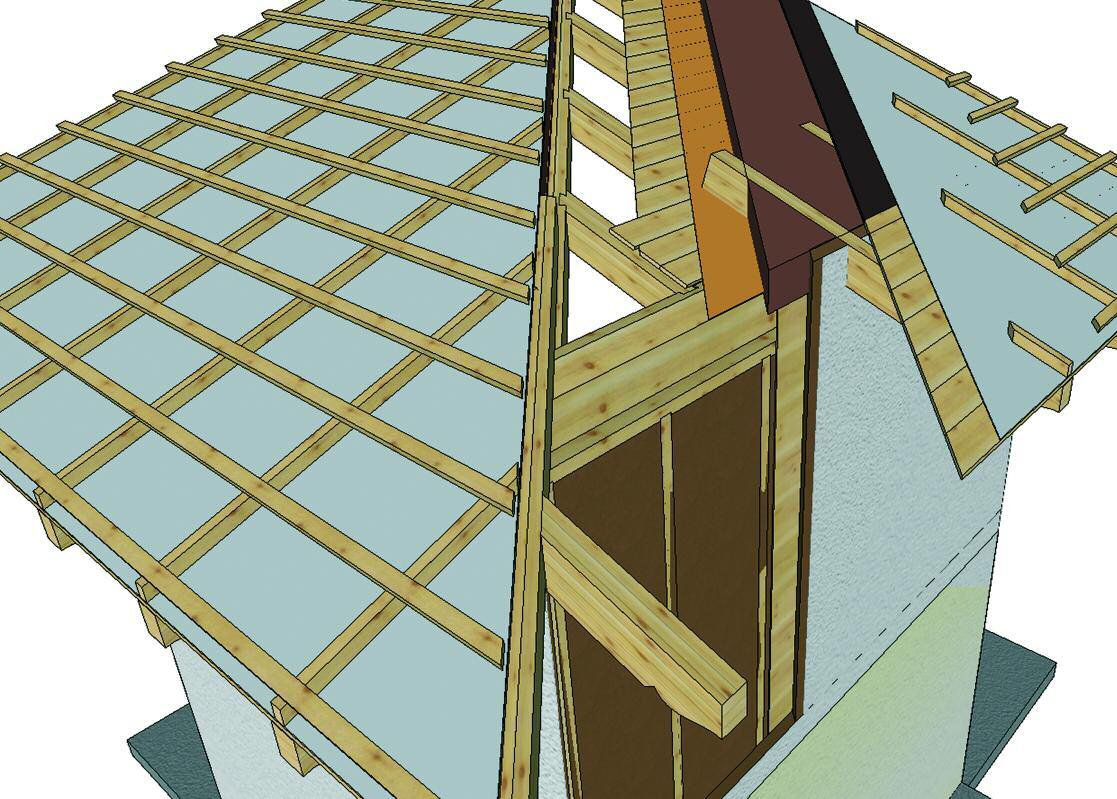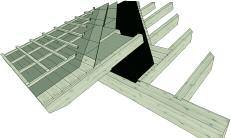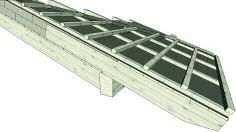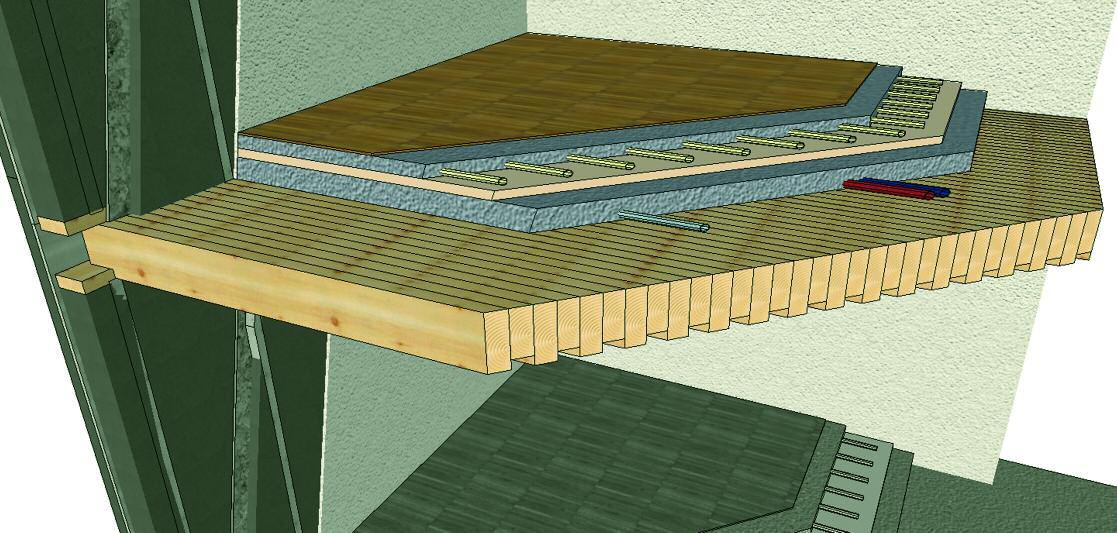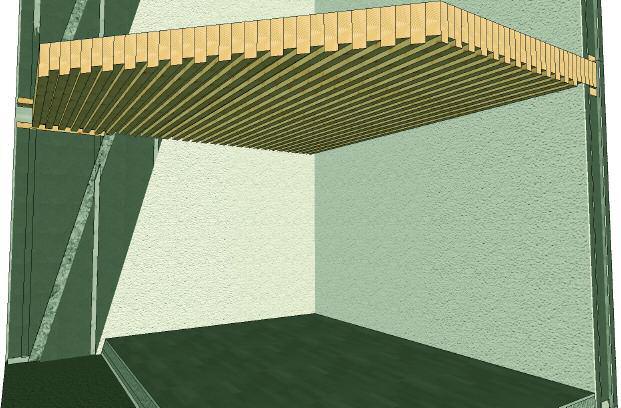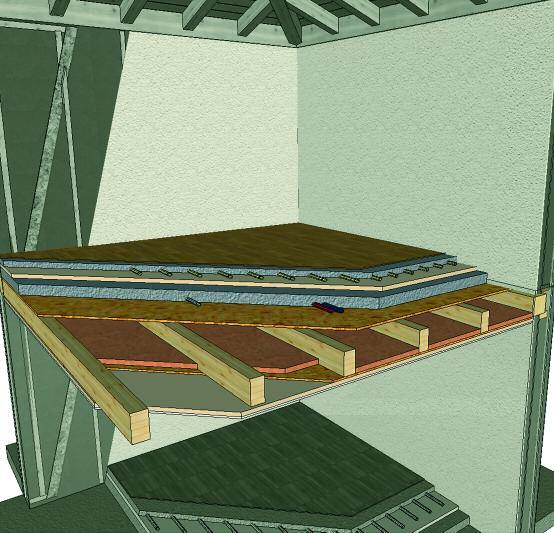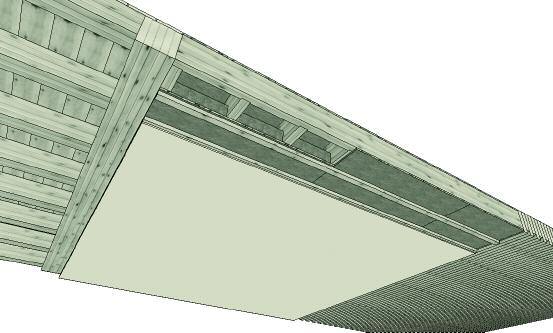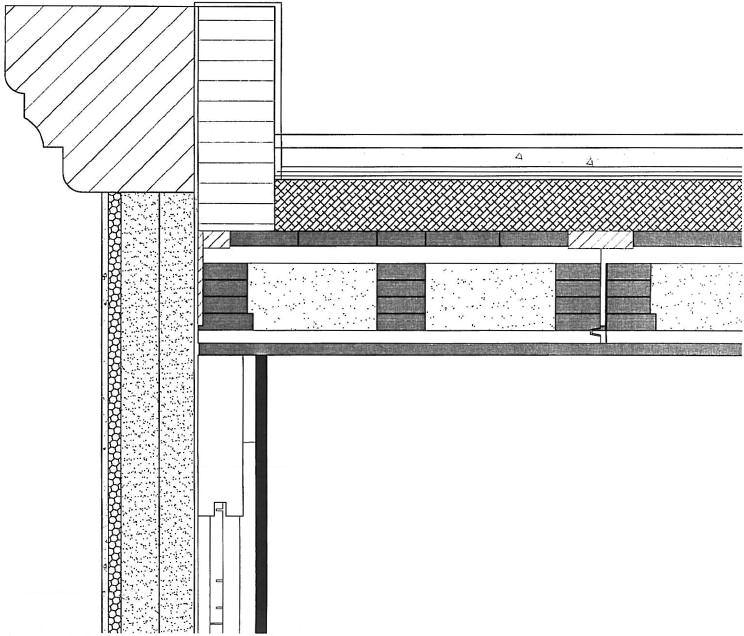con il patrocinio di in collaborazione con info e calendario www.azerotour.com febbraio | marzo perprogettare ecostruire edifici a energia quasizero tour2012 60incontri ideazione e coordinamento EdicomEdizioni




legnoarchitettura
rivista trimestrale
anno 3 – n. 6, gennaio 2012 ISSN 2039-0858
Numero di iscrizione al ROC: 8147
direttore responsabile
Ferdinando Gottard
redazione Lara Bassi, Lara Gariup
editore
EdicomEdizioni, Monfalcone (GO)
redazione e amministrazione
via 1° Maggio 117 34074 Monfalcone - Gorizia tel. 0481.484488, fax 0481.485721
progetto grafico
Lara Bassi, Lara Gariup
stampa Grafiche Manzanesi, Manzano (UD)
Stampato interamente su carta
riciclata ottenuta da fibre selezionate
prezzo di copertina 15,00 euro abbonamento 4 numeri
Italia: 50,00 euro - Estero: 100,00 euro
Gli abbonamenti possono iniziare, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile in qualsiasi periodo dell’anno
distribuzione in libreria
Joo Distribuzione
Via F Argelati 35 – Milano copertina
Letterbox House, Blairgowrie (AUS)
Foto: John Gollings - GollingsPidgeon
È vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli, disegni e foto se non espressamente autorizzata dall’editore
Edoardo Milesi


 Foto: Nome Cognome
Foto: Nome Cognome
-
Foto: John Gollings
GollingsPidgeon
06 legnoarchitettura
Foto: Studio Benedikter, Luca De Giorgi
89 97 105
tetto
esterna incontri techné sistemi dettagli 34
6
Housing Sociale in legno in Europa Travi e pilastri
pianoparete
68
Monastero di Siloe Edoardo Milesi 12
Guesthouse Paratelier 2 4
Letterbox House McBride Charles Ryan 34
Uffici Modus Architects, Lignoalp 44
Casa Damico Karawitz Architecture 58
Ampliamento Manuel Benedikter 68
Uffici Gianfranco Visentin, Andrea Zambon 78





78 58 12
F o t o L i g n o a p F o o K a r a w t z Foto: Natura Building
24
12 progetti F o o P a o l o D a R e 44
Edoardo Milesi
Progettista attento all’influenza che l’architettura ha sulle persone e nella trasformazione del territorio, a un costruire sostenibile inteso come relazione positiva tra costruito e ambiente, testimonia nei suoi lavori la grande passione per il proprio mestiere e per il legno.
Utilizzato in diversi modi e in diversi tipi, ma sempre rispettandone caratteristiche e qualità, connota fortemente tutte le sue architetture.
In questa pagina e in quella a fianco, CANTINA DI VINIFICAZIONE E INVECCHIAMENTO, Collemassari (GR), 20012006.
Progetto vincitore del Premio Internazionale Architettura
Sostenibile Fassa Bortolo (2006), il fabbricato è una scatola di legno interrata in cui l’unico elemento emergente è una quinta bianca che esce dalla collina.
Soluzioni bioclimatiche caratterizzano l’opera nel suo insieme: pareti ventilate in legno là dove l’inerzia termica va protetta, guidata e riequilibrata; legno naturale a doghe per filtrare la luce diretta del sole; lastre di zinco titanio per la protezione all’acqua; vetrate acidate a bassa emissività per bilanciare la luce naturale. La cantina è frutto di un’alta densità progettuale: risparmio energetico, bioedilizia, qualità del posto di lavoro, ingegneria bioclimatica hanno guidato la progettazione e l’accurata scelta di ogni singolo componente e materiale.

Questa è una rivista che tratta di architettura in legno. Nella sua carriera di architetto, quale importanza ha avuto questo materiale?
Il legno è una connotazione forte delle mie architetture. Qualcuno ha detto che a causa degli svariati modi coi quali lo utilizzo ne è la cifra. Certamente è un materiale che mi ha attratto sin da bambino. Possiedo ancora una collezione di piccoli pezzi di legno di essenze diverse (per metà scortecciati e per metà no) che ho raccolto nei boschi con mio padre me-
dico, ma appassionato di natura. Mi continua ad affascinare la gigantesca e generosa famiglia degli alberi, legni sempre diversi per colore, resina, consistenza, profumo, disegno della vena e della pelle. La stessa essenza cresciuta in luoghi differenti presenta connotazioni diverse, proprio come il genere umano. Questo, nella mia professione, mi ha aiutato a utilizzare con disinvoltura una moltitudine di legni che scelgo in base alle specifiche caratteristiche. Conoscerlo mi ha portato nel tempo,
6 legnoarchitettura_06 incontri incontri
F o t o P a o o D a R e

F o o C o r a d o B o n o m o

BIBLIOTECA E LABORATORIO
PLASTICI ARCHOS, Albino (BG), 2007-2010.
L’ampliamento dello studio Archos dello stesso architetto è un momento di sperimentazione. Antisismico, basso consumo energetico, grande traspirabilità, velocità di realizzazione, flessibilità distributiva, bassa manutenzione.
Unico appoggio a terra, per un edificio di 250 m2: un dado cavo (l’autorimessa) in calcestruzzo di 6x6 m ancorato al sottosuolo con micropali. L’occasione per verificare una nuova texture; il resto: ferro e legno montato a secco.
approfittando delle differenti tipologie fisiche, a evitare i trattamenti. Esistono impieghi appropriati per ogni tipo di legno, una corretta stagionatura e ossidazione restano la vera garanzia per la sua durata.
Stagionatura e ossidazione introducono un tema come quello del cambiamento dell’aspetto del legno nel tempo, dell’ingrigimento del materiale. Per alcuni progettisti è un limite e preferiscono rivestirlo, nei suoi lavori è invece a vista: considera questo cambiamento come un elemento del progetto?
Ho studiato architettura a Venezia e il gusto per la materia lavorata dal sole, dalla salsedine e dal tempo mi è venuto in quel luogo dove la natura e l’uomo hanno creato un mondo artificiale di grande fascinazione e in continua trasformazione. Così ho iniziato a utilizzare il legno naturale nei restauri, pensando alla sua mutazione cromatica nel tempo, per quei volumi aggiunti che volevo dichiarare, ma in modo gentile. Il legno invecchiato naturalmente non stona mai, è sempre di grande eleganza nella sua umiltà proprio perché riesce a mantenere sempre la sua personalità. Il cedro ossidato ha uno splendido colore cenere, la quercia diventa quasi nera, il castagno come il suo frutto e il larice mantiene sempre un sottofondo rossastro. L’abbinamento del legno naturale con la pietra, l’intonaco di calce, il metallo funziona
sempre a patto che anche questi vengano lasciati invecchiare naturalmente.
Potrebbe darci una definizione del legno?
Tutti sanno che il legno è un materiale vivo. Resta vivo anche dopo la morte dell’albero arrivando addirittura ad autoproteggersi mineralizzandosi. Lo insegnano a scuola, ma non si insegna che, per utilizzarlo bene, quella sua seconda vita va rispettata. Nutrendolo senza avvelenarlo ci garantisce a lungo un grande servizio.
Avrà capito quanto valore dò al legno che per me è molto più di un materiale.
Quali sono le possibilità tecnologiche ed espressive che il legno è in grado di offrire all’architettura contemporanea?
La vera architettura può essere solo contemporanea. Contemporanea al suo tempo. E il legno è da sempre il miglior partner dell’architetto. Il suo impiego aumenta con l’aiuto tecnologico, a patto che ne venga rispettata la sua natura. Personalmente utilizzo l’architettura, e quindi i materiali, per quello che possono darmi in termini di spazio. Non amo pensare al legno come elemento decorativo, ma per quello che mi serve strutturalmente nei grandi spazi o nei piccoli componenti funzionali alla fabbrica.
8 legnoarchitettura_06 incontri
F o t o P a o o A b b a d n
Non sono ossessionato dalla forma estetica, la forma è solo il risultato di un lavoro di ricerca prima di tutto sull’uomo poi su quello che gli sta attorno: la luce, la natura, i materiali.
Ai non addetti ai lavori può sembrare strano, ma ancor oggi il legno resta il materiale più adatto per resistere strutturalmente al fuoco. Il legno coltivato è certamente uno dei materiali da costruzione più economici (senza aggiungere che crescendo ci fornisce altri innumerevoli benefici). La sua grande famiglia è infinitamente varia e complessa e le variabili, come per la pietra, aumentano in modo esponenziale variandone il taglio, le lucidature, i trattamenti meccanici, fisici e chimici. Non esiste un altro materiale più espressivo e altrettanto economico. Il legno è il materiale sostenibile per eccellenza.
Può un architetto accostarsi al legno nello stesso modo in cui si accosta a un altro materiale costruttivo o è necessaria una certa sensibilità e/o preparazione tecnica?
Per il legno occorre preparazione tecnica, esperienza e passione. Quest’ultima aiuta ad acquisire le prime due ascoltando: la foresta, l’albero e l’artigiano che lo sa lavorare.
Nei suoi progetti ha utilizzato diversi materiali; quali sono i criteri che ne hanno guidato la scelta, in particolare del legno, e il loro abbinamento?
Amo l’architettura quanto la sua materia e per questo rispetto i materiali lasciando che esprimano tutta la propria energia. I materiali parlano con la propria fisicità. Ascoltarli aiuta a metterli nello stesso coro.
Scelgono da soli con chi stare. Non è necessario forzare la natura per ottenere risultati emozionanti. Come ho detto, esiste sempre il materiale più adatto per eseguire quel determinato pezzo. Esiste sempre un legno che risponde meglio degli altri a quella speciale sollecitazione e, ottimizzandone le performance, mai mi è capitato di sbagliare abbinamenti. La creatività aumenta e l’opera si arricchisce.
Nel caso del monastero di Siloe sono stati usati diversi tipi di legno (larice, cedro, legno lamellare). Può illustrarci i motivi e i modi del loro impiego?
Per la durabilità agli agenti atmosferici e ai parassiti nessun legno eguaglia il cedro che è della famiglia delle tuie. Leggero e stabile è ideale per i rivestimenti esterni, le pareti ventilate, i manti di copertura. Tuttavia è un legno molto morbido e pertanto inadatto per
WATERFRONT - LUNGOLAGO TADINI DI LOVERE, Lovere (BG), 2005-2006. Puntando sull’universale fascino dell’acqua, sono state interposte tra lago e strada una serie di funzioni in grado di mediare tra la magia dell’acqua, i rumori e il traffico stradale. I fari sono stati orientati verso l’acqua per richiamare i pesci durante la notte, è stata costruita una spiaggia di legno dove sdraiarsi a guardare il cielo, abbronzarsi, avvistare le barche in lontananza…

9
F o o P a o o D a R e
SCUOLA MEDIA BUONARROTI, Cinigiano (GR), 1999. Il progetto, a fronte della necessità di ampliare l’edificio, è stato eseguito per adeguare la scuola agli standards normativi. L’intervento ha interessato solo il corpo centrale, ristrutturato negli anni ‘50, molto deteriorato e non funzionale, sostituendolo con un elemento totalmente nuovo e dichiaratamente contemporaneo, riservando all’edificio storico solo interventi manutentivi e adeguamenti impiantistici. Il nuovo corpo centrale, al quale si demanda anche una funzione compositiva rispetto al ridisegno del centro cittadino, segna il riferimento spaziale verso la campagna della nuova piazza di Cinigiano.
le pavimentazioni o dove è sottoposto ad azioni meccaniche. Il larice rosso è altrettanto resinoso e per questo resistente all’acqua e ai parassiti, ma più nervoso, elastico, perfetto per infissi, pavimenti e strutture leggere anche con stagionatura a forno. Nelle travature importanti, per evitare torsioni e fessurazioni, va stagionato a lungo in tronco e per questo è introvabile. Il larice lamellare, essendo costituito da piccoli pezzi incollati assieme, è ovviamente del tutto stabile e l’ho utilizzato per le strutture verticali e orizzontali di grosso spessore. Usato all’interno lo voglio incollato con colle atossiche prive di formaldeide.
Oltre all’utilizzo di un materiale come il legno, attraverso quali scelte si esprime la sostenibilità nelle sue architetture? Ripeto da sempre che la vera architettura (non l’edilizia priva di progetto) non può che essere sostenibile. Nei materiali, nel suo rapporto con l’ambiente, con l’uomo, con le risorse del pianeta. I cardini della sostenibilità sono: l’ecologia, il risparmio delle risorse non rinnovabili, l’equità sociale.
L’edilizia è responsabile di tutta l’attività di estrazione di materie prime e produce oltre il 60% dei rifiuti umani. Da tutto ciò si evince la grande responsabilità di coloro che lavorano sul progetto nella scelta e selezione dei materiali, valutandone le conseguenze sociali, ecologiche ed economiche in tutto il ciclo di vita. Sostenibilità per me significa quindi relazione positiva tra costruito e ambiente, tra efficienza (in tutti gli ambiti) e risparmio energetico. Dove efficienza significa: poco sforzo energetico, basso rischio umano, limitato impatto ambientale. Fare di più con meno sia dal punto di vista energetico che funzionale.
Per questo l’architettura sostenibile è prima di tutto un progetto. Un progetto per l’uomo che è una cosa
sola con la natura. Per lavorare in sintonia con la natura bisogna inevitabilmente amarla, imparare a conoscerla, lasciarsi contaminare da lei.
Poiché non è possibile per un uomo “sano” progettare al di fuori della natura, cioè in modo non sostenibile, significa che l’architettura non sostenibile è in realtà semplicemente priva di progetto.
Il suo lavoro di architetto è stato definito come “architettura di relazione” perché pone al centro dell’attenzione le persone che vivono gli spazi e i rapporti tra esse e con il territorio. Può illustrarci questo suo modo di intendere l’architettura?
Continuo a ripetere che mi interessa l’architettura soprattutto per quello che riesce a far accadere tra le persone. Pesa sulle mie scelte la consapevolezza della grande responsabilità del nostro mestiere, di quanto l’architettura influenza il nostro modo di vivere, le nostre relazioni.
Basta guardare il monastero di Siloe, che avete scelto di pubblicare. Nei luoghi di culto lo spazio partecipa al rito. I riti sono fisici e hanno bisogno di un luogo definito dove la trasformazione avvenga. Il luogo deve essere in grado di “fare accadere” attraverso il rito, la liturgia, anche a insaputa di chi vi partecipa.
Inoltre, l’architettura influenza il territorio modificandolo. Non credo nell’architettura che scompare nel paesaggio, né che ne diventi protagonista. “La casa non deve essere sulla collina, ma della collina”, diceva Frank Lloyd Wright.
Nel caso del monastero di Siloe questa modificazione sta avvenendo in un arco di tempo lungo. Che ruolo hanno il tempo e la lentezza nella costruzione di un’architettura

10 legnoarchitettura_06
F o o P a o o D a R e
e nella trasformazione dell’ambiente che questa opera? Il mestiere dell’architetto è progettare lo spazio per l’uomo.
Il nostro lavoro è spostare e riorganizzare le cose senza distruggerle o alterarle in modo irreversibile, anzi interpretandole con motivazioni sociali, politiche, economiche. Commisurando quegli spazi con i comportamenti. La convinzione e la ricerca in tal senso aiutano a essere coerenti. Il tempo aiuta la ricerca. L’unico che invecchia sono io, per questo cerco di lasciare traccia nella mia opera e ai miei collaboratori del pensiero in cui credo.
Infine l’ultima domanda. Qual è il progetto a cui è più legato e perché?
Scoperta la passione per il mio mestiere, i giornalisti mi fanno spesso questa domanda. Non ho preferenze, amo ogni mio lavoro, mi ci dedico profondamente e dopo la consegna tendo a dimenticarlo. Mi capita di apprezzarlo dopo molto tempo, quasi fosse di qualcun altro. È diverso per il monastero della comunità di Siloe, un cantiere che procede in base agli aiuti, alle donazioni di amici e fedeli. Dopo dodici anni siamo quasi alla metà dell’intero complesso. È diventato come la mia casa. Seguiamo rigorosamente il progetto iniziale, studiato da subito in ogni dettaglio, ma, essendo abitato e molto frequentato, il cantiere viene orchestrato in funzione degli approvvigionamenti, della sicurezza, deve essere gradevole e fruibile da subito, anche se non ancora ultimato. Più legato di così!
Per approfondimenti: www.archos.it


Sopra e sotto a destra, SCUDERIE, Collemassari (GR), 2001-2006. A completamento della messa a sistema della tenuta di Collemassari, la scuderia. Sotto, a sinistra, CENTRO CIVICO CON PALESTRA POLIFUNZIONALE, Colzate, 1996. Con uno sviluppo a “L” l’edificio si articola su tre piani; al piano interrato la palestra dal volume in altezza pari all’intero sviluppo del complesso, al piano primo il bar, con la sua propaggine cilindrica apribile verso l’esterno nella bella stagione, una cucina, le tribune della palestra e il porticato esterno coperto; al secondo piano la biblioteca, le sale lettura, le associazioni e l’appartamento del custode.

F o o P a o o D a R e F o o P a o o D a R e F o t o F r a n c e s c a P e a n

F o o M c h e e M e s
 Edoardo Milesi
Monastero di Siloe
Poggi del Sasso
Edoardo Milesi
Monastero di Siloe
Poggi del Sasso
Una vista della parte orientale del monastero, in cui è bene evidente l’uso dei due materiali base: la pietra e il legno.
Il monastero visto da sud.
Una vista aerea del monastero, immerso nel paesaggio delle colline del Grossetano.


_1
_2
_3
14 legnoarchitettura_06 progetti 2 1 F o t o P a o o D a R e F o o M c h e e M e s

Ubicazione: Poggi del Sasso (GR)
Progetto: arch. Edoardo Milesi, Archos srl engineering consulting, Albino (BG)
Collaboratori: Ersilia Brambilla, Laura Pizzi, Paolo Vimercati, Vuleta Zdravko
Strutture: ing. Massimo Bigozzi (Lotto 1), ing. Eugenio Frigoli (Lotto 2)
Direttore dei lavori: arch. Edoardo Milesi
Appaltatore: Euro Costruzioni 2007 s.r.l., Cinigiano (GR)
Lavori: dicembre 2004 e tutt’ora in corso d’opera
Superficie utile: 1.900 m2 Lotto 1 e 2
Superficie dell’area: 38.000 m2
Importo dell’opera: 3.000.000 Lotto 1 e 2
Ora et labora
Un’architettura che lentamente cresce su un falsopiano tra le colline del Grossetano; un complesso che culmina nel monastero, un rettangolo racchiuso da lati di circa 40 metri per 60 che accoglie al suo interno l’area per il culto, le attività ricettive e di ser vizio e le residenze per i monaci. Legno, pietra, rame, ferro e vetro disegnano forme essenziali, realizzate per lotti successivi e funzionali in base agli aiuti e alle donazioni ricevute.
Il primo intervento (a partire dal 1999) ha visto la trasformazione di un vecchio ovile in una piccola cappella, la Cappella del Pellegrino. Senza modificare l’impianto primitivo, sono stati mantenuti i muri perimetrali in pietra ampliando lo spazio con un’abside e una copertura in legno. Una piccola torre in lamelle di legno per il campanile, una croce di legno e un basso recinto in cemento impastato con terra del luogo completano la riqualificazione. Un’altra cappella è stata completata nel 2004 lungo il percorso pedonale che conduce al complesso. L’impianto del monastero, realizzato per metà, si inserisce con discrezione nell’incontaminato paesaggio con forme e materiali rispettosi dell’ambiente e della sobrietà della vita monastica. Le parti in legno che caratterizzano l’architettura sono quelle strutturali in larice massello o lamellare collaboranti con una maglia di travi e pilastri in calcestruzzo, impiegato per problematiche antisismiche. Le pareti sono di tipo ventilato, gli schermi solari in red cedar, i pavimenti e gli infissi in larice oliato. L’impiantistica è ridotta al minimo per limitare i campi elettromagnetici. L’acqua raccolta dal pozzo a pochi metri dal monastero è accumulata in una cisterna sotterranea e restituita al luogo attraverso un impianto di fitodepurazione. Il secondo lotto funzionale, iniziato nel 2007, riguarda gli spazi pubblici da utilizzare per le attività culturali di cui la comunità è promotrice da anni (biblioteca, sala lettura, sala polifunzionale e sala convegni); il volume su quattro piani chiuderà il lato sud del chiostro. Il tetto è a falda unica con copertura in zinco-titanio, come per tutto il resto del monastero, e con moduli fotovoltaici in silicio amorfo in grado di produrre circa 10 kW di energia elettrica. Vincitore del Premio per le Energie Rinnovabili di Legambiente, il monastero è tutelato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali di Siena e Grosseto come architettura contemporanea di pregio.
15
F o t o A l c o o r
3
1residenza monaci
2bilioteca
3 foresteria
4 chiesa processionale
5chiostro
6agorà
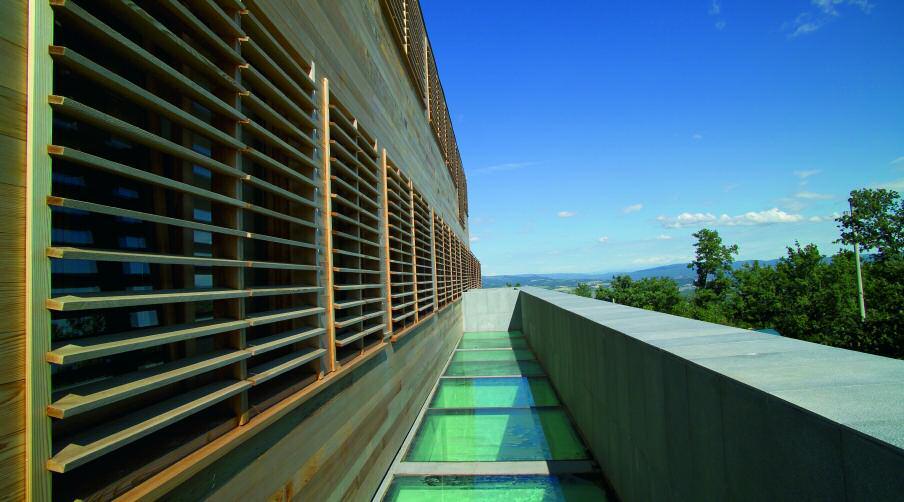
1studio testi storici
2bilioteca sala lettura
3 residenza monaci
4sala polifunzionale
5 sala conferenza
6 percorso ingresso
7foyer
8parlatoi
sezione longitudinale
1 2 4 5 7 8 6
pianta piano interrato
16 legnoarchitettura_06 progetti 1 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 4
pianta
piano terra
F o t o P a o o D a R e

_4
Dettaglio della parete a est rivestita con lamelle di legno. In primo piano la superficie vetrata che illumina la mensa sottostante.
_5
La mensa.
17 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5
pianta primo piano
F o t o S e f a n o T o r e g g i a n
pianta secondo piano

F o t o P a o o D a R e



_6_7
La parete sul chiostro interamente in legno di larice naturale e vetro.
_8
La scala in larice, il solaio in legno collaborante con il telaio in c.a.
19 F o t o F r a n c e s c a P e a n F o o P a o o D a R e F o t o F r a n c e s c a P e a n 6 7 8
In queste due pagine, alcuni rendering della chiesa processionale.



 pianta della chiesa processionale
pianta della chiesa processionale
20 legnoarchitettura_06 progetti
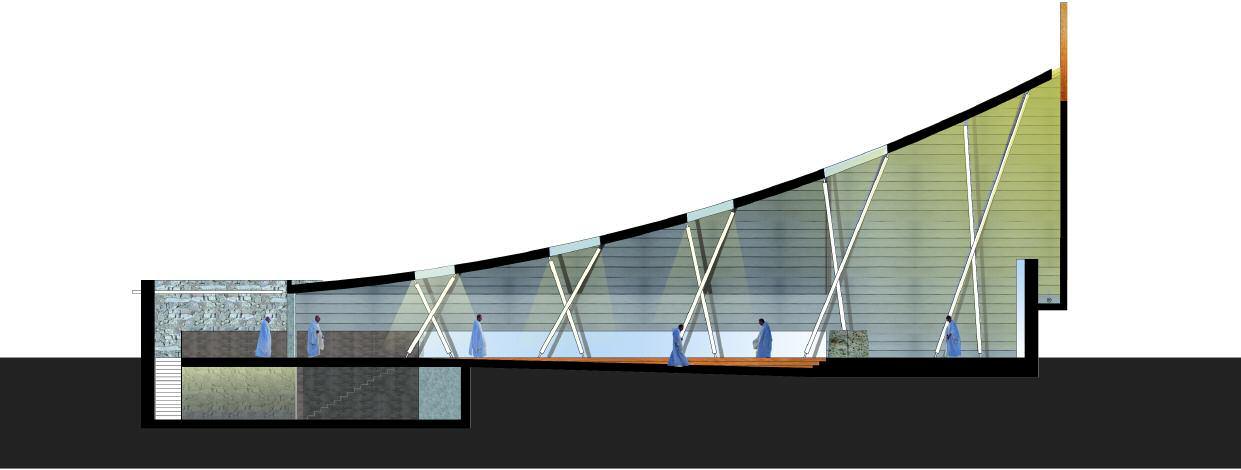
_la chiesa processionale________
Il lato nord del complesso monastico verrà chiuso dal volume della chiesa processionale caratterizzata dalla copertura in zinco titanio, a un’unica falda dalla forma arcuata sostenuta da colonne in legno, quasi un mantello disteso che lascia continuità tra l’interno della chiesa e il paesaggio collinare esterno.
La doppia fila delle colonne in legno, binate e inclinate, hanno altezza crescente ed enfatizzano l’impennata della copertura verso l’alto, accentuata ancor di più dalla leggera pendenza in discesa del pavimento a partire dall’entrata. Quest’ultima è protetta da un nartece di legno e caratterizzata dalla porta d’accesso con apertura a bilico verticale, spessa 30 centimetri, larga come tutta la navata centrale e alta quanto il nartece.
La parete a est, dietro l’altare, è contrassegnata da una fenditura centrale di 9 metri di altezza che si prolunga all’esterno con un massello di legno di cedro per ulteriori 3 metri. Una seconda fessura, posta in copertura e ortogonale alla prima, forma una croce di luce visibile solo all’interno.
L’illuminazione naturale diffusa, proveniente dalle basse vetrate lungo le navate laterali, sarà così arricchita dalla luce entrante dalle fenditure che, a partire dall’altare, traccerà il percorso giornaliero del sole lungo le pareti della chiesa.


Sezione longitudinale della chiesa processionale. Il pavimento inclinato scende verso l’altare, la copertura si innalza fino all’abside per proseguirne all’esterno la fenditura verticale che la illumina con un elemento in massello di larice.
21
sezione longitudinale della chiesa processionale
Una vista della Cappella del Pellegrino ricavata da un vecchio ovile. A destra, il campanile in lamelle di legno.


_9 L’agorà.
10
22 legnoarchitettura_06 progetti 10 9 F o t o P a o o A b b a d n F o o D o n a t o D B e o











A sinistra: vista aerea del cantiere.
A destra: dettaglio della parte a est con la sottostrutura per il rivestimento ligneo.
A sinistra si notano i tre elementi portanti caratterizzanti l’intera struttura: l’acciaio, il legno e il calcestruzzo armato.
A destra: la facciata in legno della biblioteca.
Due immagini della struttura mista c.a.-legno e l’attacco del pilastro in legno alla platea tramite staffa metallica.
La costruzione della parte in legno.
A sinistra: il monastero quasi completato.
A destra: una fase della costruzione dell’agorà.
23

Guesthouse Carvalhal (P)
Paratelier

_1
Vista notturna. I moduli abitativi, il parcheggio e il magazzino/rimessa sono immediatamente riconoscibili per l’uso differente del rivestimento.
_2
Terrazza coperta. Il volume del padiglione si apre verso la zona degli orti attraverso una zona esterna ma coperta in continuazione della zona salotto.


1 2

Ubicazione: Carvalhal, Portogallo
Progetto: arch. Leonardo Paiella e arch. Monica Ravazzolo - Paratelier, Lisbona (P)
Collaboratori: Hugo Marques Amaro, Ilaria La Conte
Strutture: Tropimaloca Lda.
Efficienza energetica: Project Uno
Progetto paesaggistico: João Gomes da Silva, Catarina Raposo - Global
Direttore dei lavori: arch. Leonardo Paiella
Lavori: 2011
Superficie utile: 115 m2
Superficie verde: 380 m2
Fotografie: Leonardo Finotti
Tra le dune
Tra le dune sabbiose della riserva naturale “Pinhal da Comporta”, di fronte all’Oceano Atlantico, immersa tra gli alberi di pino, sorge una piccola costruzione in legno, uno spazio abitativo temporaneo per gli ospiti integrato da un’area per il parcheggio e un magazzino-rimessa per le attività agricole. Il volume del fabbricato sorge parallelo a un piccolo lago artificiale che esalta i caratteri del luogo e i suoi colori vividi (il bianco della sabbia, il marrone della corteccia degli alberi e il blu del cielo e dell’acqua).
La struttura, realizzata interamente in legno, nasce dal moltiplicarsi di un modulo che richiama i caratteri dell’architettura pombalina portoghese, architettura nata dopo il terremoto del 1755 e caratterizzata dalla modularità e regolarità. Le tre parti in cui si articola l’edificio sono definite tramite sottili variazioni del disegno derivanti dalla diversa destinazione funzionale. I primi quattro moduli, aperti da un lato, costituiscono la spazio per il parcheggio coperto, i successivi due moduli sono parzialmente aperti e fungono da deposito e rimessa agricola. Il cuore dell’edificio, è costituito dai tre moduli che compongono l’abitazione vera e propria, più chiusi rispetto agli altri per indurre un senso di privacy e proteggere dal sole e dal vento. Ognuno di questi tre moduli è organizzato a seconda delle funzioni: il primo è destinato all’ingresso principale e alla zona notte, quello centrale articola gli spazi di passaggio attorno al blocco dei servizi igienici e della cucina, il terzo ospita il soggiorno con la zona pranzo. L’ultimo modulo, infine, amplia la zona salotto verso l’esterno con una terrazza coperta. L’alternarsi di parti trasparenti, semi-trasparenti e opache esalta la leggerezza e la permeabilità visiva dell’involucro mentre la colorazione scura gioca con le ombre che si disegnano sulla sabbia bianca in un contrasto che esprime il dialogo tra il nuovo oggetto e i dintorni.
27

pianta
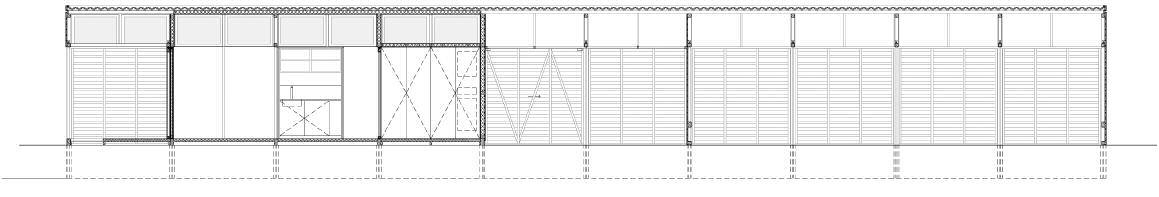
sezione longitudinale
Pianta:
1 - parcheggio coperto;
2 - deposito;
3 - abitazione;
4 - spazio esterno coperto.
_3
Posa della struttura rialzata del solaio contro terra.
_4
L’ingresso alla zona living. Il pavimento dell’area cucina al grezzo (pannello OSB sopra la struttura) prima della posa della lastra di sughero.
_5
Dettaglio dell’ingresso della zona notte con i moduli armadio della camera. La struttura e i tamponamenti di legno sono lasciati a vista.
_6
La zona giorno.
_7
Il modulo centrale dell’area abitativa, attorno al quale si organizzano gli spazi di servizio. In primo piano, a sinistra, l’angolo cucina.



28 legnoarchitettura_06 progetti
3 4 5


29 6 7
Parete esterna, dall’esterno:
tavole maschio-femmina orizzontali (2400x130 mm) fissate su struttura verticale in listelli di pino massiccio; pannello di sughero di densità 120 g (60 mm); pannello in controplaccato marittimo di pino (10 mm) fissat su struttura orizzontale in listelli di pino massiccio.
Solaio contro terra, dall’esterno:
struttura rialzata in listelli di legno massiccio; pannello OSB (20 mm); pavimento in pannelli di sughero levigato di densità 190 g con trattamento a cera naturale.
_sistema costruttivo e sostenibilità________
L’edificio è definito da un modulo base di dimensioni 250x450 cm. La struttura è interamente lignea, realizzata con un sistema a telaio, e contrassegnata da una sequenza di portali tamponati con pannelli di legno di pino all’interno, strato isolante e una controparete esterna in tavole maschiate verniciate di colore scuro.
Le pareti e il tetto, con una semplice copertura in onduline di poliestere e fibra di vetro, sono ventilati e isolati termicamente con pannelli di sughero; la caratteristica di questo sistema costruttivo garantisce un buon controllo termico mantenendo separate la superficie esterna a contatto con il clima caldo o freddo dalla superficie interna. L’intera struttura è rialzata rispetto al terreno sabbioso e il primo solaio è realizzato con pannelli OSB di 2 cm di spessore e isolamento in sughero. Il sughero è utilizzato anche per la pavimentazione con un trattamento in cera naturale. La conservazione della natura e l’importanza della sostenibilità ambientale hanno portato i progettisti e il committente a scegliere con cura i materiali, preferendo quelli di origine naturale e locale come il legno e il sughero e utilizzando vernici ecologiche, in modo da creare un’architettura altamente adattabile, sostenibile e riciclabile.
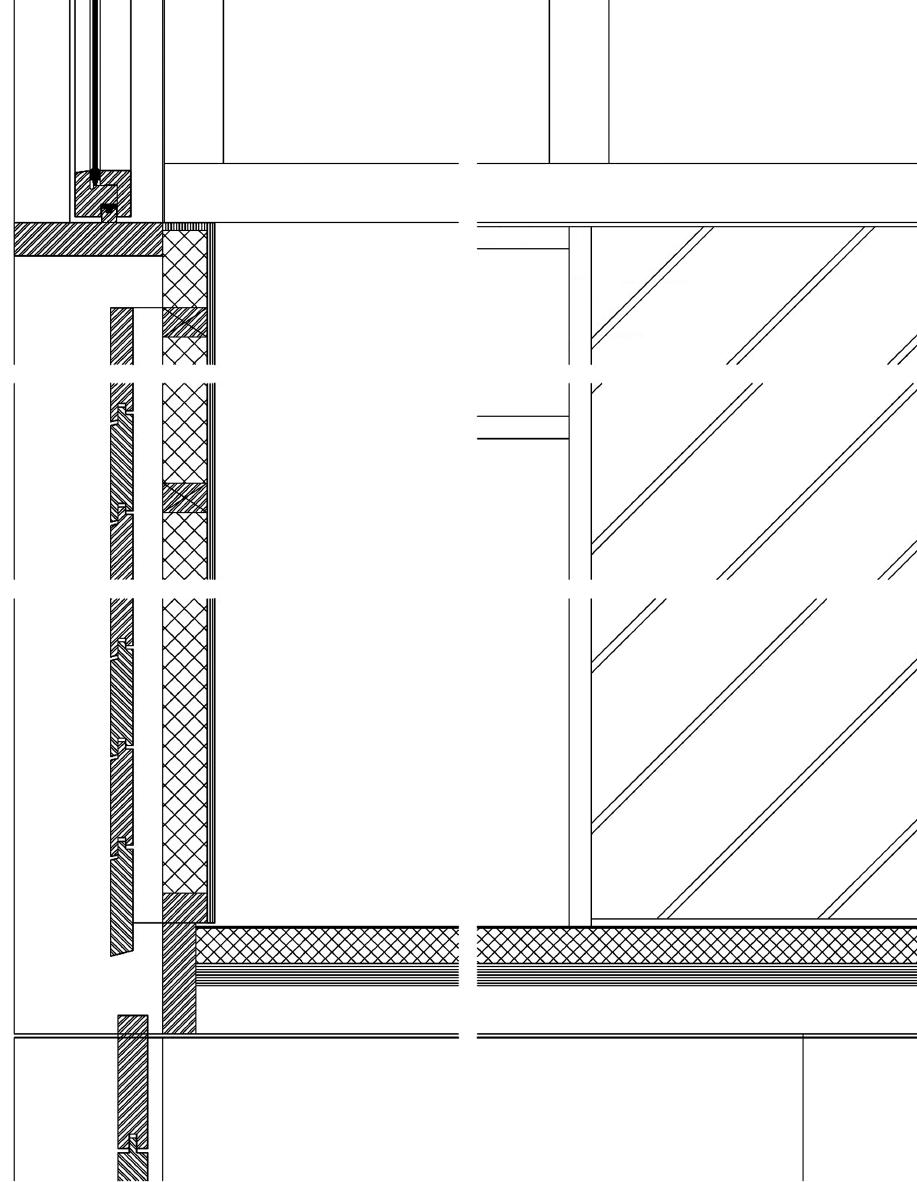
30 legnoarchitettura_06 progetti


_8
La zona dei servizi nel modulo centrale dell’area abitativa.
_9
La struttura del parcheggio e del deposito/rimessa.
31
8 9
Copertura, dall’esterno: onduline in poliestere e fibra di vetro; sistema di appoggio delle onduline in legno massiccio (45 mm x dimensione variabile); pannello di sughero di densità 120 g (80 mm); pannello in controplaccato di pino marittimo (10 mm).
1 - elemento di finitura in legno di pino (130x30 mm)
2 - vetro laminato incolore (3+3 mm)
3 - infisso in legno massiccio di pino (120x75 mm)


32 legnoarchitettura_06 progetti
_10
10 1 2 3
La struttura al grezzo del parcheggio.









La struttura portante con la copertura in onduline.
Posa dei listelli in legno massiccio della struttura portante del solaio contro terra.
Fasi di posa della pavimentazione nei moduli abitativi.
Nella foto a sinistra e al centro: la pitturazione degli elementi lignei con tinte a base acquosa di colore scuro. A destra: dettaglio del raccordo tra la struttura verticale, la copertura e il serramento.
33

McBride Charles Ryan Letterbox House
Blairgowrie (AUS)

La facciata sud ovest.
Il volume della casa si apre sul lato verso la spiaggia poco distante con un prospetto caratterizzato dal rivestimento in listelli di legno e dai colori solari dei serramenti, una originale interpretazione della “aussie verandah”.
2
Il piccolo prospetto a nord-ovest con la cassetta delle lettere (il numero 7).


_1
36 legnoarchitettura_06 1 2

Ubicazione: Blairgowrie, Victoria (Australia)
Progetto: Rob McBride, Debbie RyanMcBride Charles Ryan, Melbourne (AUS)
Team di progetto: Adam Pustola, Meredith Dufour, Michael McManus, Angela Woda, Matthew Borg, Fang Cheah, Flynn Lewer Fine lavori: 2009
Superficie utile: 290 m2
Fotografie: John GollingsGollingsPidgeon
Una casa per vacanze in Australia
Prende il nome dalla cassetta per le lettere che campeggia sulla facciata questa casa per il fine settimana che si trova sulla penisola di Mornington a Blairgowrie, a sud di Melbourne. Dalla buca per le lettere la casa si sviluppa dinamicamente verso l’interno del lotto fino ad aprirsi, sul lato che dà verso la spiaggia poco distante, in un’ampia veranda, r einterpretazione di un elemento tipico delle case australiane, uno spazio scultor eo che amplifica le sensazioni del vivere all’aperto: la luce e il calore del sole, la bellezza del cielo, la brezza, il suono e l’odore del mare. Il progetto della Letterbox House rispetta la scala delle costruzioni del luogo richiamando l’informalità della vita di una località sul mare in un’architettura che si stacca dalle convenzioni e interpreta il prospetto sud-ovest come una scenografia libera che si modifica, inarcandosi, inclinandosi e ritraendosi, e che richiama forme diverse: un ponte coperto, un’onda congelata, una scogliera, una barca capovolta; un guscio di listelli di legno che muta continuamente colore nell’arco della giornata. In contrasto, la facciata opposta è semplice, squadrata, simile a quella di molte case della regione, quasi contraddittoria rispetto al resto dell’edificio ma indice di una chiara gerarchia.
All’interno dell’abitazione, la parete a sud-ovest, dipinta con un colore rosso acceso che conferisce calore e accentua il confine tra interno ed esterno, articola e separa con il suo andamento spezzato la grande zona giorno dal blocco delle camere da letto al piano terra. Con le mensole disposte tra gli elementi verticali diventa, inoltre, uno spazio arredato destinato a ospitare i ricordi e i piccoli oggetti della vita di ogni giorno. Al piano superiore, la camera padronale dispone di un’ulteriore veranda, più intima e protetta, che conclude sul lato opposto all’ingresso lo sviluppo dell’intera struttura.
37
Pianta piano terra, rialzato e sezioni:
1 - cassetta per le lettere; 2 - spazio di servizio;
3 - garage; 4 - camera;
5 - ingresso; 6 - camera;
7 - cortile;
8 - soggiorno/cucina/salone;
9 - veranda; 10 - bagno; 11 - camera: 12 - lavanderia;
13 - sala giochi;
14 - vuoto
15 - camera padronale.
38 legnoarchitettura_06 progetti
pianta piano terra e pianta piano rialzato
sezione longitudinale a-a
sezione trasversale b-b

prospetto sud ovest
_3
La zona living e la cucina. Sullo sfondo la parete rossa che caratterizza l’interno seguendo la forma articolata della parete sud-ovest.
39
prospetto nord ovest
3


_sistema costruttivo________
La struttura della casa è realizzata con un sistema a telaio in legno marino con prestazioni –testate –di durabilità di oltre 50 anni all’aria aperta. Il legno (LVL, Laminated Veneer Lumber) è un impiallacciato laminato in continuo in lunghezza, realizzato secondo le normative vigenti in Australia, e gli strati sono fissati tra di loro con un legante di tipo “marino”. La laminazione prevede vari gradi di impiallacciatura secondo uno schema prefissato al fine di conferire al materiale proprietà strutturali. L’uniformità del materiale è la chiave per la sua alta resistenza e rigidità. Tale tipo di legname non viene di solito lasciato a vista.

La lunga parete rossa diventa con le mensole un luogo che, come sottolineano i progettisti, “nel tempo diverrà il deposito dei ricordi estivi, dei libri amati, dei bric-à-brac delle vacanze al mare, che segnano la vita della famiglia australiana, diventando spazio di vita”.
_4
La parete a sud-ovest al grezzo.
_5
Il rivestimento della parete esterna in listelli e la struttura di supporto della pavimentazione in legno lungo la casa.
41
4 5
Copertura, parete, solaio contro terra:
1 - copertura in lamiera
2 - grondaia
3 - compensato marino (18 mm)
4 - profilo in lamiera di chiusura
5 - struttura portante in legno
6 - rivestimento esterno in legno
7 - sotto struttura in listelli di legno (45x45 mm)
e lamiera di metallo
8 - pannello isolante in materiale espanso con guaina su un lato
9 - colonne portanti in legno massello
10 - sigillatura per tenuta all’aria
11 - ferramenta e telaio finestra in legno massiccio
12 - finestra con apertura scorrevole
13 - lamiera metallica lucida
14 - pavimento in legno posato su strisce di feltro bitumato
e su travetti
15 - controsoffitto in cartongesso (10 mm)
16 - piastra di base
17 - appoggio in acciaio e calcestruzzo
18 - pavimentazione lignea su travetti in legno impermeabilizzati
19 - dormiente faccia a vista in legno red gum (200x50 mm)
20 - copertura del palo di fondazione contro gli insetti
42 legnoarchitettura_06 progetti 1 234 5 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 17 20 19






A sinistra: il numero 7 che diverrà cassetta delle lettere da cui prende origine l’intera struttura dell’edificio.
A destra: la serie di teli della struttura, quasi una successione di piccoli portali.
A sinistra in alto: le colonne portanti della parete a sud-ovest .
A sinistra in basso: la parete a sud-ovest prende forma mentre un rivestimento in listelli scuri funge da raccordo con il lato nord-est, semplice e squadrato.
A destra: dettaglio della struttura; in fondo, il piano rialzato.
La facciata a nord-ovest quasi conclusa: è visibile la lamiera di metallo su cui è stata fissata la sottostruttura per i listelli lignei di rivestimento.
43

Modus Architects
Uffici
Bressanone

Il fronte principale, con il portone

1 L’angolo sud-est 2
46 legnoarchitettura 06 progetti 1
d’entrata

2
Ubicazione: Bressanone (BZ)
Progetto: Modus Architects (AttiaScagnol), Bressanone (BZ)
Strutture: Lignoalp
Impianti: Energytech Ingenieure GmbH, Bolzano
Direttore dei lavori: Lignoalp
Appaltatore: Lignoalp, Bressanone (BZ)
Lavori: 2011
Superficie utile: 1 160 m2
Fotografie: Lignoalp
Un monolite di legno
Una struttura geometricamente semplice, una prisma pluripiano, si trasforma in una scultura materica, in cui la forma del legno modifica la luce, modulandola grazie ad altissimi brise soleil che, ognuno diverso dall’altro, creano superfici plastiche complesse Unica rottura nel monolite compatto della nuova sede Lignoalp sono tre elementi aggettanti rivestiti in acciaio
Corten: la bussola d’ingresso e le due ampie finestre al terzo piano, simbolicamente rivolte verso i boschi circostanti, fonte di materia prima per l’edificio e per l’azienda
Il legno dà forma anche agli spazi interni: al primo piano un sistema con lamelle in legno verticali, tutte differenti tra loro, alte fino a 33 cm e collaboranti alla ripartizione dei carichi, crea un movimento continuo a onda; il solaio del secondo piano riattualizza invece il sistema “a cassettoni”, usando travi a lamelle incrociate e scomponendo il disegno in una serie di quadrati e rettangoli, che integrano al loro interno le soluzioni illuminotecniche
All’ultimo piano si viene accolti da un soffitto quasi ludico, con cassettoni disegnati a nido d’ape, per poi entrare in un ambiente più tradizionale con grandi travi di colmo e travetti posizionati in sintonia con il disegno lievemente inclinato del tetto
Riscaldamento e raffrescamento sono demandati a un impianto radiante a pavimento, alimentato da un sistema di cogenerazione esistente (due impianti a biomassa con potenza elettrica di 250 kW e potenza termica di 220 kW) sito nell’area aziendale; anche l’acqua calda sanitaria è prodotta dallo stesso impianto
Un sistema di ventilazione meccanica centralizzata con recupero di calore garantisce ricambi orari diversificati per le varie zone
Il nuovo edificio si caratterizza per prestazioni energetiche molto elevate, una particolare attenzione nell’utilizzo di materiali ecologici e l’impiego di fonti rinnovabili, caratteristiche che lo faranno rientrare nella classe CasaClima Goldnature
47
sezione nord-sud
48 legnoarchitettura_06 progetti
pianta piano terra
pianta primo piano
_trasmittanza media elementi costruttivi________
pareti esterne in legno: U = 0,12 W/m2K
solaio controterra: U = 0,31 W/m2K
solaio piano terra: U = 0,21 W/m2K
solaio esterno legno: U = 0,12 W/m2K copertura: U = 0,17 W/m2K superfici trasparenti: Uw = xxx W/m2K
_prestazioni energetiche________
fabbisogno energetico per riscaldamento: 9,36 kWh/m2 anno
prospetto est
49
pianta secondo pianopianta terzo piano
prospetto ovest
Sotto, a destra, modello tridimensionale della struttura.
A destra e in basso, alcuni esempi delle tavole esecutive dei singoli elementi costruttivi.
L’ingegnerizzazione del progetto ha richiesto due mesi di prepazione e la coordinazione di due ingegneri che hanno predisposto i calcoli statici, i dettagli costruttivi, i disegni tecnici e i dati macchina.
_sistema costruttivo________
Nella progettazione dell’edificio sono state studiate differenti soluzioni costruttive per mostrare le articolate possibilità e la flessibilità del costruire in legno.
Per le pareti esterne portanti si è scelto di utilizzare un sistema a telaio con pareti composte, dall’interno all’esterno, da un pannello in OSB, isolante in fibra di legno/struttura e tavolato grezzo. Il sistema strutturale, posto nella parte centrale dell’edificio, è costituito da pareti in legno multistrato a strati incrociati (X-lam) con spessore variabile tra i 12 e i 15,6 cm. Pannelli di X-lam sono stati utilizzati con funzione portante anche per costruire il vano ascensore. I pannelli, alcuni dei quali alti fino a 15 metri, sono stati posti in opera e resi solidali tra loro mediante un incastro a maschiatura. Il legno all’interno dell’edificio è volutamente lasciato a vista.
Anche i solai interpiano, costruiti a secco, sono realizzati in diversi modi; tutte le canalizzazioni necessarie all’impiantistica (il sistema radiante a pavimento, l’impianto di condizionamento/ventilazione, il sistema di illuminazione e l’impianto di rilevazione dei fumi) sono integrate nella struttura. Il solaio sopra la reception commerciale e i corridoi è realizzato in pannelli X-lam progettati con ampie fresature per inserire le reti tecnologiche. Per gli uffici commerciali si è scelto un solaio strutturale a tavole di ca. 4 cm accostate tra loro e inchiodate ( brettstapel), che possiede ottime caratteristiche di fonoassorbenza.
L’ingegnerizzazione del progetto è stata eseguita in circa due mesi.

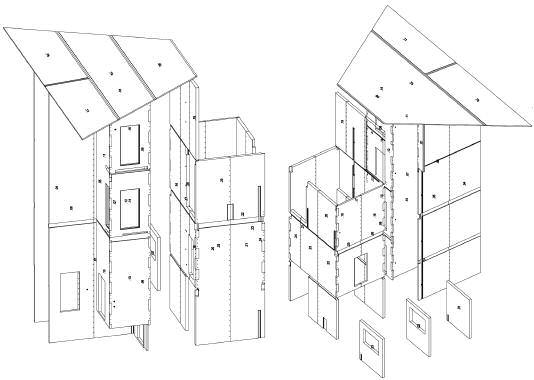
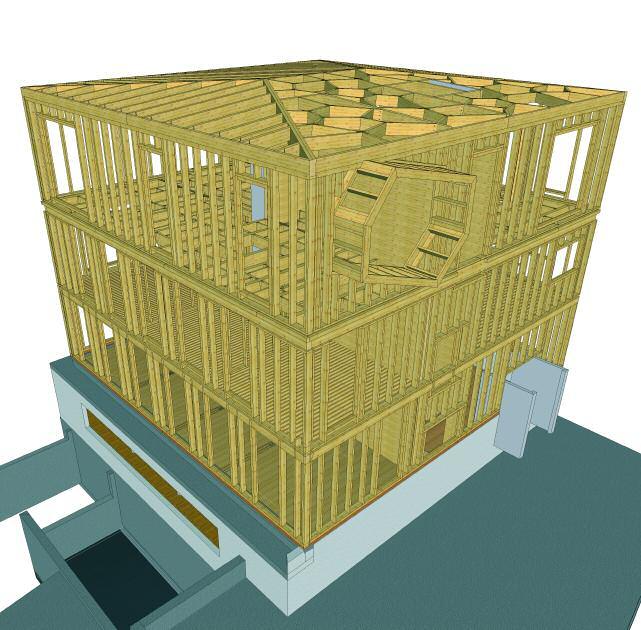
50 legnoarchitettura_06 progetti
Pacchetto primo solaio controterra (dall’estradosso):
pavimento in cemento levigato, rete elettrosaldata, tubi radianti, elementi di fissaggio del pannello, telo in polietilene 0,2 mm (87 mm); pannello acustico (50 mm); massetto livellante (133 mm); solaio in c.a. (250 mm), polistirolo estruso;

Pacchetto secondo solaio/piano terra (dall’estradosso):
pavimento in rovere massiccio (17 mm); massetto (25 mm); riscaldamento a pavimento(25 mm); pannello isolamento acustico (30 mm); pannello OSB (22 mm); sottostruttura con riempimento a secco (176 mm); telo; solaio tipo “Brettstapel” (240 mm);

Pacchetto terzo solaio/primo piano (dall’estradosso):
pavimento in rovere massiccio (17 mm); massetto (25 mm); riscaldamento a pavimento (25 mm); pannello acustico (20 mm); pannello OSB (18 mm); sottostruttura con riempimento a secco (188 mm); telo;
pannello multistrato a vista CLT (61 mm); solaio in legno, intradosso con effetto “ondulato” (230 mm)


Pacchetto quarto solaio/secondo piano (dall’estradosso):
pavimento in rovere massiccio (17 mm); massetto (25 mm); riscaldamento a pavimento (25 mm); pannello acustico (30 mm); pannello OSB (22 mm); sottostruttura con riempimento a secco (178 mm); telo;
pannello multistrato a vista CLT (61 mm); solaio in legno (230 mm)

51
La stanza all’ultimo piano che prende luce dall’occhio, elemento caratterizzante la facciata principale dell’edificio.

Copertura, dall’estradosso:
pannelli profilati in lamiera di zinco-rame-titanio prepatinato (sp. 7/10); tavolato in legno di abete fugato (30 mm); intercapedine per ventilazione copertura con travetti in abete (h 100 mm); telo traspirante (2,50x25 m); isolamento in fibra di legno (100+100 mm); isolamento in fibra di legno (40 mm); rivestimento.
1 - matite in legno (passo 300 mm)
2 - canale di gronda in lamiera di zinco-rametitanio prepatinato (sp. 7/10)
3 - viti Assy® 8x200
4 - listelli (70x100 mm)
5 - isolamento in fibra di legno (20 mm)
Parete, dall’interno:
pannello multistrato (20 mm); fibra di legno (60 mm); listelli (60x60 mm),; pannello OSB (15 mm); montanti (60x200 mm); fibra di legno (200 mm); assito grezzo (23 mm); fibra di legno (40 mm); listello di ventilazione (50x80 mm); pannello KERTO®


52 legnoarchitettura_06 progetti
1 23 4 5 3 _3
3

_le lamelle brise soleil________

Il prisma dalla struttura compatta si trasforma in un oggetto tridimensionale mutevole grazie all’articolato disegno delle lamelle che mostrano un movimento ondulatorio, sotto la luce delle diverse ore del giorno, e che conferiscono dinamismo all’intera facciata.
Le lamelle, che fungono anche da brise soleil, hanno uno spessore di 6 cm e sono distanziate tra di loro di circa 30 cm. Realizzate in Kerto®, successivamente modellate e tagliate secondo quanto previsto dal disegno architettonico, sono state impregnate in autoclave per garantirne la durabilità nel tempo e, infine, fissate alle quattro facciate.
Il fissaggio avviene mediante staffe metalliche posizionate su una sottostruttura, alla base, alla sommità e al centro dei quattro prospetti. Gli elementi del rivestimento, in corrispondenza dell’aggancio metallico, sono opportunamente sagomati e forati.






Il preassemblaggio in officina del solaio ondulato del primo piano.
Alcune immagini delle lamelle di rivestimento, dalla realizzazione in officina fino all’applicazione in facciata mediante staffe metalliche.
53

Uno degli uffici al piano terra, con i soffitti ondulati.
Gli uffici al primo piano sono invece caratterizzati da soffitti a cassettoni.
Pagina a fianco, il soffitto a nido d’ape di una parte della copertura.
 _4
_5
_4
_5
54 legnoarchitettura_06 progetti 4 5

La fondazione in c.a., la posa dei pannelli del vano servizi (scale/ascensore) con pareti in X-lam e la posa del primo solaio in legno.


A sinistra: il vano ascensore e i vani tecnici centrali.
A destra: la posa del solaio con intradosso ondulato del primo piano.


A sinistra: procede l’elevazione delle pareti esterne, prefabbricate a telaio, del primo piano. A destra: la posa del solaio a cassettoni del secondo piano.


La costruzione della copertura, realizzata in parte con struttura a falda e, in parte, con struttura a nido d’ape.


A sinistra, una fase della realizzazione della copertura “a nido d’ape”.
A destra, la posa del telo traspirante in copertura.


56 legnoarchitettura_06 progetti










La facciata principale con il foro che ospita la grande finestra che “buca” la facciata.
Due dettagli dell’aggancio del grande elemento finestrato sporgente, coibentato, prefabbricato con sistema a telaio e posato in cantiere.
Completamento della facciata per accogliere le lamelle brise-soleil.
Le lamelle vengono fissate alla parete.
Ultime fasi del rivestimento esterno.
57

 Karawitz Architecture
Casa Damico
Vallée de Chevreuse (F)
Karawitz Architecture
Casa Damico
Vallée de Chevreuse (F)
_1
Vista da sud-ovest.
La grande vetrata verso sud della zona giorno massimizza i guadagni solari.
_2
Il prospetto sud-est.
L’allineamento della casa è parallelo al confine del lotto a nord, mentre a sud il secondo volume si apre con l’ampia finestra.

60 legnoarchitettura_06 progetti 0

Una casa passiva nell’Île-de-France
Ubicazione: Le Mesnil-Saint-Denis (Francia)
Progetto: Karawitz Architecture, Parigi (Francia)
Strutture: Philippe Buchet, Versailles
Direttore dei lavori: Karawitz Architecture
Lavori: settembre 2008-gennaio 2010
Superficie utile: 176 m2
Superficie verde: 650 m2
Importo dell’opera: 380.000 (+ iva)
Fotografie: Karawitz Architecture
Situata nella pittoresca Valle di Chevreuse, questa casa passiva si compone di un volume principale disposto su tre livelli –seminterrato, piano terra e primo piano –con un tetto a falda unica al fine di minimizzare l’impatto volumetrico sul lato nord e consentire l’apertura dell’edificio a sud dove si aggiunge un secondo volume dalla copertura meno pronunciata. La casa è stata costruita con materiali (pietra, legno massello, argilla, lastre di gesso, vernici a base di cellulosa e prodotti naturali) e tecniche non nocivi per la salute, con bassi livelli di VOC e di inquinamento dovuto all’elettricità. L’involucro è realizzato con pannelli massicci di legno, isolato con fibra di legno e rivestito da listelli di larice; le finestre hanno telaio in legno e triplo vetro. La sua impronta ecologica è molto bassa sia per quanto riguarda la costruzione sia per la fase di utilizzo, in virtù dello standard passivo e delle altre soluzioni adottate. Concepito secondo il motto “l’energia più economica è quella che non si consuma”, l’edificio non dispone di alcun sistema di riscaldamento convenzionale, il camino è stato voluto dal committente e ha causato ai progettisti non pochi problemi per la certificazione Passivhaus. In inverno l’apporto di calore è garantito dai guadagni solari passivi, dalle attività umane e dagli elettrodomestici. Grazie all’alto livello di isolamento e di tenuta all’aria, per garantire il comfort e una temperatura di 19°C è sufficiente un sistema di ventilazione meccanica, con recupero di calore e scambiatore geotermico, oltre a un impianto radiante nei servizi igienici. Un impianto di recupero consente l’utilizzo dell’acqua piovana per la lavatrice, i servizi igienici e la manutenzione del giardino; dispositivi quali wc a doppio tasto, miscelatori termostatici e rubinetti dotati di economizzatori contribuiscono a ridurre i consumi idrici. L’acqua calda sanitaria è prodotta dalla pompa di calore e da collettori solari a tubi sotto vuoto.
Certificata dal Passivhaus Institut, la casa ha ricevuto un premio di 30.000 euro dal Conseil général 78 (Dipartimento di Yvelines a ovest di Parigi) per le sue eccezionali qualità architettoniche ed ecologiche.
61 2
1 - entrata
2 - cucina
3 - sala da pranzo
4 - soggiorno
5 - camera da letto 6 - bagno
7 - biblioteca/mediateca
8 - ufficio
9 - ripostiglio
62 legnoarchitettura_06 progetti
pianta piano terra prospetto nord
pianta primo piano
prospetto sud
est 7 5 9 2 6 8 4 3 5 9 5 5 6
prospetto ovest
prospetto
1
_trasmittanza media elementi costruttivi________
pareti esterne: U = 0,16 W/m2K solaio contro terra: U = 0,18 W/m2K copertura: U = 0,12 W/m2K superfici trasparenti: Uw medio = 0,76 W/m2K
_prestazioni energetiche________
fabbisogno energetico: 15 kWh/m2 anno (secondo PHPP)


_3
La diversa pendenza e dimensione delle falde (più grande e accentuata quella a nord).
_4
Il prospetto nord-ovest presenta poche aperture per ridurre le dispersioni energetiche.
L’edificio è dotato di un impianto di recupero delle acque piovane, raccolte in una cisterna della capacità di 6500 l e riutilizzata per l’irrigazione del giardino, gli sciacquoni dei wc, la lavatrice e la pulizia dei locali.
63 3 4
sezione trasversale


_la tenuta all’aria________

Due immagini della macchina del Blower Door Test dall’esterno e dall’interno della villa.
_7
Il camino nella zona giorno (potenza 10 kW).
Il grafico mette in relazione la perdita d’aria dell’edificio (in m3/h in ascissa) a seconda della pressione dell’edificio (in Pa in ordinata).
Già nel test intermedio di tenuta all’aria, che precede la prova finale obbligatoria per ottenere la certificazione di “casa passiva”, la casa ha dato prova di ottime prestazioni. In una casa passiva l’involucro deve essere quasi impermeabile, vale a dire che tutte le piccole “fughe” di aria (alla base dell’edificio, intorno alle finestre, ecc) non devono essere maggiori dell’area di un quadrato di dimensioni 10 x 10 cm (100 cm2). I risultati dopo il test intermedio sono stati straordinari: le perdite d’aria sono state di molto inferiori rispetto al valore richiesto, ovvero l’area è stata di soli 7 cm2 (2,65 x 2,65 cm).
Questi valori sono stati messi seriamente in crisi dal committente che ha voluto un camino all’interno dell’edificio. A priori un camino non è compatibile con una casa passiva per due ragioni: camino significa apertura e quindi problemi di tenuta all’aria (anche se è un camino a legna chiuso) e poi di surriscaldamento. L’impianto di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso, infatti, garantisce d’inverno una temperatura intorno a 19 °C; se si accende anche il camino, si è obbligati a utilizzare la canna fumaria e ad aprire le finestre, con perdita di calore fino all’80%. Tuttavia, nell’edificio in questione, l’eccezionale valore di tenuta all’aria ha consentito un ampio margine in termini di prestazioni, verificato anche con la macchina per il fumo freddo per individuare eventuali punti di infiltrazioni d’aria, consentendo di soddisfare i desideri del proprietario.
64 legnoarchitettura_06 progetti 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60
_5_6
56 7
a d ’
a ( m
pressione
p e r d i t
a r i
3 / h )
dell’edificio (Pa)
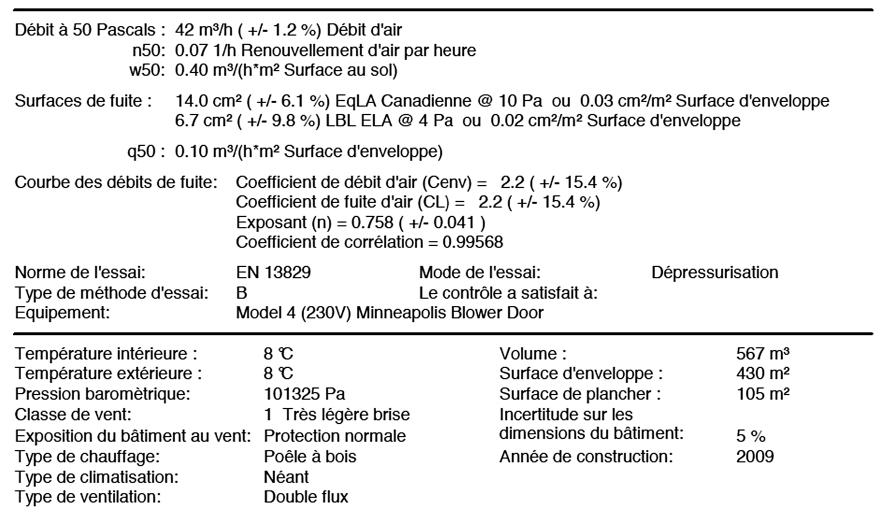


A lato due stralci del rapporto del Blower Door Test, effettuato con una macchina Modello 4 (230V) Minneapolis Blower Door, strumento idoneo per effettuare il test di permeabilità all’aria secondo la norma tecnica UNI EN 13829. Ciò permette di individuare le dispersioni energetiche dovute alle infiltrazioni e le cause delle fastidiose correnti d’aria all’interno dei locali. Il test ha evidenziato perdite minime dell’involucro in depressurizzazione.
_8
La prova con la macchiana del fumo a freddo per verificare la presenza di infiltrazioni d’aria in corrispondenza del camino.
_9
Il vano tecnico dell’edificio con l’impianto di ventilazione meccanica controllata.

65
8 9


Parete esterna, dall’esterno: rivestimento in assi di larice distanziate su telaio in legno; membrana di facciata traspirante e resistente ai raggi UV; doppio strato di isolamento in pannelli di lena di legno (2 x 120 mm); pannello in legno massiccio (94 mm).
Copertura, dall’esterno: lamiera in zinco prepatinato; placcaggio in legno (20 mm); camera di ventilazione (40 mm); pannello in lana di legno rigida (60 mm); pannello OSB (12 mm); struttura portante con isolamento in cellulosa (300 mm); membrana per tetti a falda inclinata; pannello OSB (9 mm).
A sinistra, due immagini dell’attacco tra la copertura della zona giorno al piano terra e la parete a sud del primo piano, durante la realizzazione e a edificio ultimato.
66 legnoarchitettura_06 progetti










Il seminterrato e il solaio verso il seminterrato.
A sinistra: posa delle pareti in pannelli massicci di legno del piano terra .
A destra: particolare dell’aggancio della parete al solaio. Si notano gli hold down, le piastre, i teli di impermeabilizzazione e di tenuta all’aria.
Il volume prende forma. A sinistra, si vedono in primo piano le travi e i montanti della struttura vetrata; a destra, l’isolamento in fibra di legno posato tra listelli.
A sinistra, il rivestimento esterno con il telo di tenuta all’aria e la sottostruttura per il fissaggio dei listelli. A destra, un vano interno del primo piano; i pannelli delle pareti sono fissati con angolari metallici al solaio.
Due dettagli della zona giorno esposta a sud al piano terra. Nell’immagine a sinistra è visibile l’isolamento del pavimento e la nastratura tra le fughe dei pannelli; a destra, il pavimento è quasi completato. Il rettangolo in basso a sinistra accoglierà il camino.
67

Manuel Benedikter
Ampliamento Caldaro

La terrazza si apre a sud verso il centro del paese e il lago, creando una zona giorno esterna. _3
Oltre all’ampliamento della copertura, l’intervento ha riguardato anche la riqualificazione dell’intero fabbricato.


_1 _2
70 legnoarchitettura_06 progetti 2 1

3
Ubicazione: Caldaro (BZ)
Progetto: arch. Manuel Benedikter, Bolzano; collaboratore: arch. Franz Kosta, Bolzano
Direttore dei lavori, coordinamento: arch. Manuel Benedikter, Bolzano
Progettazione impianti: Ruedl Hans OHG, Caldaro (BZ)
Appaltatore: Aster Holzbau, S. Genesio (BZ)
Lavori: ottobre 2010 - maggio 2011
Superficie fondiaria: 1.145 m2
Superficie utile: 1.166,02 m2
Fotografie: Studio Benedikter, Luca De Giorgi
La conversione di un tetto
Il risanamento energetico di un edificio degli anni ‘70 ha permesso direalizzare un attico con una terrazza panoramica e una vista che spazia dall’abitato fino al lago di Caldaro.
L’intervento ha riguardato l’intero edificio, del tutto privo di isolamento, consentendo di usufruire del bonus cubatura previsto dalla Provincia di Bolzano per la riqualificazione di fabbricati esistenti. Grazie alla coibentazione dell’intero volume e ad altri interventi che hanno anche ridefinito l’estetica complessiva del fabbricato è stato così possibile ampliare l’ultimo piano di circa 200 m3
L’attico è caratterizzato dal rivestimento in alluminio che si chiude verso nord con una leggera inclinazione, ripiegandosi quasi su se stesso, e si apre invece sul lato opposto con un grande terrazza, in parte coperta, che diventa a tutti gli effetti uno spazio abitabile. La copertura, inoltre, si estende di 70 cm verso l’esterno a protezione delle facciate. Nell’attico si contrappongono due parti, una più intima e discreta destinata alla zona notte a nord e l’altra più aperta, pubblica, della zona living. Il legno è il materiale che caratterizza tutto l’ultimo piano: dalla struttura portante, realizzata in montanti e traversi coibentati con fibra di legno, ai pavimenti interni in rovere oliato, al larice delle zone esterne. Grandi aperture vetrate si sviluppano a tutta altezza nell’area giorno e rivisitazioni dei classici bow-window ritagliano la copertura ampliando gli spazi vivibili. Il riscaldamento è garantito mediante un sistema radiante a pavimento, integrato da un sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. L’intero fabbricato è stato coibentato con polistirolo espanso sinterizzato con grafite; sono stati sostituiti gli avvolgibili mentre le finestre, oggetto di intervento nel 2005, poiché possiedono un valore Uw inferiore a quanto richiesto per legge, sono state mantenute. Non si è ottenuta una classe di efficienza energetica maggiore (l’edificio è certificato CasaClima C), poiché in Alto Adige la riqualificazione riguarda sempre tutta la particella edificale e dell’edificio fa parte anche il supermercato al piano terra che ha un’enorme superficie disperdente. La nuova unità, da calcolo, risulta una CasaClima A+.
71


_4
La grande apertura vetrata a doppia altezza che dà sulla terrazza.
_5
Dettaglio del bagno: la profonda nicchia in corrispondenza del serramento permette di osservare il panorama esterno e crea un angolo di privacy all’interno dell’ambiente.
In basso, nella sezione longitudinale, è visibile la leggera inclinazione del tetto verso nord.
72 legnoarchitettura_06 progetti 6,93 m2 13,67 m2 10,54 m2 WC WC Küche Speis Zimmer01 Zimmer02 15,60 m2 3,90 m2 6,74 m2 4,40 m2 4,45 m2 58,40 m2 13,91 m2 5,69 m2 19,51 m2 15,33 m2 12,94 m2 21,80 m2 Garderobe Terrasse e O Essbereich Eingang Wäscheraum Lesebereich und Büro Gang Dach ens er + 10 15 + 10 15 14,09 m2 Treppenraum Zimmer03 Wohnzimmer A A BB 7 4 , 3 7 3 0 7 , 2 8 3 0 7 , 2 3 5 0 6 , 2 0 4 3 4 , 2 + 3,84 ± 0,00 + 6,92 + 10,15
sezione longitudinale BB 4 5
pianta

trasmittanza media elementi costruttivi________
serramenti attico in legno alluminio e triplo vetro
Uf = 1 W/m2K
Ug = 0,60 W/m2K
_prestazioni energetiche________
Efficienza dell’involucro prima dell’intervento: 200 kW/m2a
Efficienza dell’involucro dopo l’intervento: 58,97 kW/m2a

_6
La terrazza esterna e la copertura in metallo che riflette i colori del paesaggio, schermando le vetrate della zona giorno dell’attico.
_7
La zona living con il camino centrale che caratterizza l’ambiente interno.
73
6 7
Copertura (A), dall’interno:
pannello in gesso fibra (15 mm); sottostruttura in listelli di legno (40/60 mm) per installazione impianti isolata con pannelli in fibra di legno morbida (60 mm); lastra di OSB (15 mm); struttura portante a telaio in abete (160/80 mm) e isolamento in fibra di legno morbida; assito grezzo (25 mm); pannello in fibra di legno (80 mm); telo antivento aperto alla diffusione (sd = 0,09 m); struttura in legno (40/60 mm); cassaforma grezza per il rivestimento (25 mm); rivestimento di copertura.
1 - bordo superiore del davanzale
2 - bordo superiore solaio
3 - bordo superiore vecchio solaio
4 - isolamento in poliuretano (100 mm) e intonaco (10 mm).
Solaio interpiano (B), dall’intradosso: solaio esistente (200 mm); membrana bituminosa; riempimento a secco (200 mm); isolamento al rumore da impatto (5 mm); riempimento a secco (80 mm); isolamento acustico (20 mm); strato di separazione in PE; massetto (70 mm); pavimento in legno (15 mm).

74 legnoarchitettura_06 progetti 1 2 3 0 0 , 2 0 9 0 1 , 1 4 2 0 2 0 2 1 5 8 5 5 0 8 , 2 15 70 0 1 , 1 6 1 , 1 A B 4
sezione verticale della parete della cucina
sezione orizzontale dell’abbaino della cucina

1 - isolamento del balcone, dall’intradosso: pavimento esterno (10 mm); massetto a secco (30 mm); XPS (40 mm); struttura esistente (100-240 mm); XPS (40 mm); intonaco (10 mm). sezione trasversale _8


L’edificio durante la riqualificazione.
_9_10
Il fabbricato prima e dopo l’intervento.
75 4 + 13,436 + 6,92 + 3,84 ± 0,00 ± 0,14 + 10,235 + 10,235 ± 0,00 + 0,71 + 0,01 - 0,01 + 3,82
+ 3,69
1 1 1 8 9 10
Parete esterna (A), dall’interno:
pannello in gesso fibra (15 mm); sottostruttura in listelli di legno (40/60 mm) per installazione impianti isolata con pannelli in fibra di legno morbida (60 mm); lastra di OSB (15 mm); strattura portante a telaio in abete (160/80 mm) e isolamento in fibra di legno morbida; assito grezzo (25 mm); pannello in fibra di legno (80 mm); telo antivento aperto alla diffusione (sd = 0,09 m); telaio in legno (40/60 mm) per fissaggio del rivestimento; rivestimento di copertura.
1 - bordo superiore del davanzale
2 - bordo superiore solaio
3 - bordo superiore vecchio solaio
Anche all’interno è ben chiara la deformazione della copertura. Fibra di legno per l’isolamento termico e nastrature delle connessioni per garantire l’ermeticità dell’involucro. _12
La struttuta della parete esterna opaca, come evidenziata dal dettaglio in questa pagina.
Connessione tra copertura, parete opaca e serramento: in evidenza il telo di diffusione al vapore.



76 legnoarchitettura_06 progetti 2 0 2 0 8 2 7 1 5 5 8 5 2 4 0 1 , 0 0
1 2 3 111213 A _11
_13









L’ampliamento al grezzo con l’assito a 45°di chiusura della struttura portante in legno e le travi di copertura.
A sinistra: la nastratura per la tenuta all’aria dei giunti tra le lastre di OSB e tra gli elementi strutturali in corrispondenza della vetrata d’angolo. A destra: l’isolamento della struttura.
A sinistra: la tenuta all’aria in corrispondenza della finestra sul tetto che dà luce al corridoio. A destra: connessione tra le travi di copertura.
A sinistra: dettaglio dell’angolo dello sporto del tetto.
A destra, in alto: il passaggio delle tubazioni della VMC a pavimento.
A destra, in basso: posa dell’isolamento del tetto con la fibra di legno.
77

Gianfranco Visentin Andrea Zambon Uffici San Biagio di Callalta

2
Particolare della facciata a sud: il gioco di rientranze della parete insieme agli aggetti consente la schermatura delle vetrate.

_1 L’ingresso agli uffici.
80 legnoarchitettura_06 progetti 1

Ubicazione: San Biagio di Callalta (TV)
Progetto: arch. Gianfranco Visentin, Treviso; arch. Andrea Zambon, San Biagio di Callalta (TV)
Strutture: ing. Daniele Spigariol, Treviso
Consulente CasaClima: arch. Andrea Zambon, San Biagio di Callalta (TV)
Direttore dei lavori: arch. Gianfranco Visentin, Treviso
Appaltatore: Natural Building Srl
Lavori: novembre 2008-dicembre 2009
Superficie lotto: 5.272 m2
Superficie coperta: 2.580 m2, di cui 2.182 m2 magazzino - 397 m2 uffici
Superficie lorda uffici: 794 m2 (2 piani)
Superficie verde a giardino: 345 m2
Una sede per costruire case
Realizzare in bioedilizia un edificio a uso uffici con annesso magazzino caratterizzato da alte prestazioni energetiche è stato l’obiettivo che ha indirizzato le scelte architettoniche e costruttive dei progettisti e del committente, la Natural Building di San Biagio di Callalta, un’azienda che realizza case in legno.
La struttura è regolare e compatta al fine di ottenere il miglior rapporto possibile tra superficie disperdente e volume (0,51 1/m) e l’esposizione a sud della parte destinata agli uffici permette di sfruttare al massimo l’apporto solare invernale; le vetrate a sud, inoltre sono rientranti e schermate da aggetti e sporgenze a evitare il surriscaldamento nel periodo estivo. Il magazzino è disposto a nord, strutturalmente e termicamente separato (con un’intercapedine ventilata di 30 cm tra i due fabbricati), dalla parte destinata agli uffici. Quest’ultima è organizzata con le aree di lavoro disposte a sud e quelle dei servizi a nord, adiacenti al magazzino. La zona centrale con l’ingresso, la reception e l’amministrazione separa gli uffici dalla zona espositiva e la piccola sala convegni situate nell’ala ovest.
L’edificio è stato realizzato interamente in legno, con un involucro altamente isolato e privo di ponti termici. Per limitare ulteriormente le dispersioni di energia sono stati adottati serramenti in alluminio a triplo vetro con argon. Un sistema di ventilazione meccanica consente il ricambio costante dell’aria, eliminando la necessità di aprire le finestre e le conseguenti dispersioni energetiche. L’impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento è servito da una pompa di calore elettrica da 15 kW con tre sonde geotermiche verticali; insieme all’impianto fotovoltaico (19,8 kWp) posto sulla copertura del magazzino permette all’edificio di essere totalmente autonomo dal punto di vista del fabbisogno energetico. L’edificio è certificato CasaClima Gold Plus e nel 2011 ha vinto il Cubo d’Oro nell’ambito del premio CasaClima Awards.
81 2
Nelle piante è visibile la separazione termica tra l’edificio degli uffici e il magazzino a nord.
82 legnoarchitettura_06 progetti
pianta piano terra
pianta primo piano
assonometria della struttura
sezione longitudinale

_trasmittanza media elementi costruttivi________
pareti esterne: U = 0,12-0,13 W/m2K
solaio contro terra: U = 0,12 W/m2K
copertura: U = 0,12 W/m2K
superfici trasparenti: Uw medio = 1,4 W/m2K
_prestazioni energetiche________
consumo energetico per riscaldamento: 4,91 kWh/m2 anno
emissioni CO2: 6 kg/m2 anno
_3
Dettaglio del rivestimento di facciata.
83
3
Lo strato di isolamento della parete esterna a contatto con le fondazioni in XPS e l’impermeabilizzazione della platea in cls.
5
Dettaglio del rivestimento esterno in legno.
6
Vista della struttura interna con il massetto e il passaggio impianti.
_7
Posa del rivestimento esterno in doghe di legno.




Parete esterna, dall’interno: doppia lastra in cartongesso; lana di roccia; struttura portante in X-lam; fibra di legno; tessuto traspirante; supporto in legno-cemento; intonaco armato.
1 - riempimento in ghiaione
2 - tubo drenante (160 mm)
3 - pozzetto per ventilazione (40x40 cm)
4 - getto di rialzo della fondazione
5 - XPS (10 cm)
6 - basamento in larice
7 - morale di contenimento
_4
84 legnoarchitettura_06 progetti 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
La struttura portante dell’edificio è realizzata in pannelli di legno multistrato X-lam con spessore di 95 mm, il rivestimento esterno è in listelli larice per il fronte principale, a intonaco sugli altri lati. L’isolamento è realizzato con un cappotto in fibra di legno da 20 cm accoppiato a una lastra di legno mineralizzato a supporto dell’intonaco o con intercapedine di ventilazione per le parti delle facciate rivestite in listelli di larice.
Sul lato interno della struttura l’intercapedine per il passaggio degli impianti è chiusa con doppio pannello in cartongesso e isolata con 10 cm di lana minerale; il solaio contro terra è stato coibentato con 20 cm di XPS. La copertura piana, con struttura in travi di legno e soletta di calcestruzzo, è stata realizzata con il sistema a tetto rovescio in cui l’elemento termoisolante (26 cm di XPS) è posto sopra l’impermeabilizzazione e protetto da piastre in calcestruzzo. Tale sistema elimina la possibilità di formazione di condense interstiziali. La tenuta all’aria dell’edificio è garantita dall’attenta posa in opera e dalla sigillatutra con appositi nastri.
Solaio interpiano, dall’intradosso: pavimento in legno; riscaldamento a pavimento; sottofondo alleggerito; tessuto traspirante; solaio in legno a piastra.
Sbalzo, dall’intradosso: pavimento in gres; massetto in cls; isolamento in XPS; guaina bituminosa; solaio in legno a piastra; fibra di legno; finitura in legno.
1 - davanzale in marmo 2 - protezione in rame


_8
Taglio termico in corrispondenza del serramento.
_9
L’ingresso: in primo piano le piastre di ancoraggio della struttura in X-lam.
_sistema costruttivo________
85
8 9 2 1
Solaio di copertura, dall’esterno:
finitura con piastre in cls; strato d’aria (ca. 3 cm); tessuto di separazione traspirante; XPS; guaina bituminosa doppia; massetto; pendenza con sottofondo alleggerito; soletta collaborante in cls; tavole in abete a vista.
1 - doppia lastra in cartongesso
2 - fibra di legno
3 - lana di roccia
4- pannello portante in abete
5 - separazione termica tra l’edificio per uffici
e il magazzino
Il corridoio che serve gli uffici e la sala riunioni al piano superiore.

9 1 2 3 4
_9
5









Posa dei pannelli strutturali in X-lam e la sottostruttura metallica per le contropareti in cartongesso.
La parete ovest e l’ingresso alla sala riunioni prima del montaggio del rivestimento interno per consentire il passaggio impianti.
A sinistra, dettaglio della sala riunioni.
A destra, lo spazio a doppia altezza del vano che accoglierà la struttura della scala.
A sinistra, in alto, il vano scale al grezzo; in basso, posa del rivestimento esterno sulla struttura in legno-cemento; a destra, dettaglio della copertura e della parete ovest.
87
Lo studio di sistemi e prodotti di derivazione legnosa, utilizzati per la realizzazione di alcuni interventi di social housing in Europa, offre l’opportunità di conoscere e valutare le caratteristiche prestazionali e le opzioni tecniche proprie di queste nuove tecnologie costruttive e di restituire tali informazioni a supporto dei progettisti e di coloro che si apprestano a operare nel campo dell’edilizia a basso costo.
La ricognizione delle sperimentazioni e applicazioni di nuovi sistemi e prodotti nel social housing ha evidenziato alcuni contesti europei in cui il settore della produzione ha innovato il proprio processo produttivo attraverso la corretta gestione delle risorse naturali, favorendo l’uso del legno per far fronte all’emergenza abitativa I risultati di questa indagine sono un insieme di informazioni tecniche e di indirizzo dirette alle Amministrazioni pubbliche, progettisti, imprenditori e tutti quegli operatori impegnati nella promozione ed attuazione di interventi di housing sociale, attraverso le quali coniugare qualità dell’abitare, economicità, sostenibilità ambientale e sicurezza
techné Housing sociale
Teresa Villani
Edilizia sociale in Europa
sistemi costruttivi e prodotti in legno
Teresa Villani
Ricercatore universitario in Tecnologia dell’Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università “Sapienza” di Roma, svolge attività di ricerca presso il Dipartimento DATA sulle tematiche delle tecnologie innovative, procedure e strumenti per la programmazione e la progettazione di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio

Competitività prestazionale di sistemi e prodotti in legno
Il legno e i prodotti di derivazione legnosa, utilizzati come materiali da costruzione, stanno destando oggi molto interesse nel settore edilizio
Le soluzioni tecnologiche che prevedono l’impiego di tali prodotti, specie per uso strutturale, sono però molteplici e, soprattutto, poco conosciute anche al progettista che, al fine di utilizzarle nel modo più efficace, deve tener presente prescrizioni normative, potenzialità offerte e schemi operativi di progettazione
La cultura della progettazione strutturale in legno in Italia è limitata a un ristretto numero di professionisti specializzati, mentre il crescente sviluppo del mercato in questa direzione richiederebbe una maggiore diffusione di specifiche competenze
Molti sono i segnali che indicano che nei prossimi anni anche in Italia, come in altri paesi europei, si assisterà a un notevole impulso nell’uso del legno in edilizia per i vantaggi che esso offre: l’industrializzazione del processo costruttivo limita costi e tempi di realizzazione e la leggerezza del materiale, rispetto al cemento armato e alla muratura, consente, ad esempio, di ridurre l’entità delle azioni sismiche Allo stato attuale in Italia vengono realizzati circa tremila edifici in legno l’anno1 Questo trend ha trovato riscontro nella emanazione di norme che per la prima volta in Italia regolamentano l’impiego del legno come materiale strutturale (D M 14 01 2008 preceduto dal Documento CNR-DT206/2007 Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e il controllo delle strutture in legno) con suggerimenti tecnici per l’uso di tali strutture in zone sismiche e una base normativa per le aziende
90 legnoarchitettura 06 techné

produttrici che fino a oggi, per la certificazione di prodotti in legno, facevano riferimento a norme appartenenti ad altri paesi europei, con particolare riferimento alle norme DIN tedesche
Diventa quindi interessante indagare le recenti sperimentazioni e le relative applicazioni di tali sistemi e prodotti nell’ambito dell’edilizia sociale in Europa, per fare emergere le peculiarità proprio in un ambito in cui l’esigenza di realizzare edifici sicuri utilizzando sistemi capaci di abbattere costi e tempi di realizzazione a parità di qualità edilizia, rappresenta un insieme di requisiti fondamentali di competitività
Molti sono gli indicatori prestazionali insiti nei sistemi costruttivi in legno e derivati che soddisfano i fondamenti della ricerca di nuove tecnologie per l’edilizia sociale e che ne confermano la competitività: componenti edilizi a elevato livello di standardizzazione e di integrabilità, semplicità realizzativa, flessibilità funzionale e d’uso, durabilità e manutenibilità appropriate in rapporto alla vita utile dell’edificio, prefabbricazione e assemblaggio a secco per abbattere l’incidenza dei costi della mano d’opera, aumento della produttività e della velocità di avanzamento del cantiere Inoltre, molti dei sistemi costruttivi in legno favoriscono una razionalizzazione della progettazione tecnologica attraverso l’equilibrio tra il progetto di soluzioni standard e la progettazione esecutiva dell’edificio, incidendo positivamente anche sui costi della progettazione nel suo complesso


Infine, permettono un’organizzazione del cantiere che favorisce la sicurezza e la salute dei lavoratori, basata su un modello in cui prevalgono attività di montaggio e assemblaggio di componenti prefabbricati, secondo una pianificazione organica delle sequenze di lavoro in accordo con le indicazioni della progettazione esecutiva, limitando l’improvvisazione in cantiere e incidendo sulla minimizzazione degli sfridi di materiale
Applicazioni nell’ambito del housing sociale in Europa
Tale indagine cerca di delineare una sintesi esemplificativa delle caratteristiche costruttive presenti nei diversi sistemi e prodotti analizzati e un conseguente quadro di riferimento delle recenti applicazioni nel comparto dell’edilizia sociale in Europa, articolato in modo da far emergere i punti di forza e gli eventuali punti critici, finalizzato a promuoverne l’impiego anche in Italia I risultati di alcune indagini condotte nel settore dell’housing sociale prevedono in Italia una dotazione finanziaria pubblico-privata pari a circa 10 miliardi di euro per realizzare 50 000 nuovi alloggi sociali e soddisfare così la domanda che oggi, solo nella regione Lombardia, è pari al 42,1% dell’edilizia residenziale (Cresme 2010) Molti Paesi (Germania, Nord Europa, Regno Unito, Olanda, Austria, ma anche Turchia, caratterizzata da un rischio sismico molto elevato) hanno rilanciato l’utilizzo del legno, favorendo l’applicazione di tecniche innovative per far fronte al fabbisogno di alloggi destinati a categorie soggette a emergenza abitativa, facendo as-
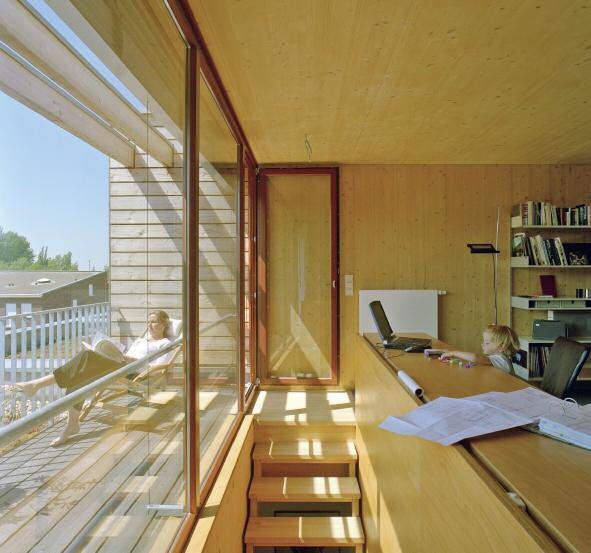
Progetto per sei gruppi di case a schiera economiche a DarmstadtKranichstein K6 (Germania); progettisti: prof. arch. Thomas Zimmermann, arch. Klaus Leber, arch. Jörg Feilberg.
Nella pagina a fianco, vista frontale di una unità abitativa Equilibrio tra gli spazi opachi e trasparenti
Sopra, da sinistra: il complesso insediativo orientato nella direzione est-ovest; la qualità degli spazi esterni privati; l’uso del legno sia per il sistema costruttivo che per le finiture esterne
Da sinistra: il benessere psicologico derivante dalle superfici in legno e dal colore; la qualità degli spazi interni
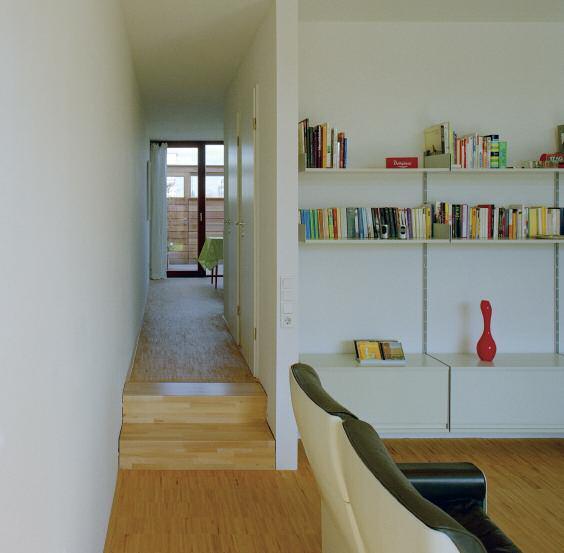
Emissioni di CO2: comparazione tra i valori del legno e quelli degli altri prodotti da costruzione
A destra: sistema costruttivo Kingspan TEK®
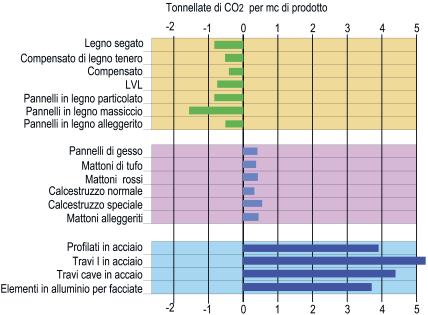
Social Housing a bassa densità abitativa a Darmstadt, Germania
La scelta del sistema costruttivo Leno Massivbau costituito da pannelli incrociati in legno ha permesso il controllo dei costi favorendo la qualità degli spazi
sumere al binomio costruzioni in legno/sostenibilità anche una valenza economica e produttiva
In Germania la promozione di alloggi sociali è assoggettata all’obbligo di introdurre misure sostenibili negli interventi proposti, in grado di porre in equilibrio le finalità economiche e sociali con quelle di carattere ambientale Non a caso proprio in Germania, negli ultimi anni, sono stati sperimentati nuovi sistemi che prevedono la sovrapposizione di pannelli in legno massiccio a strati incrociati (X-lam, Leno) che hanno trovato applicazione nella costruzione di edifici a basso costo di medie dimensioni e bassa densità abitativa, offrendo caratteristiche di resistenza meccanica alle sollecitazioni verticali e alle spinte orizzontali
Tali sistemi prevedono il completamento in cantiere con altri pannelli di finitura e con il sistema di fondazioni utilizzando semplici viti autofilettanti, chiodi, angolari e ancoraggi in acciaio con procedimenti costruttivi a secco
In questa direzione si colloca anche il concorso “Design for Manufacture (DfM) lanciato dal Governo britannico nel 2005 allo scopo di stimolare l’offerta di edilizia sociale di elevata qualità a costi di realizzazione contenuti attraverso la razionalizzazione dei sistemi costruttivi I risultati di questa iniziativa sono la realizzazione di un primo lotto dimostrativo di 1000 alloggi, certificati secondo la metodologia BREEAM “Eco Home”, utilizzando solo materiali a basso impatto am-
bientale, con la garanzia di un ciclo di vita utile di almeno 60 anni e con un limite massimo di costo pari a 60 000 sterline Il bando ammetteva sia soluzioni costruttive tradizionali sia “metodi moderni di costruzione” (MMC) e precisamente sistemi prefabbricati
Di questi alloggi, circa 200 hanno previsto l’uso di sistemi innovativi a pannelli strutturali isolati in legno utilizzati per pareti, solai e copertura (sistema costruttivo Kingspan TEK)
Altri 130 alloggi realizzati con elementi prefabbricati bidimensionali in legno (sistema Space4 Ltd) e 120 mediante l’uso di elementi prefabbricati bidimensionali in microlamellare (sistema WeberHaus) con finitura interna ed esterna e serramenti premontati Nello stesso lotto sono stati realizzati anche 25 alloggi con sistemi misti come pannelli a struttura in lamiera di acciaio zincata (sistema BUMA di produzione polacca) e con pannellatura in lastre di OSB (sistema The Home Factory timber system)
Sempre in Inghilterra, e proprio in un intervento di housing, sono state superate le limitazioni in altezza degli edifici realizzati con sistemi innovativi in legno grazie all’uso di pannelli in legno massiccio a fibratura incrociata Lo dimostra la realizzazione del Murray Grove Builiding a Londra, un edificio residenziale pluripiano (nove livelli di cui il piano terra in cemento armato e otto piani realizzati con pannelli di legno KLH Massivholz GmbH) pro-
92 legnoarchitettura 06
gettato dallo studio Waugh Thistleton Architets La crescita in altezza è legata non solo alle prestazioni meccaniche dei pannelli, ma anche a una ricorrente forma geometrica scatolare necessaria per garantire un’efficace risposta alle sollecitazioni orizzontali
L’Austria è però il paese che vede il maggior numero di costruzioni in legno Un esempio interessante è il quartiere Spöttelgasse di Vienna che ospita il progetto dell’architetto Hubert Riess costituito da un edificio residenziale di quattro piani, realizzato con struttura Cross-Lam, e il progetto Lifecycle Towers dell’architetto Hermann Kaufmann, edifici alti circa 100 m realizzati con sistemi misti in legno-calcestruzzo Nei paesi scandinavi, e in particolare in Finlandia, dove i giovani si allontanano dalla famiglia per costituire un nucleo autonomo anche durante il periodo di studio, la spinta delle amministrazioni pubbliche verso la realizzazione di alloggi a prezzi contenuti, come ad esempio gli “student housing”, si è orientata verso la realizzazione di un’edilizia diffusa in legno, suscettibile di una produzione in serie Sono stati sperimentati e applicati sistemi e componenti in microlamellare o pannelli in legno intero prefabbricati (sistemi Kerto Q, Kerto Ripa), con lo scopo di migliorare alcune prestazioni specifiche aventi dirette ricadute sotto il profilo della qualità dell’abitare
In Italia purtroppo l’emergenza casa è una realtà Il nostro paese sconta un ritardo rispetto ad altri paesi europei, nei quali la creazione di edifici sociali è andata di pari passo con la riqualificazione di intere aree urbane
Nonostante il ritardo, anche in Italia e precisamente a Firenze, nel quartiere di Gavinana, è prevista la realizzazione di un complesso di edifici di edilizia popolare interamente in legno (con altezze fino a 6 piani) promosso da Case Spa (società partecipata di 33 comuni dell’area fiorentina che progetta, realizza e gestisce il patrimonio di edilizia pubblica), con la collaborazione della Regione Toscana, il Comune di Firenze e una quota di cofinanziamento del Ministero delle Infrastrutture La tecnologia utilizzata, progettata dal CNR di Firenze e testata in Giappone, è quella che prevede l’uso del cosiddetto “compensato a tavole” (Cross-Lam) che, in quanto sistema “innovativo” e non interamente contemplato dalle normative italiane (nel resto d’Europa è utilizzato da quasi dieci anni), ha richiesto l’avvio di una speciale procedura di idoneità tecnica all’impiego da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Tra le opere in costruzione è importante segnalare
anche un edificio residenziale di sei piani interamente in legno lamellare poco lontano dal porto di Trieste (sistema costruttivo messo a punto dalla Rubner)
A dimostrazione del crescente interesse in questa direzione, si può infine citare la recente mostra Social Home Design “Abitare il futuro”, che al Made Expo 2011 ha esposto quattro progetti di altrettanti studi di architettura Idee diverse tra loro attraverso cui la social house made in Italy diventa realtà attraverso un’abitazione prefabbricata a basso impatto ambientale, realizzata in legno
Gli indicatori di performance e d’uso attraverso lo studio del sistema Leno Massivbau per la realizzazione di edilizia sociale a Darmstadt, in Germania
I sistemi costruttivi e i prodotti di derivazione legnosa utilizzati nel campo dell’edilizia sociale sono stati analizzati finalizzando il contributo di tutte le competenze, e in particolare il know-how dei rappresentanti delle industrie produttrici, dei progettisti, delle associazioni di categoria legate a tutta la filiera “legno”, alla predisposizione di un quadro di sintesi informativo Sono stati identificati alcuni indicatori di performance e d’uso quali le caratteristiche dimensionali, le modalità realizzative e gli aspetti prestazionali dal punto di vista della sicurezza (prestazioni di tipo meccanico, sistemi di connessione e controventamento dei componenti, comportamento al fuoco ecc ), della sostenibilità ambientale ed economica (LCA, emissioni di formaldeide, sostituzione delle colle a favore di connessioni metalliche o in legno ecc ), del benessere (prestazioni termo-igrometriche, acustiche, visive, percettive ecc ), della durabilità Attraverso l’analisi delle schede tecniche dei prodotti sono emersi anche alcuni punti critici, responsabili della difficoltà di diffusione dei sistemi, tra cui la qualità dell’informazione tecnica veicolata dai produttori e diretta ai progettisti Molto spesso si è riscontrata un’informazione eccessivamente specialistica, concentrata sul comportamento strutturale dei prodotti e poco sugli esiti formali e morfologici Inoltre, la fase di confronto e valutazione dei diversi sistemi e prodotti in termini prestazionali è spesso ostacolata dalla mancanza di uniformità dei dati tecnici riportati nelle schede prodotto (riferimenti normativi diversi, unità di misura differenti, omissione di alcuni requisiti connotanti ecc ) che comporta la non immediata fruibilità del dato e lo sforzo di conversione da parte del progettista, determinando così




Torre residenziale realizzata nel quartiere di Murray Grove a Londra realizzata con pannelli incrociati in legno. L’edificio detiene il primato in altezza tra gli edifici realizzati in legno e rappresenta il passaggio dal modello unifamiliare a quello plurialloggio, fattore cruciale sia sotto il profilo economico che tecnologico I pannelli in legno a strati incrociati sono realizzati in stabilimento mediante incollaggio di strati orientati di tavole in legno Una volta solidarizzati, i pannelli vengono tagliati con macchine a controllo numerico in base al progetto esecutivo In cantiere vengono movimentati da gru e assemblati tramite connessioni meccaniche o incastri
93
difficoltà nel poter operare scelte tecniche attraverso un confronto diretto
A titolo esemplificativo, si prende in esame uno dei sistemi forse meno conosciuto in Italia, ma con una consolidata tradizione costruttiva nei paesi del nord Europa e in Germania: il sistema Leno Massivbau2 prodotto dalla Finnforest Merk in Germania, utilizzato per la realizzazione di sei gruppi di case a schiera a basso costo a Darmstadt - Kranichstein K6
L’idea di base di questo sistema è quella di produrre pannelli strutturali a partire dall’unione, tramite incollaggio con resina melamminica, di lamelle di abete rosso disposte a fibre incrociate, così da offrire componenti omogenei di dimensioni variabili La denominazione comprende una gamma di prodotti quali Leno e LenoTec e la conformazione dei prodotti può variare tra pannelli standardizzati per solai, tetti e pareti fino ad arrivare a veri e propri kit di montaggio per l’intero edificio prefabbricato I componenti sono comprensivi di incavi e fresature per aperture e canalizzazioni e predisposti con cinghie di attacco per il montaggio da effettuare in cantiere Le costruzioni in Leno Massivbau presentano semplicità nella progettazione, rapidità di montaggio e quindi ottime ricadute in termini di tempi e costi di realizzazione, elevate prestazioni meccaniche e stabilità dimensionale Inoltre, utilizzando un solo prodotto si riesce ad assolvere alle funzioni strutturali, a quelle di isolamento termico e acustico e alla protezione contro gli incendi
La realizzazione di residenze di qualità, a basso costo, minimo fabbisogno energetico e ridotto impatto ambientale richiede una radicale revisione del processo edilizio dei nuovi insediamenti e soprattutto una concreta correzione di alcune prassi responsabili delle ormai croniche carenze qualitative che con-
traddistinguono il patrimonio edilizio di housing nazionale
Tra le nuove tecnologie, materiali e componenti il legno dimostra al momento di essere particolarmente appropriato per realizzare sistemi aperti, flessibili, con una produzione basata su un alto livello di prefabbricazione e/o industrializzazione e tale da garantire efficaci prestazioni a fronte di costi di progettazione, produzione, installazione, manutenzione sensibilmente più bassi rispetto alle soluzioni comunemente adottate
Alla ricerca va quindi il compito di sperimentare e proporre nuove idee capaci di stimolare le aziende produttrici, interpretare i comportamenti e i meccanismi sociali e arrivare a un equilibrio tra tecnologia, sicurezza e bellezza caratterizzato da semplicità concettuale, essenzialità delle forme e capacità operativa a basso costo, che porti a un “prodotto” concepito per durare nel tempo ai massimi livelli di efficienza e di sostenibilità sociale
Note
1 Il consumo di legno lamellare e prodotti innovativi (Duo, Trio, KVH ecc ) in ambito residenziale in Italia è aumentato dai 400 000 mc del 2000 a più di 1 000 000 m3 nel 2010
Entro il 2015 la domanda salirà del 50% Si tratta di soluzioni ecologiche e a basso consumo energetico che in pochi anni hanno raggiunto una quota di mercato interessante e stanno rivoluzionando il settore dell’edilizia italiana: nel 2010 l’8,5% di tutti gli edifici e il 2,8% di tutta l’edilizia residenziale (Fonte “Il mercato italiano delle case in legno nel 2010”, ricerca presentata al Made Expo da Promolegno e Assolegno)
2 www finnforest de
Bibliografia
Ferrante T (a cura di), Legno e innovazione, Alinea editrice, Firenze, 2008
Villani T , “Tendenze innovative degli elementi in microlamellare per uso strutturale (LVL, Kerto)”, in: Ferrante T (a cura di), Legno e innovazione, Alinea editrice, Firenze, 2008
Villani T , “Social Housing a bassa densità abitativa”, in A A V V , Low cost, Low energy, Quality architecture, Una nuova stagione per l’housing, BE-MA Editrice, Milano, 2009 Antonini E , “La variante inglese Prefabbricazione”, in Costruire n 289, 2007
1 - Strato di protezione all’acqua: guaina impermeabilizzante prefabbricata in bitume con aggiunta di polimeri saturi, posizionata al di sotto dello strato di isolamento termico Sp 4 mm
2 - Strato di isolamento termico: pannello in polistirene espanso sintetizzato Sp 160 mm
3 - Solaio bidirezionale – o non bidimensionale – che costituisce la struttura in elevazione orizzontale: pannelli Leno®Massivbau: lamelle di abete rosso incollate mediante resine melamminiche, disposte a croce. Altezza 240 mm, larghezza 600 mm, lunghezza 2400 mm, giuntato a secco.
4 - Strato di rivestimento esterno: doghe in legno sabbiate, ancorate ad una sottostruttura in legno così da formare uno strato di ventilazione. Dimensioni doghe 300 x 1200 mm
5 - Strato di supporto del rivestimento: listelli prefabbricati in legno di abete a sezione piena Dimensione 50x60 mm
6 -Sistema di serramento: profilati in alluminio verniciato a taglio termico
7 - Pannelli bidimensionali per la struttura in elevazione verticale: sistema Leno®Massivbau dimensioni variabili da 4800x2000 mm e con spessori tra i 50 e i 300 mm
94 legnoarchitettura 06 techné
2 1 3 2 7 21 4 3 6 7 3 8 5
Denominazione intervento
Committente:
Progettisti:
Collaboratori:
Progettazione strutturale:
Progettazione e costruzione
Impresa realizzatrice
Sistema costruttivo
Superficie
Costo di costruzione
Costi complessivi
Tipo di finanziamento:
Sei gruppi di case a schiera economiche a Darmstadt – Kranichstein K6
Associazione costituita da 33 investitori privati
prof arch Thomas Zimmermann, arch Klaus Leber, arch Jörg Feilberg
Alexander Dill, Kathrin Därr, Tina Kraft, Barbara Naske, Daniel Wendt, Daniela Bayer, Björn Schöneberger
ing - Büro Peter Ilgmeier, Langen
2002-2008
Finnforest Merk GmbH, Aichach, Germania
Leno Massivbau
8 500 m2
3 750 000 euro per le prime 22 unità abitative
2 000 000 euro per le ultime 11
4.500.000 euro per le prime 22 unità abitative
2 500 000 euro per le ultime 11
Pubblico/Privato
Spessori (mm)
Da 15 a 300 con n di strati ‡ 3
Caratteristiche dimensionali pannelli
Larghezza (m)
Fino a 4,80, con larghezza massima delle fughe tra le tavole di 6 mm
Proprietà meccaniche e di stabilità
Resistenza a flessione parallela alla direzione delle fibre degli strati esterni
Resistenza a flessione perpendicolare alla direzione delle fibre degli strati esterni
Resistenza a trazione parallela alla direzione delle fibre degli strati esterni
Resistenza a compressione parallela alla direzione delle fibre degli strati esterni
Modulo elastico- perpendicolare alla direzione delle fibre degli strati esterni
Modulo elastico- parallelo alla direzione delle fibre degli strati esterni
Densità media
Umidità media
Proprietà acustiche
6,7 N/mm2
11,5 N/mm2
5,5 N/mm2
8,8 N/mm2
10 000 N/mm2
6 100 N/mm2
530 kg/m3
10 + 2%
Resistenza alla trasmissione del suono (Rw) da 46 a 68 dB
Lunghezza (m)
Fino a 14,80
Campo di tolleranza (mm)
Spessore +1/-2
Larghezza +/- 5 Lunghezza +/- 2
Proprietà di resistenza al fuoco
Classe di reazione al fuoco
Resistenza al fuoco, tasso di carbonizzazione
Proprietà ambientali e di igiene
D-s2, d0 0,7 mm/min
Classe di rilascio di formaldeide Classe E1
Proprietà termoigrometriche
Conducibilità termica
Trasmittanza
Capacità termica specifica
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo
Durabilità
Classe di scelta
Sintesi degli indicatori di performance e d’uso del sistema Leno Massivbau
0,13 W/mK
0,23 W/m2K
1600 J/(kgK)
40 μ
S 10
I dati sono stati estratti dalle schede tecniche di prodotto e normalizzati secondo le unità di misura espresse all’interno del Benestare Tecnico Europeo ETA-10/0241 rilasciato nel 2010 dal Deutsches Institut für Bautechnik per la marcatura CE
Social Housing a bassa densità abitativa a Darmstadt, Germania La scelta del sistema costruttivo Leno Massivbau ha permesso: in fase di progettazione, la flessibilità e la riduzione dei rischi progettuali grazie al controllo industriale dei componenti; in fase di realizzazione, la rapidità di montaggio e il rispetto dei tempi di consegna; in fase di esercizio, prestazioni garantite e gradimento elevato da parte degli abitanti

95
Travi e montanti
Con i termini travi e montanti o travi e pilastri generalmente si identifica uno tra i metodi costruttivi in legno più antichi, il sistema a telaio, ovvero elementi verticali collegati tra di loro mediante traversi e controventati da pannelli strutturali rigidi.
È il sistema costruttivo più diffuso al mondo e permette di fabbricare agevolmente strutture pluripiano in cui il legno forma l’intelaiatura portante.
Sul mercato tali elementi strutturali sono per lo più realizzati con legno lamellare, anche se si trovano con una certa facilità strutture in legno massiccio.
Questo metodo costruttivo consente grande libertà compositiva grazie ai reticoli e ai moduli variabili che costituiscono le pareti.
Di regola gli edifici a struttura intelaiata vengono costruiti piano per piano.
sistemi
Travi e montanti
Il sistema costruttivo a telaio in legno individua una costruzione intelaiata (dall’inglese timber frame), a lastre, dove gli elementi portanti non sono fisicamente separati dai pannelli di controventatura, irrigidimento e tamponamento, ma formano, per l’appunto, un’unica lastra.
Le pareti sono composte da un’ossatura portante con montanti verticali e traversi orizzontali e sono rivestite sui lati esterni con lastre di gesso o di OSB (con funzione anche di freno vapore) o con assiti maschio-femmina ruotati di 45°rispetto alla struttura per garantire la distribuzione dei carichi su più montanti. Nel caso in cui la parete sia irrigidita dall’assito, quest’ultimo viene trattato con un fondo di antimuffa e antitarlo che ha anche funzione di stabilizzazione delle deformazioni naturali del materiale. Le giunzioni tra i pannelli vengono opportunamente nastrate per assicurare la tenuta all’aria. I carichi verticali della copertura e dei solai di piano sono assorbiti dai montanti che, se esterni, assorbono anche quelli orizzontali agenti sulle pareti a causa del vento. I pannelli di chiusura assorbono a loro volta i carichi agenti sulla lastra stessa e dovuti alla loro funzione di irrigidimento. All’interno del telaio della parete grezza si effettua il primo isolamento con fibra di canapa, che ha una densità di circa 50 kg/m3, dello spessore scelto per il telaio. Esternamente viene applicato uno strato di isolamento a cappotto costituito da pannelli di fibra di legno, mentre all’interno, sulla lastra in OSB, viene fissato una sottostruttura in legno dello spessore medio di 50 mm per il passaggio degli impianti; la camera così ottenuta, dopo l’installazione dell’impianto elettrico, idraulico e di ventilazione, viene coibentata con fibra di legno e chiusa con un pannello di cartongesso.
Con il sistema a telaio il consumo della materia prima legno è limitato; il reticolo e la distanza tra i montanti è di solito determinata dalle lastre di tamponamento, la prefabbricazione in stabilimento può essere realizzata a diversi livelli e la tenuta all’aria è eseguita mediante soluzioni semplici.
Di solito gli edifici costruiti con struttura a telaio sono realizzati piano per piano (il sistema è conosciuto come platform frame) e solo in poche occasioni – in particolare nell’America del Nord – si utilizzano elementi caratterizzati da altezze che corrispondono a più piani (balloon frame).


98 legnoarchitettura_06 sistemi sistemi costruttivi
BLM Domus con sede a Fagnano Olona (VA) è una divisione del Gruppo Bevilacqua impegnata sul fronte dell’ecosostenibilità nel campo delle costruzioni in legno.
L’Azienda offre servi di progettazione, consulenza, verifica e certificazione energetica, costruzione, trasporto e posa in opera di edifici in legno in standard passivo.
Da sinistra: Casa unifamiliare a Fagnano Olona (VA); altre realizzazioni di edifici residenziali.
_I solai nelle strutture a telaio___
Nelle strutture a telaio si utilizzano tre tipi di solai: a sistema, sandwich e Brettstapel
Il solaio a sistema è costituiro da travi portanti a vista, mentre l’estradosso è chiuso da un assito con telo freno vapore nastrato. Le travi sono in legno di abete lamellare proporzionate secondo le luci del progetto. Quando sia necessario maggior isolamento termico e acustico o quando sia preferibile un soffitto con finitura liscia, è possibile utilizzare il solaio a sandwich con struttura portante in travi legno di abete KVH, isolamento tra i travetti in fibra di legno o canapa (? 50 kg/m3), assito di chiusura in OSB nastrato all’estradosso e all’intradosso con listellatura a passo costante per il passaggio degli impianti e chiusura in cartongesso.
Il Brettstapel, che garantisce ottimi valori di isolamento acustico e termico, è invece un solaio massiccio, realizzato con tavole messe di coltello e fissate meccanicamente, dal grande impatto estetico e dalle importanti portate.



99
travi e pilastri_parete
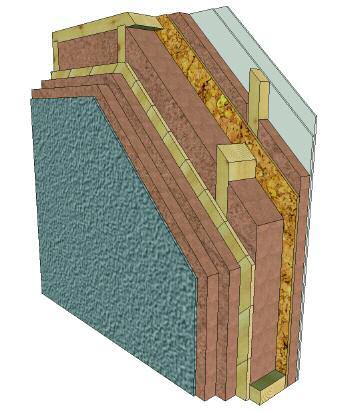
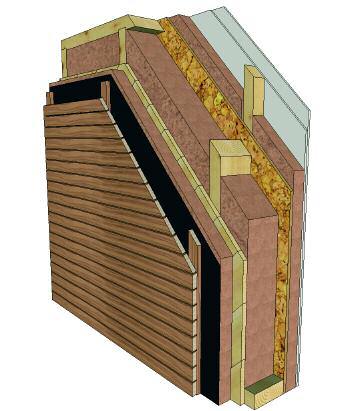
esterno
Stratigrafia della parete portante esterna con finitura esterna in intonaco (dall’esterno)
-rasatura esterna con finitura ai silicati (10 mm)
- pannello porta intonaco in fibra di legno 190 kg/m3 (60 mm)
-assito in abete controventante a 45°(20 mm)
- struttura portante ad interasse mm 625 e coibentazione in fibra di legno mm 200 (200 mm)
- OSB a funzione controventante e freno vapore (15 mm)
-intercapedine impianti e coibentazione in fibra di legno 70 kg/m3 (60 mm)
-doppio strato fibrogesso (20 mm)
Dati fisico-tecnici
peso trasmittanza termica sfasamento
riduzione dall’ampiezza di temperatura fattore di decremento
101 kg/m2
U = 0,11 W/m2K
h = 21,2
r.a.t. = 0,1
f = Udyn/U = 0,03
Stratigrafia della parete portante esterna con finitura esterna in legno (dall’esterno)
-listellatura esterna in legno (25 mm)
-sottostruttura in legno per camera di ventilazione (25 mm)
- telo freno vapore
-pannello porta intonaco in fibra di legno
190 kg/m3 (60 mm)
- assito in abete controventante a 45° (20 mm)
-struttura portante ad interasse mm 625 e coibentazione in fibra di legno mm 200 (200 mm)
-OSB a funzione controventante e freno vapore (15 mm)
-intercapedine impianti e coibentazione in fibra di legno 70 kg/m3 (60 mm) - doppio strato fibrogesso (20 mm)
Dati fisico-tecnici
peso
trasmittanza termica
sfasamento
riduzione dall’ampiezza di temperatura fattore di decremento

_Connessioni e serramenti___
102 kg/m2
U = 0,11 W/m2K
h = 21,2
r.a.t. = 0,1
f = Udyn/U = 0,03
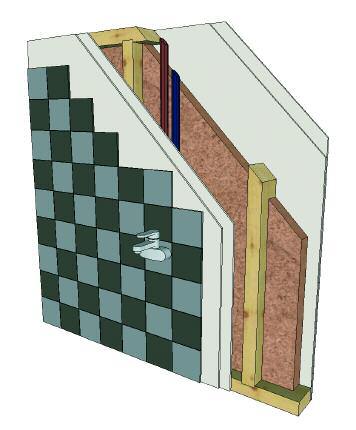
Stratigrafia della parete divisoria interna con finitura in piastrelle
-doppio strato fibrogesso (20 mm)
-intercapedine impianti e coibentazione in fibra di legno 70 kg/m3 (120 mm)
- doppio strato fibrogesso (20 mm) -rivestimento piastrelle
Dati fisico-tecnici
peso
protezione da fuoco protezione da rumore
45 kg/m2
REI 60 Rw = 45 dB
Le connessioni tra le sezioni prefabbricate delle pareti avvengono sempre in corrispondenza dei montanti e vengono effettuate con fissaggi chimici o meccanici, questi ultimi mediante piastre e tiranti metallici, hold down, tasselli, viti autoforanti, chiodi, chiambrette. Per quanto concerne i serramenti, generalmente le aperture possono essere disposte ovunque sulla parete: una finestra non allineata con il reticolo che costituisce la parete richiede di essere delimitata e circoscritta da ulteriori montanti e traversi/architravi. Una progettazione precisa che si adatta al reticolo della struttura intelaiata consente di collocare le aperture impiegando solamente i montanti strettamente indispensabili.
100 legnoarchitettura_06 sistemi
esterno
travi e pilastri_copertura
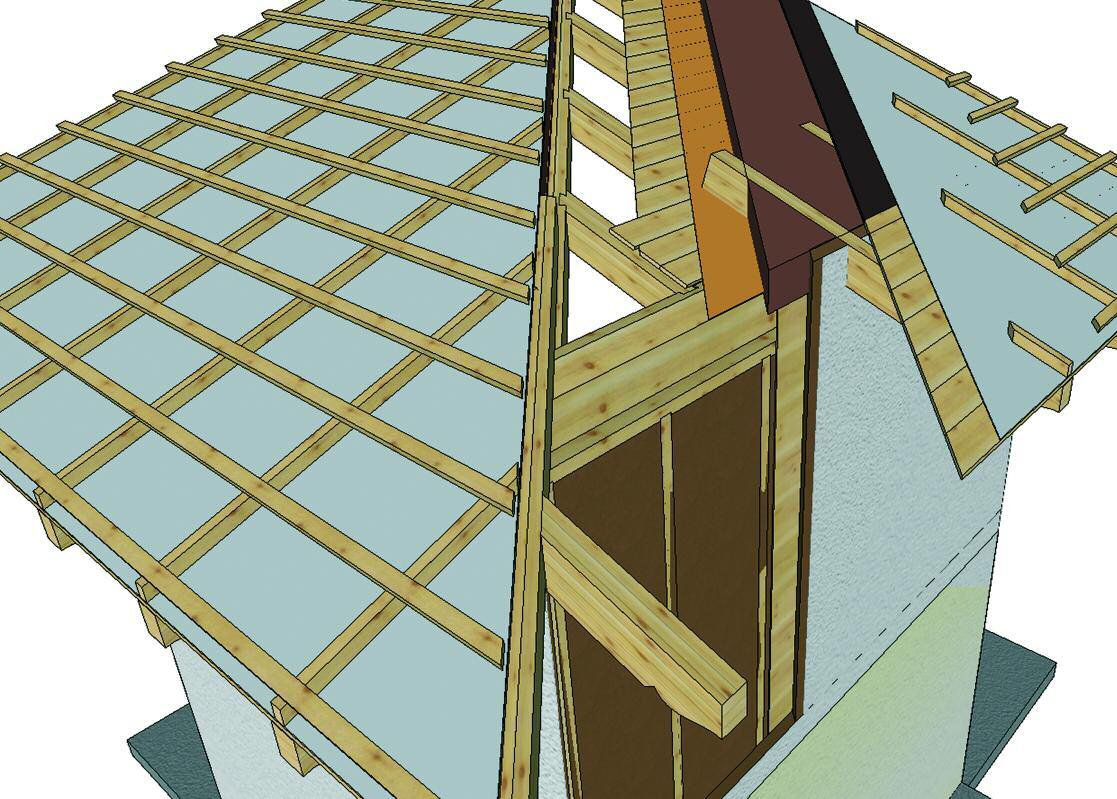
Stratigrafia struttura di copertura a travi portanti (dall’esterno)
-tegole
-listello porta tegole (40 mm)
- listello di ventilazione con punto chiodo (60 mm)
-telo traspirante di tenuta al vento con nastratura
- perlinatura in legno maschio-femmina e sporgenza di gronda (20 mm)
- struttura vin legno sporgenza di gronda
- isolamento in fibra di legno (380 mm)
-freno vapore con nastratura di tenuta all'aria
-perlinatura a incastro maschio femmina (20 mm)
-struttura portante interna
Dati fisico-tecnici
peso trasmittanza termica
sfasamento
riduzione dall’ampiezza di temperatura fattore di decremento

95 kg/m2
U = 0,11 W/m2K
h = 23
r.a.t. = 0,1
f = Udyn/U = 0,03
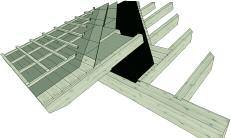
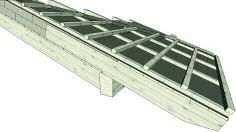

101
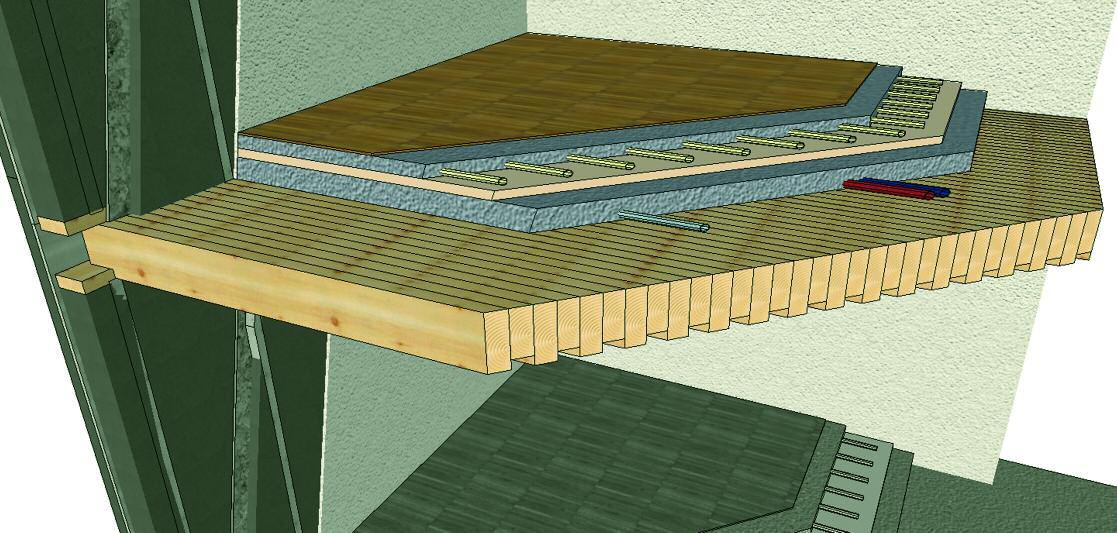
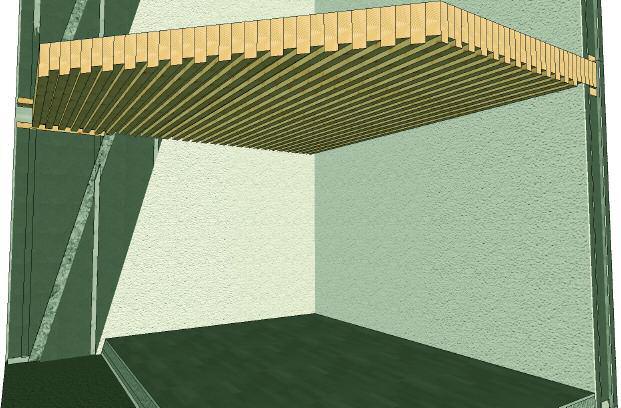
Il nodo parete-solaio
La connessione del solaio tipo Brettstapel alla parete portante esterna a telaio avviene sagomando la piastra del solaio per formare un dente dello spessore del telaio stesso. Grazie alla sagomatura il solaio appoggia al traverso/banchina della parete. Al di sopra del solaio viene montata la parete del piano superiore.
Stratigrafia del solaio interpiano con struttura portante Brettstapel (dall’estradosso)
- struttura portante abete Brettstapel(200 mm)
-barriera vapore
-granulato di marmo/impianti (150 mm)
-pannello OSB (15 mm)
-pannello radiante/fibra di legno (40 mm)
- massetto autolivellante (60 mm);
- pavimento
Dati fisico-tecnici
peso
trasmittanza termica sfasamento
riduzione dall’ampiezza di temperatura fattore di decremento
280 kg/m2
U = 0,27 W/m2K
h = 20
r.a.t. = 0,2
f = Udyn/U = 0,02
102 legnoarchitettura_06 sistemi
travi e pilastri_solaio
travi e pilastri_solaio
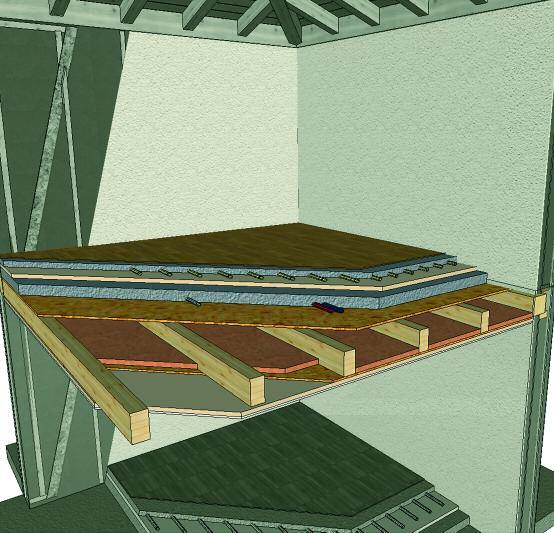
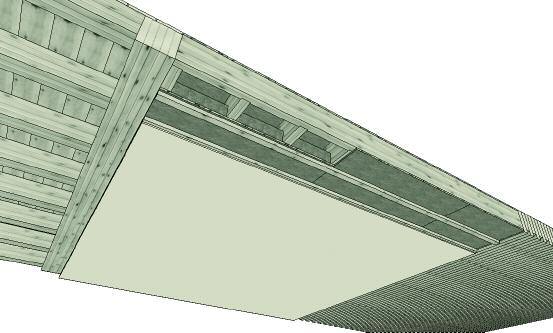


Stratigrafia del solaio verso vano non riscaldato (dall’estradosso)
- pavimentazione (15 mm)
-massetto radiante (60 mm)
-coibentazione in fibra di legno 230 kg/m3 (40 mm)
-15 OSB (15 mm)
-massetto impianti in granuli di perlite (100 mm)
-15 OSB (15 mm)
- struttura portante (200 mm), a interasse di 312 mm coibentazione in fibra di legno mm 200
-15 OSB (15 mm)
- coibentazione in fibra di legno 70 kg/m3 (60 mm)
-lastra gesso fibra
Dati fisico-tecnici
peso
trasmittanza termica sfasamento
riduzione dall’ampiezza di temperatura fattore di decremento
103
167 kg/m2 U = 0,11 W/m2K h = 22,4 r.a.t. = 0,1 f = Udyn/U = 0,03
dettagli tetto pianoparete esterna
elementi massicci uniti con viti di faggio
tavole orizzontali, verticali e diagonali unite a strato – con travetti portanti interni – con viti di legno senza colle e parti metalliche
travi e montanti
elementi portanti lineari in legno con tamponamenti piani leggeri di irrigidimento
mattoni in legno
elementi modulari cavi di legno massiccio affiancati e sovrapposti a incastro mediante spine di accoppiamento e incastri a tenone e mortasa
pannelli portanti
legno massiccio a strati incrociati e incollati connessi con giunto a pettine
pannelli multistrato
pannelli multistrato composti da tavole di legno massiccio, incollate a strati incrociati, montabili anche a secco grazie a un sistema a incastro
elementi massicci modulari
elementi modulari portanti verticali e orizzontali in legno massiccio a strati incollati combinati in maniera diversa a seconda delle necessità architettoniche e impiantistiche
elementi massicci uniti con viti di faggio
1 travetti portanti sagomati in modo da ridurre il loro spessore verso l’esterno
2 rivestimento in tavole di legno (2 cm)
3 lamiera forata antinsetti per areazione
4 nastro adesivo per tenuta all’aria
Stratigrafia copertura (dall’esterno all’interno):
- strato di ghiaia
- guaina impermeabile
- tavolato grezzo (2 cm)
- spazio di areazione (h=4 cm) con listelli
- guaina traspirante al vapore e impermeabile all’acqua
- isolamento termico in fibra di legno (20 cm) maschio/femmina
- barriera al vento
- solaio a piastra piena in legno massiccio (25 cm)
- intercapedine impianti
- controsoffitto con sistema capillare di riscaldamento /raffrescamento
Uparete = 0,130 W/m2K
Utetto = 0,125 W/m2K
Da sinistra: la posa di una piastra del solaio di copertura; il solaio dall’intradosso con la struttura portante a vista; il solaio con i fori per le canne fumarie
Disegno e foto: CasaSalute srl, Bolzano
I correnti esterni sagomati sono ancorati alla struttura portante in legno massiccio mediante viti Torx; lo stesso tipo di vite è utilizzato anche per fissare il solaio alla parete portante esterna Tra i correnti, sopra il solaio, l’isolamento in fibra di legno si raccorda con la coibentazione perimetrale, evitando in tal modo la formazione di ponti termici
Una camera di areazione con listelli permette la ventilazione dell’intero pacchetto di copertura Nastri adesivi, guaine traspiranti al vapore e impermeabili all’acqua e barriere al vento consentono un’ottima tenuta all’aria dell’involucro



106 legnoarchitettura 06 dettagli 2 1
appoggio, ancoraggio
4 3
1 telo traspirante
2 modulo cappello
mattoni in legno
3 parete con modulo Steko®
Stratigrafia copertura (dall’estradosso):
- manto di copertura su listelli di legno
- sottostruttura e camera di ventilazione
- guaina impermeabile all’acqua e permeabile al vapore
- tavolato grezzo
- isolamento tra la struttura portante
- struttura portante in travi di legno
- barriera al vento
- tavolato a faccia vista fissato su listelli di ancoraggio in legno
Stratigrafia parete (dall’esterno all’interno):
- rivestimento esterno in doghe di legno
- camera di ventilazione verticale con sottostruttura in listello
- isolamento esterno (densità > 60 kg/m3)
- carta cellulosa rinforzata con fibre di vetro (sd < 0,12 m)
- parete in mattoni di legno
- pannello di finitura interna in terra cruda
Da sinistra: uno dei moduli prefabbricati della struttura portante del tetto durante la posa in cantiere; l’intradosso di una copertura piana non ancora finita; l’intradosso di una copertura piana in cui si vede una trave rompitratta in acciaio
Disegno e foto:
Steko Holzbausysteme AG, Svizzera
Valori prestazionali tipo per la parete:
U = 0,15 W/m2K
Rw = 45 dB
REI = 30-90
In questo dettaglio del bordo di testa sono evidenti alcune particolarità del sistema costruttivo Steko® Innanzi tutto la parte terminale della parete esterna, il modulo cappello, di altezza minore rispetto al modulo base, il telo traspirante tra la struttura portante (parete e travi del solaio) che deve essere posto in opera durante le fasi di montaggio e l’isolamento che si raccorda con la coibentazione della copertura La tenuta all’aria e all’acqua del tetto è garantita da teli impermeabili all’acqua ma permeabili al vapore, mentre non sono previsti correnti o travi sagomate a formare lo sporto di gronda esterno



107
ancoraggio
3 2 1
travi e montanti
1 lamiera di protezione
2 traverso di appoggio del solaio di copertura
3 pannello OSB
Stratigrafia copertura (dall’interno):
- pannello cartongesso (12,5 mm) stuccato e pitturato liscio
- profilo metallico (40 mm)
- pannello OSB/3 (15 mm)
- guaina freno vapore variabile (sd ≈ 0,25-10,0 m)
- telaio in legno (100x280 mm) con isolamento in fibra di legno da 50 kg/m2 (280 mm)
- pannello OSB (18 mm)
- guaina impermeabile a diffusione aperta
- isolamento XPS in pendenza (60 mm)
- guaina PVC
Stratigrafia parete portante (dall’interno):
- pannelli fibrogesso (2x12,5 mm) stuccati e pitturati lisci
- listellatura per impianti + materassino in fibra di legno flessibile (60 mm)
- pannello OSB/3 (15 mm)
- telaio in legno (60x140 mm) con isolamento termico in fibra di legno da 50 kg/m2 (140 mm)
- tavolato grezzo di abete posto in diagonale (25 mm)
- pannello portaintonaco in lana di legno (40 mm)
- intonaco traspirante e idrorepellente (8 mm)
Dettagli della copertura piana
Disegno e foto:
Lignoalp, marchio registrato della DAMIANI-HOLZ&KO S p A , Bressanone (BZ), Nova Ponente (BZ)
La connessione della struttura della copertura a travi portanti alla parete avviene tramite appoggio del solaio sull’apposito traverso e fissaggio con viti Torx In corrispondenza della parete esterna, il solaio è chiuso da un pannello in OSB (vedi n 3 nel disegno) che garantisce la tenuta all’aria oltre a svolgere la funzione di barriera al vapore Entrambi gli elementi prefabbricati richiedono grande attenzione nella posa e nell’assemblaggio in cantiere



108 legnoarchitettura 06 dettagli
appoggio, ancoraggio
1 2 3
1 lamiera di protezione
2 isolante XPS
pannelli portanti
3 isolante in fibra di legno
4 trave secondaria della copertura
5 trave portante della struttura della copertura
Stratigrafia copertura (dall’esterno):
- finitura con piastre in cls
- strato d’aria di separazione
- strato isolante in XPS
- guaina bituminosa doppia
- massetto in cls alleggerito
- strato di pendenza
- massetto collaborante in cls
- strato isolante in fibra di legno
- finitura in intonaco
Stratigrafia parete portante (dall’interno):
- finitura interna in intonaco
- isolamento in lana di roccia
- pannello portante in abete
- triplo strato di isolante in fibra di legno
- finitura esterna con intonaco armato su pannello in legnocemento
Nelle prime due immagini è ben evidente il grande isolamento che avvolge la struttura portante in legno con l’unica differenza che, sul tetto vero e proprio, l’isolamento è di tipo sintetico mentre il cappotto è realizzato con più strati di fibra di legno; nel caso di uno sporto ampio del tetto, è necessario fare particolare attenzione
a non creare soluzioni di continuità nella posa dell’isolante
Disegno e foto: Natural Building, San Biagio di Callalta (TV)
Nel dettaglio del disegno è evidenziato l’appoggio del solaio in cls alla parte in X-lam Nelle foto sottostanti si individua un altro sistema: il fissaggio dei due elementi avviene tramite appoggio delle travi portanti del pacchetto di copertura alla parete Al fine di ottenere un involucro quanto più possibile ermetico, anche lo sporto del tetto è coibentato ponendo attenzione al tipo di materiale isolante laddove si presuppone una possibile presenza di umidità, in questo caso è stato utilizzato XPS



109
appoggio, ancoraggio
1 2 2 3
3
4 5
pannelli multistrato
1 parapetto in acciaio verniciato
2 rasatura superficiale
3 schermature solari scorrevoli
Stratigrafia copertura (dall’estradosso):
- guaina poliolefinica
- massetto per pendenza
- guaina impermeabile
- schiuma polyiso rigida a celle chiuse
- pannello multistrato strutturale
Stratigrafia parete (dall’esterno):
- rasatura
- isolamento termico a cappotto
- pannello portante in legno massiccio a strati incrociati BBS (17 cm)
- isolamento
- finitura
Da sinistra: la posa in cantiere di uno degli elementi portanti; la struttura portante del tetto piano in fase di fissaggio alla parete in legno
Disegno e foto: Wood Beton spa, Iseo (BS)
La copertura realizzata con sistema BBS (Binder-Brettsperrholz), composto interamente da legno massiccio in strati sovrapposti a fibratura incrociata, appoggia direttamente sulla parete portante e viene fissata mediante staffe metalliche e viti autoforanti Nel disegno riportato in questa pagina la copertura forma uno sporto importante a coprire la terrazza del piano sottostante Sulla copertura, calpestabile, è previsto un parapetto fissato con una vite autofilettante che penetra quasi per l’intero spessore del pannello La schermatura solare scorrevole del terrazzo è ancorata superiormente al pannello portante in legno, isolato a sua volta per l’intera lunghezza, impedendo così la formazione di ponti termici


110 legnoarchitettura 06 dettagli
ancoraggio
1
2 3
elementi massicci modulari
1 Elemento di finitura
2 Elemento BLOCK Q3 Lignotrend® riempito con fiocchi di cellulosa
3 tavola di giunzione
Stratigrafia parete (dall’esterno):
- intonaco (10 mm)
- fibra di legno (20 mm)
- fibra di legno (60+60 mm)
- telo permeabile al vapore
- parete in legno Fux 4s Lignotrend® (90 mm)
- pannelli in gesso-fibra (18 mm)
Stratigrafia copertura (dall’estradosso):
- massetto e pavimento
- strato di separazione e scorrimento
- membrana in PVC
- strato di separazione geotessile
- fibra di legno resistente alla compressione (40+40 mm)
- freno al vapore
- elemento portante BLOCK Q3 Lignotrend® riempito con fiocchi di cellulosa
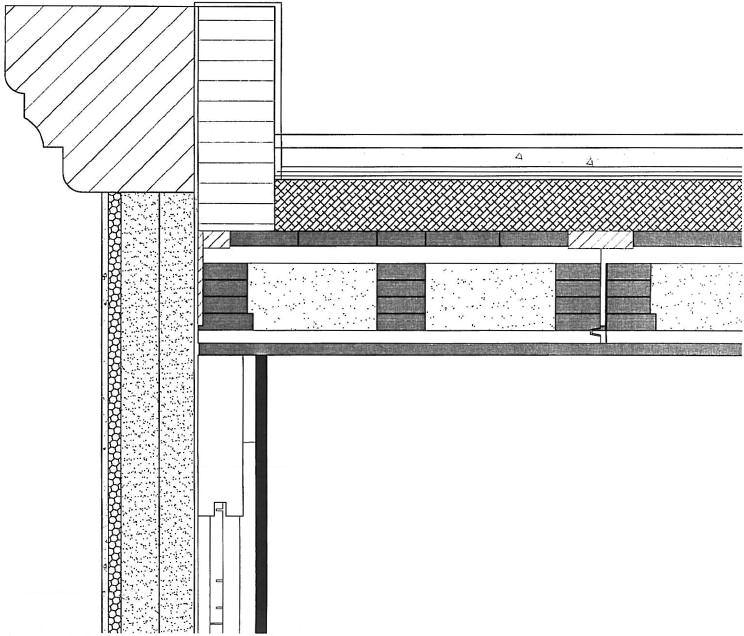
Da sinistra: le prime due immagini mostrano la posa in cantiere del solaio di copertura, prefabbricato, che verrà posizionato sulle pareti come da progetto; nell’ultima fotografia si sta effettuando il fissaggio della tavola di collegamento tra un elemento e l’altro del solaio.
Disegno e fotografie:
Adria Legno Service S r l , Morciano di Romagna (RN)
Il solaio di copertura è un elemento di legno massiccio composto da strati di tavole di abete parallele e/o incrociate, distanziate e incollate Il lato a vista è costituito, a seconda del tipo, da due o tre strati di tavole, il cui strato centrale si articola su traversi paralleli, tra i quali trova posto l’isolamento in fiocchi di cellulosa L’elemento modulare del solaio così descritto viene collegato all’altro attraverso una tavola di collegamento o giunzione, così come evidenziato nel disegno Il solaio viene poi fissato alla parete portante grazie a viti da legno opportunamente dimensionate La parete è realizzata in blocchi tavolari di legno massiccio composta da strati di tavole parallele e/o incrociate, distanziate e incollate con possibilità di posa di impianti elettrici al suo interno



111
appoggio, ancoraggio
1 23



Bamboo House
The Oval Partnership Ltd
Espoir Damien Carnoy
Monastero Jensen&Scodvin Architects
Casa Ceschi traverso-vighy architetti

07 next F o o e n s e n & S c o d v i n A r c h i e c t s F o t o D a m e n C a r n o y F o o T h e O v a l P a r n e s h p L d F o t o t a v e s ov i g h y a c h e t










 Foto: Nome Cognome
Foto: Nome Cognome















 Edoardo Milesi
Monastero di Siloe
Poggi del Sasso
Edoardo Milesi
Monastero di Siloe
Poggi del Sasso



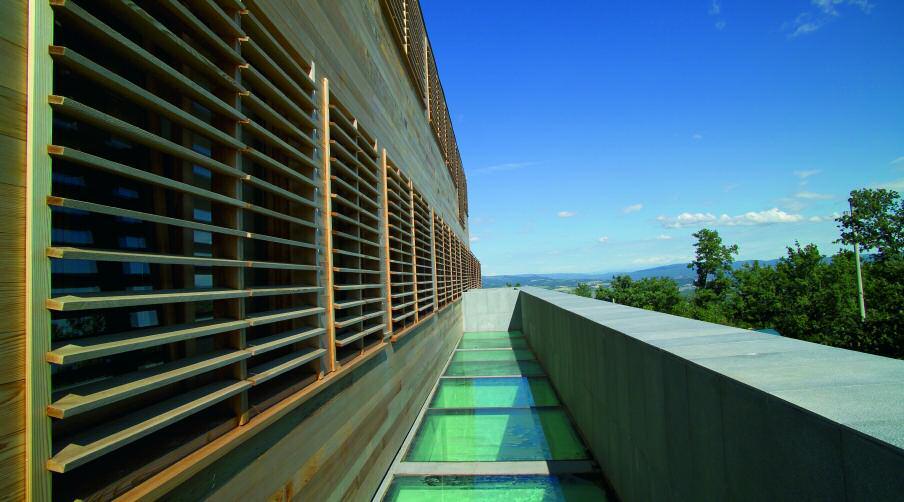








 pianta della chiesa processionale
pianta della chiesa processionale
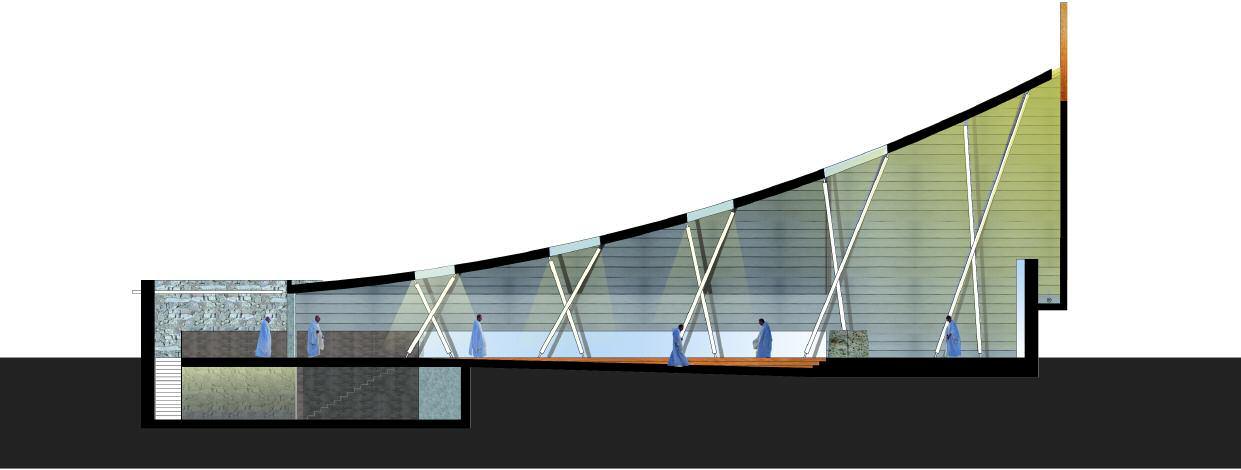





















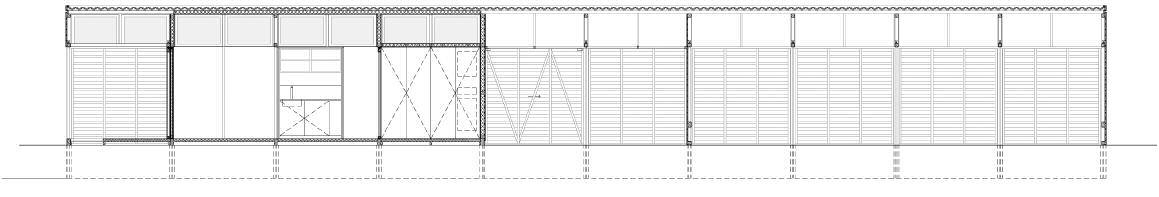





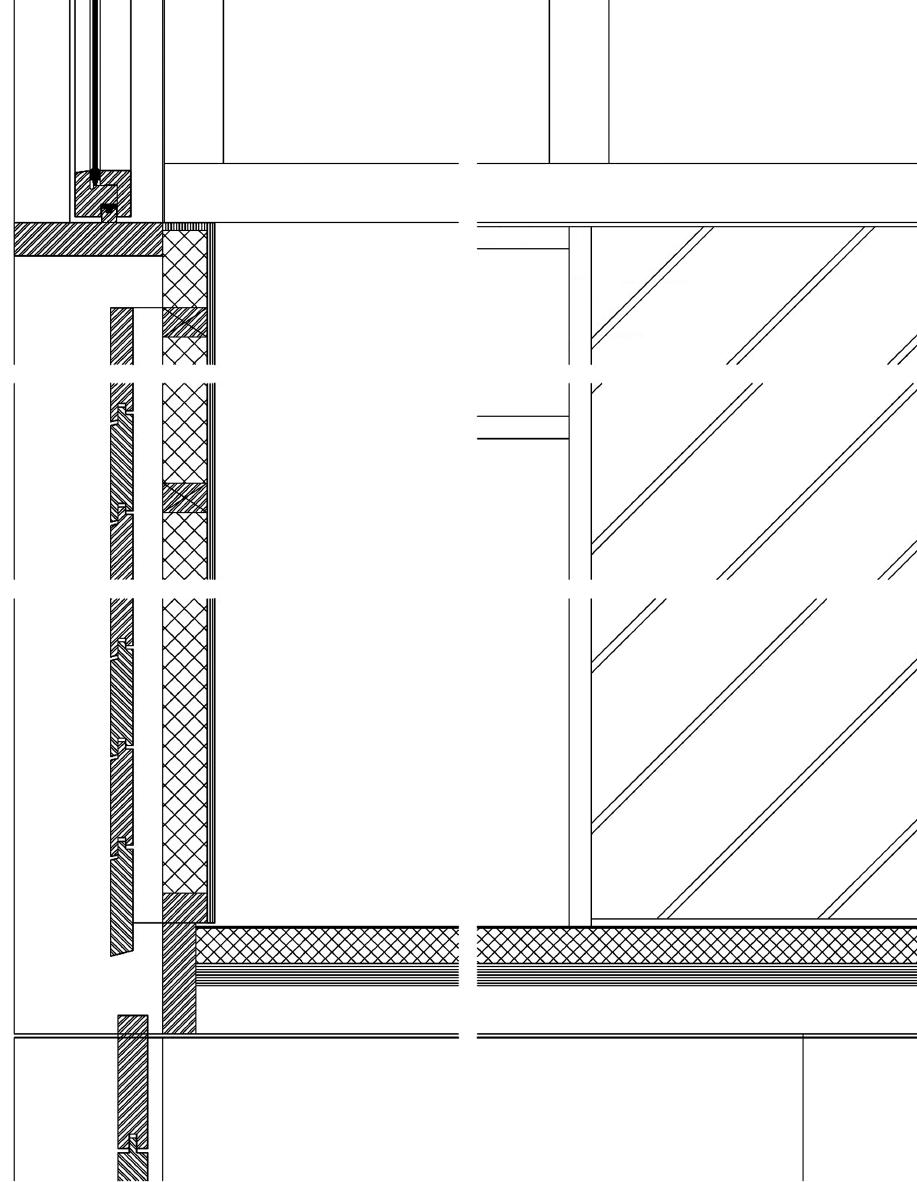

































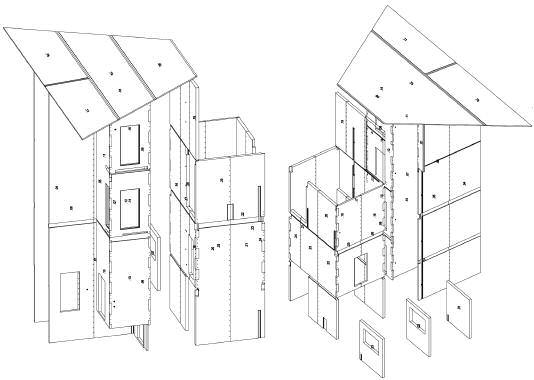
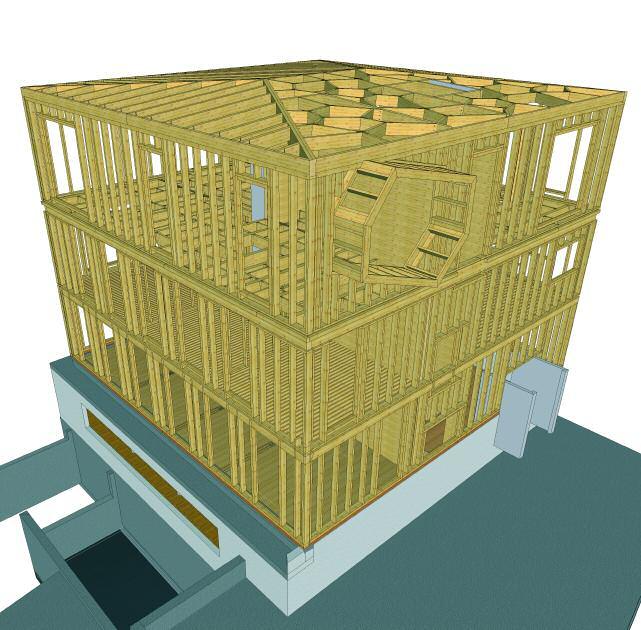

















 _4
_5
_4
_5






















 Karawitz Architecture
Casa Damico
Vallée de Chevreuse (F)
Karawitz Architecture
Casa Damico
Vallée de Chevreuse (F)