

FOTOVOLTAICO INTEGRATO
SCHERMATURE: il controllo solare attraverso le chiusure trasparenti

Risanamento a emissioni zero
Ottimiz zazione energetica di un edificio storico


Autarchia energetica sul Monte Bianco
Progettare un inter vento di riqualificazione

Un diamante in classe oro
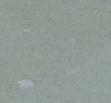




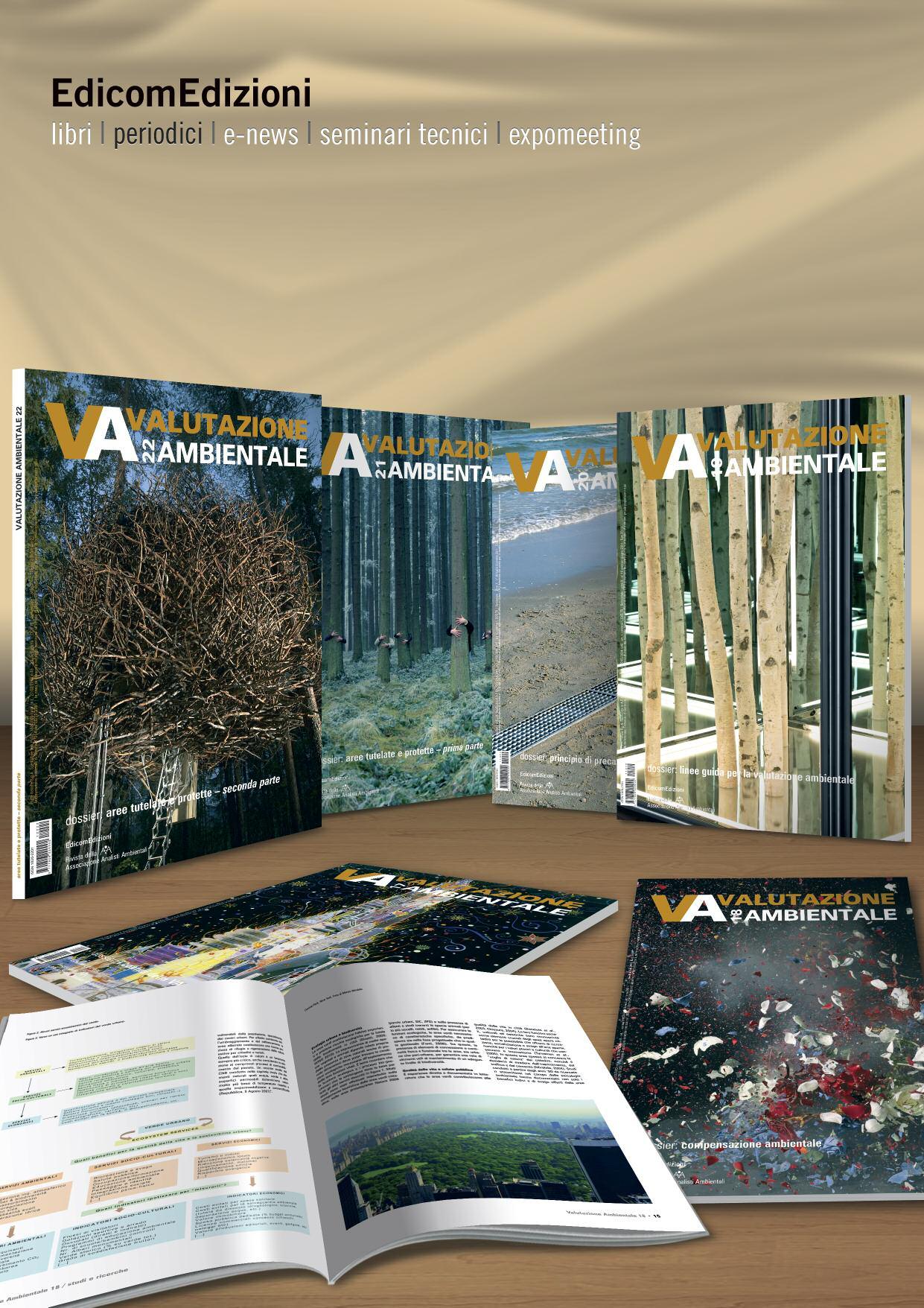
EdicomEdizioni




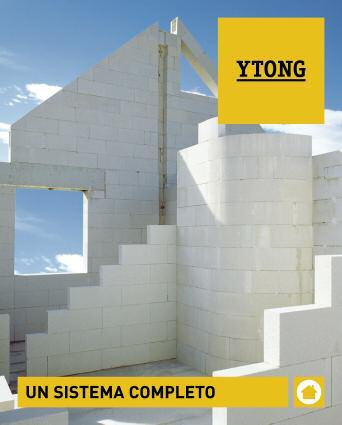


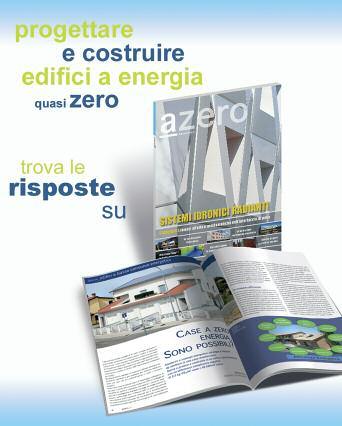


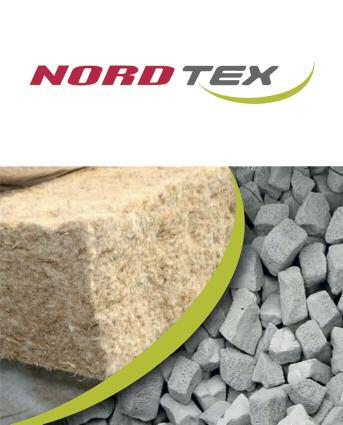






IL RAPPORTO ENEA SULL’EFFICIENZA ENERGETICA 2011
Lara Bassi, in collaborazione con ENEA SPOT PROGETTI
INTERVISTA A RINO ROMANI
UN DIAMANTE IN CLASSE ORO casa unifamiliare a Rovereto (TN)
OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO DEL XVI SECOLO casa storica a Glorenza (BZ)
AUTARCHIA ENERGETICA IN ALTA QUOTA rifugio alpino a Saint-Gervais (F)
RITORNO AL FUTURO. UN RISANAMENTO A EMISSIONI ZERO casa plurifamiliare a Südstadt-Hattingen (D)
24 | 30 | 38



azero - rivista trimestrale - anno 3 - n 07, aprile 2013
Registrazione Tribunale Gorizia n 03/2011 del 29 7 2011
Numero di iscrizione al ROC: 8147
ISSN 2239-9445
direttore responsabile: Ferdinando Gottard
redazione: Lara Bassi, Lara Gariup, Gaia Bollini
editore: EdicomEdizioni, Monfalcone (GO) redazione e amministrazione: via 1° Maggio 117, 34074 Monfalcone (GO) tel 0481 484488, fax 0481 485721
stampa: Grafiche Manzanesi, Manzano (UD)
Stampato interamente su carta con alto contenuto di fibre riciclate selezionate prezzo di copertina 15,00 euro - abbonamento 4 numeri - Italia: 50,00 euro, Estero: 100,00 euro Gli abbonamenti possono iniziare, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile in qualsiasi periodo dell’anno distribuzione in libreria: Joo Distribuzione, Via F Argelati 35 – Milano È vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli, disegni e foto se non espressamente autorizzata dall’editore
copertina: Efficiency House with electromobility a Berlino, foto: Schwarz




PROGETTARE UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
Gaia Bollini
Guglielmina Mutani, Luca Raimondo
L’INTEGRAZIONE DEL FOTOVOLTAICO. VERSO NUOVE FRONTIERE Pierluigi Bonomo, Pierluigi De Berardinis FOTOVOLTAICO IL


DETTAGLI DI CANTIERE: CA’ DELLA LUNA
ENEA 2011
Lara Bassi in collaborazione con ENEA
Il rapporto ENEA sull’efficienza energetica 2011
Il secondo rapporto sull’efficienza energetica predisposto dall’ENEA fotografa un’Italia in netto miglioramento sul fronte del risparmio energetico: 57.595 GWh/anno di risparmio conseguito (+17,1% rispetto al 2010) fanno ben sperare per il futuro energetico del nostro Paese.
Presentato a Roma lo scorso gennaio presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il secondo “Rapporto sull’Efficienza Energetica”, redatto dall’Enea quale agenzia nazionale per l’efficienza energetica. Il rapporto riporta i risultati del monitoraggio e della valutazione delle politiche energetiche nazionali relativamente all’anno 2011, mettendo in luce risultati incoraggianti e miglioramenti concreti in vista del raggiungimento degli obiettivi comunitari fissati per il 2020 Il rapporto 2011 ha aggiornato il precedente quadro, analizzando l’evoluzione dell’efficienza energetica complessiva nei singoli settori (industria, residenziale e non residenziale, trasporti e agricoltura) e la validità delle politiche adottate alla luce dei risultati ottenuti
Nel 2011 la domanda di energia primaria nel nostro Paese ha segnato un calo dell’1,9% rispetto al 2010, contrazione dovuta a diversi fattori quali le condizioni climatiche più miti, l’applicazione di politiche energetiche mirate e, non da ultimo, il perdurare della crisi economica La riduzione della domanda di energia ha interessato le fonti energetiche del petrolio e del gas, dato che conferma la specificità italiana rispetto agli altri paesi comunitari, nell’uso di combustibili fossili e nell’import strutturale di energia elettrica a fronte di uno scarso utilizzo del carbone e del mancato ricorso alla fonte nucleare (vedi grafico 1).
Anche l’impiego finale dell’energia ha subito una riduzione del 2,65% rispetto all’anno precedente con una forte incidenza di quello relativo agli usi civili (vedi grafico 2)
In questo articolo si prenderanno in considerazione il settore Residenziale, quello Non Residenziale e gli incentivi e le strategie adottate in tali ambiti al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico
Efficienza energetica: la Strategia energetica nazionale e gli obiettivi
Nel 2011 sono stati attivati alcuni strumenti e meccanismi incentivanti in materia di efficienza energetica, quali:
- PAEE 2011, il Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica, stabilito dalla Direttiva 2006/32/CE1 che rinnova l’obiettivo di risparmio a medio termine (9,6% entro il 2016);
- D L n 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n 210 il 22 dicembre che conferma le detrazioni fiscali per il 2012 (55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, 36% dal 2013);
- D M del 5 settembre 2011, che disciplina il nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR);
- D Lgs n 28 del 3 marzo 2011 che, in materia di efficienza energetica prevede, in particolare, la realizzazione di un
portale informatico per l’efficienza energetica, l’attivazione di un programma di formazione per installatori e manutentori d’impianti termici, l’avvio di un nuovo meccanismo d’incentivazione per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni
Questi strumenti nascono con lo scopo di:
- superare gli obiettivi europei al 2020;
- perseguire il miglioramento del sistema energetico in Italia e all’estero;
- risparmiare 20 Mtep di energia primaria e 15 Mtep di energia finale per conseguire un livello di consumi inferiore al 25% al 2020 rispetto allo scenario di riferimento europeo;
- evitare di circa 55 milioni di tonnellate le emissioni di CO2;
- risparmiare circa 8 miliardi di euro l’anno di importazioni di combustibili fossili
L’efficienza energetica
I singoli settori (industria, residenziale e non residenziale, trasporti e agricoltura) hanno contribuito in modo differente all’ottenimento del miglioramento dell’efficienza energetica rispetto al 2010 (+1,2 punti percentuali); nel 2011 il consumo finale di energia è stato pari a 128,1 Mtep; di questo il calore (uso finale per riscaldamento e raffrescamento) rappresenta il 45% della quota totale (vedi grafico 3 e tabella sottostante)
Il settore dei trasporti è il comparto che genera i consumi più alti (32%), seguito dall’industria (26%), dal residenziale (23%) e dai servizi (13%); il 2% circa è imputabile agli utilizzi della Pubblica Amministrazione Tenuto conto dell’incidenza di ciascun settore nella riduzione dei consumi finali di energia, il PAEE ha evidenziato che i 2/3 del potenziale risparmio sono dipendenti dal settore residenziale e terziario; quindi, si può affermare che:
- il calore è la tipologia d’uso dell’energia su cui intervenire prioritariamente per ottenere reali miglioramenti dell’efficienza energetica;
- è necessaria una strategia di intervento mirata alla riduzione dei consumi nel settore dei trasporti (evitare/ridurre la formazione di domanda; favorire modi di trasporto meno energivori; migliorare l’efficienza del veicolo in termini di sistemi, componenti e di stili di guida più efficienti);
- si devono adottare tecnologie e comportamenti consapevoli, per migliorare l’efficienza energetica e per ridurre i consumi energetici
Il settore Residenziale
Nel 2010 si è registrato un consumo energetico nel settore residenziale pari a 28 Mtep con un incremento dell’8,3% rispetto al 2009 (vedi grafico 4) e con un aumento del 9% nel consumo
di gas naturale, del 52% della legna e dello 0,9% di energia elettrica, mentre le altre fonti di energia hanno subito una riduzione nel consumo
Il maggiore impiego di gas naturale trova riscontro in parte nell’andamento climatico, in parte nella dotazione di impianti di condizionamento invernale in unità immobiliari che ne erano sprovviste, in parte nella sostituzione dei boiler elettrici e anche in un fattore comportamentale che vede famiglie formate da soggetti sempre più anziani e quindi con richieste di temperature di esercizio degli impianti di riscaldamento maggiori a quanto previsto dallo standard normativo
Nel settore residenziale, in termini di energia finale e di composizione di fonti energetiche, si è rilevato che:
- è predominante l’uso di gas naturale per la produzione di calore, di ACS e per uso cucina (dal 44,7% del 1990 al 54% del 2010);
- l’energia elettrica è la seconda fonte per approvvigionamento energetico (dal 18% del 1990 al 22% del 2010);
- l’utilizzo di gas naturale e di energia elettrica è fortemente aumentato, passando dal 62% del 1990 al 76% del 2010;
- il legname (pellet, legna da ardere, cippato ecc ) ha visto un incremento notevole passando dal 2,6 % del 1990 all’11,6% del 2010, superando il GPL (stabile nel periodo 1990-2010 al 4%) e il gasolio (6% e in netto calo nel periodo di rilevamento)
Dall’analisi emerge inoltre che il riscaldamento copre oltre i 2/3 dei consumi complessivi e che, stabile nel tempo, nel 2010 era pari al 68% Il consumo per uso cucina è passato dal 7% al 6%; quello per la produzione di acqua calda sanitaria è diminuito dall’11 al 9%, mentre l’utilizzo di energia elettrica per gli usi “obbligati” è aumentato, dal 13 al 17% (vedi grafico 5) Rispetto al 2000, nel 2010 per ogni abitazione in Italia si nota una riduzione dei consumi di energia dell’8,3%, variazione inferiore al corrispettivo valore della media dei 27 Paesi membri UE e a quelli ottenuti da Germania, Francia e Regno Unito La riduzione dell’uso di energia elettrica per abitazione è stata di poco superiore al 4% (6% media europea) dovuta principalmente alla sostituzione di apparecchi elettrici più efficienti da parte dei consumatori Non si può altrettanto dire per l’utilizzo termico delle abitazioni, diminuito di certo, ma in misura molto minore se comparato a quanto si è verificato negli altri paesi europei (vedi grafico 6)
Il settore Non Residenziale
Edifici adibiti ai servizi, al commercio e alla Pubblica Amministrazione sono compresi nel settore Non Residenziale, i cui consumi sono in forte crescita (da meno di 9,5 Mtep del 1995 a oltre 20 Mtep nel 2010, con un incremento medio annuo pari al 3,4%) In questo ambito è evidente una differente distribuzione
4 - Consumo energetico del settore residenziale, periodo 1990-2010 (ktep) - Fonte: elaborazione ENEA su dati MSE
5 - Confronto consumi per uso nel settore residenziale nel periodo 1990-2010 - Fonte: elaborazione ENEA su dati MSE.
6 - Variazione consumo totale, elettrico e del riscaldamento per abitazione (2000-2010)Fonte: elaborazione ENEA su dati ODYSSEE
7 - Confronto consumi specifici edifici terziario per diverse destinazioni d’uso
Energia elettrica Legna Carbone
combustibile
Consumo totale/ab.
Consumo riscald./ab.
Consumo en el./ab.
delle fonti energetiche rispetto al comparto residenziale, in quanto si utilizzano principalmente gas (50,4%) ed energia elettrica (5,4%) con una progressione considerevole tra il 1990 e il 2007, passando dall’81,9% (45,6% il gas naturale e 36,3% l’energia elettrica) al 95,8% dei consumi energetici complessivi Marginali sono gli impieghi del GPL (2,5%) e del gasolio (1,0%)
Recenti studi sviluppati da ENEA e CRESME hanno reso possibile effettuare una stima sugli usi specifici nel terziario per le diverse destinazioni d’uso e sviluppare una metodologia atta a determinare i risparmi energetici ottenibili, considerando le operazioni di ottimizzazione secondo un rapporto costo-beneficio Ad esempio, è possibile ridurre in maniera significativa i consumi energetici nel terziario e i costi relativi agli interventi, effettuando atti di efficientamento in concomitanza con provvedimenti necessari di manutenzione straordinaria Se, oltre a ciò, si tiene conto anche della possibilità di utilizzare una procedura che implichi la partecipazione di una ESCo, gli interventi diventano realmente fattibili dal punto di vista finanziario
Infine, la recente Direttiva 2012/27/UE impone agli stati membri di riqualificare energeticamente gli edifici pubblici dell’Amministrazione Centrale per una percentuale prestabilita ogni anno; data la difficile congiuntura economica, un approccio come quello sopra ipotizzato può essere promosso con misure e accorgimenti che ne semplifichino l’azione (vedi grafico 7).
Risparmi energetici conseguiti dal recepimento della Direttiva 2002/91/CE e attuazione del d lgs 192/05 - (GWh/anno) –Italia
Risparmi energetici conseguiti dal recepimento della Direttiva 2002/91/CE e attuazione del d lgs 192/05- (GWh/anno) per macro-aree geografiche
Le tecnologie che possono dare un significativo contributo alla riduzione dei consumi riguardano in particolare:
- l’impiantistica ad alta efficienza, come caldaie a condensazione, impianti di micro-cogenerazione, pompe di calore a compressione e ad assorbimento, sistemi integrati con le fonti rinnovabili ecc ;
- materiali e prodotti per ridurre le dispersioni energetiche delle tubazioni degli impianti termici o per un miglior rendimento della diffusione finale del calore;
- materiali strutturali e non per l’isolamento termico degli edifici;
- prodotti e sistemi per il contenimento delle dispersioni e degli assorbimenti di calore come, ad esempio, serramenti ad alte prestazioni termiche, vetri a controllo solare, schermature solari esterne mobili;
- tecnologie e sistemi innovativi, quali i sistemi domotici, involucri attivi, solar cooling, smart building, cogenerazione
Obiettivi nazionali di risparmio energetico
Il PAEE 2011 ha previsto una serie di strumenti per migliorare l’efficienza energetica e i servizi energetici nei settori di uso finale per un risparmio energetico annuale al 2016 di 126 327
GWh/anno L’analisi quantitativa dei risparmi realmente conseguiti al 31 dicembre 2011 è stata effettuata facendo riferimento a2:
- recepimento della Direttiva 2002/91/CE e attuazione del D Lgs 192/2005 (standard minimi di prestazione energetica degli edifici);
- detrazioni fiscali (55%) per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- meccanismo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi);
- misure di incentivazione per il rinnovo ecosostenibile del parco autovetture e autocarri fino a 3,5 tonnellate
Consideriamo sinteticamente gli effetti di ciascuna delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica elencate
D.Lgs. 192/2005
Il Decreto ha apportato forti novità rispetto al quadro legislativo preesistente, in particolare nella metodologia progettuale, nelle prescrizioni minime (Standard minimi di prestazione energetica), nell’ispezione degli impianti, nonché nell’introduzione della certificazione energetica degli edifici Le tabelle a pag. 7 riassumono rispettivamente i risparmi energetici per gli anni 2005-2011, ottenuti grazie agli interventi realizzati nell’ambito di questa misura per l’intero territorio nazionale e per macro-aree geografiche (vedi grafico 8)
Le aree del Nord-Est e Nord-Ovest comprendono interventi per una quota complessiva di oltre il 55% del risparmio totale nazionale
Detrazioni fiscali (55%)
In vigore dal 1° gennaio 2007, l’incentivo consiste in una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o delle società (IRES), stabilito in base alla Legge 27 dicembre 2006 n 296 (Finanziaria 2007) e successive
9 - Ripartizione per macro-aree geografiche delle attività sviluppate nell’ambito del meccanismo 55%
Nord-ovestNord-estCentroSudIsole
8 - Ripartizione dei risparmi per macro-aree geografiche.
ITALIA
Interventi
Interventi di riqualificazione globale
Coibentazioni superfici opache verticali
Coibentazioni superfici opache orizzontali
Sostituzione infissi
Sostituzione scalda acqua elettrici
Impiego di impianti di riscaldamento efficienti
Camini termici e caldaie a legna (caldaie a biomassa)
Selezione multipla
Totale
Risparmi energetici conseguiti dal riconoscimento delle detrazioni fiscali (55%) Italia.
Risparmio GWh/anno
Le detrazioni fiscali del 55%
I dati relativi agli investimenti effettuati all’interno del meccanismo di detrazione fiscale del 55% provengono dai rapporti ENEA e dalle banche dati collegate alle domande di incentivazione pervenute Per ciascuna regione è stato calcolato il valore degli investimenti complessivi per famiglia residente, utilizzando il numero medio di famiglie residenti per gli anni 2008, 2009, e 2010
Le principali indicazioni che è possibile trarre dall’analisi effettuata mostrano che gli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010 sono fortemente correlati alla capacità di spesa delle singole famiglie In generale, i gradi giorno influenzano in misura positiva il comportamento di investimento delle fa-
miglie; relazione questa che trova conferma nel minor investimento riscontrato nel sud Italia ma che si discosta dagli investimenti osservati per il solare termico, che avrebbero dovuto seguire un andamento collegato alla maggiore insolazione Le motivazioni alla base di questa “anomalia” sono probabilmente legate a una insufficiente disponibilità sul territorio di tecnologie, installatori e personale qualificato, nonché di campagne di informazione e promozione locali
Investimento totale per famiglia (nord-sud)
Costo totale Milioni di Euro
Valore totale degli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010, suddivisione per regione (milioni di Euro)
Valore medio degli investimenti effettuati per il triennio 2008-2010 per famiglia residente, suddivisi per Regione -
Investimento totale per famiglia
Nella tabella a pag 8 si riporta il risparmio energetico conseguito a livello nazionale, per gli anni 2007-2011, ripartito per tipologia di intervento
La ripartizione per macro-aree geografiche delle attività sviluppate nell’ambito di tale meccanismo evidenzia un netto predominio delle regioni del Nord con una quota del 78% del risparmio complessivo (vedi grafico 9)
I risparmi energetici conseguiti al 31 dicembre 2011 e gli obiettivi indicativi nazionali proposti nel PAEE 2011 per il 2016 sono mostrati nella tabella sottostante, dove nella seconda colonna si evidenziano i risparmi i risparmi energetici complessivi al 31 dicembre
Il grafico 10 mostra che il 72,5% del risparmio annuale conse-
Risparmio energetico annuale conseguito al 2011 - TOTALE [GWh/anno]
Risparmio energetico annuale atteso al 2016 [PAEE 2011] [GWh/anno]
Terziario
Industria
Trasporti
Totale
guito alla fine del 2011 è relativo a interventi effettuati nel settore degli edifici (Residenziale+Terziario), mentre gli interventi realizzati nel settore Industria e in quello dei Trasporti rappresentano rispettivamente il 18% e il 9,6% del risparmio complessivo
Note
1 - Direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/72/CEE del Consiglio
2 - Non si è, invece, tenuto conto dei risparmi derivanti dalla misura delle detrazioni fiscali (20%) per l’installazione di motori elettrici ad alta efficienza e di regolatori di frequenza (inverter), in ragione della loro esiguità
10 - Risparmio energetico annuale conseguito al 31 12 2011 –Ripartizione per settore di intervento
Residenziale
Terziario
Industria
Trasporti
argomenti Il futuro energetico dell’Italia

INTERVISTA A RINO ROMANI
COME VEDE IL FUTURO ENERGETICO IN ITALIA IN TERMINI DI CONSUMI?
SONO SUFFICIENTI LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E GLI STRUMENTI NORMATIVI PER INCENTIVARE PRIVATI E AZIENDE A INVESTIRE IN QUESTO SETTORE?
La nuova strategia energetica nazionale prevede un obiettivo di consumi finali di circa 126 Mtep al 2020 e l’efficienza energ e ti c a ra p p re s e n ta l o s tru m e n to p ri o ri ta ri o p e r ra g g i u n g e re tale obiettivo Per quanto riguarda le disposizioni di legge, si può affermare che sono tra le più efficienti in Europa anche se è auspicabile un incremento delle verifiche al fine di valutarne la loro applicazione ma soprattutto l’efficacia in termini di risultati prodotti Anche gli strumenti normativi e d’incentivazione degli interventi di efficientamento energetico, attualmente in vigore a livello nazionale, sembrano in grado di produrre gli effetti previsti come dimostrato dalla valutazione che a fine 2011 è stato raggiunto circa il 50% dell’obiettivo di risparmi atteso a fine 2016 (pari a circa 126 000 GWh/anno) Come risulta dall’ultimo rapporto annuale sull’efficienza energetica dell’ENEA, i meccanismi d’incentivazione che maggiormente hanno contribuito a raggiungere tale l’obiettivo sono stati:
Con l’ingegner Rino Romani, responsabile dell’Unità Tecnica sull’Efficienza Energetica (UTEE) dell’Enea, facciamo il punto sulla situazione dei consumi energetici nel nostro Paese, ipotizzando quali potranno essere gli scenari di sviluppo futuro relativamente al risparmio di energia, come richiesto dalle Direttive europee.
1) Per il settore privato e terziario lo strumento delle detrazioni fiscali del 55%, rivolte essenzialmente al settore delle ristrutturazioni civili Tale strumento ha prodotto risultati importanti sia in termini di coinvolgimento dell’utenza (più di 1 500 000 domande pervenute) che di risparmi energetici ottenuti Una sua estensione anche per i prossimi anni è auspicabile, rived e n d o , p o s s i b i l m e n t e , l ’ e n t i t à d e l l a p e r c e n t u a l e d i i n v e s t im e n t o d e t r a i b i l e p e r i s i n g o l i i n t e r v e n t i . I n a l t r e p a r o l e dovrebbero essere maggiormente incentivati gli interventi sugli involucri e quelli a edificio “pieno” piuttosto che interventi ef-

fettuati su singole parti dell’edificio stesso
2) Per il settore pubblico è stato recentemente “lanciato” il “conto termico” Tale strumento sarà operativo a breve e rappresenta per il settore pubblico un’opportunità interessante per efficientare dal punto di vista energetico il proprio parco edilizio Come ogni nuova misura, probabilmente, avrà bisogno di un certo rodaggio, di alcune revisioni e snellimenti procedurali ma rappresenterà certamente uno strumento molto valido per fare efficienza energetica in un settore ad alto potenziale di risparmio.
3) Per il settore industriale il meccanismo dei titoli di efficienza energetica, o certificati bianchi, è attualmente lo strumento più efficace È quello che negli ultimi anni ha contribuito maggiormente al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energ e ti c o , c h e l e d i r e t t i v e e u r o p e e i m p o n g o n o a l P a e s e , c o n i l miglior rapporto costi-benefici per le casse dello Stato Tale meccanismo è stato recentemente esteso fino al 2016 aggiornando gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia
QUANTO POTREBBE INFLUIRE IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE, IN PARTICOLARE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE, RELATIVAMENTE
AL RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE RESIDENZIALE NEL NOSTRO PAESE?
CHE RUOLO PUÒ AVERE IL RISANAMENTO DEL PARCO EDILIZIO ESISTENTE IN UN’OTTICA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI?
Il risanamento del parco edilizio esistente rappresenta un fattore determinante in un’ottica di contenimento dei consumi Non è un caso che la Commissione Europea abbia identificato in questo settore il “bacino di risparmio” più importante Si tenga conto che in uno studio della CE del 2010 il settore “civile”, residenziale e non residenziale, è quello che presenta il potenziale di risparmio più alto (41%) rispetto a quello dei trasporti (21%) e dell’industria (13%). Ed è anche per questo che non solo la direttiva 2010/31/CE ma anche la 2012/27/CE concentrano la loro attenzione proprio in questi settori, non soltanto per gli aspetti energeti ci ma anche per quelli non secondari e connessi con il rilancio dell’occupazione in un settore attualmente in difficoltà
La Direttiva 2010/31/UE meglio conosciuta tra gli addetti ai lavori come direttiva recast rappresenta un forte stimolo per il
Paese e al momento si sta lavorando per il suo recepimento
Prevediamo che possa contribuire fortemente a incrementare l’efficienza energetica nel settore residenziale poiché porterà nuovi e più stringenti standard prestazionali del sistema edificio-impianto e coinvolgerà direttamente anche l’utenza attraverso una serie di informazioni e indicazioni finalizzate ad evidenziare l’importanza degli interventi di efficienza e la loro efficacia in termini di riduzione dei consumi e del costo in “bolletta”
Altro aspetto importante è che da gennaio 2019 tutti gli edifici nuovi del settore pubblico dovranno essere Nearly Energy Zero
Building e dal gennaio 2021 tutti gli altri edifici, quindi anche quelli privati, che saranno obbligati a rispettare gli standard previsti dalla direttiva Per quelli esistenti, questi standard dovranno essere rispettati secondo delle procedure oggetto di definizione nel costruendo decreto di recepimento In considerazione di quanto sopra, le energie rinnovabili dovranno giocare un ruolo rilevante e trovare sempre maggiore utilizzo e integrazione negli interventi di riqualificazione dell’edilizia esistente e negli edifici di nuova costruzione c
LA DIRETTIVA 2012/27/UE, A PARTIRE DAL 2014, CHIEDE AI GOVERNI CENTRALI DEI PAESI MEMBRI DI RIQUALIFICARE OGNI ANNO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ SECONDO UNA PERCENTUALE PRESTABILITA: SECONDO LEI, PUÒ ESSERE UN’OPPORTUNITÀ DI RILANCIO SIA PER IL NOSTRO PAESE QUANTO PER IL COMPARTO EDILE CHE IN QUESTO MOMENTO VIVE UNA DELLE SUE CRISI PIÙ PESANTI? Il problema è alquanto complesso Attualmente non abbiamo una conoscenza approfondita di come sia costituito il parco immobiliare di questo settore Abbiamo iniziato a fare alcune stime, affiancando l’Agenzia del Demanio, da cui emerge che, esclusi gli edifici “sensibili” o del Ministero della Difesa come indicato dalla Direttiva, possiamo far riferimento a circa 40 000 edifici, di cui una percentuale significativa è oggetto di vincoli di varia natura Questo panorama crea delle difficoltà di valutazione Riteniamo comunque che gli interventi possano contribuire a un rilancio del settore, ma in quale misura è difficile prevederlo Non sottovalutiamo poi il problema di trovare le forme più opportune e necessarie per poter finanziare questi interventi
CHE RUOLO HANNO LE ENERGIE RINNOVABILI NEL RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA PREVISTI PER IL 2020?
Le energie rinnovabili giocano un ruolo molto importante Si tratta di un tema che dovrà essere affrontato con uno sforzo molto impegnativo di tutta la filiera A livello di “policy” si dovranno programmare con molta attenzione le politiche e le misure Da parte degli operatori, dare maggiore impulso alla ricerca e all’innovazione per cercare soluzioni che trovino integrazione con il sistema edificio-impianto e, lato produzione, individuino il giusto mix tecnologico per promuovere le Smart Grid e la Generazione Distribuita









01. Completato nel 2012, l’edificio amministrativo della arabern AG di Herrenschwanden (CH), che da decenni si occupa della chiarificazione delle acque reflue, ha ottenuto la certificazione Minergie-P-Eco Elementi salienti del progetto dello studio bauart di Neuchatel, da anni portavoce di un’architettura efficiente e sostenibile, sono la forma compatta, l’elevato isolamento, gli impianti altamente performanti www bauart ch
02. In Romagna un vecchio casolare è stato ristrutturato secondo standard passivi Il fabbisogno energetico di 15 kWh/m2 anno è stato ottenuto nonostante lo sfavorevole orientamento, i vincoli conservativi, quelli strutturali dovuti alla normativa antisismica e la richiesta di due camini interni con i conseguenti problemi di tenuta all’aria (progetto: arch Francesca Nardi)
03 Un edificio di tre piani energeticamente autosufficiente e in standard passivo è stato realizzato nella 174a strada a New York L’equilibrio termico dell’involucro è garantito dalla muratura in cls (20 cm) isolata con EPS (17 cm), tripli vetri, copertura in acciaio e calcestruzzo coibentata con XPS. La climatizzazione è fornita da una pompa di calore e un impianto di ventilazione meccanica controllata. www.loadingdock5.com
04. L’edificio a Mühlgrund-Vienna è un esempio di condominio passivo in cui convivono più generazioni di persone Grazie anche ad accorgimenti bioclimatici, come l’orientamento a sud degli appartamenti e la creazione di zone puffer nelle restanti parti, il fabbisogno energetico è minore di 15 kWh/m2 anno Lo studio ARTEC è stato per questo insignito delle certificazioni austriache klima:aktiv e ÖGNB www.artec-architekten.at
05. A Ravensburg (D) è stato inaugurato a marzo 2013 il primo museo certificato Passivhaus, progettato dallo studio di Stoccarda LRO Lederer Ragnasdòttir Oei Oltre alla forma compatta, contribuisce al bassissimo fabbisogno energetico un impianto geotermico che, collegato a una pompa di calore e all’attivazione termica delle parti strutturali, garantisce condizioni indoor costanti durante tutto l’anno www archlro de
06 La ristrutturazione integrale e il recupero del sottotetto di un edificio del 1901 nel centro di Milano hanno permesso anche di realizzare un nuovo prospetto che meglio si integra nel contesto mentre la coibentazione e gli impianti (pompa di calore ad acqua di falda e pavimenti radianti) hanno consentito di massimizzare il comfort e ridurre i consumi www filippotaidelli com
07 Riportiamo i crediti esatti del progetto della casa unifamiliare a Mascalucia pubblicata sul n 06 di azero (gennaio 2013) Progetto architettonico: arch Pina Giovanna Capace, Aci Castello (CT); progetto energetico: ing Carmelo Sapienza, Mascalucia (CT); progetto interni: prof arch Salvo Bruno Comes, Catania; direttore dei lavori: ing. Maria Fabio Mondelli, Mascalucia (CT).
Leoni & Leoni - ing. Emiliano Leoni 2009-2011 PROGETTO ARCHITETTONICO CLASSIFICAZIONE ENERGETICA
CasaClima Gold (in fase
di certificazione)



FOTOGRAFIE: Antonia Creazzi - Leoni&Leoni, Paolo Calzà
La particolare forma e volumetria caratterizzano questa casa dal bassissimo consumo energetico, corrispondente a meno di un litro di gasolio per metro quadrato all’anno
Il risultato è frutto degli studi solari e bioclimatici, dell’accuratezza nella scelta delle stratigrafie dell’involucro, della risoluzione dei ponti termici e dell’integrazione delle diverse soluzioni impiantistiche
UN DIAMANTE IN CLASSE ORO
Un volume molto compatto caratterizza questo edificio unifamiliare che sorge al posto di una vecchia abitazione demolita, in un contesto residenziale urbano frutto delle politiche edilizie del secondo dopoguerra della città di Rovereto
L’idea generale e il concept del progetto sono apparsi chiari fin dai primissimi incontri tra il progettista e la giovane famiglia committente: l’abitazione monofamiliare avrebbe dovuto rispondere agli standard di edificio energeticamente passivo, integrandosi al contempo con l’ambiente Accurati studi solari hanno suggerito di posizionare il volume, tre piani fuori terra e uno interrato, a nord del lotto (lato distinto da un declivio naturale), al fine di assicurare apporti solari quasi costanti e di ricavare la parte preponderante del giardino a sud
L’articolazione volumetrica e formale nasce dalla congiunzione di due rombi regolari, da cui deriva il nome dell’edificio (Casa Diamante), con un lato di 8,70 m, uno intero e uno diviso a metà Una griglia modulare parallela ai lati del rombo definisce il vano scala, la suddivisione dello spazio e il ritmo e l’ampiezza delle aperture. Queste ultime consentono aperture sul giardino
e sulle montagne circostanti permettendo di captare il calore solare in autunno-inverno e di controllarlo durante l’estate tramite un sistema di lamelle esterne orientabili
La copertura a pianta quadrata, a richiamare i tetti delle case circostanti, è disposta lungo le diagonali del volume sottostante al quale fornisce protezione Tutto ciò ha permesso di ottenere un’ampia facciata rivolta a sud con un leggero azimuth a ovest per poter sfruttare l’energia incidente sulla grande vetrata al piano terra; il calore immagazzinato sale poi verso i piani alti attraverso il vano scale situato nella parte opposta della pianta
La tipologia costruttiva è di tipo tradizionale con struttura portante in setti e solai in calcestruzzo armato e muratura in blocchi di laterizio, scelta che ha consentito di fornire un’adeguata inerzia termica all’edificio
Gli impianti (sonde geotermiche, pompa di calore, moduli fotovoltaici policristallini e impianto di ventilazione meccanica controllata) sono integrati al punto da risultare quasi invisibili e garantiscono il comfort invernale ed estivo e la produzione di energia elettrica.

Involucro e materiali
Dovendo realizzare un edificio dalle prestazioni termiche ridotte, tali da rientrare nello standard di una casa passiva, si sono accuratamente studiate le soluzioni tecniche e costruttive che hanno permesso di risolvere alcuni nodi tecnologici critici, eliminando così anche i ponti termici più difficoltosi
In dettaglio, per la coibentazione del solaio del piano terra verso il garage non riscaldato, sono stati utilizzati pannelli in XPS (60+60 mm), con l’ulteriore accorgimento di sviluppare tutte le murature in laterizio su un primo corso di blocchi in vetro cellulare I pilastri e le strutture portanti verticali in calcestruzzo armato al piano terra sono stati interamente rivestiti sul lato interno con pannelli isolanti compositi dello spessore di 30 mm per attenuare il ponte termico con il solaio
L’isolamento perimetrale esterno è stato realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato con particelle di grafite dello spessore di 180 mm, mentre la struttura di copertura è isolata con fibra di legno (260 mm)
Particolare attenzione si è rivolta alla corretta esecuzione delle nastrature e delle sigillature per garantire una perfetta tenuta all’aria dell’edificio in corrispondenza sia dei serramenti che di tutti gli attraversamenti e i passaggi delle tubazioni impiantistiche L’edificio ha superato la prova del Blower Door Test ed è in corso di completamento la pratica di certificazione Casa Clima Gold
Tutte le aperture vetrate, frutto di accurati studi solari, sono state progettate in maniera diversificata a seconda dell’esposizione di ciascun serramento e delle caratteristiche degli ambienti interni al fine di ottimizzare i guadagni solari I telai sono in legno di rovere con triplo vetro e fattore g variabile mediamente tra 45% e 48% circa Per l’impermeabilizzazione dell’ampio piano interrato, realizzato interamente in cemento armato, si è impiegata una soluzione che ha evitato l’utilizzo di guaine bituminose grazie all’inserimento di particolari additivi nell’impasto del calcestruzzo e di guaine e giunti a tenuta nel getto in corrispondenza dei nodi tra le strutture
pianta del piano interrato
pianta del piano terra
pianta del primo piano
pianta del secondo piano
Progetto architettonico, consulente energetico
e bioarchitettura ing Emiliano Leoni (Leoni & Leoni), Rovereto (TN)
Progetto strutture ing Francesco Misdaris (Studio MG+R), Verona
Impianti termoidraulici p.i. Nicola Cimonetti, Isera (TN)
Impianti elettrici p i Cesare De Oliva, Rovereto (TN)
Direttore dei lavori ing Emiliano Leoni (Leoni & Leoni), Rovereto (TN)
Appaltatore Edil 2 snc, Riva del Garda (TN)
Isolamento termico e intonaco di facciata Intodeb snc, Levico Terme (TN)
Serramenti esterni Wolfartec Srl, Naz Sciaves (BZ)
Arredi interni Arredis Srl, Chiusa (BZ)
Superficie fondiaria 626 m2
Superficie utile 211 m2 superficie netta riscaldata + 208 m2 piano interrato
Superficie verde 267 m2
A destra, dall’alto, il prospetto nord; una parte del fronte rivolto a sud-ovest; la facciata sud-ovest L’edificio si articola in 3 livelli fuori terra ed un livello interrato con 5 posti auto coperti più alcuni locali tecnici ed accessori La soluzione dell’ampio piano interrato ha consentito di liberare e sfruttare completamente lo spazio esterno destinato al giardino



sezione AA
sezione BB



In alto, isolamento in EPS del parapetto del terrazzo con affaccio a est Al centro, dettaglio dello spessore (180 mm) dell’isolamento della struttura in calcestruzzo armato.
Qui sopra, i canali di distribuzione dell’impianto di VMC inseriti nel getto in c a di uno dei solai
Parete esterna, dall’esterno:
Solaio terrazzo, dall’intradosso:
- finitura superficiale in doghe di legno (25 mm)
- sottostruttura di sostegno (25 mm)
- massetto pendenze (spessore variabile)
- guaina impermeabile in PVC (2 mm)
- pannello in XPS (140 mm)
- barriera al vapore
- solaio in c a (150 mm)
- intonaco a base di calce idraulica (20 mm)
Parapetto terrazzo, dall’interno:
- intonaco (10 mm)
- pannello in EPS (180 mm)
- strato di colla (10 mm)
- setto in c.a. (150 mm)
- strato di colla (10 mm)
- pannello in EPS (180 mm)
- armatura e intonaco esterno (15 mm)
- intonaco civile a base di calce idraulica (10 mm)
- pannello in EPS (180 mm)
- strato di colla (10 mm)
- muratura in laterizio alveolato (240 mm)
- isolante composto di lana di legno ed EPS (30 mm)
- intonaco a base di calce idraulica (20 mm)
- zoccolatura in XPS con membrana bugnata drenante PE/AD accoppiata polipropilene
Solaio verso garage non riscaldato, (da intradosso):
- finitura in parquet di legno (17 mm)
- massetto autolivellante a base cementizia (40 mm)
- pannello sagomato in EPS per riscaldamento a pavimento (spessore equivalente 38,2 mm)
- massetto in cls cellulare leggero (102 mm)
- doppio pannello isolante in XPS (sp 60+60 mm)
- solaio in c a (sp 260 mm)
Copertura, dall’estradosso:
- pannelli fotovoltaici
- copertura in lamiera con sistema a doppia aggraffatura
- tavolato (20 mm)
- travetti in legno (spessore variabile)
- pannelli in legno (20 mm)
- ventilazione (100 mm)
- membrana traspirante
- isolante in fibra di legno con interposti travetti di legno (260 mm)
- membrana traspirante
- solaio in c a (250 mm)
- intonaco a base di calce idraulica (20 mm)





Qui sopra, da sinistra, il consistente isolamento della copertura in fibra di legno; l’isolamento dei pluviali con lana di roccia; le contropareti interne sono realizzate a secco, nell’intercapedine, coibentata, sono alloggiate le condutture degli impianti
Qui a fianco, da sinistra, il piano interrato in c.a. e l’isolamento della struttura con XPS
Impianti
Per poter raggiungere un’efficienza complessiva dell’edificio tale da soddisfare gli standard di casa passiva è stato necessario considerare, oltre alla qualità termica dell’involucro, anche l’efficienza e la sostenibilità degli impianti installati, cercando al contempo di privilegiare sistemi che utilizzano risorse rinnovabili
Il riscaldamento invernale è assicurato da un sistema di pannelli radianti a pavimento (passo 8 e 16 cm) alimentati da una pompa di calore reversibile con potenza elettrica assorbita 1,82 kWe e COP 4,6 che utilizza come serbatoio termico il terreno, grazie a due sonde verticali di 80 metri di lunghezza ciascuna posizionate nel giardino L’impianto geotermico, che garantisce inoltre la produzione di acqua calda sanitaria, può funzionare nel periodo estivo anche per il raffrescamento degli ambienti.
Per un ottimale benessere termico e acustico degli spazi interni, nonché per un maggior comfort igienico, è stato realizzato un impianto di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore a doppio flusso in controcorrente ad altissima efficienza (portata max 550 m3/h), by-pass per free cooling e batteria di post-trattamento per il controllo e la gestione della deumidificazione nel periodo estivo L’impianto è abbinato a uno scambiatore di calore con il terreno costituito da 6 condotti flessibili in HD-PE alimentare Φ 110 mm che catturano l’aria esterna sul lato nord dell’edificio, lontano dalla strada. La resa dell’impianto, abbinato allo scambiatore a terreno, è pari circa all’87% I canali di distribuzione, coibentati, sono stati inseriti direttamente nel getto dei solai da cui si diramano fino alle singole bocchette di mandata e ripresa L’alimentazione della pompa di calore, nonché la produzione di energia elettrica, sono garantite dall’impianto fotovoltaico (potenza di 6,45 kWp) posto in copertura e collegato anche alla rete elettrica pubblica L’impianto, che rimane nascosto alla vista, è installato con inclinazione 0° e azimuth 0° ed è costituito da 2 stringhe da 15 moduli ciascuna in silicio policristallino per una superficie complessiva di circa 44 m2

INVOLUCRO
trasmittanza media elementi costruttivi pareti esterne, U = 0,14 W/m2K solaio verso autorimessa non riscaldata, U = 0,16 W/m2K copertura, U = 0,14 W/m2K serramenti, Uw = 0,7 W/m2K
emissioni CO2 evitate, - 16 kg/m2 anno; - 3,46 t/a
IMPIANTI
solare termico predisposizione per 4 collettori a tubi sottovuoto fotovoltaico
6,45 kWp (30 moduli; 44 m2) connesso in rete geotermia
2 sonde verticali di lunghezza di circa 80 m ciascuna distribuzione calore pannelli radianti a pavimento VMC
con recupero di calore; tubi sotto la platea di fondazione domotica
Sopra, i moduli fotovoltaici in copertura
Sotto, l’impianto di riscaldamento a pavimento e il locale che ospita gli impianti




Qui sopra, il living al secondo piano che si apre sulla terrazza rivolta a sud
Sopra a destra, il vano scala con la zona pranzo sullo sfondo illuminato dal lucernario in copertura
A destra, l’open space al piano terra è caratterizzato dalla scala e dai rivestimenti in legno di rovere


Qui accanto, i frangisole a lamelle orientabili
PROGETTO ARCHITETTONICO
REALIZZAZIONE
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA
E AMBIENTALE
a Glorenza (BZ)
Jürgen Wallnöfer

2007-2008
CasaClima classe C
58 kWh/m2 anno
consumo prima dell’intervento:
337 kWh/m2 anno


FOTOGRAFIE: René Riller
Architettura, tutela urbanistica, ristrutturazione competente dell’esistente, risparmio energetico, sostenibilità sono le parole-chiave di questo risanamento di un edificio medioevale del borgo di Glorenza, in Alto Adige Grazie alle soluzioni architettoniche e impiantistiche adottate, il fabbisogno energetico per il riscaldamento è ora pari a meno del 20% rispetto a quello precedente l’intervento
OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO DEL XVI SECOLO
Nella parte più antica dell’abitato di Glorenza, in provincia di Bolzano, si trova questo edificio il cui rinnovo energetico è stato insignito del primo premio nel concorso per l’Ottimizzazione energetica nelle ristrutturazioni della Provincia Autonoma di Bolzano del 2010
Ciò che ha permesso al progetto di ottenere tale onorificenza è stata l’attenzione posta dal progettista nel tutelare sia l’architettura sia l’ambiente urbano in cui essa si trova, preservando le parti soggette a tutela e adattando in modo non invasivo i nuovi, necessari interventi
Strutturalmente l’edificio, costruito probabilmente nel XVI secolo e oggetto di un ultimo intervento negli anni ‘60, si presentava in buono stato ma, poiché un incendio aveva distrutto nel 1930 tutti i pregiati interni e i mobili, il patrimonio storico di valore si limitava alle mura esterne
Al risanamento della facciata storica verso la strada con le tipiche finestre a cassetta, facciata vincolata dalla Sovrintendenza, è così corrisposta una maggiore libertà d’azione sul lato verso il cortile e negli spazi interni, privi di particolari architettonici rilevanti, senza però stravolgere l’assetto originario
Di fatto, sono stati demoliti e ricostruiti un’aggiunta in legno verso il cortile, al piano superiore, e la carpenteria del tetto; è stato poi “invertito” il modo di abitare collocando nel sottotetto la zona living e nel piano inferiore la zona notte
La nuova zona giorno è un grande e luminoso ambiente che gode di un buon comfort grazie anche alla coibentazione della struttura di copertura in lana di pecora e all’impiego di pannelli sottovuoto negli abbaini, soluzione che ha consentito di mantenerne le slanciate proporzioni
L’edificio è allacciato al locale impianto di teleriscaldamento a biomassa e il calore viene distribuito attraverso pannelli radianti a parete Tutto il legname impiegato, sia per il tetto sia per il rivestimento interno delle pareti, è a chilometro zero e proviene dal bosco comunale, contribuendo così alla sostenibilità complessiva dell’intervento
Nonostante la certificazione ottenuta, visti i vincoli d’intervento legati alla storicità dell’immobile, sia “solo” quella di una classe C CasaClima, il fabbisogno energetico della casa è passato dai 337 kWh/m2 anno precedenti all’intervento agli attuali 58 kWh/m2 anno

Piano terra: 1 cantina
2 cantina del vicino
3 passaggio per il cortile interno
4 cortile interno
5 stanza antistante la cantina
6 stanza impianti
Architettura
A partire da un’accurata analisi si è deciso di risanare energeticamente l’edificio sostituendo solo le parti non vincolate e meno meritevoli di tutela
Il tetto e la struttura in legno verso il cortile, compromessi da un incendio nel 1930, sono stati così oggetto di rifacimento
La zona giorno è stata spostata dal primo piano al sottotetto, tenuto anche conto del fatto che questa parte della casa gode di una migliore vista e illuminazione, grazie a tre nuovi abbaini, e che poteva essere coibentata in maniera ottimale vista la necessità di intervenire complessivamente sulla copertura
Il soggiorno è riscaldato per la maggior parte con una semplice stufa a legno, posizionata a sbalzo dal muro
Le finestre a cassetta che danno sulla strada sono state mantenute – così come le vecchie porte – e dotate di ulteriori vetro isolante e sigillatura per migliorarne le prestazioni.
Il rivestimento esterno degli abbaini è realizzato in acciaio Corten, il cui colore rosso ruggine si inserisce armoniosamente nella superficie delle tegole in argilla

Primo piano: 1 ingresso
2 camera
3 camera 4 bagno
5 unità immobiliare vicina
6 wc
7 ufficio
8 anticamera
9 anticamera
Sottotetto: 1 cucina
2 zona living 3 terrazza
A sinistra, un’immagine del fronte verso il cortile interno, con la parte in legno completamente rifatta
La vetrata corrisponde, all’interno, alla zona dedicata all’ufficio; sopra di essa, la terrazza, a livello del piano sottotetto
pianta del primo piano
pianta del sottotetto
pianta del piano terra
Concetto energetico e materiali
L’edificio è collegato alla rete locale di teleriscaldamento a biomassa e trae da questa l’energia – rinnovabile – necessaria per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
Le pareti esterne della zona notte al primo piano, visti i vincoli di intervento sulle murature storiche, sono state isolate internamente con fibra di legno e dotate di riscaldamento a parete
Data la minore possibilità di coibentazione della zona notte, nella quale però è consigliabile avere una temperatura dell’aria più bassa, si è dimostrata valida la scelta di cambiare la destinazione d’uso dei locali, spostando il living nel sottotetto Grande importanza è stata data all’impiego di materiali autoctoni (legno proveniente dai boschi del comune, isolamento con lana di pecore dal Tirolo orientale “Laaser Marmor”, intonaco di argilla con portaintonaco in stuoie di giunco, mobili in legno di pero autoctono, ecc.). Le sensazioni che trasmettono e la qualità di questi materiali naturali, tipici del luogo, giustificano il loro utilizzo non solo dal punto di vista architettonico e bioedilizio, ma anche da quello ecologico ed economico
Progetto Jürgen Wallnöfer, Glorenza (BZ)
Direttore dei lavori Jürgen Wallnöfer, Glorenza (BZ)
Appaltatore Christian Baldauf, Glorenza (BZ)
Superficie utile 122 m2
INVOLUCRO
trasmittanza media elementi costruttivi pareti esterne, U = 0,29 W/m2K solaio controterra, U = 0,35 W/m2K copertura, U = 0,15 W/m2K serramenti, Uw = 0,99 W/m2K
IMPIANTI
teleriscaldamento a biomassa (cippato di legno), potenza 8 kW distribuzione del calore attraverso pannelli radianti a parete, con rivestimento esterno in intonaco di argilla o di calce
Qui sotto, due immagini della posa del riscaldamento a parete sullo strato isolante interno in fibra di legno
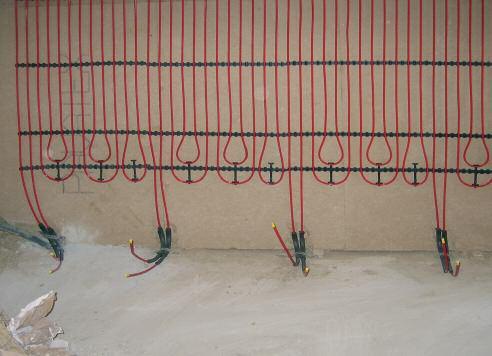

sezione AA
sezione BB
Copertura abbaino, dall’estradosso:
- rivestimento in acciaio Corten (3 mm)
- pannello in legno di abete rosso (1,9 cm)
- isolamento in pannelli sottovuoto (3 cm)
- pannello Kerto (7 cm)
- supporto per intonaco in giunchi
- intonaco di argilla
Copertura inclinata, dall’estradosso:
- tegole in cotto
- listellatura di supporto (3x4 cm)
- impermeabilizzazione
- tavolato grezzo in abete rosso (2,5 cm)
- isolamento in lana di pecora (6 cm)
- travi portanti in abete rosso (12x22 cm)
- isolamento in lana di pecora (22 cm)
- tavolato grezzo in abete rosso (2,5 cm)
- freno al vapore
- supporto per intonaco in giunchi
- isolamento a parete/soffitto
- intonaco di argilla (2,5 cm)
Parete esterna A, dall’esterno:
- muro esistente in pietra (45 cm)
- isolamento in pannelli di fibra di legno morbida (22 cm)
- tavolato grezzo in abete rosso (2,5 cm)
- freno al vapore
- riscaldamento a parete
- supporto per intonaco in giunchi
- intonaco di argilla
Solaio secondo piano, dall’estradosso:
- pavimento in legno di abete rosso in diverse larghezze (4 cm)
- listellatura in legno con isolamento in fibra di legno morbida/riempimento (10-25 cm)
- solaio esistente (25 cm)
Parete esterna B, dall’esterno:
- muro esistente in pietra (45 cm)
- isolamento in pannelli di fibra di legno morbida (6 cm)
- tavolato grezzo in abete rosso (2,5 cm)
- freno al vapore
- riscaldamento a parete
- supporto per intonaco in giunchi
- intonaco di argilla
1 schermatura solare tessile
2 finestre in legno di larice con triplo vetro (Uw=0,79 W/m2K)
3 davanzale in rame
4 grondaia interna in rame
5 legno di abete rosso sagomato
6 costruzione in legno per il cornicione
7 davanzale in larice
A destra, due immagini dello strato di supporto in giunchi, in prossimità degli abbaini, per l’intonaco in argilla con anche le tubature dell’impianto di riscaldamento radiante a parete
Sotto, un’immagine dell’open space nel piano sottotetto, con la cucina e la zona living Sulla destra, la stufa a legna protetta da un vetro di forma circolare
Al centro della stanza, a supporto della struttura in legno della copertura, è stato inserito un pilastrino in acciaio


Efficienza energetica, bilancio energetico effettivo e ciclo di vita sostenibile
Un risanamento edilizio efficace è strettamente legato all’effettivo bilancio energetico dell’edificio Solo quando l’energia per la produzione e lo smaltimento dei materiali da costruzione sono stati inclusi nel bilancio energetico complessivo si può parlare di un bilancio efficace Per questo motivo, oltre all’effettivo consumo energetico di un edificio, bisogna tener conto anche di molti altri fattori come i costi energetici legati al trasporto, alla produzione e allo smaltimento dei materiali da costruzione
La scelta dei materiali per questo intervento di risanamento è stata così influenzata da considerazioni di carattere architettonico, ecologico ma anche di tipo economico Per esempio, il legno di larice utilizzato arriva dal bosco del Comune di Glorenza. In questo modo è stato rivendicato un vecchio diritto, ormai quasi dimenticato, di ogni cittadino del comune di usufruire del legname da costruzione comunale
Inoltre, con il taglio e la lavorazione di legname del luogo si impiegano anche maestranze locali e il valore aggiunto dell’opera rimane in loco
Accanto al vantaggio ecologico di combinare prodotti di alta qualità assieme a un bilancio energetico primario basso, c’è così un bilancio economico positivo anche per l’economia locale

RISANARE L’ANTICO
3 domande a ... Jürgen Wallnöfer
Da dove si parte per riqualificare un edificio storico?
Questo è stato per me un progetto-pilota, in cui molte decisioni sono state prese anche secondo l’intuito, poiché l’edificio sarebbe diventato la mia casa Molti accorgimenti intrapresi si sono basati su soluzioni già largamente sperimentate, come l’isolamento dell’edificio dall’interno Per quanto riguarda le “decisioni intuitive” intraprese, mi riferisco ad esempio alla scelta di utilizzare legno proveniente dal bosco di proprietà del Comune di Glorenza I boscaioli locali mi avevano avvertito che quel larice non sarebbe stato adatto al mio scopo, cioè per realizzare finiture e mobili, ho voluto comunque utilizzarlo e ho avuto ragione poiché l’esperienza è stata positiva Probabilmente hanno contribuito al successo anche le conoscenze degli artigiani locali riguardo il momento gusto per tagliare il legno, il modo corretto di trattarlo ecc
Quali difficoltà, o criticità, ha incontrato durante la progettazione prima e la realizzazione poi?
All’inizio molta gente non capiva perché io avessi voluto costruire in senso così ecologico e riqualificare un edificio così vecchio anziché costruirne uno ex novo Fortunatamente, l’atteggiamento adesso è un po’ cambiato Durante i lavori sono stati motivo di grandi discussioni le lavorazioni, spesso difficili perché nuove, per esempio del legno massiccio, dell’intonaco di argilla e della lana di pecora come isolante Però, con gli artigiani ‘giusti’, aperti a idee più ‘ecologiche’, questi non sono mai stati dei veri e propri problemi
Secondo lei, il recupero del patrimonio edilizio può essere il futuro della progettazione?
Il rinnovo e il risanamento di vecchi edifici sta vivendo da noi, in questo momento, una spinta enorme. Alcune buone ragioni per agire in questa direzione sono la conservazione della cultura costruttiva tradizionale unita al modus vivendi moderno e la rivitalizzazione dei centri storici Inoltre, la densità delle vecchie strutture comporta benefici ambientali ed economici non indifferenti: percorsi brevi impediscono un traffico eccessivo, i costi delle infrastrutture diminuiscono ecc
Una nuova legge in Alto Adige supporta ulteriormente il risanamento di vecchi edifici La Provincia Autonoma di Bolzano acquista vecchi edifici in zone residenziali e li dà gratuitamente in mano a committenti che siano in grado di soddisfare i criteri di edilizia sovvenzionata Ciò attira sempre di più giovani famiglie nei paesi, contribuendo così alla rivitalizzazione delle vecchie costruzioni In Alto Adige ci sono progetti di questo tipo in molti posti e si può a ragione dire che questo è il futuro dell’edilizia
PROGETTO ARCHITETTONICO
REALIZZAZIONE
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA
E AMBIENTALE
Saint-Gervais (F)
Groupe H; Décalage Architecture

2010-2012
4 kWh/m2 anno
(per i mesi effettivi di occupazione)


Nonostante le notevoli difficoltà logistiche per il trasporto dei materiali e la rarefazione dell’aria abbiano consentito l’attività costruttiva solo nei mesi estivi, prolungando la realizzazione per due anni, questo rifugio, a 5 ore di marcia dalla vetta del Monte Bianco, è la prova del fatto che si possono costruire edifici a bilancio energetico quasi zero e autosufficienti a qualsiasi altitudine
AUTARCHIA ENERGETICA IN ALTA QUOTA
Posizionato sull’Aiguille du Goûter, a oltre 3 800 metri slm, il nuovo rifugio del Club Alpino francese accoglie gli alpinisti nella fase finale della conquista alla vetta più alta d’Europa, il Monte Bianco L’edificio sostituisce la vecchia costruzione degli anni Sessanta, posizionata più in basso, che sarà smantellata nel corso del 2013, lasciando intatto solo il recente ampliamento per le emergenze nel periodo invernale
La forma ovoidale dell’involucro a tre condizioni vincolanti: la tipologia strutturale, la tecnologia e le condizioni meteorologiche L’asse principale della pianta ellittica è infatti posizionato in direzione del vento prevalente, proveniente da ovest, al fine di accelerare le masse d’aria sui lati della struttura per creare un vortice sulla sezione posteriore, facilitando così il deposito della neve sull’unità di scioglimento della stessa La struttura dell’edificio, in legno, è rivestita da 128 pannelli trapezoidali o rettangolari, smussati a seconda dell’altezza del fabbricato e rivestiti con pannelli di acciaio inossidabile
Il rifugio è stato progettato per essere autosufficiente dal punto di vista energetico e idrico L’energia termica, per sciogliere la neve e produrre ACS, è fornita da collettori solari posizionati ai piedi della costruzione; l’elettricità è fornita da pannelli fotovoltaici installati in facciata e in copertura Un impianto di cogenerazione a biomassa funzionante a olio di colza agisce come un sistema di riserva per la produzione di calore ed elettricità L’aria è trattato con un sistema di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con portata regolata automaticamente in base al numero degli occupanti Il sistema dei servizi igienico-sanitari è stato al centro di una progettazione complessa a causa dell’altitudine e della mancanza di ossigeno: dotati di drenaggio sifonico, i servizi igienici utilizzano la stessa tecnologia adottata nei sottomarini con wc sottovuoto L’unica eccezione per l’utilizzo di materiali completamente rinnovabili è lo stoccaggio di gas utilizzato nella cucina per la cottura dei cibi e un’unità di riserva di combustibile per il cogeneratore

La struttura
Gestire un cantiere in alta quota non è impresa facile, considerando soprattutto i problemi legati al trasporto dei materiali e i rifiuti generati dall’attività costruttiva La pianificazione a livello progettuale, dalla preparazione tecnica alla gestione del cantiere, ha consentito di ottimizzare il processo costruttivo viste le difficoltà delle condizioni lavorative e dei costi ambientali ed economici della consegna dei materiali. Durante la prima fase di cantiere (estate 2010) per la realizzazione delle fondazioni sono stati utilizzati solo 10 m3 di calcestruzzo e non è stato prodotto alcuno scarto Le esigue quantità di rifiuti (isolanti, rivestimento in acciaio, legno, imballaggi ecc ) sono state stoccate e portate a valle Sono state utilizzate pitture, solventi o materiali privi di formaldeide o biodegradabili ed è stato effettuato uno studio accurato sullo smaltimento dei rifiuti prodotti anche nei periodi di attività del rifugio (dal 15 giugno al 23 settembre). La struttura lignea è a telaio, connessa a una griglia di legno appoggiata alle fondazioni, costituite da una rete di 79 micropali in acciaio ancorati alla roccia e incamiciati con calcestruzzo resistente alle intemperie Sono state utilizzate principalmente due specie legnose: 29 m3 di Douglas, resistente alle condizioni climatiche e proveniente dalle foreste co-
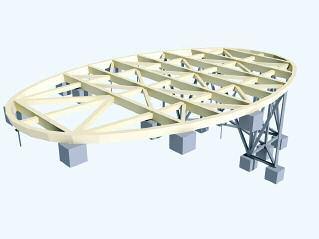
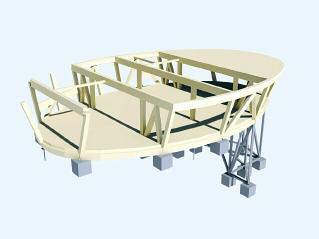

munali della Borgogna (Curgy Collonge-in-Charolais e Vaubans), per la griglia di base e per tutte la parti a contatto con il vuoto sanitario, e Abete rosso cresciuto nei boschi di Saint Gervais, gestiti in modo sostenibile (BQS Bois Qualité SavoieLegno di Qualità della Savoia), per la restante struttura Tutte le travi sono state rivestite con resina sigillante, mentre i solai sono stati costruiti con elementi lignei scatolari, leggeri e quindi di facile trasporto Pannelli di fibra di legno riciclato isolano la facciata, rivestita da pannelli di acciaio inox satinato a bassa riflessività Le partizioni interne sono in struttura leggera S/R in acciaio zincato e cartongesso, tranne che nella parte dei dormitori dove si è preferito usare elementi in OSB certificati PEFC o NaturePlus Le finestre esterne sono in legnoalluminio dotate di triplo vetro Ogni parte del rifugio è stata prefabbricata in stabilimento, dimensionata in modo da essere trasportabile e assemblata in loco La sfida è stata il trasporto in quota dei vari moduli con l’elicottero, condizione che ha imposto elementi con pesi inferiori ai 500 kg Il completamento del lavoro strutturale e dell’esterno ha segnato la fine della seconda fase di cantiere (novembre 2011)


Sopra, la sala da pranzo al primo piano
Nella pagina accanto, in alto, un’immagine dei dormitori al secondo piano
Sotto, rendering delle fasi di sviluppo della struttura portante del rifugio.
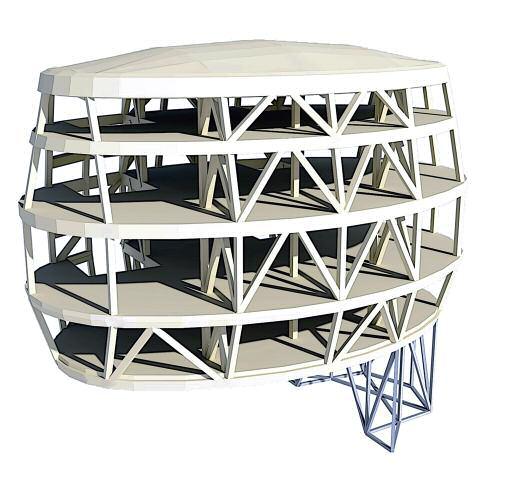

Progetto architettonico Groupe H, Parigi (F);
Décalage Architecture, Chamonix (F)
Strutture lignee Charpente Concept, Parigi (F)
Strutture fondazioni Betech, Annemasse (F)
Progettazione impianti Cabinet Strem, Lione (F)
Simulazione termica Albedo Energie, Bourget du Lac (F)
Calcolo dei costi Cabinet Denizou, Villeurbanne (F)
Appaltatore Labat&Serra/B3D/Dasta, Cart, GGM, Gaubicher, JP Maintenance, Solaravis, BDF, Domancy-Elec, Durr Equip, ERG, Aubonnet, CBA Montagne, CMBH
Superficie totale 720 m2
Superficie utile 681,3 m2
pianta del piano terra
pianta del secondo piano
sezione AA
sezione BB
La gestione dell’energia
Il contesto del rifugio di Goûter ha imposto non solamente la quasi totale autonomia energetica dell’edificio, ma anche un’ottimizzazione della capacità dell’involucro e della struttura per ridurre i fabbisogni di energia
La riduzione della domanda di energia è stata prima di tutto affrontata dal punto di vista architettonico, attraverso un’analisi bioclimatica basata sulla capacità dell’involucro di limitare le dispersioni e sullo sfruttamento dei punti di forza e delle caratteristiche del clima, al fine di ottimizzare, in modo naturale, le condizioni di comfort in ogni stagione È stata inoltre effettuata una simulazione energetica dinamica in funzione della posizione dell’edificio (piano di appoggio, dati climatici, variazioni di temperatura ), di differenti scenari di gestione (occupazione normale, guasto generale ), del comportamento termico del fabbricato ora per ora e del bilancio energetico La simulazione ha messo in luce che gli apporti termici sono prevalentemente forniti dagli occupanti del rifugio (ca 8 327 persone visitano il rifugio di Goûter in 98 giorni l’anno, con una media di 85 persone al giorno), dalle finestre e dalla cucina, mentre le maggiori perdite dipendono dalle pareti, dalla ventilazione interna e dalle infiltrazioni esterne I fabbisogni energetici totali sono costituiti per il 76% dal riscaldamento e per il 24% dall’elettricità
Oltre a garantire prestazioni elevate del pacchetto parete, copertura e solaio contro terra con adeguata tenuta all’aria dell’intero involucro, i progettisti hanno curato con particolare attenzione anche la parte tecnologico-impiantistica L’impianto di climatizzazione (VMC) rinnova l’aria, al fine di garantirne una qualità ottimale in funzione del tasso di CO2 e di umidità all’interno degli ambienti attraverso una centrale di trattamento d’aria (CTA, uno scambiatore rotativo con rendimento maggiore del 72%) a doppio flusso, regolata da sonde ambientali relative all’occupazione L’impianto di cogenerazione per produrre elettricità e calore si avvale di olio di colza come combustibile e solo nella fase di avvio e di arresto utilizza combustibile fossile, sfruttato anche come riserva e nella cucina per la cottura dei cibi
Un impianto fotovoltaico con 95 pannelli in facciata e 96 pannelli sul tetto (ciascuno di 60 Wp) produce corrente continua a 12 o 24 Volt che consente di alimentare i dispositivi elettrici, sia direttamente in continuo o, previa trasformazione con inverter,

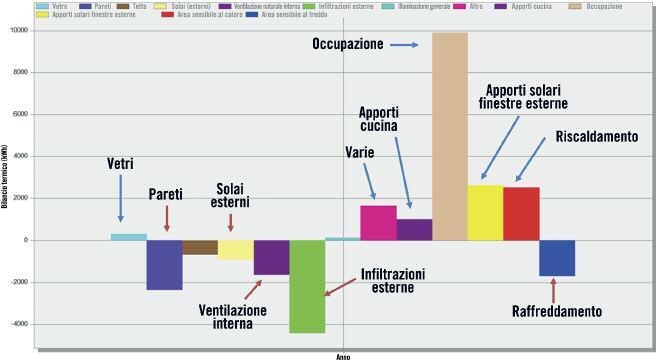
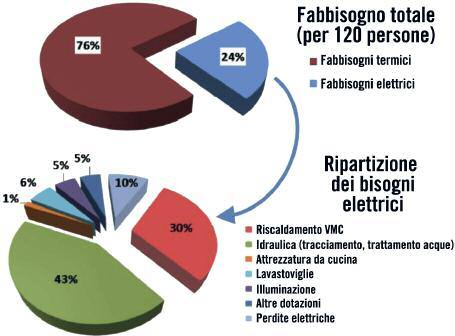

Bilancio termico
Stima e ripartizione della produzione di energia termica ed elettrica con condizioni climatiche favorevoli e con una occupazione di 120 persone
Dettaglio dei bisogni energetici del rifugio
Il rifugio visto da nord-ovest

in corrente alternata a 220 Volt Questa corrente, se non utilizzata, può essere immagazzinata in batterie Quando la tensione elettrica di uscita supera i bisogni e le batterie sono cariche, l’energia dei pannelli fotovoltaici viene scaricata in un serbatoio di stoccaggio di acqua (2000 litri) tramite una resistenza elettrica di 6 kW Tutti gli apparecchi illuminanti sono del tipo a risparmio energetico: lampade a fluorescenza compatte, fluorescenti o a LED
L’energia termica, in condizioni favorevoli, è fornita per circa l’86% da 54 metri quadrati di collettori solari termici collocati ai piedi del rifugio sulla roccia Orientati a sud e inclinati di circa 60° rispetto alla linea orizzontale, garantiscono il 100% della produzione di acqua fredda (dallo scioglimento della neve) e una parte dell’acqua calda sanitaria Il resto della produzione termica di ACS è garantito in modo variabile dall’unità di cogenerazione a biomassa
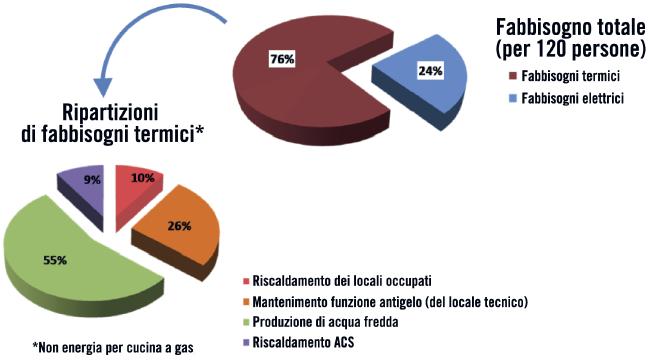
Un particolare del rivestimento esterno del rifugio, con i pannelli fotovoltaici
1 travetto dentellato
2 nastro di tenuta autocollante
3 lamiera in inox di rivestimento
4 pannello 3 strati (27 mm) sulla spalletta della finestra
5 isolamento in fibra di legno (60 mm)
6 oscurante
7 traverso in lamellare (80x200 mm)
8 infisso legno-alluminio
Stima

INVOLUCRO
trasmittanza media elementi costruttivi pareti esterne, U = 0,142 W/m2K solaio controterra, U = 0,188 W/m2K copertura, U = 0,139 W/m2K serramenti, Uw ≤ 1 W/m2K
IMPIANTI
VMC
a doppio flusso con scambiatore di calore fotovoltaico
95,5 m2; 5 292 kWh/(15 giugno - 23 settembre) solare termico
54 m2; 17 836 kWh/(15 giugno - 23 settembre) cogenerazione con olio di colza elettricità 13,3 kW; calore 30 kW trattamento delle acque grigie, cucina, servizi igienici

QEB – Qualité Environnementale dés Batiments
Il QEB raggruppa una serie di strumenti che conducono alla certificazione HQE® e corrisponde a un percorso globale di sviluppo sostenibile che consente di ottimizzare la progettazione e le strutture degli edifici in modo più salubre, confortevole e a basso impatto ambientale Il HQE® è strutturato in base a 14 obiettivi raggruppati in quattro famiglie al fine di controllare l’impatto del progetto sull’ambiente esterno; le categorie sono: sito e cantiere, gestione (energia, acqua, rifiuti, manutenzione), comfort (termico, acustico, visivo, olfattivo) e salubrità
I livelli di prestazione raggiungibili per ognuno dei 14 obiettivi sono tre: Base, il livello minimo accettabile per la valutazione
QEB, conforme alle norme; P erform a n te: corrispondente alle buone pratiche; Molto Performante: il livello misurato rispetto alle prestazioni massime ottenute da interventi ad alta qualità ambientale
Il profilo minimo QEB si ottiene, se si soddisfano 3 obiettivi al livello Molto Performante, 4 obiettivi al livello Performante e 7 obiettivi al livello Base
I serbatoi dell’acqua derivante dallo scioglimento della neve.
A sinistra, in bianco, l’unità di trattamento dell’aria nel locale tecnico al piano terra; in blu, la macchina di cogenerazione a olio di colza.
Solaio, dall’estradosso:
- rivestimento
- pannello OSB (25 mm)
- isolante in lana di roccia alta densità (80 mm)
- guaina bituminosa termosaldata
- pannello OSB (25 mm)
- elemento scatolare prefabbricato in legno per solai (h 240 mm) con isolamento in fibra di legno


Connessione parete-solaio al livello 0 (locale tecnico – unità trattamento aria):
1 controlistellatura sfalsata (80x120 mm)
2 membrana tenuta all’aria di facciata risvoltata
3 lamellare GL28h in Douglas (118x300 mm)
4 nastro di tenuta autocollante e coprinastro
5 trave laterale della griglia di base in lamellare
6 trave della griglia di base in lamellare
7 trave in legno (84-180 mm)
8 isolamento resistente all’umidità in XPS
9 pannello OSB (25 mm)
10 cassa in acciaio in rilievo
11 sovrapposizione tenuta all’aria
12 sostegno in gomma sotto i profili a U
13 struttura metallica dei profili di base
A sinistra, due fasi della realizzazione del solaio contro terra Nell’immagine a lato, la posa delle travi di bordo in legno lamellare sulle fondazioni in c a ; in basso, si procede con la realizzazione del solaio vero e proprio
Qui sotto, il rifugio in una fase avanzata dei lavori; si stanno posando i moduli fotovoltaici in copertura


Görtz Schoeneweiß Architekten Holtz Architekten GmbH 2010-2011
Passivhaus Institut Darmstadt


Nel quartiere di Südstadt, nella tedesca Hattingen, si sta terminando la riqualificazione architettonica ed energetica di 11 lotti d’intervento, per circa 45 000 m2 di superficie abitativa Uno degli edifici plurifamiliari del complesso di Südstadt, realizzato negli anni ’50 e mai seriamente riqualificato, grazie agli interventi effettuati, è stato certificato dal Passivhaus Institut di Darmstadt e consuma ora solo 15 kWh/m2
RITORNO AL FUTURO. UN RISANAMENTO A EMISSIONI ZERO
Il problema del risanamento di edifici esistenti dispendiosi dal punto di vista energetico – e quindi anche economico – ma ancora in buono stato strutturale investe tutta l’Europa e non solo il nostro Paese
Alla questione energetica legata a edifici realizzati in un periodo ormai molto lontano dal nostro, si affianca anche quella, non secondaria, della suddivisione degli spazi interni che, se rispondevano alle esigenze sociali di quegli anni, non sono oggi più adatti alla società moderna
La cooperativa edilizia hwg eG, nel Land tedesco del Nord RenoVestfalia, ha condotto sul quartiere Südstadt di Hattingen, realizzato tra gli anni ‘50 e ‘60, un grande progetto di riqualificazione A partire dal 2007, tutti gli edifici presenti a Südstadt e suddivisi in 11 lotti, sono stati oggetto di risanamento architettonico ed energetico non ancora terminato su tutti i lotti Il focus della modernizzazione ha riguardato la con-
servazione del quartiere in senso abitativo e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti con conseguente abbassamento dei costi di gestione e quindi di affitto Nell’operazione di risanamento sono stati investiti circa 60 milioni di euro, di cui 10 dati dal governo locale poiché gli edifici del 5° lotto rientrano nei criteri indicati dal bando dei “100 Climate Protection Housing Estates in North Rhine-Westphalia” dedicati espressamente al risanamento di porzioni di tessuto urbano All’interno del quartiere, gli edifici che si affacciano sulla Lessingstrasse 3-5, le cui peculiarità verranno approfondite nelle pagine successive, sono stati certificati in standard Passivhaus. Le tre palazzine passive in linea di Lessingstrasse sono state riqualificate con un intervento mirato sull’involucro, posando cioè un isolamento a cappotto con un metodo ad hoc, le cui performances sono supportate da un’impiantistica altamente efficiente e che sfrutta fonti rinnovabili come il sole e il legno

Committente hwg eG, Hattingen (D)
Progetto architettonico Görtz Schoeneweiß Architekten, Dortmund (D)
Progetto energetico Wortmann & Scheerer, Bochum (D)
Direzione lavori Holtz Architekten GmbH, Dortmund (D)
Appaltatore hwg eG, Hattingen (D)
Superficie fondiaria 1 431 m2
Superficie utile 1 030 m2
Struttura e ponti termici
Le planimetrie delle palazzine che si affacciano sulla Lessingstrasse presentavano, a inizio lavori nel 2007, un’articolazione ormai anacronistica: spazi angusti e poco flessibili a cui si è ovviato demolendo le pareti interne e modificando gli spazi costruendo nuove e più leggere partizioni Inoltre, sono state eliminate le barriere architettoniche che ancora esistevano per venire incontro alle necessità della quota crescente di single anziani che abitano nel quartiere Le entrate delle case, i bagni e le cucine sono state, di regola, orientate verso nord mentre le zone di soggiorno sono orientate a sud e sono dotate di grandi finestre, al fine di ottenere quanto più possibili guadagni solari
Aggiungendo balconi da 12 m2, ampliando le finestre fino al pavimento sui lati rivolti a sud e inserendo nel sottotetto dei grandi abbaini – aumentando cioè la metratura degli appartamenti e delle superfici trasparenti – si è riusciti a ottenere maggiore qualità abitativa e comfort
Sulla copertura a falde esistente, con struttura portante lignea, sono stati inseriti 12 nuovi, grandi abbaini, realizzati con struttura a telaio di legno, coibentati con lana di roccia (30 cm sulla parte frontale, 8 cm ai lati) e quindi rivestiti con doghe lignee come nel resto dell’edificio
La struttura portante era, ed è, in blocchi di calcestruzzo alleggerito e presentava un ridotto strato isolante esterno di 6 cm che però non continuava nel piano interrato, causando così

Stralcio della planimetria del quartiere di Südstadt in cui sono indicati tutti i lotti d’intervento Le 3 palazzine che danno sulla Lessingstrasse, e che sono state riqualificate con standard Passivhaus, sono quelle evidenziate in alto a destra
ponti termici di rilevante importanza Aspetto questo che ha rappresentato la vera sfida nella trasformazione dell’edificio in senso passivo La difficoltà di modificare le soluzioni esistenti e risolvere i ponti termici è, infatti, uno dei problemi maggiori degli interventi sull’esistente Questo è vero soprattutto per i solai soprastanti cantine non riscaldate, nodi che costituiscono quei ponti termici che portano al maggior consumo di energia Nel progettare una casa passiva è, quindi, indispensabile dedicare particolare attenzione alla problematica dei ponti termici e alle relative risoluzioni non solo per le aree critiche ma, in generale, anche per tutti i nodi strutturali Nel caso dell’edificio plurifamiliare di Lessingstrasse sono stati calcolati circa 20 ponti termici
Sotto, a sinistra, il fronte nord prima della riqualificazione Qui sotto, la facciata in fase di ristrutturazione (sono già visibili le strutture in legno degli abbaini)
Gli edifici risanati dalla hwg vengono solamente dati in affitto

Le tre palazzine passive di Lessingstrasse si sono rivelate non solo a basso consumo energetico ma anche a zero emissioni di CO2. Nel bilancio finale delle emissioni, si è tenuto conto di due possibili soluzioni.
Nel caso A, che poi si è effettivamente realizzato, l’installazione di una caldaia a pellet per il riscaldamento (che consuma ca 15 m3 di pellet all’anno) nonché la realizzazione di un impianto FV, ha fatto sì che le emissioni di CO2 finali fossero nulle
La superficie disponibile sul tetto è di ca 160 m2 Di questi, 80 m2 sono stati ricoperti con moduli fotovoltaici, 30 m2 con pannelli solari termici.
Nel caso B, ipotizzando invece l’installazione di una caldaia a gas per il riscaldamento e rinunciando all’installazione di moduli fotovoltaici, il bilancio relativo alle emissioni di CO2 nell’aria sarebbe stato eccessivo
prospetto sud
A destra, una parete interna in mattoni in fase di demolizione
Sotto, il fronte nord su Lessingstrasse una volta terminati i lavori
(credits: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co OHG)


del piano sottotetto della palazzina centrale
sezione-tipo trasversale
pianta
pannelli fotovoltaici
pannelli solari termici pannelli fotovoltaici
pannelli solari termici
pannelli fotovoltaici pannelli fotovoltaici
Soluzioni d’involucro
Poiché l’isolamento dell’involucro è il passo più significativo in un’ottica di risparmio energetico, anche nel caso dell’edificio in Lessingstrasse si è partiti da questo punto, dopo una serie di considerazioni sulle procedure da seguire
Si voleva che la facciata fosse rivestita esternamente con doghe di legno (anche al fine di richiamare la sostenibilità di fondo dell’operazione); rivestimento che doveva essere fissato alla parete portante attraverso il generoso strato di isolamento a cappotto previsto (30 cm)
Se si fossero utilizzati sistemi classici di fissaggio con ancoraggi in acciaio o alluminio, si sarebbero creati significativi ponti termici Era quindi necessario trovare un sistema che minimizzasse gli effetti negativi di tali ponti termici puntuali La penetrazione del sistema di fissaggio attraverso lo strato coibente sarebbe dovuta essere la più bassa possibile e avrebbe dovuto trasportare meno calore possibile; in sostanza, gli elementi di supporto dovevano avere piccolo spessore e bassa conducibilità termica Allo stesso tempo, il numero dei punti di ancoraggio doveva essere il più ridotto possibile, aspetto che a sua volta dipende dai requisiti strutturali
Dopo aver preso in considerazione diversi sistemi di fissaggio,
si è optato per un montaggio del supporto del sistema cappotto+rivestimento la cui realizzazione è molto simile a quella di un telaio in legno Come montanti sono stati utilizzati pannelli Kerto relativamente sottili che al contempo permettono una distanza assiale relativamente elevata a fronte di un’altezza che può raggiungere gli 8 m senza andare a inficiare la stabilità della struttura Il numero dei punti di fissaggio dei montanti alla parete esterna (ponti termici puntiformi) è esiguo Tra i montanti sono stati inseriti due strati di lana di roccia da 16 e 14 cm (per un totale di 30 cm), con la duplice funzione di isolamento e di protezione dal fuoco Una volta inserito lo strato isolante, è stata posta su di esso una listellatura orizzontale in legno (3x8 cm) sulla quale è stata incollata una membrana antivento con funzione di protezione dagli agenti atmosferici Sopra di questa sono stati inchiodati verticalmente – a distanza di 60 cm l’uno dall’altro – dei listelli verniciati di nero che fungono da sottostruttura per il rivestimento finale in doghe di abete bianco con sezione romboidale Il valore U finale di trasmittanza del sistema risulta addirittura superiore del 20% rispetto a un normale sistema a cappotto di uguale spessore
INVOLUCRO
trasmittanza media elementi costruttivi pareti esterne, U = 0,15 W/m2K solaio controterra, U = 0,13 W/m2K copertura, U = 0,13 W/m2K serramenti, Uw = 0,76 W/m2K
IMPIANTI
solare termico
32 m2
fotovoltaico
8 kWp; 6 200 kWh riscaldamento a biomassa stufa a pellet centralizzata (17-49 kW) VMC con recupero di calore
dettaglio schematico del sistema di ancoraggio del supporto per l’isolamento esterno
1 listellatura orizzontale
2 listellatura verticale
3 rivestimento esterno in doghe di legno con sezione romboidale
4 pannello Kerto da 39 mm di spessore
5 membrana nera di tenuta all’aria
6 isolamento in lana di roccia in 2 strati
7 profilo angolare nero in alluminio
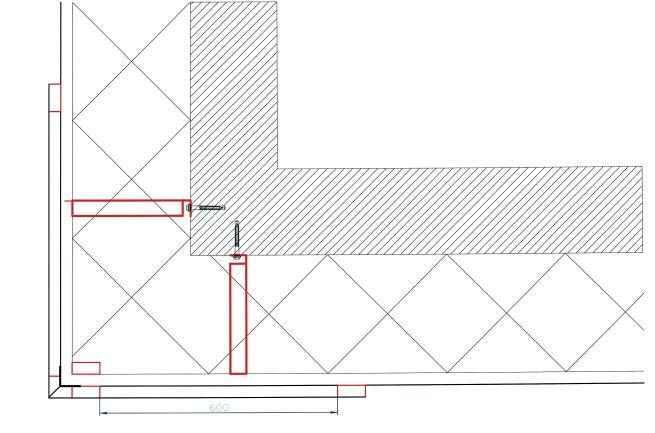

a) La posa dell’isolamento esterno realizzato in due strati di lana di roccia tra i montanti in legno Kerto b) I listelli di legno posati orizzontalmente a distanza di 60 cm l’uno dall’altro provvedono a una maggiore stabilita della struttura
c-d) La posa della membrana antivento che funge anche da protezione contro gli agenti atmosferici
e) Nel punto d’incontro tra il telaio della finestra e la struttura portante del sistema isolante esterno si è posta particolare attenzione nella posa della membrana di tenuta al vento Il colore scuro serve anche da “sfondo” per il rivestimento finale in doghe di legno f) Sui listelli verticali neri vengono fissate le doghe orizzontali in abete bianco.
g) Un angolo dell’edificio in cui è messa in evidenza la fase di avanzamento dei lavori
I crediti delle immagini di questa pagina sono da attribuire a Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co OHG


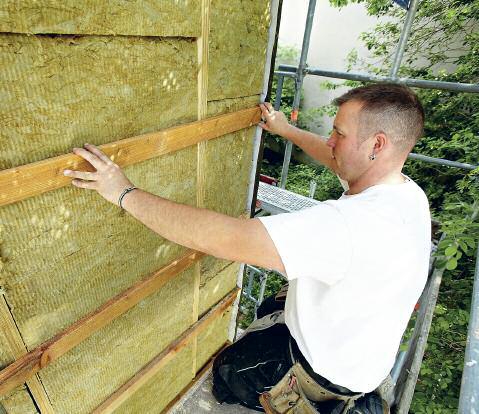



a) b)


La fase di realizzazione degli abbaini e il rifacimento della struttura portante in legno della copertura
Impianti
Prima dell’intervento di riqualificazione, gli edifici di Lessingstrasse presentavano un fabbisogno energetico per il riscaldamento di circa 150 kWh/m2 anno Oltre all’intervento sull’involucro, le prestazioni passive finali delle tre palazzine sono state rese possibili anche grazie all’installazione di un impianto di ventilazione meccanica con recupero di calore, un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, un impianto di riscaldamento centralizzato a pellet e un impianto fotovoltaico da 8 kWp
Parete dell’abbaino, dall’interno:
- doppio pannello in cartongesso (2x1,25 cm)
- listellatura di supporto in legno (5 cm) data da controlistellatura verticale (2,5 cm) + listellatura orizzontale (2,5 cm)
- barriera al vapore (0,5 cm)
- isolamento in fibra minerale tra i montanti della struttura portante in legno (16 cm)
- pannello OSB (1,8 cm)
- membrana nera di tenuta al vento (1,8 cm)
- pannello isolante in fibra di legno (8 cm)
- membrana nera di diffusione al vapore, resistente ai raggi UV
- listellatura in legno (4 cm), colorata di nero
- controllistellatura in legno (8/6) fissata ai montanti in legno posti all’occorrenza
- rivestimento esterno in doghe legno della facciata (2,3 cm), con sezione romboidale
1 pluviale
2 strato d’aria
3 montante 12/12
4 legno per stabilità facciata
5 impermeabilizzazione interna della finestra con membrana butilica
6 legno inserito per livellamento nella realizzazione delle finestre
7 serramento in PUR
8 impermeabilizzazione esterna della finestra in EPDM
9 binari per le tapparelle con isolamento integrato, stesso colore delle finestre
10 profilo a L in acciaio per fissaggio corrimano
11 imbotte finestra in fibrocemento
sezione orizzontale abbaino
Copertura, dall’estradosso:
- tegole grigie, opache
- controlistellatura 30/50 posta a interasse 33,9 cm
- listellatura 30/50 posta a interasse 63 cm
- membrana sottotetto, permeabile al vapore
- isolamento in fibra di legno sopra le travi del tetto (6 cm)
- travi portanti 10/20
- isolamento in lana di roccia tra le travi del tetto (20 cm)
- barriera al vapore (0,5 cm)
- listellatura 60/60 posta a interasse 60 cm
- isolamento in lana di roccia sotto le travi del tetto (6 cm)
- listellatura 30/50 posta a interasse 60 cm
- pannelli in cartongesso (1,2 cm)
Parete esterna, dall’interno:
- intonaco esistente (1,5 cm)
- parete esistente (24 cm)
- isolamento esistente (6 cm)
- intonaco esterno esistente (1,5 cm)
- sottostruttura del cappotto data da:
• profilo a U in alluminio su cuscinetto in neoprene avvitato alla muratura portante per fissare la listellatura in legno data da due strati di correnti 8/10 incrociati
• isolamento in lana minerale (16 cm)
• isolamento in lana minerale (8 cm)
• telo nero di facciata, permeabile al vapore e resistente ai raggi UV
• listellatura colorata di nero (4 cm)
• rivestimento di facciata in legno di abete (2 cm)
1 trave di gronda sagomata
2 angolare metallico forato di protezione
3 gronda
4 strato separatore tra i due strati isolanti
5 pluviale
6 profilo a U in alluminio posato su cuscinetto in neoprene e avvitato al muro portante per il fissaggio della listellatura
7 isolamento esistente con vecchio intonaco (6 cm)
8 muro esistente (24 cm)
9 solaio esistente
Le due immagini a lato mostrano la realizzazione della struttura portante del cappotto esterno degli abbaini, all’interno della quale vengono posati i due strati di lana di roccia
(credits: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG).


sezione verticale nodo copertura
focus on progettare la riqualificazione

Riqualificare: cosa e perché?
Il 60% del patrimonio immobiliare nazionale versa in condizioni di obsolescenza1; patrimonio che risulta composto per il 56% da edifici adibiti a residenziale2, il 55% dei quali insistenti su manufatti che hanno almeno quarant’anni3, mentre solo il 17% è collocabile dopo il 19914 Ciò significa che una fetta consistente del costruito destinato ad abitazione (ossia di quell’edificato maggiormente energivoro) è antecedente alla crisi petrolifera del 19735 (vedi i grafici a pag 47) Una prima lettura di questi dati basterebbe a spiegare il perché e la necessità odierne di riqualificare energeticamente l’esistente, sebbene si tratti di una lettura e un’analisi multilivello, che scaturisce dalla presa di coscienza, più o meno condivisa, della perdita di qualità patita, dal secondo Dopoguerra in poi, dal nostro costruito A ciò si affiancano le nuove esigenze odierne, i modi d’uso e di vita diversi, nonché la consapevolezza e la sensibilità differenti nei confronti del progettare, del costruire e dei loro impatti sull’ambiente.
PROGETTARE UN INTERVENTO
DI RIQUALIFICAZIONE
In un contesto edilizio caratterizzato da edifici esistenti obsoleti e inadeguati dal punto di vista energetico, è indispensabile, se non additittura doveroso, iniziare a recuperare e riqualificare il costruito, non dimenticando che ogni progetto di riqualificazione energetica è un caso a se stante da non standardizzare.
Gaia Bollini architetto, consulente energetico CasaClima

Veilige Veste, Leeuwarden (NL), progetto KAW architecten en adviseurs – arch Beatrice Montesano: la riqualificazione di una vecchia stazione della polizia olandese oggi certificata PHI (15 kWh/m2 anno).
L’attenzione crescente di questi ultimi anni nei confronti dell’ecosistema, dell’utilizzo delle risorse, del consumo di suolo e del controllo delle emissioni di gas climalteranti, hanno spostato l’interesse dal nuovo all’esistente Complice anche la componente culturale, per cui siamo più propensi e orientati a intervenire sul costruito (adeguandolo, trasformandolo, rileggendolo) piuttosto che a demolire e ricostruire6
Costruire un nuovo manufatto ha un suo costo e peso energetico La gestione dello stesso, estesa a un tempo di vita di circa cinquant’anni anni, ha un impatto dieci volte maggiore; analizzando il parco immobiliare nazionale, è comune riscontrare prestazioni energetiche quattro volte superiori ai limiti attuali7 Rapportando questa macrovalutazione alla realtà immobiliare evidenziata dalle percentuali precedenti, ossia alla consistenza di quanto costruito senza particolari attenzioni prestazionali dagli anni ‘50 in poi, si capisce la necessità, in termini di priorità, di leggere la riqualificazione attraverso quelle che sono le istanze di controllo, risparmio ed efficienza energetica.
Ad avvalorare tale tesi concorrono la posizione e le politiche varate negli ultimi anni dalla UE8, dove, vicino alla richiesta di ottemperare a requisiti minimi di prestazione energetica, da distinguersi tra nuova costruzione e intervento sull’esistente, si introduce quale obiettivo finale la minimizzazione dei fabbisogni energetici, con la richiesta di andare verso l’edificio a energia quasi zero anche nella ristrutturazione
Certamente un corretto approccio alla riqualificazione non può
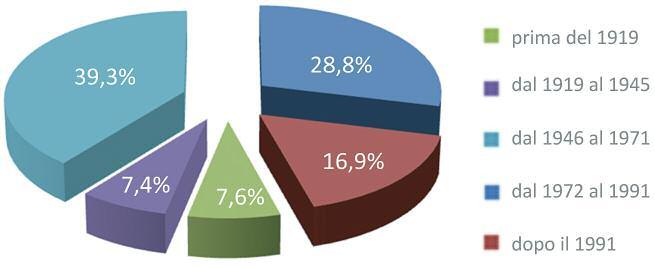
Sopra, famiglie per epoca di costruzione dell’edificio in cui risiedono (fonte: elaborazione Censis su dati Istat “I consumi delle famiglie, 2009”).
Sotto, patrimonio edilizio registrato al Catasto per tipologia funzionale (fonte: elaborazione Censis su dati Agenzia del Territorio, 2011)
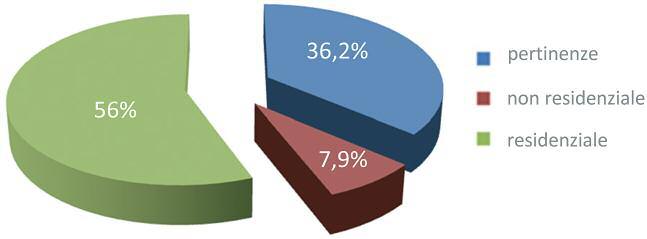
La riqualificazione nelle politiche europee
EPBD/31/2010/UE sulla prestazione energetica in edilizia
Art 4
[ ] Nel fissare i requisiti minimi di prestazione, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici esistenti e quelli di nuova costruzione
Art 9
[ ] Gli Stati membri devono adottare politiche e misure finalizzate a incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero
La nuova Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, per ciò che concerne la riqualificazione energetica del sistema integrato edificio-impianto prevede:
> il rinnovamento degli edifici pubblici: dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie utile coperta degli stessi dovrà essere annualmente ristrutturata per rispettare standard energetici minimi;
> la definizione (da parte degli Stati membri) di una strategia ad ampio respiro per “mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati”, attraverso:
- un censimento dello stato di fatto del parco immobiliare nazionale;
- l’individuazione di approcci alla ristrutturazione efficaci in termini di costi;
- stime in termini di ricadute, basate su prove di risparmio atteso (per incentivare gli investimenti);
> maggior trasparenza e rispondenza nelle bollette (adozione di contatori individuali a consumo effettivo, conteggi rispondenti all’uso ecc )
Quali criteri per il retrofitting?
Riprendendo quelli che ad oggi sono i due maggiori riferimenti in ambito di realizzazione di edifici net zero energy, ecco cosa indicano il Passiv Haus Institut di Darmstadt (Istituto case passive, PHI) e l’Agenzia CasaClima di Bolzano in tema di riqualificazione e retrofitting energetico In entrambi i casi si è nell’ambito della volontarietà
• Il PHI prevede il raggiungimento di un indice di fabbisogno netto (QH) ≤ 25 kWh/m2anno; in caso contrario bisogna dimostrare che l’intervento è stato condotto impiegando buona parte dei componenti (e delle soluzioni) certificate PHI
• L’Agenzia CasaClima ha emanato il protocollo CasaClima R per il risanamento; quest’ultimo non prevede il raggiungimento di una classe minima o di un fabbisogno specifico, ma chiede l’attuazione di tutta una serie di misure atte a diminuire le dispersioni termiche, a garantire le effettive condizioni di comfort e il rispetto di alcuni requisiti di legge (nazionale).


prescindere dalla verifica e dall’adeguamento strutturali, dall’effettiva accessibilità, fruibilità e sicurezza degli spazi o dal controllo acustico degli ambienti (in altre parole dalla riappropriazione di qualità architettonica). Il focalizzare l’attenzione sull’aspetto gestionale nasce dalla valenza che lo stesso ha assunto in questi ultimi anni La scarsa o nulla qualità energetica del costruito, infatti, ha ripercussioni sul comfort indoor, sulla gestione economica e sull’ambiente, senza considerare le implicazioni che la dipendenza energetica del nostro Paese ha sul piano degli equilibri politici internazionali
Parallelamente vi è un altro aspetto importante da considerare, ossia l’ampio potenziale di intervento insito in questa fetta di patrimonio, sia per ciò che concerne il contenimento dei consumi energetici nazionali sia, di conseguenza, di riduzioni delle emissioni di CO2. Condizione imprescindibile, però, è che si intervenga in modo sistematico, coerente e controllato
Riqualificare: come?
Punto di partenza, e obiettivo finale, è il bilancio energetico dell’edificio Bilancio inteso come fabbisogno primario di energia, ossia analisi che tiene in considerazione contemporaneamente peculiarità e prestazioni sia dell’involucro, sia dell’impianto
Obiettivo: minimizzarne il valore (in altre parole tendere al famigerato quasi zero) Se, infatti, nel progettare un nuovo manufatto a energia quasi zero, è chiara la gerarchia di approccio, tanto da porre quale punto di partenza e verifica il fabbisogno netto di energia dell’involucro, nel caso della riqualificazione tale gerarchia non è più così definita, né così rigida Involucro e impianto assumono il medesimo peso, giacché in alcuni casi quest’ultimo potrebbe rappresentare l’unico ragionevole ambito di intervento
In tal senso si vuole condividere una breve riflessione: indipendentemente da quelli che siano gli ordini di grandezza cui tendere, piuttosto che gli indici di fabbisogno definiti, in alcuni casi il valore di fabbisogno minimo potrebbe considerarsi raggiunto pur traducendosi in valori ben diversi dal comune e riconosciuto “quasi zero”. Ciò in ragione dei limiti e dei vincoli propri del manufatto oggetto di riqualificazione9, rispetto ai quali, dati gli interventi attuabili, anche nell’ottica della sostenibilità economica del progettato, la prestazione finale ottenibile è quanto di più basso si possa raggiungere nel caso specifico Certamente questo tipo di considerazioni contribuisce a rendere meno nitidi i confini di valutazione e confronto che delineano l’ambito della riqualificazione, poiché ogni intervento è un caso a sé.
Ca’ della Luna, Agazzano (PC), progetto arch
Michael Tribus: una riqualificazione con ampliamento volumetrico da 3 kWh/m2 anno
Bilancio energetico dell’edificio
UNI TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici
Parte I Determinazione del fabbisogno di energia 3 termini e definizioni
3.7
Prestazione energetica di un edificio: Quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio: la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione.
Schema del flussi energetici di un edificio (apporti solari, apporti interni gratuiti, energia primaria per il riscaldamento, perdite dell’involucro, perdite degli impianti ecc )
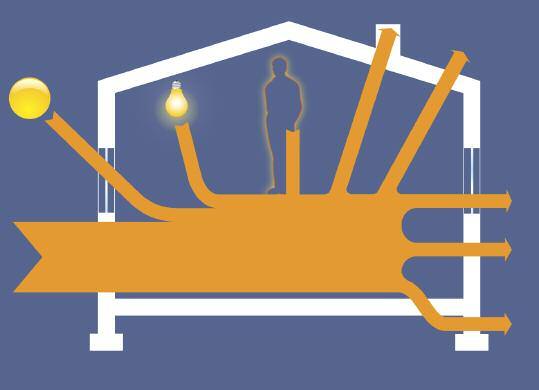
Contesto e stato di fatto
Zona climatica E; GG 2412
Appartamento in edificio anni ’70 (complesso di 4 unità) in contesto residenziale urbano Piano terra rialzato insistente su cantine e garage (chiusi)
Impianto autonomo (CT nell’interrato)
Prestazione energetica globale: 373 kWh/m2a
Stato di progetto
Intervento solo sulle chiusure verticali (opache e trasparenti):
- coibentazione delle pareti (coibentazione interna, in quanto gli altri condòmini non prevedevano alcun tipo di intervento)
- sostituzione dei serramenti con contestuale isolamento del cassonetto
Prestazione energetica ottenuta (globale): 195 kWh/m2a
Tempo di rientro di circa cinque anni (con incentivi fiscali del 55% per la riqualificazione)
Alcune considerazioni
La prestazione energetica globale di legge, per un edificio come quello ipotizzato, è dell’ordine di 97,93 kWh/m2a Gli attuali consumi sono quasi quattro volte tanto Tanta negatività energetica apre però ad ampi margini di rientro, come si vede dall’esito della sola riqualificazione dell’involucro
Un tipo di intervento di questo tipo, dove l’impianto è coevo con l’immobile, evidenzia come via sia ancora un interessante range di intervento pensando ad una sostituzione dello stesso Dopo la riqualificazione dell’involucro i fabbisogni netti di energia sono diminuiti significativamente, passando dai 235 kWh/m2a iniziali a, grossomodo, 100 kWh/mqa; questo risultato supporta la scelta di un generatore ad alta efficienza (anche a condensazione, prevedendo le termo-valvole sui terminali scaldanti) Il conseguente aumento dell’efficienza avrebbe ricadute anche sulla produzione di ACS, il cui fabbisogno, invece, rimane invariato Dal punto di vista della progettazione della prestazione in opera, si sottolineano alcune cri-
ticità che vanno gestite e controllate, ma che non trovano riscontro nella mera modellazione termica Essendo l’utente l’unico a pianificare un intervento di riqualificazione si è optato per una coibentazione interna Di seguito alcuni elementi critici da considerare nell’approcciare l’involucro:
- variato comportamento igrometrico della stratigrafia muraria;
- variato equilibrio termico in regime estivo (è stata separata la massa di accumulo dall’ambiente interno, variandone l’ammettenza interna)
- necessità di risoluzione dei seguenti nodi: parete esterna coibentata/parete interna
parete esterna coibentata/solai
parete esterna coibentata/spallette foro finestra
parete esterna coibentata/spallette/infisso
Il tempo di rientro
I parametri con cui effettuare una stima dei tempi di rientro dell’investimento, secondo parametri di attualizzazione, sono i seguenti:
> kWh risparmiati
> potere calorifico dei vettori impiegati
> costo medio combustibile e aumento stimato
> costo intervento (investimento)
> interesse bancario
> eventuali incentivi (55% )
In linea di massima un buon intervento è quello che si paga in circa dieci anni
A sinistra in alto la pianta del piano rialzato che comprende anche l’unità immobiliare riqualificata
Sotto a sinistra la situazione dell’interrato che identifica diverse proprietà rispetto a quella dell’appartamento soprastante: una difficoltà da gestire in fase di isolamento del solaio
A destra, la linea rossa individua l’isolamento interno, gli ovali gialli i punti critici che si formano in corrispondenza delle partizioni interne per l’interruzione della coibentazione e i rettangoli verdi il nodo tecnologico muratura-serramento
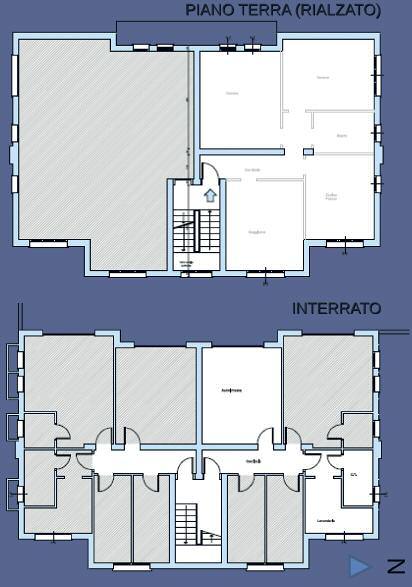

Quello che si può provare a fare, ed è l’obiettivo di queste pagine, è delineare un metodo procedurale che ne evidenzi “principi e accorgimenti progettuali” Esso si caratterizza per step successivi:
1 analisi dello stato di fatto (diagnosi energetica);
2 messa a sistema dei dati raccolti;
3 definizione degli obiettivi di intervento (in ragione delle normative in essere e del rapporto costi/benefici);
4 approccio progettuale
Analisi dello stato di fatto
Definire lo stato di fatto dell’immobile, quale punto di partenza per tutti i ragionamenti e le valutazioni progettuali successive, significa farne la diagnosi energetica; tale analisi non equivale alla certificazione energetica Quest’ultima, infatti, si limita a definire le prestazioni energetiche dell’edificio (e la classe di appartenenza) secondo indicatori predefiniti e ponendo quale presupposto l’uso standard dell’edificio È paragonabile alla fotografia del comportamento energetico dell’immobile in condizioni normalizzate. Ciò cui si sta tendendo, invece, è un’analisi di dettaglio che ne evidenzi le peculiarità proprie, anche in relazione al suo uso e alla sua gestione Qualora l’ACE fosse disponibile potrebbe essere un utile punto di partenza, in particolar modo per quanto riguarda la raccolta dei dati che stanno a monte, soprattutto geometrici e di definizione della prestazione termica dell’involucro La diagnosi, per sua stessa implicita definizione, è una procedura più impegnativa10 e dal taglio più analitico, prevedendo un rilievo, una raccolta e un’analisi dei parametri relativi ai consumi specifici e alle condizioni di esercizio dell’edificio e dell’impianto a esso asservito Si tratta di procedere integrando e comparando dati raccolti a seguito di sopralluoghi con output numerici generati dagli strumenti di calcolo deputati Il primo passo, quindi, è l’acquisizione delle informazioni basilari relative all’immobile (elaborati di progetto, relazioni e/o documentazione tecnica specifica) e ai suoi costi gestionali, ossia le bollette degli ultimi tre anni Segue la parte di rilievo tesa alla comprensione del contesto, dell’involucro e degli impianti; ovviamente in questa fase è importante capire con la maggior chiarezza e attendibilità possibile le caratteristiche fisiche dell’involucro opaco e trasparente In assenza di dati certi può rendersi necessario, non potendo procedere con analisi invasive, ricorrere ad analisi strumentali11 Contestualmente è necessario acquisire quante più informazioni possibili in merito alle caratteristiche tecniche dei principali componenti impiantistici, dal generatore ai sottosistemi di distribuzione ed erogazione, dal sistema di produzione di acqua calda sanitaria agli eventuali altri impianti che fossero presenti
Un momento importante della diagnosi è il confronto con
l’utenza12; essa, infatti, è l’unica che può evidenziare particolari criticità dell’immobile (magari non immediatamente riscontrabili), raccontare variazioni o adeguamenti che possono essere occorsi (a livello distributivo, di involucro o di impianto) e testimoniare le specifiche modalità di conduzione e gestione dell’edificio, grazie alle quali potrebbero chiarirsi eventuali discrepanze tra fabbisogni calcolati e consumi registrati Quanto sin qui raccolto servirà alla definizione del modello rappresentativo del comportamento termico dell’edificio, rispetto al quale si procederà alla individuazione e alla proposta delle soluzioni riqualificanti
Messa a sistema dei dati raccolti
Conclusa la diagnosi13 è necessario raggruppare e mettere a sistema tutte le informazioni e i dati emersi (gestionali, prestazionali, tecnologici), per confrontarli con i requisiti (minimi) di benessere abitativo e qualità indoor
Stando a quanto dichiarato in premessa, i macro obiettivi cui tendere sono la minimizzazione del fabbisogno energetico, in un’ottica auspicabile di edificio net zero energy, e la sostenibilità economica dell’intervento Gli ambiti interessati possono essere sinteticamente raggruppati in:
- modifiche delle modalità di gestione (si interviene sostanzialmente sull’utenza);
- modifiche dell’assetto impiantistico (regolazione, uso ecc ; quest’approccio è in parte correlabile al punto precedente);
- sostituzione dei componenti impiantistici (azione che può sottendere più ambiti di intervento, potendo contemplare anche l’introduzione delle rinnovabili);
- ridefinizione delle prestazioni dell’involucro
Nel procedere con le scelte progettuali possibili, è bene porre a margine alcuni riferimenti:
> una corretta analisi di quanto attuabile deve procedere da una valutazione globale delle azioni di riqualificazione, condotta sulla base degli obiettivi, delle possibilità e dei livelli di intervento;
> la reale efficienza di un impianto è strettamente correlata alla prestazione dell’involucro (pur nella consapevolezza degli eventuali limiti progettuali e/o esecutivi);
> un buon investimento si paga in circa dieci anni;
> la prestazione reale si garantisce con il controllo dei nodi e delle soluzioni tecnologiche
Rispetto a quanto indicato al primo punto si sottolinea come, in ragione di un’ottimizzazione degli obiettivi, il progetto di riqualificazione possa prevedere una pianificazione per step successivi. Questa infatti è la fase in cui individuare la globalità delle azioni tese alla riqualificazione energetica, le quali poi potranno anche essere realizzate in tempi successivi L’importante è che

Sopra, Stockerhof a Laudes (BZ); progetto arch Christian Kapeller: interno di un maso del XVI secolo in cui riqualificazione energetica e restauro architettonico concorrono a ridare nuova vita a un edificio storico Da 132 kWh/m2 anno a 65 kWh/m2 anno
vi sia coerenza e pianificazione nella scelta degli interventi, la cui priorità potrebbe essere definita sulla base dell’analisi costi/benefici
Definizione degli obiettivi di intervento
Nella fase precedente si è proceduto ad approfondire quanto emerso dall’analisi iniziale, ponendo le basi per le scelte progettuali successive
Quando si opera sull’esistente si è già evidenziato come gli interventi di riqualificazione possano riguardare la sfera impiantistica o i componenti edilizi, definendo un approccio rispettivamente attivo o passivo
L’ambito passivo (ossia relativo a quelle prestazioni che inducono un risparmio energetico) è sintetizzabile attraverso azioni sull’involucro di: - controllo termico; - controllo igrometrico;
- controllo acustico
In realtà quest’ultimo punto non ha alcuna relazione con la prestazione energetica, ma nel momento in cui l’obiettivo finale è comunque quello di riqualificare, non si può intervenire senza pensare di attuare contestualmente un controllo della componente acustica
Per ciò che attiene i primi due ambiti, i parametri da analizzare e su cui intervenire sono noti; quello che è importante è l’interrelazione tra di essi o tra le parti che concorrono alla prestazione desiderata (siano componenti o materiali).
Aumentare in modo più o meno significativo la resistenza termica del componente opaco, ad esempio, è facile; si tratta di calcolare quanto isolante inserire nella stratigrafia muraria Garantire un altrettanto idoneo comportamento estivo, l’assenza di criticità prestazionali (ponti termici) e il controllo igrometrico (assenza di condensazione interstiziale e superficiale), significa passare dal mero calcolo alla progettazione dell’isolante e della prestazione termica. Un ragionamento analogo lo si può fare nei confronti della componente trasparente La finestra, infatti, richiede un triplice controllo: nel periodo invernale è l’elemento termicamente più debole, ma contemporaneamente (in alcuni fronti) anche quello maggiormente captante, la cui presenza consente di massimizzare i contributi gratuiti del sole In estate, però, può rappresentare un fattore estremamente critico, contribuendo al surriscaldamento interno degli ambienti Il controllo igrometrico non ha a che fare solo con la durabilità dei componenti dell’involucro; esso ha forti implicazioni e ricadute in termini di salubrità indoor Questa, infatti, deve essere garantita da un corretto ricambio d’aria negli ambienti interni, dall’assenza di problematiche correlate a una eccessiva concentrazione di umidità relativa o errata gestione della sua trasmigrazione
L’ambito attivo, infine, (ossia relativo a quelle scelte che incidono sull’aumento dell’efficienza energetica), coinvolge il settore degli impianti Esso spesso rappresenta il primo passo verso una riqualificazione globale, cui far seguire nel tempo interventi più radicali sull’involucro.
Anche in questo caso i livelli di intervento sono molteplici; si può andare dalla razionalizzazione del sistema di regolazione, alla sostituzione del generatore, alla ridefinizione dell’intero impianto, valutandone al contempo l’integrazione con sistemi basati sulle fonti rinnovabili
In ogni caso, la regola di fondo rimane la medesima: l’intervento scelto deve essere coerente con le problematiche riscontrate e funzionale agli obiettivi definiti, soprattutto di rapporto costi/benefici
In questa fase diventa importante il confronto con un’altra tipologia di utente, l’utente committente È questa figura, infatti, quella che, accanto agli obiettivi di riqualificazione e fabbisogno “quasi zero”, espliciterà le sue richieste ed esigenze, in-
troducendo altri aspetti da sottoporre a verifica progettuale Contestualmente potrebbe anche rappresentare uno dei vincoli correlati alle scelte attuabili: per ragioni di budget, perché trattasi di una committenza orientata a fare dell’intervento di riqualificazione un investimento, senza diventare il fruitore di quei nuovi spazi Un situazione come questa, ad esempio, impone riflessioni in merito al livello di integrazione edificio-impianto cui ci si può spingere Non tutte le cosiddette “utenze standard” sono pronte o in grado di gestire, e quindi massimizzare, certe scelte tecnologiche (soprattutto impiantistiche).
Anche questi aspetti concorrono alla definizione degli obiettivi di intervento
Approccio progettuale
Definiti gli obiettivi, si scende di scala, entrando nel merito della progettazione Ovviamente la realtà della professione si concretizza attraverso un continuo percorso di analisi, verifica e controllo di questi ultimi due punti
Come già detto, la gerarchia di intervento è dettata dalla specificità del singolo manufatto e dai tempi di rientro delle soluzioni ipotizzabili Parallelamente è importante procedere considerando tutti gli effetti e le ricadute di ogni singola scelta (in termini prestazionali e di comfort); da ciò emerge come spesso sia necessario ragionare per gruppi coerenti di interventi Un classico esempio riguarda la sostituzione degli infissi, scelta relativamente comune, soprattutto da quando vi sono gli incentivi fiscali Un’azione di questo tipo, oltre ad aumentare la resistenza termica del componente, comporta una maggiore tenuta del serramento stesso; significa che in assenza di altri provvedimenti mirati, vi potrà essere un variazione (con tendenziale aumento) del livello di umidità relativa interna, da cui la necessità di riverificarne (e controllarne) la concentrazione14 Un altro esempio riguarda il miglioramento delle prestazioni della componente opaca dell’involucro; una volta realizzata, se non si ha modo di intervenire sulla regolazione dell’impianto, pur diminuendo le dispersioni (e quindi le emissioni di CO2), si rischia di trovarsi in una situazione di discomfort a causa della temperatura operante troppo elevata15; contestualmente, qualora detto impianto sia centralizzato, sarebbe auspicabile poter introdurre un sistema di contabilizzazione, in modo da “monetizzare” l’effettivo risparmio ottenuto
Al di là della metodologia di approccio, condizione essenziale per un corretto intervento è la progettazione tecnologica dei componenti, dei nodi e il loro controllo Diversamente si corre il rischio di ridurre la riqualificazione a un mero algoritmo matematico o all’output numerico di un software
La riqualificazione va definita e verificata (in termini di risparmio energetico ed economico ottenibili) attraverso simulazioni e modelli matematici; la performance “in opera”, promessa da
A destra, Stockerhof a Laudes (BZ); progetto arch Christian Kapeller: l’intervento di recupero ha interessato anche l’impiantistica con l’installazione di una caldaia a pellet che alimenta i pannelli radianti a pavimento.
quella stessa riqualificazione, necessita d’essere progettata e tradotta in esecutivo di cantiere: un nuovo infisso si relaziona con l’intero foro finestra, spallette, soglie, eventuali avvolgibili; il foro finestra si colloca nell’ambito di una parete, più o meno isolata L’isolamento previsto dove verrà posizionato? Se non posso operare altro che internamente devo tenere ben presenti alcuni aspetti:
- come gestire l’incontro con le tramezze esistenti (anche in ragione di ciò che tali tramezze dividono: la medesima proprietà?
Proprietà diverse?);
- come affrontare i nodi parete-solai;
- come relazionare l’infisso con il nuovo sistema coibente;
- come controllare il variato comportamento igrometrico della stratigrafia muraria;
- come riequilibrare il comfort termico estivo
Per ognuno di questi aspetti, elencati a puro titolo di esempio, vi sono diverse soluzioni, ognuna delle quali è correlata alla definizione degli obiettivi di intervento individuati nella fase precedente Comune denominatore la scala di progetto, l’attenzione al dettaglio, il controllo del nodo; in altre parole la progettazione della prestazione (vedi tabella a pag 53)
Conclusioni
Intervenire sul patrimonio edilizio nazionale risalente a quarant’anni fa consente dei margini di rientro interessanti; è un investimento che, se ben calibrato, si ripaga in tempi ragionevoli, trascorsi i quali si trasforma in guadagno
Paga in termini strettamente economici e in termini di qualità di vita, grazie agli alti livelli di comfort indoor raggiungibili; certamente quest’ultimo dato è assai meno parametrizzabile, in quanto molto più soggettivo, ma non meno importante del precedente È fondamentale avere chiaro il punto di partenza, l’obiettivo finale, gli step di avvicinamento e le ricadute prestazionali delle singole scelte
Ma la vera sfida che ci attende non è rappresentata da quel 60% di patrimonio “obsolescente”, bensì dal riqualificare tutto quel patrimonio invenduto, o comunque difficilmente collocabile sul mercato, nato già vecchio alle soglie dell’entrata in vigore delle nuove normative sul contenimento e risparmio energetico di questi ultimi anni

Note
1 - Dati Censis 1999, secondo i quali il concetto di “obsolescenza” si articola in degrado per vetustà e degrado per ragioni costruttive
2 - Dati Censis su dati dell’Agenzia del Territorio 2011
3 - Dati CRESME 2012 Si sale a percentuali del 60% per immobili risalenti a prima del 1974
4 - Dati Censis su base ISTAT 2009

Schematizzazione di possibili interventi correlati
COPERTURA
ELEMENTI ORIZZONTALI
CHIUSURE VERTICALI OPACHE
PARTIZIONI VERTICALI INTERNE
Coibentazione copertura
Coibentazione ultimo solaio sottotetto
Coibentazione solaio del piano terra
Cappotto esterno
Cappotto interno
Coibentazione intercapedine
Termointonaco
Coibentazione pareti verso locali non riscaldati
Sostituzione vetro
Sostituzione serramento
Doppio serramento
CHIUSURE VERTICALI
TRASPARENTI
Coibentazione cassonetto
Coibentazione sottofinestra
Sistema di oscuramento
Generatore ad alta efficienza
SISTEMA DI PRODUZIONE
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
SISTEMA DI REGOLAZIONE
VENTILAZIONE
Pompa di calore geotermica
Coibentazione tubazioni
Sostituzione elettropompe di circolazione
Sistema di regolazione centrale
Sistema di regolazione locale
Contabilizzazione
VMC igroregolabile
VMC con recuperatore di calore
Solare termico
Solare fotovoltaico
Caldaia a biomassa
Rielaborazione grafica di dati tratti dal testo di G Dall’O (a cura di), 2008, Manuale della certificazione energetica degli edifici, Edizioni Ambiente, Milano, p 161
5 - Il primo riferimento normativo in materia di consumi energetici in Italia è la Legge n 373 del 1976
6 - Rispetto a ciò vi sono anche altre considerazioni da fare, soprattutto di matrice ambientale di ben più ampio respiro Quanto costruito, infatti, ha una sua energia inglobata importante In ragione di quelli che erano i modelli costruttivi e tecnologici del periodo storico cui ci stiamo riferendo, una demolizione selettiva non è praticabile; ciò significa trasformare quanto destinato a demolizione in rifiuto, dissipandone la stessa energia inglobata Rispetto a ciò, decidere di intervenire attraverso azioni mirate e riqualificanti potrebbe rappresentare un modus operandi energeticamente (e quindi ambientalmente) più premiante Certamente una valutazione di questo tipo non può essere presa e applicata acriticamente a tutto ciò che compone il patrimonio edificato italiano, costituito anche da edifici storici, il cui valore (sia ambientale che culturale) non è paragonabile con quello degli immobili del boom economico, veri elementi critici nella valutazione energetica del costruito In tal senso è sempre necessario agire secondo articolate analisi, condotte sulla base di eco bilanci
7 - Fonte C Benedetti (a cura di), 2011, Risanare l’esistente, BU Press, Bolzano, p 6
8 - Si vedano anche gli articoli apparsi sui numeri 1/2011 (“Verso edifici a zero energia o quasi”) e 6/2012 (“La nuova Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”) della presente rivista
9 - Si pensi a quanto sia diverso intervenire su un appartamento in contesto condominiale, su un edificio unifamiliare convenzionale piuttosto che storico; o ancora, in ambito urbano, peri-urbano o extraurbano
10 - Si tratta di un maggior impegno sia in termini di svolgimento dell’analisi e di competenze necessarie, con ovvie ricadute anche in campo professionale 11 - Termoflussimetri o termografie
12 - Nell’ottica di codificare una procedura orientata alla riqualificazione si è introdotta una distinzione tra utente proprietario e utente committente Non è infatti detto che nell’ambito di un incarico di riqualificazione queste due figure coincidano, ma certamente hanno eguale peso e importanza, che però si esplicano in momenti differenti In questo caso si fa riferimento all’utente proprietario, ossia a quella figura che conosce l’immobile, le sue criticità, il suo storico e che, con il suo modo d’uso, influisce sulla prestazione energetica effettivamente riscontrabile
13 - A essere corretti, una vera diagnosi, come comunemente intesa, contempla già lo sviluppo dei punti che seguono L’esito di un processo diagnostico, infatti, è quello di proporre una serie coerente di interventi di riqualificazione, mirati e calibrati sul caso specifico e analizzati in termini di tempi di rientro Nella presente trattazione si è volutamente utilizzato il termine diagnosi per indicare la prima fase di analisi, con l’intenzione di enfatizzarne l’importanza e il peso nell’ambito di una riqualificazione correttamente progettata
14 - Non è da escludere, in situazioni di questo tipo, che uno degli interventi più coerenti da abbinare alla sostituzione del serramento sia quello di prevedere un sistema di VMC, magari anche solo di tipo localizzato In tal modo si eviterebbero eccessivi carichi di umidità interna, legati all’introduzione del nuovo componente trasparente, unitamente ai nostri invariati stili di vita (scarsa ventilazione degli ambienti domestici)
15 - La temperatura operante (indoor) è la media tra la temperatura interna dell’aria (cui contribuisce l’impianto) e quella superficiale delle pareti (definita dal tipo di involucro e dalla stratigrafia che lo compone) Essa è la temperatura che effettivamente sentiamo e che rappresenta il livello di comfort percepito Si capisce quindi come, in caso di intervento che porti ad un innalzamento della temperatura superficiale della parete, se non si interviene contestualmente sulla regolazione dell’impianto, ne possa conseguire discomfort per “eccesso di calore” (oltre che un inutile spreco energetico ed economico, con contestuale emissione di CO2)
Guglielmina Mutani, Luca Raimondo ingegnere, architetto
IL CONTROLLO SOLARE ATTRAVERSO LE CHIUSURE TRASPARENTI
Controllare la radiazione solare sulle chiusure trasparenti consente di ottimizzare i fabbisogni energetici di riscaldamento, raffrescamento e illuminazione artificiale di un edificio nell’arco dell’anno e, di conseguenza, il progetto delle schemature solari assume un ruolo importante. Analisi e prestazioni di alcuni schermi verdi.
Da un punto di vista energetico, un edificio si può definire come un sistema termodinamico aperto, nel quale l’ambiente interno, termicamente controllato, è separato rispetto a quello esterno da una superficie di controllo Tale superficie è rappresentata dall’involucro edilizio, ovvero l’insieme delle strutture opache e trasparenti, che in relazione alle proprie caratteristiche svolge una funzione di “termoregolazione” dei continui e complessi scambi di energia tra ambiente interno ed esterno
La corretta progettazione dell’involucro può contribuire al mantenimento di condizioni ottimali di comfort termico e luminoso, riducendo i consumi energetici, sia in inverno sia in estate
La nuova Direttiva 31/2010/CE e le vigenti prescrizioni di legge portano l’attenzione sulla funzione di controllo della radiazione solare che deve essere svolta dall’involucro edilizio nel periodo di raffrescamento, con riferimento alle chiusure opache e trasparenti In merito a queste ultime, il D P R 59/2009 prevede che il progettista1, “al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, deve valutare puntualmente e documentare l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate,
in modo da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare e ad eccezione degli edifici industriali, artigianali e adibiti ad attività sportive, è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni ” Tali sistemi sono definiti dal recente D M del 22/11/2012 come: “sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari” In particolare, risultano avere un’importanza crescente i sistemi schermanti verdi, in quanto il rinverdimento delle pareti degli edifici può contribuire all’incremento degli spazi verdi urbani, al risparmio energetico degli edifici, all’assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l’effetto “isola di calore estiva”, così come riportato nella recente Legge 10/20132.
Modalità di controllo solare
La radiazione solare che colpisce le superfici d’involucro di un edificio origina dei flussi di energia che penetrano all’interno degli spazi modificando il microclima interno Tali flussi si di-



A sinistra, cupola del parlamento tedesco di Berlino (fonte: L Raimondo)
Sotto, facciata di un edificio storico a Pizzo (VV): esempio di semplice sistema di schermatura (fonte: L. Raimondo).
stinguono in ultravioletti, luminosi e termici (infrarossi), in base alla diversa lunghezza d’onda, e possono avere apprezzamento positivo o negativo, in relazione alle esigenze espresse dagli occupanti, e variabili in funzione della stagione dell’anno, come schematizzato nella tabella in alto a pagina 56 Il controllo della radiazione solare, che deve essere previsto a livello di progetto e attuato nella fase d’uso dell’edificio, fa riferimento a un complesso quadro di esigenze-requisiti che interessa aspetti legati alla riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, il comfort termico e quello visivo degli occupanti
Nella tabella al centro a pagina 56 sono schematizzate le modalità di controllo solare attraverso le chiusure esterne trasparenti che, rispetto a quelle opache, emergono come componenti potenzialmente critiche nel periodo estivo; la radiazione solare entrante negli ambienti attraverso di esse, infatti, risulta essere la voce più significativa nella determinazione dei carichi termici di raffrescamento.
Come si può dedurre dalla tabella, le scelte che riguardano la geometria di una chiusura trasparente, le proprietà ottico-solari del vetro e la previsione di schermature concorrono tutte al progetto del controllo solare Nello specifico, l’inclinazione e l’orientamento di una superficie dovrebbero essere scelti consapevolmente, valutando le condizioni climatiche del sito e considerando l’andamento dell’irraggiamento nell’arco dell’anno; la giacitura ottimale è quella che consente il maggior sfruttamento degli apporti solari in inverno senza determinare eccessivi carichi termici in estate Il dimensionamento della chiusura e la scelta del vetro, invece, dovrebbero basarsi su un’analisi multiparametrica, volta a definire le condizioni ottimali che consentono di minimizzare i costi energetici e di garantire le condizioni di confort termico nell’arco dell’anno Esempio di tale approccio è riportato nei grafici in basso a pagina 56 I grafici riassumono i risultati dell’analisi applicata a un monolocale con destinazione d’uso residenziale a Torino e un’unica superficie disperdente; le diverse curve rappresentano il fabbisogno di energia netta per l’illuminazione, il riscaldamento e il raffrescamento in funzione della frazione percentuale dell’area vetrata dell’involucro (rapporto tra l’area vetrata e l’area della parete disperdente): la percentuale ottimale di vetratura con un’efficace schermatura estiva risulta essere compresa tra il 10% e il 40% per la parete a sud, compresa tra il 10% e il 20% nel caso di lucernari
Esempi di schermature solari
Come già accennato, le schermature solari hanno un ruolo importante nell’ambito del controllo solare: se correttamente progettate, possono offrire un comportamento selettivo nei confronti della radiazione solare diretta e diffusa nell’arco dell’anno, ottimizzando le contrapposte esigenze estive e quelle invernali
Gli schermi possono assumere configurazioni differenti in relazione alla funzione, al contesto storico-culturale e alla volontà espressiva del progettista; siano essi di natura vegetale o artificiale, possono infatti caratterizzare le scelte relative alla sistemazione degli spazi esterni e divenire elementi significativi del linguaggio architettonico di un edificio Nelle fotografie delle pagine precedenti sono riportati due esempi di schermature applicate su due edifici molto diversi tra loro: un edificio storico a Pizzo (VV) e la cupola del Parlamento tedesco di Berlino
Geometria dello schermo solare
In funzione della geometria e dell’orientamento, gli schermi possono offrire o meno una efficace funzione di controllo solare (si veda la tabella in alto a pag 57) In generale, le schermature orizzon ta li, alle nostre latitudini, hanno una buona efficacia quando collocate sulla facciata sud dell’edificio: se ben dimensionate, impediscono la penetrazione diretta della radiazione solare nelle ore centrali delle giornate estive, cioè quando l’altezza solare è maggiore (vedi la carta solare in basso a pag 57) Le schermature verticali, invece, hanno una maggior efficacia
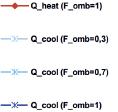

CAMPO DI RADIAZIONE SOLARE
ultravioletto (attraverso sup vetrate) luminoso (attraverso sup vetrate) termico (attraverso sup vetrate e opache)
- funzione igienizzante - luce naturale in ambiente - effetto psicologico sugli utenti - apporti solari gratuiti in inverno
- può arrecare danni a oggetti e arredi che col tempo si deteriorano
- possibile causa di discomfort, per abbagliamento, livelli di illuminamento non desiderati e poco costanti
Effetti della radiazione solare che penetra all’interno degli edifici
CONTROLLO SOLARE
Geometria e posizione della chiusura
percentuale di vetratura
Proprietà ottico-solari del componente trasparente
- carico termico in estate - possibile causa di discomfort, per contatto diretto con gli occupanti e per surriscaldamento
Schermature solari
fattore solare geometria
esposizione alla radiazione solare coefficiente di trasmissione luminosa posizione materiale
Modalità di controllo solare attraverso le chiusure trasparenti.
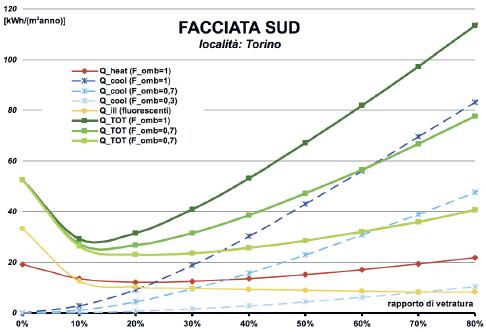
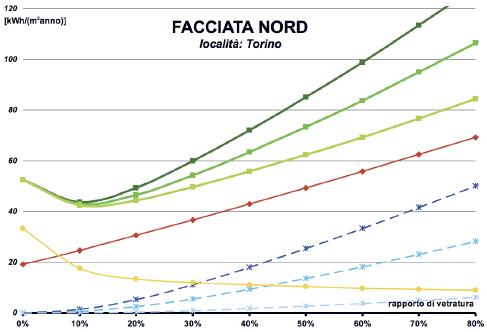
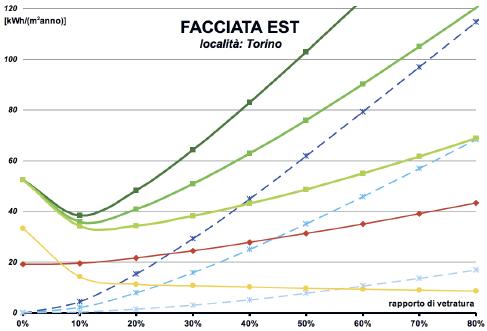
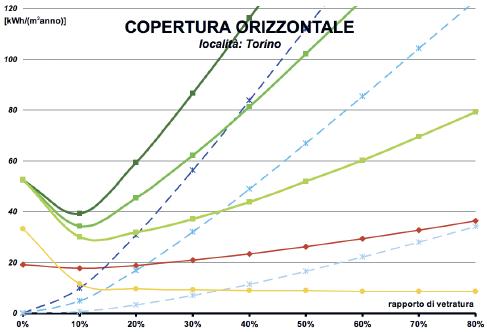
Curve dei consumi di energia netta annua per il riscaldamento, raffrescamento e illuminazione di un edificio residenziale a Torino, in relazione alla frazione di vetratura dell’involucro e del livello di schermatura.
sporto orizzontale doghe orizzontali doghe verticali fisse mobili carabottino graticci arbusti pergole
x x (x)2 x x (x)3 x
1 - occorre un’elevata inclinazione che riduca la vista interno-esterno
2 - limitata a quando risultano orientate in opposizione ai raggi solari
3 - variabile in relazione alla percentuale di foratura
secondo il ciclo vegetativo
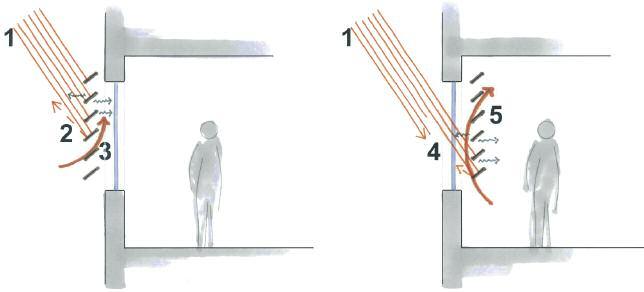
I meccanismi di trasferimento termico degli apporti solari attraverso una chiusura trasparente, in relazione alla posizione dello schermo: esterno (la radiazione solare [1] viene intercettata dalle doghe [2], e da queste in parte riflessa, in parte assorbita; il calore assorbito è dissipato nell’ambiente esterno per convezione ed irraggiamento – solo una parte delle onde infrarosse ad alta lunghezza inciderà sul vetro), interno (la radiazione solare [1], che entra nell’ambiente interno attraverso il vetro [4] viene intercettata dalle doghe [5], e da queste in parte riflessa e in parte assorbita; il calore assorbito è dissipato nell’ambiente interno per convezione ed irraggiamento - solo una parte delle onde infrarosse ad alta lunghezza inciderà sul vetro e quindi verrà dissipata all’esterno)
quando impiegate sui fronti rivolti verso est e ovest, in quanto riescono a intercettare la radiazione solare quando questa è caratterizzata da altezze solari minori Tuttavia, è importante notare che, generalmente, queste schermature hanno un elevato impatto visivo poiché interrompono la continuità tra interno ed esterno offerta dal componente trasparente
Posizione dello schermo solare rispetto l’elemento trasparente
Il primo e più importante principio nel posizionamento di uno schermo è che esso ha un’efficacia maggiore se posto all’esterno della superficie trasparente, in quanto intercetta la radiazione solare prima che questa entri nell’edificio Quanto espresso può essere meglio compreso e approfondito per mezzo della figura a lato che schematizza i meccanismi di trasferimento termico della radiazione solare in relazione alla posizione dello schermo
Valutazione dell’efficacia di uno schermo
La valutazione dell’efficacia di un sistema schermante, in una fase di verifica del progetto, deve essere svolta prendendo in considerazione parametri diversi a seconda del tipo di schermatura3, come riportato nei paragrafi successivi Tra le grandezze fondamentali ricordiamo la trasmittanza di energia solare totale e il fattore di ombreggiamento La prima caratterizza generalmente le schermature parallele all’elemento vetrato, mentre la seconda le ostruzioni che possono influenzare il flusso solare incidente su una finestra, ad esempio un’ostruzione esterna, un aggetto orizzontale o un aggetto verticale sulla facciata dello stesso edificio.
Esempio di dimensionamento di uno
mediante la procedura grafica delle maschere d’ombra (Torino, latitudine 45°07’ N)
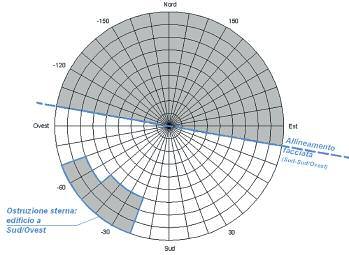
1. ANALISI DEL SOLEGGIAMENTO (per ciascuna superficie trasparente)
a Individuazione delle ostruzioni esterne e delle parti di un edificio che proiettano ombra
b Rappresentazione della maschera d’ombra
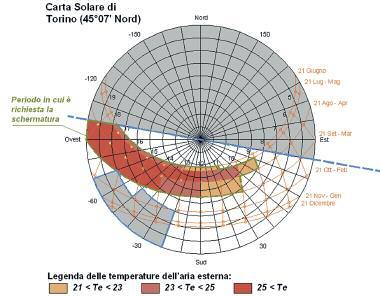
2. DEFINIZIONE DEL PERIODO DI SCHERMATURA
a Sovrapposizione della carta solare alla maschera d’ombra
b Rappresentazione del periodo con temperature dell’aria esterna > 21 °C
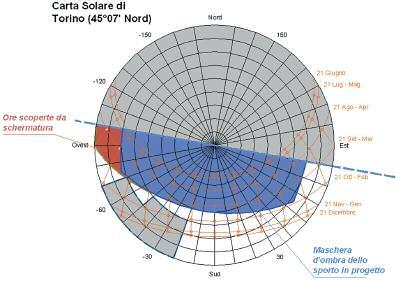
3. DEFINIZIONE DELLO SCHERMO
a Individuazione del tipo di schermo in relazione alla maschera d’ombra
b Definizione delle caratteristiche geometriche e relativa rappresentazione
Indicazione dell’orientamento ottimale per i principali tipi di schermi
schermo
La trasmittanza di energia solare totale
La trasmittanza di energia solare totale, g o TSET, rappresenta la frazione dell’energia trasmessa in ambiente dalla combinazione “schermatura solare più vetro” rispetto alla totalità dell’energia solare incidente; viene calcolata per schermature solari parallele all’elemento vetrato (ad es. tende, veneziane…). Tale fattore è adimensionale e ha valori compresi tra 0 e 1; può essere determinato in modo semplificato attraverso le tabelle o le formule riportate dalla norma UNI EN 13363-1:20084, in funzione della posizione dello schermo rispetto al componente trasparente (esterno, interno o in intercapedine nel caso di vetri doppi), in relazione alle caratteristiche dello schermo (valori di trasmissione e riflessione solare) e a quelle del vetro (fattore solare e trasmittanza termica)
I grafici a lato permettono di confrontare l’efficacia di alcuni sistemi di schermatura associati a diverse tipologie di vetri, interni, incorporati nel vetro o esterni, aventi colorazione (bianca o nera) e traslucidità differenti
Come si può notare dai grafici, gli schermi esterni sono molto più efficaci degli schermi interni in quando bloccano il flusso solare entrante quando si trova ancora nell’ambiente esterno L’efficacia dello schermo dipende però dalle caratteristiche di tutti i componenti e quindi anche dalla trasmissione, riflessione e dall’assorbimento solare del vetro e dello schermo stesso
Il fattore di ombreggiamento
Il fattore di ombreggiamento, Fs, rappresenta la riduzione di radiazione solare incidente dovuta all’ombreggiamento sull’elemento vetrato e viene calcolato per definire l’efficacia di schermature di tipo fisso, come ad esempio aggetti orizzontali o verticali facenti parte della struttura dell’edificio in esame, o l’orografia del terreno, edifici o vegetazione presente sul sito Tale fattore, adimensionale, ha valori compresi tra 0 e 1 e può essere determinato per ciascun mese dell’anno, secondo le indicazioni della norma tecnica UNI/TS 11300-15, come prodotto dei coefficienti di ombreggiamento relativi alle ostruzioni esterne, agli aggetti verticali e quelli orizzontali, desunti in funzione della latitudine, dell’orientamento e dell’angolo di vista, e riportati nelle tabelle all’interno della norma stessa
Dimensionamento di uno schermo solare
Il progetto di uno schermo solare si sviluppa attraverso successivi livelli di approfondimento, in parallelo rispetto al progetto architettonico dell’edificio Nella fase preliminare, partendo da un’analisi climatica di sito, occorre definire le caratteristiche di irraggiamento della superficie, quindi scegliere il tipo di schermatura ed effettuare un pre-dimensionamento;
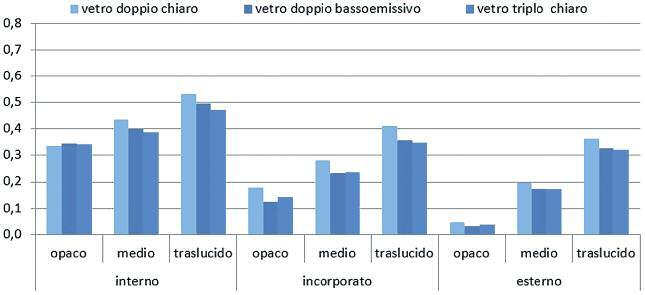
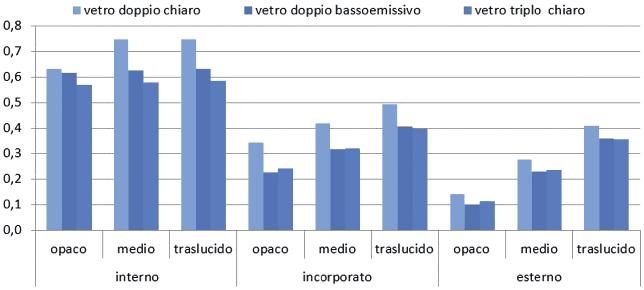
nelle fasi seguenti si procede alla definizione geometrica di dettaglio e alla risoluzione dei problemi tecnologici.
Analisi del soleggiamento
Per ciascuna chiusura trasparente occorre effettuare un’analisi del soleggiamento; questa può essere svolta attraverso la costruzione di una maschera d’ombra, assumendo un punto significativo della superficie e considerando come possibili ostruzioni sia il contesto, sia le parti dell’edificio stesso che possono proiettare ombre. La sovrapposizione della carta dei percorsi solari riferita alla località in esame permetterà di definire le ore di soleggiamento diretto della superficie
Individuazione del periodo di schermatura
Il periodo durante il quale la radiazione solare deve essere schermata, al fine di evitare effetti di discomfort e di surriscaldamento degli ambienti, dovrebbe essere definito in relazione alla temperatura dell’aria interna, determinata attraverso un bilancio energetico di tipo orario per ciascun giorno tipo medio mensile o, in modo semplificato, assumendo come parametro di riferimento la temperatura dell’aria esterna6 Le ore per le quali la temperatura dell’aria supera la soglia inferiore di com-
Confronto dei valori di fattore solare calcolati per alcuni schermi bianchi paralleli all’elemento vetrato, con posizione interna, incorporata o esterna rispetto al vetro (UNI EN 13363-1:2008)
Confronto dei valori di fattore solare calcolati per alcuni schermi neri paralleli all’elemento vetrato, con posizione interna, incorporata o esterna rispetto al vetro (UNI EN 13363-1:2008)
Fronte sud-est del corpo di fabbrica preso in considerazione: le chiusure trasparenti dell’ufficio sito al piano terra risultano protette da un rampicante su sostegni orizzontali in bambù, da un rampicante su grigliato in acciaio e da una tenda in paglia; al piano superiore è invece presente uno sporto orizzontale
fort (pari a 21 °C)7 dovranno essere riportate sulla carta dei percorsi solari sovrapposta alla maschera d’ombra, individuando l’ottimale ostruzione dello schermo
Definizione dello schermo
Poiché lo schermo ideale è quello che copre i percorsi solari nelle ore per le quali la radiazione solare non è desiderata, tale operazione può essere effettuata sovrapponendo alla maschera d’ombra che riporta i profili temporali di ombreggiamento, individuati al punto precedente, quella relativa al tipo di schermo considerato, opportunamente orientata e proporzionalmente scalata in modo tale da coprire le ore nelle quali occorre schermare
Le prestazioni di alcuni schermi verdi
Il monitoraggio è stato effettuato al fine di indagare il diverso comportamento termoigrometrico di tre tipi di schermature solari, valutandone l’efficacia in termini di controllo della radiazione solare estiva
Il monitoraggio è stato condotto presso la facoltà di Agraria di Torino, sita in Via Leonardo da Vinci a Grugliasco (TO), prendendo in esame due ambienti collocati su piani sovrapposti con fronte rivolto verso sud-est (con azimut solare pari a circa 40°) L’edificio è una tipica costruzione degli anni ‘80: la struttura è in calcestruzzo armato, i tamponamenti sono in laterizio e i serramenti hanno telai in alluminio e vetri a singola lastra, di tipo temprato
A ridosso delle chiusure trasparenti dell’ufficio sito al piano terreno, nella primavera 2012 sono stati collocati dei tutori e, nei contenitori posti alla base, sono state seminate delle piante rampicanti annuali a rapida crescita, nello specifico Ipomoea purpurea (L ) Roth, conosciuta con il nome di “Campanella blu”); i due tutori sono rispettivamente costituiti da una serie di elementi orizzontali in bambù, posti a interasse di 10-15 cm circa, e da un grigliato in acciaio a maglia più fitta Adiacente a quest’ultimo è stata posta una tenda in paglia, tipica della tradizione mediterranea Le chiusure trasparenti dell’ufficio sito al piano primo, invece, risultano essere protette da uno sporto orizzontale continuo, avente una profondità di circa 1 m.
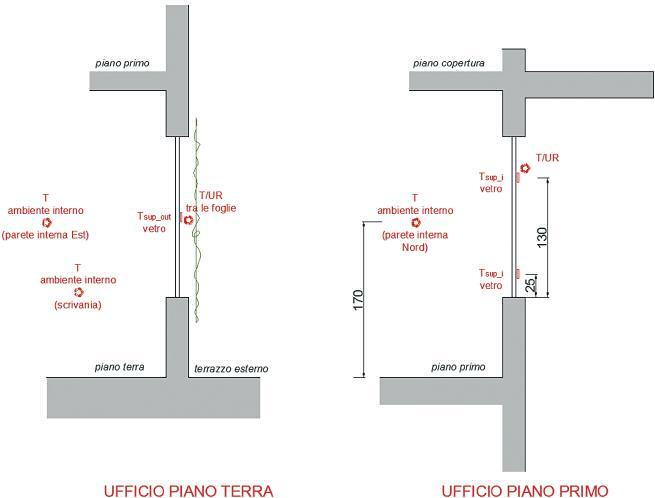

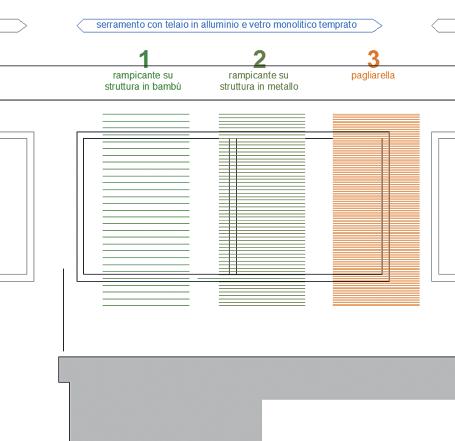
Fronte sud-est del corpo di fabbrica preso in considerazione: schema di collocazione dei tre sistemi di controllo solare posti a protezione della chiusura trasparente dell’ufficio al piano terra.
La campagna di misure è stata condotta a partire dalla ore 13 del 26 07 2012 e si è conclusa alle ore 10 del 31 07 2012 con un intervallo di 5 minuti. Inoltre sono state condotte misure spot per la valutazione di alcune grandezze caratterizzanti le schermature
Grandezze monitorate e modalità di misura
Il piano di monitoraggio, messo a punto sulla base di precedenti sopralluoghi, ha previsto la misura delle seguenti grandezze con un rilievo ogni 5 minuti: a) temperatura e umidità relativa dell’aria esterna in posizione
Schema di posa delle sonde ai piani terra (a sinistra) e primo (a destra)
Qui sotto, posizionamento delle sonde di temperatura, irradianza solare, flusso termico sulla superficie interna del vetro, nella parte retrostante il grigliato metallico con rampicante.
Più in basso, posizionamento delle sonde di temperatura e umidità relativa dell’aria, nella parte retrostante il sostegno in bambù con rampicante


ombreggiata a ridosso della parete del piano primo (in un punto) per caratterizzare le condizioni ambientali esterne;
b) temperatura e umidità relativa dell’aria interna dei due uffici (in due punti) per la valutazione delle condizioni ambientali interne;
c) temperatura e umidità relativa dell’aria esterna nella parte retrostante le tre schermature del piano terra (in tre punti);
d) temperatura superficiale esterna del vetro dei serramenti del piano terra nella parte retrostante le tre schermature (in tre punti);
e) temperatura superficiale esterna del vetro dei serramenti del piano primo, in posizione soleggiata e protetta dallo sporto orizzontale (in due punti);
f) flusso termico e irradianza solare sulla superficie interna del vetro dei serramenti del piano terra, nella parte retrostante il grigliato metallico con rampicante (in un punto)
Lo schema riportato nella figura a pagina 59 in basso mostra la collocazione delle diverse sonde di misura
Al fine di caratterizzare il fattore solare del sistema vetro più schermo, inoltre, sono stati effettuati rilievi spot dell’irradianza
solare, misurata rispettivamente sul piano di facciata (in posizione soleggiata) e sul piano interno del vetro (nella parte retrostante le tre schermature del piano terra), secondo punti casuali
Gli strumenti impiegati sono stati i seguenti:
• datalogger ALMEMO 2890-0 della ALBORN con sonde di temperatura dell’aria, temperatura superficiale, irradianza solare e flusso termico;
• datalogger TESTO 175-H2 con sensore di temperatura e umidità relativa dell’aria;
• datalogger EXTECH RHT10 con sensore di temperatura e umidità relativa dell’aria
Principali risultati
La funzione di regolazione climatica esercitata da uno schermo vegetale associa all’effetto di ombreggiamento il processo di evapotraspirazione; di conseguenza le temperature dell’aria intorno alle foglie e la temperatura radiante sul fogliame sono inferiori rispetto a quelle che si avrebbero con uno schermo artificiale La letteratura indica, infatti, che anche attraverso semplici schermi verdi è possibile abbattere la temperatura superficiale esterna di più di 4 °C nei mesi estivi8
Per caratterizzare i tre diversi sistemi schermanti è stata calcolata l’area che ostruisce la superficie vetrata attraverso l’openess factor (OF) che rappresenta la percentuale di superficie libera rispetto a quella schermata Tale analisi è stata condotta caratterizzando ogni pixel delle immagini dei tre schermi attraverso le diverse tonalità di colore (pixel recognition technique) con Adobe Photoshop® I diversi schermi analizzati hanno dunque gli openess factor OF come indicato nella tabella sottostante
I principali risultati di questa campagna di misura sono stati riportati nei grafici di pag 61 Dal grafico a) si può notare che la facciata, orientata a sud-est, non riceve più la componente di irradiazione solare diretta già verso le ore 15,30 del pomeriggio, con un abbassamento immediato della temperatura dietro agli schermi.
Il comportamento dei tre schermi, in assenza di radiazione solare diretta, è molto simile; quando colpiti direttamente dal sole, invece, risultano avere una diversa efficacia: in particolare, la pagliarella sembra attenuare in misura minore il picco di irradiazione solare Questo risultato potrebbe essere dovuto all’assenza del fenomeno di evapotraspirazione oltre che dal diverso openess factor; per la pagliarella esso è maggiore del 51% rispetto al grigliato e del 23% rispetto al bambù
Analizzando nel dettaglio l’andamento della temperatura superficiale del vetro esterno, nelle
rampicante bambù OF= 48%3

grigliato verde OP= 39% pagliarella OF= 59%


OP (Openess Factor) dei vari schermi analizzati
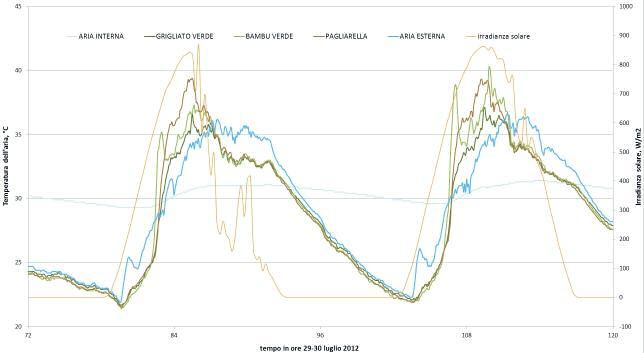
a) Andamento delle temperature dell’aria interna, esterna e sotto le diverse tipologie di schermo; i dati di irradianza solare sono ricavati dalla stazione meteo del Politecnico di Torino e fanno riferimento alla superficie orizzontale.
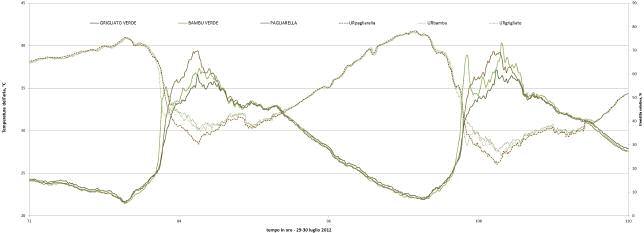
b) Andamento dell’umidità relativa sotto le diverse tipologie di schermo
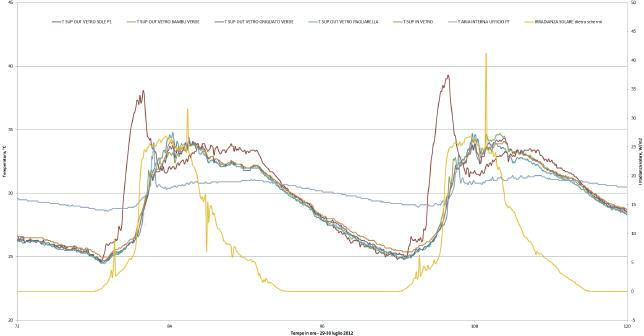
c) Andamento delle temperature superficiali della vetrata interna, esterna e sotto le diverse tipologie di schermo; i dati di irradianza solare sono stati misurati sul piano della finestra dietro gli schermi
diverse giornate, si osservano due variazioni anomale dietro il bambù: in particolare un picco verso le ore 11-11,30 (è il primo schermo a essere investito dal sole) e un successivo calo dovuto alla presenza di un grande albero che scherma parte della componente solare diretta incidente sullo schermo stesso
Nel grafico b) sono rappresentati anche i valori di umidità relativa dell’aria, misurati dietro le diverse tipologie di schermi Si nota come gli andamenti di temperatura e umidità relativa siano opposti: quando la temperatura aumenta, l’umidità relativa diminuisce e viceversa In particolare per la pagliarella, nelle ore di soleggiamento diretto, l’umidità relativa è inferiore ai valori del bambù e del grigliato
Nel grafico c) sono, infine, rappresentate le temperature superficiali del vetro (interna, esterna in posizione ombreggiata dallo sporto e dietro i tre sistemi schermanti) Anche in questo caso, in relazione alla temperatura esterna del vetro in presenza di sole (linea rossa), si può notare che essa presenta un massimo verso le ore 10 e diminuisce già attorno alle
11, quando la componente diretta dell’irradiazione solare viene schermata Anche la temperatura dell’ambiente interno presenta un massimo verso le 10,40, seguendo lo stesso andamento della temperatura superficiale del vetro non ombreggiata, nonostante tutte le finestre dell’ufficio siano schermate È inoltre opportuno osservare che, in presenza di irradiazione solare diretta, la pagliarella ha una minor efficacia rispetto al bambù e al grigliato verde
In ultimo, riguardo all’attenuazione della temperatura superficiale esterna del vetro, prodotta dagli schermi in presenza di irradiazione solare diretta, si registra, nei giorni di cielo sereno (27, 29 e 30 luglio) un’attenuazione della temperatura superficiale rispettivamente di 3, 4 e 6 °C, conformemente a quanto trovato in letteratura
Si prevede di effettuare una nuova campagna di misura nel 2013, in modo da poter confrontare con maggior efficacia le prestazioni delle tre tipologie di schermature. In particolare sarebbe interessante confrontare il bio-shading coefficient, calcolato mediante le equazioni trovate in letteratura9 e valutare il comportamento degli schermi anche in funzione della loro distanza dal vetro10
Dal punto di vista tecnologico, si pensa di apportare delle modifiche al sistema di ancoraggio del verde, al fine di ottenere una copertura più uniforme
Note
1 - D P R 59/2009, articolo 4
2 - Legge n 10/2013 - Norme per lo sviluppo degli spazi Verdi Urbani (in vigore dal 16/02/2013)
3 - V Corrado, S Paduos, La nuova legislazione sull’efficienza energetica degli edifici Requisiti e metodi di calcolo, Celid, Torino 2008
4 - UNI EN 13363-1 : 2008 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate Calcolo della trasmittanza solare e luminosa Metodo semplificato
5 - UNI/TS 11300–1 : 2008 - Prestazioni energetiche degli edifici Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale
6 - Tale metodo, proposto da Olgyay, fa riferimento alla temperatura dell’aria esterna, in quanto influente sulla temperatura dell’aria interna e discriminante nel comportamento spontaneo tenuto dagli utenti, al fine di regolare naturalmente le condizioni climatiche all’interno degli ambienti e preservare le condizioni di comfort
7 - Tale soglia può essere modificata in relazione alla destinazione d’uso e al sistema di climatizzazione presente; per ambienti caratterizzati da elevati apporti interni (ad es commercio, uffici ) si può assumere una soglia di 18 °C
8 - Wong N H , Tan A Y K , Chen Y , Sekar K , Tan P Y , Chan D , Chiang K , Wong N C , “Thermal evaluation of vertical greenery systems for building walls”, Building and Environment 45 (2010) 663-672
9 - Ip K , Lam M , Miller A , “Shading performance of a vertical deciduous climbing plant canopy”, Building and Environment 45 (2010) 81-88
10 - Perini K , Ottelé M , Fraaij A L A , Haas E M , Raiteri R , “Vertical greening systems and the effect on air flow and temperature on the building envelope”, Building and Environment 46 (2011) 2287-2294
prodotti schermature solari
ALLUMINIO
Kalzip® facciate perforate
sistemi fissi per facciate
Descrizione. Il sistema per facciate Kalzip® propone una vasta gamma di soluzioni per il controllo della luce e dell’irraggiamento Questo rivestimento consente di realizzare effetti sorprendenti: grazie ai diversi diametri dei fori è possibile infatti eseguire molteplici varianti offrendo la possibilità di distinguere il fabbricato anche in aree di immobili particolarmente sobri e uniformi I sistemi microforati per facciate sono disponibili in tutte le larghezze e lunghezze Kalzip® correntemente in uso, con bordatura verticale, finiture e superfici adatte a ogni esigenza Le lastre in alluminio possono essere diritte, convesse bombate, concave bombate La sottostruttura è installata in orizzontale o verticale, a blocco o distanziale
Utilizzo Kalzip® perforati protegge le facciate vetrate dalla luce e dall’irraggiamento solare, permette di caratterizzare le superfici differenziando tra ambiente pubblico e semipubblico, valorizzano visivamente un edificio e consentono una ristrutturazione economica delle facciate
Dati tecnici
Formato 50-65/333, 65/500, 65/305, 65/422, 50/429, 65/434-400 mm Spessore 1 mm
Colori Tonalità standard RAL, TitanColor, tonalità SoftColor e rivestimenti AntiGraffiti secondo scheda colori Kalzip, disponibili colori speciali a richiesta



KALZIP

Descrizione. La soluzione per i frangisole METRA si contraddistingue per un unico principio costruttivo che origina 13 tipologie, ovvero una lamella e due perni in acciaio che si posizionano nella sede centrale della lamella dove restano bloccati da tappi laterali. Le lamelle possono essere in alluminio estruso, di sezione ellittica di diverse larghezze, in lamiera di acciaio o di alluminio con sezione piatta o curva o in lastre di vetro temprato, di sezione piatta o curva con spessori variabili secondo i requisiti strutturali I montanti sono in alluminio estruso in barre Il profilo per il frangisole consente di applicare pannelli fotovoltaici laminati non intelaiati con spessore fino a 8 mm, larghezza 350 mm e lunghezza personalizzabile
La movimentazione è in grado di guidare le lamelle con inclinazione variabile, fornendo indubbi vantaggi in termini di utilizzo della luce e di termoregolamentazione climatica
Utilizzo I frangisole METRA proteggono dal surriscaldamento e dalle dispersioni notturne, consentono un adeguato risparmio energetico, il ricircolo d’aria e la ventilazione; possono essere collegate a un sistema di domotica con flessibilità di configurazione
ALLUMINIO / LEGNO /FOTOVOLTAICO
METRA frangisole
frangisole fissi o mobili


Dati tecnici
Lamelle alluminio estruso sezione ellittica
Larghezza 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 mm
Lunghezza 6500 mm
Lastre di vetro temprato sezione piatta o curva
Spessore da 10 a 14 mm
prodotti schermature solari
TERRACOTTA
TERREAL Shamal 14/20
grigliati e frangisole fissi o mobili
Descrizione. Terreal propone una vasta gamma di frangisole in terracotta di varie lunghezze, sezioni trasversali (quadrate, rettangolari e ovali) e colori, che si articolano in varie famiglie di prodotto.
Shamal, premiato con il Trofeo del design al Batimat 2003, è un elemento per frangisole di grande formato dal profilo ad ala di aereo Le elevate caratteristiche tecniche lo rendono idoneo anche in contesti dove è richiesta elevata resistenza ai carichi flessionali del vento e all’urto Vista la forma e l’inclinazione che può assumere il sistema - di solito posato orizzontalmente, possibilmente con leggera inclinazione rispetto all’asse verticale - Shamal assicura una reale protezione al sole e un migliore isolamento termico dell’edificio La terracotta è infatti un materiale con elevata inerzia termica, che ritarda e riduce le re-emissioni di energia assorbita. Disponibile in due larghezze da 14 e 20 cm, Shamal è conforme alle norme NF P 13304 e EN ISO 539 2 ed è proposto con finitura liscia o sabbiata e con un sistema di fissaggio anticorrosione

Utilizzo. Le possibilità di impiego del frangisole Shamal sono molteplici, innovative e moderne: si utilizza per la protezione dai raggi solari, al fine di migliorare le prestazioni termiche dell’involucro. I frangisole svolgono inoltre un pari ruolo come riflettori orizzontali: la luce incidente “rimbalza” via dalle superfici orizzontali dei frangisole e integra la luce diretta dovuta all’irradiazione solare, con luce indiretta che penetra più profondamente nella stanza

Colori disponibili bruno cioccolato, champagne, ebano, grigio perla, rosso arancio, rosa, rosso
Shamal® 14
Dimensioni – hxlxsp 46x840x140 mm - 46x1290x140 mm
Foro interno 28x24
Quantità per m2 1,19 - 0,78
Peso unitario 6,0 - 9,2 kg
Modulo 200x900 - 200x1350 mm
Shamal® 20
Dimensioni – hxlxsp 46x840x140 mm - 46x1290x140 mm
Foro interno 28x24
Quantità per m2 1,19 - 0,78
Peso unitario 8,4 - 12,9 kg
Modulo 200x900 - 200x1350 mm
Dati tecnici
ALLUMINIO, LEGNO E XPS
UNIFORM grigliati e frangisole
grigliati e frangisole fissi o mobili
Descrizione. I grigliati e i frangisole di Uniform prevedono l’impiego di lamelle che possono essere in rovere lamellare, in alluminio o in materiale isolante XPS (Polistirene Estruso Espanso) con effetto legno. Le lamelle sono montate su telai in alluminio leggeri e poco invasivi, agganciabili al contesto edile o alla facciata continua Unitherm I fissaggi rimangono occultati alla vista e permettono la rimozione delle lamelle per eventuali interventi di manutenzione Le lamelle possono essere verticali oppure inclinate a seconda delle esigenze del cliente
L’ingombro complessivo del frangisole è pari a 77 mm mentre nei grigliati l’ingombro totale è di 31 mm
Le lamelle in legno sono verniciate con finiture standard, a scelta da cartella colori o a campione Le lamelle in alluminio possono essere rifinite in tinta con il telaio, mentre le lamelle in XPS sono pigmentate in pasta ed hanno una goffratura superficiale con effetto legno
Utilizzo. I frangisole e grigliati consentono di proteggere le facciate degli edifici o i singoli serramenti dall’irraggiamento solare diretto, al fine di ridurre il surriscaldamento e controllare la luminosità degli ambienti interni migliorando il comfort abitativo

A lato: a sinistra Grigliati Uniform, a destra Frangisole Uniform Sotto: Mixed used building - Tortona 37, Studio Matteo Thun & Partners
prodotti schermature solari
ALLUMINIO / CELLE FV
WICSOLAIRE
frangisole
Descrizione. Nella progettazione di un nuovo edificio o una riqualificazione è fondamentale determinare l’apporto dell’irraggiamento solare e dell’illuminazione naturale È quindi necessario modulare sia la quantità di luce naturale entrate al fine di limitare quella artificiale, sia la quantità di calore per ottimizzare i consumi per il raffrescamento e riscaldamento Altresì è importante, in caso di facciate vetrate, limitare al massimo l’effetto serra che si potrebbe creare all’interno degli ambienti Spesso, la tipologia del vetro, da sola non è sufficiente a creare uno sbarramento al surriscaldamento
I sistemi di pale frangisole in alluminio rappresentano uno strumento innovativo per gestire e modulare la quantità di luce e di calore entranti in un edificio, controllando il guadagno termico solare attraverso radiazioni e riducono l’energia necessaria per il raffreddamento.

I frangisole possono essere a pale monoblocco o composte, a pale fisse con differenti inclinazioni e distanza tra le lamelle, verticali od orizzontali, seguendo le indicazioni progettuali, oppure possono essere movimentati manualmente o con motorizzazione
Le pale possono inoltre essere equipaggiate con celle fotovoltaiche policristalline e monocristalline, trasformando il sistema passivo di ombreggiatura in un impianto di potenza attiva Utilizzo. I frangisole a pale in alluminio WICSOLAIRE rispondono nel modo migliore alla progettazione attenta al bilancio energetico e sostenibile di un edificio Accessori a pezzo e a lunghezza completano il sistema per l’installazione sulle facciate WICONA o su sottostrutture fisse e per il collegamento alla rete elettrica

Pala fotovoltaica WICSOLAIRE
Larghezza 215 mm
Lunghezza 1200 mm
Celle fotovoltaiche
Tipologia policristallino e monocristallino
Varianti pala
7 celle policristalline su tedlar bianco, 27 Wp
7 celle monocristalline su tedlar nero, 28 Wp
Caratteristica valore
WICONA www wicona it
Dati tecnici
FILM METALIZZATO A BASE POLIMERICA
SKYLITE S20X
pellicola per vetri

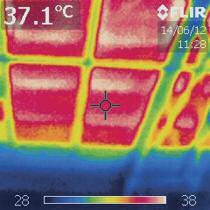
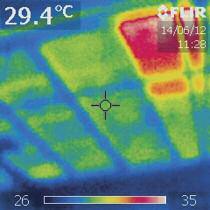
Dati tecnici
Spessore 65 µm
Coefficiente di schermatura 0,20
Fattore solare 0,17 g
Proprietà ottiche e solari
Luce visibile trasmessa 15%
Luce visibile riflessa 63%
Riduzione ultravioletti 99,9%
Riduzione abbaglio 83%
Totale energia solare riflessa 64%
Totale energia solare trasmessa 10%
Totale energia solare assorbita 26%
Totale energia solare respinta 83%
FOSTER
Descrizione. Le pellicole delle serie SKYLITE S20X, robusti film metallizzati a base polimerica, rappresentano la soluzione ideale per tutti i problemi di irraggiamento solare di lucernari e/o di coperture zenitali realizzate in vetro o in materiale plastico Esse respingono l’energia solare mantenendo gli ambienti interni freschi, confortevoli e senza abbagliamenti; proteggono dal 99% dei raggi UV che provocano lo sbiadimento degli arredi e mettono a rischio la salute; alleviano l’affaticamento oculare riducendo l’abbaglio fino al 83% SKYLITE S20X permette la riduzione del carico termico zenitale, eliminando il fastidioso “Heat Gain” alle persone che transitano nella zona sottostante i lucernari
Questi sistemi filtranti sono conformi alle linee guida per per la Certificazione energetica degli edifici, come da D P R 59/ del 2009 che definisce e introduce l’utilizzo dei sistemi filtranti ovvero pellicole polimeriche autoadesive applicabili sui vetri, sul lato interno o esterno, al fine di ridurre i consumi di energia negli edifici
Utilizzo. L’impiego delle pellicole solari consente di ridurre l’utilizzo degli impianti di raffrescamento, con conseguente riduzione della potenza impegnata e del consumo globale di energia elettrica, in particolare se l’applicazione avviene sugli edifici esistenti.

impianti fotovoltaico
Pierluigi Bonomo
Dottore di Ricerca in Ingegneria Edile/Architettura U E
Pierluigi De Berardinis
Docente di Architettura Tecnica II presso l’Università degli Studi dell’Aquila
L’INTEGRAZIONE DEL FOTOVOLTAICO Verso nuove frontiere
I moduli fotovoltaici integrati sono diventati un componente tecnologico della costruzione ed elemento caratterizzante l’edificio, anche negli interventi di retrofit. Componente che, oltre alla funzione energetica, svolge così anche il ruolo di elemento architettonico e costruttivo.
L’effetto fotovoltaico (FV) consiste nella conversione della radiazione solare in energia elettrica Ciò avviene grazie alla fotoattività di alcuni materiali come i semiconduttori (ad es il silicio) che, esposti all’irraggiamento solare, sono in grado di originare un flusso di corrente con una certa efficienza di conversione Sebbene gli aspetti impiantistici ed elettrici richiedano la competenza di specialisti di settore, la conoscenza di nozioni basilari è oggi sempre più richiesta anche nella fase della progettazione architettonica e tecnologica dell’involucro edilizio per evitare errori grossolani o risultati penalizzati dalla mancata integrazione di tutti i componenti Un impianto FV può dunque schematizzarsi come un sistema composto da elementi primari e parti complementari Ai primi appartengono il generatore (stringhe di moduli connessi tra loro con la funzione di produrre energia elettrica), l’inverter (con la funzione primaria di convertire la corrente continua in alternata) ed eventuali accumulatori (tipici di sistemi stand alone) Gli elementi complementari possono invece essere sia di tipo elettrico (cablaggi,
dispositivi di sicurezza, contatori ecc ) che edilizio (strutture di montaggio, elementi di correlazione ecc ) Le modalità di funzionamento sono quelle di impianto grid-connected, di impianto con accumulatori oppure di sistemi stand-alone La diffusione di sistemi con differenti qualità richiede oggi, da parte dei progettisti, un maggior sforzo “critico” anche sulla definizione degli aspetti energetici del FV, troppo spesso stabiliti in maniera avulsa dal contesto in cui ci si trova a operare: le caratteristiche di efficienza e di conversione delle celle, i criteri di posizionamento adeguato dei moduli, le strategie per la limitazione dell’ombreggiamento e dell’imbrattamento, le soluzioni ideali per il controllo della temperatura ecc L’industria edilizia rende da qualche tempo disponibili, su larga scala, prodotti e sistemi riconducibili a due diverse generazioni: i sistemi in silicio cristallino (mono o poli) e i thin film depositati (tipo silicio amorfo, CIS, CdS, CdTe, CIGS)1 I primi, oggetto di una progressiva evoluzione tecnologica negli ultimi decenni, devono le loro origini alla prima cella di silicio studiata negli anni ‘50 presso i Bell

Il Centre for Interactive Research on Sustainability di Vancouver (CAN) Progetto: Perkins+Will (Photo: Martin Tessler / Courtesy: Perkins+Will)


La b ora tories mentre i secondi, meno consolidati nel nostro paese, risalgono ad alcune ricerche compiute negli anni ‘70 in USA Il rapporto dei progettisti con le diverse tecnologie ha visto, soprattutto in Italia, il manifestarsi di una preferenza di massa verso i sistemi cristallini, spesso in virtù del loro alto rendimento È noto tuttavia come le buone prestazioni con luce diffusa e con basso irraggiamento, la tipica minor sensibilità alla temperatura, la leggerezza (sia materiale che ambientale) e la possibile flessibilità dei supporti contraddistinguano, al contempo, delle peculiarità dei thin film che occorrerebbe ri-considerare nelle scelte progettuali, anche alla luce dei possibili vantaggi ricavabili in alcuni contesti climatici È evidente come il minor rendimento comporti una maggiore superficie richiesta a parità di potenza installata (che tuttavia non vuol sempre dire maggior costo) Unitamente a queste due famiglie, tuttavia, la ricerca di base oggi propone materiali fotoattivi di “terza generazione”, già disponibili su un mercato di nicchia: celle solari di origine polimerica, a base di coloranti o composti organici (come
In letteratura il tema del BiPV trova spazio da diversi anni in ricerche di livello internazionale Dal 1997 al 2001, il Task 7 dell’International Energy Agency (IEA-PVPS, Photovoltaic power systems in the built environment)5 conduce una prima ricerca ponendosi come “obiettivo quello di migliorare la qualità architettonica, la qualità tecnica e la sostenibilità economica dei sistemi fotovoltaici nell’ambiente costruito per rimuovere le barriere alla loro introduzione come opzione energetica significativa”. Dalla fine del 2008 il Task 41 IEA-SHC6 riprende la ricerca “Solar Energy and Architecture” che ripropone come tema di base quello di favorire “l’architettura di alta qualità per edifici che integrano sistemi solari” Le outcomes disponibili da qualche mese riportano dei criteri per i progettisti e per i produttori, la predisposizione di strumenti d’ausilio per la fase di progettazione e la raccolta di una serie di prodotti e casi-studio di riferimento In Italia il riverbero di questo specifico know-how di respiro internazionale trova in questi anni come principale strumento i diversi “Conto Energia” che, nell’arco delle cinque edizioni prodotte dal 2005, si sono prefissati (con diversi approcci e vari gradi di successo) di incoraggiare la diffusione degli impianti a “integrazione architettonica totale” o, come più recentemente definiti, “integrati con caratteristiche innovative”7 È chiaro a tutti come il motore di crescita del settore sia stato soprattutto quello economico-finanziario, a fronte di una normativa nazionale che soltanto con il D lgs 28/11 ha reso ef-
fettivamente obbligatoria l’installazione sugli edifici (in quantità peraltro abbastanza limitata) nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazioni rilevanti In ambito normativo il concetto di integrazione è dunque passato dalle prime “guide” del G.S.E. che ponevano non pochi dubbi sulle distinzioni fra sistemi a integrazione “parziale” e “totale”, fino ai correnti criteri che prevedono “moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici”, concepiti per svolgere anche le funzioni dell’elemento edilizio sostituito; è evidente come tali criteri siano oggi entrati nel merito dell’integrabilità tecnologico-costruttiva del fotovoltaico A fronte di alcuni sistemi già disponibili per il BiPV, l’assenza di specifici standard normativi e di certificazioni sulle componenti per “l’integrazione su edificio” pongono spesso in difficoltà progettisti e installatori Basti pensare ai criteri di sicurezza vigenti per le applicazioni vetrarie secondo la UNI 7697, per incorrere nell’incertezza circa l’ammissibilità di pensiline solari realizzate con l’impiego di moduli tradizionali (tipicamente non stratificati con PVB) Così, anche relativamente ad altri requisiti, emerge l’esigenza di rendere disponibili per i numerosi produttori di sistemi BiPV, una serie di criteri di qualità finalizzati al riscontro e alla certificazione dei requisiti previsti per gli elementi di fabbrica edilizi (UNI 8289, UNI 8290, CPD 89/106/CE) Il settore del fotovoltaico si trova dunque, da un lato, a inseguire un progressivo abbassamento dei costi ma, dall’altro, a dover fare i conti con l’ingresso nel mondo dell’involucro edilizio e con le relative complessità prestazionali e concettuali. Alcune normative in preparazione, come la “prEN 50583:2012” Photovoltaics in buildings” del CELENEC, stanno introducendo un simile percorso di normazione8 Nell’attesa, le best-practices di ricercatori, progettisti, industrie e installatori a livello internazionale hanno già tracciato diverse vie e dato concreti segnali per ripensare il fotovoltaico non solo come oggetto tecnico e impiantistico ma anche come affidabile componente edilizia di qualità e come nuovo materiale dell’architettura contemporanea
il succo di arance o di uva), celle di captazione tridimensionali, tecnologie che promettono efficienze record, oppure film di nuova generazione producibili ink-jet e stampabili “roll-to-roll” in atmosfera libera. Alcune sperimentazioni prospettano addirittura l’incorporazione di particelle fotovoltaiche all’interno di tessuti in materiali fibrorinforzati che potrebbero essere tagliati su misura2
Il fotovoltaico in edilizia: verso nuove frontiere
Con l’introduzione degli impianti in architettura nasce la variabile progettuale dell’integrazione impiantistica (vedi immagini alle pagg 68-69) I temi dell’eco-sostenibilità e dell’uso razionale delle risorse tornano oggi a costituire degli irrinunciabili fattori di qualità del costruire Nel complesso paradigma della sostenibilità, l’obiettivo dell’efficienza energetica si basa su due strategie complementari: la riduzione della domanda energetica, ossia la razionalizzazione e l’efficienza degli usi finali e l’autoproduzione di energia pulita attraverso l’impiego delle fonti rinnovabili Anche i migliori edifici ecologici, infatti, in regime d’uso hanno bisogno di una certa quantità di “running energy”, benché ridotta al minimo: “la frontiera” a cui siamo chiamati è dunque quella di trasformare l’involucro edilizio da puro consumatore ad auto-produttore di energia pulita e rinnovabile. Nell’ottica europea degli edifici “Nearly Zero Energy” è
indiscutibile la potenzialità del fotovoltaico (FV), considerate anche la crescita del settore e le politiche di sostegno nei diversi paesi Affinché l’innovazione in edilizia possa procedere di pari passo con il costante progresso della ricerca di base, occorre portare avanti un parallelo processo di trasferimento tecnologico in architettura Nell’odierno impiego del FV a scala diffusa, spesso è invece doveroso parlare di applicazione più che di integrazione In molti casi, infatti, i pannelli solari appaiono sovrapposti all’edificio come un corpo estraneo, non svolgendo alcun requisito previsto per gli elementi di fabbrica Ancor più raramente essi sono concepiti come mezzo di caratterizzazione linguistica dell’organismo edilizio, rinunciando alle potenzialità espressive e semantiche dimostrate da questo nuovo “materiale” dell’architettura contemporanea Da qualche tempo il D.lgs 28/11 ha reso obbligatoria la presenza dei sistemi FV sia per nuovi edifici che per ristrutturazioni rilevanti e una delle sfide dei prossimi anni sarà affidata al retrofit del patrimonio edilizio esistente Il recupero del costruito “ordinario” configura l’opportunità di ri-qualificarne l’assetto architettonico e prestazionale per apportare un nuovo carattere e una nuova qualità tecnologica alle obsolete e degradate “machine à habiter” Anche gli insediamenti più antichi, per evitare il definitivo abbandono come nei contesti della ricostruzione post-sismica, dovranno aprirsi a logiche di recupero che non rinuncino al “giusto” contributo tecnologico nell’ottica della “trasformazione controllata”, aprendosi anche ai temi delle fonti rinnovabili
A destra, in basso, recupero, miglioramento sismico e riqualificazione energetica di un casolare a L’Aquila, con copertura FV integrata all-black Lo studio del sistema ha previsto il coordinamento geometrico sul tetto a falda con il ritaglio di “moduli passivi” e un’attenzione all’omogeneità cromatico-percettiva risolta grazie all’uso di morsetti in tinta, moduli solari all-black, griglia di correlazione e lattonerie in tinta (progetto: P. Bonomo; installazione FV: Solis SpA)
Verso queste nuove “frontiere”, storia, paesaggio, architettura e tecnica dovranno fondersi in una nuova cultura sperimentale basata su un ritrovato rapporto fra “disciplina e libertà, memoria e invenzione, natura e tecnologia”
Integrazione del fotovoltaico
Il tema dell’“integrazione” del FV è noto sul panorama internazionale con l’acronimo BiPV (Building Integrated Photovoltaics), con cui ci si riferisce a un principio o, più in generale, a un criterio progettuale secondo il quale il sistema solare è concepito, oltre che dal punto di vista energetico, anche nel ruolo di elemento architettonico e costruttivo (doppia funzione) dell’involucro Il modulo FV integrato, non più pensato come corpo applicato o sovrapposto sull’edificio, diviene elemento tecnologico dell’apparecchiatura costruttiva e strumento di caratterizzazione del linguaggio architettonico Nel lessico di settore è da qualche tempo penetrata la terminologia “integrazione di fonti rinnovabili” o “integrazione del fotovoltaico”, ma cosa vuol dire effettivamente integrazione? Il termine integrazione configura l’atto, ossia l’effetto dell’integrare o dell’integrarsi L’analisi del rapporto fra sistema FV, organismo edilizio e contesto chiama in causa il coordinamento unitario di una serie di relazioni che vanno al di là degli aspetti di natura energetica o, a ogni modo, di carattere mono-disciplinare Il progetto di integrazione del FV va dunque riconosciuto come il luogo di confronto e mediazione di diversi e, spesso conflittuali, livelli di complessità e scale di riferimento e d’osservazione Non di rado emergono risvolti, allo stesso tempo, alla scala urbana e del dettaglio costruttivo o figurale, ovvero l’esigenza di compromesso fra parametri scientifici (rendimenti, potenze, quantità energetiche ) e aspetti interpretativi (aspetti estetici, valori spaziali,

visivi, culturali …). Volendo schematizzare tale complessità attraverso una griglia semplificata di lettura, si possono riconoscere alcune classi di integrabilità fotovoltaica come sintesi delle principali relazioni che caratterizzano l’ambito del BiPV3 Tra le diverse “integrazioni” possibili, ciascuna delle quali aprirebbe a un particolare ramo di approfondimento, sono state individuate le seguenti: normativa, morfologico-figurativa, edilizio-prestazionale, tecnologico-costruttiva, morfologico-figurativa, bioclimatico-ecologica, impiantistica, contestualepaesaggistica e sull’esistente (vedi schema in basso)
FV e linguaggio architettonico: integrazione figurativa
Già negli anni ‘70 ci si poneva il problema della possibile soluzione estetica per gli impianti che (come quelli di climatizzazione, all’epoca) erano in grado di partecipare, per il loro ingombro fisico e per la capacità di generare forme, alla genesi architettonica e linguistica dello spazio Oggi, nel caso degli impianti FV, è evidente l’opportunità di assumere un ruolo architettonico rilevante, vista l’esigenza di occupare i fronti più esposti e privilegiati dell’edificio per l’esposizione alla radiazione solare. Finora tuttavia l’atteggiamento prevalente si è basato su una prevaricazione della funzionalità impiantistica rispetto ai temi dell’intenzionalità architettonica o “denuncia visiva” Fra gli anni ‘70 e ‘80 alcuni pionieri dell’architettura già sperimentavano l’integrazione dei dispositivi solari attivi, oggi culminato nei modelli Nearly-ZEB o Plusenergiehaus L’integrabilità morfologico-figurativa può essere dunque letta nella capacità del sistema FV di contribuire a esprimere le forme linguistiche e le norme che regolano la struttura e la composizione del linguaggio architettonico dell’organismo edilizio Il controllo


Schema delle classi di integrabilità fotovoltaiche (elaborate nell’ambito della tesi di dottorato di ricerca dell’autore)
Scala di osservazione
CELLA FV*
STRATIFICAZIONE
DEL MODULO
CARATTERISTICHE
DEL MODULO
Parametri da considerare
Forma e dimensione
Texture, variazione di grana, cristallografia
Colore
Contatti elettrici
Trasparenza
Vetro anteriore
Strato antiriflesso (A R C )
Incapsulamento-sigillatura
Materiale posteriore
Forma e dimensione
Densità e modalità di assemblaggio delle celle
Tipo di cornice
Fissaggi
Sfondo
Flessibilità
* La possibilità di controllo dei parametri dipende anche dal tipo di cella, cristallino o a film sottile
Parametri di controllo del linguaggio architettonico a scala del componente
A destra, il linguaggio architettonico a scala dell’edificio Ideogramma delle strategie progettuali identificabili in relazione al grado di riconoscibilità del sistema FV nella caratterizzazione morfologico-figurativa dell’organismo edilizio
del linguaggio architettonico alla scala del materiale e degli elementi costruttivi risulta un primo aspetto fondamentale nella caratterizzazione espressiva che include parametri e caratteristiche sempre più personalizzabili (dal colore, alla texture, alla stratificazione del modulo ) fra cui quelle sintetizzate nella tabella qui in alto Nell’analisi alla scala del componente costruttivo, possono essere distinti differenti livelli di lettura: la cella, quale unità materiale di base e il modulo fotovoltaico, come prodotto complesso, primo risultato di alcune forme di assemblaggio materico e figurativo. Il “componenting design” consente di esercitare una prima riflessione sulle unità semplici di significato architettonico, con l’obiettivo di controllare le possibili forme compositive ravvisabili a tale livello elementare. Passando alla scala dell’organismo edilizio, possono essere identificate diverse strategie progettuali secondo il criterio della riconoscibilità linguistica del FV: dalla mimési, in cui la sua presenza non è percepibile, fino all’integrazione vistosa e al collage, passando per l’integrazione “moderatamente riconoscibile” (vedi schema in alto a destra) Ciascuna di queste “intenzionalità progettuali” rappresenta il risultato di una delicata ponderazione di fattori architettonici e tecnologico-costruttivi Una situazione esemplificativa, in tal senso, è quella delle soluzioni d’involucro tecnomorfe4 L’idea di integrazione in tal caso sposta l’attenzione dall’espressività della pelle edilizia alla morfogenesi dell’organismo architettonico dove l’edificio nasce come sintesi morfologica di alcuni parametri di integrabilità fotovoltaica quali ad es l’orientamento e l’inclinazione ottimale, l’assenza di ombreggiature
FV e costruzione: integrazione tecnologico-costruttiva
Il “trasferimento tecnologico” dei sistemi FV apre la strada a inedite occasioni di evoluzione prestazionale dell’organismo edi-
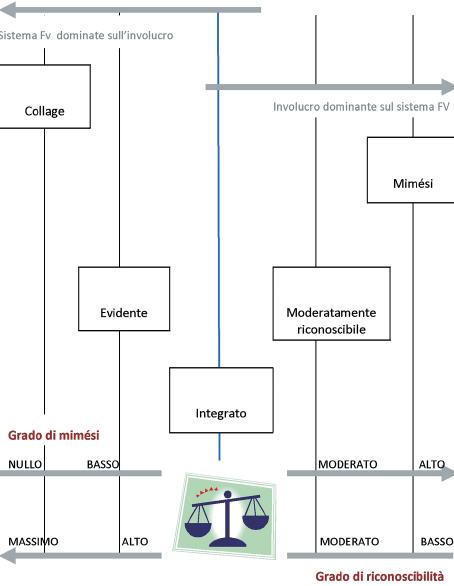
lizio, luogo di una crescente accumulazione funzionale e complessità tecnica, che lo sta trasformando in un’interfaccia sempre più sensibile, efficiente, ecologica e multi-performante Il FV è ormai entrato a pieno titolo nella famiglia degli elementi costruttivi dell’involucro Nearly-ZEB La progressiva coincidenza con gli elementi costruttivo-funzionali dell’apparecchiatura costruttiva non rende più equiparabili questi dispositivi a meri terminali impiantistici Una prima lettura dell’integrazione costruttiva può esser fatta con la definizione del cosiddetto grado di integrazione che, riferito ai diversi elementi di fabbrica (copertura, chiusura verticale ), rappresenta il livello di qualità del sistema BiPV rispetto alla griglia di requisiti edilizi ed energetici. Senza entrare nell’osservazione analitica di tali aspetti su casi specifici, si possono definire i seguenti gradi Applicazione indipendente: corrisponde all’assenza di coordi-

Un esempio di integrazione fotovoltaica nel quartiere di Vauban a Friburgo - D (foto: arch. Carmela Palmieri).
Impianto fotovoltaico su edificio industriale
L’impianto fotovoltaico qui illustrato è uno dei più grandi della provincia di Varese (312 kWp) ed è stato montato a Gerenzano sul tetto dell’edificio che ospita laboratori per la ricerca dell’Insubrias Biopark, ricoprendolo interamente
In soli 5 mesi, dal 4 agosto al 17 dicembre 2008, l’azienda fornitrice e appaltatrice (Eca Technology Spa di Grisignano, VI) ha installato, e allacciato alla rete elettrica pubblica, l’impianto I lavori hanno anche compreso la bonifica delle lastre di amianto presenti nella copertura e il rifacimento del tetto, isolato secondo quanto previsto dal D G R 5773 (trasmittanza 0,30 W/m2K)
Il campo fotovoltaico è composto da 1.388 moduli policristallini testurizzati da 225 Wp. L’adozione di celle testurizzate consente di incrementare l’efficienza della cella in tutti i momenti della giornata, anche quando c’è meno luce diretta, in quanto la testurizzazione della cella fotovoltaica crea una superficie sagomata con delle piccolissime piramidi, impercettibili a occhio nudo, che aumenta la superficie captante e le riflessioni reciproche della luce
L’impianto è completato da 44 inverter di potenza nominale 7 kW, tensione 230 Vca, per una potenza massima di 312 kWp e una produzione annuale stimata di progetto di 296 000 kWh

A distanza di 5 anni dalla realizzazione, l’impianto si conferma estremamente efficiente, rendendo, dati direttamente avvalorati dello stesso laboratorio, il 10% in più rispetto alle stime di producibilità iniziale previste
Un servizio di monitoraggio, manutenzione e assistenza, che comprende una costante analisi da parte di tecnici specializzati, previene il verificarsi di anomalie tecniche (piccole o grandi) delle quali il proprietario dell’impianto difficilmente può accorgersi e che possono causare nel tempo la perdita di produzione dell’impianto Il monitoraggio inoltre verifica il rendimento dell’impianto al fine di controllare che questo resti perfettamente in linea con gli standard di efficienza ottimali attesi
La tariffa assegnata all’impianto dal GSE, con il secondo Conto Energia, è di 0,462 eur/kWh, tariffa per un impianto totalmente integrato, con una maggiorazione del 5% dovuto alla contestuale bonifica dell’amianto.
Dati impianto
Potenza impianto 312,3 kWp
Moduli Fotovoltaici n 1388, in silicio policristallino testurizzato da 225 Wp ECA Technology
Inverter n 44, SMA
Produzione annua totale prevista 296.000 kWh
Tariffa GSE 0,462 eur/kWh (impianto totalmente integrato + 5% della tariffa grazie alla bonifica dell’amianto)

Sopra, alcuni inverter SMA installati
A destra, l’impianto fotovoltaico da 312 kWp realizzato da ECA Technology Spa presso Insubrias Biopark, Gerenzano (VA)
namento prestazionale fra i sistemi involucro e impianto, i quali rispondono ai propri requisiti, edilizi ed energetici, in maniera autonoma L’edificio ha il mero ruolo di supporto dei pannelli
Applicazione per sovrapposizione: i moduli FV sono collocati a poca distanza dall’involucro, in modo da adattarsi alla sua configurazione Non c’è alcuna sostituzione fisica degli elementi costruttivi base dell’organismo edilizio se non, indirettamente, per funzioni secondarie (protezione dalla pioggia battente, dal sole ecc )
In teg ra zion e com p lem en ta re: il modulo sostituisce lo strato esterno della chiusura svolgendo alcune sue funzioni tipiche (rivestimento, manto di copertura ecc ) Avviene la surrogazione dello strato dell’unità tecnologica secondo il principio del corpo
multiplo (vedi immagini a pag 74, in alto a destra)
Integrazione totale: non è più separabile, tanto materialmente quanto funzionalmente, lo strato FV dai restanti elementi costruttivi della chiusura edilizia L’elemento di fabbrica unitario, multi-performante e polivalente, soddisfa in maniera unitaria tutti i requisiti tecnologici energetici ed edilizi (vedi immagine a pag 75, al centro)
Da tale schematizzazione emerge come i sistemi BiPV possano ricoprire diversi ruoli costruttivi all’interno degli elementi di fabbrica dell’organismo edilizio L’ingresso nell’abaco degli elementi costruttivi base delle chiusure edilizie a corpo multiplo, ha dato esito in questi anni a molteplici soluzioni quali coppi, tegole, scandole, lastre e membrane solari (per coperture) o mo-
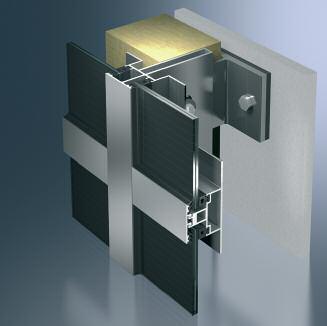

I principi costruttivi dell’involucro fotovoltaico
Il percorso d’innovazione che ha accompagnato negli anni il FV in architettura è passato da una componentistica inizialmente governata da logiche proprie, con moduli non molto diversi da quelli impiegati sui satelliti spaziali, a una produzione man mano più congruente con le peculiarità degli elementi tecnici per l’edilizia Tale percorso si è inizialmente dedicato a migliorare la “convivenza” costruttiva tra i nuovi moduli solari e le unità tecnologiche tradizionali dell’involucro, facendo fronte, via via, alla risoluzione di problemi di varia natura sul come integrare:
- la tipologia e la qualità delle connessioni fisiche con le chiusure esistenti (si pensi a tutti i sistemi basati sull’uso di frames, morsetti e ganci per copertura); - la compatibilità chimico-fisica e costruttiva con i materiali tradizionali; - l’integrazione di vecchi e nuovi requisiti funzionali ecc
A tale originaria ricerca di adattamento dell’impianto sull’edificio è seguita una rivoluzione concettuale che è passata dalla visione del terminale energetico installato, ossia del FV come corpo aggiunto sugli edifici, a quella di FV come parte integrante e caratterizzante del sistema tecnologico e architettonico dell’involucro Il passo successivo è stato quello della stratificazione delle chiusure edilizie complesse con componenti solari, in tal modo ottimizzati alla duplice funzione di elementi (impiantistici ed) edilizi
Tale “avvicinamento” all’edificio ha aperto la ricerca ai temi del linguaggio architettonico e dell’integrazione costruttiva del sistema FV, in tal modo elevato al rango di protagonista della qualità edilizia In questo caso il FV, integrato secondo il principio costruttivo del corpo unitario, diviene parte essenziale della strategia costruttiva, funzionale e prestazionale della chiusura edilizia, influendo su importanti requisiti quali il controllo del benessere termico e visivo (si pensi alle facciate continue con vetri solari) Lo sviluppo di nuovi materiali custom made rende il FV sempre più personalizzabile e, in alcuni casi, tende a trasformarlo in un ingrediente “fuso” all’interno di nuovi concept, sintesi di avanzata tecnologia e sostenibilità Facciate ventilate fotovoltaiche
Principio costruttivo del sistema FV Ruolo tecnologico del FV rispetto all’involucro
Evoluzione dell’involucro tradizionale
Corpo aggiunto Protesi Adattamento
Corpo multiplo
Corpo unitario
Corpo hi-tech
(Fonte: Schüco).
Stratificazione
Integrazione
Sostituzione
Ottimizzazione
Multifunzionalità
Nuovo concept
Schema dei principi di innovazione tecnologica dell’involucro fotovoltaico.
duli di rivestimento (per facciate ventilate) La logica di base, seppure a volte piegata alla ri-collocazione del FV all’interno di archetipi costruttivi, è stata quella dell’“ottimizzazione” dei componenti tradizionali al ruolo integrativo di produzione energetica Si pensi, ad esempio, ai moduli FV opachi per facciate ventilate o agli elementi di tenuta per coperture discontinue (tegole, coppi ) o continue (membrane, lastre) Nel seguente passaggio dalla “tegola” alla copertura solare, così come in quello dal “modulo” al rivestimento, può essere letto il salto concettuale dall’elemento base all’elemento costruttivo funzionale Tale transito da componente a sistema implica la definizione delle correlazioni, delle unioni e delle regole di combinabilità e accoppiabilità Nel progetto del sistema sorge, in altre parole, la necessità di ricorrere a parti complementari di mediazione fra i “moduli” solari e i restanti strati d’involucro. Ne sono un esempio alcune soluzioni per copertura comprensive di strati di sottomanto e di sistemi di giunto finalizzati al soddisfacimento dei diversi requisiti (tenuta all’acqua, tenuta meccanica ) In una chiave di lettura sensibile al rapporto “tra pensiero e costruzione”, a ciascuna delle strategie “semantiche” dette in precedenza è legata una coerente logica costruttiva ossia un certo studio dei sistemi, dei pacchetti, delle correlazioni e delle interfacce tecnologiche. In molti casi, tuttavia, a parità di sistema tecnico la percezione espressiva, come già detto, è rimessa alla scala della cella e del modulo Occorre perciò riconoscere la centralità del progetto, come reale mezzo risolutore delle questioni poste Non è un caso che mentre nella pratica diffusa occorre ancora diffondere criteri basilari d’integrazione, in altri esempi l’involucro appare in grado di rispondere ai criteri di eco-sostenibilità con forme e tecnologie spettacolari ed evolute.
Note
1 - Celle in silicio amorfo, realizzate attraverso la deposizione catodica di atomi di silicio gassificati; celle CIS (Copper, Indium, Selenium) utilizzano una miscela di Rame, Indio e Selenio, Diseleniuro di rame e Indio; celle CdS (Cadmium, sulphur) solfuro di cadmio, ottenute mediante bagno chimico; celle CdTe (Cadmium, Tellurium) al Telloruro di Cadmio; celle CIGS (Copper, Indium, Gallium, Selenium), la cui miscela comprende anche una piccola quantità di Gallio, consentendo così la copertura dell’intero spettro solare
2 - A H M E Reiders, H de Wit, A de Boer, “Design of fibre reinforced Pv concepts for building integrated applications” in Proceedings of 5th EUPVSEC, 2009
3 - P Bonomo, Integrazione del fotovoltaico nell’involucro edilizio Sviluppo di
Sotto serra fotovoltaica Il vetro solare semitrasparente è chiamato a svolgere in maniera unitaria tutti i requisiti tecnologici del sistema facciata La presenza delle celle solari incide, in particolare, sulla trasparenza e, di conseguenza, sul controllo solare e del benessere luminoso (Ospedale pediatrico Meyer, Firenze, 2006).

Quinto Conto Energia e fotovoltaico integrato innovativo
Il 5 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Quinto Conto Energia, che ha ridefinito le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici a partire dal 27 agosto 2012 per un importo cumulativo annuo di ca. 6 miliardi di euro, pur trovando ancora applicazione il Quarto Conto Energia Le tariffe incentivanti sono riconosciute, in particolare, anche agli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative, dove i moduli installati possono essere non convenzionali o componenti speciali
Moduli fotovoltaici non convenzionali:
- moduli fotovoltaici flessibili che sostituiscono di fatto il tradizionale manto del tetto, diventandone parte integrante; devono garantire la tenuta all’acqua e quindi l’impermeabilizzazione dell’intera struttura, una tenuta meccanica comparabile con quella dell’elemento di rivestimento che sostituiscono e una resistenza termica che non deve compromettere le prestazioni dell’involucro edilizio;
- moduli fotovoltaici rigidi quali i nastri in film sottile su supporto rigido, tegole fotovoltaiche, moduli fotovoltaici trasparenti per facciate, finestre e coperture Anche questi elementi devono dare le medesime garanzie dei moduli non convenzionali
Componenti speciali:
- moduli fotovoltaici laminati senza cornice; - sistemi di montaggio che, progettati per l’integrazione architettonica del fotovoltaico, devono assicurare, unitamente alla superficie fotovoltaica dei moduli e senza l’utilizzo di ulteriori elementi, le funzioni previste dal Decreto sopra citato, tra cui la tenuta all’acqua Con il Quinto Conto Energia gli impianti composti da tali moduli ricevono, in base alla potenza, l’incentivo più alto dal parte del GSE Oggi realizzare un impianto fotovoltaico conviene anche senza gli incentivi del GSE, applicando solamente la detrazione fiscale fino al 50% prevista dalla legge Nel mese di marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate ha infatti con-
un sistema di valutazione per applicazioni di BiPV Tesi di dottorato in Ingegneria Edile/Architettura U E , XXIV ciclo, Università di Pavia (sede consorziata Università dell’Aquila)
4 - Il termine deriva dal concetto di “tecnomorfismo”, forma evoluta di innovazione tecnologica in architettura, legata a una sorta di evoluzione e declinazione morfologica della tecnica esecutiva e delle concezioni costruttive, come esplicitato in G Nardi, A Campioli, A Mangiarotti, Frammenti di coscienza tecnica, Franco Angeli, Milano, 1994
5 - http://www iea-pvps org/tasks/task7 htm
6 - Dalla fine del 2008, per il triennio 2009-2012, è stata svolta una ricerca intitolata “Solar Energy and Architecture” da parte del Task 41 dell’International Energy Agency IEA-SHC (http://www iea-shc org/task41/index html)
7 - A partire dal “terzo conto energia” di cui al DM 06 08 2010 fino all’attuale “quinto conto” di cui al DM 05 07 2012
8 - F Frontini, T Friesen, “Fotovoltaico integrato all’edificio: sfide per produttori e progettisti” Atti di Energy Forum on Solar Building Skin, 2012
fermato che il fotovoltaico può godere della detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie abbinata allo scambio sul posto poiché tali interventi rientrano tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici (articolo 16-bis del Tuir, lettera h, introdotto dall’articolo 4 del Dl 201/2011) e dunque possono accedere alle detrazioni per un importo massimo di 96.000 euro per singola unità immobiliare.

L’impianto residenziale di Mongrando (BI) da 48 kWp di potenza, installato da ECA Technology Spa di Grisignano (VI)
sistemi fotovoltaico
SISTEMA FOTOVOLTAICO INTEGRATO
RubberSun
guaina fotovoltaica in silicio amorfo
Descrizione. RubberSun è una membrana in caucciù utilizzata per l’impermeabilizzazione dei tetti e integrata con celle di silicio amorfo per la contemporanea produzione di energia elettrica. Il prodotto offre la massima potenza anche in caso di luce debole, di forte irraggiamento solare o di ombreggiature grazie al bypass-diodo che permette a ogni cella di raggiungere una potenza maggiore rispetto ai moduli tradizionali Grazie all’estrema leggerezza questo sistema fotovoltaico non necessita di strutture protettive L’incapsulazione è effettuata con EFTE, polimero ad alta resistenza con trasmissione molto leggera, mentre l’incollaggio avviene mediante mastice adesivo vulcanizzante Ogni cella è a tripla giunzione e connessa in serie Il sistema è ecologico (l’impermeabile Giscolene non contiene cloro nelle molecole, essendo prodotto con caucciù), garantisce una notevole durata ed è resistente agli agenti atmosferici e meteorologici Il sistema è garantito per oltre vent’anni all’80% della potenza nominale


Utilizzo. La guaina fotovoltaica è la soluzione ideale per le coperture di grandi strutture industriali, commerciali e residenziali e può essere applicata sia su strutture nuove che rinnovate; in questo ultimo caso la posa può avvenire direttamente al di sopra della vecchia impermeabilizzazione, facendo aderire la guaina alla membrana esistente, previa verifica statica della struttura Può essere applicata anche in piano, anche se è consigliabile una minima pendenza per il corretto funzionamento delle celle fotovoltaiche
Dati tecnici
Moduli fotovoltaici PLV-1361
Dimensioni – l x h x p (mm)
Potenza nominale massima, Pmax (Wp)
Tolleranza di fabbricazione (%)
Voltaggio con Pmax, Vmp (V)
Amperaggio con Pmax, Imp (A)
Amperaggio di corto circuito Isc (A)
Voltaggio in circuito aperto Voc (V)
Intensità ammessa dal fusibile (A)
1 - in condizioni di test standard (STC)
2 - spessore 16 mm con scatola di connessione incapsulata
5486x394x42

Descrizione I sistemi fotovoltaici ECA Technology sono in grado di garantire l’efficienza energetica di un fabbricato sfruttando al meglio gli spazi e rispettando l’architettura dell’edificio Il tetto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative sostituisce una porzione della copertura garantendo l’impermeabilità e la resistenza alle intemperie, mantenendo costanti le prestazioni per la produzione di energia elettrica
Il modulo è composto da celle policristalline di prima classe da 6” con vetro solare temprato di sicurezza di spessore 4 mm povero di ferro ed è dotato di connettori multi-contact o compatibili e di diodi di bypass integrati
Sul prodotto si applica una garanzia di 10 anni con rendimento minimo garantito sulla produzione energetica di 25 anni Il modulo innovativo Eca Technology è riconosciuto dal gestore servizi energetici come prodotto innovativo ai sensi D M 5 luglio 2012 Il pannello è certificato IEC61215, IEC61730 e Factory Inspection per prodotto europeo.
Utilizzo L’installazione dei moduli può avvenire indifferentemente sul tetto di un edificio residenziale per soddisfare i consumi energetici di un’abitazione, sulla copertura di un fabbricato industriale per abbattere radicalmente i costi dell’energia elettrica e su pensiline, tettoie, pergole, serre, barriere acustiche dove sussistano problemi di spazio o di vincoli
Il fotovoltaico può essere integrato all’interno di un sistema più completo e complesso che comprende anche una pompa di calore, il solare termico e un sistema di climatizzazione ambiente
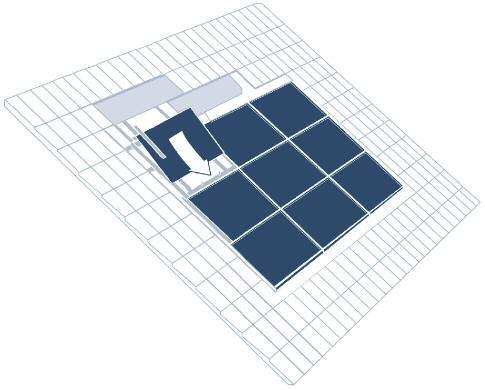
ECA TECHNOLOGY
www ecatech it
SISTEMA FOTOVOLTAICO
Dati tecnici
modulo fotovoltaico policristallino
Moduli fotovoltaici E240W-60A XP3BB/2
Dimensioni – l x h x p (mm)
Peso (kg)
Potenza nominale (Wp)
Classe di tolleranza (Wp)
Tensione a vuoto Uoc (V)
Tensione nominale Umpp (V))
Corrente di corto circuito Isc (A)
Corrente nominale Impp (A)
Efficienza modulo (%)
Massima tensione di sistema (V DC)
Coefficiente temperatura Pn (%/K)
Coefficiente temperatura Voc (%/K)
Coefficiente temperatura Isc (%/K)
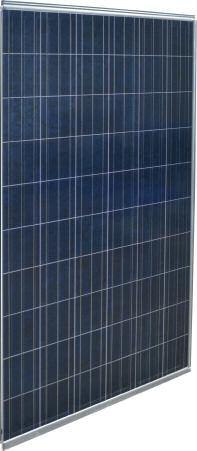
1 Copertina di partenza e nastro di guarnizione per fughe
2 Morsetto per lamiera
3 Ganci di montaggio
4 Viti a testa cilindrica
5 Conversa laterale sinistra
6 Profilo di collegamento laterale sinistro
7 Piano di montaggio
8 Listello per tegola
9 Conversa laterale alta sinistra
10 Conversa di colmo d’angolo sinistra
11 Modulo con cornice Solrif®
12 Copertura della giunzione
13 Conversa di colmo centrale
fotovoltaico
SISTEMA FOTOVOLTAICO INTEGRATO
moduli fotovoltaici
Descrizione. Sviluppati e prodotti integralmente in stabilimenti altamente automatizzati, i moduli fotovoltaici Monier offrono ottime prestazioni anche in condizioni di basso irraggiamento solare. Il pannello, dotato di vetro (a basso contenuto di ferro, spessore 3,2 mm) ad alta resistenza sul lato anteriore e di struttura posteriore in laminato (in materiale termoplastico) resistente all’acqua, alla neve, al vento e alla grandine, è composto da 48 o 60 celle policristalline (156x156 mm) La cornice è in alluminio anodizzato nero Il prodotto è garantito 10 anni; 10 anni sono garantiti anche sulla potenza nominale al 90%; 25 anni all’82% Il modulo è certificato secondo le norme IEC/EN 61215 e IEC/EN 61730, DIN/EN 15601, DIV V EN V 1187, DIN/EN 13501-5, classe di protezione elettrica II

Dati elettrici in condizioni di test standard (STC)
Potenza nominale Pmpp (Wp)
Tensione nominale Umpp (V)
Corrente nominale Impp (A)
Tensione a vuoto Uoc (V)
Corrente di corto circuito Isc (A)
Rendimento modulo η (%)
(pura tolleranza +) -0 W / +4,99 W
Utilizzo. I moduli fotovoltaici InDaX® assolvono alla doppia funzione di produrre energia solare pulita e di dare sicurezza al manto di copertura, nel quale si integrano completamente, assicurando un’elevata qualità estetica e una protezione contro le infiltrazioni di acqua ll sistema è applicabile su coperture con un’inclinazione compresa tra i 12° e i 65°, garantendo una protezione completa dalla pioggia, dai forti carichi di vento, neve o calore da insolazione La posizione dei moduli allineati a scandola e il telaio sviluppato appositamente consentono una ventilazione naturale ottimizzata sul retro di ogni modulo, assicurando alti livelli di rendimento energetico

245
STC (1 000 W/m2, spettro AM 1,5, temperatura cella di 25 °C) Tolleranza rendimento
InDaX® 230
SISTEMA FOTOVOLTAICO
Cogiwatt Energy Storage System
modulo fotovoltaico in silicio amorfo
Descrizione. Cogiwatt Energy Storage System implementa un comune impianto fotovoltaico con un accumulatore a batteria e con un sistema di controllo, per sfruttare al meglio i flussi di energia prodotti. L’energia elettrica generata dai moduli è consumata nella sua massima parte dall’utenza stessa, riducendo al minimo l’acquisto da rete pubblica
Il sistema è composto da un generatore fotovoltaico formato da 40 pannelli in silicio amorfo da 105 Wp l’uno, un inverter di rete statico cc/ca monofase, un inverter bidirezionale per la ricarica, una batteria al sodio-cloruro di nickel e una centralina di controllo La batteria è ad alta ciclicità, in grado di sopportare numerose alternanze di carica/scarica, non necessita di manutenzione e garantisce un’autonomia di almeno 12-24 ore (in funzione dal carico elettrico richiesto)
Utilizzo. Cogiwatt Energy Storage System è studiato appositamente per tutti i sistemi di generazione fotovoltaica di ambito residenziale, in quanto distribuisce la produzione fotovoltaica in funzione della variabilità dei carichi nel tempo, accumulando l’energia prodotta in eccesso rispetto alla richiesta istantanea per poi rilasciarla quando vi è la necessità anziché prelevarla dalla rete Oltre a ottimizzare l’autoconsumo dell’energia da fonte rinnovabile rappresenta un buon passo verso l’indipendenza energetica, garantendo anche una funzione di backup in caso di black-out della rete elettrica

Caratteristiche
Numero moduli 40
Potenza di picco complessiva* 4,2 kWp
Numero stringhe 8
Inclinazione tetto 20-25°
Orientamento 45°
Capacità di accumulo batteria 7,7 kWh
Capacità nominale batteria 160 Ah * in condizioni di test standard (STC)

COGIWATT www cogiwatt com
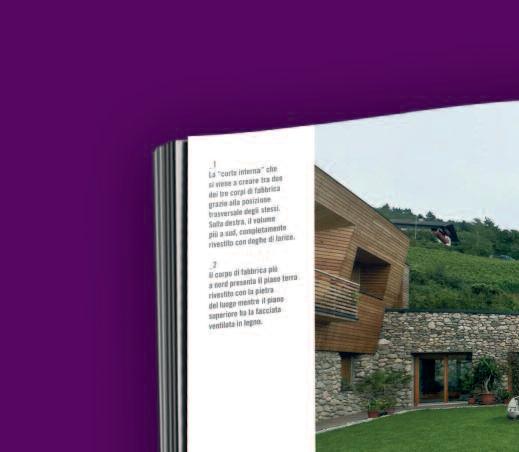
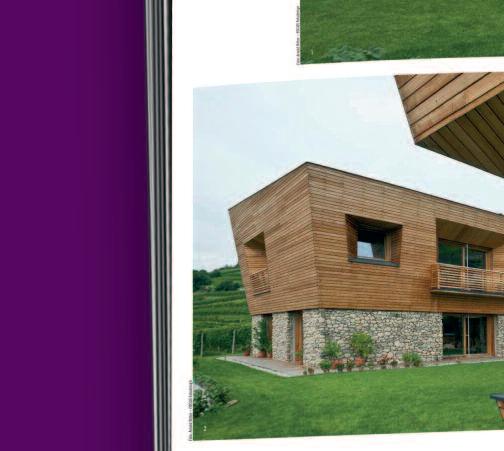
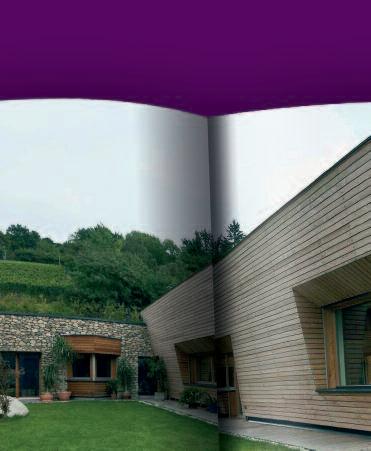




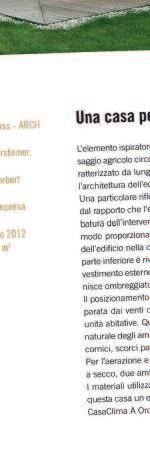

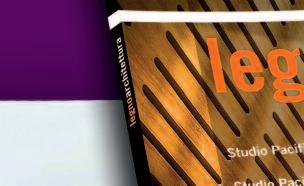




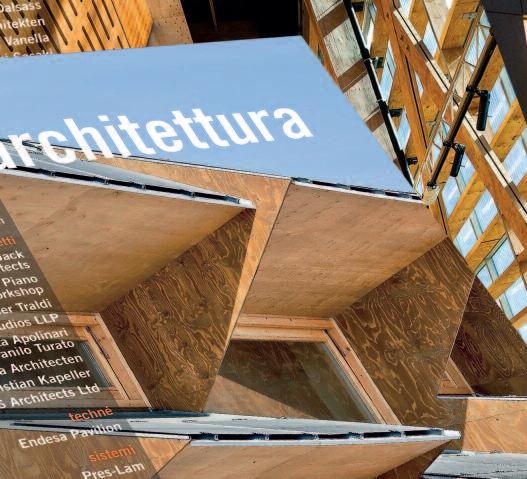








approfondimenti dettagli di cantiere
CA’ DELLA LUNA Agazzano (PC)
progettazione
Michael Tribus Architecture realizzazione 2008 consumo 3 kWh/m2 anno fotografie
Michael Tribus Architecture



In un edificio a bassissimo consumo energetico sono molti i dettagli costruttivi che devono essere presi in considerazione affinché gli obiettivi di prestazione energetica di progetto possano essere rispettati.
Il ridotto fabbisogno di energia della costruzione è frutto di un’accurata coibentazione nonché degli apporti solari gratuiti e di quelli interni, ma anche dei sistemi impiantistici Tra le soluzioni di dettaglio, particolare cura è stata riservata all’attacco soglia della finestra-muratura e al nodo cassonetto-muratura: la continuità dell’isolamento per evitare i ponti termici e l’impermeabilizzazione per scongiurare infiltrazioni d’acqua sono due semplici, ma efficaci accorgimenti adottati dal progettista. Per quanto riguarda la climatizzazione, si è adottato un impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore e un impianto radiante a pavimento alimentato da una pompa di calore geotermica L’aumento dei costi dovuti alla maggiore quantità di isolante impiegato e alla VMC è compensato dalla riduzione delle spese di riscaldamento; se prima dell’intervento di recupero e ampliamento l’edificio consumava 8 000 l di gasolio all’anno (per riscaldamento e ACS), a interventi effettuati il consumo è di 280 l all’anno





SOGLIE E CASSONETTI
Le soglie delle porte (vetrate od opache) e delle finestre sono impermeabilizzate al fine di evitare infiltrazioni d’acqua all’interno dell’edificio Le stesse soglie, inoltre, sono coibentate per fornire continuità termica all’isolamento , mentre i bancali dei davanzali sono realizzati in metallo
I cassonetti delle veneziane motorizzate sono posti direttamente nello spessore dell’isolamento così da non creare ponti termici in corrispondenza dell’attacco alla muratura Questa soluzione è stata realizzata non solo nella parte ampliata dell’edificio ma anche nella sezione recuperata del fabbricato esistente

GEOTERMIA E SOLARE
L’edificio è dotato di di una pompa di calore che sfrutta una geotermia di superficie le cui tubature sono posizionati al di sotto della platea di fondazione del nuovo fabbricato
La distribuzione del calore avviene mediante pannelli radianti a pavimento, alcuni posizionati in prossimità delle grandi aperture vetrate I pannelli solari installati in copertura garantiscono una quota del riscaldamento dell’acqua calda sanitaria e coadiuvano l’impianto di riscaldamento durante l’inverno Tutte le tubazioni dell’impianto solare, mandata e ritorno, sono coibentate


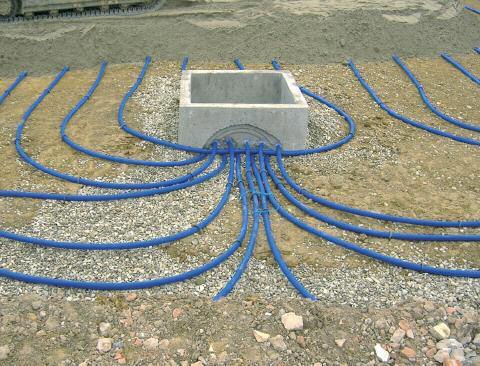





VMC
Il sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore consente di recuperare una gran parte dell’energia che altrimenti andrebbe dispersa con una ventilazione naturale dalle finestre Una sonda di CO2, temperatura e umidità consente, a seconda della temperatura esterna, di immettere aria fresca all’interno dell’edificio alla giusta temperatura e umidità
La distribuzione dell’aria avviene mediante tubazioni che corrono a pavimento al piano terra , per risalire poi ai piani superiori dove sono posizionate a soffitto



Schema dell’impianto di VMC al piano terra
innovAzione Efficiency House with Electromobility
ARCHITETTURA
ENERGETICAMENTE
EFFICIENTE
E MOBILITÀ ELETTRICA
Un esempio da Berlino
Il settore edilizio dispone di un enorme potenziale di sviluppo per quel che riguarda l’economia della sostenibilità e tutto quello che a essa si collega. Al di là di tutte le attività legate alla nuova costruzione, è da ricercare nel patrimonio esistente il più grande consumatore di energia e quindi anche uno dei settori maggiormente responsabili delle emissioni di CO2 Un rapporto responsabile verso le risorse e la protezione del clima dovrebbe essere uno dei compiti principali della politica e della società e, in questo senso, il tema dell’efficienza energetica costituisce il punto di partenza di considerazioni che possono avere conseguenze economiche rilevanti.
Partendo da queste premesse, in Germania sono state avviate già da qualche anno una serie di iniziative promosse dal Ministero Federale Tedesco dei Trasporti, dell’Edilizia e dello Sviluppo Urbano (BMVBS) il quale, con l’iniziativa di ricerca “Forschungsinitiative Zukunft Bau” (Iniziativa di Ricerca Costruire Futuro) ha messo a disposizione dei finanziamenti per progetti edilizi che abbiano come priorità obiettivi quali l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, l’impiego di nuovi materiali e tecniche costruttive e, più in generale, la modernizzazione degli edifici esistenti “Effizienzhaus Plus mit Elektromobilität”, Efficiency House with Electromobility, è un progetto, finanziato e supportato dal Ministero, che ha lo scopo di mettere in pratica le buone intenzioni di sostenibilità del comparto edilizio nonché il suo rilancio, coniugando la realizzazione di nuovi edifici e il risanamento efficiente di quelli esistenti e, soprattutto, ricercando un punto d’incontro tra le esigenze abitative e la mobilità in chiave sostenibile
Con il programma di incentivi „Effizienzhäuser Plus in Wohnungsbau“, il Ministero intende stimolare e supportare quei committenti che decidono di costruire edifici residenziali che producano quantitativi di energia maggiori di quella necessaria per il loro funzionamento Secondo i criteri stabiliti dal Ministero, una casa attiva EHP-Effizienzhaus-Plus deve generare annualmente più energia – da fonti rinnovabili – di quella necessaria per il funzionamento dei suoi impianti (riscaldamento, produzione di ACS, ventilazione e illuminazione) e per l’utilizzo degli elettrodomestici Questo surplus di energia, inoltre, deve essere utilizzato per la mobilità con alimentazione elettrica.
Grazie a questo programma vengono promossi progetti-modello su tutto il territorio tedesco
Nel 2011 sono stati messi a disposizione circa 1,2 milioni di euro (subito esauriti, visto il grande successo), e nel 2012 ulteriori 3,7 milioni di euro per le auto elettriche a supporto delle EHP Finora sono circa 30 i progetti-modello finanziati su tutto il territorio nazionale, finanziamento che avviene in proporzione alle tecnologie innovative impiegate e al supporto scientifico garantito
La più grande EHP sarà realizzata dalla Cooperativa Edilizia ABG a Francoforte sul Meno, con 74 unità abitative Nel 2013, inoltre, è stato avviato il risanamento di un edificio plurifamiliare esistente a Neu Ulm, in Baviera, al fine di allargare l’iniziativa anche al patrimonio costruito
Gli edifici che rientrano nel programma sono testati e valutati in condizioni reali. I committenti vengono comunque affiancati, di volta in volta, da un gruppo di esperti e i risultati della ri-
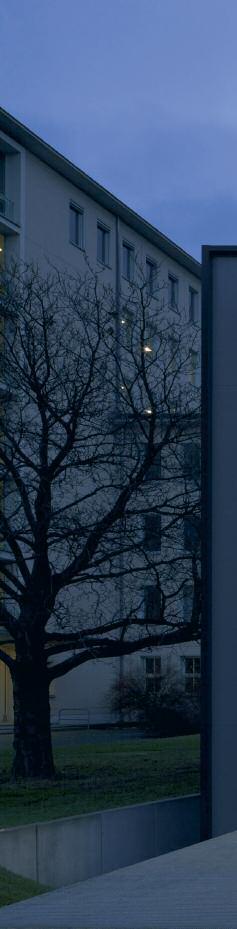

cerca sono oggetto di pubblicazione così da divulgare le esperienze portate avanti Scopo dell’iniziativa, per quanto riguarda il settore edilizio, è il miglioramento della gestione dell’energia all’interno di edifici di nuova costruzione – o di edifici oggetto di risanamento –, con conseguenti progressi dei componenti necessari per la realizzazione di un involucro energeticamente efficiente, nonché l’utilizzo di energie rinnovabili
Il progetto-modello della Effizienz Haus Plus
Nel 2010 è stato indetto un concorso pubblico rivolto alle università tedesche, in collaborazione con alcuni studi di architettura, per la realizzazione di una residenza-modello da costruirsi in un lotto prestabilito a Berlino, all’insegna del motto: Mein Haus – Meine Tankstelle (La mia casa – La mia stazione di rifornimento) Il progetto doveva dimostrare l’effettiva realizzabilità della connessione tra abitare e spostarsi, sfruttando l’elettromobilità Il primo premio è andato all’Università di Stoccarda, assieme allo studio di Werner Sobek Il Fraunhofer Institut ha poi garantito il supporto scientifico dell’intero progetto, monitorando lo sviluppo dell’edificio sia in fase di progettazione sia in fase d’esercizio. Il processo di progettazione si è basato su un approccio integrale al concetto di sostenibilità, andando oltre la mera efficienza energetica
Il progetto intende avvalorare in modo evidente che già oggi è possibile e fattibile un approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili in due ambiti della vita di tutti i giorni, quello abitativo e quello legato allo spostamento con l’automobile, anche se la sua collocazione in una delle zone più centrali di Berlino (Charlottenburg) garantisce un collega-
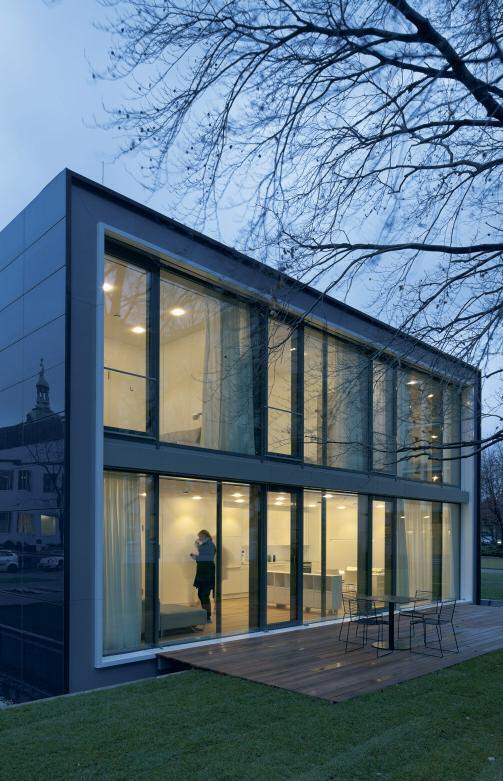
mento ottimale al sistema di trasporto pubblico Per testarne l’utilizzo in condizioni reali, la casa è abitata da una famiglia di 4 persone dal marzo del 2012 e lo sarà fino al giugno 2013
L’edificio
La EHP di Berlino presenta alcune caratteristiche di centrale importanza per un edificio che vuole essere energeticamente efficiente:
- una collocazione, all’interno del tessuto urbano, ottimale;
- un elevato livello di compattezza del progetto;
- la massimizzazione dei guadagni energetici e, contemporaneamente, la minimizzazione delle perdite di calore attraverso l’involucro;
- l’ottimizzazione dell’impiantistica dell’edificio senza perdita del comfort da parte dei fruitori;
- la copertura del fabbisogno energetico attraverso energie rinnovabili, prodotte localmente
Allo scopo di fornire agli abitanti il comfort più elevato e, al contempo, ottenere un bilancio energetico ottimale, sono stati analizzati con grande cura la fattibilità e l’orientamento dell’edificio
La EHP utilizza tutto lo spazio a sua disposizione, struttando al massimo la superficie dedicata alla copertura che può essere
utilizzata per generare energia elettrica da un impianto fotovoltaico
La facciata rivolta a nord, chiusa, minimizza le perdite di calore mentre la facciata sud, rivestita di pannelli fotovoltaici, massimizza il guadagno energetico L’ingresso all’edificio avviene dal lato ovest, attraverso la “vetrina”, zona in cui vengono parcheggiati, e caricati, i veicoli elettrici messi a disposizione e in cui gli interessati si possono informare sulla casa e le sue caratteristiche
Gli ambienti veri e propri dell’abitazione si suddividono su due piani: al piano terra il soggiorno e la sala da pranzo, le camere da letto al piano superiore
La EHP si contraddistingue tuttavia anche per il suo concetto di utilizzo flessibile per cui l’interno è pensato per adattarsi alle mutevoli necessità dei suoi fruitori, senza che siano necessari cambiamenti sostanziali Il piano terra, per esempio, è concepito – a eccezione della cucina – senza barriere architettoniche Il piano superiore ne presenta poche e, all’occorrenza, può essere modificato, così come la zona d’ingresso, in un open space La casa ha un disegno modulare e, se necessario, può essere riconfigurata per incontrare altre richieste o necessità, per esempio come luogo in cui fornire informazioni
Tra la zona d’entrata e gli ambienti abitativi si colloca l’”energy core” che contiene tutte le funzioni tecniche della casa e rappresenta il punto d’incontro tra gli immobili e la mobilità Il concetto energetico applicato unisce componenti già sperimentate ad altre più innovative. L’energia necessaria viene prodotta da due fonti: una pompa di calore aria-acqua ottiene, in inverno, il calore necessario dall’aria esterna mentre i pannelli fotovoltaici sul tetto e sulla facciata sud producono energia elettrica L’elettricità così generata può essere utilizzata subito – dopo una sorta di stoccaggio temporaneo nelle batterie della casa – oppure essere utilizzata per caricare i veicoli elettrici
Da questo momento in poi, tutta l’energia elettrica in eccesso può essere immessa nella rete pubblica
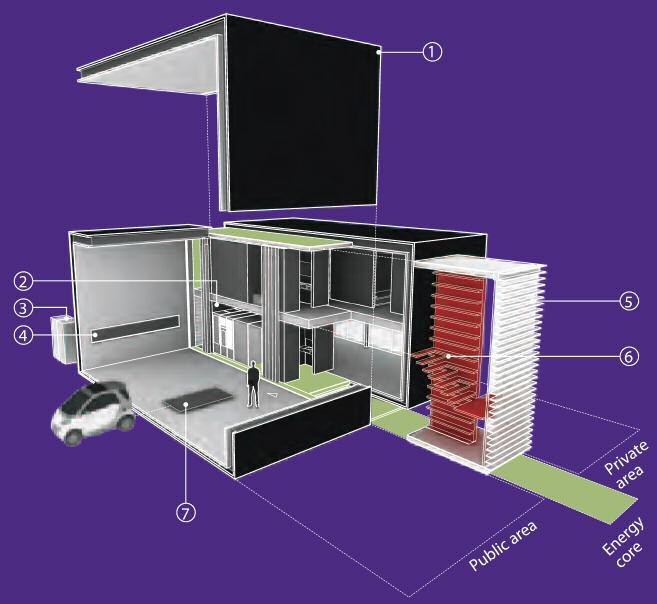

Il fronte sud con i moduli fotovoltaici integrati architettonicamente.
Componenti-chiave della EHP:
1 moduli fotovoltaici, integrati in facciata e sul tetto
2 centrale tecnica ed energetica
3 batterie domestiche
4 display esterno informativo e sistema di carica conduttivo
5 lamelle frangisole fisse
6 scale in acciaio
7 sistema di carica induttivo
Involucro: struttura, progettazione e costruzione
La casa ha elementi portanti verticali e orizzontali di legno con struttura a pannelli; la base è costituita da un solaio prefabbricato in legno su elementi di appoggio in c a Lungo i lati est e ovest, interamente vetrati, pilastri in acciaio fungono da ulteriori supporti per la struttura dei solai e del tetto
I componenti in legno dell’involucro sono altamente isolati (fibre di cellulosa insufflate) e le pareti opache presentano un ulteriore strato isolante in canapa verso l’interno per l’alloggiamento dell’impiantistica
Tutti i rivestimenti dei pavimenti e delle pareti sono posati senza incollaggio, al fine di permettere, in caso di riconfigurazione successiva o di riprogettazione, un facile smontaggio dei vari elementi costruttivi e la loro separazione entro gruppi di materiali chiaramente identificabili
Nella zona della “vetrina” la struttura non è isolata ed è destinata ai veicoli elettrici e alla loro ricarica La costruzione in legno utilizzata in questa parte dell’edificio è stata realizzata con larice mentre il rivestimento del pavimento è in legno massiccio di quercia. La terrazza sul lato est è realizzata in modo simile
Le grandi facciate vetrate sono dotate di tripli vetri isolanti: la camera più interna è riempita con gas argon La facciata vetrata rivolta a est è protetta dal sole con lamelle esterne di alluminio, regolabili sia in maniera sia automatica che manuale
I fronti chiusi sono rivestiti, sul lato sud, con una facciata ventilata data da sottili moduli fotovoltaici, che sul lato nord sono sostituiti con dei pannelli di vetro che riprendono l’estetica dei moduli fotovoltaici La copertura è quasi completamente rivestita con moduli fotovoltaici monocristallini.



pianta piano terra
pianta primo piano
sezione AA
2 serbatoio acqua potabile, ca. 288 l di capacità
3 acqua calda
4 impianto di VMC con recupero di calore
5 acqua fredda
6 aria in entrata
7 aria estratta
8 aria esterna
9 aria esausta
10 puffer termico
11 pompa di calore aria/acqua
12 riscaldamento a pavimento
13 rete elettrica pubblica
14 building management system
15 batterie domestiche
16 veicoli elettrici

Sezione schematica con il sistema di illuminazione
luce solare
celle solari (fotovoltaico)
pompa di calore aria
Diagramma schematico della generazione di energia nella EHP
luce solare aria esterna
aria estratta aria estratta aria in entrata aria in entrata aria estratta aria esausta
Sezione schematica con il sistema di ventilazione
Impiantistica e sostenibilità
La EHP utilizza il sole come sorgente energetica in due modi: attraverso moduli fotovoltaici che generano corrente dalla luce solare incidente e mediante una pompa di calore che sfrutta l’aria esterna come fonte per produrre acqua calda I pannelli fotovoltaici in copertura e sulla facciata sud producono, in una media annua, sufficiente energia per coprire il fabbisogno energetico della casa e degli elettroveicoli
La EHP è stata pensata per rimanere “in funzione” per 2-3 anni; si è deciso, pertanto, di rinunciare allo sfruttamento della geotermia perché sarebbe stato troppo costoso rimuovere le sonde una volta dismesso l’edificio Al suo posto è stata installata una pompa di calore aria-acqua altamente efficiente
Il calore necessario durante i mesi invernali è distribuito da un impianto radiante a pavimento che utilizza connessioni meccaniche facilmente asportabili per favorirne la riciclabilità Un massetto a secco offre una massa d’accumulo ulteriore in una struttura di legno che sarebbe altrimenti troppo leggera Vista la bassa inerzia termica, l’edificio può reagire velocemente ai diversi stati di carico nei diversi ambienti
Nella casa non è stato installato alcun impianto di raffrescamento poiché, come si era evinto da simulazioni in fase di progettazione, gli elementi ombreggianti – esterni e controllabili –dovrebbero prevenire il surriscaldamento nel periodo estivo
Combinando la parte impiantistica nell’energy core della casa, è possibile accorciare le varie canalizzazioni con conseguente beneficio nella minimizzazione delle perdite di energia per tra-
Struttura del tetto:
1 strato di protezione
2 impermeabilizzazione in materiale plastico, fissato con procedimento meccanico
3 pannello OSB (20 mm)
4 isolamento in cellulosa
5 trave in legno lamellare
6 pannello OSB (25 mm)
7 barriera al vapore a diffusione variabile
8 pannelli di canapa (50 mm)
9 rivestimento in cartongesso (12,5 mm)
Solaio contro terra:
10 rivestimento in legno su strato di installazioni (15 mm)
11 strato di livellamento in sughero (3 mm)
12 massetto posato a secco (2x12,5 mm)
13 elementi in fibra di legno con rivestimento in alluminio per la posa del riscaldamento a pavimento (30 mm)
14 strato con struttura a nido d’ape con riempimento (25 mm)
15 pannello OSB (25 mm)
16 isolamento in cellulosa (400 mm)
17 pannello in truciolare resistente all’umidità (15 mm)
18 intercapedine ventilata
19 striscia di fondazione
Parete esterna:
20 moduli fotovoltaici sottili
21 profili di sostegno
22 pannellatura verticale e strato di ventilazione
23 barriera al vapore
24 pannello OSB (20 mm)
25 isolamento in cellulosa
26 pannello OSB (20 mm)
27 freno al vapore
28 vano impianti con isolamento in canapa (60 mm)
29 rivestimento in cartongesso (12,5 mm)
La posa di uno degli elementi del solaio contro terra prefabbricato.

smissione
L’impianto FV collocato sul tetto, con moduli monocristallini ad alta efficienza, è a elevate prestazioni; tale tipo di moduli è stato scelto appositamente per la copertura, perché adatto alla conversione della radiazione solare diretta in energia elettrica Sulla facciata sono utilizzati, invece, moduli sottili amorfi, più adatti per l’irraggiamento diffuso, come avviene appunto in facciata Una parte dell’energia elettrica prodotta dal fotovoltaico è utilizzata per far funzionare la pompa di calore aria-acqua, che produce calore dall’aria esterna anche in caso di basse temperatura Il calore viene distribuito attraverso il sistema di ventilazione meccanica controllata e un impianto di riscaldamento a pavimento
Lo sfruttamento delle energie rinnovabili nella EHP è fortemente dipendente dalle condizioni atmosferiche; per questo motivo sono necessarie degli accumulatori in grado di accordare l’offerta con la domanda di energia
L’energia elettrica prodotta localmente è stoccata in una batteria agli ioni di litio da 40 kWh che si ottiene dal riutilizzo delle batterie automobilistiche che, a causa della perdita della loro capacità di stoccaggio e delle loro performances, inferiori ormai al 20%, non sono più utilizzabili nei veicoli In questo caso sono state utilizzate batterie provenienti da auto modello Mini E della
BMW
Le batterie fungono da accumulatore-cuscinetto per poter aumentare lo sfruttamento dell’energia prodotta che, una volta immagazzinata, può essere utilizzata per tutte le necessità della casa e la ricarica dei veicoli elettrici
La ventilazione meccanica con sistema di estrazione dell’aria garantisce un’elevata qualità dell’aria indoor In aggiunta, ogni stanza abitata della casa può essere ventilata manualmente: il calore presente nell’aria estratta viene recuperato prima che l’aria esausta venga incanalata nello spazio tra il terreno e il pavimento
La completa vetratura delle facciate est e ovest consente grande luminosità agli spazi contribuendo alla sensazione di ampiezza
Sul lato est, uno schermo solare esterno a lamelle e manovrabile fornisce l’ombreggiamento impedendo il surriscaldamento dell’edificio Sul lato ovest questa funzione è data dalla “vetrina” posta davanti alla casa L’illuminazione artificiale, dimmerabile e gestita da rivelatori di presenza, avviene attraverso luci a LED ad alta efficienza
L’equipaggiamento tecnico è collocato a vista nel cosiddetto “energy core” della casa ed è parte integrante del concetto informativo del progetto: grazie alle vetrate la tecnologia impiegata è visibile e comprensibile a tutti i visitatori
Tu t t a l a h o m e t e c h n o l o g y, c o s ì c o m e l a t e c n o l o g
a delle batterie, può essere tenuta sotto controllo e gestita dagli abitanti attraverso due touch panels e attraverso smartphones
Elettromobilità
L’elettromobilità è una delle possibilità per un sistema di trasporti sostenibile poiché le auto elettriche sono silenziose, non producono inquinanti nocivi e sono in grado di sfruttare fonti energetiche rinnovabili Completamente in linea con il motto “La mia casa – La mia stazione di servizio”, l’edificio fornisce energia al veicolo proprio davanti alla porta d’ingresso Oltre alle auto, sono state messe a disposizione anche bici elettriche. Un’applicazione per smartphone permette agli abitanti di scegliere quando vogliono usare uno dei veicoli e i km che intendono fare Sulla base di questa informazione e tenendo presente lo “stato energetico” della casa, il sistema di controllo determina anche la strategia ottimale di ricarica per i vari veicoli Una batteria tampone da circa 40 kWh di capacità di carica assicura che i veicoli possano essere ricaricati anche durante la notte, quando i pannelli fotovoltaici non producono corrente. Un connettore per ricarica rapida con una capacità di carica di 22 kW riduce i tempi necessari, fornendo sufficiente corrente per poter coprire una distanza di ca 100 km o 30 minuti
I veicoli vengono caricati tramite l’attacco di una spina alla presa di corrente o mediante un metodo induttivo sperimentale
In questo caso la corrente di carica viene trasferita senza contatto, tramite un campo elettromagnetico, da una bobina primaria montata nella zona parcheggio su una bobina secondaria collocata sotto il veicolo
Simulazioni energetiche dell’edificio
Al fine di ottimizzare la progettazione comparata del comfort, dell’efficienza energetica e delle previsioni sul fabbisogno energetico durante il periodo di utilizzo, la EHP è stata progettata con l’aiuto di simulazioni dinamiche combinate dell’edificio e degli impianti
In questo tipo di simulazioni devono essere prese in considerazione tutta una serie di condizioni al contorno, indicate come segue
Fisica dell’edificio: per ogni processo di simulazione durante la progettazione sono state impiegate le geometrie dell’edificio e le caratteristiche fisiche della struttura Particolare attenzione è stata posta alle facciate vetrate, incluse le schermature solari, che influiscono in maniera considerevole sul fabbisogno energetico e sul comfort, attraverso gli apporti solari e le perdite di calore per trasmissione La tenuta all’aria dell’involucro edilizio è stata considerata in maniera conservativa, cioè sempre costante; questo valore è stato poi verificato dopo la realizzazione in base ai risultati del blower-door-test e corretto nella simulazione
Utilizzo: nella simulazione, l’edificio viene suddiviso per zone,
ognuna delle quali è caratterizzata da uno specifico profilo di utilizzo Questo significa che, per l’occupazione, l’illuminazione, la ventilazione e la temperatura desiderata vengono applicati degli specifici fattori di carico A seconda dell’uso che si intende fare e del giorno della settimana, questi possono cambiare Per la EHP tutti i profili si sono basati su una famiglia di 4 persone
Clima: le condizioni climatiche influenzano grandemente il risultato della simulazione. Per l’ottimizzazione del progetto e la verifica degli scopi energetici (prefissati) è stato utilizzato un anno-tipo di riferimento con dati del servizio meteorologico tedesco
Tecnica dell’edificio: i livelli di efficienza dei vari impianti sono stati aggiustati continuamente per ogni simulazione
Grazie proprio alla costante verifica tra simulazione e progettazione, la precisione dei risultati è stata continuamente incrementata.
Sistema di gestione dell’energia
Attraverso il sistema di gestione, è stata raggiunta con questo progetto un’ottimizzazione dei flussi di energia in tutto il sistema: dall’impianto fotovoltaico, dalla rete elettrica pubblica, dalle automobili così come dagli accumulatori termici ed elettrici Oltre al bilancio energetico positivo, si è mirato alla minimizzazione dell’utilizzo di corrente dalla rete elettrica pubblica, sfruttando il più possibile l’energia prodotta dall’edificio
La possibilità di poter regolare i flussi di energia consente di spostare i consumi di energia elettrica nei periodi economicamente più convenienti Il sistema di gestione della ricarica per gli elettroveicoli viene dunque adattato in base all’offerta energetica o durante i periodi in cui le batterie sono al massimo della loro carica oppure, durante la notte, attraverso la rete pubblica
Una caratteristica significativa del sistema è la sua capacità di sfruttare le previsioni meteo per prevedere la corrente generata
previsione di produzione da FV
misurazione effettuata di produzione da FV misurazione effettuata di consumo elettrico previsione di consumo elettrico
Per il progetto-pilota si mostrano le prime tendenze dopo un periodo di misurazioni che va da marzo a ottobre 2012 È stato osservato che nell’anno passato, a causa di un irraggiamento solare medio inferiore del 10% ca. rispetto agli anni precedenti, si è prodotta una minore quantità di energia elettrica da fotovoltaico rispetto a quanto preventivato Oltre a ciò si mostrano, nelle condizioni reali, un consumo energetico leggermente superiore rispetto a quanto ci si aspettava in base ai calcoli Questo è il risultato, tra le altre cose, anche di un sistema impiantistico non ancora regolato in maniera ottimale. Tuttavia, la tendenza indica che il Plus positivo verrà comunque raggiunto già nel primo anno di funzionamento
Energia finale accumulata
Confronto tra l’andamento dell’energia finale accumulata secondo i calcoli e il suo reale utilizzo nell’EHP di Berlino

Sopra, un momento di carica dell’auto elettrica nella “vetrina” fuori dalla casa
A destra, fabbisogno energetico previsto espresso in kWh
dai pannelli fotovoltaici, le richieste di riscaldamento dell’edificio e il consumo di energia elettrica da parte degli abitanti I processi intelligenti utilizzati sono adattivi, cioè si adattano ai cambiamenti atmosferici e ai comportamenti degli abitanti
Recycling
Una riflessione sui materiali e sul loro riciclo, sviluppata specificamente per la EHP, permetterà che l’intero edificio, dopo il tempo previsto di utilizzo di 2-3 anni, venga smantellato e che tutti i materiali utilizzati rientrino nel ciclo dei materiali
Una parte di questi verrà ripresa indietro dai produttori stessi e direttamente riutilizzata in altri progetti (p e l’impianto FV); tutti gli altri materiali verranno riciclati in base ai loro componenti Per poter fare ciò, si è dovuta prestare attenzione già al momento della scelta dei materiali edilizi, a che tutti i prodotti fossero biodegradabili oppure che potessero essere rielaborati e diventare dei nuovi materiali riciclati Al fine di rendere possibile una raccolta pulita di gruppi di materiali durante lo smantellamento, sono stati definiti circa 20 unità di riciclaggio
che, durante la demolizione, dovranno essere raccolte in frazioni separate Al di là della selezione dei materiali e della loro separazione, ha giocato un ruolo importante anche la tecnica di collegamento La maggior parte delle connessioni è realizzata per mezzo di viti, connettori e morsetti facilmente separabili, evitando quanto più possibile l’incollaggio
Con l’aiuto di questo concetto di riciclo non solo si è potuto evitare una grande quantità di rifiuti ma anche il bilancio energetico ne è uscito positivamente influenzato.
Monitoraggio dell’edificio
Il progetto viene seguito scientificamente dal Fraunhofer Institut per quel che riguarda il monitoraggio delle prestazioni Rendimento energetico dell’edificio e comfort termico È stata installata una configurazione di misurazioni che da una parte rende possibile la formazione di un bilancio energetico completo mensile e dall’altra fornisce una valutazione delle performance degli impianti installati Da remoto vengono effettuate le misurazioni delle temperature interne e delle
Bilancio energetico annuo previsto (stand: ottobre 2011).




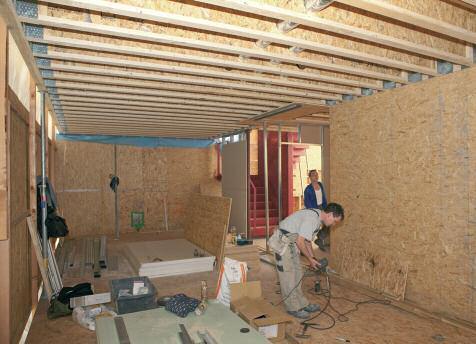

a) L’isolamento in canapa delle tubature; b) l’isolamento delle pareti;
c) le tubazioni della VMC; d) la parte dell’edificio adibita all’abitazione; e) uno dei sensori inseriti all’interno delle pareti per monitorare il comportamento dell’umidità all’interno di queste; f) la posa dei sensori all’interno della struttura portante in legno in fase di prefabbricazione
concentrazioni di CO2 in stanze rappresentative della casa Accanto a questo sono mostrati continuamente i contributi utili e i surplus di energia dalle fonti rinnovabili (contributi solari), i consumi di energia elettrica e le energie per il condizionamento Trasporto di calore e di umidità negli elementi dell’involucro altamente coibentato
Sono continuamente misurati e valutati, attraverso dei sensori collocati nelle pareti esterne in legno altamente isolate: temperatura, umidità, flusso di calore nelle pareti esterne, nel tetto e nel solaio controterra In questo modo si dovrebbe riuscire a descrivere meglio in particolar modo il comportamento dell’umidità nei materiali isolanti a pori aperti
Management energetico
Il sistema di management dell’energia dell’edificio dovrebbe riuscire a calcolare, grazie alle previsioni meteo, la quantità di energia prodotta e il fabbisogno energetico (per la casa, per le auto elettriche) e così dare indicazioni per l’utilizzo ottimale
degli accumulatori
Stabilizzazione della potenza della rete elettrica pubblica
L’effetto stabilizzante delle batterie sulla rete elettrica pubblica deve essere ancora studiato nel dettaglio Allo stesso tempo vengono però gettate le basi su come più elementi di accumulo si possono interconnettere in una „centrale elettrica virtuale“ In questo modo si può preparare in pochi minuti e in modo uniforme energia di riserva a partire dalla corrente elettrica prodotta da più fonti rinnovabili
Riutilizzo delle celle delle batterie / Dimensionamento delle batterie di casa
Vengono studiate batterie agli ioni di litio esaurite provenienti dal campo delle automobili, in base alla loro vecchiaia, alla loro capacità residua e al loro utilizzo come batterie di casa con un nuovo sistema di management e un’unità di accumulo e di inverter.
La famiglia-test di 4 persone che abita la casa da marzo 2012 e vi rimarrà fino a maggio 2013 viene seguita da alcuni sociologi, al fine di ottenere dei risultati in merito al punto d’incontro tra uomo e tecnologie innovative, l’accettazione e l’applicazione di nuove tecnologie, l’utilizzo di reti intelligenti al servizio dell’edificio e dell’elettromobilità
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Tutti i crediti delle immagini di questo articolo, laddove non diversamente specificato, sono da attribuire al Bundesministerium für Verkehr, Bau und StadtentwicklungBMVBS.
Bilancio dell’iniziativa dopo 6 mesi dal suo avvio
All’interno della rete di lavoro “Effizienzhaus Plus” del Ministero tedesco si è tenuto, a novembre del 2012, un workshop relativo al bilancio dell’edificio, energetico e non solo, dopo alcuni mesi di vita delle e nelle EHP
Sono state invitate 7 famiglie che vivono in case con standard EHP e, assieme a loro, gli architetti, i ricercatori e gli assistenti hanno discusso per la prima volta di aspetti tecnici e sociali riguardo lo standard di questo tipo di edifici.
Per il monitoraggio tecnico sono stati presi in considerazione i bilanci mensili relativi al consumo finale di energia, alle fonti energetiche e l’utilizzo dell’energia così come gli apporti dell’impianto fotovoltaico e la somma di tutti gli altri apporti energetici I primi risultati hanno mostrato che, per la EHP di Berlino, gli apporti energetici derivati da fotovoltaico sono stati, nel 2012, inferiori alle aspettative, a causa del minore irraggiamento solare, mentre il consumo energetico si è rivelato leggermente più elevato del previsto Tuttavia, l’edificio ha prodotto più energia di quella necessaria per il suo funzionamento e, al momento, il surplus generato dal fotovoltaico è finora di ca. 6000 kWh, assolutamente in linea con le aspettative
Dal punto di vista del monitoraggio “sociale”, dopo 8 mesi di fruizione dell’edificio è chiaro che l’energia prodotta per le esigenze della famiglia è più che sufficiente Le persone si trovano molto bene e si godono il comfort senza rimorsi di coscienza a causa del consumo energetico Sfruttano volentieri anche l’elettromobilità e hanno già coperto ben 8000 km con le auto e 3500 con le bici elettriche Rimane invece una sfida l’accettazione, per così dire, dell’impianto di ventilazione che, non regolabile manualmente, richiama in estate l’aria calda dall’esterno verso l’interno, comportando così un lieve surriscaldamento degli ambienti abitati
Per il Ministero è importante l’integrazione dei cittadini nel processo progettuale, la considerazione delle loro necessità e dei loro pensieri Il workshop è servito proprio come punto di sviluppo per il processo partecipativo; le persone coinvolte possono integrare il cambiamento energetico (Energiewende) nel migliore dei modi nella vita sociale di tutti i giorni Nella discussione finale si sono scambiate le esperienze delle famiglie-test relativamente
Le EHP nelle vecchie costruzioni
Nella città di Neu-Ulm, in Baviera, si stanno risanando degli edifici plurifamiliari così che possano produrre più energia di quanta ne consumano per il loro funzionamento, applicando i principi – e i finanziamenti – delle EHP.
Anche in questo caso, come per la casa di Berlino, il BMVBS, in collaborazione con la Cooperativa per l’Edilizia Residenziale Neu-Ulm, ha indetto un concorso nel febbraio del 2012 per lo sviluppo di un concetto di risanamento per un edificio esistente in plus energy
Due sono i team universitari risultati vincitori: la Hochschule
Ruhr West di Mühlheim an der Ruhr e la Technische Universität di Darmstadt.
agli impianti di ventilazione, le temperature dell’aria, il fotovoltaico, le pompe di calore e l’elettromobilità Si è, per esempio, evinto che i vantaggi e gli svantaggi di un impianto di VMC in confronto al normale rinnovo dell’aria interno attraverso l’apertura delle finestre sono stati percepiti in maniera molto diversa Questi sono infatti sì efficienti, facili da usare e riescono a garantire una temperatura costante dell’aria, ma dall’altra parte danno un’impressione di preclusione dal mondo esterno, non riuscendo a sostituire la sensazione della ventata di aria fresca data dall’apertura di una finestra
Inoltre, è chiaro che il modo in cui si produce l’energia necessaria alle necessità degli abitanti, sia essa da fotovoltaico, da solare termico o da pompe di calore, non ha alcuna influenza sulla qualità abitativa
Alcune famiglie hanno registrato un mutato rapporto rispetto al loro consumo di energia, che hanno acquisito nel nuovo ambiente abitativo; l’indipendenza dai prezzi dell’energia è molto rilassante, la rilevazione e il monitoraggio dei consumi è divertente e risveglia la voglia di agire in un modo energeticamente più consapevole.
Nel complesso, tutti gli abitanti hanno espresso un parere molto positivo sulla loro esperienza nelle EHP
La necessità di un cambiamento è stata ravvisata da tutti i presenti soprattutto in due aspetti: nella mancanza di offerta di auto elettriche a prezzi accessibili - e nella mancanza delle relative infrastrutture lontano da casa, e nella formazione degli architetti e costruttori; attualmente sono ancora troppo pochi coloro che hanno familiarità con queste materie
A entrambi i team vincitori è riuscito, con progettazioni innovative, di trasformare gli edifici plurifamiliari che necessitavano di risanamento (e il cui fabbisogno annuo di calore era di ca 507 kWh/m2) in case plus energy I surplus di energia sono realizzati con l’aiuto di impianti FV integrati architettonicamente
In totale dovranno essere risanati 4 vecchi edifici: entrambi i concetti vincitori vengono applicati in una casa in linea ciascuno su due edifici esistenti La realizzazione è prevista per il 2013 In seguito, i 4 edifici risanati rientreranno in un monitoraggio di 2 anni

