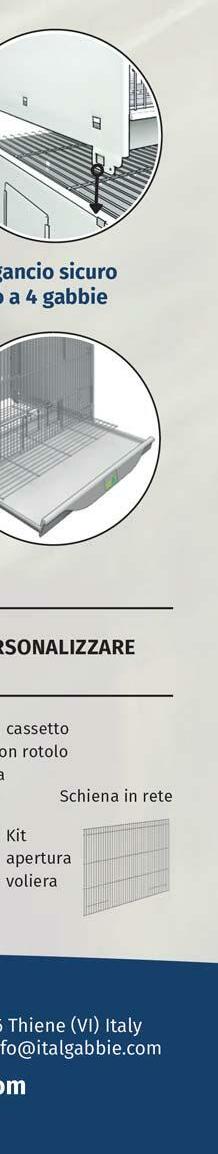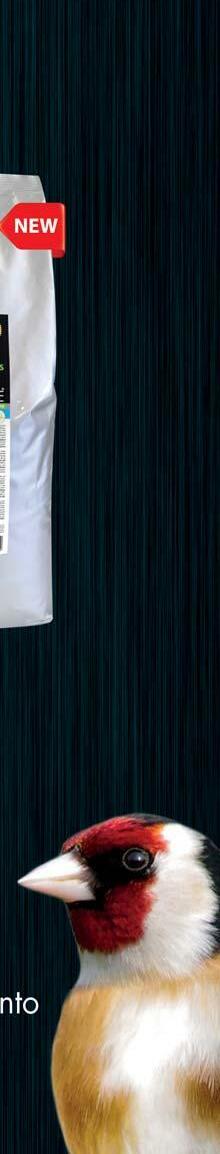ANNOnumeroXLVIII102022 Canarini di Colore dell’AgataParliamo Estrildidi Fringillidi e Ibridi Donacola petto castano x Passero del Giappone Canarini di Forma e Posizione Lisci Le deloriginiCanarino Lizard Uccelli in Natura Il martin pescatore e il mito di Alcione Rivista mensile di Ornitologia Scientifica - Tecnica - Pratica Organo Ufficiale della F.O.I.-Onlus



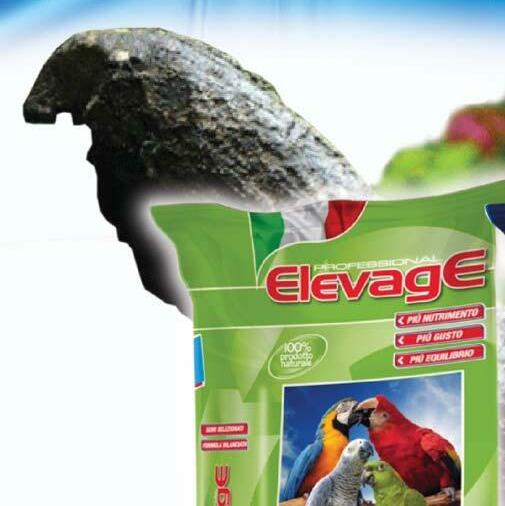





Direttore Responsabile: Antonio Sposito Gennaro Iannuccilli di Redazione: Giovanni Canali, Maurizio Manzoni, Francesco Rossini Benessere Elena Circella, Giuseppe Marruchella, Gianluca Todisco Editoriale: Lorenza Cattalani

Associato all’Unione Stampa 0391-254X
Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 4396 del 12-3-1975
Stampa: TEP s.r.l. - Strada di Cortemaggiore, 50 29122 Piacenza - Tel. 0523.504918




Inoltro postale in Italia: Effezeta srl Via Amilcare Mazzocchi, 36 - 29122 Piacenza

ABBONAMENTI Italia € 50,00 - Estero-Europa € 70,00 Estero-ExtraEuropa € 90,00 Un numero € 5,00 - Arretrato € 6,50 C.C.P. 53684957
Le quote abbonamento vanno versate, mediante vaglia o assegno, alla Segreteria. Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Rivista e la sua Direzione.

La Redazione si riserva il diritto di non pubblicare o emendare gli articoli proposti. I collaboratori assumono piena responsabilità delle affermazioni e delle immagini contenute nei loro scritti.
Vietata la riproduzione, anche parziale, se non espressamente autorizzata. © F.O.I.
In copertina: Lizard dorato calotta netta (Serinus canaria)
Foto: PHILIPPE ROCHER di Colore Fringillidi Ibridi di Forma e Posizione Lisci in Natura
AMMINISTRAZIONE E PUBBLICITÀ: Segreteria F.O.I.-Onlus Via Caorsana, 94 - Località Le Mose 29122 Piacenza Tel. 0523.593403 - Fax 0523.571613 Web: www.foi.it - E-mail: redazione@foi.it
Caporedattore:
Collaboratori
Commissione Salute,
animale e Ricerca Scientifica:
Coadiutore
Periodica Italiana ISSN
(International Standard Serial Number)
ANNUI:
ANNO XLVIII NUMERO 10 sommario2022 La volta buona Gennaro Iannuccilli 3 Parliamo dell’Agata Giovanni Canali 5 Donacola petto castano x Passero del Giappone (1ª parte) Simone Olgiati 13 Le origini del Canarino Lizard Nicola Giordano 19 Il Pettirosso del Giappone Piercarlo Rossi 25 Il martin pescatore e il mito di Alcione Aurora Civilla 30 Spazio Club Club degli Psittacidi 32 Il collezionismo ornitologico (18ª parte) Francesco Badalamenti 35 Principe Chigi della Rovere Francesco Roberto Basso e Manuel Pavanello 39 Photo Show Le foto scattate dagli allevatori 43 Ornimostre, oltre un gioco a somma zero Pasquale Leone 45 Piumaggio e muta Sergio Palma 47 Il Senecione comune Pierluigi Mengacci 49 Recensioni - novità editoriali Gennaro Iannuccilli 55 Volontariato - progetti ed eventi Associazione “Passione Pappagalli Free Flight” 56 OrniFlash News al volo dal web e non solo 58 Si può fare…un’esposizione ornitologica in estate Francesco Faggiano 61 Canarini
Estrildidi
Canarini
Uccelli
5 13 19 30 Italia Ornitologica è la rivista ufficiale della F.O.I. - Federazione Ornicoltori Italiani, pubblicata in 10 (dieci) numeri annuali a cadenza mensile, 2 (due) dei quali in versione bimestrale nel periodo estivo (Giugno/Luglio e Agosto/Settembre). Il numero 10 - 2022 è stato licenziato per la stampa il 30/9/2022



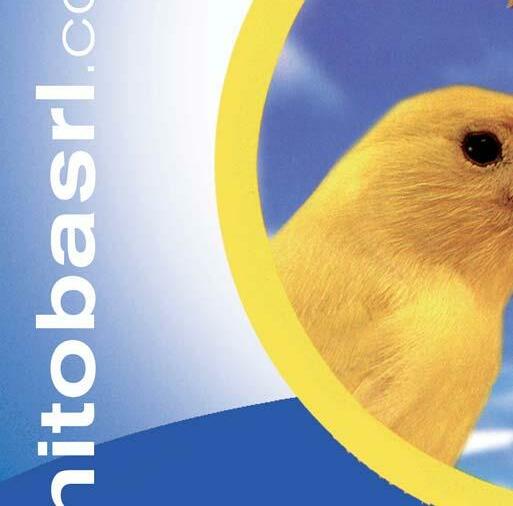


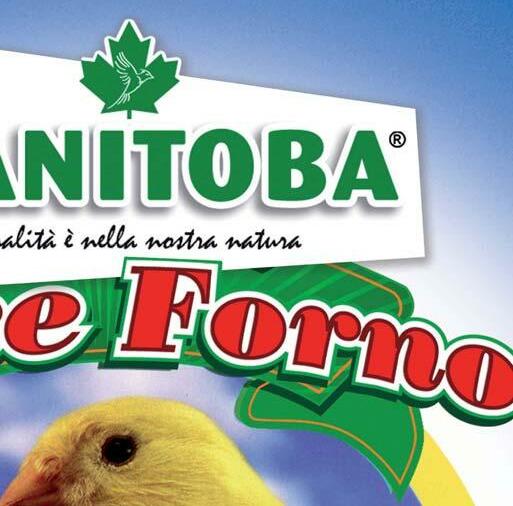


Editoriale

La volta buona
di G ENNARO IANNUCCILLI
Lanuova stagione espositiva sta per iniziare, come si evince dalle prime locandine delle mostre ornitologiche pubblicate sui vari social, siti web ecc. La cosa che salta subito all’occhio sono le frasi comprensibilmente utilizzate come “claim” (secondo il linguaggio marketing) tutte orientate alla “ripartenza”: pronti a volare di nuovo, ricominciamo a volare, riprendiamo la nostra passione, ecc. Questi slogan fanno ben capire quanta sofferenza ha portato l’annullamento, reiterato per due anni, della stagione espositiva ornitologica nella sua quasi totale interezza. C’è voglia di ritrovarsi, certamente per il piacere di esporre i soggetti dei propri allevamenti, per gareggiare sportivamente nelle mostre più importanti ma anche per presenziare in manifestazioni più circoscritte nei rispettivi territori, non meno importanti in quanto occasioni di maggiore funzione didattica, con più disponibilità di tempo da dedicare al confronto e alla discussione tecnica: attività molto efficaci per avvicinare nuovi adepti alla passione ornitologica.
I due anni di pausa forzata dalle esposizioni hanno segnato, forse in maniera indelebile, la vita ornitologica di tutti noi; ma credo che i “segni” lasciati da questa profonda ferita possano essere motore per riavviare al meglio la passione che ci muove e che stimola l’allevamento, nonostante le crescenti difficoltà del momento. Potrebbe verificarsi, auspicabilmente, che proprio le due ultime due stagioni “fantasma”, cancellate dalla pandemia e altri problemi annessi, diano invece una sferzata al senso di frustrazione e impotenza che sembrava essersi impossessato di noi, coinvolgendo inevitabilmente anche la sfera dedicata alle attività ludiche e al tempo libero riservato ai nostri interessi collaterali. Probabilmente, potrà esserci una scrematura nel variegato mondo degli allevatori ornitologici, con l’abbandono da parte di chi forse aveva inteso (o frainteso) la passione dell’allevamento per soddisfare principalmente il lato commerciale del nostro hobby. Con le attuali difficoltà economiche, sempre più pressanti, altre persone saranno costrette a tralasciare o ridurre il proprio coinvolgimento nelle attività di selezione e riproduzione delle specie allevate; a costoro, rivolgiamo l’augurio di potersi presto nuovamente dedicare a quella passione che, grazie all’evidente forte traino psicologico e motivazionale, ci ha permesso di vivere e di “sopravvivere” nei periodi più bui che abbiamo attraversato di recente.
Siamo certi che chiunque abbia o avrà una seppur minima possibilità per non fermarsi, per continuare anche se a ranghi ridotti l’allevamento ornitologico, farà di tutto per “riprendersi” il piacere - che ci è stato ultimamente negato - di visitare e partecipare alle mostre, di incontrare i “colleghi” allevatori, scambiandosi i soggetti per migliorare le linee selettive, di attivare nuovamente quelle relazioni sociali che solo la frequentazione degli eventi ornitologici può generare.

I due anni di pausa forzata da tutto ciò che rappresenta il cuore dell’ornitologia amatoriale e sportiva, come la intendiamo noi, hanno tra l’altro agevolato chi, approfittando del periodo di inerzia accidentale, ha indubbiamente colto l’occasione per creare confusione nell’ambito istituzionale e organizzativo del nostro movimento, paventando la nascita di nuove “entità” non meglio definite con l’unico scopo di minare – per malcelati obiettivi personali – la base associativa della nostra Federazione.
Ecco, ci auguriamo davvero che questa sia la volta buona affinché la ripresa delle attività ornitologiche, quelle chiaramente ufficiali e ben organizzate secondo i regolamenti vigenti, possa fugare ogni dubbio in chi è stato oggetto di comunicazioni subliminali e “inviti” atti a infrangere le regole del nostro movimento. La ricca stagione mostre della FOI, dislocata su tutto il territorio nazionale, potrà finalmente avere la funzione di farci ritrovare tutti sotto la stessa bandiera: una bandiera fatta certamente di tante anime, che remano però nella stessa direzione con lealtà, sincerità, rispetto istituzionale, senza secondi fini ma con l’unico intento di mantenere vivo il vero senso dell’ornitologia.
NUMERO 10 - 2022 3


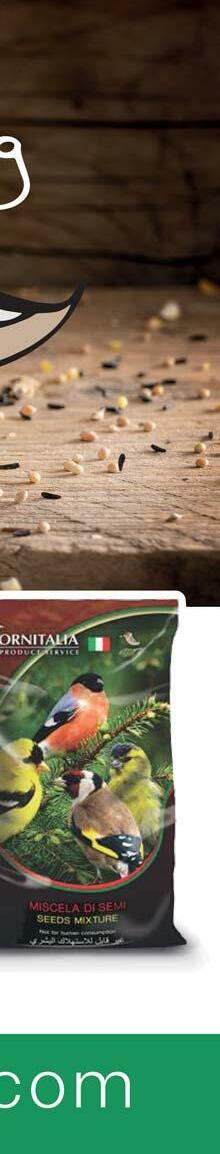






Parliamo dell’Agata
 di GIOVANNI CANALI, foto F.O.I. e E. DEL POZZO
di GIOVANNI CANALI, foto F.O.I. e E. DEL POZZO
L’agatanel campo dei melanici è la mutazione più importante; la ragione è che l’agata ha dato il via alla selezione dei diluiti, che comprende anche l’isabella che altro non è che l’interazione di bruno ed agata.

L’agata è mutazione recessiva e legata al sesso, molto sensibile a geni modificatori


L’agataautosomici.agisceriducendo le melanine in misure diverse, a seconda del maggiore o minore apporto di geni modificatori codificanti in modo utile. L’azione della mutazione agata è a tutto campo; infatti agisce non solo sulle penne, ma anche su: becco, zampe, pelle ed occhio, anche se l’aspetto dell’occhio lo si deduce solo dall’interazione con altre mutazioni, non essendo rilevabile alla vista (nell’agata classico), è logico ritenere che lo sarebbe al microscopio. Incredibile a dirsi, alcuni in passato hanno cercato di negare la natura di mutazione dell’agata, parlando di mera selezione. La natura di mutazione è evidente, anzi lampante. Già il comportamento genetico ed i risultati degli accoppiamenti lo indicano in modo certo. Un’agata maschio accoppiato con femmina nera, produce figli maschi neri/agata e femmine agata, certo atipici ma riconoscibili. Se si trattasse di selezione avremmo solo intermedi di entrambi i sessi. Come se non bastasse, alcune interazioni con tipi aggiunti evidenziano la natura di mutazione. I phaeo agata maschi, se ottimi, sono simili a dei lipocromici; impossibile con dei neri phaeo avere soggetti così atipici da annullare tutta la feomelanina. Aspetto anche più importante è l’occhio che nell’agata phaeo è rosso anche nell’adulto, mentre nel nero phaeo è rossiccio in modo percettibile solo nel pulcino di pochi giorni.
 Agata intenso rosso, foto: E. del Pozzo
Agata intenso rosso, foto: E. del Pozzo
NUMERO 10 - 2022 5 CANARINIDI COLORE
Anche l’interazione con il bruno che genera l’isabella evidenzia la natura di mutazione dell’agata per vari motivi; infatti l’occhio dell’isabella da pulcino è rosa, mentre nel bruno è rossiccio, inoltre anche la pars plumacea (il cosiddetto “sotto piuma”) nell’isabella è diversa da quella del bruno, apparendo bruna invece che nera. L’evidenza più lampante la troviamo negli jaspe; infatti mentre il nero jaspe singolo fattore ha una bifora nella stria, vale a dire contorno e rachide scure, con parti interne più chiare, l’agata jaspe singolo fattore ha la stria allargata ma di colore uniforme. Evidentemente, per ragioni non note, esiste un antagonismo fra agata e jaspe. Antagonismo non prospettabile se vi fosse solo un fatto selettivo. Segnalo che a volte le linee scure al margine della stria e la rachide pure scura del nero jaspe singolo fattore, vengono definite binari, evidentemente dimenticando che i binari sono paralleli, mentre nella bifora vi è convergenza apicale

come nella stria degli jaspe neri singolo fattore. Pensate a quanti deragliamenti vi sarebbero con binari convergenti! Molto meglio parlare di bifora, anche se ha il peccato originale di essere stata proposta da me. Inoltre ad abundantiam segnalo che nei nidi misti il colore della pelle e la riduzione dell’eumelanina nera su becco e zampe consentono di distinguere i pulcini agata dai neri. Certo sono situazioni anomale visto che non si deve accoppiare nero x agata, tuttavia accade. Ricordo che da ragazzo mi venne rifilato un nero che portava l’agata e che accoppiai con femmina

nera. Ebbene la metà delle figlie che erano agata si palesavano come tali anche nel nido, per la pelle più chiara e per la situazione del becco che aveva solo la punta nera (comunque difetto), non ricordo le unghie ma presumo pure Demolita,difettose. spero in modo sufficientemente drastico, la strana idea della selezione, passo a considerare le diverse espressioni dell’agata. Il tipo agata è anche stato definito come “nero diluito” il che è abbastanza corretto. Taluno ha criticato l’espressione diluito poiché le melanine dal punto di vista chimico si riducono ma non si diluiscono se non pochissimo. Tuttavia l’aspetto esteriore è quello tipico di una diluizione. Inoltre usando il termine tradizionale di diluizione ci si distacca da altre riduzioni od inibizioni dei vari tipi aggiunti. A mio parere l’espressione diluizione è quindi accettabile.
L’azione dell’agata riduce notevolmente la feomelanina, creando in periferia un alone detto in gergo “mandorla”. Alcuni asseriscono che questo aspetto sia il maggiore, dicendo anche che l’azione dell’agata sarebbe la più efficace proprio sulla feomelanina. Personalmente non condivido affatto questa tesi. L’azione è rilevante anche sull’eumelaIlnina.disegno di eumelanina nera è ridotto, in apparenza concentrato e reso sottile, nonché spezzato. Vale a dire che non si ha l’apparenza del binario o rigone che si ha nei neri spinti di selezione. L’alone periferico segna la diversità delle varie strie rispetto alle successive. La situazione del disegno è stata descritta “a chicco di riso”. Personalmente non amo molto questa descrizione, visto che il disegno è più sottile di un chicco di riso, almeno nei soggetti tipici. A me non dispiace dire come “un’unghiata”, almeno parlando e riferendomi ai più tipici, mi pare renda bene l’idea. Le descrizioni ufficiali hanno spesso parlato di: massima diluizione del bruno e massima concentrazione del nero. È una descrizione che io apprezzo. Rende bene l’idea, anche se ad essere precisi non si ha una vera concentrazione del nero ma una sua riduzione che rende più sottile la stria. Tuttavia quando il nero si mantiene evidente e lucido l’im-

 Agata intenso giallo, foto: E. del Pozzo
Agata intenso giallo, foto: E. del Pozzo
L’interazione con il bruno che genera l’isabella evidenzia la natura di dell’agatamutazione
6 NUMERO 10 - 2022
pressione è quella di una concentrazione. Ritengo perfino utile dire così per evitare che vengano accettati disegni grigiastri. Un ottimo agata non va considerato come un pessimo nero, bensì come un ottimo nero fortemente modificato.Neisoggetti
tipici l’alone periferico è ampio e quasi biancastro - ribadisco il "quasi" (carotenoidi a parte) per la fortissima diluizione della feomelanina. Questo alone o mandorla mette in evidenza la stria sottile nera lucida, ove il nero sembra concentrato, questo nei soggetti ottimi.




L’azione dell’agata agisce anche su becco e zampe. Becco e zampe nei soggetti tipici sono carnicini. Tracce nere sono difetto; tali tracce attengono facilmente alla punta del becco e più raramente all’inizio dello stesso, nel qual caso è difetto ancora più grave. Per quanto riguarda le zampe, si notano tracce nere spesso sulle unghie, molto raramente sulle squame dei tarsi - me-
tatarsi, nel qual caso è difetto gravisPellesimo. e occhi sono pure interessati, la pelle è più chiara, direi grigiastra, mentre gli occhi sembrano normali ma così non è, come evidenziano le mutazioni: bruno, phaeo e forse altre in interazione. Ne ho già parlato prima.
Difetti del disegno sono dovuti spesso a scarsa diluizione, nel qual caso possiamo avere: disegno largo, lungo, tracce di bruno eccessive, aloni (mandorle) poco evidenti; diverso il caso del nero sbiadito, tendente al grigiastro. Altri difetti possono essere comuni al
tipo nero, quindi non propri dell’agata ma di tutti i tipi, che derivano tutti dal nero, o meglio - nero bruno, tipo originale, mi piace chiamarlo il “tipo dei tipi”. Questi difetti sono: carenze di strie su testa, fianchi, petto e scarso apporto di eumelanina nera. Ovviamente nell’agata non è difetto la carenza di feomelanina bruna, che invece lo sarebbe nei bruni, come pure nei nero – bruni di tradizionale concezione.
La selezione dell’agata, essendo un diluito, esclude accoppiamenti con ossidati, vale a dire neri e bruni; essendo linee opposte: massima ossidazione negli ossidati, cioè espressione delle melanine e massima diluizione nell’agata ed isabella, forme diluite.
L’agata ha nell’accoppiamento in purezza cioè agata x agata la migliore soluzione. Si scelgono i migliori agata da accoppiare fra di loro. Se vi è qualche difetto non grave, si va in compensazione accoppiando con soggetti ottimi dove l’altro è carente.

Il disegno di eumelanina nera è ridotto, in sottile,concentratoapparenzaeresononchéspezzato
NUMERO 10 - 2022 7
Agata brinato rosso, foto: E. del Pozzo Agata brinato giallo, foto: E. del Pozzo
Difetti gravi che suggeriscono l’esclusione dalla riproduzione sono legati alla molto scarsa diluizione, che comporta in modo variabile: disegno lungo e largo, tendente al tipo nero, elevata quantità di feomelanina bruna specialmente nei maschi, punta del becco molto nera ed unghie molto nere, gravissimi difetti sono le tracce di nero sui tarsi - metatarsi e alla radice del becco.
Ulteriori gravi difetti comuni a tutti i tipi, sono: strie dei fianchi molto deboli o assenti, testa pochissimo striata, anche il petto pochissimo segnato è difetto grave.

In effetti il tipo agata si esprime in modo variabile, ma non si tratta di espressività variabile in senso stretto, che sarebbe pochissimo o per nulla controllabile, ma si tratta di diverso apporto di geni modificatori, che si selezionano come le caratteristiche poligeniche e rispondono bene alla seDalezione.considerare


che se il gene dell’agata è legato al sesso, i geni modificatori sono autosomici, quindi sono trasmessi indifferentemente dal maschio come dalla femmina.
Un aspetto particolare è che la feomelanina è certo ridotta dai geni modificatori con corrispondente mandorla, ma vi può essere una selezione ulteriore contro la feomelanina in quanto tale. In altri termini, la stessa riduzione che si ricerca nei neri di attuale concezione. Nel qual caso certi agata possono avere pochissima feomelanina, ma disegno lungo per carenza di mandorla. Ricordo di aver allevato un soggetto scadente con disegno lungo ma con minima feomelanina bruna, somigliava ad un nero eumo scarso. La complessa condizione poligenica del tipo può indurre moltissime L’accoppiamentovariazioni. con isabella è fattibile, purché l’isabella provenga da ottimi agata e quindi sia esso stesso ottimo. L’accoppiamento agata x isabella è un classico che giova all’isabella poiché aiuta a mantenere un buon disegno. Tuttavia non ha aspetti di aiuto nei confronti dell’agata, anche se accettabilissimo. Una precauzione quando si accoppia isabella x agata è quella di considerare che certi difetti nell’isabella potrebbero essere occulti. Tracce di eumelanina sul becco o sulle zampe non sono visibili nell’isabella ma potrebbero emergere nella prole agata. La qualità del disegno la si può valutare bene negli isabella, ma qualche dubbio potrebbe esserci per l’espressione dell’eumelanina che negli isabella è bruna. Si tenga presente quindi che l’espressione giusta del disegno isabella è nocciola, di una tonalità palesemente più scura rispetto al caffelatte della feomelanina. Un disegno bruno troppo chiaro può corrispondere ad un grigiastro nelPerl’agata.quanto riguarda gli accoppiamenti misti con ossidati neri e bruni, ho già detto che sono da escludere per via delle linee selettive opposte. Ora che gli ossidati danneggiano i diluiti è ovvio, poiché i geni modificatori, comunque
 Agata mosaico rosso maschio, foto: E. del Pozzo
Agata mosaico rosso maschio, foto: E. del Pozzo
L’accoppiamento con isabella è fattibile, purché l’isabella provenga da ottimi agata e quindi sia ottimo
8 NUMERO 10 - 2022
presenti, non codificano in modo utile all’espressione dell’agata. Invece non è affatto ovvio che anche gli ossidati subiscano un danno nella loro espressione; infatti questo non succede normalmente, come ad esempio con il pastello ali grigie, che pure ha geni modificatori, ma del tutto inefficaci sul classico, secondo la regola generale. Difronte a questa particolarità, in passato ho pensato che i geni modificatori codificanti in modo utile per all’agata potessero agire in modo, questa volta, non utile ma dannoso almeno per i nostri parametri, nei confronti delle forme ossidate. Quindi con un’azione anche in assenza del carattere prodotto dal gene maggiore. Mi sono permesso di ipotizzare un fenomeno di “geni modificatori forti”, mai descritto in letteratura scientifica e l’ho fatto anche in qualche altro caso. Ora io sono un critico severo con gli altri e severissimo con me stesso, di conseguenza mi sono posto e mi pongo Agata mosaico giallo maschio, foto: E. del Pozzo








NUMERO 10 - 2022 9
sempre alcuni interrogativi. Mi sono detto, se per caso i geni modificatori, la cui presenza è evidente, direi quasi certa, siano geni modificatori non tanto dell’agata bensì del nero, tesi a ridurre il disegno per ragioni mimetiche in natura. Nel qual caso sarebbero nocivi per le nostre selezioni domestiche del nero, che vogliamo a disegno lungo, non avendo esigenze mimetiche ma solo estetiche, ed utili nell’agata, ove cerchiamo l’opposto, cioè disegno spezzato. Un rovesciamento della frittata. Tuttavia la presenza di “mandorle” così tipiche (aloni periferici) che attengono al bruno, oltre all’aspetto generale, mi induce a mettere in dubbio, ma non ad escludere del tutto, l’esattezza della mia impressione iniziale. Valuti il lettore, se crede, questo aspetto.



Colgo l’occasione per ribadire che una tesi secondo la quale vi sarebbe anche una feomelanina gialla, è destituita di ogni fondamento (dico così per non essere troppo pesante). Che esista feomelanina gialla è certo, ma non nel canarino, ove è bruna. Secondo la tesi suddetta l’agata inibirebbe la feomelanina gialla. E questo sarebbe il motivo del fatto che alcuni lipocromici rossi con l’ala bianca sarebbero geneticamente agata. La tesi suddetta non tiene conto del fatto che l’acianismo, inibendo tutte le melanine, inibirebbe anche quella gialla, se ci fosse, per giunta le macchie melaniche non confermano la tesi che sto confutando. Inoltre, chi dice ciò evidentemente non si è dato la pena di guardare l’ala degli agata melanici, i quali se a fattori gialli
hanno il bordo giallo come tutti gli altri canarini. Se a fattori rossi hanno pure l’ala a bordo giallo, poiché nei melanici la varietà è meno selezionata rispetto ai lipocromici. L’ala bianca è propria dei rossi migliori con più fattori per il rosso; avendo poco giallo, l’ala rimane biancastra poiché i carotenoidi rossi si formano più lentamente e non fanno in tempo a pigmentare le remiganti ed altre penne forti che si formano prima e sono più grandi. Nei melanici di tutti i tipi, non ho ancora visto un soggetto ad ala bianca, ma non dispero. L’ala sotto questo aspetto è uguale in tutti i tipi, ed il biancastro può essere solo una questione di varietà ottima nei rossi.C’èil problema delle interferenze da considerare. La prima interferenza è data dell’intenso; il restringimento del vessillo causa l’accorciamento delle barbe e restringe il disegno, favorendo gli intensi. Nei brinati la stria è leggermente più larga, anche se in modo poco rilevante nei migliori brinati. Stria più larga in modo rilevante nei mosaico poiché si accoppia quasi sempre mosaico x mosaico allargando il vessillo. Un aspetto apparentemente migliorativo, ma solo apparentemente, è dato dal satiné latente che essendo allelico all’agata schiarisce l’agata. I brinati e i mosaico portatori di satiné somigliano a degli agata pastello e non sono utilizzabili da mostra. Gli intensi invece reggono, avendo il vessillo ristretto che restringendo il disegno lo mantengono da agata classico. Semmai l’ulteriore riduzione della feomelanina conferisce un pregio non proprio genuino di cui è bene tener conto. C’è poi il problema del mono melanico che inibendo la feomelanina potrebbe dare un effetto superiore; c’è da sperare che il disegno non subisca danno, ma non sono in grado di dirlo, non avendo osservato agata mono melanici sicuri, spero intervenga chi lo avesse fatto. Sia con il satiné latente che con il mono melanico sarà bene non farsi ingannare dalle apC’èparenze.poil’aspetto del fondo bianco ed avorio che mettono in evidenza la feomelanina. È perentorio tenerne conto per non penalizzarli ingiustamente. È successo ed è bene che non si ripeta.
 Agata bianco, foto: E. del Pozzo
Agata bianco, foto: E. del Pozzo
10 NUMERO 10 - 2022







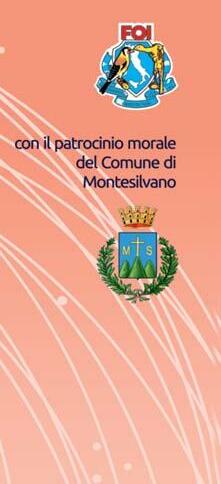










Donacola petto castano x Passero del Giappone

Ibridi e reincroci
testo e foto di SIMONE OLGIATI
La storia di questa ibridazione nasce circa sei-sette anni fa, quando, fra i miei diversi progetti, era in cantiere quello di scoprire di più riguardo una misteriosa mutazione apparsa nei miei Passeri del NellaGiappone.stagione cove 2014-2015 una coppia di P. del G. ebbe una numerosa prole, allevando anche due Ibridi di Passero del Giappone x Padda assieme ai propri piccoli (vedasi “Italia Ornitologica” n°5/2021). Il maschio era della mutazione perlato grigio, la madre una nero bruna; oltre a novelli nero bruni maschi e perlate brune femmine, ottenni anche maschi nero grigi e femmine perlate grigie (denotando il fatto che la madre fosse portatrice di grigio). Inoltre, e solo nella prima covata, nacquero tre femmine
Il maschio era della mutazione perlato grigio, la madre una nero bruna; oltre a novelli nero bruni maschi e perlate brune femmine, ottenni anche maschi nero grigi e femmine perlate grigie
dal colore inusuale: la prima presentava un colore generale seppia, con ali, coda e maschera più scuri e il disegno ventrale era abbastanza flebile; le altre due erano simili a delle rosso grigie con maschera facciale da moka grigio. Queste ultime le cedetti ad un amico e trattenni solamente la prima, presumibilmente a base bruna, sicuramente anche perlata, essendo il padre affetto da tale mutazione (ricordiamo che il perlato è una mutazione sesso-legata). Per scoprire la natura genetica di tale femmina decisi di accoppiarla ad un maschio di
specie diversa appartenente al genere Lonchura. Lo scopo era quello di ottenere F1 maschi fertili, i quali sarebbero poi stati accoppiati uno alla madre, altri a femmine di P. del G. e femmine della specie paterna per scoprire se il fenotipo inusuale della capostipite fosse ereditabile o meno. Tale scelta fu dettata dalla volontà di ottenere soggetti eterozigoti per il fattore mutante materno, ma privi di altre mutazioni o eventuali geni del Passero del Giappone che avrebbero potuto creare interferenze col fenotipo

 La femmina di Passero del Giappone capostipite di tutti gli Ibridi, perlata bruna portatrice di rosso grigio
La femmina di Passero del Giappone capostipite di tutti gli Ibridi, perlata bruna portatrice di rosso grigio
NUMERO 10 - 2022 13 ESTRILDIDI FRINGILLIDI IBRIDI
misterioso.Primaparte
Il Passero del Giappone appartiene al genere Lonchura, clade che raggruppa altre specie di Passero, di Cappuccini e di Donacole. Gli ibridi intragenerici di sesso maschile realizzati all’interno di questo taxon sono tutti fertili. Conseguentemente, i maschi nati dall’accoppiamento di un maschio appartenente al genere Lonchura e di una femmina di Passero del Giappone (invertendo i sessi delle specie genitrici, il risultato non cambia) sono fecondi. Sulla base di tali presupposti, iniziai l’esperimento.


Come padre scelsi una Donacola petto castano anellato 2013 di piccola taglia, ma con ottimi disegni e colore. Essendo già stato riproduttore ed avendone in allevamento i figli nati in purezza ero sicuro della sua Lafecondità.coppia
venne assemblata il 7 settembre del 2015 in una gabbia schermata all’inglese di dimensioni 60 x 40 x 40 cm facente parte di una batteria di otto. Come alimentazione venne fornita una miscela di semi composta da misto per esotici e per cocorite in parti uguali, pastoncino semi-morbido abbastanza “carico” (20% circa di proteine, 8% circa di lipidi), spighe

di panico, gusci d’uovo pestati e osso di seppia. Il maschio non si fece scrupoli e cominciò subito a corteggiare la compagna, la quale si trovò così intimorita da tanta focosità da scappare in ogni angolo della gabbia. Dopo qualche settimana la situazione si calmò e infatti il 3 del mese successivo la P. del G. depose il primo di sei uova, covate affettuosamente da entrambi i partner. Le prime due si schiusero il 24 ottobre, le altre nei giorni seguenti. Un embrione morì nel guscio. Però il quarto pullo si presen-
tava diverso dagli altri: aveva carnagione più chiara e, soprattutto, degli evidentissimi occhi rossicci, color vinaccia. La domanda sorse spontanea: che mutazione affliggeva quel pullo? I misteri, quindi, diventarono due: scoprire il genotipo materno e quello del figlio mutato. Confrontatomi con amici allevatori, scoprimmo che il piccolo era di colore rosso bruno. Alla luce dei fatti, ero molto perplesso: della P. del G. conoscevo i genitori e la nonna materna, una nero bruna ciuffata, e sapevo che la linea paterna era composta da un ceppo di perlati; d’altro canto, il ceppo di Donacole p.c. a cui il padre apparteneva era composto da soggetti tutti ancestrali. Quindi, per caso fortuito, assemblai una coppia in cui entrambi i partner erano eterozigoti per la mutazione rosso bruna senza che io lo sapessi. Stupefatto dell’evidenza, rimasi non particolarmente soddisfatto da ciò che era successo: il fatto che il padre fosse portatore di tale colore indicava che il suo genoma era inquinato da alleli provenienti dal Passero del Giappone, poiché la mutazione rosso bruna era stata traslata dal P. del G. alla Donacola petto castano.

 F1 rosso bruno maschio. Da notare il colore molto intenso e carico, specialmente nel sottocoda, tutto di origine feomelanica
F1 rosso bruno femmina. Il colore e piu slavato del fratello e la coda e praticamente tutta giallastra
F1 rosso bruno maschio. Da notare il colore molto intenso e carico, specialmente nel sottocoda, tutto di origine feomelanica
F1 rosso bruno femmina. Il colore e piu slavato del fratello e la coda e praticamente tutta giallastra
In questi processi di trasmutazione non si ha solo il cigeneticadell’informazionetrasferimentochecodificalamutazionecheinteressa,maanchedituttaunaseriedisequenzealleliche
14 NUMERO 10 - 2022
In questi processi di trasmutazione non si ha solo il trasferimento dell’informazione genetica che codifica la mutazione che ci interessa, ma anche di tutta una serie di sequenze alleliche che possono alterare altre componenti del fenotipo e del metabolismo, sequenze che ai nostri occhi non sono visibili o, peggio ancora, vengono considerate poco importanti. In questo caso in particolare, ero preoccupato che quella minima “percentuale di sangue” di Passero del Giappone potesse rendere vano il mio lavoro. In ogni caso, decisi di continuare a lavorare con la coppia. I pulli ancestrali venivano imbeccati ottimamente, sia dal padre che dalla madre, mentre il rosso bruno rimaneva indietro con la crescita, presentandosi di taglia minore e più lento nello sviluppo nel piumaggio. Integrando la dieta dei genitori con un estruso bagnabile asciugato con lo I quattro novelli appena involati in compagnia dei genitori








NUMERO 10 - 2022 15
stesso pastone descritto precedentemente la situazione migliorò. Un piccolo, appena impiumato, pur-





troppo morì a causa di un fortuito incidente, mentre il resto della nidiata uscì dal nido il 16 novembre, a circa venti giorni d’età. Imbeccati dal padre, i novelli vennero separati dai genitori dopo ulteriori 25 giorni. Nel frattempo, la femmina depose altre cinque uova tutte fertili, di cui tre si schiusero il 21 dicembre e le altre nei giorni successivi. Anche qui ebbi la nascita di un soggetto rosso bruno; tutti e cinque i soggetti si svezzarono con tempistiche simili a quelle della covata precedente. Purtroppo, persi un soggetto nero bruno in fase di Nellamuta.terza covata ebbi solo un uovo fecondo su cinque; nacque un altro nero bruno che però non venne imbeccato, essendo i genitori infastiditi dalla presenza dei piccoli della covata precedente. Complessivamente superarono la muta sei soggetti nero bruni e due rosso bruni, suddivisi equamente in maschi e femmine. Il maschio rosso bruno, nonostante la piccola taglia, si presentava decisamente appariscente per via di un colore rosso volpe molto intenso e brillante, più chiaro sulle ali; i disegni di testa e petto purtroppo erano poco
evidenti e si mescolavano col colore di fondo; coda, codione e sottocoda erano marrone scuro; il ventre era bianco e sui fianchi un disegno intermedio tra quello della Donacola petto castano e del Passero del Giappone. La sorella rosso bruna si presentava simile, ma di taglia maggiore e con un colore più tendente all’arancione. I sei nero bruni erano praticamente identici tra loro: maschera facciale e gola nere, con striature caffelatte sulle guance, testa e nuca marrone nerastro con disegno ocellato grigio, dorso bruno scuro con poche rachidi ma ben evidenti, ali nerastre; codione, coda e sottocoda neri, petto marrone-arancio castano, diviso dal ventre bianco da una linea nera. Sia i nero bruni che i rosso bruni avevano le valve del becco color grigio acciaio azzurrato. Incredibile ma vero, tra gli ibridi vi era dimorfismo sessuale, seppur debole: le femmine presentavano orlature giallastre ai lati delle timoniere, assenti nei maschi; addirittura, la femmina rosso bruna sembrava avere interamente la coda giallo-aranciato. In ogni caso, questo colore ocra era molto simile, se non uguale, a quello
 Nidiata di cinque F1, dove si vede chiaramente il mutato rosso bruno in mezzo a quelli nero bruni
Un F1 nero bruno ed uno rosso bruno a confronto. In evidenza il disegno ventrale del soggetto a sinistra
Particolare della coda di una femmina F1 che mostra alcune timoniere con un riflesso ocra di origine feomelanica. Gli F1 maschi hanno la coda completamente nera
Nidiata di cinque F1, dove si vede chiaramente il mutato rosso bruno in mezzo a quelli nero bruni
Un F1 nero bruno ed uno rosso bruno a confronto. In evidenza il disegno ventrale del soggetto a sinistra
Particolare della coda di una femmina F1 che mostra alcune timoniere con un riflesso ocra di origine feomelanica. Gli F1 maschi hanno la coda completamente nera
16 NUMERO 10 - 2022
della coda del papà. In buona sostanza, gli ibridi presentavano un fenotipo con distribuzione di colori e disegni molto simili a quello del padre, anche se erano presenti caratteristiche tipiche materne, come la forma della coda più lanceolata rispetto a quella della Donacola ed il disegno del fianco che ricalcava un poco quello a lisca di pesce, tipico del Passero del Giappone. Uno dei nero bruni, un maschio, spiccava sugli altri: era di taglia maggiore, aveva un portamento decisamente più fiero, il petto più ricco di eumelanina a causa del nero della gola che debordava e una quantità di disegno ventrale decisamente elevata, sebbene ricordasse solo alla lontana quello della madre. Visto il numero di soggetti ottenuti e considerato il fatto che erano di una qualità discreta, decisi di esporne qualcuno alle diverse mostre. I soggetti non delusero le aspettative, arrivando a podio a Zebra’s e ad Esotica 2016 sia come singoli che come Dopostamm.il


periodo mostre decisi di accoppiarli, ma in che modo?



Al maschio rosso bruno venne affiancata una femmina di Passero del Giappone perlata grigio, allo scopo di vedere se i figli R1 avrebbero avuto un fenotipo perlato o simile a quello della P. del G. capostipite. Altri due maschi vennero ceduti ad amici, mentre il maschio più bello sarebbe dovuto essere accoppiato alla madre, la quale però morì in un giorno di mia assenza in allevamento. Sciaguratamente non trovai femmine di Donacola petto castano per lavorare su questa linea e dall’unica coppia composta non ottenni mai nemmeno un uovo. Le femmine F1 non le accoppiai, essendo sterili. Così si interruppe il lavoro nel mio allevamento riguardo gli Ibridi di Donacola p. c. x P. del G. ma, fortunatamente, qualcuno ebbe maggior successo.

NUMERO 10 - 2022 17









Le deloriginiCanarino Lizard
di NICOLA GIORDANO (LIZARD CANARY CLUB ITALIANO), foto D. MUNGIGUERRA, FLORANIMAL RU e WIKIPEDIA ORG



Trale varietà di canarini esistenti, il Lizard occupa una posizione unica. Tutte le altre razze sono relativamente recenti, la maggior parte a memoria d’uomo: solo il Lizard sembra sia stato allevato senza aver subito alcun cambiamento nelle sue peculiari caratteristiche, da secoli, così addietro che le sue origini sono ancora misteriose. Negli antichi testi di storia naturale non si rilevano riferimenti ad alcuna particolare varietà di canarino. Poi Gesner, nella sua “Historia Animalium” (1555), descrisse la specie selvatica e indicò chiaramente che i canarini furono importati dalle Canarie nel Continente e in Inghilterra. Circa un secolo dopo, nel testo “Husbandry” (1675), Joseph Blagrowe così recitava: «Innanzi tutto comincerò con l’uccello chiamato canarino perché proveniente dalle Canarie (e penso che sia il miglior uccello cantore), ora allevato intensamente in Germania ed anche in Italia». È interessante notare che a quei tempi i canarini erano tenuti in cattività senza alcuna menzione circa le varietà. Nell’Europa Continentale le prime descrizioni delle varietà ci sono pervenute dalla Francia. Hervieux, nel “Traitè des serins de Canaries” (1713), ha indicato e descritto ben 29 varietà, la maggior parte varianti di colore che apparvero nel corso dell’allevamento (mutazioni). In ogni caso, tra le varietà indicate, ve ne era una che alcuni hanno sostenuto essere l’originale canarino Lizard, poiché era descritta come un canarino verde provvisto di disegno sul dorso; tuttavia, tale varietà non è stata indicata con un nome ben definito. Un successivo ac-
Il Lizard sembra sia stato allevato senza aver subito alcun cambiamento nelle sue peculiari caratteristiche
 Lizard maschio dorato, senza calotta, foto e all. DomenicoMungiguerra
Lizard maschio dorato, senza calotta, foto e all. DomenicoMungiguerra
NUMERO 10 - 2022 19 CANARINIDI FORMAE POSIZIONE LISCI
cenno alle origini continentali del Lizard è contenuto nel vecchissimo libro “The Bird fancier’s necessary companion”, datato 1762, che descrisse chiaramente la razza ed accennò ad essa come “La bella specie coperta di scaglie... che pochi anni fa è stata introdotta dalla Francia, ma che è stata migliorata nel colore e nella bellezza dagli allevatori inglesi”. Le indicazioni di cui sopra ci aiutano a capire l’opinione diffusa che il Lizard fu portato in Inghilterra dai profughi Ugonotti, sembra –in particolare – da tessitori. Claude St. John, dopo aver accennato ai profughi Ugonotti, scrisse che il Lizard fu introdotto in alcuni centri quali Nottingham, Middlesbrough, Norwich e Spitalfields nel XVI secolo. La nefasta persecuzione religiosa nei confronti degli Ugonotti durante la seconda metà del XVI secolo (Massacro del giorno di S. Bartolomeo, 1572) continuò per oltre un secolo, in-




tensificandosi sotto Luigi XIV (editto di Nantes 1685); gli Ugonotti stessi nelle loro continue fughe portarono con loro i canarini preferiti. Anche nel secolo XIX la storia del Lizard è nebulosa. Le società ornitologiche, seppure già esistessero, non erano certo organizzate come oggi; quindi, sono poche le tracce della loro attività. Le mostre non erano null’altro che riunioni di pochi allevatori in qualche locale o stanza adibita allo scopo dal padrone di casa. Come scritto nelle poche note rinvenute, l’unica mo-
stra di canarini riconosciuta fu, a metà del secolo XIX, quella del London Fancy, varietà estinta e strettamente collegata al Lizard. Ciò è dimostrato chiaramente da un dettagliato articolo apparso il 12 dicembre 1846 su “The Illustrated London News”. Il Lizard stesso, secondo questo articolo, non era tenuto in gran considerazione, quantunque già possedesse una bellezza comparabile a quella del London. Venticinque anni più tardi, a seguito del declino del London, il Lizard fu maggiormente apprezzato e fu allestita una mostra al Crystal Palace di Londra. Anteriormente alla Prima guerra mondiale, il Lizard rimase una razza prettamente locale e ben poche mostre furono fatte fuori dalle Contee suindicate (Nottingham, Middlesbrough, Norwich e Spitalfields). La Prima guerra mondiale inferse un duro colpo a tutte le razze esistenti, ma ancor più al Li-
 Lizard femmina argentata, calotta spezzata, foto e all. DomenicoMungiguerra
Lizard maschio argentato, calotta netta, foto e all. DomenicoMungiguerra
Lizard femmina argentata, calotta spezzata, foto e all. DomenicoMungiguerra
Lizard maschio argentato, calotta netta, foto e all. DomenicoMungiguerra
il Lizard fu portato in Inghilterra dai profughi Ugonotti, sembra –in particolare –da tessitori
20 NUMERO 10 - 2022
zard; a metà del periodo bellico, gli allevatori si contavano sulle dita di una mano, ma i pochi esemplari esistenti erano sempre esposti nelle migliori mostre. La Seconda guerra mondiale diede un ulteriore duro colpo alla non comune razza che rischiò l’estinzione. Nel 1945 fu costituita la “Lizard Canary Association” (L.C.A), fondata da Robert H. Yates di Wolverhampton, con l’obiettivo principale di salvare dall’estinzione i pochi esemplari rimasti. Furono presi contatti con tutti gli allevatori conosciuti per fare un censimento e si arrivò al seguente risultato: non esistevano più di 30 coppie di canarini tipici. Si adottò una ferma politica per salvaguardare il prezioso patrimonio ed evitare speculazioni e fu chiesto ai pochi esperti allevatori di non cedere per due o tre anni i loro soggetti se non a membri della L.C.A. Un gran contributo fu dato dall’editore di “Cage and Aviary Birds” che diede molto risalto all’opera
degli allevatori. Due anni dopo si poté iniziare la vendita dei soggetti. Il Lizard così comparve di nuovo alle mostre. I soci della L.C.A., dopo cinque anni, erano una cinquantina e crebbero di molto negli anni seguenti, estendendosi in tutte le Contee inglesi. Oggi la razza è diffusa in tutto il mondo, anche se ancora rimangono misteriose le sue origini. Su di esse, si fanno due ipotesi:

1) Ibridazione tra il Canarino e altre Specie (Serinus pusillus, Sicalis flaveola, Serinus serinus, etc.). 2) Mutazione av-




venuta in allevamento.
1) Ibridazione. Tra le specie accennate, quella che sembra essere la più probabile è la ibridazione con il Serinus pusillus (Verzellino fronte rossa). Questo è un serinus euroasiatico molto attraente, col colore di fondo giallo arancio, con una chiazza rossa sulla fronte (che potrebbe corrispondere alla calotta lipocromica del Lizard). Esso ha striature simili a quelle del Lizard, in particolare ai “rowings” su fianchi e petto, ma il suo disegno è formato da striature brevi, non interrotte da una lunetta. Vive in zone montane (ha il suo habitat dal Medio Oriente fino all’Asia, dalla Turchia all’Iran, al Pakistan, all’Afghanistan, all’India, alla Cina, al Tibet e al Nepal) ed è molto difficile da allevare alle nostre latitudini. Ha bisogno di un’attenzione speciale per l’igiene e la prevenzione delle malattie, e anche in questo caso la sua mortalità è molto elevata. Non c’è ancora una risposta del
Lizard femmina argentata, calotta netta, foto e all. DomenicoMungiguerra
Lizard femmina dorata, senza calotta, foto e all. DomenicoMungiguerra
La Prima guerra mondiale inferse un duro colpo a tutte le razze esistenti, ma ancor più al Lizard
NUMERO 10 - 2022 21
perché questi uccelli si indeboliscano improvvisamente dopo diversi mesi di buone condizioni e poi muoiano in un breve periodo di tempo. A volte non è facile portarli in condizioni riproduttive, anche se occasionalmente si sono ottenuti novelli. Un’altra precisazione: alcuni sostengono che tutti gli ibridi tra Serinus canaria x S. pusillus sono sterili; ne deriva che non è possibile sostenere il ruolo dell’esotico nella creazione della Razza Lizard. Nella realtà si sono più volte ottenuti F1 fertili dagli accoppiamenti tra il Verzellino e Canarine domestiche. Ma detti ibridi sono molto rari, manifestano la costituzionale debolezza ereditata dall’esotico (alta mortalità) e sembrano essere fertili dopo il secondo anno di vita in poi. Ai tempi attuali nessuno, ancora, si è addentrato in esperimenti di ibridazioni e di reincroci per anni di seguito nel tentativo di “ricreare” il Lizard dal S. pusillus. E non si può escludere del tutto una possibile ibridazione con il nostro Verzellino (Serinus serinus) visto che alcuni allevatori ravvisano somiglianze tra i novelli, ma anche negli adulti (zone gialle sulla fronte, che però non sono lipocromiche come la calotta del Lizard e piccole striature più scure sul dorso e i fianchi). Lasciamo ora il Verzellino ed iniziamo a parlare dello Zigolo solforato (fringuello zafferano o botton d’oro).

In un articolo apparso nel 25 maggio 1991 del periodico “Cage & Aviary
Birds”, si è ipotizzato che il Lizard sia frutto di una ibridazione tra maschio Canarino e femmina Zigolo solforato (Sicalis flaveola). Gli ibridi sono stati descritti con becco e zampe scuri, ali e coda nerastri e con striature sul dorso simili alle scaglie del Lizard. Il fringuello zafferano o botton d’oro (Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)) è un fringuello del Sud America, molto comune nelle aree aperte e semiaperte delle pianure al di fuori del bacino dell’Amazzonia. Questo piccolo uccello ha un’ampia distribuzione che comprende la Colombia, il Venezuela settentrionale (dove è chiamato “canario de tejado” ossia “canarino dei tetti”), l’Ecuador occidentale, il Perù occidentale, il Brasile orientale e meridionale (dove è chiamato “canário-da-terra” o “canarino nativo”), Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina settentrionale e Trinidad e Tobago. Attualmente, la teoria della ibridazione è ritenuta meno probabile di quella della mutazione, anche se esistono ancora sostenitori dell’ibridazione stessa nella creazione del Lizard, per una serie di motivi che indicheremo di seguito. Uno di essi è rappresentato dalle caratteristiche dei pulli del Lizard. Questi nascono con becco scuro e zampe chiare. Per quanto riguarda il becco del Lizard, come avviene nei Fringillidi, appare scura la parte superiore (rinoteca) e chiara la parte inferiore (gnatoteca). Anche da adulto il becco del Lizard pre-

senta queste caratteristiche e risente poco o nulla della azione dei raggi solari. Le zampe, invece, nascono chiare e divengono più o meno scure solo se esposte alla luce solare. Ripeto, queste caratteristiche non sono proprie del canarino, ma molto simili a quelle dei Fringillidi. Ma mi chiedo: come poterono ottenere gli allevatori del 1600/1700 questi uccelli esotici?! L’unico uccellino “esotico” presente in quei secoli in Europa era il canarino. C’erano pappagalli, ma di poche specie e in scarso numero, fagiani dorati e argentati, pavoni, tacchini, qualche razza di polli e colombi ornamentali: questi erano gli unici uccelli che sopravvivevano ai trasporti del tempo, vuoi per l’alimentazione più spartana, vuoi per le dimensioni (robustezza) degli stessi. Infine, ricordo che le penne anomale del Lizard per la punta allargata e la tessitura soffice e vellutata non sembrano essere il frutto di ibridazioni, poiché non esistono fringillidi affini al canarino con tali caratteristiche nel piumaggio. Ed ecco che si fa strada sempre più fortemente la teoria della mutazione.

2) Mutazione. Una mutazione o meglio più mutazioni avvenute nel tempo sono probabilmente all’origine del Lizard. La/le mutazione/i avrebbero colpito sia il colore di fondo sia il disegno (scaglie e rowings). Bisogna ipotizzare che nel canarino ancestrale siano avvenute in allevamento più mutazioni (come d’altronde è stato per il ciuffo e per molte varietà di canarini di colore), mutazioni aggiuntive fissate dalla selezione. La ricombinazione genetica può dare esiti sbalorditivi! Pensiamo solo ad un esempio: dal lupo al cane e, tra i cani, dal Molosso al Chihuahua! Tuttavia, il Lizard continua ad essere il più grande mistero dell’ornitologia, e resta tale nonostante tutte le attuali avanzate moderne conoscenze di ingegneria genetica e di biochimica. Sarebbe auspicabile che un gruppo di seri ed esperti allevatori si accordassero tra loro per portare avanti un programma di esperimenti e di ricerche.
Parliamo un po’ di mutazioni. Quando in un volatile si verifica una mutazione, essa si manifesta in uno dei seguenti comportamenti ereditari: o omozigotica recessiva o eterozigotica domi-
Serinus pusillus, fonte: floranimal.ru
22 NUMERO 10 - 2022
nante o sesso-legata. Nel Lizard ciò non accade. Se accoppiamo un Lizard ad un normale nero-bruno (verde - oggi definiti “nero-giallo”, NdR ), tutti i figli sono nero-bruni (portatori del “fattore Lizard”). Nell’accoppiamento con un nerobruno, sia che il Lizard utilizzato abbia una calotta piena (cap) o spezzata (broken-cap) o difettosa (over-capped o bald-face), sembra che il “fattore calotta” sia ininfluente, dato che i meticci non evidenziano alcun segno di calotta. Se accoppiamo due meticci, NeroBruno/Lizard x Nero/Bruno/Lizard nascono: 75% non Lizard e 25% volatili con le scaglie del Lizard, ma tutti variegati (salvo rare eccezioni), con una gradualità tra meticci per 3/4 scuri fino a chiari macchiati! Il “fattore spangle” deriva da un anomalo, ma ben evidente comportamento ereditario; questo comportamento genetico, nei meticci e derivati, si manifesta per diverse generazioni. Se invece accoppiamo un Lizard x canarino lipocromico (giallo o rosso-arancio - oggi definiti “rosso”, NdR) nascono figli tutti “pezzati” (o “variegati”), le superfici del piumaggio scure evidenziano un disegno simile a scaglie, e la testa, di frequente, porta vari gradi della “calotta”. Da ciò possiamo dedurre che se un Lizard è accoppiato ad un nero-bruno (verde o ardesia - oggi definiti “nero-bianco”, NdR) il “fattore Lizard” si comporta da recessivo; mentre se è accoppiato ad un lipocromico, detto fattore si comporta da dominante! Non segue pertanto la regola mendeliana 1:1. Un comportamento ereditario alquanto bizzarro. Possiamo concludere che “il disegno spangle e rowing” sembra determinato da un gene libero e recessivo, ma a comportamento anomalo. Come suggeritomi da un colloquio telefonico intercorso tra me ed il giudice Giovanni Canali, illustre esperto di genetica, coesistono allelicità ed acianismo. Questa anomalia, unica in canaricoltura, che permette il “misterioso” piumaggio dei Lizards, con piume del tutto differenti rispetto a quelle dei normali Canarini, fa ancora pensare ad un apporto genetico estraneo a quello del normale patrimonio della Specie. Questo è il motivo per cui la teoria della ibridazione è ancora valida. Nel settembre 1995 è

stato pubblicato il libro “Il Colore del volo’’, scritto dal compianto prof. Riccardo Stradi, appassionato ornitofilo e docente di Chimica organica presso la facoltà di Farmacia dell’Università di Milano. Il prof. Stradi ha sviluppato avanzati metodi di analisi adatti alla identificazione dei vari tipi di carotenoidi nel piumaggio degli Uccelli. Egli ha in particolare dimostrato che i carotenoidi del Verzellino fronte rossa (Serinus pusillus) contengono le due xantofille A e B e anche la cantaxantina. Sappiamo che la specie Serinus canaria e tutte le Razze da esso derivate (eccetto le varietà a fattore rosso del Canarino di colore derivate dal Carduelis cucullatus) possiedono carotenoidi senza cantaxantina. Nella ipotesi che il Lizard abbia avuto origine dal Serinus pusillus, se trovassimo anche la pur minima traccia di cantaxantina tra i carotenoidi delle piume del Lizard, avremmo una conferma della ipotesi di una origine ibrida dal Verzellino fronte rossa. Il prof. Stradi ha scoperto inoltre che i lipocromi dei Lizard, il giallo per intenderci, non deriva dalle “xantofille A e B” come nei normali canarini ma dalla “zeaxantina” e dalla “luteina” che il canarino acquista con la dieta. Ripeto per chiarezza. Il pigmento giallo del Lizard non contiene le xantofille A e B del canarino. La luteina e la zeaxantina vengono assorbite dal Lizard tramite l’alimentazione, perché
tale canarino non è in grado di trasformare questi carotenoidi nelle xantofille, come fanno tutti i canarini. Questa peculiare caratteristica del Lizard è invece propria di molti Fringillidi nostrani e esotici. Sempre Giovanni Canali afferma correttamente che il colore di fondo del Lizard appare molto più carico del giallo degli altri canarini, diventandone una caratteristica sua propria. In alcuni soggetti si rilevano tonalità bronzee, forse causate da tracce dei carotenoidi dell’organetto e del fanello (osservazione di Giovanni Canali). Ecco ancora un valido motivo che giustifica l’esistenza della teoria della ibridazione. Sarà in grado il nostro Club, con studi mirati di ingegneria genetica e di biochimica, in grado di risolvere il mistero? I mezzi tecnici oggi ci sono, manca - purtroppo- il “vile” denaro.

L’autore dell’articolo “I 90 anni dell’AMO”, Damiano Lo Porto, (Italia Ornitologica n° 8/9-2022), comunica le seguenti integrazioni al testo precedentemente inviato in redazione: Il nome corretto del Presidente AMO è Giuseppe Calzolari; all'elenco dei giudici AMO vanno aggiunti: Lauro Bonacini e Gianluca Gatti
 Sicalis flaveola, fonte: wikipedia_org, autore: Tom Fake
Sicalis flaveola, fonte: wikipedia_org, autore: Tom Fake
NUMERO 10 - 2022 23









Il Pettirosso del Giappone
Japanese Robin (Larvivora akahige), “il Folletto”

 di PIERCARLO ROSSI fotoF. RIGAMONTI
di PIERCARLO ROSSI fotoF. RIGAMONTI
Ilpettirosso giapponese è un uccellino dai colori molto vivaci e questo gli ha permesso di essere, un tempo, un popolare uccello da gabbia nel suo areale nativo. Vive e si riproduce nelle foreste montane da Sakhalin al Giappone meridionale, mentre nel periodo invernale migra a sud-ovest fino alla Cina meridionale e all’Indocina. Alcuni Autori riportano fino a cinque sottospecie, ma solo tre sono quelle ufficialmente riconosciute, una delle quali, la L.A. tanensis presente sulle isole Izu, è piuttosto diversa dalle altre come piumaggio, canto ed etologia; questo ci fa supporre possa trattarsi di una specie a sé stante, non ancora ufficialmente riconosciuta.
Sebbene localmente abbastanza comuni, i pettirossi giapponesi sono generalmente timidi ed elusivi, mantenendosi nel fitto sottobosco (sia nei luoghi di riproduzione, prevalentemente montani, della specie che nelle
aree di svernamento di pianura); durante la riproduzione, tuttavia, il loro canto, un trillo forte ed acuto, di solito tradisce la loro presenza. Durante la migrazione a volte si trova anche in parchi e giardini alla ricerca di cibo, dove la specie può dimostrarsi sorprendentemente confidente a seguito di questa esigenza.
Descrizione


Presenta un corpo piccolo e snello, con una lunghezza totale di 14–15 cm. La lunghezza delle ali dei maschi è di 74–79 mm, la lunghezza della coda 50–54 mm mentre il becco misura 15,5–17,0 mm. Peso stimato in 17 g.

Alcuni Autori riportano fino a cinque sottospecie, ma solo tre sono quellericonosciuteufficialmente
Maschio di Larvivora akahige
Femmina di Larvivora akahige
NUMERO 10 - 2022 25 ESTRILDIDI FRINGILLIDI IBRIDI
MASCHIO - parti superiori dalla fronte alla corona e la nuca di colore brunooliva, sfumate di marrone più luminoso o più caldo sulle copritrici della coda superiore e marrone rossiccio abbastanza brillante sulla coda. Le ali hanno lo stesso colore del dorso, ma con copritrici e frange maggiori più luminose sia sulle remiganti primarie che secondarie; l’alula e le copritrici primarie sono simili o hanno punte marrone più L’interoscuro. capo, fino alle copritrici dell’orecchio e alla parte superiore del petto/gola è di colore arancione brillante e intenso, diventando leggermente più pallido sullo stretto anello L’arancionedell’occhio. è separato dalle parti inferiori biancastre da una fascia pettorale nera a contrasto (più ampia al centro); i fianchi e la parte inferiore del petto hanno sfumature grigiastre di intensità variabile. I piumaggi differiscono solo leggermente tra freschi e abrasi; gli uccelli con piumaggio logoro possono mostrare una fascia pettorale leggermente più ampia e basi grigie più estese, specialmente sulla parte inferiore del petto, sul ventre e sui fianchi. Le zampe sono bruno-rosate con il becco nero e la coda rossa e brillante, che può essere aperta a ventaglio e messa in bella mostra.
FEMMINA - presenta un piumaggio simile al maschio adulto, ma la fronte, la corona e le parti superiori sono generalmente di un marrone più opaco, mentre la coda manca anche dei toni più luminosi con un caldo colore rosLesiccio.ali
presentano un colore marrone con strette frange marrone caldo sulle copritrici maggiori. Il colore arancione sulla testa e sul petto è meno esteso, con screziature marroni sulle copritrici e sul petto. La fascia toracica è stretta e meno distinta (talvolta del tutto assente). I lati del petto ed i fianchi presentano una colorazione che può variare dal grigio al grigio oliva; il centro del ventre e le copritrici sotto la coda sono biancastre. Nel piumaggio abraso, il colore arancione della testa può essere ancora più opaco mentre il petto, il ventre e i fianchi possono mostrare basi di piume grigie.
GIOVANE - simile alla femmina adulta ma leggermente più scuro, con macchie color cuoio pallido sulla testa fino al mantello. La testa, il mento, la gola e i lati del collo sono di color arancio, mentre il petto e i fianchi sono leggermente più chiari, con ampie punte grigio-marroni o bruno-oliva che formano barre o squame.
Variazioni geografiche
Le tre sottospecie riconosciute si differenziano principalmente per la colorazione della fascia toracica e delle parti inferiori, nonché per le vocalizzazioni.
Sottospecie

• Larvivora akahige akahige
Presente nel sud di Sakhalin e nelle isole Curili meridionali, nonché in gran parte dell’arcipelago giapponese, comprese le piccole isole a sud di Kyushu (escluse Rishiri, il largo di Hokkaido e le isole Izu, a sud di Honshu).
Questa popolazione sverna nel sud-est della Cina continentale (a nord-ovest del Fujian, a sud di Guangdong e Guangxi), a Hong Kong e a Taiwan, con un numero minore di svernanti in Vietnam e piccoli nuclei che raggiungono la penisola coreana, il Laos e la Thailandia.
• Erithacus akahige rishirensis
Non sempre riconosciuta come sottospecie poiché i suoi presunti caratteri diagnostici sono considerati dipendenti dall’età e dalla stagione da un certo numero di ornitologi giapponesi. Distribuzione: presente sulle isole Rishiri e Rebun, al largo di Hokkaido nord-occidentale, spostandosi a sud in inverno (presumibilmente nelle stesse aree Riepilogodell’akahige).dell’identificazione: Kuroda ha diagnosticato questo taxon da Larvivora a. akahige in virtù di una distinta sfumatura olivacea dalla corona alle parti su-

 Nido con uovo
Nido con uovo
Le tre riconosciutesottospecie si edellaperdifferenzianolacolorazionefasciatoracicadellepartiinferiori
26 NUMERO 10 - 2022
Il nido
Uno studio effettuato in Giappone, ha rilevato che in 27 anni la migrazione autunnale in direzione sud è leggermente ritardata
torrenti in foreste montane composte da sempreverdi a foglia larga, foreste miste di conifere e latifoglie (es. Betula, Phellodendron amurense, Ulmus effusa, Quercus e Alnus), spostandosi nel sottobosco di foreste secolari. Generalmente, questa specie nidifica tra i 1.000 ed i 2.500 m di altitudine (principalmente 1.300–2.100 m) su Honshu e Shikoku, 600–1.600 m su Hokkaido, 1.100–1.900 m su Yakushima.
periori comprese le ali, non di colore rossastro come l’akahige, ma più spento. Misure: lunghezza dell’ala 73,0–73,5 mm, lunghezza della coda 52–53 mm, lunghezza del becco 12,0–13,5 mm, lunghezza del tarso 27,5–29,0 mm.
• Larvivora akahige tanensis
Questa sottospecie è presente nelle regioni di Nishino-omote, Tanegashima, a sud di Kiu Siu.

• Luscinia akahige kobayashii
Distribuzione: residente nelle isole Izu nella zona meridionale del largo di Honshu ed in Giappone. Le popolazioni delle isole a sud di Kyushu sono state erroneamente attribuite a questa specie ma si riferiscono in realtà a Larvivora a. akahige
Si differenzia da Larvivora a. akahige per la mancanza di una fascia toracica nera ed una base pallida (giallastra) alla mandibola, una canzone più balbettante, meno trillata con una durata complessivamente più lunga e un minor numero di note pronunciate a un ritmo più lento ma una gamma di frequenze leggermente più ampia.

Distribuzione
Il suo areale spazia dal sud dello Sakhalin alle isole Curili meridionali attraverso la maggior parte del Giappone, comprese le isole a sud di Kyushu. La maggior parte delle popolazioni migra nel sud-est della Cina, con un numero minore in Indocina.
Al limite settentrionale della distribuzione di questa specie sembra esserci stata un’espansione verso nord, con la popolazione di Sakhalin, a nord di Hokkaido, che si pensa si sia stabilita solo nel secolo scorso.
Habitat
La specie nominale abita il sottobosco umido, denso e ombroso lungo valli e

La sottospecie tanensis occupa habitat simili, principalmente nelle foreste decidue e sempreverdi; a differenza degli altri taxa, tuttavia, questa specie si trova tipicamente in pianura, al di sotto degli 800 m.
Movimenti e migrazioni
Le popolazioni di Larvivora a. akahigee e Larvivora a. rishirensis lasciano le loro aree di riproduzione degli altipiani in Giappone alla fine di agosto scendendo a quote più basse tra settembre e novembre (principalmente in ottobre). Quindi migrano attraverso il Giappone occidentale e la costa orientale dell’Asia continentale per svernare nella Cina meridionale (principalmente nel Fujian, Guangzhou, Guangdong e Guangxi) e Vietnam. Numeri considerevoli sono stati registrati sull’isola di Shawaishan (Jiangsu) in autunno, ma restano scarsi a Hong Kong (da fine novembre a fine marzo). Gli uccelli ritornano ai luoghi di riproduzione tra metà aprile e Unomaggio.studio effettuato in Giappone ha rilevato che in 27 anni la migrazione autunnale in direzione sud si è leggermente ritardata; gli autori ipotizzano che, nell’area di studio, i cambiamenti climatici e l’abbondanza di cibo possano consentire alla specie di rimanere più a lungo, ritardando così la data della partenza autunnale.
Alimentazione
Come suggerisce il suo nome scientifico, che significa “mangiatore di bruchi”, questo Muscicapide si nutre di scarafaggi, insetti, vermi, coleotteri, piccoli grilli, bruchi, frutti e altri piccoli insetti.
Vocalizzazioni
Sviluppo vocale: i novelli emettono ripetutamente uno tsree dissonante
Novello appena involato
Piccoli Larvivora akahige allevati allo stecco
NUMERO 10 - 2022 27
quando chiedono cibo, che si trasforma in una serie veloce, ancora più acuta, tchree-tchree-tchree... quando vengono nutriti.
Il canto è abbastanza vario ma consiste sempre in una o due note introduttive seguite da una serie di note trillate (simile allo squillo di un telefono). Nelle canzoni vengono emesse una serie di note a formare una lunga serie, con pause di alcuni secondi, e le frasi consecutive differiscono sempre leggermente. Emette inoltre una serie di note brevi, piuttosto dure, staccate una dall’altra. Note simili possono anche essere date singolarmente o in Uncoppia.breve
singolo richiamo alto e acuto si ripete a intervalli. La frequenza sale da circa 7,5 kHz a 8,5 kHz e la durata della nota è di circa 0,1 secondi.
Il canto della sottospecie tanensis può essere distinto da quello della specie nominale con certezza, sulla base delle sue note introduttive più lunghe con una durata complessivamente maggiore in questa parte e una serie di trilli di durata inferiore, con meno note pronunciate a un ritmo leggermente più lento e con una gamma di frequenze un po’ più ampia. All’orecchio umano, per la differenza di ritmo, il canto del tanensis suona più balbettante mentre quello dell’akahige è più trillato.
Canta principalmente da aprile a giugno, in corrispondenza del periodo riproduttivo, ma può essere ascoltato anche occasionalmente fino all’inizio di Loagosto.siascolta all’alba, al mattino presto e di nuovo nel tardo pomeriggio; emette la sua melodia rimanendo appollaiato su piccoli rami in una fitta vegetazione a quote basse (0–2 m dal suolo). Mentre canta, la testa punta verso l’alto, con il becco spalancato, la coda è allargata e il corpo trema al ritmo del tintinnio.
La canzone è pronunciata in modo dominante dal maschio, ma anche le femmine cantano debolmente durante la nidificazione e l’incubazione, in risposta al maschio.
Il canto viene pronunciato dal maschio all’inizio del periodo riproduttivo per attirare la femmina ed in seguito per difendere il proprio territorio. Il canto maschile è molto ridotto una volta deposte le uova.
Nido, uova e nidiacei
La riproduzione avviene principalmente tra maggio e la metà di luglio in tutto il suo areale; da osservazioni sul campo si è notato che alcune coppie hanno effettuato una seconda covata, prolungando così la stagione riproduttiva fino alla fine di agosto.
Il nido viene collocato, solitamente, in
una cavità tra le rocce, su una sassaia, nel foro di un albero o di un ceppo.
Il nido risulta essere costruito principalmente con muschio, piccoli ramoscelli, foglie essiccate, felci e altre fibre Vengonovegetali. deposte solitamente da 3 a 5 uova di colore blu-verdastro, che vengono incubate soltanto dalla femmina per circa 12–15 giorni.



I nidiacei vengono nutriti da entrambi i genitori, con una percentuale leggermente superiore per quanto riguarda la femmina, circa il 60%.
Stato di conservazione
L. a. akahige non è considerato a rischio di estinzione. Nonostante la sua precedente popolarità come uccello da gabbia, la popolazione globale sembra essere relativamente stabile. Tuttavia, sta subendo declini locali, in particolare nel sud del suo areale. Tra i 17 siti di rilevamento nel Kyushu è scomparso da sette durante gli anni 2000 (ed è diminuito in altri), in coincidenza con i danni causati dal cervo Sika (Cervus nippon), ritenuto dagli ecologisti quale responsabile di danni nelle piantagioni di coAllonifere.stesso modo, il numero nella penisola di Kii è diminuito del 93,3% tra il 1977 e il 2010, sempre in risposta al danno dei cervi e alla perdita/degrado dell’habitat. Queste minacce potreb-
 Uova donate dall'allevatore al Museo civico di Lentate sul Seveso
Uova donate dall'allevatore al Museo civico di Lentate sul Seveso
28 NUMERO 10 - 2022
bero ora diffondersi in tutto il Giappone, sebbene non ci siano prove di cali evidenti; inoltre, nel nord del paese la specie ha effettuato un’espansione del suo areale.
La sottospecie tanensis è attualmente considerata vulnerabile. Questo taxon distintivo è limitato all’area endemica degli uccelli, in quanto nelle isole Izu è protetta, trovandosi queste ultime all’interno di un parco nazionale. La specie è inoltre presente in diversi importanti siti designati come aree protette speciali.
Tuttavia, la perdita e la modifica dell’habitat in maniera rilevante in molte isole, unita ad un areale molto limitato, lo rende a rischio di estinzione. Inoltre, l’introduzione della donnola siberiana (Mustelasibirica) a Miyake-jima negli anni ‘70, la presenza diffusa di gatti domestici e una popolazione in continuo aumento della cornacchia dal becco grosso (Corvus macrorhynchos) a causa dello scarso smaltimento dei rifiuti umani hanno aggravato le minacce di questa specie.
Come se tutto questo non bastasse, l’aumento di piantagioni di Cryptomeria (coltivata per il legname) sta rapidamente sostituendo le foreste autoctone nel suo areale, con gravi conseguenze per il suo futuro.
Allevamento in ambiente domestico
Il suo canto e la livrea sgargiante hanno fatto di questo interessante insettivoro un ambito uccello da gabbia e da voÈliera.stato importato occasionalmente tra gli anni ‘90 e 2000 da alcuni brani allevatori, soprattutto del nord Europa, che sono riusciti a creare ceppi domestici di questa specie.
In Italia attualmente viene allevato con successo da un bravo allevatore, il lariano Felice Rigamonti, che i lettori già conoscono grazie ai miei articoli sulle Niltave e sul codirosso dal cappuccio bianco Phoenicurus leucocephalus.
Ma ora lasciamo che sia proprio Felice a guidarci in questa nuova esperienza “Amod’allevamento:definirequesta specie Il folletto, come indicato da Piercarlo nel titolo dell’articolo.
Ho reperito la prima coppia dall’amico Pietro Arena cinque anni or sono e da allora ne ho sempre tenuta almeno una coppia nelle mie ampie voliere. Quest’anno, vista l’abbondanza dei soggetti prodotti ultimamente, ho deciso di allestire due coppie, che ad oggi sono entrambe intente nella costruzione del nido; li trovo molto belli e discretamente rustici, non hanno particolari esigenze alimentari e climatiche.
L’unica nota dolente è quella della penuria di soggetti disponibili per poter immettere sangue nuovo nel ceppo, anzi, se qualcuno fosse in possesso di qualche soggetto non esiti a contattarmi alla mail posta in calce all’artiUsocolo.una dieta unica nelle quattro stagioni composta da un mangime per insettivori più buffalo e pinkie, mentre nel periodo riproduttivo aumento la somministrazione degli insetti più disparati, oltre alle tarme della farina.

Le coppie sono poste in voliere plantumate di 5x2x2 metri, dove ho notato che passano buona parte della giornata al suolo alla ricerca continua di qualche Nelinsettuccio.periodo riproduttivo il maschio ama emettere il proprio canto e fare la parata nuziale dai posatoi.
Con il passare degli anni ho notato che il nido da loro preferito è quello a cassetta semiaperta che io sono solito po-
sare (più di uno) ad un metro circa da Laterra.stagione riproduttiva ha inizio a primavera inoltrata. La covata è composta da 4/5 uova di colore blu/verdastro e vengono di solito portate a termine 2 covate annue.
I piccoli abbandonano il nido dopo 12/13 giorni e sono incapaci di volare ma in breve tempo raggiungono l’indiHopendenza.notato che si distinguono i sessi già in giovane età, in quanto il maschio presenta le piume della testa più rossastre e, soprattutto, le penne delle timoniere di un colore rosso più acceso.
Come già accennato in precedenza, è una specie poco esigente e quindi adatta anche a chi si affaccia per la prima volta all’affascinante mondo degli Sicuramenteinsettivori.penso che le sfide continue siano il vero sale di questo hobby; quest’anno ho aggiunto al mio allevamento due coppie di Luscinia pectoralis, una specie molto bella cromaticamente, che spero di riuscire a riproPerdurre.concludere, questa è la mia mail: felicerigamonti.57@gmail.comSequalcheallevatoreavessesoggettidacederediquestaspecieoanchesoloperunasemplicechiacchieratamipuòcontattaretranquillamente”.
 I NOSTRI LUTTI
I NOSTRI LUTTI
In ricordo di Enrico Conforti
I Il 13 agosto 2022, è venuto a mancare il geometra Enrico Conforti (ex Giudice Internazionale di Ondulati & altri psittaciformi).
Niente e nessuno potrà riportarti indietro, senza di te ci sentiremo soli, ci mancheranno per sempre il tuo sorriso e la tua generosità.
La tua assenza è dura da sopportare ma sei volato in cielo e l’unica cosa che possiamo fare è continuare a vivere portando nel cuore il tuo ricordo.
Gli Amici di Ferrara
Dipinto di Larvivora akahige
NUMERO 10 - 2022 29
Il martin pescatore e il mito di Alcione
di AURORA CIVILLA, foto R. BALESTRIERI (ASS. ARDEA)


Ilmartin pescatore, della famiglia degli alcedinidi, è un uccello molto colorato e facile da riconoscere, per via dell’unicità della sua livrea. Lo spiccato contrasto tra l’arancio acceso del petto e l’azzurro marino del dorso, infatti, lo rende inconfondibile tra le specie acquatiche. Sin dai tempi antichi, la sua bellezza e le sue abitudini comportamentali hanno ispirato miti, leggende e letterature che lo hanno reso una
Il martin pescatore non è di certo l’unica specie ad aver ispirato la fantasia umana, spingendola a dare vita a mitografichetradizionimillenarie
creatura dall’affascinante simbologia. Nel II secolo a. C., il lessicografo Apollodoro di Atene raccontò che Alcione, figlia del dio del vento, si innamorò di Ceice, figlio della stella del mattino. Secondo il mito, il loro amore fu talmente travolgente da spingere i due giovani a paragonarlo al legame che univa Zeus, re dell’Olimpo, alla moglie Era. Tuttavia, il padre degli dèi decise di punire l’arroganza dei due innamorati, trasformando lui in un gabbiano e lei in un martin pescatore. Poi, non soddisfatto della punizione, Zeus stabilì che entrambe le specie avrebbero nidificato, ogni anno, in luoghi ostili e pericolosi, esposti alle intemperie del mare e dei fiumi. Per questa ragione, secondo diverse versioni del racconto, Eolo avrebbe donato ogni anno all’alcedinide un periodo di tregua dal vento, in corrispondenza del solstizio d’inverno. Ancora oggi, in Grecia, gli ultimi giorni di gennaio vengono chiamati “i giorni dell’Alcione”. Il martin pescatore non è di certo l’unica specie ad aver ispirato la fantasia umana, spingendola a dare vita a tradizioni mitografiche millenarie. Anticamente, infatti, i Greci hanno spesso dimostrato di saper cogliere un rapporto simbolico tra uomo e animali, attraverso l’attenta osservazione dei comportamenti di questi ultimi.

L’alcione, infatti, era considerato un animale solitario, che, oltre ad avere un’incredibile abilità a catturare i pesci con tuffi di estrema precisione, dedicava molto tempo alla cura e alla pulizia delle sue penne. Pertanto, si può dire rappresentasse il simbolo della pace e della tranquillità da emulare, al
 Martin pescatore, foto: R. Balestrieri
Martin pescatore, foto: R. Balestrieri
30 NUMERO 10 - 2022 UCCELLIIN NATURA
fine di condurre una vita equilibrata. Nonostante le considerazioni degli antichi circa l’etologia risultino del tutto prive di fondamento scientifico, nel caso del martin pescatore si possono rilevare alcune similitudini tra la fantasia dei mitografi e la scienza contemporanea. Alcedo atthis, infatti, unico alcedinide europeo, a dispetto delle dimensioni minute è un uccello molto forte e longevo; un individuo, superata la critica fase giovanile, ha buone probabilità di superare i dieci anni di vita. Non vive in gruppi, ma conduce un’esistenza solitaria nei pressi di acque dolci anche se, fuori dal periodo della riproduzione, è possibile osservarlo in prossimità del mare. È, inoltre, un formidabile pescatore, come si evince dal nome; grazie a una particolare conformazione dell’occhio, infatti, è in grado di vedere perfettamente oltre la superficie dell’acqua, per poi tuffarsi, mancando raramente la preda. Infine, il martin pescatore nidifica lungo argini sabbiosi e terrosi, scavando dei tunnel molto profondi di oltre un metro. Pertanto, l’inquinamento, la cementificazione e la canalizzazione dei corsi d’acqua contribuiscono a minacciare la specie, più dallo sconsiderato e logorante intervento umano che dal volere degli https://www.associazioneardea.it/dèi.





 Martin pescatore, foto: R. Balestrieri
Martin pescatore, foto: R. Balestrieri
Martin pescatore, foto: R. Balestrieri
Martin pescatore, foto: R. Balestrieri
NUMERO 10 - 2022 31
DORSOLUCHERINONERO“COLUMBIA” (Carduelispsaltria)Daunalunga e competente selezione soggetti di grande qualità e dalle eccezionali doti riproduttive BRUGHERIO (MB) Tel. TERUZZI347.0784494
S pazio Club


Fine
gennaio 2019: è da qui che inizia la rinascita del Club degli Psittacidi. Dopo le elezioni del Direttivo, ci siamo subito attivati per comprendere come gestire al meglio l’eredità che ci era stata lasciata. Il Club, infatti, esisteva già e noi volevamo che le attività proseguissero nel modo migliore e, anzi, coinvolgessero un numero ancora superiore di persone. Quando avevamo appena cominciato a definire progetti e attività, è arrivato il COVID-19 a bloccarci.
Gli anni della pandemia sono stati anni difficili, anni in cui sono mancate le mostre e con esse molte occasioni di confronto tra allevatori. Dal momento che ci mancava molto questo aspetto di condivisione, abbiamo cercato un modo per poterci confrontare e per rimanere in contatto nonostante non potessimo incontrarci fisicamente. Ed è così che siamo approdati sui Social Network dando vita a una pagina Facebook, “Club degli Psittacidi”, che oggi conta 17.604 follower, e a un gruppo dedicato al cerco/offro tra i soci, “Mercatino del Club degli Psittacidi”, che ha 1.669 membri. Volevamo essere vicini agli allevatori, far percepire loro che nonostante tutto il Club continuava a essere un punto di riferimento per tutti gli hobbisti e non solo. Così, in particolare nei periodi di lockdown, siamo stati presenti con pubblicazioni quasi quotidiane sui Social Network. Costanza e partecipazione sono sempre stati due aspetti fondamentali per noi e abbiamo fatto in modo che non venissero mai meno. Nel 2021 ci sarebbe dovuta essere la nostra prima mostra, ma il COVID-19 e alcune problematiche burocratiche hanno fatto sì che anche per quell’anno dovessimo Senzarinunciarvi.mostrenoi allevatori ci sentiamo orfani dei nostri amici, della possibilità di confrontarci sul nostro hobby e ci sembra che
manchi un pezzo importante della nostra Inquotidianità.questianni complessi per il nostro mondo, però, noi non ci siamo mai fermati e abbiamo sempre cercato un modo per sentirci comunque vicini e per condividere gli aspetti positivi e negativi della passione che ci unisce. Con questo preciso intento è nata la rivista del Club degli Psittacidi, ora al suo secondo numero. In questa rivista trovano spazio i contributi di veterinari, etologi, zoologi, ma anche di appassionati e allevatori che raccontano la loro esperienza nell’allevamento degli Psittacidi. Ci siamo messi in gioco e abbiamo provato ad alzare l’asticella, dando vita a qualcosa di unico. Quest’anno ci saranno tre uscite, la prossima sarà a ottobre, ma già dal prossimo anno pensiamo di arrivare a quattro numeri. Ci siamo, inoltre, prodigati nella produzione di gadget, poster e agende per far conoscere, anche a chi non aveva ancora sentito parlare di noi, la nostra realtà. Insomma, siamo un Club in costante crescita e con tanti progetti ambiziosi per il futuro, oltre che con un importante evento alle porte: la mostra “My Parrot 2022”, una mostra specialistica internazionale per Psittacidi, che si terrà dal 3 al 6 novembre a Farigliano (CN). Si tratta di un evento molto importante per gli allevatori, che è stato organizzato nei minimi dettagli, in collaborazione con il Club del Neophema, in una cornice Cid’eccezione.teniamoparticolarmente a invitarvi in quanto è la prima occasione dopo tanti anni per rivederci e confrontarci dal vivo. Non potete perderla. Vi aspettiamo dunque a novembre a Farigliano!
 Il Direttivo del Club degli Psittacidi
Il Direttivo del Club degli Psittacidi
Il Club degli Psittacidi: l’impegno e i progetti di un Club che guarda al futuro
SpecializzazionediClub
32 NUMERO 10 - 2022


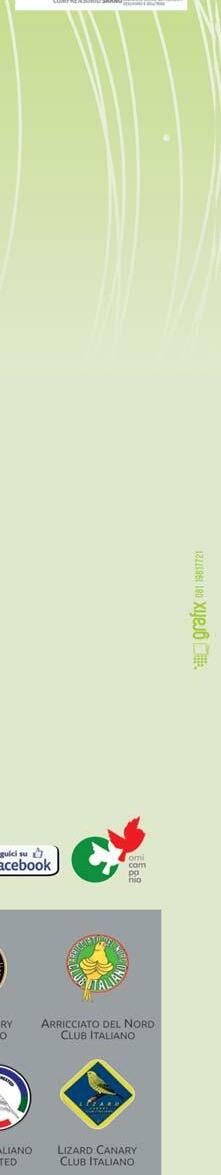






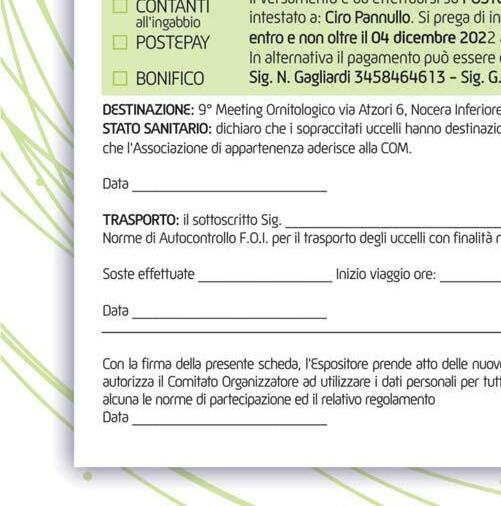


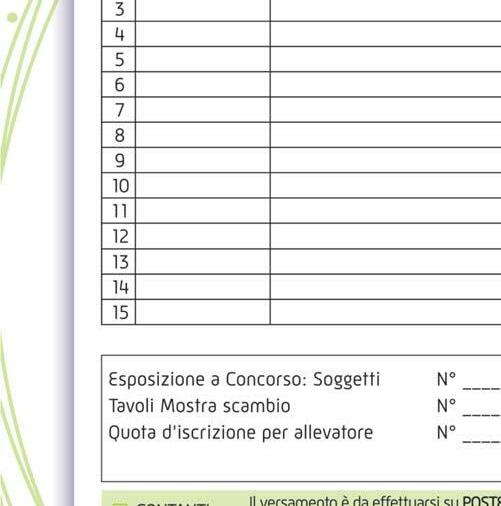
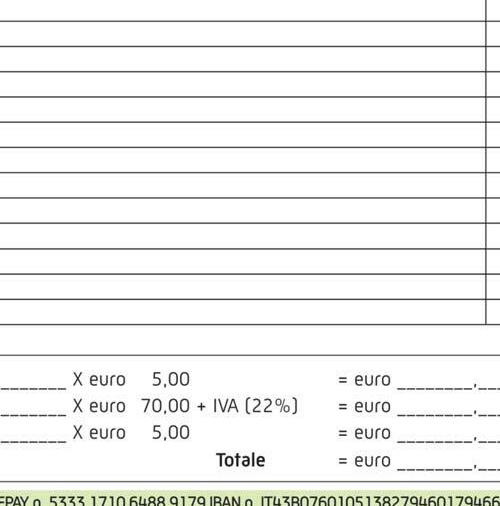




Il ornitologicocollezionismo
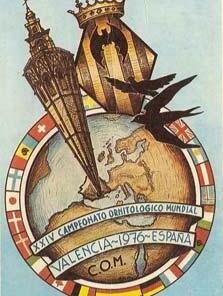
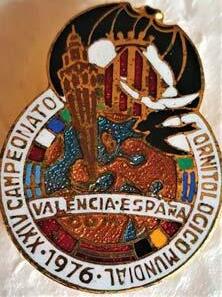

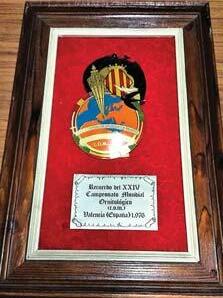
Parte conclusiva
testo e foto di FRANCESCO BADALAMENTI
Diciottesima parte
Volge

al termine questa serie di articoli sul collezionismo ornitologico - ahimè - questa è l’ultima e conclusiva parte.

A memoria ricordo che diverse volte sulla nostra Italia Ornitologica è capitato che un articolo sia stato pubblicato distribuendo il testo su differenti numeri, ma mai prima d’ora si era verificato che

si giungesse a suddividere un testo in ben diciotto parti. Posso pertanto ritenermi soddisfatto, il merito va ovviamente attribuito alle molteplici sfaccettature che un variegato hobby come il collezionismo ha consentito di sviluppare e in minima parte anche alla mia Ilcaparbietà.collezionismo, una passione coinvol-
gente che consiste nella raccolta di oggetti di uno specifico settore, ambito o categoria, nel nostro caso l’ornitofilia, un passatempo avente carattere internazionale, davvero alla portata di tutti e che non conosce limiti sul che cosa possa diventare il centro dell’interesse del singolo collezionista, dai temi per loro natura più preziosi a quelli più stravaganti e curiosi. Torno a ripetere che il valore economico non qualifica una raccolta, poiché qualsiasi oggetto presenta caratteristiche importanti, per i suoi aspetti storici, artistici, estetici, antropologici, sono questi gli elementi che contribuiscono a determinare la singolarità, l’eccezionalità e il vero valore di una Trascorsicollezione.piùdi due anni dalla pubblicazione del primo articolo (la parte prima è stata pubblicata sul n. 8/9 2020 di Italia Ornitologica), posso fare una sintetica analisi in quest’ultima e conclusiva Hoparte.incrementato e sviluppato nuovi rapporti con altri collezionisti, creando legami anche nei confronti di persone fino a ieri sconosciute, che mi hanno confessato di avere conservato oggetti particolari e rari, veri e propri cimeli ornitologici. Ho avuto la fortuna di esaminare alcuni pezzi da collezione osservandoli sotto nuovi e mutati aspetti. Ho potuto ripercorrere parte della storia ornitologica della Federazione e del movimento degli ornitofili italiani. Ho potuto approfondire vicende e storie legate a singoli oggetti. Ho avuto frequenti contatti te-
Quadretto, placca, distintivo, medaglia e locandina del XXIV Campionato Mondiale di Ornitologia C.O.M. di Valencia 1976
NUMERO 10 - 2022 35 DIDATTICA & CULTURA
lefonici, scambi di e-mail, e dialoghi con altri Ornicoltori che mi hanno raccontato aneddoti e vicende personali legate alla F.O.I. e al collezionismo ornitologico. Ho avuto l’opportunità di affrontare, anche, alcuni temi delicati come quello riguardante gli alloggi per volatili domestici e

gli irragionevoli attacchi da parte di organizzazioni pseudo animaliste/ambientaliste. Ho esposto argomenti che avrebbero meritato una trattazione scientifica, come quelli riguardanti le collezioni naturalistiche e i musei di ornitologia. Ho spaziato, qua e là per il mondo, con le emissioni filateliche e con le cartoline postali. Ho trattato anche il tema delle pubblicazioni editoriali di settore. Con un po’ di sano campanilismo, ho pubblicato foto di oggetti della mia Associazione Ornitologica e del Raggruppamento Ornicoltori Siciliani in generale (ma del resto sono quelli che più facilmente sono entrati a far parte della mia personale collezione). Sono persino andato a trovare a casa il mio caro amico Salvo Affronti, per fotografare le statuine da lui realizzate, quando eravamo entrambi nella C.T.N. CFPL e nello stesso periodo sua figlia aveva un laboratorio di ceramica artigianale. Nella ricerca di immagini e di oggetti da fotografare a corredo dei vari articoli, ho avuto l’opportunità di visionare, presso gli uffici della Federazione, moltissimo del materiale raccolto dal Presidente Salvatore Cirmi, uno tra i più grandi collezionisti del comparto ornitologico internazionale, a cui va il merito di aver conservato e arricchito la sede F.O.I. con pezzi altrimenti introvabili e unici.


Dalle informazioni in mio possesso, distintivi e piccoli gadget sono gli oggetti che hanno catturato l’interesse di un maggior numero di collezionisti. Soprattutto i distintivi, poiché facilmente mostrabili su giacche e giubbotti, costituiscono oggetti di rapido e immediato


 1985 Libretto - programma della Mostra Ornitologica AR.O.
– 1° Gran Trofeo in Oro Città di Roma
Ditali per cucire
Treviso 1961 Locandina del IX Campionato Mondiale di Ornitologia
Ceramiche: Ondulato Inglese (collezione F.O.I.)
1985 Libretto - programma della Mostra Ornitologica AR.O.
– 1° Gran Trofeo in Oro Città di Roma
Ditali per cucire
Treviso 1961 Locandina del IX Campionato Mondiale di Ornitologia
Ceramiche: Ondulato Inglese (collezione F.O.I.)
36 NUMERO 10 - 2022
scambio, in ogni occasione di incontro, e in special modo durante i giorni dedicati al giudizio dei soggetti e durante l’apertura al pubblico delle esposizioni L’amicoornitologiche.giornalista Gennaro Iannuccilli, che da Consigliere Federale cura con impegno e passione ogni numero di Italia Ornitologica, cogliendo le finalità di questi articoli sul collezionismo, ha sempre inserito questi testi nella rubrica della rivista denominata “Cultura e DiIndattica”.conclusione posso affermare che questa collaborazione con la nostra rivista mi ha arricchito personalmente, sotto diversi Giunto,profili.infine, alla battuta conclusiva allego una tabella con il riepilogo degli articoli sul Collezionismo Ornitologico e una piccola carrellata fotografica di oggetti vari da collezione del settore ornitologico riguardanti differenti ambiti del collezionismo.



Riepilogo degli articoli sul Collezionismo Ornitologico pubblicati su Italia Ornitologica:
n. 8/9 2020 -parte I (Introduzione, le raccolte in generale); n. 10 2020 -parte II (i Distintivi); n. 11 2020 -parte III (il Collezionismo Cartaceo); n. 12 2020 -parte IV (il Collezionismo Filatelico);
n. 2 2021 -parte V (le Cartoline postali); n. 5 2021 -parte VI (i Gagliardetti); n. 6/7 2021 -parte VII (i Libri di Ornitofilia); n. 8/9 2021 -parte VIII (le Medaglie); n. 11 2021 -parte IX (le Statuine); n. 12 2021 -parte X (Riviste di Ornitologia, Ornitofilia, di Ornitocultura);

n. 1 2022 -parte XI (Alloggi per volatili domestici); n. 2 2022 -parte XII (Stampe e illustrazioni); n. 3 2022 -parte XIII (Oggettistica, gadget e collezionismo minore); n. 4 2022 -parte XIV (le Ceramiche); n. 5 2022 -parte XV (Articoli per fumatori); n. 6/7 2022 -parte XVI (le Collezioni Naturalistiche); n. 8/9 2022 -parte XVII (la Collezione che la Sicilia non volle); n. 10 2022 -parte XVIII (Parte conclusiva).

 Ceramiche: Cacatua cresta gialla (collezione F.O.I.)
Ceramiche: Cacatua cresta gialla (collezione F.O.I.)
NUMERO 10 - 2022 37









Principe Chigi della Rovere Francesco (Roma 1881 - 1953)



Ultimo di 5 fratelli, il padre Mario, di nobili origini e proveniente dal Principato di Siena, per tradizione ereditaria fu Maresciallo del Conclave ed ebbe ruoli importanti nella vita romana, con prestigiosi incarichi nella direzione di istituti di credito e imprese di costruzione, tant’è che fu uno dei principali fautori dei quartieri romani di Testaccio e di Trastevere, dai quali ottenne importanti utili economici. Il Francesco, sin da giovane, fu palesemente attratto dalle scienze ed in particolare dall’ornito-

mostrò anche un grande interesse per l’automobilismo; possedette diverse macchine anche sportive e pare fosse stato anche un abile pilota nonostante i diversi incidenti, tra cui uno in cui morì nel 1923 la moglie. Si dedicò in quegli anni anche alla fotografia, costituendo un importante archivio di immagini oggi ritenute preziose in quanto documentali sulla vita romana nella prima metà del ‘900.
Dal 1939 al 1953 ottenne anche il titolo di Comandante delle Guardie Nobili Pontificie, ma l’ambito in cui
di ROBERTO BASSOE MANUEL PAVANELLO, fotoARCHIVIO CIVICO MUSEODI STORIA NATURALEDI JESOLO
Ritratto di Francesco Chigi della Rovere
Il sontuoso palazzo, residenza romana dei Chigi, in Via del Corso, eretto nel 1578, edificio che dal 1961 è sede del Governo
NUMERO 10 - 2022 39 logia. Interruppe però gli studi quando frequentava la 2^ liceo, ma la svolta in lui avvenne quando il padre, per cercare di tenerlo impegnato, gli affidò la gestione di un podere nel Comune di Ariccia: il mondo rurale lo coinvolse a tal punto che continuò come autodidatta a leggere testi, entrare in contatto con i grandi ornitologi e naturalisti dell’epoca ed annotare appunti e proprie osservazioni. Nel 1919 si unì in nozze con Maria Concetta Torlonia e nel 1921 gli nacque la prima figlia, Olimpia. Ma lui DIDATTICA & CULTURA I Padri dell’Ornitologia italiana
Ricercatori intenti a catalogare e classificare le pelli di studio della collezione Chigi





riusciva veramente a fare la differenza è stata l’ornitologia, tant’è che Gabriele d’Annunzio gli diede l’appellativo di “Principe degli UcFondòcelli”.

la rivista “Rassegna Faunistica” e fu tra i fondatori nel 1911 della Rivista Italiana di Ornitologia. Divenne amico e collaboratore del Prof. Edgardo Moltoni e del Prof. Alessandro Ghigi, già Rettore dell’Università di Bologna. Nella riserva di caccia e parco fauni-

Serie sistematica di pelli di merli dal collare
stico di famiglia di Castel Fusano istituì un osservatorio ornitologico, rivolto soprattutto allo studio degli uccelli migratori e stanziali della regione Lazio. Fu uno dei curatori nel 1931 dell’opera editoriale “Gli uc-
celli amici dell’agricoltura”. Suo assistente e intimo amico di sempre fu Mario Rotondi, a sua volta autore dell’ancora oggi attuale e monumentale opera “I migratori alati”. Non si può tralasciare che dal
 Stemma di famiglia dei principi Chigi della Rovere
Serie sistematica di pelli di merli
Stemma di famiglia dei principi Chigi della Rovere
Serie sistematica di pelli di merli
40 NUMERO 10 - 2022
1900, quindi dall’età di soli 19 anni, iniziò a raccogliere e catalogare per oltre 50 anni l’avifauna romana. Collezione tassidermica che custodiva oltre 1000 preparazioni in pelle di studio e centinaia di preparazioni montate, riferite anche a diverse specie rare e accidentali, tant’è che dopo la sua morte i suoi 7 figli la donarono al Museo Civico di Zoologia di Roma, struttura che ancora oggi vede una sala dedicata a suo nome. Nel 2021 è stato avviato un importante intervento di riclassificazione e catalogazione di questo immane patrimonio scientifico. Francesco Chigi fu anche tra i fondatori del Giardino Zoologico di Roma, oggi “Bioparco”, ma ne divenne anche Presidente della società e lottò affinché l’istituzione mantenesse prioritarie finalità scientifiche, anche attraverso l’affidamento della direzione a competenti zoologi.







Dati morfologici di una pelle di sirratte

NUMERO 10 - 2022 41






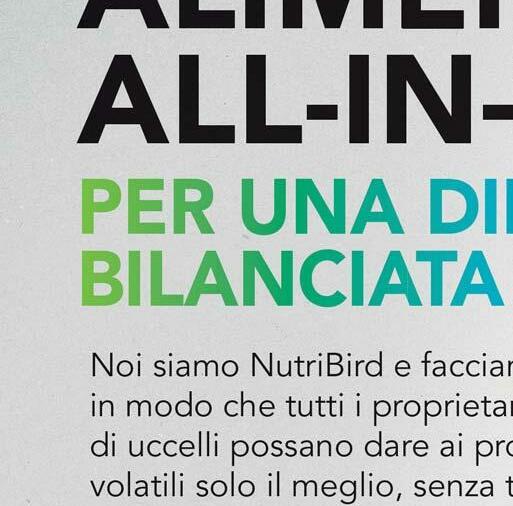
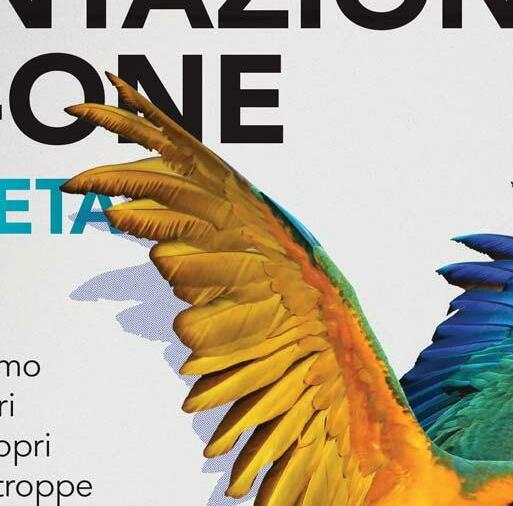









•Invitiamo tutti gli allevatori a inviare foto di all’indirizzo:mutazione,dellaconpropriprovenientisoggettidaiallevamenti,descrizionespecie,razzae redazione@foi.it •All’autore della foto baseeditoomaggioverràcomitatopresceltamensilmentedauninterno,offertoinunlibrodallaFOIinallapreferenzaealladisponibilità. Questo mese, il protagonista di Photo Show è: PAOLO MONTANINI R.N.A 268S con la fotografia che ritrae il soggetto: “Cacatua delle molucche” (Cacatua moluccensis) Complimenti dalla Redazione! (*)Tutte le foto inviate, anche quelle non Federazionepromozionaliiniziativetemporale,senzapotrannodellarimarrannopubblicate,adisposizioneFOIatitologratuitoeessereutilizzate,alcunlimiteovincoloperpubblicazioni,escopidella









Ornimostre, oltre un gioco a somma zero
testo e foto di PASQUALE LEONE
Loscorso luglio, in Calabria, si è tenuto un convegno rivolto ai responsabili della gestione informatica delle associazioni appartenenti ai raggruppamenti Puglia/Basilicata, Calabria e Sicilia nel quale è stato presentato Ornimostre, il nuovo software della FOI per la gestione delle mostre Dopoornitologiche.ilsaluto del presidente del raggruppamento della Calabria, Giuseppe Zarola e del consigliere federale Francesco Badalamenti, i lavori sono stati aperti dal presidente dell’ordine dei giudici Andrea Benagiano che ha delucidato i presenti sulle responsabilità degli organizzatori inerenti l’inserimento delle categorie a concorso, lasciando poi la parola al consigliere federale Davide Soncini, che ha magistralmente illustrato e spiegato il programma nei Eradettagli.altresì




presente Marco Potitò, referente di Ornimostre per tutto il sud Italia, onere di non poco conto per un programma del tutto simile al precedente GEM, ma dal quale sostanzialmente differisce per il fatto che operi in cloud, la nuova tecnologia che permette l’accesso ad una serie di servizi, quali software, database, server ed altro tramite internet, dando anche la possibilità di elaborare ed archiviare i dati in rete, usando finanche tecniche di virLatualizzazione.nuovastagione mostre parte dunque con ventata di aria nuova ed anche per le esposizioni sotto l’egida della COM sono stati inseriti dei cambiamenti. Da quest’anno, per tutte le manifestazioni internazionali, sarà obbligatorio da Partecipanti al corso
 G. Zarola, F. Badalamenti, A. Benagiano, D. Soncini, M. Potitò
G. Zarola, F. Badalamenti, A. Benagiano, D. Soncini, M. Potitò
NUMERO 10 - 2022 45 CRONACA
parte dell’allevatore indicare il numero di anello del soggetto esposto e da parte degli organizzatori inserire il numero del soggetto nel catalogo della manifestazione, regola che fino alle passate stagioni veniva applicata solo al campionato mondiale di ornitologia.

Sarà altresì obbligo degli organizzatori di indicare sul catalogo i nominativi dei giudici che hanno espresso il giudizio, il loro Paese di provenienza, in relazione a ciascuna categoria a concorso. Tutto questo anche in virtù del fatto che, come anticipato dalla COM-Italia, si ha l’intenzione di realizzare un database riepilogativo di tutte le manifestazioni ornitologiche internazionali organizzate nel nostro Paese al fine di ottenere delle utili informazioni statistiche.
Con l’introduzione di queste novità, cosa cambia per gli espositori?
Sembrerebbe poco o nulla, ma facendo una disamina più approfondita orientata alla volta del futuro, credo che stiamo andando, o magari ci troviamo già, verso un approccio differente proprio nel modo di interpretare le nostre esposizioni. Una moderna concezione dove il rapporto cultura - conoscenza è correlato alla tecnologia ed all’oggettività dei dati posseduti.
Chi alleva “da qualche anno” come me, ricorderà quando le mostre erano gestite con carta e penna e le classifiche venivano stilate a mano. Con l’avvento del sistema operativo Windows 95, il computer che inizialmente era una prerogativa dei professionisti, divenne alla portata di tutti; fu così anche per il nostro hobby dove Giampaolo Parise ela-


borò il software GEM. Fu un cambio epocale poiché per gestire le mostre si passò dalla biro ai floppy disk di GEM. Oggi siamo passati dalla versione tablet di GEM ad Ornimostre in cloud, potenzialmente una transizione analoga che porta il nostro hobby ad inserirsi nel più alto grado della tecnologia attuale. Gli effetti non credo si vedranno a breve termine poiché, con ogni probabilità, l’utilizzo dei database per qualche altra stagione sarà conforme a quelli utilizzati negli anni scorsi, ma pensate alla potenzialità che si creerebbero nell’avere l’interazione tra tutti i database federali in tempo reale, a quante informazioni l’espositore potrebbe avere accesso, a come la visione di una singola mostra diverrebbe ampia ed articolata. Questo non significa che il sistema ed i criteri usati finora siano obsoleti. Forse col passare degli anni e con l’evolversi delle tecniche di allevamento, considerare esclusivamente il numero di titoli conquistati dall’allevatore per valutare le sue capacità selettive, potrebbe essere riduttivo.
Le mostre ornitologiche sembravano un gioco a somma zero, cioè un momento in cui c’era soltanto chi vinceva e chi perdeva. Proprio come nella teoria
dei giochi a somma zero le vincite dei partecipanti bilanciavano in forma uguale ed opposta le perdite; proprio come un gioco a somma zero non c’erano forme di cooperazione; proprio come un gioco a somma zero, non era possibile avere un ritorno senza intaccare un altro partecipante. Si aveva l’impressione che ogni mostra, passata l’euforia o la delusione del momento, restasse fine a sé stessa. Ribadisco, non che il meccanismo precedente fosse errato. Il fatto che tralasciasse fattori come l’esemplare stesso o chi lo avesse valutato, forse stava facendo scemare l’interesse. Col trascorrere degli anni, i metodi di allevamento sono cambiati, si sono evoluti, la selezione è migliorata; parametri aggiuntivi di valutazione non potranno far altro che portare ulteriori stimoli ad un hobby che si va sempre più specializzando. Pensate ad esempio, se mentre leggiamo il catalogo di una mostra nel contempo avessimo la possibilità di confrontare le schede di giudizio, le varie singole voci, di avere statistiche, di correlare i dati della mostra a quelli degli anni passati, quale contributo l’utilizzo di queste informazioni potrebbe fornire per una migliore gestione degli aviari. Probabilmente, per quest’ultimo punto, ci vorranno degli anni ed una scelta politica federale orientata in tal senso, ma la tendenza è questa; è solo una questione di tempo e forse, da questa stagione mostre, è stata messa la pietra miliare affinché il detto “se non si vince, si fa esperienza” abbia un senso compiuto.
D. Soncini, referente federale di Ornimostre
M. Potitò (referente Ornimostre per il sud Italia) e, D. Soncini
Oggi siamo passati dalla versione tablet di GEM ad Ornimostre in cloud
46 NUMERO 10 - 2022
Piumaggio e muta
di SERGIO PALMA, foto WIKIPEDIA e ANIMALIVOLANTI.IT
Funzione delle piume Piume e muscoli sono gli strumenti che permettono ad un uccello di volare; in questo scritto voglio focalizzare l’attenzione su quello che viene definito “apparato tegumentario”. Alcuni allevatori ritengono che le piume del corpo siano lì solo per dare un contorno o un tipo di colore all’uccello, ma questo è solo nella mente dell’allevatore che non osserva e non cerca di capire.
Il piumaggio negli uccelli ha molteplici funzioni, che possiamo elencare in 4 punti:
1) Organo deputato al volo
2) Termoregolatore: funziona sia da conservatore del calore che da dissipatore dello stesso (la temperatura interna degli uccelli è di circa 40°)
3) eComunicazione,corteggiamentocompetizione

4) Difesa (mimetizzazione).
È un dato di fatto che le penne e le piume siano il miglior mezzo di isolamento esistente in natura. Le penne sono state spesso usate dagli uomini come ornamento (nativi americani), come comfort (cuscini) e per la loro funzione termica (imbottitura di giubboni ed altri indumenti). Molti uccelli, ed anche alcune femmine di canarini, usano le piume del proprio corpo o del partner, ma anche dei nidiacei della covata precedente, per rivestire i nidi. Se si osserva la penna, vedremo che è composta da lunghi filamenti che si uniscono, ancorandosi insieme attraverso degli uncini. Per le loro dimensioni e consistenza sono di due tipi: alcune abbastanza forti e rigide che servono da remi nell’aria (remiganti) e da timone o direzionali (timoniere), mentre altre servono per

mantenere la temperatura interna, ma proteggono anche il corpo dell’uccello dal vento, dalla pioggia e dal sole. È la pelle dell’uccello che produce effettivamente il piumaggio at-
traverso gli pterilii, dai quali si sviluppano le penne e le piume, a costituire il cosiddetto apparato tegumentario. Una papilla dermica si rompe e, attraverso la pelle, lo strato esterno che forma la piuma vitale crescerà con la base della piuma incorporata in un follicolo; finché la penna è viva ed in crescita, la sua morbida cavità centrale è alimentata da pigmenti attraverso vasi sanguigni. Una volta che la penna è completamente cresciuta, sigilla la cavità e, completamente espansa, indurendosi perde l’alimentazione da parte del sangue. Tutti consigliano, giustamente, di offrire con una certa cadenza il bagno quando gli uccelli sono in muta; per esperienza personale posso affermare che questa tecnica aiuta l’abbattimento della cheratina sprigionata nell’aria, con grande beneficio per le persone allergiche con crisi asmatiche. La crescita di nuove piume avviene in una guaina protettiva, che il bagno aiuta a staccare facendola depositare nell’acqua. Il bagno consente anche di far scemare l’esuberanza dei giovani canarini distraendoli e quindi abbassando il rischio che litighino tra di loro rovinandosi il piumaggio. Nessun uccello è completamente coperto dal piumaggio, ci sono in tutti gli uccelli delle chiazze di pelle nuda; questo è facilmente riscontrabile tenendo un uccello in mano e soffiando sul suo petto o sulla cloaca per esaminarne il corpo: si vedranno le piume che si dividono nel mezzo lasciando la pelle nuda. Se in qualsiasi momento dell’anno un uccello perde una delle sue piume o penne, questa ricrescerà rapidamente, senza dover attendere la sua muta annuale. Il tempo della muta arriva quando un
Le piume sono le cose che solo gli uccelli possiedono e creaturanessun’altraha!
JOHN E. ROBSON
Fonte: Wikipedia, autore: Joao Estevao Andrade de Freitas
NUMERO 10 - 2022 47 DIDATTICA & CULTURA
uccello perde le piume in maniera naturale e senza interventi esterni. Alcuni allevatori, in special modo chi alleva canarini che primeggiano per la loro lunghezza, usano, alla fine della crescita del piumaggio da nido, far allungare le code facendole ricrescere. La muta può essere un periodo molto interessante e talvolta complesso. Un uccello sano, escludendo i fenomeni della muta nuziale o primaverile, muta tutto il piumaggio una volta all’anno, tranne che per il primo anno di vita (questo è vero per canarini, cardellini ecc., ma non per i pappagalli, che hanno un altro tipo e tempo di muta) in cui cambia solo il piumaggio “dolce” (piume). La muta viene innescata da un processo naturale, che inizia quando la stagione riproduttiva sta volgendo al termine e c’è una graduale diminuzione delle ore di luce del giorno. Questo produce anche una modifica nelle ghiandole sessuali e pituitarie di un canarino. La muta la potremmo anche associare ad un “rinnovamento dell’abbigliamento” umano, logoro o rovinato. Così come c’è un momento ben preciso per la muta, c’è anche una sequenza ben definita per le zone del corpo che vanno a mutare; l’ultima zona che va a mutare è la testa. Se si verificasse una perdita di troppe piume contemporaneamente o una muta irregolare delle penne, la capacità dell’uccello di volare sarebbe influenzata negati-

vamente. Nel caso dei giovani canarini, quelli ancora col piumaggio da nido mutano le piume del corpo solo quando hanno un’età compresa tra le otto e le dieci settimane. Negli uccelli adulti questo processo normalmente inizia a luglio, a seconda anche dello stato della loro ghiandola pituitaria. A mio avviso, il periodo più impegnativo nella vita di un canarino è proprio durante la muta, sia per i giovani che per gli adulti; a fine muta entrambi hanno appena concluso una fase che richiede loro grande forza, per tante ragioni. Infatti, senza dubbio, a causa della muta subiscono un notevole abbassamento delle difese immunitarie, esponendosi più facilmente agli attacchi di possibili germi. Le piume da nido cambiate nella prima muta, in qualsiasi giovane canarino, determineranno il suo futuro come esemplare da esposizione nel bene e nel male. Il piumaggio si svi-
luppa da follicoli presenti nella cute ed è costituito da cellule di cheratina β, che è dura ma allo stesso tempo flessibile; una proteina simile alla cheratina è presente nelle squame dei rettili ma è differente da quella presente nei peli e nelle corna dei mammiferi, che sono formati da cheratina Comealfa.
tutti sappiamo esistono tre tipi di piumaggio: le penne, le piume e le filopiume
La cheratina o beta-cheratina fa parte di una famiglia di proteine strutturali presenti nella pelle di rettili e uccelli. La β-cheratina componente dello strato corneo epidermico è differente dalla alfa-cheratina prodotta dai mammiferi. La differenza tra alfa cheratina e beta cheratina dipende dal tipo di animale che la produce. Le scaglie, i becchi, gli artigli e le piume degli uccelli contengono betacheratina della famiglia aviaria. Eventi di duplicazione e divergenza hanno portato ai geni della beta-cheratina ad artiglio e un’ulteriore ricombinazione ha portato a nuovi geni di betacheratina aviaria simili a piume e penne. La prova di questi eventi di duplicazione deriva dalla correlazione della struttura piramidale nella quale sono inseriti tutti i piumati. Alcuni studi sull’evoluzione dei geni della beta-cheratina aviaria hanno fatto rilevare che la famiglia della beta-cheratina aviaria ha iniziato a differenziarsi dalla famiglia dei rettili più di 200 milioni di anni fa. È stato anche scoperto che la famiglia della cheratina delle piume non ha continuato ad allontanarsi fino a 125 milioni di anni fa, data approssimativa della comparsa degli uccelli, l’era del Cretaceo. Le β-cheratine presenti nelle piume moderne hanno una maggiore elasticità. La cheratina in generale è definita come una proteina fibrosa, principale componente della struttura di capelli, penne, artigli, corna.

Tutti gli allevatori di uccelli da gabbia e da voliera che esibiscono i propri soggetti non devono tener conto del proverbio che recita “l’abito non fa il monaco” perché, nel nostro caso, l’abito dei nostri animali, oltre a fare il monaco, fa anche il campione.

Se trovando una piuma diciamo che un uccello è passato di là, nessunosmentirci.potrà
JOHN E. ROBSON
48 NUMERO 10 - 2022
Fonte: www.animalivolanti.it
Il Senecione comune
Alias Senecio vulgaris (in dialetto solcio’n) un’erba pericolosa


 testo e foto di di PIERLUIGI MENGACCI, WIKIPEDIA, WWW.FUNGHITALIANI.IT, WWW.ISTITUTOVENETO.ORG e R. ESPOSITO
testo e foto di di PIERLUIGI MENGACCI, WIKIPEDIA, WWW.FUNGHITALIANI.IT, WWW.ISTITUTOVENETO.ORG e R. ESPOSITO
Premessa

I giorni scorsi, mentre raccoglievo alcuni rametti teneri di “farinello” e di “portulaca”, cresciuti in mezzo ai pomodori, per una misticanza di insalata e per darli ai canarini, ho notato una piccola pianticella che lì per lì mi ha lasciato un po’ perplesso. A prima vista, mi è sembrato un crespigno ma mentre ficcavo il coltello nel terreno per raccoglierla ho avuto un ripensamento. Le foglie, pur essendo frastagliate, erano meno spigolose e di un colore verde meno intenso rispetto al crespigno e l’infiorescenza formata da piccoli capolini pendenti all’apice di alcuni rametti partenti dal fusto assai fragile, mi hanno fatto sorgere
Dal libretto dei miei appunti orto-ornitofili e non solo
dei dubbi. Mentre la osservavo pensando a come fosse arrivata lì, nel mio orto tra i pomodori, e se estirparla o meno, un flash della memoria mi fa dire: -È un“solcio’n”! - e mi riporta a quando, maldestramente, da piccolo, la raccoglievo assieme ai crespigni ed altre erbe di campagna, nelle uscite con mia madre; essa veniva costantemente scartata. I “solcio’n”, così
chiamati in dialetto, per mia madre erano un’erba molto “pericolosa”; faceva ammalare gli animali da cortile ed era soprattutto considerata non commestibile, quasi “velenosa”. Inizialmente la confondevo sempre con gli “scarpégn” (crespigni), ma pian piano l’occhio si è affinato ed ho iniziato a distinguerne le differenze. Con il passare degli anni la presenza dei “solcio’n” nei campi in cui raccolgo erbe mangerecce è sempre più diminuita, fino a sparire, ed anche la mia memoria ne aveva dimenticato le caratteristiche ed il suo nome botanico.
La comparsa di questo esemplare nell’orto ha smosso un turbinio di ricordi e, nel contempo, il desiderio di veri-
Senecio vulgaris, fonte: Wikipedia
Senecio vulgaris, fonte: www.funghiitaliani.it
NUMERO 10 - 2022 49 ALIMENTAZIONE
ficarne la veridicità e di conoscere meglio quest’erba. Prendo il cellulare, faccio alcune fotografie e nel pomeriggio mi metto a confrontare le mie foto con quelle sui testi di erbe di campagna e quelle pubblicate su internet. Le ricerche mi portano ad identificare i “solcio’n” con il Senecione Comune, alias Senecio vulgaris

e, sfogliando i miei appunti “orto-ornitofili”,con mia grande sorpresa, trovo quest’erba decritta come “Erba cardellina molto appetita da cardellini e molti fringillidi”; per le proprietà, rimando alla pag. 273 del volume Segreti e virtù delle piante medicinali*. Partendo dai suddetti appunti e da quanto ho raccolto nel mio “peregrinare” nei vari testi, ho dato corso alla stesura di questo articolo, in cui sono messe in evidenza proprietà e “pericolosità” del Senecio vulgaris, ma al tempo stesso anche la sua utilità per i nostri amici alati.
Alcuni cenni botanico-storici Il Senecione comune, nome scientifico Senecio vulgaris, è una pianta annuale o biennale che appartiene alla famiglia delle Asteraceae. Originaria dell’Africa Settentrionale, delle zone temperate dell’Asia e dell’Europa, è diffusa in tutto il mondo. Definizioni comuni: Erba cardellina, Verzellina, Sollecione, Calderugia ecc. Partendo dalla radice, troviamo un piccolo rizoma, con radici fibrose secondarie poco evidenti e fittonanti. Il fusto è eretto, fragile e ramoso. Normalmente ogni pianta produce un solo stelo che può raggiungere circa 40 cm di altezza. Le foglie sono di color verde chiaro: quelle basali hanno lamina spatolata e lobata, lunghe dai 2 ai 10 centimetri, con i margini dentati; quelle lungo il fusto sono attaccate direttamente al gambo in modo alternato con “ragnatele” lungo i nervi, mentre le foglie più basse hanno un corto picciolo. Le brattee verdi che circondano i capolini hanno le punte di colore scuro. I fiori, ermafroditi, di colore giallo, sono presenti sulla pianta quasi tutto l’anno e i capolini, formati da numerosi fiori a disco, sono riuniti in grappoli lungo i gambi. I semi sono stretti, lunghi circa 2.5 millimetri, e vengono dispersi dal vento grazie ad un pappo che favorisce la disseminazione anemofila. L’ habitat tipico di questa pianta erbacea sono gli incolti, vicinanze di corsi d’acqua, bordi di strade di campagna, scarpate e campi seminati a mais o patate. Oggi, questa pianta erbacea è quasi sparita dai campi lavo-


rati a causa dell’uso dei diserbanti, essendo considerata infestante. In altitudine è facile trovarla fino a circa 1800 mt. s.l.m.
Il nome del genere deriva dal latino senex = vecchio, con allusione ai pappi biancastri, che ricordano i capelli bianchi, leggeri, fini e frastagliati di una persona anziana, mentre l’epiteto specifico vulgaris deriva dall’aggettivo latino che significa “comune”, “conosciuto da tutti”.
La storia ci racconta che questa pianta era conosciuta e utilizzata come medicinale fin dall’antichità e Dioscoride riporta che un decotto fatto con il vino ed ilsenecio alleviava i dolori di stomaco e l’insufficienza
Anchebiliare.
quest’erba non è risultata estranea alla magia. Infatti, in alcuni paesi si riteneva che mescolando della cera di una candela benedetta ad un unguento ricavato dal Senecio vulgaris se ne aumentasse il potere curativo.
Proprietà ed utilizzi I costituenti principali sono sali minerali (calcio, ferro, potassio, fosforo, magnesio ecc.), mucillagine, tannini, resina e alcaloidi che si trovano nelle parti che vengono utilizzate, vale a dire la pianta intera fiorita prima dello sbocciare dei capolini, sotto forma di infusi, tinture e sciroppi. Va precisato che gli alcaloidi presenti in questa pianta sono tossici sia per l’uomo che per molti animali e causano lesioni al fegato simili a quelle della cirrosi epatica. La più alta concentrazione di alcaloidi è presente nei fiori e le tossine aumentano nelle foglie quando la pianta è in fase di Nelsviluppo.tempo la medicina popolare ha
Solcio'n (Senecione) nell'orto dell'autore
Solcio'n (Senecione) nell'orto dell'autore
La storia ci racconta che questa pianta era conosciuta e utilizzata come medicinale fin dall’antichità
50 NUMERO 10 - 2022
riconosciuto a questa pianta erbacea proprietà astringenti, emmenagoghe, emollienti, espettoranti, vermifughe e vulnerarie. Veniva consigliata per disturbi epatici, circolatori, intestinali, emorroidi, ma in particolar modo per un ciclo mestruale particolarmente doloroso.


Il senecio viene usato nella fitoterapia popolare sotto forma di infusi, tinture e sciroppi. Oggi ciò è controindicato per la presenza di alcaloidi epatotossici e cancerogeni, oltre che per la mancanza di prove scientifiche sulla sua efficacia.*

È stato dimostrato che il Senecio vulgaris sia mortale per cavalli e bovini se ne consumano più del 7% del loro peso corporeo; altri animali, come ovini e caprini possono sopportarne il consumo, senza danni al fegato. Anche molti uccelli, particolarmente cardellini, verzellini, verdoni e fringillidi vari, in natura, si nutrono di questa pianta senza avere problemi di salute (forse si cibano solo dei semi, dove non sono presenti gli alcaloidi?).
Per uso umano, in qualsiasi testo che ho consultato ho trovato scritto: erba pericolosa, TOSSICA se ingerita in grande quantità; alcune foglioline giovani sono tollerate in misticanze di insalata.
In ambito ornitologico, riporto integralmente il sottostante scritto sull’Erba cardellinadi un esperto allevatore di cardellini, Raffaele Esposito**,
pubblicato alcuni anni fa su Facebook, che mi ha colpito per la dovizia dei particolari e che ritengo molto interessante e pertinente all’argomento trattato:
Osservazioni in natura e uso ornitologico
Con le prime e abbondanti piogge autunnali, i terreni sufficientemente umidi favoriscono la crescita di molte piante spontanee, che fioriscono principalmente nel periodo invernale. Tra
queste c’è l’Erba cardellina che insieme all’Ortica minore (Urtica urens) ed a qualche altra pianta spontanea (Borsa del pastore, Centocchio, Poa annua, ecc.) costituisce il principale nutrimento dei Cardellini e di molti altri fringillidi, in tutto il periodo invernale e gran parte di quello primaverile. L’Erba cardellina dalle mie parti (localmente chiamata “ciurella o sciurella“) è molto comune e cresce praticamente dappertutto, principalmente nei campi coltivati come campi aperti, frutteti e vigneti. In questi luoghi, specialmente nei frutteti, non è difficile vedere i cardellini, riuniti in piccoli gruppi stanziali o grandi gruppi migratori, talvolta frammisti ad altre specie, intenti a nutrirsi sia dei semi dell’Erba cardellina che di altre specie spontanee, che si trovano molto spesso negli stessi posti. Questi frutteti a partire dal mese di gennaio (ed entro la fine di marzo) vengono potati e poi puliti (con fresatura del terreno) dalle erbe infestanti. E proprio in questo periodo, mano a mano che i frutteti vengono puliti dai proprietari, i vari fringillidi si spostano, concentrandosi nei pochi frutteti rimasti ancora pieni di erbe spontanee. In questi, verso la fine di marzo-inizio aprile, si possono osservare anche centinaia di uccelli (cardellini, verdoni, verzellini, fanelli, fringuelli, ecc.), tutti alla ricerca dei nutrienti semi delle erbe spontanee a loro più gradite. Le infiorescenze di questa pianta, sono tal-
 Rosetta basale di Seneciovulgaris, fonte: Wikipedia Senecione, font: www.istitutoveneto.org
Una manciata di Erba cardellina, foto RaffaeleEsposito
Rosetta basale di Seneciovulgaris, fonte: Wikipedia Senecione, font: www.istitutoveneto.org
Una manciata di Erba cardellina, foto RaffaeleEsposito
NUMERO 10 - 2022 51
mente apprezzate dai cardellini che viene chiamata “Erba cardellina” proprio per la predilezione che hanno verso i semi di questa pianta. I piccoli semi dell’Erba cardellina hanno straordinarie proprietà nutritive; proprio per questo motivo sono molto ricercati dai cardellini (ma anche dai vari fringillidi) e sono completi di tutto quello di cui gli uccelli hanno bisogno. In alcune zone viene (spesso alternata all’Urtica urens) utilizzata come alimento principale, perché l’alto contenuto di sostanze nutritive aiuta i cardellini e altre specie che se ne nutrono a superare i duri mesi invernali. LErba cardellina è molto gradita anche dai cardellini e altri firngillidi domestici e la si può somministrare anche tutti i giorni in grandi quantità. Chi non ha molto tempo per raccogliere l’Erba cardellina lo può fare anche una volta a settimana, in quanto può essere posta (anche senza radice) in un contenitore
con l’acqua, così rimane fresca per molto tempo, anche per più giorni. Non essendoci stati studi scientifici per stabilire con certezza se i cardellini (e gli altri uccelli) siano immuni oppure no agli alcaloidi presenti nelle foglie dell’Erba cardellina, allora sarebbe meglio stare attenti e limitare l’assunzione delle foglie; quindi, quando forniamo l’Erba cardellina ai nostri uccelli, una volta che loro avranno consumato i semi contenuti nei capolini, tutto quello che resta della pianta (foglie e gambi) va eliminato, perché una volta consumati i semi loro inizieranno a nutrirsi di tutte le parti verdi della pianta, che se ingerite in grandi quantità possono (?) provocare gravi problemi epatici e intestinali, i quali possono causare anche la morte dei volatili. Esperienze personali: nel mio allevamento ho sempre utilizzato l’Erba cardellina e oltre ai semi, molto spesso, gli uccelli si sono nutriti anche di qual-
che fogliolina e non hanno mai avuto problemi epatici o di altro tipo. Quindi, per mia esperienza posso dire che le foglie di questa pianta, se assunte in piccole quantità (meglio farne ingerire il meno possibile), non danno problemi di salute, e con un po’di attenzione, facendo in modo che i nostri uccelli si alimentino solo dei semi, di sicuro ne otterranno molti benefici: così miglioreremo la qualità di vita dei nostri amati fringillidi”.Raffaele Esposito
Conclusione
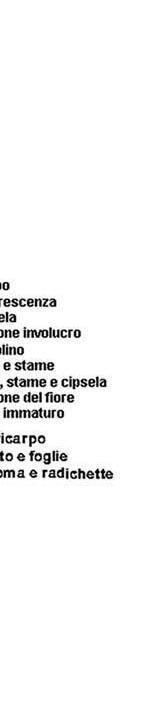
Questa pianta è la dimostrazione che la conoscenza delle erbe spontanee e le osservazioni in natura sono una “condiciosine qua non”; è impossibile raccogliere erbe di campagna per uso alimentare sia umano che animale. L‘esperienza, come quella che ho riportato (da elogiare e divulgare), frutto di osservazioni e conoscenze, ci dimostra che anche una modesta pianta erbacea come l’Erba cardellina, alias Senecione, pericolosa e tossica se impiegata ad uso umano, possa essere utile nei nostri allevamenti amatoriali. Nelle giuste dosi e senza abusarne, “sfruttando” le sue parti edibili, vale a dire le infiorescenze con i semini e, seguendo i consigli di allevatori esperti, i nostri volatili “di sicuro ne otterranno molti benefici”.
A proposito di “osservazioni”, chiudo con vecchio aforisma: “C’è un libro sempre aperto per gli occhi: la natura!” (Jean-Jacques Rousseau).
E permettetemi una digressione. Leggiamo con la massima attenzione e rispetto questo “libro”: c’è sempre e molto da imparare, soprattutto oggigiorno, mentre osserviamo impotenti il ribellarsi della natura all’uomo. Ad maiora, semper.
Alcune fonti:
-Segreti e virtù delle piante medicinali - Selezione dal Reader’s Digest 1983-**Raffaele Esposito - L’Erba cardellina –Facebook – 08 gennaio 2019

-*https://erbeofficinali.org/dati/q_scheda_res.php?-https://www.floraitaliae.actaplantarum.org/-https://it.wikipedia.org/wiki/Senecio_vulgaris–viewtopic.php?t=23932nv_erba=SENECIONE#

 Senecio vulgaris,
Senecio vulgaris,
52 NUMERO 10 - 2022
fonte: www.funghiitaliani.it


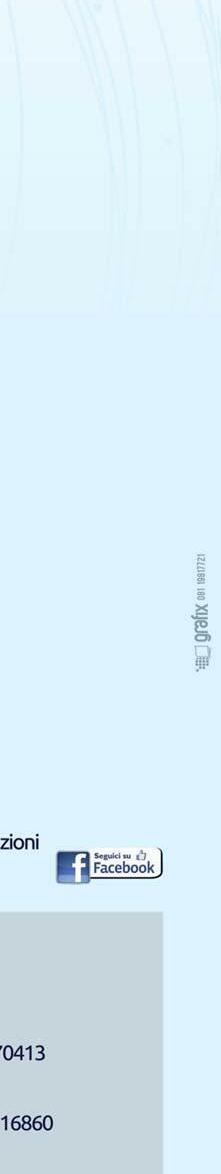






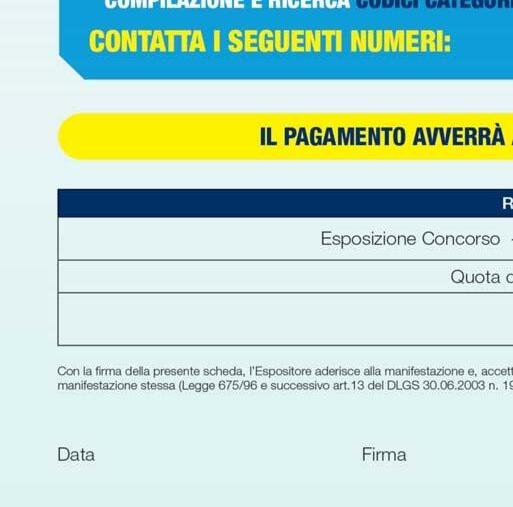



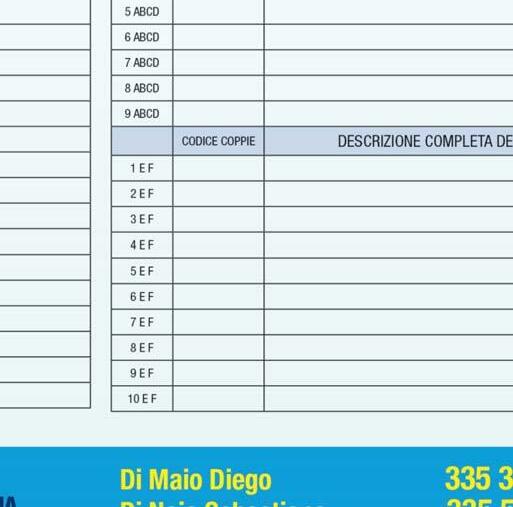

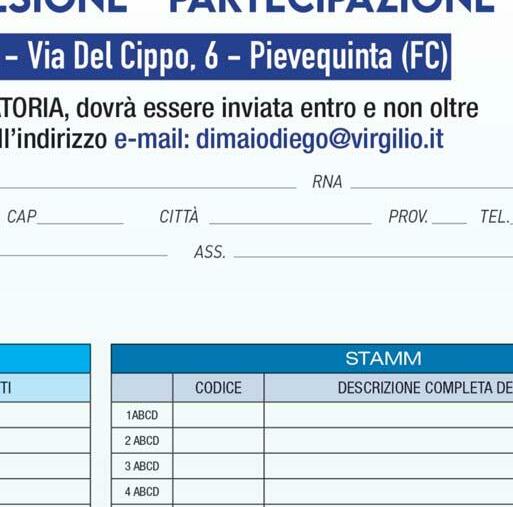


R ecensioni

Compendio di Ornitologia Amatoriale

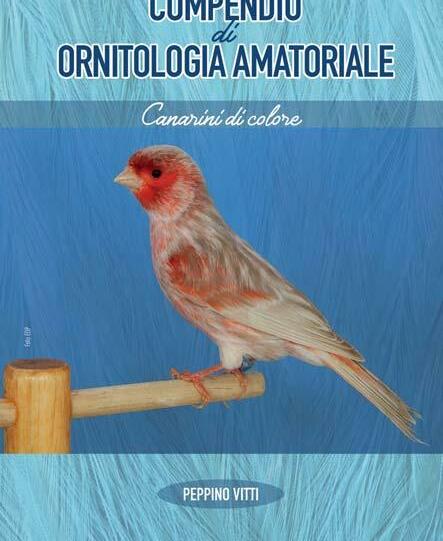
Canarini di Colore
Autore: Peppino Vitti
Edizione limitata - pagine 170 di GENNARO IANNUCCILLI
Peppino
Vitti è un personaggio di spicco dell’ornitologia italiana. Scrivo questa frase solo per i pochi allevatori e frequentatori del nostro ambiente che non hanno mai avuto modo di conoscere o quantomeno sentire parlare di lui: Peppino Vitti, infatti, negli oltre cinquant’anni vissuti nel mondo ornitologico, ha rivestito ruoli di vertice sia nell’ambito della specializzazione tecnica sia in ambito dirigenziale associativo. Sempre presente, con la sua inseparabile bicicletta, in tutte le mostre importanti non solo della sua zona ma del territorio nazionale, ha significativamente dato il suo apporto a livello organizzativo affinché ogni manifestazione in cui era coinvolto riuscisse in maniera Ora,ottimale.Peppino
Vitti ha voluto trasmettere il suo “sapere” ornitologico, acquisito in anni di studio, dedizione ed esperienza, attraverso la pubblicazione di questo Compendio dedicato alla sua passione: l’allevamento e la selezione dei Canarini di Colore, di cui è attualmente giudice mentore, dopo essere stato un apprezzato giudice internazionale. Il Compendio è stato volutamente concepito e fatto stampare dall’autore in sole 100 copie numerate, da destinare alle persone che egli stesso ha voluto omaggiare con questo “prezioso” dono; prezioso per il lavoro che traspare da ogni rigo delle 170 pagine di cui è composta la sua veste editoriale. Al suo interno, c’è tutto ciò che un allevatore appassionato dovrebbe necessariamente sapere; morfologia, genetica e nozioni scientifiche sono espresse in maniera esaustiva, sebbene riassunte per una più agevole comprensione da parte del Lalettore.parte centrale e fondamentale del Compendio è dedicata alle singole mutazioni presenti e ad oggi riconosciute nella canaricoltura di Colore. Ogni aspetto è descritto con meticolosa precisione: gli schemi di accoppiamento; il comportamento genetico da cui derivano le varie selezioni; l’aspetto fe-
notipico di ogni tipo di canarino; i difetti da tenere in considerazione per evitarne la reiterazione nel proprio Possiamoceppo.senza dubbio affermare che il Compendio di Ornitologia Amatoriale di Peppino Vitti è una pubblicazione certamente didattica, ma include anche contenuti tecnico/scientifici la cui conoscenza non può prescindere dal bagaglio culturale di ogni allevatore che interpreti la propria passione con finalità selettive a fini espositivi. La lettura del Compendio è consigliata a coloro che vogliono approcciare con cognizione e nella maniera corretta l’allevamento dei Canarini di Colore ma anche ai tanti “esperti”, i quali potrebbero trarre giovamento nel leggere o rileggere dei concetti assimilati magari tempo fa, per una opportuna verifica delle proprie conoscenze. Per tali motivi, auspichiamo che presto possa venire programmata una ristampa di questa pubblicazione che merita una più ampia diffusione e presenza nelle collezioni editoriali di allevatori e appassionati della canaricoltura di Colore.
editorialiNovità
NUMERO 10 - 2022 55
V olontariato

Fine anno scolastico: fair play tra sport e pappagalli

L’ emozione dell’ultimo giorno di scuola è uno dei pochi ricordi in comune che abbiamo
PressoSportivoL’eventodelloognicheComprensivoMelanzioParinidiMontefalco,festaAsancirel’ultimogiornoscolasticoinunastidevadasubito,poichèsapevichenonavre-vacanzeUnmistodiemozionitralafelicitàdelletutti.inarrivoelanostalgiachetipren-rivistoituoicompagnipertremesi.dipurodivertimentoèstatol’Istitutoloscorso6Giugnosièprodigatocomeannonellarealizzazionedella“Festasport”.èstatocuratodalCSI(ComitatoItaliano).gliimpiantisportividiMontefalco


un tripudio di colori, tra i tanti bambini dalle classi dell’infanzia fino ai ragazzi più grandi della secondaria, ha caratterizzato la giornata.
Le associazioni che hanno partecipato all’evento sono state molteplici come: Educare al Movimento, Asd Tennis Montefalco, Ducato Calcio, Arci Montefalco, Foligno Rugby, Aurora Volley Bastardo; ma oltre a colorare i campi in erba quest’anno si è voluto colorare anche il cielo con l’associazione Passione Pappagalli Free Flight.
Tra fuochi e giochi olimpici a cura dei bambini che con le loro magliette hanno emulato la bandiera italiana e i cerchi olimpici, i pappagalli dell’Associazione con il presidente

eventiedProgetti
56 NUMERO 10 - 2022
V olontariato


Chiara Alessandrini hanno portato davvero una nota di allegria e colore tra i ragazzi i docenti e tutte le famiglie portiproprio,sionetuttoPossiamoinsolite.perepiùcosepossibilisuquestecreaturerivolteSuccessivamente,tantedomandesonostatesisentisuglispalti.Un’esclamazionedistuporehannoIpappagallialcentrodelcamposportivopresenti.spiccatoilvolosorvolandotuttiipre-èelevataall’unisonotraipresenti.aimembridell’Associazionepersa-direcheèstataintuttoeperunagiornatadi“fairplay”,espres-chesignifica«giocoleale»nelsensonellosport,efigurativoneirap-umaniesociali.


La speranza sono le nuove generazioni, la speranza sono i nostri ragazzi. Possiamo dire che noi adulti di certo non abbiamo fatto un buon lavoro con madre natura, ed è per questo che abbiamo almeno il dovere di recuperare con i ragazzi, insegnando loro il rispetto per altri esseri viCrescerliventi. guidandoli a relazionarsi con gli animali, e in particolar modo con animali così diversi dalla loro cultura, significa educarli alla diversità e alla differenza favorendo la sensibilità a tutto ciò che li cirNoiconda.vogliamo davvero credere che loro sapranno fare meglio di noi.

eventiedProgetti
NUMERO 10 - 2022 57
O rniFlash
L’Arabia Saudita lancia il programma di conservazione del falco con ambizione globale
L’ambizioso
programma di reintroduzione del falco dell’Arabia Saudita spesso dipende dal breve momento in cui a un falco viene mostrato per la prima volta la sua nuova casa. In base ai nuovi protocolli sviluppati nell’ambito del programma, un falco viene portato per la prima volta nel suo potenziale habitat sotto un cofano. Allevato in cattività, un falco può trovare la natura selvaggia dell’Arabia Saudita inizialmente misteriosa. Gli uccelli devono essere introdotti lentamente nell’habitat. “Scopri il cofano per tre secondi. Poi lo copri e lo porti a casa”, ha detto Hussam Al-Huzaimi, CEO del Saudi Falcon Club. “Poi tre giorni dopo lo riporti indietro e fai qualcosa di diverso. In questo modo inizi a incuriosire l’uccello che inizia a interessarsi a ciò che sta vedendo e si sente al sicuro”. Il programma Hadad dell’Arabia Saudita per la reintroduzione dei falchi in Arabia Saudita è una partnership tra ricercatori, falconieri e volontari della fauna selvatica che stanno sviluppando metodi nuovi e basati sulla ricerca per ripopolare il regno con uccelli rapaci, tecniche che sperano di applicare un giorno altrove in tutto il mondo. Il programma riunisce più entità saudite e entità internazionali, inclusi esperti di voliera dell’Oregon State University. Quando un falco viene introdotto nelle riserve naturali dell’Arabia Saudita, non vi è alcuna garanzia che l’uccello rimanga. Ogni nuovo sito viene scelto con cura e i ricercatori devono raccogliere indizi accurati, come rocce macchiate che suggeriscono che a un certo punto in passato il sito fosse la dimora di un nido di falchi. Numerosi siti in tutta l’Arabia Saudita suggeriscono che potrebbe supportare una popolazione di falchi più ampia in futuro. Durante il primo anno del programma nel 2021, 33 femmine di falco allevate in cattività sono state introdotte in aree con già presenti falchi maschi. Gli eventuali accoppiamenti hanno prodotto 47 pulcini. Quest’anno sono state presentate altre 24 femmine, che hanno avuto lo stesso successo. Finora il programma di allevamento ha prodotto 151 pulcini.
Fonte: https://tebigeek.com/larabia-saudita-lancia-il-programma-di-conservazione-del-falco-con-ambi-zione-globale/

Scoperta una nuova specie in un’area remota del Cile
Una
nuova specie di uccelli da circa mezzo grammo di peso, è stata scoperta in un’area remota del Cile, in Sud America. La nuova scoperta, notano gli scienziati, è la prova dell’importanza di osservare la natura selvaggia in alcuni dei luoghi più remoti della Terra. L’arcipelago su cui è stato trovato si trova sulla punta dell’America: è un luogo davvero isolato ed è privo di predatori di mammiferi e piante legnose. Questi uccelli si muovono a distanze più brevi dal livello del suolo e invece di nidificare nelle cavità degli alberi, si riproducono in cavità nel terreno, riflettendo storie di vita diverse. Inoltre questa specie è stata trovata in un luogo senza alberi. Studi genetici hanno confermato che la specie appena scoperta differisce in una mutazione dal resto della specie classica rayadito, oltre ad altre differenze in forma e comportamento. Questa nuova specie è stata denominata rayadito subantartico (Aphrastura subantarctica). Queste isole subantartiche hanno un clima da tundra, infatti la crescita degli alberi è ostacolata dalle temperature rigide e le brevi stagioni di crescita. Quello che sorprende è che un uccello sia riuscito a sopravvivere letteralmente dentro l’oceano, in assenza di boschi. La specie potrebbe trasformarsi in un simbolo che contribuirà alle informazioni sulle oscure Isole Diego Ramirez.
Fonte: https://focustech.it/2022/09/08/uccelli-nuova-specie-cile-559997

Foto: Christiane (Pixabay)

News voloal solononewebdal
58 NUMERO 10 - 2022
O rniFlash
Gli umani che insegnano a migrare agli ibis eremiti

Nelle
ultime settimane nei cieli dell’Alto Adige, del Veneto, della Romagna e della Toscana qualcuno potrebbe aver visto qualcosa di inconsueto: due paraplani, piccoli mezzi aerei che somigliano a parapendii ma hanno un motore, seguiti da più di venti uccelli neri. Dal 16 agosto al 2 settembre si è infatti svolta la quindicesima migrazione a guida umana degli ibis eremiti, una specie a forte rischio di estinzione che un gruppo di scienziati austriaci e tedeschi sta cercando di reintrodurre in Europa. Gli ibis del gruppo hanno circa cinque mesi e sono nati in uno zoo. Sono stati separati dai genitori a pochi giorni dalla nascita, per essere cresciuti da due “madri adottive” umane e poter imparare a migrare verso sud in vista del periodo più freddo dell’anno. La migrazione infatti non è un processo del tutto istintivo, gli uccelli che la praticano devono seguire i propri genitori per conoscere in che direzione andare, e se cresciuti in cattività non hanno riferimenti. Per questo, per aumentare la popolazione selvatica di ibis eremiti si usa il metodo della migrazione a guida umana.
La maggior parte dei nuovi nati di quest’anno, che si spera potranno aggiungersi al conteggio di dicembre, sono figli di generazioni già ben inserite in natura e autonome e per questo impareranno a migrare seguendo i genitori, quando questi si sposteranno nel sud della Toscana tra settembre e ottobre. (La migrazione a guida umana viene fatta in anticipo perché servono condizioni meteorologiche più stabili per far volare i paraplani).
Fonte: https://www.ilpost.it/2022/09/05/ibis-eremita-reintroduzione-migrazione-guidata/


Ineuroni nel cervello degli uccelli consumano tre volte meno glucosio rispetto a quelli nel cervello dei mammiferi e questo spiegherebbe perché abbiano sviluppato comportamenti così complessi nonostante abbiano un cervello molto piccolo.
Le incredibili doti intellettive degli uccelli sono note non solo agli esperti, ma anche al grande pubblico. Chiunque ascoltando il canto di un uccello lira in grado di imitare perfettamente un numero straordinario di suoni diversi, non esiterebbe nel definire questi animali estremamente intelligenti. Grazie allo studio condotto dai ricercatori della Ruhr University di Bochum, in Germania, e pubblicato su Current Biology, da oggi abbiamo anche una possibile spiegazione di come fa il loro cervello a supportare questi complessi meccanismi neurali.
Il team di ricerca ha studiato il cervello dei piccioni per fare un vero e proprio bilancio energetico neuronale. Data l’incredibile quantità di neuroni presenti nel cervello dei piccioni, gli esperti si aspettavano un consumo energetico molto elevato, ma è qui che si sono dovuti ricredere. I loro studi hanno rilevato che il cervello del piccione da sveglio consuma una quantità sorprendentemente bassa di glucosio, circa 27 micromoli di glucosio per 100 grammi al minuto. Questo si traduce in un budget energetico molto basso per il cervello, soprattutto quando lo si confronta con un mammifero della stessa taglia.
In sostanza, in media i neuroni nel cervello degli uccelli consumano tre volte meno glucosio rispetto a quelli nel cervello dei mammiferi, ma il motivo per cui questo risparmio energetico sia così elevato rimane ad oggi sconosciuto. Che sia per la complessità del canto, per una bizzarra danza di accoppiamento o un comportamento sociale curioso, per ora gli uccelli continueranno ad essere un mistero del mondo naturale ancora da scoprire.
Fonte: https://www.kodami.it/lintelligenza-degli-uccelli-e-merito-di-neuroni-che-consumano-poca-energia/
L’intelligenza degli uccelli è merito di neuroni che consumano poca energia
News voloal solononewebdal
NUMERO 10 - 2022 59


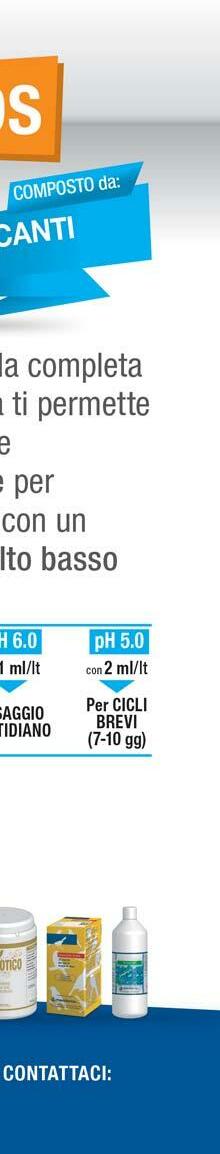



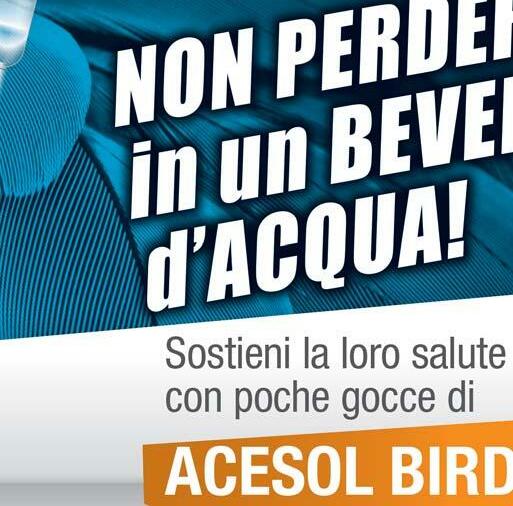


Si può ornitologicaun’esposizionefare…in estate
Salento birds show, un’esperimento di ornicoltura ben riuscito




Ilmovimento ornitologico sportivo, come qualsiasi altro sport, basa una gran parte delle sue motivazioni sul confronto e la competizione. Momento in cui l’individuo si misura con i suoi av-
versari in un arbitrato che sancisce il migliore. Un concetto che da sempre muove la società umana, bisognosa di identità e vissuti. L’ornitofilia vede nelle mostre ornitologiche, che altro non
sono che competizioni di codificata bellezza fenotipica delle varie stirpi domestiche, il momento più significativo della passione, che viene dopo gli sforzi della riproduzione e della preparazione e si
 testo e foto di FRANCESCO FAGGIANO
Best ondulato di colore, all. Di Fonso
Diamante fetonte, all. Clemente
testo e foto di FRANCESCO FAGGIANO
Best ondulato di colore, all. Di Fonso
Diamante fetonte, all. Clemente
NUMERO 10 - 2022 61 CRONACA
conclude grazie ai titoli conquistati con la cessione remunerata dei soggetti. Il mondo dell’ornicoltura sarebbe davvero ben diverso se non si organizzassero più le competizioni e lo abbiamo visto nei duri anni di Covid. Ma il mondo cambia ed è cambiato anche velocemente e le nuove dinamiche sociali ed economiche impongono adattamenti anche alle realtà più solide, compreso il mondo dell’ornicoltura. Per questo dobbiamo cambiare anche noi velocemente nei prossimi anni, ripensando ad un nuovo orientamento del nostro hobby. Tra le varie cose a cui crediamo di dover metter mano nel processo di ammodernamento dell’ornicoltura, sicuramente la destagionalizzazione del calendario mostre rappresenta un’importante occasione di miglioramento e sviluppo del settore. Da sempre il calendario mostre
concentrato in un paio di mesi o poco più ha stancato gli allevatori, che negli ultimi anni, visti anche i costi necessari per gli spostamenti e non solo quelli, si vedono sempre più costretti a scegliere a quale mostra essere presenti. Un calendario asfittico rischia inoltre di non dare la giusta visibilità a realtà che possono rappresentare nel loro piccolo interessanti focus tecnici e riuscire ad avvicinare al nostro hobby persone nuove,



grazie a quell’indispensabile intreccio di relazioni sociali necessarie a realizzare, contenendo i costi, la mostra locale. Solo così si avvicina in modo capillare la società al nostro movimento, società che difficilmente si interessa ad un “grande campionato di ornitologia”, sicuramente più prestigioso, ma molto più impersonale, più costoso ed accessibile come contenuti solo agli addetti ai lavori. Sono le piccole realtà, quelle ancora a dimensione d’uomo, che permettono di fare gruppo col neofita e sviluppare quel senso di appartenenza e di familiarità che riqualifica il nostro hobby. Per tutte queste ragioni il CD dell’Associazione Ornitologica Salentina ha deciso di tentare l’organizzazione di quello che ci è piaciuto definire un esperimento di ornicoltura: la “SALENTO BIRDS SHOW D’ESTATE”, esposizione ornitologica specialistica a carattere sperimentale, che rivela la possibilità di ampliare il calendario mostre almeno per alcune specializzazioni e ridurre quella pressione espositiva oggi per molti insostenibile. Certo non sarà possibile organizzare tra maggio e giugno mostre dedicate ai canarini di colore, né tantomeno a quelli di forma e posizione, ma considerando anche i dati delle altre due manifestazioni SOR, tenutesi in concomitanza della SALENTO BIRDS SHOW D’ESTATE, ovvero la neonata LOVEBIRD’S per gli Agapornis e la collaudata COLORADO per gli ondulati, pensare anche agli estrildidi SI PUO’!
Aspetti tecnici della manifestazione Riteniamo che organizzare una manifestazione specialistica presupponga la possibilità di inserire all’interno della stessa elementi tecnici qualificanti che permettano un confronto espositivo più specifico e magari anche più duro, ma più stimolante, oltre che un arricchimento tecnico culturale del settore. Oggi non sono più le tante categorie a qualificare come specialistica una manifestazione, anche perché quando si arriva a vincere mediamente con un soggetto esposto ogni tre, è chiaro che il livello competitivo è abbastanza basso. Se è vero che un esemplare per poter vincere in categoria deve raggiungere il punteggio minimo di 90 punti (ricor-
 DM grigio dorso chiaro PN, all. D'Urso
DM grigio dorso chiaro PN, all. D'Urso
“SALENTO BIRDS SHOW esposizioneD’ESTATE”,ornitologicaspecialisticaacaratteresperimentale
62 NUMERO 10 - 2022
dando che solo nelle mostre a punteggio globale non vige questo limite, che a nostro modo di vedere dovrebbe essere rivisto e magari lasciato come scelta al comitato organizzatore), è pur vero che il livello medio dei soggetti esposti nelle esposizioni si attesta tra gli 88 ed i 90 punti; pochi sono gli ornicoltori che spendono soldi per ingabbiare uno scarto. Nell’intento di alzare il livello competitivo e gli aspetti tecnici anche in una piccola manifestazione come la nostra, abbiamo accostato all’allargamento delle categorie i raggruppamenti, ovvero i primi classificati di categorie affini: ad esempio, tutti i primi classificati del diamante di Gould a fenotipo “classico” vengono confrontati tra loro per scegliere il migliore del raggruppamento. I vincitori di raggruppamenti affini (ad esempio, sempre per il diamante di Gould, tutte le categorie erano suddivise in tre raggruppamenti: “classici”, singole mutazioni e combinazioni di mutazione), a loro volta, si sono affrontati per conquistare il titolo di BEST DIAMANTE DI GOULD. Così anche i numerosi diamanti mandarini esposti, circa 80, e i vari estrildidi sono stati suddivisi in raggruppamenti affini e poi confrontati per stabilire rispettivamente il BEST DM ed il BEST ALTRI ESTRILDIDI. Questi tre campioni si sono poi ancora una volta affrontati nuovamente sul tavolo di giudizio per il titolo di BEST ASSOLUTO DELLA SEZIONE ESTRILDIDI. Lo stesso percorso a più livelli di competizione è stato sviluppato nella sezione ondulati. In via sperimentale e nell’intento di realizzare un ulteriore approfondimento conoscitivo dei soggetti, sono state inserite, oltre alle classi ordinarie di giudizio, sia per la sezione ondulati che per la sezione estrildidi, due classi sperimentali di giudizio: classe BABY, ovvero soggetti dell’anno a muta incompleta, e classe SENIOR, cioè soggetti con tre o più anni di età. Questo ha permesso di visionare dal vivo tutti i vari stadi fenotipici dei nostri esemplari da quando sono in piumaggio da nido a quando hanno affrontato due o più mute. Negli estrildidi la cosa è stata accolta con un po’ con renitenza e pochi sono stati i soggetti inseriti in queste due classi, mentre nell’ondulato, dove la classe baby è ormai prassi ben

accolta, il risultato numerico è stato buono, evidenziando un discreto interesse. Approfittiamo per ringraziare dell’idea il club “Amici dell’ondulato” ed il loro instancabile collaboratore Luigi Vergari. Anche le tempistiche della manifestazione sono state smart, con il conferimento dei soggetti nel venerdì pomeriggio, giudizio a valutazione globale il sabato e sgabbio la domenica mattina alle ore 13:30, permettendo ai convogliatori ed al comitato organizzatore di gestire essenzialmente solo due giornate e mezzo di impegno. Pur se con numeri contenuti, grazie a questo insieme di momenti e opportunità che gli allevatori hanno apprezzato ed alla qualificata varietà di soggetti presenti, di cui il 95% a muta ultimata e perfet-

tamente preparati alla competizione, al di sopra di ogni aspettativa considerando il periodo, possiamo affermare che la manifestazione abbia ben meritato la qualifica di mostra specialistica a carattere sperimentale.

Reportage sui soggetti 214 estrildidi conferiti da 19 ornicoltori FOI, tutti del centro e sud Italia, con il primato di specie spettante al Diamante mandarino che ha conquistato anche il titolo di BEST ASSOLUTO ESTRILDIDI con uno strepitoso bianco, che oltre ad essere un soggetto eccellente era anche eccellentemente preparato all’esposizione, risultando così non solo tecnicamente corretto ma anche accattivante e capace di rubare la scena alla
 DM bianco, all. Serra
DM bianco, all. Serra
NUMERO 10 - 2022 63
bellissima femmina di Diamante di Gould “bruna” scelta collegialmente dai giudici come Best Gould ed al notevole Diamante di Peale, a cui è stato attribuito il Best altri estrildidi. Un confronto tra Best arduo, dove i giudici Spagna e Stragapede, due amici di sempre e grandi tecnici che ringraziamo della disponibilità, hanno giustamente scelto di premiare a parità di meriti selettivi anche per il risultato ornicolturale, attribuendo il titolo all’animale più scenografico. Oltre ai Best, posso indicare come meritevoli di nota alcune femmine di Diamante zebrato “bruno”, un Diamante pappagallo lutino avorio, una bella femmina di Diamante di Gould lutino “bruno” a testa arancio, uno stamm di Kittlitz bruni e un Diamante codalunga mutato a “lipocromo giallo”, di cui mi riprometto di parlare in un prossimo articolo. Nella sezione Ondulati, dove era ospite il giudice Sabattini, persona di grande competenza e disponibilità (approfittiamo per tributargli un grande grazie), erano presenti 133 esemplari tra ondulati di Forma e Posizione e Colore in larga maggioranza. In questa sezione, a differenza che negli estrildidi, anche la classe di giudizio Baby era numericamente ben rappresentata, essendo per gli ornicoltori del settore un’esperienza convalidata e degna di nota tecnica. Molto accattivante il BEST ASSOLUTO ONDULATI, assegnato ad un
214conferitiestrildidi
ondulato di FP cannella grigio, che si è confrontato per l’assoluto contro la femmina di colore lutino, che gareggiava in classe ordinaria, titolare del Best ondulato di colore e contro il Best Baby, dove era titolare un viola cannella, molto promettente. Anche qui un bel confronto tra eccellenze differenti, dove probabilmente sempre l’aspetto scenografico e forse anche un po’ la difficoltà di allevamento dell’ondulato di forma e posizione hanno convinto il giudice. Notevole anche il soggetto a cui è andato il titolo di “miglior rainbow”, che presentava davvero un fenotipo ad arcobaleno meritevole di essere premiato con una tela della pittrice Patrizia Spada, che ringraziamo per la vicinanza al nostro mondo e che ha donato anche in quest’occasione tre sue opere a tema alla manifestazione, ritraenti rispettivamente un ondulato di Fp, un diamante di Gould e, appunto, un ondulato “rainbow”.


Conclusioni Sicuramente convincere i consiglieri dell’Associazione Ornitologica Salentina ad organizzare una manifestazione specialistica a carattere sperimentale all’inizio dell’estate non è stato semplice, ma tutto sommato nemmeno difficile; sono ragazzi straordinari, che vivono ancora con dedizione e piacere l’impegno di fare Associazione ed ornicoltura, un piacere ormai molto spesso dimenticato e sostituito con la presunzione di essere campioni solo nelle grandi manifestazioni e di allevare per cedere. Sono queste le credenze improprie di chi vive quest’hobby in modo sbagliato ed oggi che la situazione è “complessa” sono i primi che abbandonano con facilità. Un ornicoltore deve essere un campione ogni giorno, non solo all’internazionale o al mondiale; certo, quello è un traguardo ambizioso, ma di un percorso quotidiano in cui la passione è strumento e non fine, perché si è prima uomini e solo dopo campioni. In una società sempre più ingarbugliata tra ideologie ed individualismi, credere ancora nell’associazionismo e nel fare per la collettività,per il puro gusto di condividere con persone vicine qualche mezza giornata di ornicoltura, è importante perché serve all’uomo a ritrovare quella dimensione reale e non presunta delle cose che fa la differenza. Un po’ più difficile è stato, di contro, convincere gli amici fuori regione a raggiungerci; per questo un plauso più che meritato va al gruppo di ERITHRURA con a capo il grande Luciano Di Biase, che con grande rispetto ha partecipato alla manifestazione con un bel gruppo di soggetti notevoli, ed a Massimiliano Di Fonzo, convogliatore del Club amici dell’ondulato e del gruppo di Lanciano, che con temeraria convinzione ha convogliato da solo i soggetti del centro Italia, perché anche lui è uno che crede ancora nell’impegno personale e che ha piacere di fare! Un grazie va anche al Presidente dell’Ordine dei Gudici, sempre disponibile alle necessità delle associazioni e ai Presidenti delle CTN OP ed EFI. Tutti i dati e le informazioni inerenti la manifestazione sono disponibili sul sito www.aoslecce.com
 Team e Giudici
Team e Giudici
da 19 ornicoltori FOI, tutti del centro e sud Italia
64 NUMERO 10 - 2022