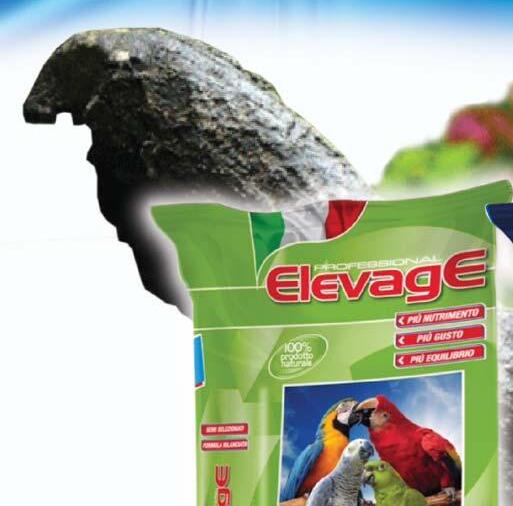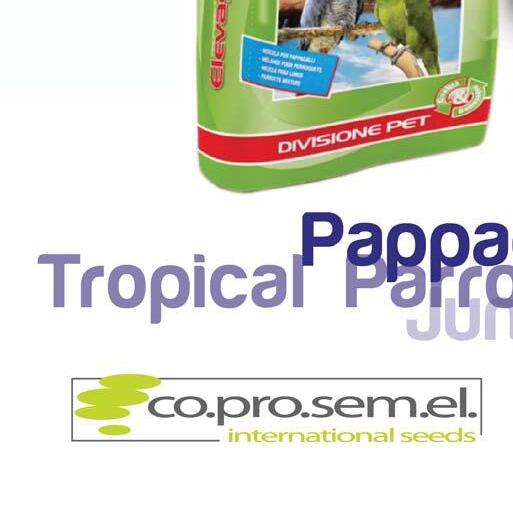ANNO LI
numero 7/8 2025





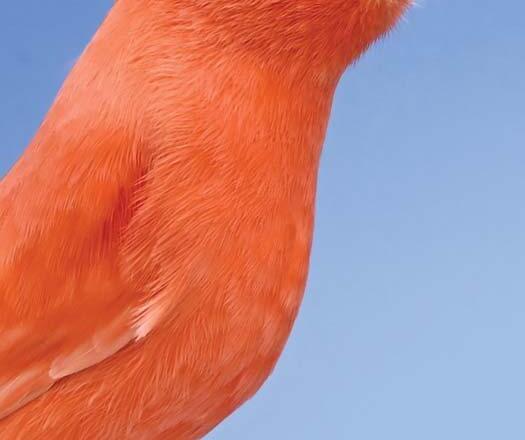



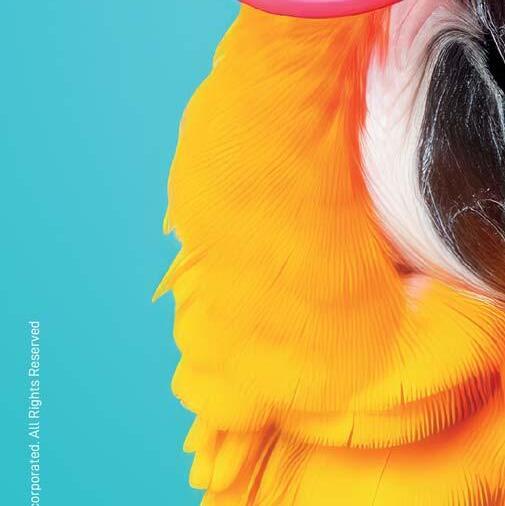
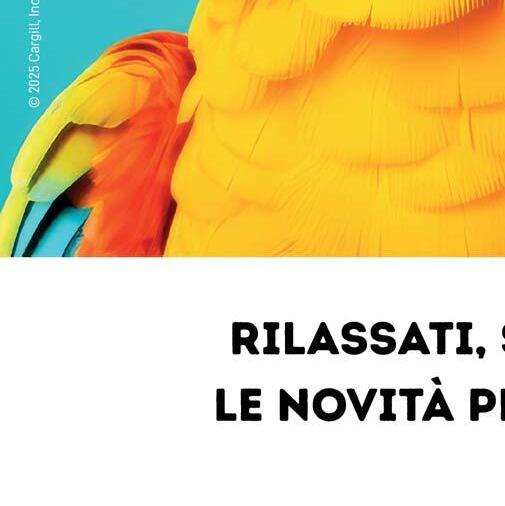


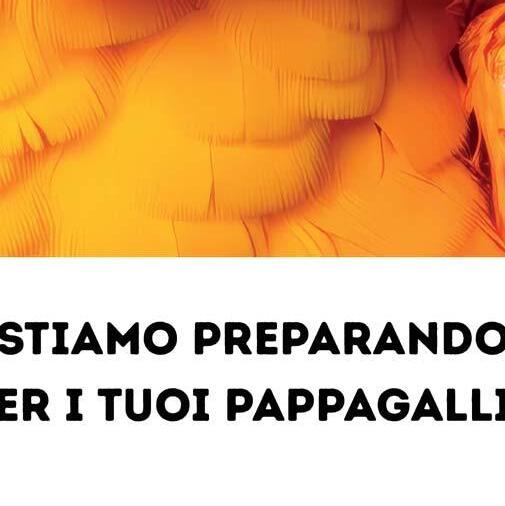




ANNO LI
numero 7/8 2025





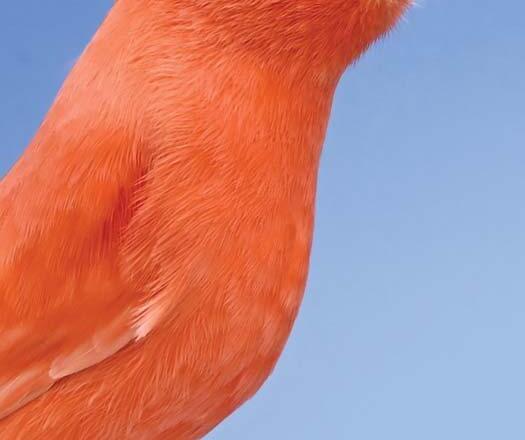



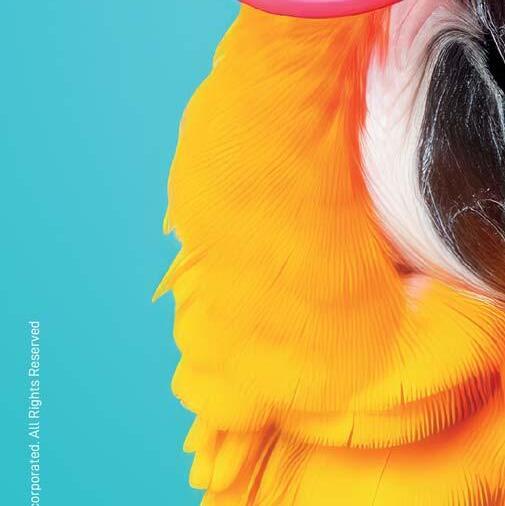
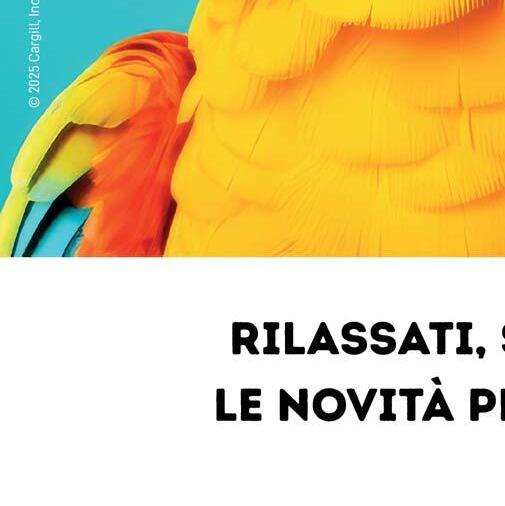


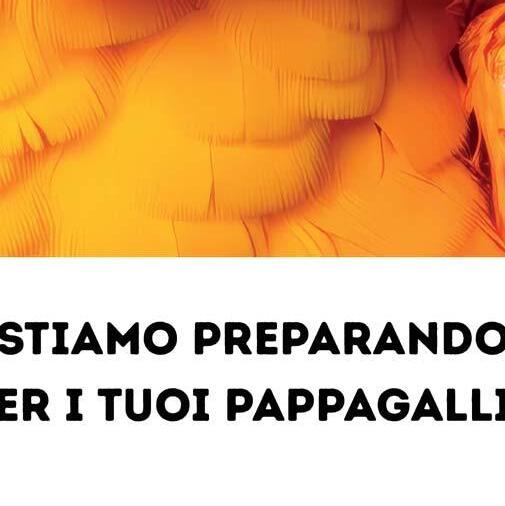


Gusti da educare Giovanni Canali
Urucum:




Carduelis carduelis
in Calabria
Nel cuore del verde:
Bosco dei bimbi”
gli amici alati
Codirossone, questo sconosciuto
Paternò


AMMINISTRAZIONE E PUBBLICITÀ: Segreteria F.O.I.-Onlus Via Caorsana, 94 - Località Le Mose 29122 Piacenza
Tel. 0523.593403 - Fax 0523.571613
Web: www.foi.it - E-mail: redazione@foi.it
Direttore Responsabile: Antonio Sposito Caporedattore: Gennaro Iannuccilli
Collaboratori di Redazione: Giovanni Canali, Maurizio Manzoni, Francesco Rossini
Commissione Salute, Benessere animale e Ricerca Scientifica: Elena Circella, Giuseppe Marruchella, Gianluca Todisco
Coadiutore Editoriale: Lorenza Cattalani

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana ISSN 0391-254X (International Standard Serial Number)
Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 4396 del 12-3-1975
Stampa: MEDIAGRAF S.p.A.
Viale della Navigazione Interna, 89 35027 Noventa Padovana (PD) - Tel. 049 8991 511
Inoltro postale in Italia: MEDIAGRAF S.p.A.
ABBONAMENTI ANNUI:
Italia € 30,00 - Estero-Europa € 50,00
Estero-ExtraEuropa € 70,00
Un numero € 5,00 - Arretrato € 6,50
C.C.P. 53684957
Le quote abbonamento vanno versate, mediante vaglia o assegno, alla Segreteria. Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Rivista e la sua Direzione. La Redazione si riserva il diritto di non pubblicare o emendare gli articoli proposti. I collaboratori assumono piena responsabilità delle affermazioni e delle immagini contenute nei loro scritti. Vietata la riproduzione, anche parziale, se non espressamente autorizzata. © F.O.I. In copertina: Urucum mosaico maschio* (Serinus canaria) All. CANARIL EBENÉZER, foto: C. LEMO * Selezione in evoluzione con contrasto tra piumaggio bianco/rosa e zone di elezione intense




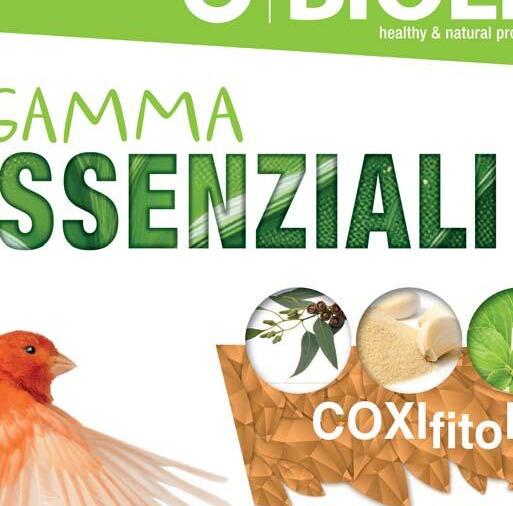
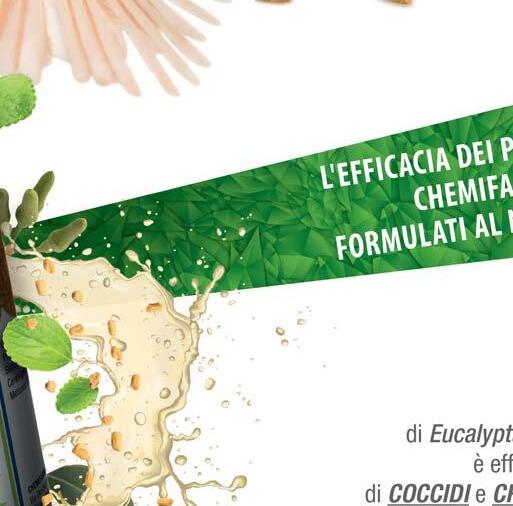


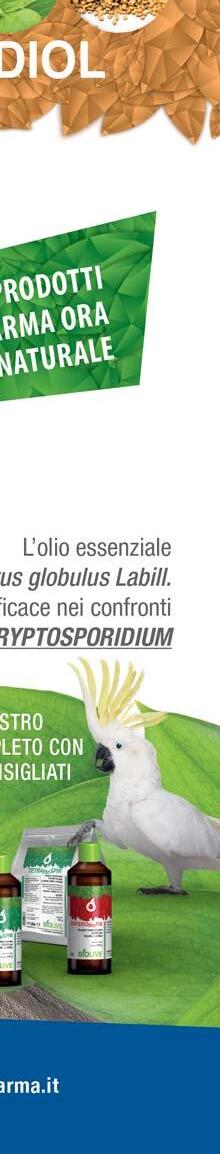
di G IOVANNI CANALI, FOTO F.O.I.
Un proverbio latino molto noto e forse anche abusato è De gustibus non est disputandum o, più completo, De gustibus et coloribus non est disputandum”; vale a dire che sui gusti ed i colori preferiti non si discute. Semmai, suppongo che i latinisti preferirebbero mettere il verbo est in fondo, quindi disputandum non est, secondo regola generale, ma non mi soffermo -del resto, non ne ho titolo-; comunque, più spesso si trova come indicato. Il suddetto è un concetto vero, ma forse non proprio del tutto, visto che certe tendenze nella nostra specie sono ben definite. Non ricordo di aver mai conosciuto qualcuno che preferisse l’olio di ricino a quello extra vergine d’oliva. Magari preferenze fra oli d’oliva di diversa provenienza sì, ma non dubbi con l’olio di ricino. Nelle scelte riguardanti le persone, in dialetto parmigiano si dice (scrivo come si legge) se neg fus la piesaia povra brutaia; piesaia non è traducibile con un solo vocabolo: sta a significare un piacere irrazionale, vale a dire i gusti; quindi, qualcuno o qualcuna può piacere anche se considerato in generale brutto/brutta, altrimenti povero gruppo dei brutti (qui detti brutaia)… non li vorrebbe nessuno. Con questo concetto, però, si rischia di dimenticare un altro proverbio: “Piuttosto che niente, è meglio piuttosto” che talora prevale, cioè ci si contenta di quello che si trova. Inoltre, in cose e persone considerate brutte ci possono essere aspetti positivi che possono prevalere

sulla condizione generale. Tipico il caso della persona di brutto aspetto, ma intelligente e di spirito, che può piacere molto.
In campo artistico le differenze sono ancora più sfumate, ma qualcosa di generale rimane. L’importante è non farsi guidare da persone non obiettive ed evitare di cadere nell’accettazione acritica della communisopinio, talora omologante. Naturalmente, però, è bene evitare di fare i “Bastian contrari”, solo per apparire originali. Ci può essere anche il tentativo di “farsi piacere” o di accontentarsi di ciò a cui si è in qualche modo indirizzati dalle circostanze, in tutti i campi. Ad esempio, chi volesse allevare cavalli da corsa non avendone i mezzi, potrebbe accontentarsi dei nostri uccellini, non meno belli ed inoltre non meno difficili quanto al perseguimento di ottimi risultati, anzi…
Dopo questo preambolo, vorrei ricordare i gusti in campo di allevamento, con accettabili orientamenti ma anche con atteggiamenti alquanto da discutere.


In un mio vecchio articolo filosofico ( Sulla filosofia dell’allevamento, I. O. n°4, aprile 2008) ho stigmatizzato le selezioni che comportano caratteristiche nocive alla vitalità, se non proprio invalidanti. Il mio pensiero è che una selezione che comporti danni alla fisiologia non dovrebbe essere accettata. Nell’articolo suddetto ho parlato di “critica della ragione funzionale”, ritenendo non accettabili selezioni, appunto,
contro la funzionalità. Fra queste segnalo le canne nasali corte che ostacolano la buona respirazione in cani e gatti o bacini troppo stretti rispetto alla testa, che comportano parto cesareo, e ve ne sono anche altre. Oggi si parla di mutazioni che comporterebbero tremiti o portamenti anomali della testa, non so se assimilabili alla condizione spastica o simile. Non sto a citarle, visto che vi sono ancora dubbi, ma se ci fossero danni, per me dovrebbe essere ovvio il non riconoscimento e, conseguentemente, la non ammissione alle mostre. Per le altre selezioni si può parlare di eccessi vari, di dubbia accettabilità, da valutare caso per caso.

Un aspetto delicato è il fatto che troppo spesso, per gusti personali o per mode talora da essi dettate, si cerchi di modificare ciò che non dovrebbe essere modificato, in quanto corretto e perfino ovvio.
Sento ancora e sempre più spesso esprimersi contro la feomelanina nei canarini. La sua esistenza nel canarino è non solo certa ma evidente e non vi è spazio per dubbi, che pure fanno capolino, ed è anche tipica in diverse linee selettive. A suo tempo ho scritto un articolo garbatamente polemico su questo tema (Povera feomelanina, I. O. n°8/9, agosto-settembre 2012). In passato si è voluto commettere l’errore di considerarla difetto nei nero-bruni e si è parlato solo di neri, anche se la natura non si è adeguata e segue i suoi schemi, non i nostri. Oggi si parla perfino di bruni senza bruno; si argomenta di maggiore brillantezza o qualcosa del genere. Ebbene, esistono canarini di tanti tipi, categorie e varietà, ce ne sono per tutti i gusti, pertanto si scelga secondo la propria inclinazione, non si cerchi di alterare ciò che è consolidato -si badi, giustamente- per assecondare non si sa bene che cosa. Che gli ossidati debbano essere scuri ed i diluiti chiari lo si sa dal secolo scorso e parlo dell’inizio! Chi ama le tonalità scure e cupe allevi gli ossidati, mentre chi ama le tonalità chiare e brillanti i diluiti! Non mi sembra difficile da accettare. Si tenga anche presente che pure i toni cupi possono essere affascinanti. A suo tempo ho scritto un articolo (Gradimento dell’atipicità, I. O. n°10, ottobre 2016) pensando anche alle recondite armonie di bellezze diverse della Tosca, bellezze brune e bionde. L’ho fatto arricchire mettendo accanto due quadri, uno di Corot, paesaggista eccelso, con luminosità, tinte delicate e riflessi suggestivi, ed uno di Van Gogh, considerato precursore dell’espressionismo,
con tinte fortissime. Fascini diversi di pari dignità; a nessuno verrebbe in mente di chiedere a Van Gogh di smorzare i toni o altro del genere, né a Corot di appesantire, se fossero vivi. Analogamente sono affascinanti il nero intenso rosso, fortissimo, e l’isabella pastello giallo avorio brinato, delicatissimo. Ciascuno opti secondo il proprio gusto e chi avesse tentennamenti lo educhi, magari con l’aiuto di qualcuno. Il suddetto era un articolo che ritenevo indicativo, ma che non ha sortito alcun esito. Comunque, dovrebbe essere chiaro che chi non ama un genere non dovrebbe allevarlo. Cosa diremmo di uno che detestasse il rosso ed amasse il giallo e che pretendesse le spalline gialle nei rossi e suggerisse di ritardare l’alimentazione colorante a tal fine e magari anche di preferire i rossi meno rossi? Suppongo gli suggeriremmo di allevare i gialli e di non interferire in settori a lui non congeniali. Ci sono poi degli standard che vanno seguiti, non ci si deve permettere di dare interpretazioni arbitrarie. Se ci fossero errori si ha il diritto/dovere di segnalarli, ma fino a che lo standard è vigente lo si segue. Inoltre i gusti, come ribadisco, vanno educati. Se ci fosse qualcosa di non chiaro, si dovrebbe approfondire; dire “Mi piace di più” non ha molto significato, a meno che non si disquisisca su aspetti opinabili e comunque non basta l’espressione generica, bisogna saper motivare; al massimo si potrebbe dire “A mia sensazione”, ma sarebbe un’espressione debolissima.
Una volta chiarite le cose, è bene educare il gusto alla luce delle motivazioni tecniche e logiche apprese. Di conseguenza, imparare ad apprezzare anche tipicità prima non apprezzate; si potranno scoprire aspetti non ben valutati precedentemente. Se proprio non si riuscisse ad apprezzare qualcosa, non resta che rinunciare a questo qualcosa, orientandosi in altre direzioni, senza creare problemi ad altri.
Certo, dovrebbe essere molto facile educare il gusto a non apprezzare caratteristiche negative per la funzionalità e la salute generale. Un poco meno facile per altri aspetti, ma logica e competenza dovrebbero essere ben considerate. Se poi volesse intervenire qualche psicologo per disquisire su quelli che sono i gusti, innati o apparentemente innati, ben venga, ma la tecnica è tecnica e l’educazione dei gusti permane, come necessaria, quando si vogliono seguire linee selettive corrette.

testo di MIMMO ALFONZETTI, foto AUTORIVARI
Nel mondo dell’allevamento dei canarini, le mutazioni genetiche sono sempre un argomento affascinante che suscita grande interesse tra gli allevatori e gli appassionati.
Non tutte le nuove mutazioni, però, hanno impatto determinante sui fenotipi esistenti ma una delle più sorprendenti e riconosciute, che contraddice questo concetto, è la Urucum, nota anche come “becco rosso”.
Queste prime note esplorano in dettaglio le caratteristiche, l’origine e la rilevanza di questa mutazione, nonché il suo impatto sulla comparsa e l’allevamento dei canarini a fattore rosso. Nella seconda parte proveremo a dare documentazione delle anomalie fisiopatologiche di questa mutazione.
La Urucum è una diversificazione genetica autosomica recessiva correlata ai canarini a fattore rosso. Questa mutazione è caratterizzata principalmente nel dare un forte colore rosso al becco, alle zampe e alla pelle (?) dei canarini. Inoltre, ha un notevole effetto, oltre che sul colore delle penne, anche sulla loro consistenza, rendendole più morbide e setose, con una colorazione rosa negli esemplari brinati e una totale assenza di brinature negli intensi che conferisce agli esemplari un aspetto unico e sorprendente.




Un po’di storia
Nella metà degli anni ‘90 in Brasile, nel villaggio di Resende, a Rio de Janeiro, più precisamente nel 1994, l’allevatore di canarini Maércio Laranjo ebbe nel suo allevamento la nascita del primo mutato con becco rosso. Sin dalla sua comparsa, a seguito di accoppiamento classico “rosso intenso per brinato”, questa mutazione ha catturato l’attenzione degli allevatori di canarini per la sua capacità di conferire un colore distintivo e unico ai canarini a fattore rosso. Poiché si tratta di una mutazione autosomica recessiva, entrambi i genitori devono essere portatori del gene affinché la caratteristica sia visibile nella loro prole. La denominazione “Urucum” comunemente indicata anche con il nome “annatto” sta ad indicare una serie di coloranti giallorossicci di struttura derivata dal carotene estratti dalla bacca Bixa orellana, una pianta nativa del Brasile. Il seme dei suoi frutti, di colore rosso, è utilizzato dagli indigeni per dipingersi la pelle nei loro vari rituali.

La saturazione della penna, oltre all’interessamento delle produzioni cutanee (becco, squame ed unghie) è quella che definisce, a mio avviso, l’originalità dei canarini Urucum. I carotenoidi nel canarino selvatico, come sappiamo, non pigmentano l’apice della penna e la evidente rarefazione delle melanine fa sembrare l’apice decolorato, come una piccola scaglia bianca. La decolorazione è forse dovuta ad una minore velocità, o meglio, ad un ritardo nella pigmentazione della cheratina da parte dei follicoli dermici.
Caratteristiche visive del canarino Urucum I canarini affetti dalla mutazione Urucum hanno caratteristiche visive uniche che li differenziano chiaramente dagli altri canarini a fattore rosso. Le caratteristiche più importanti sono:
•Becco, zampe e pelle rossi: la mutazione Urucum provoca un cambiamento nella pigmentazione, che si traduce in becco, zampe e pelle di un rosso più o meno brillante, tutte le parti nude, piuttosto che nel colore tipico carnicino.
•Piume più setose e morbide: questo cambiamento genetico influisce anche sulla struttura delle piume, rendendole più morbide al tatto e conferendo loro un aspetto più setoso.
•Brinature color rosa nelle piume brinate: nei canarini brinati, che normalmente hanno una brinatura bianca, la mutazione Urucum la tra-
sforma in una tonalità rosa tenue per saturazione (rosa confetto, secondo G. Canali), che aggiunge ulteriore bellezza a questi uccelli.
•Assenza di brinature nella categoria Intenso: negli esemplari di categoria Intenso, le brinature sono completamente assenti, il che permette al lipocromo rosso di mostrarsi uniformemente su tutto il piumaggio. Non sono, comunque, evidenti diversità cromatiche nel piumaggio rispetto ai classici.

C’è un effetto pigmentante dei lipocromi molto simile all’azione estensiva sulle melanine della mutazione Cobalto. La cloaca, che normalmente nei canarini, talora anche intensi, è impregnata più o meno di brinature, nei canarini becco rosso non presenta traccia alcuna di brinature, l’assenza è totale.
L’appellativo di “becco rosso”, oltre ad essere un segno visivo e descrittivo dei canarini Urucum, ha un fondamento scientifico accertato. I numerosi progressi tecnologici, come l’HPLC, ossia cromatografia liquida ad alte prestazioni (a), hanno portato recentemente a sostanziali progressi nello scoprire le basi genetiche della colorazione dei carotenoidi negli uccelli. La cromatografia di figura 4 (Małgorzata Anna Gazda) mostra in maniera lampante la concentrazione dei carotenoidi nei tessuti del becco, decisamente superiore a quella dei canarini non oggetto di mutazione (indicati di seguito WT, wild type), con picchi di cantaxantina quasi iperbolici. La semplice recessività autosomica di questa mutazione ha indotto molti allevatori a sperimentare combinazioni di accoppiamento per migliorarla e correggerla nelle linee di riproduzione ma anche per introdurre la mutazione in altre tipologie di canarini. Questa mutazione può essere incorporata in tutte le varianti dei canarini a fattore rosso, offrendo agli allevatori un’ampia gamma di possibilità per sviluppare nuove combinazioni genetiche e fenotipiche. La mutazione Urucum, infatti, non si limita solo ai canarini lipocromici rosso intenso e brinato, ma può essere

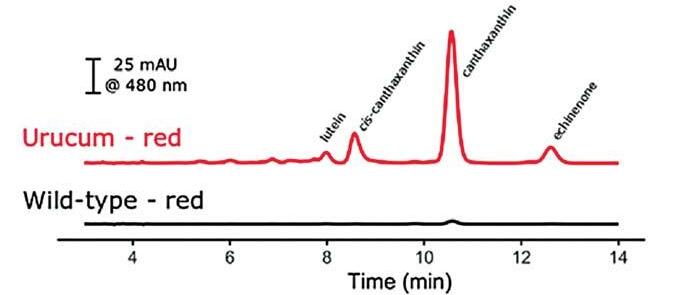

trasmessa anche ad altre tipi di canarini, come i melanici dal fondo rosso e anche i mosaico (i brasiliani hanno provato anche questo accoppiamento contraddittorio). Tuttavia, è nei canarini rossi lipocromici che l’effetto della mutazione Urucum è più evidente e apprezzato. Nei melanici, desta particolare interesse la serie diluita, dove le parti corneali hanno una tonalità chiara (carnicina) e gli effetti di questa mutazione possono essere notati più chiaramente. Gli accoppiamenti originali e alternativi, che comunque non sono stati molti, non hanno evidenziato alcuna modifica delle melanine, non ne alterano il colore, il sottopiuma (parte vaporosa) non subisce modificazioni. Quanto sopra detto può essere trasferito ai melanici “becco giallo” oggetto della stessa mutazione Urucum ma sui carotenoidi gialli.
L’introduzione della mutazione Avorio, con riferimento all’Urucum, produce una diluizione della pigmentazione lipocromica del piumaggio dell’intero Canarino da un colore rosso ad un colore “rosa” (sui generis); medesimo risultato si verifica quando si agisce sui lipocromi gialli degli esemplari a becco giallo; l’introduzione della mutazione dell’Avorio negli Urucum rossi e gialli colpisce, in maniera ovvia, anche il becco, le zampe e le unghie. Il sottopiuma dei canarini Urucum resta bianco, nei lipocromici, come quello dei canarini normali WT. In termini di riproduzione e competizione, i canarini Urucum devono soddisfare gli stessi standard dei tradizionali canarini rosso intenso e brinato. Questi

L’introduzione della mutazione Avorio, con riferimento all’Urucum, produce una diluizione della pigmentazione lipocromica del piumaggio dell’intero Canarino da un colore rosso ad un colore “rosa”
devono includere una colorazione uniforme e intensa sulla punta delle penne, comprese le penne remiganti e della coda. Inoltre, per quegli allevatori che partecipano a concorsi di canaricoltura, i canarini Urucum con un colore rosso vivo nel becco e nelle zampe sono considerati i più desiderabili e di altissima qualità. Come curiosità ma anche ai fini di un raffronto vengono indicate le descrizioni del considerando Varietà dei canarini Urucum secondo i criteri di giudizio della FOB (Federazione Ornitologica Brasiliana) per le categorie intense e brinate.


Valutazioni Descrizione punteggio
Muito bom Intensi che manifestano eccellente purezza (rosso vermiglio) quantità e distribuzione del lipocromo. Becco e zampe con eccellente intensità vermiglia 23
Valutazioni Descrizione punteggio
Muito bom
Esemplari che manifestano eccellente purezza (vermiglio vivo), quantità e distribuzione del lipocromo. Becco e zampe con eccellente intensità vermiglia. Nitido deposito dei lipocromi nei bordi della penna che conferisce un visuale “vellutata” 23
Contenuto di carotenoidi nei tessuti del canarino Urucum
Le piume e le parti nude dei canarini Urucum appaiono brillantemente colorate. Per determinare la base pigmentaria del fenotipo Urucum (rossi e gialli), i ricercatori hanno utilizzato una particolare metodica, la cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC). Hanno esaminato e confrontato l’accumulo di carotenoidi nei tessuti del becco e delle piume di canarini Urucum con quello dei canarini aventi lo stesso fondo di colore del piumaggio (wild-type WT). Particolare attenzione è stata riservata all’accumulo dei carotenoidi nella retina.
La prima tabella mostra chiaramente che i canarini affetti dalla mutazione Urucum tendono ad accumulare concentrazioni significativamente più elevate di carotenoidi nei tessuti del becco. Gli Urucum rossi immagazzinano carotenoidi in misura maggiore degli Urucum gialli.
La seconda tabella mostra, invece, che non c’è differenza statistica significativa in relazione alla concentrazione dei carotenoidi nelle penne tra Urucum e WT, anche se gli Urucum rossi sovrastano di più lunghezze quella degli Urucum gialli.
La terza tabella mostra che anche nei tessuti della retina non vi è differenza statistica di concentrazione carotinoi-
Concentrazione dei carotenoidi nei tessuti del BECCO (μg/g-1)
WT RossiUrucum 1° RossiUrucum 2° RossiWT GialliUrucum gialli
Concentrazione dei carotenoidi nei tessuti delle PENNE (μg/g-1)
WT RossiUrucum 1° RossiUrucum 2° RossiWT GialliUrucum gialli
+/-33,15
Concentrazione dei carotenoidi nei tessuti della RETINA (μg/g-1)
WT RossiUrucum 1° RossiUrucum 2° RossiWT GialliUrucum gialli 460,00+/-114,18
Concentrazione dei carotenoidi nei tessuti di canarini Urucum Rossi (2 gruppi rispettivamente da 3 e da 5), Urucum Gialli (gruppo da 4) e Rossi WT e Gialli WT secondo il Test di Mann-Whitney
Le piume e le parti nude dei canarini Urucum appaiono brillantemente colorate
dea tra gli Urucum e i WT. Qualcosa di estremamente diverso è la concentrazione degli apocarotenoidi, di cui parleremo nella seconda parte di questo articolo. In merito alla colorazione della pelle, qualche articolo ne parla, ma ho personalmente dei dubbi. Non vi è prova
scientifica di questa colorazione, i ricercatori parlano solo di piume e parti nude; a mio avviso, è forse dovuta all’apporto delle sostanze coloranti artificiali immesse nella dieta. D’altra parte, i test scientifici assicurano che per le penne Urucum non esiste differenza statistica significativa rispetto alla concentrazione dei carotenoidi delle penne dei canarini rossi WT. Le penne sono l’appendice più importante del tegumento e se queste non mostrano statisticamente un’evidente, maggiore concentrazione carotinoidea è ovvio dedurre che anche il tegumento rientri in questo concetto. Il test di Mann-Whitney è un test statistico non parametrico utilizzato per confrontare due campioni indipendenti quando il numero di osservazioni è limitato. È utilizzato per stabilire se esista una differenza significativa tra le distribuzioni di due campioni e quindi suggerisce se uno dei campioni sia stocasticamente indicativo in maniera maggiore o minore dell’altro.
Un po’ di genetica
Attraverso metodi di genomica funzionale, sono stati scopertidiversi geni la cui importanza fisiologica è rilevante per i tre distinti meccanismi di colorazione degli uccelli basata sui carotenoidi: assorbimento dei carotenoidi (SCARB1), metabolismo (CYP2J19) e degradazione (BCO2 in eccesso)
SCARB1 svolge un ruolo centrale nella mediazione dell’assorbimento dei carotenoidi e, in quanto tale, è profondamente coinvolto nei processi fisiologici di trasporto dei lipocromi nel flusso sanguigno, per cui la sua labilità evolutiva è di sicuro meccanismo di variazione del colore. È noto che una sua mutazione giustifica l’assenza totale di lipocromi nel piumaggio dei Bianchi Recessivi.
CYP2J19 è coinvolto nella conversione metabolica dei carotenoidi che transitano dal giallo al rosso (chetocarotenoidi) attraverso un processo di chetolasi (IO n° 2-2023), ma non è in grado di mediare la presenza o l’assenza di pigmentazione.
BCO2, infine, in eccesso, è coinvolto nella degradazione dei carotenoidi in

apocarotenoidi.
Un ruolo non trascurabile, è mia personale convinzione, in relazione alla mutazione Urucum è certamente svolto da ECD, complesso di differenziazione epidermica, nel processo di cornificazione delle piume.
Il gene BCO2 (betacarotene ossigenasi 2) è il gene cardine della mutazione Urucum. Le numerose osservazioni scientifiche suggeriscono che la regolazione di questo enzima svolge un ruolocentrale nel determinare l’espressione dei colori basati sui carotenoidi. I carotenoidi possonocircolare nel sangue e il controllo di BCO2 in eccesso sembra essere il meccanismo chiave per crearevariazioni di colore specifiche per tessuti e macchie, come mostrato nei Parulidi, passeriformi americani (Toews et al., 2016).
Il gene BCO2 è coinvolto nella scissione e nella scomposizione dei carotenoidi in apocarotenoidi. La scissione
Attraverso metodi di genomica funzionale, sono stati scoperti diversi geni la cui importanza fisiologica è rilevante per i tre distinti meccanismi di colorazione degli uccelli basata sui carotenoidi
ossidativa catalizzata dalla carotenoide-ossigenasi trasforma infatti i carotenoidi con catena chimica a lunghezza intera in apocarotenoidi a lunghezza corta. La mutazione Urucum abroga l’attività di scissione dei carotenoidi operata da BCO2. È effet-
tivamente una mutazione nonsenso del gene BCO2 e causa una sostituzione aminoacidica che rende l’enzima BCO2 non funzionale (mutato bco2). Non cambia la concentrazione dell’enzima ma in pratica si esprime un enzima che non è funzionale. Di conseguenza, l’attività di scissione dei carotenoidi è compromessa, portando a un accumulo di pigmenti carotenoidi nei tessuti del becco e delle zampe (le parti nude). Questa mutazione è recessiva autosomica e quindi si esprime solo in individui omozigoti per la mutazione (bco2/bco2). Perché il fenotipo Urucum si manifesti, un canarino deve ereditare due copie mutate del gene BCO2 (una da ciascun genitore). Se un individuo possiede solo una copia mutata e una copia funzionante del gene (eterozigote), il fenotipo sarà normale poiché la copia sana del gene è sufficiente per mantenere l’attività enzimatica normale.
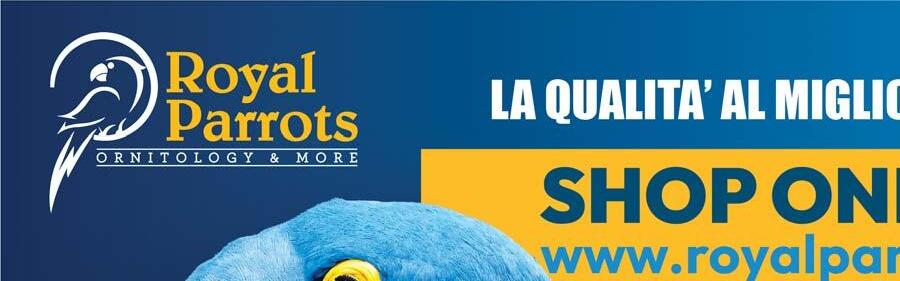




Una mutazione nonsenso si verifica quando una base nel DNA viene sostituita, causando un cambiamento nella codifica di un amminoacido. Questo cambiamento interrompe prematuramente la sintesi della proteina. Di conseguenza, la proteina risultante è più corta del previsto e spesso non funziona correttamente.
Il piumaggio dei canarini Urucum
Questa mutazione ha un notevole effetto sul colore delle parti nude, sul dissolvimento delle brinature ma interferisce anche sulla struttura delle piume, rendendole più morbide al tatto e conferendo loro un aspetto più setoso. La sensazione che ho provato nel trattenere tra le mani un soggetto Urucum giallo è stata quella di stringere qualcosa molto simile a un mannello di bambagia. A mio avviso, gli Urucum gialli intensi, ma è un parere strettamente personale, sono più appariscenti degli Urucum rossi; i gialli evidenziano una cromia gialla unica, splendente, sono di una vistosità e imponenza uniche. Ad una analisi più attenta ho potuto notare che l’estensione delle piume è più larga dei classici intensi, le piume copritrici hanno una convessità diversa, l’innesto delle penne sul rachide è prossima a 90° (negli intensi WT si avvicina a 45°), le penne sono conformate in maniera più simile a quelle dei canarini mosaico piuttosto che agli intensi. Questo aspetto serico, setoso e morbido con molta probabilità è un effetto pleiotropico della mutazione Urucum (b). Forse è anche legato a quel cluster di geni che va sotto il nome di complesso di differenziazione epidermica (ECD) che sono rilevanti nella cornificazione delle piume e, di conseguenza, anche nella assenza delle brinature.
Il complesso di differenziazione epidermica (EDC) è un composito genetico comprendente oltre cinquanta geni che codificano per proteine coinvolte nella differenzazione terminale della cornificazione dei cheratinociti, il tipo cellulare primario dell’epidermide.
Il processo di cornificazione delle piume è fondamentale per la forma-
Questa mutazione ha un notevole effetto sul colore delle parti nude, sul dissolvimento delle brinature ma interferisce anche sulla struttura delle piume, rendendole più morbide al tatto e conferendo loro un aspetto più setoso
zione e lo sviluppo delle piume degli uccelli: le cellule dell’epidermide producono cheratina, una proteina fibrosa che conferisce forza e resistenza alle piume. Il processo garantisce che le piume siano leggere, flessibili e resistenti, ideali per il volo, per l’isolamento termico e altre funzioni specifiche degli uccelli. Una breve panoramica del processo: Differenziazione cellulare: le cellule dell’epidermide iniziano a specializzarsi e a produrre cheratina β. Cheratinizzazione: le cellule si riempiono di cheratina e perdono il nucleo, diventando strutture rigide. Formazione della struttura: le piume si sviluppano seguendo un modello genetico e ambientale, creando la struttura distintiva di rachide, barba e barbule, secondo un preciso programma strutturale.
Le piume Urucum affrontano la fase di cheratinizzazione con dosi di cheratina, successive ma limitate, che portano ad un lento indurimento e in tempi meno rapidi e quindi conferendo una relativa morbidezza
I geni EDC influenzano tutto il processo, modulando le singole fasi secondo un programma genetico prestabilito. Le piume Urucum affrontano la fase di cheratinizzazione con dosi di cheratina, successive ma limitate, che portano ad un lento indurimento e in tempi meno rapidi e quindi conferendo una relativa morbidezza Il lento irrobustimento consente ai lipocromi di diffondersi nella corteccia delle piume in quantità abbondanti e di permeare subito le parti apicali delle piume, le prime a conformarsi. Le zone destinate alle scaglie della brinatura, prima dell’espulsione della piuma dalla papilla, vengono colmate di carotenoidi, conformando così la struttura originale del piumaggio dei canarini Urucum.
Non esiste alcun accertamento scientifico di quanto esposto in queste ultime righe, sono solo logiche ponderazioni personali.
Note
(a) L’HPLC, o cromatografia liquida ad alte prestazioni, è una tecnica analitica per identificare e quantificare le sostanze in una soluzione. Può essere applicata per misurare la concentrazione di carboidrati negli alimenti e nelle bevande, di pesticidi nelle acque di superficie per l’analisi ambientale o di catecolamine nelle urine per scopi clinici, per citare alcuni impieghi.
(b) Interessante è questo particolare aspetto della pleiotropia: struttura setosa e colorazione. Nella razza Lizard potrebbe esserci un meccanismo simile, ipotesi di G. Canali che mi sento di condividere. In questa razza così unica, abbiamo piumaggio molto più setoso, largo e carotenoidi non elaborati. Fenomeno certo non uguale all’Urucum ma sicuramente qualcosa di simile.
Fonti
-Luis F.F. Beraldi, Bico vermelho
-Matthew B. Toomey, Pedro M. Ara, Ricardo J. Lopes, Sandra Afonso e altri, Genetic Basis of De Novo Appearance of Carotenoid Ornamentation in Bare Parts of Canaries
-G. Canali, Italia Ornitologica, n° 8-9/2018
-M. Alfonzetti, Italia Ornitologica n°2/2023 -Małgorzata Anna Gazda, Genetic basis of simple and complex traits with relevance to avian evolution -Canaricultura.com, Mutación Urucum en Canarios: Características y Origen -Alvaroblasina.com, Mutacao Urucum -Canaryculture.com, Understanding The Red Urucum Mutation in Canaries

testo e foto di SILVIO CANALE
Il crociere comune (Loxiacurvirostra)
è un uccello che appartiene alla famiglia dei fringillidi (Fringillidae); predilige le foreste di conifere e si differenzia dagli altri uccelli poiché ha le punte del becco incrociate, un esempio di adattamento per estrarre i semi tra le scaglie delle pigne. Il piumaggio del maschio è rossiccio, mentre la femmina è di un verde olivastro con il sottogola leggermente grigio.
Questo meraviglioso fringillide è stanziale, fra i 1000 e i 2200 metri di altitudine su tutto l’arco alpino e le Prealpi, e a differenza di altri fringillidi può nidificare quasi tutto l’anno, prediligendo i mesi con maggiore disponibilità di semi di conifera (gennaio-giugno).
Durante questo periodo si possono osservare nelle foreste di conifere, specialmente sulle cime, dove c’è maggiore disponibilità di pigne, gruppi numerosi di questo meraviglioso fringillide. I maschi, quando iniziano l’estro, cantano per attirare l’attenzione delle femmine, per poi
Il piumaggio del maschio
è rossiccio, mentre la femmina
è di un verde olivastro con il sottogola leggermente grigio




in futuro formare la coppia. La femmina si dedica alla costruzione del nido posizionandolo di solito nella
parte superiore degli abeti rossi; depone dalle 3 alle 5 uova di colore bianco con delle macchioline marroni


e la durata dell’incubazione dura 13/14 giorni.
Per il periodo in cui nidifica, ossia l’inverno, con le temperature rigide che scendono anche sotto lo zero, la femmina inizia quasi subito la cova già dal primo-secondo uovo; scende molto di rado dal nido e sarà compito del maschio nutrirla; avendo abbondanza di cibo, questi uccelli possono portare avanti anche quattro covate.
La mia passione per gli uccelli probabilmente è nata fin da bambino, in particolare per i Loxia; questo fringillide mi ha sempre affascinato: un ricordo indelebile risale a quando andavo a fare delle passeggiate con mio padre,
La femmina inizia quasi subito la cova già dal primo-secondo uovo; scende molto di rado dal nido e sarà compito del maschio nutrirla
anche lui un amante dell’ornitologia, e mi soffermavo a osservarli appesi a testa all’ ingiù, come dei veri e propri acrobati.

Dopo molti anni la passione per il crociere non è mai svanita, perciò un giorno mi misi in contatto con allevatori di varie zone d’Italia per avere più informazioni possibili riguardo questa specie per me preziosa, sull’alimentazione e la riproduzione in ambiente controllato, fino a che riuscii a trovare una coppia di sicura provenienza, cosa molto importante… era regolarmente anellata. Così da subito mi misi al lavoro per dare loro il migliore habitat possibile per poi sperare di avere qualche risultato positivo, anche se a volte non è sempre facile, poiché ci vuole un po’ di fortuna e impegno costante, specialmente nella fase di prepara-


zione cove, in quanto sono uccelli a dir poco strani: un anno si riproducono senza grandi difficoltà, mentre l’anno dopo la stessa coppia non abbozza neppure il nido…
Il crociere nasce con il becco diritto, che assumerà la curvatura dopo circa due-quattro settimane di vita. I pulli nascono con un leggero piumino color marrone scuro e dopo circa 15/18 giorni sono già pronti a lasciare il nido; sono di un grigio scuro con delle striature nere sul petto e di solito i maschi hanno qualche sfumatura di un leggero giallo sul petto (si possono già notare dai primi mesi).
Ora cercherò di raccontare la mia esperienza personale di allevamento maturata nell’arco degli anni.
Abitando in montagna, sulle Prealpi vicentine, a 1100 metri con un tasso di umidità basso nella stagione estiva, ero privilegiato rispetto a chi allevava in pianura: l’habitat era favorevole per questa specie (ho notato che non amano le temperature torride).
Avevo dapprima preparato una piccola voliera (650 x 950 x 1600 cm) ben allestita, con dei rami di conifera ben disposti per dare un po’ di privacy alla coppia; l’alimentazione iniziale di mantenimento era abbastanza leggera (miscela per ciuffolotti e verdoni) con l’aggiunta di piselli scongelati e di un pastoncino proteico una-due volte a settimana, in modo da abituare la coppia gradualmente; ho osservato, in questi anni di allevamento dei Loxia, che non sono amanti dei pastoni che si trovano in commercio.
L’entrata in estro di questo fringillide non si basa sulla temperatura e sulle ore di luce come accade con altri fringillidi; è molto importante il cambiamento alimentare, detto anche in gergo “stacco”, che deve esser fatto gradualmente. Io personalmente inizio a fornire l’alimentazione ricca di semi di conifera a fine dicembre, con l’aggiunta di qualche pinolo, senza esagerare, perché poi i maschi possono diventare troppo focosi con la femmina, disturbandola durante la preparazione del nido e a volte anche distruggendolo.
Giornalmente fornisco delle pigne di pino mugo, ricche di vitamina E e non


L’entrata in estro di questo fringillide non si basa sulla temperatura e sulle ore di luce come accade con altri fringillidi; è importante il cambiamento alimentare
solo... a mio parere sono molto importanti per le loro proprietà e le raccolgo nei mesi di settembre e ottobre, conservandole poi in un congelatore. Fin da subito ho messo la coppia nella voliera, osservandola più volte al giorno; ho visto che a volte litigavano, ma poi, con il passare del tempo, il comportamento del maschio è diventato meno aggressivo nei confronti della femmina: il corteggiamento era



cominciato, il maschio aveva iniziato a cantare con dei gorgheggi, andava a nutrirsi di qualche pinolo e seme di conifera per poi andare ad imbeccarla, passandoglielo con dolcezza…. questo era un segnale positivo.
Come materiale per la costruzione del nido avevo inserito vari tipi di fibre che si trovano in commercio (cocco, juta, cotone) ma anche del materiale che riuscivo a reperire in natura tipo mu-
Meglio inserire più nidi, posizionandoli sui vari lati della voliera, in modo che la coppia scelga la posizione più favorevole per la cova


schio, licheni vari, rametti secchi di abete, molto graditi; per fare la base del nido ho usato un cestino in vimini di diametro 12 cm, inserito nell’apposito contenitore in ferro per impedire al maschio, quando la femmina sta covando, di rovinare il tutto. Un consiglio: meglio inserire più nidi, posizionandoli sui vari lati della voliera, in modo che la coppia scelga la posizione più favorevole per la cova.
Ho notato che le femmine a volte iniziano la costruzione del nido per poi cambiare posto; non deve mai mancare il calcio (osso di seppia) e una volta a settimana fornisco quello in polvere nei beverini; di vitamine particolari non faccio uso ma cerco di avvicinarmi il più possibile all’alimentazione naturale.
Dopo vari tentativi, la femmina, a metà febbraio, ha trovato il nido e la posizione ideale; ho notato che iniziava a rimanere all’interno per più ore durante il giorno, segno che non mancava molto per la deposizione, e dopo un paio di giorni finalmente il primo uovo, per fortuna mia all’interno del cestino… a volte succede che con la prima covata qualche uovo venga deposto a terra dal posatoio, rompendosi, poi di solito con le altre covate si sistema il tutto. Ciò succede quando i maschi sono troppo irruenti oppure la femmina non è ancora pronta.
Circa una settimana dopo ho controllato e aveva deposto tre uova; io personalmente li lascio tutti nel nido anche per non disturbare la cova. Qualche giorno prima della nascita metto a loro a disposizione piselli, fatti asciugare con un po’ di pastone semimorbido con l’aggiunta di qualche biscotto integrale frantumato e pinoli, il tutto fornito in piccole dosi ma sempre fresco, specialmente quando inizia la stagione più calda (primavera inoltrata), per evitare il pericolo che si formino delle muffe.
Dopo 13/14 giorni ecco le prime nascite: se la coppia è affiatata il maschio già dai primi giorni porta l’imbeccata per poi nutrire i pulli; di solito le femmine di crociere sono protettive e svezzano i pulli senza grandi problemi. Non faccio uso di balie, cerco sempre di allevare in purezza per poi avere dei

soggetti con una buona genetica, cosa da non sottovalutare per un buon ceppo.
Dopo un paio di giorni di solito faccio sempre un controllo veloce per capire se vengono nutriti a dovere; al sesto/settimo giorno metto gli anellini, una fase semplice ma nello stesso tempo delicata. Per nascondere l’anellino alla femmina metto del nastro color carnicino: alcune femmine sono maniache della pulizia del nido e, se si accorgono, potrebbero buttare i pulli fuori dal nido. Il maschio di solito non va mai tolto, solo in casi estremi; sarà lui ad aiutare la femmina a nutrire i piccoli negli ultimi giorni, prima dell’indipendenza dai genitori. Una volta involati, come dicevo prima, la femmina inizia la seconda covata; è qui che il maschio fa la differenza, perché sarà lui a portare avanti la prole fino a fine svezzamento, che ha all’incirca una durata dai 35 ai 45 giorni. In base alla mia esperienza è molto importante non dividere prima i pulli dai genitori.
Il periodo della muta è abbastanza lungo, circa tre mesi, poi molto dipende dalla stagione; metto loro a disposizione giornalmente pigne di abete rosso e pino mugo, carota, semi di conifera; importante fornire sempre acqua pulita nelle vaschette per dare loro la possibilità, specialmente nei mesi più caldi (luglio e agosto), di fare dei bagni molto graditi. Ai maschi fornisco del colorante diluito nell’acqua e
Grande qualità • Ottimi riproduttori
BRUGHERIO (MB)
Tel. 347.0784494
l’esposizione al sole è importantissima (ma non sole diretto) per avere un bel piumaggio sgargiante per poi ottenere qualche bella soddisfazione alle mostre ornitologiche. Concludendo, un doveroso ringraziamento a chi mi ha concesso questa opportunità di far conoscere la mia esperienza personale di allevamento del crociere. Buon allevamento a tutti!






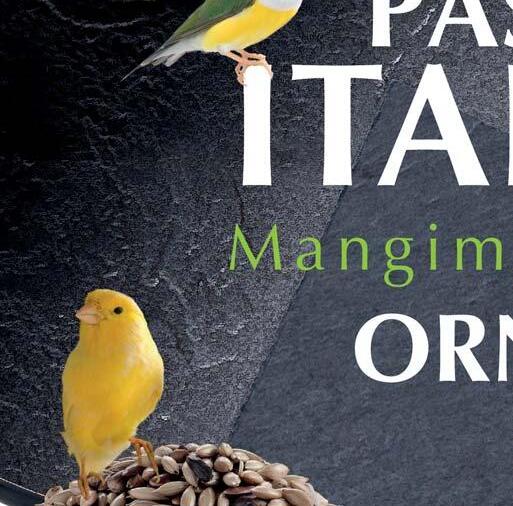



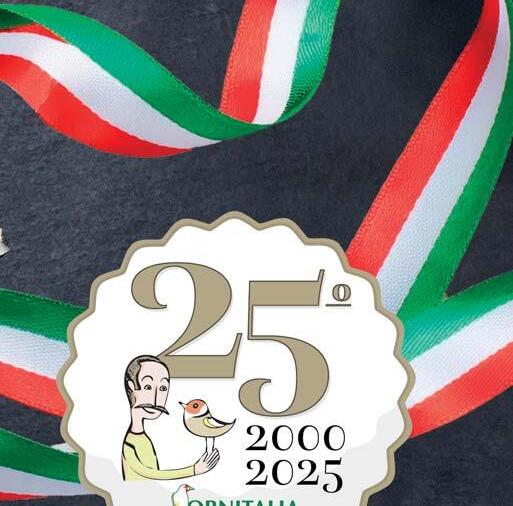



testo di IVANO MORTARUOLO, foto AUTORI VARI
Il Diamante di Kittlitz occupa una vasta area che, partendo da est della linea (immaginaria) di Wallace, comprende le isole Sulawesi, Molucche, Caroline, Salomone, Nuove Ebridi, arcipelago di Bismarck, Nuova Guinea e Australia (segnatamente la penisola di Capo York). È dunque un areale di miglia di chilometri, costituito per buona parte da gruppi insulari, che verosimilmente è il più vasto rispetto a quello che caratterizza le altre specie ascritte allo stesso genere. Le sue numerose sottospecie dimostrano un’apprezzabile somiglianza che si esprime pure con lievissime diversità morfologiche, cromatiche ed etologiche, anche se, in alcuni casi, sono state evidenziate divergenze genetiche di una certa rilevanza.
Premettendo che gli esponenti del genere Erythrura sono molto similifenotipicamente, forse perché il loro percorso evolutivo è stato “breve” e meno articolato (la loro origine è abbastanza

di Kittlitz, foto F.O.I.


Gli esponenti del genere Erythrura sono molto simili fenotipicamente

“recente”, in quanto risalirebbe a circa 6,4 milioni di anni fa), è ipotizzabile che l’“omogeneità” della trichroa, nelle sue numerose popolazioni,sia derivata anche dal fatto che è la più giovane fra i
congeneri e che quindi ha subito sviluppi più limitati e forse lineari. Il comportamentodi questo uccello è caratterizzato da una plasticità trofica e da spinte nomadiche che gli consen-
tono sia di occupare eterogenei habitat (boschi di mangrovie, foreste di alta montagna, praterie, aree coltivate, giardini pubblici eccetera), sia di mantenere la propria popolazione su livelli non allarmanti, nonostante l’avanzata dei fenomeni antropici e la possibilità di eventi dannosi (si pensi, per esempio, a fenomeni atmosferici di una certa entità, soprattutto in circoscritte aree insulari).
Le denominazioni che sono state attribuite al volatile in numerose lingue fanno esplicito riferimento alla cromia della livrea, mentre, da quanto mi è dato sapere, solo in francese e in italiano vi è un chiaro richiamo al suo scopritore, del quale fornisco alcune sommarie notizie.


Friedrich Heinrich Freiherr von Kittlitz (1799-1874) era un tedesco di origine polacca che vantava nobili natali e che si distinse per le sue eclettiche attitudini. Egli fu infatti un ufficiale della Marina Militare, un esploratore, un ottimo pittore, un botanico e un ornitologo. Nel 1825 lasciò il servizio militare per unirsi, l’anno successivo, alla spedizione russa con la corvetta Senjawin, che circumnavigò il globo fino al 1829. Ebbe così occasione di reperire una gran mole di specimenzoologici e botanici, effettuando, tra l’altro, accurati studi sugli uccelli del Cile e raccogliendo e descrivendo anche due specie ornitiche che subito dopo furono dichiarate estinte. Mi riferisco al Colombo versicolore Columba versicolor (1832)e allo Storno nero Aplonis corvina (1833), originari dell’isola Kosrae (arcipelago delle Caroline).
Sempre in quell’isola, allora chiamata Ualan, vennero catturati alcuni piccoli passeriformi con il piumaggio caratterizzato sostanzialmente da tre cromie, che lo zoologo descrisse poi nelle Mémories de
Con questa tavola Friedrich Kittlitz corredò la sua descrizione del Diamante eponimo, pubblicata su Mémoriesdel’AcadémieImperialedeSciencesdeSant-Pétrobourg (vol. II, pagg. 8 e 9, tavola X, 1835)
l’Académie Imperiale de Sciences de Saint-Pétrobourg (vol. II, pagg. 8 e 9, tavola X, 1835), conferendo loro il nome scientifico di Fringilla trichroa (tri=tre, khroa=colore).
Kittlittz visitò Kosrae nell’inverno del 1827-1828 ed ebbe così modo di con-
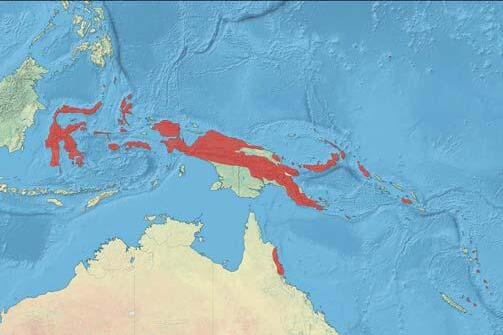
Aree di distribuzione del Diamante di Kittlitz, fonte iconografica: animalia.bio/it/blue-facedparrotfinch
statare che questo uccello sconosciuto, somigliante al Diamante pappagallo, era presente quasi ovunque, ma aveva un’indole diffidente e, quando s’involava perché spaventato, emetteva ripetutamente un verso che ricordava uno zitt zitt. Nella sua descrizione propose una sintetica rappresentazione delle caratteristiche fenotipiche, che qui di seguito riporto: becco nero, zampe carnicino chiaro, iridi marrone scuro, “il colore dominante del piumaggio di un bellissimo verde pappagallo che diviene più chiaro nel ventre, ma comunque lucente”; fronte, zona perioculare e guance di un blu oltremare, copritrici caudali superiori e coda rosso ruggine, remiganti bruno scuro con bordo gialloverde, coda a forma di aculeo. A corredo di questa descrizione, l’autore propose anche una tavola (la numero dieci) che, pur nella sua essenzialità, offre chiare indicazioni per la determinazione della specie. Gli esemplari dell’isola Kosrae sono considerati appartenenti alla sottospecie tipica, vale a dire l’Erythrura trichroa trichroa. Si dovette però attendere il 1850 per attribuire all’Estrildide l’attuale denominazione scientifica,su proposta del principe Carlo Luciano Bonaparte, nipote del famoso imperatore e grande studioso di ornitologia e di tassonomia (Conspectus Generum Avium – vol. I, pag. 457).
Tuttavia, prima che si affermasse stabilmente l’odierna nomenclatura, non mancarono le iniziative da parte di vari ornitologi. Cito alcuni sinonimi proposti: Estrelda trichura, Amadina trichroa, Acalantha kittlizii, Chloromunia trichroa, Erythrura trichros. Propongo ora una breve descrizione delle altre dieci sottospecie attualmente riconosciute (1) nel Diamante di

Kittlitz, rispettando l’ordine cronologico con cui le segnalazioni sono state pubblicate.
Sottospecie Erythrura trichroa modesta, descritta da Alfred Russel Wallace (18231913) su TheIbis (vol. IV,serie I, n. 16, pag. 351,1862). La località tipo (il luogo dove lo specimen è stato catturato e osservato, ovvero la località tipica della specie o sottospecie): Ternate (arcipelago delle Molucche Settentrionali). La segnalazione avviene in seno a una nota dal titolo On some Birds from the Northern Moluccas, in cui sostanzialmente è evidenziato che i lati del collo presentano una colorazione giallastra, le punte delle ali sono scure e le copritrici inferiori hanno cromie gialloarancio. Nelle femmine il rosso e il blu sono opachi e poco estesi. Le zampe sono di un rosso scuro.


Questa tavola costituisce la rappresentazione del primo esemplare della sottospecie
Successivamente Hernest Hartert (Novitates Zoologicae, vol.VII, n.1, pag.6, 1900), esaminando alcuni specimen acquisiti dal Tring Museum e provenienti dalle isole Ternate, Halmaheira e Bacan, ha avuto modo di confermare e integrare la descrizione di Wallace, evidenziando che: il verde è meno intenso e più giallastro, specialmente nelle aree sottostanti, le copritrici alari inferiori sono di un camoscio chiaro senza sfumature (frequenti invece nella sottospecie nominale), l’ala supera costantemente la lunghezza dei cm 60 (6265cm).
Erythruratrichroamacgillivrayi rinvenuto in Australia, fonte iconografica: Kershaw, 1918
che il verde e il rosso del piumaggio sono più chiari rispetto a quello del Diamante pappagallo Erythrura psittacea, mentre le guance e la fronte presentano un blu brillante (il nome specifico di cyanofrons evidenzia, appunto, tale peculiarità cromatica). Inoltre, viene rilevata la maggiore lunghezza delle due penne centrali della coda. La località tipo: Lifu (Isole della Lealtà).
Ulteriori rilevazioni hanno evidenziato che in questo taxon il blu della mascherina è meno esteso.
L’areale di distribuzione è sostanzialmente costituito dalle tre suddette isole insieme a quella di Tidore.
Sottospecie Erythrura trichroa cyanofrons (2), descritta da Edgar Leopold Layard (1824-1900) su The Annals and Magazine of Natural History (vol. I, serie V, pagina 375, 1878). Il testo è molto conciso e sostanzialmente indica

sottospecie in esame ha dimensioni ridotte rispetto alle woodfordi, modesta,trichroa e alla specie Erythrura papuana (allora considerata sottospecie), ma la colorazione è pressoché identica.
Per fornire ulteriori informazioni fenotipiche su questo taxon, attingo a un resoconto dell’ornitologo Hernest Hartert (Novitates Ornitologicae, volume VII, 1900), nel quale è indicato che la
Si dovette però attendere il 1850 per attribuire all’Estrildide l’attuale denominazione scientifica
L’areale comprende le Nuove Ebridi (Efate, Lopevi, Aoba, Tanna, Erro, Annitum, Vanuatu), Banks (S. Maria) e le isole della Lealtà (Maré e, naturalmente, Lifu o Lifou). Nell’isola di Vanuatu questa sottospecie convive con il Diamante reale Erythrura regia, creando un rapporto che, a seconda della collocazione delle due popolazioni, potrebbe essere definito di parasimpatria o di simpatria. Le due specie, infatti, d’ordinario occupano due habitat differenti e diversi sono anche gli orientamenti trofici. La cyanofrons è presente nelle savane, piantagioni, giardini, ai bordi delle foreste e in altre aree aperte collocate dal livello del mare fino a m.1.200 di altitudine. La sua alimentazione è in prevalenza costituita da semi di un eterogeneo numero di piante erbacee, integrata, verosimilmente durante l’allevamento dei piccoli, da insetti. Il Diamante reale ha invece una natura timorosa e schiva che lo spinge a vivere nelle foreste umide di alta montagna, anche se è stato avvistato in altri habitat come, ad esempio, nei pressi di villaggi, piantagioni e savane. Diversa è anche la sua dieta di base, costituita da fichi e, in piccola parte, da insetti trovati all’interno o in prossimità di tali infiorescenze. Dunque, fra le due specie non dovrebbero esserci competitività.
Sottospecie Erythrura trichroa sigillifera, descritta da Charles Walter De Vis (1829-1915) su The Ibis (vol. III, serie VII, pagg. 389-390, 1897), attribuendo il nome di Lobospingus sigillifer. Con questa segnalazione, inserita in un resoconto sui rari uccelli della Nuova Guinea Britannica (attualmente corrisponde alla fascia meridionale
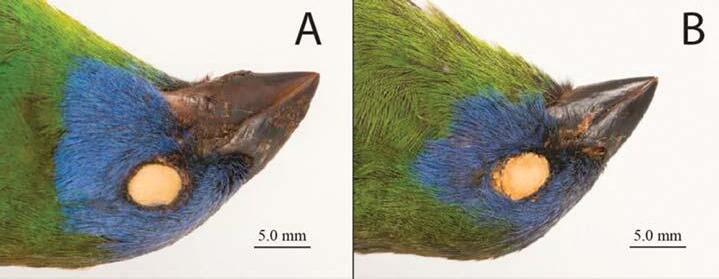
della Papuasia Nuova Guinea), l’autore istituisce un nuovo genere e una nuova specie, ma non dà alcuna indicazione del locus typicus. Al che, diversi studiosi ipotizzano che possa essere il monte Scratchley (sud-est della Papuasia Nuova Guinea), ma questa indicazione geografica non è attendibile perché è riportata dall’autore solo nella descrizione relativa al Diamante di monte, con il nome di Oreospiza fuliginosa (l’attuale denominazione scientifica è Oreostruthus fuliginosus).
Per quanto attiene alla scelta del nome specifico (detto anche epiteto), sigillifera, si è concordi nel ritenere che l’etimologia vada ricercata nelle parole latine sigillum (segno, immagine) e ferre (portare), forse per evidenziare la peculiarità e regolarità della mascherina blu. Questa mia ipotesi potrebbe essere suffragata dal fatto che De Vis, nel proporre la denominazione del nuovo genere Lobospingus (lobos= lobo; spingos=fringuello, uccello),potrebbe anche aver fatto riferimento al disegno della testa osservando il volatile lateralmente. Detto altrimenti, guardando la testa da entrambe le parti si ha l’impressione che vi siano due lobi. L’autore ha descritto questa sottospecie esaminando uno specimen conservato sotto spirito. L’areale comprende la Nuova Guinea e le isole dell’arcipelago di Bismarck. Questa sottospecie convive in alcune aree con il Diamante papuano Erythrura papuana, ma non è ben chiaro il rapporto che può intercorrere fra i due taxa (simpatria, parapatria eccetera); sta di fatto che in alcuni casi si incon-
trano e risulta molto difficile delinearne l’identificazione. Infatti, la livrea è pressoché uguale, mentre diversa è la taglia e la grandezza del becco, a favore della papuana. Tuttavia, più delineati sembrano alcuni aspetti etologici come la scelta degli ambienti e l’orientamento trofico. Ma recenti studi sul DNA mitocondriale (DeCicco et alii: New Guinea Erythrura parrotfinches: one species or two? 2020) hanno messo in luce che, a una rilevante somiglianza fenotipica, fa riscontro anche un “uguaglianza” genetica. Successivi approfondimenti (DeCicco et alii: A complete species-level phylogeny of the Erythrura parrotfinches -Aves: Estrildidae- 2023), con analisi genomiche nucleari, hanno confermato che non si tratta di due differenti unità tassonomiche, bensì la papuana potrebbe costituire un morfismo locale della sigillifera. Ulteriori riscontri si renderanno necessari, intanto nelle check-list si continua a considerare distinti i due taxa.
Sottospecie Erythrura trichroa woodfordi,descritta da Hernest Johann Otto Hartert (1859-1933) su Novitates Ornitologicae (vol.VII, pag.7, 1900). La scelta del nome specifico non è casuale in quanto vuol esprimere stima
L’areale si estende per diverse migliaia di chilometri
e riconoscenza a Charles Morris Woodford (1852-1927), un naturalista e filatelico che per otto anni fu commissario del Protettorato delle Salomone. Questi, forse grazie al potere di cui poteva disporre, fu in grado di cedere alla Collezione Rothschild due specimen di femmine: uno catturato il 30 giugno del 1887 e l’altro il 5 giugno dello stesso anno, entrambi provenienti da Aola (Guadalcanal, arcipelago delle Salomone).
Nella sua descrizione, l’autore non indica il cosiddetto olotipo, vale a dire non sceglie l’esemplare più rappresentativo della sottospecie in esame, ma si limita a riferire che le due femmine, conservate nel Tring Museum (fondato da Lord Lionel Walter Rothschild), hanno ali lunghe cm 63-64. Mentre, per quanto riguarda la morfologia, ritiene che siano simili alla sottospecie nominale, anche se differiscono per la fascia frontale più stretta e forse per la maggiore lunghezza delle remiganti.
Alla suddetta omissione Hartert rimedia con una successiva pubblicazione del 1919, sempre su Novitates Ornitologicae (volume XXVI, pag.142), nella quale indica che lo specimen più rappresentativo è quello catturato il 30 giugno 1887 (lectotipo), conseguentemente all’altro spetta solo il ruolo di paralectotipo (3), il cui scopo è di fornire un’idea della variabilità esistente all’interno del taxon. Questa sottospecie è presente nelle isole Salomone.
Sottospecie Erythrura trichroa macgillivrayi, descritta da Gregory Macalister Mathews (1876-1949) su Austral Avian Record (vol. II, n. 5, pag. 103,1914). Località tipo: erroneamente riportato Claudie River mentre è esatta l’indicazione di isola di Lloyd (Queensland nordorientale). La storia del riconoscimento di questa sottospecie ci viene in parte raccontata dal curatore del Museo Nazionale di Melbourne, signor J. A. Kershaw (The Emu, vol. VIII, parte I, pag. 1, 1918). Nel marzo 1891 il suddetto Museo ricevette dal signor F. Ayres uno specimen raccolto nel 1890 nel Queensland settentrionale. Inizialmente si credette che potesse trattarsi di un esemplare

ascritto alla sottospecie cyanofrons, ma dubbi sulla sua realeprovenienza imposero di non registrare il reperto. Nel 1914 il dott William Macgillivray era in compagnia del signor William Mc Lennan lungo un bosco di mangrovie, nell’isola di Lloyd, quando nel giorno 11 gennaio quest’ultimo uccise un uccello molto somigliante all’esemplare presente in tale Museo. Fu così che Mathews, avendo compreso che trattavasi di un taxon sconosciuto, nello stesso anno si “affrettò” a segnalarlo al mondo scientifico, attraverso la nota Additions and corrections to my list of the birds of Australia pubblicata sulla suddetta rivista Austral Avian Record,ma sbagliò il luogo di provenienza. L’autore prese le distanze dalle ipotesi iniziali di un possibile cyanofrons, evidenziandone le differenze che si possono compendiare nel becco più grande, la colorazione più scura della fronte e delle guance, le copritrici caudali superiori e la coda di un colore più intenso e le ali di dimensioni maggiori. Indica inoltre che gli esemplari provenienti dalla Nuova Guinea Britannica, attualmente inseriti nella sottospecie sigillifera, sembrano simili, ma il blu della fronte si estende fino alla sommità della testa nella forma australiana. L’autore, per evidenziarne maggiormente la peculiarità geografica, propone anche il nome volgare di Australian Green-backed Finch Non sorprende quindi che l’epiteto sia dedicato al dott. Macgillivray. L’areale è circoscritto alla parte nordorientale della penisola di Capo York. Va tuttavia rilevato che, nonostante la convinta determinazione geografica e tassonomica di Mathews, l’autorevole biologo evoluzionista Ernest Mayr (1904-2005) ritenne che questo taxon sostanzialmente non differiva, per struttura e per peculiarità cromatiche, dalla popolazione della Nuova Guinea meridionale e, quindi, propose di riunire i due gruppi nella sottospecie sigillifera (American Museum Novitates, n. 489, pagg. 1-10, 15 settembre 1931). Valutazione questa condivisa da molti studiosi. Comunque, in tempi recenti, alla macgillivrayi è stata restituita l’autonomia tassonomica, in attesa di ulteriori approfondimenti genetici e anche in
Mathews, per evidenziarne maggiormente la peculiarità geografica, propone anche il nome volgare di Australian
Green-backed Finch
considerazione della sua scarsa presenza in natura e delle insufficienti conoscenze ecologiche finora acquisite. Prima di concludere la trattazione di questa sottospecie, desidero evidenziare che l’iperattivo e “inquieto” Mathews propose anche la sostituzione del genere Erythrura con Chloromunia (Austral Avian Record - vol. V, parte 2-3, pag.40, 1923), conseguentemente il volatile in esame assunse la denominazione di Chloromunia trichroa. Ma tale iniziativa non fu sostenuta dal mondo scientifico.
Sottospecie Erythrura trichroa pinaiae, descritta da ErwinFriedrich Teodor Stresemann (1889-1972) su Novitates Ornitologicae (vol. XXI, pag. 147, 1914). Località tipo: Gunung Pinaia (isola di Seran). Risulta evidente che l’epiteto fa esplicito riferimento al luogo in cui il volatile è stato trovato. L’olotipo è costituito da un maschio, catturato il 18 agosto 1911, a cui è stato attribuito il n. 876 di registrazione nella Collezione Rothschild (Tring Museum). L’autore segnala che il taxon differisce dalla papuana (allora non considerata specie) e dalla modesta sia per le sfumature bluastre del piumaggio verde, sia perché i bordi esterni delle secondarie assumono una colorazione grigio-blu e non verde. Vive nelle Molucche meridionali (Seran, Buru)
Sottospecie Erythrura trichroa pelewensis, descritta da Nagamichi Kuroda (1889-1978) su Momiyama, “Birds of Micronesia” (pag. 27, 1922). Località tipo: isole Palew (anche dette





Questo cladogramma (parziale) evidenzia che il Diamante di Kittlitz è sia coevo del Diamante papuano sia il più recente rispetto alle altre Erythrure. Per il rapporto fra i due taxa si veda la trattazione relativa alla sottospecie sigillifera, fonte iconografica: Olsson e Alström, 2020
Palau). Fu catturato un sol esemplare e ricerche effettuate nel 1945, sull’area meridionale dell’isola di Palau, non diedero alcun risultato (si suppone che qualche soggetto potrebbe aver trovato rifugio nelle foreste di montagna).
L’epiteto fa esplicito riferimento al luogo in cui lo specimen è stato catturato.
Nella sua descrizione, l’autore riferisce che il nuovo taxon rassomiglia alla sottospecie nominale, ma se ne differenzia per il becco più spesso e robusto, per la maschera con blu deciso, per le parti inferiori più chiare e sfumate di blu. Inoltre, dal groppone alle copritrici caudali superiori il rosso diviene brillante (anziché cremisi opaco), le penne caudali centrali sono rosso brunastro (anziché cremisi opaco), la coda e le ali sono più lunghe. Dall’esame morfometrico di alcuni elementi (ala, coda, profilo della mascella e tarso) dell’unico esemplare esaminato da Kuroda, è emerso che è più grande della sottospecie nominale.
Questo taxon è ritenuto endemico delle Isole di Palau.
Sottospecie Erythrura trichroa eichhorni, descritta da Hernest Johann Otto Hartert (1859-1933) su Novitates Ornitologicae (vol. XXXI, pagg. 274275, 1924). Località tipo: isola di S. Matthias (arcipelago di Bismarck). L’olotipo è un maschio catturato il 5 luglio 1924 al quale è stato attribuito il numero 8635 di registrazione (Colle-
zione Rothschild). Tale esemplare faceva parte di un gruppetto di sei soggetti adulti (quattro maschi e due femmine) e due giovani provenienti, appunto, da S. Matthias, ai quali si aggiunsero altri due giovani prelevati invece dall’isola di Squally o Storn. I rimanenti nove soggetti, escludendo l’olotipo, costituiscono i paratipi. Tali esemplari vennero forniti dall’australiano Albert F. Eichhorn (1868-1933), un mercante di reperti zoologici che, grazie alla sua partecipazione a spedizioni nella Nuova Guinea, isole Salomone, Nuova Irlanda e Nuova Britannia, fu in grado di fornire il Tring Museum di numerosi specimen sconosciuti. Quindi, a lui è dedicato il nome specifico di questo taxon e di altri. Questa sottospecie è simile alla sigillifera, ma se ne differenzia per il blu più tenue e, soprattutto nei maschi, per la sua estensione che supera il vertice. Inoltre, rispetto alla cyanofrons, il becco è meno spesso e più lungo. È endemica del gruppo di isole di S. Matthias (arcipelago di Bismarck).
Nella sua descrizione, Stresemann riferisce che il nuovo taxon è simile alla modesta e alla sigillifera
Sottospecie Erythrura trichroa sanfordi, descritta da Erwin Friedrich Teodor Stresemann (1889-1972)su Ornithologische Monatsberichte (vol. XXXIX, pag.12, 1931). Località tipo: versante occidentale dei monti Latimodjong (isola Celebes, ora chiamata Sulawesi).
Anche in questo caso il nome specifico è dedicato a una persona. Si tratta infatti del chirurgo e zoologo Leonard Cutler Sanford (1868-1950), possessore di una rilevante collezione di uccelli tassidermizzati e collaboratore dell’American Museum of Natural History.
Nella sua descrizione, Stresemann riferisce che il nuovo taxon è simile alla modesta e alla sigillifera ma è sorprendentemente diverso il becco che, pur essendo della stessa lunghezza, è alto e largo alla base, ricordando quello della papuana (allora non considerata specie). Inoltre, rispetto alle suddette sottospecie, nel maschio le aree inferiori sono più chiare, tendenti al giallino, mentre il blu della parte anteriore e laterale è violaceo. Dal confronto, anche le ali sono diverse poiché più lunghe.
Sin qui l’autore. Successive osservazioni hanno evidenziato che questo taxon è endemico dell’isola Sulawesi.
Sottospecie Erythrura trichroa clara, descritta da NobusukeTaka-Tsukasa (1889-1959) e Yoshmaro Yamashina (1900-1989) su

Tori (vol. 7, pag. 109-110, 1931). Località tipo: isola di Truk (arcipelago delle Caroline). Molto verosimilmente l’attribuzione dell’epipeto clara è stata suggerita dal fatto che questa sottospecie presenta cromie più chiare. Infatti, rispetto alla sottospecie nominale, ha aree inferiori giallastre e meno verdi, il blu della testa è leggermente pallido e i lati del collo sono fortemente infiltrati di giallo tendente al dorato. Dal punto di vista morfologico i due taxa sono pressoché uguali. L’areale comprende le isole di Truk (anche dette Chuuk) e di Senyavin (la maggiore è Ponape).
Di questo volatile tendenzialmente elusivo vengono fornite poche e frammentarie informazioni, pertanto mi limito a proporre solo qualche curiosità. John Brandt, in una sua monografia sui nidi e le uova degli uccelli di Truk (1962), ha osservato che in diversi nidi di clara le uova erano scurite e presen-
tavano spruzzi di fango; ma l’autore non seppe comprenderne la causa, poiché, dalle sue osservazioni, i volatili non utilizzavano il fango per la relativa costruzione e non esercitavano tale attività con piumaggio bagnato. Nel 1930 lo zoologo Coultas raccolse nell’isola di Ponape vari specimen e, nel contempo, scoprì che i Giapponesi catturavano questi uccelli per poi spedirli nel proprio paese come animali ornamentali. Non si hanno notizie sul periodo in cui tale prelievo in natura fosse iniziato. Mentre è documentato che la prima importazione in Europa, esattamente in Germania, avvenne nel 1886 e l’anno seguente si registrarono già i primi risultati riproduttivi. In alcuni casi il successo fu talmente eclatante che si ottennero anche otto generazioni (Rugers, Encyclopédie de l’amateur d’oiseaux, 1966-1970).
Colgo l’occasione per segnalare un’ipotesi, abbastanza condivisa, secondo la
quale buona parte della popolazione domestica degli attuali Diamanti di Kittlitz sarebbe originata da esemplari ascritti alla sottospecie cyanofrons.

Ricerca effettuata per conto della Parrot Finches European Club
NOTE
(1) Prendo come riferimento la IOC World Bird List versione 15.1 del 20 febbraio 2025
(2) Questo è l’esatto epiteto proposto da Layard nella sua descrizione, che tuttavia ha subito leggere variazioni nel corso degli anni. Cito due esempi: cyanifrons (Hartert,1900) e cyaneifrons (Mayr, 1931).
(3) Qualora nella descrizione di una nuova specie o sottospecie, l’autore ometta di indicare l’olotipo, vale a dire l’elemento più rappresentativo, è possibile rimediare con una successiva designazione. Ma in questo caso lo specimen acquista la denominazione di lectotipo (dal greco: lektos= selezionato, scelto; typos=modello) e gli eventuali altri tipi diventano paralectotipi







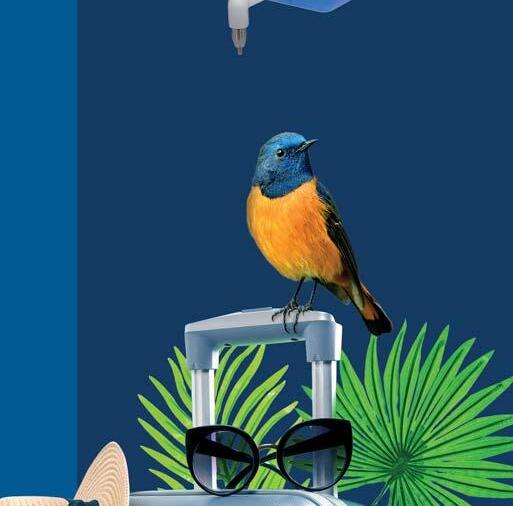




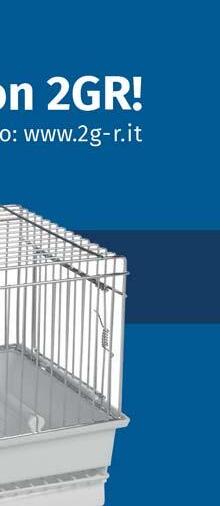

testo di RAFAEL ZAMORA PADRÓN (*), foto M. Perez (LPF)



Platycercusicterotis, foto: M. Perez (LPF)
In questo periodo dell’anno ci concentriamo sulla riproduzione dei pappagalli e per questo motivo è



(*)Direttore Scientifico Fondazione Loro Parque

Con la primavera ci sarà stato un aumento dell’attività degli uccelli, dobbiamo prevedere alcuni cambiamenti
molto importante non dimenticare gli aspetti della loro biologia che sono comuni a tutte le specie di psittacidi. Considerando che con l’arrivo della primavera ci sarà stato un aumento dell’attività degli uccelli, dobbiamo prevedere alcuni cambiamenti che facilitino lo svolgimento di diverse attività nell’arco della giornata. Una






La ricerca del cibo diventerà ancora più importante quando la femmina inizierà la cova
delle più importanti è la ricerca del cibo, che diventerà ancora più importante quando la femmina inizierà la cova. Dobbiamo fare in modo che il maschio sia impegnato a cercare cibo per aiutare la compagna. In caso contrario, in molte specie i maschi trascorrono il loro tempo cercando curiosamente di impedire alla femmina di lasciare il nido. Ciò si verifica nelle specie più aggressive, nelle coppie giovani, nelle coppie appena formate o in quelle poco compatibili. Per risolvere questi problemi dobbiamo tenere conto del comportamento alimentare tipico della specie. I pappagalli devono essere impegnati a cercare, trovare, trasportare e man-

giare cibo, lontano dagli altri uccelli e perfino dai loro partner.
Per raggiungere questo obiettivo è bene seguire questi consigli:
-Mettere il cibo in posti insoliti. Cibo verde (erbe annuali, broccoli, bietole, lattuga, tarassaco, centocchio, ecc.) disposto in diversi punti della voliera.
-È possibile ridurre le quantità offerte nelle mangiatoie ma al contempo aumentare i rifornimenti giornalieri.
-Fornire una riserva di erbe annuali piantate, di cui i pappagalli dovrebbero trovare i frutti e poter consumare le foglie o i fiori.
-Avere dispositivi di arricchimento ambientale che richiedano uno sforzo da parte del pappagallo per ottenere la ricompensa alimentare. Per ottenere lo stimolo, bisognerebbe somministrarli in giorni diversi.
I pappagalli devono essere impegnati a cercare, trovare, trasportare e mangiare cibo, lontano dagli altri uccelli
-Una volta che i pulli sono nati, aumentate l’offerta di cibo in diversi punti della voliera.
-Piantare delle erbe aromatiche sul pavimento della voliera e gettare bacche o semi in modo che gli esemplari possano trovarli.
-Posizionare sul fondo della voliera un vassoio con torba e semi interrati.
I problemi più comuni all’inizio della fase riproduttiva sono legati all’inces-
sante ricerca delle femmine da parte dei maschi. Questo comportamento può indebolire la femmina, che smette di mangiare pacificamente quando viene molestata dal compagno.
Se si rifugia nel nido, un maschio inesperto potrebbe costringerla a rimanere dentro.
Questo tipo di comportamento può culminare in un’aggressività da parte del maschio quando la femmina reagisce in modo impetuoso o quando è già troppo debole per difendersi. La distrazione naturale dei maschi, data dai compiti di ricerca del cibo da offrire in seguito a una femmina in fase di corteggiamento o di cova, consente una riproduzione più fruttuosa. Se la femmina viene aiutata fin dall’inizio, non soffrirà di carenze nutrizionali, la fertilità delle sue uova aumenterà e il tasso di sopravvivenza dei pulli migliorerà.





Razza
anellino tipo Y (nuova tipologia di anello inamovibile F.O.I.)
Sappiamo tutti che nei Canarini Forma e Posizione Lisci, la razza Rheinlander appartiene ai canarini di razza leggera, e che attualmente l’anellino calzante è di tipo A diametro 2,4. Tuttavia, nonostante abbia mantenuto la stessa taglia, è stato verificato da molti allevatori che negli anni la zampetta è diventata più robusta, causando difficoltà nell’anellare i soggetti nei tempi dovuti.
Quindi, dal Club è stata avanzata la proposta di modifica alla CTN CFPL per aumentare il diametro dell’anellino. La Commissione Tecnica Nazionale, dopo attenta valutazione della richiesta e verifiche in allevamenti di allevatori che selezionano la razza Rheinlander e in occasione delle Mostre Ornitologiche sia Nazionali che Internazionali, ha deciso di accettare la proposta e avanzare richiesta al Consiglio dell’Ordine dei Giudici per l’adozione dell’anellino superiore tipo Y con diametro 2,7, anziché tipo A diametro 2,4. La proposta, accolta dal Consiglio dell’Ordine dei Giudici, è stata ratificata dal CDF della FOI e entrerà in vigore a partire dall’anno 2026. Quindi, per gli allevatori di questa razza, la richiesta degli anellini, potrà essere effettuata dal 15 luglio 2025, in concomitanza con la nuova campagna di iscrizione per l’anno 2026.


A sinistra: Gabbia - altezza cm. 35, lunghezza cm. 26, larghezza, profondità cm. 16 Due posatoi rotondi di mm.10 posti, rispettivamente, uno in alto, al centro, a cm. 20 circa dalla sommità e l’altro in basso, dove sarà posizionato il beverino, alla quarta sbarra, a lato contro laterale presenza della sola mangiatoia.
A destra: particolarità della testa
Rheinlander - Origine: Germania
Commenti e procedura di giudizio
Come tutte le razze prettamente con posizione eretta, il Rheinlander per essere adeguatamente valutato, deve essere posto su un tavolo alto ed il giudizio inizierà solamente quando avrà guadagnato il posatoio alto e ricomposto il piumaggio. Sono ammessi soltanto soggetti interamente unicolore lipocromici (Giallo – Rosso – Bianco, Intensi e Brinati). Ed è tollerata, soltanto nei soggetti ciuffati, una screziatura, purché non si prolunghi oltre la nuca e sul collo. Anche becco e zampe devono essere interamente chiari, quindi privi di tracce melaniniche. Non sono giudicabili soggetti di colore diverso dal Giallo, dal Rosso, dal Bianco unicolore o che presentano screziature sulla testa nella varietà testa liscia. Non è giudicabile un Rheinlander con screziature che debordano dalla nuca. Non sono giudicabili soggetti con tracce di melanina sul becco e sulle zampe. Non sono giudicabili i soggetti che superano i cm.14 in quanto fuori standard. Tavolo di giudizio alto con l’obbligo di giudicare in piedi
Anello F.O.I. tipo “Y”
Sono ammessi solo i colori giallo e bianco unicolore
È ammessa la colorazione artificiale
Rheinlander p.
Ciuffo e Testa 20
Corpo 20
Posizione 20
Taglia 15
Piumaggio 10
Zampe 5
Coda 5
Condizioni 5
Totale 100


Standard analitico
Testa e Ciuffo punti 20
Ciuffo a forma di ‘’ferro di cavallo’’ che, lasciando libero metà occhio scende fin quasi alla punta del becco, più pronunciato sul davanti e meno sui lati e che deve terminare appena dopo gli occhi, essendo auspicata l’assenza del ciuffo sulla nuca.
Il punto centrale, dal quale si origina il ciuffo, deve essere netto e posto al centro della testa.
Nel Ciuffo è tollerata la presenza di piume di altro colore dal lipocromico e dal bianco, preferibilmente non monocromatiche ma variegate, la cosiddetta ‘’screziatura del ciuffo’’, che in ogni caso non devono superare la zona topografica della nuca. Pena la non giudicabilità.
Nei soggetti senza ciuffo, la testa deve essere abbastanza ampia, leggermente piatta e con visibili sopraccigli e non è ammessa la screziatura, pena la non giudicabilità.
Difetti
Ciuffo che si estende sulla nuca.
Ciuffo non centrato.
Ciuffo che copre interamente occhi e becco.
Screziatura del ciuffo che si estende anche dopo la nuca, comporta la non giudicabilità.
Testa non abbastanza ampia.
Testa arrotondata.
Sopraccigli non visibili nei soggetti a testa liscia. Screziatura sul testa liscia comporta la non giudicabilità.
Corpo punti 20
Corpo minuto, Sottile, slanciato ed elegante. Il petto ed il dorso, dopo l’attaccatura con il collo che deve apparire visibile, pieno e rientrante alla sua base, devono essere leggermente prominenti, arrotondati e devono, gradatamente, assottigliarsi verso la coda.
Attaccatura delle ali appena visibile.
Difetti
Corpo grossolano e tozzo, che non si assottiglia verso la coda.
Collo tozzo senza rientranza alla base. Petto e dorso senza o con eccessiva prominenza, né arrotondati.
Attaccatura delle ali molto visibile.
Posizione punti 20
La posizione deve essere di circa 80° con coda perpendicolare; pertanto, la forma che ne risulta è lie-

vemente arcuata.
Difetti
Posizione non eretta.
Posizione non arcuata.
Soggetto troppo vivace che non va in posizione.
Taglia punti 15
Taglia massima consentita cm. 12.
Difetti
Taglia superiore a quella indicata. Sono da considerare atipici quei soggetti che hanno una taglia superiore a cm. 14.
Piumaggio punti 10
Liscio e ben aderente al corpo.
I colori ammessi sono il bianco ed il giallo ed è consentita la colorazione artificiale.
Difetti
Piumaggio scomposto, abbondante e non aderente al corpo.
Remiganti e timoniere spezzate, sfrangiate e rovinate.
Zampe punti 5
Zampe fini, sottili e leggermente flesse.
Tibie leggermente visibili.
Difetti
Zampe grossolane e rigide.
Tibie eccessivamente visibili o non visibili.
Coda punti 5
Coda perpendicolarmente portata al posatoio, stretta, compatta e leggermente forcuta all’estremità.
Difetti
Coda larga, non forcuta all’estremità ed in linea con il corpo.
Condizioni punti 5
Massima igiene e pulizia.
Se sottoposto a colorazione artificiale, la stessa deve essere uniformemente distribuita su tutto il piumaggio.
Difetti
Soggetto sporco, zampe scagliose o sudice.
Colorazione artificiale non uniforme.





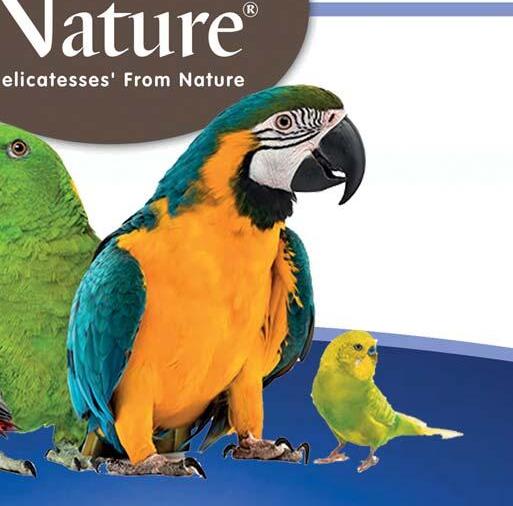




Pianta mellifera dal nome “festaiolo” e da sapori e profumi divisivi
testo di PIERLUIGI MENGACCI, foto AUTORI VARI
Premessa
Ogniqualvolta leggevo il nome Coriandolo, nell’elenco dei semipresenti in alcuni mix dei così detti “semi della salute o condizionatori”, mi sorgeva un forte desiderio misto a curiosità di conoscere il perché di questo nome così “festaiolo” e quale attinenza avesse con i “coriandoli di carta”, nonché quali benefici apportassero i suoi semi. Ma desiderio e curiosità scomparivano una volta deposto il sacchetto dei semi nell’armadietto dell’allevamento.
Anni or sono, in un supermercato di Pesaro, mentre cercavo nello scaffale delle spezie, disposte in ordine alfabetico, i chiodi di garofano, il mio sguardo si fermò sulla scritta “Coriandolo” in un vasetto di vetro lì vicino… La curiosità era forte. Prendo in mano il vasetto: è pieno di semi marroncino chiaro. Il pensiero va subito al coriandolo del mix di semi per i canarini e mi stupisco nel vederli anche tra le spezie! Leggo le poche righe nell’etichetta e il “profumo etnico” suggerito su alcune pietanze colpisce la mia immaginazione… Nel mio subconscio nasce subito una nuova curiosità culinaria e, al contempo, riemergono i desideri e le curiosità “lasciati nell’armadietto dei canarini”. Depongo il vasetto nel carrello e dico fra me e me: “Questa è la volta buona, Gigi, per soddisfare non solo la tua curiosità culinaria di profumi etnici ma anche, finalmente, per toglierti la voglia di conoscere questa pianta-spezia dal nome festaiolo: il Coriandolo!”.



Dal libretto dei miei appunti orto-ornitofili e non solo
Curiosità storiche e non solo Nel mio peregrinare fra testi di cucina, di erbe officinali, selvatiche, canaricoltura, su internet ecc. sono venuto a conoscenza che il coriandolo è da sempre considerato una spezia tra le più antiche conosciute al mondo. Infatti, viene coltivata da più di 3000 anni e si trova ci-

www.actaplantarum.org ,



tata nei papiri Egizi, negli scritti degli antichi autori Greci e Romani, nelle Sacre Scritture e in tutti i testi di botanica medioevale. Il suo utilizzo come pianta aromatica e medicinale risale al tempo dei Miceni e degli Egizi, i quali in alcune tombe lo raffiguravano come offerta votiva. Presso i Romani, oltre all’uso terapeutico riportato da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia (“semi per espellere i vermi intestinali, foglie contro ulcere, febbri terzane e colera; semi sotto il cuscino durante la notte per far sparire il mal di testa e alleviare la febbre”), il Coriandolo veniva impiegato anche per uso gastronomico; Apicio lo metteva in quasi tutte le sue ricette e consigliava il coriandratum come condimento per varie pietanze. Inoltre, i semi del Coriandolo pestati e miscelati con sale e aceto venivano usati come conservanti per carni, pesce ed altri cibi.
Si deve ai Romani la sua diffusione in tutta Europa e fu una delle prime spezie ad arrivare in America.
Nel Medioevo veniva usato anche per aromatizzare la birra. Per la medicina antica fu una pianta contraddittoria: alcuni consideravano il Coriandolo velenoso, altri lo ritenevano persino un farmaco portentoso per guarire la peste e l’epilessia e per rendere indolore il parto; c’era chi lo reputava pianta afrodisiaca e chi temperativa per la sua
azione benefica sulla funzione digestiva e sulla motilità gastrointestinale. Presso i popoli Arabi la pianta del Coriandolo è tutt’oggi di uso quotidiano, sia medicinale che gastronomico, e altrettanto nei paesi asiatici o latino-americani, dove è ampiamente usato.
Una mia curiosità, come detto in premessa, riguardava la correlazione tra i semi del Coriandolo e i piccoli cerchietti di carta colorata che vengono lanciati durante il Carnevale, i compleanni e altre feste. Ebbene, questo nome “festaiolo” ha origine dal Rinascimento, quando durante il Carnevale venivano lanciati alla folla i semi del coriandrum glassati con lo zucchero e colorati a mo’ di confetti.
Altra curiosità: il Coriandolo è sempre stato considerato una piantadai sapori e profumi divisivi, quasi da odio e amore (vedi sopra). Il fatto sembra sia dovuto ad un ricettore olfattivo particolarmente sensibile alle aldeidi presenti nelle foglie e nei semi verdi di quest’erba aromatica, per cui molte persone, oltre alla percezione del cattivo odore di cimice, avverte anche un sapore sgradevole di sapone o addirittura di vomito; altre persone, invece, percepiscono un profumo floreale e muschiato e un sapore gradevole fresco leggermente pepato e dolce, che ricorda la buccia d’arancia ed altre essenze.



Alcune ricerche riportano che i maggiori “odiatori” del coriandolo sono gli asiatici (21%), gli europei (17 %), gli africani (14%), l’Asia Meridionale, l’America latina e Medio Oriente (3-7 %) e che le donne lo detestano più degli uomini. In Italia è principalmente considerata una spezia esotica, molto “pungente” ed è presente soprattutto in piatti tipici.
Descrizione del Coriandolo (Coriandrum sativum)
Il Coriandolo è una pianta erbacea annuale appartenente alla grande famiglia delle Apiaceae (o Ombrellifere) dove troviamo presenti anche la carota, il prezzemolo, l’anice, l’aneto, il cumino, il finocchio sia coltivato che selvatico. Originaria del Mediterraneo orientale, è presente e coltivata in tutte le zone temperate della terra. In Italia è presente in quasi tutto il territorio nazionale come specie naturalizzata sfuggita alla coltura, così come in tutto il bacino
È conosciuta anche come prezzemolocinese
mediterraneo, in Asia e in America. In alcune regioni, quali Emilia-Romagna, Puglia, Marche, Toscana, Veneto in questi ultimi anni la coltivazione di questa pianta è in forte aumento, cosa dovuta soprattutto all’esportazione dei suoi semi, di cui l’Italia è diventata leader a livello globale, soprattutto per la sua elevata qualità.
È conosciuta anche come prezzemolo cinese, perché molto utilizzato in quel Paese, oppure con il nome spagnolo cilantroed anche comeerba cimicina. Botanicamente la pianta è caratterizzata da una radice sottile rizomatosa e da fusti eretti alti fino a mezzo metro e oltre, a seconda della zona, con la parte
superiore ramificata. Ogni fusto è ricoperto da foglie basali picciolate provviste di gambo e quelle cauline sono sottili senza gambo e frastagliate alla sommità. Sono di un bel verde brillante e spesso vengono confuse con quelle del prezzemolo. La fioritura avviene in primavera-estate e le infiorescenze sono a forma di ombrella con fiori bianchi o bianco-rosato. I frutti sono degli acheni sferici con scanalature che, quando sono essiccati, sembrano vuoti. L’origine della parola coriandolo deriva dal latino coriandrum, a sua volta derivante dalla parola greca “corys” o “korios” (cimice), seguita dal suffisso “ander” (somigliante), riferito allo sgradevole odore che emana la pianta fino al periodo della maturazione dei frutti, simile a quello delle cimici (per questo motivo, come detto, la pianta è conosciuta anche come erba cimicina); il nome specifico “sativum” significa “coltivato”.
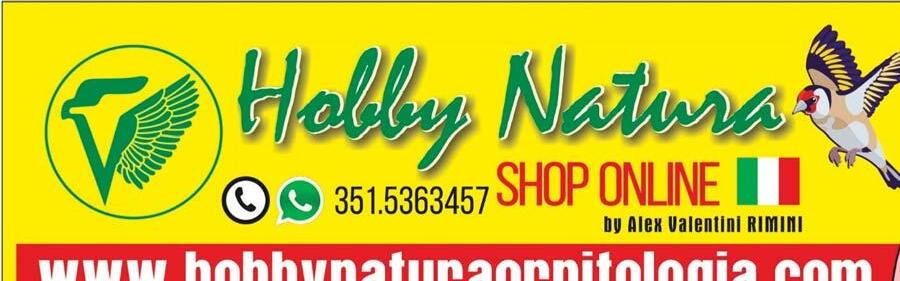




Proprietà ed utilizzi
Della pianta del Coriandolo vengono utilizzati soprattutto i frutti e le foglie essiccati, molto meno lefoglie fresche più piccanti, che invece sono molto apprezzate soprattutto in Oriente (da qui il nome di prezzemolo cinese).
Le foglie ed i semi di Coriandolo, come già scritto in precedenza, erano già noti nell’antichità grazie ai loro valori nutrizionali e alle loro proprietà terapeutiche. Oggi anche la ricerca scientifica riconosce i benefici del Coriandolo sulla salute e le sottostanti tabelle riportano le proprietà nutrizionali di questa pianta, sia essiccata che fresca, che troviamo presente non solo tra le spezie gastronomiche ma anche nelle erboristerie e nelle fitofarmacie.


Proprietà nutrizionali di 100 grammi di frutti e foglie di coriandolo essiccati:
NutrienteUnitàSemiFoglie Acquag97
Proteineg1221 Grassig175
Carboidratig5552
Fibreg4210
Zuccherig–7
Minerali
Calcio mg7091246
Ferro mg1642
Magnesio mg330694
Fosforo mg409481
Potassio mg12674486
Sodio mg35211
Zinco mg4.74.7
Vitamine
Vitamina A mcg–293
B1 mg0.2391252
B2 mg0.291500
B3 mg2.1310.7
B6 mg–0.6
Vitamina C mg21566
Vitamina E mg–1.03
Vitamina K mcg–1359
Folati mcg–62
Fonte: USDA Database
Proprietà nutrizionali di 100 grammi di frutti e foglie di coriandolo freschi:
NutrienteUnitàSemiFoglie Acquag8.8692.21
Proteineg12.372.13 Grassig17.770.52 Carboidratig54.993.67 Fibreg41.92.8 Zuccherig–0.3
Minerali
Calcio mg70967
Ferro mg16.321.77
Magnesio mg33026
Fosforo mg4048
Potassio mg1267521
Sodio mg3546
Zinco mg4.70.5
Vitamine Vitamina A IU–6748
mg–0.149 Vitamina C mg2127 Vitamina E mg–2.5
Vitamina K mcg–310 Folati mcg–62
Fonte: USDA Database



Come scritto in precedenza, la ricerca scientifica, con studi effettuati in provetta e pubblicazioni in riviste scientifiche mondiali, ha dimostrato che semi e foglie di Coriandolo contengono antiossidanti ed hanno principalmente proprietà antibatteriche, antinfiammatorie, digestive, carminative, di riduzione del colesterolo cattivo (LDL) e aumento di quello buono (HDL).
I semi e le foglie essiccati in erboristeria e fitoterapia vengono consigliati sotto forma di infusi, decotti, olio essenziale, estratto idroalcolico, tintura, ecc.
- Uso interno: spasmi intestinali e colon irritabile, gonfiore e meteorismo, cattiva digestione, micosi e batteri, sistema nervoso, contrasto dell’alitosi, problemi del cavo orale come , ulcere e perfino il mughetto.
-Uso esterno: cicatrizzazione di piaghe e ferite; stimolante e rivitalizzante nell’acqua calda del bagno.
Anche le foglie fresche, usate in cucina nelle misticanze di insalata o nei vari piatti in sostituzione del prezzemolo, arrecano molti benefici (difficile da credere per chi non ama il suo odore): sono antinfiammatorie, aiutano nei problemi digestivi e in infezioni dovute da cibi avariati o dallo stress ossidativo, sono leggermente analgesiche ed aiutano ad abbassare i livelli di glucosio nel sangue. N.B.: per gli utilizzi ad uso medicinale terapeutico, oltre alle prescrizioni riportate nelle singole confezioni, è sempre opportuno essere consigliati dal proprio medico o fitoterapista.
In campo gastronomico i semi del Coriandolo essiccati, grazie all’aroma dolce e delicato, possono essere aggiunti in molte preparazioni culinarie senza coprire il gusto delle pietanze. Vengono utilizzati per aromatizzare piatti a base di carne, pesce, alcuni insaccati come salsicce, mortadelle e la classica porchetta ma anche per profumare biscotti e confetti, mentre isemi macinati sono l’ideale per condire le verdure,sia crude che cotte.
Altri utilizzi:l’olio essenziale che si ricava dai semi è molto apprezzato in campo cosmetico e farmaceutico e viene impiegato nella preparazione di profumi, saponi, creme, dentifrici e incensi, oppure, grazie al suo aroma intenso, per
coprire il sapore sgradevole di alcuni farmaci.
I frutti vengono anche utilizzati in liquoristica (Gin), come aromatizzante della birra e, macinati, entrano nella preparazione del curry (miscela di varie spezie) nella quantità di circa il 30%. Inoltre sono utilizzati come ingrediente nella preparazione dell’acqua di melissa (antico rimedio fitoterapico dei Frati Carmelitani Scalzi che lo producono dal 1710), consigliata sia per via esterna (impacchi e lozioni) che interna (ingestioni, anemie, perdita di memoria e forte emotività).
Il Coriandolo fa parte delle piante mellifere e il miele di coriandolo viene definito “miele maschile” (sembra che aumenti la potenza maschile).Oltre al gusto particolare, è, come tutti i mieli, molto rinomato per le ottime proprietà benefiche per il nostro organismo e viene consigliato nei casi di costipazione, gonfiore, flatulenza, gastrite ed ulcere.
Oltre ai vari usi elencati, ho trovato che il Coriandolo è presente assieme ad altre spezie come ingrediente della ricetta piemontese del vin brulé (termine francese che significa vino bruciato), definito rinvigorente e ricostituente. Esistono testimonianze che anche Greci e Romani facessero una bevanda simile: per nascondere il sapore di un vino non eccezionale, aggiungevano delle spezie, tra cui il Coriandolo, lo scaldavano e lo servivano a fine pasto, con miele e pepe come digestivo.





Qui faccio una piccola divagazione: chi nelle feste autunnali o lungo le vie cittadine non ha sorseggiato un bicchiere di vin brulé con le caldarroste? Ebbene, per chi soffre i rigori invernali o quando si è giù di morale o raffreddati o assieme agli amici davanti al crepitio del fuoco nel camino… ecco la ricetta di un toccasana alla piemontese: ½ lt di Barolo (in mancanza Rosso Conero o Montepulciano d’Abruzzo), 50 g di zucchero, 3 g di cannella intera, 3 g di coriandolo in semi, 3 gr pepe nero in grani, scorza di ½ limone, un pizzico di vaniglia, una foglia di alloro, una foglia di salvia, un rametto di rosmarino. Far bollire per circa 10 minuti, filtrare, servire caldo in una tazza e… Prosit!
Utilizzo in campo ornitologico: non ho trovato alcuna descrizione o riferimento al Coriandolo sui testi in mio possesso, come cibo nell’alimentazione ornitologica, tranne la sua presenza nella descrizione del mix riportato in premessa. Viaggiando su internet, invece, ho trovato la presenza del coriandolo sia come erba che come semi nell’alimentazione dei pappagalli con le seguenti descrizioni: “Apporta oli essenziali che migliorano la digestione; stimola l’appetito e calma le irritazioni causate dagli alimenti. È una pianta ricca anche di carotenoidi e vitamine del gruppo K, ma anche di vitamine B, C ed E. I semi ricchi di zuccheri e
I semi ricchi di zuccheri e proteine danno un gusto pungente ai mix e allo stesso tempo ne accrescono le proprietà digestive
proteine danno un gusto pungente ai mix e allo stesso tempo ne accrescono le proprietà digestive, riducendo le fermentazioni intestinali”.
Tali affermazioni avvalorano la presenza utile e benefica dei semi di Coriandolo nell’alimentazione ornitologica ma, come ogni altro alimento, a mio avviso, anche il Coriandolo (come il mix dei “semi della salute o condizionatori”) va utilizzato discrezionalmente per non cadere nei problemi dovuti agli eccessi.
Conclusione
Premetto che non sono un biologo e tantomeno un nutrizionista, ma la mia professione di geometra mi ha portato spesso e volentieri ad operare in campagna a contatto con la flora. Volentieri, perché in prevalenza ho operato in luoghi e in terreni ricchi di ricordi giovanili che da sempre hanno alimentato la mia

curiosità verso le piante selvatiche e a documentarmi sulla commestibilità e proprietà di quelle che portavo nel mio piatto e nelle mangiatoie del mio “hobby canarinicolo”. Col passare degli anni, il mio interesse si è rivolto anche verso l’ecologia e sostenibilità ambientale ed alla progettazione e costruzione di fabbricati in eco-bioedilizia. Leggere che la coltivazione del Coriandolo in alcune regioni italiane è in forte aumento, tanto da far sì che l’Italia sia diventata leader mondiale nella produzione e qualità dei semi e che il Coriandrum sativum sia elencato come pianta mellifera principale nei programmi di sovvenzione governativi e che venga ritenuta ideale per progetti di schemi ecologici (*) (superfici con colture arboree sia per seminativi, con la finalità specifica diproteggere impollinatori e biodiversità) mi ha fatto riflettere sul fatto che, oltre agli usi gastronomici e medicinali suddetti, la coltura del Coriandolo, così come l’aumento di superfici agricole dedite al biologico, possa dare un contributo concreto per contrastare i cambiamenti climatici, tutelare l’ambiente, conservare i paesaggi e la biodiversità, contribuendo altresì all’aumento della base alimentare per api e altri impollinatori, custodi della biodiversità (alcune ricerche hanno dimostrato che negli ultimi decenni le popo-


lazioni di api e farfalle è in drastica diminuzione), garantendo una fonte di cibo per tutta la fauna autoctona e rendendo l’agricoltura più sostenibile.
Dietro queste riflessioni, con la curiosità di veder nascere una nuova pianticella e l’intento di rafforzare la biodiversità del mio giardino, ne ho dedicato una zona alla semina del Coriandolo, prospettando a mia moglie Angela di aumentare l’assortimento di piante erbacee per la nostra cucina e… non da meno, un alimento per i miei canarini! Inoltre, avere una zona fiorita per attirare api e altri insetti impollinatori, nonché semi per gli uccellini stanziali, esaudiva i miei desideri rispetto alla biodiversità. Però, alla prima raccolta di un mazzetto di giovani pianticelle, il profumo, per non dire puzza di cimici schiacciate con le mani, ha riempito le mie narici…
“Accidenti, è proprio vero che puzza!” esclamo. Porto il mazzetto in cucina ed alcune foglie dai canarini. Non vi dico la reazione di mia moglie che stava attendendo la novità. Quando le ho detto che quell’odore che anche lei avvertiva era del prezzemolo cinese appena raccolto ha esclamato “Che schifo! Butta via tutto, togli tutto anche dall’orto, dalla stanza dei canarini… non senti che puzza di cimice!? Mi vien da vomitare…”. Con questa esortazione imperativa, l’esperimento del Coriandolo, a malincuore, è naufragato sul nascere! Ad maiora, semper.
NOTE
(*) Eco-schema 5 del PAC 2023-2027
ALCUNE FONTI
- Segreti e virtù delle piante medicinali- Selezione dal Readers Digest - Cibi per la salute, Red edizioni - https://www.macrolibrarsi.it/speciali/coriandolo -https://www.linkiesta.it/2024/08/coriandolo-erba-aromatica-storia-usi/ -https://www.accademiafabioscolari.it/ilcommercio-delle-spezie-nel-XIII-secolo/ -https://www.humanitas.it/enciclopedia/alimenti/spezie/coriandolo -https://www.fanpage.it/innovazione/scienze - https://www.mr-loto.it/coriandolo -https://creafuturo.crea.gov.it/12546/















Dal 6 all’8 dicembre 2024 si è tenuta a Roccapiemonte l’undicesima edizione del MOC (Meeting Ornitologico Campano) organizzata in collaborazione tra le Associazioni "Alessandro Ghigi", Campania Felix, U.N.O. Campania e Rocchese il Castello, con i due propulsori dell'evento Francesco Petti e Domenico Borrelli. Aderenti a questo meeting ben 18 club della sezione di Forma e Posizione, che hanno a loro volta fatto affluire in gara 212 allevatori di 68 diverse Associazioni nazionali per un totale di 2.627 soggetti nelle specialistiche, con una media di 12,39 soggetti ad allevatore. Numeri che dimostrano la bellezza di questa competizione facendo percepire la grande “qualità sportiva” in concorso. Tra tutti questi club, quello dell’IGS con 638 canarini Gloster ha avuto il titolo di “re” della manifestazione. Meritano evidenza anche gli altri club che si sono distinti per il loro numero di soggetti in gara, tra questi il club dello Scotch Fancy e il Club dello Yorkshire, partecipando all’evento rispettivamente con oltre 300 canarini; poi, con più di 200 soggetti si sono distinti i club della

Aderenti al meeting ben 18 club della sezione di Forma e Posizione, che hanno a loro volta fatto affluire in gara
212
allevatori di 68 diverse Associazioni


Razza Spagnola e del Fife e via via a seguire tutti gli altri club con numeri di buon valore per una gara sportiva che lascia ai partecipanti la soddisfazione di una grande manifestazione di specializzazione.
Tre giorni del meeting
Il venerdì - Per chi si domanda come si sviluppa il meeting, possiamo raccontare che il venerdì è la giornata dedicata all’accoglienza e all’alloggiamento dei soggetti in gara. Qui, a Roccapiemonte, essendo molti club a concorso, ci siamo divisi in due siti. I Gloster e i Norwich nel Centro Sociale di Roccapiemonte, mentre gli altri club sono stati ospitati nella comoda palestra del Liceo B. Rescigno dove sono stati ospitati in gara 1.881 canarini di 15 diversi club. Malgrado abbia avuto amici coinvolti nelle gare tenutesi nella palestra, ho potuto seguire poco questa organizzazione ma, dai racconti ricevuti, è stata particolarmente entusiasmante, con i migliori complimenti rivolti a chi aveva organizzato questa occasione di incontro e di competizione.



Per la mia personale esperienza, vi riporto quanto accaduto all’interno del Centro Sociale, dove erano ospitate le specialistiche del Norwich e del Gloster Fancy. Particolare di queste nostre specialistiche sono le gabbie, leggermente differenti nelle misure tra Norwich e Gloster ma strutturate in modo analogo. La gabbia che ospita il Gloster è la classica gabbia inglese in legno laccata di nero su tutto l’esterno, con i posatoi posti a 7 cm di distanza uno dall’altro, la porta circolare su un lato e con le pareti interne colorate in verde chiaro per permettere una maggiore visione delle forme e della posizione assunta dal soggetto. Molti allevatori che sono in possesso di queste gabbie possono portare i soggetti in gara già alloggiati nelle loro personali gabbie, omologate e in standard, dove un controllo attento dell’organizzazione verifica che non vi siano segni di riconoscimento che possano
far distinguere il proprietario del canarino. Ci tengo a sottolineare che, in queste specialistiche, molti allevatori si assicurano che la gabbia sia ben chiusa con una fascetta ma, nonostante alcune gabbie lasciate senza questi fermi di sicurezza, alla fine di questi tre giorni, ogni allevatore ha regolarmente riportato a casa i suoi soggetti senza aver avuto furti o perdite.
Ultimate queste fasi preliminari, gli
Molti altri allevatori, sicuramente quelli residenti in zona, si sono aggiunti alla platea dei presenti in mostra per assistere alle fasi di giudizio

allevatori più vicini tornano alle loro case, mentre chi viene da lontano e vuole assistere alla gara del sabato mattina presidiando il giudizio, si ferma in loco e si organizza per passare la serata tra allevatori. Noi allevatori del Gloster ci siamo incontrati in una caratteristica pizzeria del luogo e abbiamo passato una felice serata rallegrati dall’ottima “pizza napoletana”, qualche bevanda e tante storie di ornitologia e di allevamento. Il mattino seguente, alle 8:00 tutti puntuali ci siamo ritrovati all’apertura. Alcuni di noi sono stati precettati nell’assistere l’organizzazione per portare le gabbie al giudizio o per assistere il giudice nelle fasi di valutazione.
Il sabato - La gara - Molti altri allevatori, sicuramente quelli residenti in zona, si sono aggiunti alla platea dei presenti in mostra per assistere alle fasi di giudizio che hanno preso inizio dopo che si sono suddivise le catego-


rie tra i giudici presenti. Quest’anno, in rappresentanza dell’Italia, era stato invitato il giudice Salvatore Mallozzi; poi Paul Reay (Inghilterra), Joaquim Lopes e Vitor Dias (Portogallo) che hanno giudicato con il metodo a confronto ben 638 soggetti. Con questo numero di partecipanti, la gara dei Gloster è stata la classe regina di questo appuntamento. Il metodo di giudizio prevede il confronto di tutti i soggetti in gara in ogni specifica categoria, di questi vengono scelti i sette più vicini allo standard e successivamente vengono attribuite le posizioni in classifica dal 7° al 1° classificato. Mentre tutti i canarini giudicati vengono riportati alla loro posizione nelle cavalle predisposte per la mostra, tutti i primi classificati vengono allocati su delle cavalle dedicate ad ospitarli fino al momento finale, dove tutti i giudici si riuniscono e insieme scelgono i Best di ogni categoria a concorso.
Nella stessa sala, erano presenti anche 108 Norwich giudicati dal giudice Paul Martin (Irlanda) assistito dal Presidente uscente del Club Antonio Beretta e dal nuovo presidente eletto Loris Berton.
Le tradizioni in una gara di Gloster - L’organizzazione che, in queste manifestazioni, si attiene alla tradizione inglese dell’IGBA prevede che un allevatore novizio che intende partecipare a queste competizioni si può iscrivere a concorso nella categoria “novice” (novizi). Dopo alcuni anni tra i novizi, l’organizzazione dell’IGS può favorire il passaggio dell’allevatore alla categoria “champion”. Qualora in questi primi anni l’allevatore dovesse conseguire, in tre diverse edizioni, dei titoli Best, in questo caso il comitato IGS potrebbe valutare di promuovere l’allevatore alla categoria superiore, cioè quella degli allevatori esperti dei “campioni”, all’inglese la categoria “champion”. Personalmente sono giunto alla terza esperienza in questa eccellente manifestazione, con i miei Gloster nella sezione “novice” dove, nei primi due anni, ho avuto ottime soddisfazioni ottenendo nel 2022 un Best corona e un Best in Show con la stessa canarina, mentre nel 2023 un


Nella giornata del giudizio, l’aria che si respira fa percepire la frenesia degli allevatori di sapere se uno dei propri canarini darà la soddisfazione
di un primo posto o ancor più di un Best
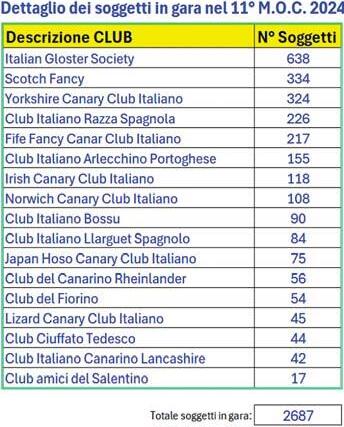
Prospetto

Best con una canarina consort. Dopo questi due anni di gloria, quest’anno non ho confermato gli stessi successi ma comunque posso dire che questo è stato l’anno dove ho comunque raccolto maggiori soddisfazioni, avendo avuto il piacere di essere stato presente per tutti e tre i giorni in gara e avendo così occasione di vivere e capire l’importanza dell’essere in presenza durante il giudizio. Queste manifestazioni permettono agli allevatori un confronto molto più diretto tra appassionati della stessa razza, mettendo a disposizione non solo le conoscenze di ogni singolo appassionato, ma offrendo il confronto diretto con le esperienze e le conoscenze degli stessi giudici che possono direttamente spiegare all’interessato i punti di forza o di criticità del soggetto in gara.
Gli allevatori e i loro sogni - Nella giornata del giudizio, l’aria che si respira fa percepire la frenesia degli allevatori di sapere se uno dei propri canarini darà la soddisfazione di un primo posto o ancor più di un Best, sogno di tutti noi che dedichiamo ore e ore della nostra vita nella cura dei nostri piccoli pennuti. Quando sta per iniziare la gara, gli allevatori prendono posto nella sala e iniziano a curiosare per capire come il giudice sta valutando i soggetti in gara.

C’è chi mette i più belli in alto, c’è chi giudica prima quelli meno belli, c’è chi posiziona i primi verso destra e chi verso sinistra e tutto il pubblico analizza ogni metodo per cercare di identificare subito un suo canarino nella selezione dei migliori.
La sala del giudizio - Nella zona dedicata al giudizio vi sono allocate le cavalle che ospiteranno le gabbie da giudicare, strutturate in modo che permettano di avere i soggetti ad altezza occhi e una seconda fila ad altezza vita per poter anche vedere i soggetti dall’alto. Oltre ai giudici, in questa area, vi sono gli addetti alla loro assistenza (personale dell’organizzazione) a poca distanza ma in posizione di favore per assistere al giudizio. L’allevatore può liberamente osservare la gara ma deve rispettare delle semplici regole come lo stare all’esterno della zona dedicata ai giudici, senza disturbare i giudici nel
Nella zona dedicata al giudizio vi sono allocate le cavalle che ospiteranno le gabbie da giudicare, strutturate in modo che permettano di avere i soggetti ad altezza occhi e una seconda fila ad altezza vita per poter anche vedere i soggetti dall’alto
loro esercizio e senza far nulla che possa influenzare o infastidire il sereno lavoro del giudice. L’allevatore,


pur essendo a poca distanza dalla gara, può presidiare a tutte le fasi riuscendo comunque ad apprezzare e capire le scelte e le decisioni dei giudici.
Scelta dei BEST - Terminato il giudizio, vengono disposti per sezione (consort, corona distinti, rispettivamente divisi tra novice e champion) tutti i canarini primi classificati che, come previsto dal catalogo delle premiazioni, vengono visionati e valutati per la scelta del Best di ogni categoria. Dopo aver definito tutti i Best e dopo aver scelto il Best in Show (il titolo maggiore di queste competizioni), gli allevatori possono approfittare della disponibilità dei giudici confrontandosi con loro per comprendere i pregi e i difetti che hanno premiato o penalizzato un canarino. Sempre sfruttando la loro conoscenza ed esperienza, si possono chiedere consigli per il loro allevamento.
Il terzo tempo o dopo gara - L’organizzazione, dopo che si sono concluse tutte le fasi di giudizio, ha apparecchiato una lunga tavolata nella quale sono stati ospitati tutti gli allevatori con i giudici e il personale dell’organizzazione. A tutti è stato offerto un pasto, creando così l’ennesima occasione di confronto per approfondire gli argomenti di una passione comune che ci identifica con un semplice termine: appassionati allevatori. Ultima giornata - La domenica alle 8.00 del mattino molti di noi sono tornati in mostra; abbiamo aiutato ad allestire il podio per tutti i Best e abbiamo iniziato a scattare foto ricordo con gli amici e con i nostri campioni. Molto bello è stato l’allestimento dei Best, fatto fare dal Club IGS per l’occasione. Delle cornici in legno con su inciso le varie tipologie di Best. Cornici che posizionate intorno alla gabbia del vincitore davano un tocco molto inglese al podio.
Poco prima di mezzogiorno, le persone dello staff hanno iniziato ad assistere gli allevatori nelle fasi di sgabbio e, una volta ultimate, ci siamo dedicati ai saluti. Quando sono ripartito per tornare a casa, con me avevo i miei canarini, due bellissimi soggetti

acquistati dai miei amici Marra e Liotino e, nello zaino, ho portato via con me un carico di tre belle giornate, di tanti amici e tante soddisfazioni. Come dico spesso, l’importante non è vincere ma VIVERE queste belle giornate in compagnia di tutti coloro che condividono la stessa passione. Non ci resta altro che attendere il prossimo anno per un nuovo appuntamento che vedrà l’organizzazione della 12^ edizione del MOC ma, da quanto mi è stato anticipato, dovremmo attendere delle belle novità; possiamo già scrivere che l’appuntamento sarà dal 5 al 7 dicembre. Concludendo, ringrazio ancora l’organizzazione che mi ha permesso di vivere e raccontare dettagliatamente i tre giorni con i Gloster e i Norwich ma invito tutti gli appassionati di tali razze a partecipare a questi appuntamenti con i propri soggetti dove, supportati dai loro rispettivi Club


(ben 18 in questa edizione), potranno meglio apprezzare le qualità degli uc-
celli in gara e il bello dell’aspetto sociale che queste occasioni creano.

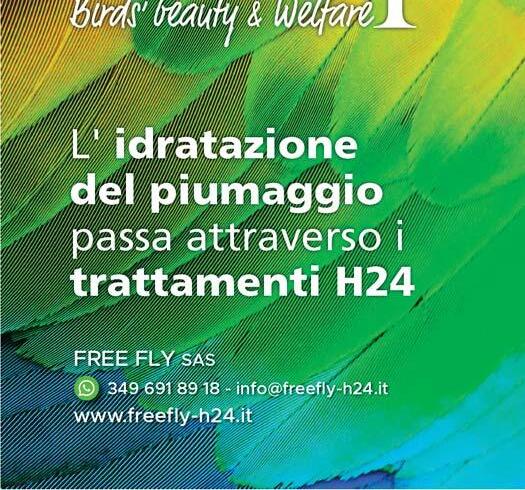

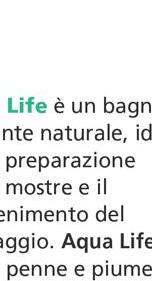





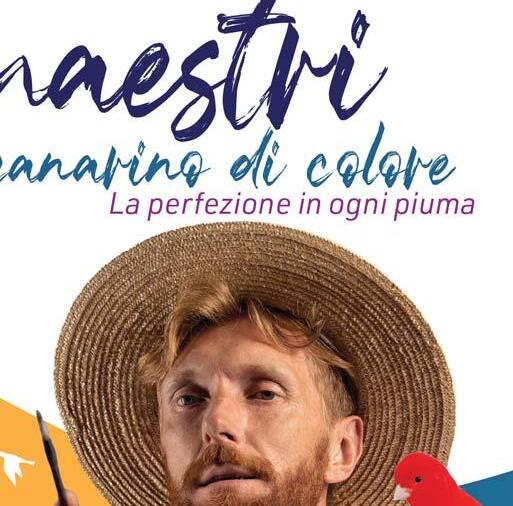





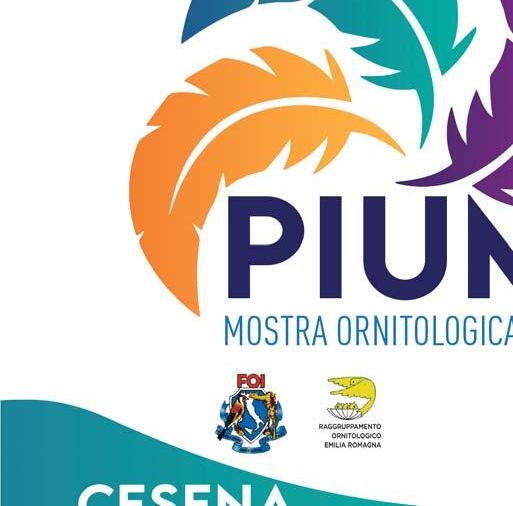




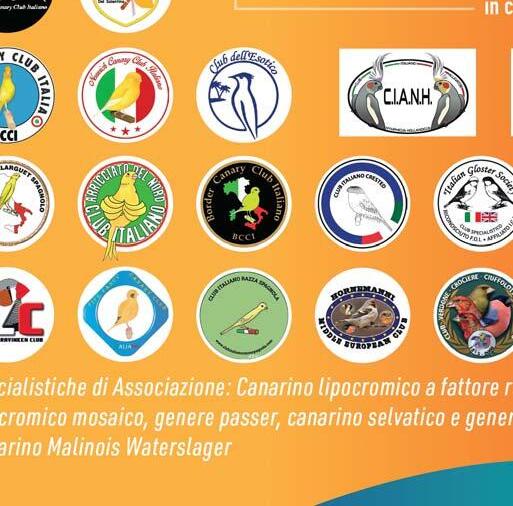






(*)Tutte le foto inviate, anche quelle non pubblicate, rimarranno a disposizione della FOI a titolo gratuito e potranno essere utilizzate, senza alcun limite o vincolo temporale, per pubblicazioni, iniziative e scopi promozionali della Federazione
Questo mese, il protagonista di Photo Show è: DOMENICO VICIDOMINI - RNA 7BAR con la fotografia che ritrae: “Nidiata canarini agata intenso e brinato rosso” (Serinus canaria) Complimenti dalla Redazione!
•Invitiamo tutti gli allevatori a inviare foto di soggetti provenienti dai propri allevamenti, con descrizione della specie, razza e mutazione, all’indirizzo: redazione@foi.it
•All’autore della foto mensilmente prescelta da un comitato interno, verrà offerto in omaggio un libro edito dalla FOI in base alla preferenza e alla disponibilità.



https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.15050084
testo e schede di PASQUALE LEONE
Abstract Il cardellino (Carduelis carduelis - Linnaeus, 1758) è un iconico uccello passeriforme della famiglia dei Fringillidi che in natura ritroviamo in un habitat piuttosto ampio.
La distribuzione geografica delle aree di insediamento comprende l’Europa, la Russia (inclusa la parte siberiana), il nord Africa e parte dell’Asia.
In Italia il cardellino è diffuso su tutto il territorio nazionale.
Per quanto concerne l’area che comprende la regione della Calabria, sia la letteratura specializzata che quella inerente il circuito scientifico segnalano la presenza stanziale esclusiva della sottospecie tschusii (Arrigoni Degli Oddi, 1902).
Invero, alcune fonti specializzate segnalano, nel periodo di migrazione autunnale, altresì sporadiche presenze della sottospecie balcanica (Sachtleben, 1919).
In Calabria esiste però di fatto una forte presenza della sottospecie parva (Tschusi, 1901) che non è stata mai segnalata e non è mai riportata in alcun testo.
Questo studio si pone come obiettivo di colmare questa lacuna e di porre le basi per ulteriori approfondimenti a riguardo.
Introduzione
La Calabria, in virtù della sua parti-

colare conformazione geografica, è una delle regioni nelle quali è presente una biodiversità molto elevata.
La presenza di microclimi differenti nel raggio di poche decine di chilometri permette la presenza di cultivar sub-tropicali e finanche tropicali. Da ciò, è facile evincere che anche un eventuale adattamento della piccola avifauna alloctona proveniente da paesi limitrofi è più che probabile.
Ne consegue che due sottospecie morfologicamente analoghe e che in natura vivono in habitat del tutto simili, se non uguali come microclima e buona parte della flora, possano convivere nell’area suddetta e soprattutto in zone nella quali vi sia una prevalenza di macchia mediterranea.
Definizione delle sottospecie prese in esame
La tassonomia della specie Carduelis carduelis, nel circuito della letteratura scientifica, non ha uno standard uni-
sono per la sua ripartizione sistematica. Questo studio, per quanto riguarda la classificazione tassonomica, ha usato quale metrica di riferimento
The Handbook of the Birds of the Words & Bird Life International per la quale vengono attribuite al cardellino euro-asiatico dieci sottospecie e al cardellino asiatico dell’Himalaya altre ulteriori quattro sottospecie.
Al fine di rendere chiare le specifiche delle singole sottospecie che andranno discusse, di seguito sono riportate delle schede esemplificative nelle quali viene comparata la topografia della sottospecie nominale e quelle delle due sottospecie prese in esame.
Da una disamina delle schede, appare chiaro che le due sottospecie tschusii e parva hanno caratteristiche morfologiche fortemente similari.
Pertanto, una corretta identificazione non necessita soltanto di un’osservazione particolarmente attenta, ma questa deve essere coadiuvata da una profonda conoscenza della razza, nonché delle singole sottospecie.

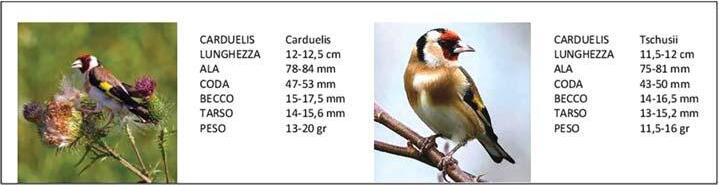

Obiettivi
Lo studio si pone l’obiettivo di stabilire la presenza stanziale in Calabria anche della sottospecie Carduelis carduelis parva, della quale è stata ripetutamente segnalata la presenza.
Lo scopo del presente scritto è quello di colmare la mancanza di letteratura specifica e scientifica a riguardo, nonché di poter essere da supporto per successivi approfondimenti.
Per inciso, l’elaborato non prevede alcuna analisi comparativa tra le due sottospecie tschusii e parva.
L’enfatizzazione delle caratteristiche distintive e delle differenze fenotipiche tra le due sottospecie non fanno parte degli obiettivi di questo scritto. Eventuali riferimenti a tale proposito sono da considerarsi a titolo meramente esplicativo.
Materiali e metodi
Con l’ausilio di dieci ornicoltori volontari, residenti nelle aree dove sono state ricevute segnalazioni di avvistamenti di soggetti parva, utilizzando come base di richiamo i propri allevamenti, i volontari hanno dovuto:
1)Identificare e/o esaminare almeno 10 soggetti della stessa sottospecie
2)Confermare le aree di insediamento
3)Utilizzare la scheda della Commissione Ornitologica Italiana per supportare il materiale fotografico, video, audio.
La procedura utilizzata è stata quella
Lo studio si pone l’obiettivo di stabilire la presenza stanziale in Calabria anche della sottospecie Carduelis carduelisparva, della quale è stata segnalata la presenza
di provare a fare avvicinare i soggetti silvestri nei pressi degli allevamenti, fornendo alimenti (sementi in modeste quantità) all’esterno dei propri aviari.
Si è avuta così la possibilità di osservare da vicino e monitorare l’eventuale presenza di soggetti appartenenti alla sottospecie parva e/o nel caso, di altre sottospecie di Carduelis diverse dalla tschusii
La durata di questo monitoraggio è stata complessivamente di due anni, con inizio il 1 ottobre 2022 e termine il 30 settembre 2024.
Risultati
Durante l’arco temporale in cui si è svolto il monitoraggio, è stato individuato un totale di 14 soggetti appartenenti alla sottospecie parva, così suddivisi geograficamente: 5 nell’area della Piana Lametina (CZ), 6 nell’area della Costa Ionica compresa tra Catan-
zaro Lido (CZ) e Roccella Ioinica (RC), 3 nell’area di Tropea (VV).
Discussione
La letteratura scientifica nel corso dell’ultimo ventennio ha subito dei notevoli cambiamenti.
Con l’avvento della grey literature (articoli e testi non pubblicati su testate e canali tradizionali, NdR) molte cose sono cambiate e, se è vero quanto alcune fonti sostengono che si sia perso qualcosa in qualità, di certo si sono allargati gli orizzonti.
Ciò quale dovuta premessa, poiché questo studio nasce sul modello di un analogo lavoro basato proprio sui principi della grey literature. Ovvero: “Stato e distribuzione di una popolazione introdotta di cardellini europei (Carduelis carduelis) nella regione occidentale dei grandi laghi del Nord America” pubblicato nel luglio del 2022 ad opera di Julie Craves e Nicholas Anich (https://doi.org/10.3897/arphapreprints.e90813).
Analizzando le procedure sistematiche usate per la ratifica dello studio nel continente americano, alcuni metodi sono stati adattati ai criteri italiani con l’obiettivo di stabilire se in Calabria la sottospecie parva possa essere considerata stanziale, di accertarsene e di trasmetterlo agli organi competenti di riferimento, sia istituzionali che a quelli di specializzazione.
La funzione dell’ornicoltore svolge un ruolo chiave in questa circostanza poiché non è sufficiente la conoscenza delle caratteristiche tipiche delle rispettive sottospecie, ma come già specificato assume fondamentale importanza l’abilità di riuscire a distinguerle a una media distanza.
Le peculiarità fenotipiche delle sottospecie vengono individuate con maggiore facilità da chi, oltre alla conoscenza, ha anche dimestichezza con la specie Carduelis carduelis allevandola con finalità ornamentali.
Basandosi su alcune segnalazioni per le quali sono stati avvistati dei parva nelle aree dell’hinterland lametino, la costa di Tropea e parte del litorale riguardante la costa ionica, è partito il progetto di identificazione.
Il cardellino in Calabria ha un’ampia e

variegata portata di punti nei quali sceglie di nidificare.
Tuttavia, l’habitat della specie, negli ultimi anni, ha subito dei cambiamenti.
La modifica delle aree di insediamento e nidificazione è stata dettata da diverse motivazioni; non ultimo, il notevole incremento della presenza di predatori come la gazza ladra (Pica pica, Linnaeus 1758) che ha fatto sì che la specie, tradizionalmente diffidente, si avvicinasse sempre più in prossimità degli insediamenti umani.
Questo comportamento adattativo ha favorito l’opera di monitoraggio degli ornicoltori portando ai dati citati nei risultati.
La conferma della presenza della sottospecie Carduelis carduelis parva in maniera stanziale in Calabria lascia spazio a una serie di valutazioni che rientrano in ambiti di varia natura.
Dal punto di vista prettamente ambientale, uno degli aspetti cruciali sarebbe quello di stabilire se l’arrivo della sottospecie alloctona possa avere, in qualche maniera, causato delle conseguenze sulla conservazione della sottospecie autoctona o apportato significativi cambiamenti alla biodiversità dell’ecosistema.
Sempre nel contesto ambientale, non dovrebbe trovare riscontro l’ipotesi di una migrazione legata all’innalzamento medio delle temperature, anche in virtù della già menzionata pluralità di microclimi presenti in Calabria. In ambito etologico, sarebbe opportuno trovare i motivi per i quali non si siano verificati degli incroci (quelli che in gergo vengono chiamati meticciamenti) con la sottospecie tschusii.
Altro aspetto etologico da prendere in considerazione, consiste nell’individuare le ragioni per le quali le due sottospecie, pur condividendo lo stesso areale e quindi, pur avendo a disposizione gli stessi materiali, costruiscono i rispettivi nidi in maniera differente.
Anche se l’epigenetica è fortemente correlata al fenotipo, ulteriori approfondimenti hanno dimostrato che ci sono segnali cellulari diretti dagli stimoli ambientali.
Alcuni di questi stimoli interagiscono col gene recettore dei glicocorticoidi
La conferma della presenza della sottospecie Carduelis carduelis parva in maniera stanziale in Calabria lascia spazio a una serie di valutazioni di varia natura
nell’ippocampo, lasciando così aperte svariate ipotesi legate al comportamento.
Altresì, alcuni studi comparati potrebbero aprire ulteriori ipotesi legate al fatto che le due sottospecie abbiano una sequenza del loro canto leggermente differente.
Le rispettive femmine sarebbero dunque stimolate ad accoppiarsi con i maschi della relativa sottospecie.
Questa serie di interrogativi è da interpretarsi con finalità propedeutica ed essi possono considerarsi un preludio a ulteriori approfondimenti su di una specie particolarmente apprezzata, non soltanto in ambito ornitico. Statisticamente, da una disamina dei metodi utilizzati, delle risorse impiegate (dieci persone volontarie) e dai numeri risultanti, si evince, in proporzione, che la presenza della sottospecie parva in Calabria sia alquanto consistente.
Ulteriori osservazioni
Per quanto concerne, invece, la presenza in Calabria della sottospecie Carduelis balcanica, di solito vengono segnalati avvistamenti durante il periodo di migrazione, per i quali sono osservati esemplari quasi esclusivamente in stormi.
Segnalazioni in circostanze del tutto
simili ma più di rado si sono verificate anche per la sottospecie nominale Carduelis carduelis
Nessuna evidenza è stata reperita o ricercata a tal proposito, in quanto l’oggetto dello studio è inerente alle sottospecie stanziali nella regione. Tuttavia, in considerazione del fatto che la segnalazione agli organi istituzionali che si occupano del patrimonio faunistico nazionale è considerata parte degli obiettivi, è stata menzionata la presenza di queste due ulteriori sottospecie.
Conclusioni
Il presente studio ha soddisfatto i requisiti minimi per fornire la segnalazione agli organi nazionali d’interesse che la sottospecie parva è presente in maniera stanziale in Calabria. Nonostante l’estrema specializzazione dell’assunto, futuri approfondimenti a riguardo sarebbero auspicabili, specialmente in considerazione del forte interesse che gli estimatori nutrono verso questa specie.
BIBLIOGRAFIA REFERENCES
-Leone, P., Quando il cardellino scoprì l’America, Italia Ornitologica, 2024 febbraio, pag. 2931. https://www.foi.it/news-documenti-pubblicazioni/italia-ornitologica/annata-2024/numero-2-2024-sfogliabile.html
- Craves, J. A., & Anich, N. M. (2023), Status and distribution of an introduced population of European Goldfinches (Carduelis carduelis) in the western Great Lakes region of North America, NeoBiota, 81, 129–155. https://doi.org/10.3897/neobiota.81.97736
- Ko, M.-C., Frankl-Vilches, C., Bakker, A., & Gahr, M. (2021), The gene expression profile of the song control nucleus HVC shows sex specificity, hormone responsiveness and species specificity among songbirds, Frontiers in Neuroscience, 15, 680530. https://doi.org/10.3389/fnins.2021.680530
-Natale, M., Pidalà, L.G., (2007), Il cardellino, Edizioni Alcedo s.r.l.
-Esuperanzi, R., (2004) - Carduelis carduelisConoscere il cardellino, FOI.
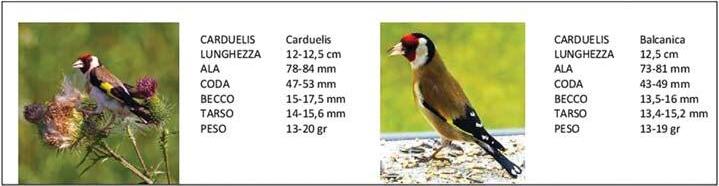

IlCardellino ha una classificazione tassonomica controversa. Lo stato delle conoscenze disponibili è in costante evoluzione, e la classificazione tassonomica degli uccelli subisce continui aggiornamenti. Non tutti gli organismi di ricerca Internazionali sono allineati tra loro nella classificazione sistematica degli uccelli. Le note di cui al presente articolo, sono scritte in riferimento al gruppo di lavoro tassonomico internazionale

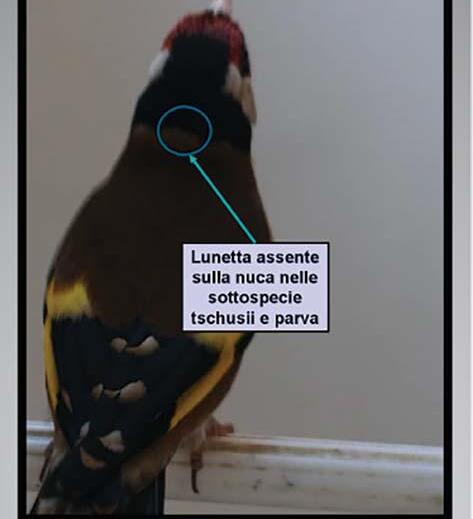
HBW - BirdLife International, che classifica il Cardellino Euro-Asiatico (Carduelis carduelis) appartenente all’Ordine dei Passeriformi, alla Famiglia dei Fringillidae, al Genere Carduelis e gli attribuisce dieci sottospecie. Mentre il gruppo caniceps dei Cardellini Asiatici dell’Himalaya (Carduelis caniceps) contempla quattro ulteriori sottospecie.
Delle 10 sottospecie riconosciute del Cardellino Euro-Asiatico, la letteratura scientifica attuale riferisce che soltanto due vivono e si riproducono in Italia: la sottospecie no-
minale: Carduelis carduelis carduelis (Linnaeus, 1758); e la sottospecie Carduelis carduelis tschusii (Arrigoni, 1902).
Fra le 10 sottospecie elencate, ve ne sono due, la tschusii e la parva, che nonostante abbiano una distri-

buzione geografica diversa, vantano caratteristiche fenotipiche molto simili, ma comunque diverse fra loro se colte da un occhio particolarmente attento. Le suddette due sottospecie, esprimono essenzialmente due comuni ed esclusive caratteristiche, nel novero delle 10 sottospecie riconosciute, che sono: la piccola taglia e l’assenza totale della lunetta solitamente invece presente nella nuca di tutte le altre 8 sottospecie del Cardellino. La sottospecie tschusii, fra tutte le altre, è la più piccola di taglia, con dimensioni corporee pari a circa 11-11,5 cm, quindi simile alla sottospecie parva che risulta essere leggermente più lunga, caratterizzata da dimensioni corporee pari a circa 11,5/12 cm. Quindi la sottospecie parva è leggermente più lunga della tschusii di circa mezzo centimetro. Un’altra caratteristica essenziale che le contraddistingue è la mancanza della lunetta, tipico disegno presente nella nuca (alla base della caratteristica croce nera) di tutte le altre 8 sottospecie




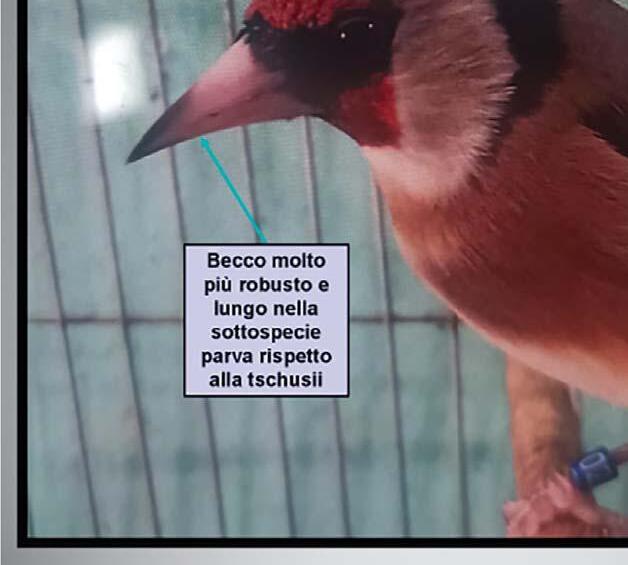
di Cardellino.
Un’ulteriore caratteristica molto importante che contraddistingue e allo stesso tempo differisce le suddette due sottospecie, risiede nelle dimensioni del becco. La sottospecie parva ho un becco molto più lungo e robusto rispetto alla tschusii.
Un’altra interessante differenza fenotipica fra le due sottospecie, parva e tschusii, risiede nella presenza più accentuata del pigmento feomelanico ed eumelanico dai toni bruni, che contraddistingue la sottospecie tschusii. Sappiamo infatti che il fenotipo classico della sottospecie tschusii è fortemente contraddistinto da una eccessiva saturazione del pigmento feomelanico presente su alcune parti del corpo (fianchi, dorso, fungo pettorale e guance). Infatti tali parti del corpo, ma specialmente le guance (che appaiono notevolmente macchiate di bruno), risultano molto più carichi di feomelanina rispetto la sottospecie parva. Ovviamente questa caratteristica fenotipica costituisce un notevole ed esclusivo pregio espositivo per la sottospecie tschusii. Una simile caratteristica che connota presenza feomelanica sulle guance delle altre sottospecie del cardellino, viene invece valutata in fase di giudizio come un difetto del colore.
L’interessante articolo, scritto dall’amico Pasquale Leone, apre nuovi orizzonti, circa la distribuzione geografica della sottospecie parva del Cardellino ( Carduelis carduelis parva ). Se ciò venisse confermato sarebbe una eccezionale scoperta nel panorama scientifico ornitologico e a tal proposito sarebbe utile poter disporre di documentazione fotografica di tali soggetti osservati in natura, cui Pasquale Leone ha fatto riferimento nel suo articolo, per confermare attraverso la presenza o meno delle caratteristiche prima descritte, che trattasi effettivamente della sottospecie parva Carmelo Montagno Presidente C.T.N.-E.F.I.

testo e
foto
di FULVIO CASATI
Un pomeriggio di meraviglia, scoperta e connessione con la natura: è quello che hanno vissuto i piccoli partecipanti dell’esperienza organizzata da Il Bosco dei Bimbi, un gruppo informale che propone laboratori immersi nel verde, con l’obiettivo di avvicinare i bambini al mondo naturale in modo giocoso e coinvolgente. In questa speciale occasione, il labora-
torio ha visto la collaborazione con l’A.O.C. (Associazione Ornicoltori Comense), gruppo affiliato alla FOI (Federazione Ornicoltori Italiani).
Grazie alla presenza degli esperti ornicoltori, i bambini hanno potuto avventurarsi nel sorprendente mondo degli uccelli.
Nel nostro campo, trasformato per un giorno in una piccola oasi di biodiversità,


i bambini hanno potuto osservare da vicino numerose specie di uccelli, ascoltare i racconti degli esperti, imparare a riconoscere canti, piumaggi e abitudini di volatili comuni e rari. L’attenzione e la curiosità si sono accese in modo particolare davanti a una collezione eccezionale di nidi di uccelli selvatici, raccolti con cura dagli ornicoltori nei boschi del territorio. Ogni nido raccontava una sto-




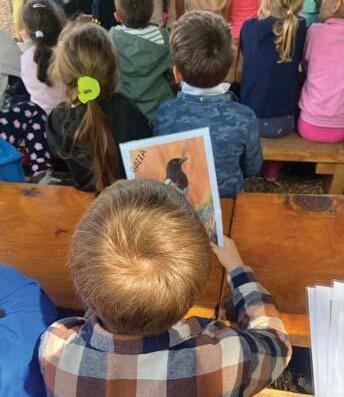

ria di ingegno, adattamento e vita selvatica, affascinando grandi e piccoli.
L’attività si è trasformata in un’esperienza educativa completa: non solo osservazione, ma anche ascolto, dialogo e contatto diretto con la natura. Il progetto ha voluto offrire ai bambini stru-



menti per guardare il mondo naturale con occhi nuovi, coltivando meraviglia e rispetto.
L’iniziativa si è conclusa con sorrisi, domande curiose e il desiderio, espresso da molti piccoli partecipanti, di tornare presto nel bosco per nuove avventure.


Per Il Bosco dei Bimbi è stata una preziosa conferma del valore della collaborazione e della forza dell’educazione all’aria aperta. E, soprattutto, un altro passo nel cammino verso una generazione più consapevole, attenta e con le ali della fantasia ben spiegate.




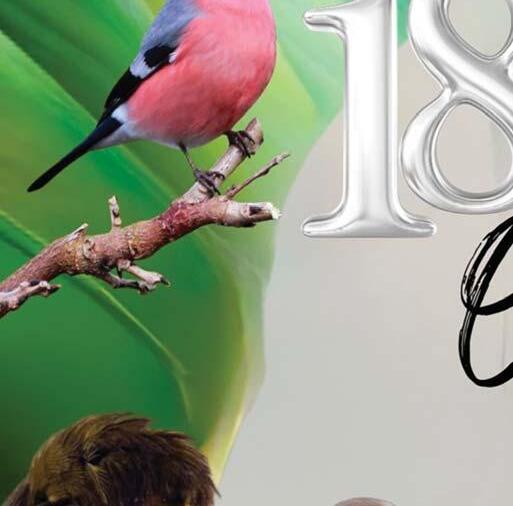

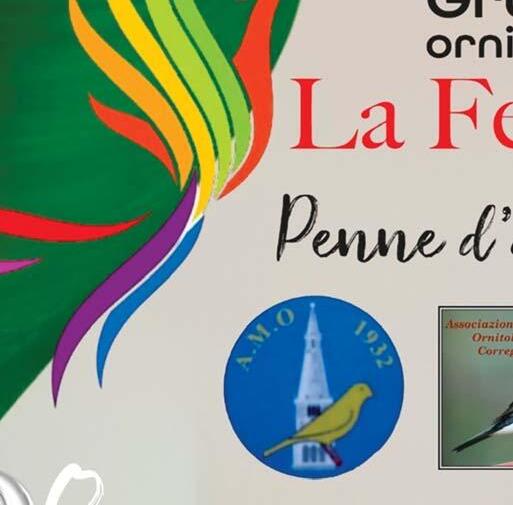


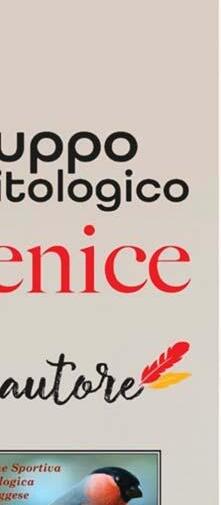
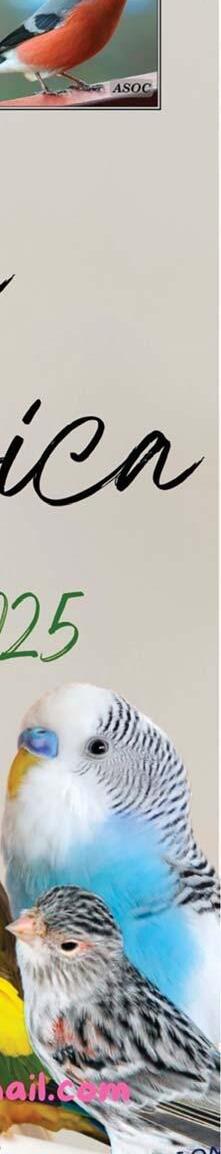
testo e foto di SEBASTIANO PATERNÒ
Introduzione
Fra i tanti uccelli della mia collezione, sono presenti anche gli insettivori di media taglia e fra questi non potevano mancare i Codirossoni, veramente spettacolari. Ho usato, a ragione, questo termine, perché è un uccello dai colori molti vivi e luminosi, ma non per l’intero anno, solo per sei mesi, mentre gli altri sei mostra colori più modesti ma sempre belli; è quindi un uccello “bicolore”.
Eppure, gli allevatori di questa piacevole specie, fra i miei conoscenti, si li-

Una prima ragione della scarsità dei soggetti domestici è facilmente intuibile. Non fa parte, pur migratore, di quegli spostamenti numerici che riguardano uccelli di simile mole
mitano alle dita di una sola mano o quasi. Ho precisato “a mia conoscenza”; ciò non toglie che sicuramente ve ne siano altri ed in effetti non riesco a capire, in ultima analisi, perché siano così pochi: due valenti giudici FOI, Alessandro Fuson e Stefano Colace, e il loro amico Giuseppe Camardese nel Lazio, poi Giovanni Musumeci in Sicilia, Beata Gallipoli in Basilicata, Fausto Bianchè in Trentino ed il sottoscritto, da sempre. Spesso ci sentiamo per scambiare esperienze riproduttive, foto e soggetti. Non sempre argomenti positivi ma in ultima analisi, dalle belle foto e dai risultati, la specie risulta magnificamente acquisita in ambiente domestico. Una prima ragione della scarsità dei soggetti domestici è facilmente intuibile. Non fa parte, pur migratore, di quegli spostamenti numerici che riguardano uccelli di simile mole - Tordi bottacci e Sasselli - che hanno interessato nei tempi andati, e in minor mi-

sura ancora ai nostri giorni, allevamenti intensivi da parte di tanti allevatori, finalizzati principalmente al canto, al passo e in questi ultimi anni anche a scopo riproduttivo, a seguito della comparsa delle tante mutazioni presentatesi, non ultima la scura nei Sasselli.
Tassonomia
Ormai non sono più inclusi nella famiglia dei Turdidi ma in quella dei Muscicapidi e vengono ascritti scientificamente al genere Monticola.


In Italia, il Codirossone non è il solo rappresentante poiché è accompagnato da altra specie presente, anch’essa interessante: il Passero solitario.
In maniera completa, ma non sempre d’accordo, il genere Monticola (Avibase
- Bird check list e Cornel Lab-Birds of the World) risulta attualmente composto dalle seguenti specie:
- Monticola saxatilis - Codirossone - 2 sottospecie (M.s. coloratus e M.s. turkestanicus);
- Monticola solitarius - Passero solitario - 5 sottospecie;
- Monticola sharpei - Codirossone di foresta - 4 sottospecie;
- Monticola angolensis - Codirossone del Miombo - 2 sottospecie;
- Monticola brevipes - Codirossone corona chiara - 2 sottospecie;
- Monticola cinclorhinchus - Codirossone capo blu - monotipica;
- Monticola explorator - Codirossone sentinella - 2 sottospecie;
- Monticola rupestris - Codirossone del capo - monotipica;
- Monticola semirufus - Monticola rupestre alibianche - monotipica;
- Monticolsa gularis - Codirossone golabianca - monotipica;
- Monticola imerina - Codirossone litoraneo - monotipica;
- Monticola rufiventris - Passero solitario ventre castano, nessuna sottospecie;
- Monticola rufocinereus - Codirossone minore - 2 sottospecie;
- Monticola erythronotus - Codirossone delle Montagne d’ambra - monotipica; L’elenco è per chi volesse approfondire conoscenze e areale di distribuzione verso tali specie ed acquisirne ceppi in allevamento domestico. Anche se, in altre liste, Il Codirossone risulta specie monotipica e senza sottospecie.
Distribuzione
È un uccello a distribuzione euro-asiatica. Il suo areale estivo in Europa ed in Asia è molto vasto. La specie nominale, essendo migratore, arriva in aprile-maggio e riparte per svernare a sud del Sahara in agosto-settembre.
La sottospecie M.s. coloratus nidifica nell’intera Turchia, sconfinando anche verso est mentre la sottospecie M.s. tur-

kestanicus ha un’areale vastissimo: l’intera Asia settentrionale.
In Europa è presente in maggior numero da ovest verso est, per poi essere, in Spagna, veramente poco rappresentato.
In Italia è presente in tutte le regioni, ma soltanto nelle aree di gradimento: zone altomontane, nude e non boschive, mediamente al di sopra dei 1.300 metri, sempre scarso e mai abbondante.
Muta pre-nuziale
A dicembre, tutti i maschi, in ambiente domestico, alcuni prima altri dopo, iniziano a mostrare delle fessurazioni nel piumaggio dei fianchi e nelle parti laterali del petto. Sta a significare che la muta pre-nuziale è iniziata. Remiganti e timoniere non sono mai interessate.

Questa muta si prolunga fino a tutto febbraio: il petto diventa di un uniforme rosso-arancio e si completa con il ricambio, per ultimo, delle piume di caponuca-collo che diventano di un azzurro turchese molto caratteristico. Da metà marzo, entrambi i sessi si presentano in pieno abito nuziale e così sono pronti per la riproduzione, che inizia immancabilmente con la costruzione del nido nel mese di aprile. La caratteristica principale è che ogni piuma estrale presenta un orletto chiaro (a differenza della piuma eclissale che lo presenta scuro –foto n.1) e quest’orletto coi giorni scompare o si riduce molto, dando in visione un maggior colorito rosso-arancio (foto n.2: un soggetto in fase di completamento muta estrale, nel cui petto si intravedono ancora piume con orletto nero non mutate e con la testa che andrà a mutare per ultima).
In ambiente domestico prediligono cassette nido semi-aperte di diverse dimensioni. Vanno bene anche le cassette nido per ondulati, a patto che l’ingresso venga allargato anche per l’intero mezzo frontale in modo tale che la femmina in cova possa facilmente guardare. Accettano anche nidi di cartone duro pressato e resistente, sempre con adattata ampia apertura e cassette vuote di aringhe o di vini ad apertura larga frontale, molto comode per ispezionare il nido.
Utilizzano per la costruzione anche il semplice materiale usato per i comuni canarini con sfilacci di juta-sisal e sono molto gradite, in aggiunta, graminacee facilmente estirpabili, le cui radichette sciacquate, pulite e tagliate sono sempre bene accette.
L’unica covata, a meno che altra sia andata in malora da subito, è costituita da 4 - 5 uova di colore verde chiaro uniforme (altri dicono con leggera macchiettatura bruna - le mie sempre senza alcuna macchia-); esse misurano mm 26 x 19,5 (foto n.3). Vengono incubate per circa due settimane (13/15 gg).
Alla nascita, i pulli si presentano nudi e con poche filopiume (foto n.4); il cibo fornito è rappresentato da camole del miele, tarme della farina, bigattini vivi e bolliti, questi ultimi sempre sfarinati

con polvere di calcio perché si sono visti pulli che dopo il 7°/8° giorno possono presentare problemi irreversibili alle dita/zampe non più prensili. Quest’anno, oltre ai grilli vivi molto bene accetti e per le esperienze degli amici laziali, assolutamente indispensabili, saranno forniti gamberetti essiccati di varie dimensioni, ammollati in acqua vitaminizzata. L’alimentazione menzionata è molto impegnativa e costosa; in assenza del cibo vivo e/o essiccato/bollito non si avranno risultati positivi. Ed è a motivo di risparmio ed anche per indurre e favorire una possibile seconda deposizione che i pulli possono essere tolti a 7/8 giorni per l’imbecco a mano con comode crocchette imbibite in acqua vitaminizzata/calcificata e con pappette per pappagalli o anche con prodotti omogeneizzati/liofilizzati per l’infanzia.
A fine maggio-prima settimana di giugno si deve concludere la fase riprodut-

tiva, poiché immancabilmente in giugno, negli adulti, il piumaggio dei fianchi denuncia l’inizio della muta estiva.
La muta eclissale È nei maschi che si nota inizialmente meglio. Le piume pettorali, oltre a virare verso un colore meno vistoso, presentano in ogni piuma un orletto apicale melaninico che per l’effetto “tegola” na-
sconde il rosso-arancio meno vivo ed è pressoché il solo a vedersi, inscurendo l’intera visione del soggetto. È con tale piumaggio dimesso che si presentano alle manifestazioni espositive. Vanno anellati con anello D e se ne vedono in realtà così pochi in mostra che, quando presenti, vanno a sicura vittoria. Trattandosi di uccelli che migliorano negli anni l’intensità dei colori, possono essere esposti fino al terzo anno dalla nascita.
-Avibase, Bird check-list; -Cornel Lab - Birds of the World; -Cage & Aviary Bird - London - 28.08.1999 - Rock’n Roll - Sebastiano Paternò -Italia Ornitologica n.10/2001 - Illuminare l’alba - Sebastiano Paternò; -Italia Ornitologica n.3/2007 - Muta pre-nuziale in Monticola saxatilis - Sebastiano Paternò; -Bruno Massa - Avifauna di Sicilia - update 2021
•Ringraziamenti: Carmelo Montagno e le “sue” liste tassonomiche





Un team di ricerca che ha riunito due Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche – l’Istituto per la ricerca sulle acque di Verbania (CnrIrsa) e l’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri di Firenze (Cnr-Iret) - e il Centro Nazionale per la Biodiversità (NBFC) ha documentato, per la prima volta in Europa, la presenza del miniottero del Maghreb (Miniopterus maghrebensis), una specie di pipistrello finora considerata esclusiva del Nord Africa. La scoperta è descritta in un articolo pubblicato sulla rivista

Mammalian Biology: lo studio è stato condotto sull’isola di Lampedusa, situata nello Stretto di Sicilia tra Europa e Africa, avamposto strategico per lo studio delle dinamiche biogeografiche. Le analisi genetiche, condotte nei laboratori del Cnr-Iret di Firenze su escrementi raccolti presso il vecchio cimitero dell’isola, hanno confermato, per la prima volta in Europa, la presenza del miniottero del Maghreb, specie finora nota solo in Marocco, Algeria e Tunisia. Un risultato che amplia i confini geografici della specie e presenta importanti implicazioni di conservazione.
Oltre al miniottero del Maghreb, lo studio ha documentato almeno altre sette specie sull’isola. Tra queste figurano l’orecchione di Gaisler (Plecotus gaisleri), finora noto in Europa solo per Malta e Pantelleria, e il ferro di cavallo di Mehely (Rhinolophus mehelyi), specie a distribuzione discontinua ristretta alla zona del Mediterraneo. Per entrambe, le sequenze genetiche identificate corrispondono a nuovi aplotipi mitocondriali endemici di Lampedusa, suggerendo un isolamento genetico rispetto ad altre popolazioni insulari o continentali. Lo studio dimostra quanto siano ancora frammentarie le conoscenze sulla distribuzione della chirotterofauna europea, ed evidenzia la necessità di intensificare le ricerche sulla fauna delle isole minori del Mediterraneo, veri laboratori naturali per lo studio della biodiversità, e oggi più che mai ecosistemi da proteggere.
Fonte: Ufficio stampa Cnr / NBFC-National Biodiversity Future Center/ Delos
Unrecente studio ha rilevato che le dimensioni e la forma del becco dei colibrì di Anna (Calypte anna), una specie originaria del Nord America, sono cambiate. Normalmente, i colibrì hanno un becco lungo e sottile, che consente di raggiungere il nettare nascosto nella profondità dei fiori. Negli ultimi decenni però i becchi dei colibrì di Anna si sono evoluti, diventando significativamente più lunghi e grandi, una conformazione che si adatta meglio ai dispenser con acqua e zucchero installati all’esterno di alcune abitazioni, molto diffusi nelle aree cittadine. L’adattamento suggerisce che queste strutture offrono ai colibrì più nutrimento rispetto al nettare dei fiori.

Lo studio, che ha esaminato le segnalazioni di avvistamenti e gli esemplari museali negli ultimi 160 anni, ha anche scoperto che i maschi stanno sviluppando becchi più appuntiti e affilati, forse per competere con gli altri colibrì per l’accesso agli abbeveratoi. … I cambiamenti morfologici dei colibrì sono avvenuti rapidamente. Secondo lo studio, le popolazioni di Calypte anna nel 1930 erano molto diverse da quelle del 1950, quando il becco degli uccelli aveva già iniziato a crescere. Nel giro di soli 20 anni, equivalenti a circa 10 generazioni, l’evoluzione ha lasciato il segno, osservano gli autori.
Per condurre la ricerca, il team ha utilizzato i dati degli avvistamenti della specie in tutte le 58 contee californiane tra il 1938 e il 2019 e ha analizzato gli esemplari conservati nei musei. Ma non solo: i ricercatori si sono basati anche sui vecchi giornali per stimare il numero di abbeveratoi in uso nel secolo scorso e hanno sviluppato un modello computazionale per prevedere l’espansione dei colibrì, tenendo conto dell’espansione dell’alimentazione assistita e della presenza di alberi di eucalipto. …
Fonte: https://www.wired.it/article/colibri-evoluzione-becco-citta-piccioni/







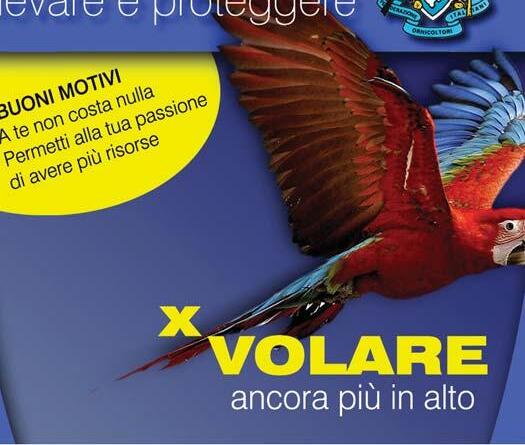




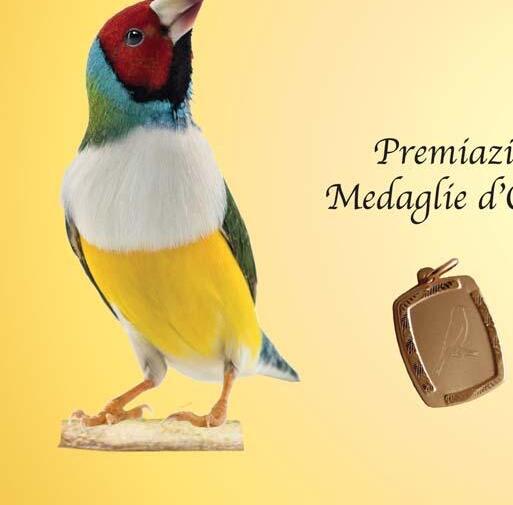






CAMPIONATO ITALIANO 2025
ASS.DILET.ORN.PARMENSE08PARMA 14/12/2521/12/25
MOSTRA INTERNAZIONALE
10ª MOSTRA ORNITOLOGICA INTERNAZIONALE C.O.M. IN ERCOLANO (EUROPEO C.O.M. COLORE 2025)
ASS.ORN.SALERNITANI APS02ERCOLANO12/10/2519/10/25 GARDA AVES SHOW (48ª EDIZIONE) - MOSTRA INTERNAZIONALE -
INTERNAZIONALE FRINGILLIDI ED AFFINI ANCHE MUTATI “DAL GARDA ALLE ALPI” -
INTERNAZIONALE TURDIDI E STURNIDI ANCHE MUTATI ASS.ORNIT.TRENTINA APS 10 RIVA DEL GARDA 22/10/25 26/10/25
8ª MOSTRA INTERNAZIONALE “TRE MARI DEL MEDITERRANEO"ASS.ORN.SUD BARESI06BARI27/10/2502/11/25
10ª MOSTRA ORNITOLOGICA INTERNAZIONALE DELLA CONCA D'ORO E CAMPIONATO EUROPEO SEZIONI “GH” FRINGILLIDI EUROPEI E LORO IBRIDI
ASS.ORN.TRINACRIA ONLUS 07 PALERMO 02/11/25 09/11/25
1ª INTERNAZIONALE DELLE ALPI OCCIDENTALIASS.ORNIT.CUNEESE09FARIGLIANO04/11/2509/11/25
84ª INTERNAZIONALE SOR SOCIETÀ ORNITOLOGICA REGGIANA APS 08 MODENA 15/11/25 23/11/25
CAMPIONATO REGIONALE O INTERREGIONALE ALI DORATE - CAMPIONATO INTERREGIONALE “LOMBARDIA-PIEMONTE/VALLE D'AOSTA - LIGURIA”
CAMPIONATO INTERREGIONALE APPULO-LUCANO DI ORNITOLOGIA
CAMPIONATO REGIONALE CALABRIA
46° CAMPIONATO ORNITOLOGICO REGIONALE CAMPANO (PER SEZIONE CANTOCAMPIONATO INTERREGIONALE CAMPANIA-LAZIO-MARCHE-UMBRIA-ABRUZZO-MOLISE)
ASS.ORN.BERGAMASCA 04CHIUDUNO08/10/2512/10/25
ASS.ORNIT.DEL POLLINO11CASTROVILLARI04/11/2509/11/25
ASSOCIAZIONE ORNIT. ACERRANA NOLANA APS 02 ACERRA 04/11/25 09/11/25
INTERREGIONALE “CUORE D'ITALIA” MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE LAZIOASS.ORN.ANCONETANA12CUPRAMONTANA06/11/2509/11/25 20° CAMPIONATO REGIONALE SICILIANO
ASS.ORN.AGRIGENTINA 07 AGRIGENTO 02/12/25 07/12/25 MOSTRA ORNITOLOGICA NAZIONALE
40ª MOSTRA ORNITOLOGICA CHIVASSO 2025ASS.CHIVASSESE ORN.09CHIVASSO25/09/2528/09/25 XXXVII MOSTRA ORNITOLOGICA PATERNESE & SPECIALISTICA
> SPECIALISTICA XXI INSECITVORAE (TURDIDI, STURNIDI E MUSCICAPIDI) E II FRINGILLIDI (FAUNA EUROPEA)
44ª MOSTRA ORNITOLOGICA CANAVESANA
ASS.ORN.PATERNESE 07 PATERNÒ 01/10/25 05/10/25
ASS.ORN.PATERNESE07PATERNÒ01/10/2505/10/25
ASS.ORNIT.CANAVESANA 09 LESSOLO 02/10/25 05/10/25
M.I.O.S. - MOSTRA ITALIANA ORNICOLTORI SPORTIVIA.O.B.A.04ABBIATEGRASSO02/10/2505/10/25
> SPECIALISTICA PASSERO DEL GIAPPONE - M.I.O.S. 2025 CLUB ITALIANO PASSERO DEL GIAPPONE 04 ABBIATEGRASSO 02/10/25 05/10/25
> SPECIALISTICA GLOSTER CANARY CLUB ITALIANOGLOSTER CANARY CLUB ITALIANO04ABBIATEGRASSO02/10/2505/10/25
43ª ESPOSIZIONE A.O.S. SASSUOLO
ASS.ORNIC.SASSOLESI APS 08 CASALGRANDE 02/10/25 05/10/25
> SPECIALISTICA CLUB DEL DIAMANTE CODALUNGA & POEPHILA CLUB DEL DIAMANTE CODALUNGA & POEPHILA 08CASALGRANDE02/10/2505/10/25
30ª MOSTRA ORNITOLOGICA CITTA DI AUGUSTA E 2ª EDIZIONE ARRICCIATI IN FESTA
ASS.ORNIT.MEGARA IBLEA 07 MELILLI 07/10/25 12/10/25
45' MOSTRA ORNITOLOGICA CITTÀ DI MARSALAASS. ORNIT. LILYBETANA07MARSALA07/10/2512/10/25
IV MOSTRA ORNITOLOGICA NAZIONALE ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA CENTRO SICILIA
DI SAN CATALDO
ASS.ORN. CENTRO SICILIA 07 SAN CATALDO 09/10/25 12/10/25
MOSTRA ORNITOLOGICA IN SICILIAASS.ORNIT.MISTERBIANCHESE07 MOTTA S. ANASTASIA 09/10/2512/10/25
48ª MOSTRA ORNITOLOGICA NAZIONALE
ASS.ORN.PORDENONESE 13 CORDENONS 09/10/25 12/10/25
> SPECIALISTICA GLOSTER CANARY CLUB ITALIANOGLOSTER CANARY CLUB ITALIANO13CORDENONS09/10/2512/10/25
> 3° SPINUS IN SHOW 25 - 3°LOXIA SHOW 25 HORNEMANNI MIDDLE EUROPEAN CLUB 13 CORDENONS 09/10/25 12/10/25
18ª MOSTRA ORNITOLOGICA “IL QUADRILATERO"ASS.ORNIT.LEGNAGHESE10CEREA09/10/2512/10/25
6° TRIANGOLARE ORNITOLOGICO 3° TROFEO DELL'ADRIATICO
ASS.ORN.RECANATESE 12 CASTELFIDARDO 09/10/25 12/10/25
> SPECIALISTICA CLUB DIAMANTE DI GOULD ITALIACLUB DEL DIAMANTE DI GOULD - ITALIA12CASTELFIDARDO09/10/2512/10/25
PSITTACUS & CO. 2025
ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA CANARIC 08 FORLÌ 09/10/25 12/10/25
> MOSTRA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB ITALIANO ALLEVATORI AGAPORNISCLUB ITALIANO ALLEVATORI AGAPORNIS08FORLÌ09/10/2512/10/25
> MOSTRA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB ITALIANO ALLEVATORI NYMPHICUS HOLLANDICUS CLUB ITALIANO ALLEVATORI NYMPHICUS HOLLANDICUS 08 FORLÌ 09/10/25 12/10/25
> SPECIALISTICA DI ASSOCIAZIONE DEL CANARINO DI COLORE ISABELLAASSOCIAZIONE ROMAGNOLA CANARIC08FORLÌ09/10/2512/10/25
> SPECIALISTICA DI ASSOCIAZIONE ALTRI PSITTACIFORMI ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA CANARIC 08 FORLÌ 09/10/25 12/10/25 > SPECIALISTICA DI ASSOCIAZIONE ONDULATI DI COLORE E FORMA E POSIZIONEASSOCIAZIONE ROMAGNOLA CANARIC08FORLÌ09/10/2512/10/25
28ª MOSTRA ORNITOLOGICA “CITTÀ DI ERICE” 2025
AS. VENERE ERICINA 07 TRAPANI 14/10/25 19/10/25
23ª MOSTRA ORNITOLOGICA NAZIONALE CITTÀ DI CALTANISSETTAASS. ORN. NISSENA07CALTANISSETTA15/10/2519/10/25
50ª MOSTRA ORNITOLOGICA SIRACUSANA
AS.NE ORNIT.SIRACUSANA 07 SIRACUSA 15/10/25 19/10/25
11° AVES EXPO DELLA VENEZIA ORIENTALE “SENZA CONFINI”ASS.ORN.VENETO ORIEN.10CAORLE15/10/2519/10/25
54ª MOSTRA ORNITOLOGICA “CITTÀ DI COSSERIA” (SV)
14 COSSERIA 15/10/25 19/10/25
MOSTRA ORNITOLOGICA GRUPPO LA FENICE ASS.SPORTIVA ORNIT.CORREGGESE08CORREGGIO16/10/2519/10/25
> SPECIALISTICA CLUB NEOPHEMA ITALIA & AUSTRALIAN GRASS PARROTS
CLUB NEOPHEMA ITALIA & AUSTRALIAN GRASS PARROTS 08 CORREGGIO

>SPECIALISTA DEL CANARINO OPALEASS.MODENESE ORN.08CORREGGIO16/10/2519/10/25
>SPECIALISTICA CLUB ITALIANO CANARINO AGATA CLUB ITALIANO CANARINO AGATA 08 CORREGGIO 16/10/25 19/10/25
>SPECIALISTICA CLUB DEL CANARINO PHAEO & TOPAZIOCLUB DEL CANARINO PHAEO E TOPAZIO08CORREGGIO16/10/2519/10/25
57ª MOSTRA ORNITOLOGICA MONSELICENSE LAROCCAASS.ORN.LA ROCCA10POLVERARA17/10/2519/10/25
>SPECIALISTICA
XV MOSTRA ORNITOLOGICA NAZIONALE DREPANUM APSASS.ORN.DREPANUM APS07TRAPANI21/10/2526/10/25
>SPECIALISTICA CLUB DEL CANARINO EUMO IN COLLABORAZIONE CON “DREPANUM APS” CLUB DEL CANARINO EUMO 07 TRAPANI 21/10/25 26/10/25
2ª MOSTRA ORNITOLOGICA NAZIONALE CITTÀ DI MALEO “SORVOLIAMO LA BASSA PADANA E L'EMILIA”
XXXVIIIª MOSTRA “CITTÀ DI AMANTEA” - IIª SPEC. DEL CANARINO DI RAZZA SPAGNOLAIIª SPEC. DEL CANARINO ARLECCHINO PORTOGHESE
ASS.ORN.BASSO LODIGIANO04MALEO22/10/2526/10/25
ASS.ORNIT.NEPETINA 11
>IIª SPECIALISTICA DI ASSOCIAZIONE DEL CANARINO DI RAZZA SPAGNOLAASS.ORNIT.NEPETINA11AMANTEA22/10/2526/10/25
>IIª SPECIALISTICA DI ASSOCIAZIONE DEL CANARINO ARLECCHINO PORTOGHESE
ASS.ORNIT.NEPETINA 11 AMANTEA 22/10/25 26/10/25
ASS. ORN. GELESE ASS.ORN.GELESE07GELA22/10/2526/10/25 ESOTICA 2025 - LATINA
ASS.ORNITOLOGICA LATINA 03 LATINA 22/10/25 26/10/25
66ª MOSTRA ORNITOLOGICA RAGUSANA + SPECIALISTICAASS.ORNIT.RAGUSANA07ISPICA23/10/2526/10/25
>SPECIALISTICA CLUB ITALIANO ALLEVATORI NYMPHICUS HOLLANDICUS
CLUB ITALIANO ALLEVATORI NYMPHICUS HOLLANDICUS 07 ISPICA
70ª MOSTRA ORNITOLOGIA A.P.A.C.O.A.P.A.C.O.09CERRO TANARO23/10/2526/10/25
48°MOSRA ORNITOLOGICA C.O.V.V. 09 SERRAVALLE SESIA 23/10/25 26/10/25 PIUME 2025
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE LIPOCROMICO MOSAICO - “MOSAICO IN MOSTRA” PIUME 2025
ASS.ORN.CESENATE APS08CESENA23/10/2526/10/25
>SPECIALISTICA CLUB DEL CANARINO PERLACLUB DEL CANARINO NERO PERLA08CESENA23/10/2526/10/25
>MOSTRA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE DEL CLUB RHEINLANDER - PIUME 2025 CLUB ITALIANO DEL CANARINO RHEINLANDER 08
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB AMICI DEL SALENTINOCLUB AMICI DEL SALENTINO08CESENA23/10/2526/10/25
>SPECIALISTA DEL CANARINO JASPE CLUB ITALIANO DEL CANARINO JASPE
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE DIAMANTE DI GOULD - “GOULDMANIA” PIUME 2025ASS.ORN.CESENATE APS08CESENA23/10/2526/10/25
>SPECIALISTICA ARRICCIATO DEL NORD CLUB ITALIANO - PIUME CESENA ARRICCIATO DEL NORD CLUB ITALIANO 08
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE DEL CANARINO MALINOIS WATERSLAGER - PIUME 2025ASS.ORN.CESENATE APS08CESENA23/10/2526/10/25
>MOSTRA SPECIALISTICA CLUB ITALIANO DEL CANARINO OPALE CLUB ITALIANO
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE DEL CANARINO SELVATICO ED ALTRI SERINUS - PIUME 2025ASS.BOLOGNESE DI CAN. APS08CESENA23/10/2526/10/25
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB CANARINO LIPOCROMICO FATTORE GIALLO - PIUME 2025 CLUB CANARINO LIPOCROMICO GIALLO 08 CESENA 23/10/25
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALECLUB CANARINO RASMI PERSIAN - PIUME 2025CLUB CANARINO RASMI PERSIAN08CESENA23/10/2526/10/25
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE DEL CANARINO LIPOCROMICO A FATTORE BIANCO “PIUME 2025"
ITALIANO DEL CANARINO LIPOCROMICO A FATTORE BIANCO
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB VERDONE CROCIERE CIUFFOLOTTO MESSICANOPIUME 2025 CLUB VERDONE CROCIERE CIUFFOLOTTO MESSICANO 08CESENA23/10/2526/10/25
>SPECIALISTICA
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CANARINO LIPOCROMICO A FATTORE ROSSO - PIUME 2025ASS.ORNIT.FAENTINA APS08CESENA23/10/2526/10/25
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE ZEBRAVINKEN CLUB - PIUME 2025 ITALIAN ZEBRAVINKEN
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB DELL'ESOTICO - PIUME 2025CLUB DELL’ESOTICO08CESENA23/10/2526/10/25
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB ITALIANO RAZZA SPAGNOLA - PIUME 2025
ITALIANO RAZZA SPAGNOLA
>MOSTRA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE DEL CLUB ITALIANO CANARINO LANCASHIRE - PIUME 2025 CLUB ITALIANO CANARINO LANCASHIRE08CESENA23/10/2526/10/25
>SPECIALISTICA DEL CLUB CANARINO AGATA CLUB ITALIANO CANARINO AGATA 08 CESENA 23/10/25 26/10/25
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE IRISH CLUB - PIUME 2025IRISH CANARY CLUB ITALIA08CESENA23/10/2526/10/25
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB ITALIANO ALLEVATORI NYMPHICUS HOLLANDICUS - MOSTRA ORNITOLOGICA “PIUME 2025" CLUB ITALIANO ALLEVATORI NYMPHICUS HOLLANDICUS
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB CIUFFATO TEDESCO - PIUME 2025CLUB CIUFFATO TEDESCO08CESENA23/10/2526/10/25
>SPECIALISTICA CLUB DEL CANARINO EUMO “PIUME” CLUB DEL CANARINO EUMO 08 CESENA 23/10/25 26/10/25
>SPECIALISTICA CLUB ARRICCIATO PADOVANO - PIUME 2025CLUB ARRICCIATO PADOVANO08CESENA23/10/2526/10/25
>MOSTRA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB FIFE FANCY - PIUME 2025 FIFE FANCY CANARY CLUB ITALIANO
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB ITALIANO PASSERO DEL GIAPPONECLUB ITALIANO PASSERO DEL GIAPPONE08CESENA23/10/2526/10/25
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB ITALIANO DEL CANARINO CLUB ITALIANO ARLECCHINO 08
>MOSTRA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE SCOTCH CANARY
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB ITALIANO CRESTED

>SPECIALISTICA DELLO JASPE CLUB ITALIANO DEL CANARINO JASPE 11REGGIO DI CALABRIA28/10/2502/11/25
>“MOSAICO IN MOSTRA” CLUB DEL MOSAICO 11 REGGIO DI CALABRIA 29/10/25 02/11/25 MOSTRA ORNITOLOGICA NAZIONALE - 2° NEBRODI BIRD SHOW 2025 + 3 SPECIALISTICHEASS.ORNIT.DEI NEBRODI APS 7TORRENOVA29/10/2502/11/25
>NEBRODI BIRD SHOW SPECIALISTICA CLUB ESOTICO CLUB DELL’ESOTICO 7 TORRENOVA 29/10/25 02/11/25
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB ITALIANO LLARGUET CLUB ITALIANO LLARGUET SPAGNOLO 7TORRENOVA31/10/2502/11/25
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB ITALIANO ARLECCHINO PORTOGHESE CLUB ITALIANO ARLECCHINO PORTOGHESE 07 TORRENOVA 31/10/25 02/11/25
51ª MOSTRA ORNITOLOGICA NAZIONALE ETNEA - “CITTÀ DI CATANIA” + 3 SPECIALISTICHEASS.ORN.ETNEA 7CATANIA29/10/2502/11/25
>SPECIALISTICA VERDONE, CROCIERE, CIUFFOLOTTO, CARPODACO CIUFFOLOTTO MESSICANO CLUB VERDONE CROCIERE 7 CATANIA 29/10/25 02/11/25
>SPECIALISTICA CANARINO RAZZA SPAGNOLA CLUB ITALIANO RAZZA SPAGNOLA 7CATANIA31/10/2502/11/25
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB ITALIANO DEL CARDELLINO, MUTATO E DA CANTO CLUB ITALIANO DEL CARDELLINO, 7 CATANIA 31/10/25 02/11/25
54ª MOSTRA ORNITOLOGICA DELLA CASTELLANAASS.CASTELL.ORN.10CASTELFRANCO V.TO30/10/2502/11/25
2° MEETING ORNITOLOGICO ALPE ADRIA ASS.ORNIT.FRIULANA 13 MARTIGNACCO 30/10/25 02/11/25
>SPECIALISTICA CLUB DEL FIORINO - MARTIGNACCOCLUB DEL FIORINO13MARTIGNACCO30/10/2502/11/25
5ª MOSTRA ORNITOLOGICA “CITTÀ DI NOTO” + 2 SPECIALISTICHE
ASS. ORN. VAL DI NOTO APS 07 NOTO 30/10/25 02/11/25
>SPECIALISTICA CLUB ZEBRAVINKEN ESOTICOITALIAN ZEBRAVINKEN CLUB07NOTO30/10/2502/11/25
>SPECIALISTICA DIAMANTE MANDARINO CLUB ESOTICO CLUB DELL’ESOTICO 07 NOTO 30/10/25 02/11/25
MOSTRA ORNITOLOGICA VALCONCA 2025ASS.ADRIATICA ALLEV.08MORCIANO DI ROMAGNA30/10/2502/11/25
>SPECIALISTICA ARRICCIATO DEL NORD CLUB ITALIANO ARRICCIATO DEL NORD CLUB ITALIANO 08 MORCIANO DI
>MOSTRA ORNITOLOGICA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE FRINGILLIA - IBRIDIAASS.ADRIATICA ALLEV.08MORCIANO DI ROMAGNA31/10/2502/11/25
>SPECIALISTICA CLUB DIAMANTE DI GOULD ITALIA CLUB DEL DIAMANTE DI GOULD ITALIA 08 MORCIANO DI ROMAGNA 31/10/25 02/11/25
>MOSTRA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB CARDINALINO ED ALTRI SPINUS CLUB ITALIANO CARDINALINO DEL VENEZUELA ED ALTRI SPINUS
>SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB VERDONE CROCIERE CIUFFOLOTTO MESSICANOFRINGILLIA 2025 CLUB VERDONE CROCIERE CIUFFOLOTTO MESSICANO 08 MORCIANO DI ROMAGNA 31/10/25 02/11/25
>MOSTRA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE DEL CLUB ITALIANO DEL CARDELLINO, MUTATO E DA CANTO CLUB ITALIANO DEL CARDELLINO, MUTATO E DA CANTO 08MORCIANO DI ROMAGNA31/10/2502/11/25
>SPECIALISTICA CLUB DEL CANARINO SELVATICO CLUB DEL CANARINO SELVATICO 08 MORCIANO DI ROMAGNA 31/10/25 02/11/25
>MOSTRA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB AGICLUB ARRICCIATO GIGANTE ITALIANO08MORCIANO DI ROMAGNA31/10/2502/11/25
42ª MOSTRA ORNITOLOGICA DI CITTÀ DI AVOLA
ASS.ORNIT.AVOLESE 07 AVOLA 04/11/25 09/11/25
2ª MOSTRA A.O.M. & A.O.C.ASS.ORN.MONZESI04BELLUSCO05/11/2509/11/25
>INTERNAZIONALE LIZARD CANARY CLUB ITALIANO -BELLUSCO (MONZA) LIZARD CANARY CLUB ITALIANO 04 BELLUSCO 05/11/25 09/11/25
>“MOSAICO IN MOSTRA” BELLUSCO MONZACLUB DEL MOSAICO04BELLUSCO05/11/2509/11/25 MOSTRA CITTÀ DI SASSARI
ASS.ORNIT.SASSARI 15 SASSARI 05/11/25 09/11/25
62ª MOSTRA ORNITOLOGICA “CONTATTO NATURA” - 3° SPETTACOLO DEL GLOSTERA.P.O.V.10BREGANZE06/11/2509/11/25
65ª ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA FERRARESE E 17ª MOSTRA ORNITOLOGICA NAZIONALE
DELL'EMILIA ORIENTALE
SOCIETÀ ORNITOLOGICA FERRARESE APS 08 ARGENTA 06/11/25 09/11/25
>MOSTRA SPECIALISTICA DI ASSOCIAZIONE “ARRICCIATO DEL NORD"SOCIETÀ ORNITOLOGICA FERRARESE APS08ARGENTA06/11/2509/11/25
>MOSTRA SPECIALISTICA DI ASSOCIAZIONE “LIPOCROMICO MOSAICO"
SOCIETÀ ORNITOLOGICA FERRARESE APS 08 ARGENTA 06/11/25 09/11/25
47ª MOSTRA NAZIONALE “COLORI NEL VENTO” 3ª EDIZIONEAS.FIORENTINA ORN.05CALENZANO06/11/2509/11/25
>SPECIALISTICA CANARINO RAZZA SPAGNOLA CLUB ITALIANO RAZZA SPAGNOLA 05 CALENZANO 07/11/25 09/11/25
>MOSTRA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB FIFE FANCYFIFE FANCY CANARY CLUB ITALIANO05CALENZANO07/11/2509/11/25
>“MOSAICO IN MOSTRA” CALENZANO (FI) CLUB DEL MOSAICO 05 CALENZANO 08/11/25 09/11/25
MOSTRA ORNITOLOGICA NAZIONALE 2025 ACESE E MESSINESE + SPECIALISTICAASS.ORNITOl.ACESE 07LETOJANNI12/11/2516/11/25
>SPECIALISTICA DIAMANTE CODALUNGA E POEPHILA CLUB DEL DIAMANTE CODALUNGA & POEPHILA 07 LETOJANNI 12/11/25 16/11/25
12ª MOSTRA ORNITOLOGICA - LAIVES A.S.A.U.-V.S.V. 10LAIVES 12/11/2516/11/25
3ª MOSTRA ORNITOLOGICA CITTÀ DI PRAIA A MARE
74ª MOSTRA ORNITOLOGICA DI PADOVA 13ª MOSTRA ORNITOLOGICA CITTÀ DI MONTEGROTTO TERME
>SPECIALISTICA CLUB ARRICCIATO PADOVANO
MOSTRA ORNITOLOGICA TERRALBA
2ª MOSTRA ORNITOLOGICA SANNITA
MOSTRA CITTÀ DI CAGLIARI
ASS. ORN. ISOLA DI DINO APS 11 PRAIA A MARE 12/11/25 16/11/25
ASS.PADOVANA ORN.10MONTEGROTTO TERME13/11/2516/11/25
CLUB ARRICCIATO PADOVANO 10 MONTEGROTTO TERME 13/11/25 16/11/25
ASS.ORN.ARBORENSE 15TERRALBA19/11/2523/11/25
ASS.ORNIT. SANNITA APS 2 MONTESARCHIO 26/11/25 30/11/25
ASS.ORNIT.SARDA 15QUARTUCCIU03/12/2507/12/25 IV MOSTRA ORNITOLOGICA NAZIONALE CITTÀ DI PONTECORVO
B. FAVOCCIA 03 PONTECORVO 04/12/25 07/12/25 >MOSTRA SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB ITALIANO CANARINO LANCASHIRE CLUB ITALIANO CANARINO LANCASHIRE 03PONTECORVO 05/12/2507/12/25 >MOSTRA SPECIALISTICA

>SPECIALISTICA GENERE ERYTHRURA PARROT FINCHES EUROPEAN CLUBPARROT FINCHES EUROPEAN CLUB01LANCIANO03/09/2507/09/25
>SPECIALISTICA DIAMANTE CODALUNGA E POEPHILA
SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB AMICI DELL'ONDULATO 2025CLUB AMICI DELL'ONDULATO08REGGIO NELL'EMILIA12/09/2514/09/25
SPECIALISTICA INTERNAZIONALE CLUB DELL'ESOTICO - ZEBRAS 2025 CLUB DELL’ESOTICO 08 REGGIO NELL'EMILIA 19/09/25 21/09/25
SPECIALISTICA INTERNAZIONALE PASSERO DEL GIAPPONE - ZEBRAS 2025CLUB ITALIANO PASSERO DEL GIAPPONE08REGGIO NELL'EMILIA19/09/2521/09/25
SPECIALISTICA INTERNAZIONALE ITALIAN ZEBRAVINKEN CLUB - ZEBRAS 2025
SPECIALISTICA INTERNAZIONE DI CLUB NEOPHEMA ITALIA &. “MY PARROT”
SPECIALISTICA INTERNAZIONE CLUB DEL PSITACCIDI “MY PARROT”
8° EUROPEAN GLOSTER SHOW PEDARA
ITALIAN ZEBRAVINKEN CLUB 08 REGGIO NELL'EMILIA 19/09/25 21/09/25
CLUB NEOPHEMA ITALIA & AUSTRALIAN GRASS PARROTS 09AIRASCA30/10/2502/11/25
SHOW” SPECIALE PSITTACIDIASS.ORN.SALENTINA06CALIMERA13/06/2515/06/25
MOSTRA SPERIMENTALE “BIRDS SHOW” SPECIALE ONDULATI ASS.ORN.SALENTINA
>SPECIALISTICA ZEBRAVINKEN
>SPECIALISTICA DIAMANTE CODALUNGA E POEPHILA CLUB DEL DIAMANTE CODALUNGA & POEPHILA 06CALIMERA13/06/2515/06/25
MOSTRA NAZIONALE DEL DIAMANTE DI GOULD ASS.ORN.DI FRANCIACORTA 04 TRAVAGLIATO
>SPECIALISTICA CLUB DIAMANTE DI GOULD ITALIACLUB DEL DIAMANTE DI GOULD - ITALIA04TRAVAGLIATO11/09/2514/09/25 I COLORI DEL SUD AS.NE ORNIT.SIRACUSANA 07 SIRACUSA 25/09/25 28/09/25
>SPECIALISTICA GENERE ERYTHRURA PARROT FINCHES EUROPEAN CLUBPARROT FINCHES EUROPEAN CLUB07SIRACUSA25/09/2528/09/25
>SPECIALISTICA CLUB DIAMANTE DEL GOULD CLUB DEL DIAMANTE DI GOULD - ITALIA 07 SIRACUSA 25/09/25 28/09/25
SPECIALISTICA AGAPORNIS + CLUB AMICI DELL'ONDULATOASS.ROMANA ORN.03APRILIA26/09/2528/09/25
>SPECIALISTICA CLUB AMICI DELL'ONDULATO CLUB AMICI DELL'ONDULATO
SPECIALISTICA CLUB ARRICCIATO DEL SUD E GIBBER ITALICUS
ARRICCIATO DEL SUD E GIBBER ITALICUS 07TORRETTA23/10/2526/10/25 COLORI AL SUD ASS.ORN.SUD BARESI 06 GIOIA DEL COLLE 29/11/25 30/11/25 >“MOSAICO IN MOSTRA"”CLUB