
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettuura
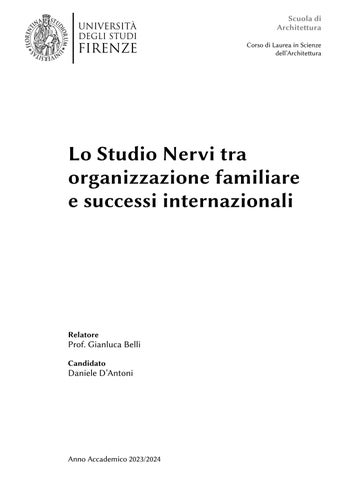

Corso di Laurea in Scienze dell’Architettuura
Relatore
Prof. Gianluca Belli
Candidato
Daniele D’Antoni
È il 2010 quando l’architettoo Italo Domenico Castore dona alla biblioteca di Scienze Tecnologiche di Firenze un totale di oltre 4000 negativi provenienti dallo “Studio Nervi architettoura e tecnica edilizia”1
L’architettoo Castore, laureatosi in architettoura a Firenze nel 1966, lavora con alcuni degli eredi di Pier Luigi Nervi all’inizio degli anni ottoanta e, fiano al momento della donazione, conserva questi materiali nel suo studio a Milano. I materiali gli sono pervenuti dopo che, nel 19812, a seguito della morte di Pier Luigi Nervi e del primogenito Antonio, lo Studio Nervi è stato defianitivamente chiuso. Castore propone così al fiaglio, l’Ing. Mario Nervi, e al nipote Pier Luigi Nervi junior, di creare uno studio associato con sedi in Italia e all’estero; viene così fondata nel 1984 “PIER LUIGI NERVI & ASSOCIATES. Architects, Engineers, Planners”. L’obbiettoivo dell’architettoo Castore è quello di sfruttoare le sue conoscenze negli Stati Uniti e la fama del cognome Nervi per creare uno studio internazionale. La cosa si rivela però più complessa del previsto e, anche a causa dei problemi di salute di Mario, la società chiude nel 1986.
Con l’occasione i materiali, ancora conservati, della “Società Ingg. Nervi & Bartoli” vengono donati allo CSAC di Parma dove si trovano ancora oggi. Dalla donazione sono esclusi tuttoi i materiali di proprietà dello “Studio Nervi Architettoura e Tecnica Edilizia”3; questi vengono in parte donati alla Fondazione Maxxi mentre una quantità consistente di negativi fianisce all’architettoo Italo Castore.
È poi la conoscenza con il professor Francesco Ventura, professore ordinario di urbanistica all’Università di Firenze a portarlo, al momento della chiusura dello studio, a donare i materiali proprio alla biblioteca di Scienze Tecnologiche fiaorentina.
Il fondo contiene una vasta serie numerata, incompleta, di negativi la cui osservazione rende chiara la volontà di Pier Luigi Nervi di creare un archivio per documentare i processi costruttoivi dei suoi edifiaci. Le immagini presenti nel fondo sono infattoi chiaramente realizzate con lo scopo di mantenere viva la memoria delle diverse fasi costruttoive e non di mostrare le tecniche costruttoive; lo dimostra il fattoo che quasi tuttoe le fotografiae sono realizzate con campi molto larghi e non rappresentano processi costruttoivi ma lo stato dei lavori a una determinata data.
Ai negativi di cantiere se ne aggiungono molti altri raffigguranti progettoi realizzati, progettoi non realizzati di studio o di concorso, plastici e modelli, tavole architettooniche o
1 httops://archivi.unifia.it/patrimonio/9587714f6-d11f-4987-ba0c-d35e0ddacb45/fondo-nervi-pier-luigi
2 MARGANI, L., NERVI, I. (a cura di), AntonioNerviiniziosuccessoepilogodellostudioNervi, Euno Edizioni, Leonforte (EN), 2023, pp. 26
3 IORI, T., “Il sistema Nervi”. In: BIANCHINO, G., COSTI, D., CantiereNervilacostruzionedi un’identità.Storie,geografiae,paralleli, Skira, Ginevra-Milano, 2012, pp. 54
struttourali e ritrattoi dell’ingegner Pier Luigi Nervi e dei suoi collaboratori o committoenti. La documentazione inizia dal 1966, in corrispondenza dell’inizio dei lavori per l’Aula delle Udienze Pontifiacie, e arriva presumibilmente fiano alla chiusura dello studio.
Di tuttoi questi progettoi quello più documentato è senza dubbio il progettoo sopracitato realizzato in Vaticano di cui sono presenti moltissime foto di cantiere, dagli scavi delle fondazioni all’edifiacio fianito e anche molte tavole esecutive oltre ad alcuni interessantissimi schizzi realizzati in prima persona da Pier Luigi Nervi. L’ingegnere era solito raffiggurare rapidamente attoraverso bozzettoi le sue idee; affigdava poi ai suoi dipendenti (solitamente a Pino Nicolettoi4) la realizzazione dei disegni defianitivi.
L’elemento che più colpisce nell’osservazione del fondo è però il dettoaglio, presente in quasi tuttoe le tavole, della mascherina posizionata in basso a destra che recita “Studio Nervi architettoura e tecnica edilizia” e subito sottoo “cav. lav. dr. ing. PIER LUIGI NERVI, dr. arch. ANTONIO NERVI, dr. ing. Mario Nervi, dr. arch. VITTORIO NERVI” (fiagura 1)

Figura1:mascherinadelloStudioNervi
Fonte:BibliotecadiScienzeTecnologiche,Firenze,fondoNervi
Certo ci sarebbe poco da stupirsi nel trovare come titolari di uno studio di piccole dimensioni un padre e tre dei suoi fiagli, la cosa però risulta a dir poco atipica se si considera la fama dello studio e la quantità di progettoi internazionali che lo interessano.
Queesta tesi cercherà dunque, nelle pagine seguenti, di fornire un quadro sulla struttoura e l’identità di uno degli studi italiani più influuenti del XX secolo. Per farlo verranno analizzati alcuni dei testi sull’Ingegner Pier Luigi Nervi, parte dei numerosi negativi presenti nella Biblioteca di Scienze Tecnologiche di Firenze e parte di quelli conservati negli archivi del MAXXI, a Roma, con particolare attoenzione sul progettoo dell’Aula delle Udienze Pontifiacie realizzata tra il 1966 e il 1971.
4 MARGANI, L., “Il mio nome è Luigi ma chiamatemi pure Pier Luigi”. In: NUTI, F., (a cura di) Raccontidicantiereprogettoare/costruire, Edizioni Polistampa, Firenze, 2014, pp. 105-107
Con un articolo pubblicato su laRepubblica il 22 dicembre del 1999 Armando Besio descrive Pier Luigi Nervi dicendo che “aveva l’audacia dell’ingegnere, la fantasia dell’architettoo e la concretezza del costruttoore”. Sarebbe infattoi impossibile defianire Nervi solamente come ingegnere, come architettoo o come costruttoore, o provare a scindere questi tre ruoli.
Per comprendere a pieno questa polivalenza è necessario conoscere a fondo la storia dell’ing. Nervi. È il 21 giugno del 1891 quando Luisa Bartoli, moglie di Antonio Nervi, dà alla luce Pier Luigi. La coppia si trova in quel momento a Sondrio per via del lavoro di Antonio ma ha origini liguri. Antonio Nervi di lavoro fa il direttoore postale e questo lo porta a spostarsi spesso per lavoro seguito dalla famiglia; sono proprio i continui spostamenti per motivi lavorativi del padre a portare Pier Luigi a frequentare l’Università di Bologna dove si laurea nel 1913 in Ingegneria civile. È a Bologna che conosce Attoilio Muggia, suo professore e primo datore di lavoro alla “Società per Costruzioni Cementizie” di cui è direttoore. La società si occupa esclusivamente di costruzioni in cemento armato ricorrendo al ‘SystémeHennebique’; un sistema di invenzione francese basato su un nuovo metodo di posa delle armature che rendeva molto più effigcienti gli edifiaci in cemento armato.
In questa prima fase della sua carriera Pier Luigi lavora nella sede di Firenze e gli vengono affigdate molte responsabilità, anche per opere complesse. Nel 1919 realizza quello che lui stesso (come specifiaca spesso nei suoi libri “Scienza o arte del costruire?” e “Costruire Correttoamente”) considera il suo primo progettoo: la copertura del salone per il gioco della Pelota. L’opera si inserisce nel grande complesso, costruito nel 1889 in Piazza Beccaria a Firenze, del Teatro Alhambra5 Queando nel 1919 il complesso fu espanso con la costruzione di un nuovo teatro e di una sala per il gioco della pelota, entrambe affigdate all’architettoo Luigi Coppedè, fu chiamata come dittoa la “Società per Costruzioni Cementizie” di cui Pier Luigi Nervi era diventato direttoore della sede fiaorentina. L’opera è stata demolita nel 1961 e lo stesso destino è toccato al ponte sul fiaume Cecina, realizzato sempre da Nervi per la “Società per Costruzioni Cementizie” tra 1920 e 1923 e demolito nel 2001.
Si può ragionevolmente supporre che sia proprio questo primo periodo della carriera del giovane a condizionare la visione che Nervi per tuttoa la vita avrà di sé stesso. Il titolo di ingegnere è infattoi il primo che gli viene conferito e non è un caso che, anche dopo aver ricevuto numerose lauree adhonoremin architettoura, continui a fiarmarsi esclusivamente “ing.”. Nervi non disprezza affaattoo gli architettoi e non rinnega certo le lauree conferitegli honoris causa arrivando anche a considerarsi in prima persona un architettoo; nei 5 httops://www.conoscifiarenze.it/come-vivevamo-a-fiarenze/45-teatro-alhambra-scomparso.html
documenti uffigciali tuttoavia continua, per tuttoa la vita, a fiarmarsi ingegnere memore della sua formazione. Il modo in cui Nervi agisce successivamente però lascia intendere chiaramente il fattoo che a lui, prima di tuttoi gli altri, la defianizione di ingegnere sta decisamente strettoa
Nel 1923 ormai ricco di un’esperienza decennale, lascia la società del suo professore e ne apre una propria insieme a Rodolfo Nebbiosi: la “Società Ingg. Nervi & Nebbiosi” con sede in Lungotevere Marzio 1 a Roma. Pur avendo spostato la sede in un’altra cittoà però gran parte dei lavori di cui Nervi si occupa in questo periodo restano in Toscana dove negli anni precedenti si era fattoo conoscere. Costruisce molti edifiaci soprattouttoo nella zona industriale di Prato; ne sono esempi il Teatro Bruno Banchini, il lanifiacio Orlando Franchi, il lanifiacio Luigi Pecci e moltissimi altri lanifiaci. Queeste opere sono le prime in cui inizia a venir fuori il singolare linguaggio nerviano; l’ingegnere comincia a edifiacare struttoure in cui l’uso dei materiali è ridottoo al minimo e la stabilità è garantita più dalle forme che dalle masse. Per questo motivo inizia a prediligere il cemento armato la cui forma può essere modellata dal progettoista in base alla necessità.
In quegli anni la fama della Nervi & Nebbiosi a Prato è straordinaria6, aiutata anche dalla forte crescita del settoore industriale della cittoà, e aiuta l’ingegnere nato a Sondrio a farsi conoscere in tuttoa Italia; nel 1926 e 1927 la società si occupa della costruzione del Teatro Augusteo di Napoli e subito dopo, con l’affaermazione della società, i due commissionano tra 1928 e 1932 la costruzione di una palazzina a Giuseppe Capponi. Paolo Portoghesi defianirà questa un’opera che “segna il passaggio dalla fase aulica a quella razionalista”7 nel panorama romano. La palazzina viene costruita in Lungotevere Arnaldo da Brescia 9. Il periodo all’interno della società Nervi e Nebbiosi proiettoa l’ing. Nervi verso un panorama nazionale; non lavora più solo in Toscana ma opera su tuttoo il suolo italiano.
Nel 1932 la “Società Ingg. Nervi & Nebbiosi” viene sciolta, per via della morte di Nebbiosi; viene fondata nello stesso anno la “Società Ingg. Nervi & Bartoli”, aperta proprio assieme al cugino Giovanni Bartoli, anche lui ingegnere. La sede rimane quella di Lungotevere Arnaldo da Brescia.
Queesto periodo, iniziato nel 1923 con l’apertura della “Società Ingg. Nervi & Nebbiosi”, per Nervi rappresenta il primo passo verso un modo di gestire i progettoi che comprende tuttoe le fasi di progettoazione e costruzione; non è più un dipendente al servizio di un’azienda e quindi diventa fondamentale saper gestire in prima persona tuttoe le scelte che devono essere prese, sia progettouali che economiche. In questo periodo Nervi smettoe di essere solo un ingegnere e diventa anche costruttoore, cosa che lo porta inevitabilmente ad aprire gli occhi sui limiti dell’ingegneria per come gli è stata insegnata all’università.
6 GUANCI, G., Costruzioni&sperimentazionel’attoivitàdelgiovanePierLuigiNerviaPrato,CGE, Firenze, 2008, p. 47
7 httops://www.rerumromanarum.com/2019/12/palazzina-nebbiosi.html
I primi anni della società Nervi & Bartoli però sono anche quelli di consacrazione per Pier Luigi ad architettoo internazionale grazie, soprattouttoo, alla costruzione tra il 1930 e il 1932 dello Stadio G. Berta (oggi Stadio A. Franchi) a Firenze. L’opera diventa da subito uno dei simboli del nuovo stile italiano, tanto che il critico Sigfried Giedion la identifiacherà come il sintomo di un “risveglio italiano” nel campo dell’architettoura.
Si trattoa di uno stadio di grandi dimensioni costruito interamente in cemento armato al cui interno sono tre gli elementi che più scuotono il panorama internazionale: le scale elicoidali, la torre di maratona e la tribuna coperta. Tuttoi e tre gli elementi appaiono come un invito dell’ingegnere a esplorare le possibilità offaerte dal cemento armato; le scale suggeriscono la volontà di superare i limiti imposti dalle casseforme, la torre e la tribuna invitano invece ad esplorare i limiti statici di questo materiale.
Nervi diventa così uno dei punti di riferimento nella discussione sulla modernità in Italia venendo citato in numerosissimi articoli su riviste nazionali e internazionali. È poi la serie delle aviorimesse costruite nel decennio precedente il secondo confluittoo mondiale a delineare un vero e proprio registro stilistico, basato sull’uso di forme determinate in base alla sollecitazione della struttoura, nelle opere di Pier Luigi. È proprio con il progettoo delle aviorimesse che Nervi elabora la prima copertura nervata, elemento che diverrà poi carattoeristico di alcune delle sue opere più riuscite come il lanifiacio Gattoi o il palazzettoo dello Sport a Roma.
Nel frattoempo Nervi ha sposato nel 1924 Irene Calosi con la quale avrà quattoro fiagli: Antonio, Mario, Carlo (unico dei quattoro che non lavorerà col padre) e Vittoorio. La sua splendida relazione con la famiglia è l’elemento chiave per la fondazione dello studio.
Antonio, primogenito, inizia a lavorare saltuariamente fian da quando aveva sedici anni nell’impresa di famiglia mentre studia. Si laurea in architettoura nel 1950 e diventa uffigcialmente un dipendente dell’impresa, fiano al 1953. Negli stessi anni, tra il 1949 e il 1953 lavora presso l’impresa anche Sergio Musmeci (autore negli anni successivi di opere straordinarie come il ponte sul Basento) che ha modo di stringere uno strettoo rapporto con Antonio fiano ad arrivare ad aprire con lui lo “Studio di architettoura e tecnica edilizia” in cui Pier Luigi risultava esclusivamente come consulente. Solo un anno dopo però Sergio Musmeci lascia lo studio e Pier Luigi entra a pieno titolo a farne parte. Il nome rimane però invariato e solamente nel 1959, dopo la laurea di Mario Nervi in Ingegneria Civile ed Aeronautica e quella di Vittoorio Nervi in architettoura, lo studio si estende (oltre che al padre) ai tre fiagli venendo uffigcialmente rinominato “Studio Nervi Architettoura e Tecnica Edilizia”.
Lo studio ha come sede la palazzina in Lungotevere Arnaldo da Brescia 9. Nella stessa palazzina sono insediati, al piano terra la “Società Ingg. Nervi & Bartoli”, al primo piano
lo “Studio Nervi Architettoura e Tecnica Edilizia” e, al secondo piano, l’abitazione privata della famiglia Nervi8
L’apertura dello studio però non è il primo momento in cui Nervi assume il ruolo di architettoo, oltre che di ingegnere e costruttoore. Nel 1953 sono già stati costruiti lo stadio comunale di Firenze, le serie delle aviorimesse, il Palazzo delle Esposizioni a Torino e moltissimi altri edifiaci che proiettoano l’ingegnere verso l’Olimpo dell’architettoura di quegli anni. Addirittoura Sergio Porettoi parlando della carriera da architettoo di Pier Luigi scrive un articolo dal titolo “Nervi che visse tre volte”9 .
Porettoi considera “prima vita” il periodo che va dalla laurea in ingegneria a Bologna fiano all’inizio del secondo confluittoo mondiale. La fase in cui Nervi si fa conoscere e elabora un suo stile.
La seconda vita è una vita di sperimentazione, non più delle forme, ma delle tecniche costruttoive; è in questo periodo che nasce il “Sistema Nervi” e viene brevettoato il “ferrocemento”, due tecnologie che saranno approfondite più avanti all’interno di questa tesi e che permettoono a Nervi di continuare la sua ascesa nel contesto di grande crisi che colpisce l’Italia nell’immediato dopoguerra.
Ad aiutare lo Studio Nervi in questa fase così complessa è però anche il livello internazionale che ha ormai raggiunto Pier Luigi nella metà degli anni cinquanta. Inizia così la terza vita di Nervi da progettoista di fama mondiale. A segnare l’inizio di questa terza fase è indubbiamente la costruzione della nuova sede per l’UNESCO a Parigi. A sovraintendere la progettoazione sono Costa, Gropius, Le Corbusier, Markelius e Rogers che, dopo accesi dibattoiti che non verranno qui approfonditi10, decidono di designare per la progettoazione Marcel Breuer, Bernard Zehrfuss e Pier Luigi Nervi.
Il ruolo principale dell’italiano in questo progettoo è quello di consulente struttourale ma come ci si poteva aspettoare dal suo passato Nervi non si limita a questo. Il risultato è un edifiacio che si sviluppa su tre ali che partono tuttoe da un unico fulcro centrale col fiane di garantire la massima esposizione alla luce di tuttoi gli spazi interni. Il materiale scelto è chiaramente il cemento armato faccia a vista usato in modo ancor più ardimentoso dei progettoi precedenti: il paraboloide che copre l’ingresso, la copertura nervata della sala delle assemblee e i pilastri a sezione variabile sono segni evidenti della maturazione ormai raggiunta dall’ingegnere italiano.
8 MARGANI, L., “Il mio nome è Luigi ma chiamatemi pure Pier Luigi”. In: NUTI, F., (a cura di) Racconti…cit, pp. 105-107
9 PORETTI, S., “Nervi che visse tre volte”. In: PORETTI, S., IORI, T., L’ambasciatad’ItaliaaBrasilia, Mondadori Electa S.p.A., Verona, 2007, pp. 9-53
10 L’argomento viene approfondito in BERGDOLL, B., “Into the fold: Nervi, Breuer and a Post-war Architecture of Assembly”. In: OLMO, C., CHIORINO, C., (a cura di) Architectureaschallenge, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2010, pp. 87-105
Si capisce quindi che già nel 1955, anno in cui vengono scelti i tre architettoi per il progettoo, la fama di Nervi ha raggiunto un livello internazionale. A confermare ciò sono i progettoi successivi commissionati allo Studio Nervi: moltissimi negli Stati Uniti, diversi in Africa e altri progettoi rivolti a un pubblico internazionale come il palazzettoo dello Sport di Roma (realizzato per i giochi olimpici) e l’Aula delle Udienze Pontifiacie. Anche in questi casi, come per la sede UNESCO, Nervi usa un linguaggio inconfondibile la cui prima visione rimanda immediatamente a lui. Sono presenti tuttoi gli elementi che negli anni precedenti ha avuto modo di provare; dalla prefabbricazione, ai pilastri a sezione variabile e al ferrocemento.
La sensazione, studiando la biografiaa di quest’uomo straordinario, è quella di trovarsi di fronte un ingegnere con nessuna intenzione di accontentarsi e smettoere di migliorare. Il passaggio da ingegnere a costruttoore e poi ad architettoo avviene perché Nervi vuole gestire in prima persona il progettoo; ha notato che spesso in un progettoo il costruttoore, il progettoista e il direttoore tecnico hanno tra loro obbiettoivi, non solo diversi ma addirittoura, opposti e le discordie che si generano fianiscono, il più delle volte, per compromettoere il risultato fianale. Nervi affaerma “Rifluettoendo sull’argomento non si vede perché il progettoista non dovrebbe essere parte integrante dell’organismo costruttoivo, oppure, contemporaneamente, progettoista e direttoore tecnico”11 . Queello che però non sta considerando è che quasi nessuno sarebbe in grado di svolgere egregiamente tuttoi e tre questi lavori che a lui riescono invece naturali.
Sempre parlando della necessità di coniugare questi tre ruoli affaerma: “I materiali, la statica, la tecnologia costruttoiva, il buon rendimento economico, le esigenze funzionali, sono i vocaboli del discorso architettoonico. Impossibile elevare tale discorso alla Poesia (Architettoura) e nemmeno alla correttoa prosa (Buona edilizia) senza la perfettoa conoscenza di tali vocaboli e delle regole di grammatica e di sintassi (Tecnica) con cui essi debbono essere composti”12 .
11 NERVI, P. L., Scienzaoartedelcostruire?Carattoeristicheepossibilitàdelcementoarmato, Edizioni della bussola, Roma, 1945, p.60
12 NERVI, P.L., Nuovestruttoure, Edizioni di comunità, Milano, 1963, p. 21


Fonte:RIBACollections
ZehrfussperilprogettoodellanuovasedeUNESCOdiParigi,1952
Dasinistraadestra:EeroSaarinen,PierLuigiNervi,ErnestoNathan Rogers,WalterGropius,LeCorbusier,SvenMarkelius(inpiedi), BernardZehrfusseMarcelBreuer
Fonte:Roma,MAXXI,archivioPierLuigiNervi
La “sensibilità statica” di Pier Luigi Nervi
“Da ingegnere, rimproverava agli architettoi la disattoenzione ignorante in materia di statica. Da architettoo, contestava agli ingegneri la ruvida mancanza di sensibilità estetica. Costruttoore, sperimentava nuove tecniche industriali e inventava nuovi materiali”13
Queesta frase riassume in modo effigcace la visione di Pier Luigi Nervi, sia per quel che riguarda i progettoi che per quel che riguarda il sistema accademico, da lui spesso criticato. Nervi è stato professore tra il 1945 e il 1962 di Tecnica delle costruzioni e Tecnologie dei materiali alla facoltà di architettoura dell’Università “La Sapienza” di Roma14 e, presumibilmente, sapendo di essere in procinto di assumere questo ruolo scrive il libro Scienzaoartedelcostruire?.
Il libro, come si intuisce fian dal primo capitolo, è rivolto proprio ai futuri architettoi e ai giovani che intraprendono questa professione. Lo scopo è quello di far comprendere il peso che la comprensione dell’ingegneria e della tecnica edilizia hanno sulla buona riuscita di un progettoo; a questo fiane Nervi espone una serie di consigli e raccomandazioni, basate sulla sua esperienza personale.
Il libro, come nel caso di Costruire correttoamente (secondo libro scrittoo da Pier Luigi Nervi), dà grande valore all’esperienza personale dell’autore cercando di fornire un metodo di lavoro che però confrontato con quello di altri architettoi o altri ingegneri risulta estremamente singolare. Nervi è molto scettoico sulla progettoazione attoraverso i calcoli e spesso ricorre per i suoi progettoi alla ‘statica grafiaca’, una verifiaca statica basata sul disegno e sull’intuito. Queesto gli permettoe di non creare forme a cui poi si dovranno adattoare le struttoure e di partire invece proprio dalle struttoure per arrivare a defianire la forma più funzionale, effigciente ed economica. Nervi è convinto che la funzionalità debba essere il fondamento dei carattoeri estetici di un’opera architettoonica, tanto da sostenere che “[…] l’umanità si sta avviando verso forme e direi quasi verso uno ‘stile’ che, una volta raggiunti, resteranno immutati ed immutabili nel tempo”, a difesa di questa sua tesi nel libro è anche presente una tavola raffiggurante due ponti, uno che segue la forma più logica per resistere alle leggi statiche e uno con una forma diffaerente. Nervi sostiene che un elemento staticamente infelice lo è anche esteticamente15 (fiagura4).
13 A scriverlo è sempre Besio nello stesso articolo de laRepubblicasopra citato
14 DESIDERI, P., NERVI, P.L. jr, POSITANO G., (a cura di) PierLuigiNervi,Zanichelli, Bologna, 1979, pg. 5
15 NERVI, P. L., Scienza o arte del costruire? … cit. pp. 68

Figura4:da"Scienzaoartedelcostruire?",pg.22
Il concettoo ‘nerviano’ di funzionalità è però strettoamente legato alle struttoure, a diffaerenza di altri architettoi che cercano le forme più funzionali dell’involucro per poi adattoargli la struttoura Nervi parte dalla forma della struttoura per defianire tuttoi gli spazi. Proprio per questo la risposta che dà alla domanda ‘scienza o arte del costruire?’ è che ciò che rende arte la tecnica e l’ingegneria è l’impossibilità di defianire un unico sistema che, in ogni suo aspettoo, risulti migliore di qualunque altro.
All’attoenzione per la funzionalità, fiaglia della sua formazione da ingegnere, si aggiunge quella per l’economia del progettoo, derivata dal ruolo di imprenditore. Nervi sviluppa un’idea ben defianita di ‘opera architettoonica’ limitata a ciò che è realizzabile criticando aspramente coloro, soprattouttoo gli architettoi, che elaborano progettoi senza tenere conto della fattoibilità economica degli stessi. L’ignoranza in fattoo di economia viene vista dall’ingegnere come una lacuna grave delle università che affarontano questo argomento solo come fattoo secondario, e non come elemento fondante al pari della funzionalità e dell’estetica.
Viene fuori in questo pensiero il Pier Luigi Nervi costruttoore che negli anni, soprattouttoo quelli della sua ‘seconda vita’, adattoa i sistemi costruttoivi esistenti e crea nuovi sistemi col fiane di ridurre i costi senza mai rinunciare a tenere alta la qualità e la durevolezza del risultato. Da un punto di vista prettoamente estetico, la forma nelle opere di Nervi è il risultato della ricerca della massima funzionalità possibile defianita attoraverso i limiti delle leggi fiasiche e del sistema economicamente più vantaggioso. Queello che poi diverrà il suo stile, carattoerizzato da forme uniche, non è altro che il prodottoo di una ricerca volta a
raggiungere l’essenziale delle struttoure; tuttoe le soluzioni tecniche trovate hanno il fiane di ridurre costi e tempi senza intaccare la qualità.
Queesto lato fortemente pragmatico di Nervi lo porta a defianire una ‘ricettoa’ per la buona riuscita di un progettoo alla cui base devono essere una “chiara visione del fiane da raggiungere e i mezzi a disposizione, e l’indipendenza di spirito nel progettoare”16. Nervi aggiunge che la scelta più importante nell’elaborazione di un progettoo è quella dell’idea di partenza, da decidersi dopo l’analisi di molteplici tentativi; partire dall’idea giusta è ciò che garantisce la migliore redditività di un progettoo, non solo intesa in campo economico ma anche da un punto di vista funzionale, e di conseguenza estetico per come Nervi vedeva le cose.
Alle raccomandazioni ai futuri architettoi Nervi aggiunge una critica al sistema accademico; secondo lui le facoltà di architettoura e ingegneria civile dovrebbero essere unite per garantire la formazione di fiagure che possano essere in grado di gestire un progettoo in tuttoi i suoi aspettoi. Propone inoltre una rivoluzione nell’approccio alla materia sostenendo che le scuole dovrebbero partire dalle basi economiche, statiche e funzionali per poi arrivare in ultima istanza allo spiegare come applicare queste basi al fiane della risoluzione del problema ultimo. Queesto metodo secondo lui permettoerebbe di usare la matematica e le formule della scienza delle costruzioni solamente come verifiaca e non come elementi di progettoo.
Ciò che non viene fuori nei libri scrittoi da Nervi sulla sua esperienza, né nelle sue lezioni, è il grande valore che l’ingegnere dà al disegno come vera e propria verifiaca in sede di progettoo; Pier Luigi Nervi, come molti architettoi che si servono di collaboratori, è solito rappresentare tuttoi i suoi progettoi in primo luogo attoraverso degli appositi schizzi che fa poi ‘tradurre’ in disegni più elaborati da membri del suo studio17. Addirittoura gli schizzi rappresentano uno strumento di verifiaca per l’ingegnere; in uno di questi, realizzato per la copertura dell’atrio di ingresso all’Aula delle Udienze Pontifiacie, scrive “N.B. controllare con uno schizzo prospettoico se il disegno sul soffigttoo si apprezza suffigcientemente”18
È il disegno a defianire fian da subito la forma dell’edifiacio e il dimensionamento delle struttoure; solo in un secondo momento arrivano i calcoli, che solitamente venivano affigdati a Mario Desideri, e i disegni defianitivi, che talvolta Nervi elabora in prima persona. Queesti ultimi vengono prodottoi in enorme quantità dallo studio; la realizzazione di elementi complessi che si sviluppano su tre dimensioni richiede infattoi che ogni
16 NERVI, P. L., Scienzaoartedelcostruire?… cit. pp. 42
17 MARGANI, L., “Il mio nome è Luigi ma chiamatemi pure Pier Luigi”. In: NUTI, F., (a cura di) Racconti…cit, pp. 105-107
18 VERNIZZI., C., IldisegnoinPierLuigiNervi, Mattoioli 1885, Fidenza, 2011, pp. 83
elemento sia minuziosamente rappresentato molte volte per non lasciare spazio alla libera interpretazione in sede di cantiere.
Lo schizzo torna poi durante la fase esecutiva come strumento di verifiaca per quel che riguarda il rapporto tra il contesto e l’edifiacio. Nervi ricorre a disegni prospettoici, spesso realizzati in prima persona, per verifiacare che ciò che sta venendo costruito si adegui come previsto al contesto per cui è stato pensato. La verifiaca attoraverso gli schizzi rappresenta una vera e propria peculiarità nell’opera di Nervi andando ad inserirsi “in un contesto culturale che tende a privilegiare le rappresentazioni considerate oggettoive a quelle soggettoive”19
In tuttoi i progettoi di Pier Luigi Nervi gli aspettoi fondamentale sono l’intuito e l’esperienza. L’ingegnere non ricorre mai a verifiache attoraverso calcoli complessi e tanto meno a disegni la cui forma derivi dalla sua fantasia o dalla volontà di rievocare simboli o forme esistenti; lo scopo è sempre quello di dare vita a struttoure che siano staticamente effigcienti. Si può paragonare il suo modo di progettoare a quello dei capimastri che, in periodo gotico, si occupavano di progettoare le grandi cattoedrali francesi fiadandosi del loro intuito in fattoo di statica e della loro esperienza; del resto non è un caso che, nel momento in cui la nipote Irene si iscrive alla facoltà di architettoura, Pier Luigi le regali il libro “I costruttoori di cattoedrali” di Jean Gimpel20
19 VERNIZZI., C., “Il disegno in Pier Luigi Nervi”. In: BIANCHINO, G., COSTI, D., CantiereNervi… cit., pp. 113
20 MARGANI, NERVI, AntonioNervi…cit, pp. 61

Figura5:disegnorealizzatodallostudioNerviperilprogettoodell'Aula PaoloVI
Fonte:BibliotecadiScienzeTecnologiche,Firenze,fondoNervi

Figura6:disegnorealizzatodallostudioNerviperlafianestradell'Aula PaoloVI
Fonte:BibliotecadiScienzeTecnologiche,Firenze,fondoNervi
L’amore corrisposto tra Nervi e il cemento armato
Nel suo libro “Scienza o ate del costruire? Carattoeristiche e possibilità del cemento armato” Pier Luigi Nervi apre il quinto capitolo in questo modo: “Il cemento armato è il più bel sistema costruttoivo che la umanità abbia saputo trovare fiano ad oggi. Il fattoo di poter creare pietre fuse, di qualunque forma, superiori alle naturali poiché capaci di resistere a tensione, ha in sé qualche cosa di magico. L’abitudine a fattoi straordinari ha diminuito la nostra capacità all’entusiasmo, ma, certamente, il cemento armato meriterebbe di suscitarne ancora molto.”21
Ciò di per sé sarebbe suffigciente per comprendere qual è il materiale più caro all’ing. Pier Luigi Nervi, ma un’ulteriore conferma ci viene dalla sua prima esperienza lavorativa. La scelta di entrare nella Società per Costruzioni Cementizie del suo professore Attoilio Muggia è il rifluesso della volontà di approfondire i suoi studi riguardo ai possibili utilizzi del cemento armato; il sistema Hennebique usato dall’azienda è un’innovazione per il contesto italiano del tempo e il giovane Pier Luigi Nervi ne è consapevole.
Nervi inizia così, immediatamente dopo la laurea, uno studio profondissimo del cemento armato e delle sue varianti. Proprio questo studio negli anni lo porta, insieme ai suoi collaboratori, ad esplorare sia le possibilità formali di questo materiale che quelle tecniche.
La prima rivoluzione che Nervi propone nelle sue opere è esclusivamente formale; ne è l’esempio lampante lo stadio comunale di Firenze, costruito tra il 1930 e il 1932. A questo punto della sua carriera l’ingegnere sta aprendo la sua personale impresa ma non dispone ancora dei mezzi necessari per effaettouare ricerche e prove di laboratorio su larga scala; la sperimentazione avviene quindi sul piano del disegno e delle forme. Ne sono esempi all’interno del progettoo tre elementi in particolare: le scale elicoidali, la tribuna coperta e la torre di maratona.
Le scale elicoidali vengono pensate dall’ingegnere come l’incrocio di due travi spiraliformi perfettoamente simmetriche; ciò permettoe di ridurre l’azione torcente della rampa che sarebbe stata eccessiva in assenza della seconda spirale. La tribuna coperta viene pensata come elemento monolitico in cui il peso delle gradinate funge da contrappeso per la struttoura aggettoante di ben ventidue metri, la torre di maratona è un elemento fortemente propagandistico creato per esaltare e dimostrare le grandi qualità ancora inesplorate del cemento armato22. Lo stadio Berta, oggi Franchi, simboleggia l’inizio di un periodo di sperimentazione per Nervi che avrà il suo apice nei vent’anni successivi ma continuerà fiano alla fiane della carriera.
21 NERVI, P. L., Scienza o arte del costruire? … cit. pp. 77
22 httop://www.ingegneriaedintorni.com/2010/08/lo-stadio-comunale-artemio-franchi-di.html#:~:text=La %20scala%20elicoidale,rampa%20genera%20nella%20trave%20elicoidale.
Il periodo successivo, dalla conclusione del cantiere dello stadio Giovanni Berta (oggi Artemio Franchi) fiano al termine della seconda guerra mondiale e agli anni immediatamente successivi, è un periodo di sperimentazione per Pier Luigi Nervi. Ne è palese dimostrazione l’acquisto, negli anni quaranta, di un terreno per costruire un capannone nel quartiere della Magliana, a Roma. Nei quarant’anni successivi l’ingegnere effaettouerà qui le sperimentazioni precedenti l’apertura di tuttoi i suoi cantieri principali. Queesto capannone, proprietà della Società Ingg. Nervi & Bartoli, vedrà negli anni successivi nascere alcune invenzioni fondamentali per l’evoluzione del registro stilistico nerviano.
Alla volontà di ricercare limiti e alternative del cemento armato si aggiunse la necessità imposta dalle leggi autarchiche. Gli ultimi anni del ventennio fascista hanno rappresentato infattoi un ostacolo per le ricerche di Nervi sul cemento armato poiché tra il 1935 e il 1936 erano entrate in vigore le prime leggi volte a limitare l’uso dell’acciaio in ambito civile per favorire la corsa agli armamenti. La conseguenza logica fu un immediato aumento dei prezzi che rese necessario ricorrere ad altre soluzioni. Nervi era però a questo punto già un costruttoore affaermato con buone disponibilità economiche che gli permisero di avviare un lungo periodo di test su materiali e modelli volto a trovare nuove soluzioni, inizia così quella che Sergio Porettoi defianisce la ‘seconda vita’ di Pier Luigi Nervi che culminerà con l’invenzione del ferrocemento e del ‘Sistema Nervi’.
Il ferrocemento, brevettoo numero 4297331 del 194423, è un sistema costruttoivo reso vantaggioso dalla possibilità di non usare casseforme. Si dispongono una sopra l’altra diverse reti metalliche di spessore mai superiore ai tre centimetri, e spesso inferiori al centimetro, per poi saturarle manualmente con la cazzuola, ricorrendo a un conglomerato di cemento e sabbia24. Si trattoa di una soluzione estremamente adattoa al contesto economico per cui viene pensata; l’Italia si trova in quel momento in un periodo di ristrettoezze economiche in cui scarseggiano sia il legno che l’acciaio, ciò che abbonda è invece la forza lavoro. Ai vantaggi economici, prima preoccupazione del Nervi costruttoore, se ne affigancava però anche molteplici di funzionali, e quindi per l’idea progettouale di Nervi anche statici e conseguentemente estetici. Il ferrocemento permettoe di realizzare forme estremamente complesse senza le limitazioni che impone invece il legno; le reti possono infattoi essere realizzate e modellate in forme curvilinee molto libere, come dimostreranno molte opere negli anni successivi (basti pensare ai padiglioni Breda realizzati negli anni cinquanta da Luciano Baldessarri). Ne consegue una libertà formale senza precedenti per le opere dello Studio Nervi che viene per la prima volta dimostrata in ambito navale.
Nel 1945 Pier Luigi progettoa e realizza il motoveliero Irene, in onore della moglie, costruendo l’intero scafo in ferrocemento. Si trattoa per il tempo di un’ottoima alternativa
23 MARGANI, NERVI, AntonioNervi…cit, pp. 11
24 IORI, T., “Il sistema Nervi”. In: BIANCHINO, G., COSTI, D., CantiereNervi…pp. 52
agli scafia in ferro, materiale più diffigcile da reperire, e in legno, materiale più complesso da modellare nelle forme volute. Nervi stesso aveva dichiarato che “se la impermeabilità si dimostrerà effaettoivamente raggiunta, le struttoure di questo tipo non avranno più a temere alcuna concorrenza tecnica od economica”25. Negli anni successivi però le prove di questo materiale sarebbero rallentate fiano a determinare il completo abbandono della progettoazione di navi con scafia in ferrocemento.
Dove invece questo materiale ha fian da subito ottoimo successo è il campo delle costruzioni. Il primo test in questo campo è la costruzione in via della Magliana, 238, a Roma, del capannone di proprietà dell’impresa Nervi & Bartoli. Si trattoa di un capannone lungo ventuno metri e largo la metà che Nervi sfruttoa proprio come prima prova di applicazione del ferrocemento nelle struttoure; si iniziano qui a intravedere le possibilità di questo materiale dalla curvatura della copertura. I veri successi del ferrocemento arrivano successivamente con la realizzazione di molte grandi opere come il Salone B del Palazzo delle Esposizioni, a Torino, o l’Aula delle Udienze Pontifiacie, in Vaticano.
La grande intuizione della Nervi & Bartoli è quella di sfruttoare il ferrocemento per serializzare i propri lavori. L’impresa capisce che la versatilità di questa tecnologia assume valore ancora maggiore quando i pezzi che si producono sono tuttoi uguali tra loro. Queesto rende possibile per l’impresa la prefabbricazione nel capannone di via della Magliana ma non solo; avere pezzi della stessa forma vuol dire anche ridurre i costi per le casseforme. Come già dettoo in precedenza negli anni quaranta in Italia scarseggia il legno e questo causa un aumento dei costi delle costruzioni in cemento armato, strettoamente legati fiano a quel momento alle casseforme di legno necessarie per contenere il gettoo prima della presa. La prefabbricazione rende invece possibile, a costi inferiori, la costruzione di apposite casseforme con materiali più controllabili, come il gesso, che assumano anche forme non realizzabili con le assi di legno.
L’esempio più riuscito in questo senso, tra le opere di Nervi, è senza dubbio il palazzettoo dello sport di Roma, realizzato con Annibale Vitellozzi tra 1956 e 1957 in vista delle olimpiadi del 1960. Proprio grazie alla tecnologia sopra citata, effigcientissima per ridurre i tempi di cantiere, la costruzione dura appena un anno e due mesi. Si sfruttoa in questo caso un sistema per la realizzazione dei pezzi basato su due generazioni di matrici: la prima generazione, le ‘nonne’, consiste in tredici calchi diffaerenti a doppia curvatura realizzati in laboratorio; da questi si ottoiene la seconda generazione di calchi, le ‘madri’, usata in sede di cantiere per realizzare i pezzi che compongono poi la struttoura. In questo modo è possibile realizzare più elementi contemporaneamente arrivando a una produzione anche di trenta pezzi al giorno di tredici forme diverse26. Risulta evidente che realizzare un edifiacio del genere in tempi simili è possibile solo se già in sede di progettoo
25 NERVI, P. L., Scienza o arte del costruire? … cit. pp. 91
26 IORI, T., “Small sports complex”. In: OLMO, C., CHIORINO, C., (a cura di) Architectureaschallenge …cit., pp. 167
si conoscono alla perfezione le tecniche costruttoive; il progettoo del palazzettoo dello sport di Roma infattoi non segue, come gli altri edifiaci costruiti per le olimpiadi, un normale concorso di appalto poiché la sola azienda in grado di realizzare velocemente i progettoi dello Studio Nervi è la Nervi & Bartoli.
La capacità, sviluppata dall’impresa di costruzioni di proprietà di Nervi e del cugino, è il fruttoo di uno studio volto a elaborare un vero e proprio sistema costruttoivo: il ‘Sistema Nervi’. Sfruttoando le due tecnologie elaborate negli anni precedenti, vale a dire il ferrocemento e la prefabbricazione, Pier Luigi Nervi è arrivato a elaborare un sistema molto più economico dei tradizionali sistemi in cemento armato. Usare il ferrocemento rende per la prima volta possibile realizzare elementi curvilinei e quindi resistenti per forma; la struttoura risultante non presenta pesi morti senza funzione struttourale, con una conseguente riduzione anche dei costi relativi ai materiali. Al ferrocemento, tecnologia esclusiva della Società Ingg. Nervi & Bartoli, si affiganca la prefabbricazione che permettoe di abbassare ulteriormente i costi. Spostare parte della produzione di un cantiere in un altro luogo, spesso il capannone di via della Magliana, permettoe di lavorare contemporaneamente sia alle fondazioni che alla struttoura soprastante. Gli elementi prefabbricati in ferrocemento vengono poi uniti attoraverso colate cementizie localizzate permettoendo così all’intero edifiacio di lavorare come un elemento monolitico.
I risultati esaltanti di questo procedimento sono presenti in moltissime opere dello studio. La copertura del Salone B del Palazzo delle Esposizioni, realizzato a Torino tra il 1947 e il 1948, ad esempio venne realizzata con pezzi tuttoi identici tra loro; i pezzi, prodottoi partendo da un’unica matrice, sono concepiti per essere resistenti per forma e quindi molto leggeri. Vengono portati in copertura con delle gru e qui uniti attoraverso colate cementizie che ne legano le estremità inferiori con gli altri pezzi. La stessa tecnica viene utilizzata, come vedremo, per la copertura dell’Aula delle Udienze Pontifiacie.
Il ferrocemento però non permettoe solamente nuove soluzioni tecniche, come la prefabbricazione, ma anche un’evoluzione formale. Già tra il 1935 e il 1942, con le due serie delle aviorimesse, Pier Luigi Nervi aveva iniziato a cercare soluzioni che permettoessero di alleggerire le coperture lasciandovi solo gli elementi con un valore struttourale. Ne risultarono ottoo struttoure a guscio, quindi già di per sé resistenti per forma, in cemento armato al cui interno si sviluppavano delle nervature tra loro perpendicolari che vanno a comporre dei motivi romboidali sull’intera copertura. Le nervature per sorreggere le coperture diventano, negli anni successivi, un motivo carattoerizzante delle opere di Nervi in quanto fortemente espressive della sua idea progettouale.
In particolare diventano famose le sue carattoeristiche ‘nervature isostatiche’ realizzate grazie all’utilizzo del ferrocemento. Nervi dopo aver depositato il brevettoo nel 1944 non ha più necessità di limitarsi alle forme imposte dalle assi di legno e ciò che ne scaturisce è una lunga serie di opere in cui le nervature non seguono più linee perpendicolari tra
loro ma si articolano in motivi complessi defianiti dalle linee isostatiche. Ancora una volta sono le leggi fiasiche a defianire il linguaggio delle opere di Nervi. È da questa innovazione che scaturiscono alcuni dei motivi più iconici del costruito nerviano: il solaio del seminterrato del lanifiacio Gattoi, la copertura del palazzettoo dello sport di Roma, le coperture nella zona del trono papale all’interno dell’Aula delle Udienze Pontifiacie. Seguire dei motivi non defianiti dal suo gusto personale ma dalle leggi fiasiche permettoe a Nervi di elaborare un linguaggio senza tempo, indipendente dalle mode o dal gusto personale dell’autore.
Un’altra soluzione di grande rilevanza ideata dallo studio Nervi è quella dei pilastri a sezione variabile. Queesti elementi, pensati per la prima volta da Pier Luigi insieme al primogenito Antonio, vengono proposti per la prima volta alla fiane degli anni quaranta del novecento, all’architettoo Lina Bo Bardi per la costruzione del museo d’arte di San Paolo27, progettoo per cui Pier Luigi faceva da consulente tecnico. Negli anni successivi sono diventati un vero e proprio marchio di fabbrica dello studio per via della loro straordinaria versatilità; sono stati usati per il palazzettoo dello sport a Roma, per la sede UNESCO a Parigi, e per l’Aula delle Udienze Pontifiacie in Vaticano. L’idea formale è ancora una volta quella di alleggerire la struttoura di tuttoo ciò che non è strettoamente necessario basandosi sulle leggi della natura. I pilastri si rastremano verso l’alto dove necessario, come nella sede UNESCO, oppure si dividono in due parti per assecondare i carichi, come per il palazzettoo dello sport.
Sarebbe incompleto un discorso sulle innovazioni delle opere di Nervi che non considerasse anche i suoi numerosi studi effaettouati sul cemento armato. Pier Luigi Nervi presta grande attoenzione alle sue costruzioni e al modo in cui si comportano durante tuttoa la fase edifiacatoria; il 4 dicembre del 1959, durante una lezione tenutasi a Roma, affaerma: “Il calcestruzzo, quando è fresco, è plastico; in altre parole non ritorna alla forma originale quando si toglie un carico. Col passare del tempo obbedisce alle leggi dell’elasticità.”28. A questo si aggiunge una “incostanza del modulo elastico dei conglomerati dovuta a variabili condizioni di compattoezza, qualità dei componenti, quantità di acqua di impasto, durata e condizioni di maturazione e in generale a specifiache carattoeristiche qualitative del materiale, indipendentemente dalle sollecitazioni”29 che lo Studio Nervi ha modo di osservare con appositi test effaettouati diversi anni dopo la costruzione su due modelli identici di aviorimesse (fiagura7)
27 MARGANI, NERVI, AntonioNervi…cit, pp. 13
28 EINAUDI, R., “Pier Luigi Nervi: lezioni romane”. In: TRENTIN, A., TROMBETTI, T., (a cura di) La lezionediPierLuigiNervi,Bruno Mondadori, Milano, 2010, pp. 67
29 NERVI, P. L., Scienza o arte del costruire? … cit. pp. 96

Figura7:da"Scienzaoartedelcostruire",pg.49
Lo studio evidenza come edifiaci tra loro identici a livello formale, costruiti con impasti cementizi realizzati allo stesso modo, negli anni abbiano subito deformazioni diffaerenti. La causa viene attoribuita a piccole variazioni, come tempi di disarmo e composizione leggermente diffaerente dei materiali, che a lungo termine comportano delle diffaerenze sostanziali nel modo di deformarsi del cemento armato.
A limitare il cemento armato però non sono solo l’irregolarità e la diffigcoltà dettoata dalla necessità di calcolare struttoure iperstatiche complesse, ma anche l’assenza di mezzi tecnici suffigcienti per assecondare le grandi capacità meccaniche di questo materiale. Sempre all’interno del suo libro “Scienza o arte del costruire?” Nervi espone il progettoo di una copertura con ben trecento metri di luce realizzata interamente in cemento armato 30 L’ingegnere sostiene che l’unico problema per questa opera, altrimenti perfettoamente realizzabile, sarebbe la costruzione delle impalcature e delle casseforme, per il resto sarebbe perfettoamente realizzabile. Si trattoa chiaramente di un progettoo pensato non per essere costruito ma per esporre le potenzialità ancora inesplorate di questo materiale.
30 NERVI, P. L., Scienza o arte del costruire? … cit. pp. 106
Proprio dall’insieme di tuttoi questi aspettoi, che rendono estremamente irregolare il comportamento del cemento armato, deriva il metodo progettouale di Nervi, basato sulle verifiache grafiache e sulla ‘sensibilità statica’. Queesto non vuol dire che Nervi non dà valore ai calcoli, come dimostra il fattoo che si faccia affigancare da un ottoimo ingegnere e calcolatore come Mario Desideri, ma che ne comprende i limiti. Si rivedono in questo suo pensiero gli insegnamenti di Silvio Canevazzi, suo professore di ‘Meccanica applicata alle Costruzioni e di Ponti e costruzioni idrauliche’ presso l’università di Bologna, il quale sosteneva l’importanza di “preoccuparsi specialmente di arrivare a formule o criteri utili nelle applicazioni dell’ingegneria anche a costo di abbandonare lo strettoo rigore matematico”31 .
Proprio riguardo alla sua idea della statica studiata attoraverso la sensibilità e l’esperienza Nervi affaerma, come a voler defianire una ‘regola d’arte’ che “l’armatura metallica deve essere sempre estetica; per dare l’impressione di un fascio di nervi destinato a dare vita alla più inerte massa di conglomerato”32
L’insieme delle tecniche e delle competenze che Nervi e i suoi collaboratori accumulano negli anni comporta la conformazione singolare che la Nervi & Bartoli e lo Studio Nervi assumono. La volontà di assecondare un linguaggio architettoonico, e un insieme di tecniche costruttoive, così lontani dalla moda è possibile solo perché allo sviluppo espressivo delle sue opere Nervi affiganca un’evoluzione della struttoura e dei metodi di lavoro della sua impresa e del suo studio.
31 EINAUDI, R., “Pier Luigi Nervi: lezioni romane”. In: TRENTIN, A., TROMBETTI, T., (a cura di) La lezione…citpp. 5
32 NERVI, P. L., Scienza o arte del costruire? … cit. pp. 91

Fonte:Censimentodellearchitettoureitalianedal1945aoggi

Figura9:motoveliero"Irene",realizzatoinferrocemento
Fonte:BibliotecadiScienzeTecnologiche,Firenze,fondoNervi
Lo studio e l’impresa sul Lungotevere Arnaldo da Brescia
È il 1923 quando Pier Luigi Nervi, direttoore della sezione fiaorentina della “Società per Costruzioni Cementizie”, riceve da Rodolfo Nebbiosi la proposta di aprire una società. Negli anni precedenti Nervi ha ottoenuto un crescente numero di incarichi all’interno della società ma, almeno a suo dire, a questo aumento degli incarichi non è corrisposto un adeguato aumento del compenso. Queesto lo porta ad accettoare l’offaerta avanzatagli da Nebbiosi, che nel frattoempo sta chiudendo la sua precedente società con l’Ing. Strazzeri. Nasce così la “Società Ingg. Nervi & Nebbiosi” con sede in Lungotevere Marzio 1, a Roma.
La società si occupa di costruzioni cementizie su tuttoo il territorio italiano; molte di queste con vecchi clienti di Pier Luigi Nervi, soprattouttoo a Prato33. La società è molto attoiva come dimostra la quantità di opere costruite e la commissione all’architettoo Giuseppe Capponi, nel 1928, della palazzina in Lungotevere Arnaldo da Brescia citata precedentemente.
L’edifiacio viene completato nel 1932, anno della morte dell’ingegner Nebbiosi; evento che comporta la chiusura della società, sostituita dalla “Società Ingg. Nervi & Bartoli” sempre nel 1932. Il nuovo socio di Pier Luigi Nervi è il cugino Giovanni Bartoli che aveva già lavorato con lui all’interno della società Nervi & Nebbiosi. Nello stesso anno, che rappresenta un momento di svolta nella vita di Nervi, riceve la sua prima grande commissione ovvero la costruzione dello stadio comunale di Firenze.
Da questo momento in poi la “Società Ingg. Nervi & Bartoli” si occupa di moltissimi progettoi di larga scala; in alcuni casi progettoando solo la parte struttourale dell’edifiacio, in altri occupandosi dell’intero processo di progettoazione e costruzione. Queesti ultimi includono quasi tuttoe le opere realizzate in Italia dalla società: lo stadio di Firenze, le aviorimesse, i progettoi torinesi, quelli per le olimpiadi di Roma, ecc.. Il grattoacielo Pirelli invece, progettoato da Gio Ponti e costruito tra il 1956 e il 1960, è uno dei pochi esempi di edifiaci in cui la società di Pier Luigi Nervi ha esclusivamente l’incarico di progettoare la struttoura mentre la costruzione viene affigdata a un’altra impresa. Il quadro è più articolato per le opere realizzate all’estero, arrivate in una fase più tarda della carriera di Nervi, per le quali è diffigcile defianire quale sia il contributo dell’impresa e quale quello dello studio.
Dal 1932 i lavori della società procedono ininterrottoi fiano agli anni della seconda guerra mondiale; Pier Luigi Nervi non vuole condividere le sue ricerche con i nazisti e così dall’armistizio, nel 1943, alla fiane del secondo confluittoo mondiale, nel 1945, l’impresa viene chiusa34. Al momento della riapertura Nervi ha brevettoato il ferrocemento e l’azienda inizia quindi a specializzarsi proprio per assecondare la sua idea progettouale.
33 GUANCI, G., Costruzioni&sperimentazione… cit., pp. 45-51
34 httops://censimentoarchitettourecontemporanee.cultura.gov.it/scheda-opera?id=734
Inizia il periodo d’oro della “Società Ingg. Nervi & Bartoli” che durerà fiano agli anni settoanta.
Tra il 1939 e il 1941 ancora adolescente, ha iniziato a fare piccoli lavori per l’impresa il primogenito di Pier Luigi, Antonio. Nel 1950 si laurea in architettoura ed inizia a lavorare a tempo pieno nella società del padre, dove conosce Sergio Musmeci. Queest’ultimo, a 23 anni nel 1949, inizia a lavorare per la “Società Ingg. Nervi & Bartoli” e negli anni successivi stringe un ottoimo rapporto proprio con Antonio Nervi. Ciò porta i due, giovani e ambiziosi, a lasciare la Nervi & Bartoli per cercare maggiori libertà: nel 1953 fondano lo “Studio di Architettoura e Tecnica Edilizia”. Il padre Pier Luigi in questo nuovo progettoo non risulta uffigcialmente come collaboratore o come socio ma come consulente, indice dell’approvazione riguardo all’idea del fiaglio.
I piani tuttoavia non vanno come previsto e, nel 1954, Sergio Musmeci decide di abbandonare lo studio (e negli anni successivi costruirà opere magnifiache arrivando ad essere considerato uno dei più importanti struttouristi italiani del novecento) . Al suo posto subentra Pier Luigi Nervi che passa così dal ruolo di consulente a quello di socio.
In questi anni lo studio, ancora guidato da Antonio, si occupa di progettoi abbastanza modesti; principalmente di ristruttourazioni di appartamenti e progettoazione di piscine35 Gli equilibri dello studio però vengono ulteriormente modifiacati, nel 1959, con il coinvolgimento di due dei tre fratelli di Antonio: Mario laureato in Ingegneria Civile ed Aeronautica, e Vittoorio, laureato in architettoura. Il nome cambia così da “Studio di Architettoura e Tecnica Edilizia” a “Studio Nervi Architettoura e Tecnica Edilizia”.
Lo studio a questo punto non è più uno strumento di sperimentazione e formazione dove Antonio agisce sottoo la supervisione del padre; diventa invece lo strumento operativo di Pier Luigi per l’elaborazione dei suoi grandi progettoi. Queesto inevitabilmente modifiaca anche i rapporti con l’impresa di costruzioni, fiano a quel momento quasi indipendente dallo studio stesso. Si costituisce una doppia struttoura piramidale avente in entrambi i casi Pier Luigi Nervi come vertice. Queesto si traduce in una spartizione della palazzina di via Arnaldo da Brescia: al piano terra vengono posizionati gli uffigci della Società Ingg. Nervi & Bartoli, al primo piano quelli dello Studio Nervi architettoura e tecnica edilizia e al terzo piano si trova l’appartamento privato della famiglia Nervi. Le postazioni dei membri dello studio si trovano in un’unica grande sala con una decina di tavoli. In fondo, separata da una parete a vetri trasparenti, si trova la postazione di Pier Luigi e Antonio Nervi36. La vicinanza tra la sede dell’impresa e quella dello studio si rivelerà un elemento fondamentale per i successi dello studio.
I fiagli assumono a questo punto ruoli diffaerenti: Antonio lavora come progettoista al fiaanco del padre, segue i cantieri durante la fase esecutiva e tiene rapporti con i committoenti.
35 MARGANI, NERVI, AntonioNervi…cit, pp. 13
36 MARGANI, L., “Il mio nome è Luigi ma chiamatemi pure Pier Luigi”. In: NUTI, F., (a cura di) Racconti… cit, pp. 103
Mario tiene a sua volta dei rapporti coi committoenti ma per il resto gestisce i lati più tecnici dello studio; si occupa dei contrattoi e dell’amministrazione della società; è l’unico dei quattoro fratelli laureato in ingegneria e assume pertanto un ruolo più legato all’impresa Nervi & Bartoli che allo Studio Nervi. Infiane Vittoorio è un architettoo poco interessato alla sua mansione e per questo presente in studio in modo discontinuo; i lavori di cui si occupa sono principalmente legati alla Società Ingg. Nervi & Bartoli37 . Nella collaborazione tra i fiagli e Pier Luigi Nervi rimane sempre chiaro un rapporto non paritario; è evidente come i fiagli riconoscano il genio del padre e non abbiano la presunzione di intromettoersi nelle grandi commesse per cui quest’ultimo viene ricercato. Ne è il chiaro esempio il cantiere della sede UNESCO a Parigi; durante la fase di progettoazione, insieme a Marcel Breuer e Bernard Henri Zehrfuss, Pier Luigi si fa spesso affigancare dal fiaglio primogenito. Una lettoera inviata a Nervi proprio da Breuer ci fa capire che Antonio attoende che sia il padre a dirgli come agire; scrive Breuer:
“[…] I suggested that Antonio, who is supposed to partecipate in our meetings […] representing Luigi, should also stay in Paris until May 28. […] I remember Antonio as a most capable and talented fellow, with added experience since, and I think he would be very helpful in this project”38
Si intuisce da questa lettoera che i fiagli evitano di chiedere in prima persona di partecipare ai progettoi più importanti del padre e, riconoscendone le straordinarie capacità, attoendono che sia quest’ultimo a richiedere il loro aiuto per i progettoi. Lo stesso rapporto si estende poi agli altri dipendenti dell’azienda, come si evince dagli scrittoi di Margani39 , che ammirano l’operato di Nervi e attoendono quindi che sia quest’ultimo a dire loro cosa fare; è questo il sistema di organizzazione piramidale citato in precedenza.
Uffigcialmente sono i fiagli a comporre il ‘gradino’ immediatamente sottoostante a Pier Luigi Nervi, si possono però individuare altre fiagure all’interno dello studio con ruoli altrettoanto importanti; tra questi senza dubbio Mario Desideri. Mario entra a far parte della società nel 1949 come socio junior, diventando socio senior nel 1955 e addirittoura titolare dello studio dopo la morte di Pier Luigi e di Antonio, tra il 1979 e il 1984 40 Ingegnere e primo collaboratore struttourale di Nervi, Mario Desideri, è soprattouttoo uno straordinario ingegnere calcolatore. La fiagura dell’ingegnere calcolatore, già di per sé utilissima in qualsiasi studio prima dell’avvento dei computer, assume un ruolo fondamentale per le opere di Nervi; opere in cemento armato estremamente complesse,
37 MARGANI, NERVI, AntonioNervi…cit, pp. 19
38 MARGANI, NERVI, AntonioNervi…cit, pp. 13
39 MARGANI, “Il mio nome è Luigi ma chiamatemi pure Pier Luigi”. In: NUTI, (a cura di) Racconti cit, pp. 103-107
40 Le suddettoe informazioni inedite provengono direttoamente da una e-mail dal Prof. Arch. Paolo Desideri, frequentatore giornaliero dello studio tra 1976 e 1978 per conto di Zanichelli e fiaglio di Mario Desideri.
la cui verifiaca non era semplice neanche per un esperto. A questo si aggiunge il tema, già affarontato, del diffigcile rapporto di Nervi coi calcoli, una delle probabili motivazioni dietro alla scelta di assumere Mario Desideri. Essendo una fiagura più legata all’aspettoo tecnico che a quello progettouale, l’ingegner Desideri viene collocato al piano terra, quello dell’impresa, dove è ‘al comando’ insieme a Mario Nervi. Per la società lavora anche Giovanni Bartoli; si può però supporre che il suo ruolo all’interno dell’azienda sia poco legato alla parte progettouale poiché raramente viene citato nelle fonti e anche i progettoi solitamente sono fiarmati solamente da Pier Luigi Nervi e altri collaboratori. Tra gli altri dipendenti dell’impresa, Luigi Margani cita, scrivendo degli anni 1962 e 1963: Rubini, autore di molti dei disegni tecnici dell’impresa, Fraticelli, Marasca e Battoaglia41 . Queesti sono però solamente gli impiegati conosciuti da Margani che lavorano alla palazzina; l’elenco non comprende tuttoi i dipendenti che operano sui cantieri.
Una parte fondamentale della Nervi & Bartoli è rappresentata dagli operai e dai capicantiere. Queesti all’interno dell’impresa diventano dei punti di riferimento per Pier Luigi Nervi che, nell’elaborare i suoi progettoi, si confronta sempre con chi dovrà poi realizzarli per assicurarsi che il risultato sia quanto più conforme possibile alle sue idee. Queesto lo porta, per progettoi in cui non è la sua impresa a gestire la costruzione, a scegliere soluzioni diverse da quelle per lui abituali; ad esempio non avviene mai nei progettoi all’estero o in quelli in cui non conosce l’impresa costruttorice che Nervi elabori soluzioni che ricorrano alla prefabbricazione poiché è consapevole della complessità di realizzare processi simili per un’impresa che non li ha mai fattoi. Queando invece si affigda alla “Società Ingg. Nervi & Bartoli” è libero di usare tecniche più complesse; i suoi operai sono sempre gli stessi e negli anni hanno potuto imparare a utilizzare al meglio le tecniche da lui ideate. La fiaducia che Nervi ripone in loro si legge negli scrittoi dei suoi collaboratori, che spesso riportano che egli è più disposto ad accettoare consigli da chi lavora in cantiere che da chi lavora nel suo studio. Un esempio della sua strettoa relazione coi suoi operai si trova anche in alcuni reperti di archivio; in occasione della costruzione dell’Aula per le Udienze Pontifiacie il papa Paolo VI visita il cantiere per controllare l’andamento dei lavori e con l’occasione Pier Luigi Nervi si fa fotografare non solo con il papa ma anche con tuttoi i suoi collaboratori (fiagura10)
41 MARGANI, “Il mio nome è Luigi ma chiamatemi pure Pier Luigi”. In: NUTI, (a cura di) Racconti cit, pp. 106-107. Delle persone citate sono indicati solo i cognomi.

Bartolisulcantieredell’AulaperleUdienzePontifiacie
Fonte:BibliotecadiScienzeTecnologiche,Firenze,fondoNervi
Riguardo allo “Studio Nervi Architettoura e Tecnica Edilizia” Margani fornisce una descrizione molto più dettoagliata andando a nominare tuttoi i membri dello studio presenti tra il 1962 e il 1962. Il più anziano tra questi è Italo Ballettoi, incaricato di molte delle rappresentazioni prospettoiche da mostrare ai clienti. Vi sono poi gli architettoi Claudio Scepi, Franco Sacchettoi e Pino Nicolettoi; il ruolo principale di quest’ultimo è quello di disegnatore: solitamente è lui a occuparsi di trasformare in disegni tecnici gli schizzi di Pier Luigi Nervi. Pierino Arlottoi è il leader tecnico della sala. Infiane lavorano al piano dello studio il disegnatore Peppe De Cicco e la segretaria personale di Pier Luigi di cui Margani ricorda solo il nome: Marcella.
In totale quindi al piano dello studio lavorano dieci persone, compresi i due Nervi, con una nettoa maggioranza di architettoi. Il numero di persone negli anni successivi aumenta fiano ad arrivare, nel 1975, a un totale di dodici ingegneri, tredici architettoi, due periti tecnici, nove disegnatori e quattoro amministrativi42. L’evoluzione della composizione dello Studio Nervi non è altro che il rifluesso dell’affaermazione del ‘sistema Nervi’ e del linguaggio sempre più codifiacato delle opere di Pier Luigi. La stessa Nervi & Bartoli prova, in un catalogo delle opere pubblicato nel 1961, a chiarire come negli anni si sono defianiti questi rapporti tra studio e impresa attoraverso il seguente schema (fiagura11)

Figura11:schemaorganizzativodiNervi&BartolieStudioNervi
Fonte:CatalogodelleoperedellaSocietàIngg.Nervi&Bartoli,1961
42 NERI, G., ANTONUCCI, M., PierLuigiNerviinAfrica:evoluzioneedissoluzionedelloStudioNervi 1964-1980, Queodlibet, Macerata, 2021, pp. 24
L’introduzione del ferrocemento e di conseguenza di una serie di sistemi complessi da realizzare come la prefabbricazione, i pilastri a sezione variabile e le coperture nervate comportano la necessità di specializzarsi sempre di più su questi elementi complessi per poterli padroneggiare al meglio; questo spiega l’aumento, negli anni, della quantità di ingegneri presenti nello studio. Del resto da quando vengono introdottoe nei progettoi di Nervi tali novità tecniche, negli anni quaranta, lo studio diventa sempre più indirizzato verso un tipo di architettoura in cui sono la struttoura e il suo dimensionamento a defianire gli spazi. Si può quindi supporre che gli ingegneri risultino fiagure più adattoe rispettoo agli architettoi per assecondare la strada che lo studio sta prendendo essendo più preparati per la progettoazione di struttoure. L’aumento della quantità di disegnatori è sempre da attoribuirsi alla tipologia di opere realizzate e alle complicazioni delle forme di queste ultime. Mentre, per un normale pilastro era suffigciente un disegno, elementi come i pilastri a sezione variabile necessitano di più disegni elaborati da più angolazioni. Così negli anni gli archivi, soprattouttoo quelli dell’impresa, si riempiono di moltissimi disegni esecutivi in scale che vanno da 1:50 fiano a 1:1 per assicurarsi che ogni elemento sia rappresentato con una precisione tale da non lasciare dubbi a chi poi si sarebbe occupato di realizzarlo. I progettoisti sanno perfettoamente chi realizzerà queste opere e quali tecniche utilizzerà e questo si vede in fase di costruzione; i cantieri di Pier Luigi Nervi sono famosi in tuttoo il mondo per la velocità con cui vengono completati: progettoi estremamente complessi come il Palazzettoo dello Sport a Roma o il Palazzo delle Esposizioni a Torino vengono completati in meno di un anno. A colpire di questo organigramma è anche la totale assenza di impiantisti; sono presenti solamente due consulenti tecnici e questo lascia intendere la preferenza di Nervi di affigdarsi a tecnici sempre diversi per gli impianti a seconda della tipologia e dell’ubicazione del progettoo.
Le fortune di Pier Luigi Nervi si possono in parte ricondurre all’operare congiunto e coordinato, sottoo le sue dipendenze, dello studio e dell’impresa di costruzioni. Lo studio lavora in perfettoa sincronia con l’impresa; i progettoi vengono realizzati tenendo conto delle tecniche costruttoive utilizzate dall’impresa e i risultati dei cantieri vengono sempre analizzati attoentamente per capire come modifiacare i progettoi per aumentarne l’effigcienza. Queesto genera un contesto in cui ogni progettoo non assume solo un fiane realizzativo ma diventa anche uno strumento di sperimentazione. L’analisi che Nervi da anni faceva in prima persona sui suoi edifiaci una volta completati, come visto in precedenza per il caso delle aviorimesse, diventa parte di una cultura comune all’interno del suo studio. Queesta continua ricerca permettoe a Pier Luigi Nervi, e con lui alla sua impresa e più tardi al suo studio, di passare da progettoi di modesto interesse a progettoi di rilevanza internazionale sempre più complessi. La specializzazione richiesta per il passaggio da opere più semplici alla realizzazione di grandi opere pubbliche è però anche una delle cause che dall’inizio degli anni settoanta portano lo studio verso il declino. Negli anni il costo dei materiali è andato diminuendo mentre è salito quello della mano d’opera; il ferrocemento non è più una soluzione particolarmente vantaggiosa a livello economico e
Pier Luigi Nervi, superati ormai gli ottoant’anni, non è in grado di rinnovare lo studio e l’impresa, e si vede costrettoo per le sue condizioni di salute a ridurre drasticamente il suo impegno.
Lo studio si trova così nella condizione di non poter più proporre soluzioni economiche e velocemente realizzabili, molti degli elementi innovativi nelle modalità di lavoro adottoate dallo studio nella verifiaca delle struttoure sono superate dalla possibilità di ricorrere al computer. Il ‘sistema Nervi’ inoltre, tanto effigciente in Italia, si è nel frattoempo rivelato diffigcile da esportare all’estero dove l’impresa costruttorice non può essere la Nervi & Bartoli. Pier Luigi Nervi, o meglio suo fiaglio Antonio ormai a capo dell’impresa e dello studio, spostano così i loro affaari verso l’Africa cercando un mercato più simile a quello dell’Italia degli anni sessanta e che ormai in Europa e in America Settoentrionale non esisteva più43. Inizia un periodo di transizione, segnato dall’abbandono defianitivo di Pier Luigi nel 1974 e dall’impegno del fiaglio Antonio, che lo sostituisce e cerca, insieme ai fratelli, di trovare una nuova identità dello studio. Queesta modernizzazione chiaramente deve passare anche attoraverso una revisione della struttoura dello studio; in una lettoera del 29 agosto del 1977 al suo dipendente Giuseppe Positano, Mario Nervi scrive
“Il nostro passato organigramma era assolutamente statico, costituito nella parte alta da un punto e da una linea orizzontale molto più in basso, mentre il presente dovrebbe essere costituito da cerchi concentrici che si creano e si annullano dinamicamente dal centro alla periferia e viceversa. Queesti cerchi sono i livelli di responsabilità che ci vengono via via affigdate a seconda delle circostanze, del caso, delle capacità naturali.44”
Queesta ristruttourazione diventa tuttoavia impossibile dopo che, nel 1979, muoiono nel giro di sei mesi prima Pier Luigi Nervi e poi il fiaglio Antonio. Nel 1980 viene chiuso il capannone della Magliana45 e dopo una breve gestione di Mario Nervi e Mario Desideri tra il 1979 e il 1984 anche l’impresa e lo studio chiudono i battoenti.
43 NERI, ANTONUCCI, PierLuigiNerviinAfrica…cit., pp. 21-22
44 NERI, ANTONUCCI, PierLuigiNerviinAfrica…cit., pp. 23
45 MARGANI, NERVI, AntonioNervi…cit, pp. 87
Il caso studio dell’Aula Paolo VI
La decisione di costruire un’aula per le udienze pontifiacie viene presa da Giovanni Battoista Montini, papa Paolo VI, meno di un anno dopo la sua elezione. Sulla scelta dell’uomo a cui affigdare questo progettoo non c’è dubbio: Pier Luigi Nervi è l’architettoo italiano più in auge del momento e nessuno può essere più adattoo di lui a costruire una grande sala per ospitare le udienze del pontefiace. Nervi, onorato della commessa, inizia a elaborare il progettoo l’anno stesso e, nel 1966, avvia fianalmente la costruzione che si protrarrà fiano al 1971.
Nervi comprende perfettoamente le diffigcoltà di costruire un edifiacio all’ombra di San Pietro; a dimostrarlo sono i racconti di Mario Desideri, che spiega che Nervi esce dal primo incontro con il papa “scosso e turbato46”, ma anche la dettoagliatissima documentazione di disegni realizzati in studio, schizzi e foto di cantiere. Sommando i reperti fotografiaci dell’aula presenti alla Biblioteca di Scienze Tecnologiche di Firenze e quelli al MAXXI si superano facilmente i tremila negativi. La amplissima documentazione di tuttoe le fasi costruttoive di quest’opera e il linguaggio ormai consolidato con cui Nervi progettoa rendono l’Aula per Udienze Pontifiacie il caso studio migliore per comprendere al meglio come lo “Studio Nervi Architettoura e Tecnica Edilizia” realizza le sue opere.
Sia negli archivi fiaorentini che in quelli del MAXXI, i cui contenuti sono estremamente simili, sono presenti negativi di alcune tavole e modelli fiasici datati 1964. Tra questi purtroppo mancano le documentazioni relative allo studio del contesto e a tuttoa la prima fase di progettoazione poiché la politica archivistica del Vaticano non permettoe la consultazione di documenti recenti47. I primi documenti non secretati, poiché conservati prima dallo studio e poi dal MAXXI, risultano comunque utili per confermare quanto illustrato precedentemente all’interno di questa tesi.
Tra i negativi più vecchi si trovano una serie di fotografiae fattoe a un modello elaborato probabilmente per la prima presentazione alla committoenza il 18 maggio 196448. Il modello, pur essendo concepito come prima proposta, presenta già alcuni degli elementi che carattoerizzeranno l’edifiacio una volta costruito. Sono presenti la copertura, con i carattoeristici elementi a ‘v’, e i pilastri a sezione variabile, due sul lato del trono e dieci sul lato opposto, come nel progettoo realizzato. È presente inoltre il modello di uno solo dei pilastri del trono per esporne la forma in una scala maggiore; questo modello, così dettoagliato pur essendo stato elaborato in una prima fase, e i vari disegni tecnici elaborati nel 1964 dimostrano che sono i sistemi costruttoivi a dettoare lo sviluppo del progettoo. Si
46 BESIO, A., L’artistadelcementoarmato. In “La Repubblica”, 22 dicembre 1999, Roma, pp. 28
47 COSSA, C., Modernismoall’ombra.LasaladelleudienzepontifiaciediPierLuigiNervi, Libreria Editrice Vaticana, Cittoà del Vaticano, 2010, pp. 87
48 Ivi, pp. 99
osserva come Pier Luigi Nervi dia grande valore all’idea da cui il progettoo parte; come già evidenziato in precedenza, Nervi ritiene che l’idea di partenza condizioni la buona riuscita del progettoo. Per questo motivo i primi modelli esposti uffigcialmente alla committoenza dimostrano già uno studio approfondito più per quel che riguarda i sistemi costruttoivi che per le forme.
Nervi, a diffaerenza degli altri architettoi, è solito partire dagli elementi costruttoivi per poi defianire gli spazi attoraverso questi. Per questo motivo dei suoi progettoi si trovano, all’interno degli archivi, pochissimi elementi riguardo alla fase ideativa; Nervi non parte dall’idea della forma che l’opera deve assumere per poi defianirne i sistemi costruttoivi ma fa il processo inverso. Gli elaborati archiviati mostrano quindi numerosi dettoagli tecnologici (per l’Aula Paolo VI gli elementi più raffiggurati sono quelli prefabbricati usati in copertura) con appunti relativi ai carichi che gli elementi dovranno sostenere e alle possibili variazioni di spessore degli elementi stessi oppure modelli struttourali per verifiacare il correttoo funzionamento dei sistemi studiati; sono invece del tuttoo assenti gli schizzi elaborati durante la fase ideativa, uno strumento a cui si può supporre che Pier Luigi Nervi ricorresse molto poco per via del suo approccio estremamente completo derivato, presumibilmente, dalla sua formazione come ingegnere e costruttoore.
L’attoenzione per i sistemi costruttoivi è alla base dell’elaborazione del progettoo. I pilastri sono pensati per essere tra loro del tuttoo identici; in questo modo una volta realizzata la cassaforma di uno dei due pilastri sul lato del trono e quella di uno dei pilastri sul lato opposto, queste possano essere utilizzate più volte. Queesto sistema, soprattouttoo per forme complesse come quelle dei pilastri a sezione variabile, permettoe di ridurre i costi delle casseforme; le foto presenti nell’archivio della Biblioteca di Scienze Tecnologiche a Firenze dimostrano che effaettoivamente i pilastri furono realizzati in momenti diversi per permettoere la costruzione di un minor numero di casseforme. [da inserire i negativi della realizzazione dei pilastri]
Anche per quel che riguarda la copertura il sistema ideato dallo studio dimostra una profonda consapevolezza dei sistemi costruttoivi. Viene pensato un sistema di elementi sottoili prefabbricati che seguono una doppia curvatura; gli elementi sono incurvati a ‘v’ lungo la direzione principale, in modo tale da essere resistenti per forma, e lievemente incurvati perpendicolarmente per assecondare la curvatura della copertura. La linea inferiore e quelle sommitali degli elementi sono piene in quanto devono assolvere la funzione statica di sorreggere la copertura; le ali invece sono svuotate del calcestruzzo e vetrate per favorire l’illuminazione dell’Aula. I pezzi vengono prodottoi nel magazzino della Magliana e vengono lasciati dei ferri esposti; questi saranno utilizzati per permettoere di legare i pezzi tra loro con apposite colate cementizie in sede di cantiere. Il sistema è quindi estremamente complesso, come dimostrano i numerosi disegni tecnici presenti negli archivi, ma il modello realizzato nel 1964 lascia intendere che fian dall’inizio lo studio era perfettoamente in grado di gestirlo.
In generale quello che i negativi presenti negli archivi dimostrano è che lo Studio Nervi lavora sempre con una grande consapevolezza dell’obbiettoivo che vuole raggiungere. Partire fian dall’inizio da un’idea chiara di struttoura, defianendo fian da subito i dettoagli tecnologici, permettoe di mantenere sempre una grande coerenza all’interno del progettoo e di non doverlo mai stravolgere. Il problema però è che per ottoenere questo risultato si devono, fian dall’inizio, conoscere perfettoamente tuttoe le tecniche costruttoive che dovranno essere utilizzate e i materiali impiegati; è dunque l’esperienza pregressa a garantire la qualità e la velocità di esecuzione delle opere dello Studio Nervi.
Sono inoltre presenti, sia negli archivi di Roma che in quelli di Firenze, numerosissimi schizzi realizzati da Pier Luigi Nervi raffigguranti diversi dettoagli dell’edifiacio. Si possono trovare disegni del contesto esterno, realizzati per studiare l’impattoo dell’edifiacio visto dalla strada e confrontarlo con la cupola di San Pietro sullo sfondo, e moltissime rappresentazioni delle nervature che compongono la copertura sopra la zona del trono.
Risulta chiara, da un’analisi degli elementi presenti in archivio, la concretezza con cui viene affarontato il progettoo. Fin dal primo momento sono chiari gli obbiettoivi da raggiungere e, grazie alle esperienze precedenti, sono chiari i mezzi a disposizione per raggiungerli. Il fattoo di lavorare a strettoo contattoo con l’impresa produttorice raffaorza ulteriormente questa consapevolezza che, sottoo la guida di un uomo esperto e geniale come Pier Luigi Nervi, diventa la ricettoa per la realizzazione di una serie di grandi opere indubbiamente irreplicabili.

Figura12:dettoagliotecnologicodiunelementoprefabbricato dicoperturadell'AulaperleUdienzePontifiacie
Fonte:BibliotecadiScienzeTecnologiche,Firenze,fondoNervi

Figura13:modellodiunpilastroasezionevariabiledell'Aula perleUdienzePontifiacie
Fonte:BibliotecadiScienzeTecnologiche,Firenze,fondoNervi

Figura14:elementiprefabbricatidicoperturaprimadiessere portatisulcantiere
Fonte:BibliotecadiScienzeTecnologiche,Firenze,fondoNervi

Fonte:BibliotecadiScienzeTecnologiche,Firenze,fondoNervi

Fonte:BibliotecadiScienzeTecnologiche,Firenze,fondoNervi

Figura17:cantieredell'AulaperleUdienzePontifiacie
Fonte:BibliotecadiScienzeTecnologiche,Firenze,fondoNervi
Conclusioni
Il fiane di questa tesi è quello di comprendere, attoraverso l’analisi dell’evoluzione dello “Studio Nervi Architettoura e Tecnica Edilizia” e della “Società Ingg. Nervi & Bartoli”, l’approccio al progettoo e la gestione dello stesso da parte di Pier Luigi Nervi. Esaminare il tipo di elaborati realizzati dallo studio, i racconti dei dipendenti e l’evoluzione negli anni di studio e impresa permettoe di capire, nelle diverse fasi della sua vita, l’approccio di Nervi alla realizzazione dei suoi progettoi. Ciò che rende interessante questo tipo di analisi è la gestione assolutamente atipica di Nervi che, essendo in primo luogo un ingegnere e un imprenditore, affaronta i progettoi in maniera totalmente diffaerente rispettoo agli architettoi.
I suoi progettoi non partono, come ad esempio per il contemporaneo Giovanni Michelucci, da disegni astrattoi che vanno defianendosi con il tempo; il punto di partenza sono piuttoosto le tecnologie utilizzate. Nervi si occupa come prima cosa di defianire gli elementi costruttoivi che comporranno il complesso e, basandosi su questa scelta, defianisce la morfologia dell’intero edifiacio. Queesto modo di progettoare lo porta a ottoenere risultati ‘opposti’ rispettoo ai suoi contemporanei; le sue opere sono sempre semplici se osservate nel loro complesso mentre raggiungono un elevatissimo grado di dettoaglio nelle soluzioni tecnologiche dei singoli elementi che le compongono. Anche quando ricorrono alle stesse soluzioni tecnologiche di Pier Luigi Nervi gli altri architettoi non le sfruttoano per la loro effigcienza ma per la loro versatilità; in questo senso l’esempio perfettoo sono i padiglioni della Breda realizzati in ferrocemento da Luciano Baldessari. L’architettoo Baldessari sfruttoa questo materiale per dare vita alle forme che ha disegnato, Nervi invece parte dalle proprietà del materiale per trovare la forma più adattoa
Se è diverso l’approccio al progettoo, a questo si deve adattoare anche il modo di lavorare dello studio. La diffaerenza nel modo di progettoare si rifluettoe in particolare sugli elaborati prodottoi, e conservati negli archivi, e sulla composizione dello studio. Dell’osservazione degli elaborati colpisce la totale assenza di schizzi che rappresentino i progettoi durante la fase ideativa; questa mancanza suggerisce che il processo ideativo parta fian da subito da un’idea estremamente concreta e strettoamente legata a un processo produttoivo ben defianito. I disegni elaborati sono disegni tecnici realizzati col fiane di chiarire le tecniche costruttoive e non per trovare un’armonia nelle forme; come già scrittoo precedentemente per Nervi la forma deve derivare esclusivamente della funzione. I disegni più grezzi degli archivi risultano comunque ben delineati nelle forme e gli appunti presenti sugli stessi sono sempre relativi a possibili variazioni di piccola entità; vengono appuntate delle soglie entro cui possono variare le dimensioni degli elementi e vengono effaettouati calcoli basilari per esaminare le condizioni di carico. Vengono anche proposte all’interno degli schizzi delle leggere variazioni formali, ma sempre giustifiacate da necessità statiche o economiche. È chiaro quindi che nello Studio Nervi, in cui il progettoo parte dall’elemento costruttoivo per arrivare in un secondo momento al risultato complessivo,
assumono valore maggiore quelle fiagure che possano permettoere il miglior risultato su scala ridottoa. Per questo la maggioranza degli impiegati sono ingegneri, più preparati da un punto di vista tecnico, e disegnatori, necessari per elaborare le complesse forme ottoenute dalla ricerca della massima effigcienza statica ed economica. Gli architettoi invece, essendo abituati a un modo diverso di progettoare, risultano meno utili per svolgere i lavori richiesti dallo Studio Nervi o dall’impresa Nervi & Bartoli.
Rilevante per la comprensione dell’operato di Pier Luigi Nervi è anche l’analisi del legame inscindibile tra lo Studio Nervi e la Nervi & Bartoli. Avviene molto di rado, e spesso con risultati deludenti, che le due società agiscano in modo indipendente e anche questo traspare dal materiale d’archivio. I negativi presenti nella biblioteca di Scienze Tecnologiche di Firenze, derivanti dallo Studio Nervi, sono molto simili a quelli conservati al MAXXI di Roma, derivanti dalla Nervi & Bartoli; una somiglianza che si può ricondurre proprio allo strettoo rapporto tra studio e impresa. Si può supporre che tra le due società di proprietà di Pier Luigi Nervi esistesse una costante collaborazione e per questo motivo i reperti di archivio risultano così simili. Gli elaborati, modelli e tavole, conservati negli archivi di Roma e di Firenze si concentrano, in entrambi i casi, quasi esclusivamente su dettoagli tecnici, rendendo i materiali provenienti da studio e impresa praticamente interscambiabili. Solo nelle fotografiae in cantiere si osservano delle diffaerenza: quelle effaettouate dallo studio sono generiche e espongono lo stato di avanzamento generale dei lavori, l’impresa invece si occupa solitamente di fotografare elementi più tecnici o di dettoaglio. È chiaro quindi, come è ovvio che sia, che studio e impresa abbiano mansioni diverse; questa distinzione però non prevede una totale divisione tra gli impiegati con compiti più tecnici, quindi quelli dell’impresa, e i progettoisti, ovvero gli impiegati dello studio. Come avviene nelle moderne fiarm, studio e impresa lavorano in modo congiunto durante tuttoi i passaggi della costruzione. A confermare la strettoa collaborazione è anche il fattoo che entrambe le società abbiano sede nella ‘Palazzina Nebbiosi’. La distinzione, esistente a livello burocratico, non è altrettoanto delineata per quel che riguarda le mansioni; questo permettoe di avere pieno controllo durante tuttoe le fasi sia dei costi che dei processi produttoivi. La capacità di Pier Luigi Nervi, attoraverso il suo studio e la sua impresa, di gestire progettoi complessi in tempi estremamente brevi e con costi relativamente molto bassi è senza dubbio una delle chiavi del suo grande successo nazionale e internazionale.
BIANCHINO, G., COSTI, D., Cantiere Nervi la costruzione di un’identità. Storie, geografiae,paralleli, Skira, Ginevra-Milano, 2012
COSSA, C., Modernismoall’ombra.LasaladelleudienzepontifiaciediPierLuigiNervi, Libreria Editrice Vaticana, Cittoà del Vaticano, 2010
DESIDERI, P., NERVI, P.L. jr, POSITANO G., (a cura di) PierLuigiNervi, Zanichelli, Bologna, 1979
GUANCI, G., Costruzioni&sperimentazione l’attoività del giovane Pier Luigi Nervi a Prato,CGE, Firenze, 2008
MARGANI, L., NERVI, I. (a cura di), AntonioNerviiniziosuccessoepilogodellostudio Nervi, Euno Edizioni, Leonforte (EN), 2023
NERI, G., ANTONUCCI, M., PierLuigiNerviinAfrica:evoluzioneedissoluzionedello StudioNervi1964-1980, Queodlibet, Macerata, 2021
NUTI, F., (a cura di) Racconti di cantiere progettoare/costruire, Edizioni Polistampa, Firenze, 2014
NERVI, P. L., Scienza o arte del costruire? Carattoeristiche e possibilità del cemento armato, Edizioni della bussola, Roma, 1945
NERVI, P.L., Nuovestruttoure, Edizioni di comunità, Milano, 1963
OLMO, C., CHIORINO, C., (a cura di) Architecture as challenge, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2010
PORETTI, S., “Nervi che visse tre volte”. In: PORETTI, S., IORI, T., L’ambasciatad’Italia aBrasilia, Mondadori Electa S.p.A., Verona, 2007
TRENTIN, A., TROMBETTI, T., (a cura di) La lezione di Pier Luigi Nervi, Bruno Mondadori, Milano, 2010
VERNIZZI., C., IldisegnoinPierLuigiNervi, Mattoioli 1885, Fidenza, 2011
Fondi archivistici consultati
BIBLIOTECA DI SCIENZE TECNOLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, Fondo Nervi Pier Luigi
CENTRO ARCHIVI DI ARCHITETTURA MAXXI, Fondo Nervi Pier Luigi
Siti consultati
httops://archivi.unifia.it/patrimonio/9587714f6-d11f-4987-ba0c-d35e0ddacb45/fondo-nervipier-luigi
httops://www.conoscifiarenze.it/come-vivevamo-a-fiarenze/45-teatro-alhambrascomparso.html
httops://www.rerumromanarum.com/2019/12/palazzina-nebbiosi.html
httop://www.ingegneriaedintorni.com/2010/08/lo-stadio-comunale-artemio-franchidi.html#:~:text=La%20scala%20elicoidale,rampa%20genera%20nella%20trave%20elicoida
httops://censimentoarchitettourecontemporanee.cultura.gov.it/scheda-opera?id=734