PRIMO PIANO
Più produzione, meno consumi

PROFESSIONI
La parte oscura del nostro stato di diritto
CULTURA Sold out per finta
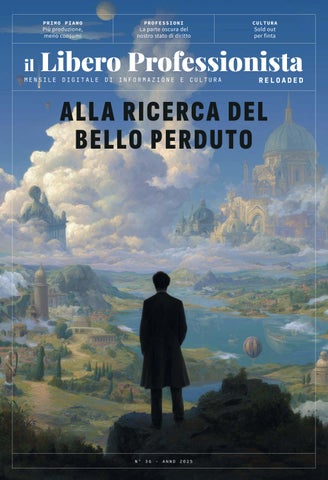
PRIMO PIANO
Più produzione, meno consumi

PROFESSIONI
La parte oscura del nostro stato di diritto
CULTURA Sold out per finta
PER LEGGERE L’ARTICOLO
(clicca sul titolo dell’articolo per accedere ai link)
La bellezza salverà il mondo di Carolina Parma
Neuroestetica un'esperienza strategica di Biancamaria Cavallini
L’estetica democratica del design di Matteo Durante
Il potere dell’arte in studio di Matteo Durante
Da canone a processo: il nuovo volto della bellezza di Giovanni Matteucci
Più produzione, meno consumi di Giovanni Francavilla
Infrastrutture, eppur si muovono di Laura Ciccozzi
L’estate calda di Ursula di Theodoros Koutroubas
Una città per chattare di Roberto Carminati
La parte oscura del nostro stato di diritto di Matteo Durante
Divorzio all’italiana di Rosanna Mura
Emergenza caldo, le parti sociali in campo di Diana Larenza
Una nuova “inquietudine scientifica” di Giampaolo Di Marco
Nell’era dei “gastro esibizionisti” di Guido Mattioni
Dieci libri sotto l’ombrellone di Sara Napolitano
Direttiva qualifiche, a metà del guado di Sabina Pizzamiglio
Le radici di un’identità
di Carmelo Russo
Le antiche pietre ci dicono chi siamo di Romina Villa
Sold out per finta di Carlo Bertotti
La misura dell’uomo di Roberto Carminati
L’Editoriale di Marco Natali
News From Europe a cura del Desk europeo di ConfProfessioni
Pronto Fisco di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi
Welfare e dintorni
In vetrina in collaborazione con BeProf
Post Scriptum di Giovanni Francavilla



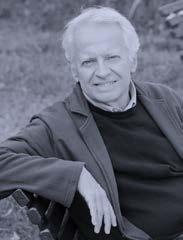
Dottore commercialista e Revisore Legale. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Finanze – Area Reddito d’Impresa. Membro dell’Advisory Board Assoholding. E’ Autore di numerosi libri in materia fiscale e articoli su riviste di settore. Relatore in eventi delle principali organizzazioni convegnistiche.
Psicologa del lavoro, Responsabile Scientifica, Consigliera d’Amministrazione e Direttrice Operativa di Mindwork. Da gennaio 2020 è membro del Consiglio dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria. TEDx speaker, scrive periodicamente per Il Sole 24 Ore ed è autrice dei seguenti libri: “Come stanno i tuoi? Perché è importante il benessere psicologico in azienda” (2022, Vallardi Editore), “Vulnerabilità” (2024, FrancoAngeli Editore) e “Ritorno al benessere: gestire lo stress e prevenire il burnout per organizzazioni sostenibili” (2024, FrancoAngeli Editore). Da febbraio 2023 è co-host del podcast di Will Media (Chora Media) e Mindwork “Troppo Poco” che parla di salute mentale al lavoro.
Professore ordinario presso il Dipartimento di filosofia dell’Università di Bologna dal 2014. Svolge ricerche prevalentemente nell’ambito dell’estetica contemporanea tedesca e anglo-americana. I suoi studi riguardano il nesso tra prassi percettiva, processi formativi e pratiche espressive secondo una concezione antropologica dell’estetico. Attualmente la ricerca ha riguardato fenomeni di esteticità diffusa e la determinazione dell’estetico in quanto campo relazionale secondo il modello della mente estesa.
Nato a Udine nel 1952, ha vissuto a Milano quarant’anni, spesi in importanti quotidiani, settimanali e mensili, ricoprendo tutti i ruoli, da cronista a vicedirettore, incarico che però, da insofferente qual è alle scrivanie, ha lasciato sua sponte per ritornare al ruolo a lui più congeniale, quello di inviato speciale, in viaggio intorno al mondo e attorno all’uomo. Dal 2015 vive nella Repubblica di San Marino, che ama in quanto luogo di sorrisi e Antica Terra della Libertà, pur senza mai dimenticare la sua “casa lontano da casa”, la bellissima Savannah, in Georgia, dov’è cittadino onorario dal 1998.
«Non c’è alcuna differenza tra un’impresa individuale e un professionista iscritto a un ordine o a una professione non ordinistica. Si tratta di un passaggio doveroso che recepisce un principio unanimemente condiviso: per impresa deve intendersi qualsiasi entità che svolge un’attività economica a prescindere da forma e organizzazione»
— Massimo Bitonci, Sottosegretario di Stato al ministero delle Imprese e del Made in Italy



Avvocata è iscritta all’albo del Foro di Cagliari dal 2001. È Segretaria di ANF Cagliari e componente del Direttivo Nazionale di ANF. È Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari e componente esterno della Commissione Pari Opportunità del CNF. Si occupa di diseguaglianze di genere e pari opportunità.
Dottore commercialista, esperto in fiscalità delle imposte dirette, accertamento e contenzioso tributario e fiscalità internazionale. Ha lavorato all’Agenzia delle Entrate e al ministero delle Finanze, dipartimento delle Finanze. Relatore e docente in numerosi corsi di diritto tributario e autore di numerose pubblicazioni. È componente della Commissione degli esperti degli studi di settore, in rappresentanza di Confprofessioni.
Il Libero Professionista
Mensile digitale di informazione e cultura
direttore responsabile
Giovanni Francavilla
redazione
Nadia Anzani, Mario Rossi
hanno collaborato
Carlo Bertotti, Lelio Cacciapaglia, Roberto Carminati, Biancamaria Cavallini, Laura Ciccozzi, Luca Ciammarughi, Isabella Colombo, Matteo Durante, Theodoros Koutroubas, Diana Larenza, Giovanni Matteucci, Guido Mattioni, Rosanna Mura, Sara Napolitano, Carolina Parma, Sabina Pizzamiglio, Carmelo Russo, Maurizio Tozzi, Romina Villa
segreteria di redazione
Miriam Minopoli
comitato editoriale
Roberto Accossu, Salvo Barrano, Paola Cogotti, Carmen Colangelo, Alessandro Dabbene, Luigi Alfredo Carunchio, Andrea Dili, Paola Fiorillo, Raffaele Loprete, Marco Natali, Maria Pungetti, Dominella Quagliata, Ezio Maria Reggiani, Gioele Semprini Cesari
redazione
Via Boccaccio, 11 – 20121 Milano
contatti
Tel. 02 36692133 Fax 02 25060955 redazione@illiberoprofessionista.it info@illiberoprofessionista.it
editore
Lp Comunicazione Srl, Via Boccaccio, 11 – 20121 Milano
Registrazione Tribunale di Milano n. 118 del 24/02/2011
progetto grafico e impaginazione Pianeta.Studio Srl Società Benefit di Massimiliano Mauro info@pianeta.studio | @pianeta_studio
Designer Francesca Fossati
disclaimer I contenuti e le informazioni contenute ne il Libero Professionista sono sottoposti ad un accurato controllo da parte della redazione, nel rispetto dei principi di deontologia professionale vigenti in materia giornalistica. Tuttavia, il Libero Professionista declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti in merito a eventuali danni che possano derivare da possibili errori o imprecisioni dei contenuti.
Il Libero professionista può contenere collegamenti ipertestuali (link) verso altri siti di proprietà di soggetti diversi da il Libero Professionista e declina ogni responsabilità riguardo il contenuto di questi siti o l’uso delle informazioni raccolti dagli stessi.
Tutti i contenuti de il Libero Professionista possono essere utilizzati, a condizione di citare sempre il Libero Professionista come fonte ed inserire un link o collegamento ben visibile a https://confprofessioni.eu/ il-libero-professionista-reloaded/.
© Il Libero Professionista • All rights reserved 2024

Sono uscito dal Teatro Mario Dal Monaco a Treviso la sera del 19 luglio, con in testa ancora l’eco de “Gli Invisibili. La solitudine dei Giusti”, lo spettacolo-evento che Confprofessioni ha voluto e realizzato insieme ad Avviso Pubblico e alle istituzioni locali. Ero scosso dalle parole potenti e dalla partecipazione appassionata del pubblico: un abbraccio ideale alle persone che nel silenzio hanno difeso la giustizia, metafora di un Paese dove il ceto medio è entrato in una crisi tanto profonda quanto silenziosa.
La spina dorsale dell’economia sconta oggi un arretramento, è sempre più ai margini, dimenticata. Professionisti, impiegati, artigiani, piccoli imprenditori, non sono poveri, ma nemmeno sereni. Stringono i denti, rinunciano, resistono. Secondo il Censis, il reddito disponibile lordo pro-capite in Italia è calato del 7% in vent’anni. La ricchezza netta del 5,5%. Ma a pesare è soprattutto la percezione: l’85% degli italiani crede che la propria posizione sociale non potrà migliorare. Assistiamo a una spaventosa crisi della speranza, della fiducia, della prospettiva verso il futuro. Non è solo un problema economico, ma di identità e coesione sociale
che investe larga parte della popolazione: secondo un sondaggio, sempre a cura del Censis, più del 60% degli italiani. Il ceto medio in Italia, un tempo vero motore della democrazia e del benessere, è ora intrappolato tra un welfare debole e una mobilità sociale inesistente. Nel pubblico a Treviso, tra i professionisti presenti, ho visto i volti di avvocati, commercialisti, medici; una classe media in bilico, spesso costretta a misurarsi con una realtà inedita: quella di un ascensore sociale bloccato, della costrizione a fare rinunce quotidiane.
La solitudine dei “giusti” rispecchia quella di una classe sociale che non chiede più solo riscatto economico, ma riconoscimento: di valore, di ruolo, di rappresentanza. È ora di costruire quindi una nuova alleanza tra cittadini e istituzioni: politiche attive del lavoro, servizi per la famiglia, una seria valorizzazione del capitale umano, pari condizioni di lavoro e di reddito tra uomini e donne. Bisogna ricostruire il tessuto del ceto medio, renderlo visibile, investire su di esso come investimento nel futuro. È ora di rimettere al centro chi lavora, chi forma, chi cura, chi costruisce. La classe media non chiede privilegi, ma futuro.


I fatti, le analisi e gli approfondimenti dell’attualità politica ed economica in Italia e in Europa. Con un occhio rivolto al mondo della libera professione
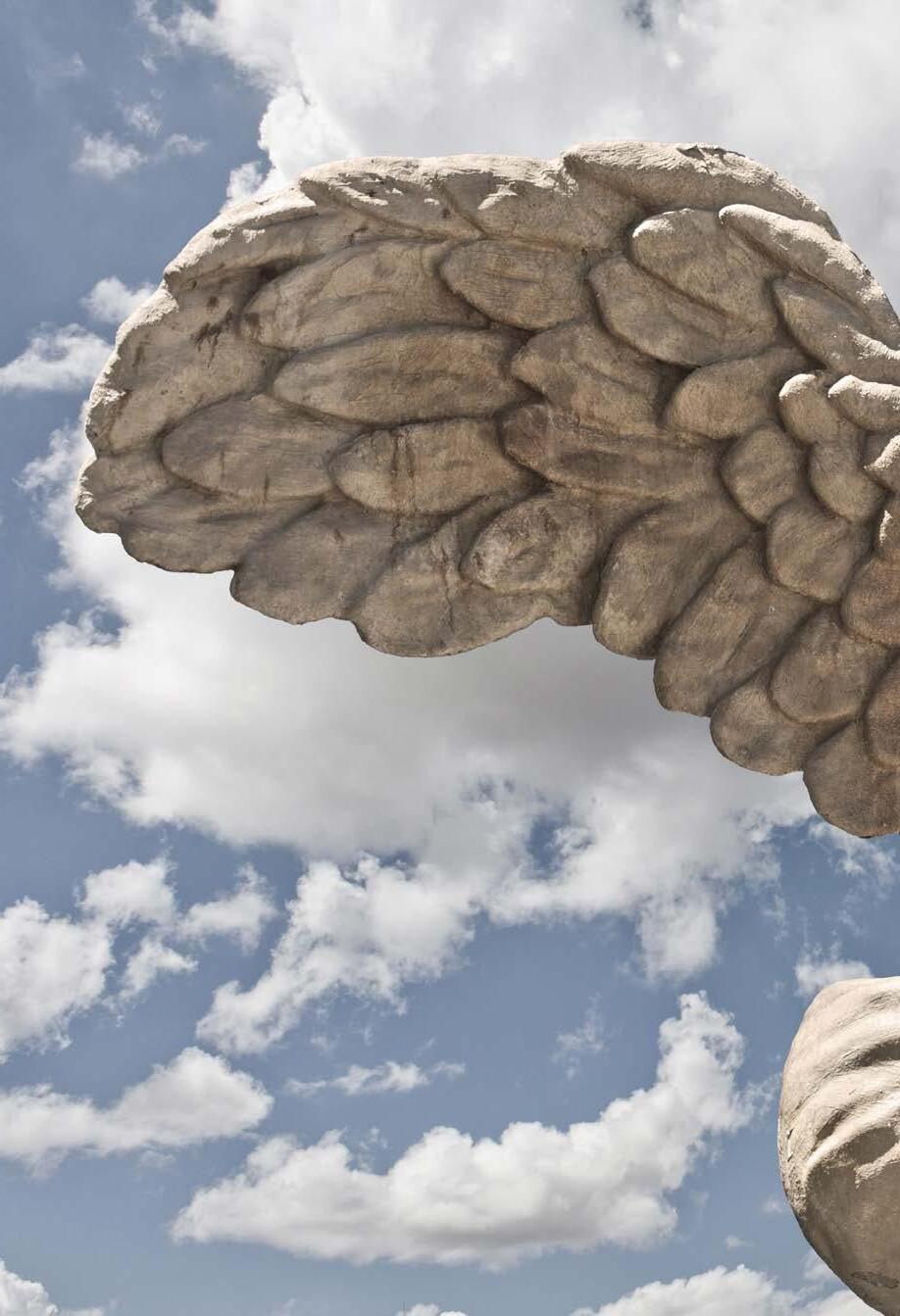



L'armonia e la bellezza sono forze vitali che nutrono la nostra psiche, stimolano la nostra creatività e migliorano la qualità della nostra vita. Sarà per questo che il mercato delle opere d'arte mostra interessanti segnali di ripresa e anche la musica classica attira sempre più le nuove generazioni. Ma non solo. L'arte fa bene anche negli ambienti di lavoro, influenzando performance e produttività
In un mondo che spesso privilegia la velocità, l’efficienza e il tangibile, potremmo essere tentati di considerare la bellezza e l’arte come lussi piacevoli ma non essenziali. Eppure, un’osservazione più attenta rivela una verità profonda: da millenni, l’essere umano ha cercato, creato e venerato il bello, manifestandolo in ogni aspetto della propria esistenza, dalle grotte preistoriche alle cattedrali gotiche, dai canti popolari alle sinfonie più complesse. Testimonianze che confermano quanto la bellezza e l’arte non sono solo un abbellimento esteriore, ma forze vitali che nutrono la nostra psiche, stimolano la nostra creatività e ci connettono a qualcosa di più grande di noi stessi, modellando in modo indelebile la nostra percezione del mondo e la qualità della nostra vita. A sostenerlo è anche la neuroestetica, disciplina nata nel 2001 che studia il misterioso processo percettivo e chimico che si attiva nel momento in cui i nostri occhi incontrano un’opera
d’arte: un iter visivo attivo costruttore dell’immagine percepita e in grado di generare in noi quelle sensazioni di bellezza e piacere che le opere d’arte sono in grado di regalarci ogni volta che ci soffermiamo davanti a loro.
Forse è anche per questo che il mercato dell’arte, seppur in flessione da qualche anno a livello mondiale a causa dell’instabilità geopolitica e dei mercati finanziari ballerini, mostra una certa resilienza e lascia sperare in una fine 2025 in ripresa. I numeri parlano chiaro. Stando infatti alla nona edizione del rapporto The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2025, redatto dall’economista culturale Clare McAndrew, fondatrice di Arts Economics, e pubblicato in collaborazione con Art Basel e UBS, che ogni anno fornisce un’analisi macroeconomica dello stato del mercato globale dell’arte antica, moderna e contemporanea, le vendite d’arte a livello globale, nel 2024 hanno raggiunto un valore stimato di 57,5 miliardi di dollari, con un calo del 12% sull’anno precedente.
A rallentare sono state sia le vendite dei galleristi sia quelle delle aste pubbliche, con cali rispettivamente del 6% e 25%. Ma nonostante tutto il settore ha mantenuto una certa dinamicità grazie alla tenuta dei segmenti a prezzo inferiore che hanno contribuito a diversificare l’ecosistema di mercato. Il periodo di grande instabilità ha portato gli amatori a una maggiore prudenza, preferendo opere con prezzi più contenuti e ad avere un approccio più cauto nell’offerta che ha portato a una presenza minore di capolavori in vendita. A confermarlo è il dato sul volume numerico delle transazioni che, a differenza del valore generato, è invece salito nel 2024. Sebbene, infatti, i valori siano diminuiti del 12% su base annua, il numero di vendite realizzate è aumentato del 3%, a dimostrazione di un certo dinamismo resiliente e costante.
Che l’arte e la bellezza siano un medicamento per la nostra psiche lo testimonia anche il buon andamento del mercato museale. A snocciolare le cifre in questo caso ci ha pensato, come ogni anno, The Art Newspaper, prestigiosa rivista internazionale dedicata all’arte, pubblicando la classifica dei 100 musei più visitati al mondo nel 2024. Così scopriamo che il Louvre si conferma essere il museo più visitato al mondo con 8.737.050 visitatori, l’1% in meno rispetto al 2024, seguito dai Musei Vaticani che hanno totalizzato 6.825.436 ingressi, registrando un aumento dell’1% rispetto al 2023, mentre la terza posizione è occupata dal British Museum che nel 2024 ha visto i suoi visitatori lievitare dell’11% sull’anno precedente. Il primo museo statale italiano lo si trova al 19esimo posto con la Galleria degli Uffizi con 2.908.028 visitatori, il 7% in più rispetto al 2023 e il 23% in più



rispetto al 2019. Al 56esimo posto troviamo invece il Palazzo Ducale di Venezia con 1.333.314 visitatori, +2% rispetto all’anno precedente; l’80esimo posto è invece occupato dal Museo Egizio con 1.036.689 visitatori, - 2% rispetto al 2023. Infine con 909.020 visitatori Palazzo Pitti di Firenze si piazza all’89esimo posto (dall’81esimo) con un incremento del 3 sul 2023. Classifica a parte, lo scorso anno in Italia i musei, monumenti, aree archeologiche (MMAA) in media hanno registrato un aumento di visitatori del 7% e di biglietteria del 6%. In leggero calo, invece, i finanziamenti pubblici, passati dal 40% al 38%, stabili quelli privati del 17% e altri introiti del 4%.
E la conferma che abbiamo bisogno di circondarci di armonia arriva anche dal mondo della musica classica che, a sorpresa, sta conquistando sempre più giovani. Basti dire che a Roma sono addirittura nati i rave di musica classica, che portano centinaia di ragazzi a ballare fino a notte
fonda sulle note di Bach e Vivaldi. Ma c’è anche Amadeus Factory, che potremmo definire come l’X Factor della classica, e il concorso pianistico nazionale Premio Venezia dedicato agli under 35, con la passione per l’opera. Non solo: dal teatro La Fenice di Venezia alla Scala di Milano, dall’Opera di Roma al San Carlo di Napoli, passando dal Santa Cecilia di Palermo, si registrano dati e affluenze in crescita sulla presenza di adolescenti e giovani nei teatri italiani. Sempre più, inoltre, sono le iniziative che mirano ad avvicinare i giovani alla musica classica e alle opere. Tanto che secondo l’Istat, circa il 16% dei giovani tra i 18 e i 24 anni ha partecipato ad almeno un concerto di musica classica negli ultimi anni. Così, mentre su TikTok l’hashtag TikTok #classictok conta circa 80 milioni di visualizzazioni, gli esperti cercano di inquadrare il fenomeno che deve il suo successo a diversi fattori. Il primo è la presenza costante di com-

posizioni di orchestra in successi pop, come la serie televisiva sudcoreana Squid Game o l’americana Bridgerton. Completano il quadro le estetiche micro-trend di quest’epoca - come la Dark Academia, sottocultura romantica che celebra bellezza del passato anche appropriandosi della musica classica per accentuare atmosfere baudelairiane - e la produzione di film che omaggiano grandi personalità del genere, come Tàr, dedicato a Lydia Tár, tra le più grandi compositrici/direttrici d’orchestra e prima donna in assoluto a dirigere un’importante orchestra tedesca e Maria, pellicola che ripercorre gli ultimi giorni di vita del soprano Maria Callas.
Ma anche negli ambienti di lavoro l’arte negli ultimi tempi ha saputo guadagnarsi interessanti spazi. Diverse sono le aziende che ospitano al loro interno collezioni d’arte o mostre temporanee. Un esempio è Elica, azienda nota in tutto il mondo per le sue cappe di design, dove l’arte viene considerata un modello etico. Motrice di creatività, innovazione, progresso, sostenibilità. Una convinzione che ha portato la famiglia Casoli, proprietaria dell’azienda di Fabriano, a creare una Fondazione dedicata al fondatore della società: Ermanno Casoli che può essere considerata una pioniera nell’indagare le potenzialità del dialogo tra arte e impresa, tanto da affermarsi negli anni come modello per la formazione aziendale, con attività artistiche rivolte ai dipendenti e alle loro famiglie. E nella bellezza credeva molto anche Pietro Barilla, fondatore del noto pastificio nazionale che amava ripetere: «L’arte è una bellezza da condividere». La sua frequentazione con critici e artisti lo portò a circondarsi di opere d’arte moderna e a circondarne tutti i suoi collaboratori. Così gli uffici e il pastificio di Pedrignano a Parma assunsero da subito l’aspetto di un affascinante museo: un connubio insolito tra la bellezza del saper produrre cibo buono e le forme dei quadri
di Boccioni, De Chirico, Magritte, Guttuso, Morandi, Chagall, Picasso e delle sculture di Rodin, Moore, Marini, Manzù. «Mi piace che quadri e sculture vivano fra chi lavora nell’azienda. In ogni ufficio un quadro più o meno importante. Importante però è solo il giudizio della critica. Per me, infatti, sono tutti importanti: li ho scelti uno per uno lasciandomi trascinare dall’emozione», diceva Pietro Barilla. Una passione che poi è stata portata avanti anche dai figli.
E non sono scelte casuali. Alcuni studi mostrano, infatti, che l’arte fa bene al business contribuendo a migliorare le performance degli indicatori economico-finanziari e a dare un’immagine positiva di un’azienda ai potenziali clienti e futuri dipendenti. Ma ci sono anche benefici che coinvolgono la sfera psicologica e del benessere della persona, contribuendo a motivare e coltivare la creatività e la socialità. ■

Non solo decoro per pareti e per uffici di rappresentanza. Il bello negli studi professionali così come in ufficio orienta in maniera inedita lo sguardo, restituisce senso, rallenta il ritmo e apre spazi di possibilità. Perché quando un luogo di lavoro è appagante le persone si sentono riconosciute, valorizzate e coinvolte


Accade qualcosa quando la bellezza entra negli uffici. Non si limita a decorare le pareti o a rendere gli spazi più curati e accoglienti. Il bello trasforma: orienta in maniera inedita lo sguardo, restituisce senso, rallenta il ritmo e apre spazi di possibilità. Negli ultimi anni, la riflessione sul ruolo dell’estetica in azienda ha guadagnato attenzione. In un mondo del lavoro sempre più accelerato, competitivo e segnato da ansia e stress, il bello può diventare un fattore strategico.
L’ESTETICA ORGANIZZATIVA
L’estetica in azienda supera la dimensione visiva: i processi cognitivi, decisionali e relazionali sono infatti profondamente influenzati dalle caratteristiche dell’ambiente in cui si svolgono. Da questo punto di vista, si potrebbe affermare che l’estetica modula i comportamenti1.
Alcuni studi2, ad esempio, hanno rilevato che l’esposizione alle opere d’arte riduce l’ansia e lo stress. Altri, che una progettazione attenta degli uffici - orientata al bello, al comfort e centrata sulle persone - non solo ha un impatto positivo sull’immagine aziendale e nell’attrarre talenti, ma migliora anche produttività e benessere3
A tal proposito, una ricerca condotta da Craig Knight e Alexander Haslam4, ha quantificato questi effetti, mostrando incrementi di produttività fino al 17–32 %, specialmente quando le persone avevano la possibilità di scegliere personalmente gli ornamenti. In particolare, lo studio ha dimostrato come gli ambienti di lavoro arricchiti con arte e piante non solo siano più favorevoli in termini di comfort fisico e psicologico e soddisfazione lavorativa, ma permettano anche di svolgere i compiti più velocemente, senza perdere in precisione. L’abbellimento dello spazio, inoltre, è stato associato a una maggiore identificazione con l’organizzazione. Le neuroscienze spiegano questi effetti: la
note
1 Dangmei, J. (2017). Organizational aesthetics and its implications for managing human resources at workplace. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 7(3), 151-156
2 https://www.auckland.ac.nz/en/ news/2021/09/29/can-viewing-art-reduce-stress. html
3 https://www.idi-design.ie/content/files/ impact-office-design-full-research.pdf
4 https://psycnet.apa.org/buy/2010-12508-006


bellezza stimola il rilascio di dopamina, un neurotrasmettitore legato al piacere e alla motivazione. L’arte favorisce inoltre la neuroplasticità, ossia la capacità del cervello di adattarsi e riorganizzarsi.
Un aspetto cruciale in contesti caratterizzati da continui cambiamenti. In particolare, esiste addirittura una disciplina multidisciplinare - chiamata neuroestetica - che studia specificamente le basi neurali dell'esperienza estetica, con l’obiettivo, ad esempio, di indagarne gli effetti terapeutici.
L’ARTE ENTRA IN UFFICIO
Sempre più aziende, in Italia e all’estero, sperimentano nei loro uffici il potere trasformativo dell’arte. Coldwell Banker Richard Ellis, multinazionale del real estate, non solo ospita collezioni permanenti nei propri spazi, ma pone particolare attenzione alla loro progettazione, con l’obiettivo che questi siano il più possibile “human-centric”. Nel nostro Paese,

Deloitte Legal ha promosso il progetto “Arte In Ufficio”, esponendo nella propria sede di Milano alcune creazioni artistiche, in collaborazione con ArtNoble Gallery. Significativa è inoltre l’esperienza di Deutsche Bank, proprietaria di una collezione di oltre sessantamila opere.
L’azienda rende quest’ultime accessibili e consultabili ai propri dipendenti attraverso un’app dedicata, e permette di “noleggiarle” per arredare gli uffici della propria sede. L’esempio di Deutsche Bank, in particolare, dimostra come l’arte possa andare ben oltre l’estetica: può diventare esperienza condivisa e strumento di connessione. Investire nel bello è una scelta che rivela molto della cultura organizzati-
va: valorizza l’esperienza umana e riconosce e legittima il bisogno di emozionarsi. Quando un luogo di lavoro è accogliente ed esteticamente appagante, le persone si sentono riconosciute, valorizzate e coinvolte. Portare l’arte in azienda è dunque un invito a ripensare il rapporto con il lavoro. Non è necessario rivoluzionare uffici e sedi.
È possibile cominciare con progetti pilota: un’opera d’arte in sala riunioni, così come una mostra temporanea negli spazi comuni. Il bello non necessità di grandi numeri, ma di piccoli accorgimenti. Di gesti concreti che rendano le organizzazioni non solo più umane, ma anche maggiormente in grado di immaginare il futuro. ■


di Matteo Durante
L’oggetto di design giusto in un luogo di lavoro trasmette calore e accoglienza e migliora la qualità della vita di chi quell’ufficio lo frequenta per diverse ore. Il bello è terapeutico: deve sostenere, ispirare, fare star bene. Parla l’architetto designer
In un mondo dove le ore trascorse al lavoro superano spesso quelle dedicate alla vita privata, l’ambiente professionale diventa il palcoscenico della nostra quotidianità. Chi meglio dell’architetto Roberto Semprini, il creatore di Delfin, il tavolino-scultura in esposizione al Design Museum di Londra e del divanetto Tatlin a forma di spirale, una delle voci più autorevoli nel campo del design, può raccontarci l’importanza della bellezza negli spazi di lavoro e di come estetica e funzionalità possano trasformare un ufficio in un luogo dove “si sta bene”, con un impatto tangibile sulla produttività e il morale? Lo abbiamo raggiunto a Ragusa Ibla, a margine della quinta edizione del Festival Barocco e Neobarocco, di cui Semprini è direttore artistico e ideatore, che anima i palazzi barocchi più belli della città patrimonio Unesco con eventi, mostre, incontri, videomapping, talk con architetti, designer, artisti, stilisti e studenti.
D. Il tema della bellezza sembra essere il cuore del suo lavoro. Quanto è importante oggi?
Direi che è imprescindibile: non se ne può fare a meno. Il design, nel tempo, ha assunto un ruolo quasi terapeutico: non è solo questione di estetica, ma anche di far star bene le persone. Questo è il suo potere, democratico, diverso da quello dell’arte. Mentre l’arte può emozionare e scuotere, il design risponde anche a esigenze di funzionalità. Una poltroncina, ad esempio, non deve solo essere bella, ma deve accogliere, essere comoda, pratica.
D. È come se il design avesse “rubato” spazio all’arte. Lei come definisce questa relazione?
Il confine tra arte e design è sottile. E la differenza tra i due mondi non sta nella bellezza o nel prezzo. Entrambi tra l’altro possono essere prodotti in serie. Ciò che

distingue il design dall’arte è la funzione. Un quadro è contemplativo, è puro piacere estetico, mentre un oggetto di design ha una missione: essere utile. Ecco perché creare un oggetto che sia funzionale e bello è una sfida molto complessa. Mentre gli artisti devono, diciamo così, rispondere “solo” al canone della propria sensibilità.
D. Lei ha definito la bellezza del design democratica. Cosa intende?
Significa che il design è accessibile. Questo è il suo potere: entrare in case, uffici, hotel, navi, e far parte della vita quotidiana di molte persone. Per essere chiaro: non è tanto il prezzo a rendere democratico un oggetto di design, visto che ci sono pezzi
Roberto Semprini, architetto e designer inventore di Delfin il tavolino-scultura esposto al Design Museum di Londra
che costano come o più di un’opera d’arte, quanto il fatto che, riprodotti in serie limitata, molti pezzi sono pensati per essere fruibili e goduti da un pubblico più ampio. È una forma di bellezza che si diffonde e si condivide, che gira di più nel mondo.
D. La funzionalità sembra essere centrale nel suo approccio. Come si traduce nel mondo del lavoro?
Un ufficio ben progettato è un ufficio dove si sta bene. La lampada giusta non è solo una fonte di luce, ma una presenza che trasmette calore e accoglienza e che migliora la qualità della vita di chi quell’ufficio lo frequenta per diverse ore. L’arte può avere un impatto emotivo: il celebre “Urlo” di Munch è un pugno allo stomaco. Il design, invece, è - deve essere - terapeutico: deve sostenere, ispirare, fare star bene.
D. Ha creato oggetti che sono diventati vere icone del design italiano, come il celebre divanetto Tatlin per Edra, celebrato pure con un francobollo. Come nascono queste idee?
Spesso da un approccio artistico. L’ispirazione arriva da forme naturali, dalla storia, dal barocco. Penso, ad esempio, alle opere ispirate alla spirale del rosone, che ho realizzato per il festival di Ragusa Ibla. È un dialogo continuo tra passato e presente, tra estetica e funzione.
D. Cosa distingue design e artigianato?
Direi che l’artigianato è il ponte tra arte e design. Un artigiano è spesso anche un artista, soprattutto quando realizza prototipi o pezzi unici per il design, anche se per conto di un’azienda. Ovviamente non mi riferisco all’artigianato commerciale, senza anima. Parlo di quello fatto con passione, con mani esperte che creano qualcosa, di taylor made, cioè su misura, unico e speciale.
D. Ha un’idea personale della bellezza funzionale. Come la descriverebbe?
Un tempo si diceva che la forma segue la funzione. Oggi possiamo affermare che è l’emozione a seguire la funzione. Gli oggetti devono suscitare emozioni, essere belli e funzionali allo stesso tempo. Questo è il design che amo: democratico, accessibile, capace di migliorare la vita di chi lo sceglie.
D. Il design made in Italy è ancora un punto di forza del nostro Paese?
Assolutamente. Il nostro design, come la moda e la cucina, ha una marcia in più. Abbiamo un patrimonio culturale immenso, una diversità regionale che arricchisce il nostro genio creativo. Questo ci rende unici e difficili da eguagliare. Speriamo di continuare a essere imbattibili!

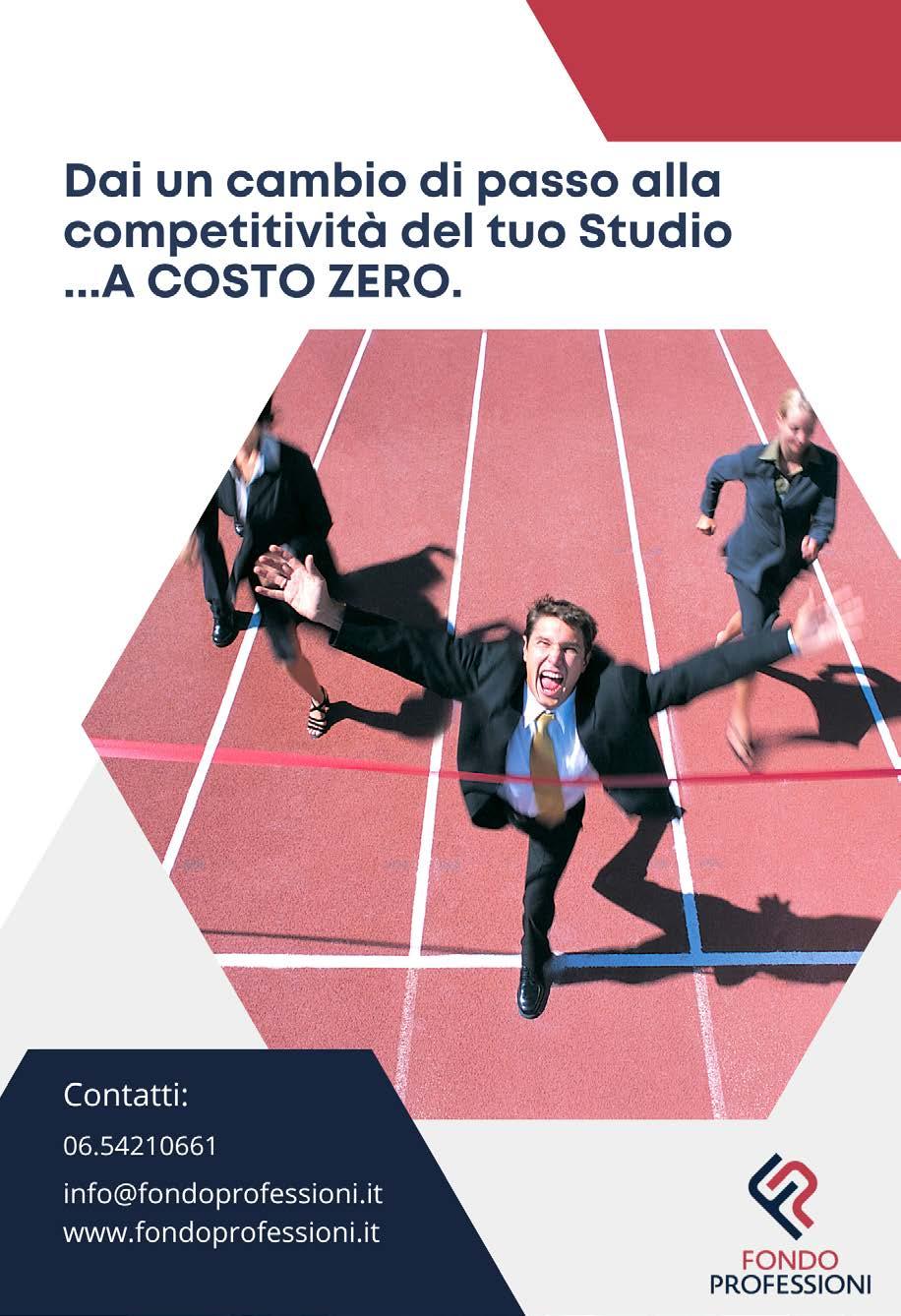
di Matteo Durante
La bellezza ha il potere di elevare gli ambienti, trasformandoli in spazi che ispirano e trasmettono emozioni. Ma è anche un valido biglietto da visita che riflette l’identità e i valori di uno studio professionale. Un modo per raccontare una storia, quella di chi vive e lavora in quegli spazi, ma anche per lasciare un segno in chi li visita. Parola di avvocato-collezionista

Luca Giacopuzzi, uno dei primi avvocati in Italia ad occuparsi anche di diritto dell'arte

«Alle famiglie e ai privati che si rivolgono al mio studio per una consulenza sull’acquisto di un’opera d’arte, la prima domanda che faccio è: perché lo vuoi fare? Per un appagamento estetico? Per un "dividendo" di tipo culturale, cioè l’idea di avere alla parete un’opera museale? O come semplice investimento? Partendo dal presupposto che sono tutte buone motivazioni, a ognuna di queste corrisponde un tipo di scelta e quindi di opera». A parlare è l’avvocato Luca Giacopuzzi, fondatore dell’omonimo studio di Verona (con sede anche a Desenzano), che dal 2005 si occupa di diritto d’impresa ed è stato uno dei primi studi legali in Italia ad occuparsi anche di diritto dell’arte, con una competenza verticale sul settore oltre che su quello delle nuove tecnologie.
D. Lei è un collezionista. È uno di quelli che pensa che circondarsi di bellezza faccia bene anche al lavoro?
L’idea nasce dalla mia passione personale per l’arte e dal desiderio di rendere il luogo di lavoro più stimolante e accogliente, sia per i collaboratori che per i clienti. L’arte ha il potere di elevare gli ambienti, trasformandoli in spazi che ispirano e trasmettono emozioni. Inoltre, credo che un ambiente ben curato, abbellito da opere d’arte, sia una sorta di biglietto da visita che riflette l’identità e i valori dello studio. È un modo per raccontare una storia, quella di chi vive e lavora in questi spazi, ma anche per lasciare un segno in chi li visita.
D. Che tipo di opere predilige per il suo studio?
Mi affido principalmente al mio gusto personale. Colleziono opere del “PostWar”, in particolare artisti degli Anni ‘50 e ‘60, perché trovo che abbiano un valore storico e culturale profondo. Tuttavia,
sono attento anche a scegliere opere che possano suscitare curiosità e interesse, anche in chi ha meno familiarità con l’arte. L’importante è che ci sia una connessione autentica con il pezzo, al di là del suo valore economico. Una collezione dovrebbe rappresentare non solo il gusto del suo proprietario, ma anche il contesto in cui si trova, in questo caso uno studio legale.
D. C’è un’opera che i suoi clienti apprezzano particolarmente?
Sì. Ed è un’opera che per il valore economico è la meno significativa, però è un po’ particolare e quindi catalizza l’attenzione di chi entra nel mio studio. Questo dimostra che non sempre il valore economico è sinonimo di fascino. È interessante vedere come anche le opere più semplici possano stimolare conversazioni e creare un’atmosfera più accogliente.

D. Come descriverebbe il concetto di bellezza, soprattutto in relazione all’arte?
Provocatoriamente, potrei rispondere che per me il discorso del bello è “ripugnante”. Nel senso che io colleziono arte secondo criteri precisi, tra i quali non è annoverato “il bello” in senso oggettivo. Perché ciò che a una persona appare straordinario, potrebbe lasciare indifferente un’altra. E perché ci sono delle opere d’arte che possono essere celebrate e richieste dal mercato dell’arte, anche se sono prodotte senza una particolare abilità manuale. E infine perché credo che il vero valore dell’arte risieda nella sua capacità di generare emozioni, di far riflettere e, talvolta, di scuotere. Quando Duchamp prende un “orinatoio” e ne fa la “Fontana”, opera sparti-acque nella storia dell’arte, ribalta in maniera palese il concetto di bello, perché sfido chiunque a sostenere che l’orinatoio sia un bell’oggetto. Voglio dire: ci sono delle opere d’arte che non sono belle esteticamente ma sono più significative di altre.
D. Qual è il beneficio principale che un’opera offre a uno studio di professionisti?
Portare arte in uno studio professionale significa introdurre un elemento di distinzione e originalità. E non parlo solo di una questione estetica, ma anche di benessere: circondarsi di bellezza contribuisce a migliorare la produttività, incidendo sull’umore dei singoli e sull’atmosfera del posto. Inoltre, l’arte è un mezzo per avviare conversazioni, rompere il ghiaccio e creare un collegamento umano. Per esempio: lavoro e vivo a Verona, città d’arte, ricca di scorci, posti e panorami di un certo fascino. Davanti ai quali, andando e tornando in ufficio, io mi soffermo ormai pochi minuti; a differenza dei turisti che li colgono, ne rimangono colpiti, li fotografano. Succede perché io sono abituato a quelle bellezze
e il loro effetto lo sento meno. A maggior ragione quando sono immerso nella quotidianità dalle scadenze, delle mille cose da fare. La verità è che un’opera arte in studio mette a proprio agio, toglie dal grigiore, permette di provare un’emozione.
D. Quale criterio segue nello scegliere un’opera d’arte?
Sono molto influenzato da quelle opere in cui vedo qualcosa, che mi parlano. Anche opere di artisti emergenti (o anagraficamente giovani) o di autori meno conosciuti che però, secondo me, meritano attenzione. Preferisco scegliere opere con un valore intrinseco, piuttosto che seguire mode passeggere. Seguo cioè un criterio anticiclico: opere importanti di artisti che magari oggi il mercato colpevolmente dimentica, o meglio che valgono secondo me anche più di quello che costano. In questo modo, si contribuisce a creare una cultura del bello più consapevole e rispettosa, anche perché il mondo dell’arte è complicato. Soprattutto a causa di certe speculazioni che a me danno fastidio, come per esempio usare un artista, “metterlo in hype” e poi lasciarlo cadere nel dimenticatoio. Questo meccanismo commerciale fa male, perché il vero collezionista acquista per passione.
D. Come lei, altri professionisti - notai e avvocati in particolare - investono in arte. Possono essere definiti nuovi mecenati?
Se il mecenatismo è far del bene allora, sì, lo siamo. Ho acquistato lavori di giovani artisti perché ci ho visto un percorso, un significato. E sono attento a che il settore possa avere nuovi adepti e sia libero da certe storture. Certo, serve preparazione ed esperienza: non esistono formule alchemiche. Le gallerie un tempo assolvevano anche a un ruolo guida sulle regole del gioco. Prima contavano i collezionisti, ora valgono di più i clienti, che è una cosa diversa. ■

L'armonia contemporanea è diventata un processo, dismettendo l’immagine ingannevole di principio canonico che ha accompagnato gran parte della riflessione estetica occidentale. Natura, paesaggio, spazi urbani e abitativi vengono osservati secondo gli stessi criteri visivi, narrativi, e soprattutto performativi che governano l’inquietudine estetica del sé
di Giovanni Matteucci

Nella storia della cultura è sempre rischioso tracciare confini tra un “prima” e un “dopo”. Per quanto, da lontano, gli eventi possano apparire ben ordinati, i processi culturali si rivelano spesso sfuggenti se osservati da vicino. Anche quando si tenta di delineare le trasformazioni di un determinato fenomeno, è dunque saggio resistere alla tentazione di fissare soglie temporali rigide. Meglio, piuttosto, parlare di tendenze e linee di sviluppo, che in singoli momenti possono mostrarsi tortuose, frammentate, talvolta persino contraddittorie.
Ciò vale in modo particolare sia per il tema di questo intervento, sia per il periodo storico preso in esame. I fenomeni estetici contemporanei, infatti, sembrano accentuare un tratto forse connaturato all’universo del gusto in quanto tale.
Qualunque sia la comunità di riferimento – locale o globale – in essa oggi convivono con crescente evidenza istanze di bellezza tra loro eterogenee, se non apertamente rivali. Se dunque volessimo tracciare un percorso “evolutivo” della bellezza negli ultimi decenni, non potremmo affidarci a una semplice sequenza cronologica di stili, come accade talvolta nei manuali di storia dell’arte o della letteratura.
Al contrario, si potrebbe affermare che la bellezza contemporanea sia diventata essa stessa un processo, dismettendo l’immagine ingannevole di principio canonico che ha accompagnato gran parte della riflessione estetica occidentale.
È significativo, a questo proposito, ricordare come in alcune lingue dell’Estremo Oriente manchino concetti unitari per “bellezza” ed “estetica”. Un dato che invita a considerare la nostra idea di bellezza come costruzione storica e culturale: una produzione specifica della “provin-
cia” occidentale, oggi messa in discussione – o quanto meno sottoposta a tensione – dalle dinamiche della globalizzazione.
L’urto prodotto da quest’ultima non si è però limitato a relativizzare il bello, come spesso si teme in chiave nostalgica o pessimistica. Ha avuto piuttosto l’effetto, forse salutare, di riattivare un carattere dell’estetico che la tradizione occidentale a lungo ha irrigidito in forme normative, puntualmente smentite dalla stessa storia dei fenomeni estetici.
Nello specifico, le dinamiche globali hanno portato a compimento istanze emerse a partire dagli anni Sessanta del Novecento, quando la bellezza ha cominciato a spostarsi dal canone all’esperienza. Così, la domanda centrale ha smesso di essere “Che cosa è bello in un prodotto?”, ed è diventata piuttosto “Come è bella una data configurazione esperienziale?”.
Questo spostamento ha reso la bellezza non solo oggetto di ridefinizione, ma anche fattore attivo delle dinamiche globali. Come processo, progetto, performance e impegno, l’estetico ha potuto allora espandersi sia orizzontalmente – nella varietà delle sue espressioni – sia verticalmente, penetrando la materialità delle merci.
In questa duplice direzione, la bellezza si è pluralizzata. Come principio che si incarna in forme provvisorie, situate, fluide, il suo paradigma non è più l’Arte Bella, con la relativa ansia di novità e unicità, bensì la logica ciclica e innovativa dell’effimero, del continuo rinnovamento. Al contempo, la bellezza estetizzante si è spinta però anche nelle profondità delle tecnologie, dove la materia sfuma nel virtuale, divenendo un vettore qualitativo diffuso presente negli oggetti e al tempo stesso irriducibile ad essi, sostanziale e al tempo stesso privo di sostanza fissa. Si diceva all’inizio che è più produttivo

individuare linee tendenziali che fissare punti assoluti. Il riconoscimento del carattere processuale della bellezza offre appunto questa possibilità. Esso giustifica un’osservazione in apparenza banale, ma certo non trascurabile.
Riconoscere l’inconfrontabilità tra forme belle di epoche diverse non va confuso con un atto di relativismo: è invece l’effetto della consapevolezza che ogni configurazione estetica ha senso e valore in quanto situata. Questo connotato, tutt’altro che relativo (chi sarebbe disposto a riconoscere di avere avuto un gusto “più cattivo” di altri?), è un assoluto, benché però locale.
Che senso avrebbe, ad esempio, chiedersi se è “più bella” la Gioconda di Leonardo o Guernica di Picasso? Una tale domanda, oltre a essere evidentemente assurda in sé, rivela quanto sia assurda l’idea stessa di bellezza come unità misurabile e ca-
none. Ed è proprio qui che si annodano le principali linee tendenziali che caratterizzano la bellezza negli ultimi decenni, come si rivelano due versanti che di recente hanno acquisito notevole rilievo.
La situazione esperienziale rende la bellezza un vettore progettuale anche in rapporto alla corporeità. Il corpo proprio, anziché essere solo valutato secondo la sua aderenza a un canone astratto, diventa sempre più un campo di sperimentazione continua, e dunque di tensione, orientato verso realizzazioni performative, che lasciano dietro di sé non tanto un prodotto formato quanto un’esperienza.
Così la bellezza agisce – certo, con l’ambivalenza implicita nel rischio di mercificazione – nella produzione di molteplici identità da articolare entro margini di libertà contingente, ossia parzialmente
svincolate da maschere precostituite. Questa inquieta pluralità processuale dell’estetico, infrangendo il monopolio del canone, genera una molteplicità di valori, ciascuno dei quali decentrato per l’assenza di un fuoco gravitazionale stabile.
In questo quadro, la bellezza è principio di valorizzazione, oltre che del sé attraverso il corpo, anche dell’ambiente, promuovendo cura e impegno per gli scenari in cui si è immersi quotidianamente. Natura, paesaggio, spazi urbani e abitativi vengono osservati – e trasformati – secondo gli stessi criteri visivi, narrativi, e soprattutto performativi che governano l’inquietudine estetica del sé.
Così, la bellezza non è più soltanto questione di arte o di natura sublime: si manifesta anche nel quotidiano, nei giardini, nelle strade, negli interni domestici. Ma anche qui si rivela un’ambivalenza. È innegabile
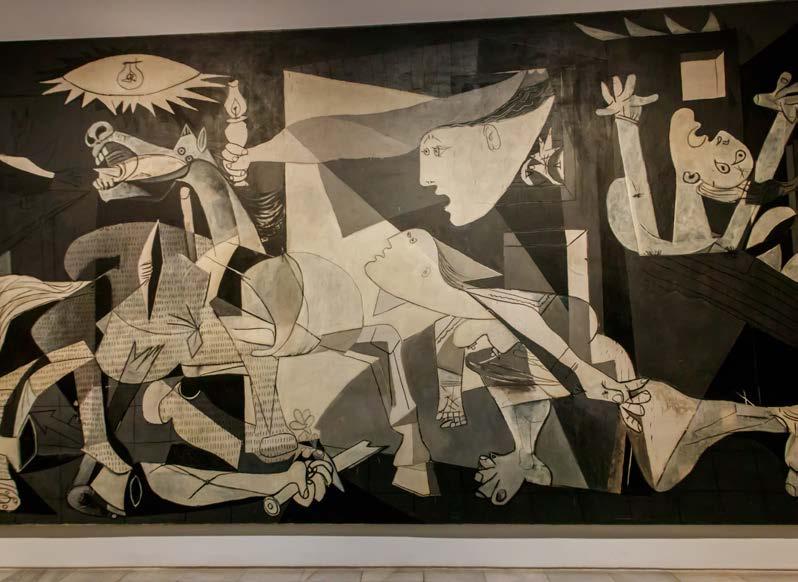
che nel contesto ipermedializzato contemporaneo questa “estetica del quotidiano” rischia di tradursi in vetrinizzazione, costruita per essere mercificata, come avviene quando non trova modo di esprimersi quella riflessività potenziale che essa comunque racchiude (come rivelano gli infiniti gesti valutativi che accompagnano la nostra quotidianità: dall’esibizione fotografica di un piatto al ristorante alle varie icone di gradimento con cui “commentiamo” contenuti di ogni sorta).
Solo una nozione di bellezza non-canonica, non arte-centrica, e fondamentalmente processuale aiuta a comprendere questa complessa poliedricità. I processi, infatti, hanno senso, valore e verità nella situazione concreta della loro manifestazione esperienziale. E potrebbe essere proprio questo, in fondo, il lascito più significativo delle pratiche estetiche “inquiete” degli ultimi decenni. ■
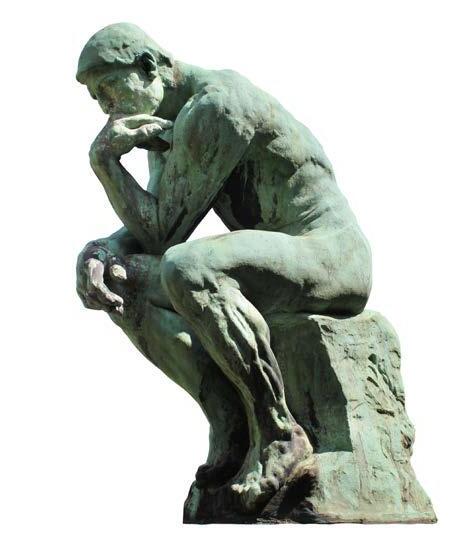

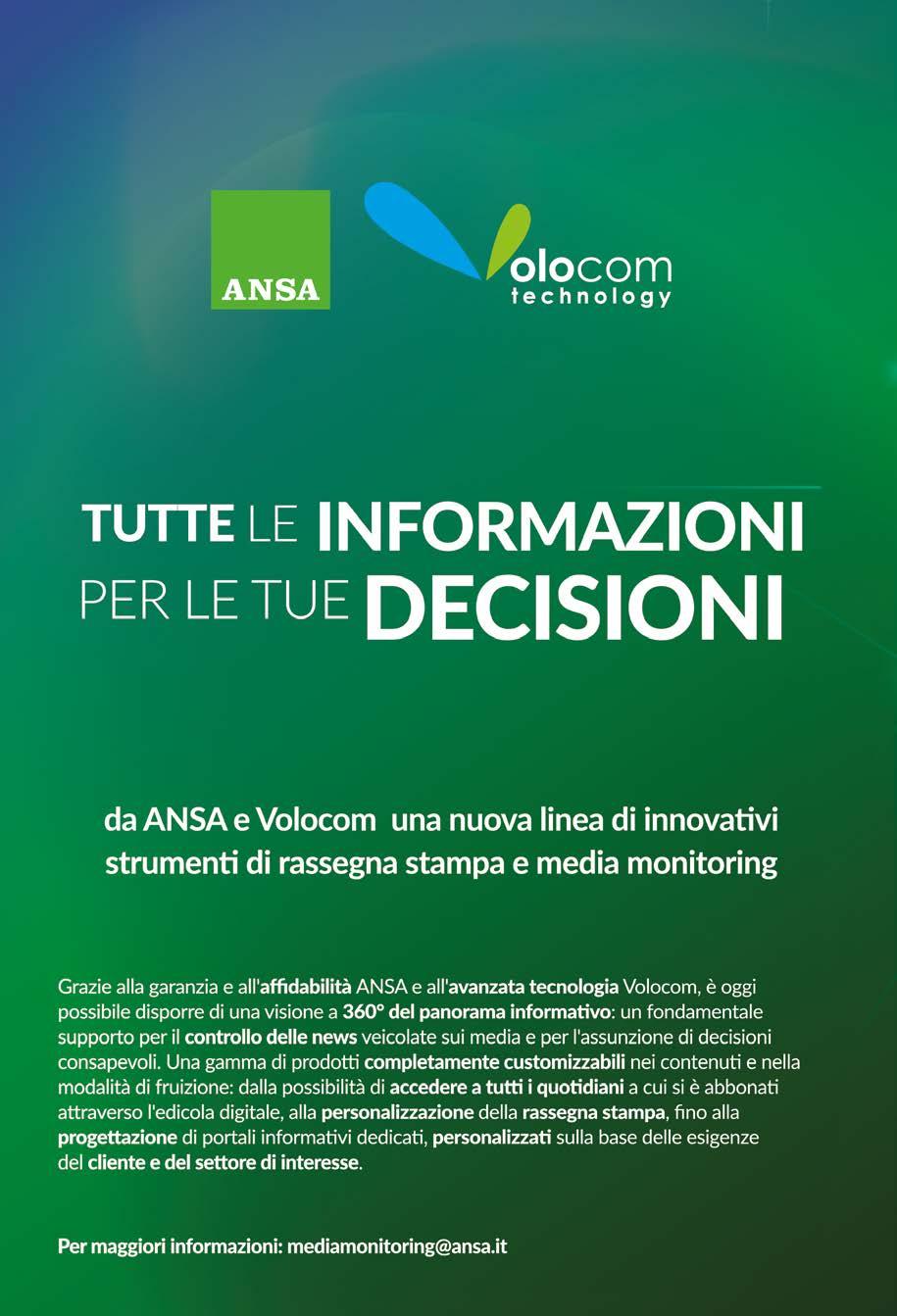
Le storie, i personaggi e le notizie di primo piano commentate dalle più autorevoli firme del mondo della politica, dell’economia, dell’università e delle professioni


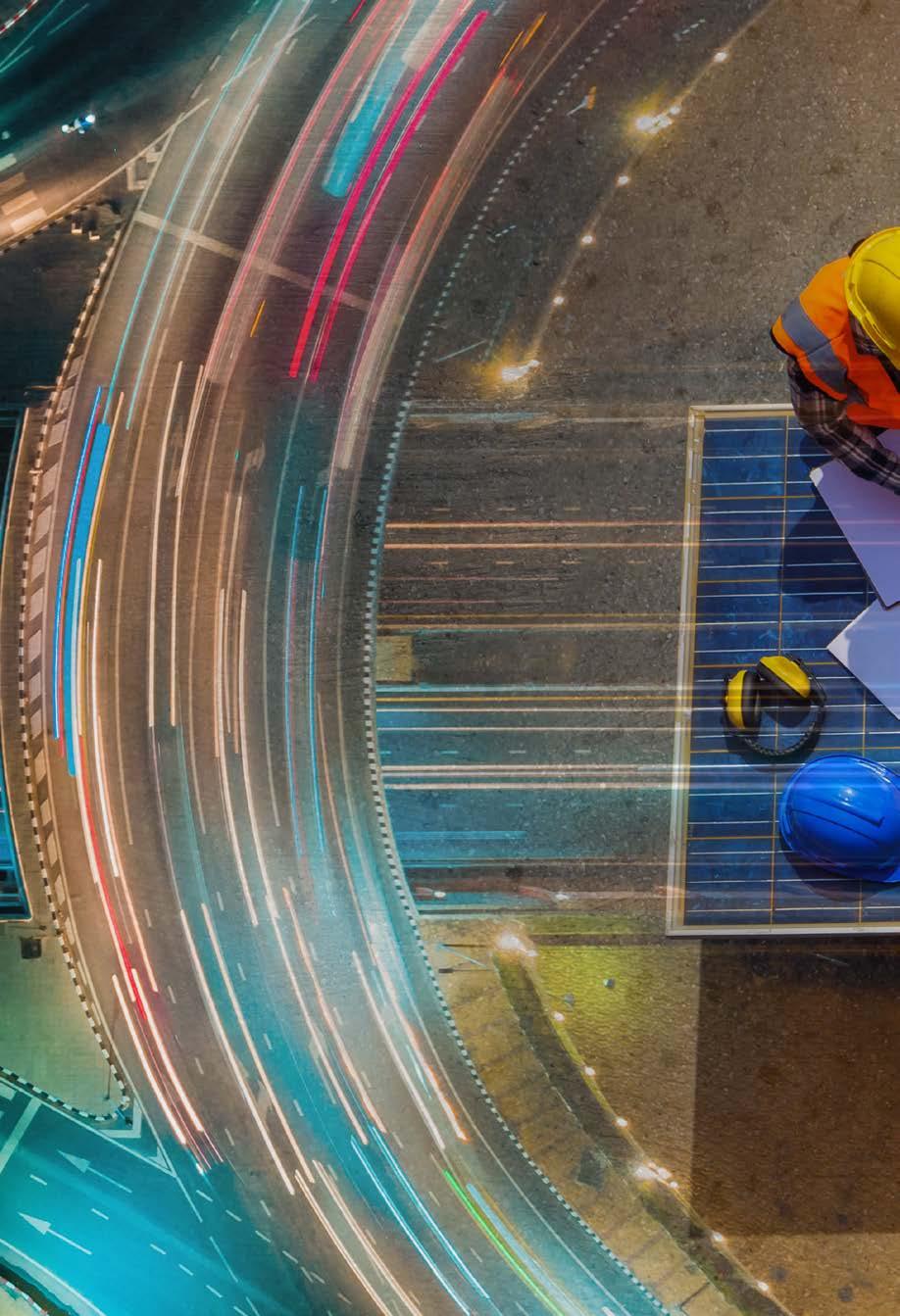
Dopo la pausa estiva il Codice unico degli incentivi sbarcherà in Parlamento. Il primo passo di una riforma che mira a semplificare e razionalizzare una selva di 2 mila agevolazioni e che per la prima volta apre l’accesso ai liberi professionisti. In dirittura d’arrivo anche l’equo compenso per le professioni non ordinistiche. Parla il sottosegretario alle Imprese, Massimo Bitonci
di Giovanni Francavilla

«Acesso alle misure. Dopo un lungo iter comincia a prendere forma lo schema del decreto legislativo, approvato dal Consiglio di ministri lo scorso ottobre, recante il Codice degli incentivi, in attuazione della delega contenuta nella legge del 27 ottobre 2023 n. 160. Che ha già incassato l’ok della Ragioneria generale dello Stato e l’intesa della conferenza Stato-Regioni. Resta ancora l’ultimo passaggio in Consiglio di Stato, prima dell’esame in Parlamento. Il Codice degli incentivi è il primo passo di una riforma strategica che ha l’obiettivo di sostenere il sistema produttivo e renderlo più competitivo nel mercato nazionale e internazionale. L’impianto normativo è noto: ricognizione sistematica delle misure, ricerca e sviluppo, digitalizzazione, transizione energetica, occupazione,

spettiamo il parere del Consiglio di Stato e dopo la pausa estiva il Codice unico degli incentivi approderà alle commissioni parlamentari competenti, con alcuni punti fermi coerenti con gli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo: semplificazione, risultati misurabili e tangibili, sostegno all’imprenditoria femminile e alle start up». Il sottosegretario di Stato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, vede materializzarsi il lungo lavoro che lo ha visto impegnato a monitorare e disboscare una selva di quasi 2 mila incentivi statali e regionali che fino al 2021 ammontavano complessivamente a circa 146 miliardi di euro e che fino a oggi hanno limitato l’efficacia degli interventi e frenato le Pmi nell’acIl presidente di Confprofessioni Marco Natali con il sottosegretario Bitonci
formazione 5.0, accesso al credito, rafforzamento patrimoniale e delle filiere produttive, un portale unico nazionale, coordinamento con le regioni, valorizzazione dell’imprenditoria femminile, rafforzamento patrimoniale, aggregazione e transizione ecologica. È questa l’architrave di una riforma che, per la prima volta, introduce l’equiparazione tra imprese e professionisti per l’accesso agli incentivi, sostenuto a spada tratta dal sottosegretario Bitonci.
D. Partiamo da qui. Possiamo mettere la parola fine alle discriminazioni che fino a oggi hanno impedito ai professionisti di accedere agli incentivi?
Ho fortemente voluto questo passaggio. C’è stata una lunga interlocuzione con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha accolto l’apertura degli incentivi ai professionisti, possibilità che sino ad oggi era praticamente preclusa a questi ultimi. Personalmente ritengo che non ci sia alcuna differenza tra un’impresa individuale e un professionista iscritto a un ordine o a una professione non ordinistica. Si tratta di un passaggio doveroso che recepisce un principio unanimemente condiviso secondo cui per impresa deve intendersi qualsiasi entità che svolge un’attività economica a prescindere da forma e organizzazione.
D. Rimanendo nell’ambito delle professioni, sembra in dirittura d’arrivo il regolamento per l’equo compenso per i professionisti non ordinistici, disciplinati della legge 4/2013. A che punto siamo?

Il decreto legislativo, che garantirà criteri omogenei e trasparenti nei rapporti tra professionisti con la Pubblica amministrazione e committenti forti, è pronto e a breve verrà emanato. Non dimentichiamo che molte di queste figure professionali lavorano da anni con la Pubblica Amministrazione: pensiamo alla criminologia, alle mediazioni familiari e a quelle culturali, ai consulenti informatici…
Abbiamo individuato i parametri che dovranno essere utilizzati attraverso una struttura tabellare che non darà indicazioni sul prezzo della prestazione, ma fornirà un’indicazione percentuale tenendo conto della complessità dell’incarico, della durata della prestazione, del grado di esperienza del professionista.
D. Il Codice unico degli incentivi si appresta al “debutto” in Parlamento. Che cosa dobbiamo aspettarci?
Ho seguito personalmente la revisione della legge delega, tenendo conto della grande selva di incentivi esistenti. Abbiamo passato al setaccio circa 2 mila incentivi statali e regionali, un articolato lavoro di monitoraggio che ci ha fornito risposte concrete: alcuni incentivi si sono dimostrati particolarmente efficaci, poiché hanno un ribaltamento diretto sulle imprese e sulle professioni; altri invece alimentano solo i consumi o settori che non avevano particolari ricadute, per esempio, nell’innovazione tecnologica.
D. Quali sono gli incentivi promossi e quali i bocciati?
Industria 4.0 è andata bene: i crediti d’imposta sono stati utilizzati per implementare il parco macchine, la produttività e per raggiungere obiettivi concreti. In altri casi, non è stato così. Prendiamo ad esempio gli incentivi per la ricerca e sviluppo quelli destinati alle start up: l’attrazione dovrebbe essere quella di avere nuovi risultati nella ricerca, oppure dare risposte in termini di innovazione, transizione, digitalizzazione, nuove tecnologie, l’AI. Che sono poi gli obiettivi di politica economica e industriale del Governo.
D. Avete usato la scure per disboscare la selva di incentivi?
Ci sarà chiaramente una riduzione del numero di incentivi, che non vuol dire necessariamente eliminazione, ma razionalizzazione e
aggregazione delle agevolazioni per arrivare al risultato che si vuole ottenere. L’obiettivo del Codice unico è quello di raggruppare, semplificare, potenziare gli incentivi, dopo di che seguiranno altre deleghe che hanno aspetti di novità rispetto al passato.
D. Si riferisce al contenzioso che si è creato sugli incentivi per ricerca e sviluppo?
È uno dei problemi che andremo a risolvere. In molti casi i crediti d’imposta erogati alle imprese sono stati contestati dall’Agenzia delle Entrate, perché magari quella determinata tipologia di investimento non è innovativa o non produce effetti tangibili sulla ricerca. L’implementazione di un software esistente, ad esempio, non può essere considerata innovazione.

D. Come se ne esce?
Stiano cercando una soluzione al contenzioso che si è creato. Negli ultimi decreti c’è stata una proroga con lo stralcio delle sanzioni per quanto riguarda gli incentivi R&S, ma per il futuro tutto funzionerà sul modello di Industria 4.0 con una certificazione ex ante ed ex post da parte di professionisti o di enti certificatori per eliminare a monte il problema del contenzioso. L’impresa potrà investire in maniera tranquilla, perché l’investimento non verrà contestato.
D. Alla luce delle crisi internazionali e di una congiuntura economica poco brillante quante risorse andranno ad alimentare il sistema degli incentivi per imprese e professionisti?
Sulle risorse che potranno essere destinate, il Governo ha aperto un confronto con la Commissione europea per ottenere il via libera all’utilizzo di stanziamenti che provengono dalla revisione dei capitoli di bilancio del Pnrr e del piano Transizione 5.0 per sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, che ha una dotazione finanziaria complessiva di 6,3 miliardi di euro.
Per il biennio 2024-2025, che andrà in scadenza a fine anno, ci sono 12,7 miliardi di euro e siamo già arrivati a 1,4 miliardi di euro di prenotazioni. Stiamo lavorando con la Commissione, affinché si possa prorogare il termine a giugno 2026. ■

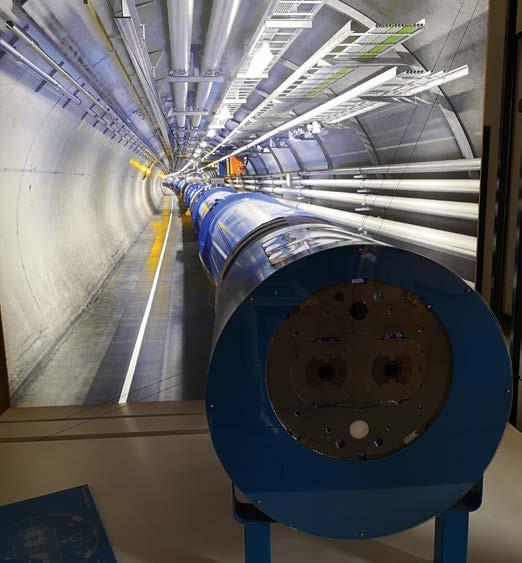
di Laura Ciccozzi
Ufficio studi Confprofessioni
Con il 92% dei fondi già erogati e il 37% della spesa rendicontata al 31 dicembre 2024, la Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile - del Pnrr registra una delle migliori performance del Piano. Una dote finanziaria di oltre 40 miliardi per ferrovie, trasporto locale, porti. Un progetto su due riguarda le regioni del Mezzogiorno, ma al Nord sono state destinate il doppio delle risorse stanziate. Rigenerazione urbana sorvegliata speciale
Giugno è stato un mese fondamentale sul fronte Pnrr: non solamente perché all’Italia è stata finalmente versata la settima rata da 18,3 miliardi, ma soprattutto perché il cronometro del Piano nazionale di ripresa e resilienza segna ora meno di 365 giorni alla scadenza. L’attenzione degli osservatori è focalizzata sulle opere pubbliche e tra queste le infrastrutture ferroviarie, opere di notevole impatto sulla vita cittadini, sono ovviamente le sorvegliate speciali. L’esigenza di contrastare il divario infrastrutturale del Paese si riflette nell’articolazione territoriale dei progetti: uno su due riguarda, infatti, le Regioni meridionali e le isole. Ma non nelle risorse stanziate, dal momento che al Nord spettano più del doppio dei fondi del Sud. Su queste opere si è abbattuta più volte la scure della revisione del Pnrr: prima con lo stralcio dell’intera tratta Roma-Pescara, poi con il definanziamento di singoli progetti dell’alta velocità. Per il primo semestre 2025 (a cui corrisponde l’ottava rata, il cui pagamento è stato richiesto alla Commissione lo scorso 30 giugno), il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha dichiarato raggiunti i due obiettivi dell’attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) su 1.400 km della rete ferroviaria nazionale, e della stipula dell’accordo attuativo con Invitalia per la creazione di una leadership sulla filiera industriale degli autobus elettrici.
Del resto, nella dotazione finanziaria di oltre 40 miliardi del Mit – 27,8 miliardi del Pnrr a cui vanno

aggiunti i 16,2 del Piano nazionale complementare – non ci sono solo le ferrovie. Tra i 40 investimenti della Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) troviamo anche mezzi pubblici per il trasporto locale, stazioni, porti, viadotti, gasdotti e reti idriche.
Pensiamo all’investimento da 3,6 miliardi per lo sviluppo del trasporto rapido di massa nelle città metropolitane: creare almeno 96 km di linee di metropolitana o tram e almeno 135 km di filovie o funivie con l’obiettivo di ottenere uno spostamento di almeno il 10% del traffico attuale su auto private

verso il sistema di trasporto pubblico. E ancora, all’investimento da 3,8 miliardi per l’acquisto di autobus e treni di ultima generazione. In particolare, è previsto che entro il 2026 nelle nostre città saranno in circolazione circa 3.500 autobus a basse emissioni, oltre a 53 treni elettrici e a idrogeno.
BEST PERFORMANCE
Ma al di là delle frequenti revisioni di cui la Missione 3 è stata oggetto – e ne potrebbe arrivare un’altra già nei prossimi mesi, per consentire un riallineamento finale degli obiettivi– come stanno andando gli interventi sulla mobilità? Dall’ultima relazione della Corte dei conti sull’avanzamento del Pnrr risulta che la Missione 3 è quella che sta registrando le migliori performances, con il 92% dei fondi già erogati e il 37% della spesa rendicontata al
31 dicembre 2024. Il che però non esclude che sussistano preoccupanti ritardi su singole opere.
Sul fronte dell’alta velocità, il Pnrr finanzia in parte, vale a dire su singoli lotti, grandi opere già avviate da anni. Si tratta dei cosiddetti progetti “in essere”, vale a dire opere che erano già in programma prima dell’avvio del Pnrr e le cui fonti di finanziamento inizialmente previste sono state modificate per includervi il Piano. Rientrano in questa categoria, al Centro-Sud le tratte Napoli - Bari, Palermo - Catania, Salerno - Reggio Calabria, OrteFalconara e Taranto - Battipaglia. Al Nord, le tratte Brescia - Padova e Liguria - Alpi. In tutti questi casi i cantieri procedono, con l’obiettivo di ultimare, entro il 2026, 211 km di linee. E ancora ferrovie, con l’investimento da 3 miliardi per il
La stazione alta velocità di Afragola, progettata dall'architetto Zaha Hadid
potenziamento di 1.280 chilometri di binari nelle grandi città e nelle aree urbane di medie dimensioni. Anche questo progetto ha l’obiettivo di spostare il traffico passeggeri e merci dalla strada alla ferrovia, aumentando l’accessibilità e l’interscambio tra le stazioni ferroviarie e le metropolitane per rendere il trasporto su rotaia più conveniente rispetto all’uso dell’auto privata.
PNC IN RITARDO
C’è poi il Piano nazionale complementare (Pnc), che sulle infrastrutture vale 9,8 miliardi. Interventi minori, ma diffusi capillarmente sui territori e per questo fondamentali. Pensiamo al potenziamento delle linee regionali, la messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel, lo sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e l’elettrificazione delle banchine (cold ironing).
Mancando l’obbligo di rendicontazione semestrale previsto per il Pnrr, è difficile conoscere l’andamento di questi progetti. Ma quello che emerge dai dati disponibili è un quadro di grave ritardo.
COMUNI SOTTO LA LENTE È di competenza del ministero delle infrastrutture anche l’investimento della Missione 5 (Inclusione e coesione) denominato “Programma innovativo della qualità dell’abitare”. L’obiettivo è costruire o riqualificare almeno 10 mila alloggi pubblici e 800 mila metri quadrati di spazi pubblici, conciliando la riduzione delle dif-
ficoltà abitative, con la riqualificazione sostenibile delle aree degradate. Si tratta di investimenti ambiziosi e fortemente innovativi sia per l’ecocompatibilità dei progetti, che devono essere realizzati senza consumare nuovo suolo in conformità al principio DNSH, (Do No Significant Harm: non arrecare un danno significativo all’ambiente) sia per il coinvolgimento dei territori al fine di preservarne l’identità sotto il profilo socioeconomico e culturale.
Anche qui sono emersi preoccupanti ritardi, che hanno recentemente spinto il Mit a svolgere una verifica sull’effettiva capacità degli enti locali coinvolti di rispettare il cronoprogramma, pena la perdita dei fondi già stanziati che saranno dirottati su altri progetti. ■


di Theodoros Koutroubas

La presidente della Commissione europea ha superato indenne la mozione di sfiducia presentata da alcune formazioni di estrema destra.
Su 719 eurodeputati, solo 553 si sono presentati al voto, di questi 360 hanno votato contro la sfiducia.
Un dato che preoccupa, anche perché molti eurodeputati tra socialisti, liberali, verdi e persino alcuni membri del Ppe hanno snobbato il voto.
Un campanello di allarme per von der Leyen, sempre più in bilico tra euroscettici e sostenitori delusi
Ameno di un anno dall’inizio del suo secondo mandato alla presidenza della massima autorità amministrativa dell’Unione europea, Ursula von der Leyen ha dovuto affrontare una mozione di sfiducia al Parlamento europeo (PE), l’unica istituzione dell’Ue eletta direttamente dai cittadini. Presentata per lo più da eurodeputati di estrema destra, la mozione ha avuto, fin dall’inizio, pressoché nessuna possibilità di essere approvata.
Secondo il regolamento del Parlamento europeo, infatti, una mozione di sfiducia contro la Commissione europea può essere discussa se un europarlamentare su 10 la sostiene, ma è necessaria una maggioranza di due terzi dei presenti al termine del dibattito. I sostenitori del testo, proposto dall’eurodeputato rumeno Gheorghe Piperea, provenivano principalmente dalle tre formazioni politiche “euroscettiche” dell’ala destra della Camera: i Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), i Patrioti ed “Europa delle Nazioni Sovrane”.
L’Ecr, che annovera tra i suoi membri gli eurodeputati del partito del primo ministro italiano Georgia Meloni, si è mostrato reticente a sostenere ufficialmente l’iniziativa, dichiarando invece che coloro che tra le sue fila l’hanno fatto, lo hanno fatto “a titolo individuale”.
Ovviamente, l’iniziativa è stata rapidamente descritta come un tentativo dell’estrema destra di destabilizzare l’Europa in un momento di crisi, e il Partito popolare europeo (Ppe), il Gruppo dei “So-
cialisti e Democratici”, i Liberali di “Renew” e i “Verdi”, come previsto, hanno fatto quadrato intorno a von der Leyen e si sono coalizzati per opporsi alla mozione.
Il risultato finale è stato quindi una facile vittoria per la contestata presidente della Commissione europea, accusata di mancanza di trasparenza e conflitti di interesse in relazione a quello che è ampiamente noto come lo scandalo del vaccino Covid, o “Pfizergate”, e per il modo generale in cui sta governando l’istituzione. Dei 553 eurodeputati che hanno votato, 360 hanno votato contro la mozione, 175 a favore e 18 si sono astenuti.
COMMISSIONE SOTTO SCACCO
Tuttavia, lungi dall’essere un caso passeggero, la mozione, per il fatto stesso di aver raccolto abbastanza
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea

firme da poter essere discussa in plenaria, e per le dinamiche rivelate dall’analisi dei risultati del voto, ha chiarito che l’attuale Commissione europea e la sua presidente hanno il tempo contato e potrebbero non sopravvivere a un’altra censura se scegliessero di continuare a fare “business as usual”.
Nonostante il comodo rifiuto della “sfiducia”, i numeri non sono molto positivi per la politica tedesca e la sua squadra: su 719 eurodeputati, solo 553 si sono presentati al voto. È chiaro che molti di loro hanno deliberatamente deciso di non partecipare, dato che la successiva votazione prevista dal Parlamento, che si è svolta solo pochi minuti dopo quella sulla censura alla presidente della Commissione, ha raccolto i voti di 636 eurodeputati.
Meno di un anno fa, la candidatura di von der Leyen era sostenuta da 370 eurodeputati, 10 in meno rispetto a coloro che avevano votato contro la mozione a luglio. Un confronto tra il numero di membri assenti allora e oggi mostra che 135 eurodeputati in meno hanno partecipato al voto di luglio 2025. Molti di loro erano socialisti, liberali, verdi e persino alcuni membri del Ppe.
Considerando i risultati dal punto di vista degli Stati membri, solo il 30% degli eurodeputati italiani e il 32% di quelli francesi hanno votato a favore del Presidente della Commissione, poiché molti di loro hanno scelto di non partecipare alla procedura. La maggioranza degli eurodeputati ungheresi, slovacchi, cechi ha sostenuto la mozione di sfiducia.

Nel campo di coloro che hanno mantenuto la fiducia a Ursula von der Leyen, l’entusiasmo è stato decisamente assente. Al contrario, i leader dei diversi gruppi politici hanno chiarito nei loro discorsi che “questa era l’ultima possibilità assoluta” per il leader dell’autorità esecutiva dell’Ue, per citare la vicepresidente del Parlamento europeo, Katarina Barley dei “Socialisti e Democratici”.
Alcuni, come il gruppo “Alleanza Libera Europea”, hanno sottolineato di “rifiutarsi di legittimare le manovre politiche di estrema destra, ma allo stesso tempo di non poter sostenere una Commissione europea che si sta sempre più allontanando dal centro politico e non riesce a far fronte alle proprie


responsabilità in materia di giustizia sociale, azione per il clima e commercio equo”. Altri, come i Socialisti e Democratici, hanno negoziato il loro voto con importanti concessioni nel bilancio dell’Ue per la spesa sociale e l’inclusione del Fondo sociale europeo nel prossimo Quadro finanziario pluriennale. Un membro di spicco del Gruppo Liberale, l’eurodeputata Valerie Hayer, ha persino detto al presidente della Commissione di “darsi una regolata”!
Con il dibattito ormai chiuso e il periodo estivo di inattività alle porte, alcuni, come il futuro vicepresidente del Ppe Siegfried Muresan, amano pensare che “il giorno del ritorno dalle vacanze ce ne saremmo quasi dimenticati”.
Dopotutto, le mozioni di sfiducia ai vertici del Collegio dei Commissari in passato (l’ultima nel 2014) non hanno avuto gravi conseguenze sulla prosecuzione del loro mandato. Questa volta, però, il numero di eurodeputati che non temono di esprimere a gran voce la propria delusione per il modo in cui l’ex ministro tedesco conduce il suo lavoro è in costante aumento e il Parlamento europeo vanta una solida componente euroscettica. In definitiva, von der Leyen potrebbe sopravvivere grazie al contesto internazionale molto turbolento.
Storicamente, dopotutto, è un dogma che “non si cambiano generali nel mezzo di una guerra”. Ma le eccezioni confermano le regole, quindi il ritorno dalle calde settimane estive si preannuncia sicuramente interessante. ■
La piattaforma realizzata da Confprofessioni e Apri International per favorire le relazioni tra i professionisti di tutto il mondo.

Iscriviti ora e connettiti con una rete internazionale di professionisti!
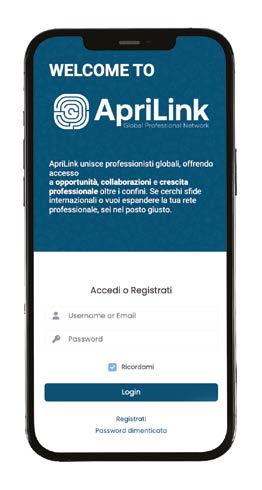
Fare una richiesta a una chatbot significa consumare fra 0,01 e 0,1 chilowatt di elettricità. E i grandi data center ne richiedono parecchia di più. Un problema per l'ambiente e per i consumi energetici, come ha dimostrato il recente blackout in Spagna. Le soluzioni sono allo studio

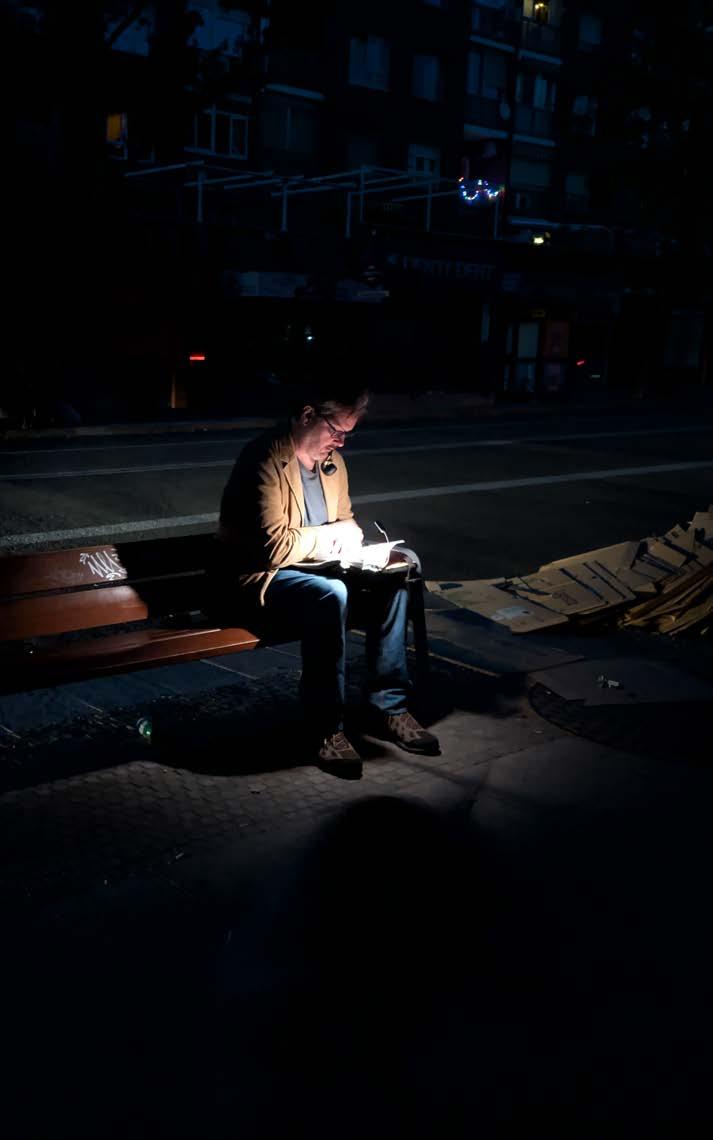
Secondo alcune stime recenti le imprese italiane avrebbero più che raddoppiato gli investimenti dedicati all’adozione e allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale accrescendoli cioè del 130% nei soli sei mesi d’apertura di quest’anno.
A paragone con lo stesso periodo del 2024 la quota delle aziende utilizzatrici dell’ormai familiare Chat GPT sarebbe salita del 52%; i budget a esso indirizzati addirittura del 229%. Il ricorso all’AI pone un problema che non interessa tanto gli utenti finali quanto piuttosto chi gli algoritmi deve addestrarli e cioè nutrirli ogni giorno di dati, affinché possano consolidare il loro bagaglio di conoscenze e migliorare la loro performance.
Ovvero che «per imparare una macchina deve fare ogni volta tabula rasa delle nozioni e competenze che ha accumulato in precedenza». Per conseguenza, il costo dell’aggiornamento di una piattaforma di AI può equivalere a svariati milioni di euro e l’operazione può generare un quantitativo di emissioni di anidride carbonica pari a quelle del ciclo di vita di un veicolo americano medio, produzione inclusa.
LA COMPLESSITÀ DELL'AI
Lo ha stimato la University of Massachusetts; lo ha confermato - suoi sono i virgolettati riportati più su - il ricercatore del dipartimento di Informatica dell’università di Pisa Vincenzo Lomonaco. Questi ha collaborato a un progetto di studio internazionale attivato dal Neuromorphic AI Lab dell’ateneo texano di San Antonio
(UTSA) e partito dal presupposto che l’esecuzione di task sempre più complessi ha imposto dal 2018 a oggi un incremento di 200 mila volte della potenza di calcolo.
In parallelo con il paradigma classico del Machine learning il team coordinato dalla professoressa Dhireesha Kudithipudi ha lavorato perciò su quello del Continual o Lifelong learning, che punta a rendere le piattaforme e gli algoritmi di AI più stabili ma anche più capaci di adattarsi alla realtà.
Divengono di conseguenza più sostenibili e meno energivori poiché se è vero che sottoporre una richiesta (prompt) a una chatbot significa consumare fra 0,01 e 0,1 chilowatt di elettricità, è chiaro che i grandi data center gestiti dai colossi globali dell’Ict ne ri- Il Data center di Google in California

chiedono parecchia di più. Per la precisione, 200 terawattora oggi; 15 volte in più di qui alla fine del decennio, secondo Enel X, convinta che al 2030 essi possano rappresentare l’8% circa della complessiva domanda di elettricità.
Si presenta così un problema con il quale da qualche parte si è già cominciato a fare i conti: lo scorso giugno il dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti ha di fatto consentito alle utility del Sud-Est del Paese di aumentare la produzione e la fornitura per fronteggiare i picchi di consumo. Quello di alleviare i cittadini dalla calura senza compromettere le attività di archiviazione ed elaborazione dei dati è stato nella fattispecie l’obiettivo che ha giustificato lo sforamento dei limiti di inquinamento fissati dal legislatore.
La maggiore flessibilità dell’erogazione a seconda dei flussi di utilizzo basata su tecnologie digitali - sull’esempio delle smart grid - offre almeno in parte una soluzione al dilemma. Per quel che riguarda più nello specifico i data center, è stato calcolato negli Usa che se soltanto essi riducessero dello 0,5% il loro fabbisogno annuo sarebbe possibile gestire altri 18 gigawatt di domanda aggiuntiva in più Stati.
Data la costante crescita della potenza IT installata, +17% fra 2023 e 2024 a quota 513 megawatt, in Italia ci si interroga invece su come dare vita a infrastrutture distribuite e tali da far sì che i data center s’integrino appieno nelle aree urbane.

La maggior vicinanza agli utilizzatori - nelle case private come negli uffici e piccole o microimprese - è sinonimo di una riduzione dei tempi di latenza e dunque di una maggior rapidità nella trasmissione delle informazioni. E da un punto di vista puramente architettonico le tante aree dismesse delle periferie e non solo potrebbero costituire altrettanti piccoli hub di prossimità, come lo unit director data center di Deerns Danilo Andreotti ha notato in un post su Il Sole 24 Ore. In più, la sostenibilità di simili progetti sarebbe garantita dal ricorso a sistemi di raffreddamento a circuito chiuso o dall’immissione in rete del calore generato a scopi di teleriscaldamento per interi quartieri. «Va ricordato», ha detto Vincenzo Lomonaco a Il Libero Professionista Reloaded, «che tuttora i
Il datacenter di Microsoft a Middenmeer nei Paesi Bassi
consumi e le emissioni riconducibili al mondo IT sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli attribuibili ai trasporti o all’industria. Ciononostante, già da tempo si sta riflettendo su come passare dal tipico scenario delle giga-factory inaugurato da Tesla a un altro per molti versi meno impattante.
L’idea è disporre di una molteplicità di strutture di calcolo dalla dimensione ridotta diffuse sul territorio e nelle città e che con la loro attività forniscano nutrimento a quelle più grandi. Sono teoricamente ubique: allo studio ci sono architetture subacquee e flotte di veicoli a guida autonoma direttamente connesse a un più vasto ambiente cloud. Ma il traguardo finale di alcune ricerche di assoluta avanguardia è una computazione intesa come parte di un ecosistema ampio cui partecipano anche i piccoli device di uso comune o le home appliance. Senza chiaramente escludere il possibile ruolo dei capannoni o magazzini dismesse né, altrove, installazioni presso le centrali idroelettriche».
È secondo Lomonaco «il sogno di tanti ingegneri informatici» e non c’è dubbio che i mini e maxi centri ipotizzati possano essere alimentati con energie verdi, a patto che la distribuzione sia bilanciata in maniera intelligente, per evitare clamorosi blackout come quello occorso in Spagna. «Né si deve pensare», ha proseguito il ricercatore pisano, «che per beneficiare delle potenzialità dell’AI siano indispensabili investimenti ingenti e strutture am-
biziose. Le GPU in cloud (laddove GPU sta per Graphic processing unit, unità di elaborazione grafica nati in origine per gestire le grandi moli di dati tipiche dell’imaging e dei più avveniristici videogiochi, ndr) mettono a disposizione del pubblico per pochi centesimi l’ora e con forme di noleggio macchine virtuali di addestramento e di abilitazione dei servizi di AI, su un marketplace basato su web e virtualizzato». Anche grazie a esse si potrà continuare in città a dormire sonni tranquilli, indisturbati dal lavorio dei data center e soprattutto, nei periodi della canicola, certi del refrigerio assicurato dai condizionatori. ■ Il blackout del 28


Le news più rilevanti dalle istituzioni europee selezionate dal Desk europeo di Confprofessioni
La conferenza finale del progetto europeo SP4SE, ospitata dal CESE a Bruxelles, ha evidenziato l’urgenza di rafforzare la protezione sociale dei lavoratori autonomi. Rappresentanti istituzionali e sociali hanno discusso sfide comuni, come la carenza di tutele per malattia e genitorialità, l’esclusione dal dialogo sociale e l’assenza di strumenti strutturali di sostegno. Il presidente della sezione CCMI del CESE Pietro Francesco De Lotto ha sottolineato il ruolo centrale del dialogo sociale, mentre il presidente di Confprofessioni, Marco Natali, ha proposto il modello italiano di welfare bilaterale come riferimento europeo. Il pro-
getto SP4SE, presentato da Martina Gherlenda, ha analizzato buone pratiche e proposto raccomandazioni per innovare i sistemi di welfare. Interventi da vari Paesi UE hanno confermato disparità e lacune, mentre la Commissione europea ha annunciato nuovi indicatori per monitorare la copertura sociale. Dal mondo accademico è emersa la necessità di un modello giuridico comune. Tra le proposte: rafforzare la contrattazione collettiva, riconoscere le associazioni professionali, sviluppare welfare mutualistico. Il progetto ha gettato le basi per una piattaforma europea inclusiva, attenta ai nuovi modelli di lavoro.


La Commissione europea ha pubblicato la sesta Relazione sullo Stato di Diritto, evidenziando i progressi nei settori di giustizia, lotta alla corruzione, libertà dei media e controlli istituzionali nei 27 Stati membri. La relazione di quest’anno pone particolare enfasi su questioni direttamente collegate al corretto funzionamento del Mercato unico, quali una sana legislazione, le norme in materia di appalti pubblici e la stabilità del contesto normativo Il rapporto 2025 collega il rispetto dello Stato di diritto alla competitività economica e al buon funzionamento del Mercato unico. Si registrano riforme positive, specie nell’indipendenza della magistratura e nella trasparenza, ma restano criticità in alcuni Paesi, soprattutto su indipendenza giudiziaria e corruzione. Cresce l’impegno nella tutela dei media e nella trasparenza dei finanziamenti, ma persistono problemi legati alla sicurezza dei giornalisti. La Commissione avverte che leggi instabili possono minare la certezza del diritto. Il rispetto dello Stato di diritto è ritenuto essenziale per attrarre investimenti, rafforzare la democrazia e garantire la stabilità dell’Ue. Rilevata anche l’importanza per i Paesi candidati all’adesione.
Nel secondo semestre 2025, la Danimarca assume la Presidenza del Consiglio Ue in un contesto segnato da instabilità globale. L’obiettivo è rafforzare la coesione, l’autonomia e la credibilità dell’Unione. Le priorità saranno: sicurezza e resilienza da un lato, crescita sostenibile e competitività dall’altro. La Presidenza danese sosterrà la difesa europea in complementarità con la Nato, rafforzando il supporto all’Ucraina, la sicurezza cibernetica e la gestione dei flussi migratori. Centrale sarà anche la tutela dello Stato di diritto e la lotta alla disinformazione. L’allargamento dell’UE resta strategico, così come la preparazione interna ad accogliere nuovi membri. In ambito economico, si punterà su innovazione, semplificazione normativa, transizione verde e tecnologie strategiche. Prioritarie anche occupazione, coesione sociale e resilienza sanitaria. La premier danese Mette Frederiksen (nella foto) ribadisce: l’Europa deve restare unita e responsabile per difendere sicurezza, libertà e valori comuni.

Tirocini, parità di genere e inclusione sociale: via libera dall’Epsco

Il Consiglio “Occupazione, politica sociale, salute e consumatori” (Epsco) ha adottato un “orientamento generale” per migliorare le condizioni di lavoro dei tirocinanti e contrastare i tirocini falsi, puntando su un trattamento equo, una giusta retribuzione e la regolarità dei contratti. La direttiva mira anche a prevenire l’abuso dei tirocini e a consentire ai rappresentanti dei lavoratori di difendere i tirocinanti in caso di cattive pratiche. Inoltre, si sostituisce il termine “dipendente regolare” con “dipendente comparabile”, lasciando agli Stati membri la flessibilità di adottare misure specifiche. In parallelo, il Consiglio ha discusso della parità di genere nell’era digitale, evidenziando rischi legati all’IA e proponendo misure contro la violenza di genere online e la misoginia. La Commissione è esortata a integrare la parità di genere in tutte le politiche future. È stata anche esaminata la direttiva sulla parità di trattamento, che punta a vietare discriminazioni in vari settori, e sono state approvate misure per promuovere l’inclusione degli anziani nel mercato del lavoro. Infine, è stato presentato un pacchetto sul Semestre europeo 2025 e sulla strategia anti-povertà, con l’intento di rafforzare la coesione sociale e i diritti fondamentali nell’Ue.
Analisi, tendenze e avvenimenti del mondo professionale, raccontati dai protagonisti delle professioni



Il presidente Mattarella e l’ex sindaco Alemanno (detenuto a Rebibbia) denunciano la crisi del sistema carcerario italiano. Sovraffollamento, suicidi, condizioni disumane: il Rapporto Antigone fotografa una realtà al collasso, dove la pena non rieduca e la dignità viene sospesa. Ma una via d’uscita potrebbe essere rappresentata dal progetto "Recidiva Zero", promosso dal Cnel, a cui anche Confprofessioni, insieme ad altre 15 sigle datoriali, ha scelto di prendere parte
di Matteo Durante

«I
l sovraffollamento delle carceri italiane è ormai insostenibile». Con la solita chiarezza, le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno duramente richiamato l’attenzione della politica e del Governo intorno a quella che lo stesso Capo dello Stato non ha esitato a definire una vera e propria emergenza nazionale. Una sferzata istituzionale su una situazione che torna di attualità a ogni inizio estate, quando le difficoltà delle persone in custodia sfiorano la crudeltà. Negli stessi giorni, dal carcere di Rebibbia si è alzata la voce dell’ex ministro ed ex sindaco di Roma Gianni Alemanno.
Che, in una lettera aperta ha messo sul tavolo una delle più disumane condizioni a cui sono sottoposti i detenuti: «C’è un’Italia che brucia in silenzio, è quella delle carceri, dove il caldo non è solo un disagio, ma una pena aggiuntiva, dove la dignità umana si scioglie». Eppure, ha concluso Alemanno: «Nessuna pena può diventare tortura, perché nessuna cella può diventare una tomba, perché nessuno dovrebbe essere trattato come meno di un essere umano».
I NUMERI DI ANTIGONE
Alemanno da dentro, Mattarella da fuori ma il messaggio è lo stesso: la questione carceraria è diventata - continua a essere, in realtà - una questione civile. La conferma viene dal XXI Rapporto dell’Associazione Antigone, dal titolo Senza respiro. Un’espressione che non è solo una metafora: descrive celle stipate, operatori allo stremo, detenuti fragili lasciati senza strumenti: «Abbiamo
superato i 61 mila detenuti, ma i posti regolamentari sono circa 51 mila», spiega Alessio Scandurra, responsabile dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone. In molte strutture, soprattutto al Nord, si scende sotto i 3 mq per persona — soglia minima indicata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Che già nel 2013 condannò l’Italia per trattamenti inumani delle sue carceri: «Ogni anno 4 mila giudici italiani stabiliscono che una persona è stata incarcerata in condizioni disumane. Eppure ci sono istituti, soprattutto nelle grandi città del nord, in cui il sovraffollamento è aumentato a dismisura rispetto alla media: a Milano, per esempio, del 200%».
Nel frattempo, la politica ha continuato a introdurre nuovi reati, a inasprire pene. «Il sistema è sotto pressione. Servivano misure per decongestionare, invece si è andati nella direzione opposta», commenta Scandurra. Il sovraffollamento è solo la punta dell’iceberg, basti pensare ai 91 suicidi nel 2024 e ai 33 nei primi cinque mesi del 2025; alle migliaia di atti quotidiani di autolesionismo; alle carenze sanitarie e di personale, anche nei penitenziari minorili. Dove il quadro si fa ancora più drammatico. Il cosiddetto decreto Caivano ha reso più facile l’ingresso in carcere per i minori, proprio in una fase storica delicatissima, dopo la Pandemia. «Stiamo parlando», continua Scandurra: «di ragazzi più fragili. Che gli operatori, dove ci sono, non riescono a gestire. Per questo, in molti Ipm (Istituti penali per minorenni) si preferisce tenerli in cella, alimentando

ulteriormente la loro rabbia, in un pericoloso circolo vizioso. Oppure in camerata a dormire, anche grazie alla sedazione da psicofarmaci. Si preferisce la soluzione chimica rispetto a quella riabilitativa».
Anche il personale penitenziario è allo stremo. Il livello di burnout di agenti e operatori, costretti a gestire emergenze quotidiane senza coordinamento e senza risorse, è elevatissimo: «I casi estremi finiscono sui giornali. Ma girando tra gli istituti, se ne vedono tante. Per esempio, il grado di pulizia degli istituti è molto peggiorato. Ora, la sporcizia non è la priorità, ma è un indicatore di una situazione che si sta sfaldando». Ecco perché, secondo Scandurra, toni e misure muscolari, servono a poco. Piuttosto: «Serve far scendere i numeri. Non è la soluzione definitiva, ma
è il primo passo per tornare a una gestione sostenibile». Perché il carcere, così com’è, non funziona. E la pena non rieduca, non reinserisce, non previene.
Per tentare di invertire la rotta, dal 2024 è in campo il progetto Recidiva Zero, promosso dal Cnel in collaborazione con il Ministero della Giustizia e firmato anche da Confprofessioni, la Confederazione italiana libere professioni, e da altre 15 associazioni datoriali, con l’obiettivo di sviluppare programmi formativi e lavorativi negli istituti penitenziari italiani.
Il progetto è ambizioso, ma parte da dati oggettivi: «Oggi i 2/3 della popolazione detenuta è composta da persone che in passato sono già state ospiti dello Stato. Vuol dire che il grado di recidiva si aggira intorno al 70%. Invece, laddove ci sono stati degli interventi di reintegrazione sociale attraverso la formazione e il reinserimento lavorativo, la recidiva crolla al 2%», spiega Emilio Minunzio, consigliere del Cnel che presiede il Segretariato permanente per l’inclusione lavorativa dei detenuti, composto da 15 esperti di altissimo profilo, tra professori universitari, rappresentanti datoriali, rappresentanti sindacali e del terzo settore. «Non è un sogno astratto, è una realtà che esiste già in alcune esperienze italiane e che stiamo cercando di sistematizzare».
Il primo passo è stato mappare i detenuti occupabili, circa la metà della popolazione carceraria. «Abbiamo avviato una profilazione curriculare, istituto per istituto,
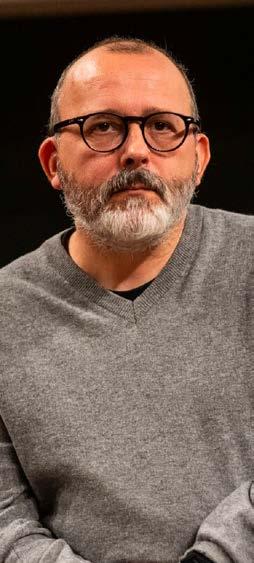

Alessio Scandurra, responsabile dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone
Emilio Minunzio, consigliere Cnel
per sapere chi sa fare cosa, che competenza vanta e che esperienze aveva prima di entrare in cella. Per poi incrociare quei dati con le richieste delle imprese», continua Minunzio. E cita casi concreti: «In Campania mancano commessi. In Emilia-Romagna servono magazzinieri. Le aziende non trovano manodopera, e in carcere ci sono persone che potrebbero lavorare. Dei circa 62 mila detenuti, distribuiti in 189 istituti, intorno ai 30 mila possono considerarsi occupabili».
Oltre all’aspetto positivo sotto il profilo etico, civile e numerico, ci sono anche dei vantaggi economici per le imprese coinvolte, con gli incentivi previsti dalla legge Smuraglia, che oggi — dopo anni di scarso e disomogeneo utilizzo — è quasi impiegata al 100%. «Prima,
il 40% delle risorse finiva nel Nord Italia. Ora la diffusione è più equilibrata. Le associazioni di categoria che hanno firmato un protocollo si stanno impegnando a diffondere capillarmente il protocollo».
E ora, chiosa Minuzio, serve uno scatto collettivo e definitivo. «Riteniamo che in autunno qualche migliaio di profili possano essere immessi sul mercato, pronti al matching con le richieste delle aziende. Non basta che le istituzioni ci credano: serve la società civile. Il Paese ora è maturo per capire che la recidiva non è un problema dei detenuti, è un problema di tutti. Una rieducazione piena, in equilibrio con la certezza della pena, significa meno reati, meno vittime, più sicurezza. Non è clemenza: è responsabilità». ■
61.275
SUICIDI IN CARCERE: Detenuti presenti (giugno 2025)
2023
51.000 circa
Posti regolamentari disponibili
2024 (più 9.3% rispetto allʼanno precedente)
Tasso di affollamento medio oltre il 120% con punte del 200%
Tra gennaio e maggio 2025
Detenuti che lavorano per imprese private circa 250 Recidiva stimata circa il 70%
Fonte: Rapporto Antigone 2025 – Osservatorio Nazionale

di Rosanna Mura
In Italia, stando ai dati dell'Istat, dal 2016 a oggi in Italia i divorzi sono diminuiti del 19,4%. E in diminuzione sono anche le separazioni. Risultati legati a doppio nodo al calo dei matrimoni. Un quadro che riflette i cambiamenti in atto nella società


Recentemente l’Istat ha diffuso i dati su divorzi e separazioni. Nel 2023 si sono registrate 82.392 le separazioni (-8,4%), mentre i divorzi si sono attestati a quota 79.875 (-3,3%), ben il 19,4% in meno nel confronto con il 2016, anno in cui sono stati finora i più numerosi (99.071). C’è da sottolineare che il trend dei divorzi è stato sempre crescente dal 1970 (anno di introduzione del divorzio) fino al 2015, anno in cui il numero di divorzi subì una forte impennata (+57,5%) in seguito all’entrata in vigore di due provvedimenti: il decreto legge 132/2014, che ha introdotto le procedure consensuali extragiudiziali senza più il ricorso ai Tribunali e soprattutto la Legge 55/2015 (il “divorzio breve”).
Le rilevazioni annuali curate dall’Istat relativamente a matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi, restituiscono un quadro in evoluzione con alcune linee di tendenza che emergono rispetto al resto. In particolare, ad una complessiva diminuzione dei matrimoni (tendenza ormai consolidata e costante da tempo), ascrivibile sia al maggior favore verso le convivenze (sia formalizzate che non), sia al dissolversi della coincidenza tra il momento di uscita dal nucleo familiare originario e il matrimonio, consegue un altrettanto complessivo decremento di separazioni e divorzi, dopo una sostanziale stabilità mantenutasi per molti anni.
I matrimoni, tra i quali si riscontra una prevalenza di quelli civili su quelli celebrati con rito religioso, riguardano sempre più per-

sone mature e spesso non alla prima esperienza coniugale, con una percentuale di coppie miste per provenienza geografica in crescita. Nelle separazioni e nei divorzi la definizione con procedure alternative a quella incardinata dinnanzi al Tribunale, rappresenta una quota significativa di poco meno del 30% (sia con la procedura di negoziazione assistita da almeno un legale per parte, sia con la formalizzazione dell’accordo - nei casi consentiti - davanti all’Ufficiale di Stato Civile).
Rimane, sia nelle separazioni che nei divorzi, una quota importante che viene affrontata e risolta giudizialmente. In tale contesto, la consensualità o i divorzi congiunti o anche giudiziali con conclusioni conformi, rappresentano la parte maggioritaria.
Questi dati sono significativi rispetto al ruolo che l’avvocato può e deve svolgere: le nuove procedure, in particolare l’accordo formalizzato di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile, si presta a rafforzare l’idea di una risoluzione che possa prescindere da valutazioni di tipo tecnico-giuridico che parrebbero messe in discussione come un costo aggiuntivo non necessario.
Tale errata convinzione si iscrive nel generale sfavore verso l’attività tecnico-legale percepita, in molti casi, come un costo inutile e superfluo, soprattutto in questioni ascrivibili all’area personale, come nel caso della separazione o del divorzio. Nulla vi è, tuttavia, di meno rispondente alla realtà, perché anche gli accordi più semplici e diretti necessitano di
una valutazione tecnica. Questo vale per le situazioni nelle quali non paiono esservi interessi di particolare rilevanza in gioco, e vale, a maggior ragione, nel caso di soggetti fragili, di figli minori o anche di figli maggiorenni con particolari situazioni di fragilità. Ipotesi tutte che necessitano di accordi meno standardizzati, così come la presenza di patti di trasferimento patrimoniale.
Nella complessiva scelta legislativa di rendere auspicabilmente sempre meno conflittuale il procedimento di separazione o di divorzio, anche per le ripercussioni che una situazione di tensione (a volte protratta per anni) ha rispetto alle persone coinvolte, non può non riconoscersi un ruolo centrale al difensore. Il legale rappresenta, infatti, il necessario spazio di garanzia per rendere effettiva la tutela dei diritti della persona e, certamente, non può essere marginalizzato nel procedimento di scioglimento della famiglia.
Se questo vale nelle procedure giurisdizionali (consensuali o non che siano), deve valere a maggior ragione nelle procedure de-giurisdizionalizzate, che non possono valersi del controllo del Tribunale e che hanno, a quel punto, solo nel difensore l’unico momento di possibile valutazione e rispetto dei diritti e interessi coinvolti.
Deve osservarsi che l’esistenza di un’area di procedimenti contenziosi è fisiologica nel sistema e, in qualche modo, corrisponde al motivo stesso dell’esistenza del sistema: ovvero il fatto che in alcuni
casi le persone coinvolte non sono in grado di trovare una soluzione in autonomia e hanno necessità dell’intervento di un giudice super partes che ponga fine al conflitto o, almeno, lo regoli.
Il fatto di avere procedure contenziose, peraltro, non necessariamente implica il fatto che le stesse siano anche conflittuali, anche se è maggiore la probabilità in questo caso.
Mentre sulla necessità che sia un terzo a dirimere la controversia non si può incidere oltre un certo limite (come detto, appartiene alla logica del sistema che vi sia questa esigenza e le norme sono predisposte proprio per questi casi), ciò che può essere oggetto di “lavoro” è il tentare di eliminare dal contenzioso, quanto più possibile, il tasso di conflittualità, con percorsi che si affianchino alla procedura e che quel conflitto lo affrontino, invece che unicamente regolarlo, lasciandolo, tuttavia, inalterato.
Il ruolo del difensore nei procedimenti in materia di famiglia è particolarmente delicato poiché le situazioni che affronta sono sempre complesse, perlomeno sul piano dei rapporti, così come delle relazioni e, spesso, anche giuridicamente. Il professionista che interviene in questi procedimenti, oltre ad avere una preparazione tecnica adeguata, deve anche avere la capacità di comprendere i confini del proprio ruolo, facilitare il ricorso ad altri professionisti che possano prendere in carico diversamente le persone per quanto
attiene al loro vissuto rispetto alla separazione/divorzio o ad altri aspetti specifici.
Resta fondamentale, nella tutela dei diritti della persona, lo spazio che una difesa adeguata deve svolgere e che, come si è avuto modo di argomentare più sopra, deve crescere proprio al decrescere dell’intervento del Tribunale nelle procedure, perché rappresenta un necessario vaglio tecnico nella salvaguardia dei diritti.Insieme alla difesa tecnica, tuttavia, di fronte alla complessità che oggi le famiglie hanno, appare sempre più necessario che l’intervento del legale non avvenga in solitario ma sia, al contrario, inserito in una logica di presa in carico complessiva della situazione di crisi. Si tratta di una sfida nuova che richiede,
anche nella organizzazione dello studio, una maggiore articolazione con il coinvolgimento di figure professionali differenti e che siano in grado di intervenire su fronti diversi. Questa necessità deve spingere verso studi sempre più multidisciplinari capaci di offrire una risposta adeguata a bisogni nuovi che riflettono i cambiamenti in atto nella società.
Una maggiore articolazione che deve essere alla portata di tutti non solo di chi ha più risorse economiche: si tratta, infatti, di un livello di assistenza necessario per la persona ed è ragionevole chiedere che sia inserito tra le attività coperte dal beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, sperabilmente con un adeguamento dei limiti di reddito dello stesso che oggi ne condiziona parecchio l’operatività. ■



Il ministero del Lavoro e le parti sociali hanno sottoscritto un Protocollo quadro per adottare misure di contenimento per rischi lavorativi legati al grande caldo nei luoghi di lavoro. Obiettivo: rafforzare la tutela dei lavoratori esposti agli effetti estremi del cambiamento climatico
Il grande caldo e le relative conseguenze sulle attività lavorative hanno riacceso l’attenzione sull’impatto dei cambiamenti climatici sul mondo del lavoro e sulla necessità di regolamentare le situazioni emergenziali.
Le ultime settimane hanno infatti visto avvicendarsi, da un lato, le ordinanze delle regioni in attuazione dell’art. 117, comma 3 della Costituzione, che annovera la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro tra le materie di legiferazione concorrente tra Stato e Regioni; dall’altro gli incontri tra Ministero del Lavoro e Parti Sociali in tavoli tecnici dedicati ai temi della salute e della sicurezza. Ed infatti, alle ordinanze regionali che, generalmente, dispongono, in via emergenziale
ed urgente, per determinate fasce orarie e categorie professionali, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, si è affiancata l’attività del Governo finalizzata a favorire misure a tutela della salute e della sicurezza tramite un dialogo costruttivo con le Parti Sociali, nell’ambito dei settori specifici di attività.
Il lavoro sinergico tra Ministero del Lavoro e Parti Sociali ha portato, quindi, il 2 luglio 2025, alla sottoscrizione di un Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. «Con la sottoscrizione del Protocollo caldo al Ministero, le parti sociali hanno dato una risposta importante ai lavoratori e alle imprese,



in un momento eccezionale», ha affermato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. «Il protocollo ha l’obiettivo di scongiurare infortuni e malattie professionali connessi al clima estremo».
Il documento, firmato da una solida rappresentanza di organizzazioni sindacali e datoriali, si pone lo scopo di rafforzare la tutela dei lavoratori esposti agli effetti estremi del cambiamento climatico, coniugando la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Tra i firmatari, in rappresentanza della categoria dei liberi professionisti ed a conferma della crescente attenzione sui temi oggetto del
Protocollo, è intervenuta Confprofessioni, la confederazione italiana delle libere professioni.
La considerazione di partenza del Protocollo è che il cambiamento climatico incide direttamente sulla sostenibilità ambientale ed economica. Per questo motivo, ferme restando le misure dettate dal Ministero della Salute, le Parti Sociali firmatarie del Protocollo hanno convenuto di adottare procedure concordate di prevenzione dei rischi, considerati gli aspetti relativi ai diversi settori, tramite la contrattazione a diversi livelli. Valorizzando le buone prassi in materia, le Parti dedicheranno particolare cura ad informazione, formazione e prevenzione, disegnando percorsi di intervento e misure condivise valide anche
nel caso di presenza di studenti impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
Le parti sindacali e datoriali hanno concordato di attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie per le realtà specifiche dei diversi settori, che potranno diventare parte integrante dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
Sono state definite, nel testo, alcune aree di intervento in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici o anche in prospettiva prevenzionale di lungo pe -
riodo: Informazione/formazione; Sorveglianza sanitaria; Abbigliamento/indumenti/dpi; Riorganizzazione turni e orari di lavoro. Il Protocollo prevede anche che in attuazione dello stesso possano essere previsti criteri di premialità riconosciuti dall’Inail a vantaggio delle imprese aderenti, in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
È prevista, infine, la possibilità di costituire, a livello territoriale o settoriale, specifici gruppi di lavoro per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle Autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per la gestione delle emergenze climatiche.
Le Parti si sono impegnate ad incontrarsi periodicamente e comunque entro sei mesi dalla sottoscrizione del Protocollo, per monitorare l’attuazione delle misure concordate.
Parallelamente, anche l’Inps è intervenuto sul tema, in considerazione dell’incidenza che le condizioni climatiche hanno sullo svolgimento delle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse.
Ed infatti, all’indomani della firma del Protocollo, l’Istituto, con il messaggio 2130 del 3 luglio 2025 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità con cui richiedere le prestazioni di integrazione salariale, ovvero il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e l’assegno di integrazione
salariale, relativo al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali, tra i quali il fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Il Protocollo si presenta dunque come un passo importante verso una cultura più consapevole dei temi della salute e della sicurezza sul lavoro con riguardo ai singoli settori rappresentati dalle Parti Sociali ed a fronte delle nuove sfide poste dal cambiamento climatico.
Tali sfide coinvolgono e coinvolgeranno anche i liberi professionisti per l’impegno comune e richiamato come obiettivo prioritario del Protocollo di coniugare continuità operativa e garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. ■

PER TUTTI I PROFESSIONISTI
Garanzie a tutela della salute e dello studio
Prestazioni in Convenzione Unisalute
Prestazioni a Rimborso
Gestione Professionisti
Cyber Risk

Rimborsi per Spese Odontoiatriche

Convenzioni
Coperture automatiche per i datori di lavoro e volontarie per tutti i Professionisti, attivabili autonomamente dalla piattaforma con versamento di un contributo annuale
BASE € 48
UPGRADE € 24
PREMIUM € 72
di Giampaolo Di Marco
Segretario nazionale
Associazione nazionale forense
Tenere testa alle nuove sfide della digitalizzazione per continuare a crescere ed essere una guida intellettuale della società. Questo l'obiettivo che devono porsi i professionisti. E Confprofessioni potrebbe essere la piattaforma culturale in grado di indicare a tutti gli associati l’agenda della riflessione basata su un sano confronto dei saperi
Negli ultimi anni, il mondo delle libere professioni si è trovato al centro di profondi cambiamenti sociali, economici e tecnologici. Medici, ingegneri, avvocati, psicologi: queste figure rappresentano oggi un motore di sviluppo tanto per la società quanto per l’innovazione dei servizi.
Ma come si preparano le nuove generazioni ad affrontare un mercato del lavoro così specializzato?
La risposta passa da uno snodo strategico, ovvero quello di una casa comune, sul piano scientifico ed intellettuale, che dia nuova linfa alle professioni intellettuali, per il bene comune.
Si tratta di individuare una realtà accademica, universitaria e professionale di natura trasversale, che metta in rete saperi diversi, ordini professionali, associazioni e tessuto produttivo.
Obiettivo? Accompagnare chi studia e lavora in un percorso che va dalla formazione accademica e universitaria al mondo del lavoro, passando per tirocini, ricerca e aggiornamento continuo, ma che si contaminino costantemente tra loro. Accanto alle figure storiche di professioni intellettuali, crescono spazi per nuove professioni legate al digitale, all’ambiente, alla sicurezza informatica e alla comunicazione.
UN NUOVO RUOLO
Il saggista e filosofo bulgaro-francese Cvetan Todorov, nella metà degli anni Novanta si chiedeva quale fosse il nuovo ruolo degli intellettuali e tra questi, quello dei

professionisti. La risposta, invero molto complessa, passava da alcune considerazioni.
Todorov riteneva che il nuovo ruolo non potesse partire da quello avuto dai professionisti nei secoli passati, ovvero di guida o profeta, ma neanche da quello di dissacratore o contestatore, ma che dovesse ritrovarsi in una funzione di critica condivisa, ovvero aperta, tra le scienze proprie delle professioni intellettuali e degli intellettuali stessi.
Ancora.
Lo storico Jacques Le Goff ha osservato che alcune categorie socio professionali, attive nel secolo scorso nei processi di emancipazione del pensiero scientifico per affrancarlo da retaggi storici, di natura politica o religiosa o da profezie e paure, principalmente frutto della scarsa alfabetizzazione della società, al momento dell’affacciarsi di nuovi ciarlatani moderni, anziché proseguire in questo percorso di costante vigilanza dei risultati raggiunti, si sono impegnate maggiormente nella sacralizzazione della propria funzione.
Riferendosi ad esempio ai medici, Le Goff affermava che erano stati i migliori professionisti capaci di liberare le proprie competenze e le proprie pratiche a favore dell’abbattimento di retaggi quasi tribali nei trattamenti sanitari, ma poi si
erano persi nella costruzione di un’immagine della propria azione e del proprio sapere, lontana dalla medesima realtà che avevano contribuito a creare.
Le Goff proseguiva, poi, con altri professionisti ed in genere con gli intellettuali, ritenendo che il grande sforzo post-bellico, si fosse poi in realtà tradotto in un’inguaribile alienazione e vanità di un sapere che a un tratto sembrava non appartenergli più.
AL PASSO CON I TEMPI
Nel condividere in parte questa visione, nell’era della digitalizzazione, dove il logos, nella duplice accezione di pensiero e parola, sembra quasi atrofizzarsi a scapito della “scorciatoia” artificiale, occorre ribadire che il lavoro intel-

lettuale non è “estetica del pensiero”, ma è “fatica” di pensare. Una battaglia con le cose, le idee, la scienza, sulle quali si tenta di fare luce, anche mediante la loro promozione nella dimensione pubblica, come percorso solutivo della società del presente, che diventa “naturalmente” futuro.
L’impegno quotidiano, infatti, dovrebbe essere quello di costante confronto delle professioni con le ansie della società presente, provando a fornire risposte a domande il cui contenuto, le renda capaci di segnare una differenza, una crescita, in sostanza la generazione di altre domande.
Al contrario, un metodo diverso, come descritto da Le Goff, degraderebbe ulteriormente le profes-



sioni intellettuali, nell’era della citata scorciatoia, a servizio o, peggio, le inquadrerebbe per dirla con lo storico Bidussa, come cenacolo di predicatori, distributori di catechismi o meri consolatori, o ideologi o agitatori, che nella storia sono stati sempre molto diffusi.
Mi piacerebbe vedere le professioni non impegnate ad essere mere stimolatrici di correzioni di errori o disattenzioni di un momento storico, così come commessi dalla politica del momento o da questa o quella istituzione, ma in grado di rivolgersi criticamente a una credenza collettiva, grazie alla condivisione delle scienze che le caratterizzano, appunto unite in una casa comune, per il bene comune. In tal senso, le suindicate domande si rivolgono a un
senso comune che oggi non sembra pronto o non ha la capacità di fornire adeguate risposte, ma neanche politiche, decisioni utili o far assumere responsabilità tanto alla comunità quanto al singolo individuo che la compone.
Questo ruolo, oggi, ci permetterebbe di creare una piattaforma culturale che ci indichi chiaramente l’agenda della riflessione, che ci solleciti e ci proietti nel futuro.
In questo ruolo non c’è solo la competenza o la formazione del professionista o dell’intellettuale, c’è la sensibilità del proprio logos e la responsabilità del proprio agere, entrambi in una costante proiezione collettiva. Nello smarrimento della rete, nell’assenza di visione di futuro come scarto
e come richiesta di discussione di fondamenti del tempo presente, siamo richiamati ad avere un atteggiamento inquieto ovvero quello che diffida dal “sapere liquido” o “facile”, che grazie alla condivisione dei saperi ci permetta non solo di partecipare all’agenda pubblica dei problemi del tempo che viviamo, ma che ci permetta di crescere nuove generazioni di professionisti ad un tempo competenti, consapevoli, sensibili e responsabili.
Dovremmo essere, per l’era digitale, ciò che siamo stati per l’era industriale, ovvero delle competenze professionali riconosciute, caratterizzate dalla passione della consapevolezza di sapersi anello di una lunga storia di generazioni che nel tempo e, tempo per tempo, non solo lascia ai posteri, ma contribuisce a crescere generazioni che siano convinte che quelle professioni vadano portate avanti.
Per questo, proprio la confederazione, potrebbe essere la casa comune delle scienze proprie delle professioni che la compongono, per una contaminazione di futuro, la cui matrice è indagare per saperne di più, come metodo e risorsa che aiutino a pensare al domani, trasformando il pensiero condiviso in attuazione del sapere.
Le professioni sono ciò che fanno e ciò che fanno non è un sapere a priori, ma sono vie per renderlo possibile anche a costo di essere scomodi, come pensatori e come lavoratori, che mettono a terra il proprio pensiero. Compito delle professioni nell’era digitale, quin-
di, dovrebbe essere quello non di predicare una verità, ma di dare forma a ciò che ritengono giusto nella dimensione pubblica di tutti e di ciascuno, con un costante progresso della consapevolezza del proprio ruolo di pensatori, sempre accompagnati da un costante bilancio della propria funzione di fare.
Proviamo, quindi, ad avere un’inquietudine generativa, nel tempo in cui si pensa a macchine generative, che chieda di sapere e di saperne di più.
Insomma, non professiamoci autosufficienti, ma esigenti con noi e tra noi, con una disincantata insoddisfazione che non venga vissuta come delusione, ma solo come coraggio di voler continuare e non smettere. ■


Il rapporto degli italiani con gli alimenti
è mutato profondamente nel tempo del digital life. Siamo passati dalle ricette tramandate delle nonne alle fotografie di piatti succulenti postate sui social, sui blog gastronomici e sui gruppi whatapp. Una vera e propria ossessione per il cibo. Fenomeno sociale da mordere, da assaporare e da condividere
di Guido Mattioni

Massì, chiamiamolo amore! Perché questo è, a ben vedere, il sentimento che meglio di qualsiasi altro riassume, soprattutto per noi italiani, il rapporto che nutriamo nei confronti del cibo. Sentimento impastato di storia e volti che non ci sono più; condito da ricordi di sapori ancestrali; speziato con memorie di viaggi, di storie di cuore ormai finite, così come appena iniziate.
Sentimento che può essere declinato in tanti altri modi. Si va dalla golosità dei più raffinati gourmand alla terrena pulsione di chi si accontenta di riempire la pancia tre volte al giorno.
Si passa dai custodi talebani delle antiche tradizioni, quelli che non sgarrano mai di un solo spicchio d’aglio o rametto di rosmarino, agli esploratori dei territori gastronomici più inesplorati, creativamente eretici e fedeli a un’unica regola: le regole (quindi anche le ricette) sono fatte per essere violate.
Si oscilla poi tra l’ossessione per il cibo sano, “senza questo” e “senza quello” - che meriterebbe l’appellativo positivo di “attenzione”, visto che i costi della Sanità ricadono su tutti - e il pericoloso autocompiacimento di sgarrare, di mangiare il peggio del cibo iper-processato, dando così lavoro anche ai medici che si occupano dell’altrettanto esponenziale fenomeno delle patologie dismetaboliche.
Di questo amore si sapeva, non è certo una novità. Era sancito dai quadernetti delle nostre nonne, scritti a mano e tramandati
gelosamente per generazioni. Ora che quei quadernetti non ci sono più – e, purtroppo, nemmeno “quelle” nonne - il sentimento degli italiani nei confronti del cibo è rimasto, ma ha cambiato volto: è divenuto 2.0, virtuale cioè nei modi, ma sempre calorico nella sostanza.
Si è trasferito dal privato di quelle pagine di carta a quadretti, scritte spesso a matita e con perfetta calligrafia scolastica, ai social. Con almeno due indiscutibili meriti: quello di aver fatto sì piazza pulita della stucchevolezza delle troppe fotografie di gattini, fate, cuori palpitanti e stelle dorate; ma anche e soprattutto delle preoccupanti dosi di amaro lasciate dai troppi odiatori e leoni da tastiera.
IL PIATTO IN LINEA
L’amore tricolore per il cibo è divenuto così, via via, fenomeno da studio sociologico. Perché micetti o insulti che fossero in passato, lascia oggi spazio a istantanee di zuccherose cassate e profiterole vicini a un cremoso scoppio; a muti e pensosi primi piani di orate e branzini al forno; a sugose carnosità di abbacchi e porchette; ma, sempre più spesso, anche a veganissimi sformati e vellutate di verdure o legumi.
Perché l’Italia cambia anche ai fornelli e a tavola, pur rimanendo in fondo sé stessa: innamorata, appunto, del cibo. E una sostanziale mano al cambiamento l’ha data la tecnologia dei telefoni cellulari.
Pensiamoci: chi mai avrebbe pensato, vent’anni fa, di vedere compassati notai o rigorosi ingegneri – giusto per citare due professioni


- fotografare al ristorante il piatto appena servito loro, prima ancora di mangiarlo? O addirittura di veder posporre l’assaggio e inviare subito quell’immagine, accompagnata da un commento salivante o da un faccino che fa slurp a un amico o a un intero gruppo whatsapp, familiare, aziendale o di condomini che sia?
Ammettiamolo: succede e non ci meraviglia nemmeno più. Anzi, confessiamolo: lo abbiamo fatto almeno una volta anche noi. Fenomeno che tocca però vette di perfezionismo e maniacalità gastronomica sulle pagine di quei membri della social community che, per passione e abilità, disdegnano il lavoro fatto dagli altri, dai ristoratori, pubblicando in fotografia e con pignole descrizioni dettagliate da ingredienti, dosi e temperature, le ricette che hanno appena realizzato nella cucina di casa e portato in tavola. Restando poi in speranzosa attesa dei like o delle richieste di ulteriori dettagli tecnici.
Con i maschi che quasi superano in numero le donne, semmai più dedite alla redazione professionale e reddituale – la concretezza del matriarcato! – di blog gastronomici, spesso anche sponsorizzati.
Fatta però la tara da queste forme d’amore gastronomico più materiali, il fenomeno esiste. Non possiamo nascondercelo, sospeso com’è tra il consolatorio e l’autoreferenziale, tra la semplice gola e l’esibizionismo. Anche chi sta scrivendo questo articolo, da
sempre apprezzato chef dilettante tra i suoi amici in carne ed ossa, ma ora anche tra quelli virtuali e molto più numerosi sui social, non ne è esente.
Incerto, semmai, nella risposta da dare a chi gli chiedesse, sorridendo: “Ma perché lo fai? In fondo hai una certa età e un’onorata carriera di giornalista alle spalle.” Non chiedetemelo. E penso di poter pluralizzare la raccomandazione, cioè anche a nome degli altri: non chiedetecelo.
Perché né io né gli altri avremmo una risposta certa, di senso compiuto. Forse bisognerebbe rivolgere la domanda a un grande studioso dei meandri della mente umana come il professor Vittorino Andreoli, unico capace
di rendere la psichiatria una lettura piacevole e comprensibile. Solo lui sarebbe in grado di dare una risposta acuta, esauriente e illuminante. Magari azzardando la nascita di un nuovo cluster sociale – la butto lì - quello dei “Gastro Esibizionisti”, pacifici individui spinti da un’intrattenibile molla a trasformare la propria passione in altro: sogni da mordere, da assaporare e da masticare.
Forse anche da digerire. Forse. Ma comunque da condividere – generosamente e pacificamente - con gli altri. Raccomandando cotture al dente anziché scagliare insulti, spargendo fili di olio evo anziché laghi d’odio, regalando raffinate sapidità agrodolci in luogo di volgare sarcasmo. Così, soltanto per amore, appunto. ■

di Sara Napolitano
Estate tempo di libri. Ma come orientarsi tra classifiche, nuove uscite e vecchi buoni propositi di lettura? Due scrittori e liberi professionisti, l’avvocato Paolo Pinna Parpaglia e l’architetto Gianni Biondillo, stilano una lista di titoli tra classici, novità e saggi per riflettere. Dai romanzi di Gadda e Orwell alla poesia di Caproni, passando per thriller sardi, saghe familiari e temi ambientali
Un italiano su due ammette di attendere le vacanze per dedicarsi finalmente ai libri. Lo certifica una ricerca di YouGov per Ready, servizio di abbonamento a quotidiani e riviste, che suddivide le preferenze in fiction (57%), quotidiani (27%) e riviste (20%). Ma chi non vuole rinunciare alla compagnia di un buon libro sotto l’ombrellone, in aereo o sull’amaca, come si districa nella giungla delle pubblicazioni, circa 85mila l’anno secondo l’Istat? C’è chi accumula titoli durante l’anno in attesa del tempo libero, c’è chi si fa guidare dalle classifiche e chi pesca dai finalisti delle ultime edizioni di premi letterari prestigiosi come Strega o Campiello. Noi abbiamo deciso di affidarci al consiglio di scrittori che sono anche liberi professionisti, Paolo Pinna Parpaglia, avvocato, e Gianni Biondillo, architetto. Biondillo pubblica per Guanda dal 2004 di narrativa, architettura e viaggi. Ha vinto, tra gli altri premi, il Bagutta 2024 con Quello che noi non siamo, un romanzo ambientato nel Ventennio che parla di architetti in lotta con il regime. Pinna Parpaglia invece pubblica i suoi gialli e legal thriller per Newton Compton. Ha esordito nella narrativa con il romanzo Verità Processuale dieci anni fa. La serie che ha per protagonista l’avvocato Antonella Demelas ha venduto oltre novantamila copie. «Purtroppo, dobbiamo ammetterlo con un po’ di vergogna, i professionisti, i manager, la classe dirigente, i politici, in Italia leggono poco» dice Biondillo. «Circa la metà dei professionisti spagnoli, un quinto di quelli francesi. Quindi leggiamo, ci conviene. In fondo c’è solo una controindicazione: “Leggere crea indipendenza”. Non è poco».


Paolo Pinna Parpaglia, avvocato scrittore
Gianni Biondillo, architetto scrittore
PER CHI VUOLE RIFUGIARSI
Carlo Emilio Gadda, La cognizione del dolore, Adelphi, edizione 2019
È un romanzo del 1941 che racconta il difficile rapporto tra un uomo e sua madre, vedova, anziana e fragile. «Gadda scrive con una lingua raffinatissima al contempo tecnica, triviale e aulica, mostrandoci fino a che punto di sperimentazione si può arrivare con la lingua italiana» spiega Biondillo. «Ed essendo un ingegnere dall’animo filosofico, sa raccontare il torbido e l’intimo dell’umano sia con umorismo che con drammaticità».
George Orwell, Fiorirà l’aspidistra, Mondadori, edizione 2016
Londra, anni Trenta (il romanzo è del 1936). Gordon Comstock, aspirante poeta, rifiuta il mito del “buon posto” e sceglie la povertà per ribellarsi alla morale borghese. Tra solitudine e frustrazione, combatte il dominio del denaro finché una notizia improvvisa cambia tutto. «Gordon è uno dei personaggi più spregevoli e fastidiosi che abbia mai incontrato nelle pagine di un romanzo» racconta Pinna Parpaglia. «Ma è incredibile la capacità dell’autore di descriverlo. La sua meravigliosa penna porta volutamente il lettore a detestare il protagonista e le sue convinzioni anticapitalistiche portate all’eccesso».
Giorgio Caproni, Tutte le poesie, Garzanti, edizione 2016
«Incomprensibilmente escluso dalla classica triade novecentesca “Quasimodo Montale Saba”, Ca-
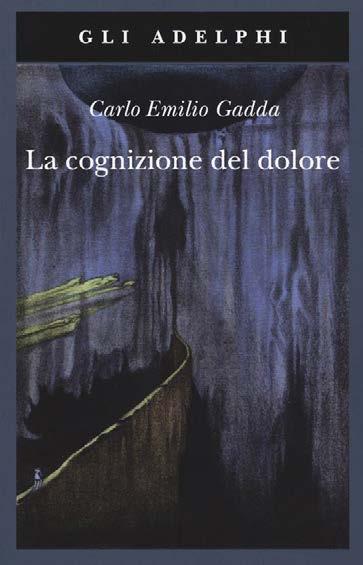
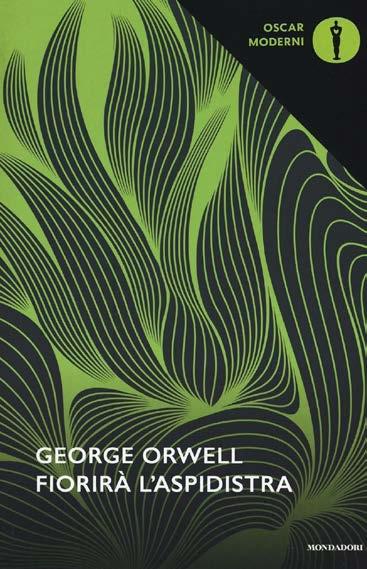
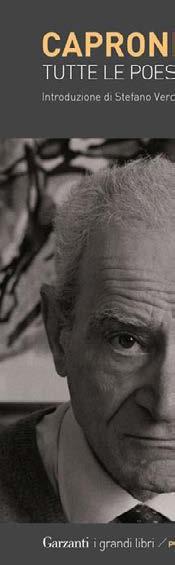
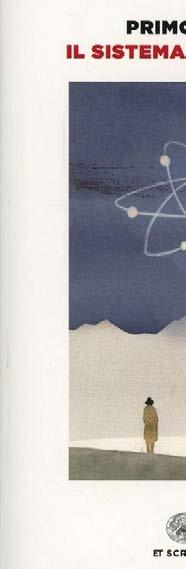

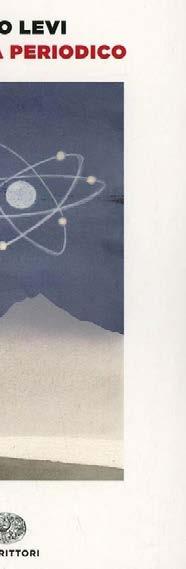
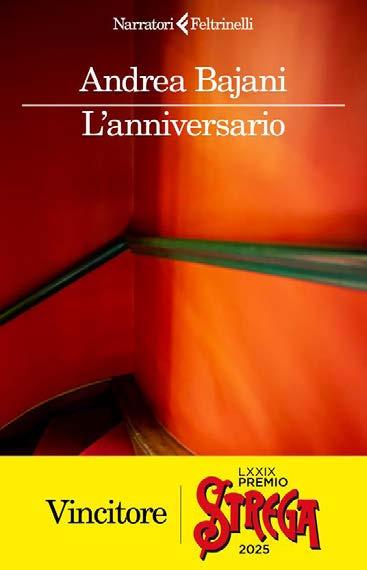
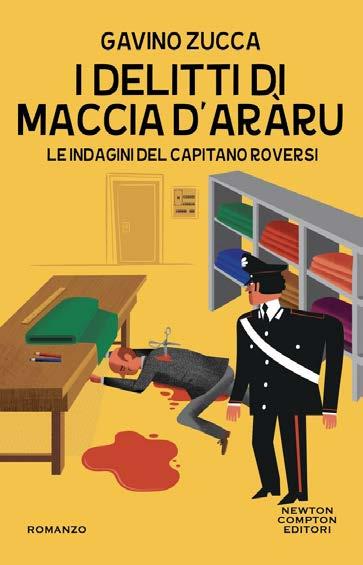
proni è un poeta tutto da scoprire per chi non lo conosce, soprattutto oggi» dice Biondillo. «È capace di una poesia intensissima, intima, profonda, ma mai oscura». La raccolta comprende tutta la produzione poetica dagli anni Trenta agli anni Ottanta.
Primo Levi, Il sistema periodico, Einaudi, edizione 2014
Ventuno racconti scritti nel 1975 che hanno come filo conduttore gli elementi chimici. Levi racconta sé stesso attraverso la chimica e racconta la chimica utilizzando sé stesso come strumento. «Ritengo sia il più grande scrittore italiano del ‘900» riflette Pinna Parpaglia. «Non solo ha sempre qualcosa di estremamente interessante da raccontare, ma lo fa con una grazia ed uno stile sublimi. Al termine della lettura si ha l’inappagabile sensazione di essere più ricchi, più colti, ma anche più consci dei drammi del ‘900».
PER CHI VUOLE “EVADERE”
Andrea Bajani, L’anniversario, Feltrinelli, 2025
Un romanzo di liberazione che scardina e smaschera il totalitarismo della famiglia. La storia di un figlio che dopo aver tagliato i ponti torna a guardare indietro per ricostruire la sua dolorosa storia familiare.
Gavino Zucca, I delitti di Maccia D’Arau, Newton Compton, 2025
Un giallo ispirato a Sherlock Holmes che vede in azione il capitano Roversi, protagonista della
saga di Zucca, alle prese con un efferato omicidio che scuote la periferia di Sassari e le cui modalità rimandano a un vecchio caso che sembrava chiuso. «Le indagini del capitano Roversi sono sempre interessanti e raccontate con uno stile snello che tiene incollati alle pagine», dice Pinna Parpaglia.
Irene Solà,
Ti ho dato gli occhi e hai guardato le tenebre, Mondadori, 2024
In un villaggio isolato nei Pirenei, sei generazioni di donne vivono tra storia e leggenda, tra vivi e morti, legate da un antico patto col diavolo. Solà intreccia folklore catalano, eventi storici e magia in un romanzo breve ma intenso, ricco di umorismo, immagini potenti e personaggi memorabili.
Pankaj Mishra, Il mondo dopo Gaza, Guanda - 2025
Lo scrittore indiano analizza la nascita e lo sviluppo dello Stato di Israele, e il ruolo che la memoria della Shoah ha avuto nell’immaginario dal dopoguerra in poi. «Un saggio che racconta il mondo che ci circonda, le sue storture, le sue contraddizioni», assicura Biondillo.
Wu Ming 1, Gli uomini pesce, Einaudi, 2024
Estate 2022: il Po è ai minimi storici. La morte di Ilario Nevi, partigiano e intellettuale ferrarese, rivela un segreto nascosto da un secolo. Sua nipote Antonia indaga, scoprendo intrecci di vite e misteri tra guerre, lotte civili e ambientali. Un omaggio al Grande Fiume.
Marco Albino Ferrari, Assalto alle Alpi, Einaudi, 2023
L’autore smonta i miti della montagna-idillio e analizza con lucidità come il turismo stia consumando le Alpi. In 129 pagine dense, riflette su sviluppo insostenibile, stereotipi e responsabilità collettive, offrendo spunti concreti in vista di Milano-Cortina 2026. ■
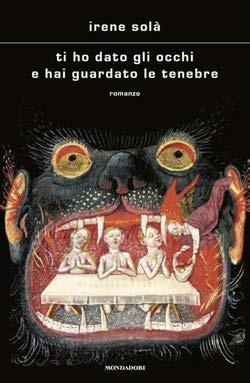

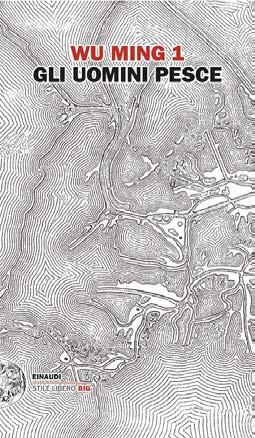


Le novità tributarie e il loro impatto sulle professioni nel commento di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi
Al di là dei benefici del regime premiale e delle varie immunità accertative, la nuova edizione del Cpb 2026 è un salto nel buio. La scelta di aderire deve essere operata guardando solo “al futuro”, senza i calcoli di convenienza per le pericolose problematiche del passato
Il concordato preventivo biennale è al suo secondo appuntamento. Non sono interessati i soggetti che hanno aderito al biennio 2024/2025, prima storica edizione, ma tutti coloro che sono rimasti scettici al riguardo, ovvero che non hanno potuto effettuare la scelta per via di cause di esclusione e/o di non ammissione. L’assunto base rimane lo stesso anche per il biennio 2025/2026. I contribuenti interessati sono
i soggetti ISA e la decisione di fondo riguarda specifici calcoli di convenienza, il principale dei quali ancorato ai risultati che si stima di raggiungere nel biennio considerato. Sul 2025 una prima valutazione parziale è ovviamente già possibile, atteso che al momento è previsto che l’opzione vada eseguita entro il prossimo 30 settembre, potendo i contribuenti almeno vagliare i risultati di 9 mesi su 12 dell’anno da concordare.
Per il 2026, invece, si deve fare un minimo “salto al buio”, tenuto sempre ben presenti i benefici che si possono fruire, non soltanto sul piano del regime premiale e delle varie immunità accertative, ma anche e soprattutto sul fronte della tassazione, laddove restano fermi i due principali vantaggi:
▪ La fissazione del reddito da dichiarare, con l’implicito assunto di non tassare ai fini delle imposte sui redditi l’eventuale surplus realizzato;
▪ La possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni, di sottoporre a tassazione agevolata l’incremento reddituale concordato rispetto a quello dichiarato nel 2024 (considerato limitatamente alle componenti reddituali “tipiche” dell’attività).
Ribadite dunque le condizioni “base” che restano immutate, il nuovo concordato è stato in ogni caso rivisto in altri para-
metri, con l’obiettivo preciso di perfezionare alcuni “difetti” emersi nella prima versione. È comunque assente, almeno al momento, l’attrattiva di eventuali sanatorie del passato (anche se il percorso dello scorso concordato ha dimostrato che, in corsa e fino all’ultimo, le modifiche per maggiorare l’appeal della proposta sono continue e repentine). Dunque, oggi la scelta deve essere operata guardando solo “al futuro”, senza i calcoli di convenienza per le pericolose problematiche del passato.
Sul tema, si sono registrati i primi chiarimenti della circolare n. 9 del 2025, che ha il pregio di fissare i capisaldi dell’istituto, richiudendo nel documento di prassi anche le vecchie precisazioni e le varie puntualizzazioni date in risposta alle diverse faq formulate sull’argomento. È possibile, pertanto, fare un adeguato punto della situazione, in modo da compiere tutte le riflessioni ed elaborare i calcoli di convenienza del caso, potendo giungere alla scelta del prossimo 30 settembre con una relativa ponderazione e certezza. ■
ANMVI - Associazione nazionale medici veterinari italiani

Sabina Pizzamiglio, Direttore responsabile
La Professione Veterinaria

La mobilità dei veterinari (ma non solo) in Europa è ostacolata da troppi passaggi burocratici. Gli studi universitari che rilasciano il titolo di “Veterinario” devono essere armonizzati in tutta l’Unione europea. Per consentire ai professionisti di trasferirsi in uno Stato membro ed esercitarvi liberamente la professione L’Italia e il suo sistema accademico dovranno adeguarsi alle novità entro il 10 aprile 2027
Nella top ten delle professioni più mobili d’Europa, i veterinari si collocano al 9° posto, superati da infermieri (al primo posto) dai medici e dagli odontoiatri. Il dato è contenuto nell’ultima relazione della Corte dei Conti Europea (2024) sugli effetti del riconoscimento delle qualifiche professionali sulla mobilità d’esercito nei 27 Stati UE. Con 5.553 pratiche, i veterinari testimoniano da un lato una tendenza ad esercitare oltre confine e dall’altro gli ostacoli ad una effettiva equiparazione del titolo accademico. Si stima che il sistema sia utilizzato solo in circa il 6 % dei casi di mobilità nell’Ue. Il dato porta la Corte a concludere che le professioni sono ancora eccessivamente regolamentate e che gli Stati membri interpongono passaggi burocratici che inficiano l’automatismo del mutuo riconoscimento delle qualifiche. Lo sportello digitale unico europeo tarda ad essere implementato, con il risultato che esercitare in un altro Stato Membro richiede di fatto un passaggio nazionale di tipo semi-autorizzativo.
Eppure, al netto di questi lacci e lacciuoli, la Direttiva qualifiche 2005/36/CE è lo stimolo legislativo più forte per un ammodernamento dei piani di studio universitari delle professioni. Quella di veterinario è stata recentemente aggiornata dalla Direttiva delegata (UE) 2025/1223 ed è significativo che, nonostante si tratti di una professione sanitaria, se ne occupi la Direzione generale del mercato interno. Vista come un servizio, la professione veterinaria non era più adeguata alla domanda, con perdita di competitività e di sviluppo. Ecco allora l’esigenza di rivitalizzarla, adeguandola ai tempi. Gli studi universitari che rilasciano il titolo di “Veterinario” devono essere armonizzati in tutta l’Unione
europea, per consentire ai professionisti di trasferirsi in uno Stato membro ed esercitarvi liberamente la professione, temporaneamente o stabilmente, offrendo competenze aggiornate. Le modifiche al piano di studio universitario riguardano tutti i veterinari dell’Unione. L’Italia e il suo sistema accademico dovranno adeguarsi alle novità entro il 10 aprile 2027.
Attualmente, si legge nella Direttiva delegata (UE) 2025/1223, la formazione veterinaria non tiene conto, o quantomeno non a sufficienza, di alcune aree di competenza che dovranno invece entrare nel patrimonio di conoscenze e di abilità del veterinario: il concetto «OneHealth»; la sostenibilità e la transdisciplinarità; l’interdisciplinarità, le competenze multidisciplinari e trasversali; i trattamenti e le terapie; la biologia, la digitalizzazione e dati digitali, gli strumenti e le tecniche diagnostiche e di laboratorio. Tutte skills che si dovranno affiancare a quelle fondative e irrinunciabili: la salute e il benessere degli animali; la salute pubblica; l’igiene e la sicurezza alimentare.
Nei fatti, la veterinaria italiana si è già notevolmente evoluta da quando, nel 2005, sono stati definiti i primi requisiti minimi di formazione armonizzata. Nel post-laurea, organizzazioni come l’Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari italiani) e le sue società scientifiche, hanno da tempo arricchito l’offerta formativa post-laurea con programmi di aggiornamento permanente d’avanguardia (vedi box in pagina) che spiegano l’accoglienza favorevole che la categoria ha riservato alla Direttiva delegata. Del resto nel diritto europeo le professioni intellettuali sono considerate “imprese” che per restare in vita
sul mercato dei servizi professionali devono basare le qualifiche su programmi di formazione universitaria che rispecchino i progressi scientifici e tecnici del loro tempo. Spetta agli Stati membri fare in modo che le professioni intellettuali siano all’altezza del cambiamento. ■
Cosa chiede
▪ conoscenze e comprensione adeguate del concetto «One Health», comprese le abilità e le competenze per la sua applicazione e integrazione nella sanità pubblica veterinaria.
▪ conoscenza dell’organizzazione e della gestione di un’impresa veterinaria, compresa la gestione di uno studio veterinario e gli aspetti economici della salute animale.
▪ adeguate conoscenze, abilità e competenze in materia di interazione interpersonale e interprofessionale, comunicazione, lavoro di squadra e collaborazione multidisciplinare.
▪ adeguate conoscenze della gestione dei dati, delle tecnologie dell’informazione e delle tecnologie digitali e abilità e le competenze necessarie per la loro applicazione pratica in ambito veterinario. ■
INARSIND
Associazione nazionale di intesa sindacale di architetti e ingegneri liberi professionisti

Carmelo Russo, Presidente Inarsind

Dalla nascita del primo sindacato nel 1950 alla rappresentanza unica di architetti e ingegneri nel 2004. Dalla Consilp a Confprofessioni, passando dalla Federazione internazionale ingegneri consulenti. La storia e i protagonisti di un’epopea di battaglie per la tutela degli interessi della categoria. Che prosegue ancora oggi, con Inarsind
Architetti e ingegneri si sono incontrati con la nascita degli ordini professionali, giunta a compimento di un processo che ha inizio con il R.D. n. 1054/1923 che modificò i canali di ingresso alle università, proseguì con il R.D. n. 2909 dello stesso anno, che introdusse l’obbligo dell’esame di Stato per gli architetti e per gli ingegneri e poi con il R.D. n. 1592/1933, che istituì le facoltà di Architettura e di quelle di Ingegneria e i conseguenti titoli accademici. Con l’obbligo dell’iscrizione negli albi professionali delle rispettive categorie introdotto dalla Legge n. 897/1938 si completò infine uno status basato su una formazione esclusivamente liceale, garantito dalla tutela legale del titolo di studio, connotato dalla dignità dottorale della laurea: condizione sufficiente – secondo il disegno elaborato - ad annullare qualsiasi rivendicazione e/o più concreti bisogni occupazionali e, in coerenza con la visione “corporativa” della società, tenere insieme soggetti dagli interessi economici differenti, evitare tensioni e rivendicazioni che si erano manifestate in passato.
Tornati in vita, dopo il secondo conflitto mondiale, gli ordini ed i collegi, la composizione di ingegneri e architetti sembra ancora privilegiare la visione di unità imposta in nome della comune formazione culturale, dello status e dell’identità, a prescindere dall’effettivo ambito professionale e dai conseguenti interessi economici. Dalla necessità di difendere i propri specifici interessi prendono vita i primi sindacati dedicati esclusivamente ai liberi professionisti i cui promotori sottolineano con forza il loro netto distinguersi da qualsiasi altra organizzazione, per poter esibire il carattere di omogeneità sociale e professionale e “attribuirsi il pregio
e vantare l’onere di essere veramente autonomo e indipendente (il Sindacato ndr) da qualsiasi vincolo di partito o di interesse di altra natura”. Il 28 aprile del 1950, dalla necessità di sopperire “all’assoluta e prolungata carenza di una adeguata legislazione di tutela professionale”, nasce a Napoli il Sindacato nazionale ingegneri liberi professionisti (Snilp), presieduto dall’ingegner Gaetano del Pezzo Insieme a lui un “piccolo gruppo di animosi” ingegneri liberi professionisti, tra i quali spicca la figura di Amadeo Bordiga, grande protagonista del Novecento; non solo ingegnere ma anche politico e teorico. Dalle sedi originarie di Napoli, Roma, Torino e Palermo il Sindacato si propaga in tutte le regioni con la costituzione di organizzazioni periferiche che nel giugno del 1950 celebrano a Napoli il I Congresso Nazionale.
Nel 1956 nasce un’altra sigla sindacale, la Federazione nazionale dei sindacati ingegneri liberi professionisti (Fnsilp), guidata dall’ingegnere Gianfelice Bertolini. Il primo decennio di vita del Sindacato segna anche la consapevolezza della necessità di un collegamento internazionale. L’ingegner Amedeo Bordiga nel suo discorso durante le celebrazioni dell’anniversario sottolinea l’importanza di raggiunge questo obiettivo che si concretizzerà nel 1992 sotto la presidenza dell’ingegner Luigi Lucherini, quando lo Snilp entrerà a far parte della Fidic, International federation of consulting engineers, che dal 1913 riunisce le associazioni nazionali dei consulenti in ingegneria, rappresentanti di 99 Paesi distribuiti in tutto il mondo. A Firenze il 30 ottobre 1965 le due sigle nazionali Snilp e Fnsilp si uniscono sancendo la nascita del Sindacato nazionale ingegneri Liberi professionisti italiani (Snilpi). Nel gennaio del ’66, durante l’Assemblea nazionale viene
ratificata la nascita del Sindacato unitario e nominato il nuovo Consiglio nazionale che durante la sua prima riunione sceglie i vertici: l’ingegner Leo Calini in qualità di presidente (tra i suoi progetti di maggior pregio è da ricordare la realizzazione della Pensilina della Stazione Termini di Roma in collaborazione con il cognato Eugenio Montuori e altri architetti, tra cui Annibale Vitellozzi) e l’ingegner Giuseppe Milone come segretario. Il 1966 segna anche la nascita della Consilp, la Confederazione sindacale italiana liberi professionisti, proprio ad opera di Leo Calini, presidente Snilpi. La Confederazione delle libere professioni comprendeva non solo ingegneri ma anche avvocati, commercialisti e medici. Nel 2004 Consilp diventerà Confprofessioni.
La storia dei primi quarant’anni di attività del Sindacato nazionale ingegneri liberi professionisti italiani è costellata – come sottolinea il presidente Lucherini nell’Annuario 1992-1993 – da “battaglie combattute a difesa della categoria, come l’ordinamento professionale, la cassa di previdenza, le società di ingegneria, l’Ilor su attività professionale, la tassa sulla salute, il rinnovo dei contratti con i dipendenti degli studi e tante altre”. Nel 2004, nel corso della presidenza dell’ingegner Marcello Conti, di Udine, il Sindacato decide che i tempi sono maturi per una rappresentanza unica fra ingegneri e architetti: nasce cosi Inarsind, Associazione nazionale di intesa sindacale di architetti e ingegneri liberi professionisti, sigla che evidenzia la radice comune con Inarcassa, la Cassa di previdenza degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti. Dal 2013, nel corso della presidenza dell’ingegner Salvo Garofalo, Inarsind è associata in Confprofessioni. ■
Il Contratto collettivo nazionale degli studi professionali ha costruito un’articolata rete di tutele intorno a tutti coloro che operano all’interno di uno studio professionale. In questa rubrica le ultime novità dalla bilateralità di settore
anni di assistenza dedicata ai Professionisti
Dieci anni di impegno e attenzione continua per migliorare condizioni e garanzie a tutela della salute dei Professionisti e dell’attività dello studio. Dal 2015 Gestione Professionisti si dedica all’attivazione delle coperture di assistenza sanitaria integrativa in favore dei professionisti. Inizialmente rivolte ai datori di lavoro in applicazione del Ccnl degli studi professionali, con BeProf le opportunità sono state rese disponibili a tutti i professionisti, anche non datori di lavoro, giovani all’inizio dell’attività, ordinistici e non, società e associazioni anche senza dipendenti. Coperture differenziate e studiate per le esigenze di ciascuno, attivate automaticamente per chi è in regola con il versamento dei contributi per i dipendenti e coperture volontarie a costi
estremamente contenuti grazie alle economie del sistema della bilateralità: da 48 euro all’anno per la Base a 72 per la Premium, 24 euro per l’upgrade, da 22 euro a 311 per le integrative infortuni, tutte acquistabili con carta di credito da BeProf. I professionisti titolari hanno a disposizione diversi pacchetti di prestazioni, alcune usufruibili nelle strutture convenzionate, altre a rimborso, tra cui diarie da ricovero e day hospital e rimborsi spese per interventi ambulatoriali, dermatologia e fisioterapie per malattia, lenti da vista e apparecchi acustici, il pacchetto odontoiatria (per implantologia, ortodonzia, corone e servizi di emergenza), indennità per malattie gravi, cyber risk, video consulto medico e tante convenzioni per ottenere ulteriori agevolazioni.

Fondoporfessioni, formazione su misura: al via l’Avviso 08/25

Il Cda di Fondoprofessioni ha approvato l’Avviso 08/25, stanziando ulteriori 600 mila euro per sostenere la formazione personalizzata nei contesti professionali. Un’opportunità concreta per gli studi professionali e le aziende interessati a percorsi “one to one” o per piccoli gruppi di massimo tre persone, puntando su interventi ritagliati sulle reali esigenze operative dei lavoratori. L’obiettivo è favorire il trasferimento delle competenze direttamente sul campo, anche attraverso l’affiancamento “on the job”. Particolare attenzione è riservata ai neo-assunti e ai dipendenti over 55, spesso più esposti ai rapidi cambiamenti del mercato del lavoro e dei servizi professionali. Ciascun piano formativo potrà ottenere un contributo massimo di 4.000 euro, con un tetto di 100 euro l’ora per allievo e un minimo di 16 ore di formazione. I finanziamenti saranno erogati secondo il regime “De minimis”. Per presentare la domanda di finanziamento, studi/aziende devono essere già aderenti a Fondoprofessioni e affidarsi a un ente attuatore accreditato. Le richieste di finanziamento potranno essere inviate online dal 15 settembre 2025.
Il congedo parentale è un importante istituto di work-life balance che consente ai lavoratori-genitori la astensione facoltativa dal lavoro per la cura dei bisogni vitali, affettivi e relazionali dei figli, da poter sfruttare (entro i primi dodici anni di vita del figlio) in aggiunta e conclusa la fruizione dei congedi obbligatori di maternità e paternità. Nel settore privato delle attività professionali, tecniche, mediche, scientifiche e giuridiche, il rinnovo del principale contratto collettivo nazionale ha permesso di integrare e rafforzare ulteriormente i servizi di conciliazione vita-lavoro, attraverso il sempre più rilevante strumento della bilateralità. Grazie al nuovo impulso, le parti sociali hanno incaricato l’ente bilaterale nazionale Ebipro per promuovere l’uso del congedo parentale da parte del lavoratore dipendente padre e da parte del lavoratore dipendente “single”, con il riconoscimento di un assegno settimanale, che integra l’indennizzo minimo statale dell’INPS, pari a cento euro lordi a settimana per massimo dodici settimane entro il terzo anno di età del bambino.


In occasione dei 20 anni di attività della Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali, Cadiprof ha avviato un ciclo di webinar realizzati in collaborazione con Adnkronos, per tracciare le sfide del futuro del welfare nel settore degli studi professionali. Il primo appuntamento, svoltosi lo scorso 16 luglio e trasmesso in diretta online su YouTube, è stato dedicato al tema “Prevenzione e corretti stili di vita” con la partecipazione di Stefano Dinatale, medico di medicina generale della ASL Torino 4; Antonio Verginelli, medico di medicina generale della ASL Roma 5, specialista in medicina dello sport; Gaetano Stella, presidente Cadiprof; e Michele Carpinetti, vicepresidente Cadiprof. Il secondo webinar verterà sulla “Sostenibilità, relazioni con il Ssn e long term care” e si svolgerà nella seconda metà del mese di settembre. Il terzo appuntamento, in calendario per il prossimo ottobre, affronterà la “Transizione digitale, AI e nuove applicazioni nei servizi sanitari”. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio di Cadiprof, che mira ad coinvolgere direttamente gli assistiti sui temi che caratterizzeranno lo svilupo dl welfare e delle attività della Cassa nel prossimo futuro.
Gli eventi, le mostre, i film e i libri del momento in Italia e all'estero da non perdere per fare un pieno di cultura e di bellezza



Musei, parchi archeologici e monumenti statali hanno registrato un boom di visitatori e di incassi. In cima alla classifica il Parco archeologico del Colosseo e quello di Pompei. Ma il nostro Paese ha un patrimonio di migliaia di siti medio-piccoli e alcune centinaia di piccoli musei, sparsi in tutte le regioni. Tutti ancora da scoprire
Per i musei, i parchi archeologici e i monumenti statali il 2024 è stato un anno da incorniciare. Secondo i dati forniti a maggio dal Sistan, il servizio di statistica del MiC, è record sia per il numero di visitatori, sia per gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti. Ecco alcuni numeri: 60.850.091 gli ingressi nei siti di competenza del Ministero, con un incremento del 5,3% rispetto al 2023. Gli incassi superano di poco i 382 milioni di euro e segnano un +23% rispetto a quelli dell’anno precedente. In particolare, per quanto riguarda gli ingressi, 31.487.563 visitatori si sono recati in parchi archeologici e monumenti. Seguono i musei che hanno staccato in tutto 18.743.830 biglietti e infine i circuiti museali che hanno registrato 10.618.098 ingressi. Il Parco Archeologico del Colosseo, che comprende oltre all’omonimo monumento, anche i Fori Imperiali, la Domus Aurea e l’area archeologica sul Palatino, guida saldamente la classifica dei trenta siti più visitati con 14.733.395 ingressi, distaccando di parecchio gli Uffizi al secondo posto, che hanno registrato oltre cinque milioni di visitatori. Sul terzo gradino del podio c’è il Parco Archeologico di Pompei con oltre quattro milioni di biglietti staccati. I numeri sono impressionanti e bisogna sottolineare che riguardano solo gli enti pubblici. Se si dovessero conteggiare anche le visite nei luoghi gestiti dai privati, i numeri raddoppierebbero.
Secondo diversi studi di settore, dall’analisi dei dati emerge in maniera preponderante la capacità dei siti archeologici di essere più attrattivi rispetto alle altre tipologie di enti. Questo dato assume più
rilevanza, se si tiene conto dello sbilanciamento a favore di questi ultimi in termini di quantità. Se consideriamo validi ancora oggi i dati del 2023 comunicati dall’Istat, i luoghi del patrimonio pubblici e privati sono 4.416. Solo il 7% è rappresentato da siti, aree e parchi archeologici, mentre riguardo al 77% rappresentato dai musei, si evince che solo il 12% di questi sono musei archeologici. L’archeologia, dunque, piace tanto, ma c’è un’importante criticità. La quasi totalità dei visitatori si concentra perlopiù
in una manciata di siti, nonostante il patrimonio archeologico del nostro paese sia distribuito capillarmente su tutto il territorio. Tra le cause di questo fenomeno, oltre all’oggettiva importanza e all’unicità di certi luoghi, è doveroso considerare le scelte quasi obbligate dei fruitori stranieri che per forza di cose hanno possibilità e tempi limitati. Milioni di turisti stranieri visitano ogni anno l’Italia, ma per la maggior parte di questi rimarrà il solo e unico viaggio nel Belpaese di tutta la vita. Paradossalmente,

tanti operatori del settore turistico e culturale affermano però che nei siti più piccoli o fuori dalle rotte del turismo di massa, la maggior parte dei visitatori non sono italiani. In secondo luogo, per la maggior parte, le aree archeologiche si trovano in zone poco servite, più difficilmente raggiungibili e dunque sacrificabili dai viaggiatori.
Tralasciando la freddezza di statistiche e numeri, risulta evidente che noi italiani, per primi, dobbiamo imparare a conoscere casa no-
stra. Non basta solamente essere orgogliosi del fatto che in Italia si conservi la gran parte del patrimonio culturale mondiale, bisogna andare sul campo e guardarlo con i propri occhi. Nessun altro paese, con un territorio limitato come l’Italia, è mai stato abitato nella storia antica da così tante popolazioni e ha visto così tanti passaggi migratori e presenze di civiltà provenienti da altre aree, come i greci o gli arabi nel Sud Italia, per esempio. I popoli stanziati nella nostra penisola prima dell’ascesa di Roma

erano parecchie decine, con origini e lingue diverse. Il lungo periodo della dominazione di Roma ha appiattito questa varietà, ma il sottobosco linguistico, per esempio, è rimasto e ha continuato a lasciare le sue tracce, anche dopo la caduta dell’Impero, mescolandosi con le lingue dei nuovi invasori. Se oggi ogni regione italiana ha i propri dialetti, una propria cucina tradizionale e architetture peculiari, sappiamo che è il risultato di questa immensa varietà che ci portiamo dietro fin dai tempi antichi.
SCOPRIRE IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
Riuscire a definire il numero di siti, musei e aree archeologiche nel nostro paese è impresa ardua anche per le istituzioni nazionali. Se si eccettuano i grandi parchi archeologici come quelli di Roma, Pompei ed Ercolano, le aree archeologiche della Magna Grecia, o i musei di antichità più conosciuti, ci rimangono migliaia di siti medio-piccoli e alcune centinaia di piccoli musei, sparsi in tutte le regioni. L’archeologia invita ad usare immaginazione e ad essere curiosi. Quando si visita un’area archeologica, dove si vedono solo rovine, è necessario farsi tante domande, osservare il paesaggio circostante, collegarla alla storia di altre aree circostanti e a quella della regione in cui sorgono. Così facendo, tutto diventa più interessante e anche un luogo, all’apparenza uguale a tanti altri, può rivelare la sua unicità e la sua bellezza. Possiamo fare alcuni esempi. Nel cuore del Molise, nel comune di Pietrabbondante (Isernia), si trova il l’area del Santuario italico, il più importan-

te luogo di culto dei Sanniti, un popolo preromano stanziato in alcune aree di Molise, Abruzzo e Campania. Erano guerrieri, riuniti in tribù. Ai Romani, che volevano espandere i loro territori nel sud della penisola, servirono tre guerre per sottometterli, le cosiddette guerre sannitiche, subendo, durante la seconda, una delle più grandi umiliazioni della loro storia, quella delle Forche Caudine. Nonostante si fossero arresi, i soldati romani furono costretti a passare disarmati sotto i gioghi nemici. “Passare sotto le forche caudine” è un modo di dire che si usa ancora oggi per raccontare un’esperienza mortificante. Gli scavi hanno messo in luce un complesso sistema di edifici, sorti a partire dal IV secolo a.C., che culmina con la costruzione del monumentale teatro (I-II sec.
a.C.), affacciato sulla splendida Valle del Trigno, i cui sedili in pietra conservano le spalliere sagomate e i braccioli scolpiti a forma di zampa di leone alate. Una passeggiata tra le pietre, abbracciati da un silenzio ieratico.
Altro luogo. Bisogna spingersi nel cuore della Sicilia orientale e immergersi nel brullo paesaggio dei Monti Erei, per raggiungere il sito archeologico di Morgantina, un raro esempio nella regione di città abbandonata in antichità e quindi senza sovrapposizioni successive. Dall’inizio della sua identificazione negli anni ’50, gli scavi hanno portato alla luce insediamenti attribuiti ai Siculi (VI sec. a.C.) e ai Greci di Siracusa, che porteranno la città al massimo splendore (II sec. a.C.). La città risulta abbandonata già nel I
sec. d.C., quando i Romani non la inclusero nei loro piani strategici. Il sito sorge nel territorio di Aidone, dove il museo archeologico locale espone notevoli pezzi, sottratti dai tombaroli a partire dagli anni’ 70 e volati nei musei oltreoceano. Tra questi, la Dea di Morgantina, una monumentale statua restituita dal Getty Museum di Malibu e due acroliti, le dee Demetra e Kore, tornate in Sicilia dopo un lungo contenzioso, mediato dal Metropolitan di New York. A poca distanza da Aidone, a Piazza Armerina, c’è la Villa Romana del Casale, notevole esempio di struttura romana di epoca tardo-imperiale, che conserva tremila mq di mosaici di raffinata fattura. Chi ancora non la conosce, prenda nota. E’ patrimonio Unesco. Alla fine, l’Italia è tutta così, piena di tesori, come Pietrabbondante
e Morgantina. Cambiano solo i protagonisti, quegli antichi popoli che qualche millennio fa (o anche molto prima se includiamo l’archeologia preistorica), hanno abitato la nostra penisola. La parola “rovine” non si addice a così tanta bellezza. ■
Museo di Aidone con Dea Morgantina
CLASSIFICA DEI 30 SITI CULTURALI PIÙ VISITATI DEL 2024
SCOPRI DI PIÙ
SITI E PARCHI ARCHEOLOGICI PIÙ SIGNIFICATIVI AL MONDO IN ITALIA
SCOPRI DI PIÙ
SANTUARIO ITALICO PIETRABBONDANTE
PRENOTA
PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA
SCOPRI DI PIÙ

Nel 2023 oltre 23 milioni di spettatori hanno riempito stadi e palazzetti per assistere a concerti musicali. Un balzo dell’88% rispetto al periodo pre-Covid, che ha spinto i ricavi a 675 milioni di euro. Ma non è tutto oro quel che luccica. Il vertiginoso aumento dei costi dei biglietti determina spesso l’annullamento dell’event, ticket da rimborsare e location meno prestigiose. Che rischiano di rovinare la festa degli artisti e dei loro fans

Esistono degli spartiacque che segnano il passaggio da un momento storico ad un altro con una serie di regole o comportamenti che mutano decisamente il panorama precedente. L’industria dello spettacolo, e in particolar modo quella legata alla musica live, è ad esempio uno settore che nel periodo post-Covid ha evidenziato una forte e significativa ripresa. In Italia, come nel resto del mondo, la crescita delle presenze nei concerti live è stata infatti un dato costante dal periodo post-pandemico, con un numero di spettacoli dal vivo quasi raddoppiati rispetto al 2019: indice di un interesse sempre più diffuso verso il mercato musicale.
Secondo il rapporto Siae del 2023, in Italia c’è stato il 14,9% in più di eventi rispetto all’anno precedente mentre nello stesso anno il settore dei concerti ha registrato 23,7 milioni di spettatori, in crescita del +13,6%. Se poi confrontiamo questi dati con il 2019, anno pre-Covid, l’incremento di spettatori è addirittura dell’88%, a testimonianza non solo di una ripresa, ma di una vera e propria crescita strutturale del settore.
Questi numeri si riflettono anche in una spesa per l’acquisto dei biglietti in deciso aumento: il solo comparto dei concerti ha infatti generato un fatturato diretto di circa 675 milioni di euro rappresentando il 92% dei ricavi complessivi legati agli spettacoli musicali. Betway ha recentemente pubblicato un’indagine che indica che l’aumento medio dei biglietti per i concerti delle star internazionali ha superato il +20% rispetto al pre-pandemia. Un settore ad alto impatto economico


e sociale per cui, per ogni euro speso in un biglietto, se ne generano almeno altri due in un indotto che comprende merchandising, viaggi, trasporti, hotel, cibo.
Il dato interessante è che, malgrado l’aumento considerevole dei costi, il pubblico sembra comunque disposto a pagare. Per molti l’esperienza del concerto oggi ha un valore simbolico che va al di là della spesa effettiva del biglietto: il live viene vissuto come un evento che ricollega fisicamente le persone e resta scolpito nella memoria ma soprattutto rappresenta per molte persone una testimonianza della propria presenza sui social, la documentazione di chi vuole certificare la propria presenza ad un evento che diventa un rito collettivo moderno.
C’è poi un altro aspetto da tenere in considerazione: in Italia, prima dell’avvento del Covid il sistema dei concerti era contraddistinto da cifre ancora ragionevoli e allineate con le reali possibilità di vendita dei biglietti per un concerto. Nel febbraio 2020, allo scoppio della pandemia, le più importanti agenzie e i principali organizzatori di concerti si sono trovati nelle proprie casse decine di milioni di euro, frutto dell’incasso dei biglietti venduti nei mesi precedenti relativi ai concerti dell’estate che stava per arrivare.
Una cifra di circa 80 milioni di euro che nei fatti ha letteralmente cambiato le regole del gioco. Per la maggior parte dei casi infatti quest’enorme cifra non è stata rimborsata visto che in media solo il

20% degli spettatori abitualmente chiede il rimborso e in più, in quel drammatico periodo, le priorità delle persone erano ben altre.
Milioni che a quel punto non sarebbero più stati investiti nelle produzioni dei concerti nelle arene estive ma che potevano essere utilizzati per mettere sotto contratto più artisti possibile con dei cospicui anticipi sui futuri tour. Le più grandi agenzie che si occupano di live hanno infatti al loro interno una sezione che si occupa specificatamente di collaborazioni con i brand. Più è lunga la lista degli artisti nel proprio “catalo-

go”, maggiori sono le possibilità di soddisfare le esigenze di un dato brand per uno spot pubblicitario, un evento social, una convention. Con questo sistema ed un cast numeroso tra cui poter scegliere, le agenzie sanno che nel corso del tempo, magari con lentezza, riusciranno a recuperare tutto l’anticipo versato agli artisti per metterli sotto contratto.
Ma perché i concerti dal vivo sono diventati così fondamentali per gli artisti? Sicuramente un ruolo fondamentale lo ha avuto l’espansione delle piattaforme di streaming con il conseguente crollo delle vendite dei supporti fisici e della musica digitale. Il fatto che il sistema delle vendite oggi sia basato essenzialmente sullo streaming che di fatto certifica trionfi e dischi di platino solo con gli ascolti e non con le vendite reali di cd o vinili altera infatti la percezione del reale successo di un artista visto che quegli stessi ascolti spesso non si trasformano in biglietti venduti per i concerti.
Tenendo presente che gli introiti variano in relazione al numero di ascolti registrati per ciascun brano e al numero di abbonamenti sottoscritti dagli utenti vediamo ad esempio che su Spotify il guadagno derivante da ciascuno stream è di 0,003 euro, ma la quota necessaria per raggiungere 1 euro è fissata a 334 stream. Nel 2024 l’artista più ascoltato in Italia, Geolier, ha occupato la prima posizione anche nelle classifiche per la canzone e l’album più ascoltato ma con 1,2 miliardi di ascolti nel 2024 ha ottenuto dalla piattaforma una cifra di poco più di 3.500 euro. Ecco spiegato perché
fino alla fine degli anni 90 i concerti non avevano questa importanza nell’economia degli artisti: prima si vendevano centinaia di migliaia di album su cd e vinili mentre l’attività dal vivo era collaterale, oggi con le cifre derivanti dallo streaming lo scenario è completamente cambiato ed ecco che si arriva all’esigenza di riempire uno stadio e poter sbandierare il tanto agognato Sold Out.
È evidente che un concerto in un posto così prestigioso rappresenti una grande forma di promozione per l’artista, capita sovente però che all’iniziale entusiasmo generato dalle agenzie di live che prospettano grandi numeri di presenze per il prossimo tour si contrappongano tutta una serie di dubbi quando le vendite per un dato concerto stentano a decollare. Si comincia allora a prospettare un ridimensionamento del programma con location più piccole o addirittura cancellazioni di date ma facendo i conti con autostima, reputazione e immagine da difendere, spesso queste scelte razionali non si possono prendere e quindi ecco l’esigenza di dover riempire a tutti i costi con il sistema dei biglietti scontati che servono proprio a riempire palazzetti e stadi a quel punto pieni solo in parte.
E allora entrano in gioco i biglietti scontati. I principali destinatari, di solito, sono le associazioni: i Cral, i ferrovieri, i pensionati delle Poste, i circoli dopo lavoro, le assicurazioni, le banche e tutte queste associazioni o aziende che hanno accordi proprio con le agenzie di live che a un certo punto rendono disponibili i biglietti che in questo modo riescono a vendere migliaia di biglietti per volta, a prezzi strac-

ciati ma comunque utili per coprire i costi di produzione e soprattutto per evitare un possibile flop con tutte le ricadute d’immagine immaginabili. L’alternativa è sempre quella di annullare il tour in cui non si vendono abbastanza biglietti per riprogrammarlo magari in luoghi più piccoli e comunque sempre tenendo presente che esiste un debito pregresso dell’artista nei confronti dell’agente che prima o poi va estinto. C’è chi si mette a fare serate, convention, ospitate in programmi tv piuttosto che il giudice in qualche talent ma alla fine l’obiettivo è sempre quello di rientrare del debito iniziale. Quel
cospicuo anticipo che spesso è assai superiore al reale valore dell’artista, alla lunga si trasforma in una gabbia dorata da cui l’artista non riesce ad uscire. Definire un range sul costo dei biglietti è un calcolo effimero in quanto dipende dalla notorietà e da altre variabili come la location degli eventi ma generalmente l’acquisto di un biglietto per un concerto può variare dai 30 euro per artisti emergenti fino a diverse centinaia di euro per cantanti di fama mondiale con guadagni per gli stessi artisti che variano a seconda degli accordi stabiliti precedentemente e che prevedono percentuali differenti per ciascun biglietto venduto.
Oltre alla vendita dei biglietti un’altra fonte di guadagno per un cantante che deriva dai concerti è il merchandising ufficiale che viene venduto alle singole date: magliette, felpe e prodotti provenienti direttamente dal brand ufficiale dell’artista. Tra gli artisti italiani con il fatturato più alto in Italia nel 2024 ci sono Ultimo (8,3 milioni), Fedez (4,9 milioni), Sfera Ebbasta (3,6 milioni) e Max Pezzali (3,4 milioni).
La crescita dei costi dei biglietti si spiega con una serie di aumenti che vanno dal cachet degli artisti alle spese di viaggio, dall’allestimento dei palchi alle commissioni delle piattaforme per la vendita dei biglietti fino alla sorta di monopolio del mercato in cui la presenza di poche grandi multinazionali di fatto controlla una notevole quota del mercato della musica. Una parte consistente degli aumenti è sicuramente dovuta alla crescita dei
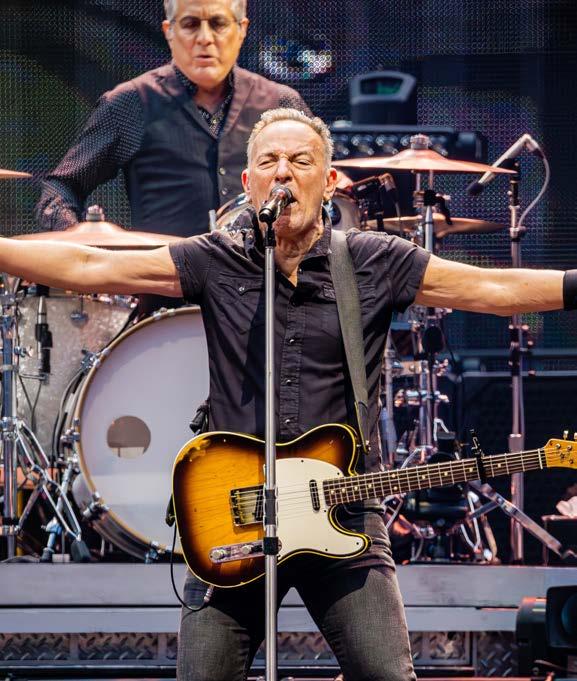
compensi degli artisti. che rispetto al 2019 sono raddoppiati e in alcuni casi triplicati. Per fare qualche esempio il biglietto meno caro per assistere all’unico concerto italiano del rapper americano Kendrick Lamar all’arena di Verona nel luglio 2023 costava 104 euro. Un posto in piedi sul prato allo stadio di San Siro per il concerto di Bruce Springsteen di qualche settimana fa costava 150 euro mentre per il biglietto del concerto dei Coldplay negli stadi nel 2024 servivano almeno 100 euro.
Vista la necessità di rendere più appetibili e instagrammabili i concerti occorre poi investire in produzioni sempre più spettacolari e costose. Un’altra parte dei rincari legati alle produzioni si spiega poi con cause più pratiche come
il costo dell’energia per allestire un palazzetto e dei carburanti per spostare Tir carichi di scenografie e impianti audio, cresciuto soprattutto in seguito all’invasione russa in Ucraina e alla crisi energetica. La pandemia inoltre ha costretto moltissimi tecnici rimasti senza lavoro a cambiare professione. Tra il 2020 e il 2021 il 30% dei tecnici ha cambiato lavoro e oggi mancano all’appello i fonici, gli operatori che montano i palchi e gli addetti al facchinaggio. E chi è rimasto oggi si fa strapagare.
Infine il mercato è ovviamente influenzato dalle politiche delle piattaforme di ticketing che determinano l’incidenza delle commissioni oltre al secondary ticketing, pratica per cui i biglietti dei concerti vengono acquistati da persone o bot automatici che
poi li rimettono in vendita online a prezzi decisamente maggiorati. Il risultato è che i biglietti spesso vengono esauriti pochi minuti dopo la messa in vendita, e l’unico modo per trovarli è spendere decine se non centinaia di euro in più del loro valore effettivo. L’incremento dei prezzi dei biglietti per i concerti è dunque il risultato di una combinazione di fattori economici, tecnologici e di mercato. Ma per il futuro, volendo garantire che la musica dal vivo rimanga accessibile a tutti, sarà fondamentale trovare un equilibrio tra le esigenze economiche degli artisti e degli organizzatori e la possibilità per il pubblico di partecipare agli eventi senza affrontare costi proibitivi altrimenti le conseguenze sul lungo periodo di questa crescita dei prezzi potrebbero essere devastanti. ■

2025
6 AGOSTO Blackpink (Ippodromo SNAI La Maura, Milano)
27 AGOSTO Post malone (Ippodromo SNAI San Siro, Milano)
29 E 30 AGOSTO Drake (Unipol Forum, Milano)
30 AGOSTO
Franz Ferdinand (Auditorium Parco della Musica-Cavea, Roma)
15 SETTEMBRE
Patti Smith (Auditorium Parco della Musica-Cavea, Roma)
5 SETTEMBRE Tananai (Ippodromo SNAI San Siro, Milano)
7 SETTEMBRE Lucio Corsi (Ippodromo SNAI San Siro, Milano)
19 E 20 SETTEMBRE Fedez (Unipol Forum, Milano)
27 SETTEMBRE Geolier (Arena di Verona) I concerti in programma

Dalla passione per gli strumenti, che da sempre accompagnano il suo lavoro, un geometra cilentano ha dato vita a un’ampia collezione e a un interessante progetto museale. Un omaggio al made in Italy della tecnologia. La storia di Pasquale Aprile di Roberto Carminati
Fra l’abitazione e lo studio nonché presso due spazi a magazzino affittati ad hoc il geometra Pasquale Aprile ha stipato nel tempo quasi un migliaio fra strumenti e pubblicazioni che raccontano circa tre secoli di evoluzione delle discipline della topografia, della cartografia e della geodesia. Iscritto al Collegio dei geometri laureati di Salerno sin dal 1977 il professionista li ha raccolti a partire dal 1980 del post-terremoto in Irpinia per uno scopo nobile, chiarito in un banner realizzato in occasione di un recente evento pubblico. Innanzitutto, «ricordare quanto è stato fatto dal Settecento al Novecento per misurare, definire, rappresentare il pianeta su cui viviamo, come premessa alla successiva conquista dello spazio». E quindi dare «testimonianza di quel che l’uomo ha saputo fare in un determinato momento della sua storia». Non da ultimo, la collezione di Aprile è in fondo un omaggio al made in Italy della tecnologia, poiché suo parere e opinione diffusa è che le attrezzature ottico-meccaniche create nel nostro Paese avessero (e abbiano) pochi eguali al mondo.
IL DONO
All’epoca di internet mettersi in contatto con colleghi e appassionati che con gli oggetti in loro possesso alimentino la collezione del geometra è relativamente semplice, specie se come in questo caso si possiede un’ottima padronanza dei social network. «Pubblico regolarmente su LinkedIn e Facebook», ha detto Pasquale Aprile a Il Libero Professionista Reloaded, «e i miei post, poco meno di 30 mila ormai in totale, riescono non di rado a

toccare la quota dei 1.500-2.000 singoli lettori. La maggior parte dei pezzi della mia raccolta sono frutto di donazioni; pochissimi sono stati acquistati. Si tratta per esempio di teodoliti (sistemi ottici per la misurazione degli angoli azimutali e zenitali, per rilievi geodetici e topografici, ndr) o ancora di calcoli e regoli, pantografi, coordinatografi e livelle, tutti rigorosamente precedenti l’ingresso dell’elettronica e del digitale nel nostro mestiere».
Il loro tradizionale funzionamento meccanico fa sì che li si possa ritrovare in piena forma dopo centinaia d’anni e in capo a viaggi decisamente impegnativi. «Proprio oggi», ha raccontato Aprile, «mi è giunta notizia di una consegna in arrivo dalla Bulgaria: più in generale i miei oltre 400 libri e gli altrettanti strumenti parlano tutte le lingue dell’Europa Occidentale e Orientale; giapponese, arabo e cinese; idiomi dell’India. E se chiaramente il web ha esteso significativamente la mia rete di contatti; d’altra parte tutto è cominciato e s’è sviluppato grazie al dialogo e al classico passaparola».
IN PRINCIPIO FU IL PROF
Non meno importante è stata da questo punto di vista la partecipazione assidua dell’intervistato a convegni ed eventi organizzati dal Collegio, in qualità di uditore o relatore. «L’interesse nei confronti della topografia», ha però chiarito, «è nato già sui banchi di scuola e in particolare con le lezioni del professor Gennaro Funicello che a distanza di anni era destinato a divenire mio cliente. Fu però la donazione della livella
e del teodolite del 1890 appartenuti all’ingegnere ferroviario Daniele Francesconi, dal cui nipote ebbi anche una compassiera con manici in avorio inciso, a indirizzarmi verso il collezionismo.
A Francesconi si devono una serie di disegni poi pubblicati e soprattutto i negativi su lastra e pellicola della diga di Osiglia (Savona) realizzata fra 1937 e 1939». L’arco temporale coperto dal geometra e collezionista di origine campana ma residente a Castelnuovo
Il geometra collezionista Pasquale Aprile

Cilento in provincia di Salerno in pieno Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, va dal 1750 al 1970 e «i modelli ottocenteschi o di inizio-Novecento di Salmoiraghi e di Officine Galileo» sono fra gli esemplari di punta della gamma. Il teodolite Salmoiraghi è con tutta probabilità l’autentica star ma «il sogno è poter reperire uno strumento di calcolo dell’arco meridiano firmato dalle stesse due aziende italiane». Di per sé «è una rarità; se fabbricato qui avrebbe pregio maggiore di uno prodotto in Germania o Regno Unito».
Inevitabile è chiedersi e domandare ad Aprile quale possa essere il valore economico di un archivio di tale originalità. La risposta è articolata. «Posso affermare», ha riferito, «che assicurarli in vista di un trasporto o di un’esposizione non è semplice. Ciò non dipende tanto da una reale quotazione di mercato quanto dal fatto che questi strumenti - talora prototipi - sono il più delle volte insostituibili o impossibili da riparare nel caso che subiscano un danno.
Alcuni pezzi sono proposti a prezzi sino a 17 mila euro, che ritengo ingiustificabili. Quel che mi muove è la pura passione e il desiderio di dare visibilità alle opere dell’ingegno: anche per questo non ho mai investito in misura eccessiva». L’obiettivo reale è poi un altro, ovvero dar seguito alle esperienze di successo fatte con le mostre tematiche di Gaeta e di Salerno ove le superfici espositive occupate sono equivalse rispettivamente a 600 e mille metri qua-


drati progettando da capo a piedi un museo. «Il sindaco di Castelnuovo Cilento Gianluca D’Aiuto», ha concluso Pasquale Aprile, «ha aperto all’iniziativa nella convinzione che essa possa dare lustro al territorio cilentano arricchendo ulteriormente il nostro patrimonio culturale, unitamente al percorso cicloturistico della Via Silente - 600 chilometri in 15 tappe fra parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - con partenza e arrivo a Castelnuovo». Contestuale al tutto (si può ipotizzare che l’installazione museale ospiti a rotazione più mostre temporanee di varie tipologie di strumenti) è la fondazione di un’associazione culturale. La finalità è gestire gli 800 articoli della collezione di Aprile. E il nome non potrebbe che essere: Il Teodolite. ■


Tutti i servizi e le opportunità per facilitare l'attività e la vita professionale. In un semplice click
in collaborazione con BeProf
BeProf, Welfare e Servizi dedicati a tutti i liberi professionisti. In un’unica App hai un insieme di strumenti e servizi selezionati per permetterti di lavorare in modo più efficiente, essere sempre aggiornato sulle ultime novità del mondo della libera professione e per farti vivere la tua vita professionale e privata con più serenità. Registrati gratuitamente e scopri un catalogo di offerte dedicate ai liberi professionisti, tra cui le coperture sanitarie a misura di professionista. Con BeProf, infatti, puoi tutelare la tua salute con le Coperture Sanitarie Gestione Professionisti che derivano
dal Ccnl studi professionali finora previste per i professionisti datori di lavoro. Le Coperture Sanitarie di Gestione Professionisti offrono al libero professionista un’assistenza medica e assicurativa di alto livello, a soli 48 o 72 euro all’anno. Tra le varie prestazioni, ogni copertura include visite specialistiche e accertamenti diagnostici, check- up di prevenzione gratuiti, copertura infortuni, pacchetto maternità, diaria per inabilità temporanea, servizio di consulenza psicologica, rimborsi diretti e molto altro. Accedi o registrati a beprof.it e scopri le coperture disponibili.
ACCEDI O REGISTRATI E SCOPRI LE COPERTURE DISPONIBILI
Le migliori coperture sanitarie e un mondo di prodotti e servizi accessibili in ogni momento da smartphone, tablet e pc
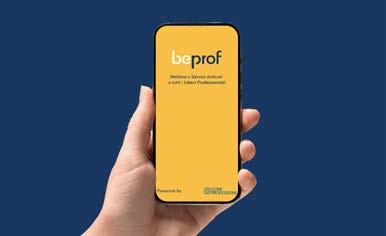

Zucchetti Store è il portale e-commerce del gruppo Zucchetti. Comodamente dalla tua scrivania, puoi acquistare in modo semplice, veloce e aiutare il tuo studio a diventare sempre più smart.
▪ TIC: Tieni il conto, il software in cloud per la fatturazione elettronica che ti permette di gestire entrate e uscite e di tenere sotto controllo la tua attività. Grazie a Tieni il Conto riesci a risparmiare tempo prezioso migliorando l’efficienza delle attività quotidiane, ottimizzando il tuo lavoro per svolgerlo al meglio, ogni giorno.
▪ Prepagato Zucchetti Store: Il Prepagato Zucchetti Store è un credito prepagato studiato per rendere ancora più semplice l’utilizzo dei servizi e per farti risparmiare tempo. È particolarmente comodo per acquisti ricorrenti e “microtransazioni”.
Grazie alla collaborazione tra BeProf e il gruppo Zucchetti puoi ottenere gratuitamente un codice promozionale che può essere utilizzato sul portale di Zucchetti Store e che ti garantisce sconti fino al 20% o estensioni gratuite dei servizi.
I Fuel Voucher Pellegrini
sono buoni carburante che possono essere utilizzati nella rete di distributori a marchio Esso, aderenti all'iniziativa. Disponibili in versione digitale, i Fuel Voucher hanno un valore predeterminato (5, 10, 25, 50 euro) e rappresentano per studi e aziende un efficace strumento di motivazione dei dipendenti, collaboratori, partner e clienti. Il Fuel Voucher garantisce importanti vantaggi fiscali: è deducibile al 100%; è esente da IVA (art 2 D.P.R. 633/1972); se acquistato per il dipendente, non concorre a formare il reddito di lavoro o fino a 1.000 euro all’anno e fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico; quando costituisce omaggio aziendale a clienti e fornitori, è deducibile secondo le regole previste per la deducibilità delle spese di rappresentanza (Decreto Legge 112/2008).
Grazie alla collaborazione con BeProf è possibile acquistare i buoni con uno sconto direttamente dalla piattaforma.


In cerca di idee per un regalo a collaboratori, dipendenti o amici? Con BeProf ti basta essere registrato per avere accesso gratuito alla Piattaforma Convenzioni, ovvero i Corporate Benefits di Generali-Welion. Ogni mese hai a disposizione nuove e vantaggiose offerte riservate ai professionisti, ai dipendenti e collaboratori con sconti su prodotti e servizi di marche prestigiose. L’accesso alla Piattaforma Convenzioni è sempre gratuito, all’interno puoi trovare i codici sconto a te riservati per ottenere immediatamente promozioni esclusive per il tuo shopping, online o in negozio. I vantaggi? Sconti esclusivi forniti direttamente dalle società produttrici o dai partner commerciali premium; l’acquisto diretto e nessuna intermediazione tra l’utente e il fornitore di prodotti e servizi; il massimo rispetto della normative privacy; offerte disponibili in ogni momento e da qualsiasi dispositivo e nessun onere amministrativo/costi/obblighi.
Apri Formazione è lo strumento operativo di Confprofessioni per la formazione e ha lo scopo di assistere i professionisti nel fronteggiare le sfide dettate dalle trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali attraverso lo sviluppo di competenze. Apri Formazione progetta e gestisce corsi di formazione e progetti finanziati e si avvale delle strutture del Sistema Confprofessioni per monitorare in modo efficace i fabbisogni del mondo delle libere professioni. In particolare attraverso l’Osservatorio delle libere professioni, l’organismo di Confprofessioni per la produzione di studi, ricerche, rapporti ricorrenti sulle trasformazioni in corso nel vasto mondo delle libere professioni. La continua interazione con gli stakeholder e con le diverse associazioni di professionisti della Confederazione consente di anticipare i fabbisogni del mondo delle libere professioni, di cogliere le opportunità di crescita e di divulgare le buone pratiche sviluppate nei territori. Grazie a BeProf puoi ottenere sconti esclusivi sul catalogo di Apri Formazione - Sconto 25% per gli iscritti a BeProf e Sconto 50% per gli iscritti a BeProf e in copertura con Gestione Professionisti.



Com’è lontana l’Europa dei diritti e della protezione sociale, della crescita sostenibile e inclusiva, del dialogo e della solidarietà. Pilastri scolpiti nel Dna dei trattati europei, che oggi vacillano paurosamente sotto il peso dei diktat protezionistici e della diplomazia delle armi. Dopo oltre 30 dal trattato di Maastricht, l’Unione europea è una potenza globale in balia dei venti di una involuzione economica e sociale che soffia da lontano. Costretta a inseguire cigni neri, senza la capacità di affermare la propria influenza nelle connessioni multilaterali che regolano il pianeta. Tutto questo ha un costo: circa 2 mila miliardi di euro, fissati nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034, presentato a metà luglio da Ursula von der Leyen. Una somma minima che spalmata sui prossimi sette anni si ridimensiona a 285 miliardi per anno, poco più di un terzo del bilancio annuale dell’Italia.
Non è, dunque, la dimensione del bilancio complessivo Ue - coperto per tre quarti dai contributi dei governi nazionali e da nuove tasse imposte da Bruxelles - quanto la distribuzione delle risorse a impressionare. Il nuovo quadro finanziario è figlio di un’Europa condizionata dalle tensioni geopolitiche internazionali e dal braccio di ferro sui dazi con Trump. Ed è in questo collo di bottiglia che la Commissione Ue ha ridisegnato pesi e contrappesi delle risorse, puntando sulla competitività dell’industria e sulle capacità della difesa, a scapito di una visione sostenibile e inclusiva dell’economia e della coesione sociale. Per dare spazio al rafforzamento difensive dell'Unione, si trascurano i settori tradizionali dell’economia. Il ridimensionamento e la riunificazione dei fondi per la coesione e la politica agricola in un unico programma integrato, per esempio, è la dimostrazione plastica dell’ennesimo cambio di rotta di una politica ambivalente, sempre più lontana dai territori e dai cittadini europei. POST SCRIPTUM