PRIMO PIANO
Occupazione su, produttività giù.
Paradosso italico

PROFESSIONI Senza competenze
CULTURA Angoli di Giappone in Italia

PRIMO PIANO
Occupazione su, produttività giù.
Paradosso italico

PROFESSIONI Senza competenze
CULTURA Angoli di Giappone in Italia
PER LEGGERE L’ARTICOLO
(clicca sul titolo dell’articolo per accedere ai link)
Gennaio 2027, l’ultima goccia di Matteo Durante
A metà del guado di Francesca Coniglio
Un patto blu per la sostenibilità di Pietro Francesco de Lotto
Agricoltura, le nuove frontiere di Alessandra Pesce
La sete della terra di Andrea Sonnino
La resilienza del territorio di Antonio Urbano
PRIMO PIANO
Occupazione su, produttività giù. Paradosso italico di Claudio Negro
Salari, andamento lento di Jacopo Sala
Donald non veste Prada di Carlo Bertotti
La Turchia tra polarizzazione e prove di forza di Valeria Giannotta
Senza competenze di Franco Valente
Un tagliando per i Fondi di Mario Rossi
L’evoluzione del lavoro nei nuovi codici Ateco di Isabella Colombo
Quando l'avvocato
portava la parrucca di Giampaolo Di Marco
Un giorno tutte le mie password saranno tue di Diego Apostolo
Lunga vita alle discipline umanistiche di Emanuela Griglié
Ritorno al passato di Simona Laderchi
Fisco, slalom tra vantaggi e criticità di Riccardo Conti
Il premio Dedalo Minosse di Bruno Gabbiani
Giovani commercialisti in cattedra di Francesco Cataldi e Serena Giannuzzi
Angoli di Giappone in Italia di Romina Villa
Sei scrittori, sei abitanti, sei racconti. E la magia di Procida di Maria Teresa Pasceri
Avrò cura di te di Roberto Carminati
L’Editoriale
di Marco Natali
News From Europe a cura del Desk europeo di ConfProfessioni
Pronto Fisco
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi
Welfare e dintorni
Un libro al mese di Luca Ciammarughi
Recensioni di Luca Ciammarughi
In vetrina in collaborazione con BeProf
Post Scriptum di Giovanni Francavilla




Laureata in legge all’Università “La Sapienza” di Roma con conseguimento dell’abilitazione professionale di avvocato, è dirigente presso l’Ufficio DISR 1 del MASAF. Il settore di competenza comprende le attività di Programmazione e gestione delle iniziative progettuali nel settore delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale. Nel 2023 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento del servizio di valutazione PSRN, mentre nel 2024, in rappresentanza del Masaf, è stata nominata componente dei Comitati Tecnico Amministrativi dei Provveditorati OO.PP. di Piemonte e della Valle D’Aosta, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, di Lombardia e Emilia – Romagna, Liguria. Infine, sempre nel 2024 è stata nominata componente della Conferenza Operativa delle Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po.
Presidente della Commissione Consultiva per i mutamenti Industriali (CCMI), ricopre la carica di consigliere del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), è membro delle Commissioni esteri e Mercato interno e ha ricoperto diversi ruoli tra cui quello di Presidente del Eastern Neighbourgh Follow-up Committee. Economista di formazione ha studiato Economia Internazionale e Economia e Politica dell’Integrazione Europea, è stato professore aggregato in Economia Internazionale all’Università di Trieste ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e advisor in progetti pubblici nazionali, regionali e camerali. Fino al 2020 è stato direttore generale di Confartigianato Vicenza e componente del board di Camere di Commercio e di società di gestione pubbliche.
Accademica esperta di relazioni internazionali e politica turca. È delegata di PLP (Psicologi liberi professionisti) per le relazioni internazionali e membro del CdA di Apri International. Direttore scientifico dell'Osservatorio Turchia del CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale), dal 2009 Giannotta è attiva in Turchia come ricercatrice e docente a Istanbul, Gaziantep, Ankara. È anche direttore del centro studi dell'Unione dei Consoli Onorari in Italia (UCOI). Quale autrice di numerosi articoli presentati a convegni nazionali ed internazionali. Per l’obiettività di analisi e l'impegno a sostegno della diplomazia italiana in Turchia, Valeria Giannotta è insignita dell’onore di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia dalla Presidenza della Repubblica Italiana.
Direttrice il Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia, del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Economia Agraria (CREA). Si occupa della definizione, monitoraggio e valutazione di politiche di sviluppo in campo agroalimentare. Ha pubblicato monografie e articoli sul sistema agroalimentare ed è chiamata come esperta su tavoli internazionali. Possiede il Dottorato di Ricerca in “Istituzioni, Ambiente e Politiche per lo Sviluppo Economico”. È stata Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo nel Governo Conte I, con deleghe inerenti la ricerca, l'innovazione il trasferimento tecnologico e la formazione in campo agroalimentare nonché tematiche su specifici comparti produttivi e iniziative nelle aree rurali e interne.
«Il
lavoro che stiamo portando avanti punta a recuperare ritardi del passato e a rendere il settore primario più resiliente di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici. Innovazione tecnologica, buone pratiche e soluzioni efficaci saranno sempre più importanti nel contribuire a una gestione più efficiente e razionale della risorsa idrica».
— Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato per l’Agricoltura, la Sovranità alimentare e le Foreste



Già segretario Uil Como e Lombardia, ha ricoperto inoltre per l’Unione Italiana del Lavoro anche il ruolo di responsabile confederale per le politiche industriali e i rapporti con le istituzioni. Attualmente collabora con il Centro Studi Itinerari Previdenziali e con la Fondazione Anna Kuliscioff, per la quale cura, tra le varie pubblicazioni, anche un Osservatorio periodico su andamenti e dinamiche del mercato del lavoro.
Laureato in Banca, Finanza e Mercati presso l’Università degli Studi di Foggia, con un focus specifico sugli strumenti di gestione del rischio in ambito agricolo. Dottorando di Ricerca in Economics and Finance of Territorial Sustainability and Well-being, presso lo stesso Ateneo, con una ricerca incentrata sul contributo strategico e multifunzionale dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione alla resilienza e alla competitività del sistema agroalimentare nazionale. È attualmente Collaboratore dell’Area Agronomica e Ambientale di ANBI - Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela dei territori e delle acque irrigue – con sede a Roma. Forte del legame con il territorio di origine, conduce l’azienda agricola di famiglia specializzata nella cerealicoltura.
Il Libero Professionista
Mensile digitale di informazione e cultura
direttore responsabile
Giovanni Francavilla
redazione
Nadia Anzani, Mario Rossi
hanno collaborato
Diego Apostolo, Carlo Bertotti, Lelio Cacciapaglia, Roberto Carminati, Francesco Cataldi, Luca Ciammarughi, Isabella Colombo, Francesca Coniglio, Riccardo Conti, Giampaolo Di Marco, Matteo Durante, Bruno Gabbiani, Valeria Giannotta, Serena Giannuzzi, Emanuela Griglié, Simona Laderchi, Claudio Negro, Maria Teresa Pasceri, Alessandra Pesce, Jacopo Sala, Andrea Sonnino, Maurizio Tozzi, Antonio Urbano, Franco Valente, Romina Villa
segreteria di redazione
Miriam Minopoli
comitato editoriale
Roberto Accossu, Salvo Barrano, Paola Cogotti, Carmen Colangelo, Alessandro Dabbene, Luigi Alfredo Carunchio, Andrea Dili, Paola Fiorillo, Raffaele Loprete, Marco Natali, Maria Pungetti, Dominella Quagliata, Ezio Maria Reggiani, Gioele Semprini Cesari
redazione
Via Boccaccio, 11 – 20121 Milano
contatti
Tel. 02 36692133 Fax 02 25060955 redazione@illiberoprofessionista.it info@illiberoprofessionista.it
editore
Lp Comunicazione Srl, Via Boccaccio, 11 – 20121 Milano
Registrazione Tribunale di Milano n. 118 del 24/02/2011
progetto grafico e impaginazione Pianeta.Studio Srl Società Benefit di Massimiliano Mauro info@pianeta.studio | @pianeta_studio
Designer Francesca Fossati
disclaimer I contenuti e le informazioni contenute ne il Libero Professionista sono sottoposti ad un accurato controllo da parte della redazione, nel rispetto dei principi di deontologia professionale vigenti in materia giornalistica. Tuttavia, il Libero Professionista declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti in merito a eventuali danni che possano derivare da possibili errori o imprecisioni dei contenuti.
Il Libero professionista può contenere collegamenti ipertestuali (link) verso altri siti di proprietà di soggetti diversi da il Libero Professionista e declina ogni responsabilità riguardo il contenuto di questi siti o l’uso delle informazioni raccolti dagli stessi.
Tutti i contenuti de il Libero Professionista possono essere utilizzati, a condizione di citare sempre il Libero Professionista come fonte ed inserire un link o collegamento ben visibile a https://confprofessioni.eu/ il-libero-professionista-reloaded/.
© Il Libero Professionista • All rights reserved 2024


di Marco Natali
TNUMERO
re gesti per un solo messaggio, una sola fondamentale lezione: portare a termine il proprio compito, anche se malati, anche se sofferenti. E’ il testamento spirituale che ci ha lasciato negli ultimi drammatici giorni Papa Francesco. Il ritorno a Santa Marta dal policlinico Gemelli, l’insistenza per incontrarne – qualche giorno dopo - il personale e infine il saluto alla sua gente, al suo popolo riunito in piazza San Pietro. C’è poi un quarto gesto, quel “ciao” – come ci raccontano le cronache private - accennato al suo infermiere pochi secondi prima di spirare. Tutto era stato fatto, le persone importanti salutate, il magistero portato a compimento. E’ qui, in questi gesti finali, che è racchiusa una lezione definitiva: quella di adempiere al nostro compito, il senso della responsabilità, il nucleo più profondo del nostro passaggio sulla terra, il fatto di esserci fino alla fine. Bergoglio è stato un personaggio ingombrante, talvolta anche contestato come è logico che sia per chi anche dallo scranno più alto della Chiesa cattolica parla ai potenti della terra. Lo aveva fatto Francesco anche con i professionisti, aveva parlato loro, in un discorso sul lavoro che ha fatto scuola. “Dal vostro osservatorio professionale, voi vi rendete ben conto della drammatica realtà di tante persone che hanno un'occupazione precaria, o che l'hanno perduta; di tante famiglie che ne pagano le conseguenze; di tanti giovani in cerca di un primo impiego e di un lavoro dignitoso”, aveva detto il Papa nel 2014. “In questo contesto è più forte la tentazione di difendere il proprio interesse senza preoccuparsi del Bene Comune, senza badare troppo alla giustizia e alla legalità – aveva proseguito Bergoglio -. Perciò è richiesto a tutti, specialmente a quanti esercitano una professione che ha a che fare con il buon funzionamento della vita economica di un Paese, di giocare un ruolo positivo, costruttivo, nel quotidiano svolgimento del proprio lavoro, sapendo che dietro ogni carta c'è una storia, ci sono dei volti”. Queste parole racchiudono il senso profondo del nostro impegno di avvocati, medici, notai, ingegneri e di tutti i professionisti. Dietro a ogni carta c’è una storia e noi lo sappiamo. Facciamo in modo di non dimenticarlo.
I fatti, le analisi e gli approfondimenti dell’attualità politica ed economica in Italia e in Europa. Con un occhio rivolto al mondo della libera professione




Con un prelievo annuo superiore ai 9 miliardi di metri cubi, l’Italia si conferma al vertice europeo per consumo di acqua potabile, anche se il 42% dell’acqua immessa in rete si disperde. Questo il quadro che emerge dalla recente relazione della Corte dei Conti. Ma la vera sfida è aumentare la captazione, soprattutto nelle zone soggette a siccità, perché il fabbisogno agricolo è enorme. Come dice il consigliere Gian Luca Calvi
Gennaio 2027: questa è la data da circoletto rosso sul calendario idrico nazionale. A fine del 2026, infatti, si chiuderanno i rubinetti del Pnrr e in Italia si porrà un’importante questione: che fare, per continuare a ottimizzare il prelievo, la rete, la distribuzione d’acqua per le case private, le industrie, gli allevamenti, le aziende agricole di tutto il territorio italiano? Ecco l’interrogativo che nasce dopo aver letto la relazione della Corte dei Conti, approvata con delibera n. 4/2025, che ha acceso i riflettori sulla "Mitigazione dei danni connessi alla siccità attraverso il miglioramento della rete distributiva e dell’approvvigionamento idrico".
«Gli elementi fondamentali di questa indagine», commenta Gian Luca Calvi, consigliere della Corte e autore - con la collaborazione di Carole Amalia Di Ruberto - della relazione: «trovano concordi tutti gli operatori del settore. La fotografia che abbiamo scattato è una buona base di partenza, da consegnare al decisore politico perché faccia le sue scelte». E l’immagine che la relazione restituisce è quella di un sistema idrico nazionale ancora lontano dalla piena efficienza. Secondo i dati riportati, nel nostro Paese, il prelievo di acqua nell’anno 2022, l’ultimo preso in considerazione, è stato superiore ai 9 miliardi di metri cubi, per un prelievo giornaliero di 25 milioni (pari a 424 litri pro capite). Questi numeri dicono che l’Italia si conferma al vertice europeo per consumo di acqua potabile, tuttavia, il volume erogato corrisponde alla metà (4,6 miliardi) del prelievo, a causa delle perdite nel trattamento di potabilizzazione (1 miliardo) e per l’inefficienza della distribuzione in cui viene sprecato circa il 40% del quantitativo immesso in rete (3,4 miliardi). Questa inefficienza è attribuibile a infrastrutture obsolete, guasti frequenti nelle condotte
e pratiche gestionali non all’altezza. Secondo la relazione, regioni come Sardegna, Sicilia e Basilicata registrano perdite superiori al 50%, evidenziando una gestione frammentata e incapace di affrontare le sfide odierne.
La situazione non è solo un problema di sostenibilità ambientale, ma anche di entrate e opportunità economica. Chiarisce Calvi: «Dobbiamo distinguere i due piani. Quando parliamo di mancanza d’acqua, non ci riferiamo più solo alla risorsa idropotabile, ma alla sua disponibilità in generale, al suo reperimento. A ben guardare, il fabbisogno idrico nazionale è così suddiviso: il 20% va al consumo potabile, oltre il 50% all’agricoltura e all’allevamento, mentre poco meno del 30% è destinato all’industria». Questo richiede investimenti significativi per infrastrutture in grado di

aumentare la capacità di captazione e per affrontare, per esempio, il problema non più trascurabile delle dighe. «Quelle oggi attive possono contare su una capacità di raccolta di circa la metà rispetto a quando sono state costruite, perché c’è stato l’accumulo del sedime che si consolida e alza il livello di fondo della diga rendendola meno capiente. Per risolvere la situazione, anche stando al parere degli esperti da noi interpellati, occorre indire nuovi bandi perché è più conveniente costruire nuovi invasi che intervenire sul sedime ormai cementato al fondo della diga» continua Calvi, sottolineando l’urgenza di investimenti nuovi, piuttosto che interventi sui bacini esistenti.
IL NODO DELLA GOVERNANCE
Altra questione cruciale nella gestione del sistema idrico nazionale, è quella della catena di comando. Sulla scorta della


direttiva europea sulle acque (2000/60/ Ce) e della norma di recepimento della stessa (d.lgs. n. 152/2006), il prelievo e il trattamento delle acque si fonda su una governance multilivello, con tre ministeri interessati, e sulla disciplina del servizio idrico integrato, prevista, e non ancora completamente attuata, dalla cosiddetta legge Galli degli Anni ‘90. Spiega Calvi: «Anche qui dobbiamo distinguere tra captazione e distribuzione. Per il primo aspetto, sono tre i dicasteri che si occupano della materia: il Ministero delle infrastrutture per le acque bianche; il Ministero dell’ambiente per le acque reflue e il Ministero dell’agricoltura che si occupa di investimenti nel settore. Questo rende il sistema articolato, ma allo stesso tempo frammentato». Anche l’Arera, autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha un ruolo cruciale nel definire le tariffe e nel controllo delle attività del settore. «Per il sistema distributivo, anche in Italia,
dalla fine degli Anni ‘90 il sistema idrico integrato, che ci ha messo in linea con gli altri Paesi dell’Europa, ogni area, ogni provincia, ha un proprio gestore locale». Ma la relazione della Corte dei Conti sottolinea come il principio del “full cost recovery” - ovvero il recupero integrale dei costi attraverso le tariffe - non sia ancora pienamente applicato. Attualmente, a fronte di un fabbisogno stimato di 6 miliardi di euro all’anno, le entrate tariffarie si attestano intorno ai 4 miliardi.
PRIORITÀ STRATEGICHE VERSO IL 2027
Guardando a domani, una delle priorità principali è ridurre le sanzioni europee legate alla gestione inadeguata delle acque reflue. Commenta Calvi: «L’Italia paga ogni anno multe all’Europa per le infrazioni relative alla depurazione delle acque. Questo è un ambito che richiede investimenti immediati». Parallelamente, occorre pianificare interventi strutturali
PRELIEVI DI ACQUA DOLCE(*) PER USO POTABILE PER TIPOLOGIA DI FONTE UE 27.
Anno 2022 o ultimo disponibile
(*) Nell'analisi non rientrano le acque marine o salmastre prelevate a scopo idropotabile
Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile.
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati istat, censimento delle acque per uso civile
per ottimizzare l’efficienza della rete distributiva e aumentare la disponibilità di risorse idriche. Secondo la relazione, sono attualmente in corso 628 interventi finanziati con i fondi del Pnrr e altre risorse, per un totale di 5,3 miliardi di euro. Di questi, 3,7 miliardi sono destinati alla sicurezza dell’approvvigionamento idrico, alla riduzione delle perdite nelle reti, alla digitalizzazione e al monitoraggio.
Resta, come detto, la domanda cruciale: e nel 2027, quando si concluderà l’impiego dei fondi del Pnrr? Calvi sottolinea l’importanza di non sprecare gli investimenti fatti finora: «Abbiamo fotografato una situazione migliorata rispetto al passato, ma per colmare il gap idrico servono scelte politiche strategiche. E non soltanto in Italia ma anche in Europa». Tra le possibili soluzioni, emerge la necessità di una revisione delle tariffe idriche e di nuovi strumenti di finanziamento per coprire il fabbisogno stimato. Un esempio significa-
tivo riguarda il settore agricolo, che utilizza oltre il 50% delle risorse idriche disponibili. «Rendere il sistema distributivo più efficiente è fondamentale, ma non basta. La vera sfida è aumentare la captazione, soprattutto nelle zone soggette a siccità, perché il fabbisogno agricolo è enorme.
E senza un aumento della capacità di captazione, non riusciremo mai a soddisfarlo completamente, neanche con una rete distributiva pienamente efficiente». spiega Calvi. «La desalinizzazione dell’acqua marina, già adottata in altri Paesi, potrebbe rappresentare una soluzione, ma richiede investimenti significativi e una pianificazione a lungo termine. Tuttavia porre l’attenzione soltanto sulla dispersione della rete distributiva rischia di essere ingannevole, perché ammettendo di raggiungere il massimo dell’efficienza nella rete distributiva non avremo comunque risolto la nostra esigenza di approvvigionamento idrico». ■
di Francesca Coniglio
Negli ultimi anni il Masaf ha investito parecchie risorse per l’efficientamento delle infrastrutture irrigue come misura di contrasto alla scarsità idrica. Tuttavia, restano ancora numerosi interventi da mettere in campo per migliorare l’accumulo di acqua, efficientare e digitalizzare le reti irrigue


Negli ultimi quattro decenni, tra il 30% ed il 40% della popolazione italiana è stata esposta a condizioni di siccità severa o moderata1. I più recenti fenomeni siccitosi (2017 e 2022) hanno colpito duramente anche le regioni del Nord Italia, storicamente ricche di acqua, mentre tuttora e ininterrottamente da molti mesi le Regioni del Sud Italia, tra cui Puglia, Sicilia, Sardegna, stanno sperimentando una scarsità di acqua tale da pregiudicare la prossima stagione irrigua, dovendo destinare le poche risorse accumulate negli invasi all’uso potabile, che è prioritario.
In questo contesto, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) ed in particolare la Direzione generale per lo Sviluppo Rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sostiene gli investimenti necessari a garantire l’uso efficiente dell’acqua lungo tutta la catena di approvvigionamento idrico, ed in particolare sulle grandi reti infrastrutturali di
irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale nell’ambito del servizio di irrigazione collettiva svolto dai consorzi irrigui e di bonifica. La competenza alla programmazione e al finanziamento di queste opere è integrata e coordinata con quella del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) in materia di infrastrutture idriche a scopo promiscuo irriguo, potabile ed idroelettrico, oltre che essere esercitata nell’ambito delle strutture nazionali di coordinamento istituite per fronteggiare la crisi idrica. Il decreto siccità2 emanato dal Governo ad aprile 2023, ha infatti istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica (a cui anche il Masaf partecipa insieme agli altri ministeri competenti3) e un Commissario straordinario nazionale, con il compito di individuare e adottare interventi urgenti per il contenimento e contrasto degli effetti della siccità.

SOS EFFICIENTAMENTO
Negli ultimi dieci anni il Masaf ha adottato una politica di investimento per l’ammodernamento delle infrastrutture irrigue di accumulo e trasporto dell’acqua, per garantire l’approvvigionamento di acqua e il suo uso efficiente e supportare, dunque, la sostenibilità e la produttività del settore irriguo. Questa strategia è stata attuata attingendo alle risorse programmate su vari fondi nazionali e comunitari assegnati al Masaf, a partire dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 e dal Piano Sviluppo e Coesione. Ulteriori investimenti irrigui extra aziendali e collettivi sono stati finanziati con le risorse nazionali messe a disposizione dalle leggi di bilancio che tra il 2016 e il 2020 hanno sostenuto gli investimenti strategici per il rilancio del Paese. Una misura dedicata è stata programmata anche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), contribuendo all’obiettivo della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” ed in particolare della Componente 4 rivolta alla “Tutela del territorio e del patrimonio idrico”. Tutte le linee di finanziamento sono state orientate a finanziare interventi in grado di migliorare l’efficientamento delle infrastrutture idriche gestite dagli enti irrigui attraverso il “miglioramento della gestione della risorsa idrica”, promuovendo la misurazione e il monitoraggio degli usi sulle reti collettive, con l’installazione di misuratori e sistemi di telecontrollo, e “l’ammodernamento delle reti irrigue collettive” per ridurre le perdite delle reti idriche esistenti, individuando nel risparmio idrico indotto dagli interventi il punto di contatto tra produttività e sostenibilità.
Nel complesso, a partire dal 2018, sono stati finanziati, o sono in corso di finanziamento, 279 progetti in capo agli enti irrigui di tutte le Regioni e Province Autonome per complessivi 2,2 miliardi di euro. Le risorse

note
1 Audizione del Commissario Straordinario Nazionale - VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici del 12 marzo 2024.
2 DL 39/2023 convertito in legge 68/2023 recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”.
3 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze nonché' dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato.
DISTRIBUZIONE PER REGIONE DEI FINANZIAMENTI MASAF (2018-2024)
Valle d'Aosta 2 interventi 22,3 mln €
Lombardia 16 interventi 127,3 mln €
Piemonte 18 interventi 210 mln €
Liguria 1 intervento 3,9 mln €
Toscana
11 interventi 107,7 mln €
Umbria 6 interventi 23,9 mln €
Lazio 18 interventi 76,3 mln €
Sardegna 12 interventi 54,9 mln €
Trentino-Alto Adige
13 interventi 82,7 mln €
Campania 22 interventi 200,4 mln €
Molise
3 interventi 23,4 mln €
assegnate sono state intercettate diversamente sul territorio nazionale, per il 61% al Centro Nord e il 39% al Sud e Isole. I progetti finanziati hanno riguardato prevalentemente (circa il 73% importo assegnato) l’ammodernamento delle reti irrigue, mentre solo poco più del 6% dei finanziamenti è stato dedicato all’incremento delle fonti idriche (invasi e riuso reflui).
Alcuni dei progetti finanziati sono stati completati e sono in via di messa in esercizio. La maggior parte degli interventi finanziati sono, tuttavia, in corso di realizzazione e sono, quindi, ancora suscettibili di espletare il loro effetto sullo stato delle acque, grazie alla messa in opera di azioni strutturali per il miglioramento del sistema irriguo ai fini del risparmio e dell’uso efficiente della risorsa idrica. Il Masaf monitora costantemente l’impatto atteso dagli interventi sulla base delle informazioni aggior-
Friuli-Venezia Giulia 16 interventi 85 mln €
Veneto 30 interventi 245,6 mln €
Emilia-Romagna 34 interventi 326 mln €
Abruzzo 6 interventi 37,7 mln € Marche 3 interventi 33,3 mln €
Puglia 10 interventi 55,8 mln €
Basilicata 10 interventi 99,2 mln €
Sicilia 15 interventi 144,6 mln €
Calabria 33 interventi 259,6 mln €
nate nel tempo da parte dei beneficiari nelle banche dati Dania⁴ e Sigrian⁵, realizzate e gestite dal Centro di ricerca Politiche e bioeconomia del Crea su input e supporto del Masaf e messe a disposizioni di tutti gli attori istituzionali competenti alla programmazione e gestione dell’acqua irrigua. Tale monitoraggio restituisce una stima⁶ di circa 994 milioni di metri cubi di risparmio idrico per ogni stagione irrigua, pari a oltre 7 volte la capacità di invaso di una diga di dimensioni medio/grandi (ad esempio la diga di Montedoglio in provincia di Arezzo) o di quasi 4 mila piccoli invasi al di sotto dei 250 mila mc. Le opere finanziate interverranno su oltre 9 mila chilometri di rete, per lo più ammodernando la rete esistente piuttosto che prevedere nuove realizzazioni, contribuendo ad efficientare l’uso dell’acqua irrigua su 1,3 milioni di ettari di superficie attrezzata collettiva nazionale. I finanziamenti daranno un im-
portante contributo alla conoscenza della quantità di acqua prelevata ed utilizzata dal momento che consentiranno l’installazione di 405 nuovi misuratori alle fonti di prelievo e di oltre 58 mila misuratori lungo la rete di distribuzione.
Oltre ad agire sull’approvvigionamento idrico collettivo, il Masaf sostiene l’uso sostenibile dell’acqua e l’innovazione anche al livello aziendale, attraverso le misure del Piano strategico della PAC. Inoltre, con “l’Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” sostiene l’introduzione di sistemi di gestione intelligente dell’irrigazione per efficientare l’uso delle risorse idriche e quindi di promuovere il risparmio idrico. In quest’ultimo caso è previsto il supporto all’installazione di sensori per la misura delle caratteristiche del suolo e delle variabili meteorologiche, nonché l’utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua di precisione.
PROSPETTIVE DI INTERVENTO
All’esito di questo sforzo collettivo sussiste tuttavia un importante fabbisogno di intervento per l’ammodernamento del sistema irriguo nazionale verso il pieno raggiungimento dell’efficienza irrigua e della resilienza ai cambiamenti climatici. Ad oggi il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (Pniissi)⁷ rappresenta il principale strumento di pianificazione di infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento idrico, di medio-lungo periodo, attuabile per stralci successivi in funzione delle risorse finanziarie progressivamente disponibili. Tra i 418 interventi individuati dal Pniissi per circa 12 miliardi di euro, 36 progetti esecutivi per circa 525 milioni rientrano nella sfera di competenza del Masaf privi al momento di copertura economica non essendo state assegnate risorse. ■ note
4 Database Nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e l'Ambiente (https://dania.crea. gov.it/)
5 Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (https:// sigrian.crea.gov.it/).
6 Dati DANIA a novembre 2024.
7 Derivante dalla reimpostazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico a seguito della Riforma 4.1 della M2C4 del PNRR attuata nel 2021 in capo al MIT («Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico»)
994 MLN di mc di risparmio idrico
405 nuovi misuratori al prelievo
9.000 KM rete oggetto di intervento
1,3 MLN di area efficientata
Fonte: elaborazioni CREA su dati DANIA, novembre 2024
Il 20% del territorio europeo è colpito da stress idrico e quasi dieci milioni di persone in Europa non hanno accesso ad acqua potabile. Nel 2023 il Cese ha lanciato la proposta EU Blue Deal, perché il problema dell’acqua non è solo ambientale, ma coinvolge tutte le politiche europee
Secondo le stime dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), circa il 20% del territorio europeo è colpito da stress idrico durante un anno medio. Inoltre, quasi dieci milioni di persone nel nostro continente non hanno ancora accesso ad acqua potabile sicura. Questo è inammissibile, poiché l’acqua è una risorsa insostituibile e fondamentale per raggiungere gli obiettivi politici dell’Unione europea.
Il Comitato economico e sociale europeo (Cese) è stato il primo organo dell’Unione a riconoscere la necessità urgente di affrontare la crisi idrica globale e a mettere il tema al centro dell’agenda politica europea. Attraverso la proposta per un EU Blue Deal, un Patto Blu europeo, il Comitato ha promosso una strategia ambiziosa e integrata per rendere la gestione sostenibile dell’acqua una priorità trasversale in tutte le politiche dell’Ue.
UNA PRIORITÀ STRATEGICA
La dichiarazione per un EU Blue Deal, presentata nell’ottobre del 2023, illustra 15 principi e 21 azioni concrete per affrontare le sfide legate all’acqua che abbiamo di fronte. L’approccio del Cese è trasversale e include la protezione dei mari e degli oceani, ma il fulcro e la novità del Patto Blu europeo è la tutela dell’acqua dolce e il raggiungimento di una gestione sostenibile delle risorse idriche per la società. Fin dall’inizio, il Cese sostiene la necessità di affrontare i problemi legati all’acqua con lo stesso livello di determinazione riservato alla decarbonizzazione.
La politica dell’acqua non può limitarsi a una politica unicamente ambientale; è necessario affrontare la questione in tutte le politiche europee, dall’industria all’agricoltura, dalle infrastrutture e l’edilizia, fino alle politiche sociali e dei consumatori. Il Comitato continua a chiedere il riconoscimento dell’acqua come una priorità

strategica e un coordinamento tra i portafogli dei Commissari europei per garantire l’integrazione della resilienza idrica nelle principali politiche europee.
L’APPOGGIO DELLE NAZIONI UNITE
Negli ultimi due anni, l’appello lanciato dal Comitato ha ricevuto il supporto di numerosi Stati membri e di altre organizzazioni internazionali come il Comitato Europeo delle Regioni e le Nazioni Unite.
Inoltre, moltissimi rappresentanti della società civile, industrie, agricoltori e Ong hanno contribuito a rafforzare il messaggio e spinto la Commissione europea ad agire. Abbiamo ottenuto risultati importanti. Per la prima volta è stata nominata
La balena di Bruges (Belgio) realizzata con 5 tonnellate di rifiuti di plastica
una Commissaria per l’Ambiente, la Resilienza Idrica e un’Economia Circolare Competitiva, Jessika Roswall. Inoltre, la Strategia per la Preparazione Civile e Militare dell’UE e la Visione per l’Agricoltura e l’Alimentazione, pubblicate di recente, riconoscono le sfide legate all’acqua.
OBIETTIVI
Nonostante alcuni passi promettenti, molti principi e azioni proposte nel Patto Blu europeo devono ancora essere raggiunti.
A questo proposito, il Clean Industrial Deal dedica uno spazio marginale all’acqua e questo rischia di essere una mancata opportunità per lo sviluppo di tecnologie innovative. Nelle prossime settimane, la Commissione presenterà la propria Strategia Europea, che si propone di essere l’iniziativa più importante sul tema dell’acqua di questo mandato. Il Cese e tutte le parti interessate hanno aspettative elevate per questa iniziativa, che dovrà avere il giusto livello di ambizione e fornire strumenti adeguati ad affrontare le sfide che l’Europa ha di fronte.
Il Comitato continuerà a lavorare per integrare la resilienza idrica in tutti in tutti gli ambiti seguendo un approccio settoriale, per realizzare azioni concrete e necessarie. Uno dei temi chiave riguarda la raccolta dati. In questo momento, in Europa c’è una carenza di dati e di coordinamento sulle pratiche di misurazione rispetto all’uso dell’acqua da parte delle industrie e delle famiglie.
In confronto alle politiche messe in atto per misurare il consumo energetico, il nostro continente è fortemente in ritardo sull’acqua. Misurare i consumi è fondamentale per formulare politiche informate. Inoltre, il Cese ritiene che l’acqua sia fondamentale per la competitività dell’economia europea. L’Ue deve assicurare

l’accesso all’acqua pulita e a costi accessibili per tutti, promuovendo al contempo lo sviluppo di un mondo più resiliente alle crescenti sfide. Gli investimenti nelle infrastrutture sono cruciali per contrastare le perdite (che ammontano al 25% del totale in media in Ue), digitalizzare il settore idrico e ottimizzare l’uso delle risorse.
Inoltre, il rafforzamento del settore delle tecnologie idriche, nell’ambito delle tecnologie pulite, contribuirà a creare nuovi posti di lavoro e a consolidare la leadership europea.
Una strategia globale dell’Ue in materia di acqua necessita di un quadro di finanziamenti altrettanto ambizioso. L’acqua dovrebbe essere riconosciuta come una priorità strategica nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale post-2027. Il Cese sostiene la creazione di un Blue Transition Fund che possa essere usato come pun-

to di accesso unico per gli investimenti idrici a livello dell’Ue, combinando gli investimenti pubblici con finanziamenti innovativi.
In aggiunta, l’uso sostenibile dell’acqua e la condizionalità in materia di risorse idriche dovrebbero diventare dei criteri in tutti i fondi dell’Ue, compresi i finanziamenti per la Politica Agricola Comune e i fondi di coesione, facilitando gli investimenti per la transizione del settore.
Il coinvolgimento della società civile e degli esperti in ogni Paese europeo è fondamentale per arrivare all’obiettivo.
Le istituzioni europee dovrebbero unire le forze insieme al Cese per stabilire una piattaforma consultiva che coinvolga tutte le parti interessate, per condividere buone pratiche, elaborare misure specifiche per favorire l’efficienza idrica, e promuovere un aggiornamento periodico dei piani d’azione sull’acqua. ■


La gestione delle risorse idriche in agricoltura gioca un ruolo fondamentale per garantire la qualità e la quantità degli alimenti e far fronte al fabbisogno di una popolazione mondiale in crescita. Da qui la necessità di proporre iniziative e sostenere investimenti per ottimizzarne l’uso. Fabbisogni, risorse e prospettive secondo il Crea

Dissetarsi e nutrirsi. Parlare di acqua significa parlare di vita e del soddisfacimento di bisogni primari. Ed è nella produzione del cibo che l’acqua gioca un ruolo fondamentale, divenendo uno dei principali fattori per garantire la quantità di alimenti in grado di rispondere alle crescenti esigenze legate all’incremento della popolazione mondiale. Ma non solo.
Il settore agroalimentare genera ricchezza e lavoro, contribuisce alla gestione del territorio e alla tutela delle risorse, assumendo – quindi – un ruolo che va oltre la sola garanzia di approvvigionamento di cibo. Questo è ancora più vero nel nostro Paese, dove la superficie irrigata copre circa un quinto della superficie destinata alle coltivazioni e l’agricoltura è la principale utilizzatrice con oltre il 41% dei prelievi di acque superficiali e sotterranee. Tutto ciò genera una Produzione Lorda Vendibile (PLV) di quasi 73 miliardi di euro, valore che, sommato all’industria alimentare con un fatturato complessivo di oltre 600 miliardi di euro, determina un peso del sistema agroalimentare del 15% circa sull’intera economia. Sistema, inoltre, che concorre significativamente alle esportazioni italiane anche grazie a oltre 300 prodotti di qualità.
Si tratta, quindi, di un sistema di grande importanza che deve essere tutelato facendo i conti con i cambiamenti climatici in atto, che inducono sempre più frequenti fenomeni di “stress idrico” in grado di compromettere le rese produttive e di intensificare il fabbisogno di acqua.
Un quadro che evidenzia il ruolo strategico della gestione efficiente dell’acqua in agricoltura e la necessità di proporre iniziative e sostenere investimenti idonei a ottimizzarne l’uso. Il connubio tra acqua e produzioni alimentari agroalimentare è inscindibile e va salvaguardato aven-

do bene in mente la sostenibilità nell’utilizzo, riducendo le perdite e puntando alla raccolta delle acque piovane e alla riduzione dei prelievi. È evidente che le diverse azioni attuabili competono, a seconda della scala di applicazione, ai diversi attori e coinvolgono competenze e conoscenze tali da richiedere un forte coordinamento e integrazione – non sempre agevoli - tra le politiche ambientali e agricole per l’acqua.
Politiche che vengono attuate attraverso una pluralità di programmi di investimento che prevedono finanziamenti da fonti differenti, la cui programmazione e gestione necessita di un forte coordinamento tra i numerosi soggetti che si occupano della governance e di una base informativa avanzata e condivisa. Tra queste è di grande rilievo il Sigrian, sistema georeferenziato dedicato alla conoscenza degli impianti collettivi di irrigazione agricola gestito da più di venti anni dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (Crea) per conto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).
UNA RETE LUNGA 43 MILA KM
Gli enti irrigui censiti in Sigrian sono oltre 600 e prelevano l’acqua da distribuire alle aziende agricole da oltre 6 mila fonti di approvvigionamento, costituite per il 50% da corpi idrici superficiali (fiumi, canali e laghi), per il 44% da corpi idrici sotterranei (falde e sorgenti) e per il restante 6% da altre tipologie (es. impianto di depurazione di acque reflue). L’acqua prelevata alle fonti viene convogliata alle aziende agricole associate tramite una rete irrigua primaria lunga circa 43 mila km. Secondo i dati Sigrian, per irrigare 1,5 milioni di ettari, gli enti irrigui che hanno effettuato il monitoraggio in banca dati, nel 2023 hanno prelevato 15 miliardi di mc dalle fonti idriche e distribuito 12 miliardi di mc alle aziende associate agli enti irrigui, restituendo alla circolazione idrica

superficiale oltre 1 miliardo di mc. Valori di grande rilievo, soprattutto in questo periodo storico, nel quale siccità e fenomeni metereologici estremi affliggono il settore primario. Da qui particolare interesse riveste la banca dati Dania, finalizzata a censire gli investimenti nell’uso irriguo della risorsa acqua. Il Crea, che, su mandato del Masaf, gestisce e alimenta Dania, a oggi, censisce circa 450 progetti irrigui esecutivi (per circa 4,7 miliardi di euro), dedicati in modo particolare (81%) all’efficientamento delle reti e al risparmio idrico (per oltre 3,4 miliardi di euro), ma capace anche di generare potenzialmente 1 milione di mc di nuova capacità di invaso.
Lo sforzo conoscitivo prodotto è ancora più importante se si tiene conto che la pratica agronomica dell’irrigazione è fondamentale non solo per la realizzazione di produzioni agricole in quanto permette di mantenere nel suolo un livello di umidità sufficiente a evitare prolungati periodi di

stress idrico per le piante. Infatti, irrigare le coltivazioni contribuisce a ridurre il rischio idrogeologico, favorisce la preservazione dei paesaggi e il mantenimento del valore ricreativo di intere aree a beneficio delle comunità che vi abitano e genera soluzioni circolari: l’acqua che ritorna in falda viene restituita al terreno naturalmente depurata e può essere riutilizzata non solo per scopi agricoli ma anche per la produzione di energia da idroelettrico, attraverso un sistema di invasi a uso multifunzionale. Per il futuro sarà importante agire non solo per usare meglio l’acqua disponibile, ma anche per incrementare la disponibilità di acqua, per esempio trattenendola e accumulandola quando è più disponibile e, ove possibile, ricorrendo a fonti non convenzionali come i reflui urbani affinati.
Oltre a investire direttamente nelle infrastrutture, occorre promuovere e sostenere finanziariamente l’introduzione di innovazioni in azienda grazie all’adozione di tecnologia digitale. Basti pensare all’uso di sensori e lo sviluppo di software dedicati, sistemi esperti, per ottimizzare la pratica irrigua sulla base dell’effettivo fabbisogno delle colture, sia in termini di volumi da distribuire sia in termini di programmazione temporale degli interventi irrigui; alle attrezzature di precisione, in grado di variare gli apporti irrigui in funzione anche delle caratteristiche pedologiche dei suoli, oppure con l’impiego di sensoristica Iot (Internet delle cose) per la misurazione dell’umidità del suolo. Sono investimenti sostenuti nel corso delle differenti programmazioni della politica di Sviluppo Rurale e che rappresentano l’ulteriore frontiera verso la quale l’agricoltura si deve spingere affinchè il concetto di sostenibilità non sia un principio astratto ma percorribile e concretamente alla portata di un sistema produttivo capace di evolvere. ■


di Andrea Sonnino Presidente Fidaf
Il 70% dell’acqua estratta è assorbito dagli usi agricoli, soprattutto per l’irrigazione dei campi coltivati. Rendere sostenibile la gestione delle risorse idriche in agricoltura diventa quindi un obiettivo a portata di mano. Grazie alle nuove tecnologie e politiche mirate

Si è tenuta lo scorso 19 marzo, in prossimità della Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo), presso Palazzo Rospigliosi in Roma, la giornata di studi “La gestione sostenibile della risorsa idrica in agricoltura”, organizzata da Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali (Fidaf), Confprofessioni e Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (Conaf), con la partecipazione del Crea. L’evento ha messo a fuoco politiche, prospettive e pratiche innovative già in uso o potenzialmente realizzabili per ottimizzare la gestione della risorsa idrica in agricoltura

Sul nostro Pianeta l’acqua è molto abbondante: più del 70% della superficie terrestre è difatti sommersa, tanto che molti si domandano se non sarebbe più appropriato parlare di Pianeta Acqua e non di Pianeta Terra. L’acqua disponibile è però quasi tutta (97%) acqua salata degli oceani, non utilizzabile per le funzioni degli ecosistemi terrestri. Le riserve mondiali di acqua dolce sono comunque molto cospicue: circa 40 milioni di kilometri cubici, che ogni anno si rinnovano, sempre a livello mondiale, ad un ritmo di circa 42.000 Km3. L’acqua è quindi una risorsa rinnovabile, ma limitata. L’utilizzo di acqua dolce da parte del genere umano è praticamente raddoppiato dal 1960 ad oggi (vedi figura 1). Nel 2014 il prelievo di acqua superficiale (da fiumi, laghi, ecc.) o sotterranea (falde, pozzi, ecc.) è stato di 3.900 Km3, meno del 10% delle risorse rinnovabili e quindi ben al di sotto della soglia critica. Questo dato è però una media globale di livelli di sfruttamento tutt’altro che omogenei nelle diverse aree geografiche. In alcune aree, particolarmente nel Medio Oriente, nel Nord Africa e nell’Asia Centrale, lo sfruttamento delle risorse idriche supera la soglia critica del 40%. La situazione, già abbastanza allarmante, è resa più grave dagli effetti del cambiamento climatico, che stanno modificando la distribuzione spaziale e temporale delle precipitazioni: l’acqua è spesso troppa o troppo poca nel corso della stessa stagione. Il 70% dell’acqua estratta è assorbito attualmente dagli usi agricoli – soprattutto per l’irrigazione dei campi coltivati -, mentre il 19% è destinato ad usi industriali ed il restante 11% a usi civili (figura 2). L’irrigazione contribuisce ad aumentare la produzione agricola per ettaro di 2-3 volte rispetto a quella conseguibile in terre non irrigate. L’uso dell’acqua per irrigazione è quindi essenziale per produrre gli alimenti della qualità e nella quantità di cui necessitiamo per nutrire la popolazione mondiale.
È dunque particolarmente importante rendere sostenibile la gestione delle risorse idriche in agricoltura, in modo da minimizzarne l’uso senza penalizzare la produzione degli alimenti di cui necessitiamo per condurre una vita sana e attiva. Le strategie percorribili sono molteplici. In primo luogo si può – e si deve - rendere più efficiente il sistema di captazione e distribuzione dell’acqua. Una rete obsoleta e malamente manutenuta è difatti responsabile di ingenti perdite, un vero e proprio spreco, che diventa non ammissibile nelle zone e negli anni di grave scarsità. In questo caso è indispensabile che i decisori politici allochino fondi adeguati e che gli amministratori li utilizzino efficientemente. Una seconda opportunità è offerta dal possibile riuso di acque reflue, che, opportunamente depurate, potrebbero offrire un’interessante fonte
alternativa. La relativa tecnologia è abbastanza matura e sufficientemente sicura, ma si tratta spesso di superare la resistenza dell’opinione pubblica che teme odori spiacevoli e possibili contaminazioni. La desalinizzazione di acque salmastre si aggiunge a questa possibilità.
L’innovazione tecnologica propone l’opportunità di razionalizzare le tecniche irrigue mediante tecniche che permettono di gestire la variabilità dei campi coltivati. Una rete di sensori terrestri, aerei (droni) e spaziali (satelliti) rilevano i dati del terreno necessari per costruire precise mappe di fabbisogno idrico, che, trasmesse ai sistemi irrigui, permettono di erogare acqua a rateo variabile, di annaffiare abbondantemente in altre parole le aree più secche e meno generosamente quelle più umide. La cosiddetta irrigazione 4.0 o di precisione
USO DELLE RISORSE IDRICHE (2021)


permette quindi di utilizzare meno acqua senza penalizzare la produzione. Si può infine intervenire sulle piante coltivate, sviluppando e utilizzando varietà più modeste nei loro fabbisogni idrici, per esempio con apparati radicali più estesi, che riescono ad esplorare strati di terreno più profondi e ad estrarre più acqua, oppure con un ciclo più breve, atto a sfuggire dai periodi di siccità, oppure dotate di altri meccanismi fisiologici che le proteggono da eccessiva traspirazione, eccetera. Sono strategie che sono perseguite dai ricercatori da decine di anni, ma che sono ancora in grado di permettere significativi progressi. Politiche, prospettive, pratiche tutte queste con valenza spesso relativa a specifiche condizioni ambientali. La loro integrazione in strategie di gestione sostenibile della risorsa agricola ci permetterà di affrontare con successo le situazioni sempre più gravi di scarsità e di eccesso di acqua che si stanno verificando in tutto il mondo in generale e nel nostro Paese in particolare. ■

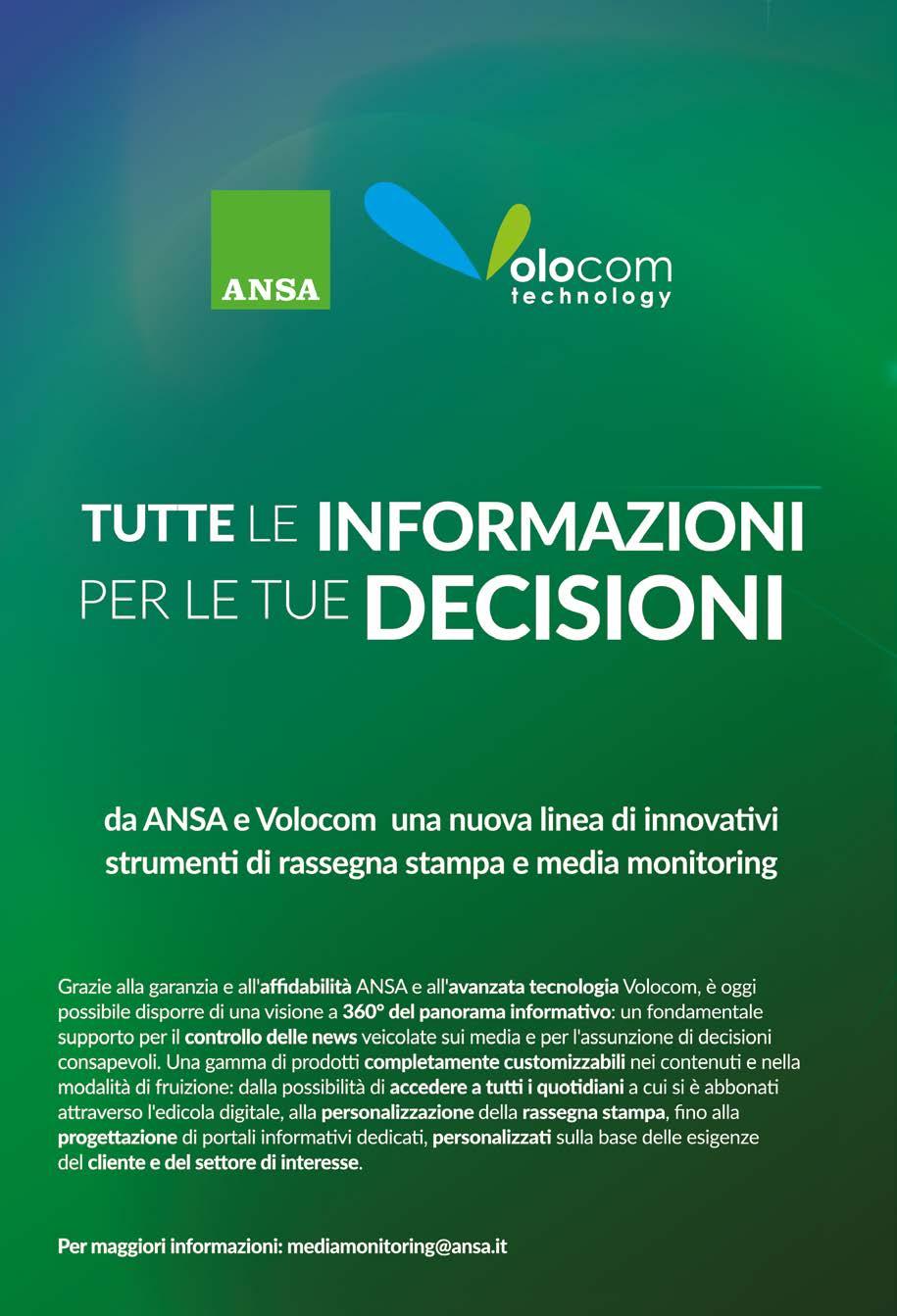


In Italia negli ultimi due anni gli eventi estremi hanno causato danni per quasi 20 miliardi di euro. Crisi climatica, infrastrutture obsolete e carenza di risorse ne sono la causa. Ma qualcosa comincia a muoversi. Come il Piano Bacini Idrici Multifunzionali lanciato da Anbi e Coldiretti. Perché il futuro del Paese si gioca sulla capacità di integrare innovazione, visione strategica e governance territoriale
Nel 2023, in Italia, gli eventi estremi hanno generato danni per 9,8 miliardi di euro e nel 2024 per ulteriori 9 miliardi di euro, a dimostrazione che tali fenomeni si strutturano in maniera sempre più forte, sempre più ravvicinata e sempre più imprevedibile. Negli ultimi dieci anni, il numero di eventi estremi è aumentato del 485%, evidenziando l’elevata vulnerabilità di un territorio, come quello italiano, da sempre considerato l’hotspot dell’Europa sul Mediterraneo.
Un dato che fotografa una fragilità strutturale difficile da ignorare soprattutto alla luce della crisi climatica e dei suoi effetti devastanti in tutti i settori. Affrontare queste sfide richiede interventi concreti, tempestivi e coerenti, all’altezza della complessità del problema. Per questo motivo la salvaguardia e la tutela della risorsa idrica diventano una priorità assoluta in particolar modo per il comparto agricolo e per tutto l’indotto del Made in Italy agroalimentare che nel 2023 ha generato un valore della produzione di 676 miliardi di euro ed un export, nel 2024, di quasi 70 miliardi di euro.
I BACINI MULTIFUNZIONALI
Ad oggi, solo l’11% delle acque meteoriche viene recuperato e stoccato in appositi bacini rappresentando un valore esiguo per fronteggiare le necessità dettate dal cambiamento climatico.
L’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi), insieme a Coldiretti, ha recentemente presentato il “Piano Bacini Idrici Multifunzionali” quale risposta concreta alle esigenze del Paese, dei consumatori e del settore primario. Grazie a questi bacini le acque meteoriche verrebbero rallentate nel loro rapido rilascio verso il mare, garantendo il loro utilizzo irriguo e polifunzionale al momento del bisogno
(potabile, dopo trattamento; energetico; ambientale, con effetti positivi sulla ricarica della falda e sul contenimento del cuneo salino e della subsidenza; di laminazione delle piene alluvionali; di soccorso nell’antincendio).
Si tratta di 10 mila invasi di piccole e medie dimensioni, senza l’uso di cemento e in terra battuta, che non vanno in alcun modo ad interferire con la vita dei fiumi bensì, si configurano come veri e propri strumenti di transizione energetica verso il processo di decarbonizzazione.
L’installazione di impianti di fotovoltaico galleggiante e idroelettrici, con relativi pompaggi ove la conformazione territoriale lo permetta, rappresenta la soluzione innovativa di mitigazione dei costi energetici. L’energia rinnovabile prodotta

contribuirebbe ad una quota significativa del fabbisogno energetico di tutti quegli impianti gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigazione.
Ad oggi, la componente energetica rappresenta una delle voci di spesa che più grava sulla gestione finanziaria consortile e di riflesso sui bilanci delle aziende agricole consorziate, con forti ripercussioni sui prezzi del cibo sugli scaffali. Un progetto che guarda al futuro dell’Italia e dell’agricoltura italiana che conta oltre l’85% delle colture irrigue e 3,5 milioni di ettari irrigui.
Al contempo, i Consorzi di Bonifica e Irrigazione stanno dimostrando, con i fatti, di essere in grado di centrare tutti i target del rigido cronoprogramma del Pnrr con riferimento alle misure M2C4 – 4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico” e M2C4 - 4.3 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”, per un totale di circa 1,48 miliardi di euro.
Il Pnrr ha rappresentato un’opportunità senza precedenti per migliorare la resilienza dell’agroecosistema italiano, facendo emergere la grande capacità del sistema consortile italiano di pianificare e progettare opere infrastrutturali per la manutenzione straordinaria, il potenziamento e l’efficientamento della rete idraulica del Paese.
Accanto all’intervento infrastrutturale, Anbi sostiene con decisione il ricorso all’innovazione e all’intelligenza artificiale. Irriframe è una risposta concreta: uno strumento di supporto alle decisioni irrigue che ad oggi viene impiegato da oltre 9 mila aziende agricole e che combina dati meteorologici, colturali e pedologici per ottimizzare l’uso dell’acqua, consen-


tendo un risparmio annuo di 500 milioni di metri cubi e rappresentando una risorsa preziosa per l’intera filiera agroalimentare. L’innovazione tecnologica si intreccia con un’altra priorità strategica: la digitalizzazione dei territori.
Digitalizzazione che deve trovare il suo fondamento nella rivitalizzazione delle aree interne, sempre più soggette a spopolamento e desertificazione imprenditoriale, che rappresentano un rischio significativo per la collettività. Meno cittadini, meno aziende che lavorano e che vivono il territorio, meno cura del paesaggio, maggior rischio idrogeologico. ■

L’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi) sta mettendo in campo una serie di strumenti di adattamento e mitigazione, a supporto del settore agricolo, che si sviluppano lungo tre direttrici: cultura, infrastrutturazione e digitalizzazione. Trovare soluzioni resilienti non basta però, urge un forte cambio di direzione che coinvolga e promuova il concetto della cultura istituzionale e dei cittadini come gestione sostenibile della risorsa idrica ma anche azione costante e continua di promozione della manutenzione nelle infrastrutture.
Anbi promuove la cultura della manutenzione e l’economia della manutenzione, in un Paese in cui oltre il 40% della risorsa idrica viene sprecato a causa di infrastrutture carenti e obsolete e dove, per l’assenza di schemi idrici di collegamento, abbiamo territori che riversano in mare acqua dolce e altri, spesso limitrofi, assetati. È fondamentale una regolare e accurata attività di manutenzione ordinaria e, soprattutto, straordinaria dei corsi fluviali e della rete idrografica di prelievo, adduzione e distribuzione della risorsa idrica per la messa in sicurezza del territorio e per l’efficientamento dell’irrigazione. ■

Le storie, i personaggi e le notizie di primo piano commentate dalle più autorevoli firme del mondo della politica, dell’economia, dell’università e delle professioni



In Italia all’aumento dell’occupazione corrisponde una quasi stagnazione delle attività produttive e delle retribuzioni. E se un sistema produttivo non è in grado di aumentare alcuni fattori (come ricerca e innovazione), il solo input di ore lavorate non consente una crescita della produttività significativa e la competitività del sistema resta determinata da quella sui costi. Come succede nei Paesi in via di sviluppo

di Claudio Negro
Il quadro delle politiche del lavoro in Italia presenta alcune particolarità piuttosto insolite rispetto alla dottrina classica: il tasso di occupazione sale costantemente dal dopo covid, superando il 60%, con una forte crescita dei contratti “stabili” che crescono a discapito dei contratti a termine, a testimoniare una crescita che le aziende giudicano robusta e non occasionale. Tuttavia altri indicatori vanno in direzioni ben diverse: la produzione industriale scende senza clamori ma costantemente dal 2023.
Al crescere dell’occupazione corrisponde un aumento sostanzioso dell’indice di inattività (ossia delle persone che non cercano lavoro- quindi non disoccupati- e non sono comunque disposte a lavorare): si tratta del 33% di quelle
in età da lavoro. Tra gli occupati e gli inattivi, i “disoccupati”, cioè coloro che cercano attivamente un lavoro, sono il 5,3% della popolazione; un record per l’Italia, che lascia aperta una grossa domanda per il futuro: la crescita simultanea (com’è attualmente), dell’occupazione e dell’inattività finirà per schiacciare la zona cuscinetto della disoccupazione e quindi determinerà un’ingessatura del mercato del lavoro, in cui la domanda eccederà stabilmente l’offerta, i giovani avranno sbocchi occupazionali ristretti e insufficienti e i nuovi accessi all’occupazione saranno prevalentemente quelli determinati dal turn over.
Questo quadro si riferisce al lavoro dipendente, ma anche il lavoro autonomo vive da anni una decre-

scita costante: fino a 20 anni fa il numero dei lavoratori indipendenti era superiore alle 6 mila unità, mentre ormai è stabilmente attorno ai 5 mila.
Un effetto collaterale di questa anomala forma di stagnazione è quello dell’immobilità delle retribuzioni, che spesso e volentieri si trasforma addirittura in perdita in termini reali: dal 2008 (quindi passando per due crisi importanti come quella finanziaria internazionale e quella del Covid), la retribuzione media in termini di potere d’acquisto ha perso l’8,3%, mentre, per esempio, quella francese è aumentata del 3,5% e quella tedesca del 5%.
Fenomeno questo che spiega l’insolito quadro in cui, nonostante sia stata alta la domanda di forza lavoro qualificata negli ultimi anni, decine di migliaia di giovani per lo più con alta formazione siano emigrati dall’Italia verso altri Paesi: 156 mila nel 2024 e, calcolando a partire dal 2013, oltre 500 mila.
Questa dinamica esercita un ruolo importante nel ritardo tecnologico che connota i nostri settori produttivi, soprattutto sul terreno dell’informatica e delle sue applicazioni più avanzate, che di solito sono veicolate dai giovani con alti profili di formazione.
E, seguendo la catena del sistema produttivo, arriviamo a quello che sta alla base della situazione vista sopra: la produttività. Un primo dato, di carattere generale ma che sottende efficacemente quello sulla produttività, e quello rela-
aumentata

tivo al Pil: dal 1990 ad oggi il prodotto interno lordo italiano è cresciuto di 19 punti, contro 46 della media europea. La produttività è comunemente definita come il rapporto tra il volume dell’output e degli input che concorrono alla sua realizzazione.
Essa misura l’efficienza dell’impiego nel processo di produzione dei fattori primari, lavoro e capitale ed è considerata un indicatore chiave di crescita. L’approccio utilizzato dall’Istat per stimarla consente di scomporre la dinamica dell’output nei contributi derivanti dai fattori produttivi primari (lavoro e capitale) e dalla PTFi. (produttività totale dei fattori). La produttività del lavoro è data dal rapporto tra valore aggiunto e ore lavorate; la produttività del capitale è misurata dal rapporto tra valore aggiunto

e input di capitale. È interessante vedere come l’andamento di questi indicatori impatti sull’economia reale. Nel caso della produttività del lavoro è opportuno ricordare che essa è misurata dal rapporto tra ore lavorate e valore aggiunto della produzione, pertanto l’aumento dell’occupazione negli anni successivi al Covid e un aumento del valore aggiunto inferiore a quello delle ore lavorate ha determinato un calo della produttività: rispettivamente +2,7% e + 0,5% nel2023, pari a un rapporto di 2,5 punti inferiore a quelli degli ultimi anni.
Questa insolita dinamica spiega in gran parte il paradosso italiano, per cui all’aumento dell’occupazione corrisponde una quasi stagnazione delle attività produttive e delle retribuzioni: l’andamento delle retribuzioni segue quello della produttività, e se un sistema produttivo non è in grado (o non vuole) aumentare alcuni fattori (l’input di capitale nel nostro caso e soprattutto di ricerca e innovazione) il solo input di ore lavorate non consente una crescita della produttività significativa, e la competitività del sistema resterà determinata dalla competitività sui costi dei fattori e quindi, in un sistema come il nostro ad alta intensità di mano d’opera, sulle retribuzioni.
In sostanza, come del resto suggeriscono altri indicatori (la spesa per R&S in Italia è pari al 1,5% del Pil, mentre la media Ue è 2,3%), quanto a competitività del nostro sistema produttivo resta prevalentemente dipendente dai bassi costi permessi dai bassi salari, come per i Paesi in via di sviluppo. ■

I salari contenuti hanno spinto decine di migliaia
di giovani italiani, per lo più con alta formazione, a emigrare verso altri
Paesi: 156 mila nel 2024 che salgono a oltre 500 mila se si considera
di Jacopo Sala
Adapt Research Fellow
Nel 2024, le retribuzioni contrattuali nel settore privato sono aumentate mediamente del 4%. Il comparto che ha registrato la crescita più significativa è stato quello industriale. Un incremento non sufficiente per recuperare il potere d’acquisto. Obiettivo che resta ancora lontano. Per questo è importante accelerare i processi di rinnovo contrattuale in modo da estendere i benefici della ripresa a tutte le categorie di lavoratori


Dopo un triennio particolarmente difficile per i salari italiani, il 2024 ha segnato un punto di svolta. I dati più recenti mostrano infatti un recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni contrattuali, con aumenti salariali che finalmente superano l’inflazione. Ma questo miglioramento è sufficiente a compensare le perdite accumulate negli ultimi anni? E quali sono le prospettive per il 2025?
Nel 2024, le retribuzioni contrattuali nel settore privato sono aumentate del 4%, a fronte di un’inflazione contenuta all’1%. In termini reali, ciò significa che i salari sono cresciuti del 3%, invertendo la tendenza negativa degli anni precedenti, quando i

DINAMICA DEI PREZZI E DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI (NOMINALI E REALI) NEL SETTORE PRIVATO NEL PERIODO 2019–2024 (VARIAZIONI PERCENTUALI TENDENZIALI, BASE 2019 = 100)
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT
lavoratori avevano subito perdite significative: -1% nel 2021, -6,6% nel 2022 e -3,3% nel 2023.
La ripresa salariale non è uniforme in tutti i comparti economici. Il settore industriale che ha registrato la crescita più significativa, con un aumento del 4,6% nel 2024, che raggiunge il 5,1% nell’industria in senso stretto.
Questo incremento è riconducibile in buona parte ai meccanismi di adeguamento dei minimi tabellari all’inflazione presenti in alcuni contratti collettivi, come il Ccnl Metalmeccanici.
Nel settore terziario, l’aumento è stato più contenuto (+3,4%), sostenuto dall’intensa stagione di rinnovi contrattuali del biennio 2023–2024, che ha visto l’aggiornamento di numerosi contratti collettivi, alcuni dei quali scaduti da tempo: Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, Ccnl Pubblici Esercizi, Ccnl Turismo, Ccnl Distribuzione Moderna Organizzata, e altri ancora.
In termini di andamento salariale, spiccano, tra i singoli gruppi contrattuali, le attività manifatturiere con un incremento del 5,3% nel 2024 e il settore del credito e delle assicurazioni con un sorprendente +8%. Seguono il commercio (+3,6%), i trasporti (+3%), gli altri servizi privati (+2,8%), mentre aumenti più modesti caratterizzano i pubblici esercizi e alberghi (+1,9%) e i servizi di informazione e comunicazione (+0,5%). Nessuna variazione è stata invece rilevata nei gruppi delle telecomunicazioni e delle farmacie private.
Nonostante questo miglioramento, il pieno recupero del potere d’acquisto rimane lontano. Considerando l’intero periodo 2019–2024, i prezzi al consumo sono infatti aumentati del 17,4%, mentre le retribuzioni contrattuali sono cresciute solo del 9,1%, determinando così una perdita del potere d’acquisto pari al 7,1%.
Considerando l’intero quinquennio 2019–2024, solo il settore del credito e delle assicurazioni si è avvicinato al pieno recupero del potere d’acquisto, con un incremento cumulato delle retribuzioni contrattuali del 15,3% (contro il 17,4% dell’inflazione). Perdite più significative si registrano nei servizi di informazione e comunicazione (-12,5%), nelle farmacie
DINAMICA DEI PREZZI E DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI (NOMINALI E REALI) NEL SETTORE PRIVATO NEL PERIODO 2019–2024 (NUMERI INDICI, BASE 2019 = 100)
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT
private (-11,5%) e nei pubblici esercizi e alberghi (-11%). Due fattori principali hanno determinato l’erosione del potere d’acquisto negli ultimi anni. Da un lato, la straordinaria pressione inflazionistica che nel 2022 ha toccato il picco record dell’8,1% (livelli così elevati non si registravano dagli anni ‘80).
Dall’altro, i ritardi nell’adeguamento delle retribuzioni all’inflazione, determinati sia dalla durata dei contratti collettivi – che non vengono aggiornati prima della scadenza – sia dalle frequenti dilazioni nei processi di rinnovo contrattuale.

Per il 2025, l’Istat stima che l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie per il settore privato registrerà un incremento del 3,4% nella media del primo semestre e del 2,3% nella media dell’intero anno. Con un’inflazione prevista intorno al 2%, i salari reali dovrebbero crescere di circa lo 0,5%. In questo scenario, la variazione cumulata per il periodo 2019–2025 risulterebbe più elevata sia per i prezzi (+19,7%) che per le retribuzioni contrattuali (+11,8%).
Di conseguenza, la perdita cumulata di potere d’acquisto si ridurrebbe leggermente, pur restando significativa al 6,6%. Un elemento critico da considerare è che, a dicembre 2024, oltre un terzo dei lavoratori dipendenti del settore privato (37,1%) era ancora in attesa di rinnovo contrattuale. Questa situazione limita ulteriormente il pieno recupero del potere d’acquisto per molti lavoratori, a meno di un’accelerazione significativa nei processi di rinnovo.
In conclusione, sebbene il 2024 abbia segnato un’inversione di tendenza positiva, con salari in crescita più dell’inflazione per la prima volta dopo anni, il recupero del potere d’acquisto rimane incompleto e disomogeneo tra i settori. Le prospettive per il 2025 indicano un miglioramento, ma non sufficiente a colmare il divario accumulato.
In questo contesto, diventa fondamentale accelerare i processi di rinnovo contrattuale per estendere i benefici della ripresa a tutte le categorie di lavoratori. ■
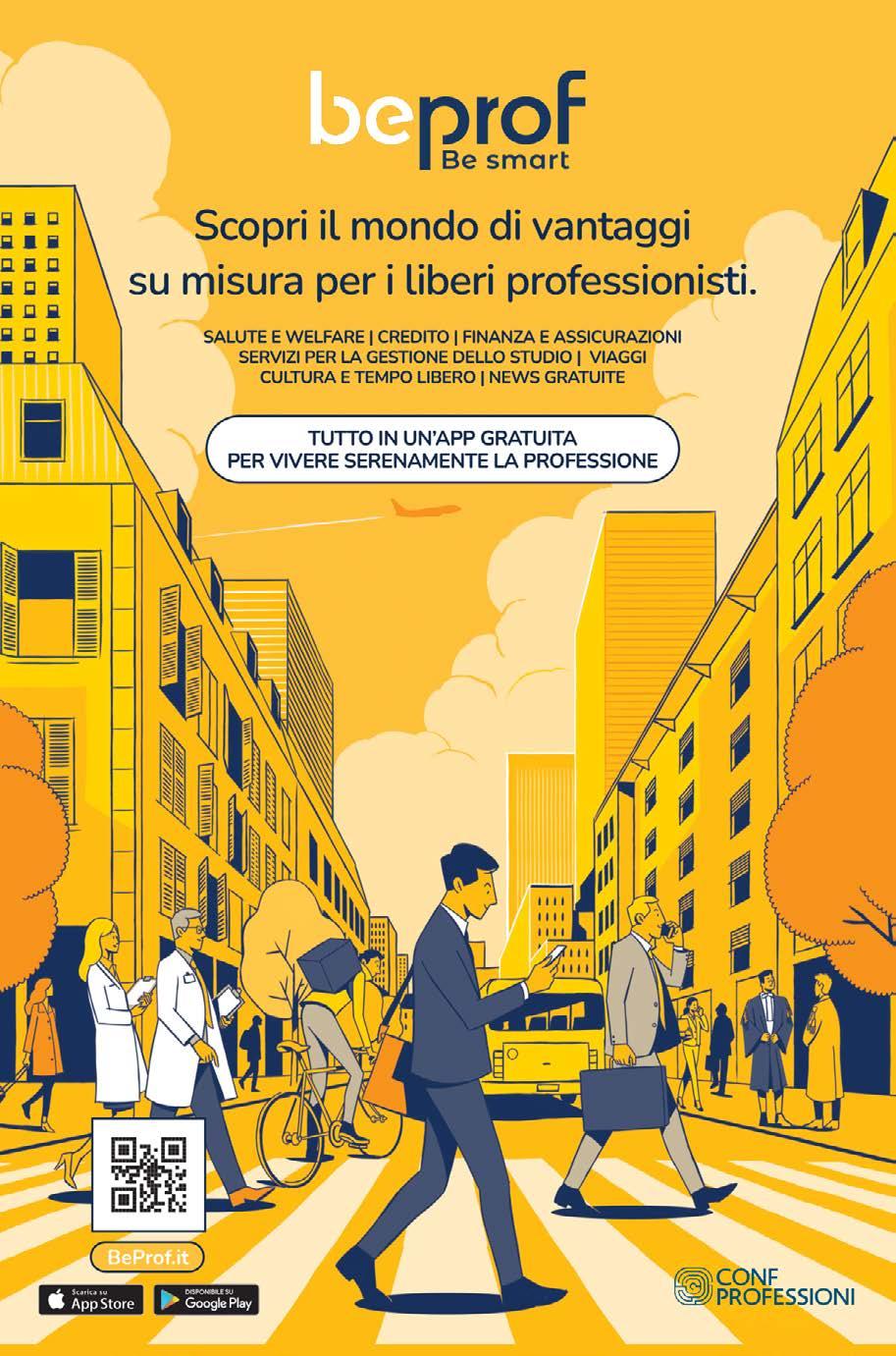
di Carlo Bertotti
I dazi di Trump rischiano di frenare le esportazioni dell’alta moda italiana che oggi valgono il 13% dell’export nazionale, registrando perdite per circa 2 mild di euro. Ma, nonostante la complessità del momento, il nostro Paese si conferma un grande attore nel panorama globale del lusso. E l’acquisizione del marchio Versace da parte di Prada è destinata a ridisegnare gli equilibri tra i grandi gruppi internazionali del settore
Idazi al 20% sulle produzioni europee prima annunciati e poi temporaneamente sospesi da Donald Trump il 2 aprile preoccupano e destabilizzano il mondo della moda italiana che negli Stati Uniti ha un fondamentale mercato di sbocco e che già nel 2024, nonostante un volume pari a 2,8 miliardi di euro, ha sperimentato una riduzione dello 0,7% delle esportazioni verso questo Paese strategico. E il parziale dietrofront e la recente sospensione della misura per 90 giorni non sono una garanzia e non rassicurano i principali player del settore. Ad allarmare non sono soltanto i dazi americani sui prodotti europei e le conseguenze dirette in termini di mancati ricavi, ma anche l’effetto delle misure sui costi delle fasi produttive e distributive dei capi.
LE PROSPETTIVE FUTURE
La nuova era di protezionismo con le sue nuove tariffe rischia quindi di far diventare la moda più costosa che mai. Gli Stati Uniti rappresentano infatti uno dei principali consumatori di abbigliamento e calzature al mondo. Nel 2023, hanno infatti speso secondo ExportUSA 175 miliardi di dollari per abbigliamento e accessori con la stragrande maggioranza dei prodotti del settore, il 98% di abbigliamento e il 99% di calzature, importata dall’estero. Ma gli effetti delle nuove tariffe non si limiteranno solo al lusso. I marchi di sportswear sono infatti tra i più esposti, avendo già diversificato la loro produzione lontano dalla Cina durante la prima presidenza Trump. Basti dire che Nike ha prodotto il 50% delle sue calzature in Vietnam nel 2024, mentre On ha realizzato nel Paese

asiatico il 90% delle sue scarpe. È quindi facile prevedere uno scenario di crisi lungo tutta la filiera della moda con le aziende impegnate a rivedere interamente come ridistribuire prezzi e costi. Di fronte a questa situazione brand e retailer dovranno scegliere se caricare su di sé gli aumenti per mantenere i prezzi invariati o se far lievitare i prezzi al consumo rischiando ulteriori ripercussioni sull’andamento delle vendite.
L'impatto sarà notevole per diversi mercati e l'Italia potrebbe subìre perdite superiori ai 2 miliardi di euro sulle esportazioni.
Secondo i dati ISTAT nel 2023 il nostro Paese risultava essere al primo posto tra i 27 dell’Unione per esportazioni di abbigliamento e accessori negli Stati Uniti con 5,1 miliardi di esportazioni (2,4 miliardi di euro per abbigliamento e 2,7 miliardi per le pelli lavorate). Sempre per il mercato Usa, l'Italia era il primo esportatore europeo nei comparti gioielleria (1,6 miliardi di euro) e calzaturiero (1,4 miliardi di euro).
A oggi il sistema moda Italia è uno dei fiori all’occhiello della nostra economia, basti dire che circa un terzo dei grandi gruppi europei della moda scelgono fornitori italiani, quota che sale ai due terzi per i brand del lusso, facendo del nostro Paese il primo produttore mondiale di alta moda. Un comparto che vale circa il 5% del PIL nazionale con esportazioni pari a 65 miliardi di euro, ben il 13% dell’export made in Italy. Nel 2024 il settore della Moda ha però visto una contrazione di fatturato del 5,3% rispetto all’anno precedente mentre, parallelamente, a fronte di questa flessione l’export ha segnato una crescita del 2%.
Tra le cause delle difficoltà figura il calo della propensione al consumo dovuta al contesto di incertezza economica e all’aumento dei costi ma anche una certa difficoltà di penetrazione in mercati tradizionali e consolidati come Regno Unito e Germania. L’intero settore vanta nel nostro Paese 62.000 imprese attive, 565.000 addetti e un fatturato da 102,1 miliardi di euro. L’Italia è peraltro il secondo esportatore al mondo, posizionandosi

solo dopo la Cina. È evidente che nel 2025 le logiche del passato non siano più valide e che l’industria della moda abbia bisogno di nuove strategie per la crescita. Questo momento storico può rappresentare un'opportunità per le aziende del comparto di reinventarsi, da un lato cercando di accelerare sul fronte innovazione e dall’altro rivolgendosi ai mercati con le maggiori previsioni di crescita, come l’India per l’high-street o il Giappone per il lusso.
Nonostante il quadro complesso l’Italia si conferma un grande attore nel panorama globale del lusso come evidenzia anche la classifica Brands di Interbrand che monitora il valore dei principali marchi a livello internazionale. I dati della classifica dicono anche una
cosa importante sull’equilibrio dei mercati e le scelte dei consumatori. Il valore dei brand del lusso, infatti, continua a crescere, con un aumento del 7% rispetto al 6,5% dell’anno precedente. Nella Top 100 dei marchi che valgono di più al mondo compaiono anche quelli italiani della moda come Prada (#83) che sta vivendo una fase di forte crescita grazie alla grande capacità di gestire la propria offerta e fidelizzare la clientela in tutto il mondo.
Ed è proprio su Prada che negli ultimi tempi si è concentrata l’attenzione dei mercati con la notizia dell’acquisizione del brand Versace. L’accordo definitivo per la cessione della griffe della Medusa da parte del gruppo che fa capo a Miuccia Prada e Patrizio


Bertelli è avvenuto sulla base di un Enterprise Value di 1,25 miliardi di euro. Nel presentare l'accordo i vertici del gruppo Prada si sono detti convinti che Versace abbia un grande potenziale e che la sua estetica, così distante rispetto a quella di Prada, possa rappresentare un vantaggio garantendo nuovi target di clientela oltre che un ampliamento della gamma di marchi. Insieme a Versace, Prada crea una realtà in grado di competere con i grandi big del mercato come i francesi Lvmh e Kering ridisegnando di fatto gli equilibri tra i grandi gruppi internazionali del settore. ■
In alto Donatella Versace
Miuccia Prada

L’arresto del sindaco di Istanbul ha sollevato le proteste di migliaia di persone, che si sono riversate nelle piazze per protestare contro il presidente turco, considerato l’artefice di una strategia per mettere fuori gioco l’opposizione in vista delle prossime elezioni del 2028. Mentre il Paese della Mezzaluna vive ormai da tempo in un clima di disagio sociale

di Valeria Giannotta
La Turchia del presidente
Recep Tayyip Erdoǧan sta attraversando nuovamente una fase critica. Il 19 marzo scorso, Ekrem Imamoǧlu, sindaco di Istanbul e uomo di punta del CHP (Cumhuriyet Halk Partisi, Partito Repubblicano del Popolo), principale formazione di opposizione, è stato posto in stato di fermo con la duplice accusa di corruzione e fiancheggiamento al terrorismo per fini elettorali; quest’ultima poi decaduta con la convalida dell’arresto. Con lui sono state detenute circa un centinaio di persone, tra impiegati pubblici della grande municipalità di Istanbul, uomini a lui vicini e giornalisti. L’operazione ha sollevato l’ira di migliaia di persone che si sono riversate in strada protestando contro il governo e il suo leader Erdoǧan, percepito quale architetto di un colpo di stato. Molti gli arresti anche tra i manifestanti. Il Paese della Mezzaluna vive ormai da tempo in un clima di estrema polarizzazione sociale, diviso tra i sostenitori del governo e coloro che non si ritrovano nelle politiche proposte e nell’azione pervasiva del Presidente Erdoǧan che, a capo di un sistema presidenziale sin dal 2018, ha ampi poteri di manovra nello spazio pubblico e politico. A conferma del diffuso disagio sociale innescato dall’arresto del primo cittadino di Istanbul, mentre iniziavano a prendere piede manifestazioni urbane, circa 15 milioni di persone si sarebbero recate alle urne per le elezioni primarie del partito CHP, optando per Imamoǧlu che, nonostante non fosse eleggibile, è stato presentato simbolicamente come unico candidato. Un’azione di protesta, che raccoglie un disagio di lunga data.
Da tempo, sul sindaco di Istanbul pesavano sospetti e condanne più o meno esplicite, riconducibili anche alle irregolarità del suo diploma di laurea, che l’Università di Istanbul ha provveduto ad annullare il giorno prima dell’arresto. Una mossa che avrebbe già escluso Imamoǧlu dalla prossima corsa elettorale prevista per il 2028; secondo la legge turca è infatti candidabile alla presidenza della repubblica soltanto chi è in possesso del titolo universitario.
Il tutto potrebbe dunque ascriversi a precisi calcoli politici e a una strategia volta a mettere fuori gioco l’oppositore, riducendo il fattore di rischio e preservando la posizione predominante di Erdoǧan e del suo governo sullo scenario politico turco. Per molti Ekrem

Imamoǧlu è la figura chiave del blocco di opposizione, colui che con la sua rapida scalata politica è emerso quale leader in grado di mobilitare le masse, scardinando la rigida e dogmatica impronta secolare del CHP, il più antico partito di Turchia, e avviandolo verso una direzione progressista, maggiormente inclusiva soprattutto per ciò che concerne le frange più conservatrici della società. Dato l’indice di gradimento e il carisma, Ekrem Imamoǧlu potrebbe essere considerato una sorta di nemesis per Erdoǧan che proprio dalla principale città sul Bosforo ha iniziato la propria ascesa politica con un programma “pigliatutto” conducendolo nel corso del tempo, riforma dopo riforma, braccio di ferro dopo braccio di ferro, a compiere il progetto della “Nuova Turchia”, esito della sintesi islamico-nazionalista propria dei suoi ultimi mandati.
Dopo le ultime elezioni politiche e presidenziali del 2023, che l’hanno incoronato leader indiscusso in Turchia, Erdoǧan e il suo governo si sono trovati a fare i conti con alcune criticità interne dovute alle disfunzioni economiche, esito di politiche non ortodosse volte a ridurre i tassi di interesse e puntare sulle esportazioni, e alla sconfitta delle elezioni amministrative del 2024. L’obiettivo oggi è garantire la permanenza al potere, caldeggiando una riforma della carta costituzionale da riscrivere ex novo, dato che quella attuale - per quanto emendata più volte - contiene il nucleo originale manu militari, quale esito del colpo di stato del 1980, ed eventualmente indicendo elezioni anticipate in

modo da garantire un’estensione del proprio mandato. Alla luce della normativa vigente che pone il vincolo di due legislature, il presidente Erdoǧan non sarebbe ulteriormente candidabile. Si tratta, dunque, di un disegno ambizioso che poggia anche sul sostegno della maggioranza parlamentare, che a oggi si farebbe fatica a raggiungere. In tale luce, più recentemente è stata intavolata una negoziazione tra il governo e le frange curde rappresentate dal partito DEM (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - Partito dell’Uguaglianza e della Democrazia dei Popoli) che a fine febbraio ha condotto al proclama di Abdullah Öcalan, leader della fuorilegge organizzazione separatista PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê - Partito dei Lavoratori del Kurdistan), sulla conclusione della lotta armata e dissoluzione dello stesso PKK.
Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoǧlu, leader dell'opposizione arrestato lo scorso 19 marzo
IL PESO DEI MILLENIALS
Calcoli e rischi ponderati, da leggersi anche in riferimento alla situazione oltreconfine, soprattutto alla luce delle nuove dinamiche siriane. Oggi gli esponenti DEM, già uniti al CHP nelle precedenti tornate elettorali, sono ben cauti nell’appoggiare le proteste, mostrando un atteggiamento distaccato nei riguardi dell’alleato, a tutela del proprio interesse a salvaguardare il processo di normalizzazione avviato con le file governative. A seguito dell’arresto di Imamoǧlu, al di là della legittimità e dell’opportunismo politico, la Turchia si trova in una condizione di profonda frattura sociale, di dicotomia e volatilità politica, e di un senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni, soprattutto del potere giudiziario, considerato assoggettato al potere politico. Ecco che “Adalet” (Giustizia) “Hukuk” (Diritto) sono i principali slogan delle piazze, invocati da tutti coloro che mirano a un cambiamento; tra questi la maggior parte sono i giovani. La generazione Z, meglio conosciuta come “millennials”, è stata la vera protagonista delle manifestazioni di Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya e altre parti della Turchia. Sono i ventenni di oggi, coloro che in Turchia sono nati e cresciuti sotto il governo dell’AKP, a volere un’altra Turchia, spinti anche dalle continue sollecitazioni dei social media. Ma il disappunto è trasversale: in piazza ci sono esponenti della società più laica, elettori storici del CHP, chi semplicemente protesta contro Erdoǧan, nonostante le proprie preferenze politiche, chi mira a mostrare il proprio malcontento per la contingente situazione economica. ■


La piattaforma realizzata da Confprofessioni e Apri International per favorire le relazioni tra i professionisti di tutto il mondo.

Iscriviti ora e connettiti con una rete internazionale di professionisti!
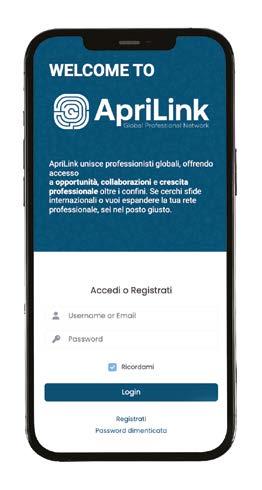
Le news più rilevanti dalle istituzioni europee selezionate dal Desk europeo di ConfProfessioni
Il 5 marzo scorso la Commissione europea ha lanciato il piano “Unione delle Competenze” (Union of Skills), per rafforzare il capitale umano dei 27 Stati membri e rendere l’Europa più competitiva. L’iniziativa si fonda su pilastri strategici, tra cui il potenziamento delle competenze di base, con il Basic Skills Support Scheme, volto a migliorare l’alfabetizzazione digitale e le capacità essenziali, soprattutto per bambini e giovani in difficoltà. Un focus particolare è destinato allo sviluppo delle competenze Stem, per incentivare carriere scientifiche e rafforzare il ruolo di ragazze e donne nelle transizioni digitali e nelle tecnologie pulite. Parallelamente, la Commissione punta a creare posti di lavoro di qualità con una nuova strategia per l’istruzione e formazione professionale
e a promuovere percorsi di apprendimento continuo attraverso il progetto pilota Skills Guarantee, che, abbinato alle EU Skills Academies, supporterà la transizione verde e la riqualificazione dei lavoratori. L’iniziativa prevede, inoltre, la Skills Portability Initiative, che renderà più semplice il riconoscimento delle qualifiche a livello transfrontaliero e favorirà il conseguimento di una laurea europea e programmi di studio congiunti innovativi. Gli obiettivi della Commissione per il 2030 puntano quindi a ridurre la percentuale di insufficienza in alfabetizzazione, matematica, scienze e competenze digitali, nonché un incremento significativo degli studenti in campi Stem e nei programmi di dottorato in Ict, in linea con l’impegno di mantenere l’Europa competitiva ed equa.


A Bruxelles si è tenuto il Tripartite Social Summit. Il tema di questa edizione è stato il rilancio dell’Europa in un contesto geopolitico sempre più complesso, con l’obiettivo di rafforzare la competitività e attrarre investimenti senza sacrificare la qualità dell’occupazione e il modello sociale europeo. Diversi i punti chiave toccati dal dibattito, a partire dalla necessità di investire nelle competenze per sostenere l’occupazione e migliorare la competitività dell’Unione. In una fase in cui le tensioni globali, la guerra in Ucraina e l’aumento dei dazi commerciali stanno mettendo sotto pressione l’economia europea, i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di mantenere la coesione interna e di costruire alleanze strategiche con partner esterni. Il presidente del Consiglio europeo, António Costa, ha ribadito che «Un dialogo solido tra sindacati e datori di lavoro, a livello europeo, nazionale e locale, è al cuore del nostro modello sociale europeo. Mentre le nostre economie attraversano profonde trasformazioni, questo dialogo è più essenziale che mai per promuovere posti di lavoro di qualità, rafforzare la nostra competitività e costruire insieme un futuro più resiliente e sostenibile».
La Commissione europea ha annunciato una revisione della politica di coesione, volta a rendere l'Ue più efficace e competitiva. L’iniziativa invita gli Stati membri e le regioni a riassegnare parte dei fondi verso nuove priorità strategiche, mantenendo la lotta alle disparità economiche, sociali e territoriali al centro dell’azione europea. La riforma prevede interventi su più fronti. In primis, si intende rafforzare la competitività e ridurre il divario innovativo, estendendo il supporto del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) a imprese di ogni dimensione, soprattutto in settori chiave come la difesa, le tecnologie avanzate e la decarbonizzazione. Contestualmente, si vuole stimolare gli investimenti nelle tecnologie strategiche, per favorire il trasferimento di conoscenze e tecnologie. La Commissione punta poi a raddoppiare i fondi per alloggi a prezzi accessibili e a promuovere un nuovo strumento finanziario in collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti, per mobilitare risorse pubbliche e private. Infine, gli Stati membri potranno finanziare la digitalizzazione delle infrastrutture idriche.

1,3 miliardi di euro per sviluppare tecnologie

La Commissione Europea ha annunciato un investimento di 1,3 miliardi di euro destinato alla diffusione di tecnologie critiche per il futuro dell'Europa e la sua sovranità tecnologica. Il finanziamento rientra nel programma di lavoro Europa digitale (Digital) per il periodo 2025-2027. “Digital Europe” con un budget di 8,1 miliardi di euro nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, mira a dare forma alla trasformazione digitale della società e dell'economia europea, in linea con gli obiettivi dell'UE definiti nella Comunicazione - Bussola digitale 2030. Concentrandosi specificamente sulla distribuzione, Digital integra gli investimenti nell'ambito di altri programmi dell’Ue, quali Horizon Europe (per la ricerca e innovazione), EU4Health, InvestEU, il Connecting Europe Facility (per l’infrastruttura digitale), nonché gli investimenti nell'ambito del Recovery and Resilience Facility e i fondi strutturali. Insieme ad altri programmi, Digital fa anche parte dell'iniziativa Strategic Technologies for Europe Platform (STEP), progettata per migliorare la competitività industriale dell'Ue e rafforzare la sovranità europea concentrandosi sullo sviluppo e la produzione di tecnologie critiche.
Analisi, tendenze e avvenimenti del mondo professionale, raccontati
dai protagonisti delle professioni
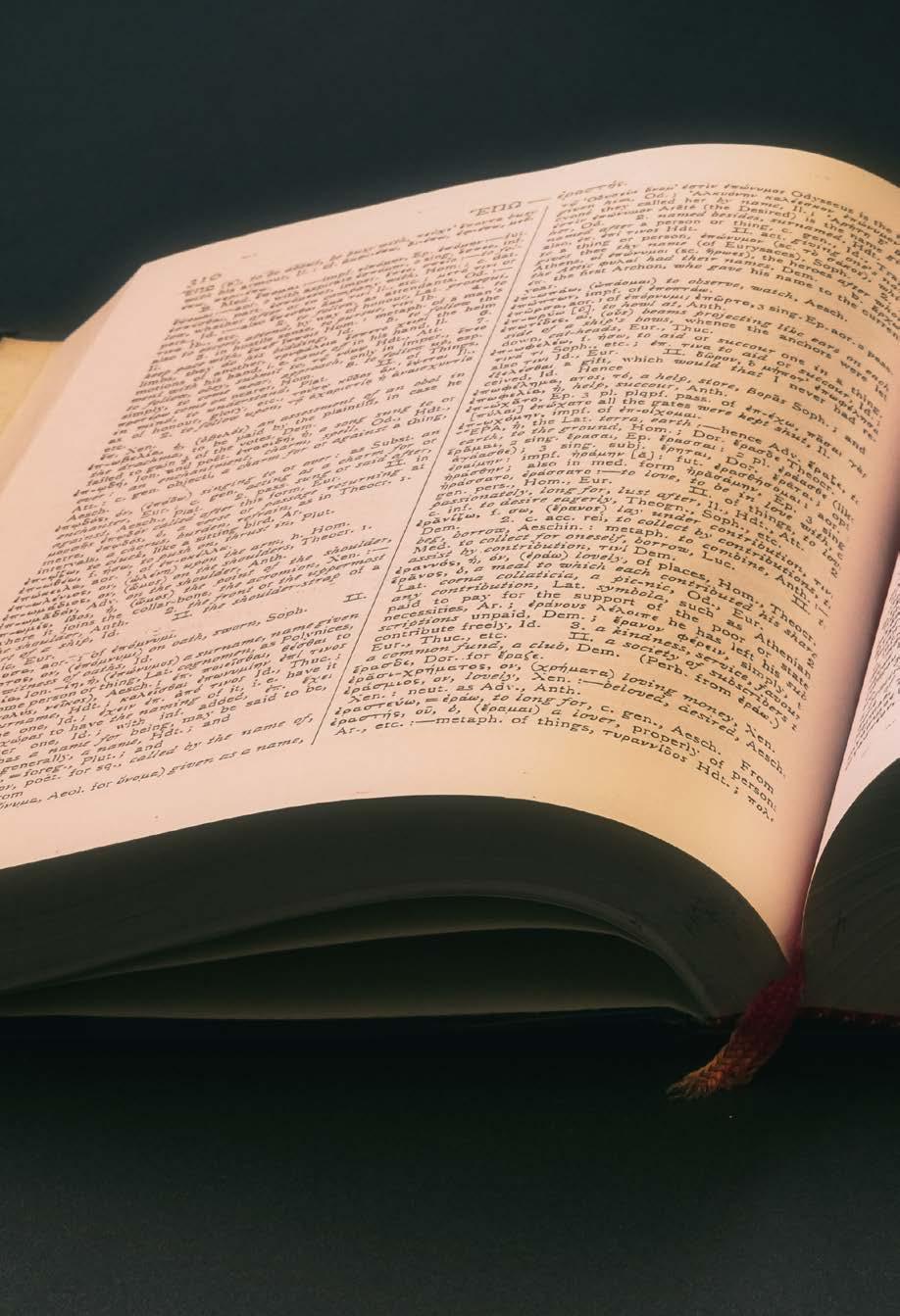


Un italiano su quattro presenta ridotte capacità nella lettura, nella matematica e nella risoluzione di problemi. Il nostro Paese sconta un grave ritardo nelle competenze cognitive rispetto alla media dei Paesi Ocse. La formazione continua potrebbe contrastare il fenomeno, ma ancora troppi ostacoli normativi e amministrativi frenano lo sviluppo dei Fondi interprofessionali. Il Rapporto di Fondoprofessioni
di Franco Valente direttore Fondoprofessioni

Il dato fa impallidire: un quarto degli adulti in Italia presenta scarse capacità nella lettura, nella matematica e nella risoluzione dei problemi. Secondo l’ultima Indagine sulle competenze degli adulti realizzata nell’ambito del Programma internazionale per la valutazione delle competenze della popolazione adulta (Piaac) dell’Ocse, in Italia il 35% delle persone di età compresa tra 16-65 anni ha un ritardo cognitivo (low performer) nella lettura e comprensione di testi (literacy), contro il 26% nella media Ocse e lo stesso risultato si registra per le capacità di utilizzo delle informazioni matematiche (numeracy), rispetto al 25% nella media Ocse; mentre sale al 46% nelle capacità di risolvere problemi in situazioni dinamiche (29% nella media
Ocse). Tirando le somme, in Italia circa un adulto su quattro mostra ridotte competenze in tutti e tre i domini cognitivi (literacy, numeracy e problem solving adattivo).
Sull’altro piatto della bilancia, le persone con alti livelli di competenze (high performer) nel nostro Paese sono significativamente mosche bianche: 5% nella lettura e comprensione dei testi (12% nella media Ocse), il 6% nell’utilizzo di informazioni matematiche (14% nella media Ocse) e appena l’1% nella risoluzione di problemi in situazioni dinamiche (5% nella media Ocse). I livelli più alti di competenza si riscontrano tra i più giovani (16-24 anni e 25-34 anni), mentre il punteggio diminuisce con l’aumentare dell’età, raggiungendo i valori più bassi tra i 55 e
i 65 anni. Una tendenza analoga emerge sul versante delle competenze digitali: in Italia, il 45,8% della popolazione possiede skill di base o superiori, contro il 55,6% della media Ue, con uno scarto di circa 10 punti percentuali.
Parte da qui il 2° Rapporto sulla formazione continua di Fondoprofessioni , presentato lo scorso 10 aprile a Roma presso il museo dell’Ara Pacis, per certificare il pesante ritardo dell’Italia nelle abilità cognitive ma anche per riflettere sullo sviluppo delle competenze (anche alla luce dei processi di digitalizzazione) e dell’accesso ai programmi di formazione negli studi professionali e nelle imprese di più piccola dimensione. «I dati del Rapporto
PUNTEGGI MEDI DEGLI ADULTI NELLE TRE AREE LITERACY, NUMERACY E ADAPTIVE PROBLEM SOLVING IN ITALIA E NEI PAESI OCSE, DIVISIONE PER CLASSE D'ETÀ
Fascia d'età 16-65 anni. Anno 2024.
Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Ocse - PIAAC
confermano il notevole gap del nostro Paese e ribadiscono l’importanza dell’aggiornamento formativo, per contrastare il processo di progressiva obsolescenza delle competenze, anche con riferimento al mutamento delle conoscenze e abilità necessarie a fronte della digitalizzazione dei processi di lavoro. Una questione quest’ultima ancor più importante se si considerano le caratteristiche demografiche del mercato del lavoro italiano, particolarmente sbilanciato verso le fasce di età più avanzate», osserva Marco Natali, presidente di Fondoprofessioni.
Per valutare l’accesso ai programmi di aggiornamento professionale, il 2° Rapporto di Fondoprofessioni ha esaminato i dati dell’indagine Eurostat Aes, focalizzandosi in particolare sulla formazione non formale di tipo job related. In Italia, il tasso di partecipazione si attesta al 27,9%, inferiore di circa 10 punti rispetto alla media Ue (37,1%) e di ben 26 punti rispetto alla Svezia (53,6%), che guida la classifica europea. Lo studio sottolinea il ritardo italiano nella formazione sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict). Nel 2024, solo il 17,9% delle imprese in Italia ha realizzato corsi Ict per il personale, a fronte del 26,4% in Germania, del 21,2% in Spagna e del 22,3% nella media Ue.
Il divario si fa ancora più evidente nelle imprese di piccola dimensione (10-49 dipendenti), dove la quota scende al 14,2%. Nelle aziende medie sale al 39,4%, mentre tra le grandi raggiunge il 67%.


Le micro-imprese (1-9 dipendenti), non incluse nell’analisi Eurostat, presumibilmente mostrano percentuali di formazione ancora più basse. L’importanza delle competenze digitali risulta ancora più evidente se si guarda all’adozione dell’intelligenza artificiale.
Secondo Eurostat, la percentuale di imprese europee che impiegano almeno una tecnologia basata sull’IA è salita dall’8% al 13,5% tra il 2023 e il 2024. In Italia, nel 2024, solo il 6,9% delle piccole imprese (10-49 dipendenti) utilizza sistemi di IA, rispetto al 14,7% delle medie e al 32,5% delle grandi. Ancora una volta, i dati sulle micro-imprese non sono disponibili, ma si ipotizza un tasso di adozione ancor più modesto.
IL RUOLO FONDI
Le micro e piccole imprese, tradizionalmente più deboli nell’accesso ai programmi di sviluppo delle competenze, rischiano di rimanere ulteriormente indietro in uno scenario in cui la terziarizzazione dell’economia rende sempre più centrale il ruolo del capitale umano. In questo contesto, i Fondi interprofessionali si confermano uno strumento fondamentale: stando al XXIII Rapporto Inapp del 2024, risultano iscritte 760 mila imprese, per un totale di oltre 10 milioni di lavoratori.
Il 45% delle aziende italiane aderisce a un Fondo, garantendo una copertura del 68% dei dipendenti. «Nonostante i risultati raggiunti in oltre vent’anni di attività, il sistema dei Fondi interprofessionali deve ancora superare ostacoli normativi e amministrativi che ne limitano il

pieno sviluppo», conclude Natali. «Resta molto ampio il margine di miglioramento, soprattutto sul fronte delle micro e piccole imprese, spesso inconsapevoli delle opportunità offerte dalla formazione finanziata. Un limite che, di fatto, frena la crescita delle competenze e la competitività dell’intero sistema economico italiano». ■
Fondoprofessioni si conferma il punto di riferimento per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, distinguendosi per la più alta percentuale di micro-imprese aderenti tra i Fondi interprofessionali. Il 93% delle strutture iscritte occupa da 1 a 9 dipendenti, e circa il 70% non supera i tre addetti, operando in una fascia dimensionale tradizionalmente meno propensa alla formazione continua. Nel 2024, il 62,5% delle nuove iscrizioni al Fondo proviene dal cosiddetto “inoptato”, ossia da studi e aziende che in precedenza non aderivano ad alcun Fondo interprofessionale. Un dato che evidenzia il potenziale inespresso della formazione finanziata tra le micro-imprese, che ancora faticano a coglierne le opportunità. Un’altra tendenza rilevante è l’aumento delle dimensioni

medie degli studi e delle aziende aderenti, un segnale dell’evoluzione organizzativa in corso nel tessuto economico italiano, con imprese sempre più strutturate in termini di forza lavoro. L’aumento delle adesioni ha portato a una crescita delle risorse derivanti dallo 0,30% del monte salari destinato alla formazione continua, con un incremento del 79,1% dei contributi assegnati rispetto al 2019. Tra le aree di formazione più richieste emergono due ambiti chiave: etica, responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, con un incremento del 174,5% dei corsi attivati rispetto al 2019; innovazione e digitalizzazione, che registra una crescita del 173,8%, in linea con le nuove esigenze del mercato del lavoro. Nel 2024, i corsi dedicati all’Ict e all’innovazione hanno rappresen-
tato il 18,8% dell’offerta formativa finanziata tramite i bandi, evidenziando il ruolo di Fondoprofessioni come facilitatore della trasformazione digitale nel settore. Le micro-imprese restano le principali beneficiarie dei fondi per la formazione: nel 2024 hanno rappresentato l’86,8% dei partecipanti agli avvisi a catalogo e il 64,7% ai bandi. Il settore professionale si conferma il più coinvolto (60% delle imprese partecipanti), seguito dai servizi di comunicazione e informazione (9,9%), dal commercio (7,7%) e dal manifatturiero (6,4%). Grazie a queste dinamiche, Fondoprofessioni si posiziona sempre più come un motore di sviluppo per le micro e piccole imprese, aiutandole a colmare il gap formativo e a restare competitive in un mercato in costante evoluzione. ■
TREND STORICO DELLE ADESIONI AI FONDI INTERPROFESSIONALI DI AZIENDE E LAVORATORI
Valori in migliaia. Anni 2003-2022.
Misure anticrisi (Finanziaria 2010 e successiva riforma AA.SS) con inclusione apprendisti e collaboratori
Eliminazione disincentivi alla mobilità tra fondi (L.2/09) ed estensione platea di imprese iscrivibili (DL112/08)
Comprese revoche e cessazioni
Escluse revoche e cessazioni
Escluse revoche e cessazioni definitive
Escluse revoche e cessazioni
Escluse revoche, cessazioni e sospensioni
Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Isfol e Anpal
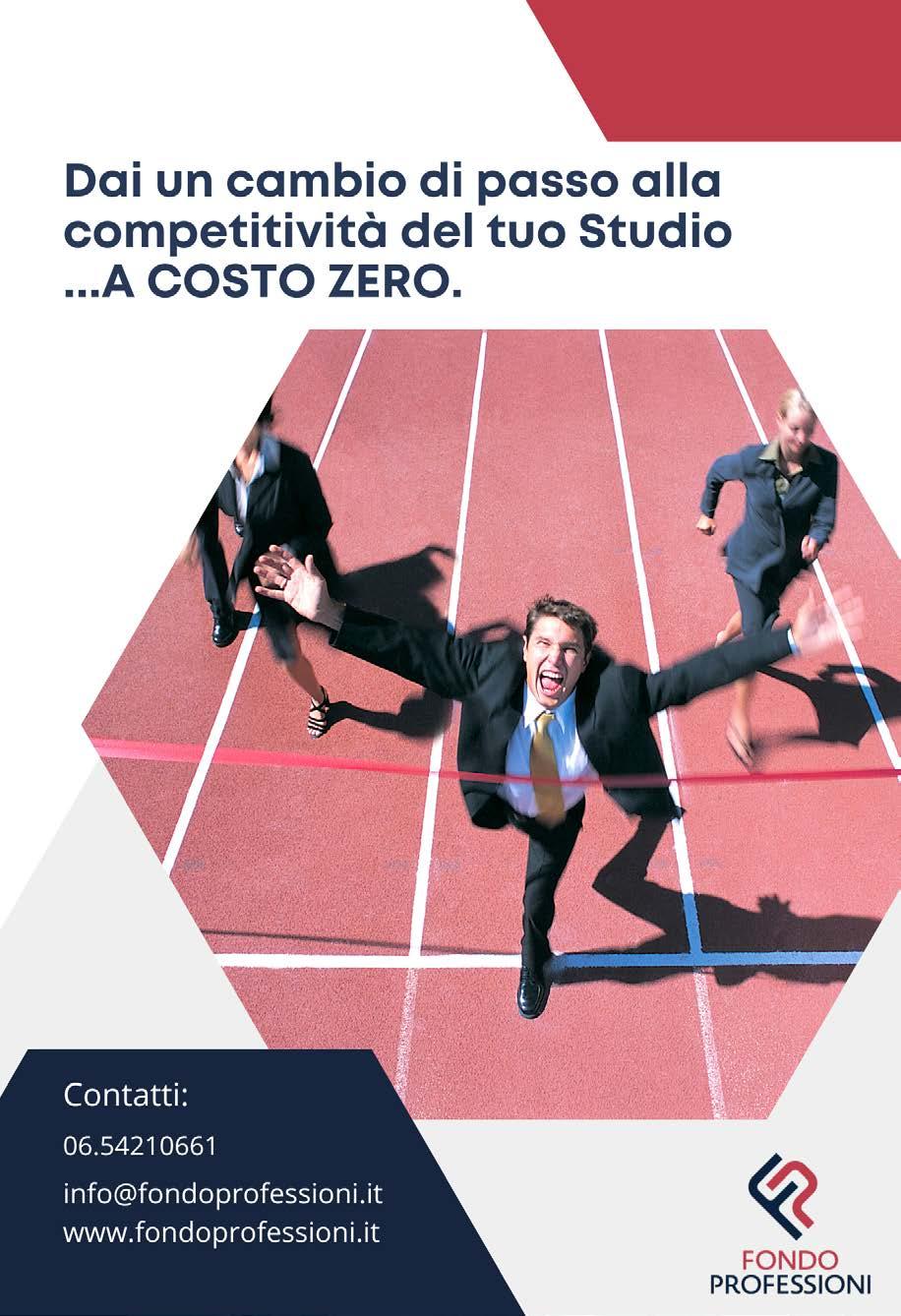
Numerosi ostacoli burocratici frenano l’accesso alla formazione nelle micro e piccole imprese.
Esenzioni contributive, incremento delle risorse e una revisione delle regole di funzionamento sono alcuni spunti emersi dal convegno di Fondoprofessioni
i quali Massimo Bitonci, sottosegretario del ministero delle Imprese e del Made in Italy; Virginio Merola, deputato Pd e componente della VI Commissione (Finanze); Maurizio Politi, esperto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre ai rappresentanti delle Parti sociali (Confprofessioni, Cgil, Cisl, Uil) e ad esperti in materia di formazione, lavoro e ricerca, quali Natale Forlani, presidente Inapp e Antonio Capone, direttore di Sviluppo Lavoro Italia.
di Mario Rossi
A25 anni dalla legge istitutiva dei fondi interprofessionali è arrivato il momento di fare un tagliando. I dati confermano che le piccole e micro aziende (tra cui gli studi professionali) ancora oggi affrontano ostacoli nell’accesso alla formazione. E per superare queste barriere, non basta migliorare la comunicazione sugli strumenti disponibili, ma bisogna affrontare i problemi pratici legati a costi, tempi e organizzazione del lavoro.
Tema spinoso quello al centro del convegno “La formazione continua tra opportunità da cogliere e ostacoli da rimuovere” organizzato da Fondoprofessioni lo scorso 10 aprile presso l’Ara Pacis a Roma, che ha riunito intorno al tavolo rappresentanti delle istituzioni tra
Numerosi gli spunti emersi per facilitare l’accesso alle attività formative da parte della fascia produttiva più estesa ma più debole, quella appunto delle piccole e micro aziende. Una possibile soluzione è l’introduzione di incentivi fiscali, come esenzioni contributive per chi partecipa a corsi di formazione. Modelli simili hanno già dimostrato efficacia in altri Paesi e potrebbero favorire una visione più ampia della formazione continua come strumento di welfare.
Altro aspetto riguarda l’aumento delle risorse destinate ai fondi interprofessionali: un incremento dell’aliquota obbligatoria, ad esempio allo 0,50%, potrebbe rappresentare un segnale forte di impegno per la formazione continua in Italia. Parallelamente, occorre ripristinare le risorse destinate ai fondi interprofessionali, che erano state ridotte dal prelievo forzoso della legge 190/2014. I tempi, però, sono cambiati e le attuali urgenze nel campo della formazione richiedono un pieno utilizzo delle risorse generate dalle aziende stesse. Un’altra questione rilevante riguarda poi l’applicazione della
normativa sugli aiuti di Stato, che può complicare l’accesso alla formazione finanziata, specialmente per le piccole imprese, a causa di un’eccessiva burocrazia che ostacola la possibile integrazione con gli strumenti contrattuali previsti dalla bilateralità.
Dal panel dei relatori, in particolare dalle Parti sociali, dunque, è emersa con forza la necessità di una revisione profonda delle regole di funzionamento dei Fondi per adattarsi alle evoluzioni del settore. «L’attuale distribuzione delle spese crea un onere burocratico che ostacola l’erogazione di risorse per la formazione», ha sottolineato il presidente di Fondoprofessioni, Marco Natali, che propone di utilizzare le risorse “inoptate”, quelle non assegnate ai Fondi, per incentivare le piccole strutture.
L’obiettivo è quello di ampliare la platea di beneficiari della formazione, coinvolgendo non solo i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi e i datori di lavoro delle piccole aziende. Una strada che presuppone un ritorno al dialogo concertativo tra le Parti sociali per garantire una maggiore rappresentatività e contrastare logiche commerciali dannose. In quest’ottica, l’idea di istituire una sede di coordinamento delle politiche formative, anche riesumando l’Osservatorio sulla Formazione Continua che ebbe poca vita nel 2004, che favorisca sinergie tra istituzioni e organismi coinvolti, ottimizzando l’uso delle risorse nazionali e comunitarie, può essere la chiave per assicurare un reale sviluppo della formazione continua nel contesto lavorativo italiano. ■


Marco Natali, presidente Fondoprofessioni
Massimo Bitonci, sottosgretario ministero delle Imprese e del Made in Italy
di Isabella Colombo
La riforma dei codici Ateco, in vigore da aprile, riflette i cambiamenti del lavoro, con nuove categorie per professioni emergenti e descrizioni più accurate per quelle che si trasformano. Un aggiornamento che non solo semplifica la classificazione delle attività a fini amministrativi, ma che offre anche una fotografia più precisa dell’evoluzione economica e professionale


Professioni che cambiano, lavori che si reinventano in nuove forme per soddisfare nuovi bisogni: il mondo del lavoro, in un’epoca di grande accelerazione tecnologica, è in continuo mutamento. Descriverne le varie sfaccettature non è facile, ma è necessario per dare ordine e struttura. Nasce da qui la revisione dei codici Ateco, quelle combinazioni alfanumeriche che individuano i settori di appartenenza, le categorie e le sottocategorie di ogni attività svolta da imprese e professionisti e che nel quotidiano servono per gli adempimenti fiscali e previdenziali, per esempio per emettere fatture o accedere a bandi pubblici.
LA NUOVA CLASSIFICAZIONE
Dal primo aprile, la nuova classificazione, modificata dopo molti anni, è in vigore. «Lo scopo è andare incontro alle esigenze dei lavoratori e rappresentare in maniera più adeguata i cambiamenti che intercorrono nella realtà economica nazionale e, statisticamente, i fenomeni economici nuovi e le attività ancora non classificate» spiegano Caterina Viviano e Francesca Alonzi, coordinatrici del comitato istituito dal presidente dell’Istat e composto da esperti statistici, rappresentanti dei principali enti amministrativi e delle organizzazioni imprenditoriali. L’Istat è il responsabile della classificazione Ateco che utilizza per finalità statistiche.
La nuova classificazione ha introdotto parecchie novità. Per esempio, sono state inserite numerose attività relative ai servizi di intermediazione, come nel
caso dell’ospitalità extralberghiera e della ristorazione, settori che sul web hanno avuto una grande espansione negli ultimi anni. Poi, è stata annullata la distinzione tra le attività economiche svolte online e non.
NUOVI LAVORI, NUOVI CODICI
Anche molte attività economiche svolte prevalentemente da professionisti, quindi in forma individuale, sono state coinvolte dal processo di revisione. Per esempio, hanno adesso un codice e una descrizione più specifica attività come la consulenza in materia di project management per la gestione di progetti che prima rientrava nella sottocategoria generica “Altre attività di consulenza imprenditoriale” o il wedding planner che in passato rientrava sotto un generico “Organizzazione di feste e cerimonie”. Lo stesso vale per attività come kinesiologia, counselling, consulenza familiare, toelettatura per animali e tante altre.
NUOVE PROFESSIONI DIGITALI
«Per chi lavora nel web, adesso c’è una netta distinzione tra attività editoriale e attività informatica» spiega Angela Amato, dottore commercialista specializzata in consulenze fiscali per business online. «E se prima gli informatici rientravano nella macro categoria degli artigiani, adesso ne hanno a disposizione una dedicata alle attività di programmazione e ai relativi servizi».
L’impatto di questi cambiamenti non è solo formale, ma anche sostanziale. «Ateco 2025 riconosce nuove professioni emergenti, come influencer marketing


e content creator digitali, che probabilmente dovranno essere riclassificati in virtù delle maggiori specificazioni offerte dalla nuova classificazione» spiegano le esperte dell’Istat. «Inoltre, alcune attività professionali potrebbero vedere una ridefinizione o un aggiornamento dei propri codici per meglio rispecchiare la natura dei servizi offerti».
La classificazione di “influencer marketing”, professione oggi chiave nel digitale, è una delle grandi novità di Ateco 2025. «L’assenza di una specifica descrizione ha portato fino a oggi molte incertezze nell’inquadramento fiscale e previdenziale di questi lavoratori che hanno sempre dovuto usare codici preesistenti» spiega Amato. «Per esempio, quelli relativi a “Ideazione di campagne pubblicitarie” o “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari” che non rispecchiavano esattamente la loro attività, generando quindi ambiguità.
Avere un codice molto vicino alla propria attività dà adesso a questi lavoratori la possibilità per esempio di accedere a fondi statali che vengono concessi proprio in base a codici specifici».
Altre professioni del web, come i creator digitali, rientrano nella stessa descrizione e altre ancora, come i blogger indipendenti, che prima rientravano in un generico “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”, adesso hanno un codice apposito nell’area delle “Attività di creazione artistica e rappresentazioni artistiche”.


«Naturalmente non è sempre facile districarsi tra gruppi, categorie e sottocategorie» continua Amato. «Anche perché la scelta, al di là della professione, dipende dal tipo di attività realmente svolta e a seconda che si lavori in maniera autonoma o all’interno di un’organizzazione imprenditoriale.
Per questo è sempre consigliabile far precedere la scelta del codice Ateco da un’analisi effettiva e prospettica del proprio lavoro e dalla consulenza di un professionista in tematiche fiscali». E poi, comunicarla non solo ad Agenzia delle Entrate e Camere di Commercio ma anche all’Istat per i fini che non sono affatto secondari. «La classificazione delle attività economiche rappresenta il quadro di riferimento per la raccolta e la presentazione di un’ampia gamma di dati, per esempio su produzione, occupazione e conti nazionali» precisano Viviano e Alonzi.
Un provvedimento fondamentale per raccogliere e presentare dati su produzione, occupazione e conti nazionali, permettendo di comparare i numeri italiani a livello europeo e internazionale, contribuendo così a rappresentare e interpretare i fenomeni economici nuovi che governano un mondo del lavoro sempre più complesso. ■
Caterina Viviano, Istat
Francesca Alonzi, Istat

Il testo di proposta di riforma
dell’ordinamento forense presentato dal Consiglio Nazionale Forense appare non condivisibile nella sua impostazione generale, nel metodo e nel merito.
Una visione ottocentesca della professione, interamente concentrata sulla difesa in giudizio e inadeguata alle esigenze di una moderna avvocatura
di Giampaolo Di Marco
Segretario generale Associazione nazionale forense

L’avvocatura italiana aspetta da oltre dodici anni una riforma della sua legge professionale, poiché la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 è una disciplina nata già superata, che presentava fin dal momento della approvazione, un gran numero di criticità e che in questi anni non è di certo invecchiata bene.
Quella legge professionale fu approvata nell’ultimo giorno della XVI legislatura, il 21 dicembre 2012, senza che fosse possibile una reale discussione parlamentare sulle modifiche che sarebbero state indispensabili per migliorarne l’impianto.
Ora parrebbe volersi un confronto parlamentare, ma non un confronto con i destinatari della riforma. Il testo che ci viene presentato oggi, però, di certo non rappresenta la risposta che l’avvocatura aspettava, dato che esso continua a riproporre tutte le incrostazioni corporative presenti nella legge vigente e – se possibile – riesce persino a peggiorarla.
Dalle istituzioni forensi, alle aggregazioni, dalle incompatibilità, ai contratti di rete, dall’abolizione del divieto del doppio mandato all’assenza di chiari riferimenti all’intelligenza artificiale, un testo privo di prospettiva e di un progetto di un’avvocatura del futuro.
L’attuale Legge professionale soffre di una impostazione CNF-centrica del tutto inadeguata alle esigenze di una moderna avvocatura. Il Consiglio Nazionale Forense, organo elettivo di
secondo grado (con elettorato attivo riservato ai soli consiglieri degli ordini circondariali), veste funzioni giurisdizionali, regolamentari ed amministrative affidate ai medesimi consiglieri, senza alcuna reale separazione interna di funzioni. Ciò rende l’attuale governance dell’avvocatura incompatibile, tra l’altro, con il dettato dell’art. 111 della Costituzione (e con i Trattati dell’Unione Europea).
È necessario introdurre una netta separazione fra la funzione giurisdizionale speciale e le funzioni regolamentari e amministrative, finalizzata a tutelare l’autonomia, l’indipendenza, l’imparzialità e la terzietà del CNF e dei suoi componenti nell’esercizio della giurisdizione disciplinare (cfr. Corte Cost. 6 luglio 1970, n. 114).
Le ipotesi di abolizione o estensione del limite dei mandati per i consigli dell’ordine, poi, appaiono essere semplicemente irricevibili.
Deve anche osservarsi che, nella proposta di riforma manca ogni richiamo (attualmente previsto dalla vigente Legge professionale) alla normativa sovranazionale. Ciò comporta il rischio di porsi fuori dalla prospettiva europea.
In questo senso appare ben poco condivisibile la scelta di indicare quale perimetro in cui deve muoversi il legale “la realizzazione della giustizia”, in quanto richiama un valore di tipo pubblicistico che non si adatta in alcun modo al ruolo di parte che il legale deve avere all’interno del processo. La giustizia, che è funzione stata-
le, non può trovare condivisione nell’operato di una parte privata, salvo ritenere che esista un valore superiore, e un bene superiore, rispetto a quello individuale fatto valere secondo le regole di diritto.
Questa impostazione richiama una filosofia illiberale, fortemente orientata all’affermazione di valori pubblicistici di tipo etico a discapito di quelli individuali attinenti alla tutela della persona.
AGGREGAZIONI NON PERVENUTE
La proposta di riforma – al pari della vigente Legge professionale – sposa un approccio ispirato ad una visione ottocentesca della professione, interamente concentrata sulla difesa in giudizio. Manca il minimo riferimento alla tutela degli interessi fuori dalla giuri-
sdizione salvo il cenno ai procedimenti amministrativi di natura contenziosa e, più in generale, ai modi di svolgere la professione che non siano ascrivibili alla funzione dell’avvocato come sacerdote del processo.
Le aggregazioni professionali rappresentano uno strumento necessario per lo sviluppo e la crescita delle libere professioni. Nell’azione legislativa degli ultimi anni è evidente che anche il legislatore è consapevole dell’importanza di favorire le aggregazioni professionali al fine di sviluppare e rendere maggiormente competitivo il mercato delle professioni. Purtroppo, la proposta di riforma sposa ancora una volta un modello superato e scarsamente dinamico di disciplina delle aggregazioni. La

principale forma di aggregazione professionale forense che viene prevista è ancora quella della “associazione professionale forense” (art. 14): un ferrovecchio, che dovrebbe essere eliminato utilizzando gli ordinari strumenti di aggregazione esistenti per tutte le altre attività economiche.
Per l’esercizio della professione in forma societaria si prevede nuovamente che la Sta (Società tra avvocati) sia l’unica modalità di esercizio, rinnovando il divieto di partecipazione alle Stp (Società tra professionisti) di cui alla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (a cui gli avvocati vi possono partecipare “solo per l’esercizio dell’attività di consulenza”, secondo quanto previsto all’art. 16).
Quello che si dovrebbe fare è esattamente il contrario: abolire le Sta e prevedere che il modo di esercizio in forma societaria della professione forense sia la Stp, anche multidisciplinare.
I liberi professionisti, oggi, hanno la possibilità di svolgere la professione in forma individuale, aggregata, in associazioni professionali, in società Stp, e Sta per quanto riguarda gli avvocati, anche multidisciplinare.
Tuttavia, l’utilizzo di questi strumenti risulta penalizzato dalla mancata armonizzazione della normativa fiscale e previdenziale, che determina, in diverse ipotesi, il duplicarsi di costi. Anche per queste ragioni il ricorso all’esercizio della professione in forma aggregata continua ad avere una

valenza residuale rispetto a quello in forma individuale. Appare necessario integrare la Legge professionale introducendo la possibilità per gli avvocati di costituire reti di impresa anche pluridisciplinari, nella forma di reti soggetto pure, cioè tra soli professionisti.
È da tempo, poi, avvertita l’esigenza di una revisione della disciplina dell’incompatibilità della professione di avvocato alla luce dell’evoluzione della professione e dei cambiamenti sociali, che impongono agli avvocati di estendere le loro attività anche a settori limitrofi rispetto al perimetro classico delle attività forensi, senza incontrare limiti irragionevoli e che li pongano in situazioni di svantaggio competitivo rispetto ad altri attori presenti sul mercato. ■

di Diego Apostolo
componente
Non più solo beni mobili e immobili. Da oggi è possibile lasciare agli eredi anche file, software e documenti informatici, nomi a dominio associati a siti web, account di posta elettronica e relativi contenuti. Ma anche profili social e dati personali collegati, account finanziari, e-commerce fino alle criptovalute. In attesa di una normativa unica europea ogni paese adotta strumenti diversi per garantire il passaggio dei beni digitali. Italia compresa
L’eredità digitale è una realtà sempre più rilevante ma ancora poco regolamentata e spesso trascurata. Se fino a qualche decennio fa il patrimonio ereditario era composto esclusivamente da beni materiali (immobili, conti bancari, gioielli …), oggi il concetto si è ampliato fino a includere anche asset digitali di varia natura. Dati, account, contenuti social, blog, criptovalute e molto altro fanno parte di ciò che una persona lascia ai propri eredi, ma la loro gestione post-mortem è tutt’altro che scontata.
L’eredità digitale rappresenta un concetto ampio e comprende beni di natura patrimoniale, ossia con un valore economico, e non patrimoniale, legati a interessi morali, affettivi o familiari. Tra gli elementi che possono rientrare in questo concetto, troviamo: file, software e documenti informatici (archiviati su computer, smartphone o cloud); nomi a dominio associati a siti web; account di posta elettronica e relativi contenuti; profili social e dati personali collegati; Account finanziari, e-commerce e di pagamento elettronico; criptovalute, che rappresentano un bene digitale con valore economico. Restano invece esclusi dall’eredità digitale contenuti piratati o concessi in licenza (come musica, film o e-book con abbonamento); account di firma elettronica e identità digitale; conti bancari online, che seguono le normali regole della successione ereditaria.
REGOLE FRAMMENTATE
La mancanza di una normativa chiara in materia, unita alla frammentazione delle regole tra Stati e

piattaforme online, rende necessaria una riflessione approfondita per garantire che le proprie volontà vengano rispettate e che i propri beni digitali non vadano persi.
A oggi, né l’Italia né l’Unione Europea hanno una legislazione specifica sull’eredità digitale. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Gdpr) del 2016 tutela la privacy delle persone fisiche, ma non si applica ai defunti, lasciando ai singoli Stati la possibilità di stabilire norme specifiche. Il Codice della Privacy italiano, dal canto suo, riconosce il diritto degli eredi di accedere ai dati personali del
defunto, salvo che quest’ultimo non abbia espresso una volontà contraria con una dichiarazione scritta. A complicare ulteriormente il quadro vi è il fatto che molte delle piattaforme digitali che utilizziamo quotidianamente hanno sede al di fuori dell’Unione europea e applicano regole diverse in base alle proprie policy aziendali.
Senza una normativa univoca, il rischio è quello di dover affrontare lunghe e costose dispute legali per poter ottenere l’accesso ai beni digitali di un proprio caro scomparso. Alcuni grandi player del digitale hanno iniziato a prevedere strumenti specifici per la gestione degli account in caso di decesso. Tra le opzioni disponibili si possono trovare: la cancellazione automatica degli account (prevista, ad esempio, da piattaforme come

affrontare lunghe e costose dispute legali per poter ottenere l’accesso ai beni
Facebook ora Meta, Instagram, LinkedIn, Google, Yahoo, PayPal e Netflix); la trasformazione in profilo commemorativo (possibile, per esempio, su Facebook, Instagram e LinkedIn), per consentire ai familiari di mantenere vivo il ricordo del defunto; la designazione di un contatto erede (come previsto da Apple), che permette di scegliere una persona di fiducia a cui lasciare l’accesso ai propri dati digitali.
Queste soluzioni, tuttavia, non garantiscono una piena tutela delle volontà del defunto né la possibilità di trasmettere i beni digitali con valore economico ai legittimi eredi. Per tale motivo è fondamentale adottare strumenti giuridici adeguati per la gestione dell’eredità digitale.
LA SITUAZIONE IN ITALIA
Nel nostro ordinamento esistono due principali strumenti per garantire il passaggio dell’eredità digitale. Il mandato post mortem exequendum è un contratto attraverso il quale una persona designa un fiduciario incaricato di “gestire” i propri beni digitali dopo il decesso. La soluzione risulta utile al fine di preservare dati e risorse digitali con valore affettivo, familiare o economico.
A tale riguardo è importante ricordare che le password non rientrano tra i beni ereditabili e che affidarle a qualcuno non implica automaticamente la trasmissione dei diritti sulle risorse a cui danno accesso. Inoltre, un profilo di attenzione relativo a tale opzione giuridica è che le chiavi di accesso (user Id e password, o credenziali) vanno aggiornate periodicamente


per evitare il rischio di perdere l’accesso ai dati. Il testamento, altra possibile soluzione in risposta a esigenze di pianificazione successoria avente a oggetto entità digitali, resta lo strumento maggiormente efficace per designare il beneficiario dell’eredità digitale, fornendogli anche le istruzioni di accesso. È possibile indicare nel testamento specifici account, dati o criptovalute da trasmettere agli eredi, garantendo così una successione più ordinata e sicura.
Data la rapidità con cui la nostra vita si sta digitalizzando, è sempre più importante preoccuparsi per tempo della gestione della propria eredità digitale. Per aiutare cittadini e professionisti ad affrontare questo tema, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul sito www.notariato.it un decalogo aggiornato sull’argomento.
Il documento, che tiene conto delle più recenti evoluzioni normative, rappresenta una guida essenziale per comprendere e pianificare al meglio la gestione del proprio patrimonio digitale.
Sebbene il quadro normativo e giurisprudenziale sia ancora in evoluzione, è già possibile adottare strumenti concreti per garantire che i propri beni digitali non vadano perduti e che le proprie volontà vengano rispettate.
Pianificare l’eredità digitale è una scelta di responsabilità che permette di evitare controversie e di proteggere ciò che, sempre più spesso, rappresenta una parte importante della nostra identità e del nostro patrimonio. ■

E' già
adottare strumenti concreti per garantire che i propri beni digitali non vadano persi
PER TUTTI I PROFESSIONISTI
Garanzie a tutela della salute e dello studio
Prestazioni in Convenzione Unisalute
Prestazioni a Rimborso
Gestione Professionisti
Cyber Risk

Rimborsi per Spese Odontoiatriche

Convenzioni
Coperture automatiche per i datori di lavoro e volontarie per tutti i Professionisti, attivabili autonomamente dalla piattaforma con versamento di un contributo annuale
BASE € 48
UPGRADE € 24
PREMIUM € 72
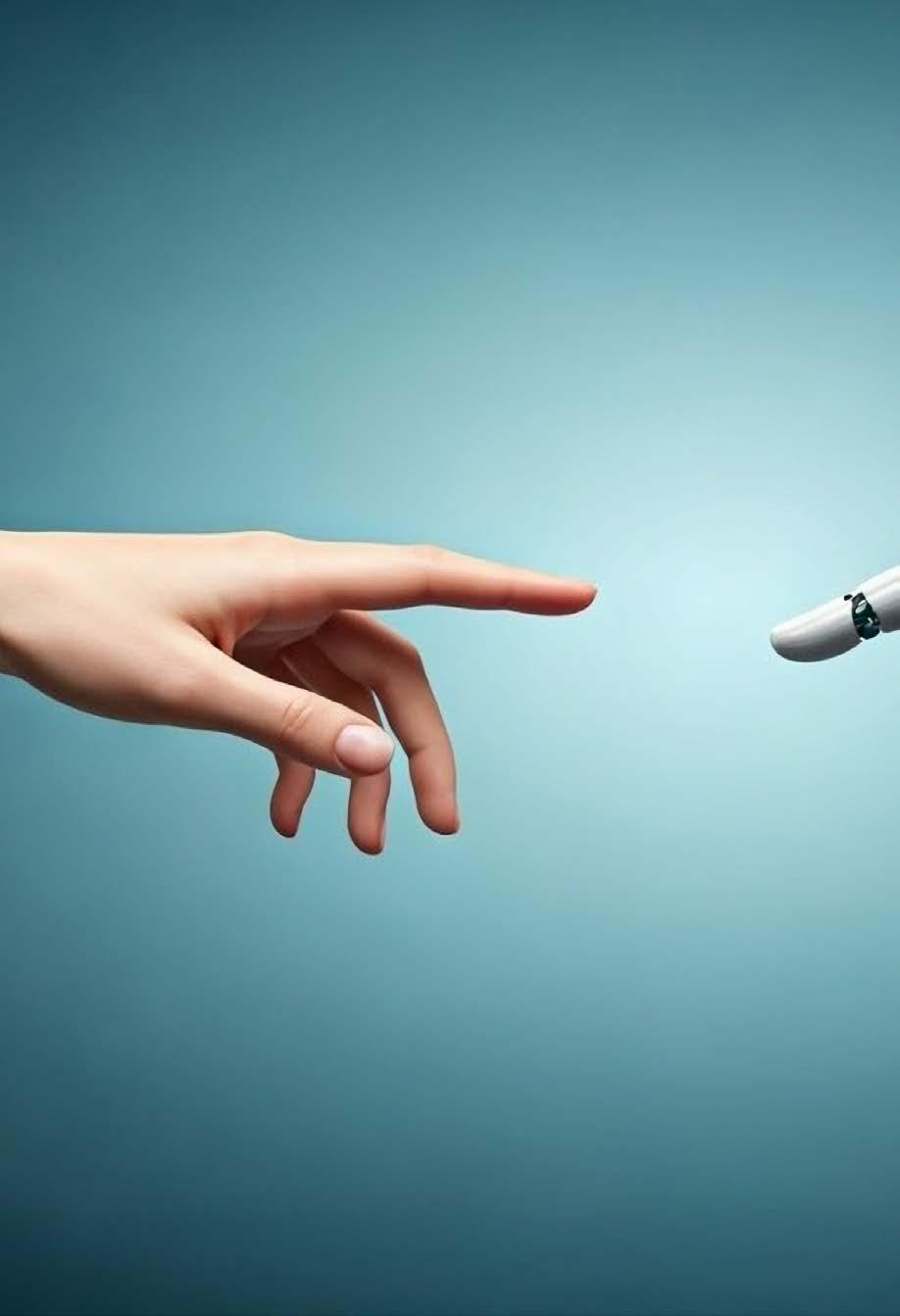
L’irresistibile avanzata dell’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche i percorsi formativi universitari. Nel 2023 i laureati in discipline scientifiche hanno superato quelli in letteratura e i corsi Stem hanno il più alto tasso di occupazione. C’è chi imputa il declino del sapere umanistico alla crisi del sistema della formazione terziaria; ma nelle università si scommette sull’integrazione tra materie umanistiche e competenze digitali

Alph versus Stem. Così, a prima vista, potrebbe sembrare il nome dell’ennesimo figlio di Elon Musk. Invece, stiamo parlando di studi universitari e di una partita che sembra essere già chiusa: Stem batte Alph 1 a 0.
Alph è infatti l’acronimo di Art, Literature, Philosophy, History: ovvero di quelle lauree umanistiche considerate sempre meno attraenti, perché, per quanto garantiscano una preparazione culturale estremamente ampia e versatile, vengono considerate di scarsa efficacia per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Le più famose Stem, invece, sono le famigerate Science, Technology, Engineering, Mathematics, ovvero quelle materie che garantirebbero un futuro “sicuro”, più roseo e profittevole.
I dati, in effetti, sembrano protendere tutti dalla parte delle Stem. Secondo il rapporto AlmaLaurea 2024, su 295.104 laureati in Italia nel 2023, ben 81.936 hanno conseguito il titolo in discipline scientifiche, mentre 62.487 hanno in tasca una laurea in materie artistiche e letterarie.
Il motivo è presto detto. I corsi universitari con il più alto tasso di occupazione a 5 anni dal conseguimento del titolo sono - in quest’ordine - Ingegneria industriale, Informatica, Economia (anche se quest’ultima non rientra propriamente nelle Stem). Guardano la classifica capovolta troviamo Giurisprudenza all’ultimo posto, Lettere e Filosofia al penulti-
mo, Arte e Design subito prima. E nel prossimo futuro la tendenza non sembra subire inversioni di rotta: secondo Skuola.net, tra i percorsi Stem - che dovrebbero offrire 72/82 mila posti di lavoro l’anno - quelli che spiccano di più in termini di fabbisogno atteso dal mercato del lavoro sono gli indirizzi ingegneristici (circa 36/41 mila nuove unità l’anno).
Anche come prospettive economiche le discipline umanistiche non promettono benissimo: Scienze dell’Antichità, Storia e Filosofia e Psicologia sono le lauree meno remunerative, con retribuzioni medie inferiori a 31mila euro l’anno (fonte Osservatorio Job Pricing).
In un mondo del lavoro che si affaccia all’annunciata rivoluzione dell’intelligenza artificiale,
dobbiamo pensare che soltanto puntare sulle Stem possa essere la salvezza? Oppure le cosiddette soft skills - come empatia, creatività, spirito d’iniziativa, originalità, flessibilità, profondità di sguardo… - più tipiche delle formazioni umanistiche potrebbero diventare requisiti sempre più ricercati - perché unici e molto “umani” - in qualsiasi tipologia di settore professionale?
Per rispondere a questa domanda bisogna iniziare con una riflessione più strutturale sul sistema universitario italiano con un occhio particolare rivolto alle discipline Alph. Ci aiutano Giovanni Belardelli, Ernesto Galli della Loggia e Loredana Perla autori del saggio di freschissima uscita (per Rubbettino editore) “Università addio. La crisi del sapere umanistico in Italia”.
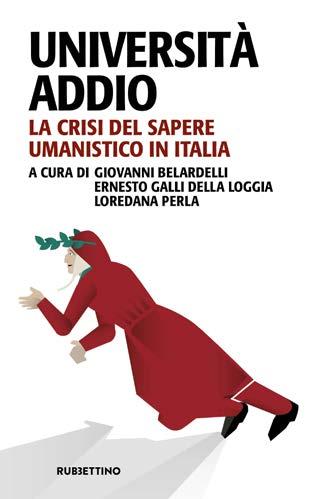
LA LENTA AGONIA
«Figlia essa per prima dell’umanesimo europeo, l’università come istituzione ha nell’umanesimo il suo cuore, il cuore della propria identità. Ma a dispetto di tutto ciò negli atenei italiani odierni le discipline umanistiche stanno agonizzando», spiega della Loggia.
«Il numero dei loro docenti, il loro rilievo, la loro capacità caratterizzante ogni singolo ateneo diminuiscono a vista d’occhio. Per almeno due ordini di ragioni. Non ne vogliamo sapere più nulla di tutto quanto non sia traducibile subito in qualcosa di concretamente utile. Ci sembra superfluo, senza scopo, qualunque sapere che non serva a inventare, a produrre o a migliorare una merce o un qualunque servizio, sanitario o finanziario che sia, ovvero che non attenga al diritto, che come ognuno sa è indispensabile a qualunque aspetto della vita sociale. Un’idea di modernità considerata unicamente sotto la specie della ragione strumentale e quindi della tecno-scienza domina ormai incontrastata l’istruzione di ogni ordine e grado. Anche perché solo un’istruzione di questo tipo sembra capace di presentarsi sotto la veste accattivante di ciò che chiede il sempre invocato mondo del lavoro», sostiene della Loggia. «Il veloce declino delle Humanities, proprio per il loro carattere di elemento storicamente costitutivo dell’istituzione universitaria, è il sintomo più significativo della crisi complessiva che affligge l’Università del nostro Paese. Ma è solo il sintomo. Nel determinare la crisi attuale che travaglia l’Università un effetto più immediato va fatto
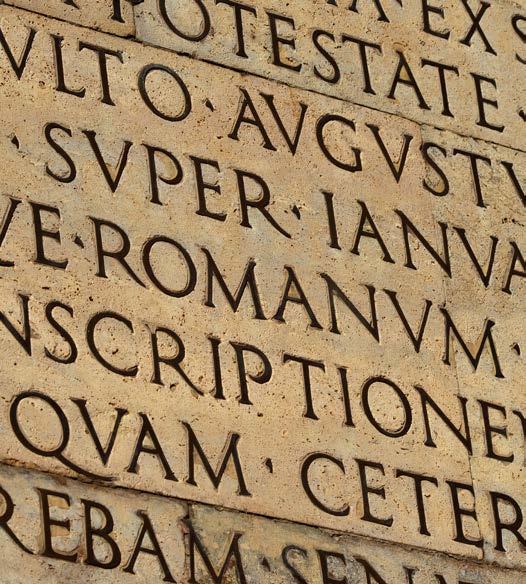

risalire ad alcune scelte che in vario modo hanno snaturato la vita degli atenei. La prima di tali scelte è consistita nell’introduzione del “3+2” con il relativo e immediato fallimento del nuovo dispositivo dovuto ai pochissimi studenti decisi a fermarsi alla laurea triennale, ridotta quindi al rango di un’assoluta inutilità o quasi».
Continua Della Loggia: «Se rinuncia a coltivare i saperi di base, se toglie il suo supporto alla ricerca libera che non produce immediatamente effetti e ricadute sul sistema produttivo, se si riduce semplicemente a formazione delle classi dirigenti, l’università tradisce la sua missione millenaria. Il declino, in alcuni casi il crollo, dei settori umanistici in generale, e in particolare, all’interno di questi, degli ambiti meno “applicativi” mostra come il sistema universitario e chi lo ha governato in questi anni considerino le fondamenta della cultura umanistica classica: un qualcosa in più, un lusso che è possibile permettersi ma con accortezza».
L’AUDACE INCROCIO
Il severo giudizio di Della Loggia sembra condannare i cultori di Dante e i figli della ragion pura in un eremo fuori dal tempo, un’élite del sapere avulsa dall’imperante logica del profitto e indifferente ai freddi algoritmi che oggi regolano un mercato del lavoro sempre più proteso verso la sostituzione tecnologica delle abilità e delle competenze umane.
Eppure, c’è una strada per evitare che le materie umanistiche vengano liquidate come un “lusso”

e vengano invece rivalutate per sbocchi professionali: abilitarle con competenze digitali. L’intersezione tra discipline umanistiche e tecnologie dell’informazione, del resto, non è una novità in ambito accademico.
I primi studi sull’informatica umanistica risalgono a metà degli anni ’40 e nel corso degli anni si è sviluppata una fiorente letteratura scientifica, che trova tra i suoi epigoni Patrik Svensson e Davide Theo Goldberg, autori del libro “Between humanities and the digital”, pubblicato nel 2015 per documentare come gli studiosi delle discipline umanistiche si siano rivolti alle tecnologie digitali come strumento di ricerca, ma anche come materia di studio da analizzare.


A partire dal 2018, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ha introdotto una laurea magistrale internazionale in “Digital Humanities and Digital Knowledge”, un percorso formativo trasversale pensato per valorizzare la crescente interconnessione tra discipline umanistiche e informatiche, che negli ultimi tre anni ha “sfornato” circa 350 laureati con un tasso di occupazione che oscilla intorno all’85%. Tra le iniziative più recenti, c’è da segnalare il master “HumanAIze: le scienze umane e sociali per l’intelligenza artificiale”, un’iniziativa lanciata nel 2023 dal Politecnico e dall’Università degli Studi di Torino per favorire l’integrazione tra discipline umanistiche e competenze digitali, con un focus particolare sull’Intelligenza artificiale e alla Digital Transformation.
«Questo Master - ha spiegato durante la presentazione il professor Paolo Neirotti, Direttore della Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico - rappresenta un interessante fronte di collaborazione con l’Università di Torino, visto l’obiettivo di creare profili capaci di avere un linguaggio comune con gli specialisti dell’AI. Le imprese infatti ritengono che il substrato di conoscenze provenienti dai corsi di laurea in scienze umane e sociali rappresenti una componente significativa per poter costruire queste nuove professionalità. Ci auguriamo che questa esperienza insieme all’Università sia la prima di una serie più lunga di percorsi specialistici orientati a formare figure ibride». Incrociamo le dita. ■
di Simona Laderchi
Tre quarti dei professionisti lavora almeno quattro giorni alla settimana in studio. Risultati confermati anche da una recente survey di Wolters Kluver. Archiviata l’urgenza dettata dalla pandemia, i liberi professionisti sono tornati alle modalità di lavoro tradizionali. Ma la tendenza non piace ai più giovani che chiedono più equilibrio tra lavoro in presenza e flessibilità. Il rischio? Allontanarli ancora di più dall’attività professionale


Il mondo della libera professione si trova ad affrontare uno scenario sempre più complesso, caratterizzato da trasformazioni epocali che coinvolgono aspetti tecnologici e organizzativi. Per restare competitivi sul mercato e per tornare a essere attrattivi per i giovani contrastando la tendenza alla mancanza di vocazione alla libera professione, è necessario un approccio globale che combini competenze tecniche e cultura organizzativa, con l’obiettivo di creare un sistema lavorativo più sostenibile, innovativo e orientato ai risultati. Ma la realtà è ancora lontana da tutto questo. A oggi, infatti, il futuro della libera professione si articola su due direttrici: l’adozione dell'intelligenza artificiale e la necessità del ritorno a un modello lavorativo più incentrato sulla presenza fisica. Quest’ultimo trend sta portando alcuni paesi come Francia e Italia a limitare se non addirittura a eliminare la possibilità di operare in smart working. Tanto che stando ai risultati di un nostro recente sondaggio effettuato tra clienti e candidati, tre quarti dei professionisti lavora ormai almeno quattro giorni alla settimana in studio. Risultati confermati anche da una recente survey effettuata da Wolters Kluver, società olandese di servizi di informazione per il mercato legale, fiscale, finanziario e sanitario.
Un ritorno alla normalità, dunque, che però solleva dubbi in relazione all'organizzazione degli spazi di lavoro e al bilanciamento tra collaborazione e flessibilità. La pandemia ha trasformato radicalmente il modo di lavorare, ma oggi
si assiste a un graduale ritorno alla presenza fisica, accolto non senza polemiche e con una certa opposizione in particolare da parte dei più giovani che contestano il fatto che si tratti di una necessità e la interpretano piuttosto come un retaggio culturale. La pandemia ha avuto un impatto molto forte sul mercato del lavoro e ha prodotto effetti notevoli sulle modalità lavorative dei professionisti mutandone, forse in maniera definitiva, logiche e dinamiche. La nostra indagine sul graduale ritorno alla normalità e con essa alle tradizionali modalità di lavoro in presenza ha svelato difficoltà nell'approccio e nella gestione delle dinamiche di


incontro di persona, soprattutto da parte dei professionisti più giovani, presumibilmente per mancanza di abitudine a modalità di relazione diretta e non mediata dai mezzi tecnologici, se non per una quasi totale assuefazione alla tecnologia. La transizione tecnologica è una necessità ineludibile, tuttavia il suo uso massiccio ed esclusivo sembra rendere difficoltosa la gestione del ritorno a una vita lavorativa di relazione in presenza.
La criticità relativa al mancato adeguamento del giovane professionista alla cultura dell'organizzazione lavorativa nella quale entra o rientra a far parte produce come effetto un diffuso disagio personale e professionale che può rivelarsi a medio e lungo termine un limite alle possibilità di crescita e alle opportunità di carriera.
La sfida da cogliere per attrarre i giovani talenti verso le professioni passa proprio attraverso la capacità di condivisione del quadro valoriale e della cultura di riferimento. Abbiamo chiesto agli intervistati di indicare gli elementi positivi di un ambiente lavorativo nel quale volentieri svolgerebbero l’attività professionale in presenza e hanno risposto:
▪ migliore opportunità di apprendimento accanto al “dominus” e ai professionisti più esperti;
▪ possibilità di creare un confine tra lavoro e vita privata, riducendo la probabilità di portare a casa lo stress legato al lavoro;
▪ maggiore visibilità e apprezzamento del proprio lavoro per una progressione più rapida di carriera;
▪ possibilità di interazione sociale con i colleghi in momenti non programmati (pausa caffè) per avere modo di creare relazioni interpersonali significative e migliorare il senso di appartenenza, difficilmente attuabile in un ambiente remoto.
In merito agli elementi considerati problematici nel ritorno in ufficio segnaliamo: costi di spostamento per il tragitto casa-lavoro, onerosi
non solo dal punto di vista economico ma anche in termini di tempo e di stress; riduzione del livello di flessibilità lavorativa, ossia limitazione dell’autonomia nella gestione e distribuzione degli orari di lavoro.
Abbiamo infine chiesto le strategie per superare la resistenza da parte dei giovani al ritorno al lavoro in presenza e le risposte sono state le seguenti: implementazione di orari di arrivo e di uscita flessibili per evitare il traffico e gestire esigenze personali e familiari, oltre all’offerta di rimborso per le spese di viaggio. Ma è altrettanto impor-
tante che gli uffici siano un luogo di lavoro moderno e dinamico, con spazi organizzati meno formali delle classiche “sale riunioni” che consentano l’interazione sociale favorendo collaborazione e produttività. La soluzione possibile è una proposta di compromesso: una configurazione di lavoro ibrida che, senza vanificare l’implementazione di una politica di ritorno in ufficio, preveda la possibilità di avere giornate di smart working. Dopotutto come ha scritto Chris Capossela, ex chief marketing officer di Microsoft, sulle pagine dell’Harvard Business Review: «Il valore dell'ufficio sta nelle persone, non nel luogo». ■
— Chris Capossela, ex chief marketing officer di Microsoft
La riforma Irpef-Ires ha introdotto cambiamenti significativi nel trattamento fiscale delle aggregazioni tra studi professionali. E se da un lato ha semplificato e incentivato il ricorso a tali operazioni, dall’altro ha lasciato aperto alcune questioni che necessitano di interventi normativi o chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate
La riforma fiscale ha introdotto rilevanti novità fiscali nel mondo delle professioni, con l’obiettivo di semplificare le operazioni di aggregazione e favorire la crescita dimensionale degli studi professionali.
Tra le principali modifiche, spiccano la riforma Irpef-Ires (d.lgs 192/2024) e la neutralità fiscale del conferimento degli studi professionali, esercitati in forma individuale o come associazione tra professionisti, in società tra professionisti (Stp).
Questi interventi normativi segnano un cambio di paradigma rispetto al passato, rendendo più chiaro il trattamento fiscale di operazioni strategiche per il settore. Tuttavia, rimangono ancora alcune incertezze applicative che necessitano di chiarimenti, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria sia del legislatore.
Pre-riforma, i costi di acquisizione della clientela erano deducibili seguendo il principio di cassa, cioè in base ai pagamenti che venivano effettivamente effettuati in ciascun periodo d’imposta. Con l’introduzione del nuovo art. 54-sexies TUIR il costo acquisizione della clientela è ammortizzabile, in ciascun periodo d’imposta, in misura non superiore a un quinto del costo.
Al fine di comprendere le differenze in termini di deducibilità pre e post-riforma, si consideri un’operazione di cessione di uno studio commercialista per cui sia stato pattuito un prezzo di acqui-
sizione pari a 300 mila euro, da corrispondersi per il 30% (90 mila euro) al closing (fissato a giugno) e tramite n. 12 rate trimestrali da 17.500 euro a decorrere dal 6° mese dopo il closing.
Le dilazioni tipiche nelle cessioni di studi professionali, come quelli di commercialisti e avvocati, fanno sì che la ripartizione del beneficio fiscale in cinque anni sia sostanzialmente allineata alla precedente disciplina.
Pertanto, non si ritiene che la nuova disciplina alteri significativamente la sostenibilità finanziaria delle operazioni M&A di studi in tali settori. Rimane però una questione cruciale ancora irrisolta: dal momento che le nuove regole si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025, come saranno trattate le operazioni concluse prima del 2025, ma con pagamenti ancora in corso? Questo scenario riguarda un numero significativo di transazioni, rendendo indispensabili chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria per definire con precisione quale disciplina applicare.
Prima della riforma, la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote in studi associati era caratterizzata da ambiguità interpretative, dal momento che non esisteva un’indicazione chiara su come trattare fiscalmente tali proventi. Nella prassi, di fatto, venivano considerate o come redditi da lavoro autonomo (art. 54 del Tuir, analogamente alla cessione di clientela) o come redditi diversi (art. 67 del Tuir) o addirittura, in
alcuni casi, come redditi non imponibili. Con la riforma, l’art. 17, lettera g-ter) del Tuir ha chiarito che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni professionali o società semplici sono ora considerate redditi da lavoro autonomo.
Se i corrispettivi vengono percepiti nello stesso periodo d’imposta, anche se in più rate, si applica la tassazione separata. Tuttavia, restano alcune criticità operative:
▪ Assenza di un regime transitorio: chi ha acquistato quote prima della riforma potrebbe trovarsi penalizzato, poiché il costo fiscalmente riconosciuto non è stato oggetto di adeguamento.
▪ Obbligo di partita Iva per i soci non titolari: i soci cedenti che non possiedono partita Iva, al momento della cessione delle quote, dovranno aprirla per dichiarare la plusvalenza come reddito da lavoro autonomo?
▪ Deducibilità del costo per l’acquirente: sarà possibile per l’acquirente dedurre il costo di acquisto delle quote? In quale modalità e in quale periodo d’imposta?
Queste domande richiedono necessariamente dei chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria al fine di evitare incertezze e potenziali penalizzazioni per i contribuenti.
Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla riforma è la neutralità fiscale del conferimento degli studi professionali, siano essi esercitati in forma individuale o associata, in STP, prevista dal nuovo art. 177-bis del Tuir. Prima della riforma, il conferimento di uno studio professionale in una società commerciale era considerato un’operazione realizzativa, dal momento che generava plusvalenze tassabili con riferimento ai beni conferiti. Con la nuova disciplina, il conferimento diventa fiscalmente neutrale: il soggetto conferente assume come valore delle partecipazioni ricevute la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite, mentre la Stp subentra nella posizione del conferente senza realizzare plusvalenze. Non vi è impatto sul regime di determinazione del reddito, garantendo continuità tra il principio di cassa (lavoratori autonomi) e il principio di competenza (società commerciali).
Inoltre, sotto il profilo delle imposte indirette, la riforma ha assimilato le operazioni di aggregazione tra studi professionali, tra cui appunto, il conferimento degli studi professionali in Stp, alle operazioni M&A che avvengono in ambito aziendale. Pertanto, ora il conferimento dello studio professionale costituisce un’operazione non soggetta ad Iva su cui si applica l’imposta di registro.
Questa assimilazione tra studi professionali e aziende, in termini di disciplina fiscale, segna senza dubbio un passo avanti per il set-
tore. Tuttavia, anche nella nuova disciplina del conferimento di studi professionali in Stp permangono delle questioni irrisolte:
▪ Obbligo di perizia di stima (art. 2343 c.c.): al pari di quanto avviene per i conferimenti di beni in natura in società, sarà obbligatorio redigere una perizia di stima per determinare il valore fiscale delle attività/ passività conferite?
▪ Trattamento delle plusvalenze latenti: nel caso di attività/passività conferite a valori contabili superiori rispetto al valore fiscale delle partecipazioni ricevute, sarà possibile ricorrere al riallineamento con imposta sostitutiva?
La mancanza di espliciti riferimenti normativi su questi aspetti potrebbe creare incertezze applicative.
Un’altra questione delicata riguarda il potenziale utilizzo elusivo della combinazione tra conferimento dello studio in una Stp e successiva cessione delle quote. Infatti, com’è noto, il trattamento fiscale della cessione diretta dello studio risulta meno vantaggioso rispetto alla cessione delle quote di una società.
Nel primo caso il cedente inquadra il corrispettivo derivante dalla cessione come reddito da lavoro autonomo, che sarà dunque tassato con aliquote progressive Irpef fino al 43%. Nel caso di cessione delle quote della Stp, si genera una plusvalenza, data dalla differenza tra corrispettivo percepito e costo fiscale della quota ceduta, da imputare a redditi diversi e che sarà tassata con imposta sostitutiva del 26% (ridotta al 18% in caso di rivalutazione delle quote).
Il dubbio che sorge è che l’Amministrazione finanziaria potrebbe riqualificare tale operazione come elusiva, considerando il conferimento e la successiva cessione di quote come un’operazione artificiosa per ottenere un indebito vantaggio fiscale.
Sul punto, richiamando il concetto di abuso del diritto così come disciplinato dallo Statuto dei diritti dei contribuenti (commi 3 e 4 dall’art. 10-bis della L. 212/2000), si ritiene che un’operazione che preveda di conferimento di uno studio in una Stp e la successiva
cessione di quote, non dovrebbe costituire in linea teorica abuso del diritto. Ciò in quanto:
▪ ai sensi del comma 4 del sopra citato art. 10-bis della L. 212/2000 “resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”;
▪ il conferimento di uno studio in Stp potrebbe essere giustificato da valide ragioni economiche (es. maggiore tutela del patrimonio personale dei soci professionisti, introduzione di soci di capitale per supportare lo sviluppo dello studio, volontà di aggregarsi con altri professionisti e ampliare l’attività ecc.)
In ogni caso, anche sotto questo aspetto, il mondo dei professionisti è in attesa di un chiarimento normativo in grado di garantire certezza giuridica ad operazioni di questo tipo. Certezza che, peraltro, già sussiste per quel che concerne il mondo aziendale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 176 comma 2-bis del Tuir, per cui non rileva, ai fini dell’abuso del diritto, il conferimento dell’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta. ■
Le novità tributarie e il loro impatto sulle professioni nel commento di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi
L’obbligo assicurativo introdotto con la legge di Bilancio 2023 è stato prorogato al 31 dicembre 2025. Ma la problematica di queste polizze resta di grande attualità. L’applicazione pratica della norma si presta per talune fattispecie a osservazioni critiche. Soprattutto per le società tra professionisti e le società di ingegneria
Per quanto il termine per la stipula dell’apposita polizza per i rischi catastrofali sia stato posticipato in zona cesarini al 31 dicembre 2025, la problematica dell’assicurazione obbligatoria contro questa tipologia di rischi resta di grande attualità. Come noto, il termine originariamente stabilito al 31 dicembre 2024 dalla Legge di bilancio per il 2023 per la stipula dell’assicurazione sui beni strumentali, è stato differito una prima volta al 31 marzo 2025 dall’articolo 13 del decreto-legge n. 202 del 2024 (cd. Milleproroghe) per poi essere fissato con l’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, al 31 dicembre 2025 per microimprese, piccole imprese e imprese di medie dimensioni.
Mentre è stato confermato al 31 marzo 2025 per le grandi imprese, seppure con 90 giorni di tolleranza. Resta fermo, invece, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura (tutte) il termine del 31 dicembre 2025 per adempiere all’obbligo assicurativo, già fissato dall’articolo 19, comma 1-quater del decreto-legge n. 202 del 2024.
La norma non coinvolge i liberi professionisti ma solo le imprese iscritte al registro delle imprese e, dunque, le società tra professionisti (Stp), le società tra avvocati, le società di ingegneria, le Srl che svolgono attività odontoiatrica nonché le società semplici che svolgono attività di lavoro autonomo.
La mancata stipula della polizza non comporta sanazioni dirette ma solo la sanzione “indiretta” che consiste nel “tener conto” del mancato assolvimento nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi
calamitosi e catastrofali. Nonostante la norma sia stata introdotta dalla oramai datata legge di Bilancio 2023 non mancano incertezze sulla sua concreta applicazione.
A queste, soprattutto per le società che svolgono attività professionale, si aggiungono perplessità di metodo posto che non si vede quale possa essere la differenza in termini sostanziali tra una Stp iscritta al registro delle imprese con obbligo assicurativo e l’associazione tra professionisti non iscritta al registro delle imprese.
Senonché, il problema concreto sembra confinato nell’ambito di quelle attività professionali svolte sotto forma di impresa che si avvalgono di impianti e strumentazione per lo svolgimento dell’attività (come talune professioni sanitarie) dal momento che l’ordinaria dotazione strumentale della maggior parte delle attività professionali svolte in forma d’impresa è esclusa dall’obbligo assicurativo.
È evidente che la disposizione si basa su plurime esigenze concrete:
▪ evitare che in caso di interruzione dell’attività per sismi, frane, inondazioni, alluvioni, esondazioni l’impresa da un lato a l’economia tutta dall’altro siano messe in ginocchio
▪ evitare che a seguito di tali eventi catastrofici lo stato debba intervenire con esborsi finanziari di sostegno alle imprese danneggiate.
Dunque, non può non convenirsi che si tratta di una norma la cui ratio è senz’altro condivisibile ma, come spesso succede, l’applicazione pratica si presta per talune fattispecie a osservazioni
critiche ancorché circoscritte. La disposizione è rivolta indistintamente a tutte le imprese che posseggono (taluni) beni strumentali, anche quelle che oggettivamente per ubicazione sul territorio il rischio catastrofale è pressoché nullo.
Ebbene, è innegabile che quanto meno le Stp e più in generale le imprese che svolgono attività di sola erogazione di servizi con utilizzo di strumentazione esclusa dall’obbligo, sono fuori dall’adempimento.
D’altronde, commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ingegneri, sono passati sotto la piaga del Covid ma hanno continuato, magari lavorando da casa, a garantire prestazioni, adempimenti e rispetto delle scadenze dal momento che trattandosi di attività “concettuali” con limitato impiego di strumentazione (computer e stampanti e collegamenti in cloud per l’archiviazione dei dati) hanno comunque portato avanti il proprio lavoro. Infatti, tale strumentazione non è compresa nell’obbligo assicurativo. Inoltre, va sottolineato che i rischi catastrofali dal punto di vista statistico graziano alcune (poche, in verità) aree del nostro paese (ad esempio il Salento, zona sismica 4, dove i corsi d’acqua sono sostanzialmente assenti. Non v’è dubbio che il premio in questi casi dovrebbe essere più contenuto rispetto ad altre aree del paese ma potrebbe risultare comunque percepito come il solito balzello. In ogni caso, c’è una categoria di imprese che non ha di che lamentarsi: le compagnie assicurative che faranno cassa e l’Erario visto che la polizza è soggetto all’imposta sulle assicurazioni! ■
ALA Assoarchitetti & Ingegneri di Bruno Gabbiani presidente di ALA Assoarchitetti & Ingegneri


Giunto alla tredicesima edizione, il Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura, promosso da ALA Assoarchitetti & Ingegneri, contribuisce e diffonde la qualità dell’architettura nella trasformazione del territorio italiano. Aperte le iscrizioni

nel nostro Paese è necessario un confronto aperto con quanto di meglio si produce nel resto del mondo. Hanno concorso al Premio Dedalo Minosse quasi 10.000 committenti, di 70 Paesi.
Il Premio Internazionale
Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura è promosso con cadenza biennale da ALA Assoarchitetti & Ingegneri ed è giunto alla tredicesima edizione. Il Premio mette in luce la figura del committente che investe risorse nella ricerca della qualità ed è attribuito al percorso che ha generato un successo. Secondo ALA, per contribuire a diffondere la qualità dell’architettura in tutte le azioni quotidiane di trasformazione del territorio
Il Premio è assegnato nel Teatro Olimpico di Vicenza e mostre oltre che nella Basilica Palladiana sono state allestite in più di 60 Città, di oltre 30 Paesi, nei luoghi più significativi: dalle Scuderie del Cremlino, all’Ambasciata d’Italia a Washington, dal Mastio Angioino, alla Torre di David a Gerusalemme e anche nel prossimo biennio la mostra viaggerà a San Francisco, Detroit, Tokyo, Buenos Aires, Gerusalemme e in Italia a Roma, Napoli, Palermo, Milano, Torino.
Dedalo Minosse è aperto ai committenti di architetture realizzate nell’ultimo quinquennio. L’iscrizione è gratuita. I premi sono tar-

ghe realizzate su un disegno donato da Bob Noorda. La Giuria valuta la qualità dell’opera realizzata, sulla base di parametri che comprendono la sostenibilità, l’innovazione tecnologica e strutturale, l’economia circolare, l’uso dell’energia, l’inserimento nel paesaggio, la funzione sociale, il design for all, la sostenibilità, l'uso di linguaggi di culture del mondo non industrializzato.
La Giuria assegna quattro premi istituzionali:
▪ Il premio Dedalo Minosse, ad un committente di qualsiasi Paese;
▪ Il premio Dedalo Minosse under 40, ad un committente di qualsiasi Paese, che abbia incaricato un giovane progettista. Questo premio ha il patrocinio dell’ OCCAM , l’Osservatorio dell’ONU per la comunicazione digitale;
▪ Il Premio ALA Assoarchitetti – Fondazione Inarcassa, ad un committente che abbia incaricato un architetto o ingegnere italiano;
▪ Il Premio ALA Assoarchitetti under 40, ad un committente che abbia incaricato un giovane progettista italiano.
▪ La Giuria attribuisce altri 8 Premi speciali e 13 segnalazioni e dispone la pubblicazione nel Catalogo e nella Mostra, di altre 24 opere.
LA TREDICESIMA EDIZIONE
Le iscrizioni alla Tredicesima edizione del Premio sono attualmente in corso e rimarranno aperte fino al 21 maggio 2025. ■
ALA – Assoarchitetti & Ingegneri, fondata nel 1999, è l’organizzazione dei progettisti architetti, ingegneri, paesaggisti, pianificatori, conservatori, designers liberi professionisti italiani.
ALA ha lo scopo di rappresentare e promuovere i diritti soggettivi e i legittimi interessi diffusi, professionali, economici e culturali degli architetti, degli ingegneri e degli altri professionisti del progetto, per migliorare la qualità della vita in Italia.
ALA sostiene che i liberi professionisti sono un autonomo “comparto produttivo” e per questo promuove la crescita culturale e organizzativa degli studi di progettazione italiani e la loro capacità di espansione all’estero, attraverso il rafforzamento delle strutture organizzative e la costituzione di reti nazionali e internazionali. ■
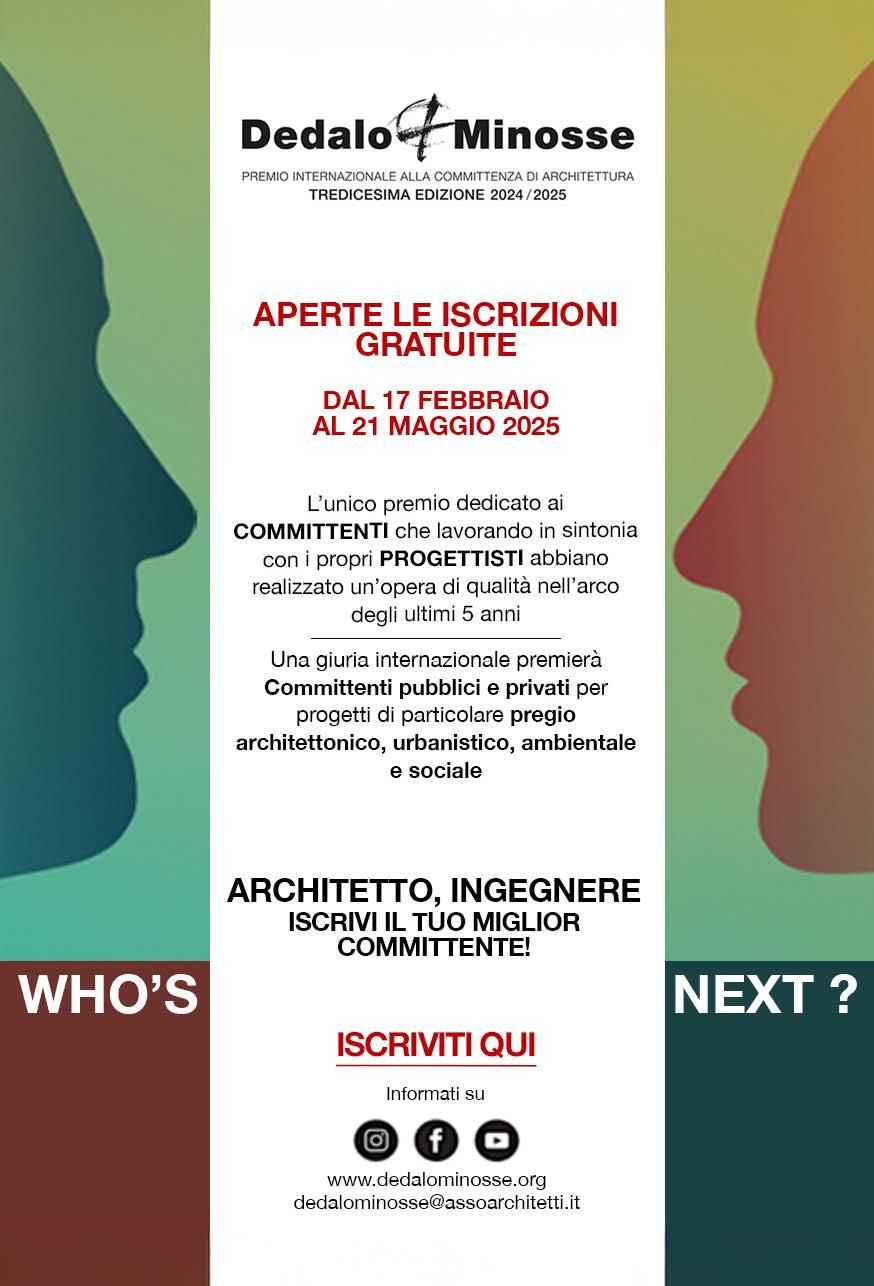
Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili

di Francesco Cataldi e Serena Giannuzzi
Che cosa fa davvero il commercialista? In che direzione sta andando la professione? Come si diventa commercialisti?
A queste e tante altre domande ha dato risposta lo scorso 12 marzo l’Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili (Ungdcec) grazie al progetto Obiettivo Uni.Co, nato con l’idea di creare una vera e propria giornata nazionale del commercialista all’interno delle università

Obiettivo Uni.co. Un progetto ambizioso nato nel 2024 e pensato e sviluppato dall’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Ungdcec), che ha visto tanti giovani unionisti impegnati e pronti a raccontarsi a migliaia di studenti in oltre 50 atenei di tutta Italia.
Il format nasce dalla consapevolezza che, per far fronte alla problematica del ricambio generazionale della categoria, sia necessario partire dalle università: contrastare il problema della percezione negativa della professione di commercialista e colmare il gap informativo sul mondo della professione è, oggi più che mai, una priorità. Il mercato sta infatti offrendo una
trasformazione delle competenze che ci sta portando verso una realtà in cui il ruolo del commercialista trascende i confini tradizionali della contabilità e del fisco e si sposta verso contesti consulenziali che lo vedono in prima linea al fianco delle imprese nel ruolo di consulente strategico e manageriale; oggi l’imprenditore richiede ai propri consulenti competenze sempre più specialistiche e trasversali che aprono le porte a nuovi importanti segmenti di mercato.
Gli studenti non conoscono questi sviluppi della professione, associando ancora l’immagine del commercialista allo stereotipo negativo di mero contabile, interfaccia della pubblica amministrazione, così come non conoscono i percorsi di formazione e di abilitazione, ovvero, sentono la necessità di azioni più incisive di orientamento alla professione all’interno
degli atenei.Obiettivo Uni.Co è quindi una giornata all’insegna della condivisione e dello scambio reciproco e realizzato con il solo obiettivo di orientare gli studenti grazie a testimonianze dirette, survey dedicate, materiale informativo e soprattutto grazie a tanti giovani commercialisti pronti a mettersi a disposizione del mondo accademico. Un progetto “Uni. Co” che, grazie al costante rapporto con le università, mira a fare da contraccolpo ad una tendenza negativa che negli ultimi anni non sembra fermarsi, come se esistesse un cortocircuito nel passaggio dall’università agli studi professionali.
Proprio in ragione di questa sua strategicità il progetto è stato patrocinato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dalla Cassa dei Dottori Commercialisti e da Confprofessioni, consapevoli che solo affrontando in sinergia le problematiche della categoria si può essere davvero incisivi e rilanciare una professione che certamente ha tanto da offrire, soprattutto alle generazioni future.
È necessario continuare a mantenere il focus sui giovani per invertire un trend che vede una disaffezione verso il lavoro autonomo; le nuove generazioni rappresentano infatti una risorsa preziosa, fonte di innovazione e dinamismo che può contribuire in modo significativo al successo degli studi professionali. Allo stesso tempo, la professione del commercialista, se intrapresa con lo spirito giusto e la necessaria determinazione, rappresenta un’opportunità concreta per gli studenti. Questo è, in sintesi, il messaggio che l’Unione porta nelle università italiane, ringraziando Confprofessioni e il suo Presidente, Marco Natali, per l’impegno nel rafforzarlo e valorizzarlo. ■
Il Contratto collettivo nazionale degli studi professionali ha costruito un’articolata rete di tutele intorno a tutti coloro che operano all’interno di uno studio professionale. In questa rubrica le ultime novità dalla bilateralità di settore
Gestione Professionisti, arriva il rimborso degli apparecchi
Da tempo ormai l’utilizzo di apparecchi acustici, dispositivi medici ad altissima tecnologia, consente alle persone con ridotte capacità uditive di sentire meglio, migliorando di conseguenza la qualità della loro vita, anche lavorativa. Tra le novità introdotte nel 2025, Gestione Professionisti e BeProf attivano la garanzia sperimentale finalizzata al rimborso delle spese per l’acquisto di apparecchi acustici in favore di professionisti titolari di copertura automatica o volontaria Premium/Premium plus. Il rimborso viene erogato nella misura del 20% delle spese sostenute dal 01 gennaio 2025 al 31 dicmbre 2025 (e comunque
successivamente alla data di attivazione della copertura Premium/Premium plus del richiedente) con un massimale di 300 euro, a fronte di prescrizione di protesi acustica effettuata da medico specialista otorinolaringoiatra o audiologo emessa dal 01 gennaio 2025. Il rimborso è unico e irripetibile nel periodo di validità del progetto sperimentale 2025 ed è erogabile una sola volta nell’arco dell’intera iscrizione a Gestione Professionisti, anche in caso di iscrizione discontinua. La domanda di rimborso può essere effettuata autonomamente dalla propria area riservata BeProf allegando la documentazione richiesta.


Fondoprofessioni si appresta a varare uno stanziamento di risorse dedicato a un nuovo Avviso monoaziendale, per il finanziamento dei piani formativi rivolti al personale dei singoli studi/ aziende. La progettazione dei piani formativi sarà a cura degli enti attuatori accreditati presso il Fondo, in base alle specifiche esigenze di sviluppo delle competenze dello studio/azienda coinvolto. Il piano formativo potrà essere articolato in più progetti, realizzati in presenza o in modalità a distanza sincrona, con una durata da 8 a 40 ore. Il contributo da parte del Fondo per il singolo piano formativo sarà di massimo 20 mila euro. «Il nuovo Avviso monoaziendale rientra nell’ambito di una più ampia pianificazione annuale - ha spiegato Franco Valente (nella foto), direttore di Fondoprofessioni. Nei prossimi mesi prevediamo di mettere a disposizione con gli Avvisi almeno altri 2,7 milioni di euro, raggiungendo, e forse superando, gli 8,6 milioni di euro preventivati per il 2025». La presentazione dei piani formativi da parte degli enti attuatori, per conto degli studi/aziende interessati, potrà avvenire tramite la piattaforma informatica di Fondoprofessioni.
Cadiprof ha annunciato di aver rinnovato per tutto il 2025 la convenzione con le Insegne di Ottica Salmoiraghi & Viganò e GrandVision Grazie alla partnership tra Cadiprof ed EssilorLuxottica Italia, tutti gli iscritti alla Cassa potranno beneficiare di scontistiche dedicate di un coupon di sconto ( areariservata.cadiprof.it/ cadiprof-web); di un extra rimborso (rimborso lenti da vista); e beneficiare del bonus prevenzione, presso i negozi Salmoiraghi&Viganò. La convenzione offre agli iscritti vantaggi su occhiali da vista e da sole completi di lenti graduate, lenti a contatto e occhiali da sole non graduati. Inoltre, per gli acquisti effettuati presso la rete dei negozi Salmoiraghi & Viganò e GrandVision, viene riconosciuto all’iscritto un rimborso extra di 40 euro che si aggiunge a quello previsto dal Cadiprof per l’acquisto di lenti da vista. Ma non solo. Gli iscritti hanno la possibilità di accedere a una serie di servizi aggiuntivi per il benessere della vista, come un check up gratuito e una prima applicazione gratuita delle lenti a contatto oltre al Bonus Prevenzione, che prevede l’erogazione di uno sconto pari al costo della visita oculistica.


Tra le numerose prestazioni erogate da Ebipro a favore degli iscritti al sistema bilaterale di settore, da diversi anni il tema della formazione in materia di antiriciclaggio è uno dei più gettonati tra i datori di lavoro dell’area giuridica ed economica. In questo ambito Ebipro rimborsa la formazione/aggiornamento effettuata dai liberi professionisti datori di lavoro e/o dai dipendenti iscritti alla bilateralità. La prestazione è direttamente attivabile dal datore di lavoro (persona fisica/ giuridica) che si sia avvalso di un ente formatore accreditato al Fondoprofessioni che abbia preventivamente inserito nel catalogo il percorso formativo. Una volta scelto, acquistato e seguito il corso accreditato, entro sessanta giorni dalla conclusione il datore di lavoro potrà richiedere a Ebipro il rimborso del 60% del costo fatturato (iva esclusa). Nel caso in cui il datore di lavoro aderisca anche al Fondoprofessioni, il ristoro conseguibile è elevato al 100% dell’importo entro un massimale di euro 500 euro.
Gli eventi, le mostre, i film e i libri del momento in Italia e all'estero da non perdere per fare un pieno di cultura e di bellezza



Cresce l’interesse per la terra del Sol levante. Non solo dal punto di vista turistico ma anche culturale. Tre mostre da non perdere per chi desidera immergersi nell’atmosfera orientale e conoscerne da vicino tradizioni e storia
di Romina Villa
Ritratto di donna, fotografia all_albumina, fine del XIX secolo, 20x26 cm
ÈGiappone-mania. Lo dicono i dati che riguardano i flussi turistici verso il paese del Sol Levante, pubblicati a inizio anno dalla JNTO, l’organismo ufficiale del turismo giapponese. Nel 2024, i turisti in entrata sono stati quasi 37 milioni, il 47% in più rispetto al 2023. La riapertura post-Covid del traffico aereo e il valore dello yen al cambio, ai minimi storici negli ultimi decenni, sono solo alcuni dei motivi che hanno portato a questo boom turistico. Il maggior numero di visitatori è giunto da
Cina, Corea del Sud e Taiwan, ma anche l’Europa non scherza, con i nostri connazionali in prima fila per numero di partenze.
ll Giappone, che per noi occidentali, è sempre sembrato lontanissimo, ma altrettanto allettante, oggi appare più vicino grazie ai social che mostrano le futuristiche metropoli e allo stesso tempo la realtà, pietrificata nel tempo, dei villaggi sperduti, dove ogni giorno si celebra il rito del tè, dei ciliegi in fiore e dei templi silenziosi. Un

paese perfettamente in bilico tra la contemporaneità e una cultura millenaria, quella raccontata nell’ukiyo-e, il genere artistico di stampa xilografica (si utilizzavano matrici di legno) che a partire dalla seconda metà dell’800, comparvero sul mercato dell’arte europeo, a testimoniare la quotidianità di una civiltà misteriosa, diversa e sconosciuta.
I francesi coniarono il termine Japonisme per indicare l’influenza che il Giappone, nel suo insieme,
stava avendo sul mondo artistico e sociale dell’occidente, ma già dal secolo XVIII l’arte orientale in generale aveva infiammato l’interesse degli europei. In particolare, i manufatti cinesi arrivarono nelle case degli abbienti e oggi, quando visitiamo una qualsiasi dimora di quel periodo, ci imbattiamo sempre in un salottino cinese, dove mobili, vasi e tappezzerie di seta adornano interamente l’ambiente. A quel tempo, una moda irrinunciabile per i ricchi, da mostrare assolutamente a chi veniva in visita.

Drago e tigre, dittico di rotoli verticali dipinti a inchiostro e colori su seta, 120x40 cm cad., firmati Naiki Hirosada con sigillo

Chinoiserie, altro termine inventato dai francesi, era usato per rappresentare non solo i manufatti provenienti dalla Cina, ma in generale dall’Oriente. Era la definizione di arte esotica. Il Giappone, invece, rimase chiuso al mondo intero fino alla seconda metà dell’800, dopo che la dinastia shogun dei Tokugawa aveva chiuso i confini a chiunque per oltre due secoli. Nel 1854, firmarono il primo accordo commerciale con gli Stati Uniti, che li avevano convinti ad aprire i propri porti a suon di cannonate. Per il Giappone stava per iniziare una transizione epocale. Era finita l’epoca dei samurai ed iniziava quella delle riforme Meiji, del governo “illuminato” dell’imperatore Mutsuhito. Oggi ad essere aperti sono gli aeroporti, a quei milioni di turisti affamati di esperienze gastronomiche, appassionati di beauty routi-
Samurai a cavallo, paravento a 4 ante dipinto a inchiostro e colori su carta, 174x240 cm, firmato Edokoro AzukariTosa Mitsu shin, periodo Mieji (1868-1912)
Paesaggio innevato con figura, Periodo Meiji (1868-1912), rotolo verticale dipinto a inchiostro e colori su seta, 117x36 cm

ne, di diavolerie tech e di manga. Il Giappone, con i suoi paesaggi da fiaba, però, sta scoprendo ora cosa sia l’overtourism e da alcune parti si sta correndo ai ripari. Come a Kyoto, dove l’amministrazione ha deciso di decuplicare la tassa di soggiorno, a partire dal 2026 (fino ad arrivare a 60 euro a notte). Staremo a vedere come va a finire. Qui da noi, ne sappiamo qualcosa.
IL GIAPPONE A CASA NOSTRA
L’Italia è sede di importanti musei di arte orientale e, in generale, il nostro patrimonio comprende notevoli raccolte di manufatti provenienti da quella parte del mondo. Da menzionare, quelli di Venezia, Genova e Napoli, non a caso, città dallo sguardo storicamente rivolto alle terre lontane. Queste monumentali collezioni si sono

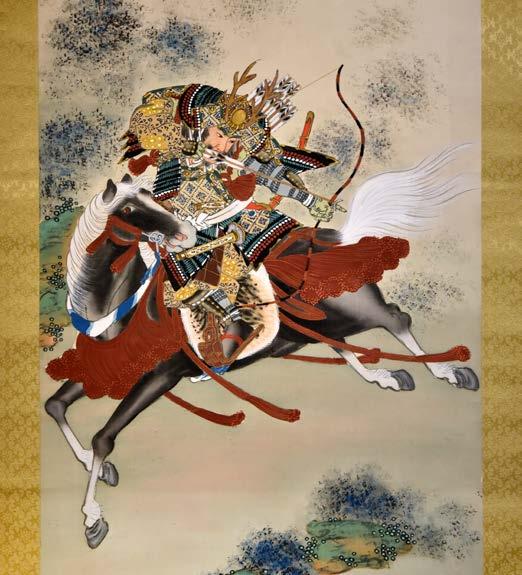
Mori Shuho, aquile, rocce e pino, paravento a 2 ante dipinto a inchiostro su carta, firmato Hogen Shuho nanajuroku hitsu, 1738-1823
Samurai a cavallo, prima metà del XX secolo, rotolo verticale dipinto a inchiostro e colori su seta, cornice in seta, 116x41,5 cm
formate grazie ai commerci quindi, ma anche grazie ad altri tipi di viaggiatori, come i missionari per esempio, o più recentemente grazie al lavoro dei nostri archeologi. Per approfondire la cultura giapponese prima di un viaggio, o semplicemente da appassionati, suggeriamo alcune mostre, in corso in questi mesi in Italia.
Al MAO, il Museo d’Arte Orientale della città sabauda, è stata allestita la mostra “Haori. Gli abiti maschili del primo Novecento narrano il Giappone”. Si tratta di una preziosa novità nel panorama espositivo europeo, che in genere si concentra sull’abbigliamento delle donne. Eppure, anche i kimono maschili, anche se meno appariscenti di quelli femminili, raccontano i piccoli gesti della quotidianità e, di conseguenza, le più grandi trasformazioni sociali.
A Torino sono esposti circa 50 haori e juban (le giacche sovra kimono e le vesti sotto kimono maschili), risalenti al primo Novecento, che svelano proprio quel cambiamento epocale, di cui si parlava sopra, attraverso le immagini che illustrano i preziosi abiti. Sono capi rigorosi, ma ugualmente eleganti. E austeri, perché a differenza dei kimono femminili, dove l’opulenza è manifesta, i decori si trovano spesso nascosti, per esempio all’interno delle giacche o sull’intera superficie dei sotto kimono. I temi però sono gli stessi: la cultura, le arti della seduzione, la politica, ma in questa selezione vi si trova anche la curiosità per il mondo occidentale e la modernizzazione. Oltre ai capi maschi-

Uno degli abiti in mostra al Museo di Arte orientale di Torino
Kimono da donna, seta, metà del XX secolo, 181x132x50 cm
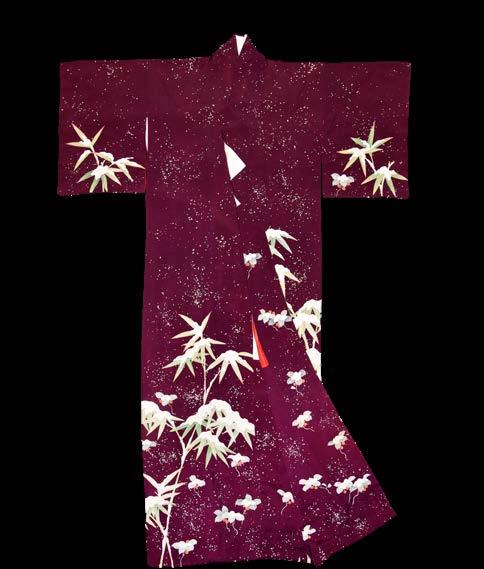
li, saranno esposti anche alcuni tradizionali kimono da bambino, provenienti dalla collezione Manavello di Treviso. All’interno del percorso espositivo, gli abiti sono posti in dialogo con alcune opere di arte contemporanea, che arricchiscono il racconto del vecchio e del nuovo Giappone.
LA TRADIZIONE ORIENTALE
Villa Contarini è il prezioso contenitore della mostra “Giappone. Terra di geisha e samurai”, presentata dalla Fondazione Giordano Emilio Ghirardi Onlus, che ha sede proprio nella villa di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. Le opere i manufatti in esposizione provengono da ricche collezioni private e, attraverso aree tematiche, la mostra costruisce un percorso di approfondimento del Giappone tradizionale, ben radicato nell’immaginario collettivo occidentale. Cuore di questo allestimento è la sezione dedicata alla geisha e al samurai, le due figure-icona di questo popolo.
La geisha ha incarnato la bellezza femminile e la seduzione che portava con sé. Con il suo incedere elegante e silenzioso, nel tempo, ha caricato di mistero la sua figura, fino a trasformarla in un essere quasi mistico. Nell’altra metà del cielo, invece, i samurai erano i coraggiosi guerrieri, spina dorsale del sistema feudale giapponese e costituivano l’esercito permanente agli ordini dello shogun, il capo supremo. C’è molto da imparare sull’antico Giappone e sui rapporti che il suo popolo aveva con la propria cultura, il pensiero religioso e quello delle correnti filosofiche, ovvero sulla vita stessa.

La toeletta, fotografia all_albumina, 20x26 cm, fine del XIX secolo
Armatura completa di Samurai, Periodo Meiji (1868-1912), metallo, cuoio

STAMPE JAPAN A ROMA
Il viaggio del Giappone verso la modernità ha attraversato profondamente anche il mondo dell’arte. La stampa artistica del “mondo fluttuante”, ovvero l’ukiyo-e, è stata rivoluzionata dallo Shinhanga, movimento artistico nato agli inizi del ‘900. “Gli Shinhanga. Una rivoluzione nelle stampe giapponesi” è il titolo di una mostra allestita a Roma, presso i Musei di San Salvatore in Lauro
Adottando le tecniche classiche della stampa con matrici di legno, tipica dell’ukiyo-e, gli artisti Shinhanga ne hanno rivoluzionato temi e colori. L’apertura dei confini aveva portato gli stranieri in casa, ma gli stessi giapponesi, ad un certo punto, si erano interessati a questi e al loro mondo. L’influenza

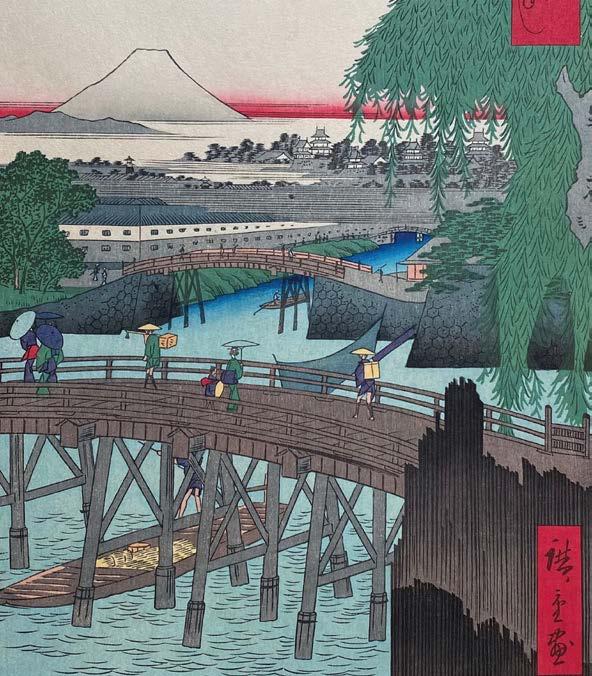
Utagawa Kuniyoshi, Hayano Wasuke Tsunenari, xilografia policroma, 1847
Utagawa Hiroshige, Il ponte Ichikoku a Edo, xilografia policroma, 1858, 33,8x22 cm
Utagawa Hiroshige, Hiratsuka la strada Nawate, xilografia policroma, 1833-34, 36,6x23,9 cm
Tigre e cucciolo, paravento a 8 ante dipinto a inchiostro e colori su carta rivestita di foglia d'argento, 150x408 cm, firmato Ryuun dipinse, periodo Meiji (1868-1912)

culturale è corsa, dunque, su due binari contrapposti e lo si percepisce dalle immagini che questi nuovi artisti consegnano alla storia. Quelle di un Giappone che fa i conti con un nuovo presente.
Dalla devastazione seguita al terribile terremoto del 1923, che fece 100 mila vittime in una vasta area intorno a Tokyo, ai nuovi paesaggi urbani. Dalle nuove figure femminili, che scalzano dal podio la geisha, alla nuova vita fuori dall’intimità delle mura domestiche. ■

Dall’11 al 15 giugno torna “Procida racconta”, il festival letterario ideato e organizzato da Chiara Gamberale, che in questa intervista ripercorre le tappe di un esperimento nato dal desiderio di creare un incontro autentico. Un racconto che commuove e che ci tiene vivi

un festival, ma anche un esperimento, un rito, un incontro che ogni volta cambia qualcosa. Sei scrittori arrivano su un’isola – Procida – e passano quattro giorni con sei abitanti. Si scelgono, si raccontano, si ascoltano. E da quell’incontro nasce un racconto inedito, che l’autore legge la sera finale, in piazza, davanti a chi l’ha ispirato e a tutta l’Isola. È un modo per ricordarci che le storie non sono solo di chi le scrive, ma anche – e forse soprattutto – di chi le vive. E di chi le ascolta. Nelle serate precedenti, poi, succede qualcosa di ancora più raro: i lettori, quelli che magari l’anno prima erano nel pubblico, si ritrovano a presentare i loro scrittori del cuore. È come se il festival si aprisse in cerchi sempre più larghi, ma senza mai perdere il centro: la relazione».
Parte da qui Chiara Gamberale per raccontare “Procida racconta”, il festival letterario da lei ideato e organizzato (ne è anche il direttore artistico), e dalla casa editrice Nutrimenti, giunto quest’anno alla nona edizione, che si terrà tra l’11 e il 15 giugno 2025 nella piccola isola del Golfo di Napoli.
D. Com’è nata l’idea?
L’idea è nata quando Andrea Palombi e Ada Carpi, fondatori della casa editrice Nutrimenti, hanno deciso di aprire una libreria proprio a Procida. In un momento in cui ovunque le librerie chiudevano, loro hanno fatto una scelta poetica e coraggiosa. Io ero lì per una presentazione, e ho sentito che quell’isola poteva accogliere qualcosa di diverso. Un modo per
far incontrare scrittura e ascolto, autori e abitanti, vita e letteratura.
D. Com’è cresciuto il festival negli anni?
In modo naturale. Ogni anno più scrittori vogliono venire, più lettori tornano, più abitanti si mettono in gioco. A un certo punto, sono arrivati anche i cantautori. È successo quasi per caso, ma ha aperto una nuova possibilità: le parole scritte hanno cominciato a dialogare con la musica, e viceversa. Il festival ha allargato il respiro, ma ha mantenuto la sua voce.
D. Cosa hanno in comune tutte le edizioni?
Lo stesso spirito: sei scrittori, sei abitanti, sei racconti. Ma soprattutto, lo stesso desiderio di crea-
re un incontro autentico. Non una presentazione, ma un legame. Non un palco, ma uno scambio.
D. Cosa c’è invece di diverso in ognuna?
Tutto. Ogni autore ha il suo modo di ascoltare, ogni abitante la sua storia. Anche l’isola cambia. Anche noi. E ogni anno nasce qualcosa che prima non c’era, ma che resterà ad arricchire l’edizione successiva.
D. Qual è la cosa che ti emoziona di più?
Quel momento in cui, durante la lettura pubblica, l’abitante si riconosce nelle parole dell’autore. Non è solo commozione. È come se tutti, per un istante, ci vedessimo tutti meglio. È lì che succede la magia.

D. È un festival i cui numeri del pubblico sono in crescita. Che effetto ti fa?
Un’enorme gratitudine. E anche una responsabilità: proteggere lo spazio di verità e intimità che rende Procida Racconta diverso. Se cresciamo, vogliamo farlo restando fedeli a quel centro.
D. Come scegli gli autori che inviti?
Cerco chi ha voglia di mettersi in ascolto. Chi è curioso, generoso, pronto a lasciarsi sorprendere. Non importa se è famoso o all’esordio. Mi interessa che sia vero.
D. Cosa ha di diverso Procida Racconta da tutti gli altri festival?
Che non è una rassegna, ma un laboratorio. Gli autori non vengono a promuovere, ma a scrivere qualcosa che ancora non esiste. Tutto è gratuito, niente è leggero. Conta la cura. Conta chi ci mette il cuore.
D. Come vive tua figlia Vita quei giorni?
Come una festa. Corre, esplora, fa amicizia con chiunque. E intanto respira questa idea di cultura come relazione, non come prestazione. È un regalo che spero le resti.
D. Otto edizioni sono quarantotto autori: chi di loro, se si può dire, ti è rimasto più impresso? Quale racconto non hai mai scordato?
Difficile scegliere. Ma penso a chi si è lanciato con me nella primis-

sima edizione che ci ha mostrato che sì: si poteva fare. Ogni anno c’è almeno un racconto che mi colpisce più degli altri. A Procida anche gli autori con più mestiere si ritrovano fuori dalla loro zona di comfort, a contatto con storie vere, vissute. E quando mettono da parte le aspettative, quando scrivono ascoltando prima che raccontando, quando si abbandonano allo stupore ecco: accade qualcosa di unico. Sono quei testi lì che mi restano addosso.
D. Che ti aspetti da questa nuova edizione?
Di essere spiazzata. Di commuovermi. Di riconoscere, tra le parole di un racconto, qualcosa che parla anche di me. Che poi è sempre questo che cerchiamo: qualcosa che ci tocchi. Che ci tenga vivi. ■

L’attenzione e la sensibilità nei confronti degli altri e della loro buona salute son quel che accomuna la professione di medico con la produzione vinicola e olearia. Che da oltre un decennio rappresenta la seconda vita di una primaria in forze a un ben noto istituto di ricovero e cura milanese di Roberto Carminati
Una certa tendenza all’iperattività è quel che contraddistingue la personalità di Silvia Cirri, dal 1977 iscritta all’Ordine dei medici di Milano e primaria di Sala operatoria e Terapia intensiva del reparto di Medicina cardiovascolare e Polispecialistica dell’IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio del capoluogo lombardo. Perché ormai da decenni una volta smesso il camice e posati i ferri del mestiere la dottoressa ogni venerdì si avventura nel traffico della metropoli alla volta della carducciana Bolgheri (Livorno), dove gestisce una ormai fiorente produzione di vini e olii su terreni ereditati dalla sua famiglia. Nei ritagli di tempo è stata fondatrice e anima dell’associazione no-profit Bambini cardiopatici nel mondo, con e per la quale ha attra-


versato in lungo e in largo le aree più remote e disagiate del pianeta per portarvi assistenza e insegnamenti. «Mi sento», ha detto Cirri a Il Libero Professionista Reloaded, «più che altro una camionista. Macino instancabilmente chilometri e mi occupo di più attività senza quasi avvertire la fatica: perché mi dà gioia. Credo esista una cultura del fare insita in molti e di cui tanti non prendono coscienza: può forse risultare eccessiva; per me è inarrestabile».
La prima collezione di vini del suo Podere Conca è stata realizzata dieci anni orsono ed è un Bolgheri Doc rosso prodotto con tipiche uve Cabernet ma con l’aggiunta di un classico autoctono: il Ciliegiolo. «Agli inizi», ha ricordato, «avevo l’intenzione di realizzare un vino
che si caratterizzasse per l’essere innanzitutto bevibile, né troppo corposo né troppo strutturato, ma fresco e in linea con il mio gusto personale. A quanto pare ho colto nel segno poiché i riscontri sono stati da subito ottimi. L’ho battezzato Agapanto in ossequio alla passione e specializzazione di mia madre: la botanica».
Ne sono seguiti Apistos, dal termine greco che indica l’incredibile e allude a un fiore questa volta immaginario: è un Cabernet Franc invecchiato per circa 16 mesi in barriques di rovere francese; e il Cabernet Sauvignon 196, ispirato al numero civico della tenuta, che si estende su dieci ettari. Infine, il bianco base Viognier Elleboro. «Con queste quattro linee», ha commentato Cirri, «posso dirmi



soddisfatta anche perché il vigneto e la cantina impongono tutto l’anno un ininterrotto impegno e oltre a un enologo e alla sottoscritta sono impiegate qui solo altre quattro persone».
Dei dieci ettari che Cirri gestisce insieme ai suoi collaboratori selezionati per competenze tecniche ma anche relazionali e linguistiche cinque sono quelli riservati alla coltivazione di ben 800 ulivi.
Se ne trae un olio certificato bio che, come il vino, trova apprezzamento e spazio anche ben oltre i confini nazionali. «Il marketing e la comunicazione on e offline, la corretta ed efficace narrazione di quel che facciamo e proponiamo, sono curati nei dettagli», ha sottolineato, «e decisivi perché le

nostre produzioni continuino ad avere successo. Il vino è venduto in Europa, in Canada e in Giappone: siamo presenti anche negli Stati Uniti e il sogno è presidiare meglio New York, ma le barriere all’import varate dall’amministrazione di Donald Trump preoccupano e complicano le cose. Anche tramite i canali dell’e-commerce l’olio è esportato per lo più in Svizzera e in Austria, molto sensibili al biologico». L’essere biologici implica un surplus di meticolosità nei controlli e nella scelta delle giuste soluzioni per debellare eventuali malattie affrontandole sin dai primi sintomi. Come fa un medico.
In agricoltura come in medicina non ci si può permettere di lasciare alcunché al caso, cioè. «Sono la prima a chiedermi talvolta», ha osservato Cirri, «che cosa abbiano in comune il mio lavoro in reparto e quello fra i vigneti e oliveti. Sono giunta alla conclusione che i tratti condivisi siano rappresentati dagli studi intensi e dal concetto di cura. Ho ricevuto in dote una terra baciata da ogni fortuna ma solo le competenze acquisite prima come sommelier e poi in enologia e agronomia mi hanno permesso di confrontarmi con una concorrenza che sul territorio è radicata e agguerrita. Il mio approccio alla potatura o all’irrigazione è scientifico e non dissimile da quello che si deve avere nei confronti di un paziente. In più, credo che l’idea del prendersi cura sia quanto mai radicata in una donna, per la sua natura di madre. Né si può dimenticare che in vigna il pensiero è sempre rivolto da un lato al meteo, data l’era di dram-

matici eventi climatici che stiamo vivendo; dall’altro all’ininterrotta evoluzione delle normative e certificazioni che rappresentano un onere pressante». Giunta a tagliare il traguardo delle 25 mila bottiglie in capo a una ricerca che l’ha portata in tutti i continenti ad apprendere i segreti delle grandi cantine e scegliere il suo percorso personale, a Cirri non resta che il sogno nel cassetto di «aggiungere due ettari di terreno ai vigneti che già possiedo, perché sette è il mio numero fortunato». Tutto sommato però, forse può andare bene anche così. ■

Le novità editoriali che non possono mancare nella libreria di un professionista
di Luca Ciammarughi

titolo : Contro la società dell’angoscia. Speranza e rivoluzione
autore : Byung-Chul Han
editore : Einaudi Stile Libero Extra
prezzo : 13 euro
In questi anni, pochi filosofi hanno saputo cogliere i nodi cruciali della nostra epoca con la capacità di sintesi e la lungimiranza di sguardo di Byung-Chul Han. Questa sua ultima pubblicazione, uscita in tedesco con il titolo Der Geist der Hoffnung (“Lo Spirito della Speranza”, più bello del titolo italiano Contro la società dell’angoscia), è una riflessione che nasce dagli scenari apocalittici della nostra epoca: una pandemia, una paventata guerra mondiale, una catastrofe climatica. L’angoscia (dall’antico tedesco “angust”), ci dice Han, è “uno strumento di dominio molto diffuso”, che si può combattere solo con la speranza. Ma quest’ultima non coincide affatto con l’ottimismo: laddove l’ottimismo non conosce né il dubbio né la disperazione, limitandosi alla piatta positività, “la speranza più intima si risveglia proprio nel cuore della disperazione più assoluta”. Il culto della positività è in fondo egoista, isola le persone,
mentre la speranza, si apre all’Altro, al nuovo, a ciò che non è mai stato. Così come l’amore è una passione (dal greco pathèin, soffrire) con il suo polo negativo, anche la speranza passa per la negatività: è Kafka, per esempio nel famoso racconto Un messaggio per l’imperatore, che ci insegna la speranza contro ogni speranza, la più pura, la più assoluta, svincolata da ogni utilitarismo. Come di consueto, Han combatte con forza la narcisizzazione della società, l’ottimizzazione di noi stessi a meri fini carrieristici e di consumo, la costrizione a essere “performanti”, ottimisti e alla lunga depressi. Cosa genera tale depressione? La mancanza di un orizzonte comune, il limitarsi a coltivare desideri individuali invece di aspirare a quel “Noi” che è racchiuso nell’orizzonte della speranza. Sebbene filosofi come Spinoza e Hannah Arendt ci mettano in guardia dal dipendere dalla speranza, che può apparire come una limitazione all’azione sul presente, Albert Camus nel discorso per il conferimento del Nobel parlò di “un debole rumore d’ali: il dolce trambusto della vita e della speranza”.
La speranza è una tonalità emotiva che non riguarda il soddisfacimento di un desiderio intramondano o il raggiungimento di un obiettivo: è un sentimento che può “assalirci, afferrarci e trasformarci” e che tocca l’ambito della fede
e del sogno. Sperare significa essere miti e gentili, capaci di sognare a occhi aperti (un tipo di sogno che Freud declassava invece a semplice momento preparatorio di quello notturno), non perdere fiducia negli altri soprattutto quando si è in prossimità dell’abisso. È il grande poeta Paul Celan a dirci che la speranza coincide con un “non esser persi”, che si risveglia spesso al cospetto della perdita totale. La speranza - ci dice Han - “è possibile solo dentro una frattura, proprio come la profonda felicità”. Il non-arrivare è il suo tratto fondamentale. Ingeborg Bachmann la eleva a “condizione di possibilità della vita”.
Nel sopracitato racconto di Kafka, il destinatario del messaggio dell’imperatore sa benissimo che il messaggero, intrappolato in una sorta di labirinto di palazzi che non ha mai fine, non arriverà mai a lui: “Ma tu stai seduto presso la tua finestra, e sogni quel messaggio, quando viene la sera”. Sognare oggi sembra stupido e infruttuoso, eppure è ciò che ci consente di vivere nella maniera più umana possibile. Quando Václav Haval, il famoso dissidente cecoslovacco sostenitore dei diritti umani, parlò della speranza come “condizione dello spirito”, non fece riferimento a una “previsione” ottimistica, ma al “cercare di raggiungere qualcosa perché questo è buono, non solamente perché ha un successo assicurato”. Nel pensiero messianico sorretto dalla speranza c’è qualcosa di onirico e infantile che combatte la pesantezza esistenziale del presente. L’intelligenza artificiale non ne è capace. Muovendosi fra letteratura e filosofia, ma anche musica (perché la speranza abita una trascendenza “che non si lascia descrivere ma solo cantare”), Han ci restituisce in queste pagine il coraggio di continuare a sperare. ■
Cinema, balletto, musica e libri. Un vademecum per orientarsi al meglio tra gli eventi culturali più importanti del momento
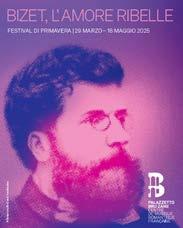

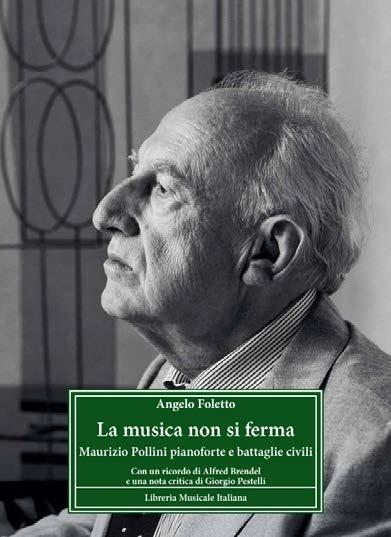

Fin dal 1972, quando alla Società del Quartetto di Milano fu costretto a cancellare un concerto in seguito alle proteste di un pubblico contrariato dal suo appello contro la guerra in Vietnam, Maurizio Pollini è sempre stato un artista sensibile ai problemi del proprio tempo e desideroso di stabilire un contatto fra arte e società. Dagli utopici progetti con Claudio Abbado per portare la musica nelle fabbriche, ai tempi della Milano di Paolo Grassi e degli innovativi “concerti per studenti e lavoratori”, fino ai recenti appelli per la sal-
La città di Orléans, a un’ora di treno circa da Parigi, vale una visita per diversi motivi: il bel centro storico affacciato sulla Loira, la magnifica Cattedrale di concezione gotica, ma anche la particolarissima collezione del Musée des Beaux Arts, posto di fronte alla fastosa Salle de l’Institut del Conservatorio. Fondato nel 1797 dal commerciante e artista Aignan-Thomas Desfriches, il Museo ha il suo punto forte nella ritrattistica e nella pittura dei secoli XVI e XVII. Al di là un celebre Davide che tiene la testa di Golia di Guido Reni e a sublimi opere di Velázquez, Correggio, Carracci, Tintoretto, Chardin, nonché opere di piccole dimensioni ma grande valore di Boucher e Fragonard, l’interesse del museo è soprattutto nella congerie di opere di mirabile fattura di autori da noi poco noti ma rilevanti, come il romantico Léon Cogniet. Splendide anche le sale dei grands tableaux, arrichite da notevoli sculture.
vaguardia della Costituzione, Pollini ha vissuto la passione politica non come bandiera utilitaristica (non ne aveva bisogno), ma per profonda convinzione. Oltre agli snodi cruciali di questo percorso, nel ricco libro “La musica non si ferma. Maurizio Pollini, pianoforte e battaglie civili”. (Lim Editore, 22 euro) Angelo Foletto tratteggia la parabola del grande musicista milanese in termini di repertorio ed evoluzione interpretativa, dagli anni della vittoria allo Chopin di Varsavia fino agli ultimi sofferti ma commoventi concerti.
In occasione dei 150 anni dalla prima assoluta di Carmen e dalla morte del suo autore, Georges Bizet, Palazzetto Bru Zane dedica un intero festival al geniale compositore francese. “L’amore ribelle” è il sottotitolo ma, intelligentemente, il focus della rassegna è piuttosto sul camerismo di Bizet e su alcune rarità di valore. Fra queste, Le Docteur Miracle, lavoro dei diciott’anni che però mostra già tutta la maestria e l’estro personalissimo del compositore. Eseguita in forma di concerto alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia, ma con l’apporto fondamentale di un attore (il coinvolgente Vincenzo Tosetto) che commenta e illustra l’azione, l’operetta ha avuto come brillanti protagonisti Dima Bawab, Thomas Dolié e Marie Kalinine, Marc Mauillon e Thomas Tacquet, magistrale nel restituire l’orchestra al pianoforte.
Da parecchi anni non mi capitava di ascoltare la pur sempre ottima Orchestra Sinfonica di Milano (ex “La Verdi”) a un livello di coinvolgimento e precisione qual è quello a cui l’ha portata in questi mesi il giovane direttore principale Emmanuel Tjeknavorian. Entusiasmo e sensualità, ma anche rigore e trasparenza, sono emersi in un concerto culminato in un Boléro staccato a un tempo perfetto (non troppo rapido, secondo i dettami dello stesso Ravel), in cui il famoso “studio su un crescendo” è stato realizzato con una varietà coloristico-emotiva rara. Prima, non meno impressionante da parte di Tjeknavorian e dell’orchestra la capacità di cogliere l’Empfindsamkeit di Haydn nella Sinfonia degli addii, fra vena Sturm und Drang, tenerezze e ironia (con la teatrale uscita di scena dei musicisti uno a uno). Suggestivo il rimando del Menuet sur le nom d’Haydn cesellato da Sergey Babayan, solista intenso e raffinato nel Concerto per la mano sinistra di Ravel, ma un po’ teso e frettoloso a causa di un vuoto di memoria nel più famoso Concerto in Sol. Pubblico in brodo di giuggiole.
Tutti i servizi e le opportunità per facilitare l'attività e la vita professionale. In un semplice click
in collaborazione con BeProf
BeProf è l’alleato ideale dei liberi professionisti. In un’unica App hai un insieme di strumenti e servizi selezionati per permetterti di lavorare in modo più efficiente, essere sempre aggiornato sulle ultime novità del mondo della libera professione e per farti vivere la tua vita professionale e privata con più serenità. Registrati gratuitamente e scopri un catalogo di offerte dedicate ai liberi professionisti, tra cui le coperture sanitarie a misura di professionista. Con BeProf, infatti, puoi tutelare la tua salute con le Coperture Sanitarie Gestione Professionisti che derivano
dal Ccnl studi professionali finora previste per i professionisti datori di lavoro. Le Coperture Sanitarie di Gestione Professionisti offrono al libero professionista un’assistenza medica e assicurativa di alto livello, a soli 48 o 72 euro all’anno. Tra le varie prestazioni, ogni copertura include visite specialistiche e accertamenti diagnostici, check- up di prevenzione gratuiti, copertura infortuni, pacchetto maternità, diaria per inabilità temporanea, servizio di consulenza psicologica, rimborsi diretti e molto altro. Accedi o registrati a beprof.it e scopri le coperture disponibili.
BEPROF È L’APP DEI LIBERI PROFESSIONISTI
Le migliori coperture sanitarie e un mondo di prodotti e servizi accessibili in ogni momento da smartphone, tablet e pc
SCARICA L'APP
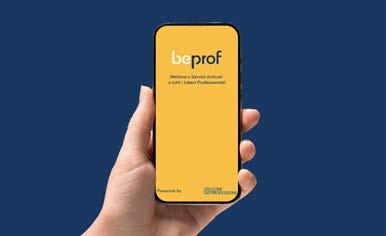
L’INFORMAZIONE
WKI IN PROMOZIONE

Sei già iscritto a BeProf? Invita un tuo collega a registrarsi e riceverete entrambi un abbonamento omaggio di 12 mesi a un quotidiano Wolters Kluwer a scelta. Bastano pochi passaggi. Invita i tuoi colleghi - Accedi alla pagina “Presenta un collega” e copia il link d’invito da condividere con colleghi, amici e familiari liberi professionisti. Ricevi il premio - Quando un tuo collega accetta l’invito e completa i dati del suo “Profilo”, entrambi ricevete l’omaggio. Scegli il tuo omaggio - Per te, 12 mesi di accesso gratuito a un servizio a scelta tra: - IlQG - Il Quotidiano Giuridico: l’informazione giuridica d’eccellenza; IPSOA Quotidiano: il punto di riferimento in ambito fisco e lavoro; HSE+: l’informazione quotidiana per professionisti tecnici.
I fuel voucher Pellegrini sono buoni carburante che possono essere utilizzati nella rete di distributori a marchio Esso, aderenti all’iniziativa. Disponibili in versione digitale, i fuel voucher hanno un valore predeterminato (5, 10, 25 e 50 euro) e rappresentano per studi e aziende un efficace strumento di motivazione dei dipendenti, collaboratori, partner e clienti. Inoltre, garantiscono importanti vantaggi fiscali: deducibile al 100%; esente da IVA (art 2 D.P.R. 633/1972); se acquistato per il dipendente, non concorre a formare il reddito di lavoro fino a 1.000 euro all’anno o fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico; quando costituisce omaggio aziendale a clienti e fornitori, è deducibile secondo le regole previste per la deducibilità delle spese di rappresentanza (Decreto Legge 112/2008). Grazie alla collaborazione con BeProf è possibile acquistare i buoni con uno sconto direttamente dalla piattaforma.

Apri Formazione è lo strumento operativo di Confprofessioni per la formazione e ha lo scopo di assistere i professionisti nel fronteggiare le sfide dettate dalle trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali attraverso lo sviluppo di competenze. Apri Formazione progetta e gestisce corsi di formazione e progetti finanziati e si avvale delle strutture del Sistema Confprofessioni per monitorare in modo efficace i fabbisogni del mondo delle libere professioni. In particolare attraverso l’Osservatorio delle libere professioni, l’organismo di Confprofessioni per la produzione di studi, ricerche, rapporti ricorrenti sulle trasformazioni in corso nel vasto mondo delle libere professioni. La continua interazione con gli stakeholder e con le diverse associazioni di professionisti della Confederazione consente di anticipare i fabbisogni del mondo delle libere professioni, di cogliere le opportunità di crescita e di divulgare le buone pratiche sviluppate nei territori. Grazie a BeProf puoi ottenere sconti esclusivi sul catalogo di APRI Formazione - Sconto 25% per gli iscritti a BeProf e Sconto 50% per gli iscritti a BeProf e in copertura con Gestione Professionisti.
WELFARE PELLEGRINI MAGGIORI INFORMAZIONI APRI FORMAZIONE
MAGGIORI INFORMAZIONI

Welt, fondata nel 1988, offre servizi qualificati di traduzione, interpretariato, corsi di lingua professionale e supporto all’internazionalizzazione delle imprese e degli studi professionali: una risposta immediata alle esigenze di comunicazione con il resto del mondo. Welt si avvale di una rete di professionisti, traduttori e interpreti su tutto il territorio nazionale e anche all’estero. Una traduzione qualificata offre al tuo studio l’opportunità di comunicare perfettamente con interlocutori esteri e di elaborare documenti congrui e conformi ai requisiti giuridici propri del paese di destinazione. Per i liberi professionisti iscritti a BeProf, Welt offre numerosi vantaggi esclusivi, a cominciare da uno sconto dal 5 al 10% sulle traduzioni giurate rispetto al listino in vigore. Ma non solo, Welt garantisce la qualità del servizio e la consegna puntuale di ogni progetto commissionato; riduzione tempi di attesa per l’asseverazione, grazie alla collaborazione con cancellerie di tribunali, garantendo ai professionisti minori tempi di attesa e il rispetto delle scadenze.
BEPROF È L’APP DEI LIBERI PROFESSIONISTI SCOPRI I DETTAGLI
Traduzioni e corsi di lingue



Autorevoli studi di analisi e di ricerca hanno calcolato l’impatto dei dazi, prima imposti e poi sospesi dall’amministrazione Trump, su diversi settori produttivi del made in Italy: un bagno di sangue. Crollo delle esportazioni, fatturati a picco, tagli occupazionali rappresentano le voci più allarmanti e più ricorrenti nei report diffusi dagli uffici studi delle associazioni di categoria. Numeri e calcoli puntuali che, tuttavia, non riescono ad afferrare l’incoerenza e l’imprevedibilità delle future mosse di Donald Trump, che tiene in scacco ogni più ragionevole previsione. Lungo questo scivoloso crinale, in Italia comincia a muovere i suoi primi passi il Documento di finanza pubblica 2025, approdato nei giorni scorsi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, che dovrà delineare gli indirizzi di programmazione economica del Paese per i prossimi quattro anni, in ossequio al nuovo Patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.
Alla luce dell’incertezza dello scenario geopolitico, a cominciare dal conflitto in Ucraina fino ai ripetuti capovolgimenti di fronte delle politiche commerciali protezionistiche dell’amministrazione americana, analizzare le tendenze della finanza pubblica dei prossimi anni appare più un esercizio retorico che non una concreta piattaforma su cui innestare una corretta politica economica. Le troppe incognite che gravano sull’inflazione, sulla produzione industriale e sulla bilancia commerciale rischiano di vanificare, nonostante i tentativi del Governo, qualsiasi ipotesi di programmazione della spesa per le prestazioni sociali (sanità e pensioni), per la pubblica amministrazione, per gli investimenti per sostenere i settori produttivi fino alle risorse destinate alla coesione territoriale. Un nodo gordiano che, secondo alcuni osservatori, potrebbe esser sciolto solo con un allentamento dei vincoli del Patto di stabilità con il rischio, però, di far sprofondare il nostro debito pubblico negli abissi di un default. POST