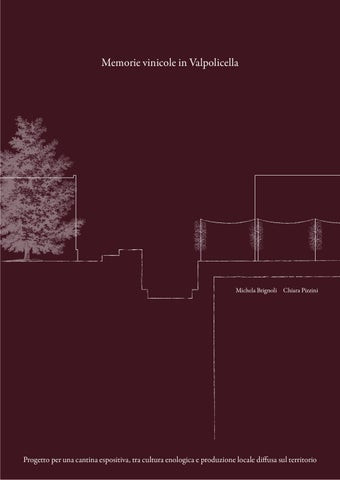Politecnico di Milano Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle CorsoCostruzionidiLaurea Magistrale in Architettura e Disegno Urbano A.a. 2021-2022 MEMORIE VINICOLE IN VALPOLICELLA Progetto per una cantina espositiva, tra cultura enologica e produzione locale diffusa sul territorio RELATORI Prof. Massimo Ferrari Prof.ssa Claudia Tinazzi CANDIDATE Michela Brignoli 951696 Chiara Pizzini 951691
Valpolicella and its wine tradition certainly embody a timeless and extremely well known union; the desire not to trivialize this bond that can sometimes be interpreted as taken for granted, but to be able to convey the true essence of this relationship was what mainly moved the desire to discover its origins, reasons and tell them within the project.
The dualism of this territory of great and modern traditionality to which we belong is what prompted us to want to design the portrait that still characterizes and represents it.
A chameleon territory, a currently strong and historically rooted soul, inhabited by traditions anchored in its valleys and roads, steeped in its architecture and imprinted in its people.
It is not a matter of listing the transformations that the Valpolicella territory has undergone over the centuries, of how wine production processes have changed and how old they are, but it is a matter of investigating and understanding the system of a territory and a culture that was born and has developed with it, of making the soul and meaning of Valpolicella and its tradition breathe through the architectures and scenarios that most belong to it.
Un territorio camaleontico, un’anima attualmente forte e storicamente radicata, abitato da tradizioni ancorate nelle proprie valli e strade, intrise nelle proprie architetture ed impresse nelle proprie genti.
ABSTRACT
Il dualismo di questo territorio dalla grande e moderna tradizionalità a cui apparteniamo è ciò che ci ha spinto a volerne progettare il ritratto che tutt’ora lo caratterizza e lo rap Lapresenta.Valpolicella e la propria tradizione vinicola incarnano di certo un connubio senza tempo ed estremamente conosciuto; la vo lontà di non banalizzare questo legame che può talvolta essere interpretato come scontato, ma di poter trasmettere la vera essenza di questa relazione è stato ciò che ha smosso principalmente il desiderio di scoprirne le origini, le ragioni e raccontarle all’interno del Nonprogetto.sitratta di elencare le trasformazioni che il territorio della Valpolicella ha subito nei secoli, di come siano cambiati i processi produttivi vinicoli e di quanto essi siano an tichi, ma si tratta di indagare e comprendere il sistema di un territorio e di una cultura che è nata e che si è sviluppata con esso, di far
respirare l’anima ed il significato della Val policella e della propria tradizione attraverso le architetture e gli scenari che più le appartengono.
0INDICE|Introduzione 1 1 | La Valpolicella 7 2 | La Valpolicella Classica 13 I tre volti del territorio: morfologia, geologia e idrologia 13 I tre principali prodotti del territorio 27 I primi insediamenti dell’uomo 33 Le caratteristiche dell’edilizia rurale 37 3 | L’evoluzione nella storia 45 La Valpolicella Classica preistorica 45 La Valpolicella Classica romana 51 La Valpolicella Classica medievale 65 La Valpolicella Classica rinascimentale 69 La Valpolicella Classica nel XIX secolo 77 La Valpolicella Classica dal XX secolo ad oggi 85 4 | L’identità della Valpolicella Classica 91 La morfologia della Valpolicella: un territorio ed i suoi volti 93 L’idrografia del territorio: il fiume Adige, i tre progni ed il sistema dei mulini 97 I nuclei consolidati delle antiche Pievi ed i principali paesi 105 La tipologia della Villa Veneta 111
La terra del vino 119 5 | La tradizione vinicola 127 Lo storico ruolo sociale del vino 129 Le differenti tipologie d’uva e allevamento 133 La Cantina ed il processo produttivo 139 Il Recioto e l’Amarone 145 6 | Villa Albertini 149 La frazione di Arbizzno 151 Il sistema dei tre mulini nella valle di Novare 155 Villa Albertini nei secoli 161 7 | Il progetto 171 Percorrere e stare nel territorio 172 La gerarchia dell’itinerario 175 I cinque volti del vino 181 Il nuovo Campo Molino 187 Il progno di Novare: ordinatore di un ossimoro 191 La cantina di Villa Albertini 195 La cedraia tra le ricchezze botaniche 199 8 | Bibliografia e Sitografia 203
1 0 | INTRODUZIONE
“… riuscita alchimia di tradizione e moderni tà” 1
Alla luce di questa volontà è risultata fin da subito evidente la chiave in grado di trasmettere l’identità di questo luogo: quale culto se non quello della tradizione vinicola sarebbe mai in grado di portare con sé le radici di un’origine immemore ed allo stesso tempo di essere la rappresentazione delle massime tecnologie applicate al giorno d’oggi per la propria produzione. Per riuscire a sviluppare questa nostra idea di progetto con cognizio1 Chierighini O., Valpolicella. Recioto e Amarone, 2002, p. 11;
Olivia Chierighini La Valpolicella, territorio a cui appartenia mo, che grazie alle peculiarità che gli sono intrinseche ha suscitato in noi l’interesse e le ragioni per approfondirne la conoscenza, dalla stratificazione morfologica alla stratifi cazione delle tradizioni sociali. La volontà di questa tesi è quella di far tra sparire e riuscire a trasmettere l’anima di un territorio, ciò che dal passato ha fatto sì che ad oggi sia ciò che è: un’intramontata tradizionalità che ancora si respira nelle moderne vie dei paesi che sono fioriti nell’antica Valle.
2 ne di causa ed una conoscenza che potesse renderci critiche nei confronti delle nostre scelte compositivo architettoniche durante il percorso, è stato fondamentale studiare sotto molteplici punti di vista questo ricco territorio, fornendoci quindi le ragioni su cui basare le nostre scelte durante l’iter pro gettuale. Il primo grande mondo preso in esame riguarda gli aspetti in un certo senso prevalenti di questo territorio: la morfologia, la geologia e l’idrografia della Valpolicel la, fondamentali per poterne comprendere la nascita e l’evoluzione degli stabilimenti dell’uomo nei secoli. Si possono infatti interpretare come causa ed effetto dei primi insediamenti antropologici di cui si ha notizia nelle più lontane cave di pietre e marmi pre senti sul territorio. Durante questo percorso di studio propedeutico alla progettazione della nostra idea di Valpolicella, uno degli aspetti che sicuramente ha catturato il nostro interesse è stato il fondamento sulla base del quale inconsapevolmente ed in maniera del tutto spontanea questo luogo si è sempre autoequilibrato: il mondo della natura offre all’uomo un rapporto di reciprocità, grazie al quale l’uomo stesso è stato quindi in grado sin dall’epoca dei romani di fondarvi inizial mente la propria sussistenza e successivamente il proprio sistema economico. Con nuove consapevolezze quindi in maniera concorde
Risiedono dunque in queste ragioni le radici delle motivazioni che hanno spinto all’idea zione di un itinerario espositivo, composto da un sistema di cinque stazioni che si di stribuiscono sul territorio della Valpolicella, regolati da una studiata gerarchia, ognuno dei quali si propone di approfondire una caratteristica del mondo vinicolo veronese. Quest’idea espositiva è stata fondamentale per poter progettare in maniera puntuale il ritratto dell’Antica Valle su cui era nostra volontà lavorare ed allo stesso tempo poter offrire un’entrata in contatto diretta con il luogo che da questo progetto viene raccon tato per poterlo respirare nell’armonia del proprio equilibrio.
abbiamo considerato il culto del vino come ciò che in maniera più calzante potesse esse re emblema di questo racconto, simbolo di tradizione e modernità, macchina motrice della Valpolicella. Allo stesso tempo sarebbe risultato a nostro avviso riduttivo circoscri vere queste nostre volontà nel progetto di una cantina vinicola, perdendo così una percezione fondamentale: quella del territorio.
3
4 “ … come elogiare le virtù di questo vino che ha il colore delle albe e dei tramonti, che è saggio ed eloquente come Nestore, lirico come Orazio e Catullo, malinconico come l’Aleardi, arguto come le poesie di Cesare e Vittorio Betteloni?” 2 Berto Barbarani 2 Barbarani B., Silvestri G. (a cura di), Tutte le poesie, 1968, p. 55.
5
6
“... non c’è collina che appaia illuminata nello stesso modo dal sole e dove la natura pare aver voluto esagerare, sciorinando tutto il suo repertorio di fantasia ed esibendosi come un pittore alla sua esposizione d’arte più impor tante.”
7 1 | LA VALPOLICELLA
3 Paolo Morganti, Sandro Sangiorgi Territorio caratterizzato dalla moltitudine di differenti volti morfologici, questa ricchezza fisica si può certamente far corrispondere anche alla tanto dibattuta e sfaccettata storia riguardante le origini del toponimo Valpolicella. Nel corso del tempo infatti, sono state avanzate numerose ipotesi sull’etimologia ed il significato intrinseco di questo toponimo, portando dunque avanti numerosi e secolari dibattiti che hanno accompagnato l’antica Valle. Dapprima è stato dato molto adito all’ipotesi che riconduceva a delle origini latine il nome Valpolicella, considerandolo quindi derivante dalla locuzione Vallis Polis Cellae, che letteralmente significherebbe valli dalle molte cantine 4. Risulta però alquanto infondato poter ricondurre le origini del nome a quest’etimologia, in quanto in real tà i primi documenti che storicamente sono stati reperiti in merito alla storia di questo A sinistra: foto dei vigneti di Negrar di Valpolicella; 3 Morganti P., Sangiorgi S., L’A marone della Valpolicella, 2003, p. 10; 4 Guy P., Morganti P. (traduzio ne) L’Amarone, 2000, p. 22;
8
9 discusso toponimo risalirebbero al XII seco lo, più precisamente ad un decreto ufficiale dell’Imperatore Federico Barbarossa scritto in lingua volgare risalente al 1177. In questo documento vi si riferisce al territorio in questione definendolo Polesèla 5, privo quin di della dicitura della lettera “c” come invece fu accreditato precedentemente nella prima ipotesi dall’etimologia latina avanzata, rendendola di conseguenza di scarsa credibilità. Verosimilmente a causa di alcuni funzionari del Comune di Verona che avrebbero dovu to compiere delle opere pubbliche e doveva no riferirsi a questo territorio di loro competenza fino al paese di Pol, la più probabile delle ipotesi ricondurrebbe quindi il toponimo Valpolicella all’etimologia volgare Val Polesèla, indicandola letteralmente quindi come la valle del Pol. Una credenza più aulica e poetica invece avanzata da alcuni umanisti della storia avrebbe invece accreditato le origini del toponimo al greco antico Polù Zèlos, letteralmente terra dai molti frutti 6. A pre scindere dalle numerose ipotesi che circondano le origini del nome di questo territorio, quando si utilizza il termine Valpolicella è necessario precisare che non esiste un’unica Valpolicella, ma è ormai consolidata e rico nosciuta un’ulteriore suddivisione di questo territorio, a causa di differenti singolarità che lo caratterizzano.
A sinistra: carta geologica della provincia di Verona, Enrico Ni colis, 1882; 5 Ivi, p. 22; 6 Silvestri G., La Valpolicella, 1950, pp. 40-41;
10
L’intera ed antica Valle infatti, viene notoria mente identificata come la composizione di tre distinte zone, ognuna delle quali è caratterizzata da specifiche caratteristiche morfologiche, geologiche, orografiche e produttive che la distingue dalle altre, pur mantenendo il medesimo scenario naturalistico che ospita queste peculiarità e ricchezze. Prendendo in considerazione il territorio da ovest, ovvero dalla linea naturale dell’Adige che ne delimita il confine occidentale, la prima delle zone che si incontra è la più antica delle tre, ovve ro la Valpolicella Classica, zona caratterizzata dalla presenza di numerose cantine, le più storiche e radicate nel territorio da decenni, come confermano le testimonianze dei ritrovamenti di un’attività produttiva vitivinicola in loco risalente al V secolo. Continuando a percorrere il territorio da ovest ad est, la prima valle che si incontra ad est della città di Verona è quella della Valpolicella Valpantena, conosciuta sin dall’antichità per la sua fertilità e la grande abbondanza di frutti e coltivazioni. Infine spostandosi nell’ultima zona all’estremo orientale della complessiva Valpolicella si trova la terza ed ultima componente del luogo, ovvero la Valpolicella Estesa/Orientale riconosciuta anch’essa per la notevole produzione vitivinicola, anche se di differenti tipologie rispetto alla Valpolicella Classica. A destra: divisione della Val policella nelle tre diverse valli riconosciute.
Il progetto sviluppato all’interno di questa tesi di Laurea Magistrale trova luogo all’in terno dello scenario della Valpolicella Classica, motivo per cui essa è stata la principale e più approfondita zona della Valle presa in considerazione come oggetto di studio all’interno di questa prima fase di analisi propedeutica all’ideazione progettuale.
11
1
12
“L’Adige è più bello dell’Arno, e io ripenso a quelle belle piante sotto le quali l’armonioso fiume scorre verde e profondo, maestoso e pure snello, quelle belle e dolci piante, fra le quali a quest’ora tremola il sole, e fra le quali ricerca il fiume ed il sole uno sguardo soave ed un bel candido viso.” Giosuè Carducci
I tre volti del territorio: morfologia, geologia e idrologia Valpolicella Classica, luogo storicamente identificato e delimitato dalle tre vallate che formano il territorio, esse sono il frutto dell’incisione del suolo da parte dei tre cor si d’acqua, i cosidetti progni, da cui esse nel corso dei secoli hanno letteralmente preso forma, e si tratta del progno di Fumane, quello di Marano ed infine quello di Negrar, che scendono dai Monti Lessini ed arrivano a confluire nel corso del fiume Adige all’altezza della città di Parona2, ovvero il paese che si trova immediatamente ad ovest rispetto alla città di Verona. Con il termine dialet tale progno si indica tipicamente un torrente che scorre sul fondo di una valle solitamente stretta e dai dirupi molto scoscesi e ripidi. Quest’ultima, scalfita dalle acque dei torrenti per secoli e assumendo quindi aguzze morfologie, tende a ricordare la forma della lettera V, per questo motivo a sua volta si è soliti identificarla con il dialettale termine vajo. In linea generale è possibile individuare in questo modo dei primi confini di questo territorio, anche se nel corso dei secoli vi sono state svariate ragioni per lo più storiche, 1 Carducci G., Vita Veronese, 21957;Silvestri G., La Valpolicella, 1950, pp. 2-3;
13 2 | LA CLASSICAVALPOLICELLA
14
15 culturali e fisiche che hanno mutato il volto del paesaggio e dei propri limiti geografici, per questo motivo non è mai stato semplice riuscire ad identificare dei precisi confini. La prima necessità di censire dei veri e propri limiti di questo territorio risale al periodo del Medioevo, quando Federico della Scala ricopriva il ruolo di Conte della Valpolicella e nell’anno 1313 decise di costituire un’identità della Valpolicella che potesse essere a favore del proprio feudo, ingaggiando un consiglio che potesse identificarne i confini amministrativi. Nonostante ciò, a prescin dere dalla natura burocratica che smosse la volontà di ordinare con dei limiti il luogo, la natura dei limiti che vennero effettivamente individuati fu ragionevolmente quella detta ta dalla morfologia del territorio, che come già anticipato mutarono svariate volte nel corso dei secoli, ma non si allargarono mai oltre all’area che si trova a far corrispondere alla Valle rispetto a questo periodo storico.
Attualmente il limite geografico a nord del la Valle è segnato dal bacino del progno di Fumane fino ad arrivare al monte San Giovanni, includendo così all’interno del confine il territorio di Breonio e di Cona, ma allo stesso tempo escludendo quello di Sant’An na d’Alfaedo, anche se questo è riconosciuto come il confine più incerto da poter individuare in maniera consolidata.A sinistra: carta dell’Almagià, la più antica mappa dei territori limitrofi di Verona, 1440;
16
Per quanto riguarda l’area orientale, il con fine invece è più evidente: corre sullo spar tiacque dei monti di San Giovanni, Loffa, Tesoro, Comune e Tondo, i quali separano la Valpolicella Classica dalla Valpolicella Valpantena e successivamente valica per il mon te Sarte e Le Sassine raggiungendo così l’A dige a Parona, completandosi come percorso circolare fino ad arrivare al Monte Pastello e Pastelletto e oltrepassando poi Breonio3. Tornando a prendere in considerazione la questione dal punto di vista amministrati vo invece, attualmente le due tipologie dif ferenti di confini non combaciano tra loro, come riportato all’interno delle pagine del libro del Silvestri, infatti se da una parte dal punto di vista dei limiti geografici ci si trova ad aver incluso anche parte della zona montuosa della Valle e parte del territorio che amministrativamente rientra all’interno del comune di Verona, dal punto di vista organizzativo e comunale vengono conside rati come territori che compongono ufficial mente alla Valpolicella Classica solamente cinque comuni, ovvero: Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, San Pietro in Cariano e Sant’Ambrogio di Valpolicella. Ognuno di questi cinque comuni possiede una singolare identità e caratteristiche ben precise sia dal punto di vista naturalistico sia dal punto di vista costruttivo e produttivo. Sicuramente 3 Ivi, pp. 3-4-5;
è rilevante sottolineare le diverse identità di questi cinque comuni, che nonostante siano adiacenti l’uno all’altro, sono stati in grado di sviluppare un ventaglio di peculiarità disparate, a causa delle differenti altitudini a cui essi si trovano e di conseguenza dei diffe renti scenari e delle diverse composizioni del suolo su cui si sono trovati a sorgere, aspetto degno di nota che sicuramente avvalora le puntuali particolarità intrinseche alla natura della Valpolicella Classica.
17
L’antica Valle dagli incerti confini si esten de per circa 240 kmq ed è composta dalla complessa varietà di tre diversi mondi che si distinguono tra loro per natura morfologica, geologica e produtti del territorio, che si possono ricondurre ai tre differenti mon di: una zona montuosa, una zona collinare e una d’alta pianura, che complessivamente si estendono dagli 80 m s.l.m. fino a circa 1200 m s.l.m. Il territorio che si estende da 600 m s.l.m. fino a circa 1100 m s.l.m. viene convenzio nalmente identificato come zona montuosa. Il suolo di questa zona è costituito da calcari cretacei, che nella loro sommità emergono dai sottosuoli dando origine agli strati che compongono i terreni ed in superficie ai pro fili dei rilievi più modesti, dando forma ai primi e più bassi monti che compongono il pianoro dei Lessini.
18
19 Diverse composizioni geologi che della Valpolicella Classica divisa nelle tre zone studiate;
20
Il territorio che si estende dai 200 m s.l.m. fino a circa 600/700 m s.l.m. viene colletti vamente riconosciuto come zona collinare.
Sicuramente si tratta di uno scenario molto differente dalla zona montuosa preceden-A destra: cave di Prun, cave da cui si estrae la pietra della Les sinia;
Qui inoltre ci si trova nello scenario culla delle principali cavità di natura carsica: in fatti le rinomate cave della Valpolicella sono tipicamente appartenenti a quest’altitudine ed alla zona montuosa, notoriamente identificata come la più ricca di cave da cui è pos sibile estrarre i conosciuti e pregiati marmi della Lessinia o la pietra di Prun. D’altro canto anche se la zona montuosa non è particolarmente ricca d’acqua, è molto popolata a fini di allevamenti e pascoli, essendo in fatti caratterizzata da grandi distese di prati molto pregiati dove numerosi pastori con il loro bestiami della zona prediligono salire rispetto ad altri pascoli di modo da mantenere l’alta qualità dei loro animali, in quanto nelle zone a quote inferiore i pascoli non vantano di altrettanta ricchezza del suolo, essendo vi maggior presenza di zone cespugliose o d’interruzione dovuta alla sporgenza della roccia. Le principali vegetazioni che completano la zona montuosa sono per lo più macchie boschive, principalmente di faggi ed abeti, talvolta anche di castagneti, anche se non mancano zone in cui si trovano estesi seminativi di frumento, segala e trifoglio.
21
22 temente descritta, ma che prevalentemente compone e caratterizza quella che è la natura maggiormente appartenente all’immaginario collettivo e tradizionale della Valpolicella Classica. Questa è la zona in cui maggiormente risultano evidenti le tre differenti vallate che compongono l’antica Valle di cui si accennava in precedenza, insieme allo scorrere dei tre rispettivi progni che solcano il territorio confluendo infine unicamente nel corso del fiume Adige. Rispetto alle al tre due zone qui la composizione geologica del suolo è differente: si tratta infatti di una composizione definita prevalentemente da calcari cretacei ed eoceni, intervallata da strati di basalto, in grado di rendere il terreno luogo fertile per lo sviluppo di abbon danti coltivazioni di viti ed olivi. Questo co nosciuto e assai diffuso tipo di coltivazione è ciò che principalmente caratterizza la zona collinare, che ne è popolata in due differenti modalità: talvolta si trovano allevamenti di vite disposti su campi di vigneti in piano, mentre altre volte a causa dei seppur modesti rilievi presenti sul territorio è necessario realizzare dei terrazzamenti, dialettalmente marogne, su cui disporre i medesimi alleva menti per svalicare il problema di eventuali pendenze all’interno di spazi adibiti ad essere coltivati. Il fatto che la zona collinare sia una delle parti di territorio in cui si possono
maggiormente trovare coltivazioni in grandi quantità è grazie anche alla presenza di nu merosi progni in loco, tramite i quali è stato sicuramente più semplice implementare un sistema d’irrigazione nella zona collinare così come si vedrà nella zona d’alta pianura, facendo di conseguenza in modo che queste due zone risultassero essere come i luoghi in cui si concentrassero principalmente le coltivazioni. Infatti, oltre ad abbondanti terreni dedicati a vigneti e oliveti, tra di essi nella zona collinare troviamo in grande quantità anche grandi distese di frumento, granotur co e molte coltivazioni di orti di verdure e Infine,fragole.il territorio che si estende dagli 80 m s.l.m. fino a circa 200 m s.l.m. viene ricono sciuto come zona d’alta pianura, corrispon dente al limite infimo della Valle veronese. La composizione del suolo della zona pianeggiante è sicuramente quella che presenta una più spiccata differenza delle tre citate a causa delle diverse modalità di formazione di questa porzione di territorio rispetto alle due precedentemente descritte. Molti terreni infatti si formarono durante l’era glaciale grazie allo scioglimento di numerosi ghiac ciai, che arrivando fino a valle e portando con sé numerosi detriti, riuscirono a costituire dei veri e propri terrazzamenti sul territorio. Anche le piene del fiume Adige por-
23
4 Morganti P., Sangiorgi S., L’A marone della Valpolicella, 2003, p. 11;
tando con sé molti detriti fu l’altro fattore caratterizzante per le composizioni dei suoli della pianura, in questo caso si tratta però di una composizione differente, in quanto si tratta principalmente di suoli siliceo-argillosi. Negli ultimi decenni svariate opere di bonifica sono state portate a termine ed han no reso molto fertile questa zona, anche per questo motivo essa si presenta ricca di terreni dedicati alle coltivazioni principalmente di ortaggi o alberi da frutto, si considerino i noti ciliegi della Valpolicella, ma anche le numerose e caratteristiche coltivazioni di pesche. Il fondamentale sostentamento che sta alla base di questa grande natura agricola della Valpolicella è sicuramente individuabile nella propria idrografia: dal fiume Adige al sistema dei progni che solcano la morfo logia del territorio, non è sicuramente da considerare secondario il grande ruolo che l’idrografia ha da sempre svolto per questa zona veronese mantenendola viva. Infatti, il sistema di mulini sull’acqua e lungo le rive del fiume ne sono testimoni, avendo trovato luogo sulle arterie blu che scorrono lungo tutto il territorio, a riprova dell’importanza che l’elemento dell’ acqua ricoprì da sempre come una delle prinicipali fonti di energia utilizzate da molti secoli in aiuto alla produzione agricola dell’uomo.
24
4 Paolo Morganti e Sandro Sangiorgi
“Il susseguirsi dei giochi cromatici vede il verde dei vigneti alternarsi al bianco dei fiori di ciliegio in primavera, al verde argenteo degli antichi olivi e a quello più scuro di cipressi e querce.”
25
26
A questo punto, avendo preso coscienza di quanto sia ricco sotto innumerevoli punti di vista il territorio veronese della Valpoli cella e da quanti scenari differenti esso sia composto, nonostante la sua non esagerata estensione, non risulta difficile pensare al fatto che i prodotti che esso è in grado di far fiorire sul proprio suolo ed offrire all’uomo che vi abita e vi lavora siano di differente genere e natura. Sempre Giuseppe Silvestri 5 ne fa un elenco dettagliato ed esplicitato in tutta la complessità, all’interno del proprio libro, dei processi lavorativi che stanno alla base di ogni prodotto del luogo, una descri zione del loro impiego ed un excursus sulla storia di ciascuno di essi. Si tratta principalmente di tre prodotti: vino, da intendersi come prodotto finito ma anche in qualità di materia prima, quindi ad esempio si pen si all’impiego di differenti uve che vengono utilizzate grazie alla loro alta qualità anche in ambito gastronomico o per la produzione di differenti prodotti tipici, quali distillati o gelatine. Come secondo prodotto offerto dal A sinistra: vigneti della Valpoli cella nella zona di Fumane; 5 Silvestri G., La Valpolicella, 1950, pp. 249-250;
27
I tre principali prodotti del territorio
28 territorio troviamo la coltivazione di alberi da frutto, principalmente si tratta di ciliegi e peschi, di cui la Valpolicella è ricca e per cui è nota a grande scala, tanto da essere motivo di una delle ipotesi etimologiche del proprio toponimo PolùZèlos ossia valle dai monti frutti. In ultimo il terzo prodotto, anche se non per importanza né quantità presente sul territorio riguarda il mondo dei marmi e delle pietre, che come precedentemente descritto, sono stati in grado sin da epoche remote di caratterizzare tutta l’edilizia loca le nelle proprie particolari tipologie ed ele menti architettonici ricorrenti nella storia. Prendendo in considerazione il primo dei tre prodotti elencati, il vino è sicuramente una delle prime ricchezze di questo terri torio, sul quale basa gran parte del proprio commercio e produzione. Le radici della tradizione vitivinicola della Valpolicella risalgono a secoli molto remoti, di cui abbiamo testimonianza fin a partire dal V secolo, grazie a ritrovamenti fossili, al reperimento di scritti o corrispondenze risalenti all’epoca romana. Non da meno sono le antiche radici e l’importanza degli altri due prodotti che tipicamente vengono riconosciuti come caratteristici della Valpolicella: la qualità dei frutti, pesche e ciliegie, di cui si è diffusa l’esportazione da tempi molto lunghi in tutta Italia6; ma anche non di meno è il pregio dei Nelle pagine precedenti A sinistra: campo di ciliegie della Valpolicella Classica col Alinare;destra: pesche di Verona IGP, appartenenti alla specie Persica vulgaris M.; A destra: oliveto su marogne a San Giorgio di Valpolicella; 6 Ivi, pp. 252-253;
29
30
7
Le parole di Elisabetta Parisi all’interno del proprio articolo nell’Annuario Storico della Valpolicella, confermano la tradizione senza tempo dell’estrazione della pietra locale e di come essa sia stata fondante caratteristica anche dell’edilizia rurale nei secoli. Nondi meno Mauro Calzolari sempre in un arti colo all’interno dell’Annuario Storico della Valpolicella8 riporta uno studio realizzato da lui stesso ed altri studiosi locali, all’interno del quale viene riportata e documentata l’ampia diffusione delle pietre della Lessinia e marmi veronesi all’interno dello scenario di tutta l’Italia settentrionale e di come essa abbia preso piede in campo edilizio non solo localmente, ma anche nelle regioni limitrofi, quali Lombardia ed Emilia Romagna.
31 marmi che da altrettanti tempi antichi carat terizzano le produzioni della Valle. “Secoli di estrazione della pietra hanno lasciato a Prun queste enormi gallerie, lunghe chilometri, con pilastri naturali lasciati durante l’estrazione manuale per sostenere la volta dell’antro.”
“Passeggiando a ridosso dei vigneti, fiancheggiando i muri a secco, osservando le antiche corti rurali costruite in pietra di Prun, si è consapevoli di un passato antichissimo, eppure vi cino, sempre presente, che la nostra civiltà non ha sapito cancellare” 9 Olivia Chierighini A sinistra: grotte di Prun, cave della pietra della Lessinia; 7 Parisi E., Un convegno sulle cave di Prun., in Annuario Sto rico della Valpolicella, 2002, p. 8318;Calzolari M., La diffusione dei marmi veronesi in età romana nell’Italia settentrionale: aspetti topografici., in Annuario Stori co della Valpolicella, 2003, pp. 9169-170-171;Chierighini O., Valpolicella. Recioto e Amarone., 2002, p. 14;
32
33
A sinistra: spuntone di roccia attorno al quale sono state sca vate le capanne preistoriche di 1110Colombare;Ivi.,p.14;SilvestriG., La Valpolicella, 1950, pp. 24-25;
Questo periodo ci è dato conoscerlo proprio grazie alla scoperta da parte dell’illustre Sci pione Maffei nel XVIII secolo11, di lapidi rinvenute all’interno di grotte e cave che si trovano nella zona montuosa della Valle, ac-
I primi insediamenti dell’uomo
“Respirando un’atmosfera che sa di poesia e d’arte, immaginando storie di popoli barbari, d’armi e cavalieri, d’osti e di santi, tra vigne e castelli, si percepisce la forza delle radici cultu rali di questa splendida valle.”Olivia10 Chiereghini Grazie all’interesse nei confronti della ricca ed antica Valle da parte di numerosi ed illustri storici, quali ad esempio Scipione Maffei, Pier Paolo Martinati, Stefano de Stefani, Gaetano Pellegrini, Achille Forti, Raffaello Battaglia e Francesco Zorzi è stato possibile avere le prime basi per ricostruire la storia dei primi insediamenti antropologici in Valpolicella, che ha fonda le proprie radici in epo che decisamente molto antiche. I primi segni dell’uomo di cui si ha notizia e testimonian za all’interno del territorio infatti, sono stati fatti risalire al periodo del lontano Paleolico.
34 compagnate anche dal disvelamento di nu merose incisioni sulle pareti rocciose delle stesse e dal ritrovamento di oggetti di pietra utilizzati verosimilmente come utensili. Per portare alcuni esempi, nel testo scritto da Luciano Salzani12, vengono elencate in maniera puntuale le aree interessate da questi primis simi insediamenti: la Mattonara (San Pietro in Cariano), dove è stato ritrovato un gruppo di selci, quel gruppo di selci strane di Breonio che furono catalogate come dei falsi, anche se in realtà dopo averle studiate ed analizzate appaiono come dei veri e propri utensili anti chi; a Sant’Ambrogio di Valpolicella sono stati rinvenuti dei materiali, frammenti di vasi ed asce, appartenenti all’età del Ferro e del Neolitico, dopo aver eseguito degli scavi per la re alizzazione dell’ ampliamento di un edificio pubblico. Sulla base di questi ritrovamenti si sono quindi ampliate le ricerche per ulteriori ipotetici ritrovamenti in zone limitrofe, ad esempio quelle di Montidon e la zona di Monte, entrambe collocate a Sant’Ambrogio di Valpolicella, nelle quali nel primo caso sono stati rinvenuti frammenti di ceramiche d’epoca preistorica in una zona di pianura agricola, mentre nel secondo caso gli utensili ritrovati furono trovati all’interno di cave di marmo. Questo genere di utensili, frammenti di strumenti in pietra o ceramica, tombe, particolari stratificazioni del terreno ed inci-
35 12 Salzani L., Aggiornate con le recenti ricerche le conoscen ze sull’antica frequentazione dell’uomo in Valpolicella. in An nuario Storico della Valpolicella., p. 6-20; 13 Salzani L., Recenti ricerche e ri trovamenti archeologici., in An nuario Storico della Valpolicella., p. 110-122;
sioni sono state ritrovate anche in altre diver se zone, ad esempio spostandosi nella zona del paese di Dolcè, più precisamente a Passo del Piccon, oppure ancora a Sant’Ambrogio di Valpolicella nella zona di Gargagnago; anche a Castelrotto e Cengia, entrambi situati a San Pietro in Cariano e a Parona, ed infine tornando in zone a più alta quota vi furono rinvenimenti anche a Breonio (Fumane) nei pressi del Monte Loffa, a Monte Comun (Negrar), a Castel Besin (Marano), e nel borgo antico di San Giorgio di Valpolicella.13
36
Le caratteristiche dell’edilizia rurale
Una volta studiata la storia che accompagna i primissimi insediamenti antropologici, è risultato interessante immergersi in quelle che sono state le trasformazioni future dei tratti distintivi per il territorio degli elementi che hanno nei secoli caratterizzato l’edilizia autotoctona, considerabile come edilizia principalmente rurale ed i materiali locali con i quali essa ebbe da sempre il pregio di essere realizzata, trovando risposta in tre principali forme insediative risalenti originariamente in epoca romana: le piccole fattorie, le aziende agricole e le villae. 14 Questo aspetto inevitabilmente durante il corso dei secoli è stato modificato dalle necessità d’ogni epoca di lavorazione e valorizzazione dei principali prodotti che questo territorio offre all’uomo ed alla propria economia, creando in questo modo un legame strettamente indissolubile tra tipologia architettonica e paesaggio natu ralistico, all’interno del quale l’edilizia rurale fonda e trova le proprie ragioni, equilibrandosi ed adattandosi con armonia in esso. A riprova di questo fatto “Giuseppe Pagano, ha osservato che dove le condizioni climatiche, le In alto a sinistra: manutenzione di una pergula. Particolare di un affresco di Francesco Cossa nel Palazzo Schifanoia di Ferrara, XV secolo; In basso a sinistra: pergolato accostato ad una dimora padro nale rinascimentale. Particolare di un affresco di Andrea Mante gna nella chiesa degli Eremitani di Padova, XV secolo; 14 Cordioli S., Il paesaggio antro pico della Valpolicella romana., in Annuario Storico della Valpo licella., pp. 35-40;
37
Le costruzioni portarono avanti nei secoli le medesime forme rimanendo invariate nei capisaldi della loro costruzione dall’epoca
15
Proprio per questo motivo, la casa dell’uomo contadino sarà inevitabilmente legata alla natura in cui essa si trova immersa, al clima dell’ambiente ed ai prodotti che vengono tendenzialmente coltivati in quella zona per poter soddisfare al meglio le necessità di la vorazione e produzione della vita agricola.
38 abitudini di vita, i fattori economici non hanno subito sostanziali modificazioni, le risul tanti edilizie dell’architettura utilitaria non cambiano, dove la costruzione è interpretata come strumento di lavoro, scaturiscono ancora oggi le stesse risultanti edilizie.”
Basti pensare ai primissimi insediamenti antropologici di cui si è descritto in precedenza: non si tratta di case di paglia, ma di rifugi nella natura dentro le cave del Monte Loffa, che in seguito si sono adattate alla prospe rità delle materie prime locali, andando di conseguenza a diventare delle vere e proprie costruzioni con materiali di abbondante reperimento in loco, quali ad esempio calcare e tufo, a differenza di ciò che avverrà nei secoli successivi invece, durante i quali per le costruzioni che si trovano nella zona d’alta pianura, a causa del vicino scorrere dell’Adige di più agevole reperimento si trovavano pietre e ciottoli trasportati dal corso del fiume.
Dopo i primi cambiamenti avvenuti nell’anno Mille, verso il XII ed il XIII secolo si può assistere all’affermarsi della tipologia della casa a portico e loggia come risultato di una graduale evoluzione. Andando a studiare ognuno degli elementi presenti nella tipologia della casa rurale della Valpolicella, Giuseppe Silvestri all’interno del suo libro La Valpolicella riporta una breve descrizione per ognuno di essi di modo da poter giustificare la ragione della propria esistenza all’interno della composizione di quest’anti ca tipologia. Il Silvestri parte prendendo in considerazione l’elemento fondamentale del portico, da una parte luogo deputato alla rimessa di carri ed utensili agricoli, dall’altra Valpolicella,
39
romana fino quasi all’anno Mille, mante nendo una tipologia a cortile chiuso con il corpo della casa che vi si poneva a difesa
15 Silvestri G., La
1950, p. 190; 16 Ivi., p. 191;
16
dello stesso pur non trattandosi di costruzioni propriamente fortificate, ma la cosa principale doveva comunque essere quella di poter avere gli indispensabili spazi per la vita produttiva sia per la pastorizia sia per la coltivazione, ed essendo quindi regolate da semplicità razionale e povertà. Come accennato in precedenza il Pagano conferma che erano architetture “… fatte con scaglie e lastre di calcare nella zona più elevata; sassi tufacei legati da malta nella zona intermedia e ciottoli alluvionali nella zona più bassa.”
40
41 invece come luogo di piccoli lavori durante i giorni di maltempo, ovvero l’antenato della barchessa tipica della tipologia della villa veneta. Il portico inoltre si presenta sempre ad arco e talvolta anche ribassato. Si trova poi la loggia, essa si trova sempre rivolta verso sud ed è anch’essa luogo di deposito, anche se in questo caso di raccolti e strami che grazie alla posizione rivolta a sud trovano il clima perfetto per la propria maturazione ed appassimento. Si tratta di logge sempre e solo ad un ordine, ma di una grande varietà di forme, infatti essa può trovarsi sia ad arco sia a piat taforma orizzontale. Un tratto distintivo dell’edilizia rurale della Valpolicella è sicuramente l’elemento della colombaia. La primitiva forma a pianta circolare, ricorda molto una torre sporgen te dal tetto, forata all’interno, ad uno o più piani, con cornici sporgenti che servono da appoggio ai colombi. Nel tempo dalla pianta rotonda si passa a quella quadrata, da qui il forte richiamo alle torri difensive tipiche dei castelli medievali, e costruite attraverso l’utilizzo di mattoni diventano un motivo ricorrente in Valpolicella, al punto tale che nonostante smise la pratica dell’allevamento di colombi l’elemento della torre rimarrà in variato, adibendolo ad abitazione, deposito o L’aspettofienile. molto interessante della tipologia A sinistra: casa Salvaterra, Prun, si possono notare le due torret te-colombaie e il duplice ordine sovrapposto della loggia rinasci mentale;
17 In merito a questa con siderazione, per chiudere il cerchio degli elementi facenti parte di questa tipologia architettonica all’emblema che è rappresentato da “La pergula di viti e gli alberi da frutto (...) si trovano dunque nel brogilo o broilo (...), il giardino/orto chiuso da muri ed attiguo alla casa.”
18
42 edilizia rurale è trattata nel volume Vite e vino nel Medioevo, in cui ci si riferisce in ma niera specifica a questo periodo storico, ma di fatto si potrà considerare come in realtà nello scenario della Valpolicella sarà così in molte epoche storiche, specialmente in quel la di dominazione da parte della Repubblica di Venezia, secondo cui “Il contrasto fra am biente urbano e ambiente rurale, (...) la campagna, le colture orticole, la vite e gli alberi da frutto si insinuano profondamente nel paesaggio urbano dando ad esso una fisionomia del tutto particolare.”
17 Maroso G., Varanini G.M. (a cura di), Vite e vino nel Medio evo. Da fonti veronesi e venete., 1984, p. 9; 18 Ivi., p. 9.
43
44 Monte Loffa ComunMonte Breonio
La Valpolicella Classica preistorica
La popolazione in questione di cui si ha notizia è come descritto quindi il popolo degli Arusnates. Molti furono i dibattiti nei secoli in merito all’origine di quest’antica popo lazione, ma considerando tutti gli studi che per secoli hanno circondato con curiosità tutto ciò che concerneva le abitudini di questo popolo alla fine verosimilmente essi furono considerati di origini etrusche. Lo storico Maffei ad esempio giustifica questa verità non solo a causa dell’etimologia del loro nome, di cui si hanno differenti ipotesi ma alcuna certezza, ma anche a causa di ri trovamenti di oggetti di venerazione a divi nità di vario tipo: locali e pagane, come ad esempio è fatta testimonianza dalla dedica alle Ninfe Auguste2 del Pagus in cui essi si stabilirono. A questo proposito infatti il culA sinistra: schema dei primi insediamenti antropologici in epoca preistorica; 1 Silvestri G., La Valpolicella, 1950, p. 24; 2 Ferri S., Considerazioni sul pro blema degli Arusnati e delle loro origini nel quadro dell’etnografia protostorica. in Annuario Storico della Valpolicella., pp. 25-28;
45 3 | L’EVOLUZIONE NELLA STORIA
“... ci hanno scoperto un nome all’antica geo grafia prima ignoto, e ci hanno insegnato come i popoli di quella parte del nostro distretto che or diciamo Valpolicella, ci chiamarono, al tempo dei Romani, Arusnates”Scipione1 Maffei
46
In alto a sinistra: oggetti di bronzo e ferro d’uso pratico raccolti da Stefano de Stefani in località Breonio, 1881; In basso a sinistra: esemplari di “selci strane” raccolte da Stefa no De Stefani nelle zone prei storiche di Breonio e Fumane, Fonte:1887-1888;Silvestri G., La Valpoli cella, 1950; 3 Paronetto L., Valpolicella. Splendida contea del vino., 1981 p. 17;
47 to di divinità pagane era solitamente tipica delle popolazioni etrusche. La tramandata testimonianza della loro organizzazione sul territorio corrispondente alle sembianze del Pagus, ovvero un’organizzazione amministrativa e territoriale ricondotta tipicamen te all’epoca preromana in grado di dare una gerarchia al territorio vissuto dagli Arusnati, che si ipotizza comprendesse le località di cui nei capitoli precedenti si è fatto elenco in merito ai ritrovamenti antichi di epoche preistoriche, ovvero le odierne località di Fumane, Mazzurega, Cavalo, Sant’Ambro gio di Valpolicella, Gargagnago, Volargne, Ponton, Pescantina. Secondo questi stessi rinvenimenti di materiali antichi in è stato inoltre individuato come fulcro del Pagus Arusnates San Giorgio di Valpolicella, dove infatti oltre all’antica pieve che conferisce a questo borgo il titolo di più antico e storico di tutta la Valpolicella, è possibile trovare in fianco ad essa i resti del loro antico tempio principale.3 Una certezza di cui si ha notizia in merito a questa popolazione riguarda la loro attività di produzione vinicola, di cui si ha testimonianza grazie alle documentazioni raffigurate a parete ritrovate ed alle tipologie di utensili utilizzati all’epoca, ad esempio un gran numero di anfore: utilizzate non solo per contenere acqua ed olio, ma anche vino di cui vi è conoscenza grazie al ritrovamento
48
A sinistra: basamento con in cisione della dedica alle Ninfe Auguste da parte del Pagus de gli Arusnates conservato presso il Museo Maffeiano, Verona;
49 di una statuetta votiva con anfora in mano, conservata negli archivi della Soprinten denza di Padova, in quanto essa secondo le documentazioni storiche sarebbe stata una la rappresentazione di una donna intenta all’offerta alle divinità di una bevanda con tenuta dalla propria anfora, ovvero come si era soliti dalle tradizioni in ambito religioso trattasi di vino.
50
Mentre nella città di Verona i romani avevano durante questo secolo già pienamente confermato il loro predominio, nella zona pedemontana il loro stanziarsi con insedia menti stabili si fece attendere, causa anche la difficoltà del territorio che incontrarono.
Dall’inizio delle prime testimonianze antropiche risalenti al V secolo a.C. di epoca preistorica, per la vera e propria romanizzazione del territorio della Valpolicella si dovrà attendere circa il I secolo a.C.
51
In linea con quelle che furono le scelte insediative dei loro predecessori etruschi, anche i romani decisero di prendere dominio delle medesime posizioni strategiche princi palmente in zona montuosa e collinare, nei pressi del fiume Adige, dove già si trovavano prevalentemente i pagus Arusnates.4
Rispetto però all’esistenza dei villaggi etru schi preesistenti sul territorio della Valpo licella, in epoca romana assistiamo in una sorta di scissione del territorio in due pagus confinanti con quello antico degli Arusnates: pagus Minervio, corrispondente circa alla zona montuosa di Marano, occupando quindi la parte occidentale della Valpolicella A sinistra: schema delle posizio ni dei villaggi abitati in epoca 4romana;Cordioli S., Il paesaggio antro pico della Valpolicella romana. in Annuario Storico della Valpo licella., p. 33-45;
La Valpolicella Classica romana
52 Classica; e pagus Vardagatesi, che insieme a Valgatara avrebbe compreso anche la parte orientale dell’antica Valle.
Entrando più nello specifico di come i romani decisero di popolare il territorio, le principali tipologie insediative presenti in quest’epoca sono principalmente tre: pic cole fattorie, aziende agricole e le villae romane. Si ha infatti testimonianza di questa tipologia di costruito grazie ai numerosi resti archeologici ed architettonici rinvenuti in maniera sparsa sul territorio. Per quanto riguarda infatti la prima tipologia insediati va menzionata, la piccola fattoria, si prende ad esempio l’abitato di Archi di Castelrotto, edificio a pianta rettangolare tipico della fattoria romana realizzato con materiali tipici della zona, quindi con struttura realizzata con ciottoli fluviali, blocchi di tufo e scaglie di calcare. Alcuni esempi di azienda agricola tipica dell’epoca romana invece si possono trovare nella zona di San Pietro in Cariano, più precisamente nel sito chiamato Ambro san e a Quar, dove le strutture del costruito, risalente circa al I secolo d.C., s’identificavano in ambienti che sviluppavano in maniera duplice sia zone residenziali sia zone pro duttive, circoscrivendo il tutto tramite una perimetrazione muraria esterna. In questo periodo infatti si hanno numerose notizie dell’incremento della produzione vinicola
In ultimo, ma non da meno, è presente la tipologia delle villae, che a differenza delle precedenti sono edifici dallo spiccato pregio architettonico e dalla componente produtti va più articolata. Un emblematico esempio si trova a Villa di Negrar, dove gli scavi relativi all’antica villa romana ed il proprio mosaico della pavimentazione riemerso dal terreno ne rendono possibile uno studio diretto, an che se parziale, della tipologia stessa. Lo stanziamento consolidato in Valpolicella del popolo degli antichi romani senza dubbio mise in moto dunque, differenti aspetti di un grande sistema che iniziò a far muovere l’intera Valle: dalla nascita di importanti nuclei storici, all’incremento delle produzioni dei prodotti offerti dalla terra, si consolidò un vero e proprio sistema sociale ed econo mico, che necessitava di collegamenti verso i paesi limitrofi ed allo stesso tempo di poter essere difeso da eventuali attacchi che potessero mettere in pericolo tutto questo
53 della Valpolicella Classica, già presente in re altà sul territorio sin dal V secolo a.C., ma di cui testimonianze più certe e dirette furono ritrovate grazie ad encomi, poemi ed epistole risalenti all’epoca romana di antichi illustri personaggi, quali Marziale, Virgilio, Orazio e Catullo, per citarne alcuni, che in numero se occasioni esaltarono la bontà e l’ unicità del vino locale.
54
A sinistra: frammenti di mosai co della pavimentazione della villa romana rinvenuti in locali tà Villa di Negrar; sistema. In epoca romana infatti fu costruita la prima importante arteria del sistema infra strutturale della Valpolicella: la via Claudia Augusta, realizzata nel 12 a.C. per volere di Druso, che attraversava l’intera Pianura Padana rimanendo fino ad oggi il fondamen tale collegamento con i paesi tedeschi ed il Trentino, passando appena a nord della città di Verona e del lungo tratto orizzontale del fiume Adige. Ci si trova quindi davanti ai primi passi mossi verso la costruzione del futuro sistema viabilistico, di cui si inizia va già a sentire la necessità principalmente per ragioni commerciali, andando quindi a collegare questa zona della Valpolicella con l’antico mondo circostante con cui si potesse avere passaggio e comunicazione. Comple mentare alla necessità di collegamento vi era quella di difesa, e nonostante non si sia mai ritrovata ad essere un grande teatro di eventi militari, la Valpolicella vanta un territorio che nei secoli ha sempre giovato di una stra tegica posizione dal punto di vista militare, godendo di barriere e difese determinate dalla morfologia della propria natura: protetta a sud ed a ovest dal corso del fiume Adige, mentre a nord dai monti Lessini e ad est dal le altre vallate, che grazie alla loro conforma zione creano una naturale barriera di rallentamento per eventuali invasioni, una volta oltrepassato lo scoglio delle mura di Verona.
55
56
La naturale difesa che la morfologia del territorio regala alla Valpolicella Classica è un vantaggio che risulta di notevole importanza, quando iniziarono le scorrerie e le invasioni da parte dei popoli che aveva in tenzione di impadronirsi innanzitutto della città di Verona e successivamente di svalicarla e raggiungere quello che da sempre fu definito il suo giardino, ricco di prosperità e vantaggi, sotto tutti i punti di vista. Dopo la successione quindi di svariate invasioni, l’inizio dell’età barbarica vede sin da subito l’inghiottire la situazione che circondava la Valpolicella, facendone scomparire quasi completamente sue notizie dai documenti storici per tutto il periodo dell’alto medioevo in merito all’organizzazione del territorio sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista politico, riconducendo tracce di questo periodo solamente a lasciti lingui stici tipici dei popoli germanici, autori delle invasioni dell’antica Valle di Verona. Durante il periodo longobardo però è documentata la grande importanza che assunse il paese di Castelrotto, il cui nome infatti probabilmente deriverebbe dallo stesso re A sinistra: schema degli inse diamenti da parte dell’uomo medievale suddivisi nelle due principali valli all’epoca rico nosciute;
La Valpolicella Classica medievale
57
58 dei longobardi, il re Rotari, che decise di stanziarvisi dal 636 al 652 e consolidare così l’antico Castrum Rotharii, come forte punto strategico e militare nonché luogo dal quale fu scritto il famoso editto di Rotari, emanato a Pavia nel 643, lasciando traccia del proprio dominio su questo territorio con “...gli avan zi del castello che viene fatto risalire al Mille, ma che ha certo origini più antiche, probabilmente romane.”
In epoca medievale il territorio della Val policella fu diviso in due differenti zone dal punto di vista amministrativo: una prima grande porzione, la valle Pruviniano, zona che comprendeva tutta la metà occidentale della Valle stessa, dall’alta pianura alle pendici montuose dei progni di Fumane e di Ma rano fino al loro sfociare nel fiume Adige. Il nome di questa valle probabilmente derivava dalla tribù che la abitava in epoca romana o più semplicemente dalla presenza del paese di Prun nella stessa area. L’altra metà della valle invece fu identificata come val Veria go, e comprendeva la totalità del bacino del progno di Negrar, dalla zona montuosa fino ad arrivare alle pendici dei colli di Parona e quindi al suo sfociare nel fiume Adige. En trembe queste distinzioni del territorio sa ranno destinate a scomparire da tutti i documenti, come ci viene riportato dal Silvestri, vero il XII secolo, lasciando spazio alla già
5
In quest’epoca di cambiamenti inoltre si possono notare degli ulteriori sviluppi per quanto riguarda la rete infrastrutturale, che conformemente alla suddivisione del territorio nelle due valli occidentale ed orientale, inizieranno a svilupparsi in direzione nordsud, sviluppandosi dalla principale arteria distributiva d’epoca romana preesistente, la via Claudia Augusta. Vennero quindi realizzate tre principali vie di comunicazione territoriale che assunsero una direzione pa rallela al corso dei tre fondamentali progni: Fumane, Marano e Negrar, da cui l’intera Valpolicella Classica è solcata.
5 Silvestri G., La Valpolicella., 1950, p. 37; 6 Ivi., p. 38; 7 Ivi., p. 39;
Come anticipato precedentemente, la prima volta in cui si vide comparire il toponimo di Val Polesèla 7 risale al 24 agosto 1177 e di conseguenza questo toponimo porta con sé quelli che sono i nuovi confini territoriali disegnati dall’imperatore Federico Barbarossa, i più ampi mai considerati nel corso della storia della Valpolicella, facendo scomparire definitivamente la precedente spaccatura a metà della valle veronese. Intorno all’anno Mille, epoca in cui la documentazione in merito alla storia ammini strativa e politica della Valpolicella torna ad essere nota, si registra un periodo di prosperità dal punto di vista economico e di conseguenza di benessere sociale, testimoniato
59 citata lingua volgare Val Polesèla. 6
62 anche grazie dal sorgere di numerosi castelli, monasteri ed istituti religiosi che iniziarono a costellare il territorio in corrispondenza al periodo dell’avvento delle Signorie sul territorio, di cui queste tipologie architettoniche sono tipiche. Exemplum dal punto di vista artistico ed architettonico di questo periodo, si trova all’interno dell’antico regno di Liutprando a San Giorgio di Valpolicella, dove con la propria pieve e ciborio d’epoca romanica costituisce testimonianza di grande pregio dell’antichità storica e della cristianità val policellese tra l’XI ed il XII secolo. In questo periodo infatti la zona occidentale della Valpolicella non era granchè soggetta all’amministrazione delle signorie ed alla presenza quindi di numerosi castelli, e questo consen tiva di avere una considerevole autonomia da parte degli uomini che abitavano il territorio, nonostante facessero comunque le veci amministrative di coloro ai quali erano sot toposti, ovvero conte e vescovo di Verona. In ogni caso, per avere un’idea della situazione in cui si trovava San Giorgio, sono da tenere in considerazione le parole dello storico Andrea Castagnetti, riportate nell’Annua rio Storico della Valpolicella dove esplicita “l’impressione di essere sì in presenza di una comunità rurale soggetta a signori, ma ben conscia della propria forza, della propria tra-
63 dizione e, soprattutto, di un collegamento diretto con il potere pubblico (...) effettivo fino al secolo precedente, non tuttavia dimenticato”
x
Riprendendo in considerazione la situazione amministrativa complessiva in quest’epoca, dal 1262 al 1387 il dominio della città di Verona e di gran parte del Veneto, si trovò nelle mani della famiglia Della Scala, detta anche degli Scaligeri. In corrispondenza di questo periodo, in particolare con l’avvento al potere del fratello di Mastino I della Scala, Alberto, si documenta un primo momento di lieve declino del benessere economico e sociale, dovuto in parte al completo assoggettamento della Valpolicella alla Signoria Scaligera da cui fu in gran parte privata della propria autonomia, essendo Alberto della Scala ufficiale fautore del passaggio dei ter ritori scaligeri da liberi comuni a Signorie. Dopo la morte di Alberto della Scala, vi furono diverse successioni al potere da parte degli esponenti della dinastia, fino a quando nel 1310 l’imperatore Enrico VII nominò entrambi i figli del defunto Alberto della Scala in qualità di vicari, ma ben presto uno dei due morì, lasciando il potere nelle mani di Cangrande della Scala, signore rispettato ed illuminato.9 Nel 1325 però Cangrande fu colpito da una malattia, lasciando così il potere a Federico della Scala che si fece eleggere principe. In corrispondenza del dominio di Nella pagina precedente: la Pie ve romanica di San Giorgio di 8Valpolicella;BrugnoliA., Il castrum e il ter ritorio di San Giorgio nel medio evo: vicende istituzionali e tracce materiali. in Annuario Storico della Valpolicella., p. 27; 9 tale.it/dinastie/della-scala/https://www.storiarinascimen ;
64
65 Federico della Scala, la Valpolicella Classica probabilemente anche a causa di una forte bramosia di potere da parte del Signore regnante, riuscì a definire una precisa configurazione dei propri confini sia dal punto di vista territoriale che amministrativo. Come prima cosa infatti, il principe Federico decise di definirne i confini geografici, riuscendo a stabilirne un’ identità indipendente rispetto all’unità amministrativa e giudiziaria della Signoria: ad ovest il territorio di competenza si estendeva fino al Trentino, limite attuale della provincia, sopra Ossenigo, per poi se guire l’Adige fino alle porte di Verona ed infine risalire verso nord ad ovest di Quinzano raggiungendo Costagrande, Montecchio, Monte Tondo, Monte Fiamene, ed il ponte di Veja, per poi arrivare a Castelberto e se guire l’attuale confine provinciale ed arrivare nuovamente ad Ossenigo. Una volta decisi i confini, Federico della Scala stabilì i rapporti che il feudo e la Signoria scaligera dovessero mantenere e si preoccupò quindi di stringere un accordo che comprendesse un trattato di estradizione, un’alleanza difensiva ed anche un trattato commerciale. In questo periodo infatti ci si trova davanti ad un ulteriore im plemento della rete infrastrutturale di cui fu molto sentita la necessità proprio per motivi di ulteriori collegamenti non solo commerciali sul territorio, ma anche per poterne aveA sinistra: “La carta lapidaria”, lunga iscrizione scolpita sulla parete meridionale del campa nile della pieve longobardo-ro manica di Negrar;
66
67 re un controllo più immediato e in maniera semplice. Alla ripresa di Cangrande della Scala dalla malattia però, egli tornò per spodestare il principe Federico, che a causa della troppa sete di politica, fu bandito insieme a tutta la propria famiglia ed a tutte quelle che parteciparono al complotto contro Can grande.10 Nel 1387 il potere degli Scaligeri cadde lasciando il segno sul territorio della propria massima espansione sia dal punto di vista dei confini, sia dal punto di vista dell’e spansione dei collegamenti nelle sue infra strutture, per lasciare spazio al dominio da parte dei Visconti sotto il quale Verona ed i territori circostanti caddero per un breve periodo, caratterizzato da imposizioni da parte di coloro che stavano al potere ed insurrezio ni della popolazione veronese che sentiva la mancanza della famiglia scaligera. I comuni rurali vennero quindi raggruppati in nuove entità amministrative, cosiddette vicariati, tra i quali fu compresa anche la Valpolicella che rimase tale fino al XVI secolo, con sede nell’attuale palazzo comunale di San Pietro in Cariano.11
A sinistra: pieve romanica di San Floriano, comune di San Pietro in Cariano, foto di Paolo 10Groppo; tale.it/dinastie/della-scala/;https://www.storiarinascimen
11 Ivi.;
68
69 La Valpolicella Classica rinascimentale Dopo questo breve periodo di dominazione da parte dei Visconti, il territorio di Verona si trova ad essere dominato per un periodo altrettanto breve e di poco conto da parte dei Carraresi. Durante questo periodo però, Venezia sta ponendo le basi per poter espandere il proprio dominio, bramando anche sulla città di Verona e territori limitrofi. Nel 1404 infatti, la Serenissima si trovò a sconfiggere il dominio Carrarese su Verona, dopo aver stretto un’alleanza con Francesco Gonzaga. Così, riporta lo storico Giuseppe Silvestri “ ... tutta in men d’un mese si ridusse alla devozione dei Veneziani.” 12 i quali ufficialmente nel 1405 iniziarono il periodo di dominio da parte della Serenissima Repubblica di Venezia, che si prolungò fino alla seconda metà del XVI secolo nonché all’avvento di Napo leone e le proprie truppe. La Repubblica ve neziana al proprio stabilirsi trovò i Comuni rurali riuniti nei vicariati precedentemente istituiti durante l’epoca di dominio visconteo e decise che le identità amministrativo-giudiziarie in cui i comuni furono prece dentemente suddivisi potesse rimanere tale,
A sinistra: schema degli svilup pi degli insediamenti ed infra strutture in epoca rinascimen tale nella Valpolicella Classica; 12 Silvestri G., La Valpolicella., 1950, p. 58;
70
71 e così fu fino alla caduta della Repubblica. Nonostante questa decisione di continuità, la Serenissima decise comunque di variare estensione e composizione dei vicariati facendo ad esempio perdere alla Valpolicella la zona montuosa orientale della Lessinia, che fu riconosciuta invece al vicariato delle Montagne, riuscendo però a rimanere invariata nella composizione dei restanti confini. La composizione organica del territorio per tutto il XVI fu resa di possibile consultazio ne grazie alle cartografie rinvenute durante i secoli, dal Toniolo alla carta manoscritta del Territorio Veronese e Vicentino di Cristoforo Sorte, che resero note le divisioni territoriali operate all’epoca. La dominazione veneziana fu caratterizzata da assoluta fedeltà del la Valpolicella alla Serenissima, il che fece godere il vicariato di un momento storico caratterizzato da quiete e pace, tanto da garantire svariati favori al territorio da parte della Repubblica stessa. A dimostrazione di ciò, ad esempio vi è il fatto che le fosse con cesso di poter avere un proprio stemma, che si trovava come frontespizio dei Privilegia et Jura Communitatis et hominum Vallis Pulicellae del 1588. L’intero scritto fu preparato da Giangiacomo Pigari in onore della Valpo licella, commissionato dal vicario dell’epoca e dal Consiglio dei Diciotto, avendo quindi carattere ufficiale. Si tratta di un volume conA sinistra: frontespizio del Pri vilegia et Jura Communitatis et hominum Vallis Pulicellae, 1588;
72
73 tenente una raccolta di documenti preceduta da due prose latine e componimenti poetici di diversi autori. Fu formato il nuovo terri-
torio amministrativo del Territorio Veronese circa alla fine del XVI secolo, ovvero lo stesso territorio che sarà successivamente ricono sciuto come la provincia attuale. Di questo nuovo territorio amministrativo all’epoca la Valpolicella rappresentava il vicariato più notevole sia dal punto di vista della propria estensione sia in merito alle ricchezze che il territorio racchiudeva, portando avanti questo titolo fino al XVII. A testimonianza della grandezza dell’antica Valle veronese a quell’epoca, nel manoscritto dal titolo Informazione delle cose di Verona e del Veronese fornita il primo Marzo MDC, conservato all’Archivio di Verona, riporta il Silvestri che “... il vicariato della Valpolicella nella sua ultima estensione aveva una circonferenza di 25 miglia e comprendeva ventisette “ville” o comuni, senza contare le “Aggiunte” e Pol, il quale ultimo dipendeva direttamente dal ve scovo di Verona.” 13 Questo periodo di pacifico dominio da parte della Serenissima inoltre, fu il momento in cui ebbe inizio il diffondersi delle prime ar chitetture identificabili nella tipologia della villa veneta, che dopo un primo momento di diffusione principalmente in zone padovane e vicentine, arrivò anche ad affermarsi in ValA sinistra: Valpoliccella Classi ca nella carta topografica mano scritta del Territorio Veronese, conservata nell’Archivio di Sta to di Venezia, 1439; 12 Silvestri G., La Valpolicella., 1950, p. 70;
74 policella. Con questa diffusione tipologica in realtà si ricrea un nuovo concetto d’abi tare, con cui i Signori Veneziani iniziano a popolare il Giardino di Verona: il concetto che sta alla base della tipologia della villa veneta infatti è quello di poter avere una casa immersa nel verde della natura, in cui poter trovare diletto lontano dalle fatiche della vita di città tipica della Repubblica Veneziana ed allo stesso tempo non di meno poter sfruttare i vantaggi produttivi della natura all’interno del quale si è ci si trova e riuscire ad avere quindi una vera e propria macchina agricola produttiva che accompagna l’abitare della casa padronale del complesso.
Come accadde in tutto il resto del nord Italia, anche il territorio della Valpolicella tra il 1576 ed il 1630 fu duramente colpito da un’ondata di epidemie di peste, che purtroppo portò con sé un grosso declino sotto tutti gli aspetti della vita degli uomini, dal punto di vista amministrativo, economico ed an che sociale, portando infatti con sè di con seguenza un duro e lungo periodo a seguire di carestie e crisi produttive. Ad aggravare la situazione, il popolo della Valpolicella fu messo a dura prova dall’invasione da parte di Napoleone e dell’esercito francese nel 1796 che segnò anche la fine della dominazione della Repubblica Veneziana.
75
76
77
Quest’invasione segnò la fine del vicariato e del dominio della Serenissima sui territori veronesi, economia dei quali però non ha perso le sue caratteristiche tipiche: la proprietà terriera è sempre nelle mani delle famiglie patrizie, mentre le zoni montane e collinari sono regolate da piccoli proprietari coltivatori e le mezzadrie. La scarsa pre senza di infrastrutture ancora e di mezzi di trasporto di grande capacità rende però l’e conomia quasi di sussistenza, infatti produzione agricola ed industriale risultano essere spesso limitate al loro luogo d’origine, ovvero il podere rustico, dove tutto ciò trova la propria nascita e si sviluppa l’attività economica del tempo. Le truppe napoleoniche si insediarono all’interno di questo scenario con la loro invasione, avvenuto il 1 giugno del 1796, e nonostante la situazione fosse ben poco favorevole per i veronesi, i tentati vi d’insurrezione da parte della popolazione come ultima prova di favore nei confronti della Serenissima avvenne poco più tardi in quegli episodi chiamati Pasque Veronesi 14 , ovvero dal 17-23 aprile 1797, che però tro -
La Valpolicella Classica nel XIX secolo
A sinistra: schema degli svi luppi degli insediamenti ed in frastrutture in epoca moderna nella Valpolicella Classica; 14 Silvestri G., La Valpolicella., 1950, p. 75;
78 varono solo come esito una dura repressione degli insorti da parte di Bonaparte. La Valpolicella perse dunque la propria iden tità di vicariato, diventando così uno dei dieci distretti in cui la provincia di Verona era stata suddivisa, facendo corrispondere quello della Valpolicella al medesimo territorio che esso comprendeva all’epoca del 1313, mantenendo come storico capoluogo quello di San Pietro in Cariano. Dopo un periodo di battaglie avvenute tra l’esercito austriaco e l’esercito di Bonaparte per il predominio sul territorio veronese e della sua campagna, si ottenne nel 1805 l’entrata di Verona nel Regno Italico, che venne fatta anche capoluogo del dipartimento dell’Adige. Diversi furono in seguito gli avvicendamenti di suddivisione del territorio, in distretti, cantoni e comuni. Dopo un periodo di repressiva e stringente dominazione francese, la Valpolicella iniziò invece a trovare benefici da parte delle migliorie apportate dagli stessi francesi, dopo l’entrata nel Regno Italico e sotto il dominio Austro-Ungarico dal 1815, i benefici riguar darono per lo più un rinnovamento amministrativo ed economico, che fece da trampoli no per la costituzione di una nuova struttura sociale e nuove forme produttive: fu ad esem pio migliorata la qualità delle infrastrutture, applicando delle migliorie all’antica arteria d’origine romana, andando a rettificarla ed ampliarla, ed incentivando i collegamenti se
79 condari, quindi costruendo nuove strade che collegassero i centri rurali, con le città e con i paesi tra di loro, riuscendo sia a trarre con ciò beneficio in merito ai collegamenti, sia smaltendo il traffico dei trasporti e di conse guenza facendo trarre beneficio per tutto ciò alla sfera produttiva ed economica. “Facilita ta così la circolazione dei veicoli, gli ostacoli al traffico ed al commercio spariscono, ed al siste ma dell’economia chiusa subentra quello degli scambi basato sui trasporti anche a distanza. Assume importanza e dignità l’esercizio delle professioni liberali. L’amministrazione della giustizia e della finanza, dei lavori pubblici e delle scuole, tutta cioè l’ossatura della vita ci vile, prende un aspetto simile all’attuale e da allora in poi non verrà più sostanzialmente mutato.”
15 Silvestri
Fu proprio in questo secolo inoltre che iniziarono a muoversi i primi passi verso la costruzione della grande linea ferroviaria che attraverserà tutta la Valpolicella nella parte bassa, costituendo una fondamentale arteria di comunicazione internazionale, mettendo in contatto Italia e Germania, meridione e settentrione d’Europa. Risultò fondamen tale infatti la costruzione di questa nuova macro arteria viabilistica come riscatto ulti mo in grado di dare un grande impulso alla rinascita dell’economia locale, fortemente appesantita da decenni di susseguirsi di malattie che colpirono la vegetazione, i vigneti e G., La Valpolicella., 1950, p. 77;
15
82 quindi la produzione agricola, che provoca rono quindi il susseguirsi di decenni di carestie ed un declino delle risorse economiche notevole. Alla fine del secolo però si reagì a questo periodo buio, con l’idea di realizzare un’opera di ampliamento della linea ferroviaria passante nella mezzadria della Valle, che fosse in grado di collegare Verona con Caprino, e solo successivamente arrivare fino a Garda. L’opera pubblica di simile portata nacque dalla volontà di un gruppo di profes sionisti, quali sindaci dei paesi limitrofi ed ingegneri principalmente, che formarono il comitato promotore dell’opera ufficialmente il 28 maggio 1883. L’importanza di tale linea ferroviaria risiedeva principalmente nel collegamento dei comuni che si trova vano in zone maggiormente sfavorevoli, ad esempio nella zona montuosa, riuscendo a toglierli dalla loro condizione di isolamento e portandoli così ad una situazione di progresso. Fu necessario attendere 3 anni prima di poter ottenere i vari permessi per la realizzazione della ferrovia, che arrivarono l’11 febbraio 1886 nel Regio Decreto n. 3762, grazie al quale si potè dare via libera ai lavori per la propria realizzazione, che ufficialmente iniziarono nel 1887 e trovarono la propria coclusione il 3 agosto del 1889.
Nelle pagine precedenti: foto storica della stazione di San Pietro in Cariano all’epoca di fine ‘800;
83
84
La Valpolicella Classica dal XX secolo ad oggi
Dopo l’avvento della Prima Guerra Mondiale e tutte le conseguenze che essa portò con sè, nel 1927 venne redatta l’ultima riforma amministrativa, che vide un’abbassamento del numero dei comuni della Valpolicella da sette a sei, quali: San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio, Fumane, Marano, Negrar e Pescantina. La prima parte di questo secolo, caratterizzata dalle due Guerre Mondiali e dalle grandi depressioni che esse portarono con sè non fu un periodo di considerevoli cambiamenti dal punto di vista urbano e sociale, se non in merito a distruzioni e ca restie. Durante il periodo immediatamente successivo, a partire circa dalla seconda metà del XX secolo iniziarono i primi movimenti verso quel processo che a posteriori verrà poi definito Negrarizzazione 16, termine in futuro diventato un vero e proprio modo di dire per indicare dei processi di intensa, incontrollata ed esasperata costruzione edilizia di un territorio, arrivando al proprio totale sfruttamento dello stesso. Questa situazione di costruzione edilizia intensiva si protrar rà circa fino quasi alla fine del secolo, forte A sinistra: schema della situa zione dal XX secolo ad oggi in merito alla viabilità e diffusione del costruito; 16 Fedrigo G., Negrarizzazione. Speculazione edilizia, agonia delle colline e fuga della bellez za., 2010, p. 15;
85
86
Ad oggi non si assiste ad un grande cambia mento dal punto di vista produttivo rispetto al secolo precedente, le principali lavorazioni infatti presenti sul territorio sono de-
87 A sinistra: carta del tracciato della storica linea ferroviaria con le proprie stazioni dopo l’ampliamento e l’arrivo dell’i tinerario fino a Garda; del periodo italiano in cui si stava vivendo: ripresa economica, rivoluzione industriale e risollevamento della situazione sociale. La grande conseguenza però si riversò inevitabilmente sullo scenario naturalistico del paesaggio della Valle, arrivando ad un intenso sfruttamento della stessa, senza alcuna regola o limite, portandone allo stremo la capacità territoriale e produttiva. Ad aggravare infatti questa drammatica situazione fu una sostanziale mancanza di un monito che potesse tutelare il paesaggio, ovvero la totale assenza di capacità d’intervento da parte dei comu ni e di piani regolatori, ha intaccato la tutela paesistico-ambientale della Valpolicella. La zona che ha più risentito di questa costruzione edilizia incontrollata è sicuramente la zona collinare, da un lato attraversata dalla strada e della ferrovia che ormai soppressa, ha lasciato il proprio spazio alla nuova costruzione del nuovo tratto di ferrovia, addosso alla quale dal 1961 si è assistito al sorgere di enormi casemoni di cemento l’uno addossa to all’altro dall’aspetto l’uno uguale all’altro che la costeggiavano costruendone un’alta barriera dal quartiere di Borgo Trento fino quasi ad arrivare a Domegliara.
88 terminate dalle materie prime da cui si è da sempre ottenuto grande sostentamento. La regolamentazione tramite strumenti urbanistici, delle costruzioni edilizie ha sicuramente aiutato nella valorizzazione e tutela di questo grande e prezioso territorio verde di cui con grande esperienza agricola si è saputo valorizzare al meglio, lavorare ed allo stesso tempo curare senza sosta grazie alla ripresa delle importanti tradizioni riscoperte dagli uomini d’oggi aiutati nel loro lavoro dalle nuove tecnologie.
89
90
Morganti e Sandro Sangiorgi
91 4 | L’IDENTITA’ DELLA VALPOLICELLA CLASSICA
“Ce n’è davvero per tutti i gusti: per l’appasio nato di storia e per chi ama perdersi tra le bel lezze artistiche, per l’architetto e per il semplice curioso, per il naturalista e per l’archeologo e, naturalmente, per gli amanti del vino e della buona tavola.”Paolo1
L’obiettivo del progetto di tesi è quello di riuscire a riproporre il ritratto dell’anima della Valpolicella, celato all’interno di un mondo espositivo in loco ed in itinere. Per poter concretizzare all’interno di un progetto coerente questa volontà è risultato fondamentale lo studio analitico e propedeutico del territorio e della propria storia, che è risultato essere per noi la solida base da cui poter com prendere al meglio gli imprescindibi senza i quali la Valpolicella non potrebbe essere tale.
A sinistra: Marano di Valpoli cella, prima tappa dell’itinera rio sulla strada del vino; 1 Morganti P., Sangiorgi S., L’A marone della Valpolicella, 2003, p. 108;
Grazie quindi alle consapevolezze acquisite, come ulteriore passo verso la progettazione, un’operazione fondamentale è dunque stata quella di delineare una prima identità del territorio, andando a cogliere non solo i fondamentali di cui non è possibile non trattare, ma soprattutto la rete di collegamento che è sempre stata alla base degli stessi e ne ha re golato sistemi e gerarchie.
92
A sinistra: schema della morfo logia del territorio della Valpoli cella Classica;
La morfologia della Valpolicella: un territorio ed i suoi volti La grande e ricca distesa di territorio su cui si è costruita nei secoli la Valpolicella è senza dubbio il fondamentale dei suoi volti dal quale è impossibile prescindere se si prende in considerazione la natura stessa di questa terra. Basti domandarsi quale possa essere quell’elemento fondamentale che caratterizza questo luogo veronese alla luce di ciò che ad oggi esso incarna e mostra di essere. E’ possibile trovare risposta in parte nella manifestazione di quelli che sono gli scenari, ovvero i luoghi che hanno da sempre composto la varietà della Valpolicella, ed in parte dalla morfologia e geologia del territorio. Que sto aspetto è ciò che da sempre nella storia è stato in grado di regalare all’uomo scenari, ricchezze, luoghi, prodotti, materiali ed anche tradizioni differenti, calate all’inter no di un unico ricco sistema. Come visto in precedenza zona montana, collinare e d’alta pianura coesistono e si regolano a vicenda, caratterizzano e diversificano paesi che sono sorti in luoghi adiacenti l’uno all’altro rendendoli tanto diversi ed allo stesso tempo tanto vicini. Le diverse colture, la vegetazio
93
94
95 ne, gli allevamenti e i fenomeni naturali che si trovano sul territorio: le cascate di Molina, il ponte di Veja, il territorio ricco di cave di Prun e della zona collinare, la convivialità delle cantine vinicole, lo scorrere dei progni e la regolarità artificiosa delle marogne, sono tutti fondamentali che costruiscono l’antico mosaico della Val Polesèla.
A sinistra: vista del territorio della Valpolicella dal paese di Negrar;
96
L’idrografia del territorio: il fiume Adige, i tre progni ed il sistema dei mulini Altro elemento imprescindibile per ricostru ire l’identità della Valpolicella sicuramente è il mondo dell’idrografico da cui il manto del territorio è inciso: dall’Adige al sistema dei progni che scorrono sul territorio, l’uomo da sempre nei secoli ha cercato il proprio sostentamento nei pressi e soprattutto grazie alla presenza dell’acqua ed anche in questo caso dall’epoca del Paleolico ad oggi l’uomo veronese non ha messo in secondo piano l’importanza di questo mondo. Da sempre risulta evidente come questo mondo sia fondamentale per l’antica Valle, la quale ad oggi presenta gli storici tre segni che l’hanno solcata verticalmente da nord a sud e da cui hanno preso vita le tre vallate che attualmente la compongono. Studiando il mondo dell’idrografia della Valpolicella è risultata fin da subito evidente la forte correlazione tra la presenza dei corsi d’acqua ed i primi stabilimenti degli uomini in epoca romana, i quali inevitabilmete sia per comodità di approvigionamento per loro stessi, sia per la A sinistra: schema dell’idro grafia ed il sistema dei mulini presente sul territorio della Val policella Classica;
97
98 vicinanza dell’elemento idrico in qualità di elemento funzionale alle loro attività agrico le cercavano la possibilità di stabilirsi quanto più vicino possibile alla fonte del loro principale sostentamento. Il principale corso d’acqua in cui tutti questi torrenti che segnano la Valpolicella confluiscono è il fiume Adi ge. Principale ordinatore del sistema idrico della Valpolicella, nonché fiume di notevole rilevanza sul territorio italiano. Contando su una lunghezza di 410 km, la sua sorgente si trova in Trentino Alto Adige, più preci samente nel passo di Resia per poi arrivare a sfociare nel mar Adriatico, nei pressi di Chioggia. Questo grande corso d’acqua ha da sempre incarnato un ruolo fondamentale senza il quale la Valpolicella non sarebbe sta ta in grado di essere così produttiva nel corso della propria storia, dall’agricoltura, all’allevamento, fino alla lavorazione delle pietre nelle cave. Infatti, in merito a quest’ultima, un altro ruolo che assume questo fiume è in qualità di grande risorsa dal punto di vista non soltanto agricolo ma anche industriale. Nei secoli infatti ne trassero beneficio ad esempio anche le grandi cave presenti nella zona collinare nel comune di Sant’Am brogio, Fumane o Marano, che come tutti i nuclei abitati hanno da sempre cercato di stanziarsi nei pressi dell’Adige per poterne godere di grandi vantaggi. In ultimo, un altro
La forza prodotta da grandi ruote a pale montate sull’Adige serviva anche per innalzare l’acqua dal letto del fiume e irrigare gli orti e i campi vicini.”
99 ruolo dell’idrografia in Valpolcella è senza dubbio quello di approvigionamento diret to di energia, riferendosi quindi a tutto quel mondo rappresentato dal sistema dei mulini che da tempi molto lontani ha creato una rete di collegamento sul territorio, andando ad alimentarlo ed aumentandone le capacità produttive, caratterizzandone il paesaggio con pittoreschi elementi lungo l’Adige ma anche lungo i progni dalle maggiori portate.
2 Le parole dello storico Ezio Filippi descrivono chiaramente il mondo del sistema dei mulini e del loro antico legame con il territorio. Infatti, risalendo al 1538 si contavano circa 91 mulini attivi e funzionan ti lungo il corso delle acque veronesi, di cui ben 27 distribuiti sul corso del fiume Adige.
“La forza ottenuta dalle ruote idrauliche serviva a più scopi: ad azionari i molini, le pile da riso, i frantoi per le olive, i magli, le gualchiere per infoltire i panni e, nei decenni recenti ma non più vicini, per produrre energia elettrica.
Si tratta principalmente di mulini che potevano trovarsi sia fisicamente sulle acque del fiume oppure sulle rive dello stesso, ma ten denzialmente erano caratterizzati dal mantenimento verticale delle acque, quindi da una ruota in piano appunto verticale e non 2 Filippi E., La valle di Fumane e i suoi ventitrè mulini in una mappa del 1735., in Annuario Storico della Valpolicella., p. 102;
100
101
A sinistra: il sistema dei mulini ad acqua sulle acque del fiume Adige all’altezza di Pescantina;
Molti di questi mulini andarono abbandonati nella prima metà dello scorso secolo a
102 orizzontale. Questa verticalità permetteva di garantire uno sbalzo di circa 4 metri alle ac que che scendevano a valle dall’Adige, il quale essendo caratterizzato da un letto privo di grandi sbalzi di quota altrimenti non avrebbe autonomamente avuto grande potenza dal punto di vista energetico.* A riprova dei primi fondamentali stabilimenti antropologici presso le sponde dei corsi d’acqua, già nella seconda metà del Settecento solo il progno di Fumane muoveva ben 25 mulini, e a metà Ottocento se ne contarono circa una trentina nella valle di Negrar. Questi nu meri riescono a dare una generica idea della portata produttiva anche in merito alla produzione di grano della Valle, essendo questi mulini ad acqua dediti alla macinazione di grano, frumento e semine in generale. Fon damentalmente la ragione delle collocazioni dei mulini presenti sul territorio è data dallo studioso Gian Maria Varanini, il quale riporta che “ … il numero maggiore era ubicato a Molina e a Prun e, quando non sfruttavano l’acqua delle sorgenti incanalate, sfruttavano quella dei progni condotta in un ribòn, un canaletto per tenerla in quota e nella quantità giusta. In questo caso l’acqua di piena scorreva nel letto del progno senza danneggiare la ruo ta e il mulino.” 3
103 3 Ivi., p. 103; causa dell’avvento delle due Grandi Guerre e di conseguenza delle grandi epoche di care stie che esse portarono con sé.
104
105 I nuclei consolidati delle antiche pievi ed i principali paesi
Come si è già accennato in precedenza, uno degli aspetti di maggior interesse senza dubbio è lo studio degli insediamenti antropo logici fin da tempi molto remoti. Senza vo ler ripercorrere dall’epoca preistorica tutta la storia dei primi insediamenti, si è voluto prendere in considerazione il primo momento d’urbanizzazione: il periodo di costruzio ne delle prime pievi sul territorio, ovvero il periodo in cui si trovarono i longobardi in Valpolicella, il periodo immediatamente successivo all’anno Mille. Attorno a queste architetture intrise di storia, l’uomo ini ziò a costruire i primi centri abitati, futura anima del territorio. A riprova della stretta interconnessione tra un’imprescindibile e l’altro, è evidente come il sistema delle prime costruzioni dei più storici paesi facenti parte della Valle si trovino in stretta prossi mità dei corsi d’acqua principali e successivamente come anche la costruzione della rete infrastrutturale sarà fortemente condizionata da questi elementi. Le antiche pievi romaniche presenti in Valpolicella si trovano a San Giorgio di Valpolicella, nel comune di A sinistra: schema dell’espan sione dei nuclei consolidati e del sistema delle infrastrutture sul territorio della Valpolicella Classica;
106
107 A sinistra: antica pieve di Negar di Valpolicella; 4 Cordioli S., Il paesaggio antro pico della Valpolicella romana. in Annuario Storico della Valpo licella., p. 27-28-29;
Sant’Ambrogio di Valpolicella, a San Floria no, nel comune di San Pietro in Cariano e nel comune di Negrar. Risalenti tutte e tre alla medesima epoca, si tratta di tre emblemi in stile romanico che raccontano la lunga storia dell’uomo della Valpolicella e ne sono preziosa testimonianza.
Per quanto riguarda la pieve di San Giorgio di Valpolicella, detto anche San Giorgio Ingannapoltron, essa trova luogo all’interno di questo prezioso ed antico borgo medievale, in cui è possibile respirare la storia e la natura dell’antica Valle, costruita da vicoli in minia tura ed architetture in pietra locale che lo caratterizzano da secoli. L’antica pieve romanica padroneggia la piazza da molti secoli, essendo stata costruita secondo alcune fonti già nel VIII secolo, ricalcando le impronte di un antico luogo di culto pagano, per essere poi ricostruita in parte attorno all’XI secolo.4 Adiacente ad essa è ancora possibile trovare e visitare il chiostro con i suoi anti chi affreschi, ed un antico ciborio risalente al 712 d.C. su cui sono presenti testimonianze scritte che lo fanno risalire all’epoca dei longobardi. Tutto il complesso è caratterizzato da elementi costruiti in tufo e pietra calca rea locale, compreso il campanile a pianta quadrata posto adiacente alla chiesa stessa, facilmente identificabile nello stesso sistema costruttivo degli altri due campanili delle al-
108 tre due pievi della Valpolicella. Associabile per utilizzo di materiali, tufo e calcare, e stile architettonico è la pieve di San Floriano, risalente anch’essa al XII secolo, e come la precedente pieve descritta anche questa edificazione avvenne in corrispon denza di una preesistenza pagana, facendo partire la propria costruzione proprio dai resti di due ceppi sepolcrali romani che si trovavano precedentemente in loco. Anche per quanto riguarda la pieve di San Floriano è possibile contestualizzarla all’interno di un complesso, tanto che anche annessa ad essa si trova un chiostro risalente all’epoca del 1600 ed un’imponente torre campanaria a base quadrata posta sul lato nord della chiesa, la quale presenta il basamento in pietra ed il resto della sua altezza realizzato in conci di tufo e Infine,cotto.perquanto riguarda la pieve situata nel comune di Negrar, è riportato nel libro Negrar. Un filo di storia.5 che la prima men zione di cui si trova notizia risale in un docu mento del 1067, ed infatti molto probabilmente si ipotizza che a questa data la chiesa sarebbe già dovuta essere presente in loco, costruita anch’essa sui resti di un precedente luogo di culto pagano. Il campanile è carat terizzato dalla presenza sul proprio lato sud di quella che fu nominata Carta Lapidaria di Negrar, ovvero un’iscrizione di 64 righe a
caratteri maiuscoli romani scolpita nel 1166 riportante dei contratti antichi in merito alla pieve Attornostessa.aquesti
109 5 Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella., Negrar. Un filo di storia., 1991, p. 53;
tre emblemi storici si è dunque sviluppata la vita dell’uomo della Valle veronese sin dai tempi dell’età romanica, andando a formare via via dei piccoli nu clei consolidati sul territorio che man mano nei secoli sono mutati e si sono espansi per arrivare a costituire le costruzioni ed i paesi attuali. La grande peculiarità dei comuni contemporanei presenti sul territorio della Valpolicella risiede nel fatto che nonostan te tutti si siano sviluppati con i medesimi concetti costruttivi, materiali e forma mentis antropologiche, ognuno di essi presenta un’identità a sé stante, grazie proprio alla grande differenza morfologica e geologica che è possibile trovare all’interno della stessa Valle. Ognuno di essi nei secoli ha sviluppato quindi una particolare natura e ne ha fatto il proprio principale punto di forza per la propria anima e crescita, regalando quindi alla Valpolicella un territorio colorato da differenti volti non solo sotto il punto di vista della naturalistico, ma anche sotto il punto di vista della storia costruita.
110
Dalla fondamentale importanza storica, sociale e produttiva, sin dall’inizio della pro pria costruzione in tutto il territorio veneto nel XV secolo per volontà dei Signori Vene ziani che in quel periodo con la Repubblica Veneziana dominavano l’intero territorio, la villa veneta rappresenta la tipologia architettonica che grazie alle proprie caratteristiche racchiude in sé gran parte dell’identità di un A sinistra: schema della presen za delle principali Ville Venete riconosciute come patrimonio tutelato della Valpolicella Clas 6sica;Ferrari S. (a cura di), Ville ve nete: la Provincia di Verona., 2003, p. XX;
“Dall’interno della villa e dai loggiati a volte in duplice ordine sovrapposto, (...) i proprietari possono osservare i frutteti della loro tenuta, controllare i contadini al lavoro e (...) sentirsi circondati dalle pitture murali illusionistiche o moraleggianti che decoravano ogni angolo e ogni parete (...). Decorazioni che creavano un’atmosfera poetica di antichità ideale a completamento del classicismo dell’architettura e della rusticità della veduta esterna: un rapporto ideale, ma anche un pratico controllo sulle attività rurali, sui cortili, sui magazzini, sui broli in una continuità tra interno ed esterno che costituisce una delle caratteristiche della villa (...).”
La tipologia della villa veneta
6
Ruggero Boschi
111
112
113 territorio con i propri usi e tradizioni. Fin dal primo momento questa tipologia archi tettonica si espanse sul territorio portando con sé dei forti legami a livello culturale con il mondo agricolo. Inizialmente voluta e vissuta dai signori di Venezia come un luogo di svago, caratterizzata dalla propria immersione nel mondo della campagna, nel quale i padroni avrebbero potuto trascorrere momenti lontani dalle fatiche della città e del lavoro, in un’architettura signorile calata in curati broli e laboriosi campi agricoli. Una prima diffusione più consistente senza dub bio si ebbe nella zona di Padova e Vicenza, le quali grazie alla mano del Palladio e delle sue realizzazioni architettoniche furono la culla del primo grande periodo di riferimen to tipologico a cui poi si rifaranno in seguito tutte le successive realizzazioni, ad oggi corrispondenti a quattromila tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si tratta quindi di una casa padronale principale affiancata da due brac cia porticate, le barchesse, adibite al ruolo strettamente agricolo di rimessa dei mezzi e deposito utensili. La simmetria è un aspetto fondamentale nel delineare le principali caratteristiche di questa tipologia ed inoltre in una prima fase costruttiva le ville contavano di alcune peculiarità di richiamo alle architetture di pregio veneziane: il salone padronale ricco di affreschi e pitture, passante e A sinistra: ridisegni di alcune piante di note ville Venete pre senti sul territorio Veneto, di cui: Villa Pisani (VI), Villa Gar zoni (PD), Villa Serego Alighie ri (VR), Villa Della Torre (VR);
114
La grande novità di questa tipologia architettonica infatti, risiede proprio nel fatto che per la prima volta nella storia dell’architet-
A sinistra: vista storica aerea di Villa Serego Alighieri, Pede monte, 1565, A. Palladio; 7 Ferrari S. (a cura di), Ville ve nete: la Provincia di Verona., 2003, p. XX;
Citando l’architetto Ruggero Boschi infat ti “Si delinea così un campo non solamente architettonico e neppure solamente agricolo, ma un modello al quale far corrispondere un modo di vita, uno stile di società, una cultura economica.”
7
115 distributivo in funzione delle due ali laterali che andavano solitamente ad abbracciare il giardino antistante la villa separandolo dal brolo retrostante ad essa. In modo più specifico, considerando solamente la tipologia della villa veneta veronese, nel corso del tempo lo sfarzo degli affreschi e delle statue di cui le architetture venivano adornate vennero via via affiancate da un nuovo concetto con il quale la tipologia della villa stessa si stava iniziando a vivere, cercando di riequili brare i due volti che le appartengono.
La tipologia della villa calata nel contesto veronese diventa quindi un emblema, un unico complesso architettonico dentro al quale per propria natura viene rappresentato il con nubio del dualismo di una realtà aulica ed aristocratica concretizzata nella casa padronale con i propri sfarzi ed affreschi affiancata alle barchesse ed ai campi agricoli, luoghi entrambi deputati all’aspetto del lavoro che avviene nel mondo campestre del contadino.
8 Nel contesto veronese, in particolar modo della Valpolicella la tipo logia della villa veneta è strettamente legata alla tradizione vinicola del posto, oltre che al luogo stesso in cui essa si trova. Ad oggi infatti la maggior parte delle ville storiche sono state ristrutturate e riportate al loro grande grado di pregio, diventando luogo adibito a ricevimento di importanti eventi con particolare importanza data alla cantina, solitamente annessa alla casa padronale. Al cuni esempi più noti sul territorio possono essere ad esempio Villa della Torre - Fumane, realizzata nel 1545 su progetto di Giulio Romano; Villa Mosconi-Bertani - Arbizzano, risalente al XVI secolo; Villa Serego - Pede monte, San Pietro in Cariano, realizzata nel 1565 da progetto di Andrea Palladio; Villa Banda Amistà - Corrubbio, San Pietro in Cariano, risalente al XVI secolo; Villa Fran-
116 tura, nonostante un luogo fosse destinato a funzioni strettamente agricole, viene consi derato con l’importanza di una vera e propria architettura, proprio come viene definita dall’architetto Stefania Ferrari “In realtà la villa, intesa come residenza rurale dotata di un’apprezzabile qualità architettonica, ri sponde a funzioni economiche e a sollecitazioni di ordine storico-culturale e “stilistico” che non possono essere meccanicamente collegate alle corrispondenti dinamiche dello sfruttamento dell’attività agraria.”
117 8 Ferrari S. (a cura di), Ville ve nete: la Provincia di Verona., 2003, p. XXI; co-Lebrecht - San Floriano, San Pietro in Cariano, XV secolo, e Villa Albertini - Ar bizzano, Negrar, risalente anch’essa al XV secolo, per citarne alcune. Si tratta dell’aulicità di una dimora padronale che incontra la tradizionalità della produzione vinicola e si mettono a sistema, creando un dualismo indissolubile quasi ossimorico, che non identificano un semplice luogo, ma parte fondamentale dell’anima dello stesso.
118
119
A sinistra: schema dei campi dedicati a vigneto sul territorio della Valpolicella Classica; 9 Paronetto L., Valpolicella. Splendida contea del vino., 1981 pp. 11-12;
Presa coscienza delle architetture del vino, ora risulta importane conoscerne le origini, per poter averne una consapevolezza com pleta in relazione agli ulteriori imprescindibili della Valpolicella in funzione al futuro progetto che troverà sviluppo all’interno di questo percorso di tesi. Le origini della produzione vinicola locale fonda le proprie radici in tempi assai remoti, viene infatti fatta risalire circa al V secolo a.C., in epoca romana, ovvero quando sono stati fatti i primi ritrovamenti fossili in grado di testimoniare la presenza di tali lavorazioni sul territorio.9
Per quanto riguarda i ritrovamenti più anti chi di questi ultimi, si consideri che si tratta di fossili di piante progenitrici, riscoperte in epoca pressoché preistorica: fossili di ampelidacee, appartenenti al genere Ampelophyl lum, ritrovate nell’area veronese, più preci
La terra del vino
Tra tutti i vari tipi di produzione visti fino ad ora sul territorio che nei secoli ne hanno composto identità e tradizioni, utili al proprio sostentamento risulta inevitabilmente essere di grande importanza il mondo delle pratiche vinicole e tutta la cultura che esse portano con sé, intrinseca a questo territorio.
120
121 samente nella zona di Bolca, circa quaranta milioni di anni fa, durante l’era dell’Eocene Medio. Ritrovamenti simili a questo, ma di fossili dei semi degli acini dell’uva, i cosiddetti vinaccioli, della specie Vitis Linifera Silvestris 10 furono ritrovati ritrovati nelle palafitte che si trovano a Peschiera e a Bor ghetto, risalenti circa all’età del Bronzo a dimostrazone del fatto che inizialmente il frutto della vite non fosse impiegato all’interno di un sistema produttivo per ottenere un ulteriore prodotto lavorato, ma in qualità di materia prima. Anche nella zona di Archi di Castelrotto è avvenuto un ulteriore ritrovamento, anche se di una specie diversa, ovvero di Vitis Linifera Sativa, che conferma il fatto che in corrispondenza di quelle epoche non esistesse ancora un’attività produttiva enologica. Dunque, come preannunciato, le prime tracce sicure dell’attività enologica veronese risalgono circa al periodo che va dal VII al V secolo a.C. Datazione confermata dalle corrispondenze ritrovate di importanti personaggi storici, nelle quali venivano esaltate la qualità dei vini veronesi scrivendone elogi o raccontandone gli speciali odori e sapori all’interno di corrispondenze. Ad esem pio Plinio il Vecchio fu uno dei principali esaltatori della qualità di questa bevanda, come si può trovare scritto nelle sue corrispondenze con l’imperatore Tiberio, al quaA sinistra: fossile di ampeli dacee ritrovato nei pressi della zona di Bolca, appartenente al genere Ampelophyllum; 10 Ivi., p. 13;
122
La partcolarità spiccatamente apprezzata di questa tipologia di vino risiede nella propria dolcezza, che ne conferisce di conseguenza la propria amabilità da parte di tutti questi storici personaggi. Cassiodoro ad esempio, il ministro di Teodorico, il re dei Visigoti che per un lungo periodo fu a capo della citta di Verona, fu uno dei più interessati ammiratori ed esaltatori del vino Retico, proprio per l’unicità che questo vino possiede come fattore intrinseco sin dal proprio processo di produzione. Viene infatti spiegato fin da questi scritti antichi come tutto il processo per arrivare ad assaporare questa tipologia di vino iniziasse con un comune vinum Acina ticum e che per poterne ottenere ed esaltare un vino dalla caratteristica dolcezza come il Recioto di oggi ci si adoperasse con una pri-
A sinistra: disegno di Bellini I., conservato al British Museum, Londra, sec. XV. Costruzione di una pergola con in basso ti nozze per la pigiatura; 11 Riferimento implicito alla cit tà di Verona, essendo la famiglia d’appartenenza di Gaio Valerio Catullo una delle principali fondatrici della città stessa;
123 le racconta dello speciale vinum Rhaeticum circoscrivendolo all’area della Valpolicella come propria zona d’origine e provenienza delle uve. Di questo vino Retico ne scrivono anche personaggi come Catone, il quale ne tesse grandi lodi; Svetonio, il quale raccon ta quanto questa bevanda fosse la preferita dell’imperatore Augusto ed anche Marziale, che in un proprio racconto vi si riferisce descrivendola come una squisita bevanda proveniente dalle medesime terre di Catullo11, non lasciando quindi spazio a dubbi in meri to al chiaro riferimento alla città di Verona.
124
125 ma fase di lavorazione delle uve in appassi mento, lasciate riposare quindi per un lungo periodo in modo naturale nei fruttai, lambite dai venti tipici della zona della Valpolicella che ne riuscivano ad esaltare la grande unicità nel sapore e renderlo quel vinum Rhaeticum tanto amato sin dall’antichità. A sinistra: miniatura del Tacu inum sanitatis della Biblioteca Nazionale di Vienna, sec. XIV.
126
127 5 | LA VINICOLATRADIZIONE “Da queste rive io più non parto qui si distilla un balsamo dolce potabile che i nervi e viscere d’ogni antichissimo male prestoacerbissimodelibera”1 Giuseppe Beretta A sinistra: vigneti di Sant’Am brogio di Valpolicella; 1 Beretta G., La Valpolicella, 1800;
128
La notevole importanza del vino sia dal punto di vista della produzione, sia in ambito sociale che in qualità di materia prima che necessita di essere tutelata, viene confermata sia dalle tradizioni secolari su cui il popolo che abita la Valpolicella ha da sempre basato i propri usi, le proprie feste e cerimonie, sia dalla nascita nei secoli di numerose istituzioni volte a tutelare la qualità, il valore e la riconoscibilità di tali vini autoctoni e le corrispondenti materie prime necessarie alla realizzazione di essi.
Negli ultimi decenni infatti si è assistito ad un grande incremento della richiesta e con seguente produzione vinicola sul territorio, che ha portato a sentire la necessità di tutelare prodotto e produttori, nonché il nome stesso del territorio. Una delle prime grandi istituzioni formatesi in questa direzione in Valpolicella è la Cantina Sociale 2, costituita da una dozzina di proprietari agricoli e pro duttori che nel 1933 decisero di compiere questo passo ed unirsi nella produzione di vini di alto pregio. Non tardarono infatti ad arrivare riconoscimenti tali da far conoscere sempre più ad ampia scala i vini locali doc
129
Lo storico ruolo sociale del vino
A sinistra: manifesto della pri ma edizione dell’antica Sagra del Recioto a Negrar; 2 Viviani G., Negrar. Un filo di storia., 1991, pp. 328-329;
130
L’ascesa economica della seconda metà del XX secolo, comportò la voglia di ricreare una sempre maggiore nuova competitività all’interno dei mercati economici, ed iniziarono quindi ad istituirsi i primi eventi in onore di questo prodotto: la festa dell’uva nel 1952 e la festa del Recioto3 del 1953, contesti paesani, ma grazie ai quali questi vini iniziarono effettivamente ad essere conosciuti ed esportati verso altre regioni ed altri Paesi, dove furono ulteriormente premiati e riconosciuti nella loro unicità. La notorietà ed il pregio che via via il vino della Valpolicella è stato capace di guadagnarsi ha portato d’altro canto alla necessità di tutelarne il nome e le qualità, tanto che nel 1970 si è istituito un Consor zio di Tutela con incarichi stabiliti di vigilanza, difesa e promozione della viticoltura e del vino a denominazione di origine controllata. Ad oggi il Consorzio si occupa di tutelare un considerevole numero di produttori: circa l’81% presente sul territorio e si estende per tutti i 19 comuni della Valpolicella DOC.
A sinistra: manifesto dell’anti ca settimana e sagra della cura dell’uva, Negrar; 3 Viviani G., Negrar. Un filo di storia., 1991, pp. 346-347-348;
131 ed il nome del territorio, favorendo in que sto modo l’inizio di una grande economia fiorente. Quest’ultima però a causa dell’avvento della Seconda Guerra Mondiale ebbe un inevitabile declino, al termine del quale dopo circa due decenni si ebbe una lenta ri presa e miglioramento economico e sociale.
132
133
Le differenti tipologie d’uva e di allevamento
A sinistra: grappolo di Corvina veronese, varietà d’uva princi palmente utilizzata in Valpoli cella Classica; 4 cella.it/;https://www.consorziovalpoli
Per produrre la grande varietà di vini che si possono trovare all’interno di questo territorio si impiega l’utilizzo di differenti tipolo gie d’uva, ognuna delle quali possiede delle particolari necessità per l’habitat di coltura, necessità d’allevamento e singolari peculiarità in grado di dare vita a differenti tipologie di vino. Le tipologie di vino riconosciute dal Consorzio di Tutela* all’interno della Valpo licella Classica sono il Valpolicella DOC, il Valpolicella Ripasso DOC, l’Amarone della Valpolicella DOCG ed infine il Recioto della Valpolicella DOCG. Ognuno di essi deri va dalla lavorazione di specie d’uva differenti, che compongono lo scenario dei vitigni della Valpolicella, in cui si trovano: Corvina, il più diffuso sul territorio, dal 40% al 70% dei vini viene prodotto da questa varietà d’uva e si trova maggiormente nelle zone di Parona, Negrar, Marano e Sant’Ambrogio ed incarna la colonna portante della produzione dei vini della Valpolicella, conferendo struttura, aromi e morbidezza al vino; il Corvinone, presente nella produzione vinicola per un 20-40% in Valpolicella, trovandosi princi
134 palmente nelle zone di Parona, Arbizzano e Prun. Quest’uva è caratterizzata da sentori di marasca molto speziati, che conferiscono complessità aromatica e struttura al vino stesso; la qualità Rondinella invece si trova in minori quantità scendendo ad un 5-25% della copertura della produzione, anche se essa risulta essere molto resistente ad intemperie e malattie ed è in grado di conferire colore intenso e sapidità al vino, è possibile trovare questo tipo di vitigno nelle zone di Parona, Negarine, Negrar e Sant’Ambrogio; infine la Molinara, da cui se ne ricavano mi nime quantità di produzione, si può trovare a Sant’Ambrogio e a Fumane. Nonostante essa rientri nella categoria di varietà minore presente sul territorio, risulta essere apprezzata grazie alla freschezza e sapidità del vino che è in grado di conferirgli. Esistono poi altre tipologie d’uva presenti in quantità molto inferiori all’interno del produttivo vinicolo, ma non per questo non tutelate o di inferiori qualità: Oseleta, Croatina, Dindarella o Spi gamonti. Ognuna delle varietà d’uva appena elencate appartiene al disciplinare produttivo del decreto del presidente della Repubblica5 del 3 giugno 1976 ed ognuna di esse pre senta delle specifiche caratteristiche che sono determinate dalla differenza della geologia su cui il vitigno in questione viene allevato e conseguentemente è possibile ottenere delle
135 Nella pagina seguente: esempio di vigneto con coltura allevata tramite tipologia a pergola; 5-6 licella.it/;https://www.consorziovalpo
differenti qualità di vino sulla base di queste caratteristiche. Principalmente vengono ca talogate per: colore, aromi, acidità, struttura e tannino, ovvero quanto la bevanda abbia proprietà più o meno astringenti. Un’altra grande distinzione che si attua in merito alle fasi di coltivazione sul campo riguarda le differenti tecniche di allevamento6, di cui principalmente per questa zona del veronese e per queste tipologie di vitigni d’uva nera si possono considerare l’allevamento a pergola o l’allevamento a spalliera. In entrambi i casi si tratta di filari scanditi dalla presenza di pali di sostegno in cemento di maggiori dimensioni per quanto riguarda gli estremi, di sezione 10x10 cm, mentre nel mezzo del filare sono di sezione 7x7 cm. Per quanto riguarda l’allevamento a pergola, esso conta una luce di 5 m tra palo e palo di uno stesso filare, mentre vi sono 4 m tra i pali di diversi filari. Si tratta di allevamenti alti 170 cm, di cui si può trovare una diffusione sul territorio del la Valpolicella del 75% circa, ed è la forma di allevamento tradizionale del triveneto: il fatto che la vegetazione sporga ai lati del tronco della pianta consente alle chiome delle viti di proteggere i grappoli d’uva dal sole diretto, ed allo stesso tempo la sua altezza consente alle uve di essere protette da eventuali danni di brina ed umidità. Di questa tipologia d’allevamento esistono alcune sottocategorie, ad
136
In base alla differenza della morfologia del territorio su cui sono presenti i vitigni in en trambe le categorie d’allevamento è possibile che si trovino in estensione in piano oppure disposte sulle marogne, termine dialettale per indicare i terrazzamenti realizzati dall’uomo per sopperire ad un’incoltivabilità del ter reno a causa di pendenze e morfologie non adatte alla coltivazione.
137 esempio: pergola veronese, pergola trentina e bellussera. L’allevamento a spalliera invece è diffuso sul territorio per il 25% circa ed essendo un tipo di allevamento che sviluppa la vegetazione lungo il proprio asse verticale la luce tra un filare e l’altro si riduce a 2,5 m. Fu introdotto nel 1870 in Valpolicella e quando risulta necessario viene utilizzato in favore delle necessità delle varietà autoctone, con la presenza di sottocategorie, quali: allevamento casarsa, cordone speronato o Guyot.
138
139
Nelle prime fasi del processo è senza dub bio fondamentale considerare la consegna A sinistra: silos in acciaio della Cantina Vinicola Farina, Pede monte di Valpolicella, (VR);
La cantina ed il processo produttivo Conosciuto il mondo agricolo in merito alle numerose tipologie di vitigni presenti in Valpolicella e a come esse vengono allevate, è ora possibile passare a considerare il processo produttivo che avviene all’interno della macchina agricola che per secoli ha accompagnato la nobile tipologia della villa veneta. All’interno di una cantina produttiva ognuna delle fasi nelle quali viene scandito il processo di vinificazione occupa uno spazio ben preciso, ordinato in una consequenzialità di percorso studiata di modo da poter garantire comodità lavorativa agli operatori in ciascuna fase di produzione, pulizia degli spazi e tutela della materia prima che viene trasformata passaggio dopo passaggio. Dopo aver avuto modo di visitare in prima persona alcune cantine vinicole di grandi dimensioni e notevole capacità produttiva presenti sul territorio della Valpolicella Classica, è risul tato più chiaro e semplice riuscire a com prendere gli spazi necessari alla composizione di un vero e proprio luogo adibito agli spazi di produzione del vino.
140
Questa fase durerà per molti mesi, durante i quali il mosto rimarrà a fermentare, per essere poi travasato sempre grazie al sistema di tubi, all’interno di botti, o di barrique, se si tratta di botti dal diametro molto più ridotto, che possono essere di diverso materiale: legno, calcestruzzo o ceramica, di cui questi ultimi meno frequenti, ma molto innovativi all’interno del mondo vinicolo. Per evitare di alterare il vino durante il processo e rischiare di rovinarne le peculiarità, è fondamentale all’interno di questa consequenzialità di spazi l’attenzione alla regolazione della luce, al ricircolo dell’aria ed alla percentuale di umidità. Durante questa fase, che avviene in un luogo con una percentuale di luminosità molto bassa e umidità intorno al 12%, la A sinistra: botti e barrique in legno della Cantina Tommasi Viticoltori, Pedemonte di Val policella, (VR);
141 della materia prima direttamente dai campi, che dovrà iniziare il vero e proprio processo produttivo con la fase di pigiadiraspatura.Si
tratta del momento in cui i grappoli d’uva vengono ribaltati dalle cassette provienienti dai campi all’interno della pigiadiraspatrice, macchinario che si occupa di pulire i grappo li d’uva e togliere le parti di scarto, i raspi, per poi procedere ad una prima pressatura degli acini puliti. In seguito il mosto ottenuto verrà poi trasferito attraverso un sistema di tubi ai primi silos in acciaio, posti per comodità in un luogo adiacente al precedente, di modo da evitare eccessivi movimenti del liquido.
142
143 scelta del materiale e dimensione delle botti risulta essere determinante per riuscire ad ot tenere differenti sfumature nel gusto, colore e profumazione del vino in base a ciò che si desidera. Dopo mesi il liquido ottenuto viene nuovamente filtrato per pulirlo da even tuali residui rimasti e successivamente si può passare alla fase di imbottigliamento del prodotto e successiva vendita. Il processo appena descritto è in linea generale il processo di vinificazione comune per qualsiasi tipologia di vino, ma la determinante caratteristica dei vini della come il Recioto e l’Amarone della Valpolicella risiede nella fase di appassimento, momento caratteristico dei vini dolci, per l’appunto i passiti, ma che caratterizza anche l’Amarone e lo rende di conseguenza unico nel proprio genere. Una delle fondamentali caratteristiche nella tipologia della cantina è il suo essere collocata sottoterra per la maggior parte dei luoghi che la compongono, questo avviene proprio per le caratteristiche intrinseche della lavorazione della materia prima che deve essere qui prodotta: l’essere sottoterra consente una regolazione di luce, aria ed umidità favorevoli e già naturalmente idonee a quelle che sono le necessità durante la vinificazione.
A sinistra: botti in cemento Cantina Vinicola Farina, Pede monte di Valpolicella, (VR);
144
Il Recioto e l’Amarone
“… rosso come la porpora o bianco come i gigli fragranti, nobile e denso … vino puro dal colore regale e dal sapore speciale, cosicchè tu pensi o che la porpora sia tinta dal vino stesso o che il suo limpido umore sia spremuto della por pora … la dolcezza di esso di sente con soavità incredibile, si corrobora la densità per non so qual fermezza, e s’ingrossa al tratto in modo che diresti un liquido carnoso, o bevanda da mangiare …” 7 Teodorico, re dei Visigoti Recioto e Amarone sono i due vini tipici di unica produzione del territorio della Valpo licella. Nel capitolo precedente nella descrizione delle fasi necessarie a compimento del processo produttivo del vino è stata volontariamente solo citata quella fase necessaria per la realizzazione di queste due speciali qualità di vini, unica e fondamentale che li contrad distingue rispetto alla realizzazione degli altri: l’appassimento, ovvero la fase che caratterizza la realizzazione di tutti i vini dolci, i cosiddetti L’appassimentopassiti.per l’ottenimento del Re A sinistra: arèle d’appassimento delle uve dedicate alla produzio ne di Recioto e Amarone all’in terno dei fruttai appartenenti alla Cantina Vinicola Masi; 7 Teodorico, re dei Visigoti, fonte: it/la-valpolicella;https://www.cortesanbenedetto.
145
8 Esclamazione da cui nascerà anche poi il nome della bevanda stessa, destinata a diventare un vino estremamente conosciuto, grazie al colore, sapore e profumazio ne molto intensi, smisuratamente utilizzato nell’ambito della gastronomia locale ed unico vino non dolce che necessita del processo di appassimento delle uve.
146 cioto, considerato l’antenato dell’Amarone, avviene nei cosidetti fruttai, ovvero delle grandi stanze, da tradizione solitamente sono locali mansardati che si trovano ai piani alti di un volume di modo che l’aria naturale delle colline della Valpolicella possa lambire i grappoli d’uva e gli acini lasciati a riposo da settembre circa a dicembre all’interno delle arele, dialettalmente delle casse realizzate in legno, dentro cui le uve trascorrono il loro periodo di appassimento.
Per quanto riguarda invece l’Amarone, esi stono numerose e note leggende che fareb bero risalire la sua nascita ad un errore: si racconta infatti che nella primavera del 1936 vi fu il ritrovamento di una botte di Recioto dimenticata in cantina - cantina Bertani di Villa Mosconi - più a lungo del previsto, da parte del capocantina della Cantina Sociale della Valpolicella Adelino Lucchese e che esso stesso assaggiandone il contenuto ne scoprisse con sorpresa la notevole bon tà, esclamando “Questo non è un Amaro, è un Amarone”.
La realtà non andò propriamente come nar rato nel mito, infatti la prima bottiglia di Amarone fu proposta al pubblico nel 1953, dal famoso enologo Alberto Bolla9, il quale si rifece ad una bottiglia del 1950. Questo vino infatti fu il frutto di decenni di nume rosi tentativi di sovrappassimento di Recioto da parte dei fratelli Bertani, che avrebbero voluto dar vita ad una nuova qualità di vino, di cui però furono numerose le prove per capirne il corretto equilibrio di dolcezza e acidità. Dopo anni e anni di tentativi e falli menti si riuscì a scoprire il giusto equilibrio che tutt’ora regola questo vino unico, dalla grande struttura, grande corpo e forti potenzialità d’invecchiamento.
147 8 Viviani G., Negrar. Un filo di storia., 1991, p. 351; 9 Guy P., Morganti P. (traduzio ne) L’Amarone, 2000, p. 8.
148
VILLA ALBERTINI
149 6 |
Attualmente in stato di ristrutturazione, Villa Albertini si trova all’interno della frazione di Novare, ad Arbizzano, paese della Valpolicella facente parte del comune di Negrar. La villa è da qualche decennio tutelata in qualità di sito vincolato dalla Soprintendenza di Verona sia per quanto riguarda il corpo padronale della villa stessa, sia per quanto riguarda il grande giardino ricco di numerose specie botaniche. E’ inoltre stata inserita all’inter no del grande elenco delle Ville Venete pre senti sul Nonostanteterritorio.questo le condizioni della villa ad oggi sono abbastanza disastrose: presenta solai e parte della copertura in stato perico lante o in parte crollati, per questo motivo attualmente il sito è inaccessibile e sono in corso dei lavori di ristrutturazione e restauro per la messa in sicurezza della stessa, di conseguenza non è possibile accedere nemmeno agli spazi interni della casa padronale stessa.
150
Per avere una consapevolezza del territorio che potesse essere il più completo possibile, si è deciso di approfondire lo studio iniziale in merito alla storia degli insediamenti an tropologici all’interno del territorio, con centrandosi ad una scala più dettagliata, di modo da avere un quadro storico più conforme alla dimensione del contesto del lotto della Ripartendovilla.
dalle carte storiche che è stato possibile trovare ad un livello di puntualità così tanto preciso, l’epoca più lontana alla quale si è riuscite a risalire è quella del XVI secolo1, da cui è stato possibile apprendere la preesistenza sul territorio della pieve di Arbizzano, la Chiesa di San Pietro Apostolo, risalente circa al XII secolo, periodo contemporaneo alla costruzione delle altre pievi precedentemente studiate presenti nella Val policella Classica. In corrispondenza al XVI secolo era già iniziato anche il periodo di costruzione delle prime ville venete, infatti è possibile notare come all’interno del nucleo consolidato vi siano anche ben quattro ville: villa Mosconi-Bertani, villa Piatti (poi villa Zamboni, ad oggi Villa Turco), villa Tomma
A sinistra: studio della storia delle costruzioni ed infrastrut ture ad Arbizzano, comune di 1Negrar;Riferimento alla carta storica detta Campion, 1589;
151
La frazione di Arbizzano
152 sini – Albertini, oggi villa Albertini - Valier ed infine villa Verità, oggi villa dall’Abaco, tutte collocate nei pressi della pieve, che iniziarono a popolare questa piccola contrada, collegata al paese di Negrar con quella che all’epoca era la più importante arteria stra dale presente sul territorio, ovvero la strada d’epoca medievale che collega i due paesi in direzione nord-sud. Si assiste successivamente nel periodo di fine Ottocento non solo ad una prima espansione del costruito verso nord, ma anche verso la zona della Valpoli cella Valpantena tramite una rete di strade in grado di creare quindi dei primi punti di contatto con la Valle adiacente. Si assiste inoltre in quest’epoca alla comparsa dei primi toponimi all’interno della stessa Arbizzano. Per assistere a delle più considerevoli espan sioni infrastrutturali e costruttive si dovrà attendere la seconda metà del XX secolo, quando rialzandosi dalla devastazione delle due Grandi Guerre e ritrovando un primo periodo di quiete e ripresa economica si ini ziarono ad espandere non solo le reti di comunicazione stradale, ma anche il sistema delle acque, come è testimoniato dalla presenza sui disegni riportati nelle carte stori che del 1950 di un acquedotto nella zona di Novare. Successivamente sarà possibile vedere come questo fosse un elemento di fondamentale messa a sistema dei tre mulini pre-
153 senti in loco e una forte caratterizzazione per la natura di ognuna delle tre ville presenti sul territorio. Seguirà successivamente un periodo di forte espansione del costruito in corrispondenza degli anni ’60-’70 del XX secolo, durante i quali anche Arbizzano fu assorbito dal fenomeno chiamato Negrarizzazione, durante il quale si assistette ad un enorme ed incontrollato periodo di edificazione sregolata e spesso rovinosa per gli scenari naturali caratteristici del luogo. In corrispondenza di quest’ultimo periodo storico infatti si assiste all’assestamento della connotazione urbana che si trova attualmente ad Arbizzano.
154
Quest’ultima zona di Arbizzano infatti è an che luogo ospite dell’acquedotto realizzato alla fine dell’Ottocento e che come si accennava in precedenza sarà una delle infrastrutture in grado di mettere in collegamento le tre case dominicali dei sistemi delle ville venete presenti sul territorio. Le tre ville venete in questione furono fatte risalire dagli studi
1 Chiappa B., Le ville di Arbiz zano: contributo per un chiari mento con particolare riferimen to alle ville Zamboni e Verità. in Annuario Storico della Valpoli cella, p. 55;
1 Bruno Chiappa
155 Il sistema dei tre mulini nella valle di Novare “La zona compresa fra Arbizzano e Novare era luogo residenziale assai appetibile nel passato per la borghesia cittadina, che trovava nella vicinanza alla città e nell’amenità del luogo motivi più che sufficienti per insediarvisi;”
Nella considerazione fatta dallo storico Bruno Chiappa, trova valore ciò che nel paragrafo precedente è stato studiato grazie all’analisi delle carte storiche di Arbizzano, secondo cui il nucleo consolidato del paese era fondato proprio attorno all’antica pieve romanica del luogo, collocata in quella che sarà poi identificata come località Novare.
156 Mulino di Villa Barzizza Mulino di Villa Tommasini - Albertini
157 Villa Barzizza, villa Piatti-Zamboni e villa Tommasini-Albertini nel disegno di G. Deottin del 1704; Fonte: ASVr, Piatti, dis. 663. Mulino di Villa Piatti - Zamboni
In questo contesto viene storicamente do cumentata inoltre da una mappa storica risalente al 1558 realizzata da Cristoforo Sorte4, la presenza di un progno che scende da Novare e di tre mulini funzionanti lungo il corso d’acqua, che durante i secoli, provoca rono non pochi asti tra le famiglie proprietarie delle ville, a causa della regolamentazione delle acque del progno e del loro utilizzo. A
158 sia di Bruno Chiappa sia del professor Marco Pasa al XVI secolo, e furono soggette a sva riati passaggi di proprietà, tutti documentati di Stato di Verona2 e fondamentali per poterne comprendere la storia e le vicende di ognuna di esse, dal Cinquecen to ad oggi. Le ville in questione sono, da nord a sud, villa Piatti, divenuta villa Zamboni, oggi villa Turco; villa Tommasini-Albertini, oggi villa Albertini; ed infine villa Verità, oggi villa dall’Abaco. E’ possibile ricondurre tutte e tre le ville a quelli che sono i dettami presenti nella tipologia della villa veneta stu diati nei capitoli precedenti, ed è facile avere conferma del tipo di vita che si svolgeva al loro interno, conservando in ognuna di esse quella duplice natura di aulico lavoro che viene riconfermato dalle parole del professor Chiappa, “La prossimità alla città consentiva, poi, un controllo quasi diretto dei lavorenti e un rapporto di strettissima consuetudine con le proprie terre” 3
nell’Archivio
159 riprova di queste ostilità è stata trovata una mappa, conservata presso l’Archivio di Sta to di Verona, risalente al 1704, disegnata da G. Deottin5 che restituisce l’immagine della contrada come poteva apparire al tempo e si può notare, paragonando la situazione an che con ciò che era stato precedentemente rappresentato nella mappa del Sorte, che se a villa Zamboni è associata la posizione del terzo mulino, per quanto riguarda la villa oggetto di progetto, attuale villa Albertini è associata alla posizione del secondo muli no in elenco. Il mulino in questione, riporta Chiappa, nel 1601 faceva parte dei beni di G. Andrea De Bonis, che godeva anche di diritti d’irrigazione, poi ceduti e passati con i passaggi di proprietà della villa agli stes si Tommasini, nonostante il mulino non si trovasse fisicamente dentro la cinta muraria della loro proprietà. E’ stato infatti necessario risalire alle mappe del catasto austriaco per poter confermarne la posizione e toglier si il dubbio in merito a questa stranezza: il mulino è rappresentato infatti esternamente dalle mura di quella che all’epoca era villa Tommasini, nonostante la famiglia ne fosse in possesso e potesse regolamentarne l’utiliz zo, godendo del corso d’acqua favorevole ai loro bisogni per quanto concerne il tratto di progno che taglia verticalmente il lotto e ne irrigasse a piacimento il brolo ed i vitigni.
2 Archivio di Stato di Verona, Piatti 505; 3 Chiappa B., Le ville di Arbiz zano: contributo per un chiari mento con particolare riferimen to alle ville Zamboni e Verità. in Annuario Storico della Valpoli cella, p. 55; 4 Disegno di Cristoforo Sorte, 10 dicembre 1558, copia di Lu igi Trezza, con il corso del pro gno di Novare; 5 Archivio di Stato di Verona, disegno di Deottin G., Villa Barzizza, villa Piatti-Zamboni e villa Tommasini-Albertini, 1704;
160
161 Villa Albertini nei secoli
Al lotto di villa Albertini è stata prestata particolare attenzione, essendo vero e proprio luogo di progetto per la realizzazione della cantina espositiva e produttiva all’interno del sistema espositivo diffuso in Valpolicel la. Riguardo alla storia della Villa stessa purtroppo non esiste grande documentazione iconografica o tecnica, ma è stato possibile ricostruire verosimilmente il conseguirsi del le vicende che la riguardano e dei suoi muta menti grazie alle descrizioni ritrovate presso l’Archivio di Stato di Verona, in cui viene riportato dal professor Chiappa che “L’atto di vendita ci parla di una casa dominicale da muro con corte cinta di muro, barchessa, torco lo, caneva, stalle, loco da forno e liscia, fenile, colombara e casa da gastaldo e con brolo prativo e arativo cinto di muro con vigne e altri alberi” e ancora “Il già citato disegno del Deottin del 1704 mostra una struttura che, rispetto a quanto sopra descritto, ha subito sostanziali modificazioni (…) la corte appare chiusa su tre lati da edifici e sul quarto da muro con portone d’ingresso (…) La casa dominicale è situata sul lato nord e presenta una struttura compatta che si innalza nella frazione centrale, residuo A sinistra: mappa da catasto austriaco raffigurante il lotto di Villa Albertini;
162
163 forse dell’originaria colombara. Sul lato est è collocata una barchessa a 8 luci (…) Elementi importanti della restituzione iconografica sono i due giardini: uno all’italiana, posto dietro la casa dominicale e con aiole di forma circolare e romboidale; e uno, situato fra la barchessa e il corso d’acqua che scende dal mulino, che sug gerisce l’idea di un labirinto.” 6
Tutta questa descrizione consente quindi di ricostruire la situazione della villa risalente al XVIII secolo e di farsi una chiara idea di come fosse la situazione al tempo di pro prietà dei Tommasini. A riconferma dei con tenziosi esistenti per l’utilizzo delle acque delle differenti famiglie e del possedimento del mulino da parte della famiglia Tommasini, negli atti si citano anche le dinamiche in merito all’irrigazione di tutti gli spazi verdi sopra elencati, dai giardini ai campi coltivati, che avvenivano tramite un bocchetto aperto nel corso del progno di Novare e che aveva provocato molto dissenso da parte delle fa miglie delle altre ville perché sostenevano che in questo modo i Tommasini portassero via loro acqua utilizzabile. Questo corso d’acqua aggiuntivo è infatti rappresentato nelle mappe del catasto austriaco e napoleo nico, per poi scomparire in quelle successive datate 1899, a ragione del passaggio di proprietà nel frattempo avvenuto e della dismissione del mulino, di cui rimase solamente A sinistra: ridisegno degli spazi verdi di Villa Albertini al 1704, giardino all’italiana e brolo; 6 Chiappa B., Le ville di Arbiz zano: contributo per un chiari mento con particolare riferimen to alle ville Zamboni e Verità. in Annuario Storico della Valpoli cella, p. 65;
164
165 A sinistra: ridisegno degli spazi verdi di Villa Albertini al 1889; A destra: ridisegno degli spazi verdi di Villa Albertini allo sta to attuale;
166
167 la ruota, che diventò parte di un’abitazione privata. Iniziarono nel corso dell’Ottocento i primi passaggi di proprietà, per arrivare poi definitivamente in possesso degli Albertini come ultimi proprietari privati del Campo del Molino e villa Albertini. Il sacerdote e proprietario Pietro Albertini si occupò del rifacimento della facciata della casa padronale, eliminando la sopraelevazione del corpo centrale della stessa e posizionandovi al suo posto delle statue decorative in stile neoclas sico. Il volume che costituisce la casa padro nale però non perse la propria caratteristica d’essere un corpo massiccio, quasi una caserma, come scriverà lo storico Luigi Messedaglia in merito all’edificio, ornato solamente da un balcone nella sua facciata principale, sorretto da quattro robuste e tozze colonne. Al momento del passaggio di proprietà a don Pietro Albertini, nonostante il cambiamento della facciata mantenne invariate le principali caratteristiche della villa: un cor po molto allungato, che in corrispondenza di dove precedentemente vi era un rialzo della copertura mantiene chiari i disegni di verticalità grazie ad una serie di linee verticali che da terra arrivano fino al quarto ed ultimo piano, inquadrando le tre campate centrali.
Questa parte centrale è l’unica che vanta di ornamenti in stile neoclassico, dalle colonne che sorreggono il balcone trasformanteA sinistra: dipinti storici della Villa risalenti al XVIII secolo.
168 in lesene nei piani superiori, sino al portale sormontato da un timpano triangolare che al piano primo fa accedere al balcone. Tutta la facciata è inoltre caratterizzata da finestre con cornice semplice al piano terra ed all’ultimo, mentre nei piani intermedi le finestre presentano cornici modanate. Dalle mappe del catasto risalenti al 1950-1960 è possibile notare i primi cambiamenti volumetrici: per quanto riguarda la casa padronale ha perduto la propria simmetria quando è stato aggiunto un corpo sul lato est e due torret te sul lato nord; è inoltre andata perduta la barchessa con annesso portale che la connetteva fisicamente al corpo padronale della villa, trasformandosi in un corpo ad L ad oggi unica parte accessibile e funzionante del complesso per funzioni pubbliche e ricreati ve; ed infine lungo parte della cinta muraria è presente una loggia ad oggi inaccessibile perché pericolante che un tempo era un corpo chiuso ospitante residenze per i lavoratori dei padroni della villa. Sempre in questi anni è stata costruita nella parte ad est del progno una scuola comunale mai utilizzata. Un’incertezza rimane in merito alla presenza di un corpo al L posto nella zona nord del lotto, incastrato tra i due corsi d’acqua, che viene rappresentato solamente nelle mappe del catasto austriaco per poi scomparire dalle mappe, probabilmente riconducibile ad una
169 cedraia, tipiche della zona del garda e di alcu ne altre ville venete presenti in Valpolicella. In merito al grande giardino all’italiana che si trovava sul retro della villa stessa, questo spazio verde ad oggi è posto sotto tutela dalla Soprintendenza di Verona, grazie alla nu merosa varietà di specie arboree che vi sono presenti, alcune addirittura da secoli, trattasi di esemplari di dimensioni considerevoli e quasi tutte in buono stato di salute. Dai documenti infatti si evince che il passaggio di proprietà corrisponde circa al cambiamento della natura del verde stesso: dal giardino all’italiana presente in precedenza di cui si parla nei documenti, il passaggio a questo grande parco ospitante ben 91 alberi catalogati e riconducibili a 15 specie arboree diffe renti tra alberi ed arbusti, corrisponderebbe al passaggio di proprietà della villa dalla famiglia Tommasini ad Albertini. Alla morte del sacerdote Albertini, nel 1863, la villa passò ai suoi successori, fino a quando nel dopo guerra ospitò l’istituto Salviamo il Fanciul lo sino al termine delle proprie attività nel 1980, passando poi in possesso della Curia di Verona. Attualmente in disuso, se non per quanto riguarda gli edifici realizzati al posto della vecchia barchessa, preposti a teatro co munale e sede di eventi estivi all’aperto, la villa è passata dal 2005 ad essere di proprietà del comune di Negrar, nel quale essa si trova.
170
A sinistra:
Condividere il complesso ritratto di natura, tradizioni e storia del luogo a cui apparteniamo, questa è stata la prima volontà progettuale. Riuscire a mettere a sistema all’interno di un progetto spazi e percorsi che siano in grado di far respirare il significato di questo luogo a chi non conoscendolo vuole entrarne in contatto ed allo stesso tempo a chi vi è cresciuto e vuole ritrovarne l’innovata tradizionalità di cui ha memoria. Arbizzano, Comune di Negrar, planivolumetrico di 6progetto;Silvestri
G., La Valpolicella, 1950, p. 70;
171 7 | IL PROGETTO
“E qui ha inizio l’amena e fertile Valpolicella, celebre fin dagli antichi tempi per il suo vino prelibato e cara a molti poeti che ne esaltarono le bellezze paesistiche e le villerecce delizie.” 1 Giuseppe Silvestri
Nelle parole di Cassiodoro, testimonian za della storia remota di questo luogo, si è riuscite quindi a trovare ragione di ciò che potesse essere in grado di esprimere la vita sviluppatasi qui nel corso delle epoche.
172 Percorrere e stare nel territorio
Un’anima composta in gran parte da quell’aspetto che si radica in origini antiche, che si è soliti respirare in Valpolicella e che ha costruito nei secoli la sua identitaria tra dizionale modernità intrisa ancora oggi tra i filari dove “L’uva scelta d’autunno nelle vigne dei pergolati domestici viene appesa capovolta e si conserva nei suoi recipienti naturali. Si appassisce, non corrompe per la vecchiaia, e trasudando gli inspidi umori si addolceisce con grande soavità. Si conserva fino al mese di di cembre, finchè la stagione invernale completa l’essicazione, e in modo mirabile in cantina si ha un vino nuovo mentre in tutte le altre si incontra un vino vecchio.”
2
D’altro canto però Valpolicella non signifi-
Per poter raggiungere questo obiettivo progettuale, ci si è poste la domanda di quali potessero essere le caratteristiche del territorio in grado di assumere un ruolo emble matico, capaci di far vivere questa narrazio ne.
173 2 Cassiodoro., fonte: la-valpolicellawww.cortesanbenedetto.it/https:// ; ca solamente raccontare il vino e le proprie implicazioni, di conseguenza ci si è poste il problema di come poter affrontare questa tematica senza banalità e senza incappare nella musealizzazione della stessa in qualità di mera esibizione enologica. A questo punto quindi sono stati presi in considerazione gli ulteriori aspetti fondamentali che compon gono il mosaico di quest’antica Valle: il territorio stesso, la natura, i rilievi, gli scenari, i prodotti, le numerose ricchezze. In queste suggestioni trova fondamento la volontà di progettare un sistema in grado di racchiude re il tema della duplicità che ha fortemente caratterizzato il nostro percorso progettuale. Stare e percorrere, connubio di luoghi produttivi ed espositivi ed allo stesso tempo far percorrere le strade della Valpolicella, im mersi nella propria autentica natura.
174
L’itinerario vinicolo progettato nella Valpolicella Classica è composto da cinque differenti luoghi, localizzati in cinque comuni del territorio, ognuno dei quali è composto dall’ideazione di un percorso che attraversa paesi ed architetture fondamentali dove in alcuni casi sarà prevista solamente la visita del luogo, in altri invece saranno previste attività interattive con i visitatori.
Nonostante non vi sia una consequenzialità predefinita di luoghi da dover visitare all’interno dell’itinerario, esiste però un luogo che è stato individuato come il vero e proprio corpo principale di questo sistema: il lotto compreso nelle mura di Villa Albertini, nel la frazione di Arbizzano, comune di Negrar.
175
La gerarchizzazione di questo sistema quindi pone al vertice la cantina produttiva ed espositiva progettata all’interno delle pro prietà della Villa, in cui il mondo vinicolo è accompagnato da un sistema di luoghi pen sati a vantaggio della collettività, diventando quasi un piccolo borgo vinicolo in cui il vino si manifesta in tutte le sfaccettature: il valore folkloristico, tradizionale e collettivo di convivialità, l’aspetto pragmatico, tecnico e
La gerarchia dell’itinerario
176
177 tecnologico delle lavorazioni di cui necessita durante il processo da materia prima a pro dotto finito, ed infine l’aspetto naturalistico storico, dei luoghi che lo rappresentano e gli appartengono, dai vitigni all’architettura della cantina produttiva.
I percorsi che mettono a sistema la rete di questi cinque luoghi sono stati pensati sulla base della preesistenza della rete stradale, cercando di individuare sia degli itinerari percorribili in auto, sia degli itinerari percorribili a piedi o in bicicletta, tipologia di turismo molto presente sul territorio e che si è quindi voluta incentivare. Specialmente nel caso dello studio dei percorsi senza au tomobile si è cercato di tracciare degli itinerari in grado di ripercorrere strade di valore storico, immerse negli scenari naturali tipici, in grado di ottimizzare tempistiche e sicurez za, basate sulla volontà esistente della futura realizzazione di nuove strade ciclabili che è sembrato interessante rimarcare e portare all’interno dei percorsi di progetto.
A sinistra: fotoinserimento del totem di progetto previsto in ogni stazione dell’itinerario espositivo, sito: Villa Albertini;
Da Villa Albertini si regolano poi i quattro siti d’approfondimento nei quali è possibile recarsi arbitrariamente in base a soggettivi interessi d’approfondimento riguardo gli aspetti del mondo vinicolo, senza la neces sità di seguire un ordine di percorso presta bilito e senza che necessariamente debbano essere visitati tutti.
180
I cinque volti del vino
181
Ad ognuno dei luoghi tematici presenti all’interno dell’itinerario studiato è stato affidato il compito di raccontare in maniera approfondita uno dei volti del mondo vini colo. Se all’interno del borgo progettato a Villa Albertini infatti viene offerta a tutto tondo la realtà vinicola nella propria completezza e ricca complessità, ad ognuno degli altri quattro siti di progetto è stata destinata una singola tematica di approfondimento, sulla base della quale è stato identificato quale tra i paesi della Valpolicella potesse essere lo scenario più adatto ad ospitare ciasuna di esse sulla base della propria natura intrinseca. Il sito più vicino a villa Albertini è colloca to anch’esso nel comune di Negrar, ad una distanza di 6 km dalla casa padronale della villa. Riconosciuto come il capoluogo antico della Valpolicella Classica, a Negrar si è deciso di affidare il compito di ospitare l’ap profondimento dell’aspetto folkloristico del mondo vinicolo, raccontando la tradizione di un popolo e della propria terra. Si è pensato quindi di completare e rafforzare i collegamenti ciclopedonali previsti da PAT come percorsi soggetti a futura trasformazione, di Nella pagina precedente: per corso previsto dall’itinerario espositivo sulla cultura enologi ca sul territorio della Valpolicel la Classica;
182
183 modo che possano passare sia dall’antica pie ve del paese, luogo dall’importanza storica e tradizionale molto forte dove si svolsero e svolgono tutt’ora la festa del vino e dell’uva nonchè l’arrivo e le premiazioni del Palio del Recioto, sia dal vitigno collocato nel centro del paese, per non perdere il contatto con la natura del luogo e di modo che funga da raccordo con i siti successivi. Spostandosi verso il comune di San Pietro in Cariano si trova la sede della facoltà di eno logia dell’Università degli Studi di Verona, situata all’interno di una delle ville venete elencate nel patrimonio veronese tutelato dai beni culturali: villa Lebrecht. Si è voluto quindi affidare l’approfondimento dell’aspetto enologico del mondo vinicolo agli spazi all’interno di questo comune ed alla villa stessa. In questo caso la presenza della villa e di spazi universitari di studio e ricerca, hanno incentivato l’idea di poter sviluppare lo studio della tematica attraverso conferen ze, ricerche, momenti interattivi tra visitatori e studenti o professori, per poter arricchire la qualità della visita dei luoghi in cui vengono testate le qualità del raccolto, le composizioni chimiche della bevanda ottenuta, valutandone la conforme qualità rispetto alle aspettative d’etichetta. Inoltre, un aspetto interessante che è stato oggetto di ulteriore arricchimento per l’approfondimento A sinistra: fotoinserimento del totem di progetto previsto in ogni stazione dell’itinerario espositivo, sito: chiostro della Pieve di San Giorgio di Valpo licella;
184 di questa tematica è il progetto di tecnolo gie innovative che dall’autunno del 2021 è nato dagli stessi laboratori di Fabbriche del vino3, grazie al quale con nuovi macchinari e tecnologie studiati si è in grado di poter analizzare lo status di un intero raccolto pur rimanendo all’interno del laboratorio. Que ste attività hanno dato l’input per pensare a delle piccole esperienze in prima persona da parte del visitatore all’interno del percorso progettato: grazie al nuovo progetto per una cantina universitaria laboratoriale previsto al posto dell’attuale Centro di Sperimentazio ne Vitivinicola infatti sarà possibile provare in prima persona le nuove tecnologie enologiche di Fabbriche del Vino. Dirigendosi verso Fumane, paese ricco di cantine, a folklore ed enologia non poteva non aprirsi il grande mondo riguardante la vita e le pratiche del vignaiolo, dal campo all’azienda agricola, dalla semina della materia prima alla vendemmia e raccolta della stessa. Anche in questo caso l’esperienza è data dal territorio, i percorsi ricalcano le previsioni future previste dagli strumenti urbanistici dando in questo caso grande importanza alla mobilità lenta, prevedendo un percorso immerso nei vitigni, che com prendesse il passaggio tra le più note aziende agricole presenti sul territorio. A completamento di questo percorso, che si pone
Anche in questo caso a fare da padrone per la qualità del sito espositivo è il territorio stesso con le proprie grandi peculiarità: si tratta quindi della progettazione di un percorso all’interno del borgo stesso in cui è possibile visitare l’antica pieve romanico-longobarda, il campanile adiacente, l’annesso ciborio ed infine anche il chiostro ancora esistente e visitabile che ospita il Museum Antiquarium di San Giorgio. Percorrendo le strette vie di questo borgo, riconosciuto nella lista dei più belli d’Italia è possibile respirare la storia della Valpolicella, le costruzioni residenziali in antichi materiali locali, le architetture reli giose, ma soprattutto la bellissima vista di cui si può godere, trovandosi ad una quota elevata dei vigneti tipici della Valpolicella Classica circondati dal Lago di Garda.
185 3 Ganz B., Tecnologie 4.0 dal campo alla cantina: a Verona apre la fabbrica del vino., 29 novembre 2021, fonte: Il Sole 24 ore;
come intento quello di dare dimostrazione delle strumentazioni necessarie nei campi ed a tutto il lavoro sulle spalle della figura del vignaiolo, è stato pensato anche ad un tratto d’itinerario in cui è possibile osservare le antiche strumentazioni e macchine vinicole.
San Giorgio di Valpolicella, detto anche lo calmente Ingannapoltron, è il borgo più antico della Valpolicella al quale da progetto è stato affidato l’approfondimento del carattere storico del territorio, dalle origini della co struzione del mondo attorno cui si è svilup pata la produzione vinicola della Valpolicella.
186
La decisione di sviluppare il vertice dell’itinerario espositivo della Valpolicella all’interno delle mura di Villa Albertini nella frazione di Arbizzano storicamente individuato come “Campo Molino”, nascono dalla volontà di far rivivere questo ampio e potenzialmente prezioso spazio attualmente in disuso, se non in piccola parte adibito per sporadici eventi estivi all’aperto di organizzazione comunale in favore della collettività locale. Attualmente esiste un progetto di restauro in atto per la ristrutturazione del corpo della villa stessa, essendo ad oggi pericolosamente instabile in molte parti dei solai, copertura compresa, ed essendo per questi motivi inaccessibile. Cercando di unire gli obiettivi progettuali elencati all’interno della stesura di questo elaborato con la volontà di rispondere an che alle reali necessità espresse per il luogo in questione si è cercato di trovare dunque l’equilibrio progettuale nello sviluppo di un sistema che possa diventare un mondo inclusivo e contemporaneo, con spazi espositivi vivibili dalla collettività in qualità di spazi dinamici, che possano essere visitabili ed allo
Il nuovo CampoMolino
187
A sinistra: attacco a terra e ac cessibilità;
188 stesso tempo conviviali. Il culmine dell’itinerario per questo motivo è stato pensato come un nuovo volto per l’antico Campo Molino: uno scrigno vinicolo produttivo ed espositivo, dedicato alla collettività, in cui sono racchiuse diverse funzioni. Da una parte si è pensato all’im portanza dell’accessibilità del luogo, quindi dei nuovi parcheggi diffusi nell’intorno del Campo Molino, per rendere più facilmente fruibili spazi espositivi e non, grazie alla previsione della riapertura di antiche soglie preesistenti nella cinta muraria che circonda il lotto di progetto, concedendo quindi gli ingressi da nord, ovest, ed est. In merito alla tematica degli accessi è stato tenuto in considerazione anche l’afflusso del turismo ciclo pedonale sul territorio della Valpolicella, che si è pensato che possa essere incentivato dalla progettazione di un itinerario espositivo sulla cultura enologica, quindi in previsione della ristrutturazione di Villa Albertini, una delle funzioni previste concerne proprio la tematica del pernottamento e ristoro di questa tipologia di turismo, che trova luogo nella parte di superfetazione della Villa stessa, mentre nei piani superiori dello storico cor po signorile si è pensato di poter dedicare de gli spazi a funzioni quali coworking e spazi studio. A ricalcare le giaciture dell’antica cedraia presente in epoca austriaca all’interno
delle mura del lotto è stata ripensata ad una nuova cedraia calata nella nostra contempo raneità, che possa accogliere degli ulteriori spazi di ricerca, accompagnati da un piccolo bar come zona ristoro circondati dal verde dei limoni, all’interno di uno spazio in for te connessione con la ricchezza del verde del grande parco antistante il volume. Villa Albertini e la propria nuova cedraia sono spazi messi in connessione dalla ricchezza botanica del parco della Villa, di cui da progetto sono stati riportati alla luce gli antichi assi principali dello storico giardino all’italiana.
Le funzioni previste all’interno del lotto vogliono legarsi all’importanza dedicata al ritrovo della collettività, di conseguenza la cantina produttiva ed espositiva compren de al proprio interno anche spazi di degu stazione, ristorazione, spazi di consocenza didattica ed interattiva con il tema vinicolo da parte del visitatore, diventando la grande macchina produttiva che affianca la propria Villa Veneta, immersa tra i filari di un nuovo vitigno che rinasce sugli spazi dello storico brolo.
189
190
191
Il progno di Novare: ordinatore di un ossimoro Il fondamentale asse segnato dallo scorrere delle acque del progno di Novare funge da principale elemento ordinatore per gli spazi progettati durante questo percorso. Si tratta di un segno molto forte che percorre il nuovo Campo Molino da nord a sud e che in un certo senso pone in contrapposizione ed allo stesso tempo a confronto le due opposte facce di uno stesso mondo. Il progno diventa quindi l’ambivalente quinta scenica, che scinde la duplicità di un’ani ma: a sinistra l’aulico mondo della casa pa dronale di Villa Albertini, accompagnata dal proprio giardino all’Italiana e dall’esile cedraia, mentre a destra la grande macchina produttiva vinicola, il mondo del lavoro agricolo, della cantina, che non spicca in alto con sottili elementi metallici come la cedra ia, ma affonda le proprie radici nella terra, dove si espande a macchia, celando i propri luoghi alla luce del sole.
L’incisione del progno è la soglia che conce pisce un ossimoro, che per natura tipologica altro non è che la storica innovazione racA sinistra: il progno di Novare ed il Campo Molino nello sce nario progettuale;
192
193 contata dalle Ville Venete. L’asse ordinatore di progetto diventa quindi esso stesso luogo d’ambivalente natura: spazio dello stare e luogo da percorrere. Si cerca di dare origine ad un contatto costante con l’acqua, ma che possa essere di differente na tura: il ricordo dell’ozio bucolico dei signori Veneziani si concretizza nella gradonata della sponda sinistra del progno, dove è possibile rimanere a sedere immersi nello scenario di un ricco parco botanico; d’altra parte la dinamicità del mondo agricolo si può per correre sull’opposta sponda destra, dove una passeggiata coperta accompagna lo scorrere delle acque di Campo Molino.
194
La cantina di Villa Albertini
Il progetto per la cantina produttiva ed espo sitiva di Villa Albertini prevede la realizza zione di uno spazio in grado di avere una propria produzione vinicola ed allo stesso tempo in grado di essere narratore della cultura enologica del territorio della Valpolicel la nonchè luogo di ristoro e convivialità per i visitatori. Due volumi emergono dal terreno e si fronteggiano, intervallandosi ad un sistema di corti sotterranee, che anticipano a coloro che ancora si trovano alla quota della strada, il vero e proprio luogo di sviluppo del progetto: l’interrato. Per potervi scendere e quindi accedere agli spazi della cantina è stato pensato a più di un punto d’accesso, di modo da poter rendere più comoda la frui bilità degli spazi viste le differenti funzioni previste all’interno del progetto e le possibili necessità di ciascun visitatore. Antistante al volume più a nord dei due si trova una prima rampa di discesa che da inizio al percorso espositivo prensato all’interno della cantina dedicato ai visitatori, mentre dall’interno e dal retro del medesimo volume sono stati posizionati gli spazi utili alle prime fasi di vinificazione ed organizzazione lavorati-
A sinistra: la cantina di Villa Albertini;
195
196 va, quali ricezione delle uve provenienti dai campi, la fase della pigia-diraspatura, ma gazzini logistici a piano terra ed un fruttaio ad aerazione naturale grazie alla presenza di feritorie al piano primo. Una delle tematiche di progetto affrontate infatti è stata quella di organizzare la coesistenza di due mondi: il doppio percorso e la doppia natura degli spazi prevista all’interno di una cantina visitabile dovevano risultare l’uno il completamento dell’altro, senza intralciarsi tra di loro ma nemmeno escludersi, facendo in modo che i lavoratori possano svolgere le loro atti vità produttive in maniera indisturbata, ma che allo stesso tempo i visitatori possano respirare l’autenticità del mondo vinicolo della UnaValpolicella.voltascesi a quota - 3,50 metri è pos sibile accedere al vero e proprio percorso interrato della cantina, delle prime fasi d’accettazione anticipano un ulteriore cambio di quota che fa scendere a - 4,50 ed incontrare le prime botti in legno dove avviene la fase della fermentazione dei liquidi ed un lungo corridoio successivo che scandito da delle feritoie mantiene sempre vicino il contatto con le acque del progno di Novare e fa ac cedere alla prima delle due corti: quella di natura didattica, dove sono previste sedute all’aperto e cinque totem espositivi in cui è possibile avere uno scenario completo dell’i-
tinerario espositivo diramato sul territorio.
L’ultima delle corti che completa il sistema diventa luogo di un teatro all’aperto, una scena pensata come appendice esterna all’e sistente sala comunale e da cui è possibile risalire alla quota della strada tramite una grande rampa urbana che completa i percorsi sotterranei della cantina di Villa Albertini.
Infine, nel secondo volume fuoriterra trova luogo un ristorante che si sviluppa su due piani ed identifica il vasto spazio esterno coperto che mette in connessione tutto questo grande sistema alla quota della strada.
La corte adiacente invece, messa in contat to visivo con la precedente grazie alla totale trasparenza delle facciate del ponte che le intervalla e crea un passaggio alla quota della strada, è di natura conviviale: si tratta quindi di una corte che alla propria destra lascia spa zio al wine shop, ed a sinistra alla biblioteca dei vini, luogo d’esposizione di pregiati vini d’annate storiche.
Tornando alla luce del sole infatti, ci trova in un grande vigneto artificiale, alter ego dei veri filari di viti che circondano l’intera macchina produttiva; i materiali richiamano alla composizione della terra, murature molto compatte e chiuse per i volumi che compon gono gli spazi della cantina, ed esili pali in metallo che sorregono un telo a copertura degli spazi vivibili al piano terra immersi nei vigneti.
197
198
199
La cedraia tra le ricchezze botaniche
Il progetto per la cedraia di Villa Albertini trova luogo sulle giaciture dell’antica posizione all’interno del parco in cui storicamente nell’epoca catalogata dal catasto austriaco sorgeva l’antica limonaia. Si tratta di uno spazio molto aperto, pensato come un luogo di ricerca e piccolo ristoro in pieno contatto con la grande ricchezza botanica che caratterizza il parco, infatti oltre ad avere solamente una piccola parte totalmente al chiuso, essa conta di una copertura apribile e di una fac ciata principale composta da un basamento in pietra di Prun, pilastri in metallo intervallati da sottili listelli metallici che fungono da brise-soleil. Il progetto è stato dunque pensa to sulla base degli elementi fondamentali che compongono le tipiche limonaie del Lago di Garda, contando quindi su parti mobili, esili ed un sistema di gradoni al proprio interno che regola la coesistenza di una ricca vegetazione in stretto contatto con gli spazi fruibili dalla collettività.
A sinistra: la cedraia tra le ric chezze botaniche; Nelle pagine seguenti: A sinistra: piano interrato; A destra: piano terra.
200
201
202
203 BIBLIOGRAFIA Cartografia e Storia Archivio di Stato di Verona, Piatti, n. 305, Piatti, n. 504, Piatti, n. 505; Istituto Regionale per le Ville Venete, Le ville venete. Itinerari tra Veneto e Friuli, Marsilio, Venezia, 1999; Fabrizio Battista, Pietro Tommasi (a cura di), I segreti del territorio, dei vigneti e del vino Amarone della Cantina Valpantena, Cantina Valpantena Verona, 2013; Francesco Bresaola, Negrar, Edizioni di “Vita Veronese”, Verona, 1957; Antonio Canova (a cura di), Ville Venete, Canova Edizioni, Treviso, 1984; Antonio Canova (a cura di), Le Ville del Palladio, Canova Edizioni, Treviso, 1985; Andrea Castagnetti, La Valpolicella: dall’alto Medioevo all’Età Comunale, in An nuario Storico della Valpolicella, Centro di documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1984;
204 Bruno Chiappa, Le ville di Arbizzano: contributo per un chiarimento con particola re riferimento alle ville Zamboni e Verità, in Annuario Storico della Valpolicella, Centro di documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 2000; Bruno Chiappa, I mulini da grano della pianura veronese, Gianni Bussinelli Editore, Verona, 2015; Olivia Chierighini, Valpolicella. Recioto e Amarone, Nardini Editore, Firenze, 2002; Eugenio Cipriani, Escursioni in Valpolicella, Cierre Edizioni, Caselle, VR, 1989; Rinaldo Dal Negro, Arbizzano: dalla Preistoria al Duemila, Comitato Benefico S-Ciapa soche de Arbissan nel ventennale di fondazione, Arbizzano - Verona, 2001; Mauro Fermarielli, Valpolicella, Andar per cantine, Mondadori, Verona, 2014; Stefania Ferrari (a cura di), Ville Venete: la Provincia di Verona, Istituto Regionale per le Ville Venete, Marsilio, Venezia, 2003; L anfranco Franzoni, La Valpolicella nell’età romana, in Annuario Storico della
205 Valpolicella, Centro di documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1982; Patricia Guy, Paolo Morganti (traduzione di), L’Amarone, Morganti Editore, Sommacampagna, VR, 2000; Gloria Maroso, Gian Maria Varanini (a cura di), Viti e vino nel Medioevo, Centro di documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1984; Luigi Messedaglia, Arbizzano e Novare: storia di una terra della Valpolicella, Tipografia Veronese, Verona, 1944; Paolo Morganti, Sandro Sangiorgi, L’Amarone della Valpolicella, Morganti Edi tori, Sona, VR, 2004; Paolo Morganti, I vini della Valpolicella, Morganti Editori, Sona, VR, 2005; Giorgia Ortolani, comune di Negrar (a cura di), I sentieri storici di Negrar, Damolgraf, Arbizzano di Valpolicella, Comune di Negrar, VR, 2006; Marco Pasa, Novare e la sua valle: sto ria di una tenuta agricola nella Valpolicella Orientale, in Annuario Storico della Valpoli-
206 cella, Centro di documentazione per la Sto ria della Valpolicella, Verona, 1996; Lionello Puppi, Le grandi Ville Venete, Istituto geografico De Agostini, Novara, Luciano1982; Salzani, Preistoria in Valpoli cella, in Annuario Storico della Valpolicella, Centro di documentazione per la storia della Valpolicella, Verona, 1981; Giuseppe Silvestri, La Valpolicella, Cen tro di documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1983 (terza edizione); Gian Maria Varanini, La Valpolicella: dal duecento al quattrocento, Centro di docu mentazione per la Storia della Valpolicella, Verona 1985; Gian Maria Varanini, La Valpolicella nella prima età moderna (1500 c. - 1630), Centro di documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1987; Giovanni Viviani, Negrar: un filo di storia, Comune di Negrar in collaborazione con il Centro di documentazione per la Storia della Valpolicella, Negrar 1991;
207 Giuseppe Franco Viviani, Ville della Valpolicella, in Annuario Storico della Val policella, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1983.
208
209 SITOGRAFIA Annuario Storico della Valpolicella: www.veronastoria.it/ojs/index.php/ASValphttp:// , ultima consultazione: 25 giugno 2022; Geoportale Regione Veneto: geoportale,regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/https://www. ultima consultazione: 15 giugno 2022; Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella: https://cdsv.it/, ultima con sultazione: 15 giugno 2022; Valpolicella. Consorzio Tutela Vini: https:// www.consorziovalpolicella.it/, ultima consultazione: 20 giugno 2022; DARV, Digital Archive Verona: http:// www.davr.it/, ultima consultazione 20 giugno Corte2022;San Benedetto: https://www.cortesanbenedetto.it/, ultima consultazione: 30 giu gno Storia2022;Rinascimentale: nascimentale.it/dinastie/della-scala/,https://www.storiariultima consultazione: 30 giugno 2022.
210
Ringraziamo il professor Massimo Ferrari e la professoressa Claudia Tinazzi, che ci hanno guidate in questo percorso, supportando il nostro lavoro e facendo in modo che riuscissimo a seguire le nostre passioni in modo libero ma Ringraziamoconsapevole.lenostre persone, coloro che ci sono stati vicini in questo periodo, affetti capaci di alleviare i momenti di fatica con Edspensieratezza.infine,ciringraziamo l’una con l’altra, colleghe in questo lungo percorso di soddisfazioni, spalle nei momenti di sconforto e amiche tra le risate che hanno reso più colorato il nostro lavoro.
211