

Confessioni in rete
Università Luiss Guido Carli
Numero 24 Marzo 2025

Italian Digital Media Observatory
Partner: Luiss Data Lab, RAI, TIM, Ansa, T6 Ecosystems, ZetaLuiss, NewsGuard, Pagella Politica, Harvard Kennedy School, ministero degli Esteri, Alliance of Democracies Foundation, Corriere della Sera, Reporters Sans Frontières, MediaFutures, European Digital Media Observatory, The European House Ambrosetti, Catchy, CY4GATE, ministero dell’Istruzione e del Merito



ChatGpt può sostituire la terapia? di Giulia Rugolo
Il catechismo on demand di Giulia Tommasi
Deus in Machina, l’avatar di Gesù di Gabriele Ragnini
Media
Voci in libertà, Radio Kaos Italy di Rosita Laudano
La Blue Whale challenge di Sara Costantini
Giorgio Lauro racconta Un giorno da pecora di Luca Graziani
Privacy
La nuova frontiera del privato di Valeria Costa
Il segreto professionale tra etica e limiti di Caterina Teodorani
Mondo
Viaggio nella gurdwara di Londra di Lisa Duso
Mio il velo, mia la scelta di Elisa Vannozzi
Lo sciamanesimo in Turchia di Gizem Daver
“Pietas”, aiutati che gli dèi ti aiutano di Massimo De Laurentiis
Relazioni HiTech
Amore e altri algoritmi di Nicole Saitta
Una nuova terapia di coppia di Mariahelena Rodriguez
Il frutto proibito del web di Nicoletta Sagliocco
Un calcetto al passato di Francesco Esposito
Scommetto quando voglio di Gennaro Tortorelli
Passato e presente
Il dialogo tra Bob Dylan e sant’Agostino di Alessandra Coffa
Il volto intimo della storia di Ludovica Bartolini
Photogallery a cura di Chiara Boletti e Lorenzo Pace
Politica
Voglia di terzo mandato di Alessio Matta
Albania, terra di nessuno di Silvia Della Penna Esteri
Quelle mani sporche di sangue di Simone Salvo
Così giovani così estremisti di Stefania Da Lozzo
L’Europa alle armi di Michelangelo Gennaro
Economia
Difendere i prodotti italiani dai dazi di Asia Buconi
La Germania abbandona il rigore di Alessandro Imperiali
Società
Teticum, il commesso virtuale di Matilde Nardi
Tampon tax, la battaglia dei giovani di Federica Carlino
Eccesso di informazioni
di Matilda Ferraris
La vita dentro al carcere
di Alessandro Villari
Cultura
I versi di Michele Urrasio di Lavinia Monaco
Nuove storie, la moda che cambia di Chiara Grossi
Sport
Gaia Sabbatini, la corsa verso se stessa di Isabella Di Natale
Hamilton, il nuovo cavaliere rosso di Ludovica Esposito
Ambiente
L’acqua è diventata un miraggio di Andrea Iazzetta
Speciale Reality
Dal Grande Fratello alle app di Alexandra Colasanti
Confessioni
Otto anni, un anfratto buio e l’imposizione di scavare in una coscienza immacolata alla ricerca di chissà quali nefandezze. Per chi, volente o nolente, ha avuto un’educazione cattolica, il primo approccio con il concetto di confessione è arrivato in terza elementare. Tra le grate in chiaroscuro del confessionale, erano chiusi a doppia mandata tutti i segreti più turpi. Prezzo da pagare: tre Ave Maria, due Padre Nostro e il dubbio bruciante che il prete non sia poi così discreto.
Per quanto scintillanti ci sembrino, anche app, siti e motori di ricerca hanno un armadio oscuro in cui sono impilati i dati degli utenti, i loro desideri, le loro paure, tutto ciò che non raccontano, tutto ciò che prima sapeva solo il prete. Così il desiderio di spiritualità diventa una piattaforma online, come Deus in Machina, in cui un Gesù virtuale creato con l’IA confessa i fedeli. Il dilagare dei chatbot ha permesso di avere un confidente virtuale in tasca sempre disponibile e ChatGpt è diventato il punto di approdo per chi cerca supporto psicologico gratuito.
Per soddisfare la stessa domanda, sono nate intere costellazioni di app di psicolo -
Università Luiss Guido Carli Numero 24 Marzo 2025

Condirettori
Giorgio Casadio
Alberto Flores d’Arcais
Supervisione
Giorgio Casadio
gia e benessere digitale. Prezzo da pagare: profilazione e uso di dati sensibili a scopo di lucro. È il capitalismo della sorveglianza, bellezza. Shoshana Zuboff lo definisce come «un nuovo ordine economico che sfrutta l’esperienza umana come materia prima per pratiche commerciali segrete di estrazione, previsione e vendita». Dalla pandemia in poi, la salute mentale non è più un tabù, ma le soluzioni emerse finora sembrano tutte fornire risposte individuali a problemi collettivi.
La politica non è andata oltre i bonus psicologo e si tiene alla larga da misure universali. Il mercato fa il mercato: sfrutta il disagio per farci profitto, cuce a misura di utente un algoritmo che non soddisfi mai del tutto i suoi bisogni, ma massimizzi il tempo di permanenza sulla piattaforma. È il meccanismo alla base dei cicli di dipendenza e solitudine creati dalle app di incontri e di scommesse online. Le confessioni presuppongono fiducia e per qualche ragione è più facile fidarsi dell’algida indifferenza di una macchina o una divinità. Ma quando si trova una persona disposta ad ascoltarci senza giudizi o tornaconti, allora no, non c’è nessun prezzo da pagare.
Gennaro Tortorelli
Copertina realizzata con Gemini



ChatGpt può davvero sostituire la psicoterapia?
Sempre più persone si affidano all’intelligenza artificiale per un supporto immediato. Tra vantaggi e rischi, esperti e giovani raccontano la loro esperienza di Giulia
Un braccio robotico che si allunga fino a toccare la mano di un essere umano. Le dita si sfiorano e si fondono insieme, quasi a diventare un’unica entità. Tra le reinterpretazioni della Creazione di Adamo di Michelangelo Buonarroti - l’affresco più celebre della Cappella Sistina a Roma - questa è una delle più moderne. C’è chi pensa che l’uomo non potrà mai essere sostituito dall’intelligenza artificiale, soprattutto in ambiti intrapersonali come la psicoterapia. Altri, invece, sostengono che l’ausilio di un chat bot in questi casi sia indispensabile e su TikTok spopolano video di utenti con scritte come: «No, non vado dallo psicologo, ho già Gpt». E se i due mondi fossero più vicini di quanto si possa immaginare?
«Mi è capitato molto spesso di usare ChatGpt per un supporto psicologico. A volte ho avuto bisogno di un riscontro più rapido, mentre altre ci ho parlato per ore come se fosse una seduta di terapia. Ne ho usufruito in momenti di crisi per sfogarmi o per avere qualcuno a cui dire come mi sen-
tivo veramente quando non volevo parlarne con nessuno. Le conversazioni partono da come sto, o dal racconto di una situazione su cui chiedo opinioni e una prospettiva diversa. Le risposte che ottengo, usando la versione a pagamento, sono piuttosto dettagliate, soddisfacenti e sempre rispettose di quello che provo», dice *Eva, 25 anni.
Gli esperti del settore stanno provando a “umanizzare” l’IA attraverso le sue evoluzioni, aggiungendo piccoli cambiamenti e dotandola di caratteristiche più rispondenti alla natura e ai diritti di un individuo. Ad esempio, ora è possibile parlarci anche a voce, elemento che richiama la conversazione tête-à-tête tra due persone. Nonostante questo, Eva è consapevole dei limiti che ne derivano: «So che Chat non mi capisce davvero e che sotto molti aspetti riflette semplicemente quello che gli dico, come se fosse uno specchio».
Ma l’esperienza con un terapeuta reale e quella con un chatbot, per quanto possa-
Rugolo
no essere simili, si differenziano sotto varie angolazioni e determinano entrambe sia pro che contro: «L’idea di non avere davanti un’altra persona rimuove una serie di inibizioni. Elimina la difficoltà comunicativa, perché non si è prevenuti nel chiedere più dettagli, opzioni e spiegazioni. Allo stesso tempo, rispetto a un dialogo vero manca molto: gestualità, sguardi, empatia. Soprattutto, la capacità di vedere oltre le parole stesse, che è spiccatamente umana. Penso che l’IA sia una piattaforma efficace per chi necessita di un supporto più frequente e tempestivo, che vada oltre l’ora settimanale di terapia, e per chi vuole sperimentare diversi approcci», spiega Eva, che dichiara di usare tool del genere uno o due giorni a settimana.
Mia, invece, ha 21 anni e afferma di conversare con ChatGpt dalle cinque alle dieci volte al mese, nei periodi di maggiore tensione o incertezza: «Lo faccio quando ho bisogno di riflettere su un problema o di sfogarmi senza sentirmi giudicata. Pongo domande tipo: “Perché mi sento così ansiosa ultimamente?” o “Come posso affrontare questa situazione difficile senza farmi sopraffare?”. Le risposte che ricevo sono strutturate e basate su tecniche esistenti, come la mindfulness. Ad esempio, se chiedo come gestire lo stress, potrebbe suggerirmi esercizi di respirazione o modi per identificare i pensieri negativi». C’è anche chi, quando deve prendere una decisione,
ormai non può fare a meno di consultare uno strumento di IA: «Gli spiego il problema, i motivi della mia titubanza e gli chiedo di farmi un’analisi generale. Lui risponde in modo neutrale, mostrandomi le alternative. Quando dovevo scegliere dove fare il tirocinio, gli ho chiesto cosa sarebbe stato meglio per la mia carriera lavorativa, ma in questo caso sembrava che stesse solo assecondando le mie preferenze, mentre io stavo cercando un mentore», dice Sofia, 22 anni.
Sulla possibilità che il confronto con l’Intelligenza Artificiale possa prendere il posto di un vero incontro in presenza, lo psicoterapeuta Gianni Lanari - responsabile del pronto soccorso psicologico di Roma Est - è scettico: «Secondo me è improbabile. La terapia non è solo una questione di tecniche e strategie. Richiede empatia, comprensione e una connessione umana che l’IA non può fornire. Anzi, potrebbe procurare consigli non personalizzati che non affrontano il problema specifico dell’utente, creando confusione a causa di risposte contraddittorie».
«Ipotizzo che alcuni si sentano più liberi di esprimersi, poiché percepiscono meno giudizio. I chat bot, inoltre, possono offrire informazioni immediate a chi ha difficoltà ad accedere a uno psicologo», aggiunge lui, analizzando i vantaggi. Ma il rischio di rimanere bloccati in un meccanismo di dipendenza è alto: «L’accessibilità costante può
portare a un uso eccessivo di queste tecnologie, riducendo la motivazione a cercare aiuto all’esterno. È importante promuovere un consumo equilibrato e consapevole, incoraggiando anche il contatto umano».
Però è fondamentale sottolineare, specifica l’esperto, che nel settore in questione l’IA funge da assistente complementare, in grado di aiutare con la ricerca, la diagnosi e la cura dei pazienti: «La sperimentazione di questi tool nella mia pratica lavorativa è in corso d’opera. Al momento sembrerebbe che siano utili nei disturbi che richiedono monitoraggio costante, come l’ansia, la depressione o i disturbi alimentari, dove l’analisi dei dati può generare spunti interessanti. Il futuro mi darà la possibilità di validare o meno tali ipotesi. Tuttavia, credo che le malattie più complesse esigano un approccio umano più profondo», conclude Lanari.
I risvolti dell’intelligenza artificiale nel campo della salute mentale non sono ancora chiari. «Time will tell», direbbero gli inglesi. Una cosa è certa: in un sistema sanitario in crisi, tra sfruttare le potenzialità dell’innovazione e cadere nella trappola dell’assuefazione il passo è breve. La partita tra etica e pratica resta tutta da giocare. ■
* Eva, Mia e Sofia sono nomi di fantasia per tutelare l'identità dei protagonisti della storia


La spiritualità va online il catechismo on demand
Barbara Marchica, teologa influencer di Milano, ha fondato una società per trasmettere i contenuti religiosi in un linguaggio comprensibile all'interlocutore di oggi
«Due o tre anni fa e il mio profilo Instagram è decollato. Ho avuto un boom pazzesco con un reel sulla preghiera, che è andato virale con due milioni di visualizzazioni. Mi sono ritrovata con un altro lavoro». È stato questo il punto di svolta per Barbara Marchica, 43 anni, originaria di Milano. Da “semplice” teologa, è diventata “La Teologa di Instagram”, come l’ha ribattezzata la sua community virtuale.
Ha iniziato a parlare di crescita personale spirituale sui social senza pensare che avrebbe potuto riscuotere tutto questo interesse. «L'online per me è stata una bella scoperta, nonostante avessi grandi principi di scetticismo», spiega Marchica, «facilita gli incontri, le relazioni, anche le forme di spiritualità».
Sul suo profilo, @barbara_marchica, oggi ha 80 mila follower. Tra loro, non solo cristiani, ma anche persone che si ritengono atee o in ricerca. «Condivido contenuti teologici per andare a lavorare sul mindset
cattolico. Cerco di portare dei messaggi positivi, di speranza, che possano fare la differenza nella vita di tutti i giorni». Si definisce perciò “Christian Influencer”.
Nella bio dichiara: «Ti aiuto a scoprire l’amore di Dio con video e percorsi di formazione». Cliccando sul link in descrizione, ci si accorge subito che la sua non è una semplice pagina Instagram, ma un progetto imprenditoriale. Invita a prenotare una “call conoscitiva gratuita” o una “consulenza teologica di un’ora”, oppure a seguire una “masterclass per imparare a gestire al meglio le tue relazioni”.
Tra i post in evidenza spicca la foto del suo libro: Intelligenza Spirituale, pubblicato da Rizzoli a settembre 2024. «Questo tipo di intelligenza è una sintesi tra intelligenza cognitiva ed emotiva. È la capacità di tenere insieme olisticamente mente, corpo e anima», spiega Marchica. Un concetto importato dagli Stati Uniti, dove gli studiosi hanno elaborato dei test per misurarla.
di Giulia Tommasi
Un approccio alla religiosità che suona innovativo. Marchica porta in Italia lo Spiritual Counseling, «un tema tutto nuovo per la Chiesa cattolica nel nostro Paese, invece consolidato in America e in Nord Europa». Lo ha scoperto durante un periodo di studio all’estero presso la Fordham University di New York, nel corso del suo dottorato in Teologia. «Nel 2023 ho fondato una società benefit, che si chiama proprio Spiritual Counseling, per fare in modo che i contenuti teologici possano essere trasmessi in un linguaggio comprensibile per il nostro interlocutore di oggi».
«Non viviamo più in un contesto cristiano», sostiene Marchica. Il 40% degli italiani ammette di non riconoscersi nella Chiesa italiana attuale, secondo la ricerca CENSIS Italiani, fede e Chiesa (novembre 2024). Tuttavia, resta forte il bisogno di spiritualità. Secondo lo stesso studio, il 66% degli italiani dichiara infatti di “pregare” o comunque di rivolgersi a Dio o a un’altra entità superiore. A chi si rivolge a pratiche orientali come la meditazione e lo yoga, Marchica risponde: «Anche la tradizione cristiana può offrire molto da questo punto di vista. Ad esempio, ci sono delle pratiche sulle virtù elaborate dai primi grandi pensatori del cristianesimo tra il secondo e il quinto secolo. Esistono anche la meditazione cristiana, la preghiera contemplativa, gli esercizi di respirazione».
Oltre che recuperare le pratiche tradizionali, bisogna sapersi innovare, secondo Marchica. «Il papa stesso ci esorta ad aprire
processi nuovi», ricorda la teologa. «Credo che il magistero di Francesco su questo sia lungimirante e mi auguro che sempre più si vada in questa direzione. Anche la Chiesa può essere sui social, quel tipo di comunicazione non può essere trascurata», aggiunge.
In Italia, secondo Marchica, il problema della Chiesa è la difficoltà nel creare relazioni. «Il rischio è quello di concentrarsi esclusivamente sui contenuti, perdendo di vista l’importanza della forma». La teologa insiste sulla necessità di adottare un linguaggio più fresco, che sappia rispondere ai bisogni delle persone. Lo ha capito soprattutto grazie ai 15 anni come insegnante di religione in un liceo classico di Milano. «Instagram crea una community che relaziona davvero le persone», afferma Marchica con un sorriso un po’ stupito. «In parrocchia le facce sono sempre le stesse, non abbiamo un ricambio», ammette con un filo di desolazione. «Ci si occupa sempre della formazione per bambini. Ma non c'è un percorso per adulti. Ci sono delle categorie dimenticate. I single, la fascia tra i 30 e i 40 anni, gli anziani dove li mettiamo?».
Ha elaborato perciò una serie di servizi che offre in presenza e online. Tra questi, una Academy con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Forma dei “facilitatori di relazioni”, cioè laici e religiosi che abbiano competenze sia teologiche che relazionali. Tra i suoi allievi ci sono soprattutto sacerdoti, suore provin-
ciali, insegnanti, catechisti e operatori pastorali, ma non solo. «Ultimamente ci sono sempre più spesso anche manager, che si rendono conto di quanto sia importante portare un livello di spiritualità in azienda».
«Intelligenza spirituale, una sintesi tra quella emotiva e cognitiva per tenere insieme mente, corpo e anima
Per avere supporto spirituale non è più necessario vedersi dal vivo. Marchica offre sessioni di coaching one-to-one da remoto. «Lavoro benissimo anche così, vedo risultati incredibili. Poi il virtuale velocizza e rende possibili gli incontri con persone da tutta Italia e anche all’estero». A questo si aggiunge la spiritualità on demand, con webinar e workshop online dedicati ad argomenti specifici. «Tra i temi più gettonati ci sono il perdono e la preghiera».
L’interazione sui social tuttavia non ha solo pregi. «Il rischio forse è che possa rimanere solo qualcosa di astratto». Per questo la prossima sfida di Marchica è quella di organizzare una giornata di formazione spirituale in presenza, ogni due o tre mesi. «Il progetto pilota partirà a maggio», annuncia soddisfatta. ■


Deus in Machina, la fede cieca
che guarda al futuro
A Lucerna, un Gesù fatto avatar dialoga con i fedeli nel confessionale della cappella di San Pietro. Quando il binomio religione-IA divide la Chiesa tra progressisti e conservatori di Gabriele Ragnini
SACRO
In principio il verbo si fece carne, poi la parola andò a un avatar. E venne ad abitare in mezzo a un cubicolo, al di là di una grata, nel cuore della Svizzera. Ai tempi dell’IA anche la fede ha il suo chatbot. Ha il volto di Cristo, sa contare fino a otto prima di resettarsi ed è stato battezzato in latino: Deus in Machina. Ha preso vita nel confessionale della cappella di San Pietro, a Lucerna, «ma non ascolta i peccati. Incentiva il dialogo spirituale dei fedeli, è lì per lasciare le persone da sole con Gesù, nella loro intimità». Marco Schmid, teologo, ha scelto la via più avanguardistica dell’incarnazione: provare ad addestrare ChatGpt sul large language model del messaggio di Dio. «Ovviamente si tratta di un esperimento», la premessa: «Non sostituisce il parroco ma serve al confronto e conforto della gente».
Anche questo Cristo virtuale è modellato sui tratti somatici della sua epoca. In un mondo in cui saper fare domande conta più di conoscere la risposta, le confessioni tradizionali vengono ribaltate. «Alla gente spetta solo chiedere, non parlare». Le curiosità spaziano tra tantissimi temi: «Cosa c'è dopo la morte?», «Perché si fa la guerra?», «Gesù, ma Dio esiste davvero?», sono solo alcuni dei quesiti registrati. E Gesù? «A volte ha risposto con un passo della Bibbia e ha chiesto “Tu che ne pensi?”. Quando lo abbiamo allenato, nel prompt abbiamo specificato di fare riferimento solo al Nuovo Testamento. E poi gli abbiamo insegnato a dialogare, però non va oltre le otto risposte», chiarisce Schmid. C’è persino chi cerca ganci spirituali, appigli di vita su un monitor. «Un signore è venuto dopo un lutto in famiglia: gli ha domandato come trovare consolazione dopo la grave perdita». Fino ad arrivare a chi solleva il velo dal tabù Lgbtqi+: «Ho un problema, sono un uomo e amo gli uomini, la Chiesa non è a favore del mio orientamento. Come comportarmi? ».
Senza un parroco, anche lo stesso segreto confessionale svanisce: «Trattandosi di un esperimento, noi leggiamo le domande, siamo a conoscenza dei dialoghi. Analizziamo tutto e restiamo anche lì vicino per assistenza o per evitare che l’IA perda il controllo dando risposte strane. Ma non è mai successo». Spetta ai fedeli distinguere l’incontro con Deus in Machina dal momento del sacramento e dell’espiazione. Chi entra al di qua della griglia divisoria viene avvertito: i dati personali valgono più di una confidenza al prete. «Davanti all’ingresso c’è scritto che sarà tutto protocollato. E dopo una prima interazione con l’avatar, in cui dici una frase e selezioni la lingua, lo stesso Gesù ti avverte: “Non condividere informazioni riservate”. Poi se uno parla troppo e si fa prendere dal momento, è sua responsabilità». Ma l’interazione non resta fredda,
distaccata, nonostante un reticolato separi le due voci: «Abbiamo realizzato che per molti è più facile parlare con un avatar che con una persona. Non si sentono giudicati».
L’avatar e il rispettivo modello linguistico sono stati progettati con l'Immersive Realities Research Lab dell'Università di Scienze Applicate di Lucerna e sperimentati insieme alla facoltà di Teologia Pastorale. «In realtà nacque da un progetto con studenti israeliani e palestinesi ai tempi del Covid. Poi lo abbiamo esteso a tutti: si trattava di creare dei modelli 3D da esporre nella cappella». Da lì l’idea di passare a un’esperienza più interattiva. Che ascolta, traduce e poi parla. O meglio sussurra, in pieno stile sacrale: «La voce è quella della persona che l’ha creato. Ovviamente modificata attraverso strumenti audio per mascherarla e renderla più divina».
Lo hanno sperimentato in 900 persone, tra cui musulmani e turisti arrivati dall’Asia, dall’America. «Abbiamo avuto 250 recensioni e il 60% lo considera un’esperienza spirituale». C’è anche chi l’ha visto valicare il confine tra sacro e profano: «Per i cattolici il problema era che tutto si svolgesse nel confessionale, mentre non se la sono presa con la scelta di Gesù come avatar. Sono abituati a vederlo ovunque, per i protestanti però sembrava quasi blasfemo». Ma le velleità trascendentali della tecnologia vanno spesso in cortocircuito davanti ai dilemmi etici. Per il professore di etica Peter Kirchschläger «dovremmo fare attenzione quando si tratta di fede. La cura pastorale è un’area in cui gli esseri umani sono superiori alle macchine». A volte, invece, la qualità del tool non bilancia le aspettative: «Le risposte erano banali, ripetitive, trasudavano una saggezza da cliché», è stato il commento di un giornalista locale.

Lo «scontro tra progressisti e conservatori» resta un tran tran anche nel mondo ecclesiastico, «ma so che dal Vaticano hanno apprezzato», è la certezza di Schmid, prima di proiettarsi verso le prossime sfide del binomio religione-tecnologia. «C’è tanta gente che si fa aiutare dall’intelligenza artificiale, la usa per la psicoterapia. Anche in quel caso fa sentire meglio le persone, perché per i praticanti non può avere lo stesso effetto di speranza un avatar? Dobbiamo essere presenti, come Gesù nelle vite dei fedeli». È il verbo che cambia tempo. E passa al futuro. ■

1. L'avatar Deus in Machina visto nel confessionale
2. Il confessionale della cappella di San Pietro

Voci in libertà nei programmi notturni di Radio Kaos Italy
Un progetto libero e inclusivo che esplora il confine tra musica, arte e confessione mediatica
di Rosita Laudano
«Nel cuore del quartiere Tiburtino, a Roma, una vetrina insolita cattura l’attenzione dei passanti lungo via Eugenio Torelli. Qui, Valerio Del Pelo, Rocco Foggia, Daniele Fasanella e i loro collaboratori hanno dato vita a uno spazio radiofonico che ha saputo ritagliarsi un ruolo di rilievo nell’ambiente delle web radio romane e nazionali. Con una programmazione variegata, Radio Kaos Italy si rivolge in particolare alle realtà alternative, urban e underground della scena musicale, ospitando artisti di rilievo e dando voce a nuovi talenti.
Radio Kaos Italy, come racconta Rocco sorridendo, deve il suo nome all’omonima emittente del film Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia. Il progetto, fondato nel 2009 da Antonio Ricci (detto “Drastiko” per distinguerlo dall’omonimo autore televisivo), è stato rilevato dal team attuale nel 2021. «Ha sempre avuto un asset molto indipendente, solidale, caotico, inclusivo» spiega Valerio, sotto -
lineando la natura fluida e sperimentale della programmazione. Nel corso degli anni, la radio ha ospitato artisti del calibro di Tommaso Paradiso, la prima intervista di Ultimo e l’ultima intervista a Bugo prima del suo ritiro dalla scena musicale. Una missione, la loro, che accetta i rischi di un progetto indipendente: «Ognuno autofinanzia il proprio programma, senza la pretesa di ottenere risultati immediati. Il nostro punto di forza è la libertà di innovare, senza pressioni commerciali» spiega Rocco. «Siamo una radio libera, non schierata politicamente, ma aperta alla sperimentazione».
L’obiettivo è quello di far convivere diverse realtà e generi, dando spazio a voci emergenti e a discussioni fuori dagli schemi. «La musica e l’arte sono liquide», afferma Rocco citando Bauman, «e in questa epoca liquida bisogna mescolare influenze e prospettive diverse». Tuttavia, la libertà d’espressione può diventare un’arma a doppio taglio. «Il media
FREQUENZE

radiofonico si presta alla condivisione spontanea, a volte imprevedibile. Il detto e il non detto sono due facce della stessa medaglia», riflette Valerio.
Ma nell’epoca dei social media, c’è ancora qualcosa da svelare o è già tutto allo scoperto? «Quando è successo, abbiamo rischiato anche troppo» sorride Valerio. «Non c’è un limite netto alla libertà di parola» aggiunge Rocco, citando Pasolini: «Tutti ci autocensuriamo quando sappiamo di essere ascoltati».
Gli ospiti, sia emergenti che affermati, si sono spesso lasciati andare a rivelazioni inattese. Tuttavia, il collaboratore Eliseo sottolinea un aspetto interessante: «Le vere confessioni avvengono quando i microfoni sono spenti». Il confine tra il detto e il taciuto resta quindi sottile e ambiguo. Tra le interviste più sorprendenti, il team ricorda quella a Ilona Staller (in arte Cicciolina), che in diretta rivelò il nome di un insospettabile compagno di set mai reso pubblico.
Luca Ravenna, stand-up comedian, invece, si lasciò sfuggire la sua antipatia per una casa di produzione. Un’altra dichiarazione inaspettata fu quella di Metal Carter, rapper italiano, che chiarì un equivoco storico nella scena hip-hop: il TruceKlan, secondo lui, era solo un allargamento dei TruceBoys e non un’unione con il gruppo In The Panchine. In un panorama mediatico dominato dai social e dal clickbait, la radio riesce ancora a portare alla luce contenuti inediti? «In un
incubatore come il nostro, è difficile controllare ciò che esce» ammette Rocco.
«Quando viene usata una parola che viola il rispetto reciproco, bisogna prendere le distanze». Il tema del politicamente corretto è centrale nell’esperienza della radio: «Abbiamo dovuto affrontarlo spesso, arrivando anche a sanzionare ospiti che si sono dimostrati irrispettosi» racconta Rocco. «Se parliamo al microfono, non possiamo far finta che certi temi non esistano. Bisogna saper dialogare con intelligenza e sensibilità».
Un episodio emblematico è legato allo stand-up comedian Giorgio Montanini, che durante un intervento in radio usò un termine molto forte. «Una parola può essere offensiva in modi che non possiamo prevedere. Bisogna scegliere un linguaggio pulito e consapevole» osserva Valerio. «Anche la comunicazione è un’arte, e merita attenzione quanto la musica».
La libertà di espressione, dunque, va bilanciata con la responsabilità. «Nei media si possono dire molte cose che nella vita quotidiana non si direbbero, ma bisogna farlo con cognizione di causa. Oggi il clickbait è spesso spacciato per libertà,
ma non è la stessa cosa». La spontaneità della radio può portare a momenti delicati, come quando un ospite decise di rivelare il proprio orientamento sessuale in diretta. «A differenza dei social, dove un post può essere cancellato, una dichiarazione in radio rimane nella memoria di chi ascolta» spiega Valerio. «Per questo la scelta degli ospiti deve essere sempre ponderata».
Radio Kaos Italy è una realtà che riflette il desiderio di spazio e visibilità di una nuova scena musicale e artistica. Con il suo spirito indipendente, rappresenta una controcultura inclusiva e necessaria nel panorama contemporaneo. Allo stesso tempo, la sua esperienza solleva interrogativi interessanti sul ruolo della radio oggi: il media tradizionale può ancora offrire qualcosa di autentico in un’epoca in cui tutto sembra già condiviso? Confessarsi non è più una pratica religiosa ma il rito che preferiamo nell’epoca della società dello spettacolo. ■


Blue Whale la challenge mortale
SFIDA Per bambini e bambine era un innocuo gioco online. Partito dalla Russia, spinse giovani vite a commettere il suicidio
stata adescata facilmente» ha aggiunto la madre.
Questo episodio ha acceso il dibattito su come proteggere i giovani dai pericoli online. «Quando ho affrontato il problema di queste ragazze, ho parlato con i genitori. Si parte sempre dalla famiglia» spiega Brocchini. Ma non basta: «Bisogna insegnare ai ragazzi a riconoscere la manipolazione online. Se i media ingigantiscono un fenomeno, poi i ragazzi lo alimentano a loro volta».
La Blue Whale Challenge, nata come un fenomeno oscuro sui social, ha mostrato il lato più pericoloso della tecnologia, spingendo giovani fragili verso sfide sempre più estreme fino al suicidio. Diffusasi dalla Russia nel 2016, la challenge prevedeva 50 giorni di prove assegnate da misteriosi “curatori”. «Le sfide iniziavano in modo innocuo, ma diventavano sempre più pericolose, fino al controllo totale della volontà della vittima» spiega il dottor Lorenzo Brocchini, psicologo esperto dei pericoli del web.
Brocchini ha raccontato un episodio avvenuto in una scuola delle Marche: «Una ragazzina si era autoproclamata esperta di Blue Whale e diceva ad altri tre ragazzi di fare dei tagli, stare svegli di notte, guardare film horror. Quando ho approfondito, ho scoperto che era un gioco tra ragazzine. Non si rendevano conto della gravità di quello che facevano».
Lo psicologo ha poi criticato l’allarmismo mediatico: «Il servizio delle Iene ha
introdotto il fenomeno Blue Whale in Italia basandosi su casi inesistenti. Ha descritto il fenomeno come un'organizzazione legata a un ragazzo russo, ma le prove erano false: le immagini mostrate riguardavano suicidi non collegati alla Blue Whale». Secondo lui, l’attenzione dei media ha contribuito a diffondere il fenomeno, «Più se ne parla in modo allarmistico, più si rischia di dargli forza».
Un caso concreto è avvenuto a Fiumicino, dove una ragazza di 15 anni, Sarah (nome di fantasia), è stata salvata grazie alla segnalazione di un’amica online. La madre ha raccontato ad Adnkronos: «Il telefono ha squillato all’alba. Un poliziotto mi ha informata che mia figlia era nel gioco della Blue Whale. Non ne avevo mai sentito parlare. Anche quattro sue amiche stavano partecipando e avevano già superato il ventesimo giorno di sfida».
La ragazza stessa ha confermato. «Quello che è successo a mia figlia può accadere a chiunque. Lei è fragile ed è
Il caso della Blue Whale Challenge ha dimostrato che la tecnologia può essere un’arma di condizionamento psicologico. «Internet offre infinite possibilità, ma può anche sfruttare le vulnerabilità di chi non ha ancora sviluppato difese adeguate» conclude Brocchini. ■

di Sara Costantini
Il programma dove i politici «diventano umani»
INTERVISTA
«Molti arrivano preoccupatissimi», Giorgio Lauro racconta Un giorno da pecora
di Luca Graziani
Dopo Porta a porta, c’è chi lo definisce la "quarta camera" della politica italiana. Giorgio Lauro, insieme a Geppi Cucciari, dal 2009 è al timone del programma cult in onda su Rai Radio1.
Perché i politici vengono a Un giorno da pecora?
Credo che siano talmente stufi di parlare di politica che l'idea di occuparsi d'altro li faccia felicissimi. Parlare di costume, dei loro racconti, di come si vestono a Carnevale, di come erano da bambini, del tifo, del calcio. Gli dà una boccata d’ossigeno, li libera, li fa diventare umani. Mettono in mostra le loro capacità, cantano, raccontano barzellette, fanno cose che esulano dal loro ruolo. È come se entrassero nel mondo dello spettacolo.
I suoi ospiti preferiti?
Ci sono quelli storici, Nardella che suona il violino, Gasparri che compone poesie. Ultimamente si è aggiunto Crisanti. Ora è senatore, uno scienziato che vive fuori dal mondo, un personaggio straordinario. Ma anche Mulè che improvvisa canzoni o Siracusano, il sottosegretario per i rapporti col Parlamento che canta benissimo. Il viceministro alla Giustizia Sisto, quando viene da noi gli facciamo le domande e risponde suonando la tastiera, ha l'orecchio assoluto. C'è tutto un gruppo di artisti prestati alla politica.
Quelli più difficili da trascinare?
Maria Elena Boschi, l’anno scorso per la prima volta l’abbiamo raggiunta al telefono per il suo compleanno. D’Alema e Carfagna non sono mai venuti, nemmeno Draghi e Mattarella. Meloni? Tornerà certamente. Abbiamo fatto il primo compleanno da presidente del Consiglio in diretta, quest’anno credo fosse ad Abu Dhabi. È un modo per avvicinarli, funziona sempre. Il nostro format è col doppio registro, facciamo delle domande di politica anche molto serie, magari con un tono leggermente più dialogante.

I politici abbassano le difese da voi?
Molti arrivano preoccupatissimi. Mi farà cantare? Mi chiederà questo? Si aspettano sempre la domanda a trabocchetto, ma la puntata è lunga, dura un'ora e mezza, con il tempo si sciolgono. L’atmosfera cordiale li porta a raccontare le cose in modo un po' più informale rispetto al classico talk show.
Vi hanno mai chiesto le domande in anticipo?
Può succedere che magari qualcuno dica di avere un problema su un certo argomento. La nostra policy è che un paio di domande le facciamo, poi uno risponde come vuole.
Qualcuno che se l'è presa?
Una volta Laura Ravetto si arrabbiò. Usci dallo studio e se ne andò, per poi tornare un attimo dopo perché aveva dimen-
ticato la borsetta. Ma non è mai successo che un ospite si sia infastidito più di tanto, c'è sempre un clima al limite della presa in giro, dello scherzo.
La dichiarazione che ha avuto più eco?
Quando il barista di Draghi ci raccontò che la moglie gli aveva detto: «Adesso andiamo al Quirinale, quindi non ci vedremo più per un po’». Da lì scoppiò l’inferno perché l’ex premier intervenne ma non smentì la notizia, gli abbiamo rotto le castagne nel fuoco. Ci sono alcuni personaggi che conservano dei piccoli segreti di vita quotidiana, possono essere molto interessanti. Come il parrucchiere della premier Meloni. Anche lì uscì una notizia, ci disse: «Devo andare a farle i capelli perché domani va a giurare». ■
Giorgio Lauro e il comico Enzo Iacchetti
1. Il conduttore

Tra fede e psicologia la nuova frontiera del privato
Viviamo la nostra
vita su internet e app e affidiamo loro anche le nostre informazioni più sensibili, senza renderci conto del rischio
È il pomeriggio dell’11 marzo 2024, 123 milioni di spettatori sono sintonizzati sull’Allegiant Stadium nel Nevada. È il Super bowl, la finale del campionato della National Football League, l’evento sportivo più importante per gli americani. L’equivalente del nostro festival di Sanremo qui e gli spot pubblicitari trasmessi devono essere la continuazione dello spettacolo non la sua interruzione.
di Valeria Costa
Nel 1984 Apple chiese aiuto al regista Ridley Scott per pubblicizzare il suo Macintosh, ispirandosi al libro 1984 di George Orwell. Nove anni dopo la Nike ha ingaggiato Michael Jordan e quest’anno gli attori Billy Crystal e Meg Ryan hanno ricreato una delle scene più famose di Harry ti presento Sally per pubblicizzare la catena di fast food Hellmann’s. Per conquistare uno slot servono migliaia di dollari e nel 2024 tre giovani ragazzi, Alex Jones, Erich Kerekes e Alessandro DiSanto, se ne sono accaparrati uno. Nel
loro spot si vede l’attore Mark Wahlberg che invita tutti ad unirsi e pregare con lui. Cosa pubblicizza? “Hallow” l’app che Jones, Kerekes e Di Santo hanno creato nel 2008, “l’app di preghiera numero uno al mondo”. Tra le sue funzionalità c’è quella di ascoltare canti gregoriani, dire il rosario, ascoltare letture divine o fare “sfide religiose” contro gli altri utenti, ad esemio nel compiere opere di bene. Si tratta di una versione religiosa delle classiche app per prendere sonno o meditare.
È la nuova frontiera del privato, che adesso diventa sempre più pubblico. E non solo nel vivere la propria religiosità su piattaforme e social, ma anche nel miglioramento personale. Prima esistevano gli audiolibri motivazionali che ti spingevano a cambiare stile di vita quando non eri soddisfatto del tuo, adesso ci sono app come “Liven” che propone «un mood tracker che agisce come uno stretto confidente che ascolta e capisce i

tuoi sentimenti mentre offre consigli» o “Mindvalley” che promette «Una migliore versione di te ogni giorno».
Utili o meno, una cosa è certa: tutte, ma proprio tutte, hanno una cosa in comune: entreranno in possesso dei tuoi dati, un po’ perché siamo noi utenti stessi a dare il consenso all’inizio e un po’ perché il nostro comportamento sulle piattaforme è registrato. Da questo «gli algoritmi riescono ad inferire caratteristiche sensibili dell’individuo», come ci ricorda Marco Delmastro, Direttore del Servizio economico-statistico dell’Agcom e coautore di “Big data come stanno cambiando il nostro mondo”.
La questione è anche più complessa perché «noi abbiamo quest’idea di razionalità che gli stiamo cedendo dei dati in maniera più o meno consapevole. Ma in realtà molte volte la maggior parte dei dati che cediamo non è consapevole». Tutto ciò che ci sembra conveniente perché fatto a costo zero per noi, in realtà ha un prezzo: le nostre informazioni personali «Tutto ciò che è gratis non è mai gratis, perché queste sono imprese commerciali che ci devono fare del profitto, quantomeno ci devono coprire i costi» aggiunge Delmastro.
Il meccanismo non vale solo per le applicazioni, ma anche in qualsiasi sito navighiamo, persino in quelli di psicologia online come “Serenis”, “Unobravo” e “Psicologo 4U” in cui i dati che cediamo all’inizio sono di per sé già sensibili. Nei questionari iniziali che sottopongo dobbiamo dire ad esempio: quante volte e in
che occasioni proviamo ansia, se abbiamo problemi con il nostro corpo o il cibo, oppure problematiche legate alla sfera sessuale o ancora se abbiamo sviluppato dipendenze. Psicologo 4U addirittura preferisce intanto assicurarsi la tua mail prima ancora di rispondere alle domande, cosicché se dovessi cambiare idea durante il questionario o subito dopo saresti comunque registrato nei loro server.
«Non siamo neanche consapevoli di quali dati stiamo cedendo»
Certo è anche vero che «ci sono siti che hanno dati più sensibili, però magari li “sanno usare” meno e sono meno pericolosi e siti che li "sanno usare" meglio e riescono a inferire caratteristiche molto sensibili, che una persona non pensa di aver trasmesso, ma che un algoritmo può desumere da semplici dati stupidissimi». Il problema però rimane: le piattaforme sono assetate di dati, perché questi sono poi trasformati in remunerativi prodotti, che permettono di predire il comportamento delle persone e per questo motivo le società li vendono alle «aziende che operano nel mercato dei comportamenti futuri, i loro veri clienti».
A dirlo è Shoshanna Zuboff nel suo libro più famoso, “Il capitalismo della Sorveglianza”, è sempre lei a raccontarci come questo meccanismo è nato, a partire dallo scoppio della bolla finanziaria dot.com all’inizio del Duemila. Il motore di ricerca più famoso al mondo Google riusciva già dalla sua fondazione a racco -

gliere una innumerevole quantità di dati, ma fu un neolaureato di Stanford, Amit Patel a comprendere che da questi dati collaterali, sottesi ad ogni azione online si poteva arrivare alle storie dettagliate di ogni utente. Prima dello scoppio della bolla, Google era contraria anche al semplice advertising, ma mors tua, vita mea e messa davanti alla scelta se fallire o sopravvivere, la società americana ha scelto la seconda. Con le capacità di Google il settore pubblicitario riusciva a raggiungere ciò che aveva sempre voluto ottenere: inviare un determinato messaggio a una determinata persona al momento giusto e con una elevata probabilità di influenzare il suo comportamento.
È ciò che la studiosa Zuboff chiama “capitalismo della sorveglianza” per le sue implicazioni economiche e sociali, il cui fine ultimo è modificare i comportamenti degli utenti in modo da raggiungere il maggior grado di certezza possibile, sia esso a fini economici che elettorali e politici. Alla base ci sono la volontà di profitto delle aziende tech e la nostra scarsa consapevolezza sul valore che i dati hanno.
Per il filosofo bielorusso Evgenij Morozov il problema è filosofico ancor prima che legislativo, motivo per cui, lasciare il problema delle privacy alle direttive sulla conservazione dei dati è stato un pensiero miope e ingenuo da parte dei politici europei. In “Silicon Valley, i signori del Silicio” Morozov scrive che la mercificazione che sta avvenendo non è contro la nostra volontà ma è ciò che noi comuni cittadini-consumatori desideriamo. «Solo l’attivismo politico e una solida e ragionata critica all’ideologia del consumismo dell’informazione, ci permetteranno di evitare l’inevitabile». ■


Il segreto professionale tra etica e responsabilità
DEONTOLOGIA
La riservatezza
di penitenti e pazienti mette in luce le sfide morali e giuridiche nella gestione delle informazioni sensibili da parte dei professionisti
Nel vasto panorama dei mestieri che implicano il rapporto con la coscienza umana, poche figure sono chiamate a confrontarsi con il concetto di segreto professionale quanto i sacerdoti e gli psicologi. Entrambi hanno accesso alle confessioni più intime delle persone, ma mentre il sigillo sacramentale è considerato assoluto e inviolabile, gli psicologi devono bilanciare la riservatezza con il dovere di tutela nei confronti della società.
Le differenze tra le due categorie nei confronti della giustizia emergono quando queste figure vengono a conoscenza di informazioni sensibili da parte di penitenti e pazienti. I limiti e le implicazioni, morali e legali, variano in modo significativo.
un crimine grave. Come sottolineato da don Michele Aramini, prete teologo morale della Diocesi di Milano, «il sacerdote agisce come un ministro in persona Christi, non come un giudice umano, e il sacramento della riconciliazione è visto come un atto sacro tra l’uomo e Dio». Le motivazioni dietro questa regola sono molteplici. La Chiesa sostiene che la confessione sia uno spazio di libertà assoluta che permette al penitente di aprirsi senza paura di conseguenze terrene. «Se il sacerdote potesse rivelare ciò che ha ascoltato, molte persone rinuncerebbero a confessare i propri peccati, privandosi del perdono e della possibilità di redenzione». Il segreto confessionale incarna la sacralità e impedisce che la Chiesa venga percepita come un braccio dello Stato piuttosto che come un’istituzione spirituale.
di Caterina Teodorani
La Chiesa cattolica ha una posizione chiara e intransigente: nessun sacerdote può rivelare ciò che ha ascoltato in confessione, nemmeno per prevenire
Nonostante questa rigidità, don Aramini sottolinea che il sacerdote non è del tutto impotente: «Pur non potendo
rivelare nulla, può esortare il penitente a costituirsi, offrirgli supporto morale o invitarlo a parlare al di fuori del contesto sacramentale, dove il segreto non avrebbe più valore». Tuttavia, la decisione ultima spetta sempre al penitente e il prete non può in alcun modo forzarlo o tradire la confidenza ricevuta.
Questa posizione ha spesso creato conflitti con le legislazioni nazionali. In alcuni Paesi, come l’Australia e la Francia, sono state proposte leggi che obbligherebbero i ministri del culto a denunciare crimini gravi, quali gli abusi su minori, ma la Chiesa ha ribadito che nessuna legge umana può prevalere. «Alcuni sacerdoti hanno scelto di affrontare processi legali pur di non violare il segreto, mentre in altre situazioni si è cercato un dialogo con le istituzioni per trovare soluzioni rispettose di entrambi gli ordinamenti», così racconta don Aramini.
A differenza dei sacerdoti, gli psicologi operano in un contesto in cui il segreto professionale ha delle deroghe ben precise. Il codice deontologico prevede che il professionista sia tenuto alla riservatezza, ma vi sono circostanze in cui è obbligato a violarla. Ad esempio, se uno psicologo viene a conoscenza di un pericolo imminente per la vita di qualcuno (come un paziente che minaccia il suicidio o la violenza su terzi), ha il dovere legale ed etico di segnalare la situazione alle autorità competenti. Questo principio si basa sul bilanciamento tra la tutela della privacy del paziente e la necessità di prevenire danni irreparabili all’incolumità personale o alla società.
Un altro aspetto riguarda i minori. Se uno psicologo sospetta che un bambino sia vittima di abuso, in molti paesi è obbligato per legge a segnalarlo ai servizi sociali o alle forze dell’ordine. L'obbligo nasce dalla priorità data alla protezione dei più vulnerabili, anche a costo di violare la fiducia del paziente. Secondo la psicologa Annamaria Casale, «non si tratta di una violazione arbitraria del segreto professionale, ma di un dovere etico che pone al centro la sicurezza delle persone coinvolte. La tutela della vita e del benessere psicologico non può mai essere secondaria rispetto alla riservatezza».
Inoltre, Casale evidenzia un altro elemento distintivo del lavoro suo e dei colleghi: «A differenza del sacerdote, lo psicologo può avvalersi del confronto con altri professionisti per gestire situazioni complesse, nel rispetto del codice deontologico. Questo permette di affrontare dilemmi etici con maggiore consapevo -
lezza e responsabilità». Se da un lato il segreto confessionale è assoluto, quello degli psicologi è relativo e subordinato alla tutela della sicurezza pubblica.
Questa differenza si fonda sulla diversa natura dei due ruoli: il sacerdote agisce in un contesto sacramentale e spirituale e funge da mediatore tra cielo e terra, mentre lo psicologo opera in un ambito terapeutico e scientifico. Il segreto professionale degli psicologi non è legato a una dimensione trascendentale, bensì alla fiducia del paziente nella relazione terapeutica. Tuttavia, questa fiducia non può prevalere sulla necessità di prevenire un danno grave e immediato.
Don Aramini sottolinea che questa distinzione è essenziale: «Mentre per lo Stato il crimine è un atto punibile, per la Chiesa il peccato ha una dimensione spirituale che va oltre la giustizia umana. La confessione non è un atto giudiziario, ma un momento di incontro tra l’uomo e Dio, e il sacerdote non ha il compito di proteggere la società quanto piuttosto di guidare il penitente verso la conversione». Sacerdoti e psicologi operano su pia-
ni distinti, ma entrambi devono affrontare dilemmi etici profondi. Il primo è chiamato a custodire un segreto assoluto, con la consapevolezza che alcune verità terribili non potranno mai essere rivelate.
Il secondo, invece, deve gestire la riservatezza con maggiore flessibilità, trovando un equilibrio tra il diritto del paziente alla privacy e il dovere di proteggere la società. Secondo Annamaria Casale, «il segreto professionale non è solo una regola, ma una responsabilità che richiede discernimento e sensibilità. Ogni caso va valutato con attenzione per garantire che nessuno subisca conseguenze irreparabili».
Entrambe le figure portano il peso delle confidenze ricevute, con la differenza che il sacerdote trova conforto nella fede e nella preghiera, mentre lo psicologo può confrontarsi con colleghi e supervisori. In un’epoca in cui la trasparenza sembra essere un valore sempre più richiesto, la questione del segreto professionale continua a essere un nodo cruciale nel rapporto tra etica, legge e morale. ■


Oltre la porta del Guru viaggio nella gurdwara di Londra
La storia del sikhismo e della comunità britannica attraverso il racconto dei volontari del tempio. «Lavorare, pregare e condividere: i nostri principi»
In punjabi, seva significa "sacrificio disinteressato" ed è un principio cardine della cultura sikh: impegnarsi, offrire il proprio lavoro e dedicarsi agli altri senza aspettarsi nulla in cambio. A spiegarlo è Tyron, che lavora come addetto alla sicurezza nel principale tempio sikh di Londra. Si tratta di una comunità religiosa del Punjab, uno stato nel nord-ovest dell'India, molto diffusa all’estero a causa delle tensioni politiche e religiose locali.
Qui sorge una delle più grandi gurdwara al di fuori dell’India e la principale di Londra. Si chiama Gurdwara Sri Guru Singh Sabha, inaugurata nel 2003. La parola gurdwara deriva dal punjabi e significa letteralmente “porta del Guru”, il maestro.
di Lisa Duso
In Europa, la maggiore presenza si registra in Inghilterra. Arrivando con la linea color viola di Elizabeth Line, la prima cosa che colpisce sono le insegne della stazione nel quartiere periferico di Ealing, il loro punto di riferimento, dove la scritta “Southall” è accompagnata da una traduzione in punjabi. Questo quartiere, infatti, è noto come “Little India” o “Little Punjab”, per la forte presenza della comunità asiatica.
Superate la scalinate d’ingresso, ci sono due entrate: a destra per le donne e a sinistra per gli uomini. All’entrata Manohar, 72 anni, sta aspettando un gruppo di studenti: lui è un volontario della Gurdwara e si occupa di lezioni agli studenti. «Quando entri, bisogna lavarsi le mani, coprire il capo ed entrare scalzi», spiega.
Manohar è accompagnato dalla moglie, Majilit. Anche lei è una volontaria nel tempio: aiuta in cucina e, in un’altra gurdwara, insegna punjabi la domenica. Majilit ha 69 anni e da quando tre anni fa è andata in pensione si impegna nel vo -
INDIA
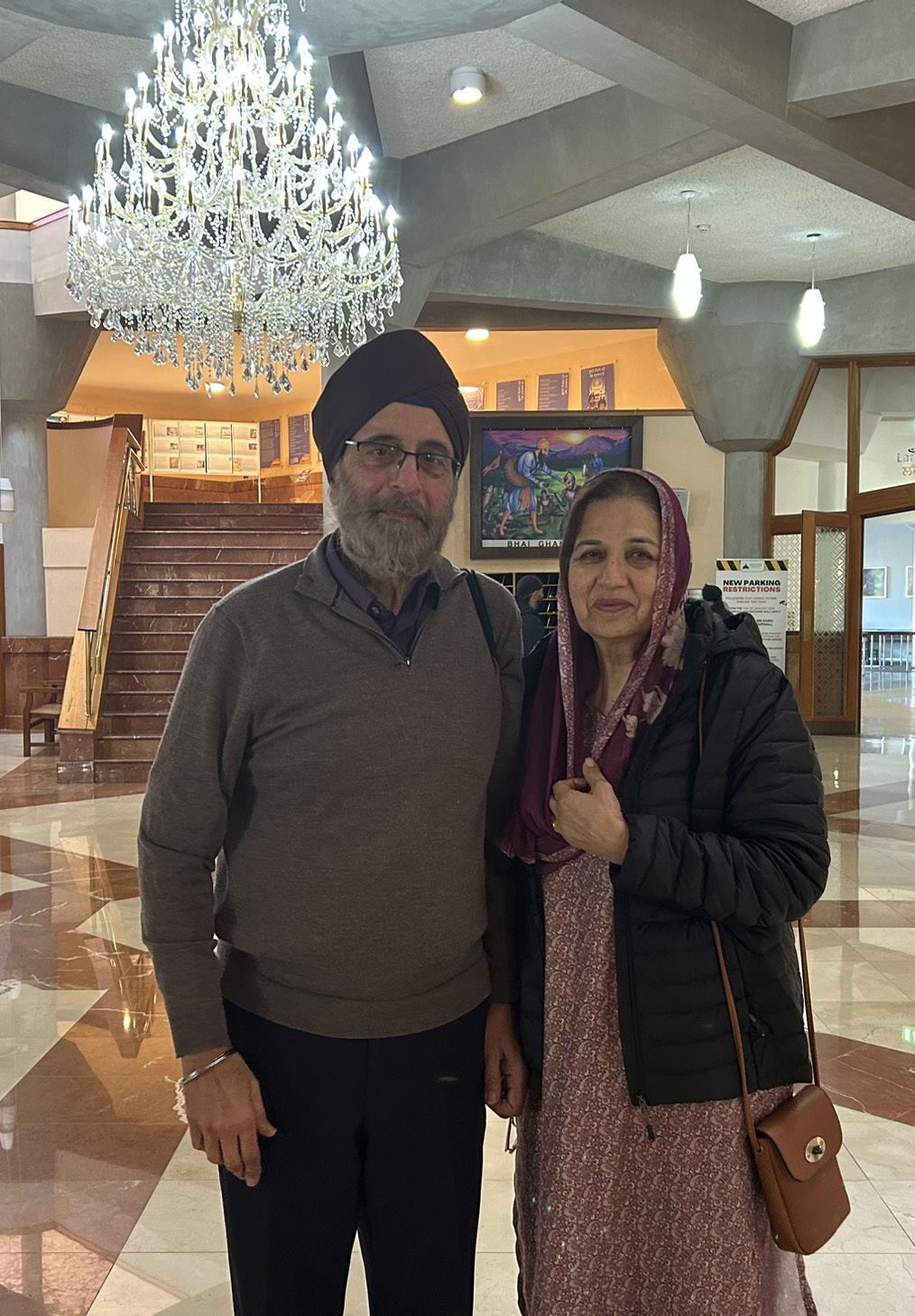
lontariato all’interno della comunità. «Il sikhismo si basa su tre principi: lavorare sodo, pregare e condividere», spiega.
Manohar e Majilit vengono dall’Uganda, dove molti sikh tra il 1800 e il 1900 erano stati spostati dai coloni britannici per la costruzione della ferrovia Uganda-Kenya. Tra questi c'era il padre di Manohar, trasferitosi nello stato africano nel 1940. Nel 1972, il dittatore ugandese Idi Amin espulse i sikh e altre comunità asiatiche, accusandoli di controllare l'economia del paese. Molti, provvisti del passaporto britannico, si rifugiarono nel Regno Unito e in Canada. Fu allora che Majilit seguì Manohar a Londra, dove lui studiava. Qui hanno costruito una nuova vita e una famiglia, senza mai dimenticare le proprie origini.
In tarda mattinata la scolaresca arriva e inizia il tour, alla scoperta dei corridoi della gurdwara e della religione sikh. «I bambini vengono per imparare i fondamenti del sikhismo», racconta la maestra Sanah. «Insegniamo loro a comparare le religioni, a riconoscere somiglianze e differenze per imparare il rispetto». Gli alunni, a cui sono stati fatti indossare dei giubbini catarifrangenti gialli, vengono poi portati verso le cucine.
«Insegniamo ai bambini a comparare le religioni, a riconoscere somiglianze
e differenze per imparare il rispetto»
Qui c'è il langar, la mensa comunitaria dove il cibo viene distribuito gratuitamente ogni giorno grazie al lavoro dei volontari. Alcune cuoche preparano il chapati, pane dalla forma piatta e circolare. Altri si occupano della cottura del daal, la zuppa di lenticchie con il curry piccante, e della preparazione del the.
Passando per il langar, i ragazzi camminano accanto ai commensali che siedono su tappeti davanti al proprio vassoio. «Qui anche se sei un re ti siedi con gli altri», spiega Manohar. Salendo le scale si arriva alla sala principale, dove si recitano le sacre scritture, e vengono intonati i canti religiosi.
Nella stanza di fronte, Manohar rivela ai bambini i principi del sikhismo. Nato nel 1469 con Guru Nanak, si tratta di una religione relativamente giovane rispetto ad altre come l'induismo o il cristianesimo. «I sikh riconoscono dieci Guru, cinque dei quali morirono per difendere il loro popolo. La storia della religione è segnata da martiri che hanno sacrificato la propria vita per proteggere gli altri».
Guru Nanak fu il fondatore del sikhismo e il primo dei Guru; fu lui inoltre ad insegnare i tre principi fondamentali della religione: lavorare onestamente, pregare e condividere con gli altri. «Sono cinque gli elementi che caratterizzano il credente sikh», continua Manohar: «Il primo è il kesh, ossia lasciar crescere i capelli e raccoglierli nel turbante, che è come una corona che si può indossare in qualsiasi momento».
Il sikhismo voleva infatti andare oltre le separazioni di casta imposte dall’induismo. Gli altri quattro simboli sono un piccolo pettine di legno, un bracciale di ferro, un particolare indumento intimo e un pugnale, «perché i sikh combattono per gli altri, per aiutarli».
Un altro fattore importante del sikhismo è la credenza nel karma. «Immaginate di guadare un fiume e di avere tutte le cose buone nel remo destro e quelle negative in quello sinistro», è l'immagine di Manohar. «Anche volendo usare solo il remo delle cose buone non si potrebbe arrivare dalla parte opposta, perché la vita richiede bilanciamento. Questo ti fa anche apprezzare di più i momenti difficili della vita, che comprendi essere necessari».
Al termine della visita Manohar riaccompagna il gruppo al piano terra, dove reincontra Tyron. È lui a spiegare che la loro gurdwara non si occupa solo della comunità locale, ma fornisce anche aiuti concreti all’esterno. «Noi sikh siamo solo il 3% della popolazione mondiale, ma il nostro dovere è aiutare chiunque», afferma Tyron. «Oltre a garantire la sicurezza del tempio, inviamo cibo e supporto logistico alle chiese locali. La gurdwara è aperta a tutti, ogni giorno dalle 5 del mattino alle 9 di sera. Chiunque si trovi in difficoltà può venire qui per ricevere un pasto o un aiuto» conclude, mentre si riavvia verso il suo ufficio accompagnato dai canti religiosi che risuonano in tutto il tempio. ■


«Il mio velo, la mia scelta»
Tasnim si racconta su Instagram
ISLAM
Con la sua voce l'influencer spiega cosa significa essere una donna musulmana in Italia, tra preghiera, stereotipi e libertà
«A scuola, sul lavoro, sui social. Da sempre sento di dover spiegare la mia fede. Non è un peso, ma una costante». Tasnim Ali, 26 anni, nata ad Arezzo da genitori egiziani, vive a Roma con il marito e la figlia Talia. Su Instagram, dove conta più di 200.000 follower, racconta l'Islam con l'obiettivo di smontare stereotipi e pregiudizi.
capire chi sei davvero», racconta. Di episodi spiacevoli ne ha affrontati tanti: «Commenti in strada, sguardi giudicanti, qualche battuta fuori luogo, persino situazioni lavorative dove mi è stato chiesto di togliere il velo. Non lo vivo con vittimismo, ma è una realtà che purtroppo esiste».
di Elisa Vannozzi
Indossare il velo, conciliare il culto islamico con la società sono temi che affronta ogni giorno sul suo profilo, dove risponde con naturalezza alle domande di chi la segue. «Essere una donna musulmana in Italia è una sfida e una responsabilità. Ti osservano, magari ti giudicano prima di conoscerti, ma hai anche l'opportunità di far
Instagram le permette di raccontarsi senza filtri. La sua vita non si discosta da quella di tante altre giovani donne: studia, lavora, cresce la sua bambina. «Mostrare la mia quotidianità aiuta a far capire che una ragazza musulmana è semplicemente una ragazza, con sogni, passioni e normalità». Ma il confronto non è sempre facile. «Se c'è curiosità sincera, rispondo con piacere.

Se percepisco malizia o provocazione, scelgo l'ironia». Commenti carichi di insulti si leggono spesso sotto i suoi post. «A volte manca la conoscenza. Non tutti sanno cosa sia l’Eid, la festa per la fine del digiuno del Ramadan, o che esistono momenti di preghiera durante la giornata. Spiegare in continuazione può stancare, ma serve» racconta Tasnim. «Poi c’è il tema del velo, che è ancora percepito come qualcosa di strano o problematico».
Le critiche occidentali spesso lo considerano un’imposizione anziché una scelta personale e spirituale, perché lo vedono attraverso la lente della sottomissione femminile. «Chi non sa, giudica solo attraverso stereotipi mediatici» spiega. Il suo obiettivo non
è convincere, ma mostrare una realtà diversa da quella narrata da chi associa la religione islamica solo ai regimi oppressivi. «Una visione di rispetto e dignità. L'Islam riconosce diritti e valore alle donne. Purtroppo, alcuni Paesi con culture patriarcali, che si definiscono islamici, ne hanno distorto l’immagine». Il dibattito si riaccende ogni volta che in questi territori si verificano episodi di repressione delle donne, come in Iran, dove è nato il movimento "Donna, vita, libertà".
Migliaia di persone scesero in piazza dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata a Teheran e assassinata dalla polizia morale per non aver indossato correttamente l'hijab. Tantissime ragazze iniziarono a filmarsi mente tagliavano i capelli o bruciavano il loro velo in segno di protesta.
Per Tasnim nessuno dovrebbe essere costretto a indossare l’hijab, come neanche a toglierlo. La fede è per lei un pilastro, una guida nelle scelte di tutti i giorni: «La mia religione mi ha insegnato a scegliere con consapevolezza, a rispettarmi e a seguire i valori in cui credo anche quando il contesto attorno spinge in direzione opposta. Io, come musulmana, mi sento valorizzata e libera». La famiglia è la sua radice, un porto sicuro. «Grazie ai valori trasmessi dai miei genitori, oggi sono fiera di chi sono».
L’organizzazione e la trasparenza sono i mezzi per conciliare la vita lavorativa e sociale con la pratica islamica. «Spiego ad amici e colleghi
quali sono le mie esigenze, ma senza isolarmi. È un equilibrio continuo, ma è possibile se c’è rispetto reciproco». L’aspetto più rassicurante è «la preghiera quotidiana, il mio momento di pace» racconta. «Qualunque cosa succeda nella giornata, so che posso fermarmi, pregare in ogni momento e ritrovare la calma, per ricordarmi che c’è sempre un disegno più grande».
«La mia religione mi ha insegnato a scegliere con consapevolezza. Io, come musulmana, mi sento valorizzata e libera»
Lo scopo di Tasnim sui social è aprirsi all’altro, per trasmettere un messaggio tramite il dialogo. Alla domanda su cosa vorrebbe far conoscere dell'Islam, risponde senza esitazioni: «Che è una religione che invita all'equilibrio e al rispetto. Non un insieme di divieti e punizioni, ma un cammino di crescita spirituale e personale». Il suo sogno? «Un futuro in cui essere musulmana in Italia non sia più strano. Dove una ragazza con il velo sia vista solo come una cittadina, non come un simbolo». E un futuro con meno pregiudizi. «L’Islam è un credo che parla di pace, giustizia e rispetto per tutti. Ti responsabilizza, non ti opprime». ■


Dove lo sciamanesimo sopravvive in Turchia
Il legame con le tradizioni e le credenze antiche nella quotidianità del popolo
«Uno degli aspetti che rende la cultura turca di oggi ricca e stratificata è che la società ha abbracciato diverse credenze nel corso della storia, ma alcune pratiche continuano a sopravvivere ancora oggi. Prima che i turchi si avvicinassero all'Islam nell'VIII secolo, lo sciamanesimo era uno dei sistemi di fede più seguiti e la sua influenza è visibile ancora oggi.
Il Prof. Dr. Bülent Gül lo definisce: «Un insieme di credenze senza un libro, un profeta o un fondatore, che per alcuni ricercatori è una religione e per altri una fede. È descritto come lo stadio successivo dell'animismo in linea con le teorie evolutive, un sistema fondato su uno spirito dualistico e su una visione del mondo che regola l'armonia tra natura e uomo basata sulla personificazione della natura».
In Turchia la tradizione vuole che il popolo visiti le tombe dei defunti e questa pratica ha origini antiche. Come spiega il professore: «La cultura della tomba e della visita continua ancora oggi. Tuttavia, la cultura delle tombe nelle società islamiche non è così. Non esiste una tradizione di lapidi perché, secondo la loro mentalità, i morti dovrebbero diventare
un tutt'uno con la terra e scomparire ed è considerato un peccato che la tomba sia ben visibile e che venga eretta una lapide. Nella geografia islamica, solo l’Anatolia prevede il rituale della pietra tombale e l'origine di questa tradizione può essere considerata lo sciamanesimo». Una delle credenze culturali della Turchia, ben nota anche agli stranieri, è l concetto del «malocchio».
«Un insieme di credenze senza un libro o un profeta.
Per alcuni è una religione, per altri una fede»
I fedeli credono che derivi da emozioni negative, come la gelosia, e che possa nuocere alle persone. La pietra blu con aggiunte di bianco e un puntino nero che assomiglia ad un occhio viene utilizzata per proteggersi da queste forze dannose. Per allontanare il malocchio è necessario eseguire quella che chiamano la colata del
piombo. In questo rituale, il piombo viene fuso e poi versato in un contenitore di rame pieno d'acqua. La forma che assume viene interpretata, come avviene anche nella tradizione del caffè turco. «Per proteggersi dal malocchio, si porta con sé un amuleto. Esistono anche tradizioni che prevedono di colare piombo, bruciare ruta selvatica e incenso per proteggersi dagli spiriti maligni e dal malocchio», spiega Bülent Gül.
Un'altra tradizione osservata nel Paese è la sepoltura del cordone ombelicale dei bebè. Il professore aggiunge: «I turchi seppelliscono il cordone ombelicale del neonato in luoghi sacri per assicurare un buon futuro ai loro figli. Oggi i cordoni ombelicali vengono sepolti in ospedali, università, moschee e istituzioni statali. Il motivo è il desiderio che il bambino riesca ad avere una buona professione, come un medico di successo o un insegnante».
Alla luce di tutto questo, l'armonia tra le varie influenze storiche e culturali contribuisce a rendere la Turchia un luogo ricco di diversità e l'incontro di queste diverse tradizioni arricchisce la vita quotidiana di chi la abita. ■
di Gizem Daver
CULTURE

"Pietas", aiutati che gli dèi ti aiutano
PAGANESIMO
Il ritorno dei culti religiosi classici in Italia
di Massimo De Laurentiis
A Roma esiste un tempio dedicato a Giove in cui è possibile trovare altari, statue, colonne corinzie e oggetti rituali. Non si tratta di un sito archeologico risalente a migliaia di anni fa, ma di un luogo di culto costruito nel 2017 frequentato tutt’ora dai fedeli della tradizione religiosa classica. Questo santuario, insieme ad altri, è stato realizzato dalla comunità Pietas, di cui fanno parte circa duemila persone che si riconoscono nei valori e nella spiritualità latina. La riscoperta delle religioni antiche, infatti, è un fenomeno in crescita in tutta Europa, dai Baltici alla Grecia.
«Vivere ciò che hanno percepito i nostri antenati ci dà un senso di continuità con dei valori sani», spiega Giuseppe Barbera, archeologo, storico e saggista che nel 2005 ha fondato l’ente e ricopre il ruolo di pontefice massimo dell’organizzazione. «Pensiamo alla gravitas, il peso delle parole, la pietas, intesa come amore e rispetto delle divinità ancestrali, o la tutela della patria come spazio comune. Sono valori importanti e modernissimi». Barbera racconta di essere cresciuto in una famiglia molto aperta per quanto riguarda le scelte religiose: «Io mi iscrissi da solo al catechismo perché ho sempre
avuto una tendenza verso la spiritualità. Poi scoprii che esistevano delle alternative al cristianesimo e a diciotto anni decisi di intraprendere un percorso di iniziazione nel filone ermetico».
Nei primi anni Duemila un gruppo di fedeli riesce a ricostruire i riti romani ed emerge la necessità di creare una comunità per i praticanti. Oggi l’associazione promuove lo studio e la pratica della sapienza sacerdotale antica, con momenti di incontro presso i templi sparsi in tutto il Paese.
«Il termine pagano nasce con un significato denigratorio, noi ci definiamo gentili dal latino gens, da cui poi è derivato anche l’aggettivo italiano per indicare una persona dolce, delicata, per bene», continua Barbera. «Ci poniamo in un rapporto paritario con la divinità e per renderci degni di questo dobbiamo migliorare innanzitutto noi stessi». Il culto gentile è animato da uno spirito di tolleranza che riprende il sincretismo della tradizione classica e crea relazioni strette anche con altre religioni, come l’induismo o il politeismo ellenico. A volte però, quest’apertura si è scontrata con un’ostilità inaspettata. «Ci sono stati alcuni esempi di persone che si
sono infiltrate tra noi per creare dissidi –dice il pontefice massimo – in alcuni templi abbiamo dovuto addirittura installare la videosorveglianza perché sono capitati episodi di vandalismo».
Per quanto riguarda i riti, i fedeli seguono delle pratiche sia individuali sia collettive e rispettano ricorrenze e festività romane. «Abbiamo una rituaria domestica che ogni gentile pratica a casa al proprio altare domestico – spiega Barbera – poi seguiamo un calendario che riprende quello latino. Il 19 marzo, per esempio, è la festa di Minerva, il primo maggio invece è la festa dei fiori».
Questo mondo forse può sembrare lontano, ma il fondatore della comunità Pietas insiste sulle connessioni della tradizione classica con la realtà in cui viviamo oggi: «Se qualcuno mi fa gli auguri di buon Natale io ricambio, alla fine si tratta di una festa pagana ripresa dai cristiani per dare continuità. Le nostre divinità non sono gelose, noi non crediamo che una religione debba vincere su un’altra». ■


Amore e altri algoritmi
Gli utenti raccontano l’effetto collaterale delle piattaforme di incontri: diventare dipendenti dal sentirsi apprezzati
Rendere razionale l’amore. È ciò che cercano di fare le app di incontri attraverso un algoritmo che suggerisce profili compatibili sulla base delle proprie preferenze. Basta rispondere ad alcune semplici domande al momento dell’iscrizione, iniziare a mettere qualche like, o skippare le foto di chi non è compatibile con i propri gusti. Alcuni studi hanno paragonato il funzionamento di app come Tinder a Netflix: si crea un profilo, si sceglie qualche contenuto da guardare e poi la piattaforma suggerisce titoli basati su quelle che percepisce come le propensioni di chi la utilizza.
modo in cui le persone vivono l’amore, la sessualità e l’autostima, con implicazioni significative per la salute mentale. Uno degli aspetti che le rendono così coinvolgenti è il meccanismo della gratificazione immediata. Ogni volta che un utente riceve un match o un messaggio, il cervello rilascia dopamina, il neurotrasmettitore legato al piacere e alla ricompensa.
di Nicole Saitta
«L’istinto è quello di aprire l’app ogni minuto, forse per manie di onnipotenza che derivano dal fatto che puoi scegliere tu con chi parlare o chi skippare», ha detto Vittoria che su Hinge ha trovato il suo attuale fidanzato. La possibilità per l’utente di decidere chi è all’altezza di ciò che sta cercando e chi invece non lo è, spesso, crea dipendenza. Queste piattaforme non sono prive di conseguenze psicologiche: l’uso intenso e compulsivo delle app di dating sta modificando il
«Ciò che genera engagement è il sentirsi apprezzato in chat da qualcuno e sapere che sarebbe disposto a incontrarti. A volte, per mancanza di stimoli o per noia, trovi in quella cosa una fonte di endorfine», racconta Daniele, utente di Grindr. Il più delle volte, il rifiuto genera insicurezze sull’aspetto fisico, soprattutto se la propria autostima è già bassa: «Un tizio mi ha bloccato dopo avermi proposto un gioco in cui mi mostravo nudo. Io ingenuamente gli avevo mandato le mie foto e ho avuto l’ansia che potesse usare tutto contro di me per ricattarmi».
Quando poi non si riesce ad attirare l’attenzione degli altri utenti, non si viene matchati o si è vittima di ghosting (non si
riceve risposta ai messaggi diretti) «ci si sente sostituibili alla velocità della luce».
Uno dei problemi principali delle app di incontri è proprio questo: la quantità potenzialmente infinita di scelta. Gli utenti sono sommersi, sopraffatti da stimoli che generano un senso di profonda irrequietezza: «Mi sentivo un po’ dipendente, avevo tantissimi match. Mi sono ritrovato anche a fare l’abbonamento perché se paghi ti arriva più gente, quindi entri in un circolo vizioso. Spero di uscirne», è la testimonianza di Giulio, che ha scaricato l’app di Tinder dopo la fine di una lunga relazione.
Gli utenti hanno raccontato che si ritrovavano ad utilizzare le piattaforme anche sul posto di lavoro, quando i pensieri «dovevano essere tutt’altri», soltanto per fare qualche skip e richiuderle, o per controllare se avessero ricevuto abbastanza like da potersi considerare desiderabili. Anche lasciare un “mi piace” nelle app di dating è strategico, bisogna valutare bene a chi, e soprattutto quando. Nelle versioni gratuite di Tinder, per esempio, se ne ha a disposizione un numero limitato. L’esperienza di Roberta testimonia come anche questo aspetto possa creare una sorta di “ansia del like”: «Mi è capitato di aprire la piattaforma con il pensiero che se non avessi sfruttato tutti quelli che avevo a disposizione in un determi-
nato giorno, avrei potuto perdere delle occasioni». Come nella vita quotidiana, ci sono tipi diversi di utenti che vivono questa esperienza nei modi più dissimili. Giorgio e Alessandro, rispettivamente proprietari di profili su Tinder e Grindr, non hanno percepito gli effetti della fatigue derivante dal loro utilizzo. «Reputo sbagliato farsi influenzare da quello che gli estranei possano pensare su di te soltanto sulla base di qualche fotografia e di informazioni che potrebbero non essere veritiere, è solo un passatempo», è l’opinione di Giorgio, anche se «conferisce a volte un pensiero distorto della realtà, ma sarebbe un errore pensare che derivi solo da queste app».
«Ho fatto l'abbonamento, se paghi arriva più gente.
È un circolo vizioso, spero di uscirne»
Anche se un buon numero degli iscritti a queste piattaforme dice di sentirsi frustrato a seguito di un rifiuto o di un mancato match, alcuni come Alessandro si sentono insoddisfatti o disillusi solo nei casi in cui non riescono a trovare persone che rispondano appieno alle proprie esi-
genze: «A un certo punto ho disinstallato tutto perché mi ero annoiato». Tinder, Bumble, Grindr, Hinge, Meetic. Sono tutti mezzi che facilitano le connessioni come tanti altri social network non finalizzati al dating. Nel caso di queste app, però, è più facile alimentare insicurezze derivanti dall’opinione altrui, perché basate su immagini e descrizioni brevi che portano gli iscritti a enfatizzare l’aspetto fisico come criterio di selezione. La creazione di una relazione, oggi, avviene in tempi del tutto diversi rispetto al passato, più veloci e più superficiali, e questo cambia il valore che si dà alle persone.
La percezione è che essersi conosciuti online conferisca il diritto di chiudere in modo quasi brutale, senza dare spiegazioni. Roberta, che su Tinder cerca altre donne, è stata spesso utilizzata come esperimento: «Sono stata contattata da donne sposate che volevano solo avere un’esperienza con una persona dello stesso sesso, o da coppie in cerca di un terzo componente casuale per avere rapporti sessuali». Così, attraverso questi mezzi, i legami sono del tutto svalutati e gli utenti riconoscono che instaurare un rapporto con qualcuno solo sulla base dell’aspetto fisico diventa, a lungo termine, tossico e quasi insostenibile. «Se una persona è già insicura, si rischia davvero di accentuare le sue incertezze, arrecando dei danni anche irreversibili. È pericoloso». ■

Relazioni HiTech

Game over o altro round?
Una nuova terapia di coppia
Molte relazioni naufragano su un terreno comune: la difficoltà di comunicare. Ed è qui che entrano in gioco i videogiodi Mariahelena Rodriguez
Uno schermo sempre acceso. Una stanza in penombra. Uno sguardo perso nel vuoto. È facile pensare che i videogiochi siano un passatempo solitario, un'evasione dalla realtà fatta di mani che scorrono su un joystick. Ma questa è una visione superata. Oggi raccontano storie quasi cinematografiche, come Death Stranding Non sono solo strumenti narrativi, ma un mezzo per connettere le persone. Possono rafforzare legami esistenti e crearne di nuovi, sia tra amici che tra coppie. Non a caso, sempre più terapeuti di coppia li usano per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra partner. Il dott. Francesco Bocci, ideatore della Video Game Therapy, afferma: «Nei giochi cooperativi, i partecipanti devono interagire e supportarsi per raggiungere un obiettivo comune. Questo aiuta a ridurre l’isolamento e rafforza la fiducia reciproca».
chi cooperativi, che obbligano i giocatori a coordinarsi per uno scopo condiviso. Allenare questo spirito di collaborazione aiuta le coppie a essere più pronte di fronte alle sfide della vita reale, e alcuni giochi li mettono davanti ai loro problemi, permettendo loro di identificarsi nei personaggi e nelle dinamiche della storia.
È il caso di It Takes Two, vincitore del premio Game of the Year nel 2021. Il titolo non si limita a richiedere cooperazione: la sua trama ruota attorno ad una coppia in crisi. Cody e May, trasformati in due piccole bambole di pezza, devono collaborare per superare puzzle e ostacoli. Attraverso il gioco si è chiamati a mettere in pratica fiducia, comunicazione e strategia, come nella vita reale.
Se It Takes Two si concentra sulle dinamiche emotive di coppia, Overcooked mostra cosa succede quando lo stress prende il sopravvento. In questo frenetico simulatore di cucina, i giocatori devono prepara-
re piatti in un tempo limitato, rispettando ordini e tempistiche. Lo stress è il vero nemico: se si perde la calma e si comincia a incolparsi a vicenda, è game over. Secondo Bocci «l’approccio cooperativo riduce il carico emotivo, perché i giocatori condividono le difficoltà e si sostengono a vicenda».
La collaborazione nei videogiochi non è solo un passatempo, ma uno strumento di crescita. Il concetto di flow, teorizzato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, descrive quello stato di totale immersione che si verifica nei giochi cooperativi, creando un ambiente di condivisione e supporto emotivo. «Nei contesti terapeutici, il flow aiuta a sviluppare empatia, fiducia e comunicazione» spiega Bocci.
I videogiochi possono essere così un valido aiuto per ritrovare sintonia. La prossima volta che le parole sembrano mancare, forse la soluzione è accendere la consolle e giocare insieme. ■
Sempre più partner usano i videogiochi per ritrovare sintonia e stimoli condivisi
CONNESSI

Il frutto proibito del web
DESIDERIO
Il racconto di Salvatore, ex operatore per siti di messaggistica per adulti
di Nicoletta Sagliocco
Puoi essere un ragazzo, una ragazza o non rientrare in nessun genere. Nel momento stesso in cui firmi il contratto stringi un patto con il tuo creatore virtuale e scegli chi essere. Una nuova identità donata dal demiurgo internet che plasma il nuovo te e lo presenta al mondo. Donna transgender o uomo gay non importa, basta attenersi alle regole e scrivere le esatte parole che gli utenti delle chat erotiche stanno aspettando ormai da un’intera giornata seduti su una sedia davanti al pc o stesi sul letto con il cellulare tra le mani. Un click e poi possono finalmente rilassarsi e godersi la loro chiacchierata fatta di sexting e foto osè.
«Ho scelto io di assegnarmi il genere femminile, non so perché mi andava così. Era un profilo digitale, entravo con nome utente e password e non avevo limiti di tempo», spiega Salvatore che è stato operatore per una chat erotica qualche anno fa. «Era il 2018, si cercavano lavori da poco ed era difficile trovare un lavoretto decente. Trovai questo, con contratto e pagamento online. Non ebbi alcun tipo di remora morale, anzi è stato anche divertente. Quando feci la registrazione ero con un mio amico e ci divertimmo tanto». Iscriversi è semplice, ma ci sono dei codici da rispettare soprattutto per chi è cliente e se si cerca qualcosa in più, come allega-
re immagini ai dialoghi, bisogna attivare un abbonamento specifico che aumenta i guadagni dei siti.
«Mi sono registrato tramite una mail che avevo creato apposta per questo, - racconta Salvatore - era tutto automatizzato, ricevevo dei pacchetti di foto da poter usare durante le conversazioni. Anche i responsabili con cui mi sono confrontato per parlare del mio lavoro sembravano bot, anzi penso proprio che lo fossero». La retribuzione non è delle migliori ed è relativa al numero e alla lunghezza dei messaggi scambiati, pochi centesimi per qualche battuta hot. Il contenuto del discorso è suggerito dalla stessa chat, all’operatore non resta che cliccare e inviare le frasi giuste per accendere il desiderio dell’interlocutore. «In due giorni ho parlato con dieci persone, tutti uomini. Non trovo particolari elementi comuni tra gli utenti con cui ho parlato se non la voglia di conoscermi oltre le interazioni online».
Tutto si svolge sul web, dalla recluta di nuovi operatori allo svolgimento effettivo del lavoro. Conversazioni potenzialmente infinite con chi ti ha scelto per piacere ma non solo: «Molti mi facevano domande private che andavano oltre i messaggi consigliati dal sistema. Mi chiedevano dove abitassi, cosa studiassi, che lavoro
facessero i miei genitori. Devi osservare tutto questo dal punto di vista sociologico, è particolare. Erano su delle chat erotiche ma erano anche interessati al lato esistenziale della donna che pensavano di aver contattato». Da allora il mondo della messaggistica per adulti è molto cambiato e il numero di piattaforme che consentono queste conversazioni online è difficile da calcolare. «Se volevi guadagnare tanto dovevi avere una passione e un talento per le chat che io non avevo. Ci dovevi mettere dedizione e tempo. Le persone non erano moleste ma sole».
Un impegno che non molti sono disposti ad assumersi. Così negli ultimi anni sono comparsi in rete siti che permettono di scrivere a qualsiasi persona, reale o di fantasia lasciando ai clienti anche la possibilità di scrivere a personaggi dei manga. Ma dietro tutto questo non ci sono più persone reali, non per forza. L’Ai è entrata anche nella sfera più intima dell’essere umano e sta iniziando a governare e gestire i suoi desideri sessuali rispondendo alle richieste degli utenti che si rivolgono alle chat erotiche. In questo modo il panorama sta diventando sempre più vasto, migliore per chi desidera questo tipo di esperienze e peggiore per chi cerca ancora un contatto umano e spera di conoscere chi si cela dall’altra parte del monitor. ■
Relazioni HiTech

Un calcetto al passato partite organizzate sull'app
Uno dei passatempi preferiti dagli italiani si trasforma e riesce oggi a trovare un suo spazio digitale RITI
di Francesco Esposito
Ogni sera (e la mattina durante il fine settimana) in tutte le città italiane, tribù di uomini si riuniscono in luoghi predisposti per celebrare un grande rito al fine di rinvigorire virilità e spirito comunitario. Indossano una divisa, recitano formule e offrono i loro corpi in sacrificio. Insomma, giocano a calcetto. Si inizia da ragazzini, alle scuole medie, e i più atletici e temerari continuano anche fino ai 70 anni. In un secolo e più di storia del calcio, anche questa pratica si è evoluta come quella che oggi guardiamo in tv.
Nel 2007 è nato Fubles, social network per organizzare partite di calcetto e non solo. «Eravamo sette universitari di Bicocca e Politecnico», dice Giuseppe Calbi, uno dei fondatori e oggi presidente e amministratore delegato. L’obiettivo era dare agli studenti fuorisede un modo semplice ed economico – «In quegli anni un sms costava quindici centesimi», aggiunge Calbi – per organizzare partite.
Oggi l’app conta 22 mila centri sportivi collegati e più di un milione di utenti. «È perfetta per chi ha voglia di giocare e non sempre ha un gruppo fisso con cui farlo»,
dice Davide, che usa l’app solo da pochi mesi. «Ti iscrivi, scegli uno slot partita in base alla zona che preferisci e in pochi click puoi prendere parte al match».
Sull’onda di Fubles sono nate tante altre app: Goalcup, SquadraPiù, SportEasy. «Ma l’idea veramente originale è la nostra, quella di Vito Zongoli», commenta Calbi. Questo, però, è il periodo d’oro di Playtomic, per organizzare partite di tennis e padel, sport che sta mettendo in crisi il dominio del calcetto. «Noi veramente giocavamo a calcio, a undici», interviene Alfredo, 74 anni. «Facevo i campionati dell’Uisp, Unione italiana sport popolare». «Ero portiere», dice invece Giovanni, «e stavo in una porta vera». Trovare campi a undici è sempre più raro. Perché far giocare 22 persone dove potresti farne giocare 80?
Una componente fondamentale per la buona riuscita di una partita di calcetto è il livello dei giocatori. Deve essere equilibrato così come lo devono essere le due squadre. Per questo su Fubles esiste il “rango”: calcolato in base a età, gol realizzati, vittorie e media voto. Chi vota? Ovviamente
gli altri giocatori. «È utile perché posso capire che partita aspettarmi», commenta Fabio, altro utente novizio dell’app. «Per quanto riguarda i voti, all’inizio ero molto attento ad assegnarli, poi ho capito che giocano tutti a rialzo anche se hanno giocato di merda». «È divertente. Quando ero a Bologna c’erano dei giocatori d’élite che ero curioso di incontrare», è il commento di Emanuele, che da quando è tornato a Roma ha smesso di usare l’app, «si creavano delle piccole leggende locali».
Un elemento tipico dei videogiochi entra nella realtà e la partita smette di essere solo una partita. Diventa anche una statistica. Una cosa bellissima del giocare fra amici è che una giornata no viene presto dimenticata. Con le app una prestazione, sia buona che cattiva, resta nei libri così come per i professionisti. Però trovare qualcuno con cui giocare, magari in città in cui ci si è trasferiti da poco, può non essere facile. E perché rinunciare al proprio passatempo preferito solo perché non si ha un gruppo fisso? «Alla fine», conclude Davide, «è una buona occasione per farsi degli amici». E tornare a poter giocare di merda. ■

Scommetto quando voglio la dipendenza dietro l'angolo
BETTING
Il gioco d’azzardo legato agli eventi sportivi è in aumento. App e siti online lo rendono accessibile in ogni momento e a farne le spese sono soprattutto i più giovani
di Gennaro Tortorelli
È impossibile seguire il calcio senza essere sopraffatti dalle pubblicità di scommesse. Nel prepartita, durante l’intervallo, nel post-partita, sui cartelloni pubblicitari, sulle maglie dei giocatori. Il ritornello è sempre lo stesso: «Segui il nostro sito per non perderti le ultime news, analisi e statistiche su tutti i tuoi sport preferiti».
È una formula studiata a tavolino per permettere al betting di farsi spazio tra le maglie larghe del Decreto Dignità, che ha introdotto il divieto di «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro». I “siti di news” lo aggirano facilmente.
Vengono usati come cavallo di Troia per dirottare il traffico verso la sezione dedicata alle scommesse. Lo dimostrano i nomi neanche troppo fantasiosi dei sedicenti portali di informazione: starcasino.sport, pokerstarsnews.it, leovegas. news, bet365news. Il gioco d’azzardo è lì, nascosto in piena vista. È intenzione del governo sopprimere anche queste blande regolamentazioni. Una risoluzione approvata mercoledì 5 marzo in commissione Cultura al Senato propone di rivedere la
legge, perché ritenuta «non efficace al contenimento dei fenomeni di ludopatia» e, al contempo, dannosa per il sistema calcio. Il giro d’affari, d’altronde, è di quelli in grado di giustificare quasi tutto. In Europa, il mercato delle sponsorizzazioni nel betting calcistico vale 1,5 miliardi di euro annui.
Cifre che ridefiniscono le priorità, o almeno dovrebbero. Come quelle raccolte dall’Osservatorio sul gioco d’azzardo della società di consulenza Nomisma, secondo cui il 37% dei ragazzi tra i 14 e 19 anni ha scommesso nell’ultimo anno, con un aumento significativo tra gli utenti abituali.
Un dato trainato soprattutto dal betting online e dalle scommesse sportive. Lo conferma Michela Colarieti, psicologa e psicoterapeuta specialista in dipendenze: «Ho aperto un centro per la cura del gioco d'azzardo patologico nel 2012. Se in passato c’è stato un boom delle slot machine, oggi i problemi di dipendenza degli under 40 hanno spesso a che fare con le scommesse sportive». La cosa più grave è che «i ragazzi pensano di essere in controllo, di poter raggiungere il risultato con
lo studio delle partite. Ma è un'illusione». Le app sono progettate per tenere gli utenti attivi il più possibile, anche a scapito della loro salute: «Sono accessibili a tutti in ogni momento», continua Colarieti «e la virtualità del denaro non permette di avere contezza dei soldi che si stanno perdendo».
«Prima non potevo fare da stanza a stanza senza telefono, oggi lo prendo quando esco di casa e lo lascio rientrando». In un’intervista rilasciata a Repubblica, il calciatore Sandro Tonali ha raccontato del percorso terapeutico per uscire dalla dipendenza da gioco d’azzardo. Il suo caso, insieme a quello di Nicolò Fagioli, ha scrostato la patina di ipocrisia con cui il mondo dello sport tratta le conseguenze sociali del betting online.
«Ho avuto tanti calciatori come pazienti», spiega Michela Colarieti, «essere immersi in quel mondo non aiuta. La pubblicità è ovunque ed è suggestiva, ti fa venire voglia di fare qualcosa che magari non avresti fatto se non l'avessi vista. Da lì in poi, chi è più incline alle dipendenze può solo peggiorare». ■
Passato e presente

Il dialogo impossibile tra sant'Agostino e Bob Dylan
L'incontro tra due voci creative che si raccontano attraverso forme confessionali, distanti nel tempo ma vicine nell'essenza di Alessandra Coffa
L'arte della confessione autentica sfida i confini del tempo. Ne è prova il dialogo a distanza tra le "Confessioni" di sant'Agostino e l'opera di Bob Dylan, in particolare "I Dreamed I Saw St. Augustine", brano del 1967 dove il cantautore americano evoca il teologo di Ippona mentre cammina, inquieto, tra le strade della modernità.
Questa canzone viene registrata durante un periodo di profonda trasformazione per l'artista americano, all'interno dell'album "John Wesley Harding", che segna un punto di svolta: abbandonato il rock elettrico e psichedelico degli anni precedenti, il musicista si orienta verso sonorità essenziali e testi densi di riferimenti biblici. L'orchestrazione ridotta all'essenziale - chitarra acustica e batteria discreta - contrasta con la complessità del testo, che si apre riecheggiando la canzone popolare "Joe Hill" ma creando subito un paradosso: mentre Joe Hill era un sindacalista martirizzato, il santo nordafricano non subì il martirio fisico, suggerendo l'assenza di guide morali nella modernità.
Le "Confessioni" agostiniane rappresentano la prima grande autobiografia spi-
rituale della cultura occidentale. Raccontando il proprio percorso dal manicheismo al cristianesimo, il filosofo crea un modello di autonarrazione che trascende la mera cronaca personale per diventare un'esplorazione universale delle contraddizioni umane. Con inedita schiettezza, rivela i suoi errori giovanili, le ambizioni mondane, i dubbi intellettuali che precedono la sua conversione.
Secondo Antonio Musarra, docente di Storia Medievale presso l’Università la Sapienza di Roma, le "Confessioni" agostiniane contengono tratti di sorprendente modernità. «L'elemento della narrazione non è banale per un testo di quel secolo», spiega Musarra. «Il racconto viene immaginato come edificante per chi lo legge, ma a prima vista è un dialogo tra il sé e la propria anima, una profonda riflessione su sé stesso. È un elemento che oggi è presente nella narrativa. Quel modello è vincente».
Il professore sottolinea un altro aspetto rilevante: «Agostino fa costante riferimento a personaggi esistiti e vicende storiche che hanno attraversato il suo tempo. Risulta calato appieno nel proprio tempo,
POESIA
elemento che ad oggi è proprio della narrazione contemporanea». La modernità del pensiero agostiniano si riflette nell'opera di Bob Dylan, che ha saputo cogliere e reinterpretare questo approccio confessionale, trasformandolo in un linguaggio artistico. Il teologo è così un precursore di quella narrazione intima e al contempo universale che il cantautore americano ha tradotto in versi e musica.
Nel santo evocato da Dylan, Agostino appare come un predicatore che corre tra i quartieri poveri con "respiro infuocato" e un ambivalente mantello d'oro che potrebbe simboleggiare tanto la ricchezza interiore quanto gli eccessi mondani. La confessione del cantautore opera un ribaltamento prospettico: «Ho sognato di vedere Sant'Agostino / Vivo, con l'alito di fuoco / E ho sognato che ero tra quelli che lo misero a morte / Oh, mi svegliai
con rabbia, così solo e terrorizzato / Ho messo le mie dita contro il vetro / E chinai il capo e piansi». L'autore si identifica con i persecutori, esprimendo un senso di colpa irrisolto.
«Le Confessioni sono un dialogo tra sé e la propria anima»
Questa tensione è quanto accomuna le confessioni dei due artisti. Se per il santo il cuore resta "inquieto finché non riposa in te", il cantautore americano trasforma

questo turbamento in principio creativo permanente. Non ambisce alla quiete della certezza, ma alla fecondità del dubbio.
Il recente film "A Complete Unknown" illumina questo aspetto della poetica dylaniana, mostrando come il giovane Robert Zimmerman abbia costruito la sua identità artistica attraverso mascheramenti e reinvenzioni continue. Il cantautore moltiplica in maniera consapevole le proprie identità, facendo della frammentazione una forma paradossale di autenticità.
La pellicola rivela un artista che, nonostante la fama, vive in solitudine, condizione che ricorda lo stato di isolamento descritto dal filosofo prima della conversione. Entrambi sperimentano il paradosso della comunicazione pubblica: quanto più sono acclamati - uno come retore, l'altro come portavoce generazionale - tanto più avvertono una distanza tra l'immagine proiettata e la verità interiore. Il testo agostiniano è un'opera che integra narrazione, filosofia e preghiera; analogamente, le canzoni di Dylan trascendono il formato della ballata folk per diventare complesse esplorazioni poetiche. Entrambi trasformano l'autonarrazione in arte, utilizzando il racconto personale come veicolo di verità universali.
Il brano dedicato ad Agostino è stato riconosciuto da critici e appassionati come uno delle più significative nella produzione del cantautore. In un sondaggio pubblicato dalla rivista Mojo nel 2005, è stata indicata come la sua migliore composizione. Bob Dylan l'ha eseguita in momenti chiave della sua carriera, come al festival dell'Isola di Wight nel 1969, trasformandola in un lento valzer che amplificava la dimensione onirica del testo, una metamorfosi che sottolinea il carattere aperto della confessione artistica.
Ciò che unisce queste due figure non è una semplice analogia tra percorsi personali, ma una comune consapevolezza della complessità dell'io e della natura sfuggente della verità individuale. Le loro confessioni, pur nella diversità di forme e contesti, ricordano che raccontarsi significa confrontarsi con le proprie contraddizioni.
L'Agostino di Dylan non è il dottore delle certezze teologiche, ma una figura inquieta che continua a cercare. È l'emblema di una ricerca che non trova mai compimento, che diventa motore creativo. Un'irrequietezza che attraversa i secoli, dai manoscritti di Ippona alle ballate di Woodstock, creando quel dialogo necessario tra confessioni distanti nel tempo ma vicine nell'intento: la ricerca dell'autenticità che sempre sfugge e sempre chiama. ■
Passato e presente

Testimonianze scritte, il volto intimo della storia
EPISTOLA
Tra rivelazioni, manipolazioni e memorie personali, lettere e diari hanno segnato la storia, offrendo prospettive uniche ma non sempre imparziali
Per secoli, la storia è stata raccontata attraverso documenti ufficiali e archivi istituzionali, strumenti ritenuti oggettivi. Tuttavia, lettere e diari hanno avuto un ruolo cruciale nel rivelare segreti, influenzare decisioni politiche e offrire prospettive intime sugli eventi più importanti. Queste fonti permettono di entrare nella mente dei protagonisti, di comprendere le loro emozioni e i conflitti interiori. Ma quanto possiamo considerarle affidabili? La soggettività dell’autore, il contesto in cui vengono scritti e il rischio di manipolazione pongono interrogativi.
di Ludovica Bartolini
Secondo lo storico Marcello Flores, il punto di vista personale è ormai considerato centrale nella comprensione della storia, anche se non è sempre stato così. La tradizione storica ha a lungo privilegiato le fonti ufficiali, ignorando le voci individuali. È solo con l’Ottocento e il Novecento che lettere e diari hanno acquisito una nuova rilevanza, permettendo di cogliere sfumature che i documenti istituzionali non offrono. Tuttavia, Flores avverte che questi scritti non sono immuni da distorsioni: la memoria non è mai neutra e può essere influenzata dal contesto politico,
sociale e personale in cui viene costruita. Un esempio emblematico è quello dell’Unione Sovietica stalinista, dove la repressione politica alterava perfino il modo in cui le persone percepivano la realtà. Esistono diari in cui le autrici, mogli di uomini accusati di tradimento dal regime, arrivano a convincersi della colpevolezza dei loro mariti. Una donna sovietica degli anni Trenta scrisse nel suo diario che non aveva mai conosciuto veramente suo marito e che le autorità avevano ragione a trattarlo da traditore. Poco dopo, fu arrestata e inviata in un gulag. Questo caso dimostra quanto il potere possa penetrare nelle vite private e influenzare la narrazione personale fino a farla coincidere con la versione ufficiale.
Diari e lettere, però, non si limitano a raccontare la storia. In molti casi, l’hanno influenzata. Il Diario di Anna Frank non è solo la testimonianza di una ragazza ebrea nascosta durante l’occupazione nazista, ma è diventato un simbolo universale della Shoah. Anche il diario di Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, ha avuto un impatto enorme, rivelando il funzionamento interno della macchina dello sterminio. Le lettere scambiate tra
Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt, invece, furono determinanti per il coinvolgimento degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale, mentre la corrispondenza tra John Fitzgerald Kennedy e Nikita Krusciov contribuì a scongiurare una guerra nucleare durante la crisi dei missili di Cuba del 1962.
Il valore delle lettere e dei diari emerge anche in ambito culturale e filosofico. Gli epistolari di Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir non raccontano solo la loro relazione, ma offrono una testimonianza diretta delle tensioni politiche e sociali del ’68. Flores cita anche alcuni diari meno noti ma dal grande impatto storico, come quelli di Anatolij Lunacharskij, membro del governo bolscevico, e quello di una donna internata ad Auschwitz, disponibile solo in olandese, che offre uno sguardo personale sull’esperienza nel campo di concentramento.
Lettere e diari possono però essere strumenti di manipolazione. Flores sottolinea come spesso vengano estrapolati brani selezionati per rafforzare una certa narrazione, tralasciando informazioni che potrebbero contraddirla. Questo fenomeno è visibile in molte ricostruzioni storiche, dove
singoli passaggi vengono isolati per dare un’impressione distorta degli eventi.
Un caso interessante è quello di Max Salvadori, agente britannico durante la Resistenza italiana. Per anni, le sue lettere e memorie hanno raccontato il suo operato come patriota, ma l’apertura degli archivi britannici ha rivelato che l’Inghilterra aveva autorizzato la sua attività di spionaggio molto prima di quanto dichiarato. Questo esempio dimostra che la verità storica non sempre coincide con la narrazione lasciata dai protagonisti, e che spesso solo l’accesso a fonti più ampie permette di ricostruire un quadro completo.
Flores sottolinea anche un altro aspetto critico: la perdita progressiva di queste fonti. Oggi, lettere e diari stanno scomparendo, sostituiti da email, messaggi e post sui social media. Se in passato gli epistolari e i diari personali erano conservati con cura e tramandati, oggi gran parte della comunicazione è frammentata e online. Secondo lo storico, la raccolta di email potrebbe diventare l’equivalente moderno degli epistolari, ma questo pone nuove sfide agli storici. La quantità immensa di dati, la difficoltà di accesso e la rapida obsolescenza dei

supporti digitali rendono complessa la loro conservazione.
Questa trasformazione solleva interrogativi: in futuro, quali saranno le fonti che permetteranno di comprendere la nostra epoca? I social media, con il loro flusso continuo di informazioni, possono davvero sostituire la profondità di un diario? Se le lettere di Winston Churchill o i diari di Anna Frank hanno contribuito a costruire la memoria collettiva, sarà possibile fare lo stesso con le email e i messaggi digitali?
Lettere e diari restano strumenti fondamentali per la ricerca storica, ma devono essere analizzati con spirito critico. Il loro valore risiede nella capacità di offrire uno sguardo intimo sugli eventi, ma la loro soggettività e il rischio di manipolazione impongono cautela. In un’epoca in cui la memoria collettiva è sempre più digitale e frammentata, il compito degli storici sarà quello di trovare nuovi strumenti per raccogliere, conservare e interpretare la testimonianza del nostro tempo. ■
1. Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir
2 Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt

I viaggi del Papa
di Chiara Boletti e Lorenzo Pace



1. L’abbraccio con il Papa emerito Benedetto XVI all'arrivo nella residenza estiva di Castel Gandolfo, 23 marzo 2013
3. Papa Francesco tocca le pietre del Muro del Pianto, nella Città Vecchia di Gerusalemme, 26 maggio 2014
In dodici anni di pontificato il cammino di Papa Francesco ha portato pace e speranza nel mondo con più di 50 viaggi apostolici internazionali, visitando oltre 60 Paesi in tutti i continenti



2. Il saluto ai fedeli all'arrivo a Rio de Janeiro, 22 luglio 2013.
4. Il Papa in partenza per un viaggio di una settimana in Messico, 12 febbraio 2016




5. L'abbraccio con Ahmed al-Tayeb, Gran Imam dell'Istituzione al-Azhar in Egitto, al Cairo, Egitto, 28 aprile 2017
7. La preghiera per le vittime della guerra a “Hosh al-Bieaa”, Piazza della Chiesa, nella città vecchia di Mosul, Iraq, 7 marzo 2021
8. L'incontro con le comunità indigene delle Prime Nazioni, dei Métis e degli Inuit a Maskwacis, Alberta, Canada, 25 luglio 2022




6. Il Papa accolto all'aeroporto internazionale di Yangon, Myanmar, 27 novembre 2017
9. L'incontro con i giovani di Scholas Occurrentes presso il Centro Giovanile Grha Pemuda a Giacarta, Indonesia, 4 settembre 2024
10. I devoti pregano durante una messa presieduta da Papa Francesco allo Stadio Nazionale di Singapore, 12 settembre 2024

La voglia di terzo mandato rimescola le carte in tavola
REGIONALI
Il Pd chiude a De Luca e punta su una nuova alleanza, mentre in Veneto il centrodestra si divide sulla possibile ricandidatura di Zaia
Gli stessi volti, lo stesso potere, più a lungo. Il 9 aprile sarà una data cruciale per il futuro politico dei governatori di Campania e Veneto Vincenzo De Luca e Luca Zaia. La Corte Costituzionale dovrà esprimersi sulla legge regionale della Campania che consente un terzo mandato ai presidenti di Regione, un verdetto che potrebbe ridisegnare gli scenari politici in vista delle elezioni.
Se la Consulta dovesse bocciare la legge, De Luca dovrà dire addio alla corsa per la riconferma. Ma anche in caso di esito favorevole, per lui il problema non sarebbe solo giuridico. Il Partito Democratico ha già fatto sapere che non lo sosterrà in ogni caso. A confermarlo è il parlamentare campano del Pd Sandro Ruotolo: «A prescindere dal verdetto, abbiamo già fatto una scelta chiara: dopo due mandati, soprattutto per ruoli di vertice come quello dei presidenti di Regione, è necessario un ricambio. Per questo siamo contrari al terzo mandato. Pensiamo che la coalizione di centrosinistra, con il coinvolgimento anche dei 5 Stelle – che non hanno mai appoggiato la giunta De Luca – sia la strada giusta per vincere le prossime elezioni». Uno dei nomi in circolazione del campo largo è quello di Roberto Fico, ex presi-
dente della Camera. Ruotolo però smorza gli entusiasmi: «Per ora siamo ancora in una fase iniziale. Il nome verrà fuori dopo un confronto con le diverse liste civiche del territorio, con l'obiettivo di costruire una coalizione forte. Solo allora, tutti insieme, sceglieremo la persona più adatta a sfidare il centrodestra».
Se per la Campania il Pd ha già fatto la sua scelta, in Veneto la situazione è più incerta. Zaia ha lasciato intendere che, se la Consulta dovesse aprire alla possibilità di un terzo mandato, lui potrebbe essere ancora in corsa. «A leggi invariate, senza alcuna variazione si andrà votare entro novembre. Dopodiché, che accada qualcosa strada facendo non ve lo so dire, non mi occupo di questo», ha dichiarato il governatore a margine di un evento a Padova.
Nel frattempo, la base della Lega si muove. Il segretario della Liga Veneta, Alberto Stefani, sta portando avanti una raccolta firme per chiedere la ricandidatura di Zaia: «Il limite dei mandati è un retaggio storico negativo, valorizzare la democrazia significa superare queste imposizioni e liberare i cittadini dai vincoli imposti dalla legge al loro libero esercizio del voto. Le 10mila firme già raccolte ne
sono la conferma». Eppure, all'interno del Carroccio non tutti sembrano allineati. Gli esponenti della Lega in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, evitano di esporsi in maniera chiara sulla questione. Il segretario Matteo Salvini, impegnato nel congresso del Carroccio previsto per il 5 e 6 aprile, ha preferito non sbilanciarsi, limitandosi a ribadire che alle regionali la Lega sarà «il primo partito». Intanto, nel centrodestra crescono le pressioni di Fratelli d'Italia e Forza Italia, che vedono il Veneto come una Regione contendibile e potrebbero spingere per un'alternativa al governatore uscente. ■

di Alessio Matta

Centri in Albania terra di nessuno
ALBANIA
Viaggio dentro alle strutture per migranti, costruiti dal governo italiano. Gli edifici sono tutt'ora vuoti
di Silvia Della Penna
«Sembra la Fortezza Bastiani nel romanzo Il Deserto dei Tartari». Così Marco Calvetto, presidente nazionale dell’organizzazione umanitaria Ipsia Acli descrive il centro per migranti di Gjader, in Albania. Nel romanzo di Dino Buzzati, la roccaforte sorge ai limiti del deserto, immersa in una sorta di stregata immobilità, ed è l’ultimo avamposto dell'Impero. È lì che il tenente Drogo consuma la propria vita nella vana attesa del nemico invasore. «Ci sono tante persone specializzate: operatori sociali, infermieri e forze dell’ordine. Sono lì in attesa di qualcuno che non si sa quando arriverà» racconta Calvetto, che durante un incontro internazionale delle Acli ha avuto la possibilità di visitare la struttura.
Costruito dall’Italia, l’impianto è composto da tre blocchi principali: un centro di trattenimento con 880 posti, un centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) da 144 posti e un carcere da 20 posti. È una delle due strutture, l’altra è a Shengjin, nate dopo la firma del protocollo Albania a novembre 2023 tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro albanese Edi Rama. «Il centro di Gjader si trova all’interno di un’area molto vasta perché è un ex territorio dell’aviazione al-
banese. Un base militare che è stata completamente messa in sicurezza perché è a ridosso di una collina arida. Ci sono stati grandi lavori di consolidamento: la zona è in aperta campagna e intorno ci sono case e baracche sparse, dove le persone vanno a prendere l’acqua in pompe pubbliche», spiega il presidente. I due centri servivano per trasferire le persone migranti per le quali il governo italiano intende seguire la procedura di frontiera o di rimpatrio, che prevede un esame semplificato delle domande di asilo di chi arriva in Italia.
Tuttavia, l’iter può essere applicato solo ai migranti che provengono da paesi definiti “sicuri”, cioè in cui non vengano negati i diritti fondamentali, o comunque non ci siano motivi di considerare a rischio l’incolumità delle persone che dovessero ritornarci. Dall’apertura dei centri ad oggi, sono stati fatti due tentativi di trasferimento di circa 50 persone: il tribunale di Roma, però, non ha convalidato il trattenimento dei migranti in questi centri, non ritenendo i loro paesi di provenienza pienamente sicuri. Ad oggi quindi, sia Gjader che Shengjin, sono vuoti e inutilizzati: «Quando arrivi vedi che è una cosa fatta bene, nel pieno rispetto di quelle che sono le normative. I bagni hanno le dimensio -
ni adeguate, ci sono i presidi sanitari e di culto. Il personale scelto, inoltre, è assolutamente professionale e preparato». Per Calvetto però questa visione è alterata, perché la struttura è ancora inutilizzata: «È tutto ancora imbellettato quindi la percezione adesso è che la struttura sia decisamente dignitosi. Tuttavia in ogni container vivranno 4 persone e avranno un cortile di 50 mq, sotto il sole. Messa così diventa uno spazio restrittivo importante».
Lo scorso giugno, durante una visita nella capitale dell’Albania,Tirana, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni aveva ricordato che complessivamente i fondi assegnati per l’attuazione del protocollo ammontano a 670 milioni di euro per cinque anni, quindi 134 milioni di euro l’anno, che corrispondono al 7,5% delle spese connesse all’accoglienza dei migranti sul territorio nazionale.
Per il presidente di Ipsia Acli, i flussi sono assolutamente gestibili per paesi strutturati, come quelli Europei: «I migranti presenti in Europa sono, in media, il 10% della popolazione europea. I numeri non sono così elevati da avere la necessità di creare sistemi come quelli del protocollo Albania. Abbiamo tanti problemi a livello internazionale ma sul contrastare l’immigrazione ci si mette sempre d’accordo. È un dato di fatto questo. In molti Paesi, i migranti vengono utilizzati come strumento su cui fare propaganda per vincere le elezioni». ■


Quelle mani sporche di sangue
Quinto mese di manifestazioni contro il governo di Vučić dopo la tragedia della stazione di Novi Sad, in cui sono morte sedici persone, che ha svelato la corruzione nel paese
Strade invase da tamburi, fischietti e campanacci. «L’atmosfera in piazza è tale che non puoi controllare le emozioni: la gente piange, si abbraccia, ride. Si respira un vento di libertà e amore diffuso». Mihajlo è un giovane della provincia di Vojvodina che da mesi si unisce alle grandi proteste contro il governo nel nord della Serbia. Il clima quasi festante nasconde in realtà «una rabbia e un’indignazione accumulate da anni, esplose dopo i fatti dell’autunno passato».
I primi raduni prendono la forma di veglie, in cui si omaggiano le vittime con quattordici minuti di silenzio (poi aumentati a quindici e sedici). Con il passare dei giorni il movimento si fa più rumoroso e inizia a pretendere chiarezza sulle responsabilità dell’accaduto. Le prime conseguenze sono l’apertura di un’inchiesta e le dimissioni del ministro delle costruzioni Goran Vesic.
di Simone Salvo
Tutto ha inizio il 1° novembre 2024, quando a Novi Sad, la seconda città più grande del Paese, il crollo di una pensilina in cemento nella stazione ferroviaria causa sedici morti: quattordici sul colpo, due in seguito a un lungo ricovero in ospedale. «La tragedia rappresenta l’ennesima dimostrazione della scarsa manutenzione delle infrastrutture e della corruzione dilagante», spiega Mihajlo.
Nelle settimane successive marce e occupazioni si diffondono a macchia d’olio in tutto il Paese. «Una fiumana di universitari, lavoratori e pensionati. Le proteste sono trasversali e coinvolgono tutte le generazioni», ma sono gli studenti la forza trainante del movimento. «Migliaia di giovani sono disposti a camminare per decine di chilometri -sfidando i blocchi del trasporto pubblico- pur di partecipare alle manifestazioni. Lungo il cammino vengono accolti come dei liberatori e ri-
SERBIA
cevono cibo, acqua e alloggi gratuiti».
Mihajlo descrive le manifestazioni come «pacifiche e prive di violenza». Non sono mancati, tuttavia, episodi di vandalismo e disordini, cui il presidente Vučić si è appellato per screditare il movimento. Dopo i tumulti del 5 novembre a Novi Sad, Vučić ha promesso il pugno di ferro contro i manifestanti, paragonando l’assalto al Municipio agli attacchi nazisti di novant’anni fa: «Tutti i partecipanti saranno puniti. Non succederà più che qualcosa di simile si ripeta nel nostro Paese».
Alle minacce sono seguiti i fatti, con una serie di arresti e azioni legali contro i rivoltosi. In diversi casi la polizia ha fatto ricorso a cariche con manganelli. Nella recente manifestazione del 15 marzo a Belgrado, le forze dell’ordine sono state accusate di aver impiegato armi soniche per disperdere i partecipanti.
no il presidente di aver sfruttato la televisione di Stato (Radio-televizija Srbije, Rts) per diffondere fake news e messaggi propagandistici. In particolare, la Rts è stata criticata per aver rilanciato le affermazioni di Vučić secondo cui le proteste sarebbero state finanziate da servizi segreti stranieri con l’obiettivo di destabilizzare il governo. Mihajlo racconta: «Ogni giorno provano a riempirci di menzogne e quasi tutti i media sono coinvolti. Al presidente è concesso di fare i suoi proclami straordinari su base quotidiana, senza alcun contraddittorio».
«Una mano sporca di sangue
con scritto "Your hands are bloody" è il nostro slogan»
La dura reazione delle istituzioni ha contribuito ad accrescere il malcontento, come anche i tentativi di manipolare l’opinione pubblica. I manifestanti accusa-
La rabbia nei confronti dell’attuale governo ha radici profonde. Negli anni Vučić è stato accusato di corruzione e autocrazia e il suo partito è ritenuto responsabile di una spirale di violenza nel Paese. «Negli ultimi anni la Serbia è stata toccata da diverse tragedie. Il 3 maggio 2023 un ragazzino di 13 anni ha aperto il fuoco in una scuola di Belgrado, uccidendo dieci persone tra bambini e addetti alla sicurezza. Il giorno dopo, 4 maggio, un altro massacro: nove persone sono state assassinate a colpi di pistola nei villaggi di Dubona e Malo Orašje».
In seguito alle sparatorie il presidente ha inasprito i controlli per ottenere il porto d’armi ma secondo l’opposizione non avrebbe fatto abbastanza.
Negli ultimi mesi i manifestanti sono stati vittime di violente aggressioni, con percosse o armi bianche. In alcune occasioni (1 dicembre, 16 gennaio, 31 genna-


io) delle auto sono state lanciate a tutta velocità contro i cortei, causando diversi feriti. In seguito al primo di questi attacchi Vučić ha dichiarato «folle» la richiesta di arrestare il conducente, che «stava semplicemente passando di lì».
«Una mano sporca di sangue, con scritto “Your hands are bloody”. È questo il nostro slogan», spiega Mihajlo. «Descrive bene il livello di corruzione del nostro governo, capace di uccidere i cittadini con la sua negligenza».
Il 17 gennaio scorso, durante un sitin di protesta davanti agli studi televisivi della Rts, i manifestanti hanno diffuso una registrazione audio con tutte le loro istanze: la pubblicazione dei documenti riservati sull'incidente del 1° novembre, l'archiviazione delle accuse contro gli studenti e gli attivisti arrestati, l'avvio di procedimenti penali contro gli aggressori dei manifestanti e un aumento del 20% del budget pubblico per le università.
A queste si aggiunge oggi una quinta richiesta: ottenere risposte sul presunto uso di armi soniche durante la manifestazione del 15 marzo.
La posizione di Vučić intanto inizia a vacillare sotto i colpi inferti della “rivoluzione colorata”, come lui stesso l’ha definita. In seguito alla grande manifestazione di Belgrado del 15 marzo (300.000 partecipanti secondo la stampa internazionale, 100.000 in base ai calcoli del governo), il primo ministro Miloš Vučević ha annunciato le dimissioni e il presidente si dice adesso pronto a indire nuove elezioni.
«È un grande momento per il nostro Paese», conclude Mihajlo. «Con il sostegno che ci arriva dal resto del mondo, è la nostra occasione per ricreare una Serbia unita e in armonia». ■

Così giovani così estremisti
Gli analisti hanno studiato la forte polarizzazione del voto alle elezioni per il Bundestag del 23 febbraio 2025, in cui il partito AfD è arrivato secondo con il 21%
«Una vittoria storica» ha commentato Friedrich Merz, leader dei cristiano-democratici della Cdu che con il 28,52% dei voti è diventato il partito di maggioranza al Bundestag. Una percentuale che però non permette ai cristiano-democratici di governare da soli. L’aspetto più interessante di questo voto sono le percentuali raggiunte dai due partiti che siedono nelle aree più estreme del Parlamento: die Linke, partito della sinistra radicale e Alternative für Deutschland, formazione di estrema destra. Il partito guidato da Alice Weidel ha raggiunto il 20,8%, duplicando i voti presi nel 2021. Die Linke, che fino a dicembre 2024 era secondo i sondaggi sotto alla soglia del 5%, ha avuto una crescita rapida che lo ha portato a raggiungere quasi il 9% e si è affermato come prima forza politica nella capitale Berlino.
«Il voto giovanile ha visto una sorta di polarizzazione, la maggior parte dei giovani ha votato Die Linke ma è andato molto bene anche AfD» commenta Ubaldo Villani, Professore di Storia delle Istituzioni Politiche presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento. Le ragioni di questi risultati sono diverse: «Questi partiti hanno una comunicazione moderna ed efficace nei social network - afferma il professore - dall’altro un elettore molto giovane vota senza la costruzione intellettuale storica che può
avere un elettore più adulto». La chiave di forza di questi partiti politici, secondo l’esperto, risiede in una comunicazione funzionale che adotta un linguaggio semplice e diretto.
Analizzando le percentuali di voto, i cristiano-democratici hanno vinto con il 28,52% delle preferenze mentre i socialdemocratici si sono fermati al 16,41%. «Il voto dei giovani non va sovrastimato - afferma Villani - si tratta di un voto marginale rispetto al complesso delle elezioni tedesche, mutazioni che valgono ad ogni competizione elettorale tendendo ad essere variabili nel tempo».
«Considerare AfD come fenomeno legato alla zona della ex Ddr [Repubblica Democratica Tedesca] è riduttivo», prosegue il professore. Il partito di Alice Weidel ha raggiunto il 21% affermandosi come secondo partito dietro Cdu. Ha raddoppiato i voti rispetto all’elezione del 2021 e vede aumentare i seggi in parlamento a 152. «Ha raggiunto consensi anche ad ovest prendendo voti trasversali in tutte le classi sociali» sostiene Villani. Il contesto internazionale ha anche influito sul successo del partito. Per Villani «AfD ha una posizione molto rigida sull’aiuto all’Ucraina». Inoltre, gli appoggi internazionali della nuova presidenza americana hanno dato vigore al movimento. «Alla confe-
renza per la sicurezza di Monaco, il Vice Presidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha calorosamente salutato Alice Weidel», commettendo uno sgarbo istituzionale grave nei confronti dell’allora Cancelliere Olaf Scholz.
Comunicazione semplice, uso dei social media, messaggi funzionali diretti agli elettori: la comunicazione è forse la vera chiave di lettura di questo voto. Die Linke, partito che per due anni era rimasto sotto la soglia di sbarramento, in poche settimane è riuscito a raggiungere 8,8% ed è stato votato dal 25% dei giovani. ■

di Stefania Da Lozzo
GERMANIA
1. Alice Weidel, capo di AfD 2. Il Bundestag tedesco a Berlino

L'Europa alle armi
DIFESA
ReArm Eu è il nuovo piano presentato dalla Commissione ai primi di marzo e criticato da molti
di Michelangelo Gennaro
Prendete il prodotto interno lordo di Taiwan e spendetelo in armi. Neanche così tocchereste gli 800 miliardi di euro annunciati da Ursula von der Leyen per riarmare l’Europa. Il 19 marzo la presidente della Commissione ha presentato il Libro bianco per la difesa europea, fissando una tabella di marcia fino al 2030. Nel documento strategico approvato dall’Europarlamento, il sostegno all’Ucraina è la priorità immediata a cui si affianca l’aumento di medio termine della produzione bellica. Sono previsti 150 miliardi di prestiti garantiti dall’Unione europea, a patto che il 65% delle attrezzature arrivino da fornitori dell’Ue, di Ucraina e Norvegia.
I restanti 650 miliardi saranno a carico degli Stati membri, chiamati ad alzare dell’1,5% del Pil le spese militari, come previsto dal programma ReArm Europe presentato da von der Leyen il 4 marzo. Gli investimenti in difesa verranno slegati dal Patto di stabilità sui deficit nazionali, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione delle industrie belliche del continente. La decisione è arrivata dopo che il presidente Donald Trump ha messo in discussione lo scudo militare garantito dagli Stati Uniti.
Le lacune nei settori strategici partono dalla mobilità. «Nel 2021 gli europei si sono appoggiati agli aerei americani per riportare a casa lo staff impegnato in Af-
ghanistan», racconta il ricercatore dell’Istituto affari internazionali Elio Calcagno. I Paesi dell’Ue sono all’avanguardia nella produzione di caccia come gli Eurofighter e carri armati come i Leopard tedeschi.
Non hanno però un sistema satellitare paragonabile a Starlink, la flotta di Elon Musk vitale per la resistenza ucraina contro l’invasione russa, con oltre seimila satelliti operativi. «Costruire un’alternativa europea è una sfida enorme», prosegue Calcagno, «che non dipende solo dai soldi. Richiede decenni e la capacità di fare uno sforzo congiunto, per valutare quali sono le minacce e come affrontarle».
Nel piano di riarmo vuole inserirsi la Gran Bretagna, con il premier Keir Starmer che cerca un’intesa con Bruxelles. Secondo il quotidiano Daily Telegraph, Starmer punta a far classificare come europee le aziende belliche del Regno Unito per intercettare gli investimenti. Una partnership a cui si oppone il presidente francese Emmanuel Macron, per evitare la concorrenza dei produttori britannici.
«Privarsi del contributo inglese sarebbe miope», prosegue l’esperto dell’Istituto affari internazionali, «parliamo di un Paese che spende 70 miliardi in difesa ogni anno», oltre il doppio dell’Italia. Londra ha anche un ruolo di primo piano nello
sviluppo dell’intelligenza artificiale.
Tra il 2021 e il 2024, la spesa militare degli Stati membri dell’Ue è aumentata di oltre il 30%. Nel 2024, ha raggiunto la cifra stimata di 326 miliardi di euro (1,9% del Pil dell'Unione), un terzo del budget della difesa statunitense secondo l’International Institute for Strategic Studies. Un report dell’Osservatorio conti pubblici italiani ha paragonato le spese militari a parità di potere d’acquisto, rilevando che i Paesi europei dell’Alleanza atlantica spendono il 58% in più rispetto alla Russia. Tuttavia i governi del continente non fanno acquisti condivisi, utili ad abbassare i prezzi e semplificare la collaborazione tra eserciti nazionali.
Resta distante l’ipotesi della difesa comune europea. «Non si può fare dall’oggi al domani, mentre un migliore coordinamento delle forze è realistico nel breve termine», afferma il colonnello Franco Di Santo, esperto di strategia ed ex direttore della Rivista militare. «La prospettiva è di ricerca, sviluppo e produzione degli armamenti», afferma l’ufficiale, «per rafforzare il pilastro europeo della Nato». ■

1. La Presidente Ursula von der Leyen

«I nostri prodotti vanno difesi»
Beatrice Ughi, fondatrice di Gustiamo, porta l’autenticità dei prodotti italiani nel Bronx mentre affronta le sfide delle tariffe imposte dall’amministrazione Trump
di Asia Buconi
Portare un pizzico d'Italia nel Bronx. Da oltre venticinque anni è questa la mission di Beatrice Ughi, fondatrice di Gustiamo, un'azienda che importa negli States prodotti italiani di alta qualità. Un impegno, il suo, che le è valso l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica, consegnatale proprio al consolato di New York. "Guerrigliera del Gusto e del Giusto", come si definisce sui social, oggi Ughi è una dei molti imprenditori che si trova a fare i conti con i dazi annunciati (o minacciati) dall'amministrazione di Donald Trump.
Come nasce Gustiamo e con quale scopo?
Nasce 25 anni fa. Noi vogliamo rappresentare i bravi contadini, i piccoli produttori e i pescatori italiani negli Stati Uniti. E quindi cercare, nel nostro piccolo, di rappresentare l'Italia migliore, che lavora e che è custode del territorio.
Quali prodotti vendete? E quali sono i più richiesti?
Noi acquistiamo dall'Italia e teniamo nel nostro magazzino nel Bronx vari prodotti, visibili anche sul nostro sito, che serve tutti gli Usa. Vendiamo pasta artigianale, pomodori di diversi contadini italiani,
— Zeta
in particolare San Marzano, ma quelli veri. Qui negli Usa le etichette riportano spesso la scritta "San Marzano", ma in realtà pochissimi lo sono davvero. Altro nostro prodotto di punta è l'olio extravergine di oliva, che prendiamo da produttori della Sicilia, della Sardegna, ma anche del Molise, dell'Umbria. Importiamo anche pesce e mandorle dalla Sicilia, ma anche nocciole dal Piemonte.
Chi sono i vostri clienti?
I nostri prodotti finiscono nei ristoranti e nelle gastronomie di tutti gli Stati Uniti, da New York alla costa orientale, ma anche molto in California, in Texas, nel Tennessee. I nostri clienti sono chef, per lo più americani, che hanno un enorme rispetto per la cultura e i prodotti veri italiani.
Pensa alle conseguenze dei dazi minacciati da Trump verso i prodotti europei?
Tendo a non fare speculazioni. Adesso l'amministrazione Usa è imprevedibile, i danni fatti alle conquiste che avevamo raggiunto in merito al rispetto del pianeta, delle generazioni future, sono enormi. Sono quindi preoccupata in generale per
ciò che sta accadendo. Sui dazi - annunciati, ritirati, poi ripresi, prima del 100%, poi del 200%, ogni giorno cambiano - io cerco di non fare previsioni. E questo mi porta a non prendere particolari decisioni imprenditoriali in questo senso.
I dazi sono un problema solo di oggi?
I dazi qui già esistono per i prodotti alimentari. Il tonno paga il 35%, la pasta artigianale il 20%, i pomodori dal 9 all'11%.
Per cui già soffriamo i dazi. Semmai dovessero arrivare al 200%, come ha minacciato Trump, sarebbe un brutto momento per i prodotti agricoli italiani, specialmente per quelli fatti bene, da produttori che rispettano i processi produttivi giusti.
Perché?
I prodotti che noi importiamo sono di qualità, quelli che costano di più. Ad esempio, un prodotto che l'Italia esporta negli Usa e proviene dalla Cina costa poco e il dazio quindi incide di poco. Sul prodotto vero italiano, invece, il dazio è esponenzialmente più importante. ■
1. Beatrice Ughi, Gustiamo
DAZI

La Germania abbandona il rigore
PIL
Cambia la costituzione tedesca e Berlino rinuncia all'austerity dopo tre anni di crisi
di Alessandro Imperiali
In una seduta storica, il Bundestag ha dato il via libera alla revisione costituzionale voluta da popolari e socialdemocratici, con il supporto dei Verdi, per allentare il freno al debito previsto dalla Legge fondamentale. La Germania rompe il rigore fiscale con un maxi-indebitamento di oltre mille miliardi per difesa, infrastrutture e transizione ecologica. Friedrich Merz, leader della Cdu e prossimo cancelliere, ha argomentato questa scelta con il mutato contesto geopolitico, attribuendo alla guerra di Vladimir Putin non solo contro l'Ucraina, ma anche contro l'Europa, la necessità di rafforzare la sicurezza nazionale. Secondo Merz, la Germania subisce attacchi quotidiani attraverso strumenti di guerra ibrida, rendendo necessario un incremento della spesa militare, esentato dai limiti di bilancio se superiore all'1% del Pil.
Questo cambio di passo segna una rottura con la tradizionale ortodossia economica tedesca. «La Germania si è trovata bloccata per una combinazione di fattori economici e scelte politiche», afferma Federico Niglia, professore di storia internazionale. «I precedenti governi – continua- hanno tentato una transizione nel settore energetico, ma il peggioramento del quadro geopolitico ha generato un au-
mento esponenziale dei costi, colpendo duramente comparti strategici come l'automotive, già in fase di ristrutturazione».
L'incremento dell'indebitamento non si limiterà al settore militare, ma riguarderà anche le infrastrutture e il rilancio di un'economia in difficoltà, che rischia di registrare un terzo anno consecutivo di recessione nel 2025. Il nuovo piano economico rappresenta anche una risposta al crescente isolamento dell’Europa da parte degli Stati Uniti.
«L'industria della difesa tedesca era rimasta in secondo piano per anni, ma ora sta vivendo una rapida crescita e potrebbe rivelarsi un motore per l’economia - sottolinea Niglia - Rearm Europe è un'opportunità importante, ma restano molte incognite sulla sua attuazione». Nonostante la spinta agli investimenti, restano nodi da sciogliere. «Le risorse da sole non bastano», avverte il socialdemocratico Lars Klingbeil. Servono riforme per «ridurre la dipendenza dallo Stato e garantire un uso più efficiente delle risorse pubbliche».
Un altro settore chiave è l’industria automobilistica, cruciale non solo per la Germania ma per l’intera Europa. «L'automotive è un pilastro economico inter-
connesso- spiega Niglia - con numerosi Paesi europei, dall’Italia alla Polonia. La vera sfida sarà fronteggiare la concorrenza cinese, caratterizzata da costi ridotti e forti sovvenzioni statali. Berlino dovrà decidere se introdurre misure protezionistiche, come dazi, o puntare su una regolamentazione che prevenga distorsioni della concorrenza». L'ultimo ostacolo sarà l'approvazione del Bundesrat il 21 marzo.
Nonostante il contesto politico incerto, Merz potrebbe avere un'opportunità unica. «A differenza di Scholz, ha la possibilità di rafforzare l'integrazione europea in un momento cruciale. La politica è fatta di capacità strategica, ma anche di tempismo, e Merz potrebbe rivelarsi fortunato. Nonostante l'etichetta di anti-Merkel, non è escluso che adotti strategie in parte in continuità con quelle dell'ex cancelliera», osserva Niglia.
Investire massicciamente per garantire sicurezza e crescita economica oppure cercare un equilibrio tra espansione e rigore fiscale. Berlino scommette sul debito per riaffermare la propria leadership in Europa, ma dovrà affrontare le conseguenze di una decisione che potrebbe ridefinire il suo ruolo economico e politico nel lungo periodo. ■

Teticum, il commesso virtuale pensato per l’e-commerce
La storia di una giovane startup nata dal coraggio di un gruppo di amici che ha trasformato la propria formazione in un progetto imprenditoriale
«Teticum è nato come un sogno condiviso tra amici, un progetto che ha preso forma mentre ancora studiavamo all’università», racconta fiero Alessandro Ceni, uno dei fondatori della startup, insieme a Pio Scielzo, Lorenzo Cardini e Valerio Ginestroni. «Volevamo costruire qualcosa di nostro, qualcosa che potesse cambiare veramente il modo in cui le persone acquistano online», continua.
Teticum sviluppa assistenti virtuali per e-commerce con due obiettivi chiari: accompagnare l'acquirente nell’intero processo d’acquisto suggerendo il prodotto giusto, ed estrarre informazioni utili dalle interazioni - in forma aggregata e anonima - per offrire ai venditori una visione complessiva dei bisogni dei clienti attraverso una dashboard intuitiva, ovvero un pannello di monitoraggio.
vogliamo portare l’esperienza umana del commesso, quello che ti ascolta, capisce cosa cerchi e ti accompagna nella scelta, anche nel mondo digitale», prosegue Ceni: «Molti e-commerce non sanno nemmeno perché le persone escono dal sito senza comprare. Noi vogliamo dare loro gli strumenti per capirlo e agire».
«In un negozio fisico il personale ti accoglie, ti ascolta e ti guida. Online invece ti trovi davanti a una vasta scelta senza nessun aiuto. In media nei negozi fisici 30 persone su 100 comprano, mentre online solo 2 su 100 concludono un acquisto, nonostante gli enormi investimenti in marketing. E soprattutto, non si ha modo di capire bene perché gli altri 98 se ne vanno», puntualizza il ragazzo.
di Matilde Nardi
«Oggi i siti sono pieni di filtri, migliaia di articoli, e pochissimo supporto. Noi
Ceni, Scielzo e Cardini si sono conosciuti durante la triennale in Ingegneria a Firenze, ma è stato durante l’esperienza della magistrale con doppia laurea a Lu-
cerna, in Svizzera, che il legame si è consolidato: un anno e mezzo di convivenza, studio e lavoro fianco a fianco che ha gettato le basi per la nascita di Teticum «Siamo stati i primi studenti di Firenze ad accedere alla doppia laurea con l’università di Lucerna. Dopo un anno e mezzo in Svizzera, ci siamo laureati il 30 gennaio lì, e il 19 febbraio in Italia. E cinque giorni dopo abbiamo fondato Teticum», racconta Ceni.
A loro si è unito ufficialmente dal 1° febbraio 2025 Valerio Ginestroni, classe 1997, sviluppatore di software esperto, fondatore di una sua azienda tech e amico di Scielzo. «Valerio è una persona con un forte background tecnico ma allo stesso tempo dotata di ottime capacità di relazioni umane, insomma un connubio perfetto tra tecnologia e imprenditoria», con queste parole lo descrivono i suoi colleghi in Teticum.
Nei primi mesi, i cofondatori hanno fatto di tutto spaziando da un’attività all’altra: sviluppo del prodotto, contatti con gli investitori, organizzazione di eventi e gestione di possibili clienti. «Eravamo in pochi e con risorse limitate, ma abbiamo sempre avuto grande determinazione e voglia di fare». Ora i ruoli sono strutturati: Ceni guida la parte commerciale, Cardini si occupa della pianificazione operativa, Scielzo cura la visione strategica, e Ginestroni segue lo sviluppo tecnologico. «Ci dividiamo le responsabilità, ma condividiamo ogni passo».
Un traguardo importante arriva con la selezione per Hubble, il programma di accelerazione di Nana Bianca, uno startup studio nato nel 2012 - con sede a Firenze - in cui orbitano aziende e startup e liberi professionisti attivi nella rivoluzione digitale e nel campo dell’innovazione: «Essere tra le sei startup scelte in Toscana è stato un riconoscimento del nostro impegno e una validazione del problema che vogliamo risolvere», afferma Ceni.
Oggi Teticum lavora con due aziende di moda e un e-commerce vinicolo. Ma guarda avanti con la volontà di crescere: «Vogliamo espanderci in nuovi settori, dalla cosmetica alla parafarmaceutica. Il nostro agente virtuale si può adattare ad ogni contesto, riuscendo in futuro non solo a consigliare il prodotto ideale ma anche la persona o il servizio migliore per l'utente».
Sebbene il cuore tecnologico di Teticum sia l'intelligenza artificiale, la vera sfida è integrarla in una soluzione che mantenga un autentico tocco umano. Per
questo la squadra dedica tempo e risorse allo studio e all'integrazione dei modelli di intelligenza artificiale, mantenendo sempre un dialogo costante con i clienti e garantendo un'esperienza che metta al centro l’essere umano.
«Il nostro è un agente virtuale che sa conversare ed eseguire compiti per l'utente proprio come farebbe un commesso»
Ceni punta ad aprire, nel breve periodo, un canale su Instagram e TikTok «per far conoscere il lavoro», e precisa:
«Il nostro è un agente virtuale in grado di conversare e eseguire compiti per l'utente proprio come farebbe un commesso, non un semplice chatbot, che rimane nei confini di un livello puramente conversazionale».
Teticum è una startup giovane, fresca e piena di energia. È nata dal coraggio di un gruppo di amici che ha trasformato il legame interpersonale e la propria formazione in un progetto imprenditoriale ambizioso. Nonostante le difficoltà tipiche di ogni inizio, il team ha scelto di costruire qualcosa di concreto e utile, con l’obiettivo di innovare l’esperienza d’acquisto online. Ceni si descrive ottimista per ciò che verrà e conclude con un messaggio diretto a chi voglia iniziare un percorso imprenditoriale: «Non serve aspettare il momento giusto per cominciare ma serve solo crederci a fondo e circondarsi delle persone giuste». ■


Tampon tax, la battaglia dei giovani
Una proposta di iniziativa popolare chiede un taglio al 5% all'Iva sugli assorbenti
di Federica Carlino
«Non vogliamo che questa diventi una battaglia politica, ma un tema condiviso da tutti». Con queste parole Luca Frescura, presidente dell’associazione giovanile Giovani e Futuro, riassume il cuore di una proposta di legge di iniziativa popolare che mira ad abbassare l’Iva sui prodotti per l’igiene femminile e per la prima infanzia. La raccolta è stata avviata da un gruppo di giovanissimi con un’età media di appena 23,1 anni, e ha già raggiunto il 14% delle firme necessarie.
Ad oggi in Italia i prodotti essenziali come assorbenti, coppette mestruali, pannolini e latte per neonati sono tassati al 10%. Ancora più alta l’aliquota sui seggiolini per auto fissata al 22%. La proposta di legge, denominata “Legge Frescura–Menia Corbanese–Belfi”, chiede una riduzione dell’Iva al 5%, in questo modo ci si allineerebbe agli altri paesi europei che hanno già adottato misure simili. In
Francia l’Iva sugli assorbenti è al 5,5%, in Germania al 7%, mentre Spagna e Regno Unito hanno già eliminato la tampon tax.
L’Italia, invece, aveva abbassato l’aliquota al 5% con la legge di bilancio 2022, salvo poi riportarla al 10% nel 2023. «Una scelta che non abbiamo compreso - spiega Frescura - perché l’impatto economico per lo Stato sarebbe stato contenuto, ma il beneficio per le famiglie enorme». A differenza di molte altre petizioni online, questa iniziativa popolare: «Non è solo una richiesta simbolica: ma è un testo legislativo a tutti gli effetti».
Un altro punto di forza del progetto è l’indicazione chiara delle coperture economiche. La riduzione dell’Iva avrebbe un costo stimato di circa 180 milioni di euro annui, cifra che i promotori propongono di ricavare dalla riduzione delle dotazioni finanziarie della Camera dei deputati e del Senato.
«Nel 2020 gli italiani hanno votato per il taglio degli onorevoli, ma il bilancio del Parlamento è rimasto invariato. È il momento di utilizzare quelle risorse per aiutare le famiglie». La sensibilità per il tema e la voglia di fare qualcosa di concreto incentiva gli organizzatori: «Abbiamo visto in passato altre proposte simili arenarsi. Non vogliamo che accada lo stesso con questa». Il rischio, secondo lui, è che
il tema diventi oggetto di battaglia politica tra maggioranza e opposizione: «Non deve essere un pretesto per attaccare il governo, ma un’iniziativa di civiltà. Tutti dovrebbero sostenerla».
La questione della tampon tax in Italia è da anni al centro del dibattito pubblico. La proposta di legge di iniziativa popolare si inserisce quindi in un percorso già avviato ma ancora incompleto, e punta a colmare quel divario fiscale che pesa sulle donne e sulle famiglie italiane. Secondo l’Unione Europea, almeno una ragazza su dieci nel continente non può permettersi prodotti sanitari adeguati, mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che nel 2020 ben 5,6 miliardi di persone vivevano in condizioni di scarso accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. La combinazione di questi fattori rende ancora più urgente un’azione politica concreta. ■

EQUITÀ

Se l’eccesso di informazioni diventa un problema
Il sovraccarico informativo che compromette la concentrazione e il benessere mentale di
Matilda Ferraris
Viviamo in un’epoca dominata dall’informazione. Ogni giorno siamo sommersi da notizie, aggiornamenti, notifiche e contenuti digitali che invadono le nostre giornate. Internet e i social media ci hanno dato un accesso senza precedenti a dati di ogni genere, ma questa sovrabbondanza sta creando una condizione sempre più diffusa: l’infobesità, un eccesso di informazioni che può avere conseguenze negative sulla nostra capacità di concentrazione, sulle nostre decisioni e persino sulla nostra salute mentale.
Il termine infobesità, derivato dall’inglese infobesity o information overload, descrive la difficoltà crescente di elaborare e gestire il volume impressionante di dati a cui siamo esposti. Se in passato la sfida era accedere alle notizie, oggi il problema è opposto: la quantità di contenuti disponibili è tale da rendere difficile distinguere ciò che è rilevante da ciò che non lo è, ciò che è affidabile da ciò che è fuorviante. Il fenomeno è alimentato da diversi fattori. Innanzitutto, la diffusione di internet ha reso possibile l’accesso istantaneo a qualsiasi tipo di informazione, spesso senza filtri di qualità. Inoltre, i social media e le piattaforme digitali incentivano un consumo continuo e com-
pulsivo, con algoritmi progettati per catturare la nostra attenzione il più a lungo possibile. Le notifiche costanti, la paura di perdersi qualcosa di importante e la moltiplicazione delle fonti ci spingono a un’assimilazione incessante, che spesso diventa più un’ansia che un reale bisogno.
Uno degli effetti più evidenti è la difficoltà di concentrazione: il cervello, bombardato da stimoli continui, fatica a focalizzarsi su un’attività alla volta. Leggere un libro senza essere interrotti da notifiche o completare un compito senza la tentazione di controllare il telefono sta diventando sempre più difficile. A questo si aggiunge la cosiddetta “paralisi decisionale”: quando abbiamo troppe informazioni a disposizione, scegliere diventa un compito più complicato, perché ogni nuova variabile sembra aggiungere un livello di incertezza.
Di fronte a questo sovraccarico informativo, poi, c’è chi sceglie di ritirarsi. È il caso di Berenice, 25 anni, che di fronte a una mole sempre più alta di aggiornamenti “mordi e fuggi” ha scelto di smettere di affidarsi ai media tradizionali come fonte principale. «Da tempo ho deciso di non accettare passivamente tutte le informa-
zioni che ricevo, consapevole dell’enorme accessibilità ai contenuti e della loro natura spesso contraddittoria. Per questo ho adottato una sorta di "agnosticismo informativo": non assorbo indiscriminatamente ciò che mi arriva, ma seleziono con attenzione quello che voglio approfondire. Cerco di limitare l’esposizione a elementi superflui o invasivi, soprattutto sui social, dove i cosiddetti "trigger warning" mi sembrano una soluzione troppo superficiale rispetto alla reale necessità di una maggiore consapevolezza visiva e sonora».
Ma non è solo una questione di produttività. Il sovraccarico di notizie può generare stress e ansia. Essere costantemente esposti a aggiornamenti – spesso negativi o allarmanti – può creare un senso di sopraffazione e impotenza: «Ho smesso completamente di guardare il telegiornale, perché mi trasmetteva solo eventi devastanti accompagnati da immagini impattanti. Per proteggere il mio benessere emotivo, ho scelto di fare un passo indietro e accettare questa mia necessità. Questo non significa che io sia disinformata, ma che seleziono con cura ciò che voglio sapere, evitando l’eccesso di contenuti» conclude Berenice. ■

«Dare un senso al tempo»
la vita dentro al carcere
Restituire un significato alle vite trascorse dietro le sbarre non è cosa da poco. Un’importante iniziativa a riguardo arriva da Perugia
«La peggior sensazione che dà il carcere è quella di trascorrere una vita vuota: se passi giorni e giorni senza nessun senso la tua disperazione ti porta al suicidio», sono le parole di Emilio Santoro, professore di Filosofia del diritto dell’università di Firenze e presidente del comitato scientifico dell’associazione L’altro diritto. Secondo l’organizzazione Antigone, nel 2024 sono state ottantotto le persone che si sono tolte la vita nei penitenziari: un dato che ha superato il triste record del 2022, quando i casi sono stati ottantacinque. Dall’inizio dell’anno fino al 15 marzo invece, i morti per suicidio negli istituti di pena sono già stati diciassette.
comunale di arrivare alla sottoscrizione di un protocollo che consenta alle persone coinvolte in procedimenti penali, detenuti compresi, di partecipare alle attività sportive e di svolgere lavori socialmente utili all’interno di questi contesti, compresi quelli legati alla cura delle disabilità e presso la Croce Rossa.
di Alessandro Villari
In questa situazione, restituire significato alle vite trascorse dietro le sbarre non è cosa da poco. Un’importante iniziativa a riguardo arriva da Perugia: il 14 febbraio scorso, l’assessore allo Sport Pierluigi Vossi ha proposto nella giunta
L’assessore ha unito le sue due passioni: lo sport e il diritto. Avvocato da ventisette anni, fa parte del Consiglio nazionale forense, ma da ragazzo ha giocato nelle giovanili del Perugia fino ad arrivare in Serie C e ora è vicepresidente vicario dell’Associazione italiana allenatori di calcio. «Ho sentito l’esigenza, anche con gli altri colleghi dell’Ordine di Perugia, di redigere un protocollo dove emerge la volontà di andare a prendere quelle fragilità, tra adulti e minori, e farle immergere in una realtà, come quella sportiva, che magari non hanno mai frequentato». Lo scopo è quello di imparare a riconoscer-
GIUSTIZIA
si nei valori della competizione: sacrificio, bellezza e sano agonismo. Uno degli aspetti centrali dell’accordo è la possibilità di applicare misure alternative alla detenzione, come il lavoro di pubblica utilità favorendo percorsi educativi che rafforzino il senso di responsabilità individuale e tentino di dare un’ancora di salvezza per chi è in cella: «Lo sport dà la possibilità di sfogarsi e liberare energie positive. L’iniziativa segue l’esempio di Milano e Roma che hanno già lavorato in questa direzione e si potrebbe anche esportare il modello a livello nazionale», commenta l’assessore.
La vera importanza di progetti del genere consiste nel ridare un senso alla vita, nel concepire in maniera costruttiva la detenzione e di «restituire valore al tempo buttato via, sensazione che rende avvilente l’esistenza del singolo», commenta Santoro. E si può raggiungere questo scopo istituendo nelle carceri corsi che tengano impegnato in maniera assennata il detenuto. Ed è proprio sul concetto di responsabilità che insiste il professore facendo un distinguo tra la nostra cultura e quella del nord Europa: «Noi stiamo continuando a parlare di carcere-rieducativo, invece in altri Paesi ha attecchito la definizione di carcereresponsabilizzante che consiste nell’autonomizzare i prigionieri e non renderli dipendenti dall’istituzione».
Da quelle parti, racconta Santoro, il carcere è organizzato come se fosse una specie di college o di residenza universitaria, perché i detenuti hanno perfino dei
soldi da amministrare e sono organizzati con le cucine in comune dove possono prepararsi i pasti. In Norvegia, le prigioni sono strutturate ad albero come un paese del Far West con una strada principale che divide da una parte le diverse attività da svolgere e dall’altra le celle.
Nel secolo precedente ci sono stati alcuni tentativi di migliorare la situazione. Nel 1940 il sociologo americano Donald Clemmer pubblicò un saggio, The Prison Community, in cui sosteneva che le carceri non creano socializzazione, ma prigionizzano e abituano le persone alla vita carceraria che è del tutto diversa rispetto a quella esterna. In ambienti di questo tipo risulta quasi impossibile impedire l’effetto distruttivo del socializzante annichilimento della detenzione.
Uno dei maggiori architetti italiani del XX secolo, Giovanni Michelucci, che ha progettato anche la stazione di Firenze Santa Maria Novella e la chiesa di San Giovanni Battista, sognava una città in cui l’istituto penitenziario non fosse inteso né come concetto né come luogo. Diceva di voler rendere il penitenziario una parte del paese e far diventare la vita dei detenuti il più possibile simile a quella esterna: quando ha costruito un giardino dentro il carcere Solliciano di Firenze lo ha chiamato il “Giardino degli incontri” proprio per questo motivo.
Purtroppo, l’approccio carcerario dominante in Italia è figlio della cultura lombrosiana: Cesare Lombroso è stato un medico, antropologo, filosofo, giurista
e criminologo italiano. Influenzato dalla fisiognomica, dal darwinismo sociale e dalla frenologia, è il fondatore dell’antropologia culturale. Le sue teorie si fondano sul concetto del criminale per nascita: le origini del comportamento criminoso sono connaturate nelle caratteristiche anatomiche di una persona ed è quindi la genetica a determinare la differenza tra un delinquente e un bravo cittadino.
L’unico approccio utile per redimerlo era far ricorso al trattamento clinicoterapeutico. «Da questo orientamento è derivata la concezione secondo cui se un criminale è autonomo commette i reati e quindi bisogna togliergli l’autonomia. Il concetto stesso di rieducazione è figlio dell’idea che esista un criminale da rieducare».
Sono anni che le associazioni per i diritti dei carcerati si battono affinché la situazione nelle carceri cambi, ma «finché ci sarà un sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia che dice di provare gioia nel togliere il respiro ai detenuti in regime di massima sicurezza è inutile dire qualsiasi cosa». Il riferimento è alla frase che Andrea Delmastro Delle Vedove di Fratelli d’Italia ha pronunciato durante la presentazione dell’autovettura blindata del Dipartimento dell’autorità giudiziaria (Dap) che ha suscitato non poche polemiche. La politica è simbolica e il diritto penale è simbolico per eccellenza: «Le manifestazioni in piazza non sono la soluzione, bisogna ridare un senso al tempo che i detenuti passano nelle carceri e responsabilizzarli». ■

Cultura

Alle radici del sentimento, i versi di Michele Urrasio
LETTERATURA
Malattia e cura, sussurro e forza dirompente, la poesia è un viaggio nel paesaggio dell’anima umana
di Lavinia Monaco
«Oggi sembra che non ci sia più bisogno della poesia. Sembra che i poeti siano diventati una voce inascoltata in un mondo dominato da miseria morale, superficialità e indifferenza. Ma non è così. Proprio perché viviamo in tempi convulsi e assurdi, la poesia ci dà l’occasione di ripiegarci in noi stessi, di riscoprirci affranti dalla solitudine e dall’abbandono, per poi restituirci rinnovati e interi al mondo».
Parole dense di significato che Michele Urrasio pronuncia con una convinzione e un’intensità tali da incantare chiunque abbia la fortuna di assistere ad una delle lezioni che tiene di tanto in tanto in università e circoli culturali. Poco tempo fa è stata pubblicata la sua ultima raccolta di componimenti scritti in vernacolo, Frónna jelate sott’a lune (Una fo -
glia gelata sotto la luna), a cui, assicura, ne seguiranno presto delle altre.
Nato ottantotto anni fa ad Alberona, un piccolo borgo arrampicato sui Monti Dauni, in Puglia, si cimenta per la prima volta nella composizione di versi durante le scuole medie. Nel 1965 pubblica la sua prima raccolta, Fibra su Fibra, che gli regala un po’ di visibilità e le prime collaborazioni con giornali letterari.
Ma è nel 1970 con il Premio letterario “Umberto Bozzini”, conferitogli da una giuria presieduta dal famoso storico della letteratura italiana Mario Sansone, che avviene la sua consacrazione come poeta. Da quel momento in poi, la sua copiosa produzione lirica otterrà il plauso di pubblico e critica, e gli varrà numerosi altri riconoscimenti, tra cui quello di
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Direttore di riviste e periodici, membro di varie associazioni ed esperto di arte del Novecento, è diventato ben presto un punto di riferimento nel panorama culturale locale e nazionale. Tutte queste attività, però, non gli hanno impedito di lavorare per quarant’anni nelle scuole pubbliche come maestro.
L’insegnamento, infatti, è sempre stata una colonna portante nella sua vita, come dimostrano le lezioni che ancora oggi fa all’Università della Terza Età e i laboratori di scrittura creativa con cui, alcuni anni fa, ha voluto condividere il suo amore per quest’arte con gli alunni delle scuole medie del paese natale. A chi gli chiede cosa sia la poesia e come si arrivi
a comporla, Urrasio non dà risposte semplici: «Fare poesia è difficile. Trovare le parole giuste per fare una bella rima non basta. Come diceva Platone, la poesia non deve dire ma essere. Soltanto quando il poeta si piega in se stesso e viene arato dentro dal dolore, dalla nostalgia, dalla miseria, anche dalla gioia, solo allora la voce che scaturisce dal profondo del suo animo si fa poesia, cioè espressione intima dell’intera umanità».
Ed ecco perché, secondo lui, il poeta moderno non “canta” più come gli antichi. Il suo fine non è quello di limitarsi a cogliere gli aspetti appariscenti della natura e delle cose, ma aspirare al silenzio, ad un viaggio nell’inconscio e nell’ignoto, pur di recuperare se stesso e il senso della propria identità. Solo in questo modo, potrà sollevare i suoi simili dalla prostrazione causata dal turbinio delle passioni e dei mali che li minacciano, donando un barlume di quiete. Un concetto che esprime mirabilmente in una delle sue ultime liriche:
«I poeti rivestono la vita di silenzio./ Non inseguono il respiro dell'alba che accende le voci del giorno,/né il fruscio delle ali del falco che tende all'infinito./I poeti aspettano rassegnati/che la sera raccolga nel grembo/ le ragioni del cuore e il brusio delle stelle».
Già in questi pochi versi si possono ravvisare alcuni dei tratti caratteristici del poetare di Urrasio: la presenza co -
stante della natura, che dà forma alle sue emozioni, il silenzio, che si identifica con il mistero delle cose stesse, e la meticolosa ricerca delle parole, rivestite di un significato metaforico, simbolico, allusivo. I temi che ha trattato nelle sue liriche, però, sono molti di più.
Come racconta lui stesso: «Il mio curriculum poetico segue un percorso circolare. Sono partito dal mio paese e dalla sua gente contadina, dai ricordi d’infanzia, quando da ragazzo non mi importava se le gambe mi sanguinavano, graffiate dalle stoppie, pur di poter portare un po’ di acqua alla mamma che lavorava.
Poi, ho visto gli orrori della guerra, ho patito la sofferenza, la solitudine e l’essere diventato orfano». Un groviglio di emozioni che trasmette con efficacia nei primi versi di Nel visibile e oltre, il componimento dedicato a suo padre, morto poco il suo ritorno a casa, all’indomani della Seconda guerra mondiale:
«Raccoglievo ciottoli sulle rive/del fiume quando mi fu detto/di te, del tuo ritorno./Percorsi con il cuore in gola/i sentieri di ortiche, saltai/le rovine del mulino posto/a guardia del prato. -Non l’eroe,/non il soldato: all’angolo/del camino un brandello di cuore/osava ancora battere per noi».
«Poi piano piano mi sono distaccato dagli affetti domestici per trattare di temi sociali. Erano gli anni ’70, ’80 e le piazze fremevano per le proteste, le strade
e i luoghi pubblici erano dilaniati dalle stragi, i valori di un tempo si stavano dissipando nel nulla. Ad esempio, in Attentati, lirica contenuta nella raccolta Il Segmento dell’esistenza, evoco la solitudine e la disperazione di due ragazzi».
«È notte ormai. Sul selciato/non resta che l’ombra/dei tuoi vent’anni sotto il peso/ dei fiori disfatti. Lontano/qualcuno si buca le vene/per dissolvere/nel delirio la tua morte».
«Infine, ho chiuso il cerchio ripiegandomi di nuovo in me stesso. Sono tornato a dialogare con il silenzio, con la mia terra d’origine e ad ascoltare i discorsi sommessi sull’uscio nelle ore di quiete». Come nella poesia A se stesso, contenuta nella raccolta Radici del sentimento:
«Foglia stremata dal vento,/siedimi accanto:/narrami delle estati dissipate/ sull’orlo del silenzio, dell’’inganno/dei lumi in attesa dell’alba,/delle mani gonfie di solitudine».
Un percorso a volte doloroso, ma prezioso che gli ha permesso di esplorare le regioni interiori dell’anima, di immergersi «nelle plaghe dell’eterno e dell’infinito, sino a sfiorare la vertigine degli spazi siderali. Perché il viaggio della vita è anche e soprattutto la ricerca e l’impegno a diventare “uomo vero tra la folla”». ■


Nuovi volti, nuove storie la moda che cambia
Il racconto di Alessandro, un giovane modello alla Milano Fashion Week, tra social media, aspettative, autostima e rapporto con il cibo
di Chiara Grossi
La nuova collezione autunno inverno 2025/26 di Gucci fa tesoro del passato per guardare al futuro. E lo fa con tantissimi nuovi volti che hanno calcato la passerella della Milano Fashion Week. Uno di loro ha lo sguardo sicuro, filtrato da grandi occhiali stile anni ’70. Si chiama Alessandro Nardi, ha 19 anni, è italo-ucraino e vive a Latina. È uno studente di Igiene dentale all’università La Sapienza di Roma e il 25 febbraio ha debuttato come modello durante la settimana della moda.
Il suo percorso è nato da un incontro casuale, grazie alla visibilità sui social: «A fine novembre ero al bar dell'università con i miei compagni e un fotografo di strada mi ha fermato chiedendomi di fare un paio di foto e un video per TikTok. All’inizio ho rifiutato perché non mi fidavo, ma anche perché sono sempre
stato abbastanza insicuro sul mio aspetto in generale. Però alla fine mi sono fatto convincere». Dopo la pubblicazione del video diventato virale sono iniziate ad arrivare le prime richieste di lavoro, fino a chiudere un contratto con la Steel Models Management di Milano. «È la mia agenzia madre che si occupa di mettermi in contatto con quelle di booking, che gestiscono le relazioni tra modelli e clienti. Ne puoi avere una per ogni nazione e io al momento ne ho tre, a Parigi, Berlino e Barcellona. Sono fondamentali perché, per esempio, Valentino pur essendo un brand italiano ha la sede in Francia e si può sfilare per lui solo se si ha anche un'agenzia francese».
Finiti i colloqui online, da gennaio Alessandro si è dovuto destreggiare nelle coincidenze tra treni e aerei per i preca-
sting fra Italia e Francia: «Sono appuntamenti fondamentali per farsi conoscere dai vari brand e casting director e per ricevere poi proposte di lavoro in futuro. Durante quei giorni mi hanno comprato i vestiti, insegnato a camminare, mi hanno anche tagliato i capelli, insomma un cambio di look generale. Infine mi hanno scattato delle foto che vengono chiamate polas».
Subito ha ottenuto i primi ingaggi per Ferragamo e Gucci a Roma. La maison fiorentina, infatti, è stata la prima a farlo sfilare alla Mfw, una vera e propria sorpresa perché «all'inizio credevo che sarei partito “dal basso”, invece parlando con le mie agenzie ho scoperto che i marchi importanti cercano sempre facce nuove e se si è fortunati, si debutta subito con una casa di moda abbastanza famosa».
BACKSTAGE

E così ha ricevuto la notizia di essere stato scelto alle sei di sera del giorno prima della fashion show: «All’inizio ero molto euforico, poi sono stato scaramantico e non ho detto niente a nessuno, neanche ai miei genitori. Le uniche persone a saperlo eravamo io e i miei agenti. Ero concentrato sulle prove e sulla camminata in pista».
Per vincere l’ansia ha utilizzato uno stratagemma curioso: immaginare di trovarsi in una recita scolastica. Tra il pubblico, però, non c’erano i suoi genitori a guardarlo, ma personalità come la direttrice di Vogue America Anna Wintour e il tennista Jannik Sinner: «Purtroppo non ho potuto vedere nessuno di loro perché ero davvero concentrato. Una volta calcata la passerella sapevo che avrei dovuto continuare a camminare e fare del mio meglio, perché ci sono tante cose a cui devi fare attenzione come l'altezza del mento e lo sguardo fisso. Tranne in determinati punti in cui loro ti dicono di guardare le telecamere, si ha il divieto di guardare gli spettatori».
La Paris Fashion Week, invece, è stata a detta sua «deludente», nonostante delle prime richieste da Alexander McQueen e Valentino: «La mia agente mi ha detto “Guarda Ale domani mattina devi prendere un aereo per Parigi” mentre
ero a letto con la febbre a 39. Sono partito senza avere nemmeno la certezza di sfilare. Avevo un incontro sia con Alexander McQueen che con Valentino, che mi ha chiesto di fare un fitting per decidere l’ipotetico outfit della sfilata. Purtroppo non sono stato preso e sono rimasto un po’ male, anche perché gli abiti mi piacevano davvero molto. Non mi sento ancora al mio agio quando cammino e forse proprio per questo sono stato scartato. Ci sono brand che cercano una camminata più aggressiva come Dsquared, mentre alcuni la vogliono più sobria. La mia ora la definisco insicura, storta, ma anche un po’ elegante».
Dell’insicurezza nel mondo della moda, forse, non se parla ancora abbastanza. Erroneamente si è abituati a pensare che chi lavora con la propria immagine non abbia questi complessi. «Prima ero più insicuro del mio aspetto, del mio fisico e del viso. Il fatto è che ogni giorno vedi centinaia di modelli e magari è normale fare dei paragoni o sentirsi “inferiori”, ci sono molte persone che sono cadute in depressione per questo. Poi, però, impari che ognuno di noi è adatto a fare lavori diversi. È un mondo dove devi acquisire a forza autostima, perché ogni casting è vissuto come una vera e propria competizione. Sono fortunato perché le mie agenzie mi spronano molto, mi dico -
no “se tu sei qui c’è un motivo”. Ora sono consapevole dei miei punti forti». Scegliere questa professione significa anche affidare ad altri il potere decisionale sulla propria immagine. Per contratto, infatti, Alessandro è tenuto ad avvisare sempre l'agenzia prima di fare una qualsiasi cosa che possa cambiare la sua estetica, da un taglio di capelli a una decolorazione, ma anche tatuaggi, orecchini e piercing.
La questione del peso, invece, è più complessa. Nel corso degli anni sono state tante le polemiche e anche le proposte di legge per tutelare la salute di chi lavora nella moda, a volte ai limiti dell’anoressia. «In generale le fashion agencies possono consigliarti di prendere un po’ di peso a livello di muscoli oppure no. A me non è stato mai detto di mangiare alcune cose o di assumere un determinato numero di calorie, anche perché non è importante il peso, ma che tu rispetti determinate misure sulla vita e sul petto, mentre il discorso è più complicato per la moda femminile dove ci sono misure molto più limitanti. Personalmente sono abbastanza fortunato perché ho un metabolismo molto buono». Ma allora perché il catering non viene quasi mai toccato nel backstage? «È anche un fatto di ansia. Mangiare un piatto di pasta prima di fare una sfilata così importante? Rischi di sentirti male», ammette ridendo. ■


Gaia Sabbatini, la corsa verso se stessa
L’atleta racconta il crollo psicologico dopo l’infortunio e l’addio alle Olimpiadi di Parigi
«Non mi divertivo più a gareggiare. Avevo perso il motivo che per cui ho iniziato a praticare la corsa». Si racconta così Gaia Sabbatini, mezzofondista e campionessa europea under23 dei 1500 metri a Tallinn, nel 2021.
Abituata a macinare chilometri, un anno fa sceglie di fermarsi e prendersi cura della sua salute, fisica e mentale: «Ho scoperto di avere il morbo di Haglund, una calcificazione vicino al tendine d'Achille che ha poi richiesto un’operazione – spiega l’atleta delle fiamme azzurre – Ho cercato di stringere i denti in vista dei Giochi olimpici di Parigi, ma il forte dolore non mi ha permesso di andare ai campionati italiani, ultima gara utile prima della Francia». Ad una situazione già difficile si aggiunge un ulteriore problema: «Nello stesso periodo mi sono beccata anche un virus intestinale che mi ha fatto perdere 4 chili in un paio di settimane». In quel momento Gaia inizia a sentirsi crollare, i giochi visti da casa sono un rimpianto difficile da digerire. Tutto diventa pesante, è schiacciata dalle pressioni, critiche e giudizi: «Alcune persone mi scrivevano che dovevo pensare ad allenarmi, anziché farmi le foto sui social», racconta. La soffe-
renza che da fisica diventa anche mentale riapre in Gaia le ferite del passato: «Lì ho capito di non aver mai elaborato la perdita di mio padre, avvenuta dieci anni fa a causa di una valanga sul Gran Sasso. Non mi sono permessa di soffrire perché volevo essere una ragazza forte». A salvarla da quel momento nero durato troppo a lungo arrivano uno psicologo, un fidanzato e le pagine di un diario: «Ho iniziato a mettere nero su bianco i pensieri, mi liberavo di tutto quello che sentivo dentro e che magari non volevo ammettere». Il ricordo di quei momenti è affidato anche a un post di Instagram: “Non so come uscirne, non sto bene e vorrei solo essere felice”. Uno sfogo coraggioso che oggi le permette di parlarne senza filtri.
Nel centro sportivo delle fiamme gialle dove si allena, al suo fianco ci sono il coach Andrea Ceccarelli e Laura Dedo, preparatrice e migliore amica di Gaia: «Mi ha aiutata tanto. Il tatuaggio con i cinque cerchi che ho sul braccio, fatto dopo i giochi di Tokyo, è un suo regalo – spiega con il sorriso ritrovato - È lo stesso simbolo della collana, uno dei tanti gioielli portafortuna che indosso per le gare». Tra una corsa e l’altra, in attesa del ritiro di fine marzo in
Sud Africa, si dedica anche alle altre passioni: lo shopping, l’arrampicata e il makeup: «È un mondo che mi affascina, amo guardare tutorial, mi serve a rilassarmi», racconta, così come rilassanti sono i ritorni a Teramo, la sua città natale, il posto sicuro dove ritrovare sé stessa.
La delicatezza dei modi riflette quella dell’animo e Gaia ne è la prova: «Non voglio pensare a tutte le cose brutte che mi sono successe e dire che sono una persona sfortunata. Penso sia stata l’occasione per migliorarmi, adesso mi sento sulla strada giusta». Ogni rinascita passa dalla consapevolezza e da un motto: "Vola solo chi osa farlo", dice citando il film “La Gabbianella e il gatto”. E lei sta imparando di nuovo a volare. ■

di Isabella Di Natale
ATLETICA

Il nuovo cavaliere rosso
F1
Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha iniziato la sua prima stagione in Ferrari
di Ludovica Esposito
Il primo punto, la prima vittoria e la prima squalifica. L’inizio di stagione con la scuderia di Maranello per Lewis Hamilton ha condensato i momenti più alti e più bassi per un pilota. «Almeno un punto» è stato il commento del sette volte campione del mondo dopo aver corso la sua prima gara con la Ferrari e aver concluso il gran premio d’Australia in decima posizione, dietro a entrambi i piloti della Mercedes.
Alla sua seconda gara, Hamilton ha ridato speranza ai tifosi, ottenendo pole e vittoria nella prima sprint race della stagione. Il pilota britannico è arrivato sesto in Cina, ma dopo la gara e i controlli della FIA è arrivata la notizia della squalifica di entrambe le macchine.
Dopo aver visto il risultato dei primi due gran premi potrebbe sembrare che le speranze di rivalsa siano stato infrante. Sui social, i componenti del team LH44 (così si chiamano i seguaci del pilota britannico) divenuti ferraristi hanno reso nota la loro delusione e ammesso che finalmente comprendevano che cosa avessero passato gli scorsi anni i fan degli altri piloti della scuderia del cavallino rampante. Alcuni hanno scherzato e finto che la nuova sta-
gione non fosse ancora iniziata.
Dopo oltre dieci anni con la scuderia tedesca, all’inizio di febbraio 2024 è arrivata la notizia che Hamilton avrebbe corso con la squadra italiana a partire dalla successiva stagione. L’annuncio ha sorpreso fan e tifosi. Si sono tutti domandati se questo avrebbe significato l’occasione di vincere l’agognato ottavo titolo iridato per Hamilton e un ritorno in vetta alla classifica del mondiale costruttori per la Ferrari.
Il britannico Lewis Hamilton ha iniziato la sua carriera in Formula 1 nel 2007 con la Mclaren e ha concluso la sua prima stagione come vicecampione del mondo e ha vinto il Mondiale Piloti l’anno successivo; nel 2013 è passato in Mercedes, con cui ha vinto sei volte il titolo di campione del mondo; nel 2025, a quarant’anni anni, ha iniziato il suo contratto pluriennale con la scuderia rossa di Maranello.
«Indossare il rosso è qualcosa di speciale» aveva dichiarato Lewis Hamilton all’evento di presentazione dei piloti Ferrari a Milano e i tifosi aspettano di vedere se le prossime gare riusciranno a essere altrettanto speciali. ■
Lewis Hamilton in Formula 1
2007 McLaren
Vicecampione del mondo
2008 McLaren
Campione del mondo
2009 McLaren
2010McLaren
2011 McLaren
2012 McLaren
2013 Mercedes
2014 Mercedes
Campione del mondo
2015 Mercedes
Campione del mondo
2016 Mercedes
Vicecampione del mondo
2017 Mercedes
Campione del mondo
2018 Mercedes
Campione del mondo
2019 Mercedes
Campione del mondo
2020 Mercedes
Campione del mondo
2021 Mercedes
Vicecampione del mondo
2022 Mercedes
2023 Mercedes
2024 Mercedes
2025 Ferrari

Il pianeta è sempre più arido spesso l'acqua è un miraggio
Il pianeta affronta l’incedere di una crisi idrica globale sempre più invasiva, causata dai cambiamenti climatici e altri fattori che provocano siccità ed eventi estremi
La mattina, tra il profumo di caffè e gli occhi ancora assonnati, il modo migliore per cominciare la giornata, come consigliano molti medici e nutrizionisti, è bere un bicchiere d’acqua. Un gesto che noi tutti diamo per scontato. Eppure, l’andamento delle risorse idriche globali suggerisce che, in un futuro (forse non troppo) lontano, la disponibilità d’acqua corrente come la conosciamo oggi potrebbe cambiare, e per alcuni paesi è già così. La giornata mondiale dell’acqua, celebrata il 22 marzo, vuole ricordare che bisogna prestare attenzione a come intendiamo scrivere il nostro futuro: perché, con questo andamento, quel bicchiere mattutino potrebbe rimanere sempre più spesso asciutto.
del ciclo idrogeologico e causando eventi meteorologici estremi in diverse parti del mondo. Il report mostra l’andamento in diversi elementi idrici del pianeta. Il dato più allarmante riguarda i ghiacciai, scelti come tema ufficiale della giornata dell’acqua 2025. Secondo le rilevazioni, nel 2023 i ghiacciai globali si sono ridotti di 600 gigatonnellate (Gt) d’acqua: l’equivalente di circa 785mila grattacieli.
di Andrea Iazzetta
Secondo l’ultimo rapporto della World Meteorological Organization (Wmo), State of Global Water Resources 2023, la situazione non sembra rosea. Il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato, con una temperatura di 1,45°C superiore ai livelli preindustriali (molto vicina al tetto massimo previsto dall’accordo di Parigi sul clima, tra +1,5°C e +2°C). Questo aumento ha avuto conseguenze significative sulle risorse idriche del pianeta, alterando diverse componenti
Si tratta di circa 100 Gt in più rispetto alla media degli ultimi cinque decenni. I fiumi seguono la stessa tendenza dei ghiacciai, con portate inferiori alla norma. Secondo il report, più del 50% dei bacini fluviali mondiali ha registrato variazioni nel volume d’acqua, nella maggior parte dei casi con una riduzione, mentre solo in pochi si è verificato un incremento.
«Il report indica che l'aumento delle temperature dell'aria si traduce anche in condizioni sempre più aride nei fiumi globali, accompagnate da eventi di precipitazione sempre più irregolari ed estremi», commenta Sulagna Mishra, ufficiale scientifico della Wmo. «Per affrontare le sfide derivanti dai cambiamenti nei cicli idrologici,

i governi dovrebbero implementare misure di adattamento, concentrandosi contemporaneamente su strategie di mitigazione».
La situazione in Italia
In Italia, la situazione non è più incoraggiante. Secondo il progetto Gesesa, del gruppo Acea, il nostro Paese è tra i maggiori consumatori d’acqua in Europa. Secondo uno studio della The European House–Ambrosetti, gli italiani consumano in media 215 litri d’acqua al giorno, un dato superato nell’Unione Europea solo da Grecia e Irlanda. Tuttavia, le risorse idriche nel paese stanno subendo perdite. «In linea generale, la siccità ha continuato a caratterizzare tutto il 2023, seppur in modo diversificato sul territorio nazionale e in misura leggermente inferiore rispetto al 2022» ha dichiarato l’Ispra. «Negli ultimi tre mesi dell’anno, si è registrato un consistente deficit di precipitazioni, che ha determinato una situazione di siccità estrema. Gli effetti si sono protratti nel 2024, aggravandosi ulteriormente a causa delle scarse piogge nei mesi suc-
cessivi». Sulagna Mishra spiega però come il paese si dimostri attivo nel fronteggiare questa crisi: «l’Italia è fortemente impegnata nell’adattamento alla crisi idrica aggravata dai cambiamenti climatici», ricordando che varie città stanno adottando il razionamento dell’acqua fra le misure di contrasto. «L’Italia ha anche mostrato leadership negli sforzi internazionali, partecipando attivamente a diverse iniziative della Wmo, per migliorare i servizi di gestione idrica».
Eventi meteorologici estremi: una minaccia crescente
Un altro problema emergente legato alle risorse idriche globali è l’aumento degli eventi meteorologici estremi. Secondo il report dell’Omm, il 2023 è stato segnato da numerosi eventi catastrofici legati all’acqua: dal ciclone Daniel in Libia a inondazioni e siccità in tutto il mondo. In Italia, sia nel 2023 che nel 2024 l’Emilia-Romagna è stata la regione colpita più duramente. Tra settembre e ottobre, la regione ha subito forti inondazioni che hanno costretto migliaia di

persone all’evacuazione e provocato ingenti danni al territorio.Tuttavia, il paese ha dato prova di una reazione decisa. «L’Italia ha dimostrato un’avanzata capacità di allerta precoce per le alluvioni, come evidenziato durante quelle in Emilia-Romagna nel 2023», commenta Mishra. «L'evacuazione tempestiva di migliaia di persone entro 24 ore ha rappresentato un esempio di buona gestione a livello internazionale».
Un impegno globale per il futuro
«Attualmente stiamo affrontando una crisi idrica che può essere vista e avvertita in molti modi» ha dichiarato Audrey Azoulay, direttrice generale dell’Unesco, nel report Water for prosperity and peace. «Diciamolo chiaramente: questa situazione potrebbe provocare una crisi sistemica nelle nostre società». Secondo il report World Water Development 2024 delle Nazioni Unite, l’accesso alle risorse idriche non è compromesso solo dal cambiamento climatico, ma anche da fattori geopolitici, pandemie, migrazioni di massa, iperinflazione e altre crisi globali. A pagarne le conseguenze maggiori sono sempre le popolazioni più povere e vulnerabili.
Istituita dall'Onu nel 1992, la giornata mondiale dell’acqua mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle criticità legate alle risorse idriche e a promuovere un impegno globale per la loro tutela. «Abbiamo ancora tempo per intervenire, ma dobbiamo agire insieme ora», ha concluso Azoulay. ■
1. State of Global Water Resources 2023. Anomalia dell'equivalente in acqua della neve di marzo 2023 rispetto al periodo di riferimento (1991–2020)
2. State of Global Water Resourcer 2023. Anomalia dell'equivalente in acqua della neve di marzo 2023 rispetto al periodo di riferimento (1991–2020)
Privacy, un bene da proteggere
Dal Grande fratello alle app
Negli anni la tecnologia è diventata sempre più invadente e i dati personali sono ormai il «nuovo petrolio»
«Negli anni 2000, il programma televisivo Grande Fratello, trasmesso per la prima volta in Italia su Mediaset, ha introdotto una forma di intrattenimento che ha segnato una svolta nel modo di concepire la privacy. In questo esperimento sociale, un gruppo di sconosciuti veniva isolato in una casa, senza possibilità di comunicare con l'esterno, mentre le loro vite venivano sorvegliate e trasmesse in diretta. Un'idea che sembrava pura spettacolarizzazione del controllo, ma che, oggi, riflette in modo inquietante la nostra realtà.
Se all'epoca l'invasione della privacy era un gioco, adesso è diventato un rischio concreto per milioni di persone. «I dati personali sono il nuovo petrolio» e, afferma l'esperto di cybersicurezza, Giovanni Ziccardi, docente all'Università di Milano: «La privacy non è più una questione individuale, ma un problema sistemico che riguarda la sicurezza globale», ribadisce il professore prima di sottolineare come oggi «gli utenti siano geolocalizzati in tempo reale, i loro movimenti tracciati, le conversazioni intercettate tramite dispositivi che, sotto l’apparenza di utili strumenti tecnologici, celano potenziali minacce alla sicurezza personale e collettiva».
Un esempio sono le app. «Molti utenti, inconsapevoli, scaricano applicazioni che, pur essendo gratuite, raccolgono enormi quantità di dati. Dati che vengono
poi utilizzati per creare profili dettagliati, che possono essere venduti a terzi o utilizzati per scopi meno trasparenti. Alcune sembrano innocue, come quelle per il fitness o per il fotoritocco. Possono, invece, essere veicoli di veri e propri trojan che compromettono la nostra privacy», spiega Eugenio Moretti, esperto in cybersecurity. «In alcuni casi, questi software possono registrare le nostre conversazioni, monitorare la nostra posizione geografica e accedere a dati sensibili senza il nostro consenso».
Inoltre, l'introduzione di tecnologie come la sintesi vocale nei dispositivi mobili ha portato a nuove preoccupazioni. Sebbene pensati per facilitare la navigazione e l'interazione, questi sistemi sono stati sfruttati anche per raccogliere informazioni sui comportamenti degli utenti. Un'analisi condotta da The Electronic Frontier Foundation ha evidenziato che, nei dispositivi più utilizzati, il microfono è attivo anche quando non è in uso, raccogliendo suoni che potrebbero poi essere trasformati in dati utilizzabili per marketing mirato. Ma i rischi non si fermano qui. Le pratiche di sorveglianza potrebbero evolversi, come avviene per esempio all’aeroporto di Changi a Singapore che ha implementato sistemi di riconoscimento facciale per il controllo dei passeggeri. Questo tipo di tecnologia potrebbe diventare un mezzo per controllare le masse, utilizzato per tracciare ogni movimento di una persona.

«La tecnologia è diventata così pervasiva che è ormai quasi impossibile proteggere la nostra privacy. Viviamo in un mondo dove ogni click, ogni parola pronunciata, ogni movimento che facciamo può essere tracciato», afferma Alessandro Acquisti, professore di informatica all'Università Carnegie Mellon, esperto di privacy digitale.
Secondo Acquisti, questo «controllo totale» potrebbe essere accettato passivamente dalle persone, per il semplice fatto che ha facilitato molte attività quotidiane, ma ha anche creato un paradosso: «La società moderna ha sacrificato la privacy per il comfort e la convenienza, senza rendersi conto che il prezzo da pagare potrebbe essere molto alto». Gli utenti, infatti, non sembrano aver ancora compreso pienamente le implicazioni di questa invasione della privacy. Si accetta di buon grado
il monitoraggio, magari ignorando gli avvertimenti sulla sicurezza, perché il comfort e la facilità d'uso prevalgono sulle preoccupazioni.
Fino a che punto, quindi, siamo disposti a sacrificare la nostra privacy per la comodità di una vita sempre più connessa e automatizzata? Come ha sottolineato Shoshana Zuboff, professoressa emerita alla Harvard Business School e autrice di The Age of Surveillance Capitalism: «Siamo di fronte a una trasformazione radicale del nostro rapporto con la tecnologia, dove il controllo non è solo una questione di protezione dei dati, ma di libertà individuale». La risposta a questa domanda potrebbe determinare il futuro della nostra società, in un mondo che sembra essere sempre più un Grande Fratello a cielo aperto.
di
Alexandra Colasanti
Luiss Data Lab
Centro di ricerca specializzato in social media, data science, digital humanities, intelligenza artificiale, narrativa digitale e lotta alla disinformazione
Partners: ZetaLuiss, MediaFutures, Leveraging Argument Technology for Impartial Fact-checking, Catchy, CNR, Commissione Europea, Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis, Adapt, T6 Ecosystems, Harvard Kennedy School, Parlamento europeo



Master in Journalism and Multimedia Communication Show, don’t tell
Lectures: Marc Hansen, Sree Sreenivasan, Linda Bernstein, Ben Scott, Jeremy Caplan, Francesca Paci, Emiliana De Blasio, Colin Porlezza, Francesco Guerrera, David Gallagher, Claudio Lavanga, Eric Jozsef, Federica Angeli, Paolo Cesarini, Massimo Sideri, Davide Ghiglione
@Zeta_Luiss
giornalismo.luiss.it zetaluiss.it Zetaluiss
@zetaluiss
