






































18 dei primi 500 prodotti a prezzo basso permanente.






edizione
MONDO MIGROS
Pagine 4 / 6 – 7
SOCIETÀ Pagina 5
Da marzo in Svizzera sarà consentita la guida automatizzata su tratti di strada autorizzati
Le trattative svizzere e i temi più discussi al Forum economico mondiale di Davos
ATTUALITÀ Pagina 12
CULTURA Pagina 17
A Mendrisio un doppio appuntamento con Art Brut grazie alla lungimiranza del Club ’74
Aberdeenshire sorprende con dune battute da raffiche di vento, foche, castelli gotici, fari e villaggi da film
TEMPO LIBERO Pagine 26-27

Carlo Silini
Non è vero che alla «gente», al cosiddetto «popolo», piace l’«uomo forte». Trump, Netanyahu e Putin per esempio sono potentissimi, ma non propriamente «forti». Sono abili e prepotenti: è diverso. Triste dirlo, ma l’arroganza sembra sedurre molto più della vera forza. In altre parole, i leader citati sono indubitabilmente energici, determinati, capaci di decidere controvento. Tuttavia, sono forti in modo distorto. Il potere gli deriva da elettori più o meno liberi di scegliere (è bene distinguere tra democrazie reali – Usa e Israele – e «democrature» di fatto, come la Russia). Ma la delega popolare non è una cambiale in bianco che autorizza l’eletto a farsi beffe delle norme di civile convivenza. La forza fuori controllo ci mette niente a diventare violenza. E prima o poi lo diventa. Saremo ingenui, idealisti, ma forte è l’uomo che non ha bisogno di violare le norme correnti e/o
le leggi per imporsi. La forza autentica si misura dalla capacità di emergere per bravura, intelligenza, carisma rispettando le regole del gioco. Come nello sport, dove gli atleti si sfidano a condizioni di partenza identiche, attenendosi scrupolosamente ai regolamenti. Nel migliore dei mondi possibili, se vinci barando non sei forte, sei un baro.
Le regole del gioco politico per uomini realmente forti sono quelle della democrazia, il sistema di potere meno peggio che conosciamo. A cominciare dal rispetto delle leggi, delle carte costitutive e dei verdetti dei tribunali. Non è che se perdi le elezioni – è cronaca di quattro anni fa – cerchi di rovesciare il Campidoglio con una rivolta al limite del golpe. E non è che se torni sotto quella cupola da vincitore legittimamente eletto – come è successo a Trump una settimana fa – puoi graziare i rivoltosi che menavano spranghe di metal-
lo sugli agenti, come se i codici giuridici non contassero nulla. E non contassero nulla non perché hai ragione, ma perché hai vinto.
Così come – su un piano di responsabilità sensibilmente più grave – non puoi ordinare al tuo esercito di sparare missili su persone inermi, violando il diritto di guerra e le convenzioni di Ginevra, commettendo cioè crimini contro l’umanità e/o la popolazione civile (poco importa che sia in Ucraina, nella Striscia di Gaza o in uno dei troppi scenari di spregio del diritto) e poi gridare allo scandalo se la Corte penale internazionale spicca un mandato d’arresto contro di te per una lista di brutalità assortite. Lo sprezzo per le regole non dimostra forza, ma degrado democratico: attesta l’incapacità di competere rispettando le norme. È un tentativo di plasmare il mondo non attraverso la fatica di una lotta leale, ma grazie alla scorciatoia dei privilegi
e di un’autocomprensione anarchica del proprio ruolo. Sgomito ergo sum, insomma. E sembra funzionare. Alla «gente» piace il boss che esercita il proprio strapotere con ostentata insolenza. «Ha le palle», dice, e va pure in sollucchero. Non solo in America, ma a tutte le latitudini. Non faremo altri nomi ma spesso, a prevalere, sono leader (o ducetti) sfrontati, capipopolo al testosterone, lady di ferro tonanti. Ma davvero ci rappresentano? Siamo noi a renderli molto più forti di quanto dovrebbero. Come smantellare il loro ipertrofico potere? Lo scrisse cinque secoli fa Etienne de la Boétie (Discorso sulla servitù volontaria): «…non è necessario combatterlo, né abbatterlo. Si dissolve da sé, purché il paese non accetti di essergli asservito. Non si tratta di togliergli qualcosa, ma di non dargli nulla». Soprattutto, quando sarà il momento, di non dargli il voto. Nel frattempo stringiamo i denti.
Anniversari ◆ Congratulazioni e un «grazie» ai collaboratori di Migros Ticino che festeggiano i 25 anni in azienda
Raffaella Vaghi
La tempra di chi è abituata a combattere la si riconosce subito: Raffaella Vaghi prende le situazioni di petto e con una certa ironia. Proprio in questi giorni festeggia i 25 anni a servizio di Migros Ticino. In altre parole (come altri collaboratori), parliamo spesso di mezza esistenza. Nel suo tempo libero Raffella si dedica soprattutto ai figli, oggi adolescenti, che porta a sciare e a fare gite fuori porta. Ama anche andare al cinema e occuparsi della casa.

Raffaella Vaghi
Lavora per Migros Ticino dal 26 gennaio 2000
Raffaella Vaghi, qual è il suo ruolo all’interno di Migros Ticino?
Sono stata per diversi anni la responsabile della pasticceria di Agno. Con l’arrivo del mio primo figlio ho ridotto la percentuale di lavoro, e sono stata per qualche anno attiva alla Migros di Caslano. Ora sono di nuovo ad Agno, in veste di cassiera.
Dopo tutti questi anni, cosa le piace in modo particolare del suo lavoro?
Se devo essere sincera, sono molto
contenta di essere ad Agno, perché è dove ho cominciato, e quindi lo sento come il mio ambiente. Del mio lavoro amo soprattutto il contatto con la gente, poiché sono una persona aperta che scambia volentieri due parole con le clienti e i clienti.
Quali sono a suo avviso le sfide più grandi dei prossimi anni?
Io mi sento tranquilla, perché conosco il mio lavoro e cerco di svolgerlo al meglio. Siamo in un momento di grande transizione aziendale, per cui credo che sia importante che ognuno faccia la sua parte.
Cosa augura a Migros, in occasione del compleanno dei 100 anni?
Auguro a Migros di tornare a essere e di potere rimanere il «gigante arancione».
Cosa rappresenta Migros per lei?
Migros mi ha aiutato nei momenti di difficoltà che ho incontrato. È sempre stato un datore di lavoro flessibile, disposto ad ascoltare le mie necessità. Credo sia dunque giusto che io restituisca qualcosa attraverso il mio impegno personale.
Johnny D’Agostino
Fra le decine di figure professionali presenti in Migros vi è anche quella dell’autista di camion. Un anello fondamentale della catena che in ultima istanza permette alla cliente e al cliente di ritrovare il prodotto desiderato sugli scaffali del proprio ne-
gozio. Da un quarto di secolo questo compito viene svolto con serietà ed entusiasmo da Johnny D’Agostino: nonostante gli anni passati al volante, infatti, la passione per i mezzi pesanti non è diminuita, anzi.

Lavora per Migros Ticino dal 17 gennaio 2000
Quale è il suo ruolo all’interno di Migros Ticino?
Il mio ruolo all’interno di Migros Ticino è quello di autista di autocarri, mi occupo quindi di consegnare la merce nelle varie succursali Migros del Canton Ticino.
Venticinque anni sono un quarto di secolo: cosa le piace maggiormente del suo lavoro dopo tutti questi anni?
Devo dire che io adoro guidare, soprattutto i camion! All’interno dell’azienda il lavoro è sempre stato interessante e stimolante, e questo mi ha permesso di non perdere mai l’interesse per questa professione.
E quali sono invece le sfide che l’aspettano per i prossimi venticinque anni?
Iniziative ◆ Non perdetevi i Changemakers Grants per una maggiore coesione
Vi impegnate a favore dell’integrazione e della convivenza? Necessitate di un sostegno finanziario e di una guida per rendere la vostra associazione più forte e partecipativa? Oggi più che mai la nostra società ha bisogno dell’associazionismo, di momenti di aggregativi al di là di quelli professionali o famigliari. Stare insieme in una mo-
Come partecipare

Il bando dei Changemaker Grants si aprirà il 27 gennaio e si chiuderà il 21 marzo 2025. Nel maggio del 2025 una giuria sceglierà tra 10 e 15 associazioni e organizzazioni che saranno sostenute fino alla fine del 2027 con un contributo finanziario e un accompagnamento professionale. Il sostegno finanziario varia tra i 6 0’000 CHF e i 150’000 CHF per organizzazione/associazione. L’importo sarà corrisposto sull’arco di tre anni. In fase di selezione, saranno prese in considerazione un’ampia copertura di temi legati all’integrazione e la varietà regionale. Per informazioni www.ici-gemeinsam-hier.ch/it
dalità di progettualità non può che fare bene, sia al singolo individuo, sia alla società. Ecco perché «ici. insieme qui.» lancia un bando molto particolare che, oltre a un sostegno economico, offre anche un accompagnamento da parte di professionisti. Ne abbiamo parlato con Angela Zumbrunn, Responsabile di progetto affari sociali.
Cosa sono i Changemaker Grants e perché si tratta di un’iniziativa a lungo termine?
I Changemaker Grants di «ici. insieme qui.», programma di coesione, si rivolgono ad associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che si impegnano a favore di integrazione e coesione. Queste devono essere disposte a svilupparsi insieme a noi sull’arco di tre anni, condividendo le competenze. La promozione a lungo termine è importante, poiché i cambiamenti necessitano di tempo. Grazie a un accompagnamento competente e continuativo e a un regolare scambio delle proprie esperienze, le organizzazioni e le associazioni che godono del nostro sostegno possono equipaggiarsi al meglio per il futuro e rafforzare la coesione sociale.
Chi può candidarsi e quali sono le condizioni necessarie?
Possono candidarsi le organizzazioni e le associazioni che hanno idee innovative, che si impegnano per l’integrazione e la coesione, che promuovono la parità di diritti e che desiderano rafforzare il ruolo dei vo-
All’interno dell’azienda mi sono sempre trovato molto bene; per me sarebbe un grande piacere riuscire ad arrivare al pensionamento!
Cosa augura a Migros nell’anno dell’anniversario?
Ho sempre apprezzato la politica aziendale di Migros Ticino, grazie alla quale i collaboratori possono beneficiare di numerosi vantaggi. Il mio augurio per il futuro, malgrado i tempi difficili, è che noi tutti insieme a Migros, si possa continuare su questa strada.
Ma dunque cosa rappresenta Migros per lei?
Migros per me è come una grande famiglia, perché c’è sempre stata. Migros è un ricordo che ho sin da quando ero bambino, quindi auguro all’azienda altri 100 anni di attività!
Irena Pavlovic
La sede di lavoro di Irena Pavlovic, che nel suo tempo libero si dedica alla famiglia, alle camminate, alla lettura, e a un po’ di shopping (come tutte le donne, aggiunge), è Lugano Centro.
Irena, quale è il suo ruolo all’interno di Migros Ticino?
Il mio ruolo all’interno di Migros in questi venticinque anni è stato quello di venditrice presso i reparti non food, in particolare del settore casalinghi e mercati specializzati.
Cosa le piace maggiormente del suo lavoro dopo questo lungo quarto di secolo?
Nel corso di questi anni ciò che mi ha portato a svolgere al meglio il mio lavoro è stato sicuramente il contatto costante con la clientela, il poter lavorare all’interno di un gruppo, oltre alla possibilità di migliorare ogni giorno le mie conoscenze nel settore.

Quali sono le sfide che l’aspettano per i prossimi venticinque anni? Nonostante ci troviamo nella cosiddetta era della digitalizzazione, mi auguro che i cambiamenti saranno possibilmente morbidi per tutti i collaboratori di Migros
Cosa augura a Migros nell’anno dell’anniversario?
Alla mia azienda auguro altri 100 di questi anni.
Cosa rappresenta Migros per lei? Migros rappresenta una parte importante della mia vita. È il luogo in cui lavoro da venticinque anni!

lontari. Esse devono essere disposte ad analizzare in modo critico i propri processi interni e a sviluppare processi decisionali equi. Le organizzazioni devono esporre in modo trasparente le misure specifiche che intendono attuare a questo proposito e le modalità con cui coinvolgono sistematicamente il loro gruppo tar-
get, ad esempio attraverso riunioni periodiche o votazioni online.
Perché si sono creati i Changemaker Grants?
I Changemaker Grants di «ici. insieme qui.» Promuovono organizzazioni e associazioni che abbattono le barriere e concorrono a creare
responsabile del
una coesione tra pari. Ad esempio offrono sostegno ai volontari, creano punti di contatto e coinvolgono sistematicamente i gruppi target nei propri processi decisionali. L’obiettivo è promuovere idee innovative che mettano le organizzazioni su un piano di parità maggiore, preparandole al futuro.
Covid e sistema immunitario
La pandemia ha avuto un’influenza sul nostro sistema immunitario? Ne abbiamo parlato con il dottor Christian Garzoni
Pagina 9
Come si sentono i giovani
Pro Juventure ha pubblicato uno studio sulla salute psicologica dei ragazzi tra i 14 e i 25 anni in Svizzera
Pagina 10
Dai mattoni all’arte
A Riva San Vitale è in corso il recupero di una vecchia fornace e di un essiccatoio, il progetto prevede la messa in funzione di due nuovi forni
Pagina 11
Mobilità ◆ In dicembre il Consiglio federale ha approvato la nuova ordinanza che consente dal prossimo marzo la guida automatizzata su tratti ufficialmente autorizzati
Ora la legge c’è. Si attende soltanto il segnale di partenza. Non siamo mai stati davvero così vicini al futuro e presto quello che appariva materiale esclusivo per film di fantascienza potrà realizzarsi sul nostro pianeta terra: auto senza conducenti in cammino verso posteggi dedicati, vetture guidate a mani libere, letteralmente lontane dal volante, su tratti di strada ufficialmente autorizzati.
Potenza della tecnologia, ma anche della politica: il Consiglio federale lo scorso dicembre ha infatti dato luce verde a un’ordinanza che autorizza la guida automatizzata. Adesso spetterà a ogni singolo Cantone consentirne l’entrata in vigore. Dal canto suo l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha messo in campo delle istruzioni in materia, inoltre un gruppo di esperti per la consulenza è stato appositamente costituito.
Da luglio agli esami teorici e pratici chi farà la patente dovrà dare prova di conoscere i sistemi di assistenza alla guida e i sistemi di automazione
In Ticino, dove i tempi di messa in circolazione dei futuristici veicoli non sono ancora stati comunicati ufficialmente, il sintagma «auto senza conducente» non rappresenta un termine completamente sconosciuto. L’argomento appare tuttavia decisamente divisivo, tanto da formare schieramenti opposti: tra chi teme e intravede in questa rivoluzionaria revisione della legge sulla circolazione stradale il presagio ad una catastrofica deriva che porterà inevitabilmente a un maggior numero di incidenti sulle strade e chi invece saluta la novità con attesa crescente, con la certezza che grazie all’intelligenza artificiale e alle sempre più sofisticate innovazioni tecnologiche sarà vero il contrario, ossia che con la guida automatizzata il trasporto privato e la viabilità non potranno che conoscere una maggiore sicurezza, paragonabile, se non addirittura superiore, a quella dell’aviazione, la quale come noto da sempre si conferma decisamente la più affidabile. Otto mesi fa – era il 4 maggio scorso – con l’analoga emozione che si può improvvisamente provare alla veduta di un’astronave, in occasione della Giornata di porte aperte della Sezione della circolazione di Camorino, USTRA ha esposto il primo veicolo a guida automatizzata di produzione svizzera. Un traguardo sorprendente, quanto tangibile. Il video promozionale pubblicato sul canale YouTube è tuttora consultabile e parecchio cliccato.

Parliamo dell’avvincente tema con Michele Parravicini, aggiunto capoufficio tecnico della Sezione della circolazione di Camorino, il quale sta seguendo da vicino l’evoluzione destinata a traghettarci progressivamente verso il «pilota automatico». Partiamo dal video. Ha suscitato interesse tra il pubblico l’esposizione del primo veicolo a guida automatizzata? «Sì, oltre ad esserci stata un’importante affluenza, le persone hanno partecipato alle dimostrazioni con palpabile curiosità. Molti hanno posto domande sulla tecnica e alcuni hanno messo alla prova il veicolo interagendo fisicamente per verificarne le reazioni». Ma quali peculiarità possiede il rivoluzionario veicolo? «È stato sviluppato combinando sensori e logica di programma all’avanguardia. La sicurezza viene garantita attraverso un sistema di tripla ridondanza. Combina sensori avanzati e algoritmi potenti per offrire una visione a 360°, capace di rilevare oggetti, persone e animali con estrema precisione. Inoltre, il costruttore parla dell’intelligenza artificiale come di un pilota di F1 che opera affiancato da un software aggiuntivo “copilota”, garantendo così un’affidabilità totale».
A suo avviso siamo ancora molto distanti dal momento della concre-
ta messa in circolazione sulle nostre strade di veicoli a guida automatizzata? «Rispetto ad altri Paesi, in Svizzera adottiamo un approccio più cauto verso queste tecnologie. Tuttavia, il progresso avanza rapidamente e l’interesse crescente è sicuramente una spinta verso il futuro. Sono convinto che presto anche qui da noi ci sarà un’apertura più significativa in questo ambito, e che l’intelligenza artificiale giocherà un ruolo fondamentale nel velocizzare l’evoluzione di moltissimi settori».
Eppure, una svolta significativa è già avvenuta a livello legislativo: lo scorso dicembre il Consiglio federale ha approvato la nuova ordinanza che consente dal prossimo 1. marzo la guida automatizzata su tratti ufficialmente autorizzati. I veicoli dovranno essere tuttavia monitorati da un operatore «in remoto» situato in una centrale. Secondo lei il Ticino è pronto? «Il popolo ticinese ha sempre dimostrato un equilibrio tra tradizione e apertura, anche grazie alla sua posizione di ponte culturale tra nord e sud Europa. Curioso verso le novità, affronta i cambiamenti con pragmatismo, mantenendo vive le proprie radici e trovando un bilanciamento tra innovazione e identità. Le sfide non
mancheranno, soprattutto per quanto riguarda la conformazione del territorio e il traffico. Penso ad esempio che il Ticino è ricco di strade montane, talvolta strette o con particolari caratteristiche, spesso uniche o molto specifiche. In altre zone invece si è confrontati con traffico intenso, segnaletica provvisoria, o condizioni meteo particolari. Se siamo pronti? Certo che sì, anche se qualche perplessità iniziale è del tutto naturale e comprensibile».
Alla Sezione della circolazione di Camorino avete già richieste e domande in tal senso da parte dei conducenti? «Qualche interessato si è già fatto avanti, anche se credo che molti lo faranno più avanti nel corso del 2025. Un tema che capita di trattare e che può portare a confusione è per esempio la differenza tra guida assistita e guida autonoma, che risiede sostanzialmente nel grado di coinvolgimento del conducente. Naturalmente ogni domanda è comunque benvenuta e rispondiamo sempre con piacere ad ogni curiosità».
Intanto, la nuova ordinanza federale prevede pure che dal 1. luglio chi farà la patente dovrà dare prova di conoscere i sistemi di assistenza alla guida e i sistemi di automazio-
ne agli esami teorici e pratici. Vi state già preparando in tal senso? «Certamente, molti sistemi di guida assistita sono una realtà solida nel mondo dell’automobile, e la guida autonoma lo diventerà in breve tempo. La Sezione della circolazione è attiva in numerosi gruppi di lavoro a livello federale, e siamo attualmente all’opera per garantire che tali ordinanze vengano applicate in modo corretto e fluido. Saremo sempre più influenzati nel lavoro quotidiano da queste tecnologie ed è sicuramente stimolante vivere i cambiamenti in prima linea». La nuova ordinanza contempla pure il parcheggio automatico, senza la presenza del conducente a bordo, in posteggi appositamente definiti. Realtà o fantascienza? «È più realtà che fantascienza! Sebbene non sia ancora stato introdotto alle nostre latitudini, il parcheggio automatico senza conducente è invece già una realtà tangibile altrove. L’ordinanza rappresenta sicuramente un passo avanti, ma ci vorranno ancora alcuni aggiustamenti. Insomma, presto potremo far parcheggiare l’auto da sola, ma speriamo che non diventi tanto indipendente da decidere di prendersi una vacanza senza avvisarci» – chiosa con ironia Michele Parravicini.
Attualità ◆ Il Vacherin Mont-d’Or DOP è una specialità apprezzata per la sua consistenza cremosa e il gusto caratteristico Una delizia svizzera in vendita anche a Migros Ticino. Alcune curiosità su questo formaggio unico
Il Vacherin Mont-d’Or è un formaggio cremoso originario delle regioni del Giura vodese svizzero e del Giura francese. Entrambi i Paesi producono questa specialità secondo le proprie tradizioni, ed entrambe sono protette dalla denominazione di origine protetta (DOP). La variante svizzera è prodotta con latte termizzato, mentre quella francese è a base di latte crudo.

Il formaggio Vacherin Mont-d’Or viene prodotto unicamente dalla metà di agosto a fine marzo. Il latte utilizzato proviene da mucche che d’estate pascolano sugli alpeggi ricchi di erbe e fiori, ciò che influisce in modo determinante sulla qualità del latte. Solo una manciata di caseifici è autorizzata a produrre e stagionare questo formaggio DOP, verosimilmente vecchio di quattro secoli.
Una delle particolarità del Vacherin Mont-d’Or DOP è l’affinamento di tre settimane in una scatola di corteccia di abete, anche quest’ultima prodotta da alcuni piccoli artigiani della regione.
Questo Vacherin è talmente cremoso che può essere gustato anche al cucchiaio, a temperatura ambiente, dopo averlo tolto dal frigo almeno un’ora prima del consumo. Si distingue per il suo sapore delicato, legnoso, leggermente salato e poco acido. Può essere consumato anche caldo, facendolo sciogliere lentamente in forno nella sua scatola e gustato come se fosse una fondue accompagnato da patate bollite e pane croccante.
Attualità ◆ Le lasagne alla bolognese sono una specialità imprescindibile della cucina italiana. Per portare in tavola un buon piatto, vi consigliamo di assaggiare le nostre lasagne prodotte in Ticino
Le nostre lasagne fresche pronte al consumo non hanno nulla da invidiare a quelle fatte in casa. Sono infatti preparate in un piccolo laboratorio di gastronomia facendo capo a materie prime fresche, seguendo una ricetta tradizionale.
Oltre ai classici ingredienti quali polpa di pomodoro, verdure, besciamella, sfoglia di semola di grano duro, formaggio grattugiato, nella ricetta del ragù viene utilizzata anche carne macinata di manzo Black Angus svizzero.
Questa razza di origini scozzesi – allevata con successo da qualche anno anche in Svizzera – è rinomata per la qualità delle sue carni, che risultano particolarmente aromatiche, tenere e finemente marezzate. Gli animali sono allevati in Svizzera secondo gli standard di IP-SUISSE, vale a dire con pratiche sostenibili e rispettose del benessere animale.
La preparazione di queste lasagne è facile: è sufficiente scaldarle nel forno tradizionale oppure, per una modalità ancora più rapida, anche nel microonde per qualche minuto.
15%
Lasagne alla bolognese con manzo Black Angus in self-service, prodotte in Ticino, per 100 g Fr. 1.85 invece di 2.20 dal 28.1 al 3.2.2025


Attualità ◆ Sono tornate le irrinunciabili frittelle di carnevale della Migros

Le mitiche frittelle della Migros da 90 anni stanno al carnevale come il panettone sta al Natale. Queste dolci tentazioni ondulate dalla croccantezza senza pari vengono prodotte fin dalla loro nascita dall’industria Migros seguendo praticamente la stessa ricetta, solo la produzione è stata negli anni in gran parte automatizzata. La produzione delle frittelle inizia già durante le festività natalizie e si protrae fino al famoso carnevale di Basilea, che quest’anno verrà inaugurato il 10 marzo con la Morgenstreich. L’impasto a base di
farina di frumento, uova, zucchero e olio di girasole viene spianato ad uno spessore di qualche millimetro e tagliato in dischi. I resti vengono recuperati e riutilizzati per ridurre al minimo gli scarti. Infine, i cerchi di pasta vengono fritti immergendoli in un bagno di olio di girasole bollente, per poi essere sgocciolati, cosparsi di zucchero a velo e confezionati per tutti i negozi Migros della Svizzera. Si stima che ogni anno vengano prodotte qualcosa come oltre venti milioni di frittelle di carnevale Migros.

Raccogli ora i bollini per la tua box sorpresa.

Solo fino a esaurimento dello stock Dal 14.1 al 10.2.2025 un bollino ogni 20.CHF spesi (max 15 bollini per acquisto). Nei supermercati Migros, presso i partner Migros, le filiali VOI e su migros.ch. Fino a esaurimento dello stock. Per ogni cartolina di raccolta completa (20 bollini) una Merci Box con prodotti di uso quotidiano. Periodo di utilizzo del buono valido fino al 17.2.2025. Ulteriori informazioni su: migros.ch/merci-box
Per saperne di più
Salute ◆ Risposte chiare ed evidenze scientifiche sul «prima» e il «dopo» pandemia aiutano a sfatare falsi miti, come ci spiega il dottor Christian Garzoni
Maria Grazia Buletti
Oggi è di molti la percezione di ammalarsi maggiormente di influenza e in modo più pesante rispetto al periodo pre-pandemico. Sensazione certo sostenuta dal fatto che, durante gli anni 2020/2021, le misure atte a contrastare il Covid hanno prodotto un periodo di calma e oggi ci facciamo caso maggiormente. «Bloccando gli scambi naturali fra le persone, la pandemia ha forzato l’umanità nel creare una situazione di vita anomala e artificiosa, e questo anche a livello di germi patogeni (virus e batteri). Nel biennio 2020/2021 le misure messe in atto per bloccare la pandemia (distanziamento sociale, mascherine, maggiore igiene delle mani e lockdown) hanno inibito quello che deve essere il normale passaggio di agenti virali e batterici a livello delle vie respiratorie. La minore circolazione di patogeni ha fatto sì che in quel periodo la popolazione si sia ammalata di meno».
Da noi sollecitato a tornare sul tema della pandemia Covid per aiutarci a fare chiarezza sul «dopo», il dottor Christian Garzoni riflette sul fatto che durante la pandemia il sistema immunitario ha avuto meno contatto con i virus respiratori che normalmente incontra (e si allena regolarmente a combattere) soprattutto durante l’inverno: «Non dobbiamo dimenticare che l’incontro regolare del nostro sistema di difesa immunitaria con virus e batteri gli permette di mantenere una sorta di memoria per riconoscerli e un certo “allenamento e prontezza” a combatterli».
Concetto che potrebbe sembrare semplicistico e perciò dobbiamo ricordare la complessità del nostro sistema immunitario che, come spiegava l’immunologo e ricercatore professor Carlo Chizzolini da noi incontrato nel 2020, «oggi è protagonista involontario, ma non dobbiamo dimenticare che si tratta del nostro scudo naturale alle aggressioni esterne e vanta pure una memoria da elefante». Niente paura né pregiudizi, quindi, perché il nostro sistema di difesa reagisce agli agenti patogeni come sa fare e non ne nega certo l’esistenza, solo che neces-
sita di incontrarli costantemente, ricorda Chizzolini: «Il sistema immunitario è fra i più complessi del nostro organismo (un po’ come il cervello); la sua assenza o i suoi difetti importanti sono incompatibili con la vita. È perciò il nostro scudo naturale alle aggressioni esterne senza il quale nessuno sopravvivrebbe a lungo; è un sistema di difesa del nostro organismo che riconosce con precisione segnali di pericolo attraverso i suoi campanelli d’allarme che lo spingono ad attivarsi quando intuiscono che sta arrivando qualcosa di potenzialmente pericoloso (virus, batteri, altri agenti patogeni)».
Di conseguenza, il dott. Garzoni ci ricorda che entrare in contatto con agenti patogeni come i virus influenzali è tanto inevitabile quanto necessario per mantenere attivi memoria e allenamento delle nostre difese: «Vi sono patogeni dei quali le nostre difese conservano una certa memoria pur senza entrarvi in contatto frequente, mentre per altri l’allenamento all’incontro abituale e regolare permette alla memoria di essere sempre viva, attiva e rapidamente efficace. La tendenza ad ammalarsi aumenta quando questa memoria diminuisce, ma essa non si cancella mai del tutto ed è per questo che ci sa proteggere da infezioni gravi e mortali». Lo specialista porta ad esempio la differenza fra virus respiratori e altri tipi di virus: «Se hai contratto il morbillo, o ne sei vaccinato, sarai protetto a vita. Diverso è per i virus respiratori che sono moltissimi e mutano un po’ di anno in anno. Ciò significa che, giocoforza, è normale che ci si potrebbe ammalare un po’ tutti gli anni, ma con infezioni non gravi».
Sembrerebbe che ammalarsi sia comunque meglio di vaccinarsi ma non è così, spiega Garzoni entrando senza giudizio o pregiudizio (e nel modo più scientifico possibile) nel tema delle vaccinazioni: «Per tenere allenato il sistema immunitario, il vaccino dell’influenza fa tanto bene quanto lo fa ammalarsi davvero. Però il vaccino comporta molti meno effetti collate-

rali e questo ha un peso ancora maggiore per le persone dalla salute vulnerabile o per le persone anziane, per i quali il virus può essere anche mortale». Lo spiega il cosiddetto «effetto buster»: «Se faccio il vaccino influenzale ogni anno, il sistema immunitario riconosce il patogeno perché sarà ben allenato, anche se i virus respiratori mutano sempre un po’ e non è detto che poi si entri in contatto esattamente con il virus per il quale si sia stati vaccinati. Comunque, ci ammaleremo in modo più lieve». Senza dimenticare che per altri virus molto frequenti non ci sono vaccini perché sono poco pericolosi, o ce ne sono troppi ceppi e non si riesce a produrre un vaccino efficace: «Ad esempio, il Rhinovirus (raffreddore) è molto fastidioso ma non esiste vaccino; ci si ammala anche più di una volta all’anno per via dei vari ceppi; fa quindi parte della natura delle cose che in inverno siamo confrontati con tanti virus e, di conseguenza, ci ammaliamo». Ciò non significa che ammalarsi sia salutare: «Però si deve considerare l’ineluttabilità del bisogno naturale di allenare le nostre difese dell’organismo dagli agenti patogeni dai quali ci dovranno difendere, sia attraverso il
vaccino (che, ricordiamo, protegge da decorsi con effetti collaterali gravi) sia nell’incontro con il virus stesso». Dopo aver compreso un po’ meglio la complessità e il funzionamento delle nostre difese immunitarie, chiediamo al dott. Garzoni una lettura dell’odierna percezione comune di ammalarsi di più: «Nel 2020/21 ci siamo dovuti proteggere e ci siamo ammalati meno a causa, dicevamo, delle misure messe in atto (eravamo chiusi in casa, non avevamo contatti e scambi naturali di una situazione di vita normale). Nel 2022, e un po’ nel 2023, la tendenza mostra che nei Paesi occidentali ci si ammalava di più dei virus respiratori più frequenti (influenza, virus RSV) rispetto all’epidemia di Covid. Un aumento temporaneo in quanto quest’anno i casi sono tornati stabili e paragonabili “all’era pre-Covid”. Una delle ipotesi riguarda il cosiddetto “debito immunologico” che, di per sé, non contempla necessariamente casi estremamente gravi, ma è come se il sistema immunitario per un paio d’anni abbia perso una parte di allenamento, così come il calciatore professionista reduce da un incidente che per un paio di mesi è più debole degli altri, ma poi recu-
pera come prima». Dati alla mano, la percezione di ammalarsi di più e più gravemente resta tale: «È certamente sostenuta dal fatto che per un paio d’anni abbiamo avuto un periodo di calma “artificiale” per le misure attuate; oggi notiamo semplicemente la differenza del ritorno alla normalità». Va ridimensionata pure la responsabilità attribuita al Covid: «Oltre al debito immunologico, l’ipotesi che il Covid abbia contribuito a una sorta di indebolimento del sistema immunitario non trova riscontro negli studi o nelle evidenze scientifiche». E pure additare il vaccino lascia il tempo che trova, sebbene «si comprendono i motivi di questa falsa percezione, dettati soprattutto da una comunicazione che sarebbe dovuta essere migliore». Il professor Carlo Chizzolini, d’altronde, già nell’era Covid aveva espresso alcuni spunti di riflessione: «Ciò che ci pare un flagello nuovo, non lo è per il nostro sistema immunitario, meravigliosamente evoluto e funzionante proprio per affrontare situazioni come queste. Disponiamo di un sistema di difesa programmato a combattere proprio questi “nemici” e lo fa con un interesse di sopravvivenza per la specie, più che individuale».
Pubblicazioni ◆ Il «romanzo medico» del dottor Filippo Donati è una testimonianza piena di coraggio e umanità
Barbara Manzoni
«Mi colpisce il fatto che nello spazio di pochi istanti sono passato a essere ufficialmente colui che si siede dall’altra parte della scrivania del medico, da curante sono diventato paziente colpito da una malattia che per di più è inclusa nel mio campo di specializzazione. Ironia della sorte?». Inizia così il libro I giorni che verranno scritto dal dottor Filippo Donati affiancato dalla scrittrice Federica Lehner (ed. Dadò). I giorni ai quali il dott. Donati guarda sono quelli in cui dovrà convivere con la malattia di Parkinson. Per anni è stato primario del servizio di neurologia del Centro ospedaliero di Bienne, di Parkinson sa tutto dal punto di vista medico, ma viverlo sulla propria persona, sul proprio corpo cambia la prospettiva, decide così di tenere un diario che racconti «il viaggio nella malattia». Nel tempo il diario è diventato un progetto più articolato, ne
è nato un libro con una struttura che si articola su più piani: la parte narrativa, costituita dal diario del protagonista, e la parte «tecnica», costituita da schede scientifiche che trattano in modo chiaro, divulgativo e rigoroso aspetti medici, neurologici e psicologici della malattia. Queste schede tecniche sono, a loro volta, arricchite da disegni di sette artisti contemporanei svizzeri che illustrano con la loro sensibilità il tema medico specificamente trattato. Il libro ha a tutti gli effetti la forma di un diario ma non si deve credere che la narrazione della malattia sia totalmente lineare, salta a volte anche lunghi periodi, riprende dopo mesi, eppure Donati riesce sempre a coinvolgere il lettore, senza cedere mai all’autocommiserazione. La forza delle pagine, che l’autore stesso definisce come un «romanzo medico», nasce da una grande capacità di introspezione che, come

capita normalmente nella vita, lascia spazio agli eventi grandi e piccoli del quotidiano, gli incontri con gli amici e
i loro problemi, i brevi e lunghi viaggi, l’uscita al cinema, le riunioni di famiglia, la propensione del protagonista a fare progetti per il futuro, la gioia quasi illogica di comprarsi una moto. Ritorna spesso l’analisi del rapporto con la moglie e con i figli; Donati si domanda quanto parlare in famiglia del decorso della malattia. Sarebbe meglio affrontare l’argomento più spesso, in modo più diretto? In questo campo nessuna risposta è certa, ma il sentire la stabilità degli affetti è essenziale. Più volte poi ritorna il tema dell’importanza del rapporto con il proprio medico, tanto che Donati stesso si chiede fin da subito: «Sono sempre stato all’altezza umanamente, oltre che professionalmente, con tutti i miei pazienti?». Filippo Donati ci ha donato, è proprio il caso di dirlo, un libro pieno di coraggio e di umanità, capace di coinvolgerci emotivamente, ci rende parte-
cipi dei pensieri personali e delle intime paure di chi un giorno riceve una diagnosi che gli cambierà il resto dell’esistenza. Come sottolinea anche Elmar Zwahlen, presidente di Parkinson Svizzera, nella prefazione, non si può che ammirare la determinazione di Donati nel «continuare a perseguire e realizzare i suoi obiettivi di vita» e la capacità di affrontare le difficoltà anche cercando aiuto nei momenti in cui sente che da solo non ce la farebbe. Il diario è una testimonianza importante e da condividere con chi vive una situazione simile, sia i malati sia chi li accompagna in questo viaggio, compresi i professionisti nel campo della salute.
Bibliografia
Federica Lehner e Filippo Donati, I giorni che verranno. La mia vita con il Parkinson, Armando Dadò editore, 2024.
Giovani ◆ Pro Juventute ha pubblicato un’indagine rappresentativa su come i ragazzi tra i 14 e i 25 anni in Svizzera affrontino lo stress, le crisi, l’uso dei media e la resilienza. I risultati mostrano differenze significative tra i generi
Alessandra Ostini Sutto
Dal 2019, l’attività di consulenza del numero di emergenza 147 di Pro Juventute è aumentata di oltre il 70%; una crescita impressionante, confermata per mezzo di altri dati e risultati che mostrano un aumento della pressione psicologica tra i giovani in Svizzera.
Alla luce, anche, di queste cifre, Pro Juventute ha voluto indagare su come si sentano gli adolescenti e i giovani adulti nel nostro Paese e quali sono i fattori che causano loro stress e preoccupazioni. «Vi sono ancora pochi dati sulla salute psicologica dei ragazzi in Svizzera. In qualità di maggiore fondazione per i bambini e i giovani, desideriamo studiare i giovani nel lungo periodo; questo primo sondaggio è quindi solo l’inizio», afferma Lulzana Musliu, responsabile politica e media di Pro Juventute. Lo Studio sui giovani è stato condotto in collaborazione con il Dipartimento di psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza della Clinica psichiatrica universitaria di Zurigo e dell’Università di Losanna, interrogando un campione rappresentativo di ragazzi tra i 14 e i 25 anni, in diverse situazioni scolastiche, formative o professionali.
Tra i principali risultati, emerge che l’88% dei giovani afferma di sentirsi bene mentalmente; cifra che raggiunge il 94% se si parla di salute fisica. Nonostante questi dati elevati, il 30% dei ragazzi dichiara di essere spesso stanco o spossato. Per quel che riguarda il tema caldo dei social media, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, dalla ricerca emerge che essi costituiscono una fonte di stress solo per il 15% circa dei ragazzi. A logorare sono piuttosto lo stress legato alla formazione, la pressione per le prestazioni e il confronto con richieste elevate, le preoccupazioni economiche e i timori per il futuro professionale.
«L’accresciuta pressione che il mondo degli adulti mette sulle spalle dei giovani, l’esasperata competitività a cui sono costantemente confrontati, i tempi di reazione strettissimi che sono chiamati ad adottare, la necessità di essere belli, performanti, capaci, vincenti sono alcuni dei fattori che costituiscono il problema, riguardo al quale bisogna essere consapevoli che siamo noi adulti a chiedere a bambini e giovani ciò che noi non possiamo più essere –afferma Ilario Lodi, responsabile regionale di Pro Juventute per la Svizzera italiana. Dal canto loro, bambini e ragazzi sanno adattarsi alle nuove situazioni in modo che, forse, a noi pare sorprendente. Se si chiede a un giovane se gli piace passare tre, quattro o cinque ore sui social, risponderà molto probabilmente di sì; se gli si chiede di rinunciare (o, almeno, contenere) il suo rapporto con le nuove tecnologie o di riconsiderare la sua relazione con il mondo secondo modalità differenti da quelle legate alla competitività, alla bellezza o al potere, con ogni probabilità dirà di no. Ora la questione è: a noi adulti piace il mondo che stiamo “of-
A. Negli ultimi 14 giorni
Sentimenti negativi: % di risposte «sovente/sempre»
Spossata/o
B. Negli ultimi 14 giorni
Sentimenti positivi: % di risposte «sovente/sempre»
In forma fisicamente
Molta energia
Mi sento bene psicologicamente
Sentimenti negativi (A) e positivi (B) negli ultimi 14 giorni tra i partecipanti di sesso maschile e femminile (% di risposte «spesso/sempre») - Fonte Pro Juventute
frendo” ai bambini e ai giovani? Il problema sta soprattutto qui, credo». Una questione che segnatamente i genitori si dovrebbero porre, anche visto che dal sondaggio commissionato dalla Fondazione il rapporto con mamma e papà è emerso essere determinante per la percezione del benessere dei ragazzi; un aspetto forse scontato ma sul quale non sempre ci si sofferma quando si affrontano queste tematiche. Nello specifico, i risultati dell’indagine mostrano quanto una relazione di fiducia tra genitori e figli influisca su questi ultimi, in particolare sul fatto di sentirsi più in forma ed avere un’immagine di sé più positiva. I genitori sono quindi una «risorsa importate» per tutelare la salute mentale dei giovani e, al riguardo, i dati sono promettenti: quasi il 90% degli intervistati ha infatti dichiarato di poter contare su mamma e papà in caso di problemi o preoccupazioni. «Un dato molto positivo, che indica inoltre un cambio di paradigma rispetto alla generazione precedente che tendeva a ribellarsi ai genitori», sottolinea Susanne Walitza, Direttrice del Dipartimento di psichiatria infan-
tile e adolescenziale dell’istituto zurighese e responsabile del team di ricerca dello Studio.
Un problema però è dato dal fatto che non sono solo i ragazzi a sentire il peso delle pressioni psicologiche esercitate dal contesto, ma pure le famiglie. «Immaginiamoci che io, come genitore, mi sento ripetutamente dire che “senza l’inglese mio figlio è fuori dai giochi” o che “se mia figlia non sa programmare una linea di codice ha perso il treno”; qualche preoccupazione, in virtù dell’amore per i miei figli, mi verrà e, di conseguenza, se non saprò reggere questa pressione, finirò per dare fiducia a chi mi dice queste cose, riversando il tutto sui miei figli; ed è qui che “casca l’asino”, nel fatto cioè di credere che quanto il mondo chiede ai miei figli sia sistematicamente più importante di quanto io, come genitore, credo sia importante per loro – spiega Lodi – quindi ai genitori dico: fidatevi di più di quello che siete e di quello che sapete fare e trasmettere ai vostri figli ciò in cui credete. E se credete di non avere molto da dare, mettetevi al lavoro: leggete, studia-

te, andate al cinema, a teatro; fate un viaggio, ascoltate quanto la realtà vi dice e condividete tutto con i vostri figli. Si può fare un’ottima educazione anche solo partendo da un passaggio al supermercato».
La relazione con i genitori rappresenta inoltre un punto fermo nell’attuale contesto di multi-crisi – o «permacrisi» come lo definiscono le Nazioni Unite –, riguardo al quale lo studio di Pro Juventute ha voluto anche indagare su come i ragazzi ricevono le notizie e quali effetti esse hanno sul loro benessere.
Circa un quarto degli intervistati si è detto particolarmente colpito dagli eventi mondiali. Su questi aspetti – come su altri, che vedremo – si riscontrano differenze di genere. Gli esponenti di sesso maschile si preoccupano un po’ meno rispetto alle intervistate, toccate in particolare dall’ingiustizia nel mondo, dal razzismo e dal sessismo.
nel genere maschile o piuttosto come il risultato di una minore consapevolezza emotiva», dichiara Walitza. Riprendendo il tema dell’aiuto psicologico, al momento dell’indagine il 12% dei partecipanti era sottoposto a trattamento psicoterapeutico. Di fronte ai dati visti, l’impressione è che oggi vi sia una maggiore propensione a chiedere aiuto, che procede di pari passo con una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione rispetto alle tematiche di salute mentale.
«Chiedere aiuto è importante. Bisogna però intendersi sui termini: quale forma di aiuto? Io non credo infatti che le questioni esistenziali cui facevamo cenno necessitino di un aiuto psicologico sottoforma di psicoterapia – commenta Ilario Lodi – credo piuttosto che ci sia più bisogno di pedagogisti poiché il problema del “disagio giovanile” non è solo di natura individuale, ma anche, forse soprattutto, collettiva».
Se quindi da un lato è oggettivo che vi siano numerosi ragazzi, e pure bambini, che usufruiscono a ragione di un sostengo individuale, dall’altro è necessario lavorare sulla collettività, poiché è lì che il problema si origina. «E allora rientrano in gioco la dimensione della scuola – che, a mio parere, dovrebbe essere chiamata a compiti di natura più esistenziale, come quello di insegnare a “rifarsi a sé stessi” piuttosto che credere che la riuscita della propria vita debba necessariamente passare dall’inglese –, delle attività extrascolastiche, di quelle da svolgere durante il periodo estivo, che mai come oggi le famiglie tendono a considerare un’occasione per “recuperare il tempo perso” facendo ripetizioni piuttosto che, per esempio, un’occasione per sperimentare la vita residenziale delle colonie, dove si fa vacanza per davvero», continua Lodi.
In conclusione, un tema che non poteva mancare nello Studio sulla gioventù è quello dell’utilizzo digitale di bambini e ragazzi, risultato – come anticipato – meno problematico di quanto si sia portati a pensare. Tra gli effetti positivi connessi ai media digitali, quasi il 30% dei giovani intervistati dice di usarli per migliorare il proprio umore e gestire lo stress, oltre la metà per tenersi in contatto, mentre il 20% dichiara di aver fatto amicizia grazie ad essi. Tra gli aspetti problematici, citiamo le discussioni con amici e familiari a causa dell’utilizzo dei media, riferite da circa il 15% dei ragazzi. «Che le nuove tecnologie siano entrate a far parte della vita di bambini e ragazzi (come della nostra di adulti) è un dato di fatto. Al riguardo non dobbiamo però dimenticarci che i social sono delle imprese commerciali, il cui scopo è quello di fare quattrini, prima che di mettere in relazione le persone (che è piuttosto un mezzo per raggiungere il detto obiettivo) e chiederci quindi se questo sia il modo più efficace o più adatto alla crescita dei nostri figli», conclude Ilario Lodi. Al momento dell’indagine il 12% dei partecipanti era sottoposto a trattamento psicoterapeutico. (Pro Juventute)
D’altra parte, i partecipanti maschi sono più preoccupati per gli sviluppi politici e la divisione della società, seguiti dalle manipolazioni e distorsioni dei media e dell’intelligenza artificiale. Più in generale, dallo Studio sulla gioventù si nota come le ragazze stiano peggio rispetto ai loro coetanei. Ad esempio, il 36% delle intervistate dice di sentirsi spesso stanca ed esausta, contro il 21% dei ragazzi. Alla domanda se si fossero già sottoposti ad un trattamento psicologico o psicoterapeutico, il 33% delle ragazze ha fornito una risposta affermativa, contro il 22% dei ragazzi. A spiegazione di questi dati, lo studio mostra che esse tendono a preoccuparsi di più per il mondo, reagiscono con maggiore emotività allo stress e sono più sotto pressione per la formazione, oltre a vedere sé stesse con un occhio più critico. «Non è chiaro se questo possa essere interpretato come una maggiore resilienza
Territorio ◆ Nel nucleo di Riva San Vitale si sta portando a termine il recupero di un’antica fornace e di un essiccatoio, il progetto prevede di mettere in funzione due nuovi forni professionali e di favorire produzioni artistiche e attività culturali, sociali e didattiche
Stefania Hubmann
Edifici segnati dal tempo legati ad attività produttive scomparse, un brand che ne indica la rinascita, un cantiere e ora la visione di un comparto restaurato quasi pronto per accogliere la lavorazione della ceramica quale forma d’arte ai più alti livelli. Attraversando il nucleo di Riva San Vitale negli ultimi cinque anni si è potuto seguire questa evoluzione del Comparto Fornaci, dove nell’Ottocento ferveva l’attività di produzione di coppi e mattoni sfruttando la vicina presenza di due cave d’argilla. Il progetto di recupero ha una lunga storia ed è caratterizzato dalla volontà del Comune, con il sostegno dell’Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio e del Cantone, di valorizzare questa peculiarità del nucleo dove si contano ben sei fornaci. Nel 2021 l’acquisto degli edifici di proprietà della famiglia Pellegrini ha permesso al Comune di concretizzare l’iniziativa che sta ora giungendo al termine dell’intervento di ristrutturazione per poi lasciare spazio a contenuti di natura artistica, formativa, culturale e sociale. Il compito di elaborare questi concetti spetta alla Fondazione Le Fornaci di Riva San Vitale, costituita dal Comune l’anno scorso. L’inaugurazione è prevista a fine estate.
Nell’Ottocento a Riva ferveva la produzione di coppi e mattoni sfruttando la presenza di due cave d’argilla
Il progetto di recupero riguarda tre edifici nel nucleo di Riva San Vitale, ma è destinato a suscitare un interesse più ampio, esteso a livello nazionale e internazionale. Uno dei due nuovi forni a gas permetterà infatti di cuocere oggetti di grandi dimensioni, ciò che rappresenta una novità per il Ticino. Inoltre, grazie alle competenze e alla rete di contatti dei membri della Fondazione, sarà possibile coinvolgere partner importanti provenienti dalla regione, che vanta una propria tradizione nel campo artistico della ceramica, come pure da oltre i confini cantonali e nazionali. Agli artisti e agli enti interessati a collaborare si potranno offrire due forni professionali, un atelier con torni e tavoli da lavoro nell’ex essiccatoio, oltre a spazi interni ed esterni adatti a esposizioni e ad altri tipi di eventi pubblici.
Il restauro conservativo e il pozzo ritrovato
È all’architetto Enrico Sassi – nostra guida nella visita al complesso cantiere – che si deve la nuova concezione del Comparto Fornaci. Specializzato nelle ristrutturazioni, venne contattato per questa iniziativa dall’Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio già nel 2011. L’idea iniziale interessava un’area di maggiori dimensioni comprendente più fornaci. Riguardo all’attuale progetto, l’architetto evidenzia innanzitutto il lavoro compiuto in tandem con l’ingegnere Giorgio Galfetti. Quest’ultimo, per salvare le strutture esistenti, in particolare quelle dell’essiccatoio, ha appositamente ideato diversi tipi di supporti in metallo chiamati a svolgere la fun-

zione di sostegno che i vecchi muri non sono più in grado di assicurare. I pilastri, in origine privi di fondamenta, hanno avuto bisogno di sottomurazioni sempre per una questione di stabilità. «C’è stato fra noi un intenso scambio di schizzi disegnati a mano – precisa l’architetto Sassi – per permettere un restauro il più conservativo possibile. Dei tre edifici – fornace, essiccatoio, garage annesso alla fornace – solo quest’ultimo è stato abbattuto poiché più recente e privo di valore architettonico». La sua demolizione ha però portato alla luce un pozzo ben conservato, profondo 2,8 metri e contenente acqua del lago utilizzata in passato per lavorare l’argilla. Per mantenerlo visibile è stato necessario rivedere i piani della Casa dei forni (che sorge al posto del garage) e inoltrare una nuova Domanda di costruzione. Questo iter si è per
fortuna risolto senza intoppi. Il nuovo edificio ha due piccole ciminiere ottagonali (i camini dei forni) su un terrazzo fruibile. Ciminiere e muri sono rivestiti con pezzi di coppi e mattoni rinvenuti sul posto. Uno dei principi di questo intervento è infatti il riutilizzo del materiale laterizio esistente». I locali della vecchia fornace potranno svolgere più funzioni, da sala didattica a spazi espositivi e sociali.
Da rilevare, ancora, che negli stabili storici le parti vecchie e quelle nuove sono entrambe visibili, sia a livello di muri e sostegni metallici, sia per quanto concerne la carpenteria con travi ripulite e precedenti riparazioni ancora distinguibili. Un’attenzione per i dettagli da attribuire al progettista che da parte sua menziona però anche l’accurato lavoro svolto dalle maestranze.

Un progetto che coinvolge anche la popolazione
«Il potenziale di questo progetto è molto elevato», afferma da parte sua il municipale Noris Guarisco, responsabile del Dicastero Cultura, sport e tempo libero, culto (chiesa). «Dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale del credito di 3,8 milioni di franchi per la ristrutturazione degli stabili, ci siamo subito chinati sulla questione della visibilità per tenere vivo l’interesse del pubblico durante i lavori. Abbiamo quindi promosso la nascita del sito internet unitamente a un brand che accompagna ogni attività legata alle Fornaci. Durante questi anni sono stati organizzati incontri e porte aperte per informare regolarmente la popolazione».
«A livello di gestione delle nuo-

ve strutture – prosegue Guarisco –nel 2024 il Municipio ha deciso di costituire la Fondazione Le Fornaci di Riva San Vitale con il compito di promuovere in questi spazi produzioni artistiche e attività culturali volte all’eccellenza. Contiamo pure sull’affetto manifestato dalla popolazione affinché partecipi attivamente alla rinascita delle Fornaci. L’acquisizione da parte del Comune della vicina casa Gorla – ristrutturata dai precedenti proprietari e ora in locazione –rappresenta un’ulteriore premessa per lo sviluppo del Comparto». Sviluppo che può ad esempio passare da una collaborazione con le Città della Ceramica e gli artigiani locali. Lorenza Capponi, segretaria comunale e persona di collegamento con la Fondazione, precisa che «al momento si sta cercando di far conoscere il progetto delle Fornaci presso enti che operano nello stesso ambito in Svizzera e nella vicina Italia, ma soprattutto a livello di scuole cantonali, da quelle dell’obbligo a quelle professionali fino a SUPSI E USI». La lavorazione dell’argilla e la sua importanza nella storia di Riva San Vitale sono già un tema anche per l’Istituto scolastico comunale. Sempre Lorenza Capponi: «L’Istituto ha promosso durante questo anno scolastico un progetto che verte sulla storia della lavorazione dell’argilla a Riva San Vitale e sulla realizzazione di piccoli oggetti. Gli sarà sicuramente dato spazio nell’ambito dell’avvio dell’attività alle Fornaci».
La storia di questo progetto è strettamente legata a quella della famiglia Pellegrini che nel 2021 ha venduto al Comune i tre edifici interessati dalla ristrutturazione. L’erede Danilo Pellegrini conserva l’archivio di famiglia, composto da documenti, fotografie, pagine di diario, istrumenti di compra e vendita e oggetti. In un’immagine risalente al 1899 sono identificabili i suoi bisnonni e suo nonno (bambino) negli spazi esterni; la bisnonna è al pozzo che è stato rinvenuto durante la demolizione del garage. «L’archivio – spiega Danilo Pellegrini – comprende sette libri delle spese (entrate e uscite) con regolari annotazioni quotidiane dal lontano 21 aprile 1874 al 22 dicembre 1959. In questi quaderni sono pure riportati aneddoti della famiglia e avvenimenti significativi del paese. Nell’archivio non mancano attrezzi da lavoro e stampi, oltre a prodotti finiti con impresse tracce di zampe di animali domestici e di dita e mani di chi li ha realizzati». Sono tutte informazioni importanti sull’attività fornaciaia della famiglia Pellegrini che grazie ad Armida e a suo fratello Domenico (padre di Danilo), figli dell’ultimo fornaciaio, hanno potuto essere tramandate ai discendenti, così come gli edifici. Fra qualche mese questi ultimi apriranno nuovamente le loro porte alla lavorazione dell’argilla anche se in forme e con scopi diversi rispetto al passato. Oggi si punta sull’arte e sul suo ruolo culturale, turistico ed economico nella società contemporanea.
Informazioni www.fornaci.ch
Due popoli, una difficile convivenza
Dalla guerra arabo-israeliana del 1948 al tragico ottobre del 2023, con l’assalto di Hamas e la dura reazione di Tel Aviv
Pagina 14
Tra israeliani e palestinesi
A una settimana dall’entrata in vigore della fragile tregua tra Israele e Hamas cerchiamo di capire come si muovono gli attori in campo
Pagina 15
L’Europa di fronte a Trump
È interessante osservare come gli Stati europei stiano reagendo in ordine sparso all’avvento del «nuovo» presidente americano
Pagina 15
Diplomazia ◆ Dalle ipotesi di Trump per una pace in Ucraina agli accordi di libero scambio con il Kosovo e la Thailandia, passando per le soste della presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter al ristorante della Migros
Ogni anno in gennaio la politica svizzera vive una sospensione di qualche giorno. Partiti, associazioni e sindacati riducono al minimo le loro attività perché una buona parte dell’attenzione si sposta su Davos e sul Forum economico mondiale (Wef). Non per nulla, in quei giorni targati Wef, la località grigionese si trasforma in una sorta di sede d’alta quota del Consiglio federale, visto che i nostri ministri vi si trasferiscono in gran numero per incontrare i loro omologhi in arrivo da tutto il mondo. Quest’anno, nell’edizione che si è svolta la scorsa settimana, ben sei consiglieri federali su sette hanno trascorso qualche giorno al Forum economico mondiale. L’unico a essere rimasto a Berna è stato Albert Rösti. Gli altri suoi colleghi di Governo si sono ritrovati a gestire una quaranta di incontri bilaterali, Davos conferma così di essere un volano diplomatico di primo rango per il nostro Paese.
L’anno scorso, proprio in occasione del Wef, era nata l’idea di una Conferenza internazionale sull’Ucraina, che si era poi svolta all’inizio dell’estate sul Bürgenstock. Anche quest’anno quel conflitto è stato al centro delle attenzioni e, per quanto riguarda la Svizzera, il nostro ministro degli esteri Ignazio Cassis ha incontrato a Davos il suo omologo ucraino Andri Sibiha, mentre la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha avuto un colloquio con Volodymyr Zelensky. Su questo fronte, il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump ha di fatto aperto una nuova fase, visto che l’ex e al contempo neo-presidente degli Stati Uniti si è detto in grado di risolvere alla svelta questa guerra. La diplomazia a stelle e strisce è al lavoro, anche per mettere Putin sotto pressione con ulteriori sanzioni e dazi commerciali. Nel suo intervento di giovedì scorso, in collegamento streaming con il Forum economico mondiale, Trump ha messo l’accento anche sul prezzo del petrolio, dicendo di essere pronto a chiedere, o imporre, una sua riduzione ai Paesi dell’Opec (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio). Con un prezzo del greggio in calo «la guerra in Ucraina si fermerà immediatamente», ha lasciato intendere il presidente degli Stati Uniti, visto che la Russia continua a finanziare i suoi sforzi bellici anche attraverso la vendita di petrolio. In questo contesto – dominato dalla figura di Trump, ma anche dalle tante incertezze che segnano questo cambio della guardia alla Casa Bianca – il nostro Paese non ha al momento un ruolo diplomatico specifico. Kiev è comunque tornata a chiedere a Berna la disponibilità ad assumere il compito di rappresentare i suoi
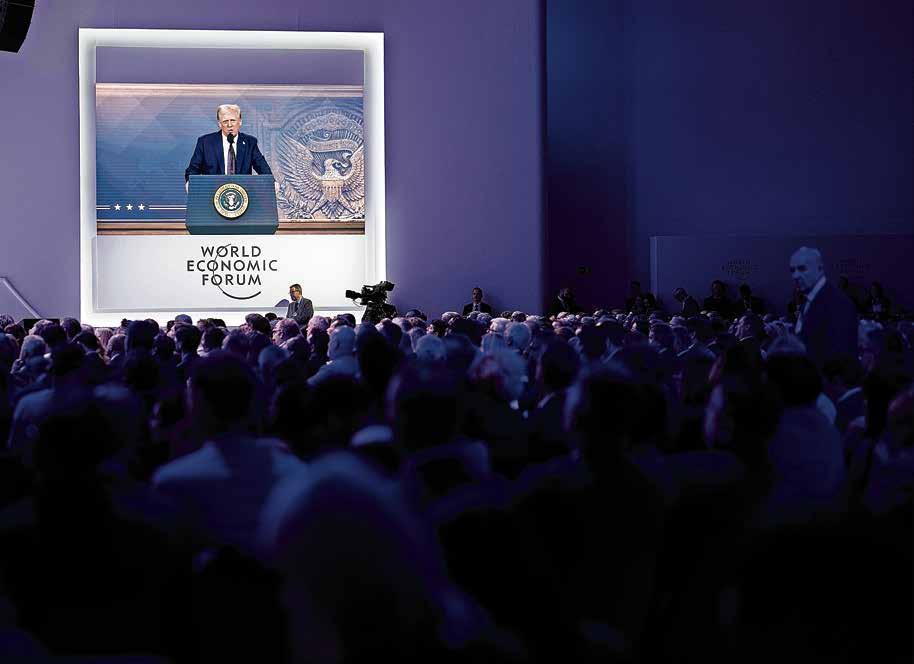
interessi diplomatici in Russia, più o meno quello che la Svizzera svolge ad esempio tra Stati Uniti e Iran. Un ruolo per facilitare i contatti tra Paesi nemici che Mosca si è finora sempre rifiutata di accordare a Berna, visto che a suo dire la Svizzera ha ormai perso lo statuto di Paese neutrale, per essersi schierata dalla parte di Kiev e dell’Occidente. A Davos Ignazio Cassis ha anche incontrato la ministra degli esteri finlandese Elina Valtonen. La Finlandia al momento presiede l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ruolo che nel 2026 verrà assunto dalla Svizzera. La nostra diplomazia sarà dunque presto chiamata a dirigere le operazioni di questa organizzazione che già in passato ha avuto un ruolo di primo piano nella ricerca della pace in Ucraina, dopo i primi scontri armati del 2014, e prima ancora nei Paesi dell’ex Jugoslavia.
A Davos comunque non si è parlato solo di Ucraina e dell’invasione russa di questo Paese. C’è stato spazio anche per una delle leve classiche della nostra diplomazia, quella commerciale. Il nostro ministro dell’economia Guy Par-
melin ha siglato due accordi di libero scambio, con il Kosovo e con la Thailandia. Due intese non certo di primo rango ma che aumentano il numero di queste convenzioni. Stando alla Seco, la Segreteria di Stato per l’economia, il nostro Paese dispone al momento di 35 accordi di libero scambio, a cui vanno aggiunti quelli con l’Unione europea e quelli con l’Associazione europea di libero scambio. Su questo fronte, a detta dello stesso Parmelin, il 2025 sarà caratterizzato soprattutto dal rinnovo dell’accordo commerciale tra il nostro Paese e la Cina, che è in vigore da oltre dieci anni.
Gli Usa sono il partner commerciale più importante con cui Berna non ha ancora concluso un accordo di libero scambio, dice la Seco
Un dossier che è destinato a suscitare parecchie polemiche interne, tra chi mira a intensificare le relazioni commerciali con Pechino e chi invece mette in guardia sul mancato ri-
spetto dei diritti delle persone da parte del regime cinese. Da marzo Berna riaprirà queste trattative, una sorta di via svizzera verso la Cina, e viceversa. Un rapporto con Pechino che diversi altri Paesi ci invidiano ma che internamente non mancherà certo di far discutere. Accordi commerciali che al momento rappresentano una sorta di contromisura alle minacce statunitensi di imporre dazi e barriere doganali un po’ dappertutto nel mondo. Una strategia del «bastone» che un The Donald decisamente su di giri è tornato a ripetere anche nel suo infuocato collegamento video con Davos, alzando i toni in particolare contro l’Unione europea e le sue pratiche commerciali. Una dinamica in cui anche il nostro Paese potrebbe venir risucchiato.
E qui va detto che gli Stati Uniti sono diventati nel corso del 2023 il mercato al mondo che più importa beni e servizi di origine elvetica. Una bilancia commerciale in attivo per la Svizzera, che rischia di non piacere per nulla alla Casa Bianca. Da notare che gli Stati Uniti sono al momento – così ricorda la Seco – il «partner
commerciale più importante con cui la Svizzera non ha ancora concluso un accordo di libero scambio». Tornando al Forum economico mondiale di Davos, va detto che c’è stato spazio pure per le nostre relazioni con l’Unione europea, dopo la conclusione delle trattative per i bilaterali del futuro. Poche le novità al momento su questo fronte, che ha visto Karin Keller Sutter incontrare la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e Ignazio Cassis dialogare nuovamente Maros Sefcovic, l’uomo di Bruxelles in questi negoziati. Il ministro ticinese ha offerto al commissario europeo una fondue al formaggio, in nome di una diplomazia che al Wef si confonde spesso anche con l’arte culinaria, e pure viti-vinicola. E qui, in conclusione, ci sono da segnalare le scelte gastronomiche della presidente della Confederazione. A Davos Karin Keller-Sutter è stata vista più volte al ristorante della Migros, con tanto di vassoio in mano, intenta a scegliere gli ingredienti del suo pasto. Un’immagine di sobrietà, lassù tra i nomi più blasonati, e facoltosi, di questo pianeta.
Svizzera ◆ Il 9 febbraio si vota sull’iniziativa «Per un’economia responsabile entro i limiti del pianeta», le ragioni pro e contro
Alessandro Carli
Il 9 febbraio prossimo Popolo e Cantoni dovranno decidere se ridurre, entro 10 anni, l’impatto ambientale della Svizzera per rispettare i limiti naturali della Terra. È quanto chiede l’iniziativa popolare dei Giovani Verdi «Per un’economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)», riuscita nel febbraio del 2023. Il progetto vuole ancorare nella Costituzione il rispetto dei «limiti del pianeta», superati i quali le risorse naturali della Terra, in determinati settori come il clima o la biodiversità, non sono più in grado di rigenerarsi. Esige che l’economia svizzera, comprese le sue importazioni, rientrino nei citati limiti naturali. Per raggiungere questo obiettivo, la proposta modifica costituzionale non indica tuttavia misure specifiche, quali prescrizioni, divieti e incentivi, ma affida questo arduo compito al legislatore.
L’iniziativa avrebbe troppe ed eccessive conseguenze economiche e sociali, sottolineano Governo e maggioranza parlamentare. Essi respingono dunque il progetto, tra l’altro perché la Costituzione già annovera disposizioni equilibrate per promuovere la sostenibilità. In una fase transitoria comporterebbe un notevole aumento degli oneri a carico di Confederazione e Cantoni. L’iniziativa per la responsabilità ambientale – secondo i promotori – chiede qualcosa che dovrebbe essere ovvio: conservare le basi della vita umana. Per lodevole che sia, questa richiesta appare ai contrari poco realistica, parecchio utopica. Comporterà prescrizioni e divieti che avranno ripercussioni sullo stile di vita della popolazione e che non saranno «socialmente sostenibili». La proposta non convince, tanto che – secondo i sondaggi – ha poche
possibilità d’essere accolta in votazione, visto anche lo scarso interesse che suscita. Stando al comitato d’iniziativa, i limiti naturali del pianeta sono punti di riferimento ecologici, definiti da scienziati ed esperti, che l’attività umana è chiamata a non superare per non correre il rischio di sbilanciare irreversibilmente la Terra e raggiungere punti di non ritorno. Se il testo in votazione dovesse essere accolto, la Svizzera sarebbe tenuta a ridurre gli impatti ambientali causati dal consumo nazionale. L’obbligo di diminuire drasticamente il consumo verrebbe applicato in sei settori: il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, il consumo d’acqua, l’utilizzazione del suolo, l’inquinamento atmosferico, nonché le immissioni di azoto e fosforo. Per raggiungere gli obiettivi dell’iniziativa – che rientra negli sforzi volti ad abbandonare le energie fossili come petrolio, gas naturale e carbone – le emissioni di gas serra tra 10 anni dovrebbero essere ridotte di oltre il 90%, la perdita di biodiversità dovrebbe diminuite di circa il 75% e l’immissione di azoto dovrebbe essere dimezzata. I fautori dell’iniziativa sottolineano che la nostra economia consuma molte più risorse di quelle che la natura riesce a rigenerare. Ricordano le catastrofi naturali estreme che si verificano con sempre più frequenza come inondazioni, siccità e scioglimento dei ghiacciai. Occorre dunque adottare provvedimenti. Per i sostenitori dell’iniziativa non si deve più dare la precedenza ai profitti a scapito dell’ambiente e della popolazione. Per questo motivo difendono un sistema economico che garantisca un’equa ripartizione delle risorse naturali e che dia la precedenza al principio secondo cui «chi inquina paga», poiché non spetta alla collettività assumere i costi dei danni ambientali. La sostenibilità dell’economia e della società deve diventare una priori-

tà collettiva. L’iniziativa è sostenuta a sinistra dai Verdi, dal Partito socialista e dalla Gioventù socialista. È appoggiata anche da organizzazioni ecologiste come Greenpeace, Uniterre (movimento sindacale contadino), l’Associazione dei piccoli contadini e le Anziane per il clima, nonché da 80 scienziati svizzeri e dal Partito evangelico. In Parlamento, i Verdi e il Ps erano i soli a difendere il progetto. Hanno inutilmente cercato di far passare un controprogetto diretto che riprendeva il resto dell’iniziativa ma che non conteneva alcun termine di attuazione.
Dato che è l’unico oggetto in votazione, per la campagna è stato annunciato l’investimento di 684 mila franchi. Per difendere il loro progetto, secondo il Controllo federale delle finanze, i sostenitori hanno preventivato 233’500 franchi, di cui 174’500 messi a disposizione dai Giovani Verdi, promotori dell’iniziativa. Greenpeace ha messo sul piatto 59’000
franchi. A nome dello schieramento opposto, il PLR ha comunicato che si è deciso di sborsare 450’000 franchi, di cui 290’000 messi a disposizione da economiesuisse, 100’000 dall’USAM e 50’000 dai proprietari immobiliari svizzero tedeschi. Ma qual è la posizione degli oppositori? Riconoscendo la necessità di preservare le risorse naturali del pianeta, Governo e Parlamento ricordano che da decenni la Confederazione dà grande importanza alla protezione dell’ambiente e intende proseguire su questa via. «Acqua pulita, aria fresca e un suolo fertile sono la base della vita» e stanno a cuore anche al Consiglio federale, ha sottolineato Albert Rösti, capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Datec). La sostenibilità del nostro Paese si basa su ecologia, economia e socialità. Orbene – ha aggiunto il ministro dell’ambiente – questi elementi hanno portato stabilità e prosperità
alla Svizzera. A suo modo di vedere, un «sì» all’iniziativa dei Giovani Verdi metterebbe in pericolo questo modello di successo: per giustificata che sia, la responsabilità ambientale avrebbe il sopravvento sull’economia e il benessere della popolazione. Inoltre l’iniziativa va troppo lontano: con il suo periodo di attuazione di 10 anni, troppo corto, provocherebbe costi considerevoli per tutti. Questo breve lasso di tempo –per Rösti – imporrebbe alla Svizzera di adottare provvedimenti rigorosi, che avrebbero conseguenze gravi per l’economia e la società. I prodotti e i servizi destinati al mercato elvetico sarebbero sottoposti a esigenze più severe rispetto a quelli destinati al mercato estero. Molte aziende dovrebbero adattare la loro produzione o abbandonare dei prodotti. Di conseguenza il mercato svizzero potrebbe diventare meno attraente, costringendo le aziende ad andarsene. Il consumo subirebbe restrizioni nei settori dell’alimentazione, dell’alloggio, dell’abbigliamento e della mobilità. In sostanza, gli oppositori temono un’esplosione dei prezzi e una diminuzione del tenore di vita. A farne le spese sarebbero soprattutto i ceti meno abbienti, proprio perché molti beni di consumo quotidiano diverrebbero più cari.
Secondo il consigliere federale Albert Rösti, sostenuto dalla netta maggioranza parlamentare, il costo dei provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’iniziativa dei Giovani Verdi sarebbe insopportabile. La Costituzione già annovera disposizioni per incoraggiare lo sviluppo sostenibile e cercare di conservare, nel limite del possibile, le basi naturali della vita, senza minare gli interessi della popolazione. È giusto che il campanello d’allarme degli iniziativisti risvegli le coscienze, ma non deve creare più problemi di quanti ne vuole risolvere.
La consulenza della Banca Migros ◆ I fondi sono un modo ideale per accedere al mondo degli investimenti, ecco perché
Sì, è una buona idea. I fondi sono particolarmente adatti per entrare nel mondo degli investimenti perché non richiedono conoscenze ed esperienze approfondite in fatto di gestione dei titoli. Inoltre di solito è possibile cominciare già con piccoli importi. I fondi sono come grandi contenitori in cui un gran numero di investitrici e investitori versa congiuntamente i propri soldi. Il denaro viene investito in diverse classi di asset, ad esempio in azioni, obbligazioni o immobili. Di conseguenza il rischio è ampiamente distribuito: se un titolo non ha un rendimento ottimale può essere compensato da altri titoli del fondo che hanno un andamento migliore. L’obiettivo di un fondo è combinare abilmente dei titoli in modo da generare un rendimento sul capitale investito.
Dei gestori esperti si occupano di amministrarlo. Sono loro a decidere su quali titoli investire, sulla base della strategia d’investimento del rispettivo fondo. Se ad esempio si tratta di un fondo azionario orientato alla crescita, la scelta cade in genere su azioni di società tecnologiche che si ritiene possano registrare in futuro una crescita del fatturato e degli utili superiore alla media.
La propensione al rischio influisce sul rendimento
Le opportunità di rendimento sono più o meno elevate a seconda del profilo di rischio del fondo in questione. Alcuni fondi azionari, ad esempio, investono in mercati volatili o in setto-

ri specializzati come la tecnologia o i mercati emergenti. Puntando su tali fondi azionari si possono ottenere rendimenti più elevati ma anche subire perdite maggiori. A differenza dei fondi azionari ad alto rischio, quelli obbligazionari presentano minori fluttuazioni del valore, a fronte però di rendimenti nettamente inferiori.
Quindi, per decidere il tipo di fondo più indicato occorre definire la capacità di rischio e la propensione al rischio individuali in relazione agli obiettivi d’investimento.
Importante: un fondo comporta anche fluttuazioni del patrimonio. Per compensare le perdite temporanee è quindi consigliabile investire il più possibile a lungo termine: minimo quattro anni, meglio ancora se dieci. Quanto più elevata è la quota aziona-
ria del fondo, tanto più lungo dovrebbe essere l’orizzonte d’investimento.
Consiglio
Con un piano di risparmio in fondi presso una banca può fare prelevare regolarmente un importo fisso dal suo conto e investirlo in un fondo. Questo la aiuta a creare una routine di risparmio. Richiedi una videoconsulenza gratuita Pubblicità di un servizio finanziario ai sensi della LSerFi.
Spunti di storia ◆ Dalla guerra arabo-israeliana (1948) al tragico 7 ottobre 2023, con il terribile conflitto a Gaza (e non solo)
Alfredo Venturi
Una tregua ha sospeso (o quasi, vedi operazione «Muro di ferro» di Israele in Cisgiordania) le ostilità nella Striscia di Gaza, e una volta ancora il conflitto fra Israele e Palestina è affidato a un problematico processo di pace. Si vedrà fra alcune settimane, al termine della prima fase dell’intesa, se la novità nasconde dentro di sé il prezioso tesoro della pace. Purtroppo la storia del Medio Oriente ci costringe al pessimismo: come mettere d’accordo due controparti separate da un pregiudizio così radicale? Ci sono di mezzo due visioni opposte. Secondo quanto ci racconta la politologia, gli elementi costitutivi di uno Stato sono un territorio, un popolo e un sistema legislativo. Ma che fare quando sullo stesso territorio sgomitano due popoli, ognuno dei quali desideroso di localizzarvi la propria legge?
Nel 1993 Arafat riconobbe – con una comunicazione ufficiale al primo ministro Rabin – lo Stato d’Israele e il suo diritto all’esistenza
È proprio questo il caso di quella tormentata parte del mondo nella quale convivono due gruppi che le vicende della storia hanno reso nemici. Sono contrapposti per etnia, religione e cittadinanza: da una parte ebrei che sono insieme israeliti e israeliani, dall’altra arabi che si riconoscono nella tradizione musulmana e nell’identità palestinese. La loro coesistenza così difficile da rasentare l’impossibilità ha provocato quattro guerre e un diabolico intreccio di sanguinoso terrorismo e spietata repressione, ha reso il Medio Oriente l’area più infiammabile del pianeta e da sempre tiene il mondo col fiato sospeso.
Eppure la diplomazia si è sempre affaccendata attorno a quella che viene definita «questione palestinese». È impossibile dimenticare quel settembre 1993, quella stretta di mano fra il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, il presidente dell’OLP che aveva proclamato l’indipendenza della Palestina, davanti a un raggiante Bill Clinton, il presidente americano che aveva scommesso sulla pace. Le controparti avevano appena firmato gli accordi negoziati segretamente a Oslo, e la grande disputa mediorientale sembrava finalmente archiviata. Ma l’illusione durò poco, giusto il tempo necessario agli intransigenti per affilare le armi e riprendere la lotta. Rabin uscirà da questa vicenda con il premio Nobel per la pace e con una condanna a morte da parte della destra sionista: pagherà infatti con la vita, vittima di un nazionalista israeliano, la sua volontà di districare finalmente il nodo palestinese.
Non era la prima volta che davanti alla Casa Bianca di Washington statisti ebrei e arabi celebravano significativi progressi nel secolare dissidio che per interminabili decenni ha insanguinato il Medio Oriente. Quattordici anni e mezzo prima degli accordi di Oslo, precisamente nel marzo 1979, un altro primo ministro d’Israele, Menachem Begin, e il presidente egiziano Anwar al-Sadat si scambiarono una storica stretta di mano in quel luogo simbolico davanti al presidente degli Stati Uniti, all’epoca Jimmy Carter. Sadat e Begin avevano firmato quello che per decenni era parso impossibile, un trattato di pace fra Israele e la massima potenza

militare del mondo arabo. Le due delegazioni lo avevano negoziato in rigoroso segreto nella quiete protetta di Camp David. Per effetto di quel trattato l’Egitto recuperò il Sinai, che gli israeliani avevano occupato nell’ottobre del 1973 durante la guerra dello Yom Kippur.
La pace di Camp David pose fine al coinvolgimento diretto degli Stati arabi nella lotta contro Israele.
Quattro guerre erano state combattute, con un bilancio impressionante di lutti e devastazioni. La prima era esplosa nel 1948, subito dopo la proclamazione dello Stato d’Israele da parte di David Ben Gurion sulla base di una risoluzione delle Nazioni Unite che spartiva la Palestina in due Stati e prevedeva per Gerusalemme uno statuto speciale. Accetta-
ta dagli ebrei, questa sistemazione fu respinta dal mondo arabo nel suo insieme. Contrari alla spartizione della Palestina alcuni Stati, l’Egitto, la Siria, la Transgiordania, l’Iraq e il Libano, invasero in armi la nuova creatura politica.
Negli anni Settanta e Ottanta del Novecento si estese il ricorso al terrorismo da parte di militanti palestinesi
Il neonato Israele resse l’urto e le sue forze armate penetrarono a loro volta nei Paesi nemici. L’anno dopo i trattati di pace assegnarono allo Stato ebraico più territorio di quanto fosse previsto dalla risoluzione Onu. In
particolare gli concessero la preda più ambita, Gerusalemme ovest.
A dare un drammatico contenuto demografico alla nascente questione palestinese alcune centinaia di migliaia di profughi arabi si rifugiarono negli Stati confinanti, in pratica destabilizzandoli al punto da provocare reazioni violente come il «Settembre nero» in Giordania, che a sua volta destabilizzò il Libano dove i profughi in fuga da Amman avevano cercato scampo. Il conflitto Israele-Palestina coinvolse così la «Svizzera del Medio Oriente», come il Libano era stato chiamato fino a quel momento per la sua florida pace sociale e la pacifica coesistenza interreligiosa. Non a caso si affacciava in quegli anni alla ribalta delle cronache una carismatica figura di uomo di guerra, il generale israelia-

Il generale
no Moshe Dayan, che avrà un ruolo centrale nei conflitti seguenti. Negli anni Settanta e Ottanta del Novecento si estese il ricorso al terrorismo da parte di militanti palestinesi divisi fra numerose organizzazioni. Nello Stato ebraico gli arabi erano ormai rimasti in netta minoranza.
La seconda guerra è quella del 1956, quando la Gran Bretagna e la Francia cercarono di contrastare la nazionalizzazione del Canale di Suez voluta dal presidente egiziano Gamal Nasser. Alleate degli anglo-francesi, le truppe israeliane attraversarono il Sinai fino al Canale, ma poi l’intervento di Washington e Mosca, per una volta uniti nel segno della pace, riuscì a bloccare il conflitto. Sarà la terza guerra, chiamata dei sei giorni e combattuta nel giugno del 1967, ad apportare alla regione i più significativi mutamenti e a proiettare la questione palestinese sul gradino più alto dei contenziosi internazionali. Al termine di quel conflitto scaturito da un blocco navale egiziano, l’esercito d’Israele guidato da Dayan occupò anche Gerusalmme est, la Cisgiordania, la Striscia di Gaza, il Golan e il Sinai. Solo quest’ultimo territorio sarà restituito con l’intesa di Camp David.
A questo punto Arafat, al timone dell’OLP che aveva riunito buona parte del fronte palestinese, si rese conto che bisognava sparigliare le carte: incurante delle molte opposizioni interne riconobbe lo Stato d’Israele e il suo diritto all’esistenza. Lo fece nel 1993 con una comunicazione ufficiale al primo ministro Rabin, sulla base degli accordi nel frattempo raggiunti a Oslo. Il trattato che ne conseguì fu al centro dell’intesa siglata davanti al presidente Clinton. Purtroppo l’illusione durò poco, il conflitto riprese vigore con la resistenza degli oltranzisti israeliani che portò alla morte di Rabin e i ripetuti episodi di terrorismo brutalmente repressi. Fino al tragico ottobre del 2023, con il massiccio assalto di Hamas e la successiva reazione israeliana nella Striscia di Gaza, che non pochi osservatori definiscono un genocidio.
Einav Zangauker, mamma dell’ostaggio Matan, denominata «la leonessa». (Keystone)

Medio Oriente ◆ Cosa succede tra israeliani
Sarah Parenzo
È trascorsa solo una settimana dall’entrata in vigore della fragile tregua tra Israele e Hamas e dagli scambi iniziali di ostaggi e prigionieri, e le incognite non fanno che aumentare minando la possibilità che la seconda parte dell’accordo possa venire rispettata secondo i termini previsti. Il premier Benjamin Netanyahu subisce le pressioni dei partiti sionisti religiosi che minacciano di dimettersi se la guerra a Gaza non verrà ripresa a breve, mentre festeggiano le dimissioni rassegnate dal capo di Stato maggiore, il generale Herzi Halevi, da loro considerato troppo morbido e responsabile di non aver annientato Hamas. Quest’ultimo, del resto, ha colto l’occasione del rilascio di Emily Damari, Doron Steinbrecher e Romi Gonen, il 19 gennaio, per offrire al mondo uno spettacolo mediatico di forza dal messaggio inequivocabile. Le tre giovani sono infatti salite sul mezzo della Croce Rossa che le attendeva, circondate da decine di miliziani armati con il volto coperto e, per quanto la speranza è che si tratti di propaganda, il tempo sembrava essersi fermato il 7 ottobre e il timore che i prigionieri rilasciati dalle carceri israeliane vadano a ingrossare le fila dell’organizzazione ha sfiorato la mente di tutti.
Del resto si tratta di un paradosso, dal momento che il Governo israeliano continua a rinforzare Hamas riconfermandolo come unico interlocutore e ignorando l’Autorità nazionale palestinese nonché la possibilità di altre reggenze nella Striscia di Gaza. Prosegue anche l’implementazione della riforma che mira di indebolire il potere giudiziario e persino l’ordine degli avvocati, mentre la tensione in Cisgiordania è alle stelle a causa della nuova operazione «Muro di ferro» condotta dalle Forze di difesa israeliane e della liberazione dei coloni in detenzione amministrativa, che possono così tornare indisturbati a «pogromizzare» i palestinesi della regione. Gli attentati palestinesi si moltiplicano, soprattutto a Tel Aviv, e affinché la tregua e l’accordo rimangano in vigore come stabilito, alle famiglie degli ostaggi ancora prigionieri a Gaza non resta che riporre le speranze nell’imprevedibile Donald Trump e nella sua influenza su Netanyahu e Hamas. Risulta difficile, infatti, attribuire la liberazione dei primi ostaggi all’imponente movimento di protesta dei civili israeliani che prosegue ormai da due anni, o alla pressione miliare
L’analisi ◆ L’Ue riuscirà ad affrancarsi dagli Usa?
Lucio Caracciolo
C’era una volta l’Europa franco-tedesca. Centrata sul compromesso geopolitico fra le due storiche potenze continentali, variamente diminuite dalla guerra civile europea scandita nei due atti mondiali (1914-18 e 193945). Perno asimmetrico. La Francia, pur umiliata dalla Germania nel 1940, si era agganciata in extremis al carro del vincitore americano. Dotata di un impero coloniale, della bomba atomica e del senso della gloria. La Germania federale, ovvero occidentale, residuo del Reich, di fatto semiprotettorato americano compartecipato da britannici e statunitensi, era presto risalita al vertice economico europeo.
esercitata dall’esercito. Mentre è verosimile che l’insediamento del nuovo presidente Usa costituisca un incentivo o forse un imperativo che non lascia altra scelta, anche nell’ottica dei cambiamenti in atto nella regione e delle aspirazioni intorno al consolidamento degli Accordi di Abramo.
Nel frattempo i media israeliani main stream, concentrati sulle famiglie degli ostaggi liberati e su quelle in attesa, cercano maldestramente di restituire dignità al contratto sociale nel tentativo di ripristinare l’etica violata. Tra gli eroi di questa attesa estenuante emerge l’attivista Einav Zangauker, mamma dell’ostaggio Matan, denominata «la leonessa» e inserita dalla «BBC» tra le 100 donne più influenti del 2024.
L’Europa potrebbe condannare le politiche di Israele quando serve e assumersi la responsabilità dell’antisemitismo e dell’islamofobia che la infestano
Anche negli ultimi giorni Zangauker non ha esitato ad accusare il premier Netanyahu di agire ricattato da fantasie messianiche sulla colonizzazione di Gaza, chiedendo l’appoggio della popolazione civile affinché continui a manifestare al suo fianco fino alla fine: «Da qui in poi la lotta si intensificherà, perché finché il primo ministro che ha affossato e sventato gli accordi continuerà a minacciare di tornare a combattere e a non porre fine alla guerra, nessuno garantisce che tutti gli ostaggi rimasti indietro torneranno». Ma se il riscatto degli ostaggi, quale che sia il prezzo da pagare, è il primo passo per restaurare l’umanità perduta, la strada per il riconoscimento del dolore altrui in Israele sembra ancora lunga e la popolazione continua a confrontarsi anche con una crisi interna che contrappone le fazioni ebraiche esasperando insofferenze e rancori. In questo baratro le accuse di genocidio che provengono dall’estero e i tentativi degli storici, anche di quelli israeliani come Amos Golberg, di definire gli eventi in corso secondo categorie note in letteratura, sembrano cadere nel vuoto del caos e della tensione in cui versa lo Stato ebraico. Da qui anche il crescente imbarazzo con il quale ci si accosterà alla Giornata della memoria oggi, 27 genna-
io, le cui commemorazioni stridono di fronte alle cifre imbarazzanti dei morti di Gaza senza nome, ma anche di fronte all’antisemitismo di ritorno che, seppure troppo spesso confuso con la legittima critica nei confronti del Governo israeliano, è tornato in voga. Sensi di colpa e confusione regnano sovrani e così le dicotomie superficiali che persistono nel vedere Israele come baluardo in Medioriente contrapposto al fondamentalismo islamico che minaccia il mondo occidentale.
L’Europa potrebbe intervenire condannando le politiche di Israele quando serve, nonché assumendosi la responsabilità dell’antisemitismo e dell’islamofobia che la infestano. Potrebbe proporre agli studenti nuovi approcci di didattica della Shoah che tengano conto anche dei traumi altrui pur nel rispetto delle ovvie asimmetrie. Invece la menzione della Shoah accostata ad altri eventi traumatici come la Nakba palestinese continua a suscitare disagio anche a causa della feroce opposizione e del profondo risentimento manifestati da parte di ebrei e israeliani. Eppure l’interconnessione storica degli eventi è innegabile, come ricorda lo storico Alon Confino che, nel capitolo VI del volume Olocausto e Nakba. Narrazioni tra storia e trauma, curato dai ricercatori palestinese e israeliano Bashir e Golberg, presenta la storia di Genya e Henryk Kowalski. Sopravvissuti all’Olocausto, i coniugi Kowalski arrivarono in Palestina dove nel 1949 ricevettero dall’Agenzia ebraica la chiave di un appartamento a Giaffa la cui popolazione araba era per la maggior parte fuggita o era stata cacciata fuori durante la guerra del 1948. I Kowalski arrivarono all’appartamento ma, come raccontò Genya decenni dopo in una video installazione, «non entrammo nemmeno in casa perché nel cortile c’era una tavola rotonda imbandita di piatti, e non appena abbiamo visto questo (…) ci siamo spaventati. Ci ha ricordato come dovevamo lasciare la casa e tutto alle spalle quando sono arrivati i tedeschi e ci hanno buttato nel ghetto. (…) Non volevo fare la stessa cosa che hanno fatto i tedeschi. Abbiamo lasciato e restituito la chiave». Una reazione tanto rara, quanto umana nella sua naturalezza. Arendt ha parlato della banalità del male, ma in questo momento storico dobbiamo piuttosto appellarci a quella del bene e sperare che nonostante tutto abbia presto la meglio.
vid) su cui i membri dell’Ue abbiano parlato con una sola voce, per il semplice motivo che ne hanno 27. È dunque abbastanza interessante osservare come gli Stati europei stiano reagendo in ordine sparso all’avvento di Trump, il presidente americano meno interessato al Vecchio Continente che si conosca. Sintomo di sconcerto e di angoscia, cui Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha cercato di opporsi avvertendo: «Il mondo sta cambiando. Noi siamo pronti». A ben guardare, non è così.
L’asse Parigi-Berlino era figlio di due progetti. Il principale, l’americano. Fondato sulla scelta di rimanere in Europa occidentale per impedire che cadesse in mani sovietiche ed esportasse il morbo comunista Oltreatlantico. Di qui Piano Marshall (1947) e Nato (1949). Il secondario, coltivato dai fondatori delle Comunità europee, progenitori dell’Unione europea attuale: De Gasperi, Schuman, Monnet, Adenauer, Spaak, il fior fiore del centrismo cristiano nel Vecchio Continente. Sotto forma europeista nasceva e si consolidava così in Europa occidentale, poi nel resto d’Europa dopo il crollo dell’Urss, l’impero europeo dell’America. Oggi espresso nella convergenza territoriale fra Nato e Ue, il cui ambito societario e territoriale è quasi identico.
Uno strano animale
Che cosa ne resta, che cosa ne deriverà domani dopo la «cura Trump» che si annuncia radicale? Davvero l’Europa, come ha ammonito Zelensky a Davos il 21 gennaio, rischia di essere cancellata dalla storia? Se per Europa intendiamo l’Ue – in Svizzera la distinzione fra i due nomi è marcata, negli altri Paesi europei si usano i due termini quasi indistintamente –la risposta è scontata: no. No perché l’Ue è già fuori dalla storia, anche per sua scelta.
Se per soggetto storico s’intende un attore della scena internazionale, dunque uno Stato, l’Unione europea non lo è, non lo è mai stata e nemmeno ambisce a diventarlo. È uno strano animale, una peculiare organizzazione internazionale i cui 27 soci hanno accettato di cedere parte della loro sovranità in cambio di variabili forme di integrazione, tra cui la monetaria (per 20 di essi), ma non la militare né la fiscale. Su altri dossier decisivi, come le politiche migratorie, le differenze non potrebbero essere più marcate. Soprattutto, non si conosce crisi geopolitica, economica o sanitaria (Co-
L’approccio trumpiano è basato sulle sfere d’influenza. Per Washington l’Ue è la sua zona d’influenza europea in quanto braccio economico dell’alleanza militare, la Nato. Nel primo caso gli Stati Uniti si riservano un diritto di vigilanza, spesso imbastendo dure battaglie commerciali con la Commissione. La quale, presa dalla mania regolatrice, interviene per normare processi e dinamiche economiche commerciali in cui ormai gli europei sono retroguardia: dall’intelligenza artificiale (AI) ai social, dalle politiche ambientali allo strapotere di alcuni trust. Nel frattempo, il divario con Usa e Cina sulle dimensioni strategiche si è fatto incolmabile. Nello Spazio come nell’AI gli europei contano poco o nulla. Per esempio: non c’è concorrente europeo per Starlink, la rete satellitare di Musk, a meno di non considerare tale il progetto Iris, che dovrebbe mettere in orbita neanche 300 satelliti entro il 2035 quando SpaceX ne ha già lanciati quasi 7mila. Se poi osserviamo il campo AI, il quadro peggiora: su 100 brevetti, 62 sono americani, 21 cinesi, 2 europei. Ma la spaccatura geopolitica è ancora più netta, accentuata dalla guerra in Ucraina. Qui si è formato un asse fra Regno Unito, Polonia, Paesi baltici e scandinavi, per i quali non si tratta di salvare l’Ucraina e nemmeno di battere la Russia, ma di distruggere ciò che resta dell’impero di Mosca. Gli altri Paesi, Francia, Germania e Italia incluse, già studiano come riallacciare i rapporti con il Cremlino, specie in campo energetico. Con Trump tutti i giochi sembrerebbero riaprirsi. In teoria. La sua America è concentrata sulla Cina e vuole chiudere i contenziosi europei e mediorientali il prima possibile per concentrarsi sulla competizione con il grande rivale. Questo apre due scenari per gli europei. Il primo, coalizzarsi per formare un nucleo di potere alleato degli americani ma capace di agire per i propri interessi. Il secondo, continuare a parlare del primo scenario senza muovere un dito per concretizzarlo. Indovinate come finirà?

Gli economisti hanno cominciato a farsi conoscere in Ticino a partire dalla fine degli anni Cinquanta dello scorso secolo. Ma pochi sapevano e sanno che cosa sono in grado di fare. A gettare un po’ di luce sulla loro attività è arrivata la bibliografia che Coscienza svizzera ha pubblicato per rendere omaggio a Remigio Ratti, suo presidente onorario, in occasione dell’ottantesimo compleanno. Per il periodo 1969-2024 essa elenca più di 350 pubblicazioni, tra libri, articoli in riviste di vario tipo, interventi a congressi e seminari e altri testi. Accanto a questo lungo elenco, l’attività e la figura di Ratti vengono presentate da persone che gli sono state vicine nel corso della sua carriera. Ratti è stato, dall’inizio degli anni Settanta fino alla fine dello scorso secolo, direttore dell’Ufficio delle ricerche economiche nel Dipartimento dell’economia pubblica del Cantone (in seguito Istituto dell’USI). Successivamente ha
diretto, fino al pensionamento, la Radio televisione della Svizzera italiana. Parallelamente ha svolto attività di insegnamento anche nelle università di Friburgo e Lugano nonché al Politecnico di Losanna. Per una legislatura è stato inoltre consigliere nazionale e ha assunto la presidenza di diverse associazioni e organizzazioni a livello cantonale e nazionale.
Nella sua vita, nella sua carriera non ha quindi impersonato la figura dell’intellettuale chiuso in una torre di avorio. Lo provano anche i temi che figurano nella bibliografia appena pubblicata. Il primo, quello che lo tenne occupato nel periodo del dottorato e della tesi di abilitazione, è la ferrovia, anzi, per essere più precisi, la ferrovia del San Gottardo. Ancora oggi possiamo affermare che Ratti è l’economista ticinese con maggiori conoscenze in materia di problemi ferroviari e dei trasporti. Diventato direttore dell’Istituto delle ricerche economi-
che, si ritrovò a gestire i dossier della politica economica del Cantone. In quel momento al centro dell’attenzione era soprattutto l’aiuto alle regioni di montagna, istituito dalla LIM, la legge federale il cui obiettivo era quello di promuovere gli investimenti in queste regioni. Nello stesso decennio si stava però anche terminando di realizzare l’autostrada del San Gottardo, con il tunnel che avrebbe consentito alle automobili e agli autocarri di accedere al Ticino anche durante l’inverno. Ratti analizzò e commentò questi temi in più di una pubblicazione per metterne in evidenza l’importanza e anche per sollecitare la realizzazione delle opere previste. A partire dagli anni Ottanta egli si propose di ampliare l’attività dell’istituto che dirigeva. Cominciò così a partecipare, coi suoi collaboratori, ai programmi di ricerca nazionale con un contributo sul frontalierato che fece conoscere la piccola unità di ricerca ticinese
Il discorso di insediamento di Donald Trump assomigliava molto ai suoi comizi elettorali. Non un programma, ma una serie di slogan: «Farò finire le guerre ed eviterò la terza guerra mondiale». Come, non si sa. Senza progetto: «Trump will fix it», lui risolverà tutto. Il trumpismo è messianesimo e improvvisazione: «Tornerà l’età dell’oro americana». Gli unici presidenti che cita e considera sono George Washington, Ronald Reagan e Abraham Lincoln. Soprattutto Lincoln, perché anche a lui hanno sparato; la differenza è che Dio, distratto al momento dell’attentato a Lincoln, a Trump ha salvato la vita. A questo punto il copione prevede che il presidente ruoti la testa mostrando alla platea l’orecchio sinistro, ferito nell’attentato in Michigan: «Vedete? Potrei essere in una delle mie stupende case sulla spiaggia, con la mia bellissima moglie; invece sono qui, a rischiare la vita, a combat-
tere, per voi». In campagna elettorale ho visto Trump chiamare sul palco di Salem, Virginia, le nuotatrici della squadra locale – «siete bellissime, ma oggi a dirlo ci si rovina la carriera politica» – che si battono per non gareggiare contro le transgender, più forti. Lui, The Donald, prometteva che libererà la scuola da queste ultime. Belle ragazze, capelli lunghi, giovani. I genitori scattavano foto con il telefonino. Tutte indossavano una maglietta rosa con la scritta «no transgender». Ma a Salem quante nuotatrici transgender ci saranno? Probabilmente nessuna. Ammettiamo che siano una o due. Perché queste ragazze sentono il bisogno di lanciare un allarme così accorato? Per salire sul palco con Trump e farsi fotografare dai genitori? Più in generale: perché, se una persona transita da un sesso all’altro, oppure se due omosessuali si sposano e adottano un bambino, una persona
Attraverso gli otto episodi finora proposti dalla RSI sotto il titolo Edizione straordinaria: quando la cronaca diventa storia, gli ideatori del programma, Lorenzo Mammone e Lorenzo Buccella, hanno presentato un’immagine del Ticino recente che merita una riflessione. Sulle prime ha prevalso lo stupore per eventi che il tempo si era incaricato di cancellare dalla memoria. Fatti di sangue, pluriomicidi, tentativi di evasione dal carcere finiti in tragedia, traffici loschi e giudici corrotti, trafugamento di materiale bellico dai depositi dell’esercito per armare le Brigate rosse, i profitti legati alla coltivazione della canapa… Frammenti di una storia criminale che gettava sul Cantone una luce livida, da provincia sudamericana. Era proprio così il Ticino di quegli anni, un’appendice mafiosa, una zona franca in cui prosperavano operazioni illega-
li e un’estesa «economia grigia» in cui mettere a frutto i capitali in fuga dal fisco italiano?
Certamente allineare in rapida successione tutto questo sottobosco poteva ingenerare nei telespettatori l’idea che il Paese si fosse incamminato sulla via della perdizione, con ripercussioni che intaccavano la sua onorabilità anche sul piano dell’etica pubblica. In realtà tutto questo avvenne sull’arco di un trentennio, dagli anni Settanta del Novecento al principio del nuovo secolo. Era la fase in cui il Cantone si stava riprendendo dopo la crisi petrolifera che aveva investito tutto l’Occidente produttivo nel 1974, cercando di cavalcare il ciclo della ripresa dei successivi anni Ottanta. Nel 1985 apparve un libro che proponeva una prima radiografia di questa faticosa rinascita: Un paese che cambia, raccolta di saggi curata dall’economista Basilio M. Biuc-
di Angelo Rossi

nel mondo della ricerca applicata della Svizzera. E da qui allo studio degli effetti economici della frontiera e dei problemi di una regione aperta – che sono forse i temi di ricerca in cui Ratti si è maggiormente profilato, anche a livello internazionale – il passo è breve. Accanto a questi temi, l’attualità di quel periodo lo portò a esaminare anche gli aspetti dello sviluppo di medio e lungo termine, come la pianificazione delle attività dello Stato o la formulazione di scenari per lo sviluppo futuro del Ticino, della Svizzera e addirittura dell’Arco Alpino.
A cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta Ratti fu poi attivo nei gruppi di lavoro che dovevano, percorrendo un cammino non facile, sfociare nelle proposte di creazione dell’Università della Svizzera italiana, a metà anni Novanta. Questa sua attività trovò naturalmente riscontro anche nelle sue pubblicazioni di quel periodo. Sempre in questo decennio
spuntano però anche due nuovi temi: l’Europa, che allora era un tema importante della discussione politica, e le nuove tecnologie dalle quali, in quel periodo di forte recessione, si sperava potesse venire lo sprone per una più che necessaria ripartenza economica. Passato col nuovo secolo a dirigere radio e televisione, è normale che Ratti si interessasse allo sviluppo di questi media e ai loro problemi. Ma negli anni Duemila egli si occupò anche di globalizzazione e dei suoi effetti a livello locale. Particolarmente a cuore gli stava il ruolo della lingua come segno distintivo dell’identità. Come si può costatare, il ventaglio dei temi ricercati e commentati nella sua bibliografia è molto largo. Bibliografie come la sua rappresentano una validissima testimonianza di quanto fruttuosa possa essere l’attività di un economista al servizio del suo Paese. Resta da sperare che non siano consultate solo dagli addetti ai lavori.

non transgender e non gay dovrebbe sentirsi coinvolta e offesa? Qualcuno dice: gli elettori, in particolare i poveri, si offendono perché la politica non si occupa di loro, ma degli «altri». In effetti la politica dovrebbe occuparsi di più dei poveri. Ma la politica per definizione si occupa di tutti; pure degli «altri». Perché il riconoscimento di un diritto altrui dovrebbe limitare il mio? Ma Trump nel discorso di insediamento l’ha ripetuto: «Nella mia America ci saranno solo due sessi, maschio e femmina». La vescova di Washington che gli ha chiesto misericordia, per tanti bambini spaventati, è stata guardata con odio da Trump e dalla sua famiglia. Eppure le persone ermafrodite e transgender esistono da sempre, e sempre esisteranno. Ma la cosa più preoccupante è che Trump rifiuta qualsiasi forma di cooperazione internazionale. Ha ritirato gli Usa dall’Organizzazione mondiale del-
la sanità e dagli accordi di Parigi per la lotta al cambio climatico. Ha vanificato la tassa minima del 15% sulle multinazionali della rivoluzione digitale, che mandano sul lastrico i piccoli commercianti e gli editori tradizionali e non pagano le tasse agli Stati che Trump considera vassalli. Una situazione gravissima, che i suoi sostenitori considerano normale. Il capovolgimento, rispetto a quando i repubblicani erano il partito dell’establishment e i democratici erano i populisti, è totale. Lontano anche il tempo in cui i repubblicani pensavano di tornare alla Casa Bianca con centristi come Mitt Romney oppure outsider come John McCain. La svolta radicale era cominciata già con il Tea Party, la rivolta contro il Governo e le tasse, cui però mancava un leader. Quel leader è Trump. I pazzi che aveva mandato contro il Campidoglio per tentare di rovesciare il ver-
detto delle urne del 2020 sono stati graziati, quindi di fatto incoraggiati a riprovarci, se le prossime elezioni dovessero andar male. Tuttavia non credo che la svolta verso l’estrema destra sia una tendenza irreversibile o molto duratura, come quella degli anni 80. Nel 1984 Ronald Reagan vinse tutti gli Stati tranne il Distretto di Columbia e il Minnesota. All’epoca i repubblicani vinsero tre presidenziali di fila. Certo, Trump è Trump, e ha vinto di nuovo restando sé stesso. Mi permetto però di instillare un dubbio in tutto questo trionfalismo a destra. Siamo sicuri che Trump porrà fine alle guerre? E in che modo? Siamo certi che «togliere la paghetta a Zelensky» sia il modo migliore di mettere pressione a Putin? Ora che sta vincendo, perché lo zar dovrebbe accontentarsi del Donbass anziché centrare il suo obiettivo iniziale, piazzare un suo uomo a Kiev?

chi (Dadò editore). L’opera metteva in luce gli innegabili progressi compiuti nel secondo dopoguerra, il balzo demografico, l’espansione del settore terziario, i benefici della riforma scolastica (scuola media). Ma nel contempo faceva emergere anche i risvolti negativi, le storture, le tare di una crescita disordinata che era sfuggita di mano, come il controllo delle risorse idriche, il saccheggio speculativo del territorio, la dipendenza da centrali di potere situate altrove, soprattutto nell’area zurighese.
La questione riguardava anche la mentalità o, come si diceva una volta, l’«indole» degli abitanti. Buona parte di questi si era infatti convinta che per arricchirsi conveniva infilarsi nelle nicchie che la legislazione lasciava aperte, su entrambi i lati della frontiera. Gli affari più redditizi provenivano dal riciclaggio di capitali, un
fiume di denaro che poi tracimava in altri alvei dell’economia grigia, come la prostituzione, i bordelli, i cinema a luci rosse, la vendita e il consumo di droga. Un mercato in cui la criminalità organizzata aveva piazzato le sue pedine, in modo discreto, dietro il paravento di società rispettabili e di esercizi commerciali.
Per completare il quadro bisognerebbe poi considerare le relazioni con la politica, i partiti, le associazioni di categoria che chiusero gli occhi o assecondarono questa deriva. È un intreccio che rimane da indagare. Pensiamo all’euforia per il gioco d’azzardo e per l’intenzione di trasformare il Ticino in un unico grande casinò, con palazzi luccicanti distribuiti in tutti i principali centri; oppure agli interessi legati allo smaltimento dei rifiuti, che si tradusse in contenziosi infiniti e con progetti che si rivelarono equivoci e alla
fine fallimentari (caso Thermoselect). In tutto questo svolse un ruolo di primo piano la Lega dei ticinesi, movimento e poi partito che prometteva di fare piazza pulita: combattere la «banditocrazia», limitare lo strapotere delle «grandi famiglie e i loro vassalli», consegnare agli archivi «il regime dei landfogti» (primo editoriale del «Mattino della Domenica», 11 novembre 1990). Terra di mezzo tra la «Greater Zurich Area» e la metropoli milanese, il Ticino sa che la sua posizione strategica è all’origine di opportunità come pure di rischi; è fonte di iniziative imprenditoriali sane e di tecnologie innovative come pure di operazioni speculative opache. Troppo spesso l’economia della rendita ha avuto la meglio sulla cultura d’impresa fondata sulla produzione di beni e servizi reali. Ora è il turno delle criptovalute, chissà in quale regno benedetto dagli dèi ci condurranno.
50 anni di Buchmann
Dopo mezzo secolo dedicato all’arte, Elena Buchmann cessa l’attività di gallerista: la storia di un percorso di belle scoperte
Pagina 19
Il racconto di Borsellino in graphic novel Vita (e morte) del magistrato siciliano, narrate con intensità visiva e profondità emotiva, in un volume di Marco Sonseri e Gian Luca Doretto
Pagina 21
Un debutto autobiografico
Alla 60esima edizione delle Giornate di Soletta, Filippo Demarchi esplora il burnout con un documentario autentico e privo di enfasi
Pagina 23

Mostre ◆ Collettiva ’74, un appuntamento di Art Brut organizzato dal Club ’74 e visitabile fino al 20 febbraio presso il Campus SUPSI e LaFilanda di Mendrisio
Daniele Bernardi
Il termine Art Brut appare per la prima volta nel giugno del 1945, quando Jean Dubuffet, durante un viaggio in Svizzera in compagnia di Jean Paulhan, sostiene di essere alla ricerca di «un’arte immediata, senza fronzoli –di un’arte grezza». Guidato da questa spinta, il pittore francese inizia quindi a raccogliere opere la cui principale caratteristica è quella di non aver nulla a che spartire con ciò che, in quel preciso momento storico, è possibile vedere in un museo. Ciò che gli preme è che le creazioni delle quali è a caccia «si appellino all’essenza umana originale e all’invenzione personale e spontanea» piuttosto che al talento e al virtuosismo.
Nel corso della sua indagine, Dubuffet si interessa presto a figure di artisti che non si dichiarano tali, che operano nell’ombra e nell’anonimato per propria pura necessità, incuranti dello sguardo altrui, sprovvisti di formazione così come di qualsivoglia inquadramento accademico. Sovente si tratta di carcerati, solitari, pazienti psichiatrici, medium ed emarginati, ma pure di uomini e donne assoluta-
mente comuni. Ciò che segue è oggi noto, e appartiene ormai da tempo alla Storia dell’arte del Novecento: la collezione di Dubuffet man mano va ampliandosi e il concetto di Art Brut dà nome a un fenomeno preesistente, che trova qui una sorta di legittimità. Con l’inizio degli anni Settanta, grazie alla mediazione di Michel Thévoz, l’insieme delle opere viene donato alla città di Losanna, dove oggi ha ancora sede sotto il celebre nome di Collection de l’Art Brut.
Ciò detto, l’idea di Art Brut ha avuto e ha una forte importanza e a questa, nel tempo, sono state affiancate altre definizioni, che ne mostrano le intrinseche sfaccettature e diramazioni, come, ad esempio, la Neuve Invention (collezione facente parte del sopraccitato museo). Non è dunque un caso che, per celebrare i suoi 50 anni di attività, anche il Club ’74 di Casvegno, l’associazione culturale che opera all’interno dell’Ospedale Sociopsichiatrico Cantonale attraverso le attività della socioterapia, abbia scelto di valorizzare pubblicamente il proprio prezioso patrimonio artisti-
co con una mostra presso il Campus SUPSI e LaFilanda di Mendrisio. Certo, l’operazione era rischiosa, poiché l’abusata equazione «Art Brut = arte dei folli» non solo è riduttiva, ma oltremodo scorretta: come già esposto, questo non è mai stato né il parametro di Dubuffet né di chi ha portato (e porta) avanti il suo progetto. Ciò che conta, in un’iniziativa del genere, è in primo luogo questa consapevolezza. Secondariamente, e di conseguenza mi viene da dire, determinanti sono i parametri di selezione delle opere, che non possono essere di matrice prettamente sociale: si cadrebbe in un approccio «pietista», di ostentazione di buoni propositi, poco utile e non artistico. La Collettiva ’74, questo il titolo dell’esposizione visitabile fino al 20 febbraio, schiva entrambi i pericoli grazie alla sobria curatela dello storico dell’arte Ivano Proserpi che, assieme a un gruppo di lavoro composto da grafici, studenti (CSIA), fotografi, architetti e operatori sociali ha dato forma all’evento. Infatti, le 90 opere esposte – forse con qualche rarissima eccezione – ri-
spettano i criteri di valutazione per essere definite Art Brut. Si tratta di creazioni pittoriche e plastiche in cui, a dispetto di una standardizzata e condivisa concezione del talento e dell’abilità, c’è un’ostinazione che fa segno. Nell’ammirare le molte composizioni oniriche, in cui si palesa un personale ordine simbolico, il visitatore percepisce un preciso bersaglio ripetutamente colpito per bisogno, non per vanità. Ciò pone in primo piano l’oggetto di interesse di ogni opera con dirompenza, appunto, grezza, ma non per questo non elaborata all’estremo. Si vedano, in questo senso, ad esempio, i bellissimi acquerelli di Renzo Marcacci o i disegni di Ines Lingenhag, dove chiaramente nulla è lasciato al caso. O, ancora, le impressionanti forme a mosaico di Sergio Vassalli, che immediatamente ricordano i «mandala» degli storici artisti brut Augustin Lesage e Adolf Wölfli. Dal lato dell’espressione della sofferenza specificatamente psichiatrica invece, certo si è colpiti dalle tele di Françis Rougier, nelle quali appaiono chiaramente quegli angosciosi fe-
nomeni di corpo – la percezione della fisicità frammentata, dell’interno confuso con l’esterno – che tragicamente caratterizzano un certo dolore psichico (le stesse considerazioni si potrebbero estendere agli artaudiani lavori di Ygor Rossi). Non da ultimo però, sono pure il colore e il gioco a farla da padroni nella Collettiva ’74: ci si soffermi, in visita, sui commoventi, troppo grossi, tronchi d’albero di Enrico Ferrari, per respirare un’aria variopinta e bambina, così come sui bellissimi busti di Stefano Bean, che certo potrebbero entrare direttamente, a pieno titolo e senza ombra di dubbio, nella nota collezione losannese.
Dove e quando Collettiva ’74, Campus Supsi (Dacd) Mendrisio (Via Flora Ruchat-Roncati 15); orari: lu-ve 9-19. Le opere esposte negli spazi della mensa sono accessibili fino alle ore 18. Una selezione di opere è esposta anche a LaFilanda. Per domande o informazioni www.club74.ch











































































Gallerie ◆ La Buchmann Galerie importante punto di riferimento culturale nel nostro territorio, conclude la sua attività espositiva
Alessia Brughera
Cinquant’anni or sono, a San Gallo, nasceva la Galleria Buchmann. A fondarla Elena e Felix, marito e moglie, entrambi grandi appassionati d’arte. Forse nemmeno loro immaginavano che quello spazio espositivo affittato al piano terra dell’edificio in cui Felix aveva la sua agenzia pubblicitaria avrebbe segnato l’incipit della lunga e prolifica storia di un luogo d’arte e di cultura internazionale, apprezzato da artisti, collezionisti e amanti del settore.
Dotati di una profonda sensibilità nei confronti dell’arte così come di un’attitudine innata a riconoscere gli animi e gli ingegni più promettenti, i coniugi Buchmann hanno sempre lavorato con entusiasmo, solerti nel vagliare tutto ciò che accadeva nel panorama artistico mondiale e abili nel coglierne con acume e lungimiranza i risvolti più interessanti.
Lo dimostra, già dagli esordi sangallesi, la scelta di esporre artisti emergenti svizzeri diventati poi grandi nomi, come Matias Spescha, Urs Lüthi e Dieter Roth, e di presentare linguaggi espressivi avanguardistici come la Video Art.
La lungimiranza ha contraddistinto il lavoro dei coniugi Buchmann sin dall’inizio della loro attività, a San Gallo
Con il trasferimento della galleria a Basilea, nel 1983, i Buchmann organizzano grandi mostre dedicate a figure del calibro di Georg Baselitz, Daniel Buren, Lawrence Carroll, Tony Cragg, Wolfgang Laib, Giuseppe Penone e Mario Merz. Proprio di Merz è la rassegna inaugurale della nuova sede basilese, dove vengono accolti gli imponenti lavori che il maestro italiano aveva realizzato al Castello di Rietberg, nel Canton Grigioni, frutto di un innovativo progetto che dava la possibilità agli artisti di operare in un contesto messo a loro completa disposizione e dotato di tutto il necessario per dar vita alle loro creazioni.
Con intraprendenza, Elena e Felix spostano nel 1998 la sede della galleria nel nostro Cantone, ad Agra, in un edificio con un ampio giardino scelto appositamente per ospitare sculture di grandi dimensioni. Questi sono gli anni in cui Felix fa parte del comitato di Art Basel adoperandosi molto per sollecitare un’apertura della fiera verso tale tipo di espressione artistica.
Dopo la scomparsa del marito nel 2008, Elena continua a gestire la galleria con energia e tenacia, accostando nel 2013 alla sede di Agra un’area espositiva in centro a Lugano: «Un luogo di meditazione sull’arte», come lei stessa lo ha sempre definito, aperto con la convinzione che, nel cuore della rumorosa città, potesse favorire, anche solo per un attimo, una condizione di raccoglimento e di riflessione interiore.
Nell’autunno del 2020 chiude la galleria di Agra e tutte le attività vengono concentrate nella sede luganese, che raccoglie così il testimone di decenni di solide e feconde relazioni instaurate con gli artisti. Dopo un lustro, nel 2025 termina anche l’attività espositiva nello spazio cittadino.
Mezzo secolo di vita non è semplice da riassumere in poche parole.

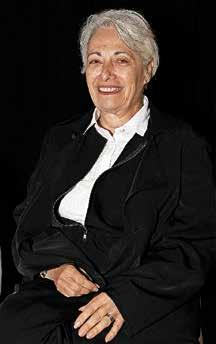
Quando però chiediamo a Elena Buchmann che cosa di tutti questi anni ricorda con maggior piacere, non ha alcun dubbio: «È il contatto con gli artisti, il rapporto umano che abbiamo instaurato con loro. Questo rapporto per me ha avuto sempre più valore di ogni altra cosa. Sono tanti i maestri con cui abbiamo avuto a che fare, spesso molto diversi tra loro, e con ciascuno siamo riusciti a entrare in sinergia, a creare un legame autentico che ci ha coinvolti in maniera totale e che ci ha aperto la mente. Per noi gli artisti erano persone di casa. Dieter Roth, ad esempio, a mio parere una delle figure elvetiche più rilevanti, veniva spesso da noi a San Gallo per dipingere in una sala adiacente agli uffici di mio marito: avevamo acquistato un suo quadro non finito e lui si recava qui per portarlo avanti. È un’opera che adesso fa parte della collezione del Museo di Aarau. Quando l’artista arrivava a casa nostra, chiacchierava con Felix e dipingeva. Poi, dopo aver lavorato, si metteva a suonare una piccola fisarmonica per i miei due bambini. Eravamo come una famiglia. Per me essere una gallerista significa proprio costruire un rapporto continuo con gli artisti: è un mestiere che non finisce con una mostra o con la vendita di un quadro, ma
che vive di relazioni alimentate costantemente e fondate su una profonda stima e su una crescita reciproca». Diventata un punto di riferimento importante nel panorama artistico ticinese, elvetico e internazionale, Elena Buchmann, oltre ad aver gestito la galleria e la sua partecipazione alle maggiori fiere d’arte contemporanea (è presente ad Art Basel fin dal 1981), ha collaborato con istituzioni museali e spazi privati a progetti di ampia portata, sempre nel segno della valorizzazione dell’arte.
In merito agli eventi culturali realizzati in anni recenti in Ticino, Buchmann ricorda in particolare Lugano Mostra Bandiera, una rassegna en plein air organizzata nel 2015 dalle gallerie della città come evento celebrativo in vista dell’apertura del LAC, e, soprattutto, l’esposizione allestita al Santuario della Madonna d’Ongero a Carona nel 2018, «un progetto a cui tenevo molto e che ha coinvolto tanti artisti chiamati a confrontarsi con la Via Crucis di quattordici cappelle che conduce all’edificio religioso, in una suggestiva e audace connessione tra arte contemporanea e spiritualità», sottolinea.
Ripercorrendo la storia della galleria, Buchmann non nasconde che negli ultimi anni ci siano stati cambiamenti profondi nella percezione e nella fruizione delle mostre da parte del pubblico. «Oggi molte persone non vedono più le esposizioni come una proposta culturale ma come un evento a cui partecipare solo se vi viene allestita attorno una cornice più “mondana”. Ho notato che si è perso molto dell’autentico valore di una rassegna. Per me l’obiettivo è sempre stato quello di arricchire le persone, di dare loro degli stimoli su cui riflettere».
Ed è così anche per la mostra scelta per concludere l’attività espositiva di Lugano, un prezioso omaggio ad Alberto Garutti, artista scomparso nel 2023 con cui la galleria ha mantenuto per anni uno stretto rapporto. Il lavoro del maestro italiano è sempre stato mosso dall’urgenza di penetrare la realtà del mondo esterno e la vi-
Netflix ◆ Convince La prova di Lisa Siwe
Simona Sala
ta della collettività, innescando meccanismi di partecipazione e dialogo con il pubblico. Nello spazio luganese (dove è stato anche presentato l’esaustivo volume dedicato all’artista, concepito da Germano Celant) sono state esposte alcune opere della serie Orizzonti, nate alla fine degli anni Ottanta: lastre di vetro dipinte con pittura nera e bianca, ciascuna delle quali esiste in virtù della relazione di Garutti con un suo collezionista o committente.
Dal suo Lugano Office Elena Buchmann continuerà a occuparsi di promozione e consulenza in campo artistico
L’artista trasferisce così in queste creazioni la linea dell’orizzonte della propria carriera, costellata dagli incontri e dalle relazioni con le persone che lo hanno apprezzato e sostenuto. «Il titolo Orizzonte è particolarmente significativo proprio perché incarna il concetto di infinito, di qualcosa che non si conclude ma che anzi si schiude a qualcosa di nuovo», sottolinea Buchmann. «Oltre a questa serie, in rassegna abbiamo voluto presentare un’opera che Garutti ha realizzato appositamente per il progetto di Carona e, negli spazi del nostro Lugano Office, abbiamo esposto alcuni raffinati olii su carta», prosegue. Sarà proprio da questo ufficio in centro città che Elena Buchmann continuerà a dedicarsi alla promozione dei suoi artisti e a fornire consulenza a collezionisti e istituzioni, proseguendo il lavoro iniziato mezzo secolo fa all’insegna della volontà di trasmettere un’idea di arte come insostituibile strumento di apertura verso il mondo.
Dove e quando Alberto Garutti – Orizzonte. Buchmann Galerie, Lugano. Fino al 28 febbraio 2025. Orari: da ma a ve 14-18, sabato su appuntamento. www.buchmanngalerie.com
Sono probabilmente le atmosfere, di un beige tendente al blu-petrolio a rendere accattivante questa serie sin dalla prima inquadratura. Oltre alla linearità delle forme, che va a braccetto con quella della narrazione, o alle luci degli interni che ben contrastano alcuni esterni mozzafiato. Non siamo a Stoccolma, né in qualche landa desolata del Paese scandinavo, ma a Lanköping, deliziosa cittadina del sud della Svezia, scossa all’improvviso dal doppio omicidio di un bambino e di una donna di mezza età – uno a pochi passi dall’altra – che nella vita non si erano mai incontrati. Il dolore e lo sconforto dei parenti delle vittime si manifesta senza mai caricare lo spettatore, grazie a quella sorta di dignitoso pragmatismo svedese che è diventato quasi un marchio di garanzia e di riconoscimento per una produzione recente –soprattutto letteraria – intensissima. Basata su una storia vera, la serie La prova (The Breakthrough) di Lisa Siwe, ispirata al libro Genombrottet della giornalista Anna Bodin e del genealogista Per Sjölund, racconta un’inchiesta condotta da John (Peter Eggers) in cui anni e anni (sedici per l’esattezza) di indagini a tappeto non hanno portato ad alcuna risoluzione, trasformando la tragedia di due persone accoltellate di primo mattino, in un cold case. E tale sarebbe rimasto, questo misterioso caso (un po’ come quello di Olof Palme, si ricorda nella serie), se non fosse subentrata la scienza. Grazie al suo lavoro di ricerca certosina, che si avvale non solo di banche dati digitali, ma anche di vecchi archivi scritti con un inchiostro ormai stinto, il genealogista Sjölund (Mattias Nordkvist) riesce a risolvere il caso, sollevando però anche qualche lecito dubbio su quali siano i limiti di natura etica, quando si comincia a frugare non solo nel passato di altri, ma perfino nel loro DNA. Fra i meriti di un lavoro che già si avvale di toni bassi, un ritmo lento, momenti di silenzio, l’inesistenza di colpi di scena e una recitazione decisamente intensa (soprattutto grazie ai primi piani), vi è sicuramente anche quello dei tempi. La prima stagione della Prova, infatti, dura solamente quattro puntate per poco più di due ore, che se guardate senza interruzione, è un po’ come quando eravamo abituati a guardare i film, e ancora non sapevamo che un giorno ci saremmo assoggettati a ore e ore di serie contrappuntate da continui flashback e diluite su un numero sempre maggiore di puntate.









Graphic novel biografiche ◆ La vita di Paolo Borsellino ci ricorda che gli eroi vecchio stampo non sono solo leggende cavalleresche
Benedicta Froelich
Per chiunque fosse, al pari di chi scrive, abbastanza cresciuto da comprendere la gravità dei fatti dell’epoca, le morti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – avvenute nel 1992, ad appena 57 giorni di distanza l’una dall’altra – conservano la valenza simbolica di uno strappo netto nella coscienza non solo dell’intera penisola italiana e dei suoi abitanti, ma anche di chiunque, in tutto il mondo, avesse a cuore l’integrità della coscienza civile per come espressa nella lotta contro la mafia. All’interno di una vicenda già di per sé straziante, quella di Paolo Borsellino è infatti una parabola particolarmente tragica, molto simile, negli intenti come nei sentimenti, a un romanzo cavalleresco d’altri tempi, in cui l’eroe si immola in modo consapevole per il bene comune, accettando l’immane e ineluttabile sacrificio come qualcosa di dovuto e naturale. E – dato l’innegabile valore non solo narrativo, ma anche educativo, di una vicenda umana del calibro di quella del magistrato siciliano – non stupisce che la scelta di dedicargli innumerevoli volumi didattici destinati a ogni fascia d’età (tra cui più di una graphic novel) sia apparsa del tutto naturale –soprattutto dal momento che il mezzo espressivo fornito dalla letteratura disegnata rappresenta un modo semplice e immediato di attirare il pubblico giovanile. In effetti, il fumetto di stampo biografico offre quello che può considerarsi come uno sguardo privilegiato sulla vita di un personaggio: romanzandone (ed enfatizzandone, tramite il disegno) l’esperienza a partire da fatti e situazioni reali, permette di avvicinarsi a emozioni, sentimenti e percezioni del protagonista di turno tramite la più autentica identificazione – quella capacità d’immedesimazione e «transfert» emotivo che solo la fiction di qualità può offrire. Ed ecco che in Paolo Borsellino –Una storia da raccontare, volume firmato da Marco Sonseri ai testi e Gian Luca Doretto alle matite e pubblicato nel 2021 per i tipi di Renoir Comics, quest’anelito è portato al pieno successo narrativo tramite un uso sapiente della narrazione in prima persona, tale da permettere al lettore di camminare a fianco del giudice palermitano fino al tragico epilogo della sua avventura. Il racconto attraversa infatti tutte le fasi dell’esperienza umana di Borsellino, dalla guerra e dall’idealismo politico e militante della gioventù fino alle grandi sfide dell’età matura, esaminando a fondo il sentimento che più ha definito la sua vita – ovvero, la profonda passione per la giustizia e, soprattutto, l’impegno nella lotta contro la mafia a fianco del collega e grande amico Giovanni Falcone, con la morte del quale Borsellino si sarebbe trovato a dover combattere da solo, sapendo benissimo di essere, per


molti versi, un morto che camminava. Avviene così che una delle sequenze più riuscite dell’intera graphic novel sia proprio quella in cui Borsellino, chiamato in ospedale al capezzale dell’amico subito dopo l’attentato di Capaci, assiste impotente alla morte del compagno di tante battaglie per poi fare ritorno a casa nel più pietrificato e sconvolto silenzio – un silenzio nel quale sembra quasi di affogare, e da cui si può essere salvati solo dall’abbraccio comprensivo e salvifico di una moglie. A quel punto, diventa subito chiaro come Borsellino fosse perfettamente consapevole di quanto lo attendeva, e del fatto che presto sarebbe stato chiamato a condividere la sorte dell’amico scomparso; e il fumetto riesce a catturare, in tutta la sua drammaticità, quella sorta di «limbo» all’interno del quale il giudice proseguì nel suo instancabile lavoro, cercando, per quanto possibile, di portare avanti i propri ideali in quelli che sapeva essere i suoi ultimi giorni – fino alla strage di Via D’Amelio, nella quale perderà la vita insieme agli agenti della sua scorta.
All’interno di una traiettoria tanto dolente, che ha le caratteristiche di una tragedia greca, la fusione tra testo e immagine si carica di una responsabilità per certi versi ancor più grande, dovendo trasmettere la drammaticità della vicenda e, allo stesso tempo, l’elemento salvifico fornito dallo spessore umano del giudice, che riscatta con la propria semplicità e dedizione l’orrore di una morte annunciata. I testi di Sonseri, nome ormai collaudato nell’ambito del fumetto d’autore italiano (sua la sceneggiatura dell’unica graphic novel su Bud Spencer, già recensita su queste pagine) mostrano un invidiabile equilibrio tra l’intensità richiesta dall’argomento e la leggerezza di cui Paolo Borsellino era capace nella vita reale; il tutto in perfetta combinazione con il tratto sicuro e pulito di Doretto, il quale, come prevedibile, decide di utilizzare le atmosfere «noir» e malinconiche che solo il monocromatico – nello specifico, il bianco e nero arricchito dalla scala di grigi offerta dall’inchiostrazione a china – può fornire a un fumetto. Una scelta azzeccata, soprattutto nelle molte sequenze ad alto voltaggio emotivo, le quali,
Tutto ciò fa di Paolo Borsellino –Una storia da raccontare uno sguardo evocativo e toccante sulla quieta battaglia personale di un uomo apparentemente comune, costretto a divenire suo malgrado un eroe soprattutto per spirito di servizio nei riguardi del proprio Paese; e in un certo senso, davanti a un simile dono – a un sacrificio di questa magnitudine – le parole sembrano quasi superflue, a meno che non vengano rivestite di nuova dignità e potenza dai disegni che le accompagnano. E proprio in questo, in fondo, sta la vera, grande forza del fumetto d’autore: nella sua capacità di raccontare una storia «dal di dentro», attraverso gli occhi del protagonista, permettendo al lettore di sperimentare di riflesso tutti i drammi e le gioie dell’esperienza reale. Esperienza che, nel caso dell’opera di Marco Sonseri e Gian Luca Doretto, riesce a schivare la facile trappola della caduta nell’archetipo del cosiddetto «eroe dolente» per dipingere invece un ritratto a tutto tondo di un uomo solo contro il mondo – e che, proprio per questo, rappresenta qualcuno in cui noi tutti vorremmo avere il privilegio di poterci riconoscere.
nonostante l’uso di una struttura della pagina convenzionale, sono gestite con taglio fortemente cinematografico e inquadrature immersive (si vedano l’ampio uso di primi e primissimi piani
e l’alternanza di campo e controcampo); il che, tra splash panel dal notevole impatto visivo e toccanti didascalie introspettive, permette un coinvolgimento pressoché totale nella vicenda.


Bibliografia
Marco Sonseri (testi) e Gian Luca Doretto (disegni), Paolo Borsellino – Una storia da raccontare, Renoir Comics, 2021.

















Docu-fiction ◆ Il film autobiografico L’Osteria all’undici, presentato in anteprima alla 60esima edizione delle Giornate di Soletta, affronta il burnout senza retorica né drammatizzazione
Premio Soletta ◆ Il film di Zijad Ibrahimović esplora la vita e la ricerca delle proprie radici di Irvin Mujcić, figlio di una vittima del massacro del 1995
Nicola Falcinella
Il cinema elvetico ha dimostrato più volte grande attenzione alle storie legate alla ex-Jugoslavia, alla sua dissoluzione e alle sue guerre, e agli emigrati che spesso hanno trovato rifugio e accoglienza in Svizzera. Esempi ne sono tre pellicole ormai classiche di inizio millennio come Oltre il confine (2002) di Rolando Colla, Tout un hiver sans feu (2005) di Greg Zglinski e Das Fräulein (2006) di Andrea Staka oltre ai documentari Chris The Swiss di Anja Kofmel e Hotel Jugoslavija di Nicolas Wagnières. Ad arricchire il filone si aggiunge il titolo di maggior spicco della rappresentanza ticinese alle 60esime Giornate cinematografiche di Soletta, in corso fino a mercoledì. Si tratta de Il ragazzo della Drina di Zijad Ibrahimović, prodotto da Rough Cat di Nicola Bernasconi e prossimamente distribuito in sala da Noha Film.
L’opera è inserita tra le sei in concorso per il Premio Soletta, comprendente quattro documentari e due di finzione, ed è stata proiettata in prima assoluta sabato, mentre una replica è in calendario domani pomeriggio.
La prima impressione che si ha quando si guarda Osteria all’undici (Picfilm e RSI) – presentato sabato in prima mondiale alle 60esime Giornate di Soletta, e prossimamente in TV – è quella di un film sincero e dove non si vuole spingere l’acceleratore sulla spettacolarizzazione e la drammatizzazione. Infatti, l’ultimo lavoro del locarnese Filippo Demarchi punta parecchio sulla normalizzazione di un problema (la sindrome da burnout) e sul conseguente percorso di recupero.
Rinunciando all’enfasi, l’autore e regista permette al film di trasmettere autenticità e una maggiore vicinanza allo spettatore
Si tratta di un autoritratto in cui l’autore, in un momento delicato e successivo a un ricovero in una clinica, si confronta con il lavoro di regista, con le proprie paure e le proprie aspirazioni. L’opera si colloca tra il film autobiografico e la docu-fiction, e chiede agli spettatori di immergersi nel mondo interiore del protagonista. La narrazione si snoda tra passato (il racconto del burnout e del soggiorno in clinica) e futuro (il film che vuole realizzare e che inizia a scrivere), mentre Filippo cerca di reintegrarsi professionalmente affrontando alcuni colloqui di lavoro, fino a trovare un’occupazione a metà tempo come receptionist all’Ostello della Gioventù di Locarno.
Ambientato tra casa sua a Minusio e il luogo di lavoro a Bellinzona, il documentario – oltre al percorso personale – racconta anche i disturbi psichici e le storie molto personali di alcuni colleghi che lavorano con lui all’Osteria.
Come evidenzia lo stesso Demarchi «ogni ritratto è un incontro; ogni storia ha il proprio spazio e trova punti comuni con le altre. Alcuni desiderano emanciparsi da un’etichetta che li cataloga come persone con un disa-
gio psichico e senza possibilità di un lavoro stabile. Tuttavia, ci sono anche altre persone che trovano soddisfazione e sicurezza nel lavorare in un laboratorio protetto come quello dell’Osteria all’undici. La mia intenzione era proprio quella di raccontarle, senza pregiudizi né moralismi».
E infatti è questo uno dei pericoli che poteva correre il film di Demarchi; restare impigliato nelle reti della facile retorica pietista. Per fortuna riesce a schivare l’ostacolo, anche se il tema è stato affrontato durante la lavorazione del film. «All’inizio le note del violoncello di Zeno Gabaglio erano più enfatiche e l’effetto che ne scaturiva non mi convinceva, così ne abbiamo parlato e abbiamo calmato i toni, in modo da essere più asciutti per raccontare quelle storie in modo più neutro. Non volevo assolutamente drammatizzare le emozioni, ma filmare il mio percorso, senza spettacolarizzarlo. Il mio scopo era quello di porre l’accento sugli scambi di esperienza tra colleghi di lavoro. In definitiva, preferisco il naturalismo e il realismo all’enfasi. Sia le musiche sia gli effetti scenici sono quindi andati in questa direzione. Non volevo lanciare fuochi d’artificio, ma cercare di descrivere alcune storie come la mia». Il documentario di Demarchi è interessante anche perché, durante il suo burnout, quando si era auto isolato dal mondo, era riuscito a filmarsi. Una lucidità artistica, sicuramente non scontata né ovvia, che ha contribuito a rendere più reali le situazioni che descrive a posteriori e durante il percorso di recupero. «Devo ammettere – sottolinea Demarchi – che ci sono stati dei momenti di conflitto interno non semplici da superare. Non ero completamente convinto di raccontare alcuni aspetti difficili di quei momenti, ma il regista che è in me mi spingeva verso la massima trasparenza e a mettere sul tavolo tutte le fragilità vissute; mi ha spinto a non restare troppo in superficie e a essere anche spigoloso nel racconto. Il tutto
per offrire allo spettatore un numero di elementi sufficienti per capire meglio la complessità della vicenda che ho vissuto. Inoltre, ho usato anche alcuni pensieri che ho annotato durante la convalescenza e mi hanno aiutato a ricordare quei momenti delicati». Importanti e presenti ne L’Osteria all’undici sono state le letture fatte in quei mesi di isolamento. Lo afferma lo stesso Demarchi durante il filmato. Ha infatti letto, più volte, alcuni libri come L’ultimo giorno di un condannato a morte di Victor Hugo e Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon di Jean-Paul Dubois. «Entrambi parlano di redenzione e descrivono un crollo che avviene nella vita di una persona e la sua rinascita. Uno scoppio improvviso che ti fa andare in fondo a un buco nero, ma che poi ti permette anche di ritrovare un nuovo equilibrio per reintegrarti nella società. Mi ci sono ritrovato perché anche io, come i personaggi di quei libri, ho dovuto intraprendere quel percorso».
Così come fondamentali sono stati gli scambi avuti con gli amici e soprattutto con il direttore della fotografia Nikita Merlini. «Abbiamo avuto un continuo scambio di pareri sulle varie scene e le abbiamo costruite in modo semplice e cercando di essere il più neutri e naturali possibili nel filmarle. Per esempio, quando i colleghi raccontano la loro esperienza abbiamo usato i classici campo-controcampo con alcuni piani d’ascolto e mantenendo l’attenzione sulle loro storie. Anche durante il montaggio, insieme a Davide Briccola, abbiamo tenuto buona parte di quanto avevamo filmato perché le scene le avevamo preparate in anticipo, e spesso ci siamo resi conto che la prima versione del girato era più vera e spontanea delle seguenti».
Il tutto a confermare la prima impressione avuta da L’Osteria all’undici; un filmato autentico che usa toni tranquilli e pacati per descrivere alcuni percorsi di rinascita.
L’opera affronta direttamente uno dei più grandi traumi della storia europea recente, il massacro di Srebrenica: l’11 luglio 1995 più di ottomila musulmani furono assassinati dai soldati serbo-bosniaci agli ordini del generale Ratko Mladić. Tra i morti ci fu anche il padre di Irvin Mujcić, il «ragazzo» del titolo, il cui cadavere non è mai stato ritrovato. Mentre nell’aprile 1992, agli inizi del conflitto, moglie e figli piccoli lasciavano la città della Bosnia orientale che stava per cadere nelle mani degli aggressori, l’uomo restò nella loro casa e diventò poi interprete per i caschi blu olandesi. Un impiego che avrebbe dovuto metterlo al sicuro, ma non fu così. È la stessa occupazione della protagonista del bel Quo vadis, Aida di Jasmila Žbanić, regista sarajevese che nel 2020 raccontò bene i fatti. La location principale di quella pellicola era costituita dal capannone industriale nel quale i residenti della zona si erano riparati sotto il controllo dei militari dei Paesi Bassi, che però cedettero alle pressioni di Mladić, il quale fece deportare e massacrare gli uomini. La grande costruzione, simbolo del fallimento dell’intervento internazionale in quei mesi tragici, è uno dei luoghi cardine anche nel film di
Ibrahimović, che però ci arriva con calma e seguendo un percorso insolito. Il ragazzo della Drina è un lavoro sorprendente, che si differenzia dai tanti che in questi decenni hanno cercato di raccogliere testimonianze e ricostruire le vicende. Il regista che vive in Ticino segue Irvin, cresciuto in Italia, nel suo ritorno a Srebrenica il 5 dicembre 2014, un rientro «per restarci», in un villaggio sulle colline circostanti che prima del conflitto aveva 200 abitanti e ora solo quattro. Tra loro l’anziano Emin, che in guerra ha perso figlio, fratello e nipote e vive da solo di un’agricoltura di sussistenza, utilizzando vecchi attrezzi. Alla situazione – utilizzare le risorse disponibili con gli arnesi disponibili e conservando un approccio tradizionale – si adegua il giovane, il cui sogno è costruire un villaggio di case in legno in una radura della foresta. Lo stesso bosco nel quale si inoltra per il taglio e la raccolta di legno e per seguire le tracce delle fughe e dei nascondigli dei bosniaci che trent’anni or sono cercavano una salvezza. Ci sono ancora i segni dei passaggi, sotto forma di vecchie coperte abbandonate, resti di confezioni di cibo o di scarpe. Irvin aveva trovato «un’ancora di sicurezza» in Italia, perdendo poi i contatti con il genitore e scoprendo più tardi la verità. Dunque, la Bosnia costituiva «il» trauma difficile da affrontare, fino alla scelta di rientrare. «Tornare ti mette di fronte al trauma: finché non si fa questo passaggio, è impossibile andare oltre» spiega il protagonista nel film. È interessante il processo che compie il regista: non restare nel territorio della memoria e del passato, ma provare a guardare avanti, passando anche dalle fosse comuni diventate di nuovo campi coltivati o dalla foresta silenziosa che parla forte di fuggiaschi, di paure e di morti.
La storia di Irvin è semplice e straordinaria, sta tra la tragedia e la speranza, il dolore del ricordo e la volontà di ripartire e trasmettere. Ibrahimović (già autore dei documentari Custodi di guerra e Periferia del nulla) unisce l’osservazione e la riflessione, non indugia, ma riesce a commuovere. Senza citarlo, fa tornare alla mente Il ponte sulla Drina di Ivo Andrić, sempre ambientato sulle sponde del fiume simbolico che qui è chiamato «madre».

Ramen con pollo
Cucinare in un lampo un piatto asiatico? Per queste ricette ti basta un wok e in un attimo potrai servire in tavola tutto un menu
Buono a
Nel wok il calore è distribuito in modo diverso rispetto alle padelle convenzionali. Al centro la temperatura è più alta ed è ideale per una rosolatura breve. Il bordo alto può essere utilizzato per cuocere delicatamente gli ingredienti già rosolati e mantenerli caldi.
Cosa si cucina con il wok?
Il wok è ideale per saltare velocemente le verdure, la carne o il pesce. Particolarmente importante




La lattuga così non l’hai mai provata! Con sesamo, wasabi e limetta, dà vita a un pesto saporito dalle note asiatiche che è perfetto con le tagliatelle thai.

La curcuma gli regala un tocco di colore, lo zenzero e il cardamomo ne arricchiscono il gusto e questo riso indiano alle lenticchie titilla i palati vegani.



Una specialità esotica vegetariana subito pronta, grazie al curry in pasta pronto per l’uso e alle verdure surgelate che si versano in padella così come sono.

One pot asiatico di spätzli ai funghi
Piatto principale per 4 persone
600 g di pak choi
400 g di funghi misti , ad es. champignon, shiitake
2 cipolle
4 cucchiai d’olio per la cottura
800 g di spätzli
sale
ca. 2 cucchiai di salsa di soia
ca. 2 cucchiaini di sambal oelek
3 cucchiaini d’olio di sesamo
½ mazzetto di coriandolo
1. Sminuzza il pak choi. Taglia i funghi a fette, le cipolle a striscioline. Rosola i funghi nell’olio. Aggiungi il pak choi e le cipolle e continua la rosolatura per ca. 3 minuti.
2. Nel frattempo lessa gli spätzli in acqua salata per ca. 2 minuti. Scolali e mescolali subito con le verdure senza farli sgocciolare. Condisci con la salsa di soia, il sambal oelek, l’olio di sesamo e il coriandolo.

Piatto principale per 2 persone
1 vasetto di ceci da 330 g, peso sgocciolato 220 g
1 broccolo piccolo
200 g d’ananas
1 mazzetto di cipollotti
1 peperoncino rosso
200 g di shiitake
2 cucchiai d’olio di sesamo
6 cucchiai di salsa di soia shoyu
vegan
250 g di riso precotto, ad es. Subito, o resti di riso
1 cucchiaio di semi di sesamo tostati
1. Scolate i ceci. Staccate dal broccolo le cime. Tagliate l’ananas a pezzetti. Tagliate i cipollotti a fettine sottili. Tritate il peperoncino. Tagliate i funghi a fette.
2. Saltate i ceci nell’olio. Unite l’ananas e le verdure e fate rosolare per ca. 3 minuti, mescolando. Condite con la salsa di soia.
3. Scaldate il riso con un po’ d’acqua in una padella. Cospargete i ceci saltati con i semi di sesamo e servite con il riso.
CONSIGLIO UTILE Potete scaldare il riso precotto anche nel microonde, seguendo le istruzioni sulla confezione.

Ananas al pezzo Fr. 2.30

Personaggi fai-da-te e divertimento sonoro Così si trasformano capsule e materiali di recupero in un gioco educativo che stimola l’udito dei bambini, incoraggiandoli a riconoscere i suoni degli alimenti
Parigi dice addio agli uffici turistici
La chiusura dell’ultimo punto informazioni segna la scomparsa di un’icona del turismo parigino, sempre più sostituita dall’assistenza digitale per i visitatori

Reportage ◆ Castelli avvolti dalla nebbia, scogliere battute dal vento e spiagge popolate da foche, caratterizzano un angolo di Scozia che incanta con i suoi paesaggi senza tempo
Enrico Martino, testo e foto
«Attenzione. Foche. Siete pregati di tenere sotto controllo i cani per evitare che gli possa succedere qualcosa di spiacevole». Con un understatement squisitamente british il cartello annuncia la Forvie National Nature Reserve, uno dei sistemi di dune più intatti del Regno Unito affollato di foche che gattonano e rumoreggiano al sole sull’ultima ansa del fiume Ythan prima di sciogliersi nell’Atlantico.
Sabbia, sole e foche. Un’immagine lontana dagli stereotipi scozzesi di brughiere e castelli: l’Aberdeenshire sembra fatto per smentire i luoghi comuni con sorprese che insidiano persino la celebrata costa occidentale, e maree che ogni giorno inventano isole e canali tra lunghe spiagge e strapiombi. Non mancano neppure vecchi hotel fanés al punto giusto, dove i fishing books raccolgono entusiasti commenti che parlano di «gra-
ziosi salmoni» appena pescati. Fuori, un raggio di sole basta a dare il senso a un’intera giornata, accendendo improvvisamente di sfumature cieli imbottiti di nuvole basse e illuminando il verde dei prati mentre le onde si trasformano in una nebbia luminosa.
Grotte marine, Pennan e la Drum House
Ai Bullers of Buchan l’Atlantico ha scolpito uno scenografico arco naturale popolato di uccelli abituati a una vita in verticale che dà un senso alle esistenze di compassati birdwatchers, accompagnati da famiglie rassegnate che congelano al vento in attesa di qualche miracolosa rarità ornitologica.
In fondo a una baia, un tappeto setoso di spuma scivola sulle onde fino a lambire un’infilata di cottage rigoro-
samente bianchi accucciati ai piedi di prati che precipitano sulle scogliere. È Pennan, una location cult dai tempi di Local Hero, divertente film degli anni Ottanta in cui Burt Lancaster gigioneggiava nel ruolo di uno stravagante petroliere texano che voleva comprare il villaggio per costruirci una raffineria, per poi rinunciare grazie alla resistenza di un abitante ostinatamente deciso a non rifarsi la vita altrove. Tutta un’altra storia dalle pompose architetture georgiane della vicina Banff, famosa per i suoi green amati dai golfisti e le collezioni d’arte della Drum House, sede distaccata della National Gallery of Scotland. Un edificio imponente dalla storia architettonica a dir poco tormentata, furibonde diatribe incluse fra architetto e committente, Lord William Braco che nel 1730, stufo delle spese vertiginose necessarie a completare l’edificio, si rifiutava persino di guardarlo,
abbassando le tendine della carrozza ogni volta che era costretto a passarci davanti.
I castelli di Slains e Dunnottar
Gli appassionati di atmosfere dark e decadenti compiono invece solitari pellegrinaggi fino alle rovine neogotiche di un inquietante scheletro di pietra che emerge da ciuffi d’erba verde smeraldo, Slains Castle scoperchiato dall’ultimo proprietario nel 1925 per non pagare le tasse. Non manca neppure uno stecchito pennuto, appena schiantato davanti all’ingresso, per contribuire a un’atmosfera così sottilmente angosciosa da avere ispirato uno degli ospiti più famosi del castello, lo scrittore Bram Stoker, per il suo Dracula. Molto più romantiche, le rovine di Dunnottar Castle sono letteralmente incastrate su un teatrale
cubo di roccia circondato dal mare e illuminato dall’ultimo sole, una location perfetta per l’Amleto di Zeffirelli ma anche per Game of Thrones Probabilmente le sue mura sbrecciate da secoli di cannonate, vento e tempeste non hanno fatto una piega di fronte al nevrotico agitarsi delle troupes, con le loro pietre slabbrate abituate alle tragedie seriali di molti protagonisti della storia scozzese, da William Wallace ormai irrimediabilmente inchiodato come icona di Braveheart all’infelice Maria Stuart. Fu l’ultimo castello ad arrendersi nel 1652, dopo otto mesi di resistenza, alle truppe di Cromwell che cercavano i gioielli della corona scozzese e l’archivio di re Carlo II, ma i primi erano stati saggiamente nascosti sotto un pavimento e i documenti erano usciti dal castello sotto le gonne di una donna del vicino villaggio. Nella vicina Stonehaven invece rischiano gros-

so gli eventuali diavoli di passaggio nella notte di Capodanno, quando gli spiriti maligni vengono cacciati a colpi di Fireballs, le «Palle di Fuoco», micidiali contenitori metallici pieni di materiali in fiamme fatti pericolosamente ondeggiare sulla folla da scatenati interpreti di una tradizione dura a morire.
Sferzate di vento
Fari e castelli sgranati lungo la costa più orientale della Scozia punteggiano promontori come Kinnaird Head che vanta i venti più forti della Gran Bretagna con una rispettabile punta di circa 225 chilometri orari registrata nel 1989. Un primato non da poco persino qui, fronteggiato con successo dalla massiccia mole quadrata di Kinnaird Castle, il più antico faro scozzese costruito nel XVI secolo ma perfettamente funzionante fino al 1991, quando l’ultimo guardiano se ne andò per sempre.
All’interno, un museo raccoglie giganteschi prismi recuperati da fari in disuso e il racconto dell’epopea della più famosa dinastia di costruttori di fari scozzesi, realizzati in condizioni spesso impossibili da ben cinque generazioni di Stevenson fra cui il padre dello scrittore Robert. Testimonianze e oggetti rivelano storie e leggende di una specie umana quasi estinta, i guardiani dei fari capaci di sopravvivere ai lunghi inverni di una delle coste più ostili del mondo. Controllando e alimentando ogni notte quel raggio di luce che salvava vite e mercanzie per uno stipendio di uno scellino per notte e il foraggio per allevare una vacca. Senza mai dimenticarsi un accessorio a prima vista indefinibile ma fondamentale, lo stiracravatta di legno perché – anche se in capo al mondo – il guardiano sorpreso con una cravatta stropicciata in caso di ispezione o, Dio non voglia, di arrivo improvviso dello yacht reale Britannia perdeva il posto.
Nella terra dei pescatori
Lungo questi porti, dove anche l’aria sa di pesce, le tute da pescatore sventolano come insegne araldiche di famiglia davanti alle case, da Fraserburgh a Peterhead dove giganteschi pescherecci che sembrano quinte mobili di ferro colorato fanno girare svariate decine di milioni di euro all’anno. «Non è più come una volta» sospira Jacqueline Yule proprietaria con il marito del più antico affumicatoio scozzese, la Ugie Salmon Fish House dove da oltre quattro secoli nessuno mette in discussione i metodi tradizionali di affumicatura con il legno di quercia. «Oggi a Peterhead c’è ancora molto pesce ma parecchi han-
no venduto le loro barche per lavorare nell’industria petrolifera, soprattutto sulle navi rifornimento, anche se magari rimpiangono la vita di prima perché un pescatore sarà sempre un pescatore». I pescherecci li vedi ancora, ma sempre più spesso fermi nei porti perché anche l’illusione della Brexit ha tradito questa gente sottraendo pesce, soldi e lavoro.
La Città della Rosa
Il petrolio invece lo puoi solo intuire perché le piattaforme sono oltre l’orizzonte, disseminate nel mare del Nord, ma l’incessante rombo degli elicotteri che trasportano il personale annuncia Aberdeen già a molti chilometri di distanza. Una città che «si detesta come un innamorato respinto odia la persona amata», un’alternativa secca di odio o amore lapidariamente riassunta dal romanziere Lewis Grassic Gibbon nativo di queste parti. Non aiutano un’austera grisaglia architettonica impregnata di un clima decisamente atlantico in una latitudine a nord di Mosca.
Così, per addolcire le infinite sfumature di grigio della terza città scozzese, l’ufficio del turismo l’ha ribattezzata Città della Rosa seminando tra parchi e rotatorie oltre due milioni di rose e dieci di giunchiglie che le hanno fatto vincere più volte l’ambito titolo di Britain in Bloom, (Gran Bretagna in fiore). Tutto nell’impossibile tentativo di far dimenticare il soprannome di «Città di granito» affibbiatole da sempre. Del resto, per sfuggire a un destino apparentemente segnato già nel XII secolo, l’antica Aberdon si era inventata un destino commerciale e peschereccio, inframezzato da innumerevoli guerre e ribellioni contro i soliti inglesi. Rifugio del re scozzese Robert Bruce, piazzaforte strategica di Edoardo I d’Inghilterra, liberata dagli abitanti in una notte del 1306 massacrando, tanto per non sbagliare, la guarnigione inglese, contraccambiati da Edoardo III che nel 1337 distrusse l’intera città.
Giacimenti di petrolio
Unico punto fisso nei secoli il rapporto costante e indissolubile con il mare, rinsaldato dal boom petrolifero nel Mare del Nord. Un’epopea che qui chiamano lo «spirito del Klondike» quando con la scoperta dei giacimenti offshore arrivarono i texani che ritrovi nelle nostalgiche fotografie piene di cappelli da cowboy del Museo Marittimo, un inno all’industria petrolifera completo di riproduzione in scala ridotta di una piattaforma. Sembra quasi una rivisitazione dell’immaginario western, dove all’immagine dell’arrivo in città di mandrie e av-



venturieri basta sostituire quella degli operai che scendono da elicotteri e navi appoggio. Una vera e propria età dell’oro che raggiunse il suo culmine a metà degli anni Ottanta con una produzione di 2,6 milioni di barili al giorno.
La prima devastante frenata arrivò nel 1986 quando il prezzo del barile crollò a dieci dollari e Aberdeen perse un migliaio di posti di lavoro al mese. Due anni dopo l’incendio della piattaforma Piper Alpha, e 167 morti, costrinsero Governo e industria petrolifera a cambiare in modo radicale le regole di sicurezza. Nel frattempo, compassati manager avevano sostituito i pionieri delle trivelle ma il ger-
go petrolifero yankee era entrato per sempre nel patrimonio locale.
Da allora il porto nel cuore della città è sempre affollato di coloratissime navi rifornimento che fanno ogni giorno la spola con le piattaforme, cambiando i connotati di una città che in percentuale ha più miliardari di Londra. Superando persino i fasti del diciannovesimo secolo, testimoniati da un’imponente architettura classica e neogotica che celebra i successi di una borghesia che aveva dato all’impero britannico la supremazia mondiale nel commercio del tè cinese grazie ai mitici clipper, i velocissimi velieri costruiti nei cantieri navali locali.

La città perduta
Della vecchia Aberdon rimangono le torri della cattedrale di San Machair che emergono tra gli alberi e le lapidi di un cimitero nascosto fra gli alberi. Ultime testimonianze di una chiesa fondata nel 580 d.C. lungo il fiume Don seguendo il consiglio del monaco irlandese San Columba che, secondo un’antica cronaca, aveva suggerito al suo discepolo Machair di costruire un luogo di culto dove l’ansa di un fiume ricalcasse la forma di un bastone vescovile. Intorno si estende una lost city, una «città perduta» come la chiamano nostalgicamente in molti, di romantiche casette e stradine lastricate tra cui torreggiano gli edifici del King’s College fondato nel 1495. Una perfetta camera di compensazione tra la frenetica Aberdeen e le rilassate atmosfere da capsula del tempo dei villaggi dell’Aberdeenshire.
D’altronde anche prima dei clipper e del petrolio questo mondo di porti stipati di scafi neri, il colore quasi d’obbligo dei pescherecci scozzesi, ha sempre saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista, in un continuo scambio di ruoli con il granito di Aberdeen.













Crea con noi ◆ Un gioco semplice e divertente per stimolare l’udito dei bambini utilizzando capsule e alimenti secchi
Giovanna Grimaldi Leoni

Ecco un gioco facilissimo da creare. Con materiali di recupero come le capsule delle pastiglie di vitamine, possiamo dare vita a simpatici personaggi sonori che intratterranno i bambini stimolando il loro udito e la loro curiosità. Il gioco consiste nello scuotere i personaggi e provare a indovinare il contenuto all’interno basandosi sul suono. È perfetto per sviluppare le capacità sensoriali e il riconoscimento dei suoni!
Procedimento
Raccogliete le capsule delle vitamine e pulitele bene. Misurate la lunghezza del tubetto e tagliate le strisce di adesivo necessarie per il rivestimen-
to. Rivestite i tubetti con fantasie differenti.
Aggiungete una testa al personaggio usando palline di legno. Incollate prima un tappo sulla sommità della capsula, poi la pallina di legno e infine un secondo tappo che farà da cappello.
Scegliete gli alimenti da utilizzare per ogni capsula, disponete tutti gli alimenti in piccoli contenitori e scattate una foto chiara. La foto servirà come riferimento per aiutare i bambini ad abbinare il personaggio al contenuto.
Inserite in ogni capsula un tipo diverso di alimento, ad esempio: riso in una capsula, lenticchie rosse in un’al-
Cruciverba
«Sai, una volta sono stato baciato dalla fortuna…» Trova il resto della frase leggendo, a soluzione ultimata, le lettere evidenziate.
(Frase: 2, 13, 3, 2, 5, 2, 5)
grezzo
11. Uccise Golia
12. Centro dell’Uganda
13. Antico strumento musicale
15. Provocante, scandaloso
17. Isola del Mar d’Irlanda
19. Sono piccole a notte alta
20. Lotto di terreno
21. L’attrice Valle
23. Sgradite e-mail
24. Non le conforta la fede
25. Negazione russa
27. Lago dell’Asia
28. Un libro della Bibbia
29. Un numero inglese
31. Il celebre Hur
32. Ottimo sui maccheroni
34. Le iniziali del giornalista Giannino
35. L’ora... avanzata
37. Le cause dei civilisti
39. Opera di Donizetti e nome femminile
40. Ha un valore di mezzo
VERTICALI
1. Si intrecciano con gli orditi
2. Carattere nell’antico alfabeto germanico
3. Le iniziali dell’attore Delon
4. Nome dell’attore Gibson
5. Fissano scadenze
6. Dopo il 40 orizzontale... è un periodo storico
7. A voi
8. Olfatto
9. Balena... nella testa
11. Severa, intransigente
14. Particella atomica
16. Un figlio di Noè




tra e pasta in un’altra ancora. Riempitela solo fino a un terzo della sua capacità, in modo che gli alimenti abbiano spazio sufficiente per muoversi e produrre il suono desiderato quando vengono scossi.
Assegnate un nome a ciascun personaggio e scrivetelo sulla capsula (ad esempio: Noah, Alice, Luca). Utilizzando un pennarello nero, disegnate dei piccoli occhi sui volti dei personaggi. Qui abbiamo scelto uno stile volutamente minimal, ma potete personalizzarli ulteriormente aggiungendo dettagli come bocche, capelli o altri elementi decorativi per renderli ancora più personali.
Come giocare: Iniziate mostrando ai bambini i personaggi sonori e invitateli a prenderne uno alla volta. Chiedete loro di scuotere ciascun personaggio, ascoltare attentamente il suono prodotto e provare a indovinare cosa potrebbe esserci all’interno. Dopo un momento di sperimentazione e ipotesi, presentate loro la fotografia con i vari alimenti utilizzati nel gioco o ancora meglio gli ingredienti stessi. Incoraggiateli a collegare ogni personaggio al possibile contenuto. Una volta che tutti hanno fatto le loro associazioni, lasciate che controllino le risposte aprendo i personaggi. Buon divertimento!

• Capsule di plastica delle pastiglie di vitamine (o altri contenitori simili con coperchio).
• Alimenti secchi con consistenze e pesi differenti, come riso, pasta, lenticchie, ceci secchi, semi, …
• Adesivi o carta colorata per rivestire i tubi (l’adesivo permette di pulirli con un panno bagnato)
• Colla a caldo o colla universale
• Perle in legno da 2,5 cm
• Tappi di bottiglia
• Stampante per la foto degli alimenti usati
(I materiali li potete trovare presso la vostra filiale Migros con reparto Bricolage o Migros do-it)
Tutorial completo azione.ch/tempo-libero/passatempi
Sudoku Scoprite i 3 numeri corretti da inserire nelle caselle colorate.
18. È sempre... sulla cresta dell’onda
20. Un insetto
22. Preposizione articolata
23. Gli indirizzi web
24. Desinenza verbale
25. Occipite
26. Famoso teatro di Torino
27. Famoso gruppo musicale svedese degli anni 70
28. Insenatura costiera
30. Conosciuti
32. Croce Rossa Italiana
33. Un’incitazione spagnola
36. Interpretava
«La signora in giallo» (iniz.)
38. Deridere… in cuor suo

Regolamento per i concorsi a premi pubblicati su «Azione» e sul sito web www.azione.ch I premi, tre carte regalo Migros del valore di 50 franchi, saranno sorteggiati tra i partecipanti che avranno fatto pervenire la soluzione corretta entro il venerdì seguente la pubblicazione del gioco. Partecipazione online: inserire la soluzione del cruciverba o del sudoku nell ’apposito formulario pubblicato sulla pagina del sito. Partecipazione postale: la lettera o la cartolina postale che riporti la soluzione, corredata da nome, cognome, indirizzo del partecipante deve essere spedita a «Redazione Azione, Concorsi, C.P. 1055, 6901 Lugano . Non si intratterrà corrispondenza sui concorsi. Le vie legali sono escluse. Non è possibile un pagamento in contanti dei premi. I vincitori
esclusivamente a lettori che risiedono in Svizzera.
















«Je t’aime… moi non plus » cantavano nel 1969 Serge Gainsbourg e Jane Birkin, declinando la complessità e le contraddizioni dei sentimenti amorosi. E proprio Paris je t’aime era il nome degli uffici turistici di Parigi, aperti nel 1971: cinque spazi accoglienti, il più conosciuto nel monumentale Hôtel de Ville, il municipio della città nel IV arrondissement, sulla riva destra della Senna. In questi uffici passavano ogni anno mezzo milione di turisti, per acquistare souvenir, prendere un dépliant o una cartina e ricevere informazioni sul loro soggiorno nella capitale francese. Il 13 gennaio di quest’anno tuttavia l’ultimo ufficio turistico di Parigi ha chiuso i battenti, aggiungendosi alla lista dei luoghi prediletti che vanno scomparendo nella capitale francese: le portinerie (celebrate da Muriel Barbery nel best-seller L’eleganza del riccio), le cabine telefoniche, le picco-
le librerie indipendenti, i Café e i cinema di quartiere, i venditori di libri usati lungo la Senna (bouquinistes), le piccole enoteche (cave à vins), i vecchi lavatoi pubblici… Certo, qualcosa di simile sta accadendo in tutte le grandi città, per effetto della globalizzazione, della diffusione di grandi catene e piattaforme digitali, dei cambiamenti nelle abitudini di consumo, dell’aumento dei costi; ma a Parigi fa più impressione. Inoltre pochi avrebbero immaginato che gli uffici di informazione turistica fossero inclusi in questa lista; dopo tutto, Parigi è la città più visitata al mondo, con cinquanta milioni di visitatori l’anno, e oltretutto beneficia ancora della ricaduta d’immagine dei giochi olimpici. I responsabili hanno liquidato la questione rapidamente, spiegando che i turisti vogliono informazioni aggiornate, in tempo reale, ovunque
L’umiltà del cotto romanico lombardo delle chiesette in disparte, spesso inatteso o agguantato di sfuggita, da sempre, in mezzo al caos milanese, mi consola. La ritrosìa, inoltre, di questo cotto metropolitano situato in arretrato rispetto alla strada, lascia lo spazio di movimento necessario, senza imposizioni di grande bellezza o molta bruttezza che ti si parano davanti, per andargli incontro con gli occhi e accoglierlo anche nel cuore. A passi sincopati, sul sagrato in ciottoli di fiume, assaporo dunque l’umiltà rosso mattone della facciata, seppure rimaneggiata con rosone neogotico da Maciachini – l’architetto del cimitero monumentale già incrociato sul nostro cammino – della chiesa di San Marco. In controcampo, oltre i platani e le macchine, c’è un palazzo di Magistretti – autore delle lampade Atollo ed Eclisse – del 1971 che s’intona, rispettando i
due colori preesistenti (il rosso mattone e il bianco del portale marmoreo e delle lesene), alla chiesa fondata nel 1254 dove ora entro. Magra consolazione Magistretti in tinta, visto che fino agli anni trenta, in faccia alla chiesa dedicata al santo lagunare, c’era un naviglio omonimo che formava persino, poco più avanti, un laghetto. La gloria angelica, subito a destra appena entrato, lassù nel catino absidale in fondo alla cappella Foppa, dipinta tutta nel 1571 da Giovan Paolo Lomazzo (1538-1592), ultima opera prima di diventare cieco a trentatré anni e divenire grandioso trattatista e poeta, già si annuncia coloratissima e turbinosa. La luce, verso le tre meno un quarto di un pomeriggio a fine gennaio con cielo azzurro, penetra dalle finestrelle-oblò. Oltre il cancello in ferro battuto nero, sotto la volta con profeti e sibille che precede il catino
si trovino, e le cercano in rete. Dal 2026 dunque sarà potenziata la presenza sui social, oltre a un nuovo sito web, chat dedicate di WhatsApp e cinquanta chioschi (senza personale) sparsi per la città. Non tutti però sono convinti. Per cominciare le altre grandi città turistiche (Londra, Madrid, Roma) continuano sulla vecchia strada, sottolineando quanto l’elemento umano sia importante nel viaggio o come la tecnologia non possa sostituire l’incontro e il consiglio personale, specie nei primi giorni dopo l’arrivo, quando siamo inevitabilmente spaesati. Inoltre solo i giovani dipendono interamente dalla rete. Nel nostro tempo tuttavia, per la prima volta nella storia, convivono sei generazioni diverse (indicativamente Silent Generation, Baby Boomers, Generazione X, Millennials, Gen Z, Generazione Alpha) e tutte amano viaggiare;
di Claudio Visentin

a molti una voce amica fa senz’altro ancora piacere. Parigi insomma potrebbe aver anticipato troppo i tempi del cambiamento.
A Berlino intanto hanno puntato su Emma per raccontare le attrazioni della città. Emma è una berlinese di aspetto gradevole, sulla trentina, moderna, cosmopolita; parla venti lingue compreso l’inglese, con inappuntabile accento posh. Peccato solo non sia vera. Emma infatti è un avatar creato con l’intelligenza artificiale, attivo su Instagram (@EmmaTravelsGermany). E per non sbagliare i suoi creatori si sono tenuti alla larga da pelle chiara, capelli biondi e occhi azzurri: certi ricordi fanno ancora paura. Emma sin qui se l’è cavata piuttosto bene, con qualche minimo scivolone nella generazione delle immagini (i soliti pignoli hanno segnalato un post con un dito mancante nella mano che regge una tazza di
caffè). E tuttavia Emma non ha sostituito gli impiegati in carne e ossa, né gli influencer su Instagram, semmai li ha affiancati, fornendo soprattutto informazioni pratiche; ma lascia agli umani il compito di creare connessioni autentiche e contenuti basati su esperienze personali. Per ora Emma ha solo cinquemila follower: d’altronde senza personalità è difficile crearsi un pubblico e guadagnarsi la sua fiducia (compiti impegnativi anche per gli esseri umani). La Venere di Botticelli, immaginata a suo tempo dal Ministero del turismo italiano, ha raccolto più seguito, ma anche i suoi interventi generano poca interazione. Questi primi esperimenti insomma danno indicazioni contrastanti. Non mancano valutazioni positive, ma per ora l’ultima parola spetta a un utente che ha scritto: «Per favore, usate persone vere con una vera passione».

absidale, ecco altra luce piombare zenitale da un foro-ottagono e diffondersi propizia. L’altro giorno invece, al mattino, con cielo grigio, non era il massimo e un visitatore cercava invano, tastando le mura, l’interruttore. Stupisce, sulla sinistra, l’affresco-trompe-l’oeil con la caduta di Simon Mago come se fosse caduto dal buco ottagonale allo zenit della cupola e i moti di spirito leonardeschi degli spettatori. Afferro l’utilizzo, qua e là, di un curioso turchino lattementa. Però è alzando gli occhi nel vortice absidale della gloria angelica, la vera emozione, lo smarrimento totale, il rapimento alieno. La prima piccola percezione corre, con uno sbalzo temporale, al miglior Severini vorticoso di La danse del pan-pan al Monico. Un’assonanza meno futurista ci porta, sempre con naso all’insù, al Concerto degli angeli (1535) di Gaudenzio Ferrari affrescato sulla cupola
Mattia Croci-Torti, prodotto doc del Mendrisiotto, ha acceso il cuore dei luganesi ed è stato chiamato a porgere il saluto ufficiale di Capodanno alla popolazione della Città. Luca Gianinazzi, luganese nel DNA, è stato costretto a fare fagotto e a lasciare sui due piedi il suo posto di lavoro alla Cornèr Arena. Un destino forse già scritto. Figlio di due società sportive, FCL e HCL, che stanno sovvertendo una tendenza pluridecennale. Quando, negli anni Sessanta e nei primi anni Settanta, lo stadio di Cornaredo era molto spesso stracolmo di tifosi bianconeri esultanti, gli hockeisti che solcavano il ghiaccio della Resega erano poco più che un onesto e volenteroso gruppo di semiprofessionisti appassionati. Un bel giorno, un abile e ricco imprenditore locale, ebbe la felice intuizione di investire in questo gruppo. Mise sul ghiaccio il suo denaro, le sue idee, le sue visioni e la sua passione. Geo Mante-
gazza, scomparso lo scorso 10 ottobre all’età di 96 anni, trasformò una società sportiva fino a quel momento ancorata ad ambizioni modeste, in una corazzata capace di dominare la scena per un paio di decenni. Furono anni in cui i cugini del calcio vissero una parabola discendente, dalla quale è stato molto difficile svincolarsi. Ora, l’inversione di tendenza sembra proprio essere in atto. Il FCL gioca bene, piace, vince, tiene alto il nome della Città anche in campo europeo. Angelo Renzetti ha avuto pazienza e intuito. Ha traghettato i colori bianconeri verso un approdo sicuro, verso un nuovo «Patron» che si è dotato di una struttura solida, professionale, abile nella pianificazione del lavoro e dei sogni. Viceversa, l’HCL sta vivendo una parabola involutiva. L’affluenza di spettatori alla Cornèr Arena è in costante ribasso, mentre a Cornaredo sta cominciando a risalire lentamente, con l’auspicio da parte
della Società che possa trasformarsi in un’ondata di partecipazione e di entusiasmo nel nuovo Stadio che dovrebbe aprire i battenti nella stagione 20262027. Le tre finali di Coppa Svizzera in cui il «Crus» e i suoi ragazzi sono riusciti a portare a Berna una media di 11mila sostenitori vorranno pur dire qualcosa. Non sta a me tessere le lodi di Mattia, che pochi giorni fa ha prolungato fino al 2028 il contratto che lo lega ai colori bianconeri, e neppure stigmatizzare i presunti demeriti di Luca. Dall’esterno manca uno sguardo oggettivo. Non posso affermare se la crisi di gioco e di risultati dell’HCL sia da imputare all’Head Coach, a tutto lo Staff, al DS che non ha saputo allestire un organico all’altezza, all’atteggiamento della squadra stessa, alla dirigenza che non ha supportato in modo adeguato chi quotidianamente scende sul ghiaccio.
L’HCL, tra il 2006 e il 2022, ha bru-
del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno. Non c’è gara però con il turbinare d’ali e drappi qui, un affollamento da stadio, galleggiante su una base di nubi plumbee e manieriste. Colgo ancora, vagando in giro con gli occhi, quel verde turchino lattementa che qui sembra oltremare o ogni tanto «verde di berildo» come lo indica Lomazzo stesso nella parte prodigiosa sui colori del Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura (1584) che potrebbe forse riferirsi ai riflessi minerali e preziosi del berillo. Attutite, entrano, a ravvivare il mio girotondo con sguardo in su, le sonorità del traffico che scorre su via Fatebenefratelli. Anche lì a fianco, un tempo, c’era un naviglio: dunque questa, dove nel 1874 si esegue per la prima volta la Messa da requiem di Verdi e Mozart quattordicenne un secolo prima suona l’organo, era quasi una chie-
sa acquea. Tenendo a bada il capogiro, catturo, nell’affresco ciclonico, un angelo a mani giunte: non in preghiera ma per spiccare un tuffo a testa, nel vuoto. Dal Lomazzo, il cui Autoritratto in veste di abate dell’Accademia della valle di Blenio (1568) – combriccola antiborromaica di artisti ispirata dai facchini bleniesi emigrati a Milano – potete vedere qui vicino, alla pinacoteca di Brera, dove sembra quasi un homus selvaticus alpino o uno spirito dei boschi con pelliccia di volpe, cappello bacchico da cui spiovono pampini e viticci, tirso avvolto da edera, sorriso elfico-beffardo, ci si può aspettare di tutto. Figura fuori dal comune per la sua epoca, dimenticato per secoli e riscoperto poi da Erwin Panofsky in Idea (1924), ispira infatti, attraverso i suoi Rabisch (1589), poesie-arabeschi in dialetto facchinesco ticinese, a Lainate, lo straordinario ninfeo.

ciato 18 allenatori, fra i quali anche alcuni gioielli di famiglia come Mats Waltin e Kent Johansson, trascinatori del Grande Lugano degli anni Ottanta. Poi, di botto, liquidato il ruvido e forse scomodo Chris McSorley, la società presieduta da Vicky Mantegazza, ha optato per un progetto locale, a km zero. Nell’ottobre del 2022, ha spiazzato tutti annunciando che la squadra sarebbe stata affidata a Luca Gianinazzi. Aveva solo 29 anni, un paio di partite da giocatore in Swiss League con i Ticino Rockets. Da tecnico aveva guidato gli Under 17 e gli Under 20 del Lugano. L’obiettivo era probabilmente anche quello di ridare una connotazione più locale, più luganese, alla squadra, senza tuttavia perdere di vista le ambizioni del club blasonato forgiato dal padre. L’avventura del «Giana» è durata circa tre anni. Tra picchi che lasciavano intravedere il potenziale del gruppo, e cadute decisamen-
te demoralizzanti. Si è a lungo avuto l’impressione che il Consiglio di Amministrazione volesse insistere con la soluzione casereccia. Avrebbe potuto essere una rivoluzione epocale. Probabilmente, il disorientamento e la disaffezione dei tifosi, sia sulle tribune, sia nei vari blog, ha indotto la dirigenza a dire stop. Da pochi giorni, alla transenna c’è Uwe Krupp, un colosso di fatto e di fama. Un uomo con un pedigree da paura, sia come giocatore, sia come allenatore. Spetterà a lui invertire la tendenza e riaccendere il cuore dei tifosi più tiepidi e soprattutto più delusi. Il suo sarà un compito molto delicato. Dovesse fallire – e se nel contempo i cugini del FCL si cucissero al petto un ulteriore trofeo, magari due (perché no?) – l’operazione sorpasso sarebbe compiuta. Nel cuore di chi ama le squadre luganesi immagino ci sia posto per tutte. Nel portafogli, coi tempi che corrono, solo per una, quella che vince.




28. 1 – 3. 2. 2025



1.25 invece di 1.80 Carne di manzo macinata M-Classic Germania, per 100 g, in self-service 30%
33%


9.95
invece di 15.–
a partire da 3 pezzi 40%

Tutti i tipi di pasta e di sugo, Agnesi per es. pennette rigate, 500 g, 1.50 invece di 2.50, (100 g = 0.30)

a partire da 2 pezzi 30%
Capsule Café Royal e Delizio e sfere di caffè CoffeeB In confezioni grandi, per es. Café Royal Lungo, 36 pezzi, 10.47 invece di 14.95, (100 g = 5.51), offerta valida dal 30.1 al 2.2.2025
Fino a esaurimento dello stock. Da tutte le offerte sono esclusi gli articoli M-Budget e quelli già ridotti.
a partire da 2 pezzi 30%
Filetti di salmone con pelle M-Classic, ASC d'allevamento, Norvegia, 4 pezzi, 500 g, in self-service, (100 g = 1.99)

Tutto l'assortimento di sottaceti e di antipasti, Condy per es. cetriolini, 290 g, 1.82 invece di 2.60, (100 g = 0.63)

2.95 invece di 4.95
Bratwurst di vitello IP-SUISSE 2 pezzi, 280 g, in self-service, (100 g = 1.05), offerta valida dal 30.1 al 2.2.2025 40%
Avocado Migros Bio Spagna, il pezzo 31%


1.20 invece di 1.75


40%

Tutto l'assortimento di calzetteria da donna e da uomo (articoli Hit esclusi), per es. collant da donna transparent mat nude Essentials, il pezzo, 5.97 invece di 9.95
Validi gio. – dom.
imbattibili weekend del Prezzi

Tutti i tipi di toast American Favorites, IP-SUISSE per es. XL, 730 g, 2.38 invece di 3.40, (100 g = 0.33), offerta valida dal 30.1 al 2.2.2025 30%








1.25
31% 28. 1 – 3. 2. 2025


invece di 1.80 Carne di manzo macinata M-Classic Germania, per 100 g, in self-service 30%




a partire da 3 pezzi 40%









Tutti i tipi di pasta e di sugo, Agnesi per es. pennette rigate, 500 g, 1.50 invece di 2.50, (100 g = 0.30)

9.95
invece di 15.–

Filetti di salmone con pelle M-Classic, ASC d'allevamento, Norvegia, 4 pezzi, 500 g, in self-service, (100 g = 1.99)



1.20 invece di 1.75


Avocado Migros Bio Spagna, il pezzo


Tutto l'assortimento di sottaceti e di antipasti, Condy per es. cetriolini, 290 g, 1.82 invece di 2.60, (100 g = 0.63) a partire da 2 pezzi






Tutto l'assortimento di calzetteria da donna e da uomo (articoli Hit esclusi), per es. collant da donna transparent mat nude Essentials, il pezzo, 5.97 invece di 9.95 40%



Prezzo basso

10.50

5.95

3.95

1.85

2.30
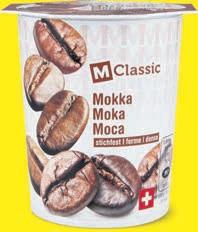

2.10

2.10
Offriamo già 500 prodotti a prezzo discount: da M-Budget alla qualità bio. I prezzi bassi si trovano su tutto l’assortimento e includono i prodotti preferiti dalla nostra clientela, rendendo gli acquisti sensibilmente più convenienti per tutti. Ma non è tutto: stiamo già lavorando per offrire ulteriori prezzi bassi.

4.50
Filetti di salmone con pelle Migros Bio d'allevamento, Irlanda, per 100 g, in self-service

2.–
Sminuzzato di pollo M-Classic
Svizzera, per 100 g, in self-service

3.95
Nuggets di pollo M-Classic
Brasile, 250 g, in self-service, (100 g = 1.58)

1.80 Cervelas M-Classic
Svizzera, 2 pezzi, 200 g, in self-service, (100 g = 0.90)

–.95

1.05
Sale da cucina Jura Sel iodato e fluorato, 1 kg, (100 g = 0.11)
Concentrato di pomodoro M-Classic 200 g, (100 g = 0.48)

1.50
Red Bull Energy Drink 250 ml, (100 ml = 0.60)

3.– Bastoncini di pesce impanati Pelican, MSC prodotto surgelato, 450 g, (100 g = 0.67)

1.50
Sfoglie per lasagne M-Classic
500 g, (100 g = 0.30)

6.30
Milette Maxi 4, FSC® 9–14 kg, 42 pezzi, (1 pz. = 0.15)









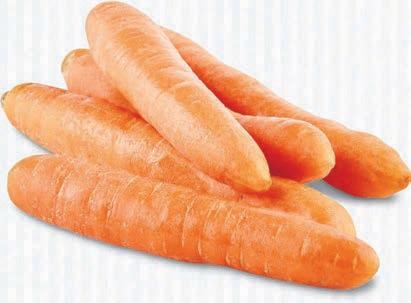











2.10

Italia Svizzera, al kg





5.90

Bacche miste Marocco/Spagna, 2 x 250 g, (100 g = 1.18)

2.95 invece di 3.95 Extra Clementine foglia Spagna, al kg 25%

2.20 invece di 2.80 Arance bionde Spagne, rete da 2 kg, (1 kg = 1.10) 21%
a partire da 2 pezzi 20%

Tutto l'assortimento Farmer's Best prodotto surgelato, per es. spinaci tritati, IP-SUISSE, 800 g, 3.12 invece di 3.90, (100 g = 0.39)

Tutti i minestroni (escl. bio) Ticino, al kg, per es. Minestrone nostrano, Ticino, 5.95 invece di 7.80 23%


































































Raclette al naturale Raccard, IP-SUISSE in blocco maxi o a fette in conf. da 2, per es. in blocco, per 100 g, 1.80 invece di 2.25, prodotto confezionato 20%

2.40 invece di 2.85 Sole del Ticino per 100 g, prodotto confezionato 15%

29.25 invece di 36.60
Fondue Moitié-Moitié Champion AOP 2 x 600 g, (100 g = 2.44)

2.05 invece di 2.60 Fontal Italiano per 100 g, prodotto confezionato 21%

Tutto il Grana Padano Da Emilio per es. grattugiato, 120 g, 2.42 invece di 2.85, (100 g = 2.02) 15%
Naturalmente senza lattosio

2.20 invece di 2.80
Formaggella della Leventina per 100 g, al banco 21%

1.36 invece di 1.70 Emmentaler dolce circa 250 g, per 100 g, prodotto confezionato 20%



Leerdammer a fette
Original o Lightlife, in conf. speciale, per es. Original, 350 g, 5.30 invece di 6.65, (100 g = 1.51) 20%

conf. da 4 1.30 di riduzione
14.50 invece di 15.80 Il Burro 4 x 250 g, (100 g = 1.45)
da 2 20%

Mozzarella e mozzarella mini, Galbani in confezioni multiple, per es. mini, 2 x 150 g, 5.50 invece di 6.90, (100 g = 1.83)
da 4 20%

Yogurt LC1 Immunity Nestlé disponibili in diverse varietà, per es. arancia sanguigna e zenzero, 4 x 150 g, 3.50 invece di 4.40, (100 g = 0.58)
conf. da 2 15%

5.95 invece di 7.–
Panna intera UHT Valflora, IP-SUISSE 2 x 500 ml, (100 ml = 0.60)
a partire da 2 pezzi 20%

Tutti i drink this is food Yfood per es. Classic Choco, 500 ml, 3.96 invece di 4.95, (100 ml = 0.79)
Pratici quando non hai tempo di cucinare
–.20 di riduzione

Snack al latte refrigerati Kinder Fetta al Latte, Pinguì, Choco fresh e Maxi King (articoli singoli esclusi), per es. Fetta al Latte, 5 pezzi, 140 g, 1.50 invece di 1.70, (100 g = 1.07)
Pane e prodotti da forno












3.50 Pane campagnolo integrale IP-SUISSE
400 g, (100 g = 0.88)


Il nostro pane della settimana, con una nota aromatica di cereali, si mantiene fresco a lungo. Grazie alla sua forma è la scelta perfetta per creare panini proprio












Tutte le paste in blocco e già spianate, Anna's Best per es. pasta per pizza, spianata, rettangolare, 580 g, 4.– invece di 5.–, (100 g = 0.69)





Tutte le coppette ai vermicelles per es. 95 g, 2.– invece di 2.50, (100 g = 2.11) 20%



Bastoncini alle nocciole e fagottini alle pere, Petit Bonheur o fagottini di spelta alle pere Migros Bio per es. bastoncini alle nocciole Petit Bonheur, 4 pezzi, 220 g, 2.72 invece di 3.40, prodotto confezionato, (100 g = 1.24) 20%

3.50 Oat Cookies Petit Bonheur 230 g, prodotto confezionato, (100 g = 1.52)

5.95

da 2
Pasta Anna's Best con ripieno, refrigerata tortellini tricolore al basilico o tortelloni ricotta & spinaci, per es. tricolore al basilico, 2 x 500 g, 6.95 invece di 11.60, (100 g = 0.70)

Pizze Anna's Best, refrigerate al prosciutto o margherita, per es. al prosciutto, 4 x 400 g, 14.95 invece di 21.60, (100 g = 0.93) conf. da 4 30%

Bonheur 450 g, prodotto confezionato, (100 g = 1.32) 20x CUMULUS Novità 7.90 invece di 9.90
ai mirtilli
scaloppine al pepe e al limone o cordon vert, per es. scaloppine, 2 x 220 g, (100 g = 1.80)


Senza lische e senza pelle

17.75 invece di 25.50





Marinare il tonno con olio d'oliva, salsa di soia, succo di limone e pepe. Lasciar riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Quindi rosolare in una padella molto calda e leggermente unta per circa 2 minuti su ogni lato fino a formare una crosticina. Per un sapore superlativo, il cuore del trancio deve rimanere leggermente crudo e quindi bello tenero. Servire con verdure croccanti.




Consiglio: perfetti per il Mississippi cake, ricetta su migusto.ch













Kägi Fret
6 x 50 g o 2 x 128 g, per es. 6 x 50 g, 6.30 invece di 7.90, (100 g = 2.10)
cioccolato svizzero




9.95
invece di 14.41 Branches Frey Midi Milk in conf. speciale, 650 g, (100 g = 1.53) 30%

3.60
al burro e cioccolato
= 2.77)


10.25
di 14.70
di cioccolato Frey
Noir Special 72% o al latte finissimo, 6 x 100 g, (100 g = 1.71)
















Involtini primavera J. Bank's prodotto surgelato, con pollo o verdure, per es. con pollo, 2 x 6 pezzi, 740 g, 9.80 invece di 14.–, (100 g = 1.32)

Funghi misti o funghi prataioli, M-Classic per es. funghi misti, 3 x 200 g, 9.80 invece di 12.30, (100 g = 1.63) conf. da 3 20%

10.80 invece di 13.50
Snack Asia con salsa sweet chili, ASC involtini primavera gamberetti e verdure, gamberetti impanati e Money Bags, 640 g, (100 g = 1.69) 20%

Ripieno per vol-au-vent M-Classic con funghi prataioli e carne o Forestière, per es. con funghi prataioli e carne, 3 x 500 g, 11.50 invece di 14.40, (100 g = 0.77)

Kellogg's disponibile in diverse varietà, per es. Tresor Choco Nut, 2 x 620 g, 11.10 invece di 13.90, (100 g = 0.90)

Tutto l'assortimento Ponti e Giacobazzi per es. aceto balsamico di Modena Ponti, 500 ml, 3.36 invece di 4.80, (100 ml = 0.67)
Spuntini per chi ama l'attività fisica


Tutte le barrette singole sport e lifestyle (prodotti Alnatura, Farmer e Ovo esclusi), per es. Protein Bar Crispy Cookie Chiefs, 55 g, 2.28 invece di 3.25, (10 g = 0.41)



Listerine

denti
5 volte più efficace del filo interdentale



La marca propria Molfina offre un'ampia scelta di articoli per l'igiene femminile, dai salvaslip agli assorbenti, dai tamponi ai prodotti per le parti intime, che convincono per la buona qualità e il prezzo conveniente.














Questa macchina da caffè è formidabile: oltre a tutti i vantaggi di una macchina per caffè in capsule convenzionale, cioè facilità d'uso, quantità di caffè per tazza programmabile, riscaldamento rapido e consumo energetico minimo, vanta capsule smaltibili con il compostaggio domestico che non generano rifiuti. E dal 30.1 al 2.2 le sfere di caffè CoffeeB sono pure in azione.

da












2.95

Bratwurst di vitello IP-SUISSE
2 pezzi, 280 g, in self-service, (100 g = 1.05), offerta valida dal 30.1 al 2.2.2025
Questa settimana sono in azione anche le macchine per il caffè CoffeeB