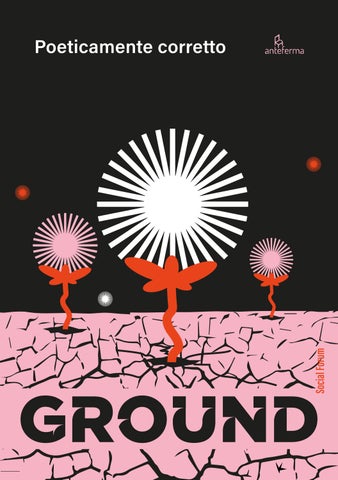Poeticamente corretto
Colophon
GROUND
Poeticamente corretto
ISBN: 979-12-5953-172-8 (cartaceo).
ISBN: 979-12-5953-066-0 (digitale).
citazione: Michela Pace (a cura di), GROUND. Poeticamente corretto. Anteferma Edizioni, Conegliano, 2025.
comitato scientifico: gli autori e le autrici dei saggi sono parte del comitato scientifico di GROUND Social Forum 2025. Il comitato scientifico è composto da: Stefano Balbi, Maria Berlato, Mattia Bertin, Mauro Bossi, Giorgio Brizio, Morena Cadaldini, Enrico Coniglio, Francesca Costenaro, Jacopo Dalai, Silvia Dalla Rosa, Marta De Marchi, Barbara Di Tommaso, Adele Donanzan, Elena Ferrarese, Giovanna Ferretti, Gianfranco Franz, Alessia Franzese, Roberta Fusari, Jacopo Galli, Chiara Grigoletto, Anna Lambertini, Sara Lando, Marco Lo Giudice, Francesco Malavolta, Luca Mazzarella, Marie Moise, Stefano Munarin, Riccardo Nardelli, Michela Pace, Andrea Pase, Michele Patuzzi, Luca Pazzaglia, Ennio Ripamonti, Enrico Remonato, Francesco Scarel, Agnese Sonato, Cinzia Tasca, Enrico Zarpellon.
fotografie: Francesco Malavolta.
grafica e illustrazioni: Andrea Koes Crestani.
editore: Anteferma Edizioni, Conegliano.
prima edizione: settembre 2025.
Questo libro è l’esito di GROUND Social Forum, organizzato da Rete Pictor e Università Iuav di Venezia, sostenuto da Fondazione CariVerona all’interno del progetto ClimHub e finanziato con fondi del bando CariVerona Habitat 2022.
copyright
Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale –No opere derivate 4.0 Internazionale
Indice
GROUND è abitare la terra
UN MANIFESTO
Primo strato
Michela Pace
Convivio: un banchetto di sguardi, parole, metafore e relazioni
Luca Pazzaglia
Popoli in movimento
fotografie di Francesco Malavolta
Speranza
Mauro Bossi
Come bucato, al vento
Marco Lo Giudice
L’arte di problematizzare il mondo.
Sulle spalle di Paulo Freire
Ennio Ripamonti
Potere è potare
Mattia Bertin
Smielatura n.1
Riccardo Nardelli
Le voci altre
Enrico Zarpellon
Il suono delle aree a margine
Enrico Coniglio
La grande zolla
Michela Pace
GROUND e il Quarto spazio: un incontro tra arte, scienza e società
Francesco Scarel
Stare con i piedi per terra
Alessia Franzese
Elogio al tempo perso
Sara Lando
Smielatura n.2
Riccardo Nardelli
Turning Ground
Andrea Pase
All’intersezione tra oppressione e privilegio
Marie Moise
UnLimiteDNA
Enrico Remonato
Agio e morte
Jacopo Dalai
Paesaggi di resistenza
Anna Lambertini
Smielatura n.3
Riccardo Nardelli
Di sonore relazioni, libere espressioni e arricchenti fragilità
Elena Ferrarese
Distanza e metamorfosi
Gianfranco Franz e Roberta Fusari
La violenza degli argini
Silvia Dalla Rosa
Atlanti/de
Marta De Marchi
Green man walking
Michele Patuzzi
Scienza aperta e tecnologia democratica per un futuro sostenibile
Stefano Balbi
Rivoluzione quantica e comunità: gli impatti sconosciuti del progresso
Luca Mazzarella
Chat/doc?
Morena Cadaldini
Il paradosso del rispetto: oltre i limiti del politicamente corretto nel dialogo sulla disabilità
Adele Donanzan
Smielatura n.4
Riccardo Nardelli
Tutta colpa dell’architetto.
Riscoprire l’evoluzione per errori
Jacopo Galli
Errare per natura
Agnese Sonato
Riscoprire e progettare le reti minori come “labirinto di libertà multispecie”
Stefano Munarin
Le reti di prossimità nella disabilità: un’ambizione possibile?
Maria Berlato e Cinzia Tasca
Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore
Giovanna Ferretti
Notizie sugli autori e sulle autrici
GROUND è abitare la terra
GROUND è stare al livello del suolo, vivificare lo spazio aperto come piazza, superare i confini, i cancelli, le esclusioni. GROUND è brulicare di esistenze diverse che si mescolano, si contaminano, si organizzano. GROUND è moltitudini che operano individualmente e che si ricompongono in uno spazio comune, paritetico. GROUND è mettere le basi, generare un’idea, è ispirare.
È un atto fondativo, centro di discussione, di proiezione, di orientamento. GROUND è una condizione comune che ci trattiene e ci spinge a immaginare, ad agire, a stare nel cambiamento. La necessità, sempre più urgente, di considerare la conversione ecologica, economica e sociale come parte di una nuova idea di terreno alimenta gli spunti di soggetti collettivi che operano per un cambiamento nel proprio territorio, nel tentativo di ridurre i divari e le esclusioni, attraverso e nello spazio pubblico, dal pianeta alla strada, per restituire usi e orientamenti sempre più ecosistemici.
Primo strato
Ogni edizione di GROUND è fatta di molte voci. Voci che raccontano esperienze, avanzano ipotesi e domande, ma, soprattutto, si sedimentano le une sulle altre, come strati geologici che, nel tempo, trasformano un terreno in qualcosa di più profondo, denso, fertile.
La seconda edizione del Social Forum, che nel 2025 abita e anima nuovamente Villa Angaran San Giuseppe a Bassano del Grappa, nasce infatti da questa stratificazione. Tra le pieghe del tempo e della terra trova spazio il Convivio, un esperimento di riflessione condivisa avviato nel 2024 tra alcuni membri della cabina di regia e del comitato scientifico. Il Convivio si è svolto il 19 e 20 ottobre 2024 e ha rappresentato una tappa fondamentale nella costruzione collettiva di GROUND 2025. Non un convegno, non una call, ma un invito alla partecipazione profonda, un incontro attorno a un tavolo comune. Un tempo lento, articolato in quattro sessioni (Arnia, Sciame, Prato, Miele), che ha messo in circolo pensieri e pratiche, a partire da esperienze molto diverse tra loro, ma unite da un desiderio condiviso: interrogare il presente senza cercare risposte uniche, produrre orientamenti senza chiudere i significati, accettare il rischio della complessità.
L’immaginario scelto per accompagnare il Convivio è stato quello dell’alveare. Come le api, che costruiscono
collettivamente, visitano territori, portano nutrimento e generano relazioni invisibili ma vitali, così le persone invitate al Convivio sono state chiamate a contribuire con uno sguardo, un’intuizione, una riflessione che potesse metterci in discussione e spingerci oltre. «Attorno a quel tavolo si sono sedute una neurologa, un geografo, un architetto, un professore, una fotografa, formatori, cooperatori e educatori. Non eravamo lì per i nostri titoli, ma per il nostro sguardo sul mondo» racconta Luca Pazzaglia.
Ogni sessione ha previsto un momento di smielatura, in cui un “apicoltore” ha avuto il compito di raccogliere, selezionare, restituire parole chiave, immagini, intuizioni. Non era una sintesi, ma una tessitura che ha generato connessioni nuove e inattese.
Quello che segue è l’esito corale di questo processo: una raccolta di saggi scritti da 33 membri del comitato scientifico di GROUND, che hanno scelto di reagire alle sollecitazioni emerse durante il Convivio, ciascuno secondo la propria prospettiva, competenza e sensibilità. Ai saggi si aggiungono le smielature nella propria forma originale: restituzioni poetiche, porose, mai definitive. A partire dai temi condivisi — da multispecie e dominio a salvaguardia del dissenso, da istituzione e destituzione a evoluzione per errori — il volume compone una costellazione di pensieri che intende a essere un ulteriore strato di riflessione.
I temi di GROUND 2025, esito del Convivio e strato di riflessione condiviso, includono:
Multispecie e dominio / Diritto alla distanza / Interdipendenza inquieta / Evoluzione per errori / Agio e morte / Fare quanto basta, con quello che resta / Legami deboli / Positività tossica / Compensazione del corpo / Eretico, erotico, errante / Fragilità e libertà / Istituzione e destituzione / Violenza degli argini / Equilibrio e caduta / Salute è plurale / Metamorfosi e manutenzioni / Salvaguardia del dissenso / Disfunzione e concretezza
LUCA PAZZAGLIA
Convivio: un banchetto di sguardi, parole, metafore e relazioni
Ma che cos’è un Convivio?
Ricevo una chiamata dagli amici di Bassano del Grappa: «Stiamo organizzando un incontro tra persone con provenienze, formazione e professionalità diverse, i cui pensieri e pratiche si sono intrecciate con noi. Vi chiediamo di portarci riflessioni dal vostro specifico sguardo sul mondo. Il vostro contributo è totalmente libero, ma vi chiediamo di portare il suggerimento di un prodotto culturale (libro, musica, serie tv, film, videogame, arte in genere). L’incontro si chiama Convivio e sarà organizzato in quattro sessioni: Arnia, Sciame, Prato e Miele. Ci sarà anche un “apicoltore” che si occuperà della smielatura di quello che emergerà dal confronto. Tu farai parte della sessione Sciame».
Mentirei se dicessi che a fine telefonata avevo compreso precisamente la natura di un simile invito. Tuttavia, non ho esitato ad accettare la proposta. La fiducia negli amici di Bassano, il piacere di ricevere un invito in cui mi venisse chiesto semplicemente di
portare il mio sguardo, hanno reso facile la mia decisione. Inoltre, le parole incontri, sentieri, intrecci, differenti saperi, usate per descrivermi le due giornate, hanno da subito suscitato in me un riverbero familiare e piacevole.
Ma che cos’è un Convivio?
Dante Alighieri nei primi anni dell’esilio, tra il 1304 e il 1307, ha realizzato un saggio con questo titolo dove raccontava di un banchetto in cui offriva 14 vivande (le canzoni) e il pane (il commento) per nutrirsi. Chiunque sia disposto a sedersi a tavola, a condividere, a imparare, è invitato. Il Convivio è un atto di comunità, di condivisione.
Quali erano la vivanda e il pane che volevo condividere?
Sulla mia scrivania c’era la poesia Scrivere un curriculum di Wisława Szymborska.
Cos’è necessario?
È necessario scrivere una domanda, e alla domanda allegare il curriculum. A prescindere da quanto si è vissuto il curriculum dovrebbe essere breve.
È d’obbligo concisione e selezione dei fatti.
Cambiare paesaggi in indirizzi e ricordi incerti in date fisse. Di tutti gli amori basta quello coniugale, e dei bambini solo quelli nati.
Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu. I viaggi solo se all’estero.
L’appartenenza a un che, ma senza perché. Onorificenze senza motivazione.
Scrivi come se non parlassi mai con te stesso e ti evitassi.
Sorvola su cani, gatti e uccelli, cianfrusaglie del passato, amici e sogni.
Meglio il prezzo che il valore e il titolo che il contenuto.
Meglio il numero di scarpa, che non dove va colui per cui ti scambiano.
Aggiungi una foto con l’orecchio scoperto.
È la sua forma che conta, non ciò che sente.
Cosa si sente?
Il fragore delle macchine che tritano la carta.
Questa poesia contiene ed esprime meravigliosamente le riflessioni e le sensazioni che mi accompagnano negli ultimi anni.
È quello che voglio condividere!
Mi occupo da sempre di educazione e servizi dedicati alle persone con disabilità. Questa attività è il mio lavoro, ma è qualcosa di più, è sempre stata la mia possibilità di osservare l’umano. Occuparsi di educazione e, nello specifico, di educazione delle persone con disabilità è un’avventura non solo professionale, ma anche personale: la relazione educativa non può essere trattata solo in modo teorico, non ci si può nascondere dietro ai manuali, è un sapere relazionale, uno scambio che si costruisce attraversando gli incontri con tutta la nostra essenza. La propria umanità che incontra quella degli altri.
Vivere la relazione come veicolo principale della responsabilità educativa è impegnativo, ma è anche una grande occasione che costringe a una continua manutenzione di sé stessi. Ma c’è di più, queste dinamiche relazionali sono immerse in un contesto sociale e comunitario. La comunità è il luogo in cui si realizzano i percorsi di inclusione e le identità, in cui agisce la Vita.
Realizzare progetti inclusivi significa prendersi cura di questo terreno, nutrirlo, proteggerlo. La nostra quotidianità, in gran parte, è vissuta in società fatte di “curriculum”, ci muoviamo tra ruoli precisi, incastriamo pezzi di noi nei contesti giusti, viviamo luoghi definiti dalla loro funzione. La specializzazione moderna ci ha convinti che questa frammentazione sia necessaria, efficiente. Ha reso gestibile la complessità umana tagliandola a fette.
Ma la Vita è plurale, è fatta di contraddizioni, di corpi che si muovono, di relazioni che si intrecciano in modi imprevedibili. Eppure, gli spazi in cui possiamo essere interi stanno scomparendo. I luoghi digitali creano bolle, ci separano dalla fisicità, dal contatto vero, dalla multimedialità del nostro corpo. La biodiversità delle relazioni si impoverisce. E questo ci rende fragili.
Per le persone con disabilità tutto questo può essere amplificato. Hanno già percorsi più tortuosi verso l’identità e l’appartenenza.
Se ricevono supporto solo attraverso uno sguardo tecnico, specialistico – quello che vede la diagnosi ma non la persona, la patologia ma non i desideri, le paure, i sogni – saranno guardati, ma non visti. E restare invisibili è la peggiore delle solitudini. Ognuno di noi ha bisogno di essere visto e pensato per poter diventare.
Servono progetti, servizi e educatori capaci di vedere l’intera persona. Professionisti che sappiano creare legami anche con il territorio, trasformandosi in “incubatori di comunità”. Non basta il linguaggio degli specialisti: serve una lingua che respiri, che dia spazio e forma alla vita intera. Una lingua in cui coabitare, che faccia posto all’interezza di ciascuno.
Anzi, non serve un linguaggio, ma tutti i linguaggi necessari. Poesia compresa!
Il Convivio di Bassano è stato esattamente questo: una tavola imbandita di pensieri diversi, uno spazio dove nutrirsi di idee, storie, esperienze vive. Per due giorni, abbiamo respirato insieme. La sapienza è fiorita dall’incontro, nella tensione tra il parlare e l’ascoltare, tra l’essere e il divenire.
Attorno a quel tavolo si sono sedute una neurologa, un geografo, un architetto, un professore, una fotografa, formatori, cooperatori ed educatori. Non eravamo lì per i nostri titoli, ma per il nostro sguardo sul mondo. Lo Smielatore ha raccolto i nostri pensieri, li ha intrecciati con metafore che hanno attraversato confini disciplinari; ha creato ponti tra mondi separati, connessioni inattese con un pensiero trasversale e generativo tra l’astratto e il concreto, tra ciò che è familiare e ciò che è complesso.
Ovviamente si è fatto aiutare dalle Api, perché loro sanno quello che noi dimentichiamo: le identità smarrite creano comunità di solitudini.
Popoli in movimento
FRANCESCO MALAVOLTA
La migrazione, il movimento, lo spostamento sono tratti peculiari della natura umana. L’umanità è da sempre in movimento e questo movimento assume tratti tanto più drammatici quanto più si cerca di ostacolarlo, ripiegando su paure e posizioni illogiche e anacronistiche. Poeticamente corretto è creare ponti e non muri. Poeticamente corretto è porgere una mano e non ritrarla. Poeticamente corretto è amare e non odiare. Poeticamente corretto è l’empatia e non l’indifferenza. Per me, poeticamente corretto significa esserci, schierarsi e raccontare attraverso la fotografia, dove gli scatti recano testimonianza dei diritti negati, delle ingiustizie e del loro evolvere, concentrandosi sui loro protagonisti costretti alla fuga. Ogni scatto, un racconto. Ogni racconto, una storia. Ogni storia, un tentativo di salvare la peculiarità della Vita, ritratta sfuggendo alla logica spersonalizzante che presenta le migrazioni come fenomeni “idraulici” e anonimi. Il mio obiettivo è, infatti, rendere omaggio a un’umanità caparbia che, un passo alla volta, guadagna centimetri di libertà.
Poeticamente corretto è stare dalla parte giusta di questo mondo! Quello dei diritti per tutte e tutti.













Lampedusa, Italia. 2013.
L’interruzione
Se non sei arrivato, se non hai oltrepassato il filo spinato né toccato la costa, è perché sei morto.
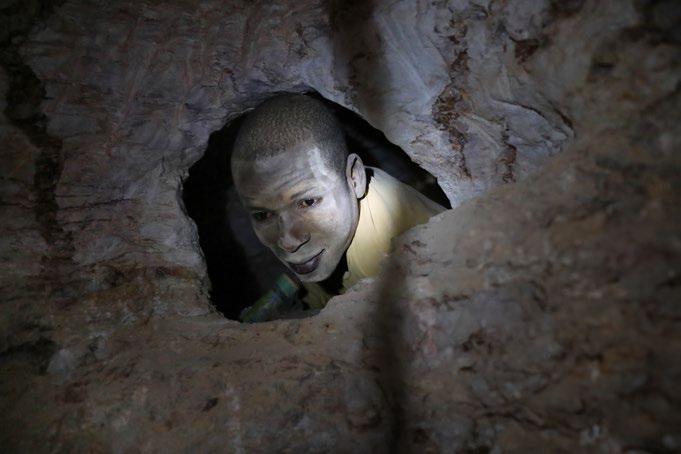
Speranza
La speranza è un modo di stare nel presente, una modalità estremamente concreta, un fare, una prassi
Ho letto Diluvio di Stephen Markley, romanzo epico della crisi climatica. Milletrecento pagine per descrivere il collasso ecologico e sociale degli Stati Uniti, nell’arco di trent’anni, tra eventi meteo estremi e l’avanzata dell’autoritarismo. Vite parallele di personaggi tragici, nel senso proprio e antico del termine: donne e uomini a confronto con un destino soverchiante, in lotta per sopravvivere, ma più ancora per trovare e lasciare ad altri il senso di quella battaglia contro l’impossibile. Attivisti che credono nella mobilitazione non violenta di massa, ricercatori convinti che la scienza possa orientare la politica in un tempo di crisi, ecoterroristi dediti al sabotaggio dell’industria petrolifera, una coppia di tossicodipendenti che non hanno nulla ma hanno un figlio da salvare, un pastore protestante che sfida, in nome del Vangelo, la violenza dei gruppi fondamentalisti pseudocristiani. Al termine della parabola, non potevo evitare di chiedermi: in questa narrazione di una corsa collettiva verso il baratro, dov’è la speranza?
Che cos’è la speranza e che significa sperare?
Una traccia di risposta sembra emergere alla fine del romanzo, quando uno dei protagonisti immagina di dire alla figlia neonata, quando lei sarà cresciuta: «Qualcuno ci ha provato, qualcuno si è battuto come un dannato». In altri termini: qualcuno ha trovato in sé un principio in grado di attivare le sue risorse di resistenza, di tradurre il sentire in agire e di dare un orientamento a tutta la vita. Questo principio ha nomi diversi per ciascuno dei personaggi di Markley, come per ognuno di noi: democrazia, scienza, fede religiosa; ma in ogni caso, è ciò che attiva la speranza: la forza che ci mantiene in contatto con la nostra umanità, proprio quando la storia e le circostanze della vita minacciano di distruggerla. La speranza può manifestarsi con volti diversi, ma questi volti hanno sempre dei tratti in comune.
In primo luogo, più che proiezione sul futuro, la speranza è un modo di stare nel presente, una modalità estremamente concreta, un fare, una prassi che si apprende e si esercita nel tempo. Si impara a sperare, muovendosi giorno per giorno nella direzione desiderata, mettendo in atto le pratiche che già anticipano il mondo che vogliamo. Questo è altro dall’ottimismo ingenuo di chi immagina che tutto andrà per il verso migliore. Chi spera, invece, sa che la realtà non è ancora quella che desidera e che esistono enormi resistenze al cambiamento; tuttavia, riesce ad aprire uno spazio, nel quale ciò che non è ancora qui può rendersi visibile.
Un’altra deriva della speranza è affidarsi all’intervento di un deus ex machina che risolva ogni problema: è la tentazione della deresponsabilizzazione, che gioca a tutto vantaggio degli autocrati di ogni epoca. Al contrario, chi spera sa assumersi la responsabilità del proprio mondo; sperare è un atto di fedeltà al reale e di amore per il presente. Parallelamente, per imparare a sperare bisogna esercitare la memoria: richiamare alla mente i momenti della storia nei quali
persone come noi hanno messo in gioco la propria vita e hanno impresso una svolta agli eventi, perché hanno saputo credere in una realtà diversa da quella che tutti o quasi tutti davano per scontata. Questo ci permette di leggere la nostra storia in una vicenda più grande e di renderci conto che noi viviamo realmente quelle che ieri sono state considerate utopie irrealizzabili. Impariamo a ricordare quando le cose sono andate migliorando, quando siamo stati in grado di compiere i passi necessari per dare vita a una società più umana. Le vittorie ci rammentano che non siamo impotenti e che impegnarsi non è inutile.
Un altro aspetto fondamentale è che nessuno può sperare da solo. La speranza può essere pensata solo all’interno di un tessuto di relazioni, perché deve incarnarsi in situazioni concrete e interpellare persone reali, motivandole a dare il meglio di sé. Nel momento in cui stiamo per affrontare uno sforzo o un sacrificio per il bene comune, proviamo a richiamare alla memoria una persona alla quale potremmo dire: lo sto facendo anche per te. Dobbiamo sempre sperare per qualcuno e l’atto di sperare per lui o lei rivela l’amore che abbiamo nei suoi confronti. Ma dobbiamo anche sperare in qualcuno. Se siamo in grado di stabilire legami basati sulla fiducia, il cammino della speranza è in piano. Spesso, infatti, è proprio il senso di isolamento che ci porta sconforto, quando abbiamo l’impressione di essere da soli a desiderare un certo cambiamento. La speranza ha un peso che nessuno può portare da solo; è necessario allora che questo peso sia condiviso, poi accade l’inatteso: il peso diventa leggero, la solitudine diventa comunità, il futuro si apre. «Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero» dice Gesù nel Vangelo di Matteo ai discepoli che vogliono seguirlo, aprendo loro il cammino verso una speranza tale da superare ogni morte.
Cammina più leggero chi ha imparato a sperare, cioè a volere bene al mondo e ad accogliere con serenità la propria quota di responsabilità del presente; chi ha trasformato l’ansia del carico di lavoro necessario per trasformare il presente nella felicità di poterlo condividere con altri.
Come bucato, al vento
I tempi son quel che sono, e non abbiamo molti strumenti tra le mani
I tempi son quel che sono, e non abbiamo molti strumenti tra le mani. Lo dico meglio: abbiamo molti strumenti tra le mani, non ne abbiamo mai avuti così tanti, la tecnica non è mai stata così tanto politica, eppure non ci sembra di averli scelti (non più, almeno) o comunque non sappiamo bene cosa farcene. Proprio ora, proprio qui, in quest’angolo di mondo in declino, ci mancano i numeri, ci manca un sapere condiviso, forse ci mancano i collettivi. Per le nostre vite – chi più, chi meno, chi zero, – “la forza del collettivo” è una locuzione pallida, stanca, ormai svuotata del suo significato. Di noi, chi l’avrà vissuta, chi l’avrà sentita raccontare, chi l’avrà sentita evocare, chi l’avrà letta nei libri. È forza retrovisiva, si rivolge ad altri tempi, ad altre battaglie, ad altre possibilità. Perché c’erano, una volta: tempi, battaglie, possibilità. Oggi quali sono i collettivi possibili, se siamo disallineati, frangibili, friabili, frantumabili, e se l’unica “forza” possibile sta nella polarizzazione, se l’unico “noi” si contrappone a “loro”, se
non ci sono altri noi, altri voi? Quali collettivi possibili, se la frammentazione è un tratto costitutivo di ogni singolo individuo, se ognuno di questi individui che fanno i “noi” e i “loro” è altroché forte ma psichicamente a pezzi, compresso, accelerato, consumato? Quali individui per quali collettivi, se l’identità occupa il discorso pubblico come una misera chimera mascherata da principio e valore?
Saggezze da un passato vicino ci hanno detto di non cercare risposte e di abitare domande. Ne abbiamo abitate e ne continuiamo ad abitare, di domande come queste. Ma i tempi son quel che sono, e abitare non è più cosa scontata. Le domande costano, come le case – e come le case ci frammentano, ci polarizzano, ci isolano. Le domande le abitiamo, per carità, ma se un tempo potevano essere case spaziose dove potersi ritrovare, riconoscerci, dove fare della domanda un connettore politico di senso, ora sempre di più assomigliano a monolocali a chilometri di distanza l’uno dall’altro. Abbiamo abitato tutti uno di questi monolocali, per quasi tre anni dal 2020 al 2023, senza averci ancora capito granché.
Dopo tanto domandare, non ci restano che le risposte, le risposte in quel che resta. Dei frammenti di quel che siamo, cosa rimane a terra?
Dei collettivi, cosa rimane? Rimane che sono cosa rara e preziosa. I collettivi si compongono temporaneamente, per combinazioni non sempre previste, si sfaldano in tempi brevi, è vero, ma si saldano in tempi lunghi, carsici, in meccanismi controintuitivi per le logiche attuali. I collettivi oggi sperano perché intraprendono, perché fanno, commuovono per l’energia microscopica e caparbia che liberano, ovunque. I collettivi si ritrovano nei luoghi, nelle cose, negli oggetti, di cui le idee sono solo un’eventuale conseguenza. Degli individui, cosa rimane? Che sappiamo fare i conti con noi stessi. Abbiamo capito che se da qualche parte dobbiamo partire, è
meglio partire da qui, da noi, da me, da dove ci troviamo, a tenere insieme i pezzi caduti, appunto. Ci rimangono poteri deboli: il potere del no, del non so, del non sono sicuro; il potere del per sé, del per me, del per il mio bene; il potere del frammento, dell’incompleto, del non ancora, della ricerca. Del “dividuo”, che si può – ancora, continuamente, sempre – dividere e mai individuare. E di quel che resta, che ne facciamo?
Sono resti, sono poca cosa, e perciò lasciamo ad altri le grandi narrazioni, dalle galassie ideologiche dove tutto si tiene e si perde torniamo al micro, all’atomo, all’infinitesimale. Seguiamone le piste, come hanno scritto e detto i greci quasi trenta secoli fa, e troviamo il nostro clinamen, il punto di scontro e incontro; il punto dove i nostri (miei e tuoi) frammenti possono incontrarsi, sintonizzarsi, risuonare, dove lo scontro tra quel che resta di me si può fare grumo con altri, si può agglomerare, addensare, ammassare. Per poi, forse, con il tempo, aggregare in forma collettiva.
Lasciamo ad altri le funi, i moschettoni e i chiodi delle grandi imprese in cordata, del non lasciare nessuno indietro, del salvarsi tutti nonostante tutto. Teniamoci le mollette del bucato, che ci tengono appesi finché una mano, con un po’ di forza di volontà, ci toglie dal filo. Teniamoci questo legame debole, che sa assecondare il vento, che evapora al sole, che non stringe troppo e non costringe nessuno, ma che può essere benedetto in questi tempi in cui volontà e forza sono potenti ansiogeni, in questi tempi che saranno quel che saranno, ma sono ancora nostri.
ENNIO RIPAMONTI
L’arte di problematizzare il mondo. Sulle spalle di Paulo Freire
O
mundo não é, o mundo está sendo1
Il lavoro del pedagogista e filosofo brasiliano Paulo Freire ci invita, a molti anni di distanza, a addentrarci nelle questioni che il concetto di “problema” porta con sé, un’espressione che utilizziamo quotidianamente, sia nella sfera personale che nella vita pubblica, ma il cui significato non possiamo dare per scontato. Per semplicità possiamo parlare di problema in una situazione nella quale un soggetto (individuale o collettivo) avverte una difficoltà e/o una mancanza che è motivo di disagio e insoddisfazione. Così descritti i problemi si presentano come fenomeni relativi e soggettivi, in un duplice senso: a) poiché implicano la presenza di soggettività umane che li qualifichino come tali; b) perché chiamano in causa l’esistenza di molteplici visioni. Detto in altri termini, sono problematiche le situazioni che s’intendono modificare rendendole (quantomeno) accettabili. La lezione di Freire è “problematizzante” nel senso che fa nascere i problemi, soprattutto quando una realtà viene
presentata come “normale” o “naturale”. Non di rado, infatti, il sapere istituzionale veste i panni della spiegazione piuttosto che del problema. Adottare un approccio basato sulla problematização significa recepire il mondo e restituirlo sotto forma di problema, decostruendolo e ricostruendolo in modo da coglierne le contraddizioni, le ingiustizie e le iniquità. Se per alcuni dirigenti di scuole secondarie superiori, per esempio, l’alto tasso di abbandono fra gli studenti del biennio è indice del valore del proprio istituto, per altri costituisce un indicatore di dispersione e di scarsa inclusività della formazione. Nell’Italia della fine degli anni Sessanta, la selezione scolastica era raccontata come “naturale”, una rappresentazione restituita in forma di problema da don Lorenzo Milani e i ragazzi di Barbiana nella celebre Lettera a una professoressa (1967). Pochi anni prima Danilo Dolci, a Partinico, svela le dinamiche mafiose ponendo domande scomode circa l’accesso all’acqua e la sua distribuzione diseguale.
Le situazioni-problema che ci si trova oggi ad affrontare mettono in luce la centralità di due processi sociali quanto mai delicati: il riconoscimento e la solidarietà. Gli studi del filosofo Axel Honneth mostrano la centralità dei fenomeni di “riconoscimento”, cioè del processo attraverso cui un attore sociale prende consapevolezza di sé e viene collocato e apprezzato. Da parte di soggetti deboli e marginali il processo di riconoscimento del punto di vista rispetto a una determinata situazione o problematica chiama in causa dimensioni di senso e di identità ad almeno tre livelli: relazioni primarie, relazioni giuridiche e comunità etica.
Prima ancora della risoluzione (più o meno compiuta) di un certo problema ci misuriamo con la legittimazione di chi lo vive e, in mancanza di ciò, con una spirale di ingiustizia e umiliazione che colpisce l’integrità, i diritti e l’autonomia morale delle persone.
A noi il compito di contestualizzare pensieri e pratiche di problematizzazione in un Paese, il nostro, dai tratti sempre più paradossali, ben colti da Luca Ricolfi nel suo La società signorile di massa (2019): il numero di cittadini che non lavorano ha superato ampiamente il numero di cittadini che lavorano; l’accesso ai consumi opulenti ha raggiunto una larga parte della popolazione; l’economia e la produttività è stagnante da oltre vent’anni.
L’inedito intreccio di questi fattori ha plasmato un tipo di organizzazione sociale fondato su tre elementi chiave: la ricchezza accumulata dai padri, la distruzione sistematica della scuola pubblica e un’infrastruttura economica di stampo paraschiavistico. Ed è così che intravvediamo un’inedita continuità fra i bóias-frias delle periferie brasiliane che migravano (e migrano) da una regione all’altra in cerca di lavoro agricolo e i moderni rider che consegnano cibi a domicilio2 per conto di piattaforme o applicativi web, oltre che fra l’analfabetismo primario strumentale (brasiliano, ma anche italiano) degli anni Cinquanta e Sessanta e l’analfabetismo funzionale contemporaneo, una condizione in cui le persone sono incapaci di usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana e alla fin fine, per comprendere appieno il mondo in cui vivono.
La saldatura fra dominio della tecnica e pervasività delle logiche del mercato è resa evidente dall’enfasi culturale attribuita all’efficienza come valore assoluto, con il rischio, sempre più evidente, di smarrire la dimensione di senso, il motivo ultimo per cui si fanno le cose.
Si tratta quindi, oggi più che mai, di allestire spazi di pensiero libero (e liberatorio), concepire le persone come soggetti pensanti, attivi, partecipi e responsabili. In questo crocevia ritroviamo tutta la potenza della domanda che apre varchi di immaginazione
inediti e di percorsi di ricerca che analizzano molteplici forme di dialogicità basate sul dubbio, l’ipotesi, l’esperienza personale e il confronto comunitario. Anche qui, però, la strada si mostra in salita. Le competenze dialogiche appaiono oggi tutt’altro che in salute. La ricollocazione dei soggetti e dei contenuti dentro i format del linguaggio televisivo e dei social network hanno rattrappito queste competenze, lasciando crescere in maniera ipertrofica la forma del monologo. L’analisi dei problemi prende la forma di messaggi semplificati nei contenuti e impoveriti nella forma che, allo stesso tempo, indulgono in un esasperato antagonismo che congela ed estremizza le posizioni. Ma tutto questo contribuisce ad alzare lo share, aumentare i follower e moltiplicare like e le condivisioni online.
Nella concitazione dei confronti-spettacolo prevale un antagonismo vissuto “colpo su colpo” in cui i soggetti perdono totalmente la loro funzione di analisi, ricerca, sintesi interpretativa e proposta. Niente di nuovo sotto il sole, si potrebbe dire. L’odierna politica spettacolo non fa che rilanciare, in chiave moderna, un approccio che, molti secoli fa, Platone aveva indicato come una minaccia per la democrazia: la retorica; una forma del confronto pubblico poco interessata all’analisi approfondita e razionale dei problemi e tanto meno all’aumento delle conoscenze e delle competenze per affrontarli.
Scopo ultimo della retorica (rhetorikè téchne come arte del dire) è la persuasione dell’interlocutore attraverso un’efficace argomentazione linguistica che fa leva sulle dimensioni emotive. L’abilità del retore è quella di tessere un discorso sul discorso capace di toccare i tasti giusti nell’uditorio, allo scopo di confermare la validità delle proprie tesi. Il primato dell’opinionismo contemporaneo reca con sé, inevitabilmente, un deficit d’interpretazione delle complesse questioni con cui oggi ci
troviamo a misurarci. Secondo Harry Frankfurt, uno dei caratteri salienti dell’opinionismo contemporaneo è l’incessante produzione di bullshits (stronzate), un effetto determinato da una forma di vita culturale in cui le persone sono chiamate a esprimersi su argomenti di cui sanno poco o nulla. Il filosofo americano distingue il “dire stronzate” dal mentire. Se nel caso della menzogna il soggetto fa deliberatamente un’affermazione falsa, con il bullshitter siamo di fronte a una persona sostanzialmente disinteressata alla verità e preoccupata unicamente di impressionare il pubblico. Ed è proprio per questo motivo che, come dice Frankfurt, la stronzata è un nemico della verità più grande della menzogna.
La proliferazione dell’opinionismo alimenta, e nel contempo trae forza, dall’affermarsi di una forma particolare di potere che di recente è stata definita mediocrazia, cioè da figure sociali (nel mondo economico, politico, giornalistico, educativo) più attente ad assecondare il mainstream che a sviluppare capacità critiche e creatività. Si tratta di un insieme di fenomeni tutt’altro che irrilevanti, poiché contribuiscono a diffondere l’idea che è impossibile conoscere davvero le cose e che, di conseguenza, ogni argomentazione intellettuale vale come un’altra, se è persuasiva. I bassi livelli di competenza culturale della popolazione italiana, segnalati da molte indagini internazionali, costituiscono un ulteriore fattore di vulnerabilità.
Se il bersaglio della critica freiriana era spesso il potere della gerarchia, in questo caso ci troviamo disorientati di fronte alla moltiplicazione di forme anonime e impersonali di potere e influenzamento, forme di oppressione 4.0, che non di rado prendono la forma di algoritmi. E se alla domanda di quale fosse la cura per la crisi della democrazia Amartya Sen, premio Nobel per l’economia, rispondeva maggiore democrazia, vien da dire che la migliore cura per la crisi delle nostre capacità dialogiche è
l’intensificazione delle opportunità per praticare il dialogo, dando vita a setting che lo rendono possibile.
1. “Il mondo non è, il mondo sta essendo”, Paulo Freire [T.d.A.].
2. Nonostante la diversità di tempi, luoghi e forme che caratterizzano bóias-frias e rider, in entrambi i casi possiamo facilmente riscontrare una condizione lavorativa fatta di precarietà, sfruttamento, scarsa protezione sindacale e ricattabilità. Due esempi quantomai paradigmatici di working poor, un fenomeno in forte crescita, dove s’intrecciano bassi redditi, incapacità di risparmio e rischio di esclusione sociale.
Potere è potare
Chi decide cosa tenere e cosa cambiare?
Chi decide cosa tenere e cosa cambiare? La modernità ha espanso una colata di cemento e asfalto ovunque sia arrivata, immobilizzando e impermeabilizzando le terre e le colture, e allo stesso modo le teste e le culture. La compressione e il contenimento portano a stati di eccitazione, all’accumulo di energia potenziale. A scala globale il cambiamento climatico è questo: un aumento dell’energia disponibile causa una serie crescente di reazioni violente che rompono l’equilibrio forzoso della stabilità delle reti economico-infrastrutturali. Una rivoluzione, detta altrimenti, da cui sappiamo dove si entra ma non dove si esce.
Non è possibile salvare tutto, è una certezza. L’unica possibilità per non atterrare di faccia sul cambiamento climatico è tagliare con grande rigore ciò che non è necessario salvare.
Ma cosa tagliare? Le nostre città sono completamente patrimonializzate. In Italia ogni edificio che ha più di 70 anni è sottoposto a una valutazione della sovrintendenza. Nessuno vive nei centri storici ma non siamo disposti a trasformarli. Le proprietà immobiliari nei quartieri e nei paesi si accumulano vuote e inutilizzate ma non siamo disposti a confiscarle. Al contrario, pur essendo lì da molto prima, i fiumi, i boschi e le poche distese ecologiche sono considerati erodibili, sempre trasformabili. Il processo di difesa del costruito è detto conservazione. Ricordiamo che la conservazione è l’atto dei conservatori.
Non riguarda solo le case.
Dopo decenni di tagli economici “per il bene dell’Europa”, in cui il mantra era che non ci possiamo permettere questi livelli di welfare, di sanità, di trasporti pubblici, di colpo la spesa è non solo accettabile ma necessaria se si tratta di armi ed eserciti. Agitando lo spauracchio della guerra alle porte, nonostante – o forse proprio per coprire – l’aumento di disastri di origine climatica in Europa, d’un tratto spendere enormi risorse pubbliche è imperativo.
Potere è potare.
Ci dicono che tutto non si può pagare, sappiamo che tutto non si può salvare. Allora il tema è cosa tagliare, cosa abbandonare, cosa definanziare, cosa lasciare fuori. È urgente un riordino di priorità, collettivo e consapevole. Cambiamo mentalità e rinunciamo a un modello di conservazione dell’esistente capzioso, derivante dall’abitudine più che dal senso. Il titolo di questa edizione di GROUND è Poeticamente corretto. Per sviluppare un prodotto, o un progetto, poeticamente corretto è necessario attenersi molto più alla sostanza che alla forma, è necessario decidere, e recidere. Potere è potare quindi, e non
possiamo subire questa potatura ubriachi di un’ideologia del tecnico, dell’inevitabile.
Insieme potiamo.
Dobbiamo, non l’impersonale “è necessario” o “si deve”, né l’incerto “dovremmo” o “dovremo”. Oggi dobbiamo prenderci la piena libertà di scegliere cosa potare, come disobbedire e quanto tagliare di ciò che è inessenziale. Potiamo presto, come pratica quotidiana, dalla disconnessione, dalla rinuncia a quelle persone e a quelle situazioni tossiche, e come pratica politica di resistenza attiva, difendendo i fiumi e i prati, ribellandoci alla spesa bellica e alla conservazione di beni inutili. Noi potiamo.
Ho anche immaginato di dare un senso a tutto ciò, ma poi ho pensato che non dobbiamo stare per forza dentro certe strutture/vincoli. Ci insegnano a farlo da quando siamo piccoli fino al regno della burocrazia (nutrita dalla sempiterna domanda “di chi è la responsabilità?”), ma possiamo provare a fare resistenza e re-esistenza. Così mi sono fatto quattro disegni/storielle di un protagonista che prova a fare tutto quello che abbiamo detto. Ma poi arriva il masso, il negativo. Ma niente spoiler, iniziamo.
Il protagonista primo sono le api: storia di un’intelligenza collettiva, di sciame, di sciami, di shining!, spersi e diversi nel labirinto di Shining. L’autore del film (il sommo Kubrick) ha dis-integrato il tema del libro di King (il sommo King), che spesso rende donne e infanzia protagonisti. In questo caso l’autorialità ha eliminato la centralità della vulnerabilità e ha nutrito il mito del superuomo (il sommo Nicholson). A noi piace di più la dimensione di intelligenza collettiva, la dipendenza che diventa interdipendenza, la guida illuminata che diventa bosco. Fuori dalla bio-diversità, dall’eco-sistema, ri-conosciamo tutto ciò che ci resta come peso, come masso: la violenza degli argini, degli individui e individualismi, di città e collettività che muoiono.
Secondo protagonista l’architetto: storia dell’individuo, si parte dai licheni che ci hanno caricato di speranza nel lavoro collettivo, nelle esperienze comunitarie, nel poter fare propoli, e anche nel poter investire più sulla curiosità e non sulla sicurezza (senza cura, senza preoccupazione).
Non serve che mi curi, ma accompagnami in questo vivere. Il masso qui è che attualmente siamo comunque costretti a mangiare HACCP, che manteniamo ciò che c’è ed eliminiamo Khartoum.
Terzo protagonista le scarpe di Salgado: tutto è falsamente autonomo e fortemente in dipendenza. Con la difficoltà di lavorare per il benessere creando ghetti (coinvolgiamoli tutti basta che si facciano gli affari loro). Questo è stato portato come il volare ma mantenendo le pesantezze, e ricordandoci che nel bios comanda la pluralità, che tiene dentro tutto e tutte le fatiche, le vulnerabilità. In questo ci aiuta la cedevolezza, l’abbattere anche quegli argini che dicevamo prima, lo svincolare, fare passi indietro, magari di lato. Ci aiuta incorporare la morte, i morti, le sepolture verdi. Il masso qui è che dobbiamo innanzitutto assicurarci che nei nostri luoghi non ci sia vita, e distruggiamo pure le città dei morti stessi! Un upgrade di distruzione! Quarto protagonista è il tempo: il presente, l’essere presente non per finta ma davvero, consapevolezza che non c’è niente da capire ma molto da imparare e sperimentare, sulla nostra pelle, sul nostro corpo, anche in maniera collettiva. Nessuno capirà mai cosa sta succedendo: non esistono soluzioni e risoluzioni, ma sguardi diversi per affrontare temi e problematiche. Ground con-vivio e con-morte! Abbiamo tutti responsa-disabilità. Qui il masso è la morte dell’abilità di rispondere (la responsabilità), il non generare contesti conviventi (la sfiducia), il fondere e con-fondere cura e potere (la paura).
Smielatura n.1
Le voci altre
Risuona la Terra in conversazione – coro silente per l’orecchio umano
Risuona la Terra in conversazione – coro silente per l’orecchio umano, capace di cogliere solo poche note. La gran parte delle conversazioni in atto nel mondo naturale avviene fuori dall’intervallo di udibilità (e in generale di comprensione) degli umani. Il coro degli infrasuoni del pianeta ci circonda inavvertito, e così gli ultrasuoni ci attraversano inudibili. È questione di limiti fisiologici e pure, secondo qualcuno, di limiti psichici; resta il fatto che non abbiamo grandi capacità di ascolto delle voci non umane. Eppure la Terra è in conversazione costante, anzi: è una conversazione costante. E chissà: come sceglieremmo di vivere, se queste voci altre fossero udibili e dotate di significato per noi? Ci aiutano tecnologie digitali sempre più sviluppate che aumentano le nostre facoltà uditive, e i progressi di scienze come la bioacustica e l’ecoacustica ci segnalano conversazioni in linguaggi che non sono il nostro (e non possiamo sviluppare qui le implicazioni, pur rilevanti, legate all’uso di termini come “linguaggio” o “voce” in
una connotazione antropocentrica). Occorre, però, ricordare che ogni suono e ogni voce sono più del dato digitale in cui vengono tradotte: sono significato e musica, sono natura di un luogo e di ciò che lo popola in relazione.
Da questo punto di vista, una tecnologia umana da riscoprire è l’immaginazione, soprattutto quando si sviluppa in forma narrativa. Immaginare e raccontare storie è un’attività comune, una tecnologia di base e al tempo stesso raffinatissima. Per lo scenario futuro, che è possibile intravedere, è urgente, allora, dotarsi di un “kit narratologico” e allenare l’immaginazione, usando anche la letteratura come tool, attrezzo, strumento conoscitivo. Arranchiamo, infatti, in una crisi immaginativa di vasta portata (lunga vita a GROUND che muove in direzione opposta!). Proprio quando avremmo bisogno di trovare un immaginario condiviso radicalmente nuovo, smettiamo di pensare l’impensato, l’inimmaginabile, l’inedito; la letteratura continua a tradursi soprattutto nel racconto di avventure morali individuali, e il nostro immaginario si restringe sempre più. Raccontare storie, tuttavia, è ciò che permette di immaginare possibilità, di immaginare il mondo come se fosse altro.
Quale posto trovano, allora, nelle storie che raccontiamo, le voci altre e non umane? Voci anche solo immaginate, sì, evocate dalla parola letteraria. Quali suoni e conversazioni riempiono le nostre storie? Più che una rassegna di esempi valga qui la sottolineatura dell’urgenza di una postura da assumere. E dunque perché, nell’epoca della grande cecità, non affidarsi all’orecchio, più facile da disarmare rispetto ai nostri occhi rapaci di controllo e possesso, più inerme ed esposto a ciò che può raggiungerlo?
Potrebbe sembrare uno strano crossover quello che tenta di innestare suoni e voci (legati alla dimensione orale) dentro la parola scritta; ma la scrittura, dopotutto, è la forma fondamentale
secondo cui la cultura occidentale organizza il proprio rapporto con l’altro e con la voce dell’altro – che sempre dovrebbe essere qualcosa di inatteso, di letteralmente inaudito.
Proprio perché l’immaginario è un sentiero che nasce dal passo, i nostri racconti dovrebbero farsi cassa armonica, e risuonare delle conversazioni fra tutto ciò che ci circonda. Dovremmo raccontare sempre più storie capaci di accogliere o evocare le voci altre di organismi ed ecosistemi. Abbiamo bisogno di narrazioni concave, a forma di orecchio, in grado di ospitare le note, i timbri, gli intervalli, i silenzi, le voci che compongono l’iperoggetto acustico in cui siamo immersi. È importante raccontare storie capaci di mostrare che tutto ciò che fa vibrare i sensi è collegato, storie che trasmettano lo stupore e la consapevolezza che tutto, nella foresta, è la foresta.
Storie così ci permetterebbero di comprendere meglio i paesaggi (esteriori e interiori) in cui esistiamo, perché un paesaggio non si conosce come somma delle identità di quel che contiene ma come percezione delle relazioni al suo interno; e, dunque, una buona storia serve almeno quanto un preciso catalogo di elementi, e sicuramente più di una formula definitoria. Occorre al contempo ricordare che ogni voce altra è e rimane un mistero al quale applichiamo un nome: le buone storie sono mappe, antenne ma anche incantesimi, e la verità della Terra è qualcosa di vivo e impronunciabile da una voce solista.
L’inaudito è ovunque nella Terra risonante, e talvolta, oltre allo spazio, supera il tempo. È il caso di una breve storia che mi accompagna da un po’, una sorta di suggestione e immagineguida nel processo tratteggiato fin qui. Testimonia che è un gesto antico, una postura che sappiamo assumere fin dalle origini della letteratura.
La vicenda, in sintesi. Pochi anni fa, nel Kurdistan iracheno, viene ritrovata un’antica tavoletta d’argilla – terra riemersa dalla terra (e dal contrabbando postbellico). Durante i lavori di traduzione, la scoperta sensazionale: quei caratteri cuneiformi riportano una ventina di versi fino ad allora sconosciuti dell’Epopea di Gilgameš. Capolavoro letterario, storia mitologica fondativa, migliaia di anni di storia e azione sull’immaginario mitico-religioso di culture e popolazioni diverse, e… cosa raccontano questi versi ritrovati?! L’avrete intuito: raccontano (meravigliosamente) un coro di voci non umane. Gilgameš e il suo compagno Enkidu giungono infatti, nel corso della loro avventura, nella Foresta dei Cedri, dove si batteranno con il mostruoso guardiano Humbaba. La Foresta dei Cedri era rimasta a lungo silente. In realtà, i versi ritrovati raccontano in modo mai visto prima il paesaggio sonoro della foresta: onomatopee riproducono i versi di uccelli, mammiferi, insetti fra i cedri rumorosi, e una stupefacente opera di composizione immaginativa e acustica rende la vitalità delle conversazioni non umane. È un paesaggio di voci altre che interagiscono, descritte anche con rimandi al canto e alla musica percussiva; un coro (meravigliosamente) cacofonico all’orecchio di Gilgameš, a segnalarci, insieme all’incanto, lo spaesamento per la prossimità di interlocutori non umani, in una relazione che può essere tanto intima quanto perturbante.
Grazie a questi suoni ritrovati, dunque, il primo poema epico della storia ci offre una “matrice” di scrittura delle voci altre, che ora riemergono dalla terra e dall’oblio. Suoni inauditi che tornano ad abitare la nostra immaginazione, a risvegliarla forse, desiderosa di conversazioni con voci altre e capace di ospitarle nelle storie che racconta.
Anche questo testo è l’esito di un’ininterrotta conversazione: quella fra chi ha scritto e i libri e le pratiche di Michel de Certeau, Barry Lopez, Matteo Meschiari, Amitav Ghosh, Laura Pugno, Karen Bakker, Richard Powers, Timothy Morton [N.d.A.].
Il suono delle aree a margine
I confini sono spazi di transizione, territori fluttuanti, sfuggenti alla rigida logica della compartimentazione
«I find myself drawn to [the] edges with a sense of urgency, knowing that they may be gone tomorrow – not just extended but really, finally gone».1
I confini sono spazi di transizione, territori fluttuanti, sfuggenti alla rigida logica della compartimentazione. I margini urbani sono luoghi dalla natura effimera, destinati a mutare, sparire o ricomporsi in forme imprevedibili. In questi spazi di confine si genera un’ibridazione, un processo di osmosi tra elementi apparentemente eterogenei, un palinsesto in cui i segni del passato si sovrappongono a nuove stratificazioni.
Il concetto di confine, tradizionalmente concepito come netta separazione tra ambiti distinti, nel contemporaneo si sfalda per divenire interfaccia, un’area di negoziazione. Già nella topografia della città medievale, e ancor più nelle evoluzioni
urbane moderne, il confine non è mai linea, ma area buffer, luogo di contraddizioni e di mediazione. L’idea di una città suddivisa in comparti funzionali risulta ormai obsoleta: le zone industriali, residenziali e commerciali si intersecano in un continuum che sfida le tassonomie della pianificazione urbana di fine Ottocento. Questa metamorfosi investe non solo l’organizzazione spaziale, ma anche la dimensione acustica. Il paesaggio sonoro ne è testimone privilegiato: nelle aree marginali non esistono suoni autoctoni, ma eventi acustici transitori che si ricompongono secondo schemi inattesi. Il ruggito del trattore agricolo risuona lungo i grandi assi viari extraurbani, lo zirlo del tordo si sovrappone al ronzio delle linee elettriche ferroviarie. Il tutto si dissolve in una tessitura sonora indistinta, una trama in cui sul piano acustico ogni suono si rifrange a creare una polifonia inedita.
Il margine non è un limite, bensì un dispositivo di connessione, un elemento di saldatura tra realtà solo in apparenza contrapposte. I confini perdono lo status di perimetro, per divenire luoghi di soglia.
Alcuni vogliono che la peculiarità di un luogo si definisca attraverso la sua identità, una sorta di timbro distintivo. Oggi questa identità si costruisce nella sintesi e nella convergenza di prospettive diverse. Ecco che allora il concetto di “impronta sonora” può esistere solo in chiave antinostalgica e assumere un nuovo significato quale rete di rimandi. Ogni evento non esiste, infatti, in modo isolato, ma acquista senso attraverso il suo legame con altri elementi. In questo caso, nel contesto del paesaggio sonoro, significa che nessun suono, ma soprattutto nessuna esperienza di ascolto, può essere considerata pura, ma è sempre parte di un insieme più ampio di influenze, contaminazioni e riferimenti incrociati.
Eppure non si tratta di una perdita, bensì dell’accettazione di un saldo di paradigma: il margine è laboratorio dell’ibridazione, dimora di un genius loci che si ridefinisce nell’accogliere componenti “altre”, aumentando di conseguenza la propria complessità composita.
Le aree a margine, dunque, sono laboratori in cui il luogo, e i suoi attributi topologici, si reinventa incessantemente. Esse ci insegnano che l’identità (sonora) non esiste nella sua fissità, ma si costruisce nel cambiamento. Accogliere questa fluidità significa abbandonare ogni rigidità classificatoria e riconoscere che se il paesaggio è un testo in perpetua riscrittura, la ricchezza esiste esattamente dove le differenze s’incontrano, si scontrano e si fondono, generando nuovi significati e inedite possibilità di interpretazione, e di ascolto, del mondo che ci circonda.
1. Charles Pratt, The Edge of the City: Words and Photographs. Nazraeli Press, Paso Robles (CA), 2005.
La grande zolla
«We all are compost in traning» direbbero i Ramshackle Glory
Quando Albrecht Dürer dipinge La grande zolla è il 1503. Si tratta di un dipinto in cui appaiono alcune erbe in primissimo piano, come se qualcuno avesse infilato una vanga nella terra e ne avesse estratto una vivace rappresentanza del giardino comune: piantaggine, fienarola, tarassaco, pimpinella misti a fili d’erba disordinati. È di fatto il primo dipinto di una comunità di erbacce, ma è anche la scoperta dell’ecologia da parte della pittura, almeno in Europa. Nella Grande zolla le erbe non sono ritratte con intento funzionale come quando nel Medioevo il loro disegno doveva accompagnare le descrizioni medicinali, e nemmeno con intento ornamentale quando le cornici fiorite e i prati di corte ornavano i libri delle ore. Diversamente da qualsiasi pittura convenzionale, che mostrava fiori ed erbe frontalmente o dall’alto, questa zolla è ritratta dal basso, e sembra invitarci sulle ginocchia a sentire la terra esposta sotto le mani, ad avvicinare il naso agli steli e osservare attentamente, forse anche a distenderci, il corpo consapevole del pungolio dell’erba sotto di noi.
Dovranno passare molti anni, se non addirittura alcuni secoli prima che altri osservatori, da Shakespeare a Goethe, offrano sguardi tanto ravvicinati sulle erbe comuni, combinando l’osservazione della loro minuscola universalità con un’ampia visione del genere umano.
Come ci insegna bene Mabey nel suo Elogio delle erbacce, la storia della malerba è un ambito incredibilmente complesso che incrocia circostanze pratiche con elaborazioni culturali, e che colpisce in pieno l’apparente inconciliabilità tra operato umano e naturale. L’idea di natura che abbiamo ereditato dal passato è quella di un luogo verdeggiante e spesso incontaminato, sottoposta alle leggi della biologia e delle relazioni ecologiche. Verde, estesa, imprevedibile, la natura sarebbe opposta alla città, luogo di dominio degli uomini e delle loro leggi. L’apparente inconciliabilità tra i due mondi deriva dalla cosiddetta “grande partizione”, uno dei più noti pilastri dell’Occidente, che ha generato, nel tempo, due visioni precise di natura: da un lato la natura come risorsa da estrarre e mettere a profitto secondo un atteggiamento riduzionista e predatorio; dall’altro la natura romantica e nostalgica legata a immobilismi conservatori e carichi di colpa, che riconoscono nell’azione umana le cause del degrado e dell’assottigliamento delle risorse.
Eppure le erbacce, che poco ricadono in queste due visioni opposte, suggeriscono altri modi di osservare il rapporto con il non umano. In primo luogo, le erbacce mettono in discussione gli incessanti tentativi di marcare un confine tra selvaggio e addomesticato, evidenziando piuttosto la porosità del tessuto che collega città e campagna. Anche la dicotomia tra pubblico e privato è irrilevante, perché le reti ecologiche si espandono orizzontalmente alle categorie predeterminate. La dimensione percolativa della natura marginale è resistente, filo salvifico per
ecologie sottili che si muovono su piccole ali in cerca di continuità, e al contempo dannazione per chi, come i sarchiatori di un tempo, ne riconosce l’indole infestante. Tuttavia, i tentativi di isolamento della malerba, il più delle volte andati a male, hanno dato luogo a riconoscimenti importanti, sia culturali che scientifici.
Non è un caso che il poeta John Clare inizi a scrivere delle minute se pur estese qualità delle erbe e del paesaggio di Helpstone dopo che i campi iniziarono a essere recintati e suddivisi tra i proprietari terrieri per essere messi a reddito. La scomparsa di un paesaggio ecologicamente variegato aveva mutato non solo l’aspetto della campagna ma anche le pratiche di comunità che facevano di quei campi una risorsa comune. L’impoverimento delle qualità del paesaggio, d’altra parte, è uno dei grandi temi della modernità e risuona con il monito dello scienziato politico
Stephen Meyer in The End of the Wild: gli esseri umani hanno modificato l’ambiente in cui vivono fin dall’antichità, favorendo modelli poco differenziati a svantaggio della spontaneità e dell’imprevisto. Il rischio è che prevalgano generalisti adattivi e che anche il lato più incontrollabile della natura sia appiattito sul modello umano dominante. Che fare? In quale misura la salvaguardia dell’ambiente risponde al paradosso che sta tormentando la scienza dell’ecologia, ovvero che per tutelare il lato incontaminato della natura bisogna sottoporla a un grande controllo?
Il Rambunctious garden, di cui parla la giornalista e scrittrice Emma Marris nel suo recente libro di successo, offre qualche prospettiva, spaziando dalla migrazione assistita al rewilding passando per l’adozione di nuovi ecosistemi. Ma l’atteggiamento che ci propone non è nuovo, anzi affonda le sue radici nel Wild garden scritto da William Robinson nel 1870, uno dei libri più influenti di tutti i tempi nella storia del giardinaggio.
In fondo, sia Marris che Robinson ci dicono che è impossibile pensare il formale senza il selvatico, il pianificato senza l’imprevedibile e che una visione contribuisce a costruire l’altra.
In fondo, le erbacce sono una grande metafora di resistenza, per dirla con Tsing, per cui ecologie secondarie e marginali possono insegnarci come vivere tra le macerie del capitalismo. La casualità dell’incontro, le contingenze, le caratteristiche elettive delle unioni non sono necessariamente vantaggiose ma includono assenze, scomparse e vuoti lontani dalla scalarità lineare del prodotto.
Questa minoranza apolide ci ricorda, insomma, che la vita non è così ordinata. Come costellazioni in movimento, le erbacce si nutrono di contaminazioni per espandersi, ritrarsi, definire nuove geografie multispecie anche all’interno di un paesaggio altamente controllato. Perché è ormai ovvio che nessun organismo, umani compresi, può diventare sé stesso senza le interazioni con altre specie. “We all are compost in traning” direbbero i Ramshackle Glory. “Compost and not postumans!” esclamerebbe Haraway.
FRANCESCO SCAREL
GROUND e il Quarto spazio: un incontro tra arte, scienza e società
In questo paesaggio culturale in continua evoluzione siamo spinti a ripensare il nostro rapporto con l’ambiente che abitiamo
GROUND è un social forum che invita ad abitare lo spazio aperto come luogo di incontro, contaminazione e azione collettiva. Proprio come GROUND si propone di essere un terreno fertile per nuove idee e connessioni, il concetto di “Quarto spazio” trova in questo contesto un’opportunità straordinaria per ridefinire il dialogo tra arte, scienza e società.
Il Quarto spazio, concepito come un ambiente interdisciplinare di esplorazione, nasce come evoluzione del “Terzo spazio”, teorizzato nella ricerca pubblicata da MIT Leonardo Emergent Knowledge in the Third Space of Art-Science, che descrive un luogo di incontro tra diverse discipline e saperi. Questa visione si lega al concetto di “Terzo luogo”, definito dal sociologo Ray Oldenburg, che identifica quegli spazi informali di socialità – come caffè, biblioteche e piazze – fondamentali per la costruzione di comunità e lo scambio di idee.
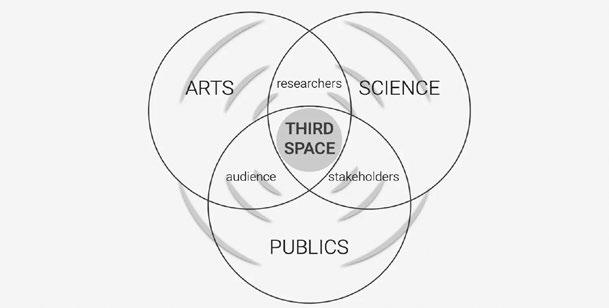
schematica del
Tuttavia, mentre il Terzo spazio si concentra sulla convergenza di artisti e scienziati in un contesto collaborativo, il Quarto spazio amplia questa visione integrando la comunicazione della scienza come elemento di risonanza, essenziale per creare un ponte con la società. Se il Terzo luogo permette alla società di sviluppare dialoghi spontanei e di condividere conoscenze, il Quarto spazio ne raccoglie l’eredità, trasformandolo in un laboratorio dinamico, dove arte e scienza si incontrano per produrre nuove narrazioni culturali e strumenti di comprensione del mondo. In questo senso, il Quarto spazio non è solo un luogo di ricerca e sperimentazione, ma diventa anche uno spazio di dialogo, dove le conoscenze scientifiche e artistiche possono essere condivise e trasformate in nuove prospettive collettive. Seguendo il modello di Neri Oxman nel suo Krebs Cycle of Creativity, che mostra come arte, scienza, design e ingegneria si interconnettano ciclicamente, il Quarto spazio permette una fusione di approcci diversi, unendo la razionalità scientifica con la creatività artistica. Esso si esprime, quindi, in un ecosistema creativo, un luogo dove le moltitudini disorganizzate si riconoscono, trovano punti di contatto e riorganizzano il sapere in modo partecipativo.

È un’opportunità per esplorare temi urgenti e fondamentali come il cambiamento climatico, la sostenibilità, le nuove tecnologie a disposizione e il rapporto tra umano e non umano, attraverso linguaggi che intrecciano dati e immaginazione, scienza e poesia, tecnica e intuizione.
In questo paesaggio culturale in continua evoluzione, dove la ricerca scientifica e artistica si mescolano per generare nuove visioni del futuro, siamo spinti a ripensare il nostro rapporto con l’ambiente che abitiamo. GROUND e il Quarto spazio condividono la stessa tensione verso il cambiamento: entrambi rappresentano un movimento che parte dal basso per costruire consapevolezza e ispirare nuove possibilità.
Stare con i piedi per terra
Il risveglio della natura, la primavera rigeneratrice
Atto primo. Il risveglio della natura, la primavera rigeneratrice. Nel 1913 Igor Stravinskij porta in scena la sua composizione musicale più famosa. La sagra della primavera è un’opera ardita e d’avanguardia, di una novità esplosiva, istintiva, scandalosa, insolita e selvaggia, fauve. Uno strano spettacolo, in cui i contrasti delle sovrapposizioni politonali e l’innovazione ritmica fanno della durezza la caratteristica dirompente di questo nuovo linguaggio musicale. Si fa interprete della violenza con cui irrompe la natura “che spacca la terra”, e a cui è legato un altrettanto estremo atto di violenza: la consacrazione –l’atto sacro, in questo senso “sagra” – di una giovane, il suo sacrificio attraverso il rituale (pagano) della danza come atto propiziatorio. Oggi è considerata un’opera rivoluzionaria, liberatoria nei confronti degli stili precedenti, ma è stata piuttosto un fenomeno isolato per il suo tempo, senza discendenza, che allora sconvolse il mondo musicale tanto da non riuscire ad assorbire il suo portato innovativo e continuando così nel consueto tracciato, facendo della Sagra un mito.
Dal balletto di Nižinskij in poi, Massine, Graham, Béjart, MacMillan sono alcuni dei grandi nomi della danza che hanno interpretato questa opera con coreografie personalissime, cambiandone di volta in volta il finale. Ma è la versione del 1975 di Pina Bausch quella più intensa e drammatica (e, forse, celebre). Il palcoscenico è ricoperto di terra, a rappresentare il legame diretto con la natura, su cui si muovono ballerini e ballerine, i cui corpi si fanno sempre più imbrattati e affannati in una danza selvaggia e primitiva, sporchi ansimanti denudati, esposti. Prima dell’inizio dello spettacolo, sul palco viene arata la terra a sipario aperto: l’allestimento si fa anch’esso performance, facendo cadere le barriere tra la preparazione della scena e il pubblico, in un contatto diretto – vero – di tutte le parti dell’opera. Stravinskij e Bausch hanno segnato in maniera incisiva il mondo novecentesco delle arti performative, rivoluzionando il linguaggio della musica e della danza. A più di centodieci anni dall’opera musicale, e a cinquanta da quella coreutico-teatrale, la Sagra continua ad avere un impatto artistico profondamente emotivo, che prendiamo in prestito come metafora per sentire e sperimentare il mondo, per creare nuovi modi di vedere.
Atto secondo. Ancorarsi alla terra, all’humus, alla dimensione umana del mondo, è un modo di rapportarsi a esso, è farne esperienza e non solo evento. Attraverso la dimensione fisica, sensoriale, percettiva ed emotiva del corpo ristabiliamo un equilibrio con il mondo: punto di giunzione tra istinto e razionalità, il corpo ricostruisce la relazione tra le persone e le cose, riempie lo iato tra logos e bios, direbbe Roberto Esposito. Il corpo può segnare il confine oppure la soglia per rapportarci al resto. Ma è nella sua figura collettiva – fatta di corpi che, esprimendo bisogni e desideri, entrano in conflitto e si ricongiungono – che il corpo dei popoli si fa figura politica di ricomposizione. La crescente riscoperta del corpo – nella misura individuale e collettiva, privata e pubblica
– riporta al centro del discorso la vita, in una dimensione di prossimità che è l’unica che ci consente di fare dell’esperienza oggetto condiviso di emancipazione.
Un modo di stare al mondo è affondando i pieni nella terra, è osservarlo ad altezza umana (ognuno con la sua): da questo punto di vista – che diamo a volte per scontato ma che rimane così privilegiato – il corpo collettivo può riscoprire le sue interdipendenze, i suoi equilibri instabili e dinamici, può accogliere il negativo, farne un uso produttivo, riconoscere le sue imperfezioni come parti costitutive e istituenti della vita. E con i piedi che si muovono nella terra, traendo linfa vitale da essa, la testa esplora la potenza performativa dell’immaginazione, intesa come paradigma di un continuo e incessante processo istituente del reale. Tra conservazione e trasformazione, l’energia del pensiero istituente ha l’attitudine ad amalgamare poli apparentemente opposti, contrastando le dicotomie, rinunciando alla riduzione a un sistema binario.
Per realizzare questo progetto di coesistenza ecologica, critico ma non giudicante, orizzontale e conflittuale, dobbiamo essere disposti a modificare radicalmente le strutture e le istituzioni su cui fondiamo la nostra vita.
In questo rito laico di rifioritura, cosa diamo in dono per questa primavera culturale rigeneratrice, che cosa siamo disposti a sacrificare per la “ri-evoluzione”?
Elogio al tempo perso SARA LANDO
La verità è che il pensiero creativo si infiltra ovunque
Negli ultimi decenni, la creatività è stata trasformata in una competenza da perfezionare, una skill con cui eccellere, produrre, performare. È diventato difficile vedere persone che ballano o cantano in pubblico, che disegnano, che fanno foto senza fare un corso per poter avere il permesso di qualcuno più autorevole di loro. E, quando lo fanno, spesso sentono il bisogno di giustificarsi, di specificare che non lo fanno “per davvero”. Se, per una congiunzione di eventi fortuiti, una di queste persone raggiunge un livello nel proprio percorso amatoriale che viene considerato valido, il suggerimento è sempre lo stesso: «Dovresti venderlo, dovresti farlo per lavoro».
Abbiamo preso qualcosa di innato – un bisogno, un comportamento, una funzione dell’esistenza, come potrebbe essere costruire nidi o il cantare per gli uccelli – e l’abbiamo reso un prodotto, valutandone il valore in base al prezzo di vendita, ai like, all’attenzione che riesce
a catturare. Creare è diventato un atto finalizzato all’output più che al processo, e in questo spostamento abbiamo perso il contatto con la sua vera natura.
La creazione non appartiene solo agli artisti né solo agli oggetti che finiscono in gallerie o libri d’arte. Il processo artistico si insinua nella quotidianità, nel modo in cui disponiamo la tavola, scegliamo i fiori da mettere in un bicchiere, pieghiamo una maglietta in un cassetto. È nel tono con cui lasciamo un messaggio scritto in fretta – “Sono uscita a comprare lo zucchero” – nell’inclinazione della calligrafia, nella decisione di aggiungere un punto esclamativo o un cuore accennato, nel modo in cui quel foglietto si piega lungo le mani di chi lo legge. Se la creatività fosse solo il risultato di un talento straordinario, sarebbe poco più di un’eccezione nella vita delle persone. Ma la verità è che il pensiero creativo si infiltra ovunque: nel modo in cui risolviamo un problema, componiamo una frase, scegliamo il percorso da fare per tornare a casa. È il nostro modo di dialogare con l’esistente, di imprimervi qualcosa di noi.
L’arte, prima ancora di essere un oggetto finito, è una traccia del nostro passaggio attraverso il mondo. Non serve a dimostrare talento, né a produrre valore quantificabile: è un modo di stare nel tempo, di lasciare segni, di esplorare ciò che ci circonda. L’idea che il tempo impiegato a creare per diletto senza fini commerciali possa essere tempo perso si fonda su una concezione della produttività che non contempla l’interiorità. Ma il tempo dedicato alla creazione non scompare nel nulla. Non si dissolve nel vuoto. Sappiamo benissimo dove va. È tempo vissuto, trasformato, sedimentato nella materia e nella memoria. Slegati dall’idea che tutto debba essere ottimizzato, possiamo finalmente vedere come forse la retta sia la strada più breve tra due punti, ma non necessariamente la più interessante. E se più persone cominciano a rifiutare l’esistenza a forma di linea retta, le loro vite cominciano a incrociarsi in più di un punto, l’allontanamento non è più una
sentenza, l’impossibilità di essere ridotti a equazioni semplici diventa un modo per accettare che non possiamo prevedere quello che viene dopo, ma possiamo contare sulla nostra capacità di cambiare direzione senza avere una crisi d’identità.
Creare non è solo un atto di espressione, ma un processo necessario per orientarsi nell’esistenza.
L’arte, nella sua forma più essenziale, non serve tanto a trovare risposte quanto a definire meglio le domande. Un dipinto, una poesia, un gesto qualunque compiuto con attenzione e intenzione non servono a risolvere il mistero di cosa significhi essere qui, ma a renderlo più vivido, più percorribile. Forse dovremmo smettere di chiederci se ciò che creiamo sia utile o vendibile.
Forse dovremmo ricordarci che l’arte è sempre esistita prima di essere mercato, che le pitture rupestri non erano merce, che la musica nasceva prima delle registrazioni, che il bisogno di raccontare storie è antico quanto il linguaggio stesso. Creare non è un lusso né un privilegio: è una caratteristica del vivente e uno spazio di incontro con gli altri.
Due storie, che cominciano da esperienze personali, due narrazioni forse di storie forse di un sogno.
Dentro di me ricordo un elastico vissuto da bambino tra la parte generativa e la parte più mortifera, dove ti senti un verme, un fallito. Vado a cercare di fare comunità nei campi di grano dietro casa, siamo 4-5 bimbi sugli 8-9 anni e cerchiamo di fare comunità con un gruppo di adolescenti che iniziano a tirarci pietre e ci lasciano ai margini. Io dico alle mie amiche e amici: «Cosa ci può capitare di male? Al massimo moriamo».
Questi individui tra distanza e appartenenza, con la consapevolezza di non essere api e che la stanza è in silenzio. Ci siamo fatti colonizzare da sogni stretti (per lista di sogni stretti vedi sigla di Trainspotting), un modello pervasivo in cui qualcuno ha più diritto di altri di essere felice in quel modello lì, e altri non hanno possibilità di scegliere. Perché ogni uomo è un mondo? Che figata se abitassimo davvero in un alveare? Se i figli potessero esser tigli? Se potessi fregarmene davvero di mio cugino. Appartenenze a che e non al perché. In questo regno (The Kingdom) che in qualche modo Lars Von Trier ci descrive come un alveare un po’ terrifico. Uno sciame, due sciami, due shining. Quanti tipi di arnia? Quanti tipi di miele? Quante paure? Quante paure collettive? La paura di non cogliere risonanze? Di non sentire suoni? E dopo di noi? Il dopo di noi? Essendo e tessendo, la vita ha creato la morte, la morte che chiede persone e anche corpo. Tutti dentro l’inghiottitoio, cercando
la non autonomia, la dipendenza, per generare istituzioni buone e comunità buone, istituenti, capaci di dare del tu alla vita.
Seconda storia. In adolescenza il regalo più bello che mi hanno fatto è l’abbonamento dell’autobus. Io facevo il giro della città in autobus, guardando le comunità che si scioglievano. Webfare, è davvero questo che vogliamo?
Dov’è finita la confusione del web? Io volevo navigare cazzo! Dov’è l’unicità della persona? Prima il paziente? Medici?
Operatori? Nessun prima, evidenziamo le connessioni! Riappropriarsi dell’idea comunitaria. Cortili a forma di U, la vocale meno utilizzata, versi dello stadio, vocale debole.
Prendere scelte insieme, diventare gli umani di più gatti possibili. Sii più uomo, riscopri il corpo, vai di corpo. Poesia, inespresso esistente, coraggio delle nostre presidenze.
Ma sei disabile? No, sono incubatore di comunità! Stiamo con, rallentare, arrendersi, sostare, so stare. Un numero di scarpa.
Smielatura n.2
Turning Ground ANDREA PASE
Sullo scrivere in corsivo, sull’arare la terra e sulla compresenza di vivi e di morti. Cosa significa avere il futuro alle spalle
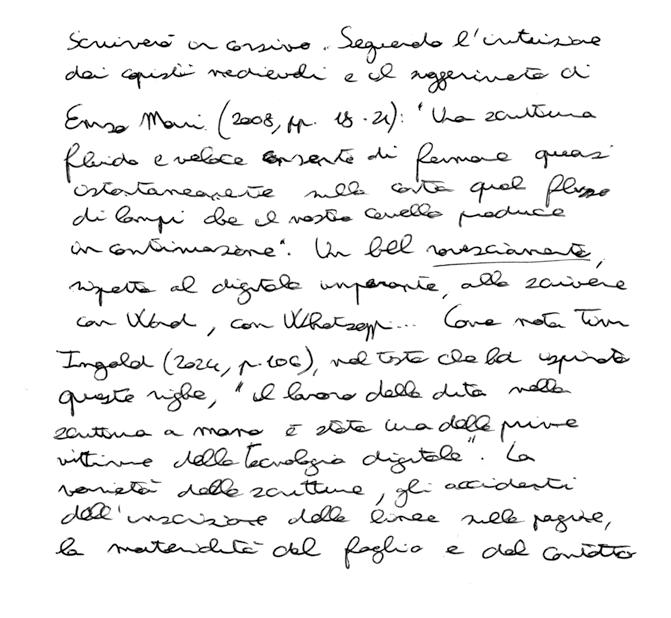

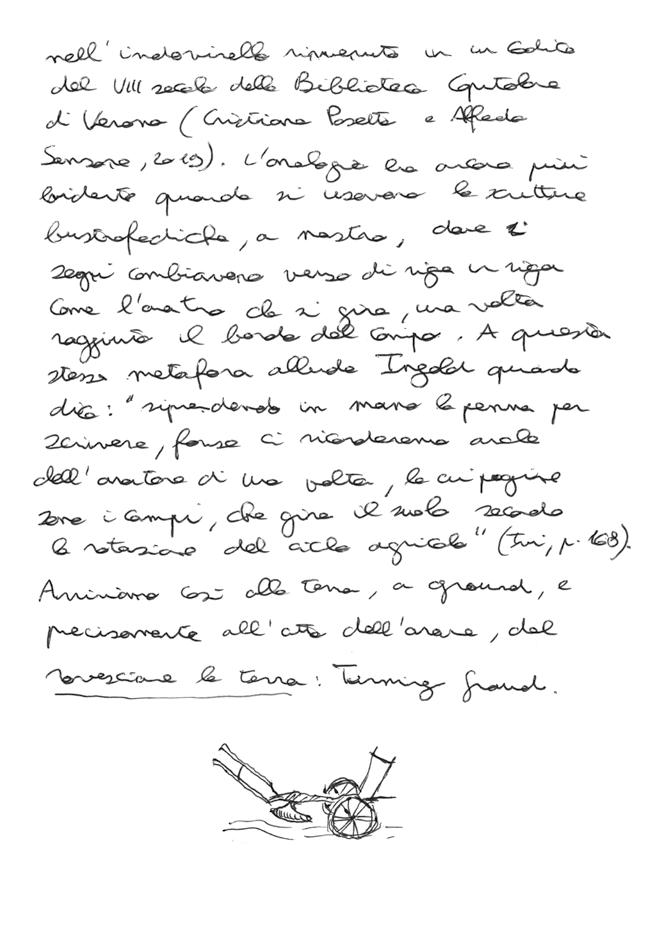
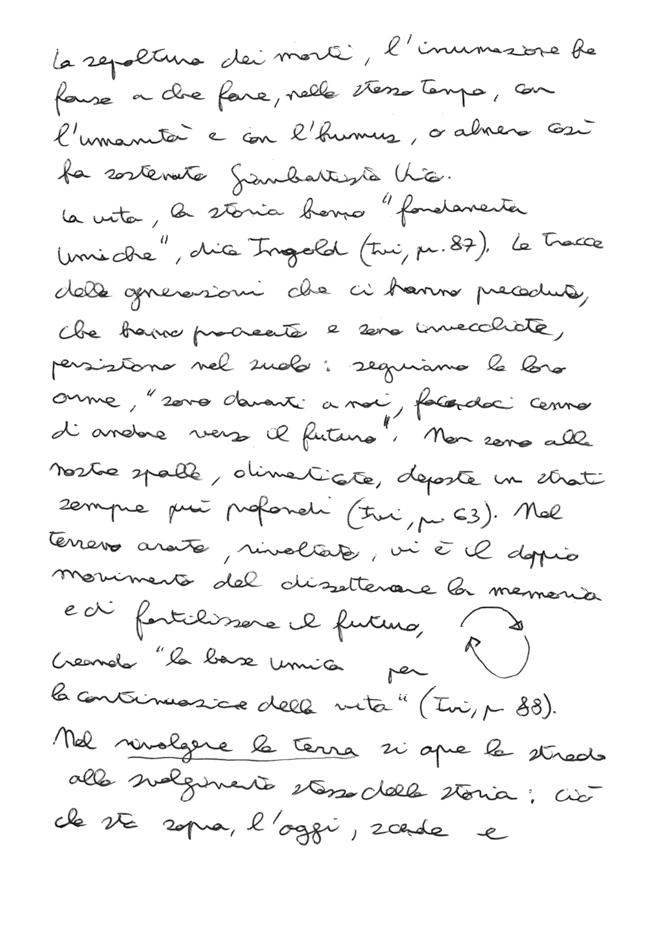
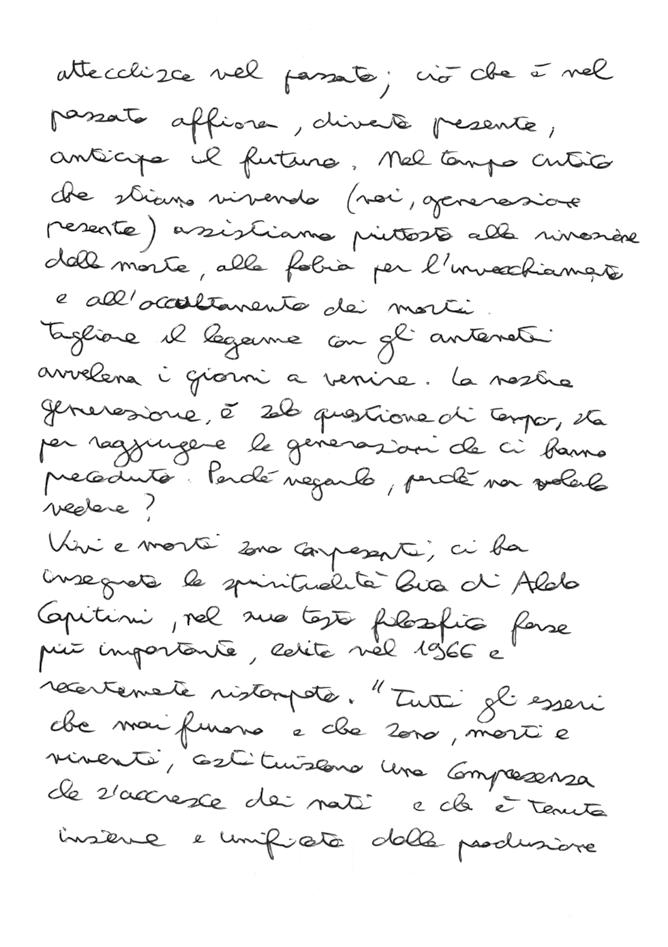
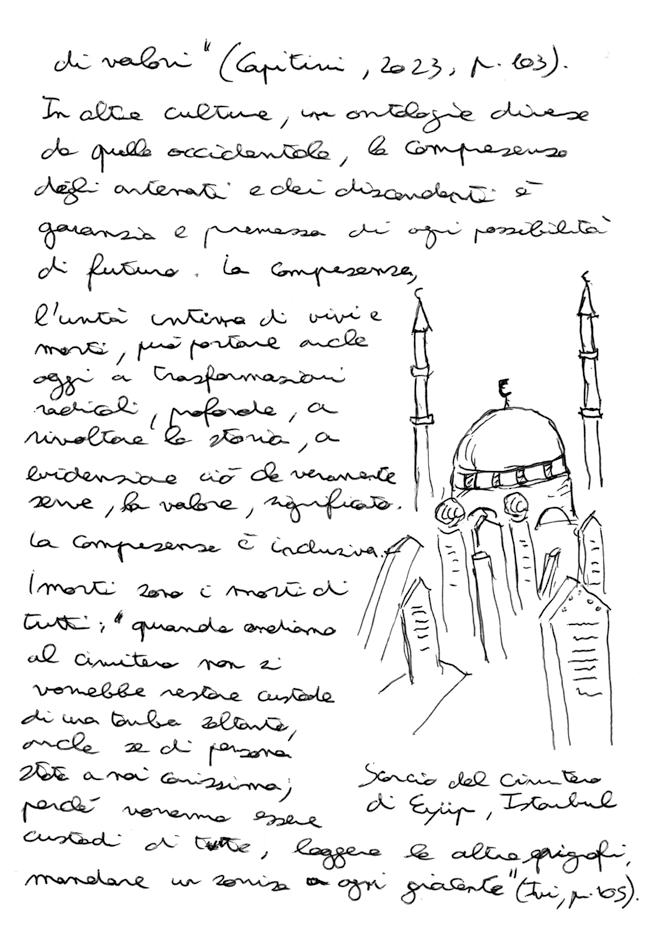
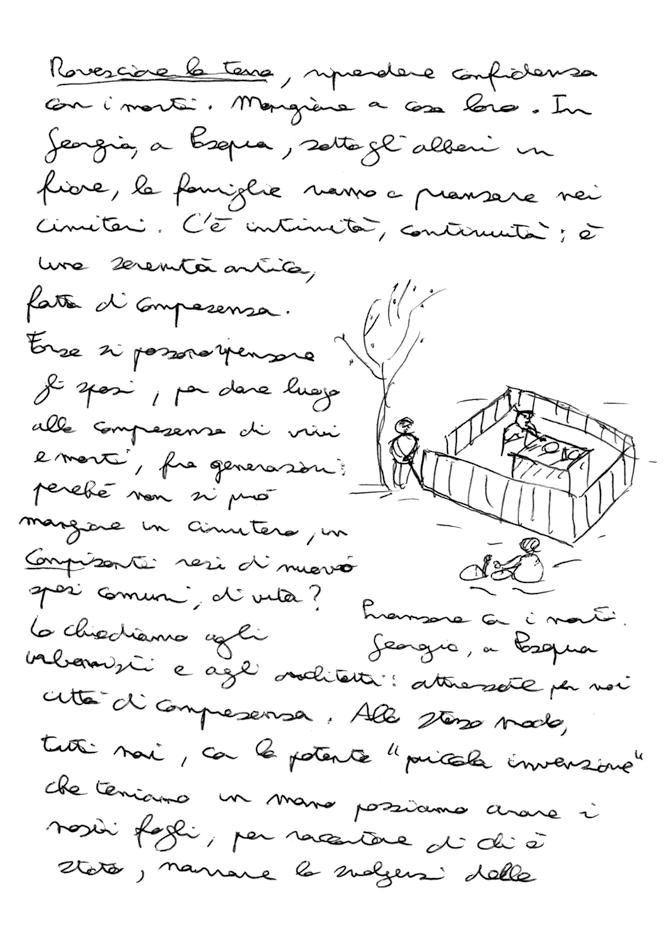
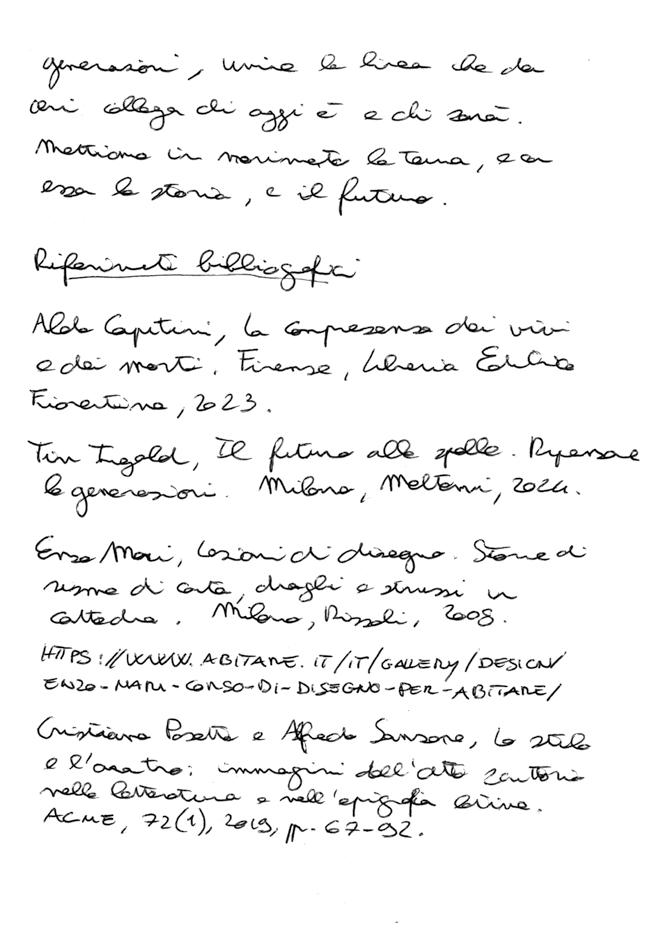
All’intersezione tra oppressione e privilegio
La nostra storia ci ossessiona perché è stata sepolta ingiustamente
Parto da me: da quando ho iniziato a indagare sulla storia di migrazione della mia famiglia, ho realizzato che la bianchezza che porto in volto è l’esito di un processo: un processo di razzializzazione e sbiancamento. Una storia, piccola, particolare, che attraversa la Storia con la S maiuscola. Quella di una famiglia di haitiani, accomunati dal cognome che porto a mia volta, Moise, discendenti dei figli di quella deportazione di massa per mare, meglio conosciuta come tratta transatlantica degli schiavi. Io sono l’unica Moise bianca di una numerosa famiglia diasporica di Moise neri e discendenti di unioni tra persone razzializzate e no.
La storia della schiavitù, della colonizzazione e della razza lascia le tracce in questo presente, e per dirlo con Grada Kilomba, afrofemminista portoghese, è una storia che mi ossessiona: «La nostra storia ci ossessiona», scrive l’autrice, «perché è stata sepolta ingiustamente».
Io non ne porto addosso che i tratti non evidenti, quelli che mi collocano, in termini di razza, dalla parte del potere e del privilegio, a differenza della mia stessa famiglia di sangue. È potere di sfruttare e di beneficiare direttamente o indirettamente del corpo e del lavoro logorante di chi si trova da secoli confinato dall’altra parte del rapporto di razza; è il potere di espropriare e colonizzare terre e corpi altrui; è il potere di affermarsi superiori e di agire con le parole la deumanizzazione dell’altra persona – ricondotta dalle mie stesse parole a non persona – ma ancora più spesso di affermarsi superiori mentre si nega di esserlo, mascherando l’insieme di consuetudini e leggi che definiscono normale e giusto ciò che in realtà è una normalizzazione e una giustificazione dell’oppressione e dello sfruttamento.
Non conosco il razzismo sulla mia pelle, perchè sono nata con la cittadinanza italiana, godo sin dal mio primo giorno su questa Terra del diritto del sangue italiano, lo ius sanguinis: diritto di voto, di elezione attiva e passiva, di partecipare ai concorsi per lavorare nella pubblica amministrazione, di prendere casa in affitto senza essere rifiutata al primo incontro dal vivo con il proprietario di casa, senza correre il rischio di essere sfrattata in seguito a un mancato rinnovo del permesso di soggiorno. In poche parole: sono nata con il diritto e le possibilità di restare o andarmene e costruirmi un progetto di vita dove meglio ritengo, purché sia all’altezza della mia dignità.
Aggiungo: conosco sul mio corpo e la mia psiche le molestie e la violenza sessuale e di genere, ma solo quella che si riserva ai corpi ricondotti alla femminilità bianca (che è intrisecamente eterosessuale e cis, come vedremo). Significa che se subisco violenza, abusi o molestie da un uomo bianco, magari dal mio datore di lavoro e decido di denunciarlo pubblicamente, non verrò creduta, diranno che sono una pazza, che cerco vendette, ecc.
Se, invece, subisco violenza o abusi da un uomo nero e lo denuncio, domani la notizia è su tutti i giornali, senza nemmeno il bisogno di verificare la veridicità della notizia.
Nelle parole di Djamila Ribeiro: «Anche se una persona bianca ha valori morali positivi – ad esempio, è gentile con le persone nere – non solo beneficia della struttura razzista ma molte volte, anche senza rendersene conto, è complice della violenza».
Non vivo tutto questo e non ne conosco direttamente le conseguenze materiali, posso dire di conoscerne le conseguenze indirette, perché sono figlia di tutte queste storie. Da parte della mia famiglia paterna eredito tutte queste memorie, private di una degna sepoltura. Ad Haiti, la schiavitù è stata abolita nel 1804, ma la nonna di mio nonno, che proveniva dalle Antille olandesi, è nata quando il regime di schiavitù era ancora in vigore nel suo Paese.
In questi termini tiro i fili che, annodati tra loro, definiscono il mio posizionamento, ovvero il punto di intreccio tra una molteplicità simultanea di logiche strutturali di potere in cui mi colloco, con la mia capacità riconosciuta o negata di agire, analizzare il mondo e cercare di cambiarlo. È premessa epistemologica e politica del mio lavoro di ricerca e trasmissione di saperi, e caratterizza il pensiero femminista decoloniale quanto il suo progetto di liberazione radicale: è l’assunzione dichiarata di una visione parziale del mondo, nel suo duplice significato: parziale perché non totale, tanto meno universale; parziale perché di parte – dalla parte di chi questo sistema di potere lo subisce, o meglio, lotta ogni giorno per opporvi resistenza e roversciarlo.
Grada Kilomba conia il concetto di “Memorie della piantagione” per dare lettura del razzismo contemporaneo fin dentro alle sue espressioni nelle interazioni quotidiane. Il razzismo, secondo
Kilomba è una vera e propria riattualizzazione sul piano simbolico e psichico, oltre che economico, del regime coloniale della piantagione schiavista.
L’autrice, riprendendo il lavoro della studiosa femminista nera Jenny Sharpe, si riferisce alla schiavitù come a una “ossessione della storia” che continua a disturbare le vite contemporanee delle persone razzializzate, facendo collassare il passato sul presente. Ogni episodio di razzismo nel tempo contemporaneo ripercorre a ritroso le linee di ascendenza della diaspora tomentando le vite dellə antenatə e facendo riaffiorare quotidianamente alla memoria il dolore della schiavitù. Di qui, l’intuizione di Kilomba: la nostra storia ci ossessiona perché è stata sepolta ingiustamente.
Per questo diamo forma di parola alle nostre memorie da “sottopelle”: è il nostro modo per resuscitare un’esperienza collettiva traumatica e seppellirla nel modo giusto.
UnLimiteDNA
Siamo pronti a lasciare spazio alla vita mettendoci in disparte, senza contare ore, giorni o anni, ma ere?
Disorientati, privi di direzione, ci lasciamo guidare dalla fiducia nei confronti dell’indigeno, custode di un bagaglio di esperienze e di una storia ancestrale.
Il termine indigeno deriva dal latino indigenus (gìgnere ‘generare’, con il prefisso indu-, da in- ‘dentro’), e ci ricorda che essere indigeni significa appartenere a un luogo e avere una profonda connessione con esso. Per nascita o per discendenza, l’indigeno stabilisce una connessione radicata con l’ambiente circostante, questo legame porta con sé un adattamento fisico, culturale e spirituale.
Con la sua conoscenza ancestrale, l’indigeno percepisce il paesaggio non solo come un luogo fisico, ma come parte integrante della sua identità. In esso riconosce segni e segnali che raccontano di cambiamenti climatici, cicli stagionali e risorse disponibili.
Queste informazioni, trasmesse di generazione in generazione, costituiscono un sapere collettivo che arricchisce la comunità e ne garantisce la sopravvivenza.
Il paesaggio, dunque, diventa il riflesso del nostro ambiente naturale, modellato dalle nostre azioni e reinterpretazioni. In questo processo, possiamo anche noi diventare indigeni per gli altri; adattandoci e interagendo con il nostro ambiente, apprendiamo le tecniche necessarie per sopravvivere e sfruttare a nostro favore le sue caratteristiche. Quante volte impersoniamo l’indigeno per gli altri? Con quale DNA ci muoviamo nel nostro ambiente naturale?
Tendiamo a cercare una natura che non ci presenti troppe sfide, poiché la vera natura, quella che custodisce la vita, ci chiede di mettere in gioco la nostra stessa esistenza per mantenere l’equilibrio naturale. Quanto tempo riusciremmo a sopravvivere in una foresta primaria senza la guida di un indigeno che ci insegni a seguire le sue orme?
Il nostro DNA è un libro vivente che narra la storia della nostra specie, un racconto complesso di adattamenti, sfide superate e ambienti esplorati.
Quest’ultimo, con la sua scrittura intricata e precisa, guida la sintesi delle proteine essenziali per la vita, influenzando ogni aspetto, dalla struttura fisica ai comportamenti. La bellezza di questo sistema risiede nella sua complessità e capacità di adattamento, riflettendo l’evoluzione continua della vita sulla Terra. Tuttavia, la vera bellezza dell’essere umano risiede nella capacità di oltrepassare il proprio patrimonio genetico, evolvendosi culturalmente e adattandosi a nuovi contesti attraverso l’apprendimento e la creatività. Mentre il genoma rappresenta la nostra base potenziale, la cultura, l’educazione e le esperienze personali plasmano chi siamo oggi.
Quando si cerca di comprendere l’equilibrio naturale di un ecosistema complesso, molti ricercatori si rivolgono alle ultime foreste primarie, come quella amazzonica. Alcuni sentono il bisogno di entrare nel suo cuore per coglierne l’essenza profonda, spinti dal desiderio di decifrarne gli schemi e le relazioni; per questo motivo, chiedono l’assistenza di un indigeno che possa guidarli, passo dopo passo, all’interno di un ambiente naturale che ormai non ci corrisponde più.
La nostra immagine di una foresta primaria ci porta a immaginarla come un luogo incantato, caratterizzato da un verde brillante e una grande tranquillità; in realtà, è esattamente il contrario. Ci si immerge in un ambiente buio ed estremamente ostile, ricco di vita e di una competizione intensa, un luogo dove l’essere umano è vulnerabile e soggetto a ogni sorta di pericolo.
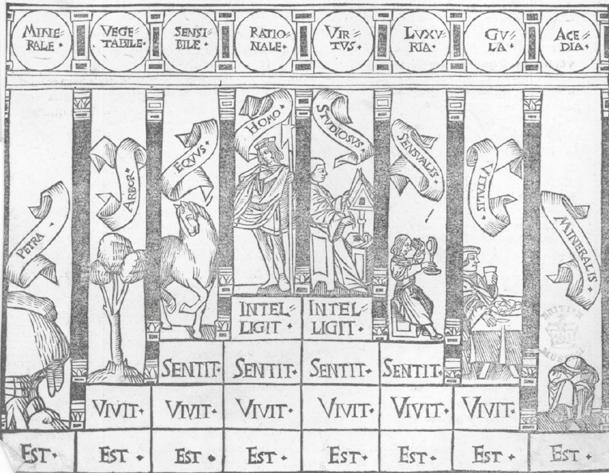
Altri ricercatori, invece, decidono di osservare la foresta dove incontra il cielo e scoprono un altro ecosistema, con interazioni diverse, la classica immagine che riceviamo dai documentari trasmessi attraverso i nostri schermi mentre siamo seduti su di un comodo divano.
E proprio lì possono incontrare specie che, per natura, hanno superato tutte le altre avvicinandosi il più possibile ai raggi del sole. Forse è proprio la storia scritta nel nostro genoma a spingerci verso ambienti privi di rischi, sicuri e depurati da tutto ciò che potrebbe influenzare il nostro status, attaccandoci alla rappresentazione di Charles de Bovelles della Piramide dei viventi.
E quando non abbiamo più una foresta primaria riconoscibile, quando abbiamo ormai smarrito tutto il potenziale naturale a nostra disposizione, da cosa possiamo ripartire? Forse è proprio dal mantenimento di ciò che resta che possiamo generare nuova vita, non con l’obiettivo di ristrutturare, ma di favorire e proteggere, non come destinazione d’uso, ma semplicemente come atto di nascita.
Siamo pronti a lasciare spazio alla vita mettendoci in disparte, senza contare ore, giorni o anni, ma ere?
L’uomo tende a semplificare sistemi complessi per giustificarli a sé stesso, alleggerendo il peso delle proprie azioni e sottovalutando le conseguenze.
Quante volte, in virtù di un sistema intrinseco a noi stessi, ci creiamo bolle di conferma che rendono assolute le nostre teorie, pur non avendo mai indagato una conferma scientifica autentica?
Questo comportamento può portare a una visione distorta della realtà, poiché si tende a vivere in un ambiente informativo chiuso, dove le proprie convinzioni vengono continuamente rafforzate e mai messe realmente in discussione. Quante volte strumenti
come i social media e altre fonti di informazione personalizzate, ci mostrano contenuti selezionati in base alle preferenze individuali, contribuendo ulteriormente a isolarci come individui in ecosistemi di pensiero omogenei e autoreferenziali.
Partiamo da ciò che possiamo nominare e identificare empiricamente, cercando di costruire un’alfabetizzazione scientifica che ci consenta di decostruire le barriere teoriche e consolidare strutture di forme complesse. Non siamo noi stessi complessi? Non è estremamente complessa la natura di cui facciamo parte? Come potremmo rivendicare il diritto di semplificare, senza la consapevolezza di portare con noi un messaggio attraverso l’espressione genetica, che rimarrà scritto nella storia dell’umanità?
Coltiviamo la responsabilità collettiva, condividiamo la bellezza e la cura di ciò che ci circonda, e superiamo le attuali strutture economico-politiche, evitando l’illusione del profitto immediato a scapito del bene comune.
Agio e morte
Ovvero parliamo di tutto, ma non di quello
«Adesso tu mi dici cosa cazzo ho».
Carlo non avrebbe mai pensato di arrivare a questo punto. Di essere messo al muro da un suo paziente.
Le mani di Giulio gli stringevano forte il collo, spingendolo contro un poster di Bianca e Bernie. Che poi, quel poster, in uno scalcinato studio di ematologia pediatrica a Giulio aveva sempre fatto ancora più paura.
Maledetti topolini. Giulio è talassemico, da quando è nato ogni mese una trasfusione e ’sta minchia di Desferal tutte le sere, ci mancano solo ’sti due scemi che guardano allegri. Hanno appena ristrutturato su al terzo piano il reparto Pediatria 1, ora sembra il PlayPlanet e si fa fatica a entrarci, sembra il tunnel dell’orrore.
Ma poi, perché ha una cartella clinica grossa il triplo degli altri ragazzi del reparto? Perché Carlo cambia sempre discorso? Perché nessuno ha spiegato com’è morto il loro amico Luca il mese scorso?
«Abbiamo tutti 18 anni o quasi e ci trattate come dei dementi».
«Giulio, hai l’HIV».
«Ma non poteva dirmelo prima? Pensavo molto peggio».
Era il 1994, a Milano, per l’HIV si moriva.
Carlo, con tutta la sua straordinaria devozione per bambini e ragazzi, i suoi colleghi, familiari e tutta la cerchia intorno ai ragazzi del reparto avevano aderito a quella che è stata definita la congiura del silenzio1. Ovvero parliamo di tutto, ma non di quello. Per paura, per un’idea di protezione, per provare a sotterrare l’angoscia, per le potenti metafore e pregiudizi intorno alla malattia, quella malattia2. E Giulio, con poche parole, ce ne ha descritto un effetto indesiderato.
Trent’anni dopo, siamo nel pieno dello storytelling del tipo “la vita è un figata” dal reparto oncologico, dei giorni di malattia fotografati e postati.
Splende di colpo così tanto sole su questi temi, sull’affresco fotografico di quei giorni in ospedale, da farci sospettare che Byung-Chul Han abbia le sue grandi ragioni a dirci che queste forme di esposizione – genuine e profonde per chi le propone – si intersecano in un grande non-racconto, dentro una selva oscura priva di ascolto e di vicinanza3.
Siamo così lontani da quel poster di Bianca e Bernie?
Senza perderci negli infiniti tentativi di definizione di agio e disagio, può essere interessante osservare quante nuove leve arrivino all’esercito del “o agio o morte”, dove la malattia diventa spettacolo e l’inquietudine psicopatologia.
Ed è un “esercito di pace” così pacificante da farci stare male.
1. Elisabeth Kübler-Ross, La morte e il morire. Cittadella editrice, 1976.
2. Susan Sontag, L’Aids e le sue metafore. Einaudi, 1989.
3. Byung-Chul Han, La crisi della narrazione. Informazione, politica e vita quotidiana. Einaudi, 2024.
ANNA LAMBERTINI
Paesaggi di resistenza
C’è una parola chiave che non smette di sollecitare la mia
attenzione: resistenza
C’è una parola chiave che non smette di sollecitare la mia attenzione e sulla quale mi trovo a indugiare da molto tempo nelle mie ricerche: resistenza. La s’incontra sempre più spesso, tra le tante affiorate in particolare negli ultimi decenni, in studi interdisciplinari interessati a indagare nuove espressioni dello spazio pubblico o caratteri emergenti di certi processi di trasformazione sociale di luoghi, paesaggi, insediamenti. Parola di uso comune, ‘resistenza’ indica genericamente «la capacità o la proprietà di resistere a particolari azioni o forze, fattori o effetti, contrari, dannosi o comunque negativi»1. Esprime un’opposizione, attiva o passiva, con cui qualcosa – o qualcuno – tende a impedire che una determinata azione raggiunga uno scopo.
Tuttavia, la sua etimologia, ma ancor di più gli ulteriori significati di cui è stata caricata nel Novecento, suggerisce di questa parola
anche altre sfumature di senso, che la rendono particolarmente adatta all’aggiornamento di categorie interpretative utili per descrivere e comprendere peculiari famiglie di spazi aperti dei paesaggi contemporanei.
Vale la pena di ricordare che ‘resistenza’, calco del francese résistance, derivato dal latino resistentia, trova la sua radice nel verbo resistere, composto dal prefisso ‘re-’ (che indica il ripetersi di un’azione nello stesso senso o in senso contrario) e da ‘-sistere’, traducibile in italiano con un’ampia gamma di voci verbali sia transitive che intransitive: far stare, collocare, porre, erigere, fermare, rafforzare, stare, stare saldo, presentarsi, fermarsi. Coerentemente con l’origine etimologica, l’espressione “fare resistenza” indica ad esempio un’azione di contrasto che implica l’immobilizzarsi, lo stare fermi per non cedere ad una spinta contraria. In questo senso, l’idea di resistenza parrebbe evocare un’azione conservativa, di mantenimento di uno status quo.
Non è così, però. In questa accezione connessa allo stare fermi, al fermarsi, al posizionarsi saldamente, viene facile trovare connessioni con il concetto di “restanza” inventato e descritto dall’antropologo Vito Teti2. Teti invita a riconoscere il diritto a restare nei luoghi in cui si è nati e cresciuti non come una scelta comoda o di accidiosa attesa, ma piuttosto come «un processo dinamico e creativo, conflittuale, ma potenzialmente rigenerativo tanto del luogo abitato, quanto per coloro che restano ad abitarlo». Restare come possibile atto di resistenza all’erosione del senso dei luoghi e come diritto alla loro risignificazione.
Nel corso della prima metà del Novecento, come ben sappiamo, la parola resistenza si è poi colorata di ben altre tonalità semantiche. Ha acquisito un marcato rilievo politico quando si sono cominciati a definire “di resistenza” quei «movimenti di opposizione e di lotta
armata che si determinarono durante la Seconda guerra mondiale nei Paesi occupati dai nazisti e dai fascisti, o comunque soggetti a regimi e governi filonazisti o filofascisti, contro gli occupanti e contro tutte le forze, politiche e militari, che collaboravano con essi»3. Oltre a indicare un fenomeno oppositivo, la parola resistenza è pertanto capace di evocare l’idea di forze democratiche proattive e propositive, espressioni di attivismo eco-sociale e di pratiche collettive ‘dal basso’ messe in campo per contrastare, ad esempio, scellerate e insostenibili politiche di trasformazione di luoghi e paesaggi o ambigui interventi di rigenerazione urbana. Pratiche – individuali o collettive, temporanee o di lunga durata –che sovente si traducono in forme di cura, gestione, reinvenzione di spazi fisici marginali, negati, sospesi, spesso dimenticati dai più ma non da tutti. In questo senso, prendendo a prestito quanto afferma lo scrittore Marco Balzano, la parola resistenza si rivela come la «più carica di futuro che ci sia»4.
Seguendo questa traiettoria di pensiero, altrove5 ho indicato i paesaggi di resistenza come realtà, situazioni, assetti di spazi aperti, dove è possibile trovare presidi, tracce, indizi ed esiti di azioni di opposizione a processi, pianificati e non, di trasformazione anonima, anestetica e acritica di luoghi e territori. Nei paesaggi di resistenza fermentano o sono attive politiche del possibile, forze di attrito disposte a opporsi e a contrastare l’avanzare di immaginari collettivi sterili e mortiferi, prodotto della «incapacità di immaginare l’altro, di immaginarsi con l’altro, di immaginare un altro modo di fare comunità»6.
Paesaggi di resistenza si rivelano dove trovano spazio pratiche eco-sociali che difendono il valore delle diversità, dell’incontro multiculturale, il diritto a vivere in luoghi comuni desiderabili. E dove si manifesta la forza di un pensiero critico capace di allevare, ad esempio, idee di natura alternative al paradigma
antropocentrico, estrattivista e determinista di nature for people. Dei paesaggi di resistenza fanno parte costellazioni eterogenee di giardini in movimento, orti-giardini condivisi, parchi sociali, spazi aperti del terzo paesaggio e della quarta natura, boschi di vicinato, prati urbani, campi coltivati con attitudine agro-poetica e ancora altre specie di spazi dove si afferma il diritto di coesistere e di coevolvere di spazi esterni e della naturalità diffusa di “altri”: irregolari, diversi, scartati, contesi, inconsueti, non propriamente conformi ai rassicuranti standard del cosiddetto verde attrezzato. Si tratta perlopiù di spazi e luoghi considerati di non eccezionale valore, ma talmente ordinari che quando vengono curati in modo speciale possono raccontare ed esprimere idee di bellezza fuori dal comune. È nei paesaggi di resistenza che possiamo sperimentare nuove categorie etiche-estetiche del quotidiano con le quali combattere la miseria percettiva e cognitiva che ci impedisce di affrontare la complessità del mondo.
1. Cfr. voce Resistenza, Treccani online, www.treccani.it/vocabolario/resistenza/. Ultimo accesso 11 aprile 2025.
2. Vito Teti, La restanza. Einaudi, Torino, 2022.
3. Cfr. voce Resistenza, Treccani online, www.treccani.it/vocabolario/resistenza/. Ultimo accesso 11 aprile 2025.
4. Si rinvia all’intervista di Annarita Briganti a Marco Balzano in la Repubblica, 13 maggio 2018, disponibile online al link: www.repubblica.it/speciali/robinson/salone-libro-torino2018/2018/05/13/news/ marco_balzano_quando_restare_vuol_dire_resistere-196299831/. Ultimo accesso 11 aprile 2025.
5. Mi riferisco a: Anna Lambertini, “Altro, Altrove. Farsi attraversare dai paesaggi di resistenza”, pp.101104 in Eliana Martinelli, Stages of Memory. Strategie per la rigenerazione dell’ex manicomio di San Salvi. Tab Edizioni, Milano 2023.
6. Matteo Meschiari, Geografie del collasso. L’Antropocene in 9 parole chiave. Piano B edizioni, Prato, 2021, p. 97.
La prima immagine è tratta dal libro Fame d’aria. Il papà alla fine abbraccerà Jacopo nella pioggia in un’ultima scena fortissima. Immagine vista come in un film. Il ghetto delle esclusioni dove non escludiamo parti oscure, non esiste sapere assoluto, ma solo figlio, figli, figlie, eutanasie inconsapevoli con frammentazioni di sguardi in un presente eterno. Per cambiare il mondo non servono i soldi, forse serve la mescolanza, questa nuova intercultura tra cinesi asiatici italiani pakistani. Tutti uniti per un nuovo modello a Prato. Un modello assoldati, sfrutta il tuo simile, non i simili degli altri altrimenti esplode tutto. Anche in queste oasi! Comunità tra esseri umani, anzi tra essere umano e ambiente. Da essere isole di ieri a essere oasi di oggi. Siamo qui a pettinare le acque, a scavare pozzi, a condensare le masse, a inarcare la schiena, a creare la vita. So stare nella relazione perché conta la relazione nel e tra le organizzazioni. Senza togliere voce, senza togliere diritto a essere sgradevole. Dal dare voce a portare il culo e stare zitti. Da repubblica delle banane a repubblica degli alberi. Lavoro benedetto: tutto benedico! Io benedico che ci tocca la bruttezza.
Prato di Villa, orto davanti a vigneto. Specie in via d’estinzione, speciali in via di estinzione. Allargamenti, parti oscure, periferie, abbazie. Abbiamo bisogno di sopravvivenza. Fame d’aria è perché hai troppa aria dentro. Liberarsi da aria in più. Per questo nei prati vanno api adulte. Biodiversità è difficile, non si improvvisa. La libertà espressiva è difficile per privilegiati che non arrivano ai
trent’anni. Questo ground di genere, generazionale, senza sprangate. Ground per dialogare con i vulcani, per tutelarci da colonialismi e capitalismi, per tutelarci dal terraforming. Dalla noce moscata, alla maledizione della noce moscata. Mancuso, Coccia, Boccia? Sguardi multipli da più lati. Free Earth: politicamente corretto e poeticamente corretto.
Film La vita segreta delle api, l’immagine potente della bambina completamente coperta dalle api (impotente). Da disumanità a bioumanità: l’incontro di api e fiori si è evoluto nel tempo. Le relazioni si evolvono: familiari, educative, professionali, amicali. Tutto deve mantenere la fase istituente. Murgia, citata più volte, che non combatteva malattia come battaglia o meglio non la combatteva. Vincere o perdere. Architetto solo di ieri, essere ieri, self made men, ieri eroe, oggi elefante solo che non vola più ma che sa bene dove fermarsi, dove fare le tappe. Partorendo collettivamente comunità plurali, non Comuni. Dove si può stare da soli a farsi i cazzi propri. Una città d’acqua, la nostra innovazione legata alla tradizione. Un visto per essere ridicoli! Una poligea, una policultura e perché no un po’ un poliamore.
Smielatura n.3
Di sonore relazioni, libere espressioni e arricchenti fragilità
La musicoterapia è al servizio delle situazioni di fragilità, ma non solo
«Per essere costruttiva, ogni relazione intima ha innanzitutto bisogno di spazio e di confini, nonché del rispetto, da parte di ciascuno, per “l’alterità” dell’altro»1.
Il risveglio, la consapevolezza, la volontà e la necessità di mettere in gioco, anche se più tardi dell’ordinario, i talenti che mi sono stati dati in consegna, nonché l’incidente/opportunità di ritrovarsi mamma di uno splendido bambino con un cromosoma in più, mi hanno portato recentemente a studiare musicoterapia.
Tutti gli argomenti che questo nuovo percorso mi sta facendo conoscere mi toccano profondamente, ma il concetto di setting in musicoterapia, in particolare, sta scatenando in me strati di riflessioni, nonché associazioni con quelle che potrebbero essere le buone pratiche dell’abitare la Terra e relazionarsi con i suoi abitanti, del tutto filtrate da una visione puramente e unicamente
poeticamente corretta, da studentessa quale sono, non ancora professionista della materia.
Il musicoterapeuta, nella costruzione del setting per la seduta con un/a paziente, deve mettere in atto tutte le strategie utili a favorire la massima libertà espressiva, facilitando una reale espressione del sé. In quell’atto improvvisativo dell’espressione del sé, la/il paziente può solo essere completamente immerso/a nel presente, nel “qui e ora”, ma in quel suo “qui e ora” c’è tutta la sua identità, culturale, sonora, emotiva, il suo passato, il suo vissuto, le aspettative e le speranze per il futuro.
Il setting si costruisce pensando non solo alla scelta degli strumenti sonoro-musicali da proporre al/alla paziente e alla dimensione fisica del luogo dove si svolge la musicoterapia («un luogo definito, riconoscibile, delimitato, costante, con una forte caratterizzazione architettonica, legato indissolubilmente ad una funzione»2), ma anche psicologica, «dove la relazione terapeutica si sviluppa e dove il paziente trova libertà di pensare, sentire ed esprimere»3, e acustica, evitando spazi fortemente riverberanti, avendo cura che ci sia buon isolamento dai suoni esterni, ma anche che le voci e i suoni interni restino nell’intimità del laboratorio di musicoterapia. Oltre a questi requisiti, che rientrano nell’ambito di quella che viene chiamata “cornice spaziale” del setting, occorre tenere conto della “cornice temporale” che riguarda, ad esempio, l’importanza della frequenza delle sedute di musicoterapia, della loro durata e delle fasi all’interno della stessa, e di quella “comportamentale”, che tocca la sfera dell’etica professionale e personale.
Il setting, anche se sviluppato nella stessa stanza, sarà chiaramente diverso per ogni paziente, in base all’anamnesi patologica e ad altri numerosi fattori, tra cui ad esempio l’età, le possibilità motorie, la verbalità o la non verbalità, le informazioni comportamentali, l’approccio alla musica.
Cosa c’entra tutto questo con la Terra e le relazioni tra i suoi abitanti?
In questa infinita cura nel creare un “ambiente” favorevole all’espressione libera dell’altro, io ci vedo un concetto universale dove protagonista è l’ascolto, un ascolto profondo che avviene non soltanto con le orecchie, ma anche con la testa, con le mani, con il cuore. L’intenzione di aiutare l’altro/a soltanto ad “essere”, a esprimere liberamente quello che è, senza etichette e preconcetti, e vedere, in questa condivisione dell’essere, un potenziale, una ricchezza per lei/lui, per sé stessi e per tutti. «Porsi all’ascolto è mettersi in relazione con il mondo, con l’altro dal sé, con il paesaggio sonoro in cui si è immersi. Ma significa anche ascoltarsi, sintonizzarsi con il proprio sé»4.
La musicoterapia è al servizio delle situazioni di fragilità, ma non solo. E l’atto dell’ascolto non riguarda esclusivamente la musica: «è fondamentale nelle relazioni educative ed è centrale in tutti quei servizi alla persona che mettono al centro la relazione di cura e di aiuto. Ne risulta, dunque, che ascoltare e mettersi in relazione sono un tutt’uno»5.
Aprirsi all’ascolto degli altri, ricercare i punti di contatto fra esperienze diversificate, analizzare il terreno comune, le fertilizzazioni reciproche, le ibridazioni felici che uniscono culture e modi di essere differenti. Ecco le pratiche (po-)eticamente corrette.
1. Massimo Borghesi, Andrea Ricciotti, “Il Setting in musicoterapia”, Quaderni italiani di Musicoterapia 4.
2. Ibidem
3. Ibidem
4. Luca Bertazzoni, Quaderni di Pedagogia e Comunicazione Musicale, volume 6/2019.
5. Ibidem
Distanza e metamorfosi
I fiumi avevano un diritto alla distanza dagli umani?
I fiumi avevano un diritto alla distanza dagli umani? Se anche lo avessero avuto non gli è stato riconosciuto. Oggi in Europa forse solo il Tagliamento è un fiume libero. Tutti gli altri sono stati costretti all’interno di argini, sempre più alti, sempre più –apparentemente – possenti. E gli argini solo dunque violenza. Essi costringono, riducono gli spazi di libertà dei fiumi, li rendono disfunzionali e quindi pericolosi. In una civiltà che ha eretto la concretezza a religione, la funzionalità della violenza degli argini è apparsa come costosa ma necessaria, salvo “dimenticarsi” della loro manutenzione, altrettanto costosa. Così i fiumi si vendicano e rompono gli argini. In tutta l’Emilia-Romagna, nell’ottobre del 2024, si sono allagate decine di migliaia di ettari. Ancora non esiste una stima definitiva. Solo nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma si sono contate 23 rotture di argini. Il 21 ottobre 2024, in provincia di Reggio si sono verificate simultaneamente 5 rotture di argini fra il torrente Crostolo e i canali Canalazzo,
Tassone e Cava, la cui sicurezza sarebbe dovuta essere assicurata dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Ma gli agenti della nostra arroganza verso la natura, nel momento in cui sono a corto di risorse finanziarie, diventano disfunzionali e non riescono a garantire la concretezza per la quale sono stati attivati.
In assenza di metamorfosi nel nostro rapporto con il territorio, con l’ambiente, con gli ecosistemi e al cospetto della crisi climatica che sta diventando sempre più estrema, incontrollabile e imprevedibile nelle sue manifestazioni e nei suoi effetti, la manutenzione diventa una pratica di rincorsa, incapace di riprodurre e garantire l’antica violenza che generò gli oggetti da manutenere.
Ecco che oggi, davanti ai nostri errori, dovremmo riconoscere quel diritto alla distanza che abbiamo negato non solo ai fiumi, ma alle montagne, disboscate per far spazio a innumerevoli e sempre più inservibili piste da sci, alle colline, disboscate, come in Romagna, per far spazio a coltivazioni intensive e ad alto valore aggiunto di kiwi e ciliegie, alle spiagge, alle cui spalle o anche sopra di esse abbiamo edificato milioni di metri cubi di edifici.
Distanza e metamorfosi oggi divengono le uniche pratiche possibili per proteggersi dalle reazioni della natura alla nostra violenza. Sono, in definitiva, le uniche azioni concrete – e costosissime – da mettere in campo, sapendo che dovremo imparare a fare quanto basta con quello che resta.
SILVIA DALLA ROSA
La violenza degli argini1
Decostruire linguaggi e semantiche per la giustizia ambientale
e sociale
Transizione, sostenibilità, inclusione, resilienza tutti termini entrati nella nostra quotidianità: popolari, sentiti, letti, abusati. Ne cogliamo il significato, anzi, fingiamo spesso di sapere a cosa alludono, attribuendone comunque un senso di bontà intrinseca. Li aggettiviamo per uno spolvero di contemporaneità ai discorsi, alle pratiche. Anche a quelle educative, soprattutto a quelle educative. Allora perché non stanno funzionando? Cosa non sta funzionando?
Sostenibilità è diventata una parola passpartout che non significa più nulla, ci dice Benasayag, un invito a fare attenzione solo per poter continuare come prima. «La sostenibilità non mette in discussione le logiche colonialiste, l’approccio antropocentrico e il paradigma neoliberista che hanno condotto l’umanità e i viventi fino a questo punto»2.
La transizione, soprattutto ecologica, porta con sé un senso di rassicurante gradualità, di cambiamento indolore del modello, di traiettorie quasi bonarie verso un futuro radioso in cui si ridurranno le emissioni, scompariranno i combustibili fossili, ma senza alcuna modifica sostanziale del nostro stile di vita3.
L’inclusione si rivela un concetto paternalistico fondato sullo squilibrio di potere che vede la maggioranza prima di tutto in diritto di escludere e poi, con un gesto caritatevole, di includere le minoranze, stabilendo arbitrariamente le condizioni dell’inclusione4.
E infine la resilienza: la panacea rispetto ai traumi, ai disagi. La capacità di adattamento, di assorbire gli urti senza rompersi. Un superpotere individuale, un voucher, un bonus che delegittima lo sguardo alle cause che portano disagi e traumi a stratificarsi sempre negli stessi luoghi, sempre sulle stesse spalle.
Transizione, sostenibilità, inclusione, resilienza: da concetti che potevano essere dirompenti, che dovevano interrogare il nostro modo di abitare il mondo e metterlo in discussione, a termini buoni per tutte le stagioni e per tutti gli usi, specialmente per il marketing aziendale. Pervasivo anche nelle nostre realtà sociali (cooperative come imprese, unità sanitarie oggi aziende, ecc.).
In un modello di sviluppo dove ad essere messa in discussione è l’universalità dei diritti (salute, istruzione, cittadinanza, libertà di movimento, ecc.) e che oggi, in nome di queste parole, individua ancora persone, territori e Paesi sacrificabili, legittima e ripulisce un colonialismo mai risolto, giustifica una delocalizzazione degli impatti e delle responsabilità. E ancora oggi in nome di queste parole si perpetuano conflitti, occupazioni di suoli e Paesi, distruzioni di paesaggi e natura, sfruttamenti di persone, con tutto ciò che ne consegue in termini di deforestazioni, inquinamento, mafie, migrazioni forzate. I fiumi in piena.
Perché le parole e le semantiche non condizionano solo le narrazioni, ma anche la nostra capacità di affrontare le sfide contemporanee, che hanno vincoli collettivi, e, nonostante una presunta democraticità, possono perpetuare logiche perverse. Spesso si sente dire come i danni ambientali siano democratici, non facciano distinzione di genere, razza, classe sociale… e che se l’aria o l’acqua sono inquinate, lo sono per tutte le persone. Probabilmente è vero. Ma non lo è del tutto. Perché, statisticamente, le industrie e le discariche più inquinanti e pericolose, tendono a collocarsi in aree popolate da minoranze povere. E, in modo eguale e contrario, le abitazioni vicine ai siti più inquinati e inquinanti, finiranno con l’essere abitate da persone che appartengono a minoranze povere e più le comunità sono povere, meno sono aggregate e meno hanno capacità di fare pressione politica5.
La narrazione di ciò che è non è mai neutra. Se le persone non sanno che disegno c’è dietro le parole che vengono loro propinate, queste parole perdono di senso insieme alla progettualità che vorrebbero rappresentare.
È quindi necessario un cambio di paradigma che dovrebbe essere accompagnato da un cambio di vocabolario. Per rispondere ai bisogni, per disegnare nuovi orizzonti, dobbiamo poter incidere sugli strumenti. Dobbiamo poter contare su un lessico all’altezza dei tempi e delle sfide. Viviamo un’epoca in cui la gradualità può essere fuorviante, le domande di futuro implicano una radicalità di scelte che deve trovare anche una sua definizione. Piuttosto che di transizione sarebbe allora meglio parlare di conversione ecologica come suggeriva Langer; la giustizia ambientale dovrebbe prendere il posto della sostenibilità; la convivenza delle differenze scalzare l’inclusione e la sua logica di dominio.
E la resilienza? Un cambiamento radicale richiede il coinvolgimento consapevole di chi lo deve interiorizzare e realizzare. Nessun
cambiamento radicale avviene senza massa critica e, soprattutto, senza gioioso slancio rivoluzionario6. Teniamo questo, teniamo il gioioso slancio rivoluzionario, come possibilità per cogliere la carica profetica della vulnerabilità. Che non deve essere ammansita. Per non disperdere l’energia del fiume in piena.
«Dentro l’oscillare di continuità e cambiamento, di attesa e di trasformazione, di cinismo individualista e di coesione collettiva, il respiro sociale cerca un proprio ritmo. […] In questi anni difficili e dopo un così lungo tempo trascorso nell’attesa bisogna prendersi il rischio di andare oltre»7, scegliere parole nuove e liberare il fiume.
1. «Tutti vedono la violenza del fiume in piena, nessuno vede la violenza degli argini che lo costringono», Bertolt Brecht.
2. Miguel Benasayag, Oltre l’antropocene. Per un’uscita critica dalla prospettiva antropocentrica verso pratiche concrete di sobrietà gioiosa, videoconferenza, GROUND 18 settembre 2023.
3. Stefano Liberti, in L’Espresso, 7 novembre 2021.
4. Fabrizio Acanfora, “La diversità è negli occhi di chi guarda: superare il concetto di inclusione della diversità sul lavoro”, agosto 2020, www.fabrizioacanfora.eu.
5. Luciana Grosso, “La nuova frontiera del razzismo è l’ingiustizia ambientale”, in L’Espresso, ottobre 2022; rapporto Caritas e Legambiente, Territori civili. Indicatori, mappe e buone pratiche verso l’ecologia integrale. Edizioni Palumbi, Teramo, 2020.
6. C. Petrini, “Transizione ecologica, non bastano due parole”, in la Repubblica, 12 aprile 2021.
7. CENSIS, 58° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, 2024.
Atlanti/de
Le mappe non sono solo territori da esplorare, ma tracce di quello che resta quando il cambiamento è inevitabile
L’Enciclopedia Einaudi del 1982 alla voce ‘Memoria’ associa alcune altre parole chiave: atlante, collezione, documento/monumento, fossile, memoria, rovina/restauro.
Nel titolo, le parole chiave sono elencate in ordine alfabetico, ma nel testo della voce enciclopedica la parola atlante arriva dopo qualche pagina, dopo che le parole memoria, fossili, documenti/ monumenti e collezione sono già state esplorate. Quasi a ricordarci come l’atlante contenga potenzialmente tutti i concetti precedenti.
L’atlante è definito come un «documento scritto particolare», una raccolta di carte geografiche, frutto di viaggi, esplorazioni, misurazioni e studi per «proiettare su una superficie piana un settore della superficie del globo terrestre con i suoi vari accidenti». E poi la rivelazione: l’atlante registra e trasmette una storia pluridimensionale e assai complessa. Registra e trasmette, annota e comunica. Qualcosa di complesso e stratificato.
L’atlante è tradizionalmente visto come una raccolta di mappe che tracciano confini e direzioni, ma è anche inteso come uno strumento di esplorazione e di relazione tra mondi. Assistiamo oggi a una nuova stagione di atlanti, con esperienze più o meno originali, che provano a rinnovarne il senso e reinterpretarne l’uso e le finalità. Oggi, infatti, l’atlante non è più un semplice strumento di orientamento geografico, ma una collezione di rappresentazioni che invita a riflettere sull’interdipendenza e sulle trasformazioni, sempre in divenire. Lo fa il Feral Atlas di Anna Tsing, in cui il numero effettivo di cartografie è molto limitato. Lo faceva già il Mnemosyne Atlas di Aby Warburg, che mette insieme atlante e memoria cinquant’anni prima dell’enciclopedia.
L’atlante, allora, diventa il luogo in cui raccogliamo e osserviamo le metamorfosi in atto. Ma nel momento esatto in cui proviamo a rappresentare qualcosa, a catturarne un attimo, l’oggetto del nostro atlante è già cambiato. Le trasformazioni, gli accidenti, non sono lineari né prevedibili, eppure l’atlante è lì per mostrarle, per ricordarci che il mondo non è mai statico. Le mappe, dunque, non sono solo territori da esplorare, ma tracce di quello che resta quando il cambiamento è inevitabile.
L’atlante, storicamente, rappresenta il bisogno di tracciare e comprendere il mondo, di fissare con precisione ciò che ci è dato conoscere. Le sue mappe sono punti di riferimento, guide che ci permettono di orientare il percorso e, al tempo stesso, di archiviare una testimonianza di ciò che è stato. Se da un lato è possibile tracciare confini, dall’altro dobbiamo riconoscere che ogni linea disegnata è permeabile e mutabile. Ancora una volta, la memoria. Di qualcosa che non è più, che è svanito, eppure ha significato, ha condotto fino a qui. Un’Atlantide, dunque, che si contrappone all’atlante, una tensione tra la rappresentazione del mondo e la sua distruzione, sul potere del sapere e la sua caducità.
Platone racconta il mito di Atlantide, descrivendola come una civiltà avanzata che, a causa della propria hybris, motivata dal tentativo di dominare la natura, viene distrutta da un cataclisma. Un monito niente affatto banale se lo rileggiamo oggi, alla luce dell’evoluzione delle società occidentali.
In questo senso, allora, l’atlante non è più solo un luogo di rappresentazione, ma può essere un invito a pensare e agire in modo responsabile. Le mappe sono state per secoli uno strumento di dominio, di controllo, di rappresentazione di una volontà, più che di una realtà. Utili a segnare confini, fissare limiti, definire forme finite. L’atlante, che pure può raccogliere mappe e cartografie, può oggi avere un senso diverso. Quello di catturare istantanee instabili di corpi e ambienti in mutamento. Pur raccogliendo le mappe di mondi conosciuti, costituisce una testimonianza della fragilità di quei mondi, di quegli Atlantidi.
Come Atlantide è destinata a scomparire, anche le mappe più precise e dettagliate svaniscono, cedendo il posto a nuove visioni e nuove rappresentazioni del mondo. L’atlante non è mai definitivo, ma è piuttosto una traccia di ciò che esiste ora, sempre vulnerabile al cambiamento. Eppure, nonostante la consapevolezza della mutevolezza del mondo e della fragilità del sapere, l’atlante continua a stimolare l’esplorazione del mondo e l’osservazione delle trasformazioni. Ci ricorda che, come nel mito, il mondo è sempre temporaneo e in mutamento.
In questo parallelismo, l’atlante e il mito di Atlantide diventano entrambi simboli di un equilibrio precario, tra il desiderio di comprendere e l’inevitabilità del cambiamento, tra la ricerca di stabilità e il riconoscimento della nostra vulnerabilità.
Green man walking
Oggi mi sento green perché passeggio lungo il fiume e osservo lo scorrere imperterrito dell’acqua
a
valle
Solitamente è camminando lungo la Brenta che il mio cervello fa le associazioni più bizzarre. Oggi mi ha riportato a un film del ’95, Dead man walking, dove Sean Penn interpreta un condannato, nel braccio della morte, un percorso senza speranza dall’inevitabile finale. Ovviamente non era questa l’associazione che il mio cervello voleva fare ma il gioco di parole che ne è venuto fuori, Green man walking, mi incuriosisce. Non è forse un morto che cammina l’uomo green? Chiedo un aiutino a ChatGPT, non so fare di meglio. Cosa vuol dire Green man walking? Esiste quest’espressione? Verifico. «Green man walking: può richiamare al simbolo del semaforo verde per i pedoni, suggerendo movimento, via libera e possibilità di avanzare». Vabbè speravo di capirne di più e, come al solito, mi ritrovo con un pugno di mosche. Oggi mi sento green perché passeggio lungo il fiume e osservo lo scorrere imperterrito dell’acqua a valle, ho perfino capito che
una parte s’infiltrerà e andrà a ricaricare la falda e che posso darle anche una mano a farlo con delle opere idrauliche che ne facilitano l’infiltrazione, andrò così a ricaricare la falda e quell’acqua la potrò bere depurata dalle piante e dagli orizzonti di sostanza organica, argilla, sabbia, limo, ghiaia e roccia.
Mi sento un vero Green man walking, respiro l’ossigeno donatomi dalle piante che mi circondano, mi sento in perfetto equilibrio, mi sento clorofillico. Sempre meglio che petaloso. Perché allora il mio cervello ha pensato a quel film, perché quell’associazione, quel gioco di parole. Ripenso quindi a quanto letto, ascoltato e studiato in queste settimane, mi sento di fatto tradito, un uomo verde (che ha sempre pensato green!!) che non capisce più dov’è finito il Green Deal del vecchio continente che invece programma il riarmo, verosimilmente con testate nucleari. Non capisco più dove sia finita la diplomazia della lungimirante Unione europea, la strategia!!! Quando abbiamo smesso di usare lo strumento della diplomazia e cominciato a fare programmi di riarmo? Dov’è finito il nostro principio di precauzione?
Mi piaceva l’idea del Green Deal, meno emissioni, energia pulita e rinnovabile, tutela della biodiversità, mobilità sostenibile, economia circolare, agricoltura sostenibile. Difficile? Si ma non è necessario provarci davvero? Come possiamo far conciliare questo con un programma di riarmo?
Per questo credo che il Green man walking debba ancora rappresentare un cammino di speranza, di rispetto, di precauzione, di strategia. Mi sento quindi di abusare della parola green, in fin dei conti con la parola resilienza non ci è andata molto bene.
I’m a Green man walking e su Marte non ci vado, a me piacciono la Brenta e la grappa!
STEFANO BALBI
Scienza aperta e tecnologia democratica per un futuro sostenibile
Viviamo in un’epoca in cui il legame tra politica, tecnologia e benessere collettivo non è mai stato così cruciale
Viviamo in un’epoca in cui il legame tra politica, tecnologia e benessere collettivo non è mai stato così cruciale. In questo inizio di 2025, la politica appare sempre più un esercizio di facciata, incapace di affrontare con serietà le sfide urgenti che minacciano l’equilibrio delicato tra ambiente, società ed economia. La tecnologia, invece di essere un motore di emancipazione, troppo spesso si piega agli interessi di pochi, amplificando disuguaglianze e minando la salute mentale delle persone e la legittimità delle istituzioni democratiche. La guerra commerciale è ormai iniziata, e quella militare sembra bussare alle porte di casa.
Dopo vent’anni di ricerca sulla sostenibilità e il cambiamento climatico, l’idea di abbandonare tutto per rifugiarmi con la mia famiglia in un angolo remoto del pianeta è tentatrice. Due consapevolezze mi trattengono ancora. La prima è che quel rifugio non esiste: siamo interconnessi, parte di un ecosistema
globale in cui nessuno può realmente isolarsi. La seconda è che sono coinvolto in un progetto scientifico-tecnologico che potrebbe rivoluzionare il modo in cui produciamo e utilizziamo la conoscenza, democratizzando l’accesso all’informazione di qualità e migliorando le decisioni che influenzano il nostro futuro. Non so come andrà a finire, ma qui voglio raccontare al popolo di GROUND una realtà possibile: un mondo in cui scienza e tecnologia siano davvero aperte e al servizio di tutti. Ma attenzione: la tecnologia, da sola, non basta. Senza un cambiamento politico, sociale e culturale, anche le innovazioni più promettenti rischiano di diventare strumenti nelle mani di pochi, rafforzando o peggiorando lo status quo.
Dalla crisi alla “cono-scienza” aperta per la sostenibilità. Le sfide legate alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo economico e al benessere sociale impongono la necessità di adottare politiche che superino le barriere tradizionali, favorendo spazi aperti di collaborazione e condivisione del sapere. La tecnologia aperta emerge come uno strumento fondamentale per abitare la transizione ecologica in modo inclusivo, favorendo la contaminazione di saperi e la costruzione di un terreno comune attraverso la “cono-scienza”.
La crisi ecologica che stiamo affrontando è ben più grave ed urgente di molte emergenze del passato, eppure le risposte che abbiamo dato finora sono state insufficienti. Pensiamo all’emergenza Covid-19: sebbene dolorosa, ha rivelato la nostra capacità di mobilitazione e solidarietà di fronte a una crisi globale. Abbiamo dimostrato che, quando necessario, possiamo mettere il bene collettivo al primo posto e adottare misure straordinarie, anche a costo di sacrifici e limitazioni. Certo, non sono mancate criticità – dalla compressione di alcune libertà individuali a un approccio tecno-globalista e per niente aperto nello sviluppo dei
vaccini (vedi Big Pharma) – ma resta il fatto che l’umanità ha saputo reagire. Perché, allora, di fronte a un’emergenza ancora più profonda, come il collasso climatico e ambientale, esitiamo ancora? È come se la società fosse bloccata da altre questioni, sempre più impellenti: l’accaparramento delle risorse naturali, i consumi, il profitto, i tassi d’interesse, ecc. La crescita economica a breve termine continua a essere anteposta alla stabilità ecologica di lungo periodo, come se il sistema potesse prosperare ignorando i limiti del pianeta.
La scienza della complessità ci offre un approccio sistemico per comprendere e anticipare le interazioni tra sistemi ambientali, economici e sociali, che permette di affrontare le sfide della sostenibilità non come problemi isolati, ma come parte di un insieme di relazioni dinamiche e multilivello. Piuttosto che cercare soluzioni lineari, si tratta di comprendere le connessioni, i cicli di retroazione (detti feedback loops) e le interdipendenze tra diversi elementi – ambientali, sociali, economici e tecnologici – che compongono un sistema più ampio. Attraverso modelli integrati, che simulano le componenti del sistema e le loro complesse interrelazioni, possiamo valutare gli impatti delle decisioni sulla sostenibilità su diverse scale temporali e spaziali – oltre il “qui e ora”. Questo non è solo un esercizio accademico, ma un’opportunità concreta per adottare scelte informate e responsabili, capaci di considerare le conseguenze a lungo termine sulle generazioni future e sull’intero pianeta, evitando soluzioni frammentate che rischiano di generare nuove criticità, invece di risolvere quelle esistenti.
Uno degli aspetti più significativi della governance basata sull’evidenza scientifica è la sua capacità di offrire ai decisori politici e alle comunità strumenti operativi per valutare i compromessi tra diverse strategie. L’uso di piattaforme distribuite
open access e open source consente di rendere trasparente il processo decisionale, favorendo la partecipazione attiva e il controllo diffuso sulle scelte che impattano l’ambiente e la società. La trasparenza e la condivisione dei dati diventano quindi elementi chiave per costruire fiducia tra istituzioni, imprese e cittadini, rafforzando il legame tra conoscenza scientifica e azione politica.
Collaborazione planetaria digitale per il bene comune
Perché questo potenziale si realizzi, è essenziale colmare le lacune di conoscenza e connettere su larga scala i saperi oggi frammentati, spesso generati da soggetti indipendenti e non coordinati. D’altronde, nessun singolo attore o istituzione può affrontare questa sfida da solo: solo attraverso uno sforzo collettivo e collaborativo è possibile costruire soluzioni efficaci e, al tempo stesso, rafforzare la fiducia nel processo decisionale. Con piattaforme aperte e dati accessibili, diventa possibile coinvolgere digitalmente una moltitudine di attori – ricercatori, istituzioni, comunità locali, imprese – nella cocreazione di soluzioni che tengano conto delle interdipendenze tra natura e società. Certamente, per farlo servono anche spazi fisici di confronto come GROUND, per immaginare e sperimentare nuovi meccanismi di incentivo a comportamenti sociali ed economici orientati alla responsabilità civica e al benessere collettivo –superando logiche basate unicamente su estrazione e sfruttamento.
Questa democratizzazione della conoscenza non beneficia solo i responsabili politici, ma anche ricercatori, imprese e comunità locali. La ricerca arricchisce la qualità delle conoscenze e delle metodologie disponibili per tutti, mentre le imprese possono integrare dati aziendali per mitigare i rischi e promuovere la sostenibilità. Le comunità locali, dal canto loro, possono valorizzare i saperi tradizionali, affiancandoli alle conoscenze scientifiche, contribuendo a un processo decisionale concertato e garantendo equità nell’implementazione delle decisioni sul campo.
Dunque, per un futuro sostenibile, è fondamentale investire in infrastrutture digitali aperte e interoperabili, capaci non solo di connettere dati e modelli, ma anche di creare legami tra persone e progetti all’interno di un ecosistema realmente accessibile e decentralizzato. A differenza delle piattaforme chiuse e proprietarie, che concentrano il controllo nelle mani di pochi attori, le infrastrutture aperte consentono una governance distribuita e trasparente, favorendo la condivisione equa della conoscenza e delle risorse. La progettazione di questi spazi digitali inclusivi non è quindi solo una questione tecnica, ma un atto fondativo che ispira nuove visioni del futuro, plasmando un terreno comune in cui l’innovazione è davvero al servizio della società.
L’ideale della conoscenza come bene comune e dell’uso pubblico della ragione si contrappone strutturalmente al paradigma mainstream dei giorni nostri, in cui il sapere è recintato, sfruttato e capitalizzato da pochi, perciò il rischio che venga cooptato all’interno di logiche neoproprietarie e di sorveglianza è concreto.
La questione fondamentale è se l’apertura e l’integrazione della conoscenza si tradurranno effettivamente in un accesso equo e in una redistribuzione del potere conoscitivo, oppure se diventeranno uno strumento che, pur apparendo inclusivo, continui a favorire le logiche estrattive di alcuni attori dominanti.
La tecnologia che (ancora) non abbiamo, ma di cui abbiamo bisogno
Questa è la sfida intrapresa da ARIES (ARtificial Intelligence for Environment and Sustainability), il progetto a cui lavoro, che oggi è diventato uno strumento adottato dalle Nazioni Unite per integrare la conoscenza umana e misurare il capitale naturale e lo sviluppo sostenibile in modo rigoroso e allo stesso tempo rispettoso delle peculiarità locali. Superando i confini della conoscenza proprietaria, la tecnologia aperta permette di sviluppare strumenti dinamici e adattabili alle esigenze
dei territori, rendendo la pianificazione della sostenibilità più inclusiva e consapevole. Certamente la tecnologia può essere un alleato in questo processo – ma non quella plasmata da miliardari sociopatici che si appropriano dei nostri dati per poi rivenderci prodotti o servizi di dubbia utilità.
Perché ciò accada, è fondamentale migliorare la raccolta e la standardizzazione dei dati, garantire l’interoperabilità dei modelli, promuovere una collaborazione più stretta tra ricercatori, decisori politici e altri stakeholder. Allo stesso tempo, dobbiamo sfruttare i recenti progressi tecnologici per potenziare la modellizzazione della sostenibilità. La connessione di una rete di conoscenze immensa e distribuita – che integri metodi scientifici peer-reviewed, grandi basi di dati raccolti sia da agenti umani che da sensori, modelli statistici e di machine learning, nonché gemelli digitali per la simulazione in tempo reale – apre nuove frontiere per un sapere più efficiente, modulare, curato da esperti, e connesso. Questo approccio consente non solo di validare ipotesi di azione in ambiente protetto, attraverso “laboratori digitali”, ma anche di incorporare le preferenze e le esigenze di diverse categorie di stakeholder in un’analisi realmente integrata. In questo modo, il processo decisionale può essere allo stesso tempo partecipativo e supportato da prove concrete, tenendo conto delle specificità locali e delle interdipendenze tra sistemi ecologici, economici e sociali.
Guardando al futuro, la chiave per migliorare le politiche informate dalla scienza risiede nella collaborazione e nella condivisione delle migliori conoscenze a nostra disposizione. L’approccio tecnologico qui proposto non è quello in cui le macchine interpretano e generano il linguaggio umano (il risultato del modello) sulla base di miliardi di parametri, dell’intero testo di internet e di algoritmi incomprensibili, come sta avvenendo con i large language models e i famosi chatbots. Piuttosto, è un
approccio di orchestrazione semantica della conoscenza in cui le macchine ci aiutano ad automatizzare la connessione tra pezzi di conoscenza attentamente ed eticamente generati e curati da scienziati, ricercatori ed esperti.
In conclusione: chi decide il futuro? Potere, tecnologia e giustizia.
Ma un approccio tecnologico è sufficiente? No. È fondamentale investire nella formazione alle competenze digitali, affinché chi prende le decisioni sappia comprendere e utilizzare gli strumenti di modellizzazione come supporto al processo decisionale, e non come verità preconfezionate. Esiste poi una dimensione culturale ed etica imprescindibile: l’inclusività nei processi decisionali e l’etica della scelta politica non possono essere delegate alla tecnica. Alla fine, chi decide e con quale finalità conta più della tecnologia stessa. La tecnica può aiutarci a navigare la complessità, ma la scelta di farlo è tutta nostra! Per questo l’innovazione tecnica deve andare di pari passo con un’evoluzione culturale che metta al centro la giustizia sociale e ambientale e la redistribuzione del potere.
Eppure promuovere l’accesso aperto ai dati, incentivare la collaborazione – specie a livello digitale – tra istituzioni, imprese e ricercatori, e investire nella formazione di nuove competenze restano passi necessari per affrontare la sfida della sostenibilità. Adottare un approccio aperto e collaborativo alla tecnologia non è solo una scelta strategica, ma una necessità per garantire un futuro sostenibile. E credetemi, di questi tempi, anestetizzati dal doom scrolling e con gli oligarchi del neofeudalesimo tecnologico al comando, questo è un atto profondamente rivoluzionario.
Post scriptum: proprio mentre scrivo (11/2/2025), due eventi “europei” mettono in luce le contraddizioni del momento storico attuale. A Parigi, i leader mondiali si sono riuniti per discutere di
Intelligenza Artificiale, confermando come il dibattito globale sia controllato da pochi attori economici e geopolitici, che considerano la tecnologia principalmente come strumento di potere, invece che mezzo per il bene collettivo. Invece che stabilire le condizioni affinché la tecnologia sia al servizio degli scopi pubblici, i governi cercano di attirare le compagnie Big Tech offrendo incentivi strategici (ad esempio, la Francia ha annunciato l’intenzione di destinare un gigawatt di energia nucleare alla creazione di una delle più grandi infrastrutture di calcolo, proponendosi come hub energetico per il settore). Nel frattempo a Bruxelles, la decisione dell’Unione europea di ritirare la Direttiva sulla responsabilità dell’Intelligenza Artificiale solleva dubbi sulla capacità di regolamentare efficacemente i rischi connessi a queste tecnologie. Sembra che il mondo abbia deciso di affidarsi a degli apprendisti stregoni proprio nel momento di massima vulnerabilità: dobbiamo assolutamente diminuire il consumo di energia, non aumentarlo! Le ultime rilevazioni climatiche parlano chiaro, mostrandoci un pianeta ormai avviato verso un aumento medio della temperatura di oltre due gradi rispetto ai livelli preindustriali, con il rischio di un collasso ambientale e sociale a livello globale già durante la decade 2030.
Rivoluzione quantica e comunità: gli impatti sconosciuti del progresso LUCA MAZZARELLA
Il 2025 segna il centenario dalla nascita della meccanica quantistica
Il 2025 segna il centenario dalla nascita della meccanica quantistica. Questa teoria rivoluzionaria permette di descrivere precisamente il comportamento di oggetti come atomi e fotoni (le particelle che compongono la luce). Essa è, inoltre, popolata di fenomeni bizzarri e apparentemente paradossali: particelle che si trovano in luoghi diversi allo stesso momento (principio di sovrapposizione), particelle che si comportano come onde e onde che si comportano come particelle (principio di complementarità), gatti allo stesso tempo vivi e morti, e correlazioni così poderose da propagarsi istantaneamente da un capo all’altro dell’universo come nel caso dell’entanglement (aggrovigliamento). Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger e Richard Feynman sono solo alcuni dei nomi dei fondatori di questa teoria; le loro vite sono anch’esse piene di contraddizioni e di aneddoti che hanno dell’incredibile, oltre a essere profondamente legate ad eventi segnanti del ’900 come le sorti della Seconda guerra mondiale.
Per un secolo la meccanica quantistica ha superato prove di ogni genere. Infatti, nientemeno che Einstein in persona mise in dubbio la validità del suo impianto teorico. Tuttavia, nel corso degli anni la sua validità è stata confermata da esperimenti sempre più sofisticati e dal sapore fantascientifico, come ad esempio il teletrasporto (disclaimer: non quello di Star Trek), in cui singoli fotoni e atomi vengono manipolati con altissima precisione in un modo che gli stessi fondatori ritenevano impossibile. Inoltre, la meccanica quantistica ha portato ad alcune innovazioni che sono uscite dal laboratorio e vengono usate nella vita di tutti i giorni come il laser e gli orologi atomici (fondamentali per i moderni sistemi di navigazione).
Nel corso dell’ultimo decennio, un numero crescente di università, enti di ricerca e aziende si stanno impegnando per sfruttare le proprietà della meccanica quantistica al fine di produrre miglioramenti in molteplici campi, tra cui il calcolo numerico, le telecomunicazioni e la metrologia. Sfruttando il fenomeno senza analogo classico dell’entanglement, infatti, si possono realizzare computer quantistici in grado di fare calcoli che richiederebbero centinaia se non migliaia di anni anche per il più avanzato super computer, come ad esempio la simulazione di molecole per sintetizzare nuovi medicinali. Nel campo delle telecomunicazioni, la meccanica quantistica permetterebbe di comunicare in modo sicuro al riparo da possibili intercettazioni e di preservare così dati sensibili, come ad esempio le cartelle cliniche. Infine, nel campo della metrologia, permetterà di migliorare la precisione con cui vengono misurate quantità fisiche come campi magnetici e gravitazionali. Questi miglioramenti permetteranno di effettuare scansioni del cervello umano non invasive, usando sensori compatti e dal costo ridotto rispetto alle tecniche attuali e di ottenere informazioni sulla composizione del sottosuolo senza dover effettuare scavi. In sintesi, computer più potenti, comunicazioni sicure e sensori più precisi.
Insomma, grazie alla meccanica quantistica si profila una vera e propria rivoluzione tecnologica, anche se non è facile stimare l’orizzonte temporale in cui queste nuove applicazioni raggiungeranno la maturità e saranno disponibili su vasta scala, al di fuori di laboratori specializzati e nella vita di tutti i giorni. Ancora più difficile è immaginare quali saranno i cambiamenti che queste produrranno a livello economico e sociale per le collettività.
Chat/doc? MORENA CADALDINI
Agnese si trova improvvisamente in un luogo che non conosce, pieno di luci, di rumori
Agnese si trova improvvisamente in un luogo che non conosce, pieno di luci, di rumori.
Alcune persone la circondano; le sorridono, ma il loro agire è rapido.
Non riesce a parlare, il braccio e la gamba di destra non si muovono.
Sente freddo, la coprono. La spostano in un’altra stanza, la mettono su un’altra cosa (dentro di sé sa che si tratta di una barella ma non riesce a dirselo e a dirlo). Lentamente percepisce che è in pronto soccorso. TAC e doppio accesso venoso, poi la terapia per tentare di riportare il flusso ematico nell’area cerebrale, che non lo sta ricevendo.
Agnese ha 78 anni, vive da sola; è vedova da circa tre anni. Ha due figli che abitano lontano. Lei ha voluto rimanere nella casa di campagna. Adora il suo orto e i suoi fiori. Sì, è vero, cammina col bastone per gli esiti di una frattura alla caviglia, il ginocchio dolente; ma riesce a prepararsi da mangiare, a vestirsi, a lavarsi. Per la spesa, l’aiuta una vicina. Per le pulizie della casa, una signora una volta alla settimana. Lei ama preparare i piatti con la verdura del suo orto. E poi ogni tanto passa anche qualche amica dell’infanzia, che ha rivisto dopo che è tornata al paese, una volta andata in pensione. I figli la chiamano quasi tutti i giorni. Insistono affinché ci sia un’assistenza più continuativa, ma finora non ce n’è stato bisogno. Lei ha sempre avuto una vita piena; ha “tirato su” due figli lavorando.
Agnese viene ricoverata. Inizia presto la riabilitazione neuromotoria e logopedica. Torna a camminare col bastone. Alla dimissione restano modestamente impacciati i fini movimenti delle dita della mano destra; nel parlare è meno fluente e talora la parola giusta non arriva; riesce comunque a esprimersi, a farsi capire.
La paura dei primi giorni è andata lentamente calando. Le domande rimangono tante. Questa volta è andata bene, ma l’ischemia cerebrale potrebbe ripresentarsi.
Cosa avrebbe fatto se avesse perso la capacità di camminare? Come avrebbe affrontato la disabilità motoria? E se non fosse più stata in grado di esprimere la sua opinione? E se l’ischemia le avesse tolto anche la possibilità di mangiare? E se non fosse più stata in grado di ricordare?
I suoi figli, ora, premono ancor di più per affiancarle una persona per l’assistenza, quotidiana, almeno durante tutto il giorno.
La rapidissima evoluzione della tecnologia e la sua inarrestabile applicazione in ambito medico hanno portato a un aumento della
longevità nei Paesi del Nord globale (e per le élite del Sud).
L’invecchiamento si accompagna alla malattia (in particolare quelle cronico-degenerative) e alla necessità di affrontare la disabilità che ne consegue, in una società che vede una quota crescente di anziani senza figli o con i figli che vivono lontano. Accanto alla necessità di cercare quali modelli di welfare sostenibile possano affiancarsi a quello fondato sulla famiglia, sulla quale finora si è fatto affidamento, rimane importante continuare a riflettere sul concetto di salute, sui cambiamenti che stanno travolgendo la medicina moderna.
Nel 1948 l’Organizzazione mondiale della sanità ha definito la salute «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattia o infermità».
Nel 1978 ha specificato che la tutela globale della salute dell’individuo si propone il fine di ottenere, nel rispetto della personalità dei singoli e dell’equilibrio dinamico uomo-ambiente, una vita socialmente ed economicamente produttiva per tutti. La malattia sopraggiunge inaspettata, coglie l’individuo di sorpresa; questi si trova ad affrontarla e l’attesa è che essa sia sconfitta, rimossa. Nella malattia cronico-degenerativa vi è la necessità di una convivenza dalle infinite sfumature, che dipendono dal tipo di patologia (dimensione biologica), dal malato (percezione soggettiva) e dalla comunità che lo aiuta ad affrontarla (dimensione sociale).
Nella medicina moderna, l’individuo dovrebbe essere posto al centro del percorso di cura, cercando un atteggiamento proattivo che gli consenta di esprimere i propri bisogni e i propri desideri, coinvolgendolo secondo le soggettive capacità residuali determinate dalla disabilità.
Le scelte personali (espresse verbalmente o per iscritto, come nelle direttive anticipate di trattamento) costituiscono la base dalla
quale partire per costruire il percorso che permetta di affrontare le varie fasi della malattia.
A che punto siamo?
Affinché ci sia effettiva libertà di scelta è importante che ci siano luoghi e occasioni di riflessione. L’individuo invece è sempre più solo e la relazione medicopaziente in continua evoluzione. Nel trattino oggi si nascondono il web e le sue molteplici risposte. La persona malata accede rapidamente alle informazioni sanitarie che esso sembra dare. L’eccesso di informazioni rischia di mettere sullo stesso piano aspetti che non lo sono. Le fonti non sono sempre attendibili.
ChatGPT (o forse DeepSeek?) potrà sostituirsi al medico nell’orientare le scelte degli individui delle future generazioni? Lo sta forse già almeno un po’? C’è il rischio che l’algoritmo tolga spazio all’esperienza, all’intuizione e alla fantasia che porta il sarto a cucire l’abito giusto per le occasioni speciali? Come valorizzare le risorse e i punti di vista del soggetto la cui salute è in questione, ma anche la rete di relazioni in cui è inserito? Dove ritrovare la dimensione sociale di elaborazione, fondamentale per evitare l’isolamento dell’individuo?
ADELE DONANZAN
Il paradosso del rispetto: oltre i limiti del politicamente corretto nel dialogo sulla disabilità
L’istituto dell’enciclopedia italiana Treccani nel 2024 ha scelto ‘rispetto’ come parola dell’anno
L’istituto dell’enciclopedia italiana Treccani nel 2024 ha scelto ‘rispetto’ come parola dell’anno. Un termine che evoca un valore fondamentale in tutte le relazioni umane. Tuttavia, quando parliamo di rispetto in ambito socio-sanitario, e in particolare nel lavoro con persone con disabilità, questo termine può assumere una forma che, paradossalmente, limita. Rispetto non significa solo conformarsi a una serie di regole che impongono un determinato comportamento ma, piuttosto, implica la libertà di esprimere pensieri, anche scomodi o difficili, senza la paura di essere giudicati o etichettati. In molte situazioni, soprattutto nel contesto della disabilità, ci si trova di fronte a un fenomeno che, purtroppo, diventa sempre più prevalente: il politicamente corretto. Spesso si tende a evitare le discussioni che possano sembrare negative o critiche nei confronti della disabilità, come se le opinioni che non rispecchiano l’ideale di inclusione universale e di rispetto assoluto possano essere percepite come offesa o pregiudizio.
La disabilità, come qualsiasi altra condizione, non è sempre associata a un’immagine totalmente positiva. Il politicamente corretto e il senso comune mettono in luce un’idea idealizzata rispetto al concetto di disabilità: generalmente ci si immagina una persona disabile sempre sorridente, positiva e integrata in contesti preposti a questo compito. Ma la realtà è ben più complessa. Non è necessario, e spesso nemmeno possibile, che ogni individuo con disabilità sia incluso in ogni contesto sociale per dimostrare di essere rispettato o valorizzato. Come possiamo, nel nostro lavoro, accettare che il rispetto non implichi sempre l’inclusione, ma piuttosto la libertà di essere sé stessi, anche nelle difficoltà e nei limiti? Secondo il mio punto di vista, la vera dignità di una persona con disabilità risiede nel poter usufruire di servizi che siano costituiti da operatori che detengano un adeguato livello di professionalità.
Il politicamente corretto, nella sua forma più restrittiva, tende a evitare queste riflessioni e a imporre una visione distorta: quella di una disabilità che deve essere costantemente celebrata e che non può essere vista in termini negativi.
Nel nostro lavoro con le persone con disabilità, spesso è presente la paura di essere giudicati o di essere vittime di fraintendimenti. La paura di dire qualcosa di “politicamente scorretto”, di non rispettare le aspettative di inclusività, è un peso che emerge nella relazione con l’altro. Come possiamo migliorare il nostro operato se non affrontiamo questi temi con sincerità e franchezza?
La condivisione di opinioni critiche, non dovrebbe condannare la persona a un etichettamento come “intollerante” o “discriminatorio”. Quanto è giusto, nell’approccio professionale, evitare di affrontare temi critici sulla disabilità per non sembrare “politicamente scorretti”? Non rischiamo, in questo modo, di ignorare una realtà che è molto complessa e ricca di sfaccettature?
Questo tema non coinvolge solo i professionisti, ma anche, e soprattutto, i familiari delle persone con disabilità che spesso sono vittime di questa stessa forma di politicamente corretto che limita la loro libertà di espressione. Il timore di non essere visti come caregiver “perfetti” o di non rispettare la visione idealizzata di ciò che dovrebbe essere una famiglia “inclusiva” li spinge a omettere frustrazioni, stanchezza e avversione. Quante volte un genitore ha il diritto di dire che è stanco, che non ce la fa più, senza che venga classificato come un cattivo genitore? Anche in questo caso, il rispetto deve significare poter narrare sinceramente delle difficoltà, dei limiti, delle emozioni complesse che accompagnano il vissuto personale. Come possiamo garantire che la libertà di espressione di ogni individuo, inclusi i familiari, sia tutelata, senza che il moralismo linguistico impedisca una discussione autentica e il riconoscimento delle diverse prospettive sulla disabilità? Il politicamente corretto, quindi, non dovrebbe limitare la libertà di pensiero e di espressione, ma, al contrario, dovrebbe favorire una discussione sincera, che abbraccia le difficoltà e le differenze senza annullarle.
Se il rispetto non riesce ad abbracciare la pluralità dei pensieri, se diventa un concetto rigido e classificante, allora non rappresenta un valore, ma un’arma per la marginalizzazione e l’omologazione.
Sono arrivato alla fine di questa terapia di gruppo.
Ho capito molte cose. Adesso posso parlare al maschile (buongiorno a tutte e tutti), quindi parlo di me. Posso dirmi uomo. Ho capito che sapevano tutto di me, di mio padre: «solo delusioni figlio mio, solo delusioni». Il fallimento è stata una grossa parte del mio processo artistico. Poesie imperfette senza correggere mai ciò che genera bellezza. Infallibile non esiste, nemmeno il Papa, nemmeno Dio. Solo decidere per ultimo: mi infilo in un’ecologia oscura. Partecipazione, non trattenersi, non trattenere. Destruire i vecchi, il vecchio, senza nessuna preposizione. Ci vuole un fisico bestiale!
Elogio del tradimento, tradiremo tutti perfino noi stessi. Erotici, divertenti, divergenti, dissentire senza dissenteria, profondamente leggeri, sulla fune, attenti a non cadere o a far cadere l’attenzione, la tensione (della fune). Mezzi per essere umani, per esseri umani. Spazzatura? Mi sento, divento un control free, un control freak, uscire da questa benedetta casa che mi ingabbia. Lottare contro abusi edilizi degli abusi di piccione. A posto così, q.b., quanto basta! Disabitare sogni stretti, oracoli e falò, lasciare infallibilità delle mie scelte alle carte, a un processo collettivo artistico, infinita energia del caso. Deorganizzazione, funzioni mobili, allestimento dei contesti, rapporti di affidabilità o di fedeltà, responsabilità, inclusione ennesima foglia di fico, meglio convivenza... AAAAIUTOOOOOO!!!!
Contagiami. Ricoprimi di ruggine. Oggi si parla di miele, ieri propoli, propolis, pro-poli. Via al televoto di vastità! Essere sempre io, eretico erotico errante. Ultima parola a un eforo. Ultima parola a un’efora: suolo, piedi sul suolo, uno a uno, evanescenti, con ironia, su pavimenti che non reggono, ovviamente scalzo, possibilmente muto, sicuramente nudo.
Smielatura n.4
Tutta colpa dell’architetto. Riscoprire l’evoluzione per errori
L’architetto è con tutta probabilità il professionista meno apprezzato dal pubblico generalista
L’architetto è con tutta probabilità il professionista meno apprezzato dal pubblico generalista, pochi ne comprendo l’utilità, molti lo ritengono futile e qualche volta persino dannoso. È un sentimento comune a varie latitudini ma particolarmente sviluppato in Italia, il paese con la più alta percentuale di architetti pro-capite del pianeta. Il saggio From Bauhaus to our House1 pubblicato da Tom Wolfe nel 1981 come critica alla disumanizzazione portata dall’architettura modernista è diventato nella traduzione italiana un lapidario Maledetti architetti2 . Il titolo ha stranamente riscosso grande successo tra gli architetti stessi, tanto da essere abbracciato dall’Ordine degli Architetti di Genova per una serie di camminate urbane nella città che «descrivono un rapporto spesso conflittuale, fatto di incomprensioni, insofferenza, polemiche e rancori tra progettisti e comunità»3. Franco La Cecla nel 2008 amplia la riflessione oltre la persona fisica nel pamphlet Contro l’architettura, una critica feroce a una disciplina sempre
più legata all’ego personale dei suoi protagonisti, perfettamente rappresentati dal ridicolo termine archistar, e scissa da ogni genere di utilità sociale: «gli architetti si rifugiano in una artisticità che li esclude da qualunque responsabilità. Purtroppo ad essi spesso viene affidata la trasformazione di interi pezzi di città, trasformazioni che spesso compiono con incompetenza, superficialità e convinti che si tratti di un gioco formale»4.
L’architetto è visto come la punta dell’iceberg di una società consumista senza alcuna attenzione al bene collettivo, non è una novità se pensiamo che Ayn Rand, la filosofa libertaria dell’individualismo americano nel suo romanzo-manifesto The Fountainhead5 affida proprio all’architetto Howard Roark, poi portato sul grande schermo da Gary Cooper, il compito di rappresentare l’individuo in lotta con il sistema uniformante. Adrian Brody nel recente The Brutalist6, premiato con tre premi Oscar e tre Golden Globe, riporta sulla scena la figura dell’architetto ossessionato dal proprio riconoscimento personale e opposto a ogni forma di comprensione e dialogo con la società.
L’architetto come individualista, autore egocentrico e autoreferenziale di opere spesso fantasmagoriche ma più spesso inabitabili, indispettisce la società nel suo complesso che fatica a comprenderne la figura e ad accettarne l’utilità. Il rifiuto si tramuta sempre più spesso negli ultimi anni in una negazione tout-court dell’architettura moderna e contemporanea a favore di una romanticizzazione del passato, visto come uno spazio idilliaco e rassicurante, comprensibile nelle sue dinamiche e nelle sue forme. Il movimento Arkitekturupproret, traducibile come ‘la rivolta dell’architettura’, nato in Svezia nel 2016 nasce per contrastare: «architetti che “ignorano palesemente” quello che vuole la gente: […] più di tre quarti della popolazione preferirebbe edifici di architettura tradizionale che siano in armonia con il
paesaggio circostante, rispetto a quelli ultramoderni, che a suo dire spesso comportano costi molto elevati e “imbruttiscono” le città, […] edifici che sembrino edifici, e non giganti scatole di scarpe, giocattoli o errori»7. La versione italiana chiamata Rivolta Architettonica rivendica un’architettura a partecipazione popolare, proprio perché tra le arti non è «la più raffinata, né quella che richiede maggiori competenze ma è la più importante perché è quella più prepotente […] l’architettura plasma l’ambiente in cui viviamo, determina il nostro piacere estetico e la fruibilità dei luoghi»8. Si tratta di gruppi con scarso livello di organizzazione in cui molto spesso elementi retrogradi e identitari possono infiltrarsi con lo scopo di promuovere una visione conservatrice della città e della società nel suo complesso. È il caso di alcuni dibattiti sui processi di ricostruzione in Germania, realizzati per ragioni storico-politiche a decenni di distanza dalla distruzione, in cui elementi modernisti che segnavano una netta rottura con il passato nazista sono sostituiti da edifici copie dell’antico che mettono insieme la volontà, popolare e innocente, di spazi più a misura d’uomo con piccoli gruppi di infiltrati con agende politiche estreme, è il caso di recenti progetti a Francoforte, Potsdam o Berlino «dove assistiamo a una tendenza culturale ad utilizzare termini apparentemente innocui come “identità”, “tradizione” e “bellezza” per stabilire un’idea di purezza etnica protetta da una fortezza Europa»9.
Come affrontare questo iato sempre più netto tra architetti e società evitando pericolosi scivolamenti è uno dei temi, completamente ignorato ma sempre più pressante, che i progettisti dovrebbero affrontare collettivamente. È forse arrivato il momento di ripartire dalla comprensione profonda della definizione di architettura data da William Morris nel 1881: «Il mio concetto di architettura è nell’unione e nella collaborazione delle arti, in modo che ogni cosa sia subordinata alle altre e con esse in armonia […]. È una
concezione ampia, perché abbraccia l’intero ambiente della vita umana; non possiamo sottrarci all’architettura, finché facciamo parte della civiltà, poiché essa rappresenta l’insieme delle modifiche e delle alterazioni operate sulla superficie terrestre, in vista delle necessità umane, eccettuato il puro deserto»10. Si tratta di una prospettiva ampia, pressoché onnicomprensiva, che trascende ogni considerazione di tipo scalare e abbraccia attività oggi non considerate parte dell’operato dell’architetto. È una definizione che ci interroga sulla possibilità di costruzione di un architetto saldamente cosciente della sua specificità nella comprensione e modifica dello spazio ma allo stesso tempo capace di sostenere dialoghi improrogabili e intessere collaborazioni necessarie con una moltitudine di saperi.
Gli strumenti che l’architetto dovrà sviluppare per riuscire a inserirsi attivamente nella prospettiva di Morris sono riassumibili in due caratteristiche fondamentali: la capacità di agire come collettore di saperi altri, umanistici e scientifici, traducibili immediatamente in fattori di modifica continua dello spazio e la predisposizione ad una visione anticipatoria e prospettica nel tempo, individuando un’idea di futuro e i differenti percorsi11 che possono portare alla sua realizzazione. L’architetto si configura come un anticipatore di spazi cangianti sviluppando sistemi di operatività progettuale strategica che abbandonano ogni visione statica e tendono alla continua modifica del processo allo scopo di raggiungere per progressive approssimazioni l’equilibrio dinamico desiderato. In questa visione l’architetto torna a essere un membro attivo della società in cui opera, partecipando attivamente ai dialoghi comunitari e accettando gli inesorabili errori.
Accettare l’evoluzione per errore, che è lo strumento che ha portato alla alta qualità degli spazi urbani storici, e l’incertezza dei risultati, rivoluziona in modo completo l’operato dell’architetto.
Scendere dal piedistallo e abbandonare ogni ego da demiurgo
riuscirà forse a riconciliare architetti e società, rendendo evidente il ruolo nella definizione degli spazi e nella costruzione di processi progettati e progettanti che caratterizza il pensiero architettonico. Non si tratta di forbite scelte materiche o di stupefacenti eroismi strutturali, ma di ricostruire un dialogo proficuo con la città e i suoi abitanti nella piena comprensione del ruolo di tutti e di ognuno. Per una architettura nuovamente grounded nel mondo.
1. Tom Wolfe, From Bauhaus to our House. Farrar, Straus & Giroux, New York, 1981.
2. Tom Wolfe, Maledetti architetti. Dal Bauhaus a casa nostra. Bompiani, Milano, 2001.
3. Vedi il sito dell’Ordine degli Architetti di Genova con la promozione della camminate urbane intitolate Maledetti Architetti. Genova e l’Architettura del ’900: un secolo di amore e odio.
4. Franco La Cecla, Contro l’architettura. Bollati Boringhieri, Torino, 2008.
5. Ayn Rand, The Fountainhead. Bobbs-Merrill Company, Indianapolis, 1943.
6. The Brutalist è un film del 2024 diretto da Brady Corbet che racconta della vita di László Tóth, architetto ungherese sopravvissuto all’olocausto ed emigrato negli Stati Uniti.
7. “Il movimento che ce l’ha con gli edifici troppo moderni”, Il Post, 12 agosto 2023.
8. Enrico Ratto, “Una rivolta architettonica per impedire alla bruttezza di conquistare la città”, Rivista Studio, 6 Marzo 2025.
9. Rowan Moore, “Is far-right ideology twisting the concept of ‘heritage’ in German architecture?”, The Guardian, 6 ottobre 2018. [T.d.A.].
10. “Prospects of Architecture in Civilizaition”, discorso tenuto da William Morris alla London Institution il 10 marzo 1881, traduzione in Mario Manieli Elia (ed.), William Morris Opere. Laterza, Roma-Bari, 1985.
11. Per una visione panottica delle tecniche di futurologia si veda Futuribles, The history and memory of foresight. Futuribles, Parigi, 2023.
Errare per natura
«A volte qualcuno trova ciò che non cerca»
«A volte qualcuno trova ciò che non cerca». Con queste parole il medico e biologo scozzese Alexander Fleming parla di una delle scoperte più rivoluzionarie della storia della medicina, quella del primo (e fondamentale ancora oggi) antibiotico: la penicillina. Le parole dello scienziato ben descrivono com’era andata, perché quella scoperta è stata frutto di un errore, frutto di una casualità. Nel 1928 Fleming stava studiando alcuni batteri e alcune delle capsule che li contenevano si contaminarono con una muffa di colore verde. Questo non era in programma, non doveva succedere. Però, quest’evento rivelò qualcosa di inaspettato: i batteri intorno a quella muffa non crescevano più, morivano. Quella muffa “assassina di batteri” fu scoperto essere la Penicillium notatum che con gli anni divenne la penicillina, uno dei farmaci che ha salvato e salva la vita a milioni di persone in tutto il mondo.
La scienza è costellata di grandi scoperte o teorie frutto di errori. E la natura stessa lo è, perché noi evolviamo per errori, grazie a mutazioni genetiche che casualmente avvengono e che portano a inaspettati progressi e conquiste. A volte può anche succedere che non portino da nessuna parte e che, anzi, ci creino qualche svantaggio, come la nostra appendice o i denti del giudizio rimasti “per errore”, che non sono più fondamentali e ci creano fastidi. Oppure, il nostro cranio molto grosso e che quindi porta a difficoltà nel parto, a differenza di quello che succede in altre specie vicine alla nostra. Insomma, pare proprio vero che “errare è umano”, ma potremmo piuttosto dire che “errare è naturale”. Gli errori esistono, ci sono, possono portare a qualcosa di straordinario e di utile, oppure a niente. Li commettiamo anche noi gli errori, continuamente, e solo riconoscendoli e analizzandoli, possiamo progredire, evitando di ripeterli oppure prendendone il frutto e creando qualcosa di nuovo.
In generale, siamo (ancora) troppo abituati a percepire l’errore come qualcosa di negativo, come qualcosa a cui deve seguire un giudizio, qualcosa per cui va trovato un colpevole più che un progresso e uno sviluppo. Forse perché ci fermiamo poco a pensare all’origine della parola ‘errore’, alla sua etimologia. ‘Errore’ deriva dal verbo ‘errare’, cioè, in prima battuta, ‘l’andar vagando, peregrinazione, vagabondaggio’ e poi ‘lo sviarsi, l’uscire dalla via retta’. E quindi uscire dal cammino che si era programmato ci fa sbagliare, ci fa andare in senso contrario. Da qui tutte le altre accezioni di significato che nel linguaggio comune prevalgono. Ma se restiamo fermi all’immagine del viaggio, come lo è l’evoluzione, come lo è una ricerca, come lo è un lavoro, e pensiamo che ogni tanto capiti di vagare casualmente e percorrere strade alternative, fuori dal percorso prefissato… allora errare potrebbe risultarci un fatto naturale, non una colpa. In fondo la vita stessa è un viaggio in cui anche uscire dalla strada principale può portare a conquiste inaspettate.
STEFANO MUNARIN
Riscoprire e riprogettare le reti minori come “labirinto
di libertà
multispecie”
Un invito a ripensare lo spazio pubblico immaginando nuovi modi di “vivere assieme”
Parlare di mobilità, che oggi implicitamente consideriamo diritto inalienabile della persona, vuol dire parlare di molte cose: di come ci muoviamo, di perché ci muoviamo, dei costi economici, ambientali, sociali, energetici, degli effetti che ha sulla forma della città e sul territorio. Ed è per questo che, da urbanista, me ne occupo: perché parlando di mobilità parliamo di come vogliamo “vivere assieme”, affrontando questioni ampie e centrali del nostro tempo: non si tratta di un tema specialistico ma di un modo per occuparsi di come viviamo e di come costruiamo il nostro ambiente di vita.
Mi interesso in particolare di mobilità attiva, per i seguenti motivi.
• Andando a piedi o in bicicletta (in sinergia con i mezzi pubblici) non siamo necessariamente “lenti”, anzi, possiamo essere veloci (ad esempio nell’attraversamento di una città) e, soprattutto,
siamo molto efficaci (consumiamo poco, non inquiniamo, non facciamo rumore, ecc.). Non è vero che solo chi viaggia a bordo di enormi SUV sta lavorando per il Paese e producendo PIL: andando a piedi o in bicicletta possiamo e sappiamo essere rapidi, efficaci, e financo “produttivi”.
• Fa bene alla salute, al corpo ma anche alla mente perché, come ci ricorda il neuroscienziato Shane O’Mara in Camminare può salvarci la vita, ci siamo evoluti muovendoci nello spazio con i nostri sensi, siamo dei “dispositivi cognitivi mobili”, camminando e pedalando teniamo accesi i nostri sensi, facciamo esperienza diretta dell’ambiente che attraversiamo, e da questo impariamo.
• Fa bene all’ambiente e alla città, sia perché riduce l’inquinamento diretto e indiretto, legato a produzione, utilizzo e smaltimento dei mezzi di locomozione; sia perché porta a pensare diversamente lo spazio pubblico, a progettarlo e costruirlo per essere più inclusivo, disponibile, giusto, e finanche bello. Richiede una maggiore “democrazia dello spazio pubblico” uscendo dal vicolo cieco (concettuale e reale) della separazione della strada in tante “piste” esclusive, tendenza che riduce lo spazio pubblico a “riserve indiane” che ogni categoria rivendica come proprio ambito monopolistico.
A partire da qui, esplorare il territorio a piedi o in bicicletta, osservando la forma delle cose e al contempo i soggetti e le pratiche. In particolare, anche grazie all’utilizzo di biciclette gravel (adatte a pedalare su ogni tipo di fondo: strade bianche, sterrati, argini, ecc.) sono uscito fuori dalle “rotte abituali” (strade asfaltate e piste ciclabili) riscoprendo quella fitta rete di “percorsi minori” che innerva il nostro territorio e non è ancora stata ridotta e omologata alle esigenze dell’automobile, non è ancora stata “autostradalizzata”. Pedalando mi ritrovo così, dentro al paesaggio,
e riconosco in questa rete un vero e proprio “labirinto di libertà multispecie”1 costituito da almeno tre elementi: 1) i percorsi (carrarecce, argini, sentieri); 2) i corsi d’acqua (fiumi, fossi, canali, rogge); 3) la vegetazione (filari, siepi, piccoli boschetti o grandi alberi isolati) che li accompagna. Nel loro insieme, e attraverso varie combinazioni, questi elementi danno luogo di volta in volta a diversi paesaggi e costituiscono un supporto pervasivo a servizio della mobilità attiva non solo degli umani, ma anche delle altre specie animali e vegetali, svolgendo al contempo un fondamentale ruolo idraulico.
Camminando e pedalando attraverso questo composito labirinto poi, mi ritrovo sovente in compagnia di varie “popolazioni” (anziani, atleti, famiglie, turisti di prossimità e viaggiatori di lungo corso, ecc.) che stanno finalmente riscoprendo le potenzialità di questa rete. Attraverso questa rete si condividono pratiche, matura un “sapere contestuale” che riscopre luoghi e porta con sé la voglia di prendersene cura, diventando sapere condiviso e rivendicazione di questi luoghi riscoperti dietro casa (gli argini di un fiume, un antico bosco, un vecchio mulino, ecc.) come beni comuni.
Giorno dopo giorno, singoli cittadini, piccoli gruppi di appassionati, associazioni, scoprono percorsi possibili, aprono pertugi e tracciati prima “vietati” o considerati inadatti o inadeguati (strade poderali, argini, sottopassi, ex ferrovie, sentieri, ecc.) comunicando ad altri le loro “scoperte” attraverso i social o iniziative di condivisone (bike festival, social ride, seminari, walkshop, ecc.), portando a condividere spazi prima negletti, che così diventano parchi de facto, ancor prima di entrare nell’agenda politica e venire istituzionalizzati.
Queste pratiche però, giustamente, non si accontentano di ciò che trovano: pongono nuove domande al progetto urbanisticoterritoriale, fanno emergere la richiesta di un modo nuovo di
intendere le “infrastrutture” per la mobilità attiva, non richiedono più solo “piste ciclabili” fatte di cordoli in cemento, fondo in asfalto, staccionate tipo saloon del West e lampioni urbani, ma ricerca di nuovi materiali di fondo (terra battuta, calcestre, cemento colorato, ecc.), valorizzazione delle preesistenze, adattamento del disegno all’ambiente nel quale il percorso s’inserisce, riuso e riciclo di ciò che già c’è.
Insomma, come per la lancia nel racconto Orazi e Curiazi di Bertolt Brecht, la mobilità attiva è «molte cose sono in una sola»2. Una cosa apparentemente semplice e “banale”, perché non ha bisogno di rilevanti investimenti e non sembra “tecnologicamente avanzata”, ma che può aiutarci a ripensare il nostro ambiente di vita e quell’immensa risorsa costituita dalle reti minori che caratterizzano molti territori, italiani ed europei. Come già detto, non sono un trasportista e nemmeno un economista o un veggente, non so come andrà il nostro futuro, so però che questa “cosa sola” può aiutarci (assieme ad altre) a rispondere alle tante emergenze che abbiamo di fronte e costituisce un invito a ripensare lo spazio pubblico, ripensare il progetto di suolo, immaginando nuovi modi di “vivere assieme” il tempo della mobilità.
1. Riprendo il termine “labirinto di libertà” dal libro Antiche vie del naturalista ed esploratore inglese Robert Macfarlane, (Einaudi, Torino, 2013). Ciò che mi interessa è proprio l’apparente paradosso: mentre associamo il labirinto a un luogo nel quale è difficili districarsi (soprattutto perché privo di gerarchie prima che di altre indicazioni esplicite), in realtà queste reti minori (sia interne ai nostri tanti centri antichi, sia distese su ampi territori) costituiscono ambiti di libertà, anche interpretative: ognuno di noi sceglie la sua via… di libertà.
2. Bertolt Brecht, “Gli Orazi e i Curiazi”, in Emilio Castellani (a cura di), Bertolt Brecht. Teatro. Einaudi, Torino, 1963.
MARIA BERLATO e CINZIA TASCA
Le
reti di prossimità nella disabilità: un’ambizione possibile?
Se pensiamo alla nostra vita senza disabilità certificate possiamo affermare di essere completamente autonomi?
Nel nostro lavoro con adulti con disabilità intellettiva spesso il focus della nostra azione educativa riguarda la relazione con l’altro. In una situazione laboratoriale diurna, come forse ancor di più in una comunità alloggio, una parte essenziale è la relazione con i pari. Questo processo risulta molto faticoso, pieno di insidie frequenti, incidenti di percorso, riaggiustamenti tipici di ogni percorso tra pari. Nella nostra esperienza abbiamo constatato che nella disabilità mentale si verifichi spesso una difficoltà a uscire dal proprio egocentrismo e pensare all’altro da sé. Perché ci “accaniamo” a insistere su un aspetto così complicato?
Da una parte l’interazione con altre persone è quotidiana, quindi renderla il più possibile adeguata alle regole di convivenza sociale è il primo fattore di una potenziale inclusione sociale. In seconda battuta, si aggancia a una visione più a lungo termine, che si lega al nostro modo di vedere e di vivere la società. Vorremmo
scavalcare il termine “autonomia”, abusato nella disabilità e non solo, per abbracciare una visione in cui la nostra vita viene vista come interdipendente rispetto agli altri. Se pensiamo alla nostra vita senza disabilità certificate possiamo affermare di essere completamente autonomi? In quanto esseri sociali abbiamo tutti bisogno di un intreccio relazionale che ci sostenga, e questo risulta ancora più importante se riguarda persone con fragilità.
In questo, anche le famiglie si trovano spesso in una situazione di solitudine, dove l’unica rete che riescono a creare è con altre famiglie con figli con disabilità. Un esempio è come viene impiegato il tempo libero di questi giovani adulti. Le famiglie, raramente supportate, trovano per i loro figli situazioni di benessere quali la piscina, il baskin, attività promosse da associazioni di volontariato. I ragazzi si trovano a frequentare gli stessi giovani/adulti, si conoscono tutti e durante la settimana si spostano tra le varie attività in gruppi formati più o meno dagli stessi protagonisti. Siamo ben lontani da una situazione che noi reputiamo si possa definire di inclusione. Le realtà frequentate dai nostri giovani adulti raramente sono frequentate anche da pari senza disabilità, se non in termini di volontariato; le attività proposte spesso sono pensate ad hoc per loro: se da un lato riteniamo siano necessari questi percorsi, dall’altro non possono esistere solo questi, con il rischio di settorializzare anche alcune attività che possono essere condivise da tutti.
Da qui la necessità di ripensare a un sistema differente, che preveda politiche di buon vicinato, di una condivisione che coinvolga sempre più attori, piuttosto che di reti sociali a maglie sempre più strette, formate cioè sempre dagli stessi protagonisti, unite ad un inevitabile cambio di pensiero a livello di politiche sociali del territorio e quotidiane.
In questo nostro agire quotidiano, ben consapevoli che non sia sufficiente ma contemporaneamente necessario, lavoriamo cercando di raggiungere dei codici comunicativi condivisi sia nelle relazioni tra loro, sia con gli sconosciuti, con le persone che rivestono diversi ruoli sociali (ad esempio con il barista posso rivolgermi in modo diverso rispetto al bigliettaio della stazione), con le persone che rivestono un ruolo di autorità… cercando di far diventare proprio un modo di relazionarsi che tenga conto dell’importanza delle personali modalità comunicative verso gli altri.
Risulta quindi un investimento non solo per il loro benessere di oggi, ma pone le basi per il loro domani. Si tratta, infatti, di una palestra continua per offrir loro la possibilità di apprendere competenze che saranno in grado di utilizzare anche in contesti meno protetti, dove non sempre ci sarà la mediazione di un operatore o di un familiare a sostenerli in maniera continuativa. Allenarli alla gestione di variabili e slegarli gradualmente dalle figure di riferimento che li accompagnano lo reputiamo un valore aggiunto, una risorsa in più in loro possesso per affrontare situazioni meno conosciute che si presenteranno nel lungo termine.
Continueremo ad “accanirci”, quindi, per raggiungere un obiettivo molto ambizioso, ma che riteniamo essenziale per gettare il pensiero oltre al già esistente, per immaginare e costruire per loro una prospettiva di vita sempre più indirizzata a un’idea di condivisione sociale.
GIOVANNA FERRETTI
Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore
Sono possibili evoluzioni se non c’è una cura quotidiana?
Il titolo di questa edizione di GROUND, Poeticamente corretto, mi ha preso immediatamente. Ha dato spazio, occasione di visibilità, a un verso che da molti anni mi accompagna:
Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore1 .
È un verso del Magnificat, che si recita alla sera, ogni sera, nel momento dei vespri. L’ho incontrato sul finire degli anni Settanta, quando nella mia parrocchia, in una piccola cappella, un gruppo di ragazze e ragazzi s’incontrava a recitare i salmi. L’ho fatto mio a poco a poco. Parole che ti costruiscono. Metamorfosi e manutenzioni. Sono possibili evoluzioni se non c’è una cura quotidiana?
Alda Merini ha scritto: «Mi piace la gente che sceglie con cura le parole da non dire». Ecco, prima di procedere a dare voce a questi
versi ho voluto andare a fondo di queste parole, come per essere certa che non fossero parole da non dire. Contemporaneamente, “poeticamente corretto” a me rimanda, non so se così fosse nelle intenzioni, un diritto alla distanza dal politicamente corretto, il diritto a una presa di posizione.
Ha disperso… gettato qua e là, sparso in varie parti. Un atto che non è solo perdersi, ma una separazione che non permette di connettersi, un muoversi disorientato sul terreno. Non sai dove sei. Una cosa persa si può trovare, una dispersa è introvabile. Perdersi e non disperdersi allora.
Lascia la porta aperta all’ignoto, la porta all’oscurità.
È da lì che vengono le cose più importanti, da dove vieni tu stesso e dove andrai.2
Quello che ci serve è un modo di perdersi, non ignorante né banale. Un modo di perdersi che comporta la capacità di essere pienamente presenti a sé stessi e di rimanere in una condizione di incertezza e di mistero. Condizione possibile solo se non pianifichiamo l’imprevisto, con progetti tanto razionali, quanto inflessibili, che lo rendono impossibile.
Non smetteremo di esplorare…3
… i superbi… ‘superbo’: che mostra enorme stima di sé, altero, sprezzante; magnifico, bellissimo, eccellente; da superbus “altero, arrogante”, ma anche “eminente, illustre”. Del latino superbus non è agevole spiegare la desinenza -bus. È incerto se derivi dalla radice sanscrita bhu (essere) o dalla radice greca ba (andare, da cui anche piede e parte opposta al vertice). Letteralmente un essere, un crescere
sopra: non è facile che una sola parola ci presenti insieme tanto biasimo e tanta ammirazione.
Molte le parole che rimandano al superbo: altezzoso, borioso, presuntuoso, sdegnoso e altre ancora, di sinonimi ce ne sono una caterva. Segno che la lingua (cioè noi) trova questo punto della realtà molto interessante.
La superbia è, dunque, una qualità articolata e complessa, propria di chi “va al di sopra”, di chi non sta a livello del suolo. Costui potrà abitare la terra? Noi quale contatto abbiamo con la Terra? Il superbo sta in relazione solo con sé stesso. I pensieri del proprio cuore prima o poi si incartano, però, e diventano persino noiosi, sempre gli stessi, sempre con lo stesso centro universale: il sé. Da una splendida solitudine alla paranoia il passo può essere brevissimo.
Quando qualcuno pensa che tutto gli sia dovuto, ed è convinto di possedere la verità si “dis-perde”. Non sa più dove si trovi realmente, vive in uno mondo suo, dove è l’unico re, l’unico dio. Crea un universo parallelo dove svaniscono i propri limiti. …nei pensieri del loro cuore…
L’unica saggezza che possiamo sperare di acquisire È la saggezza dell’umiltà: l’umiltà è infinita4 .
Per gli ebrei di duemila anni fa il cuore era la sede dei pensieri, non c’era una distinzione tra mente e cuore. Anche se un po’ tutti sperimentiamo questa percezione, nell’idea comune, forse non propriamente quella di questa platea, il pensare è al contrario un processo distinto dal sentire. La mente non considera ciò che il cuore dice.
Nella mistica ortodossa esiste la preghiera del cuore, nata con i padri del deserto e praticata dal pellegrino russo. Consiste nella
ripetizione di un’invocazione, ritmata sulle fasi del respiro. A un certo punto le parole non fluiscono dalla testa ma dal cuore.
“Ri-petere”, custodire, “ri-flettere”… nei pensieri del loro cuore… ha generato una sorpresa! Ho conosciuto, direi con il corpo, la sede dei pensieri. Eretico, erotico, errante.
Non smetteremo di esplorare
E alla fine di tutto il nostro andare
Ritorneremo al punto di partenza
Per conoscerlo per la prima volta. 5
… e allora potremo fare quanto basta con quello che resta.
1. Luca 1,51.
2. Rebecca Solnit, A Field Guide to Getting Lost. Penguin Books, 2005.
3. Thomas S. Eliot, Quattro quartetti, 1941.
4. Ibidem
5. Ibidem
Notizie sugli autori e sulle autrici
Stefano Balbi Ikerbasque Research Associate Professor, Basque Centre for Climate Change (BC3)
Maria Berlato educatrice, Cooperativa Conca D’Oro
Mattia Bertin ricercatore in urbanistica, Università Iuav di Venezia
Mauro Bossi redattore di Aggiornamenti Sociali, Compagnia di Gesù
Morena Cadaldini medica neurologa, ULSS 6 Euganea
Enrico Coniglio environmental sound recordist and sound artist
Jacopo Dalai psicologo e psicoterapeuta relazionale, Nivalis
Marta De Marchi ricercatrice in urbanistica, Università Iuav di Venezia
Silvia Dalla Rosa pedagogista, Rete Pictor
Adele Donanzan educatrice, Associazione Conca D’Oro
Elena Ferrarese giornalista
Giovanna Ferretti infermiera e consulente, Cooperativa Area
Gianfranco Franz professore di politiche per la sostenibilità e lo sviluppo locale, Università di Ferrara
Alessia Franzese assegnista di ricerca in urbanistica, Università Iuav di Venezia
Roberta Fusari architetta, funzionaria pubblica
Jacopo Galli professore di architettura, Università Iuav di Venezia
Anna Lambertini professoressa di architettura del paesaggio, Università di Firenze
Sara Lando artista e fotografa, Papermoustache
Marco Lo Giudice educatore, Cooperativa Adelante
Francesco Malavolta fotogiornalista
Luca Mazzarella fisico quantistico, Organizzazione olandese per la ricerca scientifica applicata TNO
Marie Moise docente in studi di genere e decoloniali, John Cabot University, Roma
Stefano Munarin professore di urbanistica, Università Iuav di Venezia
Riccardo Nardelli smielatore, Villa Angaran San Giuseppe
Michela Pace ricercatrice in urbanistica, Università Iuav di Venezia
Andrea Pase professore di geografia storica, Università degli Studi di Padova
Michele Patuzzi agrotecnologo, Cooperativa Conca D’Oro
Luca Pazzaglia educatore, Cooperativa Il Labirinto
Enrico Remonato agrotecnologo, Cooperativa Luoghi Comuni
Ennio Ripamonti psicosociologo, Rete Metodi
Francesco Scarel comunicatore della scienza, artscience
Agnese Sonato divulgatrice scientifica, PLaNCK! Magazine
Cinzia Tasca operatrice sociale, Cooperativa Conca D’Oro
Enrico Zarpellon animatore culturale, Walkabout – Perdersi e trovarsi nei libri
GROUND non è politicamente corretto. È poeticamente corretto. Non cerca risposte rassicuranti, ma immagini porose, mai definitive, capaci di generare nuove tessiture e intuizioni. GROUND dà spazio a voci altre — sopra e sotto il suolo — per accogliere nuove consapevolezze e immaginare nuovi equilibri. È un’agitazione collettiva, multistrato e multispecie, nata dall’urgenza di una ri-evoluzione possibile.