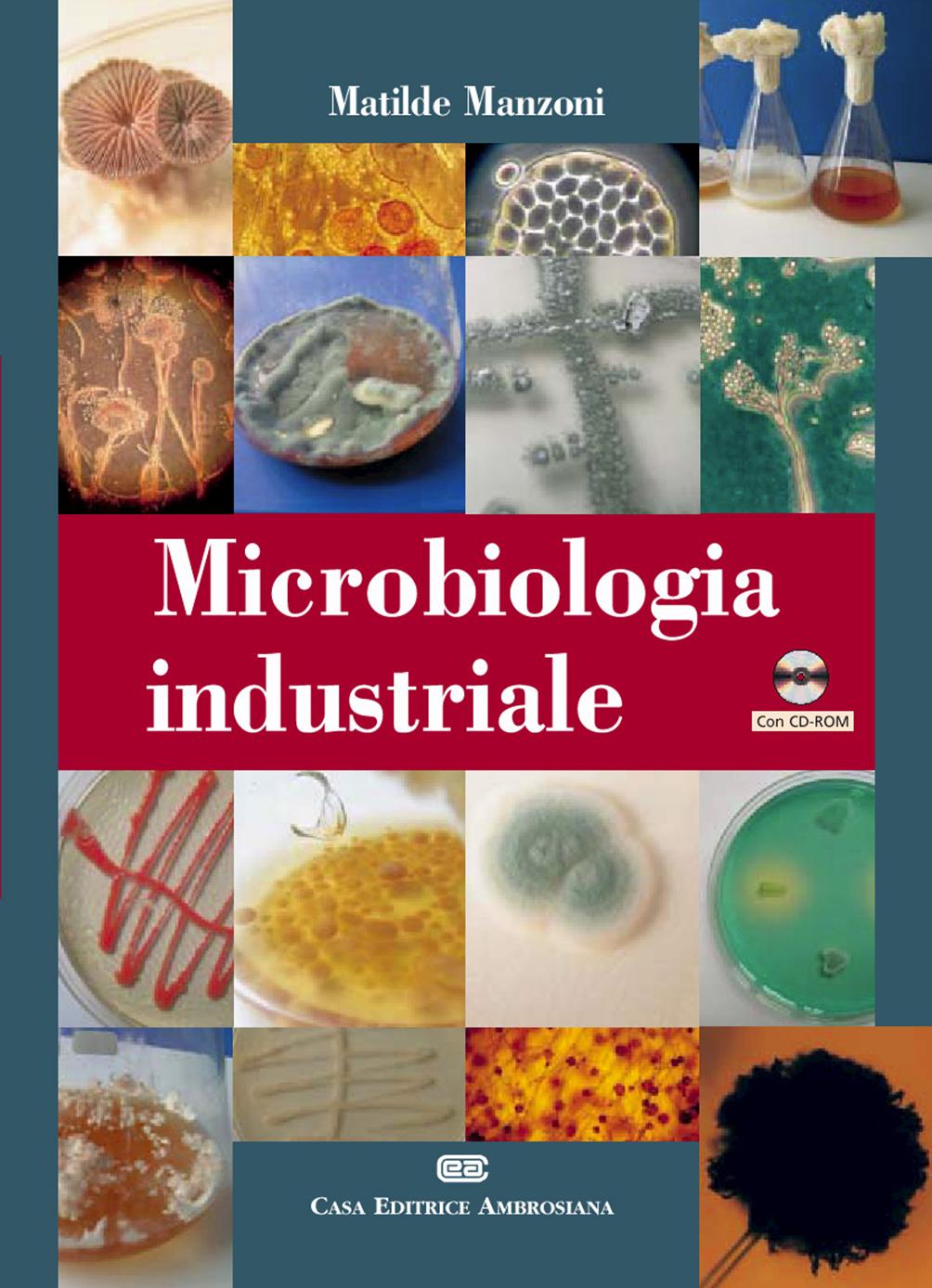
Matilde Manzoni

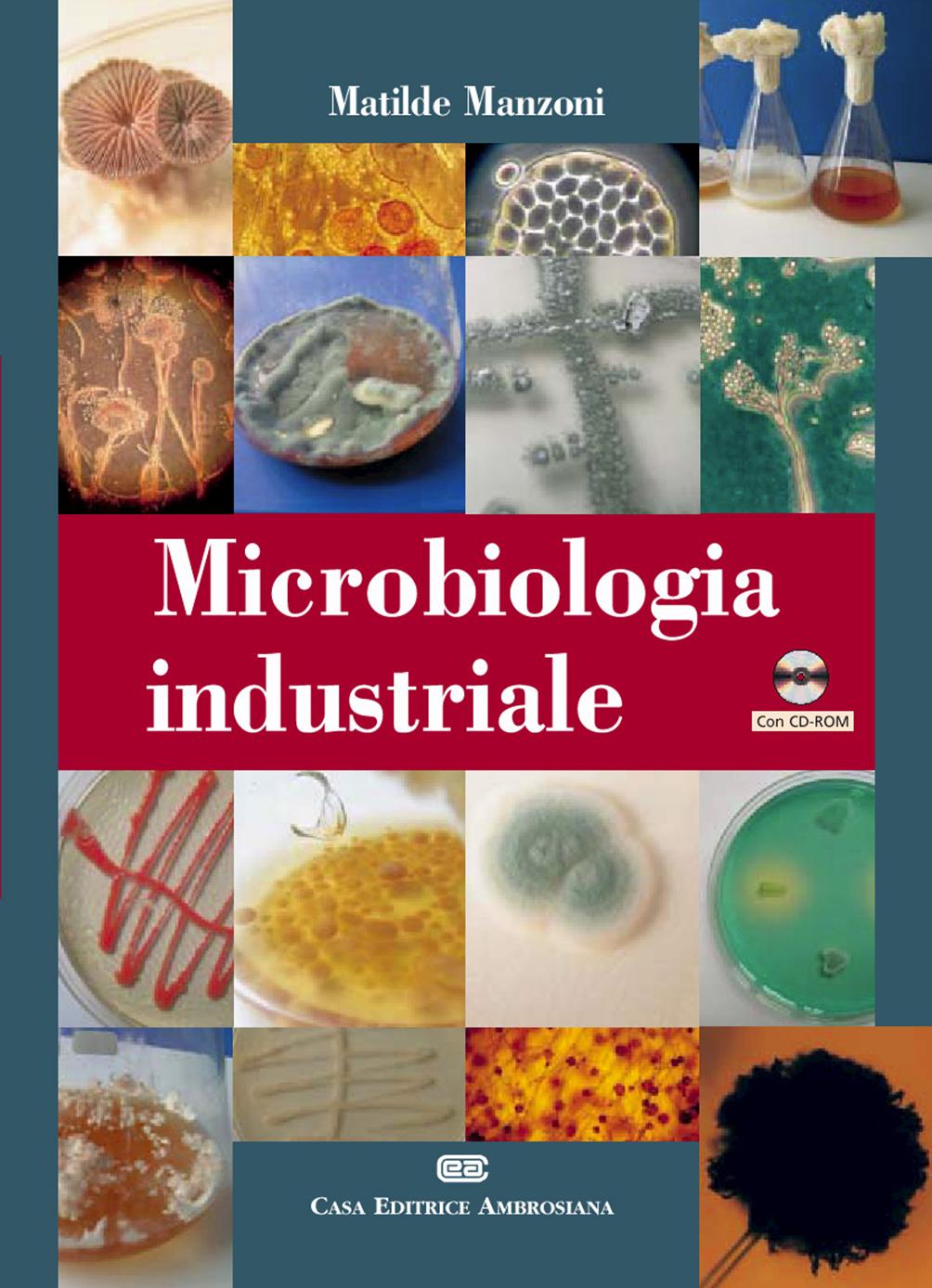
Matilde Manzoni
Copyright ©2006 C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi.
Fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale) nei limiti del 15% di ciascun volume possono essere effettuate negli esercizi che aderiscono all'accordo tra SIAE - AIE - SNS e CNA- Confartigianato - CASAdel 18 dicembre 2000, dietro pagamento del compenso previsto in tale accordo. Per riproduzioni ad uso non personale l'editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume. Le richieste per tale tipo di riproduzione vanno inoltrate a:
Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’ingegno (AIDRO) via delle Erbe 2 20121 Milano tel. e fax 02809506 e-mail: segreteria@aidro.org
L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale. La riproduzione a mezzo fotocopia degli esemplari di tali opere esistenti nelle biblioteche è consentita, non essendo concorrenziale all’opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell’editore, una successiva edizione, le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. Nel contratto di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei ed archivi, la facoltà di cui all'art. 71 - ter legge diritto d'autore.
Realizzazione editoriale: Epitesto - Milano
Impaginazione: BaMa - Vaprio d’Adda (Mi)
Copertina: Editta Gelsomini
Prima edizione: 2006
Ristampa
43210 20062007200820092010
Realizzare un libro è un’operazione complessa, che richiede numerosi controlli: sul testo, sulle immagini e sulle relazioni che si stabiliscono tra loro. L’esperienza suggerisce che è praticamente impossibile pubblicare un libro privo di errori. Saremo quindi grati ai lettori che vorranno segnalarceli.
Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro rivolgersi a: C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana via Gargano 21, 20139 Milano fax 02 52202260
e-mail: redazione@ceaedizioni.it
www.ceaedizioni.it
Stampato da Arti Grafiche Stefano Pinelli via Farneti, 8 - Milano per conto della C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana, via Gargano 21, 20139 Milano
Capitolo1–Processifermentativi1
1.1Evoluzionescientifica1 1.2Lebiotecnologie5 1.3Processifermentativi7 1.4Criteridiclassificazionedeiprocessifermentativi10 1.5Iprodottidellamicrobiologiaindustriale13 1.6Rese18
1.7Isolamentodeiprodottidellediverseclassi20 1.8Imicrorganismidellefermentazioniindustriali21 Bibliografia23
Capitolo2–Accumulimetabolicidiinteresseindustriale25
2.1Aspettimetabolici25 2.2Meccanismicoinvoltinellaproduzionedimetabolitimicrobici28
2.3Strategieperl’ottenimentodimetabolitimicrobici32 Bibliografia41
Capitolo3–Procedureperl’ottenimentodimetabolitimicrobici43
3.1Ottenimentodinuovimetabolitimicrobici43 3.2Screeningprimario46
3.3Screeningsecondario52 Bibliografia66
Capitolo4–Terrenicolturaliematerieprime67
4.1Esigenzenutrizionalideimicrorganismi67 4.2Composizionedeiterrenicolturali68 4.3Fontidicarbonio72 4.4Fontidiazoto80 4.5Fontidivitamineefattoridicrescita83 4.6Minerali85 4.7Agentiantischiuma85 4.8CorrettidipH86 4.9Precursori86 4.10Acqua87 4.11Gestionedellematerieprime87 Bibliografia88
Capitolo5–Ilfermentatore.Misureeregolazionineiprocessifermentativi89
5.1Tipidicoltura89
5.2Ilfermentatore91
5.3Sistemidicontrollo93
5.4Bioensori100
5.5Agitazione103
5.6Aerazione105
5.7Reattorinonconvenzionaliacircolazione111
5.8Sterilizzazionedelfermentatore113
5.9Criteridiscale-up116
5.10Aziendaeimpiantodifermentazione116
5.11Aspettieconomici119 Bibliografia120
Capitolo6–Immobilizzazionedicellulemicrobiche123
6.1Procedurediimmobilizzazione124
6.2Reattoripercelluleimmobilizzate130 Bibliografia136
Capitolo7–Aspetticineticideiprocessimicrobiologici137
7.1Curvadicrescita137
7.2Classificazionedelleproduzionimicrobiologichesubasecinetica139
7.3Biotecnologiadellefermentazioni142 Bibliografia148
Capitolo8–Valutazionedellosviluppomicrobico149
8.1Analisidellecolture149
8.2Valutazionedellesviluppomicrobico149 8.3Metodidiretti151
8.4Metodiindiretti155 Bibliografia159
Capitolo9–Isolamentodeiprodottidifermentazione(dowstream)161
9.1Separazionedellecellule163
9.2Strategiedirecuperodeidiversimetaboliti169 9.3Rotturadellecellule171
9.4Proceduredirecuperodeimetabolitimicrobiciextracellulari172 Bibliografia181
Capitolo10–Trattamentomicrobiologicodelleacquereflue183 10.1Classificazionedelleacquereflue184 10.2Parametricaratterizzantileacquereflue187 10.3Smaltimentodelleacquereflue:depurazionebiologica192 10.4Digestioneanaerobica201 10.5Meccanismicoinvoltinellabiodegradazione205 Bibliografia207
1-Biomassemicrobiche
1.1Biomassemicrobicheaelevatocontenutoproteico214 1.2Lievitoperpanificazione220 1.3Funghiacarpoforo225 1.4Biomasseparticolari:coltureinsetticidedaBacillus234 1.5Biomasseparticolari:Rhizobium236
La microbiologia industriale, e più in generale la microbiologia applicata, è basata sull’impiego di microrganismi come mezzo di produzione di beni e servizi, in condizioni controllate. L’elaborazione spontanea di materie prime alimentari, ad opera di microrganismi ambientali, costituisce uno dei primi esempi di applicazione non deliberata dei microrganismi. L’identificazione dei responsabili di tali processi ha dato il via alla microbiologia come disciplina scientifica, consentendo di individuare la modalità di svolgimento dei diversi processi e di convertire le biotecnologie classiche da tecnologie passive, a sistemi di trasformazione pilotati e controllati. Inoltre in tempi recenti le applicazioni delle tecniche genetiche hanno avuto un impatto rilevante sulle biotecnologie microbiche, permettendo la messa a punto di prodotti/processi che non sarebbe stato possibile ottenere con le procedure tradizionali.
Lo sviluppo di un processo microbiologico per l’ottenimento di un prodotto dipende dalle conoscenze scientifiche, associate alle richieste del mercato. In tale ambito questo testo introduce gli aspetti applicativi, relativi all’impiego dei microrganismi, che in relazione alla loro versatilità sono utilizzati su larga scala, per l’ottenimento di prodotti impiegabili in diversi settori. Il ruolo dei microrganismi è inoltre di fondamentale importanza a livello ambientale con lo sviluppo di processi, quali il trattamento degli effluenti e la produzione di biomasse impiegabili nel settore agronomico, che contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente.
Il testo è suddiviso in due sezioni, con la finalità di fornire al lettore gli strumenti e le conoscenze, relative allo sviluppo dei processi biotecnologici che prevedono l’impiego dei microrganismi. La prima parte, costituita da dieci capitoli, copre i diversi aspetti che sono alla base dei processi fermentativi. Il testo nel suo insieme, a partire dal ruolo chiave della fisiologia microbica, unitamente ai meccanismi coinvolti a livello metabolico, introduce gli aspetti coinvolti nell’accumulo dei diversi metaboliti, comprese le fasi biotecnologiche di processo.
Nei primi capitoli, partendo dall’evoluzione scientifica, viene offerto un quadro relativo alle diverse classi in cui possono essere inquadrati i prodotti della microbiologia industriale; sono inoltre analizzati i principali mecca-
nismi coinvolti nell’accumulo di metaboliti microbici. Questa parte è completata dalle procedure di screening, per l’ottenimento di nuovi ceppi/prodotti (capitoli 1-3).
Il capitolo 4 analizza gli aspetti più strettamente tecnologici dei processi fermentativi che rivestono un ruolo molto importante e hanno fortemente contribuito allo sviluppo di nuovi settori della microbiologia applicata. In tale contesto la scelta del substrato e la messa a punto del terreno colturale, in funzione del tipo del microrganismo e del prodotto da ottenere, rappresenta un punto cardine nello sviluppo di un processo fermentativo (capitolo 4). È infatti dalla sinergia microrganismo-substrato che dipende l’economicità dell’intero processo.
I successivi capitoli affrontano gli aspetti tecnologici relativi alla scelta e la messa a punto del bioreattore e ai sistemi di controllo. Lo sviluppo di modelli cinetici relativi alla crescita microbica, associata all’andamento del consumo di substrato e alla formazione del prodotto, ha inoltre consentito di intervenire in modo rilevante nella messa a punto e/o miglioramento dei processi microbiologici. Tutti questi aspetti consentono di definire strategie di azione su quei parametri, che maggiormente influiscono sull’economicità di processo. In questa parte del testo sono inoltre introdotte le procedure per l’immobilizzazione delle cellule microbiche, che in funzione dei risultati sino ad oggi ottenuti, hanno assunto sempre più importanza fino a costituire una valida alternativa all’impiego degli enzimi immobilizzati (capitoli 5-7).
La parte relativa agli aspetti tecnologici è completata dall’analisi delle procedure di isolamento dei prodotti di fermentazione (capitolo 9).
Questa parte del testo termina con un capitolo dedicato al trattamento microbiologico delle acque reflue, aspetto correlato al problema degli scarichi domestici, urbani e industriali, che ha assunto negli ultimi anni crescente importanza. I diversi paesi hanno predisposto leggi, in merito alla protezione dei corsi d’acqua, dagli inquinamenti dovuti ai diversi tipi di scarico, anche in recepimento di direttive in ambito comunitario, pertanto questo aspetto non può essere trascurato nello sviluppo e messa a punto di un processo microbiologico su larga scala (capitolo 10).
La seconda parte del testo è organizzato in schede relative ai singoli processi della microbiologia industriale. Questa impostazione ha la finalità di fornire allo studente le informazione relative all’ottenimento dei metaboliti microbici in forma schematica e dettagliata, in modo di favorire l’apprendimento.
Questa parte è corredata da una proposta di sperimentazioni pratiche di laboratorio, che si collegano sia alle procedure descritte nella prima parte del testo, sia alle schede relative ai processi. Il testo è completato da una documentazione fotografica allegata sia in Appendice che su CD Rom.
1.1Evoluzione scientifica
La moderna microbiologia industriale deriva dall’applicazione di agenti microbici selezionati per specifiche esigenze di processo. Le biotecnologie classiche hanno radici antichissime e il settore alimentare è uno dei campi di applicazione più vasto e più remoto. L’elaborazione spontanea di materie prime alimentari a opera di microrganismi ambientali costituisce uno dei primi esempi di applicazione, non deliberata, dei microrganismi. L’identificazione dei responsabili di tali processi ha dato il via alla microbiologia come disciplina scientifica, la quale ha permesso di individuare le modalità di svolgimento dei diversi processi (biochimica e fisiologia microbica), consentendo di convertire le biotecnologie classiche da tecnologie sfruttate passivamentea sistemi di trasformazione pilotati e controllati. La fermentazione del succo d’uva, la produzione di aceto, di diversi tipi di latte fermentato e di formaggi, sono esempi di processi basati sull’intervento di microrganismi che risalgono a tempi remoti (fino al 4000-2000 a.C.; tab.1.1). Questa fase basata su un impiego puramente empirico e inizialmente quasi magico, può essere identificata come protobiotecnologia.
Lo sviluppo dei processi microbiologici è avvenuto in tempi relativamente recenti; ad esempio, è solo alla fine del XVII secolo che la produzione di birra è stata avviata in condizioni che in linea di principio risultano analoghe a quelle attualmente impiegate, anche se tracce relative alla birra risalgono a Sumeri, Babilonesi ed Egiziani.
La nascita della microbiologia industriale coincide con gli studi di Louis Pasteur sulla fermentazione lattica e alcolica (1857). In particolare, le ricerche condotte hanno consentito di dimostrare che la fermentazione alcolica, e quindi la produzione di vino e birra, era il risultato di un’attività microbica e non un processo chimico. È in questa fase che è stata messa a punto la procedura di pastorizzazione applicata alla conservazione di alimenti e bevande, in particolare vino e birra. Occorre inoltre ricordare che i processi microbiologici sino alla fine del XIX secolo sono stati condotti in sistemi non isolati, cioè non sterilmente, condizione che
da tecnologie sfruttate passivamente a sistemi di trasformazione pilotati e controllati
studi sulla fermentazione lattica e alcolica
tecniche in coltura pura
produzione fermentativa di acetone e butanolo
è stata sviluppata in tempi successivi. In questa fase i processi su larga scala erano prevalentemente il trattamento delle acque di scolo e il compostaggio dei rifiuti solidi urbani.
Altro significativo contributo allo sviluppo della microbiologia a livello industriale è rappresentato dalla messa a punto delle tecniche in coltura pura a opera di Emil Hansen, presso la Carlsberg, in Danimarca. Per la prima volta, nel 1883, è stato infatti allestito il processo di birrificazione impiegando una coltura pura di un ceppo di lievito, il Carlsberg Yeast No. 1 (ceppo originariamente appartenente alla specie Saccharomyces carlsbergensis, ora riclassificato come Saccharomyces cerevisiae). È in questo periodo che è stato messo a punto, in Austria, il processo per la produzione di lievito da impiegare specificatamente in panificazione; tale processo era già noto in Olanda dal 1781.
I principali processi sviluppati nell’arco di tempo compreso tra il 1900 e il 1940 hanno consentito di ottenere numerosi prodotti su larga scala. In particolare, la produzione fermentativa di acetone e butanolo, sviluppata da Chaim Weizmann (1913-1915) impiegando un ceppo di Clostridium acetobutylicum, costituisce il primo esempio di processo allestito in condizioni di stretta sterilità e ha rappresentato la base per lo sviluppo successivo dei processi microbiologici. Un esempio rilevante è costituito anche dalla produzione di acido citrico, processo messo a punto agli inizi degli anni venti impiegando un ceppo di Aspergillus niger.
produzione di metaboliti
È negli anni quaranta che, in concomitanza della seconda guerra mondiale, la richiesta di chemioterapici (antibiotici) ha portato allo sviluppo del processo per la produzione di penicillina su larga scala. Questa fase è stata di fondamentale importanza per la microbiologia applicata e negli anni successivi i processi fermentativi hanno avuto un forte impulso nello sviluppo delle biotecnologie moderne. In tale periodo è stata infatti messa a punto la produzione di diversi metaboliti, fra cui alcune vitamine, aminoacidi, enzimi e steroidi. Si è inoltre assistito a profondi cambiamenti relativamente alle tecnologie di processo, con la costruzione di reattori di dimensioni variabili da 80 a 150 m3.
processi in coltura continua
Dagli anni sessanta i metaboliti microbici hanno suscitato particolare interesse e sono stati oggetto di studi per la ricerca di attività diverse da quelle antimicrobiche, precedentemente evidenziate. Le procedure di screening sono diventate via via sempre più sofisticate, fino alle attuali procedure miniaturizzate e automatizzate. Contemporaneamente è stata sviluppata la ricerca relativa alla produzione di biomasse microbiche, impiegabili come possibili fonti proteiche, che ha portato alla messa a punto di reattori non convenzionali, privi di dispositivi di agitazione meccanica. In tale contesto è stata inoltre sviluppata la tecnologia relativa alla coltura continua. I reattori hanno inoltre raggiunto dimensioni notevoli. Rilevante è stata l’applicazione della coltura continua nel processo per la produzione di biomassa microbica da un ceppo di Methylophilus methylotrophus impiegabile in alimentazione animale (Pruteen®) (Imperial Chemical Industries, ICI), allestita in un reattore appositamente sviluppato.
L’esigenza di protrarre nel tempo processi in coltura continua, in particolare di grosse dimensioni, ha portato all’introduzione di importanti innovazioni tecnologiche nei sistemi di fermentazione, fino all’impiego di dispositivi di controllo di tipo computerizzato. L’impianto relativo al pro-
cesso Pruteen®, pur rappresentando un enorme successo dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, in relazione ai costi non competitivi rispetto ad altre fonti proteiche convenzionali quale la soia, ha cessato la sua attività nel 1989, in concomitanza con la fine di una fase che ha portato a significative innovazioni nell’ambito dei processi fermentativi. Occorre inoltre ricordare che lo sviluppo delle tecniche riguardanti l’immobilizzazione di enzimi e cellule microbiche risale ai risultati ottenuti nelle ricerche svolte in quegli stessi anni.
In tempi più recenti, a partire dagli anni ottanta, si è assistito al passaggio di interesse da prodotti di basso valore, in grossi volumi, a prodotti di alto valore, in piccoli volumi. È in tale fase che, sfruttando l’ingegneria genetica, è stato possibile ottenere, come metaboliti microbici, molecole caratteristiche delle cellule animali (ad es. insulina, ormone della crescita, interferone ecc.), impiegabili in terapia umana. Le applicazioni di tali tecnologie hanno avuto un impatto rilevante sulle biotecnologie microbiche, consentendo la messa a punto di prodotti/processi che non sarebbe stato possibile ottenere con le tecniche tradizionali, basate sulla selezione.
In concomitanza con le applicazioni dell’ingegneria genetica si è assistito allo sviluppo della produzione di anticorpi monoclonali, fase che ha portato a un significativo progresso dell’industria fermentativa. La disponibilità di anticorpi monoclonali ha consentito una più ampia applicazione di impiego di tali prodotti, non limitato al solo settore analitico, ma anche a livello terapeutico (ad es. trattamento di diverse forme di carcinoma). Gli sviluppi successivi hanno portato all’ottenimento di colture di cellule animali per la produzione di molecole ad attività biologica. In tale contesto, in relazione alla limitata resistenza meccanica delle cellule animali, è stato necessario adattare e modificare le tecnologie fermentative sviluppate in precedenza per le cellule microbiche.
Occorre inoltre considerare che i progressi conseguiti, in tempi recenti, nell’ambito della produzione di molecole ad alto valore aggiunto, hanno in parte oscurato i progressi ottenuti nei processi relativi all’ottenimento di metaboliti microbici convenzionali. Alla fine degli anni ottanta sono stati poi sviluppati processi per la produzione di molecole quali le ciclosporine (immunomodulanti), che hanno consentito di ottenere progressi rilevanti nell’ambito dei trapianti di organi, e le statine, farmaci di fondamentale importanza nel controllo dei livelli ematici di colesterolo.
Gli anni novanta sono stati caratterizzati da un nuovo sviluppo dei processi su larga scala, basati sull’impiego delle tecniche genetiche, per l’ottenimento di diverse classi di prodotti, tra cui importanti molecole ad attività biologica (vaccini, ormoni, immunomodulanti ecc.), impiegabili per la prevenzione o la cura di diverse patologie.
In conclusione, in relazione ai più recenti successi relativi alle biotecnologie fermentative appare sempre più attuale quanto già affermato da Foster nel 1949: occorre non sottovalutare le potenzialità dei microrganismi.
tecniche di immobilizzazione
produzione di molecole caratteristiche delle cellule animali
produzione di anticorpi monoclonali
produzione di ciclosporine e statine
Tabella 1.1 Principali tappe biotecnologiche che hanno contribuito allo sviluppo della microbiologia industriale.
Processo/Prodotto Anno
Lievitazione del pane e produzione di vino (Egiziani)4000 a.C.
Produzione di birra e formaggi (Egiziani, Sumeri e Babilonesi)4000-2000 a.C.
Produzione di aceto da bevande fermentate (Egiziani, Assiri e Babilonesi) 4000-2000 a.C.
Produzione di etanolo per distillazione da bevande alcoliche (spirito di vino)1150 d.C.
Produzione di aceto (Orléans) dal XIVsecolo
Prima osservazione microscopica e nascita del termine “cellula”(R. Hooke) 1663
Primo birrificio (Canada)1668
Prima descrizione di cellule microbiche (A. van Leeuwenhoek)1675
Produzione di lievito per panificazione (Dutch process, Olanda)1781 (Austria)1846
Descrizione della fermentazione lattica (L. Pasteur) 1857
Ruolo dei lieviti nella fermentazione alcolica (L. Pasteur) 1860
Messa a punto della pastorizzazione (L. Pasteur) 1863
Studio di batteri in coltura pura (R. Koch) 1881
Produzione di acido lattico 1881
Sviluppo dei primi vaccini (colera, difterite e tetano) 1885-1890
Produzione di acetone e butanolo (C. Weizmann) 1915
Impiego per la prima volta (in forma scritta) del termine “biotecnologia” 1919
Produzione di acido citrico (coltura di superficie) 1923
Scoperta della penicillina (A. Fleming) 1928-1929
Sviluppo di processi in condizioni di sterilità 1940
Nascita del termine “ingegneria genetica” (A. Justin) 1941
Produzione di penicillina 1941-1944
Scoperta di altri antibiotici (streptomicina, tetraciclina ecc.) dal 1944
Prima descrizione della struttura del DNA(J. Watson e F. Crick) 1953
Produzione di acido citrico (coltura sommersa) 1955-1960
Isolamento dei primi enzimi di restrizione (H. Boyer) 1970
Primo impiego della DNAligasi (P. Berg) 1972
Nascita della tecnologia del DNAricombinante (S. Cohen e H. Boyer) 1972-1973
Creazione del primo ibridoma per la produzione di anticorpi monoclonali 1975
Primo kit diagnostico basato sull’impiego di anticorpi monoclonali 1981
Approvazione di impiego di insulina umana da Escherichia coli geneticamente modificato (clonata nel 1978) 1982
Primo vaccino da DNAricombinante a uso animale 1982
Messa a punto della PCR (K. Mullis) 1983
Produzione di altre molecole ad attività biologica (interferone, ormone della crescita, vaccino epatite B, eritropoietina, interleuchine, fattori della coagulazione ecc.) dal 1985
Primo prodotto ottenuto con l’ingegneria genetica per il settore alimentare (chimosina per caseificazione) 1990
Lancio ufficiale del progetto mondiale Genoma Umano 1990
Pubblicazione della sequenza Genoma Umano (Nature e Science) febbraio 2001
Tabella 1.2 Esempi di beni e servizi ottenibili dalle applicazioni biotecnologiche.
Beni
•Biomasse microbiche impiegabili in nutrizione animale e umana
• Commodities chimiche (acidi organici, alcuni aminoacidi ecc.)
•Specialità (antibiotici, vitamine ecc.)
•Inoculanti del suolo (azotofissatori) e delle piante (lotta biologica)
•Enzimi
•Probiotici e vaccini
Servizi
•Trattamento di rifiuti liquidi e solidi
•Valorizzazione di residui agroindustriali
•Diagnostica (anticorpi monoclonali)
Le biotecnologie microbiche trovano ampia applicazione nella microbiologia industriale. Con il termine biotecnologia si identifica l’applicazione deliberata e controllata di agenti biologici semplici, quali cellule (microbiche, vegetali, animali) vive o morte, o loro componenti, in operazioni tecnologiche utili per la produzione sia di beni, sia di servizi (tab. 1.2).
Il terminein senso stretto identifica l’attività riguardante la biologia molecolare e le tecnologie del DNAricombinante (ingegneria genetica), finalizzate ad applicazioni pratiche, che hanno portato allo sviluppo delle nuove biotecnologie. In senso lato, esso identifica le operazioni di biologia applicata a diversi settori.
Lo sviluppo di biologia molecolare, biochimica, genetica ela conoscenza del DNA, dei meccanismi di codifica, trascrizione e traduzione delle informazioni genetiche, hanno consentito una maggiore comprensione dei processi che stanno alla base del metabolismo microbico e ha aperto la strada alle biotecnologie innovative o avanzate.
Lo studio degli aspetti biotecnologici dei processi fermentativi ha inoltre dato origine allo sviluppo di una nuova disciplina, in seguito identificata con il termine biotecnologia delle fermentazioni. In tale ambito sono stati definiti i modelli cinetici relativi a sviluppo microbico, associato all’andamento del consumo di substrato e alla formazione del prodotto. Tali conoscenze hanno consentito di intervenire in modo rilevante nella messa a punto e/o nel miglioramento dei processi microbiologici, con conseguente azione su quei parametri (ad es. resa di fermentazione e resa di conversione) che maggiormente influiscono sull’economicità di processo. Inoltre, l’azione sinergica tra le discipline tecnologiche e quelle scientifiche (fig. 1.1), oltre a portare a rilevanti miglioramenti di aspetti prettamente tecnologici, quali l’aerazione e l’agitazione, ha consentito di realizzare tecnologie di fermentazione di tipo innovativo, quale la coltura continua. In tale settore i successi più recenti hanno portato allo sviluppo di nuovi bioreattori in grado di fornire prestazioni notevolmente superiori rispetto a quelli tradizionalmente impiegati, nonché alla messa a punto di processi che prevedono l’impiego di cellule immobilizzate.
applicazione deliberata e controllata di agenti biologici semplici
modelli cinetici di sviluppo microbico, consumo di substrato, formazione di prodotto
Meccanismi di regolazione
Biologia molecolare
Finanza
Economia di processo (materie grezze ed energia)
Miglioramento e selezione
Genetica
Biocatalizzatori (enzimi e cellule)
Sviluppo cellulare Formazione prodotto
Biochimica
Fisiologia microbica
Ingegneria chimica
Trasferimento di massa (ossigeno)
Ingegneria meccanica
Bioreattori, centrifughe, filtri ecc.
Tassonomia Metabolismo
Microbiologia
Progettazione di processo
Modellazione
Figura 1.1 Connessioni tra discipline scientifiche e tecnologiche nella messa a punto di un processo biotecnologico (Sikyta, 1995).
Introduzione
Le biomasse microbiche trovano applicazione:
•per il loro contenuto: come fonte proteica non convenzionale (in alimentazione umana e animale) e per l’estrazione di metaboliti particolari (lipidi, enzimi, acidi nucleici, vitamine ecc.);
•per la loro attività: su substrati complessi (lievito per panificazione, colture starter nel settore alimentare, come inoculanti del suolo, colture insetticide ecc.) e su molecole particolari (biotrasformazioni).
Gli animali e le piante hanno da sempre costituito le principali fonti alimentari di tipo convenzionale. Tuttavia anche i microrganismi, seppur in misura limitata, entrano nella catena alimentare (formaggi, funghi, lievito, alghe).
Composti organici e/o inorganici
Anidride carbonica
Energia
Presupposti
Energia solare
Affinché le biomasse microbiche possano trovare impiego, sia in alimentazione umana, sia in quella animale, occorre che i costi relativi alla loro produzione siano concorrenziali rispetto alle tradizionali fonti proteiche. La voce che maggiormente incide sui costi di produzione delle biomasse microbiche è rappresentata dal substrato (fino al 50-60% dei costi). Per tale motivazione i processi esistenti si basano sull’impiego di substrati economici (carboidrati semplici e complessi, sottoprodotti o surplus agricoli, alcani, metano, metanolo ecc.).
Limitazioni
L’utilizzo delle biomasse microbiche presenta, in alcuni casi, limitazioni d’impiego dovute ad aspetti diversi:
•contenuto in acidi nucleici, che presenta ampia variabilità, nell’ambito dei diversi gruppi microbici. Gli acidi nucleici possono creare problemi a livello metabolico nell’uomo e negli animali;
•presenza di sostanze tossiche o cancerogene, che residuano dal substrato (ad es. paraffine a catena dispari);
•digeribilità, che in alcuni casi è limitata (ad es. presenza di chitina);
•possibilità di reazioni allergiche.
Composizione percentuale di biomasse microbiche e fonti proteiche convenzionali.
BatteriLievitiMuffeAlgheSoia*Latte**
Proteine50-8045-6030-5545-6540-5032-35 Lipidi7-107-105-105-150,5-21
Acidi nucleici10-206-103-104-6-Minerali10-126-105-77-105-75-6
* Farina degrassata
** Scremato polvere
•Approvvigionamento dei singoli ingredienti che costituiscono il terreno colturale, ed eventuale pretrattamento delle materie prime grezze.
•Preparazione del terreno colturale costituito da: fonti di C e N, sali minerali, fattori di crescita ecc.
•Sterilizzazione del terreno colturale e dell’impianto.
•Stadio di fermentazione.
•Separazione della biomassa dal filtrato colturale (microrganismi unicellulari per centrifugazione, microrganismi miceliari per filtrazione).
•Trattamento finale della biomassa e stoccaggio.
SCHEMA GENERALIZZATO DI UN PROCESSO DI PRODUZIONE DI BIOMASSE MICROBICHE Stoccaggio prodotto
Stoccaggio ingredienti t.c.
Biomasse da batteri
•Generalmente ottenibili a pH compreso tra 5 e 7, range ad alto rischio di contaminazione.
•Biomasse caratterizzate da un alto contenuto proteico (fino all’80% p/p), ma anche da elevati livelli di acidi nucleici, soprattutto RNA(fino al 20% p/p).
•Biomasse che possono presentare problemi di separazione, in relazione alle piccole dimensioni.
•Buon profilo aminoacidico, in alcuni casi, carente in aminoacidi solforati.
Biomasse da lieviti
•I processi per la produzione di biomasse da lievito, su larga scala, sono in uso da lungo tempo. I primi processi risalgono a circa 100 anni fa.
•La velocità di crescita è relativamente elevata, ma inferiore a quella dei batteri.
•Il pH di sviluppo è compreso tra 3,5 e 5, range che riduce il rischio di contaminazione, rispetto ai batteri.
•Più facilmente recuperabili, rispetto ai batteri, in quanto presentano maggiori dimensioni.
•Biomasse caratterizzate da un buon contenuto proteico (fino al 55-60% p/p), leggermente inferiore rispetto a quello dei batteri. Contenuto medio in acidi nucleici (fino al 10%).
•Biomasse caratterizzate da un limitato contenuto in aminoacidi solforati, ma con un buon contenuto in vitamine del gruppo B.
Biomasse da muffe
•Le muffe sono caratterizzate da tempi di sviluppo più elevati, rispetto a batteri e lieviti.
•Le muffe si sviluppano in un range di pH compreso tra 3 e 8, ma è possibile operare a pH inferiore a 5, al fine di minimizzare il rischio di contaminazione batterica.
•Biomasse con un buon contenuto proteico (fino al 50%). Le muffe a più rapido sviluppo presentano un alto contenuto in RNA(fino al 15%). L’azoto totale comprende anche la chitina, costituente della parete cellulare, difficilmente digeribile. Il profilo aminoacidico è buono, anche se carente in aminoacidi solforati.
•Alcune muffe producono micotossine, evento da considerare nella scelta del ceppo.
Aspetti economici
Diversi fattori influiscono sull’economicità di processo:
•substrato: approvvigionamento, stoccaggio e pretrattamenti dei substrati (incidenza del costo del substrato in alcuni processi fino 50%);
• upstream: lavaggio fermentatore, sterilizzazione ecc.;
• downstream: separazione e successivi trattamenti – essiccamento ecc.;
• utilities: H2O, energia, vapore ecc.;
•costi variabili: manodopera;
•costi fissi: ammortamento, assicurazioni ecc.
Note conclusive
Trattamenti della biomassa
In funzione del tipo di uso, umano o animale, e del substrato impiegato, potrebbe essere necessario trattare la biomassa a fine processo:
•può sussistere l’esigenza di eliminare residui del terreno colturale, per esempio nel caso di produzione di biomasse da n-paraffine;
•in relazione al contenuto di particolari molecole, per esempio RNA. La rimozione dell’RNAè generalmente effettuata per attivazione delle ribonucleasi endogene, presenti nelle cellule microbiche.
Introduzione
Il termine Single Cell Protein (SCP) è stato coniato alla metà degli anni Sessanta dal MIT(Massachusetts Institute of Technology, Stati Uniti). SCPidentifica le biomasse microbiche a elevato contenuto proteico, impiegabili in toto, per le loro caratteristiche dal punto di vista nutrizionale, in alimentazione umana e animale. Le biomasse microbiche, in funzione della loro composizione chimica, possono, infatti, costituire un valido contributo alla risoluzione dei problemi legati alla carenza di proteine a livello mondiale, andando a competere con fonti di proteine di tipo tradizionale.
Presupposti
Igienico-sanitario
Assenza di patogenicità e valutazione di eventuali manifestazioni allergiche.
Microbiologico-tecnologico
•Stabilità genetica.
•Specificità per il substrato.
•Esigenze nutrizionali.
•Separabilità.
Nutrizionale
Composizione della biomassa e relativo valore nutrizionale.
Economico
•Substrato impiegato in relazione alle rese ottenibili.
•Tecnologia impiegata (batch, coltura continua, downstream).
•Gestione di processo in relazione alla scala.
•Investimento finanziario.
Produzione di Single Cell Protein
Fonti di carbonioGeneri
CO2
Spirulina Chlorella
Metano Methylomonas Methylococcus
Alcani Yarrowia
Metanolo Methylophilus Candida Pichia
Etanolo Candida
Glucosio da amido Fusarium
Inulina Candida Kluyveromyces
Melasso Saccharomyces Candida
Siero di latte Kluyveromyces
Liscivio solfitico Paecilomyces
Residui cellulosici Agaricus
Note conclusive
Dagli anni Sessanta sono stati sviluppati numerosi processi per la produzione di SCP, impiegando un’ampia gamma di substrati e microrganismi appartenenti a più generi e specie. Tuttavia un limitato numero di impianti è oggi funzionante, in alcuni casi in relazione ad aspetti di tipo economico e/o legati allo scale-up di processo.
AspettieconomiciAspettidi scale-up
•Impiego di substrati economici.•Richiesta di ossigeno e suo trasferimento.
•Incremento delle rese.•Gradienti di nutriliti e temperatura.
•Incremento del valore nutrizionale/•Difficoltà a rimuovere la composizione delle proteineCO2 nei processi aerobi. da microrganismi.•Effetti della pressione idraulica
•Valorizzazione dei sottoprodotti.in fermentatori di grosse dimensioni.
•Riduzione dei costi di downstream.
Substrati
Metano
Numerosi sono gli studi che hanno previsto, per la produzione di biomasse microbiche, l’impiego del metano, idrocarburo gassoso. Le limitazioni al suo utilizzo, dovute al rischio di esplosione e alla difficoltà di trasferire due gas (ossigeno e metano) nelle colture, possono essere superate con impianti che prevedano grossi investimenti dal punto di vista tecnologico.
Alcani
Possono essere impiegate paraffine dal C9 al C18. Quelle a corta catena hanno un effetto solvente sulla frazione lipidica delle membrane cellulari. Gli alcani dal C10 al C18 sono scarsamente solubili in acqua e questo può creare problemi a livello di trasporto all’interno della cellula. Il loro impiego è condizionato dal miglioramento delle condizioni biotecnologiche di processo.
Metanolo
I substrati impiegati per la produzione di SCP possono essere:
• di origine fossile,
• di origine rinnovabile.
SUBSTRATO
Rinnovabile
CO2
Glucosio (da amido)
Melasso
Siero di latte
Cellulosa
Liscivio solfitico
I problemi legati alla produzione di biomassa da metano possono essere superati impiegando il metanolo. Questo substrato, totalmente solubile, presenta minori rischi di esplosione ed è utilizzabile da più microrganismi; ha tuttavia, in funzione della concentrazione, effetti tossici.
Etanolo
È utilizzabile da microrganismi appartenenti a tutti i gruppi microbici. Non presenta effetti tossici.
CO2
È la più semplice fonte di carbonio rinnovabile, può essere utilizzata solo da microrganismi in grado di ottenere energia da meccanismi indipendenti.
Melasso
Costituisce il sottoprodotto della lavorazione della barbabietola e della canna da zucchero, è impiegato nei processi che prevedono prevalentemente l’impiego di Saccharomyces cerevisiae e specie del genere Candida.
Siero di latte
Costituisce il sottoprodotto dell’industria casearia, è impiegato dopo rimozione della quota proteica.
Amido e cellulosa
Si tratta di polisaccaridi generalmente impiegati dopo idrolisi, in forma di sciroppi di glucosio.
L’idrolisi della cellulosa presenta ancora problemi legati a pretrattamenti, formazione di prodotti secondari e distruzione dei monosaccaridi formati. Altri substrati cellulosici in forma solida sono impiegati prevalentemente per la produzione di funghi.
Liscivio solfitico
Residuo del processo di produzione di cellulosa da legname. Contiene pentosi ed esosi in rapporti diversi in funzione della materia prima d’origine.