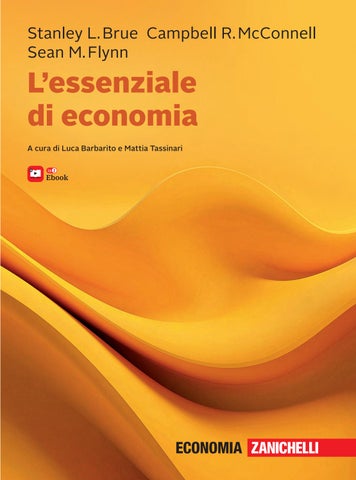Sean M. Flynn
L’essenziale di economia

ECONOMIA
INDICE
Prefazione IX
Autori XI
Curatori dell’edizione italiana XIII
Parte 1
Introduzione
CAPITOLO 1 Limiti, alternative e scelte 1
Il punto di vista economico, 1
Scarsità e scelte, 1; Comportamenti mirati, 2; L’analisi marginale: confrontare costi e benefici, 2
Teorie, principi e modelli, 4
Microeconomia e macroeconomia, 5
Microeconomia, 5; Macroeconomia, 5
Il problema economico dei singoli individui, 6
Reddito limitato, 6; Desideri illimitati, 6; La curva di bilancio, 7
Il problema economico della società, 9
La scarsità delle risorse, 9; Le tipologie di risorse, 9
Il modello delle possibilità produttive, 10
La tabella delle possibilità produttive, 10; La curva delle possibilità produttive, 11; La legge dei costi-opportunità crescenti, 11; L’allocazione ottima, 12
Disoccupazione, crescita e futuro, 13
Un’economia in crescita, 14; Scelte attuali e possibilità future, 16
ANALISI APPLICATA
Facebook è gratis?, 2; Le code ai fast food, 3; L’economia delle pandemie, 15; Tecnologie dell’informazione e biotecnologie, 15
FOCUS SUL CONCETTO Zuckerberg, Seacrest e Grande prendono decisioni sbagliate?, 3
CONFRONTO PER IMMAGINI
Micro e macro, 5; Beni di prima necessità e beni di lusso, 7; Risorse economiche, 9
ISTANTANEA DAL MONDO
1.1 Il reddito medio in un campione di Paesi, 6
1.2 L’investimento fisso lordo in percentuale del reddito nazionale in un campione di Paesi, 17
Riepilogo, 17 • Termini chiave, 18 • Domande, 18 • Problemi, 19
Appendice al capitolo 1, 20
I grafici e il loro significato, 20
Costruire un grafico, 20; Relazioni dirette e inverse, 20; Variabili dipendenti e indipendenti, 21; A parità di altre condizioni, 21; La pendenza di una retta, 22; La pendenza di una curva non lineare, 23
Riepilogo, 24
• Termini chiave, 24
• Domande, 24 • Problemi, 24
CAPITOLO 2 Sistema di mercato e flusso circolare 26
I sistemi economici, 26
Il sistema dirigista, 26; Il sistema di mercato, 27
Le caratteristiche del sistema di mercato, 28
La proprietà privata, 28; La libertà di impresa e di scelta, 29; L’interesse personale, 29; La concorrenza, 30; Mercati e prezzi, 30; La tecnologia e i beni capitali, 30; La specializzazione, 31; Gli usi della moneta, 31; Politiche pubbliche attive, ma limitate, 32
Le quattro domande fondamentali, 32
Cosa verrà prodotto?, 33; Come saranno prodotti i beni e i servizi?, 34; Chi riceverà la produzione?, 34; In che modo il sistema promuove il progresso?, 35
Il modello di flusso circolare, 36
I nuclei familiari, 36; Le imprese, 37; Il mercato dei prodotti, 37 Il mercato delle risorse, 38
ANALISI APPLICATA
La Corea di notte, 27; La sovranità dei consumatori durante una pandemia, 33; Bitcoin ed elettroni a buon mercato, 34; La “mano invisibile”, 35; La rovina dei sistemi dirigisti, 36
ISTANTANEA DAL MONDO
2.1 L’indice della libertà economica in un campione di Paesi, 29 2.2 Le dieci società di capitali più grandi del mondo, 38
CONFRONTO PER IMMAGINI
Mercati delle risorse e mercati dei prodotti, 38; Beni durevoli, beni non durevoli e servizi, 39
Riepilogo, 39 • Termini chiave, 40 • Domande, 40 • Problemi, 41
Parte 2
Prezzo, quantità ed efficienza
CAPITOLO 3 Domanda, offerta ed equilibrio di mercato 42
La domanda, 42
La legge della domanda, 43; La curva di domanda, 44; La domanda di mercato, 44; I cambiamenti della domanda, 45; Le variazioni della quantità domandata, 47
L’offerta, 48
La legge dell’offerta, 48; L’offerta di mercato, 49; Le determinanti dell’offerta, 49; I cambiamenti dell’offerta, 49; Le variazioni della quantità offerta, 50
L’equilibrio di mercato, 51
Prezzo e quantità di equilibrio, 52; La funzione di razionamento dei prezzi, 52
I cambiamenti della domanda, dell’offerta e dell’equilibrio, 53
I cambiamenti della domanda, 53; I cambiamenti dell’offerta, 53; I casi più complessi, 53
I controlli dei prezzi, 55
CONFRONTO PER IMMAGINI
Beni normali e beni inferiori, 46; Sostituti e complementi, 47
ANALISI APPLICATA
Equilibri emergenti, 53; I livelli massimi di prezzo della benzina, 56; L’equo canone, 56; I livelli minimi di prezzo del frumento, 57
ISTANTANEA DAL MONDO 3.1
Il prezzo medio di una pagnotta di pane bianco in un campione di Paesi, 55
Riepilogo, 58 • Termini chiave, 59 • Domande, 59 • Problemi, 60
Appendice al capitolo 3, 62
Altri esempi di domanda e offerta, 62
Cambiamenti della domanda e dell’offerta, 62; I prezzi prestabiliti, 64
ANALISI APPLICATA
Uber e la tariffa dinamica, 64
Riepilogo, 66 • Domande, 66 • Problemi, 67
CAPITOLO 4 L’elasticità della domanda e dell’offerta 68
L’elasticità della domanda al prezzo, 68
Il coefficiente e la formula dell’elasticità della domanda al prezzo, 69; Interpretazioni di Ed , 70; Il test del ricavo totale, 71; L’elasticità al prezzo lungo una curva di domanda lineare, 73; Le determinanti dell’elasticità della domanda al prezzo, 75
L’elasticità dell’offerta al prezzo, 78
L’elasticità dell’offerta al prezzo: il periodo immediato, 79; L’elasticità dell’offerta al prezzo: il breve periodo, 80; L’elasticità dell’offerta al prezzo: il lungo periodo, 80
L’elasticità della domanda al reddito, 82
Beni normali, 82; Beni inferiori, 82
L’elasticità incrociata della domanda al prezzo, 82
Beni sostituti, 83; Beni complementari, 83; Beni indipendenti, 83
CONFRONTO PER IMMAGINI
Domanda elastica e anelastica, 70; Offerta elastica e anelastica, 79
FOCUS SUL CONCETTO
Un’analogia un po’ stiracchiata, 71
ANALISI APPLICATA
L’effetto Southwest, 75; Elasticità della domanda al prezzo e rette universitarie, 77; La decriminalizzazione delle sostanze illegali, 77; Accise e gettito fiscale, 78; Raccolti a resa elevata e reddito degli agricoltori, 78; Antiquariato e riproduzioni, 81; La volatilità del prezzo dell’oro, 81; Quali sono i prodotti di consumo la cui domanda si contrae maggiormente durante una recessione?, 82; L’uso dell’elasticità incrociata nel processo decisionale di imprese e governi, 84
ISTANTANEA DAL MONDO
4.1 L’elasticità al reddito della domanda di benzina in un campione di Paesi, 83
4.2 L’elasticità incrociata della domanda al prezzo tra spesa per l’istruzione e aumento dei prezzi del cibo in un campione di Paesi, 84
Riepilogo, 85 • Termini chiave, 85 • Domande, 86 • Problemi, 86
CAPITOLO 5 I fallimenti del mercato: beni pubblici ed esternalità 88
I fallimenti del mercato nei mercati concorrenziali, 88
I fallimenti del mercato dal lato della domanda, 89; I fallimenti del mercato dal lato dell’offerta, 89
Il funzionamento efficiente dei mercati, 89
Beni privati e beni pubblici, 90
Le caratteristiche dei beni privati, 90; La fornitura redditizia di un bene, 90; Le caratteristiche dei beni pubblici, 91; Confrontare beneficio marginale e costo marginale, 94
Le esternalità, 95
Le esternalità negative, 95; Le esternalità positive, 96; L’intervento pubblico, 97; La quantità socialmente ottima di riduzione delle esternalità negative, 101
Il finanziamento del settore pubblico: la tassazione, 102
La ripartizione dell’onere fiscale, 103; Principio delle prestazioni e controprestazioni e principio della capacità contributiva, 103; Imposte progressive, proporzionali e regressive, 104
Il ruolo dello Stato nell’economia, 104
CONFRONTO PER IMMAGINI
Beni privati e beni pubblici, 91; Esternalità positive e negative nel consumo, 96
FOCUS SUL CONCETTO
L’arte per l’arte, 92; Gli apicoltori e il teorema di Coase, 97
ANALISI APPLICATA
L’analisi costi-benefici, 94; La tariffazione della congestione stradale, 100
ISTANTANEA DAL MONDO 5.1
La percentuale di emissioni di CO2 sottoposta a tassazione in un campione di Paesi, 100
Riepilogo, 105 • Termini chiave, 106 • Domande, 106 • Problemi, 107
Parte 3
I mercati dei prodotti
CAPITOLO 6 L’impresa e i suoi costi 109
I costi economici, 109
Costi espliciti e costi impliciti, 109; Profitto contabile e profitto normale, 110; Il profitto economico, 111; Breve periodo e lungo periodo, 111
Le relazioni di produzione di breve periodo, 113
La legge dei rendimenti decrescenti, 113; L’importanza per le imprese, 113; Rappresentazioni sotto forma di tabelle e grafici, 115
I costi di produzione di breve periodo, 117
Costo fisso, costo variabile e costo totale, 117; Il costo unitario o medio, 118; Il costo marginale, 119
I costi di produzione di lungo periodo, 121
Dimensioni dell’impianto e costi, 121; La curva di costo di lungo periodo, 122; Economie e diseconomie di scala, 123; Scala minima efficiente e struttura del settore, 127
CONFRONTO PER IMMAGINI
Gli aggiustamenti di lungo periodo delle imprese, 112; Le economie di scala, 125
FOCUS SUL CONCETTO
I rendimenti decrescenti dello studio, 114; I voti agli esami, 115
ANALISI APPLICATA
I costi sommersi, 118; Un aumento del prezzo della benzina, 120; La pressa per stampaggio Verson, 126; Impianti per l’assemblaggio di aeromobili e impianti per la produzione di cemento, 128
ISTANTANEA DAL MONDO 6.1
I costi di produzione relativi in un campione di Paesi, 121
Riepilogo, 128 • Termini chiave, 129 • Domande, 129 • Problemi, 130
CAPITOLO 7 La concorrenza perfetta 132
I quattro modelli del mercato, 132
La concorrenza perfetta: caratteristiche ed esempi, 133
La domanda di un venditore perfettamente concorrenziale, 134
Domanda perfettamente elastica, 134; Ricavo medio, ricavo totale e ricavo marginale, 135
La massimizzazione del profitto nel breve periodo, 136
Un esempio di massimizzazione del profitto, 137; Un esempio di minimizzazione delle perdite, 138; Un esempio di cessazione dell’attività, 139
Costo marginale e offerta di breve periodo, 141
Una rappresentazione generale, 142; Impresa e settore: il prezzo di equilibrio, 143
La massimizzazione del profitto nel lungo periodo, 145
Le ipotesi, 145; L’obiettivo della nostra analisi, 145; L’equilibrio di lungo periodo, 146; L’offerta di lungo periodo in un settore a costi costanti, 148; L’offerta di lungo periodo in un settore a costi crescenti, 149; L’offerta di lungo periodo in un settore a costi decrescenti, 150
Concorrenza perfetta ed efficienza, 151
L’efficienza produttiva: P = CMT minimo, 151; L’efficienza allocativa: P = C′, 152
CONFRONTO PER IMMAGINI
Beni standardizzati e beni differenziati, 133; Settori a costi crescenti e settori a costi decrescenti, 150
ANALISI APPLICATA
L’albergo Ancora Lì, 141; Dirigere un’azienda è un’impresa, 148
Riepilogo, 153 • Termini chiave, 154 • Domande, 154 • Problemi, 154
CAPITOLO 8 Il monopolio puro 156
Il monopolio puro: un’introduzione, 156
Le barriere all’entrata, 157
Economie di scala, 157; Le barriere legali all’entrata: brevetti e licenze, 158; Proprietà o controllo di risorse essenziali, 158; Strategie di prezzo e altre barriere strategiche all’entrata, 158
La domanda in regime di monopolio, 159
Il ricavo marginale è inferiore al prezzo, 159; Il monopolista è price maker, 161
Determinare prezzo e quantità, 161
I dati sui costi, 161; La regola R′ = C ′, 161; Concezioni errate sulla determinazione del prezzo in regime di monopolio, 163
Gli effetti economici del monopolio, 164
Prezzo, quantità ed efficienza, 164; Trasferimento di reddito, 165; Complicazioni di costo, 166
La discriminazione di prezzo, 168
Condizioni, 168; Esempi, 169; Analisi grafica, 169
Monopolio e politica antitrust, 171
Poco diffuso, 171; La politica antitrust, 171
ANALISI APPLICATA
Il monopolio del sale, 163; Il potere di monopolio nell’era di Internet, 167; La discriminazione di prezzo sul campo da baseball, 170; Stati Uniti contro Microsoft, 172
ISTANTANEA DAL MONDO 8.1
La concorrenza delle multinazionali estere, 171
Riepilogo, 174 • Termini chiave, 175 • Domande, 175 • Problemi, 176
CAPITOLO 9 Concorrenza monopolistica e oligopolio 178
La concorrenza monopolistica, 178
Prodotti differenziati, 179; Facilità di entrata e di uscita, 180; La pubblicità, 181; I settori in concorrenza monopolistica, 181
Prezzo e quantità in concorrenza monopolistica, 181
La curva di domanda dell’impresa, 181; Il breve periodo: profitti o perdite, 181; Il lungo periodo: soltanto un profitto normale, 182
Concorrenza monopolistica ed efficienza, 183
Né efficienza produttiva, né efficienza allocativa, 183; Capacità produttiva in eccesso, 183; Varietà e perfezionamento dei prodotti, 184
L’oligopolio, 185
Pochi grandi produttori, 185; Prodotti omogenei e prodotti differenziati, 185; Controllo sul prezzo, ma interdipendenza, 185
Le barriere all’entrata, 186; Le fusioni, 186
Il comportamento oligopolistico: una panoramica sulla teoria dei giochi, 186
L’interdipendenza: una rivisitazione, 188; La collusione, 188; L’incentivo a tradire, 188
Il modello della curva di domanda spezzata, 189
La curva di domanda spezzata, 189; L’inflessibilità dei prezzi, 190; La leadership di prezzo, 190
La collusione, 191
La massimizzazione del profitto congiunto, 192; Gli ostacoli alla collusione, 193
Oligopolio e pubblicità, 194
Gli effetti positivi della pubblicità, 195; I potenziali effetti negativi della pubblicità, 195
Oligopolio ed efficienza, 196
Inefficienza, 196
CONFRONTO PER IMMAGINI
Concorrenza monopolistica e oligopolio, 179
ISTANTANEA DAL MONDO
9.1 Il numero di ristoranti per 100 000 abitanti in un campione di città, 180
9.2 Le 10 marche più grandi al mondo, 196
FOCUS SUL CONCETTO
Il comportamento strategico creativo, 185; Il dilemma del prigioniero, 187
ANALISI APPLICATA
Quando la leadership di prezzo viene meno: le guerre di prezzo, 191; Cartelli e collusione, 193; Gli oligopoli di Internet, 197 Riepilogo, 198 • Termini chiave, 199 • Domande, 199 • Problemi, 200
Parte 4
PIL, crescita e instabilità
CAPITOLO 10 PIL e crescita economica 201
Il prodotto interno lordo, 201
Una misura monetaria, 202; Evitare i conteggi multipli, 202; Escludere le vendite di seconda mano e le transazioni finanziarie, 203
Misurare il PIL, 204
La spesa per consumo (C), 204; L’investimento privato nazionale lordo (Il ), 204; La spesa pubblica (G ), 205; Le esportazioni nette (X n ), 205; La somma finale: PIL = C + Il + G + X n , 206
PIL nominale e PIL reale, 207
La crescita economica, 208
La crescita come obiettivo, 209; L’aritmetica della crescita, 209
La crescita in Italia, 210
Le determinanti della crescita, 210
I fattori dal lato dell’offerta, 210; Il fattore dal lato della domanda, 211; Il fattore di efficienza, 211
L’analisi delle possibilità produttive, 212
Crescita e possibilità produttive, 212; Lavoro e produttività, 213
Le cause della crescita, 214
Quantità di lavoro e produttività del lavoro, 214; Il progresso tecnologico, 214; La quantità di capitale, 215; Istruzione e formazione, 216; Economie di scala e allocazione delle risorse, 216; Le istituzioni che promuovono la crescita, 217; La domanda e altri fattori, 217
Le recenti fluttuazioni della crescita media della produttività, 218
Le determinanti dell’aumento del tasso di crescita medio della produttività negli Stati Uniti e in altri Paesi europei tra il 1995 e il 2010, 218; Le conseguenze per la crescita economica, 220; La recente stagnazione della produttività, 220
Desiderabilità e sostenibilità della crescita, 221
Il punto di vista contrario alla crescita, 221; In difesa della crescita economica, 222
CONFRONTO PER IMMAGINI
Beni intermedi e beni finali, 202; Beni nuovi e beni di seconda mano, 203; Investimenti pubblici e privati in infrastrutture, 215; Gli elementi chiave per la crescita della produttività negli Stati Uniti, 220
ISTANTANEA DAL MONDO
10.1 Il PIL di un campione di Paesi a confronto, 206
10.2 L’economia sommersa in percentuale del PIL in un campione di Paesi, 208
10.3 La divergenza tra tenori di vita, 1820-2000, 211
ANALISI APPLICATA
L’economia sommersa, 208
FOCUS SUL CONCETTO
I tassi di crescita contano!, 209
Riepilogo, 223 • Termini chiave, 224 • Domande, 224 • Problemi, 225
CAPITOLO 11 Ciclo economico, disoccupazione e inflazione 226
Il ciclo economico, 226
Le cause dei cicli economici, 227; Effetti ciclici: beni durevoli e non durevoli, 229
La disoccupazione, 231
Misurare la disoccupazione, 231; Le tipologie di disoccupazione, 232; La definizione di piena occupazione, 233; Il costo economico della disoccupazione, 233
L’inflazione, 234
Misurare l’inflazione, 234; I dati dell’inflazione, 235; Le tipologie di inflazione, 236
Gli effetti ridistributivi dell’inflazione, 237
Chi viene penalizzato dall’inflazione?, 238; Chi non è influenzato o viene avvantaggiato dall’inflazione?, 238; L’inflazione attesa, 239
L’inflazione incide sulla produzione?, 239
Inflazione da costi e produzione reale, 240; Inflazione da domanda e produzione reale, 240
ANALISI APPLICATA
Prezzi delle azioni e instabilità macroeconomica, 230; Rigidità al ribasso dei salari e disoccupazione, 233; Lo spettro della deflazione, 240; L’iperinflazione, 241
ISTANTANEA DAL MONDO 11.1
I tassi di inflazione di alcuni Paesi industrializzati, 236
FOCUS SUL CONCETTO
Svilire la moneta, 237
Riepilogo, 241 • Termini chiave, 242 • Domande, 242 • Problemi, 242
CAPITOLO 12 Domanda aggregata e offerta aggregata 244
La domanda aggregata, 244
I cambiamenti della domanda aggregata, 245
La spesa per beni di consumo, 246; La spesa per beni di investimento, 247; La spesa pubblica, 249; La spesa per esportazioni nette, 249
L’offerta aggregata, 251
L’offerta aggregata nel periodo immediato, 251; L’offerta aggregata nel breve periodo, 252; L’offerta aggregata nel lungo periodo, 253; Concentrazione sul breve periodo, 255
I cambiamenti dell’offerta aggregata, 255
I prezzi dei fattori di produzione, 256; La produttività, 257; L’ambiente legale e istituzionale, 257
Livello dei prezzi di equilibrio e PIL reale di equilibrio, 258
Le variazioni dell’equilibrio, 259; La rigidità al ribasso del livello dei prezzi, 261; L’effetto moltiplicatore, 264; Autocorrezione?, 264
ANALISI APPLICATA
Quale effetto ricchezza?, 247; L’inflazione da domanda, 259; L’inflazione da costi, 260; Recessione e disoccupazione ciclica, 262
ISTANTANEA DAL MONDO
12.1 La spesa per investimento lorda in percentuale del PIL in un campione di Paesi, 249
12.2 Esportazioni nette di beni e servizi in un campione di Paesi, 250
12.3 Le dimensioni del divario di PIL in un campione di Paesi, 263
CONFRONTO PER IMMAGINI
Inflazione da domanda e inflazione da costi, 261
FOCUS SUL CONCETTO
L’effetto cricchetto, 262
Riepilogo, 265 • Termini chiave, 266 • Domande, 266 • Problemi, 267
CAPITOLO 13 Politica fiscale, disavanzo e debito 269
Politica fiscale e modello DA-OA, 269
La politica fiscale espansiva, 269; La politica fiscale restrittiva, 271
La stabilizzazione automatica, 272
Gli stabilizzatori automatici, 272; Rilevanza economica, 272
Valutare la politica fiscale, 273
Problemi, critiche e complicazioni, 275
Il problema temporale, 275; Considerazioni politiche, 275; Il rovesciamento di politiche passate, 276; Politiche finanziarie locali di compensazione, 276; L’effetto di spiazzamento, 276
Il debito pubblico in Italia, 277
Proprietà del debito, 278; Debito e PIL: confronti internazionali, 278; Interessi sul debito, 279
Preoccupazioni infondate?, 279
Bancarotta, 279; L’onere per le generazioni future, 280
Problemi sostanziali, 281
La distribuzione del reddito, 281; Gli incentivi, 281; Il debito pubblico di proprietà estera, 281; L’effetto di spiazzamento: una rivisitazione, 281; Opzioni future di gestione del debito pubblico italiano ed europeo, 282
ISTANTANEA DAL MONDO 13.1
Il debito pubblico: un confronto internazionale, 280
Riepilogo, 283 • Termini chiave, 284 • Domande, 284 • Problemi, 285
Parte 5 Moneta, sistema bancario e politica monetaria
CAPITOLO 14 Moneta, sistema bancario e istituzioni finanziarie 286
Le funzioni della moneta, 286
Le componenti dell’offerta di moneta, 287
Misure monetarie: M1, 287; Misure monetarie: M2, 289
Cosa “garantisce” l’offerta di moneta?, 290
Il valore della moneta, 290; Moneta e prezzi, 290
La banca centrale e il sistema bancario, 292
La banca centrale, 292; Le banche ordinarie, 292; Funzioni e responsabilità della banca centrale, 292
La crisi finanziaria del 2007-2008, 293
Una visione d’insieme, 294; I prodromi della crisi, 294; Le cause della crisi, 294; La crisi, 295; La reazione immediata, 295
I cambiamenti normativi in seguito alla crisi, 296
Il sistema bancario a riserva frazionaria, 296
Una singola banca ordinaria, 297
Prima transazione: creare una banca, 297; Seconda transazione: acquisire proprietà e attrezzature, 298; Terza transazione: accettare depositi, 298; Quarta transazione: depositare le riserve presso la banca centrale, 298; Quinta transazione: liquidare un bonifico di un’altra banca, 300; Sesta transazione: concedere un prestito (creare moneta), 300
Il sistema bancario: l’espansione multipla dei depositi, 302
Il potenziale creditizio del sistema bancario, 302; Il moltiplicatore monetario, 304; Reversibilità: la distruzione moltiplicata di moneta, 305
CONFRONTO PER IMMAGINI
Moneta: passato e presente, 289
FOCUS SUL CONCETTO
Le carte di credito/debito sono moneta?, 291
ISTANTANEA DAL MONDO 14.1
Le 10 istituzioni finanziarie più grandi del mondo, 293
ANALISI APPLICATA
Gli episodi di panico bancario tra il 1930 e il 1933, 305
Riepilogo, 306 • Termini chiave, 307 • Domande, 307 • Problemi, 308
CAPITOLO 15 Tassi di interesse e politica monetaria 309
I tassi di interesse, 309
La domanda di moneta, 309; Il tasso di interesse di equilibrio, 312
Gli strumenti di politica monetaria, 313
Le operazioni di mercato aperto, 313; Il coefficiente di riserva obbligatoria, 314; Il tasso di rifinanziamento, 315; Gli interessi sulle riserve in eccesso, 316; Importanza relativa, 316; Politica monetaria espansiva e restrittiva, 316
Politica monetaria, PIL reale e livello dei prezzi, 317
La catena di causa ed effetto, 317; Gli effetti di una politica monetaria espansiva, 319; Gli effetti di una politica monetaria restrittiva, 320
La politica monetaria in azione, 321
Gli obiettivi della Fed e della BCE, 321; Problemi e complicazioni, 323
ISTANTANEA DAL MONDO 15.1
Tassi di interesse nominali a breve termine in un campione di Paesi, 310
FOCUS SUL CONCETTO Quello è l’interesse, 312
ANALISI APPLICATA
La politica monetaria in Europa e negli Stati Uniti in anni recenti, 322
Riepilogo, 324 • Termini chiave, 325 • Domande, 325 • Problemi, 326
Parte 6
L’economia internazionale
CAPITOLO 16 Commercio internazionale e tassi di cambio 327
Alcuni dati sul commercio internazionale, 327
La base economica dello scambio, 328
Vantaggio comparato e specializzazione, 328; Il vantaggio comparato: l’analisi delle possibilità produttive, 330; Lo scambio in presenza di costi crescenti, 333
Il mercato dei cambi, 333
Tassi di cambio, 334; Deprezzamento e apprezzamento, 335; Le determinanti dei tassi di cambio, 335
Politiche pubbliche e commercio internazionale, 337
Barriere commerciali e sussidi alle esportazioni, 337; Gli effetti economici dei dazi, 338; I costi netti dei dazi, 339
Tre argomentazioni a favore del protezionismo, 339
L’argomentazione dell’aumento dell’occupazione nazionale, 339; L’argomentazione del lavoro estero a buon mercato, 340; L’argomentazione della protezione dal dumping, 341
Le conseguenze del cambiamento della competitività internazionale, 341
Gli accordi commerciali multilaterali e le aree di libero scambio, 342
L’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, 342; L’Organizzazione mondiale del commercio, 343; L’Unione europea, 343; I recenti disavanzi commerciali degli Stati Uniti, 344; Le cause dei disavanzi commerciali, 344; Le conseguenze del disavanzo commerciale statunitense, 345; La bilancia commerciale italiana, 346
ISTANTANEA DAL MONDO
16.1 Le esportazioni di beni e servizi in percentuale del PIL in un campione di Paesi, 329
16.2 Il tasso di cambio tra euro e un campione di valute estere, 334
FOCUS SUL CONCETTO
Commercialista e imbianchino, 330
ANALISI APPLICATA
La delocalizzazione del lavoro è un male?, 342 Riepilogo, 347 • Termini chiave, 347 • Domande, 348 • Problemi, 348
Parte 7
I mercati delle risorse
CAPITOLO 17 Disuguaglianza del reddito e povertà 350
I dati sulla disuguaglianza del reddito, 350
La distribuzione per classi di reddito, 351; La distribuzione per quintili (quinti), 351; La curva di Lorenz e il coefficiente di
Gini, 351; La mobilità del reddito: la dimensione temporale, 3 53; Gli effetti ridistributivi dello Stato in Italia, 353
Le cause della disuguaglianza del reddito, 353
Capacità individuali, 354; Istruzione e formazione, 354; La discriminazione, 355; Preferenze e rischi, 355; La distribuzione ineguale della ricchezza, 355; Fortuna, conoscenze e malasorte, 355
La disuguaglianza del reddito nel tempo, 356
L’aumento della disuguaglianza del reddito dal 1980, 357; Le cause della crescita della disuguaglianza, 357
Equità ed efficienza, 358
Un punto a favore dell’equità: la massimizzazione dell’utilità totale, 359; Un punto a sfavore dell’equità: incentivi ed efficienza, 360; Il trade-off tra efficienza ed equità, 360
L’economia della povertà, 361
La definizione della povertà, 361; L’incidenza della povertà, 361
Problemi di misurazione, 362
Il sistema di ridistribuzione del reddito in Italia, 362
I programmi dello stato sociale in Italia, 362
ISTANTANEA DAL MONDO 17.1
La percentuale del reddito totale ricevuta dal 10% più ricco dei percettori di reddito in un campione di Paesi, 356
FOCUS SUL CONCETTO
Affettare la pizza, 361
ANALISI APPLICATA
Il reddito di base universale, 363 Riepilogo, 364 • Termini chiave, 365 • Domande, 365 • Problemi, 366
Glossario 367
Indice analitico 376
Le risorse digitali
A questo indirizzo sono disponibili le risorse digitali di complemento al libro: universita.zanichelli.it/brue
Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it inserendo il codice di attivazione personale che si trova sul bollino argentato nella prima pagina del libro.
Dal sito del libro è possibile:
• trovare il link per i test interattivi di autovalutazione;
• utilizzare i grafici interattivi;
• guardare i video;
• consultare la sezione La parola ai grafici;
• accedere direttamente alla versione Ebook
Le risorse digitali sono disponibili per chi acquista il libro nuovo. L’accesso all’Ebook e alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile, né autonomamente né con la cessione del libro cartaceo.
PREFAZIONE
L’essenziale di economia si focalizza sui principi fondamentali di micro e macroeconomia, tralasciando argomenti più complessi o specifici che si trovano in manuali più ampi. Gli autori hanno preferito concentrarsi su un numero contenuto di concetti, curando però in modo eccellente la qualità e la semplicità con cui questi sono stati espressi. Inoltre, gli argomenti presentati sono sempre calati nella realtà di oggi, con validi esempi riferiti alla vita quotidiana.
I contenuti affrontati nel volume sono adatti a un corso semestrale, poiché possono essere facilmente insegnati interamente, senza che il docente si trovi a dover rinunciare ad affrontare alcuni capitoli, come spesso accade. Il libro, inoltre, è particolarmente indicato per i corsi di studio nei quali l’economia viene erogata a supporto di altre discipline, come il marketing, la progettazione d’impresa o lo studio dei sistemi economici e politici.
Un testo molto sintetico ed essenziale come quello proposto in questo volume presenta sia un vantaggio, sia un difetto.
Il vantaggio è che può essere arricchito dal contributo individuale del docente per espandere la trattazione su argomenti di particolare interesse. Ogni concetto spiegato è estremamente conciso e per questo si presta facilmente a integrazioni e approfondimenti, nonché all’aggiunta di ulteriori esempi.
I l difetto è che non può essere riassunto. Osservando la traduzione in italiano abbiamo realizzato che non è possibile riuscire a esprimere i concetti espressi nel libro in un numero di parole minore rispetto a quello utilizzato dagli autori.
Ci si potrebbe chiedere se il libro possa risultare troppo sintetico. Un docente esigente potrebbe rispondere affermativamente; tuttavia, se si fa riferimento ai corsi di laurea nei quali l’economia non è la disciplina principale, a nostro avviso ha più importanza che i concetti presentati siano ben esposti e, dunque, auspicabilmente ben compresi, anziché cercare di completare un programma che potrebbe risultare troppo esteso. In altre parole, questo libro permette di chiedere a chi studia uno sforzo di approfondimento qualitativo su contenuti fondamentali, e non quantitativo su un elevato numero di contenuti nuovi.
Ogni capitolo è ben organizzato: gli obiettivi formativi elencati all’inizio dei capitoli sono chiari e coerenti con il testo, così come il riassunto, le parole chiave, le domande e i problemi collocati a lla fine. Il livello degli esercizi proposti è perfettamente allineato con il testo. Tutte le domande e tutti i problemi sono alla portata di studenti e studentesse e potrebbero essere utilizzati come modelli per una verifica finale.
Abbiamo ritenuto opportuno personalizzare la versione italiana, integrandola con informazioni ed esempi vicini al contesto europeo e, in particolare, a quello italiano. Numerosi paragrafi nei quali gli autori si riferiscono al sistema economico statunitense sono stati quindi affiancati da esempi riguardanti la nostra realtà nazionale e corredati di dati relativi al nostro Paese.
Riteniamo ne sia scaturito un manuale efficace, che rappresenta non solo uno strumento utile per i docenti di economia, ma anche una valida risorsa per chi si avvicina per la prima volta alle scienze economiche.
Luca
Barbarito e Mattia Tassinari
Strumenti di supporto allo studio
Il testo è arricchito da varie schede di supporto allo studio per facilitare l’apprendimento dei concetti fondamentali trattati in ciascun capitolo e mostrare come tali concetti possano essere applicati alla nostra vita e al mondo in cui viviamo.
• Confronto per immagini facilita la comprensione visiva degli argomenti trattati attraverso una selezione di immagini rappresentative;
• Focus sul concetto chiarisce gli aspetti più complessi della materia economica utilizzando analogie ed esempi tratti dalla vita quotidiana o da fatti di attualità;
• Analisi applicata collega la teoria alla pratica analizzando argomenti e casi specifici legati agli eventi e alle politiche del mondo reale;
• Istantanea dal mondo offre uno sguardo sulle dinamiche economiche globali per mezzo di indagini statistiche rappresentate graficamente al fine di facilitare la comprensione dei dati raccolti ed evidenziare tendenze e relazioni.
Ogni capitolo si conclude con rubriche per consolidare e verificare le conoscenze: il Riepilogo fissa i concetti principali, i Termini chiave ripercorrono il lessico specifico, mentre una sezione di Domande a nalitiche e Problemi, collegata agli Obiettivi di apprendimento indicati all’inizio del capitolo, induce al pensiero critico e mette alla prova le competenze acquisite.
Il testo è inoltre corredato da un sito web dedicato nel quale sono disponibili ulteriori risorse per lo studio, quali test interattivi di autovalutazione, video di approfondimento, grafici interattivi e materiali utili per la strutturazione delle lezioni.
La concorrenza perfetta
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
7.1 Riassumere le principali caratteristiche dei quattro modelli fondamentali del mercato
7.2 Elencare le condizioni fondanti di un mercato perfettamente concorrenziale
7.3 Descrivere il modo in cui le imprese perfettamente concorrenziali massimizzano i profitti o minimizzano le perdite
7.4 Spiegare perché la curva di costo marginale di un’impresa concorrenziale è anche la sua curva di offerta
7.5 Descrivere come i profitti e le perdite siano il motore del processo di aggiustamento di lungo periodo in concorrenza perfetta
7.6 Spiegare le differenze tra settori a costi costanti, settori a costi crescenti e settori a costi decrescenti
7.7 Mostrare come in concorrenza perfetta l’equilibrio di lungo periodo produca un’allocazione efficiente delle risorse
Per decidere quale prezzo praticare e quanto produrre, le imprese analizzano i propri ricavi e costi. Le decisioni di prezzo e di produzione di un’impresa dipendono fortemente dal settore in cui opera. A un estremo troviamo i settori dominati da un unico produttore; all’altro estremo, i settori in cui operano migliaia di imprese, ognuna delle quali produce soltanto una piccola quota dell’offerta di mercato.
Dato che non possiamo esaminare ogni settore singolarmente, ci concentriamo su quattro modelli fondamentali della struttura di mercato. Presi insieme, questi modelli ci aiutano a comprendere come vengano determinati il prezzo e la quantità nei mercati dei prodotti, a valutare l’efficienza o l’inefficienza di tali mercati, e ad analizzare le politiche pubbliche (come, per esempio, le normative antitrust) che si applicano a imprese e settori specifici.
I quattro modelli del mercato
Gli economisti suddividono i settori in quattro strutture di mercato, che si distinguono in base al numero di imprese nel settore, al tipo di prodotto che queste offrono (standardizzato o differenziato), alla facilità con cui possono entrare nel settore e al grado di controllo che hanno sul prezzo del proprio prodotto. Elenchiamo i quattro modelli qui di seguito.
• La concorrenza perfetta si ha in presenza di un numero molto elevato di imprese che offrono un prodotto standardizzato (per esempio, il cotone offerto da un produttore è praticamente identico a quello offerto dagli altri produttori). Nuove imprese possono facilmente entrare o uscire dal settore. Le imprese devono accettare il prezzo di mercato come dato.
• La concorrenza monopolistica è caratterizzata da un numero relativamente elevato di imprese che offrono prodotti differenziati (per esempio, abbigliamento, mobilio e libri). È molto diffusa la concorrenza su fattori diversi dal prezzo, u na strategia di vendita con cui l’impresa tenta di distinguere il proprio prodotto dagli altri sulla base di caratteristiche quali il design e la qualità (un approccio detto differenziazione del prodotto). Sia l’entrata, sia l’uscita da un settore
in concorrenza monopolistica sono relativamente facili. Le imprese in concorrenza monopolistica hanno un certo controllo – ma non troppo – sul prezzo di vendita del proprio prodotto.
• In un oligopolio, un numero ristretto di venditori offre un prodotto standardizzato (per esempio, l’acciaio) o differenziato (le automobili). Di conseguenza, ciascuna impresa subisce gli effetti delle decisioni delle rivali e deve tenerne conto quando determina il proprio livello di prezzo e di produzione.
• Il monopolio puro è una struttura di mercato in cui un’impresa (per esempio, un fornitore locale di energia elettrica) è l’unico venditore di un bene o servizio. Poiché l’ingresso di altre imprese nel settore è bloccato, la singola impresa costituisce l’intero settore. L’impresa monopolistica produce un singolo prodotto unico e ha il pieno controllo sul prezzo di tale prodotto.
La concorrenza perfetta: caratteristiche ed esempi
La concorrenza perfetta è piuttosto rara nella realtà; ciò nonostante, questo modello del mercato assume grande rilevanza in alcuni settori. In particolare, studiando il modello della concorrenza perfetta possiamo apprendere molto sui mercati dei prodotti agricoli, del pesce, dei cambi, dei metalli v ili e delle azioni. Inoltre, la concorrenza perfetta è un punto di partenza significativo all’interno di qualunque discussione su come si determinino prezzi e quantità. Il funzionamento di un’economia perfettamente concorrenziale offre anche un punto di riferimento per valutare l’efficienza di u n’economia nel mondo reale.
Esaminiamo più nel dettaglio le caratteristiche della concorrenza perfetta:
• moltissime imprese: una caratteristica fondamentale dei mercati perfettamente concorrenziali è la presenza di un numero molto elevato di venditori che agiscono in maniera indipendente e spesso offrono il proprio prodotto su mercati di grandi dimensioni su scala nazionale o internazionale. Ne sono esempi i mercati dei prodotti agricoli, il mercato azionario e il mercato dei cambi;
• prodotto standardizzato: le imprese perfettamente concorrenziali producono un bene standardizzato (identico o omogeneo). A parità di prezzo, i consumatori sono indifferenti rispetto a llo specifico venditore da cui acquistare il prodotto. I compratori considerano i prodotti delle
concorrenza perfetta la struttura di mercato nella quale un gran numero di imprese vende un prodotto standardizzato, l’entrata è facile, ciascun venditore individuale non esercita un controllo sul prezzo del prodotto e non c’è concorrenza su fattori diversi dal prezzo; un mercato caratterizzato dalla presenza di un gran numero di compratori e venditori
Beni standardizzati e beni differenziati
Il frumento è un esempio di bene standardizzato, mentre lo shampoo Pantene (nella foto) è un esempio di bene differenziato.


price taker un venditore (o compratore) che non è in grado di influenzare il prezzo al quale viene venduto un prodotto o una risorsa modificando la quantità di prodotto o risorsa che vende (o compra)
imprese B, C e D come sostituti perfetti del prodotto dell’impresa A. Poiché le imprese in concorrenza perfetta vendono prodotti standardizzati, non si sforzano in alcun modo di differenziare il proprio prodotto da quello delle altre e non praticano altre forme di concorrenza su fattori diversi dal prezzo;
• “price taker”: nei mercati perfettamente concorrenziali, le singole imprese non esercitano alcun controllo sul prezzo del proprio prodotto. Ciascuna produce una quota talmente irrisoria della produzione totale che incrementare o ridurre la quantità prodotta non ha un effetto percettibile sull’offerta totale e, di conseguenza, sul prezzo del prodotto. In breve, l’impresa concorrenziale è price taker, ovvero “subisce” il prezzo: non può modificare il prezzo di mercato, può solo adeguarvisi. Il singolo produttore concorrenziale è quindi alla mercè del mercato e praticare u n prezzo superiore al livello di mercato è un’impresa futile. Infatti, i consumatori non acquisteranno dall’impresa A se questa pratica un prezzo di 2,05 euro, mentre tutti i suoi 9999 concorrenti vendono un prodotto identico a 2 euro. Analogamente, poiché l’impresa A può vendere qualunque quantità al prezzo unitario di 2 euro, non ha motivo di praticare un prezzo più basso, per esempio 1,95 euro, perché questa decisione avrebbe l’unico effetto di ridurre i profitti dell’impresa; • libertà di entrata e uscita: nuove imprese possono entrare liberamente nei settori perfettamente concorrenziali, e le imprese esistenti possono uscirne liberamente. Non esistono ostacoli significativi dal punto di vista legale, tecnologico o finanziario che impediscano a nuove imprese d i vendere il proprio prodotto in un mercato concorrenziale.
La domanda di un venditore perfettamente
concorrenziale
Al fine di sviluppare un modello della concorrenza perfetta, esaminiamo ora la domanda dal punto di vista di un venditore perfettamente concorrenziale, e vediamo come questa influisce sul suo r icavo. Potrebbe trattarsi di un agricoltore che coltiva il frumento, di un intermediario finanziario, di un produttore di abbigliamento a contratto o di un altro tipo di venditore in concorrenza perfetta. Poiché ciascuna impresa perfettamente concorrenziale fornisce soltanto una quota irrisoria dell’offerta totale di mercato, essa deve accettare il prezzo predeterminato dal mercato. I venditori in concorrenza perfetta sono price taker, non “price maker”: subiscono il prezzo, non lo determinano.
Domanda perfettamente elastica
La scheda di domanda con cui si confronta la singola impresa che opera in un settore perfettamente concorrenziale è perfettamente elastica in corrispondenza del prezzo di mercato, come mostra la Figura 7.1 . Il prezzo di mercato, riportato nella prima colonna della tabella nella Figura 7.1, è pari a 131 euro. L’impresa del nostro esempio non è in grado di praticare un prezzo più elevato riducendo la produzione, né ha bisogno di abbassare il prezzo per aumentare le vendite. La prima e la seconda colonna della tabella indicano che l’impresa può produrre e vendere la quantità che desidera a l prezzo di mercato di 131 euro.
Con questo non stiamo affermando che nei settori concorrenziali la domanda di mercato sia perfettamente elastica. Infatti, la domanda di mercato è rappresentata da una curva con pendenza negativa. L’intero settore (tutte le imprese che producono un determinato prodotto) può influenzare il prezzo modificando la produzione totale del settore. Per esempio, agendo indipendentemente e simultaneamente, tutte le imprese possono spingere il prezzo al rialzo riducendo la produzione. La singola impresa concorrenziale non è invece in grado di farlo, perché la quantità che produce costituisce solo una quota modesta della produzione totale del settore. Per la singola impresa concorrenziale il prezzo di mercato è quindi un valore fisso, al quale può vendere la quantità che desidera. Alla luce di queste considerazioni, la rappresentazione grafica della curva di domanda del prodotto della singola impresa concorrenziale è quindi una retta orizzontale, come D nella Figura 7.1.
ANALISI APPLICATA
L’albergo Ancora Lì
Vi è mai capitato, guidando, di scorgere un edificio in cattive condizioni di manutenzione e chiedervi perché il proprietario non lo sistemi o non lo dismetta definitivamente? La ragione, sorprendentemente, è che apportare miglioramenti alla struttura potrebbe non essere redditizio, mentre potrebbe esserlo continuare a utilizzarla così com’è per un certo periodo di tempo. Esaminare questo caso potrà aiutarvi a comprendere la decisione tra “continuare o cessare la produzione” con cui si confrontano le imprese quando la domanda del loro prodotto diminuisce.
Consideriamo l’albergo Ancora Lì, che si trova nei pressi di Qualunqualia, lungo la Vecchia Autostrada del Nord. Il proprietario l’ha costruito alcuni decenni fa sulla base dell’andamento del traffico e della concorrenza presenti allora. Ma dopo la costruzione di una nuova autostrada, la vecchia strada su cui si trova l’albergo è diventata relativamente poco frequentata. Oltretutto, l’albergo è sottoposto a una concorrenza spietata da parte delle nuove catene di alberghi che si trovano molto più vicine alla nuova autostrada.
Al diminuire della domanda e dei ricavi, da redditizio che era, l’albergo Ancora Lì ha cominciato a riportare perdite (P < CMT). All’inizio, i ricavi dall’affitto delle stanze erano sufficienti a coprire i costi variabili totali e a ripagare parte dei costi fissi, quali l’assicurazione e le imposte sugli immobili (P > CMV). Rimanendo in attività, l’albergo Ancora Lì ha subi-
to perdite inferiori a quelle che avrebbe riportato chiudendo i battenti. Ma da quando il ricavo totale ha smesso di coprire i costi totali (P < CMT), il proprietario ha capito che, nel lungo periodo, sarà necessario intervenire in qualche modo; di conseguenza, ha deciso di abbassare il costo medio totale minimo riducendo la quantità annuale di manutenzione. Di fatto, il proprietario ha deciso di permettere all’albergo di deteriorarsi per riconquistare una temporanea redditività.
Questa rinnovata redditività non può durare, perché con il passare del tempo non sarà possibile ridurre ulteriormente i costi di manutenzione. Il progredire del deterioramento strutturale determinerà prezzi di locazione delle stanze ancora più bassi e, quindi, un ricavo totale ancora minore. Il proprietario dell’albergo Ancora Lì sa che, prima o poi, il ricavo totale ricadrà nuovamente al di sotto del costo totale (ossia che P tornerà a un livello inferiore a CMT), anche evitando di spendere alcunché in manutenzione. Quando ciò accadrà, il proprietario chiuderà l’attività, demolirà la struttura e venderà il terreno. Ma fino ad allora, l’albergo è ancora lì: aperto, decadente e redditizio.
Perché anche gli alberghi ben tenuti e redditizi finiscono per chiudere nel lungo periodo, se il valore del terreno su cui si trovano diventa estremamente elevato a causa dello sviluppo economico delle zone circostanti?
Costo marginale e offerta di breve periodo
Nel paragrafo precedente abbiamo scelto tre diversi livelli di prezzo e ci siamo domandati quale quantità offrirà a ogni livello di prezzo l’impresa concorrenziale che cerca di massimizzare il profitto, dati i suoi costi. Questo insieme di prezzi e corrispondenti quantità offerte è parte della scheda di offerta dell’impresa concorrenziale.
La Tabella 7.1 sintetizza i dati relativi alla scheda di offerta per i tre livelli di prezzo citati (131, 81 e 71 euro) più altri quattro. La tabella conferma la relazione diretta tra prezzo e quantità offerta che abbiamo identificato nel capitolo 3. In primo luogo, si noti che l’impresa non produrrà se il prezzo
Tabella 7.1
La scheda di offerta di un’impresa concorrenziale a confronto con i costi riportati nella tabella della Figura 7.2
a un’importante arteria autostradale gli conferisce un vantaggio di posizione, che può permettere al proprietario di praticare prezzi più elevati sulle stanze rispetto ad altri alberghi che si trovano in una posizione meno comoda.
MARCHI E CONFEZIONI Anche l’uso dei marchi, la tipologia delle confezioni e l’associazione a personaggi famosi può creare una differenziazione dei prodotti. Per la maggior parte, le compresse di aspirina sono tra loro molto simili, ma molti di coloro che soffrono di emicrania ritengono che un marchio – per esempio, Bayer, Mylan e Teva – sia superiore ai sostituti generici e come tale valga la pena di pagare un prezzo più elevato per ottenerlo. Il nome di un personaggio famoso associato a un determinato orologio, profumo o scarpa sportiva può rendere il prodotto più attraente per alcuni compratori. Infine, una confezione che riporti la scritta “sorgente naturale” può attirare clienti aggiuntivi verso un determinato marchio di acqua in bottiglia.
UN CERTO GRADO DI CONTROLLO SUL PREZZO Grazie alla differenziazione dei prodotti, i venditori in concorrenza monopolistica esercitano un certo grado di controllo sul prezzo del proprio prodotto. Se i consumatori preferiscono i prodotti di un determinato venditore, entro certi limiti saranno disposti a pagare di più per soddisfare tale preferenza. I venditori e i compratori non si appaiano casualmente, come nei mercati perfettamente concorrenziali. Ciò nonostante, il controllo sul prezzo dei produttori in concorrenza monopolistica è piuttosto limitato, perché il loro prodotto ha molti sostituti potenziali.
Facilità di entrata e di uscita
L’entrata in un settore in concorrenza monopolistica è relativamente facile. Poiché di solito le imprese in concorrenza monopolistica sono di piccole dimensioni, esse presentano scarse economie d i scala e basse esigenze di beni capitali. Tuttavia, possono presentarsi barriere di tipo finanziario legate alla necessità di sviluppare e pubblicizzare un prodotto diverso da quello dei rivali. Alcune imprese custodiscono segreti commerciali sui propri prodotti o dispongono di marchi registrati sul proprio nome che ne rendono difficile e costosa l’imitazione da parte di altre imprese.
ISTANTANEA DAL MONDO 9.1
Il numero di ristoranti per 100 000 abitanti in un campione di città
Il numero e la densità delle imprese concorrenti nel settore della ristorazione, un mercato in concorrenza monopolistica, variano considerevolmente tra le diverse città del mondo. L’ampia variabilità nella densità dei ristoranti riflette le differenze locali sia nella domanda, sia nei costi di produzione.
Fonte: World Cities Culture Forum, 2018.
Numero di ristoranti per 100000 abitanti
La disoccupazione
Nel corso del ciclo economico insorgono due problemi: la disoccupazione e l’inflazione. Cominciamo dall’analisi della disoccupazione.
Misurare la disoccupazione
Ogni economia sviluppata si avvale solitamente di un istituto di statistica nazionale (in Italia l’Istat) che conduce regolarmente un’indagine per determinare chi sia occupato e chi non lo sia. In base alle risposte fornite, l’Istat stima il tasso di disoccupazione corrente nel Paese.
La Figura 11.2 ci aiuta a spiegare il metodo di calcolo del tasso di disoccupazione. L’Istat suddivide la popolazione italiana in quattro gruppi: il primo è composto dagli individui di età inferiore a i 15 anni e superiore ai 65 anni, che vengono considerati non abili al lavoro date le loro circostanze. Il secondo gruppo, di cui fanno parte i “non appartenenti alla forza lavoro”, è composto dagli i ndividui di età superiore ai 15 anni che né hanno un lavoro, né lo stanno cercando: questo gruppo include, per esempio, i genitori che non lavorano per dedicarsi alla cura dei figli, gli studenti a tempo pieno, i pensionati e i disoccupati “scoraggiati” che non cercano più lavoro. Presi insieme, il terzo e il quarto gruppo formano la forza lavoro, che nel 2024 costituiva circa il 67% della popolazione italiana in età lavorativa, ma solo il 41% della popolazione totale. La forza lavoro è composta sia dagli individui occupati, ossia impiegati, sia dai disoccupati, definiti come coloro che non hanno un lavoro ma che lo desiderano e lo stanno attivamente cercando. Il tasso di disoccupazione è la percentuale di occupati all’interno della forza lavoro:
disoccupati
Tasso di disoccupazione = × 100
forza lavoro
I dati statistici alla base delle cifre arrotondate nella Figura 11.2 mostrano che, nel 2024, il tasso di disoccupazione italiano era in media pari al:
1 664 000
25 500 000 × 100 = 6,5%
Popolazione non in età lavorativa (< 15 anni e > 65 anni)
Non forza lavoro = inattivi
Disoccupati
Occupati
Figura 11.2
Forza lavoro, occupazione e disoccupazione in Italia, 2024
La forza lavoro è composta dagli individui di età superiore ai 15 anni che sono (1) occupati o (2) disoccupati in cerca di lavoro. Fonte: Istat.
forza lavoro gli individui di età superiore a 15 anni che sono occupati oppure disoccupati e in cerca di lavoro
tasso di disoccupazione la percentuale della forza lavoro attualmente occupata
FOCUS SUL CONCETTO
Commercialista e imbianchino
Consideriamo il caso di un commercialista che è anche un abile imbianchino. Supponiamo che sia anche più bravo dell’imbianchino professionista che stava pensando di ingaggiare. Supponiamo inoltre che, lavorando come commercialista, possa guadagnare 50 euro all’ora, e che il compenso dell’imbianchino sia di 25 euro all’ora. Infine, poniamo che il commercialista impiegherebbe 30 ore per imbiancare tutta la casa, contro le 40 ore dell’imbianchino professionista.
Il nostro tuttofare dovrebbe sottrarre tempo al suo lavoro di commercialista per ridipingere la casa, o dovrebbe assumere l’imbianchino? Il costo-opportunità di ridipingere la propria abitazione è di 1500 euro (= 30 ore di lavoro da commercialista sacrificate × 50 euro all’ora di lavoro da commercialista). Il costo di assumere l’imbianchino è di soli 1000 euro (= 40 ore di imbiancatura × 25 euro all’ora di imbiancatura). Sebbene il commercialista sia più bravo in entrambi i mestieri, può sostenere un costo inferiore per l’imbiancatura della casa se si specializza nel mestiere di commercialista e impiega parte dei propri guadagni da commercialista per ingaggiare un imbianchino. Analogamente, l’imbianchino può ridurre i costi di ottenere servizi da commercialista specializzandosi nell’imbiancatura
e utilizzando parte del proprio reddito per assumere il commercialista affinché compili la sua dichiarazione dei redditi. Supponiamo che, per preparare la dichiarazione dei redditi, l’imbianchino impiegherebbe 10 ore, contro le 2 ore del commercialista. L’imbianchino sacrificherebbe quindi 250 euro di reddito (= 10 ore di lavoro da imbianchino × 25 euro all’ora) per svolgere un compito che potrebbe affidare a un commercialista per 100 euro (= 2 ore del commercialista × 50 euro all’ora). Specializzandosi nell’imbiancatura e assumendo un commercialista affinché compili la sua dichiarazione dei redditi, l’imbianchino abbassa i costi che deve sostenere per presentare la dichiarazione dei redditi.
Come vedremo, quel che è vero per il nostro commercialista e per il nostro imbianchino è vero anche per le nazioni. Specializzandosi secondo il proprio vantaggio comparato, i Paesi riducono il costo di ottenere i beni e i servizi che desiderano.
Come potrà cambiare la specializzazione sopra descritta una volta che il commercialista sarà andato in pensione? Quale generalizzazione sulla permanenza di un particolare schema di specializzazione potete trarre dalla vostra risposta?
Il vantaggio comparato: l’analisi delle possibilità produttive
Il nostro semplice esempio dimostra che la ragione per cui la specializzazione è desiderabile dal punto di vista economico è che permette una produzione più efficiente. Ora mettiamo la specializzazione nel contesto del commercio internazionale e usiamo il concetto ormai familiare di tabella delle possibilità produttive per condurre la nostra analisi.
IPOTESI E COSTI COMPARATI Supponiamo che due nazioni, Messico e Stati Uniti, abbiano la possibilità di produrre solo due beni. Le possibilità produttive di ognuno dei due Paesi sono mostrate rispettivamente nella Tabella 16.1 e nella Tabella 16.2 . Ciascun Paese deve rinunciare a una quantità costante di un bene per poter incrementare la produzione dell’altro bene di un certo ammontare. (Questa ipotesi semplifica la nostra discussione senza compromettere la validità delle nostre conclusioni. Più avanti prenderemo in considerazione i costi crescenti.)
Sempre per semplicità, supponiamo che i due Paesi dispongano di una forza lavoro di uguali dimensioni. Su questa base, i dati ci comunicano che gli Stati Uniti hanno un vantaggio assoluto nella produzione di entrambi i beni. Se entrambi i Paesi utilizzano la propria intera forza lavoro per produrre avocado, gli Stati Uniti possono produrne 90 tonnellate, contro le 60 tonnellate del Messico. A nalogamente, gli Stati Uniti possono produrre 30 tonnellate di fagioli di soia, contro le 15 tonnellate del Messico. Dato un numero uguale di lavoratori, le possibilità produttive sono maggiori negli Stati Uniti. Di conseguenza, per entrambi i beni la produttività (la quantità prodotta per lavoratore) è maggiore negli Stati Uniti che in Messico.
Tabella 16.1
La tabella delle possibilità produttive del Messico (in tonnellate)
Un settore in cui l’Italia è particolarmente competitiva sul mercato internazionale è quello dei macchinari. Questo settore, sebbene non sia di particolare interesse per il grande pubblico, vanta aziende italiane ed estere (in particolare tedesche) con una notevole reputazione a livello internazionale. L’Italia eccelle a livello internazionale anche in settori come la farmaceutica, la produzione di tubi e profilati in metallo, i prodotti agroalimentari e la moda.
L’Italia, come molti altri Paesi, è importatrice di energia (petrolio e gas), materie prime, metalli, prodotti chimici, tessili e beni ad alta tecnologia.
Riepilogo
I numeri in azzurro nel Riepilogo, nelle Domande e nei Problemi indicano gli obiettivi di apprendimento elencati a inizio capitolo
16.1 Elencare alcuni dati fondamentali sul commercio internazionale.
La Cina è il leader mondiale per volume di scambi internazionali, superando in anni recenti il primato degli Stati Uniti. Ciò nonostante altre nazioni più piccole tendono ad avere una maggiore incidenza del commercio internazionale sul proprio PIL. Gli Stati Uniti esportano principalmente prodotti chimici, prodotti agricoli, beni di consumo durevoli, semiconduttori e aeromobili, e importano principalmente petrolio, automobili, metalli, elettrodomestici e computer. Gli Stati Uniti hanno storicamente un forte disavanzo commerciale. L’Italia ha una bilancia commerciale tendenzialmente in pareggio, con esportazioni che includono macchinari, prodotti agroalimentari e moda, e importazioni di materie prime come energia e petrolio.
16.2 Definire il vantaggio comparato e spiegare in che modo la specializzazione e il commercio internazionale facciano aumentare la produzione nazionale. La specializzazione e lo scambio reciprocamente vantaggiosi sono possibili tra qualsiasi coppia di Paesi che differiscono tra loro per il rapporto di costo-opportunità nazionale nella produzione di due beni. Specializzandosi secondo i rispettivi vantaggi comparati, i Paesi possono ottenere un livello maggiore di reddito reale a partire da una quantità fissa di risorse. Le ragioni di scambio determinano il modo in cui tale aumento della produzione mondiale viene suddiviso tra i diversi partner commerciali.
16.3 Spiegare come si determinano i tassi di cambio. I tassi di cambio flessibili tra le diverse valute nazionali sono determinati dalla domanda e dall’offerta di tali valute. Le valute si deprezzano e si apprezzano in conseguenza dei cambiamenti delle preferenze e delle variazioni relative del reddito, dei tassi di inflazione, dei tassi di interesse e della speculazione monetaria.
Termini chiave
16.4 Esaminare criticamente le argomentazioni più frequenti a favore del protezionismo. Le argomentazioni più convincenti a favore del protezionismo sono quelle dell’industria nascente e dell’autosufficienza militare; la maggior parte delle altre argomentazioni sono portate avanti da gruppi di interesse particolare oppure discendono da errori di ragionamento che pongono enfasi sugli interessi dei produttori a discapito di quelli dei consumatori o sugli effetti immediati delle barriere commerciali ignorandone le conseguenze di lungo periodo. L’argomentazione protezionistica del lavoro estero a buon mercato non è valida, perché si concentra sui costi orari del lavoro, anziché sui costi che contano veramente, vale a dire i costi del lavoro per unità di produzione.
16.5 Spiegare gli obiettivi dell’Organizzazione mondiale del commercio e dell’Unione europea.
Nel 1974 è stato istituito l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) per incoraggiare il trattamento non discriminatorio di tutti i Paesi membri, ridurre i dazi ed eliminare i contingenti di importazione. Il ciclo di negoziazioni dell’Uruguay (1993) ha ridotto dazi e contingenti, liberalizzato gli scambi di servizi, ridotto i sussidi all’agricoltura, ridotto la pirateria della proprietà intellettuale ed eliminato gradualmente i contingenti di importazione sui tessuti.
Il successore del GATT, l’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), ha 166 Paesi membri e mette in pratica gli accordi raggiunti, arbitra le dispute tra Paesi membri e funge da foro per i dibattiti in materia di liberalizzazione degli scambi. L’ultimo ciclo di negoziazioni commerciali si è aperto alla fine del 2001 a Doha ed è ufficialmente ancora in corso.
Le aree di libero scambio liberalizzano il commercio internazionale all’interno di una regione. L’esempio principale è l’Unione europea (UE), che conta 27 Paesi membri, 20 dei quali hanno abbandonato la propria valuta nazionale per adottare una valuta comune, l’euro.
vantaggio comparato • ragioni di scambio • mercato dei cambi • tasso di cambio • deprezzamento • apprezzamento • dazio • contingentamento delle importazioni • barriere non tariffarie • restrizioni volontarie delle esportazioni • sussidi alle esportazioni • dumping • delocalizzazione • Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) • Organizzazione mondiale del commercio (WTO) • ciclo di Doha • Unione europea (UE) • euro
Domande
1. In termini quantitativi, quanto è importante il commercio internazionale per l’Italia? Quali sono i Paesi principali con cui opera scambi commerciali? La bilancia commerciale registra un avanzo o un disavanzo? (16.1)
2. Supponiamo che Paesone possa produrre 80 unità di X se impiega tutte le proprie risorse nella produzione di X oppure 60 unità di Y destinando tutte le risorse a Y. Invece, a partire dalle proprie risorse Paesino può produrre 60 unità di X o 60 unità di Y. Nell’ipotesi di costi costanti, nella produzione di quale bene dovrebbe specializzarsi ciascun Paese? Spiegate. Quali sono i limiti delle ragioni di scambio tra questi due Paesi? (16.2)
3. Spiegate perché la domanda statunitense di peso messicani ha pendenza negativa e l’offerta di peso ha pendenza positiva. Indicate se ciascuno dei seguenti eventi farebbe apprezzare o deprezzare il peso, a parità di altre condizioni. (16.3)
a. G li Stati Uniti riducono unilateralmente i dazi sui prodotti messicani.
b. Il Messico attraversa un periodo di forte inflazione.
c. Il deteriorarsi delle relazioni politiche tra i due Paesi determina una diminuzione del turismo statunitense verso il Messico.
d. L’economia statunitense entra in grave recessione.
e. G li Stati Uniti intraprendono una politica monetaria di tassi di interesse elevati.
f. I prodotti messicani diventano di moda tra i consumatori statunitensi.
g. Il governo messicano incoraggia le imprese statunitensi a investire nelle riserve petrolifere messicane.
h. Il tasso di crescita della produttività statunitense diminuisce drasticamente.
4. Indicate se concordate con le seguenti affermazioni, e perché. Applicate l’ipotesi di parità di altre condizioni. (16.3)
Problemi
1. S upponiamo che i rapporti di costo-opportunità tra due prodotti – latte in polvere per neonati e tonno – nei due Paesi di Inscatola e Pinnata siano i seguenti: Inscatola, 1 confezione di latte in polvere ≡ 2 confezioni di tonno; Pinnata, 1 confezione di latte in polvere ≡ 4 confezioni di tonno. In quale produzione dovrebbe specializzarsi ciascuno dei due Paesi? Quale delle seguenti ragioni di scambio potrebbe essere considerata accettabile per entrambi i Paesi? (16.2)
a. 1 confezione di latte in polvere ≡ 2,5 confezioni di tonno.
b. 1 confezione di latte in polvere ≡ 1 confezione di tonno.
c. 1 confezione di latte in polvere ≡ 5 confezioni di tonno.
a. Una nazione che cresce più velocemente dei suoi principali partner commerciali può aspettarsi un deprezzamento della propria valuta.
b. Una nazione con tassi di interesse che crescono più rapidamente di quelli di altre nazioni può aspettarsi un apprezzamento della propria valuta.
c. L a valuta di una nazione si apprezza se il suo tasso di inflazione è inferiore a quello del resto del mondo.
5. Supponiamo che un orologiaio svizzero importi componenti per orologi dalla Svezia ed esporti orologi negli Stati Uniti. Supponiamo inoltre che il dollaro si deprezzi e la corona svedese si apprezzi rispetto al franco svizzero. Ragionate sulle ricadute negative di questi eventi sull’orologiaio svizzero. (16.3)
6. Q uali misure intraprendono i governi per promuovere le esportazioni e limitare le importazioni? Chi trae beneficio e chi viene danneggiato dalle politiche protezionistiche?
Qual è il risultato netto per la società? (16.4)
7. Nel 2018 gli operai statunitensi guadagnavano un salario medio orario di 21,86 dollari. Nello stesso anno gli operai messicani guadagnavano un salario medio orario di 3,20 dollari. Per i produttori statunitensi è possibile competere con quelli messicani? Perché non si produce tutto in Messico e negli altri Paesi a bassi salari? (16.4)
8. Cos’è la delocalizzazione dei lavoratori nei servizi, e che relazione ha con il commercio internazionale? Perché la delocalizzazione è aumentata negli ultimi decenni? Fornite un esempio (diverso da quelli presentati nel testo) di come la delocalizzazione possa distruggere alcuni posti di lavoro nel Paese, ma anche crearne di nuovi. (16.2)
9. Identificate e spiegate l’importanza di ciascuna delle seguenti entità legate al commercio: (a) la WTO, (b) l’UE e (c) l’eurozona. (16.5)
2. L e tabelle seguenti riportano le ipotetiche possibilità produttive di Nuova Zelanda e Spagna. Ciascun Paese può produrre mele e prugne. Tracciate in due diversi grafici le curve delle possibilità produttive dei due Paesi e rispondete alle domande che seguono. (16.2)
Tabella delle possibilità produttive della Nuova Zelanda (milioni di chili)
PRODOTTOALTERNATIVE
Titolo originale: Essential of Economics, Fifth Edition
Published by McGraw Hill LLC, 1325 Avenue of the Americas, New York, NY 10019. Original edition copyright © 2023 by McGraw Hill LLC. Previous editions © 2019, 2014, 2010. All rights reserved. Italian edition copyright © 2025 Zanichelli editore S.p.A., via Irnerio 34, 40126 Bologna Bologna [79920] www.zanichelli.it
Traduzione: Matilde Soligno
Revisione: Luca Barbarito e Mattia Tassinari
Diritti riservati
I diritti di pubblicazione, riproduzione, comunicazione, distribuzione, trascrizione, traduzione, noleggio, prestito, esecuzione, elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale e di adattamento totale o parziale su supporti di qualsiasi tipo e con qualsiasi mezzo (comprese le copie digitali e fotostatiche), sono riservati per tutti i paesi. L’acquisto della presente copia dell’opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce.
Fotocopie e permessi di riproduzione
Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E. del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E.
Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico, commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l’editore potrà concedere a pagamento l’autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume.
Le richieste vanno inoltrate a: Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (CLEARedi), Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano e-mail: autorizzazioni@clearedi.org e sito web: www.clearedi.org
L’autorizzazione non è concessa per un limitato numero di opere di carattere didattico riprodotte nell’elenco che si trova all’indirizzo www.zanichelli.it/chi-siamo/fotocopie-e-permessi
L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale. La loro fotocopia per i soli esemplari esistenti nelle biblioteche è consentita, anche oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all’opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell’editore, una successiva edizione, né le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. Nei contratti di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei e archivi, la facoltà di cui all’art. 71-ter legge diritto d’autore. Per permessi di riproduzione, diversi dalle fotocopie, rivolgersi a ufficiocontratti@zanichelli.it Licenze per riassunto, citazione e riproduzione parziale a uso didattico con mezzi digitali La citazione, la riproduzione e il riassunto, se fatti con mezzi digitali, sono consentiti (art. 70 bis legge sul diritto d’autore), limitatamente a brani o parti di opera, a) esclusivamente per finalità illustrative
Coordinamento editoriale: Daniele Bonanno
Redazione: Francesca Divano, Federica Russo
Indice analitico: Matilde Soligno
Impaginazione: Garon, Cremona
Copertina:
– Progetto grafico: Falcinelli & Co., Roma
– Immagine di copertina: © Waro Photos/Unsplash
Prima edizione italiana: settembre 2025
Ristampa: prima tiratura
a uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. (La finalità illustrativa si consegue con esempi, chiarimenti, commenti, spiegazioni, domande, nel corso di una lezione); b) sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le parti di opere sono utilizzate; c) a condizione che, per i materiali educativi, non siano disponibili sul mercato licenze volontarie che autorizzano tali usi. Zanichelli offre al mercato due tipi di licenze di durata limitata all’anno accademico in cui le licenze sono concesse:
A) licenze gratuite per la riproduzione, citazione o riassunto di una parte di opera non superiore al 5%. Non è consentito superare tale limite del 5% attraverso una pluralità di licenze gratuite, B) licenze a pagamento per la riproduzione, citazione, riassunto parziale ma superiore al 5% e comunque inferiore al 40% dell’opera. Per usufruire di tali licenze occorre seguire le istruzioni su www.zanichelli.it/licenzeeducative L’autorizzazione è strettamente riservata all’istituto educativo licenziatario e non è trasferibile in alcun modo e a qualsiasi titolo.
Garanzie relative alle risorse digitali
Le risorse digitali di questo volume sono riservate a chi acquista un volume nuovo: vedi anche al sito www.zanichelli.it/contatti/acquisti-e-recesso le voci Informazioni generali su risorse collegate a libri cartacei e Risorse digitali e libri non nuovi Zanichelli garantisce direttamente all’acquirente la piena funzionalità di tali risorse. In caso di malfunzionamento rivolgersi a assistenza@zanichelli.it
La garanzia di aggiornamento è limitata alla correzione degli errori e all’eliminazione di malfunzionamenti presenti al momento della creazione dell’opera. Zanichelli garantisce inoltre che le risorse digitali di questo volume sotto il suo controllo saranno accessibili, a partire dall’acquisto, per tutta la durata della normale utilizzazione didattica dell’opera. Passato questo periodo, alcune o tutte le risorse potrebbero non essere più accessibili o disponibili: per maggiori informazioni, leggi my.zanichelli.it/fuoricatalogo
Soluzioni degli esercizi e altri svolgimenti di compiti assegnati
Le soluzioni degli esercizi, compresi i passaggi che portano ai risultati e gli altri svolgimenti di compiti assegnati, sono tutelate dalla legge sul diritto d’autore in quanto elaborazioni di esercizi a loro volta considerati opere creative tutelate, e pertanto non possono essere diffuse, comunicate a terzi e/o utilizzate economicamente, se non a fini esclusivi di attività didattica.
Diritto di TDM L’estrazione di dati da questa opera o da parti di essa e le attività connesse non sono consentite, salvi i casi di utilizzazioni libere ammessi dalla legge. L’editore può concedere una licenza. La richiesta va indirizzata a tdm@zanichelli.it
5 4 3 2 1 2025 2026 2027 2028 2029
Realizzare un libro è un’operazione complessa, che richiede numerosi controlli: sul testo, sulle immagini e sulle relazioni che si stabiliscono tra essi. L’esperienza suggerisce che è praticamente impossibile pubblicare un libro privo di errori. Saremo quindi grati ai lettori che vorranno segnalarceli. Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo: Zanichelli editore S.p.A. Via Irnerio 34 40126 Bologna fax 051293322
e-mail: linea_universitaria@zanichelli.it sito web: www.zanichelli.it
Prima di effettuare una segnalazione è possibile verificare se questa sia già stata inviata in precedenza, identificando il libro interessato all’interno del nostro catalogo online per l’Università. Per comunicazioni di tipo commerciale: universita@zanichelli.it
Stampa:
per conto di Zanichelli editore S.p.A. Via Irnerio 34, 40126 Bologna
Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell, Sean M. Flynn
L’essenziale di economia
A cura di Luca Barbarito e Mattia Tassinari
L’Essenziale di economia è un manuale che fornisce i principi economici di base per comprendere i problemi economici, le questioni specifiche che essi sollevano e le politiche economiche che potrebbero risolverli. Partendo dal concetto di scarsità e dalle scelte che essa impone a individui e società, spiega in che modo l’economia ci aiuta a capire come si utilizzano risorse limitate per soddisfare bisogni illimitati, evidenziando l’importanza del costo-opportunità e dell’analisi marginale nelle decisioni economiche.
È un’opera compatta, che introduce gli argomenti in modo progressivo e per capitoli tematici, ciascuno con specifici obiettivi di apprendimento, che aiutano a focalizzare i concetti fondamentali.
Il linguaggio chiaro, coinciso e accurato porta ad assimilare gradualmente il lessico specifico della materia. L’uso di esempi concreti e casi di studio permette di illustrare in modo efficace concetti complessi, come la transizione da economie pianificate a economie di mercato, il funzionamento del sistema bancario a riserva frazionaria e le strategie di politica fiscale e monetaria.
Stanley L. Brue è un economista di fama mondiale. Ha insegnato presso la Pacific Lutheran University, dove è stato insignito del Burlington Northern Faculty Achievement Award. Ha ricevuto il premio nazionale Leavey Award per l’eccellenza nell’insegnamento dell’economia. Ha ricoperto il ruolo di presidente nazionale e presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Omicron Delta Epsilon, onorificenza internazionale in economia.
Campbell R. McConnell ha insegnato presso l’Università del Nebraska-Lincoln. Ha ricevuto il Distinguished Teaching Award dell’Università del Nebraska e il James A.Lake Academic Freedom Award. È stato presidente della Midwest Economics Association.
Sean M. Flynn insegna presso lo Scripps College di Claremont, in California.
Gli esempi proposti vanno dal prezzo del pane nei diversi Paesi ai sussidi per l’energia verde, dai Bitcoin alla presunta gratuità di Facebook, da Uber al dibattito sul reddito di base universale (UBI) e in molti casi riguardano l’Europa e l’Italia, così da essere ancora più vicini all’esperienza di studentesse e studenti italiani.
Il testo è corredato da numerose schede:
• Confronto per immagini facilita la comprensione visiva dei concetti
• Focus sul concetto chiarisce gli aspetti più complessi
• Analisi applicata collega la teoria alla pratica
• Istantanea dal mondo offre uno sguardo sulle dinamiche economiche globali
Ogni capitolo si conclude con rubriche per consolidare e verificare le conoscenze: il riepilogo fissa i concetti principali, i termini chiave consolidano il lessico specifico, mentre una sezione di domande analitiche e problemi, collegata agli obiettivi di apprendimento indicati all’inizio del capitolo, induce al pensiero critico e mette alla prova le competenze acquisite.
Le risorse digitali universita.zanichelli.it/brue
A questo indirizzo sono disponibili le risorse digitali di complemento al libro.
Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su my.zanichelli.it inserendo il codice di attivazione personale contenuto nel libro.
Libro con Ebook
Chi acquista il libro nuovo può accedere gratuitamente all’Ebook, seguendo le istruzioni presenti nel sito.
L’accesso all’Ebook e alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile, né autonomamente né con la cessione del libro cartaceo.
Inquadra e scopri i contenuti BRUE*ESSENZIALE DI ECONOMIA LUM