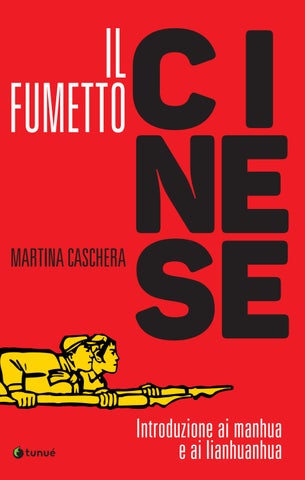IL FUMETTO C I NE SE
LAPILLI GIGANTI
IL MEGLIO DELLA SAGGISTICA MONDIALE
COLLANA DIRETTA DA MARCO PELLITTERI
COMITATO SCIENTIFICO DI COLLANA:
Daniele Barbieri
Accademia di Belle Arti di Bologna
Marco Bellano
Università di Padova
Sergio Brancato
Università Federico II di Napoli
Juri Meda
Università di Macerata
Toshio Miyake
Università Ca’ Foscari di Venezia
Martino Negri
Università di Milano Bicocca
Marco Pellitteri
Xi’an Jiaotong-Liverpool University
Università della Tuscia






Collana «Lapilli Giganti» n. 15
I edizione: maggio 2023
A cura di: Marco Pellitteri
Diritti di traduzione, riproduzione e adattamento riservati per tutti i Paesi
Copyright © 2023 Tunué S.r.l.
Tunué
Via degli Ernici 30 04100 Latina – Italy tunue.com | info@tunue.com
Direttore editoriale Massimiliano Clemente
Copertina: Sebastiano Barcaroli
Tutte le immagini appartengono ai rispettivi legittimi titolari del copyright (©) e sono qui riprodotte unicamente a scopo di critica e ricerca
GUIDA PER LA CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA
Il fumetto cinese Introduzione ai manhua e ai lianhuanhua
Questo libro è stato soggetto al referaggio indipendente di due docenti universitari esperti italiani nel campo della sinologia e ha passato ambo le valutazioni. Il testo è stato altresì vagliato e carica per la collana in cui il libro appare.
Questo volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
INTRODUZIONE, 9
CRONOLOGIA DELLA STORIA DELLA CINA E NOTA STORICA ORIENTATIVA, 17
I. DEFINIZIONI E INFORMAZIONI PRELIMINARI, 33
33 | I. 2. Come si dice «fumetto» in cine34 | I. 2.1. Lianhuanhua, 35 | I. 2.2. Manhua, 36 | I. 2.3. Lianhuanhua, 38 | I. 3. Questione di approc40 | I. 3.1. Rapporti intermediali e transtestuali, 42 | 44 | I. 4.Il proto-fumetto in Cina, 48
II. DALLE ORIGINI AGLI ANNI VENTI DEL XX SECOLO, 53
XIX e XX secolo, 53 | II. 5.1. La stampa periodica nel XIX secolo e le prime riviste illustrate, 53 | II. 5.2. La rivista illustrata Dianshizhai, 55 | Youru, 57 | II. 5.4. Elementi transculturali nello sviluppo dei linguaggi gra-
58 | II. 5.5. La rivista Shanghai Puck e Shen Bochen, 61 del lianhuanhua (disegni sequenziali) e del manhua (disegno «spontaneo» o vignetta satirica), 66 | 66 | Le due anime del manhua moderno: il «disegno spontaneo» di Feng Zikai e la vignetta satirica, 71
III. DAI TARDI ANNI VENTI AGLI ANNI QUARANTA DEL XX SECOLO, 79 79 | III.viste illustrate e riviste «a fumetti» negli anni Venti e Trenta, 79 | 83 |tori, distribuzione e boom, 90 | 90 | 92 | 93 | 99 | 99 |105
111 |
111 | III. 8.2. Le Squadre di propaganda a fumetti e il ruolo del manhua, 116 | III. 8.3. Verso un nuovo lianhuanhua, 122 | III. 8.4. Il lianhuan manhua negli anni Quaranta. Sanmao, eroe e vittima delle guerre, 125
IV. IL PERIODO MAOISTA, 1949-1976, 129
129 | politica culturale maoista e la creazione del «nuovo lianhuanhua», 129 | 136 |
137 | 144 | IV. 10. Autori e stili rappresentativi, 149 | IV. 10.1. Autori e opere di spicco fra arte tradizionale e ispirazioni straniere, 149 | IV. 10.1.1. Autori maggiori, 153 | IV. 10.1.2. Altri autori di rilievo, 159 | IV. 10.2. Note ulteriori sugli stili rappresentativi, 162 | IV. 10.2.1. Illusionismo e naturalismo, 164 | IV. 10.2.2. Ispirazione al Realismo socialista sovietico, 167 | IV. 10.2.3. Progressiva sinizzazione del lianhuanhua: il Romanticismo rivoluzionario, 167
171 | IV. 11.1. Manhua e «manhua concatenati» (lianhuan manhua), 171 | IV. 11.2. Ideologia e censura, 175 | IV. 11.2.1. Critica e autocritica: Il «caso Sanmao», 176 | 177 |
183
V. LE RIFORME ECONOMICHE E IL NUOVO FUMETTO CINESE (DAL 1978 AI PRIMI ANNI DUEMILA), 191
V. 12. Rinascita e declino del lianhuanhua, 191 | V. 12.1. Nel segno di Mao. Le cicatrici del periodo post-maoista nel manhua e nel lianhuanhua, 191 | V. 193 | V. 12.1.2. Le «cicatrici» del lianhuanhua, 195 | V. 12.2. Il lianhuanhua e il suo declino nel corso degli anni Ottanta, 197 |
206 | V. 12.3.1. La crisi del lianhuanhua e la malìa del
nuovo. Gli anni Ottanta, 208 | 212 | 218 | V. 13. Il XXI secolo. Pratiche generaliste e soluzioni alternative: il fumetto digitale e il fumetto indipendente, 220 | V. 13.1.Nuove forme di disseminazione e fruizione PC: dalle riviste online
ai webtoon, 220 |ground cinese, 229 | V. 14. Fumetti in viaggio e fumetti sinofoni, 235 | V. 14.1. Fumetti in translation, 236 | V. 14.1.1. Zao Dao, 239 | V. 14.1.2. Zuo Ma, 242 | V. 14.2. Fumetto sinofono. Collaborazioni sino-europee e approfondimento su due autori pubblicati in Italia: Li Kunwu e Yi Yang, 243 | V. 14.2.1. Li Kunwu, 247 | V. 14.2.2. Yi Yang, 248
CONCLUSIONI, 251
APPENDICI, 255
1. PROPOSTE DI LETTURA PER LA SCOPERTA O RISCOPERTA DEL FUMETTO CINESE, 257
Dieci fumetti da conoscere, 257 258
2. TABELLA SINOTTICA E GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI DEL FUMETTO E DELLE ARTI IN CINESE, 259
Tabella sinottica dei principali termini utilizzati nel XX secolo per indicare il «fumetto cinese, 259
260
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI, RISORSE INTERNET E FONTI DELLE IMMAGINI, 265 265
Risorse internet, 296
Fonti delle immagini, 297
INDICE DEI NOMI DEGLI AUTORI E PERSONAGGI STORICI CITATI
E TITOLI DELLE OPERE MENZIONATE CON GRAFIE IN CINESE, 303
INTRODUZIONE
Fumetto cinese: perché?
La storia del fumetto cinese si articola in storia del fumetto cinese continentale, storia del fumetto taiwanese (che segue un suo percor-
colonia britannica dal XIX secolo. Ciascuno di questi percorsi ha sue
delle distinzioni storiche e politiche fra Cina continentale, Taiwan e -
duzioni fumettistiche, specialmente dagli anni Cinquanta, si occupa primariamente della produzione relativa alla Cina continentale, con solo brevi cenni alle altre due produzioni.
-
cupava una posizione centrale nel contesto mediatico della Repubblica popolare cinese (RPC). Fino agli anni Novanta del XX secolo il fumetto è stato infatti uno dei media attraverso cui il discorso della RPC tuttavia, esso non è in grado di ottenere lo stesso impatto: il merca-
seconda potenza economica mondiale ha ripreso a investire), grazie anche dalla fruizione in digitale via siti e app gratuite, ma la forma dei prodotti autoctoni di maggiore successo è troppo vicina al modello giapponese e dunque ben lontana dai desiderata della linea nazionale e nazionalista. Di fatto, il fumetto cinese oggi più popola-
re, lo xinmanhua (cfr. il Capitolo II),1 non ha caratteristiche univo-
è dunque internazionalmente riconoscibile e ha un impatto globale estremamente basso rispetto a quello di Giappone e Corea del Sud. Per capire cosa distingua il fumetto cinese da quello dei suoi cugi-
Il fumetto in Cina non ha mai smesso di mutare ed adattarsi alle circostanze e agli ambienti, cercando di tenere in piedi un contatto più o meno visibile con la tradizione. La questione estetica e stilistinel mercato del fumetto internazionale (cfr. il Capitolo V).nerale produzione culturale nazionale durante il corso del XX secolo,
autori e opere. Infatti, dato il recente incremento di traduzione e produzione di titoli di autori cinesi in Italia, si è ritenuto importante
capire cosa sta guardando e dove risiedono quelle caratteristiche peculiari che, quando presenti, non sono così immediate da cogliere,lia (si vedano la collana «Bao» della Bao Publishing, la costante attenzione alle opere cinesi di Oblomov Edizioni e Add Editore e la -
sia) si è reso manifesto il bisogno di un avvicinamento non solo di studenti e ricercatori, ma anche del pubblico generalista alla storia e al mondo dei fumetti cinesi. Questo libro, unico nel suo genere in Italia, è allora una guida per orientarsi e uno spunto per ragionaregrati in un percorso omogeneo e accessibile.
1 I fumetto cinese.
Per questo motivo Il fumetto cinese si rivolge a più tipi di lettori: dai curiosi di Cina, che notano ormai la presenza del gigante asiatico in tutti i telegiornali e si vogliono avvicinare alla sua cultura percorle proprie conoscenze osservando da un punto di vista diverso feno-
se, su questo discorso, valga la pena di investire tempo ed energie.
Letteratura accademica di riferimento e obiettivi
Per comprendere la forma presente e le prospettive future del fumetto cinese è necessario comprenderne origini, evoluzione e caratteristiche. È qui che entra in gioco questo libro, che si propone non solo di fornire un inquadramento teorico e chiavi metodologiche per lo studio del suddetto medium, ma anche di collocarne storia, autori e opere rappresentative nel più ampio contesto del XX secolo al XXI secolo. -
verte su scala internazionale, ma in particolare nel mercato editorialemento del tema. Tra i lavori a disposizione in lingua italiana vi sono-tori contemporanei. Questo libro, invece, mira a riempire le maggiori -
Mancando tuttavia un testo omogeneo da cui attingere coordinate storiche e strumenti analitici per lo studio dei linguaggi del fumetto o addirittura errate. Quei lettori non esperti di Cina che desiderano avvicinarsi alla produzione culturale di un Paese sempre più pre-
nazionale, troveranno Il fumetto cinese di facile accesso, grazie alla -
gnare il testo in concomitanza dei principali snodi storici, e sono altresì indispensabili per comprendere le analisi testuali.
In ambito sinologico, Il fumetto cinese rappresenta un passo importante per lo studio del linguaggio del fumetto cinese. Nonostante in Cina la cultura popolare abbia sempre incluso una forte compo-
la sua lingua scritta, lo studio della sua cultura popolare visuale halentemente inesplorata. Gli albi e libri a fumetti, in quanto prodotti esemplari della cultura visuale popolare, sono diventati oggetto di scrutinio accademico e «tecnico» solo negli ultimi decenni. In Cina
intenti ideologici, che ha escluso per lungo tempo la produzione puramente commerciale o, più di recente, un approccio cosiddetto «post-socialista» (etichetta che riassume il passaggio al capitalismo «cinese») mirato ad analizzare vendite e tendenze di mercato. Le
War and Popular Culture Mao’s New World Political Culture in Early People’s Republic (2011), che illustrano i rapporti tra diversi prodotti della cultura popolare, tra cui le vignette satiriche e di propaganda, e il loro contesto da un punto di vista primariamen-
moderna si riferisce anche Paul Bevan nel suo A Modern Miscellany
Il più recente Manhua Modernity, Chinese Culture and the Pictorial Turn (2020) di John Crespi si occupa primariamente del manhua, 2 -
2 Nel Capitolo I -
completo a oggi sul manhua e sul periodo storico che va dagli anni Venti agli anni Sessanta del secolo scorso, ed esamina diversi aspet-da il fumetto propriamente detto, ossia un testo narrativo visuale pionieristico) lavoro di Andreas Seifert Bildgeschichten für Chinas Massen. Comic und Comicproduktion im 20. Jahrhundert illustrate per le masse cinesi. Fumetti e produzione a fumetti nel xx del XX secolo, oltre a mostrare un approccio analitico alle opere. Il libro prende le mosse dalla collezione personale di Seifert, che oggi supera i 4000 titoli. In lingua inglese, Asian Comics (2015) e Comics Art in Chinatali fonti di informazioni storiche di prima mano sui linguaggi del fumetto asiatico (vignette, strisce, narrazioni illustrate) dalle origini agli ultimi anni del XX secolo, essendo il testo incardinato su interviste svolte dal prof. Lent nel corso di decenni. Rispetto allo studio
Il recente lavoro di Marco Pellitteri I manga. Introduzione al fumetto giapponese (2021), in italiano, e i succitati lavori di Lent e Crespi, in inglese, costituiscono importanti riferimenti per questo
una sintesi ragionata della letteratura esistente riguardo autori emanuale o compendio, poiché presenta percorsi e nuclei tematici che sorgono dalla mia personale ricerca e propone interpretazioni e discorsi originali. Esso si pone il duplice obiettivo di assicurare informazioni accurate ed essenziali per un primo approccio al tema, adottati strumenti ad hoc (Capitolo III).
anni recenti, manhua indicava in Cina le vignette singole, lianhuanhua le storie illustrate in sequenza e dagli anni Ottanta il termine «manhua» è stato risemantizzato a indicare i fumetti sequenziali, insieme ai «nuovi manhua», detti xinmanhua
Il volume contribuisce, in ultima analisi, a rendere chiara non solo -
ma anche quella della Cina contemporanea, che oggi integra il fumetto nel suo discorso pubblico nazionale e internazionale.
Organizzazione del libro
Pur non potendo essere una dettagliata storia del fumetto cinese, questo libro illustra gli argomenti seguendo un ordine cronologico. Questo è fondamentale soprattutto in un contesto, come quello italiano, in cui molti lettori, sicuramente, hanno poca o nessuna comprendere la questione terminologica, che si evolve nei decenni, sarebbe impossibile se non integrandola in un più ampio per-
Il libro è suddiviso in cinque macro-capitoli indicati da numeri romani, a sua volta suddivisi in un totale di 14 sezioni primarie (con subsezioni) e alcuni apparati.
A questa Introduzione seguono una Tavola cronologica e una Nota -
gure storiche che si riproporranno nel corso del libro. Questi primi apparati sono stati realizzati per rendere facile (o comunque meno
Il Capitolo Isioni introduttive dal punto di vista teorico e metodologico, mentre il Capitolo II presenta al lettore il contesto in cui il fumetto cinese manhua e lianhuanhuaterculturali nella formazione dei primi autori di vignette e fumetti cinesi.
Il Capitolo III si occupa della maturazione del mercato editoriale cinese e della Seconda guerra mondiale, che ha un enorme impatto su quello e, di conseguenza, sulle forme del fumetto cinese. Il Capitolo IV segue un cambiamento epocale, ossia la fondazione della Repubblica popolare cinese e la riorganizzazione del sistema culturale: qui si propone una periodizzazione delle fasi fondamentali
del lianhuanhua adottata in letteratura: una prima fase coincide con i primi diciassette anni dalla fondazione della RPC -
V segue i cambiamenti della Cina post-maoistafenomeno è in velocissima evoluzione, ma grazie anche al contributo delle digital humanities, in particolare, e al web, più in generale,e narratologica) del fumetto cinese.
RINGRAZIAMENTI
dal 2011, mi ha supportata nelle ricerche sul fumetto cinese, condividendo la
particolare un elaborato del prof. Federico Greselin, utilissimo nella stesura di romana della professoressa, passati a confrontarmi col prof. Franco Mazzei sulle possibili interpretazioni politiche, economiche e sociali di alcune vignette selezionate per la tesi di dottorato. Il professore, da poco venuto a mancare, fu solo nelle analisi, ma anche nella tensione al raggiungimento di un metodo interdisciplinare. Su questo aspetto devo poi ringraziare anche la prof.ssa Vaanche la prof.ssa Alessandra Cristina Lavagnino, che mi ha «vista» e accolta, maniera matura e consapevole ma senza rinunciare a uno spirito appassionato. Similmente anche il prof. Gianluigi Negro, che un giorno a Prato mi disse che USI di Lugano, dimostrandomi che ci credeva. Un ringraziamento speciale anche al prof. Luca Stirpe, che mi ha accolta e sostenuta a Pescara, permettendomi di conoscere il mondo uni-
litteri devo due tipi di ringraziamenti. Il primo è per aver avuto estrema cura
da punti di vista prima non considerati, forzandomi verso una dimensione di ricerca (e di scrittura) più completa.
vato», ossia tutte le persone che mi hanno sostenuta in maniera instancabile (quasi fosse un lavoro, appunto), in tutti questi anni: da mio padre Maurizio Caschera, ingegnere editor, al mio compagno Roberto Turchi, uomo dal cuore
Antonio e Vera, le mie nonne e i miei amici, pur se non coinvolti direttamente nelle ricerche e sul testo, li ringrazio per la stima e la pazienza nel sopportare i bronci e le assenze. Spero ne sia valsa la pena.
CRONOLOGIA DELLA STORIA DELLA CINA E NOTA STORICA ORIENTATIVA
Cronologia della storia della Cina
Dinastia Xia
Dinastia Shang
Dinastia Zhou
Dinastia Qin
Dinastia Han
Periodo dei Tre regni
Dinastia Jin
Dinastie del Nord e del Sud
Dinastia Sui
Dinastia Tang
Cinque dinastie e dieci regni
Dinastia Song
Dinastia Yuan
Dinastia Ming
Dinastia Qing
Repubblica di Cina
Repubblica Popolare cinese
Nota storica orientativa
Una storia millenaria
Nonostante la storia del fumetto cinese vera e propria inizi nella seXIX secolo, la storia della Cina antica e pre-moderna saranno molto presenti tra le pagine del libro, soprattutto per questioni estetiche (riferimenti a modelli classici) e intertestuali (riferimenti a generi e opere tradizionali). Si intende in questa Nota storica dare al lettore alcune informazioni di massima per orientarsilenaria» (Vogelsang 2012).1
Come osserva la sinologa Elisa Giunipero, «dividere la storia insione a cui siamo abituati in Italia, non trova corrispondenza nella(ibid.divisa nei periodi segnati dalle diverse dinastie, e dunque i concetti di dinastia e periodo, per quanto semanticamente non sovrappopersonaggio politico di riferimento e dunque avremo per esempio 2 che mutua il suo nome da Mao Zedong
1 Ci si limita qui a indicare dinastie, eventi e personaggi storici menzionati o necessari a comprendere aspetti trattati nel libro. Per i dovuti approfondimenti si rimanda ai testi di Vogelsang (2012), Sabattini e Santangelo (2003) e i due testi di Samarani dedicati alla Cina contemporaChang e Owen (2010a e 2010b), Pirazzoli e Pesaro (2020). Per una disamina degli aspetti cul-
2 La trascrizione dei nomi dei personaggi storici (così come dei termini in cinese) è conforme al
La periodizzazione dinastica è legata alla stirpe dei re, prima della fondazione del primo impero, e degli imperatori, successivamente. Il criterio dinastico viene applicato dal II millennio a.C. al XX secolo(III millennio-II millennio a.C.), si innesta sulle origini mitologiche della Cina. Questa è seguita dalla prima dinastia della quale ci sono pervenute tracce scritte: gli Shang (II millennio a.C.). Durante glicise su ossa di buoi e carapaci di tartaruga a scopi divinatori: risalgono dunque al 1250 a.C. circa le prime forme di scrittura cinese.III a.C.).
Prima di allora la Dinastia Zhou (secc. XII-III a.C.) aveva gestito un territorio vasto, ma molto più ridotto rispetto alla Cina di oggi, con il suo baricentro nelle pianure centrali. A questa lunga dinastia, si ricorda, va attribuita la nascita sia del pensiero confuciano, legato VI-V secc. a.C.) e Mencio (Mengzi, IVIII secc. a.C.), che di quello daoista, riconducibile in particolare agli scritti di Laozi (VII IV-III secc. a.C.).III a.C.- III d.C.) si compì un ulteriore passo avanti in questo campo, poiché è (un quadrato).3 In breve: la forma odierna dei caratteri deriva dalla 3 Ogni qual volta occorre indicare la rilevanza di una parola tecnica, questa è contrassegnata da un asterisco, che rimanda al Glossario in fondo al volume. Invito i lettori a consultare di volta in volta il Glossario.
libro, per ragioni primariamente letterarie. Il primo è quello cosiddetto «dei Tre Regni» (220-280 d.C.), che ha inizio dopo la caduta -
tosto scarno, le Cronache dei Tre regni (IIIportante Romanzo dei Tre Regni, scritto durante la dinastia Ming, che narra le avventure di alcuni personaggi storici divenuti ormai leggenda: il primo ministro Cao Cao, lo stratega Zhuge Liang, il leale sovrano Liu Bei e il potente condottiero Guan Yu, venerato come vero e proprio dio della guerra. Un altro personaggio storico ricorVIIdia per poi riportare in Cina un gran numero di testi sacri sulla cui nato un altro romanzo classico, il Viaggio in Occidente, ma più che -
Questi e altri romanzi Ming (secc. XIV-XVII) e Qing (secc. XVII-XX) sono un punto di riferimento fondamentale per il fumetto cinese e dunque torneranno più volte tra le pagine di questo libro. Alla dinastia Qing è riservata particolare attenzione anche per un altro riferimento importante del fumetto: il teatro musicale detto «Opera -
zione di altre forme teatrali più antiche. È caratterizzato dalla commistione di mimo, danza, arti marziali, canto e musica. Gli attoriviene così chiamata in italiano per il grande peso che hanno canto e musica nelle esibizioni.
Le lingue cinesi
infatti parlare più correttamente di lingue cinesi o sinitiche. A livellociali è il cosiddetto mandarino standard, in cinese chiamato «lingua
comune» (putonghua), ma sul territorio della Repubblica popolare sidi km2) suolo cinese sono legate indissolubilmente alla storia della Cina continentale come territorio composito. I dialetti del Nord, da cui deriva la lingua comune, sono parlati dalla maggioranza della popolazione e sono mutuamente comprensibili. Tra i più parlati vi -
(usati nella provincia dello Jiangxi), ossia i dialetti del centro, e idella Cina meridionale.
libro, che a seconda del contesto di utilizzo si possano utilizzare parole diverse per esprimere gli stessi concetti (cfr. il Capitolo II). Si è
di partenza per comprendere questa suddivisione di massima sono -
va (Vogelsang 2014: XXIII). Si tratta di una regione fertile, dal clima nord (clima continentale secco) e sud (clima caldo e umido): i monti Qinlin (ivi: XXIV). Mentre i territori settentrionali sono più omogenei o comunque più adatti al movimento di persone e beni, e a preva-gelsang: «molti aspetti della storia cinese si possono comprenderegione e regione» (ivi: XV).mentale nel corso della storia della Cina. La lingua scritta ha contri-
buito a questo, garantendo la comunicazione tra i cittadini con una XXbeta)4
Le prime tracce di scrittura risalgono alla dinastia Shang: da quel momento è possibile indagarne la sua evoluzione. La scrittura cinese non mira a trascrivere suoni distinti come quella alfabetica, mami o, più semplicemente, caratteri (hanzi), che sono anche morfemi, -
mi, simbologrammi, ideogrammi, ideofonogrammi o caratteri fo-
Le prime quattro si distinguono sulla base di diversi criteri di combinazione dei componenti e del loro rapporto con il referente. ren 人, che mu 木 shan 山-
menti simbolici che danno informazioni sulla lettura del carattere indicando quale parte del pittogramma considerare e come. Esempi chiashang 上 xia 下 shang,xia si sviluppa
Gli ideogrammi sono rappresentazioni simboliche e nascono il suono). Un esempio molto semplice è il carattere ming 明ri 日 yue 月
4 Si veda la ricerca di Ross et al., secondo cui un netto miglioramento si è registrato in seguito UNESCO 2022). I dati oscillano a seconda dei criteri di riferimento.
Contrariamente a quanto si possa pensare, tuttavia, la rappresentazione scritta di un carattere non è completamente indipendente dalla sua pronuncia: la tipologia più comune sono gli ideofono-
sempio più semplice, presentato spesso durante la prima lezione di cinese per principianti, è il carattere ma 妈 una componente semantica a sinistra 女 (nünetica a destra 马 (ma
(che sono, spesso, anche semantiche). Un esempio menzionato di frequente è lai 来 lai 莱 caso manca la componente cao (草 o 艹), collocato nella parte susemantico dei vegetali.
lao 老 考 al secondo carattere poiché chi esaminava era solitamente anziano.dividono anche in “tradizionali” (fanti zi), utilizzati nella RPC
sione sulla scrittura di almeno un cinquantennio prima (per un riassunto agevole e divulgativo si veda Liu 2023), informa anche la più un mito (Paoliello 2021), e in quanto mito ci aiuta a comprendere meglio il costrutto storico, politico e culturale che è «la Cina».
Per far sì che chi non conosce i caratteri riesca a leggerli (ossia a conoscere la loro pronuncia), oggi il sistema di trascrizione fonetica in caratteri latini più utilizzato è il cosiddetto pinyin (cfr. la Nota 2), impiegato anche nel presente libro.
-
XVII-XX) e la Gran«Trattati ineguali».5 Questi ebbero sulla Cina un grande impatto: -
Kong fu ceduta come colonia alla Gran Bretagna. Inoltre, in seguito ad altri trattati successivi a quello di Nanchino e ugualmente «ineguali», a Shanghai furono instituite la Concessione britannica (poi anglo-statunitense) e la Concessione francese. In queste zone, citta-
cittadini cinesi a sfuggire persecuzioni politiche. Molti personaggi cinesi di spicco (autori, artisti e politici) vi si rifugiavano per portareXX). Le guerre contro le potenze occidentali del XIX
XVIII parte della storia. Nel corso del XX
5naccia delle cannonate del commodoro Perry e dei suoi vascelli neri di fronte al porto di Yokohama nel 1853.spartizioni successive.
litiche ed economiche ma anche, e questo è importante nel nostro
non si prendesse in considerazione questo punto di partenza. Per «Occidente» (e i suoi derivati) come dato di fatto e si forniranno indicazioni più puntuali e oggettive. Tuttavia, quando questi termini siano da inquadrarsi nel discorso culturale cinese, allora verranno mantenuti in questa accezione.
zione letteraria. Secondo la critica cinese, a cui la sinologia interna-
moderna viene collocato in concomitanza del movimento del Quat-
prescindibile: i sinologi Bonnie McDougall e Louie Kam osservano che «il concetto stesso di letteratura nella Cina moderna deriva da
coincide invece con la fondazione della Repubblica popolare cinese
Oltre a dover gestire le guerre con le potenze straniere, durante il XIX
modello degli eserciti europei (in particolare quello che allora era
a un lungo processo di rinnovamento, partito nel XIX secolo con dei -
voluzionari cinesi, la Lega giurata (Tongmenhui), un gruppo segreto repubblica), che univa diversi gruppi rivoluzionari intenzionati a rovesciare la dinastia mancese e a stabilire una repubblica.
periodo di caos politico in cui alcuni governatori delle province, e le loro cricche militari, divennero dei veri e propri regnanti. È il periodo aveva richiesto alle potenze europee e agli Stati Uniti un sostegno per arginare le richieste territoriali del Giappone. Terminata la guerra, tuttavia, il Trattato di Versailles sancì non la restituzionedel Quattro maggio, la prima vera e propria protesta studentesca della storia cinese. Le manifestazioni si innestavano su un percorso di rinnovamento ormai avviato da tempo: da qualche anno infatti, sulla rivista progressista Gioventù nuova, si proponeva un rinnova-ce, comprensibile e accessibile.
letteratura cinese moderna, segnata in questi primi anni da perso--
della storia della Cina moderna e contemporanea. In alleanza conCC
nazionalista da pechino a Nanchino (Shanghai rimase in ogni caso il centro economico prima e culturale poi) e diede inizio a quello che è stato poi chiamato il Decennio di Nanchino, che si concluse con lo scoppio della Seconda guerra sino-giapponese.
alleati, i membri del PCC sopravvissuti si erano rifugiati nello Jian-che sarebbe passata alla storia come Lunga Marcia. Il percorso è RPC perché costellato di eventi e atti di eroismo che fecero emergere su
Shanxi (nord), in ottomila, dopo aver percorso circa 10mila km, e lì
di annientamento del nemico comunista perché un altro nemico era ormai alle porte, e dunque nazionalisti e comunisti si allearono nuovamente nel Secondo fronte unito, questa volta contro il Giappone. -
un altro «incidente» causato ad hoc dalle forze armate giapponesi
importanti furono ottenuti dai soldati comunisti anche in battaglie frontali, ma le truppe preferivano ricorrere a strategie di guerriglia
colonizzazione giapponese. -
fondamentale per scrittori e artisti: letteratura e arte dovevano essere subordinate alla politica. Per questo motivo, eventi e decisioni governative prese nel corso del periodo maoista ebbero un impatto diretto sulla produzione culturale e, di conseguenza, per comprendere le articolazioni formali e contenutistiche dei fumetti cinesi non possiamo prescindere dagli eventi e dalle linee guida imposti dal partito.
I diciassette anni che intercorrono dalla fondazione della Repub-
nazionale da eventi quali il lancio di piani quinquennali, sulla base dei quali i regimi socialisti decidono le politiche economiche, e di
ampio e continuo coinvolgimento delle masse nella vita del Paese. Tra le prime campagne politiche legate al ruolo internazionale della RPC vi fu «Resistere agli USA, supportare la Corea» (Kangmeimocratica di Corea). Per ragioni politiche, la RPC era schierata con la Corea del Nord, ma intervenne solamente quando gli Stati Uniti, -
a esprimersi liberamente, anche proponendo critiche costruttive.-
portano che la popolazione diminuì di 10 milioni, ma altre stimeredini della Cina, guidandola verso una direzione più moderata, RPCRPC e Liu Shaoqi fu criticato, allontanato e morì per i maltrattamenti subiti
La Grande rivoluzione culturale proletaria, conosciuta come Rivointestina tra la fazione maoista, più radicale, e quella più moderata di Liu Shaoqi. Questa seconda corrente interna al partito aveva acavanti e stava muovendo il discorso pubblico verso toni più modera-to Mao Zhuxi yulunosciuto come Libretto rosso di Mao che divenne riferimento cardine delle masse durante tutti gli anni Sessanta e per gran parte degli anni Settanta.
tra fazioni di giovani Guardie rosse. I giovani, anche troppo giovani, furono un soggetto sociale e politico fondamentale per Rivoluzione,forza politica da lui stesso liberata, e le Guardie rosse, giovani protagoniste della rivoluzione, assunsero un nuovo nome e un altro ruolo. Ne seguì una lunga manovra di espulsione delle Guardie rosse dai territori urbani: la «gioventù istruita» (zhiqing) fu allontanata. La successore di Mao era stato scritto nella Costituzione, morì in quello lui legati avevano tentato un colpo di stato e il suo aereo in fuga ver-
di alcuni canoni estetici rappresentati, nel teatro, dalle otto «Opere rivoluzionarie modello». Queste otto opere, selezionate dalla moglie di Mao, Jiang Qing, divennero il bacino più autorevole a cui attingere immagini e pratiche. Alcune di queste opere, ossia i «balletti moderni rivoluzionari» come Il distaccamento femminile rosso (cfr. § 10.1), erano spiccatamente interculturali: ispirate al balletto
gianti ispirati al teatro tradizionale cinese. Il balletto rivoluzionario era un «balletto sinizzato» che combinava il balletto (di origine eu-
comitato centrale del PCC
Il motore delle riforme furono le «quattro modernizzazioni» (sige xiandaihua), che riguardavano agricoltura, scienza e tecnologia,
ro anche istituite delle Zone economiche speciali (ZES), tra cui per stranieri trovarono terreno più che fertile a causa della regolamentazione ad hoc. caratteristiche cinesi» o, più precisamente, «sistema economico so-
to con quello dello sviluppo economico quale strategia nazionale. La
tico, sociale ed economico, ma anche letterario e artistico. Gli anni Ottanta erano stati un decennio di grande apertura e sperimentazione, che aveva visto alternarsi momenti di nichilismo e idealismo in chiaramente il compromesso tra le forze politiche e gli attori sociali, meno) di rimanere in patria: se arricchirsi divenne «glorioso», sviluppare tattiche di adattamento in un contesto di controllo ideoloavevano avuto durante gli anni Ottanta e anche il loro ruolo nella Novanta sono caratterizzati da un estremo pluralismo, dalla nascita -
zione della cultura e dando vita a fenomeni profondamente diversi,RPC -
zione mondiale del commercio (OMC), avvenuta nel 2001 sotto laci, culturali e sociali se non propriamente politici) apertisi durandiscussioni sulla democratizzazione, vista come inevitabile conse-
tao hanno visto emergere fenomeni socioculturali molto interessane desideri completamente nuovi rispetto alle generazioni precedendesigna un gruppo sociale ma anche un vero e proprio fenomeno letterario commerciale (i balinghou cavalcano il nuovo secolo con ultimi capitoli di questo volume.
IL FUMETTO CINESE ESISTE, HA UNA SUA STORIA, UNA SUA IDENTITÀ E UN GRANDE SPAZIO DI MERCATO.
Il fumetto cinese è, in Italia, un oggetto sconosciuto. Un oggetto però con una storia ricca e affascinante, che merita di essere scoperta ed esplorata dagli amatori di narrativa disegnata, dagli studiosi di culture e media visuali, dagli orientalisti e da coloro che si interessano ai fumetti asiatici, forse già incuriositi dal debordante successo dei manga (giapponesi) e dalla crescente presenza dei manhwa (coreani).
Il fumetto cinese, tuttavia, oggi noto come manhua, ha le sue personalità multiple, i suoi stili di racconto, la sua complessa storia socioculturale ed estetica. Questo libro, scritto da una delle maggiori esperte italiane, è la migliore introduzione possibile all’argomento: accurata, completa, informata, riccamente illustrata e abile nel rendere chiare ai lettori le componenti contestuali della storia moderna e contemporanea cinese, fattore fondamentale per orientarsi agevolmente nella vicenda storica dei fumetti in Cina e, di recente, della loro espansione all’estero.
MARTINA CASCHERA (Napoli, 1986) è ricercatrice presso l’Università degli Studi di Bergamo. Dal 2019 si interessa di traduzione di fumetti dal cinese e della loro popolarizzazione nel contesto italiano. Tra le ultime pubblicazioni, TransculturalTransmediaReinvention:Shuihuzhuan(WaterMargin)fromChinese classictoItaliancomicart(per l’editore Brill, 2022), Ilfumettocinesetracentro eperiferia (H-Ermes, 2018) e Women in Cartoons (International Journal of Comic Art, 2018).