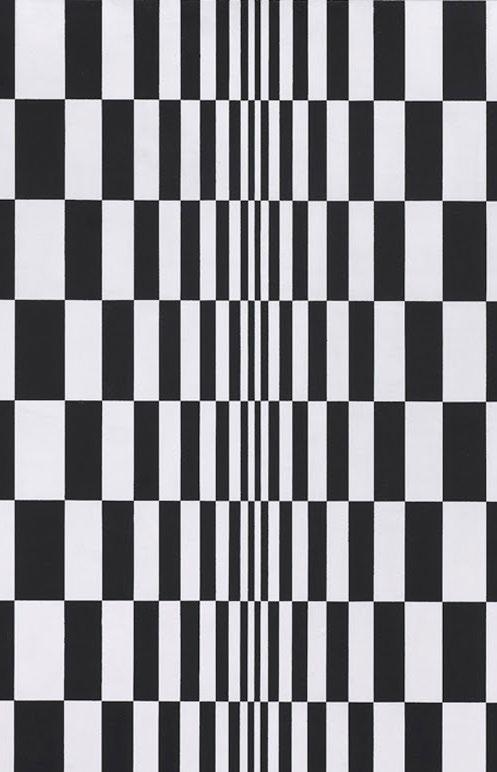
4 minute read
Il Bene Comune
Le buone notizie sono impossibili o invisibili? Il bene comune ha per sua natura una estensione e uno sguardo al futuro? Chi se ne deve occupare? Per rispondere, nel libro pubblicato da Armando Editore, parto da queste considerazioni.
Chi si deve occupare del bene comune? Pensare oltre il particolarismo, pensare oltre l’interesse, cercare di conciliare, e di agire: intraprendere azioni anche quando non sono vantaggiose per sé nell’immediato, per la prossima tornata elettorale, per le scadenze utili ad assecondare le richieste dell’elettore, dell’iscritto, ma capaci comunque di essere Politica, ossia immaginare, prevedere, programmare, pensarsi comunità e bene comune. Fare semplicemente il proprio dovere per principio, in ragione di leggi morali superiori anche allo Stato, se queste sono insufficienti a garantirlo, come direbbe Antigone. E la Politica è ridurre queste distanze. “La classe dirigente che non persegue obiettivi comuni e comunque non nello stesso tempo” fa dell’Italia quel Paese del Nì di cui parla il Presidente dell’Eurispes nel Rapporto Italia 2019.
Advertisement
Il bene comune spiegato da una bambina di 6 anni.
“Mamma voglio fare un mercatino. Perché, a cosa ti serve? Perché lo scivolo della mia scuola è rotto, non il mio, perché non ho mai avuto uno scivolo. Ma non andrai più in quella scuola. Non mi interessa per me, ma per il prossimo bambino che andrà in quella scuola. Per tutti i bambini. Voglio organizzare una raccolta fondi. Mamma devi aiutarmi. E se non vuoi aiutarmi lo faccio da sola. Farò delle limonate e le venderò”. Ecco il bene comune, pensare a chi verrà dopo, preoccuparsi per chi capiterà in quella scuola e non potrà usufruire come hanno fatto loro di un gioco che piace a tutti i bambini, che aiuta già nei primi giorni ad ambientarsi. I ricavati saranno dedicati a uno scopo di cui la bambina non beneficerà neanche, in prima persona. Ecco un esempio di coscienza civile e di cittadinanza attiva.
C’è poi chi, a Genova, servendosi del libro, ha pensato ad un alfabeto del bene comune in didattica a distanza seguendo la domanda del sottotitolo: Dove spingere lo sguardo della Politica.
“Ciò che impariamo a scuola si aggancia a chi saremo in futuro e a chi siamo fuori da scuola”. Un percorso, questo, che ha coinvolto la redazione del giornale scolastico insieme al professore Maurizio Braggion e all’associazione The Bright Side: un’esperienza di giornalismo incentrato cioè sulle notizie e sulla soluzione ai problemi, imparando a “interloquire con chi quelle soluzioni le deve portare”.
Il libro quindi è diventato di testo nelle scuole e i lavori intorno al bene comune sono stati premiati dall’agenzia stampa Dire.
La Civil Economy, quel senso civico alla base delle istituzioni, dell’impresa e della scuola, secondo Stefano Zamagni, fa riflettere su questa affermazione: “Il modello bipolare Stato/Mercato è finito e bisogna passare ad un modello tripolare Stato/Mercato/ Comunità”.
In caso contrario si crea un sistema immobile, basato sia su un lento e conflittuale ricambio generazionale, soprattutto nel mercato del lavoro - contemporaneamente tanto ingessato quanto precario - sia su talune altre disfunzioni tipiche del nostro Paese. Ricordiamocelo nel processo di creazione di una cittadinanza europea, che sicuramente è ancora da costruire nella nostra società in cui bisogna non rinunciare ai corpi intermedi e ai luoghi fisici che favoriscono la creazione di comunità ( biblioteche, musei,..).
Parliamo ora di occupazione giovanile, ossia storie di un presente che non pensava al futuro.
Perché facciamo fatica a trovare lavoro, a innovare, a colmare il mismatching tra domanda e offerta? Perché siamo il penultimo Paese della UE per numero di laureati?
Nel libro parlo del fatto che siamo un Paese che invecchia e dove prevalgono le età centrali e che, per la creazione delle competenze, si fa riferimento soltanto alla scuola o all’università. In pratica i giovani si formano e si aggiornano, mentre chi lavora appende i libri al chiodo.
Il risultato è una working class con competenze appassite o, peggio, obsolete. Per fornire un numero, la percentuale di popolazione adulta che ha fatto formazione nell’ultimo anno è bassissima: circa il 7%. La soluzione è quindi tornare a investire sulle competenze. E tradurre la conoscenza in comportamento così da contare su lavoratori e cittadini dotati di senso critico. La mancanza di istruzione incide infatti su salute, economia, cultura, lavoro, politica e tutela ambientale.
Il mercato del lavoro italiano è stato indebolito – come dimostrano le statistiche occupazionali dei nostri laureati – dal fatto di aver separato le lauree umanistiche da quelle STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) e lo ha privato di profili che sarebbero potuti essere utili e funzionali all’innovazione.
Intanto lì dove il tessuto economico li ha favoriti e la mentalità non li ha osteggiati, l’82% dei neodiplomati presso gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) trova lavoro. Ma ciò avviene solo nel Nord produttivo.
Vediamo ora come l’alternanza scuolalavoro, rinominata «percorsi per le competenze traversali e per l’orientamento, sta procedendo:
• riducendo le ore obbligatorie (da 400 a 210 nei professionali, da 400 a 150 nei tecnici e da 200 a 90 nei licei) lasciare il tempo di farle funzionare. Che Paese stiamo creando dove 4 laureati su 10 non hanno un lavoro dopo 36 mesi dall’ottenimento del titolo?
• dove non si riesce a far dialogare discipline diverse, creando ponti tra le scienze sociali, le materie scientifiche e quelle umanistiche.
Il bene comune è partecipazione, débat public, giornalismo costruttivo, fare bene il proprio lavoro.
Quando i giovani restano fuori dal mondo del lavoro, alle imprese vengono a mancare energia, entusiasmo, innovazione, gioia di vivere, che sono preziosi beni comuni che migliorano la vita economica e aumentano la felicità delle persone.
Benedetta Cosmi






