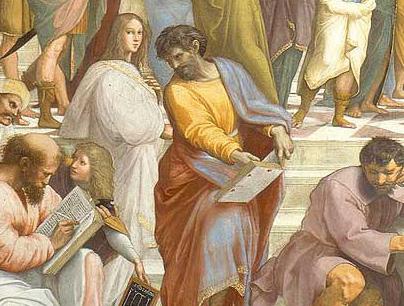7 minute read
Intervista a Enrico Falck
Presidente di FALCK Renewables spa e di Fondazione Sodalitas
Rispetto ai partner europei, l’Italia è avanti nella produzione e nel consumo delle energie rinnovabili. Come mai questo primato? Che cosa ci servirebbe per aumentarne ulteriormente la diffusione?
Advertisement
Gli impianti solari in Italia, grazie al maggiore monte ore di sole annuale, funzionano a piena potenza per un periodo più lungo rispetto a Paesi con minore irraggiamento. Di conseguenza, a parità di costi, l’investimento è più attraente perché minore è il costo del kWh. Ma questo non sarebbe stato sufficiente a consentire lo sviluppo attuale: le politiche di sostegno e incentivazione della scorsa decade sono state determinanti nella diffusione degli impianti di produzione da fonte rinnovabile.
Negli ultimi cinque anni, nonostante gli elevati target nazionali, si è registrato un rilevante rallentamento nello sviluppo,
dovuto, fondamentalmente, a lentezze burocratiche. È necessaria, quindi, una riforma organica delle procedure di autorizzazione, che passa dall’uniformare i procedimenti a livello nazionale e regionale, al rispetto di tempistiche stabilite entro le quali le amministrazioni, chiamate a rendere un parere o a esprimere valutazioni tecniche, devono rispondere. Serve poi una spinta verso l’elettrificazione del consumo, accompagnata da quote crescenti di acquisto di energia verde da parte, in primis della Pubblica Amministrazione, ma anche da parte dei consumatori civili e industriali in generale. Infine, è necessario si investa sugli accumuli di energia verde, quali batterie elettrochimiche o idrogeno verde, affinché le rinnovabili siano integrate nel mercato elettrico.
Fatto 100 l’investimento totale in un impianto di rinnovabili, quanto pesa il suo sistema di stoccaggio?
È difficile dare un range specifico, poiché molto dipende dal tipo di stoccaggio e dai costi ad esso associati, che dipendono a loro volta dalla maturità della tecnologia. Il dimensionamento dello storage è legato sia a motivi di natura tecnica sia economica e varia in funzione della capacità dell’impianto e dei servizi che andrà a prestare. Tutte queste valutazioni rispetto all’investimento vengono fatte caso per caso. Questo dà l’idea della complessità associata a questa tecnologia.
Se le politiche di sviluppo industriali si indirizzassero verso i sistemi di accumulo di energia verde invece che verso nuovi impianti a gas e a risolvere gli effetti della non programmabilità delle fonti primarie di vento e sole, avremmo uno sviluppo delle rinnovabili molto più rapido e sostenibile. Un recente studio indipendente inglese (“Foot off the gas – Why Italy should invest in clean energy”, Carbon Tracker Initiative e RMI, https://carbontracker.org/) dimostra che un Clean Energy Portfolio sarebbe in grado di fornire gli stessi servizi oggi forniti da impianti tradizionali con costi minori. Se vogliamo sviluppare un mercato elettrico basato sulle rinnovabili è necessario avere una visione di lungo termine e per abbandonare definitivamente gli impianti a fonti fossili, e soprattutto non costruirne di nuovi come vorrebbero i recenti piani di sviluppo, gli accumuli sono un elemento necessario ed essenziale.
Per l’esercizio 2020 Falck Renewables, di cui lei è il Presidente, ha dichiarato di aver evitato la produzione - e la conseguente dispersione in atmosfera - di 569mila tonnellate di CO2. Ora, dato che una persona ne genera annualmente 13 tonnellate, significa che voi avete fatto risparmiare al Pianeta il consumo di 43.769 persone. Di fronte a questi dati, ci aspetteremmo di assistere ad una diffusione molto più estesa di rinnovabili. Cosa osta?
Torno su un punto già toccato: risolvere la questione autorizzativa è la chiave per poter innescare quella transizione che ancora oggi stenta a prendere il via. Ci sono poi altri elementi che rallentano la diffusione delle rinnovabili e in generale la transizione energetica. Uno di questi è la remunerazione delle esternalità negative causate dall’inquinamento. Se le fonti di emissione pagassero il prezzo dei danni che causano all’ambiente e alla salute umana, nel giro di pochi anni andremmo tutti ad auto elettrica o ad idrogeno e tenderemmo ad elettrificare tutti i nostri consumi. Ma la cosa affascinante è che scopriremmo che il tutto può già avvenire a costi competitivi e, soprattutto, quanto migliorerebbe la qualità di vita nostra e dell’ecosistema attorno a noi!
C’è quindi bisogno di un cambio di paradigma. Di una riallocazione delle risorse a beneficio di investimenti che favoriscano e spingano la decarbonizzazione. Ad esempio ci si aspetta che il sistema EU ETS/carbon pricing contribuisca a dare maggior supporto al prezzo dell’energia elettrica: è necessario proseguire nella sua ristrutturazione, ma stiamo andando nella direzione giusta.
Ma il vero paradosso è che stabiliamo obiettivi basati sulle rinnovabili e sulla decarbonizzazione spesso con forti critiche, ingiustificate se non per specifici interessi, sulla loro sostenibilità economica. E invece la reale insostenibilità, non solo economica ma generale, è un’Unione europea che sovvenziona in modo molto evidente i combustibili fossili, attraverso finanziamenti diretti, esenzioni fiscali, sovvenzioni all’acquisto di diesel, il tutto per un importo che pesa per circa 55 miliardi di euro all’anno. A livello europeo ci siamo dati un obiettivo di net-zero al 2050. Se non ci sarà un cambio di passo, non lo raggiungeremo.
Da poco più di un anno lei è il Presidente di Sodalitas, fondazione nata nel 1995, la prima a promuovere la cultura della sostenibilità d’impresa. Dopo così tanti anni perché imprenditori e opinione pubblica fanno ancora fatica ad adeguarsi alla sostenibilità?
Fondazione Sodalitas è nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e dell’allora Presidente Ennio Presutti ed è stata la prima realtà a promuovere la Responsabilità Sociale d’Impresa in Italia, e siamo orgogliosi di aver contribuito a diffondere una consapevolezza che oggi è diffusa nella cultura d’impresa del nostro Paese.
Al tempo stesso va detto che il contesto è senz’altro diverso rispetto a 25 anni fa. Io credo che su questo tema l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, lanciata esattamente cinque anni fa, nel settembre 2015, abbia segnato un punto di svolta. L’Agenda ha avuto il merito di far crescere in modo diffuso la sensibilità e il senso di urgenza e di imprimere una forte accelerazione all’impegno degli stakeholder pubblici e privati sul fronte dello sviluppo sostenibile.
Sempre più imprese, in particolare, hanno progressivamente sviluppato un approccio più maturo e consapevole, arrivando a considerare la sostenibilità non più una questione di filantropia o di generico impegno sociale, ma un elemento fondamentale della propria strategia di sviluppo da orientare alla rigenerazione di quei capitali da cui dipende la crescita dell’azienda stessa: economico, naturale, umano, produttivo, sociale e intellettuale. Molto è stato fatto, ma certo molto rimane ancora da fare. Se tutti gli stakeholders del Paese, dall’opinione pubblica, alle imprese, dallo Stato ai vari enti pubblici e privati, avessero l’indirizzo comune di preservare e sviluppare tutti i capitali in modo omogeneo vivremmo in una società che cresce di più a costi decisamente inferiori.
Quanto è importante integrare governance aziendale e sostenibilità?
Più che importante, direi decisivo. La sostenibilità è un fattore strategico nella creazione di valore competitivo per l’azienda e nella creazione di valore per gli stakeholder e la comunità. Credo che le aziende associate a Fondazione Sodalitas, e in generale molte grandi imprese, abbiano ormai la sostenibilità nel loro DNA.
Vanno invece sostenute le PMI, che operano attraverso assetti industriali meno complessi e per questo motivo più a rischio avendo meno possibilità di diversificazione. Per queste imprese è importante dimostrare che la sostenibilità non è solamente un tema di comunicazione, che sarebbe una semplificazione inutile, o un tema di modello gestionale, che se mutuato dalle grandi aziende risulterebbe una complicazione altrettanto inutile. È necessario lavorare su modelli gestionali flessibili ed efficaci, in poche parole rendere la sostenibilità sostenibile.
Proprio in tal senso recentemente abbiamo lanciato, insieme a SDA Bocconi e con la collaborazione di Fondazione ENEL e Falck Renewables, un progetto chiamato eSG Lab.
Un’iniziativa nata proprio dalla riflessione, condivisa con il Rettore dell’Università Bocconi Gianmario Verona, sull’importanza che anche le piccole e medie imprese intraprendano in modo diffuso un percorso di crescita imprenditoriale e manageriale sui temi ESG (Environmental, Social e Governance), e integrino queste dimensioni nei processi decisionali e di governance per diventare più competitive grazie alla sostenibilità.
Abbiamo preso in prestito il Pianeta dai nostri figli. Cosa lasciamo loro?
È una responsabilità grande. Bisogna saper guardare al futuro con lo sguardo dei giovani. E mi fa piacere constatare che forse oggi proprio le giovani generazioni rappresentano la parte della società più attenta ai temi della sostenibilità e dell’ambiente. Ma allo stesso tempo sono generazioni a cui spesso tocca esprimere il loro dissenso in modo anche molto aperto e plateale; penso ai Fridays for Future per l’ambiente, a Occupy Wall Street per la finanza, a Black Lives Metters per i temi razziali e sociali, ed altri movimenti simili. E soprattutto mi preoccupa quando questo dissenso è invece muto, disperato e solitario come dimostrano i dati in crescita sulla disoccupazione giovanile, con il fenomeno dei NEET, e in generale tutti gli indicatori di disagio giovanile. In particolar modo durante questo periodo del COVID. Sintomo che la comunicazione e la comprensione intergenerazionale non funzionano bene, probabilmente nemmeno in passato hanno mai funzionato tanto bene ma adesso ciò ha effetti su tutto l’ecosistema del Pianeta. Oltre ad un Mondo migliore ai nostri figli dobbiamo lasciare una maggiore capacità di ascolto e di empatia, altrimenti ne mortificheremmo la loro fiducia nel futuro.
Su questo tema abbiamo lanciato con Sodalitas la Call for Future, una campagna rivolta alle imprese che nel nostro Paese sono più impegnate a realizzare azioni, progetti e soluzioni per un futuro sostenibile, contribuendo ad attuare l’Agenda 2030 dell’ONU, e dove abbiamo voluto coinvolgere anche i giovani, che sono i principali portatori di interesse del futuro.